

ARTE | STORIA | ARCHEOLOGIA | LETTERATURA | SOCIETÀ | MUSICA | SCIENZE 78|2022 NUMERO NOVEMBRE
ISSN 1127-5871 Rivista di divulgazione culturale e artistica del territorio marchigiano | Sped. in a.p. - 70% - Filiale di Ancona
La Vergine del Mystère

Una Venere-animale incisa nella pietra diecimila anni fa è la regina del museo Archeologico di Ancona
Il mistero attorno alla figura preistorica ha dato il via a una provocazione di fantasia con un personaggio di carta
La contaminazione è con Martin Mystère il detective-archeologo disegnato dall’anconetano Alessandrini
La storia del protagonista del fumetto diventa vita per la matita marchigiana pluripremiata come miglior disegnatore

3 Preludio

Controllori o controllati Bisogna collaborare
Allorquando una delle peggiori pandemie che si ricordino sembrava quasi debellata e superata, le ombre del conflitto russo-ucraino si sono allungate su questo 2022 ed anche il terremoto è ricomparso all’improvviso poche settimane fa al largo delle coste del pesarese e dell’anconetano. Questo a ribadire che qualsiasi progetto razionale deve fare i conti con l’essenza della natura che è imprevedibile e che risponde a logiche che seguono un loro corso appena pronosticabile e da noi difficilmente programmabile.
Non vi è dubbio che è in atto un profondo ripensamento tanto del nostro modello di sviluppo quanto della globalizzazione che stiamo vivendo o subendo dall’inizio del nuovo millennio. Ma è altrettanto vero che siamo diventati dei grandi progettisti e pianificatori, abbiamo sviluppato una umana presunzione di razionalizzare e regolamentare la natura, della quale non conosciamo le “ n” variabili che la compongono, seppure per secoli abbiamo imparato ad osservare, conoscere e capirne alcuni suoi meccanismi.
Infatti oggi siamo capaci di controllare il micro ambiente come quello di una stanza, di un edificio o come negli studi di Buckminster Fuller quello di una grande porzione di città come Manhattan; ma di tutt’altri strumenti e calcoli avremmo bisogno per poter controllare il macro ambiente proprio a causa delle infinite variabili che sono in gioco. Sebbene già i filosofi presocratici convennero che
l’universo fosse composto da pochi infinitesimi elementi che chiamarono atomi e li rappresentarono mediante la quaterna Aria, Acqua, Terra e Fuoco, noi non siamo ancora riusciti a “governarne” neppure uno dei quattro.

Oggi, infatti, nonostante le innumerevoli scoperte, non controlliamo ancora l’aria che è capace di muovere immense quantità d’acqua che provoca uragani , alluvioni e smottamenti. Non controlliamo l’acqua, sebbene siamo giunti a degli ottimi risultati nei Paesi Bassi e nell’applicazione del Mose nella laguna di Venezia. Non controlliamo il fuoco, che può devastare foreste e villaggi, né le eruzioni vulcaniche. Di pari passo, legati al fuoco ed alla terra, ci sono i movimenti tellurici, che ricordavamo all’inizio, che ci ammoniscono sulla precarietà delle nostre costruzioni.
Dalla comprensione che non abbiamo una natura statica dobbiamo cominciare a pensare di non essere obbligati a conservare uno “status quo” ed addirittura di non potercelo permettere, ma piuttosto di intraprendere una collaborazione mediante la quale comprendere ed armonizzare la nostra idea di sviluppo ad una natura in perpetuo divenire. In questa prospettiva è prudente diffidare dei falsi profeti che credono sia possibile regolamentare la natura, in gran parte a noi sconosciuta, e stabilire quote e soglie da non superare entro dati limiti di tempo.
Già … il Tempo! Un altro parametro che non conosciamo e non controlliamo. ¤
5 L’editoriale
di Filiberto Bracalente Presidente de Le Cento Città
Presuntuosi nel pensare di governare la natura, in realtà non governiamo né l’aria né acqua né terra e né fuoco
di Franco Elisei Direttore de Le Cento Città

Archeologia e Mistère una contaminazione
Archeologia, mistero e Mistère insieme. Non è una provocazione, piuttosto una contaminazione per valorizzare i soggetti coinvolti. Di stampo tutta marchigiana. Con una preziosa e straordinaria particolarità: la copertina di questo numero. Un pezzo unico disegnato per l’occasione ed esclusivamente per le Centocittà, dal notissimo illustratore anconetano Giancarlo Alessandrini che vogliamo festeggiare così, nei servizi di Pellegrino e Giantomassi, per i suoi cinquanta anni di successi e di professione completamente dedicata a realizzare storici fumetti come Tex, Dylan Dog, Ken Parker e, appunto, Martin Mystère, il detective dell’impossibile e del mistero.
Lo stesso mistero di cui è avvolta una piccola pietra, che il nostro protagonista del fumetto tiene in mano, su cui è inciso un corpo di donna con la testa di animale. Stile Minotauro. Una Venere preistorica che risale a circa diecimila anni fa, conservata nel museo archeologico di Ancona. Il ciottolo è stato ritrovato a Tolentino in una cava d’argilla, quindi patrimonio tutto marchigiano. Dal valore inestimabile. Un’opera d’arte paleolitica che equivale ad un gioiello “senza eguali nel mondo”, come afferma il direttore del museo Diego Voltolini, perché ritenuta la prima rappresentazione astratta dell’uomo. Una Venere-animale che ha tutti i crismi per diventare un simbolo del museo archeologico del capoluogo. Un po’ – azzardiamo – come lo è l’atleta di Lisippo nel Paul Getty Museum di Los Angeles. Altro reperto – conte-
so- proveniente dalle Marche. La Venere di Tolentino è una regina della preistoria e del mistero. E per celebrarla, quale miglior occasione se non quella di affidarla fantasticamente, in copertina, alla penna che disegna Martin Mistère, il personaggio in edicola da 40 anni esatti e che nel proprio curriculum risulta laureato in antropologia con specializzazione in archeologia? Oltre che investigatore del mistero? Un modo per festeggiare il nostro Alessandrini che tratteggia e anima il protagonista del fumetto e per accendere i riflettori sulla fantomatica regina di diecimila anni fa.
Altri riflettori, di altra natura - come è nella mission della rivista – sono stati accesi nelle pagine seguenti, su un’interessante ricostruzione di progetti e tematiche affrontate alla fine degli anni Settanta e ancor oggi attualissime, a distanza di oltre cinquanta anni. Luca Maria Cristini ha rispolverato il modello/sogno di “Città Regione” e il suo sviluppo dal punto di vista socio-economico e culturale. Ha ricordato come il progetto e l’opportunità dell’arretramento dell’autostrada siano stati sollevati ben dieci lustri fa dai cosiddetti “kennediani”, ovvero portatori di un’idea innovativa nel clima politico, imprenditoriale e sociale, aggiungendo un’ipotesi di Pedemontana e una griglia di mobilità che intendevano liberare le Marche da un isolamento ancora oggi non del tutto risolto. Un isolamento che non le permette di valorizzare come vorrebbe e dovrebbe, il bellissimo patrimonio che possiede. ¤
6 Il punto
In copertina il disegno di Alessandrini in esclusiva per le Centocittà con Martin e la pietra preistorica
Sommario

Marchigiani nel mondo Emigrante nel cuore, il sogno di un lavoro e la nostalgia in rima
DI PAOLA CIMARELLI
Il ricordo Bruni, abile scrittore e “medico di una volta”

DI CLAUDIO DESIDERI

Quarant’anni dopo Dalla Chiesa, giovane ufficiale a San Benedetto
DI MARIO AREZZINI
L’uomo della glasnost Gorbaciov, a Urbino la sua idea della Terra

DI SIMONETTA MARFOGLIA
La mostra a Sassoferrato Salvi e Samorì, visioni controcorrente dell’arte
DI FEDERICA FACCHINI
Non solo ritratti I collezionisti, giganti del mecenatismo




DI MARCO BELOGI
Contaminazioni Piattella nell’azzurro un poeta del colore
DI ALBERTO MAZZACCHERA
7
Argomenti
10
20 27 29
15 17 19
31

Sommario
L’artista

La riscoperta di Bazzali il pittore nomade
DI GRAZIA CALEGARI
34 38 45 49 52 57
Regine della Preistoria
La Venere “Minotauro” gioiello del Paleolitico
DI LUCILLA NICCOLINI
Il personaggio
Il segno di Alessandrini su Mystère detective degli enigmi

DI ALBERTO PELLEGRINO
L’intervista
Alessandrini:
“Nato con la matita in mano”
DI SERGIO GIANTOMASSI
Il borgo

La mia Pietrarubbia città di pietre narranti


DI GIORDANO PIERLORENZI
San Girolamo a Urbino Sotto i libri universitari un carcere fine ‘800

DI MARIA ELENA MARSICO ED ENRICO MASCILLI MIGLIORINI
Il volume Paesaggi d’architettura attraverso la fotografia
DI ALBERTO PELLEGRINO

8 Argomenti
61 65

Sommario
Il progetto Un centro culturale dalle “ceneri” industriali

DI GIOVANNI FILOSA
La manifestazione | 1 Messaggi di pace dal Premio Fabriano
DI CLAUDIO SARGENTI
69 71 73 82 85
La manifestazione | 2 Arte, cultura e imprese occasione di dialogo

DI CLAUDIO SARGENTI
Nozze d’argento sul palco Ventisei ore in coda per un posto a teatro

DI LUIGI BENELLI

Marche ‘70
I giovani “kennediani” e l’idea di città regione


DI LUCA MARIA CRISTINI
Non solo Rof e Sferisterio Nelle Marche in scena anche un’Altra Lirica
DI FRANCO DE MARCO
L’incursione
Tre eroici pesaresi nel raid dei Dardanelli
DI DANTE TREBBI

9
Argomenti
Si firma Ollens e scrive poesie. Ha compiuto 92 anni il 30 gennaio e racconta in rima la sua storia, i sentimenti, i ricordi. Nelle sue vite precedenti, Nello Spaghetti è stato manovale, minatore, conduttore, elettricista specializzato ma prima di tutto emigrante. Vive con Adria, sua moglie da 60 anni, "abbiamo festeggiato le nozze di diamante il 1 settembre", in una casa, "costruita muro dopo muro, stanza dopo stanza, da me e il mio manuale", scherza riferendosi alla consorte, "la sua roccia", in rue de l'Eglise, a Marspich, un "village" della Moselle. Un dipartimento del nord-est della Francia, caratterizzato da un grande sviluppo economico nel dopoguerra grazie alla presenza delle miniere e dell'industria siderurgica, comparti che hanno offerto lavoro a tanti migranti, moltissimi italiani. Due rami produttivi che hanno subito una profonda trasformazione con il cambio dell'economia francese ed europea.





Monsieur Spaghettì è nato a Roma dove ha passato i primi anni con la mamma Lina. "I primi tempi mi aveva messo a balia a Frosinone. Lavorava a servizio dal professor Nathan - ricorda – che ha permesso di farmi stare in casa con loro a condizione che non dessi fastidio a nessuno. Mi chiamava trombetta, perché giravo suonando questo piccolo strumento, e mi diceva sempre vacca di un papusso". A 5 anni, viene portato dai nonni materni, Caterina e Nicola, che vivono a Sassoferrato. Cresce in una famiglia unita e numerosa, con le sorelle della mamma, Maria, Lucia, Lisa, i cugini Rosina, Luigi e Felice che, un po' più grandi di lui, non lo salvano dai piccoli scherzi fra bambini. Passa la giovinezza alle pendici del monte Strega, a Sant'Egidio e Frassineta. Per andare alle scuole elementari, a Valdolmo, deve fare quattro

Marchigiani nel mondo
di Paola Cimarelli
Il grande passo a 19 anni quando decise di raggiungere lo zio Gustavo costretto a scegliere la via della montagna per passare il confine
A destra, Nello Spaghetti in una foto da giovane e subito sotto nel cantiere di Hombourg-Haut Sopra il titolo, in una pausa con i colleghi Sotto, Nello con Adria nel giorno del loro matrimonio Sullo sfondo, il vecchio impianto siderurgico di Hayange
Emigrante nel cuore il sogno di un lavoro e la nostalgia in rima
chilometri a piedi. Si sposta con i parenti a San Donato, nel fabrianese, e, poi, con il rientro della madre da Roma, si stabilisce di nuovo a Sassoferrato, vicino alla chiesa di Santa Maria. Racconta dell'infanzia con dolcezza e grandi occhi velati. "Era nonna Caterina il centro della nostra casa - dice -. Ci preparava i tagliolini pelosi, buonissimi. Li chiamava così perché erano senza uova. Li metteva nell’acqua con qualche pezzo di pomodoro e con il battuto di guanciale e cuoceva tutto insieme come una minestra. E poi la Befana, che si aspettava con emozione, con la calza appesa la sera prima sul camino, in cucina. La mattina trovavamo una rotella di fichi secchi, una o due arance, ma c'era anche la paura di avere solo carbone. Il desiderio era di trovare una banana, un frutto prelibato e costoso. Comunque, era sempre una grande gioia". Dopo le elementari, comincia l'avviamento professionale, ma, pur con buoni risultati, sente forte il richiamo
del lavoro. A 12 anni va a lavorare da un fabbro, Domenico Lepri, dove si occupa della forgia, e poi, da 14 a 17 anni, nel lanificio sassoferratese Sadori, alla filatura. Erano gli anni della guerra e “spesso mancava la luce per due-ore e allora io andavo a giocare a pallone al campo sportivo”. Il tempo passa e i soldi però non sono abbastanza e a 19 anni decide di fare il grande passo, andare in Francia dove, da sei mesi, si è trasferito lo zio Gustavo, fratello della madre.
precursore, alla fine del 1949, dell'emigrazione della famiglia in terra francese. Oltre a Nello saranno diversi i nipoti che lo seguiranno per cercare una vita migliore, lo stesso Luigi con cui giocava da bambino e con cui condividerà un pezzo di vita nella terra delle miniere. Gustavo ha i documenti italiani in regola per espatriare ma non ha il permesso di lavoro francese. Per passare il confine, è costretto a scegliere la via della montagna con altri cinque compagni.È protagonista, quindi, di una vicenda simile a quella raccontata l'anno dopo dal regista Pietro Germi nel film "Il cammino della speranza", con Raf Vallone ed Elena Varzi. Entra in Francia da clandestino. Il gruppo viene fermato dai gendarmi e finisce brevemente in cella. Sarà il Comune di Hombourg-Haut, nella Moselle, a tirarli fuori obbligandoli a tagliare alberi nei boschi vicini. Una volta rientrato a valle, Gustavo Spaghetti comincia a cercare un impiego e Nello, dopo un po',




11
È il
NELLO SPAGHETTI, 92 ANNI, DA SASSOFERRATO A MARSPICH CON ADRIA
decide di raggiungerlo. Lo zio, però, gli chiede, per lettera, di aspettare perché in quel periodo non ha lavoro e al suo arrivo si troverebbero entrambi in difficoltà. Nello parte lo stesso e compie il lungo viaggio in treno, più di venti ore, con la signora Maria Costantini, la padrona di casa dove era in affitto a Sassoferrato, che raggiunge il figlio che lavora nella stessa zona. "Arriviamo alla stazione di Metz alle 3 di notte. Era bellissima, con le volte disegnate ed era piena di gente - racconta -. Avevo scritto dell'arrivo a mio zio ma non sapevo a che ora sarebbe potuto venirmi a prendere. Così, con la signora Maria, ci siamo messi in un angolo ad aspettare, lei il figlio, io Gustavo. Lo riconosco da lontano, dopo diverse ore. Ci siamo salutati e abbracciati e poi mi ha fatto subito una ramanzina dicendomi che quello non era un buon momento per arrivare". Per percorrere i 50 chilometri che separano Metz da Hombourg-Haut prendono la corriera che allora era a carburo. "Fuori dal paese, mi dice che eravamo arrivati. Guardo e non vedo la porta d'ingresso della casa - ricorda ancora -. Zio va a prendere una scala a pioli e con questa ci arrampichiamo per raggiungere un portellone. Era uno spazio di circa due metri per due, c'era una specie di letti a castello, fatti con delle tavolacce, dove sopra non c'erano le lenzuola e le coperte ma un sacco a pelo di pelle di pecora. Era agosto e la notte si moriva di caldo lì sotto. Praticamente era un tugurio, che il proprietario usava prima come fienile, ma non ho detto niente perché zio mi stava aiutando". Il bagno non c'era. Bisognava scendere a pian terreno e andare nelle stalle dove c'era anche il lavandino per potersi lavare. "Ogni mattina e ogni sera su e giù dalla scala".
Dopo un paio di giorni, inizia la ricerca di un impiego in un
cantiere "dove si lavorava con picco e pala a parte i parigini, che erano operai specializzati". Gustavo, che fa da traduttore per il nipote, viene preso mentre per Nello niente da fare perché non ha il permesso di lavoro francese. Viene dirottato nell'ufficio che rilascia i permessi che lo rimanda però al mittente perché, per averlo, gli dicono, occorre un documento di assunzione. "Così per una settimana, ho fatto avanti e indietro, mi rimpallavano uno con l'altro e il non sapere il francese non mi aiutava di certo". Finalmente, tramite "un omone grosso, che scopro essere italiano, vengo preso. Salgo insieme agli altri operai su un camion con due tavole per seduta e ci portano in cantiere – racconta -. Dovevamo fare delle buche sotto dei grandi tubi di ghisa già messi sul terreno, che servivano per portare l'acqua. In quel buco poi entrava un lavoratore specializzato per mettere la guarnizione al tubo. Io sono sempre stato gracilino ma ho cercato di fare tutto quello che potevo, ho scavato tutto il giorno. E la sera, dopo queste giornate, crollavo nel letto dopo la cena preparata nello stanzino con un fornelletto a benzina. Ero talmente stanco che non sentivo nemmeno più la puzza della pelle di pecora". Dopo qualche giorno, Nello si accorge che qualcosa non va al lavoro. "Vedevo il caposquadra che scuoteva la testa e diceva qualcosa in francese. Ho pensato che mi avrebbero licenziato. Viene da me un italiano e mi dice che non siamo ai lavori forzati e che devo fare una buca per volta. Quando la guarnizione era montata, potevo fare un'altra buca. L'avrei abbracciato forte perché avevo avuto proprio paura di essere mandato via".

L'emozione del ricordo traspare ancora oggi nei suoi occhi. Nello vuole crescere, aspira ad un lavoro migliore e a guadagnare anche più soldi. A casa, nelle Marche, c’è la mamma

12 Marchigiani nel mondo
In alto, Nello bambino e qui sopra con Adria e una delle nipoti In alto a destra, le sue poesie e sotto un'altra immagine di Nello e Adria
Il primo alloggio era un ex fienile al quale si accedeva con una scala a pioli Senza bagno e sacco di pelle di pecora per dormire
L'Emigrante
Oh Italia!
Che nel mondo rinomata, sei per l'arte la storia e la bellezza; per il tuo clima da tutti sei invidiata. Del tuo bel canto e del tuo idioma bella la ricchezza. Intorno a te d'azzurro sei bagnata; maestosa è la corona dei tuoi monti, tutto in te è bello o terra da me amata!
Belli i tuoi luoghi, i tuoi momenti, le tue fonti. Solo è mancato a te il più che importante!
L'arte di nutrire tutti i figli tuoi. Come tanti altri; tu l'hai costretto ad essere emigrante. Oh Italia mia!
Perché hai tu più prole che nutrir non puoi?
Ora sono vecchio, e il sacrificio mio ben vano è stato, amo la Francia, amo l'Italia, eppure, quasi senza una patria mi ritrovo. Qui son straniero, come straniero son la dove sono nato; E vado e vengo e mi dimeno come una fiera che non ha più un covo.
I francesi mi chiamano il rital, o il maccaroni. Gli italiani dicono di me: il francese è di ritorno quando rimembrare l'infanzia torno nel mio bel suol natio, l'animo in festa sia pur per un breve soggiorno, mi fa capire che da altri è già occupato, e che di fatto ei non è più mio.
D'intender ciò è afflitto il cuore mio più ch'io non possa; eppure, come a sua volta Ei disse dir non vorrei anch'io. Ingrata patria: tu non avrai in consegna le mie ossa!!!
2000
da aiutare e poi c’è il desiderio di formarsi una famiglia. Desiderio che si concretizzerà con la conoscenza di Adria Durastanti che abitava con la numerosa famiglia, in tutto erano 11 fratelli, a Montecarotto. “Ho conosciuto questa bella ragazza ma, per paura di essere respinto, ho scritto alla madre Livia chiedendo di poterla frequentare. Avuto il sì, abbiamo cominciato a scriverci e, appena sono stati pronti i documenti, ci siamo sposati in Comune e siamo venuti subito in Francia”. La famiglia si allarga presto, nascono Manuela, Lauretta, scomparsa prematuramente ad otto mesi ma sempre presente nei racconti di Nello e Adria, e Josiane. Adesso, tutti insieme, con generi, 4 nipoti, la pronipote, sono in 12. Ad Hombourg-Haut c’è una miniera di carbone, Nello decide di tentare questa strada per migliorare la sua posizione. “Eravamo in un pozzo a meno 500-600 metri – ricorda -, si scendeva anche fino a meno 800 metri,
Diciannove anni!
Tante speranze e le mie chiome al vento, quando decisi di lasciar l’Italia mia. Avevo fame!
E proprio non pensavo in quel momento, Che partendo, avrei imparato cosa sia la nostalgia. Ora che è pieno o quasi il mio tegame, più non ho le mie chiome al vento. Duro mi è stato superar l’esame. Tutto però del tutto non fu vano!
D’esser partito sognando non mi pento. Non mi pento!
Ma il mio pensiero vola via lontano dove fingendo di essere contento raggiunsi qua l’anziano. Lasciando là il mio cuore, la mia gioventù, il mio primo amore… e della mamma, l’addolorato pianto.

Ora sono qui in buona compagnia, al riparo dal vento, e con i miei cari al canto. Solo a momenti questa nostalgia, m’assilla ancora.
Con dei ricordi belli o tristi alquanto per essere partito, il fiore in bocca e le mie chiome al vento, allontanandomi da te, Italia mia!
dentro un enorme secchio che risaliva poi con il materiale pietroso che avevamo scavato. Stavamo sempre dentro l’acqua”.
Un lavoro veramente faticoso, pesante in cui rischia anche la vita. “Un giorno c’è stato un gran temporale e un fulmine ha rotto la cabina della corrente elettrica. Le pompe che svuotavano i vari livelli del pozzo non funzionavano più e saliva l’acqua. Tutta la mia squadra è rimasta bloccata, la paura ovviamente c’era anche perché non riuscivamo a comunicare con fuori. Ci hanno mandato giù un biglietto con uno spago dicendoci di non farci prendere dal panico perché avrebbero fatto qualcosa. Dopo qualche minuto, hanno buttato giù una rete larga a cui ci siamo aggrappati per risalire. Ad un certo livello c’era un motore a scoppio per l’emergenza, che andava a benzina, e tramite quello siamo riusciti a risalire con il cestello. All’uscita ci aspettavano tutti gli ingegneri dell’azienda,
Nello Spaghetti non si demoralizza lavora in cantiere poi in miniera rischiando la vita e nella siderurgia fino a 12 ore al giorno
13 Marchigiani nel mondo
Ma
ci hanno pagato anche il pranzo”. Lavorare sottoterra, però, è veramente duro. Tramite degli italiani che conosce in treno, in un viaggio di ritorno dalle Marche, Spaghetti si sposta ad Hayange dove trova lavoro in una “lusina”, un’industria siderurgica. Dopo un breve periodo di formazione, diventa conduttore del carro ponte che serve a sollevare le grandi lamiere di acciaio, destinate alla costruzione delle navi. Spaghetti, però, non è ancora soddisfatto della paga e torna in miniera, questa volta di ferro, per cercare di guadagnare di più. “Dovevamo riempire un carrello con il materiale scavato e venivamo pagati a cottimo – spiega -. Per avere un salario decente bisognava riempire almeno 11 vagoncini al giorno. Io potevo arrivare a 3-4, la paga alla fine era come quella della fabbrica”. Tre mesi dopo riprende la strada della siderurgia. Lo riassumono nello stabilimento, c’è ancora posto ma soprattutto lui ha lasciato il ricordo di un lavoratore veloce, sempre pronto ad imparare. Dopo un po’ di tempo arriva anche un’altra opportunità. “Stavo in fabbrica almeno otto ore ogni giorno, tutta la settimana, senza riposo, perché i forni erano sempre accesi. Quando smontavo dalla ‘lusina’ andavo a lavorare in un centro di assistenza per gli elettrodomestici e facevo altre quattro ore. Insomma, ogni giornata era di 12 ore almeno. La sera la stanchezza era tanta ma era giusto così. C’era la famiglia e la casa da ristrutturare e costruire. Abbiamo lavorato tanto ma andava fatto”.
L’estate, però, il pensiero è solo per l’Italia: l’unica strada da percorrere è quella per le Marche, per Montecarotto e tutti i posti dove sono sparpagliati i parenti e gli amici. Ogni anno sono migliaia i chilometri fatti per tornare e cercare di lenire quel dolore e quella nostalgia per aver dovuto lasciare la terra d’origine, che Nello racconta nelle sue poesie. “L’Italia mi manca sempre ma sono contento di quello che ho potuto fare in Francia, cercando sempre un miglioramento nel lavoro” dice. Dopo qualche anno, lascia la fabbrica e accetta di lavorare a tempo pieno nel centro di assistenza dove la sua specializzazione è molto apprezzata dai clienti. A 60 anni, dopo le migliaia di ore lavorate fuori e dentro casa, arriva la pensione e piano piano il desiderio di scrivere. “Avevo provato a buttare giù dei pensieri a mano ma non mi convinceva, la mia calligrafia era tremolante – dice -. Uno dei miei generi mi ha dato un computer, ho cominciato con due dita, poi è andata sempre meglio. La prima poesia, nel 1998, l’ho dedicata alla vecchia quercia della famiglia di Adria, suo padre Ottorino, che mi ha accolto come uno dei suoi figli”. Un figlio che ha radici sia in Italia sia in Francia e che ha sempre mantenuto la nazionalità italiana. “Scherzando, con la nostra famiglia, diciamo che gli unici stranieri siamo noi due – raccontano insieme Adria e Nello -. Non abbiamo mai sentito il bisogno di chiedere la cittadinanza. Ci hanno sempre trattati da francesi”. ¤


14 Marchigiani nel mondo
In alto, Nello Spaghetti nel giorno del suo compleanno festeggiato in famiglia Qui sopra, la chiesa a Marspich-Rue de l'Église
Il pensiero è sempre rivolto all’Italia mantenendone la cittadinanza Ma Nello sorride: “Siamo stati sempre trattati da francesi”
Bruni, abile scrittore e “medico di una volta”
 ASCOLTAVA, VISITAVA E CURAVA ANCHE CON LE PAROLE
ASCOLTAVA, VISITAVA E CURAVA ANCHE CON LE PAROLE
Leonardo Bruni, il medico scrittore non è più tra di noi. Ci ha lasciato lo scorso 15 luglio, all’età di ottantasei anni, dopo aver trascorso una vita interamente dedicata a far star bene gli altri e sopratutto i bambini. Ha svolto la sua professione di pediatra con competenza, preparazione, disponibilità e passione ma soprattutto con grande umanità dove l’altro veniva messo sempre prima di se stesso. Per lui era normale, quando era necessario, trascorrere una notte in ospedale per stare accanto ai piccoli ma-
potrà essere colmato. Il suo ricordo resterà sempre vivo nelle centinaia di bimbi che ha curato, ora uomini e donne, che pensando a lui rivivranno il sorriso di un medico che non indossava il camice per non spaventarli. Durante l’attività professionale scrisse numerosi saggi scientifici su riviste specializzate in pediatria con particolare riguardo ai problemi legati alla neuropsichiatria infantile, alle vie respiratorie e all’asma. Era un uomo poliedrico con interessi rivolti a diversi campi.
Socio delle Cento Città per decenni ha in più occasioni scritto nella nostra bellissima rivista di argomenti che spaziavano dalle tradizioni della cucina marchigiana alla storia. Chi volesse rileggerlo consigliamo i numeri dal 40 al 43 dove affronta temi culinari come i vincisgrassi o il brodetto e storici come il Risorgimento. E si perché quel periodo, molto importante nella storia della nostra Italia, era per lui l’elemento cruciale all’unificazione della penisola e alla futura Repubblica.

lati e alle loro famiglie.
Potremmo dire che era il “medico di una volta”, quello che ascoltava, visitava e poi curava con la medicina e con le parole. Un modello che oggi purtroppo non conosciamo più e il vuoto che Leonardo Bruni ha lasciato a Senigallia difficilmente
Nel corso della sua esistenza è stato un sincero mazziniano applicando sempre il pensiero del Grande Italiano in ogni cosa che faceva. Ha ricoperto posizioni di coordinamento nell’associazione dedicata a Mazzini, l’Ami, senza compromessi, non accettando nulla che non potesse essere compreso.
Il pensiero mazziniano era il solco in cui ha concretizzato la propria vita e il rapporto con gli altri, istituzioni e singole persone. Tra i suoi libri di storia ricordiamo
15 Il ricordo
di Claudio Desideri
Leonardo Bruni con la moglie Elvira in una riunione dell'associazione delle Centocittà
“Cronistoria del Movimento operaio e proletario in Italia (1840 - 1990). La storia era, infatti, una delle sue passioni e fu il fondatore dell’Archeo Club di Senigallia portando l’archeologia alla portata di chiunque volesse conoscere questa disciplina organizzando convegni e visite agli scavi del territorio e del Paese facendo così appassionare tantissime persone alla scoperta delle antichità. Un’altra materia a
te della tradizione culinaria dei nostri territori costruendo un ricettario prezioso con piatti che in alcuni casi sono scomparsi dalle nostre tavole mentre altri sono ancora presenti nei nostri menù. Ha anche scritto su riviste come “Cucina della Tavola” e “Accademia della Cucina Italiana”. Il mondo della cucina, per Bruni, era una passione e nel suo studio aveva una intera libreria dedicata a questo settore.
Era membro dell’Accademia della Cucina marchigiana e il suo schedario è ancora pieno di scritti pronti per la pubblicazione come “Tutti i pesci del Mediterraneo”, un’opera cui dedicò molto del suo tempo e che oggi sarebbe un testo di grande interesse per chi studia la materia e l’evoluzione delle specie marine attualmente in atto dovuta ai cambiamenti climatici.
lui cara era la filosofia e fece parte del gruppo costituitasi nella sua città, partecipando ad incontri a tema sui filosofi e sul loro pensiero. Per lui filosofia era veramente amore per il sapere, una ricerca mai conclusa del comprendere, del conoscere. Un altro libro scritto da Bruni reca il titolo “Ricette raccontate”.

Questo libro è particolarmente interessante perché Bruni lo realizzò dopo aver intervistato persone anziane delle nostre Marche cui chiese di raccontare le ricet-
Il mare era un altro dei suoi interessi, dalla vela al nuoto che praticava sino a novembre inoltrato. Anche la montagna lo attirava molto e fu lui a fondare la sezione del CAI a Senigallia contribuendo a far avvicinare tantissime persone alle escursioni. Persona di raffinata intelligenza in alcuni casi poteva apparire un provocatore o un burlone ma dietro a questi atteggiamenti vi era sempre la volontà sincera di tirar fuori dal profondo delle persone i sentimenti più spontanei e veri perché per lui era importante il confronto, il dibattito, non prevaricare ma raggiungere l’obiettività che solo la verità è capace di esprimere. ¤
16 Il ricordo
Uomo poliedrico con interessi rivolti in diversi campi del sapere, autore di saggi scientifici ma anche di storia e cucina
Un'immagine recente del medico Leonardo Bruni
Dalla Chiesa, giovane ufficiale a S. Benedetto
SIGNIFICATIVI I PRIMI ATTI DA COMANDANTE DELLA STAZIONE

Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato un uomo che ha saputo lasciare un segno intangibile nella storia dell’Italia repubblicana. Di quell’Italia che ha subìto un attacco devastante alle sue radici di democrazia con l’offensiva del brigatismo che stava per mettere in ginocchio lo Stato. Dobbiamo riconoscenza a personaggi come Carlo Alberto Dalla Chiesa se lo Stato in una extrema ratio ha saputo difendersi e non alzare bandiera bianca. Quella lotta vittoriosa al brigatismo Carlo Alberto non l’ha potuta suggellare e duplicare con la mafia. Non ha avuto tempo. Il flagello siciliano, ben sapendo della sua potenza, ha subito reciso ogni possibile belligeranza oscurando per sempre la sua fede insieme alla sua giovane consorte.

A Palermo Dalla Chiesa ha subìto da quello Stato che aveva sempre difeso un benservito degno della peggior Repubblica. Lasciato solo in pasto alla delinquenza mafiosa e senza scampo si è immolato per quell'ideale di Patria
e di Servizio che ora gli fa onore e per questo motivo lo ricordiamo come umile servitore dello Stato che non deve e non può arrendersi contro questa delinquenza che ha fermato lo sviluppo di una terra meravigliosa come quella di Sicilia. Ho scritto che Dalla Chiesa era stato lasciato solo: ebbene lui stesso lo aveva capito e lo aveva certificato in una memorabile ed ancor oggi illuminante intervista a Giorgio Bocca su Repubblica pochi giorni prima di morire sotto il piombo mafioso. Chiuso da solo nella Prefettura si sentiva isolato, senza poteri con una mafia sempre più arrogante che lo avrebbe da lì a poco eliminato. La sua esperienza lo portava a presagire quella fine, anzi l’aveva in un certo senso anticipata uscendo insieme alla sua seconda moglie Emanuela Setti Carraro a bordo di un’anonima A112 di colore bianco che ebbe subito un impatto con la violenza più estrema. Due vite oltre a quella del poliziotto di scorta Domenico Russo che li seguiva su una berlina blu, immolate in nome di una lotta alla mafia che lo Stato non deve perpetuare all’infinito ma che deve effettuare in maniera non poliziesca bensì una metanoia, ossia un cambiamento radicale sulla ricerca delle cause di una società che riceve dalla mafia un supporto alla propria identità. Occorre operare affinché alla mafia vengano recisi i suoi tentacoli che operano indisturbati in un mondo dove la Giustizia e l’Equità sono un bene per pochi ; solo superando queste antiche ed ancestrali iniquità si potranno superare queste disuguaglianze che dall’unità
17 Quarant’anni dopo
di Mario Arezzini
d’Italia si stanno combattendo purtroppo solo a parole. Lo sbarco a Marsala del Maggio 1860 di Garibaldi e dei suoi Mille, la vittoria di Calatafimi, l’entrata trionfale a Palermo di Garibaldi e subito la mafia cambia opinione e parere sorreggendo, come il pescarese Ennio Flaiano insegna, i vincitori. Pertanto questa mafia multiforme va sconfitta dal punto di vista culturale e proprio Carlo Alberto l’ha capito e quindi si è immolato per suggellare la sua impotenza militare al cospetto della sua lungimiranza politica che ha portato i suoi figli Nando, Simona ed ora Rita a proseguire sui banchi parlamentari quel progetto di Eticità che è alla base di ogni azione sociale e politica.
Il sacrificio di Dalla Chiesa non è stato vano e lo Stato ha saputo riconquistare una parvenza di legalità utilizzando quel sacrificio annunciato. Pertanto oggi ricordiamo quest’uomo che non era scevro da ancoraggi umani ma all’opposto era una persona che aveva saputo lasciare un
carico enorme di umanità. Lo ricordiamo appunto giovane ufficiale comandare la stazione di San Benedetto del Tronto con i sottoposti che presagivano per il giovane comandante un futuro ai massimi livelli; già si presagiva per Dalla Chiesa una carriera densa di soddisfazioni. Solo il ritorno a Palermo da civile, da Prefetto, e non da Carabiniere e la rivincita sanguinaria di quella mafia che seppe nel giro di un decennio spegnere le speranze di Giustizia non solo del Prefetto Dalla Chiesa ma anche dei Giudici Falcone e Borsellino. Dalla Chiesa insieme a Falcone e Borsellino si è immolato per rendere più grande il nostro rimorso per non aver fatto nulla per far uscire la Sicilia dal Medioevo sociale e culturale.
Ricordiamo il Generale affinché possiamo con la sua testimonianza credere in un’Italia migliore, più fattiva, più sincera,meno ipocrita, affinché il suo sacrificio sia di monito per le giovani generazioni.Viva l’Italia, Viva la Democrazia. ¤

Quarant’anni dopo 18
Lasciato solo nella lotta contro la mafia il suo sacrificio ora sia di monito per le giovani generazioni
Nella pagina precedente, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e qui sopra, un'immagine drammatica dell'attentato del 1982
Gorbaciov, a Urbino la sua idea della Terra
Nei giorni a cavallo tra la fine di giugno e l’inizio del luglio 2001 le Marche accolsero Mikhail Gorbaciov, l’uomo della glasnost e della perestrojka, l’ultimo segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, il propulsore di quella stagione di eventi che portarono alla dissoluzione dell’Urss e alla caduta del Muro di Berlino con la riunificazione delle due Germanie. Protagonista di un’epoca complessa, al tempo stesso di grandi speranze e cocenti disillusioni, Gorbaciov, scomparso lo scorso agosto, indiscutibilmente è stato tra quelle personalità visionarie che hanno attraversato la Storia marcandone il territorio. Più di 21 anni fa, il premio Nobel 1990 per la pace portò la sua idea del mondo tra Urbino, Ancona, Loreto e Ascoli. Incontrò gli imprenditori parlando di energia, alla Politecnica ricevette una laurea honoris causa in economia politica dall’allora preside di facoltà Enzo Pesciarelli, ma fu a Urbino che, il 2 luglio, all’Università Carlo Bo, con Rita Levi Montalcini presentò la Carta della Terra, consegnandone ai posteri la firma. Greta Thunberg non era ancora nata, e con lei i ragazzi dei Fridays for Future. Anche definizioni come “climate change” o transizione ecologica, oggi così familiari, erano ancora da venire. Giusto si cominciava a masticare il termine di globalizzazione. Eppure la Carta della Terra con i suoi 4 pilastri e i 16 enunciati, già delineava i valori comuni dell’oggi e del domani: 1) rispetta la Terra e la vita nella sua diversità, 2)

prenditi cura della comunità vivente con comprensione, compassione e amore, 3) costruisci società democratiche che siano giuste, partecipative, sostenibili e pacifiche, 4) tutela i doni e la bellezza della Terra per le generazioni presenti e per quelle che verranno. Gorbaciov venne a Urbino come presidente della Green Cross International, l’organizzazione che aveva fondato 8 anni prima, nel 1993. La salvaguardia del pianeta era appunto lontana dall’essere al centro del dibattito mondiale, ma è stata questa intuizione ad affinare la sensibilità dell’uomo e del politico Gorbaciov che scelse Urbino, già culla dell’Umanesimo del duca Federico, per lanciare il messaggio del nuovo Umanesimo del XXI secolo: coniugare economia, sostenibilità e ambiente. “Se non saremo in grado di affrontare la sfida ecologica adeguatamente - aveva ammonito - molto della nostra vita perderà di significato”. La Carta doveva incardinare le priorità per uno sviluppo sostenibile e durevole destinato alle future generazioni. Le basi erano state poste formalmente con la stesura avviata nel ‘94 in Olanda, e quel giorno d’estate l’Università di Urbino, con le Marche, ne aveva raccolto idealmente il testimone. Due decenni dopo l’Earth Charter resiste nonostante la “concorrenza” di movimenti più mediaticamente presenti e diffusi: le attività di sensibilizzazione vanno avanti ma concentrate principalmente in America. La prossima iniziativa è in calendario in Costa Rica i primi di dicembre. ¤

19 L’uomo della glasnost
Un ritratto di Mikhail Gorbaciov
NEL 2001 PRESENTÒ LA “CARTA” CON LEVI MONTALCINI
di Simonetta Marfoglia

Salvi e Samorì, visioni controcorrente dell’arte

UNO RIVOLTO AL CLASSICO, L'ALTRO A

Passato e presente collegati insieme idealmente in un dialogo serrato, inedito e aperto a molteplici letture tra due artisti lontani nel tempo: Giovan Battista Salvi (Sassoferrato 1609-1685) e il contemporaneo Nicola Samorì (Forlì 1977).
L’idea prende forma nella 71^ edizione della Rassegna Internazionale d’Arte, Premio G.B. Salvi, tra i più longevi premi artistici italiani, dopo la Biennale di Venezia e il Premio Michetti di Francavilla al Mare. Rassegna che mi vede curatrice insieme a Massimo Pulini, ospitata nella prestigiosa sede di Palazzo degli Scalzi a Sassoferrato, fino al 15 gennaio 2023. Diverse le analogie
FERIRE L'IMMAGINE
tra i due artisti accomunati indissolubilmente da vari aspetti, a partire in primis dall’attitudine quasi ossessiva alla riscrittura di temi e modelli che si traduce in una rielaborazione continua e vorticosa delle immagini che si offrono a noi quasi con impavida sfrontatezza.
E come Giovan Battista Salvi, detto “Il Sassoferrato”, aderiva volutamente a una visione rigorosamente classica con una ricerca pittorica controcorrente, orientata al recupero di valori rinascimentali in un clima culturale caratterizzato da una visione dinamica, che prediligeva composizioni movimentate e ariose tortuosità barocche, così Nicola Samorì replica con estrema
21 La mostra a Sassoferrato
di Ferderica Facchini
A sinistra, l'immagine del manifesto della mostra "Salvifica" a Sassoferrato Sopra, Madonna in adorazione del Bambino di Giovanbattista Salvi detto il Sassoferrato
Ad accomunare i due artisti interviene una sorta di dipendenza dalle forme perpetrata incessantemente dal reciproco pennello con una forte volontà di indagine nei meandri della pittura.
Giovan Battista Salvi, in aperta controtendenza, aderiva volutamente a una visione rigorosamente classica impostata su costruzioni studiatissime, dove il disegno ne costituisce l’indagine primaria e dove a dominare è la compostezza, la sacralità e il silenzio, mantenendo saldo il suo sguardo al Rinascimento, alla lezione di Perugino ma soprattutto a quella ancor più aulica e ideale di Raffaello, collocandosi in quella traiettoria purista del XVII secolo che aveva il suo apice nella pittura bolognese dei Carracci, di Guido Reni e del suo maestro Domenichino.

L’ideale classico cui tendeva il Salvi si riflette formalmente nella compostezza delle figure e con-

22 La mostra a Sassoferrato
“Il Sassoferrato” ricercava valori rinascimentali in un clima in cui prevalevano le tortuosità del barocco
cettualmente nel silenzio spirituale ed etico che sostanzierà tutto il suo lavoro. La ieraticità, la solennità, la bellezza delle sue figure erano al servizio di un raccoglimento interiore e spirituale. Le sue Madonne moltiplicate quasi all’eccesso diventano un emblema tangibile, un viatico al sacro, tanto la loro resa era così fisica e solida, semplice nei gesti e nei sentimenti, rispetto alla più eterea bellezza raffaellesca.


«I suoi personaggi – scrive Massimo Pulini - non vengono colti mentre sospendono un gesto, non sono nel corso di un’azione e in nessun caso lasciano intendere l’esistenza di un prima o di un dopo. Sono pure idee fisiche e dimostrano di essere immagini sin dalla loro origine, forme del pensiero tornite nello spazio; dimensioni effimere della spiritualità e nondimeno incarnate nella materia concreta della pittura. Addolorate che non mostrano alcun segno di sofferenza ci

rivolgono il loro sguardo superandoci e lasciando, nella scia di quella traiettoria perforante, le domande più inaccessibili. Salvi sembra aver cercato per tutta la vita le forme amorevoli della bellezza, quelle che ogni individuo conserva dentro di sé».
La sua arte pittorica, spesso tacciata superficialmente come modesto esercizio di ricopiatura da più noti modelli iconografici, va invece pertanto osservata attraverso quell’atteggiamento di rigorosa attenzione e severità nella ricerca che ha trovato esito in una pittura che guardava i modelli e i riferimenti aulici del Rinascimento con grande consapevolezza e perizia tecnica per diffondere e reiterare un atteggiamento filologico e iconofilo - più etico che estetico - legato ad un sentimento profondamente devozionale e sacro.
Un complesso lavoro di idealizzazione quello del Salvi, rivalutato solo negli ultimi 40 anni, grazie alla
23 La mostra a Sassoferrato
A sinistra e al centro della pagina Artaud (foto Danilo Donzelli) Qui sopra, La logica e La bocca VI di Nicola Samorì
preziosa ricerca di Federico Zeri prima e di François Macé de Lépinay e Massimo Pulini successivamente, e ritenuto totalmente anacronistico se messo a confronto con le coeve composizioni dinamiche e le forme grandiose e monumentali dello stile barocco caratterizzato dall'accentuazione degli effetti drammatici attraverso i forti contrasti di luce e ombra. «Si può perfino constatare nelle opere del Salvi –continua Pulini - che anche gli estremi cromatici furono sottoposti a potatura. Non vi si registra mai l’uso del nero e nemmeno i bianchi giungono all’assoluto, preferendo sempre, anche nel velo di una Madonna, un tono in meno rispetto alla luce scintillante che invece cercava l’altro grande purista, Carlo Dolci», il pittore toscano che peraltro viene considerato un alter ego del Salvi.
«L’artista - spiega lo stesso Pulini - aveva costruito la sua torre d’avorio in piazza di Spagna, al centro del mondo cristiano e dipingeva come fosse un eremita, capace di isolarsi in una specie di trance che lo rese a suo modo invulnerabile. Nell’era montante del barocco, che bruciava ogni novità estetica nel giro di una manciata d’anni; nella città scenica, che rendeva effimera ogni forma e fagocitava come un fiume in piena qualsiasi ricerca artistica, possiamo immaginare il Sassoferrato come uno stilita, fermo ed eretto, in cima a una colonna, mentre tutto scorre attorno a lui».
Se per il Sassoferrato “i sentimenti estremi sono qualcosa da introiettare non da esibire” non di certo questo vale per Nicola Samorì chiuso nel suo studio-fucina a Bagnacavallo, un luogo sospeso nel tempo e realizzato, ironia della sorte, in una chiesa sconsacrata del
Seicento. Samorì, tra l’altro, diplomatosi all’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 2004 con una tesi su Mattia Moreni, è partito proprio dal disegno e dall’incisione, volendo trovare un’altra analogia con il Salvi.
Quello di Samorì è un confronto che non si estingue nella mera interpretazione dei modelli artistici di un passato prossimo o remoto, ma che desidera addentrarsi in maniera epica, oserei dire, nei codici del linguaggio pittorico e scultoreo, i media più nobili della tradizione dell’arte occidentale. Per indagarli nel profondo e poi eviscerarli letteralmente dissolvendo, lacerando, rimuovendo la materia di cui sono costituiti, a dimostrazione che le immagini non sono portatrici di verità e di come anche dietro alla bellezza si celi l’ineluttabile caducità del mondo e delle sue cose. Quest’esigenza continua dell’autore a deformare l’immagine lo avvicina a mio avviso, anche ad un altro genio del Novecento come Francis Bacon, che vedeva nella deformazione dei corpi e dei volti, l’unico mezzo per rendere visibili le forze oscure, di dissipazione, come quella del tempo o della morte. Ma se Bacon vedeva nella cavità delle bocche urlanti l’abisso della disperazione, il tormento del mostro che ognuno si porta dentro, in Samorì il vuoto, il buco può anche schiudere lo spazio ad un altrove, ad una nuova possibilità di riscatto. Non a caso un’opera del 2019 titola “la luce è un buco”.
Nonostante sin dall’inizio abbia sottoposto lo sguardo dell’osservatore a corpi e volti sfilacciati, erosi, consunti, logorati, spellati, coagulati, Samorì si ritiene un iconofilo, perché crede nel potere delle immagini, se ne prende estrema cura - partendo da un’esecuzione rigo-


24 La mostra a Sassoferrato
Qui sopra dall'alto, Busto di Madonna con mano al petto e Busto di Madonna di Giovanni Battista Salvi In alto a destra, La bocca VII e La bocca VIII di Nicola Samorì Sotto, Madonna col Bambino dormiente del Sassoferrato
Salvi anelava forme amorevoli della bellezza e le sue Madonne moltiplicate all’eccesso diventavano un viatico al sacro
rosa, lenta e studiatissima, padroneggiando le tecniche antiche della rappresentazione - e solo una volta conclusa, l’opera è pronta per essere immolata, sacrificata, dalla mano del suo stesso creatore, sull’altare di una spietata indagine: pittorica, anatomica, concettuale e poetica. «Non posso accettare la semplicità e la rapidità ho bisogno di torturarmi» ha affermato, e torturarsi equivale a torturare la sua creatura. Samorì è l’impietoso demiurgo che innesca il tarlo della degenerazione in ciò che ha creato, per renderlo più fragile e più instabile e disinnescarne la sacralità.

Samorì scava nella materia come fosse carne ma nell’effrazione della superficie
«c’è modo e modo di intaccare una forma» e a lui non interessa cadere nel ripugnante, nell’orrorifico. La sua è un’operazione serrata di verifica, innescando un cortocircuito tra il visibile
e l’immaginazione per sondare i limiti umani con una tensione alla verità.
Se in alcune opere la figura è realizzata sopra un composto di oli ancora parzialmente fresco, quando il pigmento diviene asciutto sulla parte più superficiale del supporto lui agisce con gesto deciso, generando un’apertura materica viva e pulsante sulla superficie liscia e bidimensionale della tela, asportando la parte epidermica del volto o del corpo e lasciando irrompere alla vista i vari registri cromatici interni come fossero viscere, resti di un’identità che non è più possibile comprendere. Le superfici diventano aggettanti, tridimensionali, tattili, e i corpi diafani o i volti di madonne si offrono alla non-visione, lacerati o a brandelli.
A volte la pellicola pittorica è accartocciata su se stessa come un sipario che oscura la visione, nega il nostro sguardo sul soggetto rap-
Samorì dal canto suo replica con perizia i capolavori dell’antico e del Seicento napoletano sui quali poi infierisce con impeto

25 La mostra a Sassoferrato
Corpi
erosi, consunti Samorì innesca un cortocircuito tra il visibile e l’immaginazione in un’alta tensione
presentato, e veicola altre realtà. Una teatralizzazione della pittura che rivela scenari inaspettati, perturbanti appunto, perché da placidi incarnati si schiudono visioni surreali. Ecco che il gesto, del palmo della mano sulla pittura, diviene azione teatrale. Un’azione che non lascia all’artista troppo tempo di meditare ma che non è casuale, perché lui va ad infierire su punti nevralgici, psicologici della visione, su quei fulcri di attenzione sensibili all’osservatore.
La sua ricerca vive di una tensione fortissima di tanti elementi che concorrono alla definizione del risultato finale: visivi, emotivi, culturali, antropologici. Ad alterare ancora di più i nostri canoni dello sguardo, nella più recente ricerca del pittore romagnolo, avviene un’ulteriore estremizzazione, una radicalizzazione del supporto, che lo spinge a relazionarsi in maniera sempre più stretta con la materia.

Molto accuratamente l’artista sceglie delle lastre in
onice, marmo rosa del Portogallo, breccia di Vendome, pietra di Trani in cui è la Natura ad avere tracciato dei segni, delle lacune, dei vuoti. Il geode, la cavità, la carie della pietra diventano il pretesto attorno a cui far originare i soggetti e le loro mutilazioni.
Il corpo a corpo ora non è più solo con la pittura e la sua storia ma si spinge anche all’interno della materia stessa e delle sue cavità naturali.

L’artista porta così alle estreme conseguenze la vocazione della pittura ad essere scultura e a lavorare intorno al vuoto, creando un’interferenza tra la pietra che simula la pittura e la simulazione pittorica dell’artista stesso.
La forma pittorica di un volto o di un torso germina così da un’imperfezione della materia, e Samorì ancora quasi con attitudine sciamanica ci mostra come dal vuoto, dal buco nero, possa sgorgare qualcosa di immaginifico e di estatico. ¤

La mostra a Sassoferrato
e volti sfilacciati
Dall'alto, Tre putti e un tritone e Salvator Mundi di Giovanni Battista Salvi
26
In alto a destra, Madonna del Sasso di Nicola Samorì
I collezionisti, giganti del mecenatismo
MOLTI CAPOLAVORI COMMISSIONATI DA AMANTI DELL’ ARTE
Molti dei musei che oggi visitiamo non avrebbero potuto esserci se non fossero esistiti i collezionisti. Una verità purtroppo dimenticata. La nostra società, basata in gran parte sul presente, è indotta a pensare che i capolavori della pittura siano nati sulle pareti di Brera o del Palazzo ducale di Urbino. Invece no, sono sempre nati altrove prima di essere spostati, o in parecchi casi deportati, nei musei. Sono nati dalla passione di collezionisti, ricchi, colti e generosi, che hanno commissionato opere d’arte poi confluite nel nostro patrimonio culturale. Raccontare la vita e le opere di quanti hanno creato questo patrimonio ci aiuta a comprendere non solo l’amore per l’arte ma anche la loro personalità.
Un esempio tra i più famosi è quello di Andrea Odoni. Era un mercante come tanti con un occhio particolare verso l’arte attraverso cui cercava quell’immortalità che il suo lavoro non gli avrebbe mai concesso. Di origine lombarda, residente a Venezia, assoldò nel 1527 un pittore bravissimo che non gli costò troppo siccome in quel periodo era oscurato dal grande Tiziano. Era Lorenzo Lotto. L’opera, vista anche dal Vasari, nel 1660 entrò nelle collezioni reali inglesi, acquistata sulla piazza di Amsterdam. Il quadro costituisce un’opera simbolo dell’umanista, raffigurato nel suo studiolo accanto a elementi della propria collezione artistica, tra le prime rappresentazioni nella storia del Rinascimento. Oggi il ritratto di Odoni è al castello di
Windsor, visto chissà quante volte dalla regina Elisabetta e chissà quanti visitatori lo vedranno ancora. Perché il ritratto pittorico è lo strumento più efficace per eternare sembianze e personalità superando i crudeli limiti della vita fisica. Al contrario delle immagini tecnologiche inevitabilmente destinate all’obsolescenza, i dipinti durano nei secoli. Federico da Montefeltro sarebbe oggi solo un nome nei libri di storia se fosse stato soltanto uno dei vari duchi di Urbino. Come grande mecenate ha commissionato a Piero della Francesca il ritratto di profilo che lo ha reso un’icona del Rinascimento italiano. Il dipinto della Gioconda, uno dei quadri più enigmatici della storia dell’arte, iniziato da Leonardo a partire dal 1503, fu commissionato, secondo il Vasari, da Francesco del Giocondo mercante di stoffe, anche se esistono altre versioni sulle quali non è il caso di addentrarci. Francesco faceva parte di una delle famiglie più in vista del tempo e Lisa Gherardini sarebbe stata la sua seconda moglie. C’è un ritratto nella pinacoteca della mia città che esprime in modo esemplare la personalità del committente. E’ il ritratto di Vincenzo Nolfi, eseguito nel 1628 da Giovanni Francesco Guerrieri. Personaggio di spicco del ceto nobile fanese, poeta, letterato e principe dell’Accademia degli Scomposti, era figlio adottivo di Guido Nolfi, importante giurista e raffinato mecenate alla corte dei papi. Il dipinto proviene dal Collegio-Università Nolfi da lui fondato dove si trovava

27 Non solo ritratti
Da Odoni che assoldò Lorenzo Lotto a Federico da Montefeltro con Piero della Francesca fino alla Gioconda
di Marco Belogi
accanto a tante altre opere, purtroppo disperse, provenienti dalla casa romana paterna. Nella lettera affissa con un chiodo alla libreria si legge il sonetto che il letterato fanese dedica al pittore in occasione del ritratto. L’autografia del pittore e la data sono pomposamente certificate nella composizione poetica che costituisce quasi un agone tra pittura e poesia.
Una gara tra il fraseggio e il pennello e la possibili-
tà di dare voce alla pittura, eseguita probabilmente con l’intento di ricordarlo come fondatore del collegio Nolfi. Il committente vuole che dietro di lui compaiano i testi fondamentali della sua formazione, Platone e Cicerone, mentre lui, in piedi dietro la scrivania e vestito di tutto punto, intinge la penna d’oca per comporre. Una regia che Vincenzo ha meditato e orchestrato per la sua autocelebrazione. Al pittore non rimane che esprimere l’ironia della situazione attraverso lo sguardo, la posizione delle mani e il sorriso del com-
mittente. Un vero capolavoro interpretativo che coglie la vita in ogni suo dettaglio. Un committente dunque di tutto rispetto se nell’ottobre del 1641 versò al Guercino la somma di 232 scudi per il quadro del Santo Angelo Custode che rimase come pala d’altare nella cappella di famiglia nella chiesa di Sant’Agostino sino al 1943.Il dipinto fu reso famoso anche nel mondo della letteratura anglosassone dalla poesia di Robert Browning, dal titolo The Guardian Angel, scritta nel 1848 dopo una visita a Fano. Un disegno autografo a penna per le due figure del quadro si trova nella Collezione Reale inglese a Windsor Castle proveniente sempre dal collegio Nolfi dove era conservata una raccolta di disegni di valenti pittori iniziata a Roma dal padre Guido. Questo periodo fu uno dei più prolifici per la storia dell’arte fanese se si volge lo sguardo anche ai dipinti nella nuova chiesa dei padri filippini giunti da poco in città. Fu Girolamo Gabrielli, discepolo diretto di San Filippo Neri, appartenente ad una nobile famiglia fanese a cui si deve anche la costruzione dell’eremo di Monte Giove, a commissionare a Guido Reni nel 1620 il dipinto dell’Annunciazione pagandolo di tasca propria. Per la sua spiccata sensibilità verso il nuovo si rivolgerà proprio ad uno degli artisti più emergenti tra Bologna, Roma, Napoli, a quel Guido Reni che scriverà di aver ricevuto la commissione di due tavole per la chiesa filippina fanese, pietre miliari della storia dell’arte nelle Marche. ¤

28 Non solo ritratti
Un ritratto di Nolfi nella pinacoteca di Fano eseguito da Guerrieri esprime la personalità del committente
Sopra, un ritratto di Vincenzo Nolfi eseguito nel 1628 da Giovanni Francesco Guerrieri
Piattella nell’azzurro un poeta del colore
MOSTRA A SENIGALLIA, QUANDO L'ARTE INCONTRA LA MODA
Una mostra inevitabile, frutto di un incontro tra un artista sperimentatore, quale è Oscar Piattella (recentemente insignito del Premio Marche, 2022), ed un designer come Luca Bucari che, spaziando con il suo talentuoso staff dal fashion al design, concentra l’attenzione del suo giovane, raffinato brand sul denim.
A tal proposito Luca Bucari può scrivere che “la prossimità tra arte e moda suggerisce sapienti incursioni capaci di costruire dialoghi fecondi. Certamente non è una novità come ha in passato insegnato, già negli anni Trenta del secolo scorso, la couturier Elsa Schiapparelli con il lungimirante dialogo con Salvador Dalì che ha generato capi e accessori di stravagante bellezza. Come, poi, dimenticare il formidabile successo tributato a Yves Saint Laurent quando, nel 1965, presentò l’indimenticabile collezione Mondrian, magistralmente ispirata alla purezza delle opere del maestro olandese Piet Mondrian. […] Ma l’incontro di due mondi creativi, quali sono quello della moda e dell’arte, produce stupefacenti contaminazioni non solo nell’orizzonte del fashion designer ma anche, crediamo, nei fruitori delle nostre boutique”.

Da qui la mostra Oscar Piattella: quando nasce l’azzurro (Senigallia, Spazio in Tomboy, Via Pisacane n. 55, fino al 04.03.23) che costituisce la prima tappa di Incursioni, a cura di Alberto Mazzacchera.
Proprio per tale motivo il cannocchiale di questa prima esposizione, connubio sem-
pre proficuo tra arte e moda, viene a focalizzarsi su quella porzione di produzione artistica di Piattella che ha nelle pezze di jeans la sua essenziale materia, e nelle declinazioni dell’azzurro la sua tavolozza.
Pur nel mutare dei materiali inconsueti, queste opere appartengono a quella lunga, felice stagione dei muri, di cui, una prima serie, fu esposta nel 1958 alla Galleria
L’Ariete di Milano a cura di Franco Russoli e successivamente, nel 1960, a Roma alla Galleria La Medusa
Quelli che prendono corpo sulla fine dei Cinquanta, sono anni densi di confronti. La visione si dilata in un piano internazionale che rapidamente conduce ad un’espressione compiuta ed originale. Nel ricorso ad una materia di granulosa percezione, incisa come argilla, si disvela la profonda attrazione dell’artista per la luce e per i segreti di catturarne l’energia da fissare, infine, in una fonte inestinguibile di onde emozionali. Un uso della materia che gli consente di placare istanze di tridimensionalità e spazialità sulle superfici pittoriche che va ‘fabbricando’ con abili alchimie.
Nelle sue opere si ritrova un’eco della pittura informale scientemente perimetrata al ricorso ai materiali non tradizionali, poiché in Piattella è sempre vigile una scansione delle superfici generata da un magnetismo architetturale, da quello che lui indica come “fraseggio geometrico”.
La questione del muro, tema di straziante centralità nel Novecento, è espressa attraverso registri differen-
29 Contaminazioni
L’artista insieme al designer
Luca Bucari due mondi creativi capaci di dialoghi fecondi e stupefacenti
di Alberto Mazzacchera
ti, espressioni tangibili delle molteplici fasi di ricerca che si sono dispiegate e che Piattella sviluppa lungo due fondamentali, diverse direttrici. Da una parte, prende le mosse da tasselli del reale costruito dall’uomo, ne evoca la presenza in sua assenza, per condurre l’osservatore dinanzi ai muri politici e quella che appare una sorta di ossessione, non sfugge, infatti, alle proiezioni dell’ombra lunga e inquietante dei muri degli uomini contro le libertà che hanno a lungo flagellato i popoli europei del Novecento. Dall’altra, il muro di Piattella è anche porta di accesso agli strati profondi della mente, diaframma da varcare verso uno sterminato universo interiore.
Sa ben leggere Massimo Cacciari quando scrive che nelle opere di Piattella “ciò che appare non è che il frantumarsi della Luce interiore; i colori non sono che il timbro che la Luce assume illuminando il ‘paesaggio dell’anima’ ”.
Le tele con le azzurre pezze di jeans seguono quella produzione nella quale parrebbe di trovare una traccia dell’opera di Alberto Burri. Ma è solo un’impressione di superficie, in quanto Burri mani-

polava con estrema efficacia la materia col fuoco al limite della sua dissoluzione, mentre in Piattella il ricorso al calore avviene per una elaborata e calibrata ricerca di infinite gradazioni di colore. È così che, per tale via, prendono corpo le opere della seconda metà degli anni Ottanta in parte dominate dagli azzurri, che, quando non si strutturano in mirabili scansioni di muraglie, vanno a cogliere la leggerezza impalpabile di una superficie fluida.
Queste opere di Piattella, magistralmente costruite, inducono Yves Bonnefoy, il grande poeta e critico d’arte francese, a scrivere, nel 2002, che “allora è l’azzurro come quando lo si vede farsi intenso, incavarsi nel cielo d’estate, un assoluto che trascina lo spirito nel non – visibile, nel non – pensabile: questo silenzio vertiginoso della caduta nel cielo, del cadere all’infinito nell’azzurro del cielo di cui i bambini sono capaci, di cui gli adulti si ricordano”.
Due anni prima, Oscar Piattella, ragionando in un suo libro dedicato alla ricerca dell’azzurro (ABC: Azzurro blu celeste), osservava: “se distillassimo tutti i mari del mondo non rimarrebbe un accenno del loro azzurro”, inutili sarebbero “le nostre reti di seta” gettate sui fondali, finché ci si renderebbe conto “che un po’ di quella ‘materia’ è lì, fusa con il colore del nostro sangue, come in un sogno, come il sogno di quella stessa ‘materia’ “. Una materia che in Piattella, sapientemente sublimata dalla luce, è in grado di suggestionare l’inconscio, e di spalancare orizzonti mentali nuovi. ¤

30 Contaminazioni
Le tele con le azzurre pezze di jeans fanno riemergere il tema dei muri espressa in registri differenti e diverse direttrici
In alto, Oscar Piattella con il designer Luca Bucari durante l'allestimento della mostra Qui sopra l'artista mentre spiega le sue opere
di Grazia Calegari

La riscoperta di Bazzali il pittore “nomade”
PRIMA ANCONA, PESARO, FIESOLE POI ROMA E TRIESTE
Spero di fare cosa gradita riproponendo artisti del grande repertorio del 900 marchigiano poco noti, recuperati nella splendida e vastissima collezione pesarese di Elio Giuliani, già utilizzata in precedenti articoli per questa rivista.
Il cosiddetto 'secolo breve' è stato davvero una fucina di artisti figurativi soprattutto nella parte settentrionale della regione e l'analisi singola di alcuni di loro può contribuire a comporre un mosaico variegato e inedito, da aggiungere a storie personali già note e consolidate e a proporre accostamenti con esperienze regionali diverse.
E' il caso di Luigi Bazzali (Catanzaro 1908-Grottaferrata 1968), di madre anconeta-
na e padre toscano, nato nello stesso anno del terremoto di Messina. Questo disastro indusse i genitori a tornare ad Ancona, città natale della madre e successivamente a trasferire la famiglia a Pesaro, dove Luigi studiò alla Scuola Artistico Industriale, alunno di Fernando Mariotti.
Nel 1927 partecipò al Convegno d'Arte degli artisti della provincia di Pesaro esponendo quattro opere e in quell'occasione alcuni amatori d'arte che lo avevano conosciuto e apprezzato lo presentarono al pittore toscano Baccio Maria Bacci, che divenne il suo maestro a Fiesole per quattro anni, fino al 1931. Bacci era un affermato artista legato al regime fascista e al recupero della cultura figurativa tosca-

31 L’artista
Nella pagina precedente
Autoritrato con tavolozza (1957) Sopra, Il lettore (1940) e al centro delle pagine
Natura morta con pigne e conchiglie (1953) A destra dall'alto
Donna che dorme (1940) Paesaggio (1931) e un'incisione con natura morta (Foto di Luca Toni)
na rinascimentale, soprattutto quattrocentesca e monumentale.
Nel 1928 Bazzali partecipò alla III Esposizione d'arte di Pesaro con nove opere, che raffigurano nature morte, un nudo e alcuni paesaggi toscani, temi che saranno costanti nella sua ispirazione e produzione pittorica.

Dal 1930 al 1938 partecipò a varie mostre a Firenze, Ancona, Cagliari, Pesaro, Recanati, Napoli e Siracusa, dove diresse la locale Scuola d'Arte. Alla fine del 1938 decise di trasferirsi a Roma, sposò un'insegnante triestina, si spostò a Trieste dal 1940 al '46, finchè decise di tornare a Roma, dove abbandonò l'insegnamento e si dedicò solamente alla pittura. Visse gli ultimi anni a Grottaferrata vicino a Roma, in un vecchio casale isolato, dove morì nel 1968.

Questo itinerario nomade di Bazzali è rappresentativo di un modo di vivere inquieto legato alla provincia italiana e radicato nell'Italia della prima metà del 900, che qui possiamo riassumere brevemente nella sua opera, fatta conoscere come tante altre nella storica, grande mostra 'Arte e immagine tra ottocento e novecento. Pesaro e provincia', tenuta a Pesaro nel 1980. Fu definito in quel ricco catalogo il ruolo svolto dalle Marche nelle innumerevoli mostre d'arte pura e decorativa e vennero definite le storie singole degli artisti, destinati a scelte definitive come quelle di restare qui o di partire per varie destinazioni.
Il decennio 20-30 offre ai giovani molte possibilità culturali, nel vorticoso alternarsi di Mostre Regionali, di Biennali Veneziane, Biennali Monzesi, Biennali Romane, Mostre degli Amatorie Cultori di Belle arti romane, ecc. (....) Nel 1926 lo storico dell'arte G. Edoardo Mottini scrive: 'Certo, in Italia, si dipinge troppo e soprattutto troppo si espone.'( in “Rivista
d'Italia”, agosto 1926)
Tra il 1926 e il 27 anche le Marche costituiscono un Sindacato interprovinciale fascista artisti: esserne iscritti è condizione preliminare per accedere alle varie mostre selettive regionali e nazionali.
A Pesaro, si profilano scelte definitive verso la fine del decennio: alcuni rimangono, altri decidono di spostarsi, a Parigi o in varie città d'Italia.
Luigi Bazzali sceglie Firenze dove rimane, come s'è detto, tra il '29 e il '31.
“Gruppo che poteva consistere e che si disperde...; il che sta a dimostrare ancora una volta come la nostra provincia e la regione marchigiana non siano troppo gelose delle proprie energie artistiche e come, ma il discorso mi porterebbe troppo lontano, mai quivi potranno svilupparsi e vivere comuni tendenze del carattere della propria terra improntate.
(E sì che la regione non sarebbe da meno delle altre, e sì che alcuno l'ama e la sente, bellezza aspra e dolce, come rinserrata, che vuol essere
32 L’artista
Le sue nature morte e i paesaggi toscani saranno temi costanti della sua ispirazione e produzione pittorica
scoperta quasi a fatica, e goduta nell'intimo, in silenzio, ma da lontano non la puoi dimenticare).” Così Francesco Carnevali nel 1930.

E' la diaspora marchigiana, che accosta alle esperienze della provincia pesarese, quelle diverse e ben più note, di Scipione, del primo Licini, di Mannucci, di Cagli, di Bartolini, di Lorenzo Gigli e di altri. A Firenze il giovane Bazzali si caratterizza dall'inizio per il rigore morale e per la necessità di trovare in se stesso la propria visione del mondo attraverso la pittura.
L'ambiente artistico fiorentino è influenzato da Strapaese, il movimento letterario e culturale che a partire dal 1926 esalta il ruolo delle tradizioni italiane 'paesane' contro l'esterofilia. Le idee di Strapaese confluiscono nella rivista 'Il Selvaggio' di Malaparte e Maccari, alla quale collaborano artisti e letterati come Soffici, Bartolini, Cardarelli, De Pisis.

In pittura le opere di Bazzali risentono soprattutto di Ardengo Soffici, e nella produ-
zione incisoria, fatta di fittissimi segni delicati e ordinati, si può pensare anche all'opera del bolognese Giorgio Morandi, in una personale bazzaliana visione intimistica e composta, quasi crepuscolare. Nel dopoguerra, con lo spostamento a Roma, Bazzali dimostra una maturità influenzata anche dal tonalismo romano che ripercorreva le lezioni di Cézanne e dei Fauves, cioè di una semplificazione formale insieme volumetrica e coloristica. Così sarà nell'ultima fase della sua vita durante la quale, nell'appartata quiete dell'abitazione di Grottaferrata, dedicò molto del suo tempo alla grafica, girando alla ricerca di posti da disegnare nella campagna di Roma. Riscoperto negli ultimi decenni, Bazzali è stato bene valutato dalla critica e figura in molte collezioni private e pubbliche.

Merita di essere conosciuto insomma per un'origine marchigiana aperta a varie suggestioni regionali ma sempre intensamente portato all'analisi di sè e del proprio rapporto con la storia. ¤

33 L’artista
Nell’ultima fase della sua vita nella quiete della sua casa di Grottaferrata dedicò molto tempo alla grafica

Regine della Preistoria
La Venere “Minotauro” gioiello del Paleolitico
HA DIECIMILA ANNI ED È ESPOSTA AL MUSEO DI ANCONA

Piccina e nuda, viene da lontano. Diecimila anni fa, millennio più millennio meno, un artista l'ha graffita su un ciottolo appuntito, stregato da un'immagine scaturita dalla sua mente. La chiamano “Venere di Tolentino”, e regna sovrana a Palazzo Ferretti di Ancona. Condivide lo scettro soltanto con un'altra donna millenaria, la Venere di Frasassi, che di anni ne ha quasi il doppio. Forever young, entrambe provengono da quella notte dei tempi che raramente lancia segnali luminosi dei nostri antenati. Così diverse, così iconiche, come tutte le miss si contendono l'ammirazione. Diego Voltolini, il
e pancia rigonfi, attributi femminili esasperati, a simboleggiare la fertilità. Questa di Tolentino, invece, con mammelle e pube stilizzati in triangoli, incrocia le braccia sul ventre, quasi negando la maternità. Ma soprattutto è un ibrido». Spiega: «Alla maniera del Minotauro, ha corpo umano e testa di animale. Un bovino o un equino, c'è chi dice un lupo; sulle gambe sono graffiti segni che simulano la peluria. Denota, è evidente, una fase più evoluta della riflessione su ciò che va oltre l’uomo, la capacità di creare un essere semi-umano, in contatto col divino e l’oltre-umano».

direttore del museo, non ha dubbi: «La Venere di Tolentino ci racconta di una fase più evoluta, in cui l'astrazione prevale sul naturalismo». Bidimensionale, non è formosa come la statuetta ritrovata, nel 2007, nella grotta della Beata Vergine a Frasassi, che ha seni
Se ne accorse subito il conte Aristide Gentiloni Silverj che, trovato il ciottolo in una cava d'argilla della sua tenuta attorno a Tolentino, nel 1884, aveva preparazione e acume per afferrarne il valore, inestimabile. È facile immaginare l'emozione che deve aver provato questo archeologo ante litteram, paletnologo per passione, quando l'ebbe tra le mani e, ripulendo la superficie, riconobbe le fattezze di questa donna-vitello. La sorpresa, poi, rigirando la piccola pietra, si accrebbe nel trovare incisa, sul retro, un'altra testa di animale, di perfette fattezze. Se vivesse oggi, si attaccherebbe al telefono, per chiedere conferma della sua intuizione. All'epoca, affidò il suo stupore, la consapevolezza dell'importanza della scoperta alla lentezza della corrispondenza epistolare. Lo testimoniano le lettere che scrisse a Luigi Pigorini, un luminare in materia, all'epoca, per sol-
35
di Lucilla Niccolini
A sinistra, la Venere di Frasassi più formosa e la Venere "Minotauro" ritrovata a Tolentino dal conte Aristide Gentiloni Silverj nel 1884. Sopra, una sala del Museo Archeologico ad Ancona
Nelle pagine alcune vedute del Museo Archeologico ad Ancona ospitato a Palazzo Ferretti In basso a destra un'altra immagina della pietra su cui è inciso il corpo di una donna con seni e pube stilizzati in triangoli e volto di "animale"



lecitarne il parere: chiedeva se non sembrasse anche a lui, che una simile rappresentazione, di chiara funzione cultuale, andasse riferita a una fase animista del Paleolitico. Pigorini si professò dubbioso, con scetticismo dettato forse, visto da lontano, da una sorta di invidia, per non essere stato lui il protagonista della scoperta. Però, l'ipotesi di Gentiloni Silverj sarebbe stata confermata, decenni dopo, da altre scoperte del Paleolitico superiore, prima fra tutte quella del cosiddetto Sciamano di Fumane, in provincia di Vicenza. Risalente a 40mila anni fa, è considerata una delle più antiche fi-
più antiche, in ogni angolo della Terra. Più interessante, per noi marchigiani, è notare una singolarità, che fa della Venere di Frasassi un unicum. Il nostro antenato sciamano è una donna!
gure di uomo-animale: disegnato in ocra rossa su pietra calcarea, porta sul capo due corna, e rappresenterebbe un essere umano dotato di capacità profetiche e taumaturgiche. Uno sciamano, appunto.
Sarebbe lungo riassumere le ricerche e le scoperte che hanno portato gli antropologi a riconoscere le caratteristiche di tali personaggi, attestati in tutte le culture
Fu lo stesso Gentiloni Silverj a donare il ciottolo, assieme a molti altri reperti da lui trovati e indagati nella sua area, tra cui i resti di tombe picene “orientalizzanti”, all'allora Museo Regio, fondato nel capoluogo dorico all'indomani dell'Unità d'Italia dal commissario straordinario per le Marche Lorenzo Valerio. Fu Carisio Ciavarini, prof di Lettere al Ginnasio, assieme a Carlo Rinaldini, cui oggi quel liceo è intitolato, ad avviare la raccolta “di tutti i monumenti dall'età della pietra in poi, rinvenuti con certezza nella regione”, secondo i principi della Commissione Conservatrice, di cui fu il primo segretario e instancabile operatore. «Da allora – continua Diego Voltolini – la Venere di Tolentino fa parte del patrimonio del nostro museo, ma solo un secolo più tardi, grazie alle indagini di Agnese Massi, Mauro Coltorti, Francesco D'Errico, Margherita Mussi e Daniela Zampetti, se ne è potuta appurare la datazione con ragionevole certezza: un'opera d'arte paleolitica, databile tra 10mila e 8mila anni fa. Un reperto di straordinario rilievo per lo studio della preistoria. Un gioiello per le Marche, di cui, a oggi, non si sono trovati uguali nel mondo».
A lei cede il passo la Venere di Frasassi, una tipologia relativamente più “comune”, e di più chiaro significato. «Ma entrambe portano lo scettro – annuncia il direttore Voltolini - di regine del Museo Archeologico di Ancona. Al termine della riorganizzazione della collezione, saranno esposte, pro-

36 Regine della Preistoria
Corpo di donna e testa di lupo o vitello, incisa in un ciottolo ritrovato a Tolentino
Il direttore Voltolini: “unica nel mondo”
tagoniste, al terzo piano, destinato alla Preistoria, con un nuovo allestimento idoneo a permettere la lettura dei reperti, lungo il percorso espositivo, da parte degli studenti, di ogni età. Rigore scientifico, ma una diversa modalità di comunicazione».
Poi, entra nei particolari dell'itinerario museale riformato: «Subito al di sotto, il mezzanino sarà dedicato a illustrare il passaggio dall’Età del Bronzo all'Età del Ferro, con pezzi che testimoniano la vita quotidiana e l’idea di casa nel mondo antico. Quindi, al primo piano, offriremo ai visitatori i capisaldi della civiltà Picena, dal 1000 al 400 a.C., di cui il museo possiede un patrimonio immenso, il più ricco al mondo».
Il primo piano nobile di Palazzo Ferretti prosegue nell'ala più recente, ricavata nell'ex Convento degli Scalzi, con i reperti riferibili

all'Ellenismo nelle Marche: Celti e Dori, poi la sezione Romana, curata dalla dottoressa Nicoletta Frapiccini, attuale direttrice dell'Antiquarium di Numana.

In via di completamento, prosegue nel primo seminterrato. «Ma poiché il materiale che riusciamo a esporre costituisce appena un decimo dell'intera collezione – conclude Diego Voltolini – l’obiettivo è aprire al pubblico anche quattro sale dei magazzini, attraverso un progetto da finanziare con i fondi del PNRR, accanto ai laboratori di restauro, attorno a un salone dedicato alle ricerche degli studiosi».
Un museo in divenire, fervido di attività dei suoi archeologi, con cui collaborano atenei italiani e stranieri. Su di loro veglia la regina/ sciamana, la giovane donna nuda, la magica e misteriosa Venere di Tolentino.
A Palazzo Ferretti è esposta anche la Venere di Frasassi simbolo di fertilità di oltre 20mila anni fa ma l’altra mostra un segno più evoluto
37 Regine della Preistoria
¤
Ken Parker, Tex Willer
Dylan Dog
gli altri personaggi tratteggiati
dal noto disegnatore marchigiano
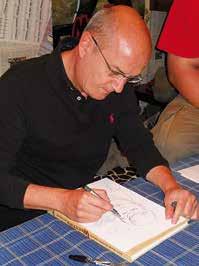
in 50 anni di carriera
Il marchigiano Giancarlo
Alessandrini (Jesi, 1950)

è uno dei più affermati fumettisti italiani che, dopo aver conseguito il diploma nell'Istituto d'Arte di Ancona, ha iniziato la sua carriera nel 1972, entrando nella redazione del Corriere dei Ragazzi, per il quale ha disegnato le serie Uomini contro, Fumetto verità, Anni 2000 e Lord Shark su sceneggiature di vari autori. Nel 1976, su testi di Alfredo Castelli e Mario Gomboli, ha creato per Cosmopolitan otto episodi che hanno come protagonista Eva Kant, successivamente raccolti in un volume pubblicato da Mondadori e intitolato Eva Kant - Lontano da Diabolik. Nel 1977 ha iniziato la sua collaborazione con Sergio Bonelli Editore, disegnando sei episodi della serie Ken Parker, lo straordinario protagonista di Berardi-Milazzo che, pur operando nel West, incarna i valori e miti dell’epica contemporanea, un personaggio

“colto” al centro di avventure dove ricorrono con frequenza richiami alla letteratura, alla poesia, alla musica, al teatro e soprattutto al cinema. “L’Uomo dal Lungo Fucile” non è un giustiziere né un vendicatore, ha letto Shakespeare e Karl Marx, fa delle scelte “democratiche”, perché difende i nativi dalle angherie dei bianchi, si batte contro le ingiustizie e la violenza del potere, ha un profondo rispetto per la natura e per le creature animali.
Alessandrini è anche l’autore del volume L'uomo di Chicago che appartiene alla bella collana Un uomo, un'avventura, nella quale sono riunite opere di grandi disegnatori italiani. Nel 1978 ha collaborato per un breve periodo con la casa editrice Mondadori alla serie SuperGulp! come autore di Allan Quatermain, una storia scritta da Alfredo Catelli e che per certi versi anticipa il futuro Martin Mystere; è state il disegnatore
Il personaggio
di Alberto Pellegrino
In alto nel riquadro Giancarlo Alessandrini mentre disegna il volto di Martin Mystère
Il segno di Alessandrini su Martin Mystère detective degli enigmi
di Steve Vandam, avventure scritte da Tiziano Sclavi (l’inventore di Dylan Dog). Dal 1980 al 1983 è entrato nella redazione del “Giornalino”, realizzando la serie Rosco & Sonny, scritta da Claudio Nizzi, alcuni episodi della serie Ai confini dell'avventura tratta dai documentari di Folco Quilici, Storie di tutti i tempi, scritte da Renata Gelardini.
Nel 1990, in collaborazione con lo sceneggiatore Roberto Dal Prà, ha disegnato per la rivista “Torpedo” L'Uomo di Mosca, una bella storia poliziesca liberamente ispirata al romanzo Gorky Park di Martin Cruz Smith e all’omonimo film di Michael Apted. A partire dal 1991 vengono pubblicate sulla prestigiosa rivista “L'Eternauta” le storie del detective Anastasia Brown sempre su testi di Roberto Dal Pra. Su Comic Art ha realizzato come sceneggiatore e disegnatore due brevi racconti della serie Fatti e misfatti a Planet
Arium. Nel 2004 ha disegnato l’album n. 13 Dylan Dog Gigante e nel 2006 il ventesimo Texone, l’albo di formato gigante pubblicato ogni anno e dedicato al personaggio Tex Willer. Dal punto di vista stilistico, Giancarlo Alessandrini dagli anni Settanta alla seconda metà degli anni Ottanta ha adottato una linea grafica caratterizzata dall'uso di un forte tratteggio e dall'impiego massiccio del nero. Con la nascita di Martin Mystere si è invece verificata una evoluzione del suo stile che si è avvicinato al tipico disegno della cosiddetta “linea chiara” di origine franco-belga, caratterizzata da una grande eleganza ed essenzialità del tratto. Per i suoi meriti artistici sono stati assegnati ad Alessandrini il Premio ANAF come migliore disegnatore del 1991 e il Premio Yellow Kid sempre come miglior disegnatore italiano per l’anno 1992.

Nel 1982 nasce Martin
Mystere – Detective dell’impossibile (Sergio Bonelli Editore), un personaggio ideato dallo sceneggiatore Alfredo Castelli e realizzato graficamente da Giancarlo Alessandrini che lo segue per lungo tempo e che è anche l’autore di tutte le copertine. Quest’anno si festeggiano i primi quarant’anni della serie e per l’occasione il 9 aprile è uscito un album celebrativo dell’evento (il n. 386), per il quale Alessandrini ha firmato la copertina e ha partecipato alla realizzazione della storia insieme ad altri colleghi: “Quarant’anni non sono pochi, – ha dichiarato Alessandrini - una volta ero preso anche da altre cose, ma oggi, ancora più di ieri, mi sono dedicato a pieno ritmo a disegnare fumetti. Ho la stessa voglia, senza disegno non so stare. A Martin Mystere sono particolarmente legato, la passione per lui c’è sempre…e spero di continuare ancora nei prossimi anni a realizzarlo. Non mi
39
L’ILLUSTRATORE MARCHIGIANO FESTEGGIA 40 ANNI DEL FUMETTO

Il personaggio

40|41
stancherò mai di disegnare Martin Mystere”. Nel dare vita a questa serie di successo, i due autori hanno deciso di non creare un supereroe, ma di proporre come protagonista di queste storie un serio e stimato professionista, una persona "normale" con alcuni piccoli difetti che dovevano renderlo "umano" e accattivante, un uomo amante dell’avventura senza farne uno spericolato e irresponsabile avventuriero.

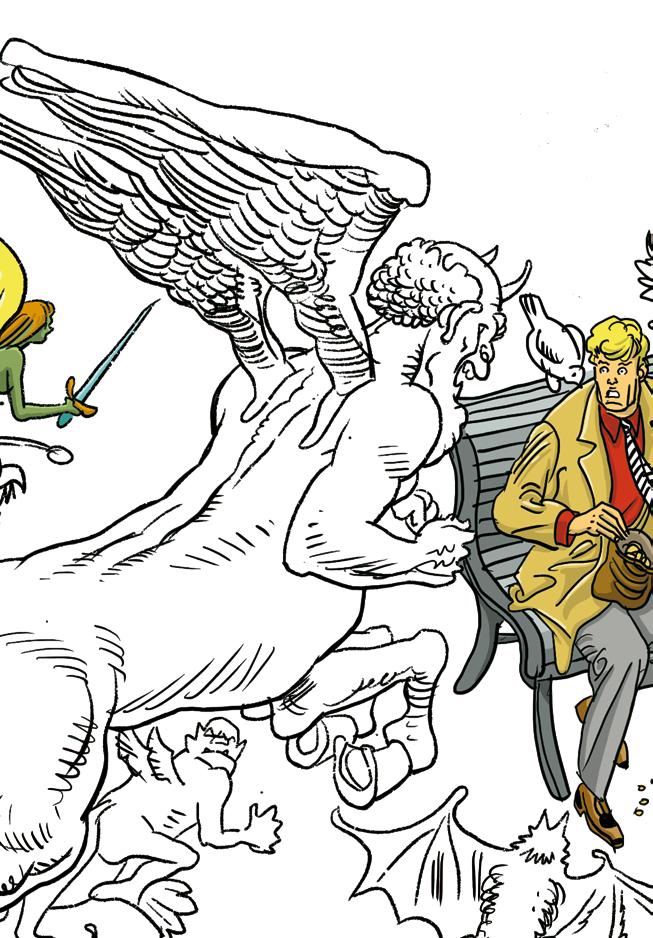
Martin Jacques Mystere nasce negli Stati Uniti d’America e, quando fa la sua apparizione, è bello, biondo, robusto e coraggioso, nonché affezionato alla sua Ferrari Mondial Otto. Si è laureato in antropologia alla Harvard University; si è specializzato in archeologia alla Sorbona; ha studiato storia dell'arte a Firenze e cibernetica applicata al linguaggio al MIT. Martin è dotato di una vasta cultura, non è mai saccente e pedante, perché sa essere anche autoironico; possiede una saggezza di stampo antico che proviene dalla cultura orientale, perché per un certo periodo ha vissuto in un monastero tibetano accanto al filosofo Kut Humi, che è stato il suo maestro spirituale e lo ha iniziato ai misteri e alla visione di vita del mondo orientale; inoltre gli ha donato un'antica arma a raggi paralizzanti chiamata Murchadna e proveniente dal misterioso continente Mu.
A partire dal 1965, come giovane ricercatore, Martin Mystere ha vissuto spericolate avventure ma, una volta superati i 40 anni d’età, è diventato un uomo maturo che lavora molto al computer per scrivere il prossimo libro in perenne ritardo con il suo editore, ma che è soprattutto impegnato a preparare le puntate del suo programma televisivo di successo, "I
Misteri di Mystere", con il quale può finanziare nuovi viaggi e acquistare libri per la sua sterminata biblioteca. Martin vive a New York al numero 3/a di Washington Mews, in un appartamento pieno di libri e di oggetti curiosi e originali.

Non esegue indagini su commissione, ma entra in azione soltanto se l'argomento gli interessa, in modo particolare quando si trova di fronte a "grandi enigmi" mai risolti e che la scienza "ufficiale" non prende in considerazione, oppure a enigmi scientifici e parascientifici che la comunità scientifica ritiene senza soluzione. Interviene anche quando ci sono fatti misteriosi come i ritrovamenti archeologici; quando vengono alla luce misteri esoterici che rappresentano aspetti inesplicabili e inquietanti all’interno della società contemporanea, tali da far irrompere il fantastico nell’ordinata vita quotidiana di una piccola comunità urbana o di una metropoli, sconvolgendone la tranquillità.
Martin, oltre a dedicarsi all’archeologia e ai fenomeni parascientifici, ama occuparsi di avvistamenti Ufo, di pericolose congiure messe in atto dai cosiddetti “poteri forti”, di ogni evento che apparentemente non presenta nessuna spiegazione razionale e scientifica. Per questo viene soprannominato il Detective dell'Impossibile anche se non è mai stato un investigatore privato nel senso tradizionale del termine, in quanto non ha clienti che si rivolgono a lui per proporgli dei casi da risolvere. Ama definirsi un “consulting detective” specializzato in mysteri e, sul modello di Sherlock Holmes, accetta solo incarichi di consulenza, i quali finiscono tuttavia per coinvolgerlo in avventure molto movimentate, come
42 Il personaggio 40|41
Nella pagina precedente, un'opera di Giancarlo Alessandrini Sopra, due illustrazioni fantastiche dello stesso autore A destra in alto, un disegno a china con sullo sfondo la Mole Vanvitelliana di Ancona; a destra in basso una delle copertine realizzate per il mercato internazionale
Martin Mystère nasce nel 1982 da un’idea di Castelli e tutte le copertine sono state realizzate fino adesso da Alessandrini
del resto accade anche a Indiana Johns. Per le sue competenze e per il suo intuito, a volte si rivolgono a lui per avere un aiuto sia il commissario Travis della polizia di New York, sia il comandante di una agenzia governativa segreta denominata “Chris Tower” per risolvere casi particolarmente complicati e difficilmente decifrabili.
Le avventure di Martin Mystere sono ambientate nell’epoca contemporanea, oppure sono proiettate nel passato e nel futuro, ma sono sempre collocate in contesti storicamente studiati e rigorosamente realistici grazie a un lavoro di ricerca documentaristica da parte degli autori. Quando deve riportare alla luce testimonianze di antiche civiltà dimenticate, battersi contro i licantropi, lottare contro gli spietati Uomini in Nero, Martin Mystere guida sempre il lettore alla scoperta di bellezze artistiche, di culture sconosciute, di luoghi miste-


riosi, d’interessanti curiosità archeologiche come l'origine delle statue dell'isola di Pasqua o la nascita di personaggi fantastici come il mostro di Loch Ness, l'Uomo delle nevi o gli alieni. Nel corso delle sue avventure Martin incontra noti figure letterarie come Sherlock Holmes; s’imbatte in avvenimenti storici dimenticati e in antiche leggende come il segreto del Santo Graal, le origini della civiltà etrusca, la scomparsa dei mitici continenti di Atlantide e di Mu; ha l’occasione di scoprire inediti particolari biografici di grandi personaggi come Cristoforo Colombo, Leonardo da Vinci o William Shakespeare.
I principali personaggi
Java è il miglior amico nonché assistente personale del Professor Mystere. È un Uomo di Neanderthal proveniente dalla misteriosa Città delle ombre
43 Il personaggio
Gli autori non volevano creare un supereroe ma un professionista con piccoli difetti e autoironia amante dell’avventura
diafane celata in una introvabile valle dell'Himalaya. Martin, nel corso di una drammatica avventura, si è guadagnato la sua stima e Java lo ha seguito in America, dove è riuscito ad adattarsi alla civiltà moderna. L’uomo in origine si esprimeva gutturalmente, ma poi ha imparato la lingua dei segni dei sordomuti. Possiede una straordinaria forza fisica oltre ad essere intelligente e perspicace, tanto che riesce a comunicare con Martin senza bisogno di parole, in quanto lui comprende i suoni gutturali dell'amico.
Diana Lombard è un’assistente sociale e una fedele collaboratrice di Martin Mystere. Bella, bionda, elegante, intelligente è stata per molti anni la fidanzata ufficiale del protagonista. Finalmente nel numero speciale, pubblicato per i vent’anni della testata, si è appreso che i due si sono sposati in gran segreto il 14 dicembre 1995.
Sergej Orloff è il personaggio destinato a ricoprire il ruolo dello scienziato pazzo, un tempo amico e collega di Martin, con il quale è stato discepolo del filosofo orientale Kut-Humi. Successivamente si è dedicato al crimine, celando la sua vera natura dietro la facciata di un rispettabile uomo d'affari, di un mecenate e benefattore dell’umanità. Soltanto Martin sa che Orloff è in realtà un assassino senza scrupoli, tanto che in numerose occasioni si è scontrato con lui e ha tentato di ucciderlo. Orloff è rimasto sfigurato in un incendio, per cui è costretto a coprire
il volto con una maschera; ha perso anche un braccio che gli è stato sostituito con un arto artificiale, nel quale ha inserito la pericolosa arma a raggi donata anche a lui da Kut-Humi. Viene immancabilmente rappresentato come un individuo mentalmente disturbato che periodicamente decide di conquistare il mondo e che viene regolarmente sconfitto da Martin Mystere dopo una serie di drammatici scontri.
Mister Jinx è un criminale dall’identità sconosciuta, che s’impossessa spesso delle invenzioni fatte da altri, con le quali si propone di realizzare, attraverso diabolici progetti, i sogni "impossibili" dei suoi ricchi clienti (l'immortalità, l'eterna giovinezza, l'ubiquità, i poteri soprannaturali, ecc.).


Le sue azioni provocano spesso degli effetti negativi o addirittura disastrosi, per cui Martin Mystere viene chiamato in ballo ed è costretto a intervenire per sventare i suoi piani criminali. I più feroci e accaniti avversari di Martin sono gli Uomini in Nero, una setta segreta che vorrebbe distruggere ogni traccia del nostro remoto passato e che pertanto cerca di opporsi a ogni scoperta che vada contro l'ordine costituito e la cultura ufficiale.
Si tratta di nemici del progresso che cercano di distruggere ogni ritrovamento o di impadronirsi dei reperti archeologici riportati alla luce da Martin Mystere, il quale è costretto a ingaggiare lotte furibonde per salvare se stesso e le sue scoperte.
44 Il personaggio
¤
Biondo, robusto e coraggioso antropologo e specializzato in archeologia con strani compagni d’avventura
Due ritratti del famoso detective dell'impossibile realizzati dal marchigiano Giancarlo Alessandrini
AFFEZIONATO A MYSTÈRE, MAI STANCO DI DISEGNARLO


“Atre anni avevo la matita in mano. Praticamente ci sono nato”. Giancarlo Alessandrini, il maestro del fumetto “da grandi”, è nella sua casa di Trento, 72 anni, da cinquanta alle prese con le tavole, i disegni dei personaggi e le nuvolette. Disponibile e affabile. A casa ha anche dieci chitarre elettriche: “Quando vengo ad Ancona mi capita di suonare ancora con gli amici” confida. E’ facile entrare subito in empatia. Dalla sua matita sono nati Martin Mystère, Ken Parker, Tex e Dylan Dog. “Fin da piccolo disegnavo da matti. Come un treno. Non bastava mai la carta. Era una malattia”.

“Divoravo il Corriere dei Piccoli – racconta - che i miei mi
compravano. E ho cominciato copiando le storie di Hugo Pratt. Cercavo di imitarle. Alla scuola d’arte di Ancona, allora, non si insegnava l’illustrazione dei fumetti ma io li disegnavo sottobanco. Come è scattata la molla? Fondamentale fu un giorno in cui vidi un disegno dal vero. Il professore si presentò con una modella, staccò un pezzetto di ramo da una pianta, lo bagnò in una boccetta d’inchiostro e iniziò a tratteggiare il foglio. Noi rimanemmo con la bocca aperta. Con una grafite ripercorse i tratti e da lì ho capito. Da lì è scattata la scintilla. Hugo Pratt faceva i disegni così. In modo molto spontaneo. E quando mi interessava una cosa, copiavo, vedevo come faceva le pieghe, le ombre. E
45 L’intervista
Alessandrini: “Nato con la matita in mano”
di Sergio Giantomassi
mi rendevo conto di come venivano disegnati i tratteggi. Mi sono diplomato con un dieci in decorazione pittorica. Al preside sono piaciuto e mi ha dato il massimo dei voti. Poi ho lavorato un paio di anni alla Dante Alighieri, tra i libri scolastici e anche un po’ a spasso. Dopo, ho tenuto seminari sul fumetto a Falconara e Jesi”.
La svolta?
“Quando ho conosciuto Silvano Marinelli, uno che sapeva il mestiere. Usava gli strumenti giusti. Li ho visti. Io invece disegnavo con le matite. Mi ha dato consigli utilissimi. Silvano lavorava al Corriere dei ragazzi e un giorno mi invitò con lui a Milano in redazione. Avevo 22 anni. Portai dietro la cartellina con i miei disegni. Ricordo di una lunga anticamera prima di entrare. E quando si trattò di visionare i lavori, il caporedattore invece di prendere la cartellina di Silvano prese la mia per errore. Guardò dentro e la portò via. Quando tornò, disse che aveva visto cose interessanti e che gli sarebbe piaciuto conoscermi. Subito dopo mi chiese di fare una prova. Io ero già svenuto dall’emozione. Mi diede una sceneggiatura e mi invitò a disegnarla. Appena finita, la dovevo portare su a Milano. Sono corso alla stazione, ho preso il primo treno e sono tornato ad Ancona. Proprio in tempo per sentire le forti scosse di terremoto. Era il 1972. Ma non mi sono perso d’animo. Ho finito quanto prima il lavoro e gliel’ho mandato”.
E cosa è successo poi?
“Mi telefonò. Il tono era serio, non mi piaceva. Per un attimo
ho pensato che la prova fosse andata male. Niente da fare. Ma con lo stesso tono continuò a dirmi che mi avrebbero inviato una nuova sceneggiatura e così anche il contratto. Sognavo. Mi sono traovato in mezzo a grandi illustratori come Milo Manara, Sergio Toppi, Dino Battaglia, Di Gennaro e non mi sembrava vero. Ho avuto la fortuna di essere capitato nel posto giusto al momento giusto”.
A casa come l’hanno presa?
“I miei volevano che facessi il geometra ma al primo assegno si convinsero che ero sulla strada giusta, quella che desideravo. Con il Corriere sono stato qualche anno. Poi mi ha notato Bonelli che mi affidò un incarico per la collana Un Uomo, un’avventura. Ho disegnato L’uomo di Chicago in stile Al Capone e a Bonelli interessò molto. In quel contesto ho conosciuto Castelli”.
Da quali altri autori, oltre a Hugo Pratt, ha tratto ispirazione?
“Con Pratt è scattata la prima scintilla. E’ stato sempre un maestro per me. Poi ho attinto dalla scuola americana, disegnatori come Frank Robbins, Gordon ma anche da molti italiani come Gino d'Antonio, Alex Toth fino a Moebius. Se mi trovo in difficoltà, guardo lui”.


Quale tipo di difficoltà?
“Tratteggiare le espressioni mi diverte. Non ci sono difficoltà ma complessità, superabili con espedienti di mestiere. Per certe vignette casomai ci vuole pazienza, per esempio quando mi hanno chiesto di disegnare Manhattan dall’alto, con molti particolari. Con Tex ho avuto inizialmente problemi nel disegnare i cavalli. Poi, in uno stesso volume ne ho realizzati 2.500. Adesso li faccio anche con la testa girata da un’altra parte”.
46 L’intervista
In alto a destra Giancarlo Alessandrini mentre disegna le tavole a fumetti e nelle pagine a seguire alcuni suoi lavori
“Fin da piccolo disegnavo da matti Non bastava mai la carta. Era una malattia Hugo Pratt è stato un maestro per me”
E Martin Mystère come é nato?
“Stavo illustrando Ken Parker quando Alfredo Castelli, lo sceneggiatore con cui ho legato subito, si inventò un nuovo personaggio, un americano sui 40/50 anni, biondo e coraggioso, una specie di detective dell’impossibile e del mistero con una gran Ferrari M8, che ora non usa quasi più, e con compagni di viaggio straordinari, dalla bella Diana all’incredibile Java. Castelli voleva che lo disegnassi io. Ho lasciato Ken e mi sono buttato sulle tavole di Martin. In poco tempo l’ho tratteggiato ed è piaciuto subito. Posso dire che sono l’unico che da allora ha disegnato tutte le copertina di Martin Mystère”.


Da quaranta anni il detective dell’impossibile è in edicola e ha confidato che non si stancherà mai di disegnarlo…
“Ci sono affezionato in pratica l'ho creato io graficamente. Alfredo Castelli mi ha dato ampia libertà. Mi forniva indicazioni generiche, al resto pensavo io. E ci tengo che altri disegnatori mantengano que-
sta impostazione. Soprattutto per i lettori che sono abituati a vederlo con questi tratti e riconoscerlo immediatamente ”
Non ha mai cambiato stile?
“Ogni personaggio ha un suo stile. Nel caso di Tex ho dovuto cambiarlo proprio per venire incontro ai lettori. Bisogna stare attenti. Per esempio quando Tex parla, non muove mai le mani mentre Martin Mystère sì. E molto. E’ anche chiacchierone. Con lui si va via veloce, due pagine disegnate al giorno. A volte sono riuscito anche a finirne cinque o sei, tutte con molti dialoghi. Martin mi resta più spontaneo e il mio tratto si è evoluto da sé, mai in modo forzato”.
I protagonisti dei fumetti non invecchiano mai…

“Meglio se non invecchiano. Altrimenti finirebbe la serie. Avete mai visto topolino invecchiare?”
Disegnare fumetti è come dare una vita propria ai personaggi?
“E’ come disegnare un film.
47 L’intervista
“In un volume di Tex ho disegnato ben 2500 cavalli ormai li faccio anche con la testa girata da un’altra parte”
Devi farli muovere, li devi vestire. Devi creare l’ambiente. Sei al tempo stesso scenografo, attore e costumista. Devi fare tutto. E mi affascina”.
Anche un po’ regista...
“Certamente. All’inizio mi dicevano, fai questa scena in primo piano, metti sullo sfondo quest’altro, oggi, con Martin Mystère ho piena libertà di interpretazione”.
Mai tratto spunto da personaggi viventi?
“Una volta, in un racconto di Martin Mystère, ho tratteggiato personaggi che avevano una somiglianza con Lillo e Greg. Poi gliel’ho regalato. Altre volte ho inserito il volto di qualche amico mio. E in uno persino il mio”.
Come i grandi pittori… “E’ divertente. Ma anche molti ambienti sono reali, riprodotti con minuzia di particolari, come la casa di Martin Mystère”.
Che rapporto ha con il disegno digitale?
“Non lo uso. Solo in post produzione. Preferisco affidarmi alla carta, agli strumenti e colori tradizionali. Mi affascina però l’Ipad”.
Come vede il mercato dei fumetti?


“So che c’è stato un avanzamento dei Manga. Bonelli, comunque, con Tex mantiene uno zoccolo duro e ho saputo di una ripresa del mercato della graphic novel. Ma, ad esempio, rispetto a noi in Francia esiste un altro mercato. Quando stilano la classifica dei libri più venduti, non è raro veder comparire fumetti...”

Un aneddoto…
“Me ne ricordo uno, in particolare. Avevo inviato alla editrice Bonelli dieci tavole di Martin Mystère. Il giorno dopo mi chiamò al telefono il caporedattore. E con fare cupo mi disse: senti non va bene. Sei stato troppo sintetico. Qui non lo siamo… Mi sono impaurito. Cosa avevo combinato? Avevo spedito tutte pagine bianche, mai disegnate. Gli originali erano a casa, li avevo dimenticati. Siamo poi scoppiati in una risata”.
Si diverte ancora?
“Ma scherzi? Non ci posso stare senza disegnare. E lo faccio sentendo la radio, leggendo le sceneggiature. E’ il momento più bello della giornata. La fatica non la sento. Se c’è passione, è solo sana stanchezza”. ¤
48 L’intervista
“E’ come disegnare un film, i personaggi devi farli muovere vestire e devi creare l’ambiente Sei scenografo, regista e costumista”
La mia Pietrarubbia città di pietre narranti
Quando penso a questo scoglio arcigno che si erge come un monolite, un obelisco tra gli oscuri ed intriganti luoghi montefeltreschi la mente corre subito all’inconscio immaginandone qui una sua vivida rappresentazione materiale.
L’inconscio, che cosa è se non la generica indicazione delle attività mentali -pensieri, emozioni, istinti, rappresentazioni, modelli comportamentali, spesso alla base dell'agire umano - non presenti alla coscienza di un individuo? “In psicologia, la sfera dell’attività psichica che non raggiunge il livello della coscienza (detta perciò anche livello inconscio)” (da Treccani).
L’inespresso, sustrato formidabile cui attinge con lena la vis creativa è l’inconscio.

Ecco, per me Pietrarubbia è la proiezione del mio inconscio: i picchi e le valli, gli antri e le lande, gli orridi e i calanchi: metafore preziose del mio incedere esistenziale che ritrovo come cristallizzati nel castello, nella torre campanara, nel ciglio a forma di dito, nella chiesa di San Silvestro, nella lunga via d’accesso al borgo: riepilogo del mio piccolo mondo antico, ma non già crepuscolare come in Fogazzaro, piuttosto l’alba, anzi l’aurora di una palingenesi, di una nuova modernità che riaccentra sull’uomo protagonista dell’universo e compendio e concerto di tutti i saperi. Quel borgo medievale così somigliante a quello della vallesina, Poggio San Marcello, dove sono nato e ho trascorso la mia silvana fanciullezza.
Sì, rivedo in Pietrarubbia la storia, le arti e i mestieri,
il paesaggio ora selvaggio, ora diversamente coltivato, il quieto vivere, l’accoglienza calda e sincera: ricchezza delle tradizioni e spontaneità creativa. Tutto qui mi è familiare!
Ma Pietrarubbia è di più; è un archetipo, è il simbolo della terra, la pietra appunto, che la filosofia naturalistica greca con Talete, Anassimene ed altri, postula insieme con l’aria, l’acqua e il fuoco, all’origine del cosmo. La pietra, la pietra rossa, carica di ferro che nel suo nome –omen nomen- ne disegna il destino.
E’ qualcosa di più di un segno, di un simbolo; è il tòpos della infanzia mia e di ciascuno, che permane, alimenta, rinforza e guida l’energia creativa.
E’ la cifra intellegibile del processo trasformativo dell’energia che si in-forma e si oggettiva in un’immagine, un prodotto, una struttura-sistema.
E’ il laboratorio in cui l’uomo integrale di maritainiana memoria può esprimersi in tutte le sue dimensioni di corpo, di mente e di cuore: la larghezza, l’altezza, la profondità. E sperimentare quanto le categorie aristotelico-scolastiche dell’hic et nunc siano superate dalla simultaneità e dall’ubiquità per l’iperconnessione che il web impone nell’illusione di una nuova conoscenza forse anche un pò disumanante.
Pietrarubbia è la rappresentazione tridimensionale; per natura e storia è il ‘rendering digitale’ della potenza creativa che l’inconscio cerca di trattenere e che invece in quel luogo strabocca per attualizzarsi grazie agli spunti
49 Il borgo
Omen nomen: la pietra rossa carica di ferro di quel luogo medievale
ne disegna il nome e il suo destino
di Giordano Pierlorenzi
SOSPESO TRA ARTE E NATURA, DOVE L’UTOPIA TROVA LUOGO
del coro scenografico che ammaglia; agli incoraggiamenti polisensoriali che il paesaggio aspro e cordiale offre; all’ospitalità delle comunità dal cibo genuino e dai borghi vocianti che attrae; all’opera monumentale del castello che il vento impetuoso cesella come un bulino.


Ma soprattutto è il mistero in cui è racchiuso nei millenari recessi appenninici il mithos che si coniuga con l’èthos per esplodere nell’èpos: l’epica, le gesta generative della nostra civiltà, della nostra cultura, della nostra arte, che in ossequio ai nostri avi, chiamiamo a gran voce e con orgoglio Storia Picena.
Pietrarubbia è l’utopia che trova luogo, in cui cioè il mistero dirada le sue fitte trame e si apre all’antropologia culturale nella narrazione orale dei racconti e leggende. Come non ricordare la Sibilla e i suoi oracoli? Ed insieme si apre all’antropometria: l’uomo può finalmente misurarsi, prendere contezza del suo essere ed esistere; si apre alla prossemica, scienza delle relazioni socioculturali degli uomini tra loro, dell’uomo con la natura, dell’uomo con l’arte come espressione alta del suo genius loci che gode e fa godere della sua opera connaturale e simpatetica.

Sì, dove l’utopia trova luogo: espressione fugace, retrospettiva, caleidoscopica dell’inconscio collettivo dove ciascuno può rivivere flashback del suo vissuto personale e ritrovare solidarietà, amicizia, amore. Pietrarubbia riscopre nel raccontarsi la sua funzione catartica e dispensare ad libitum, a piacere benessere e bellessere psicologico. Sì, è la caverna di cui parla Platone, dove come in un film autobiografico si può rivedere le idee, le cose conosciute nel mondo iperuranio: reminiscenza per la filosofia, anamnesi per la psicologia. Ma avvera un po’ anche “La città del sole”, l’uto-
pia di Tommaso Campanella, ispirata a “La repubblica” di Platone, dove “una congrega di spiriti liberi – novelli sacerdoti solari-, un po’ visionari e creativi chiamati a presidiare quell’avamposto culturale per dar vita a un progetto il cui segno ideale è offerto generosamente dalla natura stessa” (dalla brochure istituzionale della Poliarte sede di Pietrarubbia), cercano altri solari, cittadini cioè della Nuova Città del Sole che condividano il convivio: lo spezzare il pane, l’arte e la cultura, dialogare, comunicare per fare comunità: l’io che, per Martin Buber, cedendo qualcosa di sé, costruisce il noi. Comunicare nel senso più vero e ancestrale di scambiarsi un dono, cum munere: una parola, un sorriso, un gesto. La prossimalità che diviene socialità, solidarietà, fraternità. E’ dunque pure, un villaggio dal valore totemico dove cadono tabù e prescrizioni: una società aperta, larga, essoterica in un borgo, il vicus, dove il limen,
50 Il borgo
Il paesaggio aspro e cordiale, l’ospitalità e l’opera monumentale del castello sono un ammaliante coro scenografico
Dall'alto, la pala d'altare di Arnaldo Pomodoro nella chiesa romanica di San Silvestro. Sotto, una sala del museo dedicato all'artista con opere del TAM (Trattamento Artistico dei Metalli). Al centro, una panoramica del borgo di Pietrarubbia e a destra alcuni suoi scorci
il confine è labile – non più dentro e -fuori-, è libero, sorretto soltanto dall’imperativo etico-naturale che Kant riassume nel Tu devi. Dove è possibile ‘guardar le stelle’ con gli occhi dell’astronomo e quelli del sognatore ispirato da Urania. Dove le arti delle muse in particolare di Tersicore per la danza, Eutèrpe per la musica e Calliope per la poesia e il teatro, guidano i solari nella vita ordinaria e straordinaria del borgo, meta di alto turismo culturale. Ma dove soprattutto Mnemosyne, la madre delle muse conservatrice della memoria, potrà guiderà la scelta delle pietre narranti e dei suoi interpreti, fil rouge della vita a Pietrarubbia. Ecco allora approfondendo la riflessione, comprendo perchè Arnaldo Pomodoro, come un moderno Vulcano, abbia voluto eleggere questo avamposto appenninico ad officina, laboratorio di trasformazione artistica dei materiali ed abbia marcato questo incantevole, favoloso
territorio con le sue inestimabili opere connaturate, perché espressione spontanea, proiezione della natura agente in lui come vocazione e contributo all’armonia del creato: l’ergonomia omeostatica tra l’uomo, l’opera e l’ambiente. La sua opera nella chiesa di San Silvestro nel borgo ne è l’icona magistrale. E capisco pure Umberto Eco che ha scelto come ritiro culturale Montecerignone a pochi passi da Pietrarubbia.
Perché? Perché?
Perché Pietrarubbia è l’iconostasi della bellezza, il divisorio tra inconscio e coscienza, tra realtà e virtuale. Perché è librata tra cielo e terra, tra natura concreata e contemplazione.



Il luogo ideale dove l’uomo può trovare la trascendenza e magari riscoprire che “Dio non è morto”, parafrasando la canzone de I Nomadi.
Hic manebimus optime, qui staremo benissimo. ¤
Arnaldo Pomodoro ha voluto eleggere questo avamposto appenninico a laboratorio di trasformazione artistica dei metalli
51 Il borgo
Un corridoio lungo e buio, ai lati inferriate e celle vuote. Solo una rete arrugginita e qualche bagno alla turca ricordano che lì dentro, dietro quelle sbarre, hanno vissuto centinaia di uomini. Siamo a San Girolamo, a Urbino, sotto la biblioteca dell’Università Carlo Bo inaugurata nel 2020. Una volta in quei locali si trovava l’ex carcere della città, chiuso definitivamente nel 1987. Lo avevamo raccontato in esclusiva sull'ultimo numero del Ducato, la testata dell'Istituto di formazione al giornalismo di Urbino. Ora con nuovi volti e nuove carte.
Tra la polvere dei piani inferiori, dove la vegetazione esterna col tempo è entrata nella struttura, c’è anche il cadavere mummificato di un gatto a testimoniare come lì dentro non metta piede nessuno da anni. Per visitare quei luoghi, le vecchie celle e i corridoi, così come i locali delle docce, bisogna scende-
re e attraversare un cortile oggi popolato da studenti, e un tempo da detenuti durante la cosiddetta “ora d’aria”. Meglio avere una torcia potente, quella del cellulare a volte non basta a illuminare quei luoghi. Così è possibile notare le tracce di un passato recente o remoto che emergono dalle pareti. L’ex carcere occupa due livelli su quattro dell’edificio, quelli più bassi.


La luce che entra dalle finestre è insufficiente a illuminare i locali. Sulle pareti ci sono testimonianze di un’altra epoca come un poster di Nelson Piquet a bordo della Lotus gialla a fine anni Ottanta, o quello strappato della nazionale olandese di calcio vincitrice dell’Europeo ’88 con gli attaccanti del Milan di Arrigo Sacchi. Incollate alle mattonelle di un’altra cella sorridono – da oltre trent’anni - le caricature di Caterina Caselli, John Travolta e Mike Bongiorno. Sono le figurine della rivi-

San Girolamo a Urbino
di Maria Elena Marsico
e Enrico Mascilli Migliorini
Sotto i libri universitari un carcere di fine ‘800
sta Tv Sorrisi e Canzoni. In quella che era la cucina, sotto la gamba di una sedia, spunta un giornale dell’epoca. Intorno ci sono coperchi di pentole e posate di plastica. Siamo al piano superiore dell’ex carcere, qui in alcune celle non si può entrare perché il passaggio è sbarrato da pile di calcinacci e travi di legno. Si può però guardare l’interno attraverso le sbarre o tramite lo sportello delle porte di ferro, quando sono chiuse. Il pavimento del lungo corridoio in alcuni punti è rotto e bisogna fare attenzione. Vicino ai muri si notano anche alcuni disegni. In uno è rappresentata una guardia carceraria, accanto c’è un demone. Per arrivare al piano inferiore dell’ex prigione bisogna percorrere una scalinata di cui non si vede la fine, tanto è buio, e che per questo motivo sembra condurre verso il vuoto.
Lì c’è un altro corridoio, ancora più lungo, circondato da celle più grandi e più
spaziose, sia a destra sia a sinistra. All’interno ci sono i bagni e le volte sul soffitto. Su questo piano, che è quello inferiore, c’è un altro cortile che però è abbandonato. E’ impossibile varcare la soglia che conduce all’esterno perché la vegetazione ha avvolto ogni cosa.


Quello che rimane dell’ex carcere, però, è soprattutto altro. Sono le storie dei detenuti che sono passati in quei locali. Chi per qualche mese, chi per diversi anni, chi in attesa di giudizio, chi a scontare una pena. Racconti di vita e tracce biografiche che sono raccolte nei fascicoli e nei faldoni dell’Archivio di Stato di Urbino, come prevede la legge. Pagine ingiallite e usurate dal tempo raccolgono le memorie di un secolo di quello che era l’istituto penitenziario della città.
Da Palazzo Ducale all’ex convento San Girolamo
La storia dell’ex carcere comincia alla fine dell’Ottocento, quando da Palazzo
Ducale i detenuti furono trasferiti a San Girolamo, un tempo convento dei Padri Gerolamini. In Archivio è documentato tutto il passaggio e tra le carte del tempo c’è un articolo di Corrado Ricci, su La Tribuna, del 23 novembre 1886. Si legge: “In una parte del Palazzo Ducale d’Urbino si tenevano i galeotti, che si lasciavano spesso liberamente passeggiare, urlare, bestemmiare e far qualcosa di peggio nel bel mezzo d’un chiostro su cui rispondono le finestre della residenza dell’Accademia Raffaello”. La notizia è su “Un disegno di legge all’ordine del giorno della Camera. Acquisto di stabile per l’impianto di una casa di custodia in Urbino”.
Non è la prima volta che in Comune si parla della questione. Un documento di due anni prima, del 29 luglio 1884, sottolinea che l’uso delle carceri “nell’ex Palazzo Ducale non si addice ad un monumento di sì grande
53
CELLE VUOTE E MURI IN DEGRADO RACCONTANO UN SECOLO DI DETENZIONE
Nella pagina precedente e in queste successive alcune immagini e dettagli di ciò che resta dell'ex carcere di fine '800 a San Girolamo di Urbino in attesa di altra sistemazione dall'Università di Urbino
pregio artistico”. Cominciano così i lavori di sgombero e di trasferimento “in un’altra località”, come si legge in alcuni verbali. Lavori che in totale durano otto anni, compresi quelli di “finimento”, secondo quanto riportato dalla documentazione del Fondo Comunale dell’Archivio di Stato. Nel Palazzo del Duca andrà l’Accademia di Belle Arti di Urbino. Un documento riporta che la struttura San Girolamo è costituita da “52 vani” e “due corti interne”, di cui oggi soltanto una è utilizzata come giardino della biblioteca.
Il carcere entra in funzione, a tutti gli effetti, dal 1890. Nelle relazioni conservate nei faldoni dell’Archivio, il suo funzionamento viene definito spesso come “soddisfacente”. Nel corso del suo secolo di vita, però, è stato anche teatro di scioperi della fame, rivolte e proteste come quelle degli anni Settanta del Novecento.

Una di queste rivolte scoppiò nel carcere di Fossombrone, braccio di quello di Urbino ma riservato ai menomati fisici, oggi istituto penitenziario di massima sicurezza. Quella del 16 gennaio 1974 fu la prima volta in cui ai detenuti fu concesso di parlar con la stampa. Il Resto del Carlino titolava: “Basta coi detenuti di lusso”. Solo quattro anni prima, il 14 febbraio 1970, il ministero di Grazia e giustizia aveva inviato una circolare sull’introduzione della stampa politica negli istituti penitenziari. Per il ministero, si legge, dato “il rilievo dato dalla Costituzione ai diritti delle persone”, la trasformazione della società e dei costumi” e “l’elevazione culturale e della sensibilità individuale” che si riflette anche nelle carceri, i tempi sono maturi perché anche i detenuti possano leggere giornali e periodici con opi-

nioni politiche.
Non mancano poi le lamentele. In una nota di un detenuto di quegli stessi anni si può leggere che l’istituto penitenziario di Urbino appare “privo di una lavorazione, privo di un cortile decente per l’aria”. E ancora: “nel periodo invernale bisogna stare 24 su 24 ore in cella. Manca la televisione che potrebbe rappresentare l’unico mezzo diversivo almeno nelle ore serali, come in tutte le altre carceri”. E già negli anni Cinquanta i detenuti richiedono di stare al passo con la modernità con l’acquisto di un radio, al tempo negato. Nel febbraio 1970 viene anche lamentata la scarsa luminosità delle celle e “l’eccessiva promiscuità”, oltre alla carenza di personale tra la polizia penitenziaria.
Ci sono comunque testimonianze di una vita carceraria non estremamente rigida, e forse lo si può dedurre dalla quantità di richieste di trasferimento in altri carceri, anche per ragioni amorose, inviate e accettate dal Ministero di Grazia e giustizia. Ad esempio, si poteva lasciare denaro in punto di morte a un altro detenuto per farglieli donare in beneficenza a un ordine ecclesiastico per poi far celebrare messe in onore di quella persona, è il caso di Annamaria nel 1968. Sappiamo anche che i detenuti potevano contrarre debiti e fare credito, come nel caso di tale Nicola che, trasferito da Fossombrone alla Sicilia, ha ancora diritto al credito che altri detenuti avevano contratto con lui mentre si trovava a Urbino.
In alcune relazioni contenute nei fascicoli dell’Archivio si sottolinea l’amicizia tra detenuti. Anche se non tra tutti: come il caso di un uomo, negli anni Sessanta, “tutt’altro che benvoluto”
54 San Girolamo a Urbino
La prigione costituita da 52 vani e due corti interne venne aperta nel 1890 e chiusa definitivamente nel 1987
dagli altri. “Lo prendevano in giro e lo odiavano perché si rimpinzava di cioccolatini e dolciumi sperperando in tal modo i suoi denari”, si legge.
Leggere le storie di chi ha popolato le celle dell’ex carcere di Urbino è un po’ come fare un viaggio nel tempo. Si possono scoprire i nomi dei loro famigliari, così come i reati commessi: da quelli più comuni come furto, rapina, oltraggio a pubblico ufficiale, truffa, alla violenza carnale e all’omicidio. Compare anche qualcuno imprigionato per obiezione di coscienza o per aver guidato senza patente.

Negli anni della guerra, poi, si andava in carcere anche per macellazione clandestina, furto di tabacco o di “carte da giuoco” e, nel 1945, di una rivoltella delle Forze Armate Alleate. Tra le carte dell’Archivio si scopre poi che anche dall’ex carcere di Urbino fuggirono dei detenuti. Viene descritta
l’evasione di tre uomini che scapparono nelle prime ore del mattino. Due furono catturati.
Nel corso dei suoi cento anni, l’ex istituto penitenziario ospitò anche delle donne. Nelle relazioni è registrata la presenza di una detenuta con un bambino che non si sa se sia nato in carcere o abbia dovuto seguire la mamma.
La fonte principale resta l’Archivio di Stato di Urbino, nel pieno centro storico della città. Se lì si apre il fascicolo delle “circolari ministeriali”, si possono prendere nota dei cambiamenti di costume della società anche nelle carceri. Ad esempio, i detenuti da sempre sono considerati cittadini di fronte alla legge e soprattutto alla fonte primaria di queste, la Costituzione. Eppure soltanto il 3 luglio 1969 vengono dichiarati incostituzionali gli articoli 142 e 143 del regolamento penitenziario che “vincolano il detenuto
In precedenza i reclusi erano ospitati a Palazzo Ducale ma nel 1884 si scrisse che ciò non si addiceva a un immobile di così grande pregio

55 San Girolamo a Urbino
maggiore degli anni ventuno alla fede religiosa dichiarata all’ingresso in carcere” e il 144 che “obbliga il minore degli anni 21 a seguire la religione nella quale è nato”. Stesso discorso vale per i pranzi e le cene dei detenuti, che secondo il Ministero meritano un’alimentazione più variegata e salutare. In un allegato è presente addirittura una tabella che indica cibi e quantità previste a settimana

anche gli uffici di alcuni professori.
Il rettore dell’Università Carlo Bo, Giorgio Calcagnini, ha spiegato che la prima idea era quella di fare delle aule nei locali dell’ex carcere. “Non è stato possibile perché per la soprintendenza il progetto non era coerente con il contesto. Le finestre non bastano e non possono esserne aperte altre”, ha detto.
Alcune carceri dismesse come quelle di Saluzzo, in Piemonte, o le Nuove di Torino sono state recuperate. All’interno sono stati realizzati dei percorsi museali che raccontano la storia del luogo e affrontano temi collegati alla giustizia.

Per il San Girolamo non si è mai parlato di progetti simili, “ma potrebbe essere una buona idea”, ha aggiunto Calcagnini.
Presente e futuro di San Girolamo
Le celle di San Girolamo sono abbandonate da oltre trent’anni. Nel 2000 la struttura è stata ceduta in comodato d’uso perpetuo – quindi gratuitamenteall’Università di Urbino dal ministero delle Finanze, a cui era passato da quello di Grazia e Giustizia. Così, nel 2020, ai piani superiori della struttura, è stata inaugurata la biblioteca che ospita
Il professore Roberto Mario Danese ci ha mostrato i piani superiori dell’ex carcere che oggi ospitano la biblioteca universitaria di Urbino. Oltre ai numerosi volumi raccolti al suo interno – oltre 150mila – ci sono anche sale dedicate alle disabilità visive con tutti gli strumenti necessari, dalle tastiere ai monitor, e laboratori di digitalizzazione sonora e di libri antichi.
Parte della struttura, quindi, ha trovato una nuova vita. Poi c’è il carcere abbandonato, che oltre a essere un luogo da ristrutturare e valorizzare, è anche e soprattutto il testimone della vita di persone che hanno vissuto un periodo della loro esistenza dietro quelle sbarre e porte di ferro. ¤
56 San Girolamo a Urbino
Oggi dell’ex prigione rimangono le tracce lasciate dai detenuti e la memoria conservata nei faldoni dell’Archivio di Stato sopra c’è una biblioteca
Paesaggi d’architettura attraverso la fotografia

Fabio Mariano, uno dei nostri soci più prestigiosi, è stato professore ordinario di “Restauro Architettonico” nella Facoltà d’Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche; è l’autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche riguardanti la storia dell’architettura e la ricerca storica. È stato il primo studioso che si è dedicato alla Storia dell’architettura delle Marche con contributi di fondamentale importanza che hanno aperto la strada a una serie di ricerche riguardanti monumenti e autori marchigiani finora poco noti o addirittura sconosciuti. La prima opera importante è stata l‘Architettura nelle Marche Dall’età classica al liberty (Nardini Editore, 1995), seguita dagli studi sulle fortificazioni militari nel Montefeltro e nella Marca centrale. Un altro campo di ricerca è stata l’architettura teatrale marchigiana come dimostra il volume I Teatri delle Marche. Architettura, Scenografia, Spettacolo (Nardini Editore, 1997), realizzato in collaborazione con Franco Battistelli e Alberto Pellegrino, nel quale vengono fatte un’analisi completa dell’architettura teatra-
le, una storia dello spettacolo regionale dal XV al XX secolo e una schedatura di tutti i teatro storici marchigiani.
Ora ha dato alle stampe Paesaggi d’architettura con brevi note storiche sulla fotografia dell’architettura (Andrea Livi Editore, 2022), nel quale ha raccolto 241 fotografie selezionate dal suo vasto archivio fotografico e scattate nei vari continenti tra il 1970 e il 2020.
Mariano apre questo suo lavoro con un’ampia Storia della fotografia dell’architettura (con eccessiva modestia definita “brevi note storiche), nella quale si parte dall’archeologia dell’immagine fotografica con gli studi e gli esperimenti sulla camera oscura tra il XV e il XVIII secolo per arrivare alla nascita della fotografia attraverso le scoperte di Niepce, Daguerre e Talbot nella prima metà dell’Ottocento, un arco di tempo durante il quale ha origine anche la fotografia architettonica. Nella seconda metà dell’Ottocento si ha un’ulteriore crescita del rapporto fotografia-architettura negli Stati Uniti e in Europa, mentre in Italia danno un significativo apporto i primi fotografi professionisti tra i

57 Il volume
VIAGGIO INTORNO AL MONDO CON LE IMMAGINI DI MARIANO
di Alberto Pellegrino
Sopra, la copertina del lbro dell'architetto Fabio Mariano "Paesaggi d'Architettura" A destra, Sarzana, Fortezza degli Architetti Francesco di Giovanni detto il Francione e Luca del Caprina 1488-1502
Qui
New York - Bayard-Condict Bldg.,

Sullivan,
quali si distinguono i Fratelli Alinari e Giorgio Sommer.
Nel Novecento si registra un notevole sviluppo di questo genere fotografico grazie all’introduzione sul mercato di macchine tecnologicamente avanzate come la Leica e la Rolleiflex. Un contributo fondamentale arriva dalla Bauhaus con l’opera di Lazlo Moholy Nagy, di Albert Renger-Patzsch, di Alessandro Rodcenko, degli statunitensi Alfred Stieglitz e Berenice Abbot. In Italia è importante la presenza di fotografi come Giuseppe Pagano, Tommaso Vasari e Ottavio Savio; da segnalare anche il contributo fornito da grandi architetti come Giovanni Michelucci e Paolo Portoghesi che s’impegnano in prima persona come fotografi. L’excursus storico si conclude con l’omaggio a due maestri della fotografia d’architettura: l’americano Ezra Stoller (1915-2004) e Gabriele Basilico (1944-2013).
Anzi Mariano afferma che questo grande architetto-fotografo italiano è stato ed è un suo costante punto di riferimento con la piena condivisione di queste sue parole che danno un senso al lavoro fotografico: “Capii allora un principio che resta ancora fondamentale per il mio lavoro ancora oggi: con la fotografia non puoi migliorare il mondo, ma puoi fare una cosa preliminare e necessaria: misurarlo. Prendere le misure dei luoghi da noi crearti è molto più urgente che giudicarli”.
L’esordio di Fabio Mariano come fotografo è avvenuto a Roma nel 1968/69, quando da studente universitario ha cominciato a fare e a vendere ad alcune riviste delle fotografie socialmente impegnate in linea con la rivoluzione culturale di quegli anni. Questa sua attività gli ha permesso di conoscere importanti storici e critici della fotografia come Giuseppe Turroni e Wladimiro Settimelli. Purtroppo i 450 ne-
gativi scattati in quel periodo sono andati perduti, ma per fortuna sono rimasti questi negativi scattati con l’occhio dell’architetto e selezionati sulla base degli interessi specifici dello storico dell’architettura.
Il volume consente di compiere un viaggio intorno al mondo con una serie d’immagini che ci portano in località disseminate in tutti i continenti: in Africa (Kenia, Libia, Nigeria); Medio Oriente (Egitto, Giordania, Israele, Siria, Turchia); nell’America Latina (Messico e Perù); in diversi Paesi europei con particolare riferimento ad Atene, Parigi, Vienna, Barcellona, San Pietroburgo, nelle principali città dalmate. Naturalmente non potevano mancare molte fotografie riguardanti l’Italia: da Torino alla Sicilia, da Roma a Milano, da Napoli a Venezia, da Genova a Bologna, Parma, Ferrara, Ravenna e Padova. Sono presenti anche i centri minori che sono preziosi contenitori di monumenti ed esempi di cultura urbanistica come Civita di Bagnoregio, Spello, Viterbo, Matera, San Gimignano, Tuscania, Amalfi, Pomposa, Monte Sant’Angelo. Dall’analisi del volume emerge anche la passione di Mariano per i teatri greci e romani (Segesta, Epidauro, Bosra, Sabratha) o per Teatro Farnese di Parma, capolavoro del Barocco; nonché il suo intesse di storico per castelli, roccaforti e fortificazioni, a partire da quelli più celebri come Castel del Monte, il Forte Spagnolo dell’Aquila, la Rocca di San Leo, La Fortezza Aragonese di Ortona, la Fortezza d’Istanbul, la Fortezza Vecchia di Corfù, la Cittadella fortificata di Aleppo fino a quelli meno noti e documentati in tutti i continenti.
Per quanto riguarda stile e contenuti, le fotografie di Mariano si caratterizzano per la grande padronanza tecnica della macchina fotografica, perché nella fotografia d’ar-
58 Il volume
sopra,
arch.Louis
1897-99 A destra, Tomar - Convento do Cristo, Chiostro di Giovanni III - archh. Diogo de Torralva e Filippo Terzi
Nelle
geometrico
efficace uso della luce
Foto scattate con l’occhio dell’architetto
inquadrature rigore
ed

Mariano:
chitettura è essenziale che la forma coincida con i contenuti. Le sue inquadrature si distinguono per il rigore geometrico delle linee e l’efficace uso della luce; per la capacità di messa a fuoco senza mai perdere di vista il punto focale o la profondità di campo; senza mai commettere un errore di parallasse, anche quando decide di cimentarsi nelle complesse e rischiose inquadrature dall’alto o dal basso. Vi è poi un sofisticato impiego del grandangolo e del teleobiettivo con eleganti passaggi dal campo totale e dai primi piani al dettaglio, attraverso il quale l’autore riesce a far diventare il significante una rappresentazione dell’intero significato. Rare volte nelle immagini di Mariano è presente la figura umana, eppure si avverte in tutte la presenza costante dell’uomo all’interno del contesto paesaggistico in un significativo rapporto con le varie strutture urbane e naturali, una presenza testimoniata da straordinari manufatti costituiti da chiese, castelli, fortificazioni, mulini o moderne strutture come aeroporti, stazioni ferroviarie, torri delle telecomunicazioni. Un’altra qualità di Mariano è quella di saper cogliere la “presenza umana” delle statue, di riuscire a comunicare la componente culturale di questi manufatti artistici, di farle interagire e “farle parlare” con il contesto urbanistico come avviene con le statue del Partenone o del Duomo di Milano, le statue del Vittoriano, le Muse del Achilleion Palace di Corfù, con quella Musa in primo piano che sembra voler uscire dall’inquadratura per dialogare con l’osservatore. ¤
Premio Marche Un omaggio al disegno
Il “Premio Marche 2022 - Biennale d’arte contemporanea” organizzato dall’Amia (Associazione Marchigiana Iniziative Artistiche), ha preso il via nella doppia veste di rassegna regionale e di mostra monografica: alla Galleria Nazionale delle Marche, nella Sala delle Grandi cucine di Palazzo Ducale esposte fino al 22 gennaio opere di una cinquantina di artisti marchigiani, o operanti nella regione Marche; alla Galleria Civica Albani, invece, fino al 26 febbraio si può visitare la mostra monografica dal titolo “Aspetti del disegno negli artisti marchigiani del Novecento”, con opere di una settantina di artisti.
Si possono vederi tratti di Arnaldo Pomodoro e Cucchi, di De Carolis, Licini e Scipione, di Sante Monachesi, Mattiacci, Cintoli e Gino De Dominicis, del Premio Oscar Dante Ferretti e di Andrea Pazienza. La “Rassegna artisti marchigiani” è stata curata da Bruno Ceci, Gualtiero De Santi, Federica Facchini e Arianna Trifogli mentre gli “Aspetti del disegno negli artisti marchigiani del Novecento” è stata curata da Fabio Mariano, Sefano Papetti, Marina Massa, Bruno Ceci e Gualtiero De Santi. ¤

60 Il volume
“Con la fotografia non puoi migliorare il mondo ma puoi prendere le misure dei luoghi da noi creati “
Sopra, Parigi, Quartiere de La Defense, monumento di Alexander Calder, 1980
Giovanni Filosa
 EX CASCAMIFICIO DI JESI, FUTURO SPAZIO MULTIFUNZIONALE
EX CASCAMIFICIO DI JESI, FUTURO SPAZIO MULTIFUNZIONALE

Nei paesi anglosassoni l’Archeologia Industriale prese forma e sostanza nella prima metà del XX secolo. Lo scopo? Studiare le vestigia della rivoluzione industriale, recuperando e valorizzando l’intero patrimonio del passato più o meno recente fatto di fabbriche tessili, ponti, mulini, fornaci, solo per citare alcune tipologie di beni, e tutte le testimonianze materiali ed immateriali ad essi collegate. Ovvia l’importanza di aprire una finestra sul patrimonio posseduto e sovente in disuso, creando eventuali connessioni e possibilità di confronto e riqualificazione. Sembra questo il sogno che la Fondazione Pergolesi Spontini, unitamente ad Enti pub-
blici e privati, sta cercando di realizzare proprio alle porte della città federiciana e pergolesiana. L’ex Cascamificio di Jesi, una delle più importanti strutture archeologiche industriali jesine, oggi abbandonata, potrebbe divenire un centro culturale multifunzionale che metterà a disposizione della comunità un luogo di lavoro, di formazione, di contaminazione culturale, di ispirazione, di aggregazione e di memoria. Tutto questo grazie al Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili che finanzierà il progetto di riqualificazione urbana presentato dai Comuni di Jesi, Maiolati Spontini, Monte
61 Il progetto
In alto l'interno dell'ex stabilimento jesino nella situazione attuale
Un centro culturale dalle “ceneri” industriali
di
Sopra, un'immagine dello stato attuale dell'area destinata al nuovo progetto di riqualificazione A destra dall'alto una foto d'epoca del cascamificio; la direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini
Lucia Chiatti e una veduta dei locali nella situazione attuale

Roberto e Castelbellino, per il tramite della Regione Marche, e di cui la Fondazione Pergolesi Spontini è partner privato. Ne parliamo con la direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini, e del Consorzio Marche Spettacolo, Lucia Chiatti, cercando di addentrarci nei meandri delle iniziative che
formano lo studio di fattibilità di un sogno, chiamiamolo così, che potrebbe, se realizzato, avere un peso specifico nella propagazione culturale della nostra regione. Un progetto ambizioso, ci pare…
Sì, è un progetto molto ambizioso. Per noi rappresenta un punto di arrivo per alcuni versi ed uno di partenza per altri considerato che risponde ad un’esigenza che abbiamo sempre avuto, vale a dire trovare un luogo che risponda alla domanda crescente, ad esempio, della realizzazione degli allestimenti. E se è vero che questo progetto cavalca anni di grande difficoltà sociali, sanitarie ed economiche, sono fiduciosa perché, pur impantanati nel Covid, abbiamo potuto progettare e volgerci verso nuove sfide, dedicandoci ad esse in modo
ancor più intenso. L’immobile di cui parliamo era stato messo all’asta ed ecco che in questo caso la crisi si è trasformata per noi in una opportunità. L’abbiamo acquistato al secondo incanto, ciò ha permesso un ulteriore ribasso del prezzo. A questo punto abbiamo scelto di portare avanti l’operazione che, dal punto di vista della sostenibilità economica, era già insita nel prezzo dell’acquisto. Vale a dire che il prezzo era paragonabile e confrontabile a quello del magazzino che noi abbiamo in affitto da tanti anni ed un investimento il cui costo annuo si attesta intorno a quello dell’affitto, ci ha palesato la convenienza dell’operazione. Passeremo, in sostanza, da uno spazio che oggi utilizziamo di 1.500 metri quadrati ad un altro che è di oltre dieci volte tanto. 18.000 metri quadri, di cui circa 9.000 al chiuso e altrettanti all’aperto, uno spazio che già, nell’immaginario collettivo, ci trasporta in un’altra dimensione. Una dimensione in cui il respiro creativo può trovare spazio, espressione, sviluppo e rispondere ad una domanda crescente di realizzazione di allestimenti non solo per la Fondazione Pergolesi Spontini ma anche per conto terzi. Che vuol dire non solo per teatri ma anche per altre realtà. Un esempio, abbiamo realizzato l’allestimento per il film di Pupi Avati su Dante, un allestimento per la Rainbow, elementi scenici e di allestimento per delle mostre, fiere, addirittura su tematiche distanti dal mondo dello spettacolo dal vivo. Questa attività accessoria è strumentale all’attività principe, che è quella di produzione ed allestimenti per la Fondazione, di scene e costumi mirati alla stagione lirica e per il festival Pergolesi Spontini realizzato fra agosto e settembre. E’ un poten-
62 Il progetto
In cantiere la riqualificazione dell’immobile per trasformarlo in uno spazio destinato ad allestimenti teatrali e non solo
ziale commerciale davvero sfidante. Non dobbiamo aver paura dell’attività commerciale quando pensiamo che l’attività istituzionale ha necessità di essere ossigenata. Non è più possibile pensare che l’attività che svolgiamo possa o debba solo contare sulle istituzioni pubbliche né affidarci in modo passivo ed accomodante su qualcuno che potrà sostenere la nostra attività, perché il valore è immenso, quello di pubblico servizio. E’ importante che il Ministero continui a sovvenzionare la nostra attività, abbiamo due titoli che la riconoscono e qualificano, come il titolo di Teatro di Tradizione e il titolo di Festival, abbiamo il sostegno della Regione Marche, un importante, fondamentale ed imprescindibile sostegno del Comune di Jesi. Tutto ciò può rischiare di non essere sufficiente se il respiro lo si immagina soltanto circoscritto alla provincia. E’ il contrario, invece, questa potrebbe essere un’occasione per provare nuovi progetti, mettendo in campo le nuove leve, giovani talenti in uno spazio che può ospitare anche residenze artistiche, che può trasformarsi in una vera palestra, in uno scambio fra soggetti che realizzano e fanno teatro, che creano e provano a fare spettacolo dal vivo.

Che tipo di spettacolo, per esempio?
«Non uno spettacolo ristretto in un ambito di nicchia, come dicevo, legato al solo campo della lirica o della musica colta. Sappiamo come la musica abbia una valenza sociale, fondamentale, quanto contribuisca al benessere psichico delle persone e della Comunità. Questo spazio ha la possibilità di abbracciare tanti tipi di attività in ambito culturale e sociale. Dalla formazione alla produzione, all’attività
laboratoriale che comprenda, direi, sia materiale di magazzino di repertorio, un laboratorio di scenotecnica per realizzazioni di grandi dimensioni. E’ possibile, faccio un esempio, pensare di riportare esattamente, in questo spazio, la dimensione reale del palcoscenico del Pergolesi, direttamente dentro l’ex cascamificio. Quello spazio può ospitare tanti tipi di messe in scena, che so, dal teatro off al contemporaneo, che magari non troverebbero nel Pergolesi il luogo ideale. Poi le realizzazioni pittoriche fatte a terra. Voglio ricordare tutta la riduzione che realizzammo nell’attuale magazzino, della Traviata di Svoboda, compiuta dai nostri decoratori, persone con competenze formative importanti, alcuni dei quali vengono dall’Accademia di Belle Arti e svolgono principalmente questo tipo di lavoro».
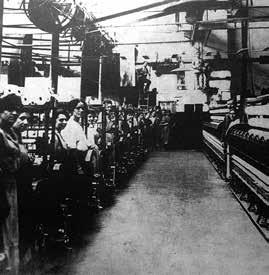
Altre attività, al di fuori dello spettacolo?
«L’attività convegnistica, conferenze, incontri, mostre. Per esempio raccontare la genesi e l’importanza sociale e culturale, per la storia di Jesi, del luogo stesso, per evidenziare la caratteristica dell’artigianato di queste nostre zone, che costituisce un valore aggiunto. Senza dimenticare uno spazio cinematografico vero e proprio. Sicuramente un luogo di aggregazione, che comprenderà anche zone di ristoro, caffetteria, bar, foresteria e di svolgimento di attività sociale, ospitando associazioni e non solo, per realizzare un welfare culturale, su cui già siamo impegnati ma di cui scopriamo l’importanza soltanto ora. Forse perché stiamo prendendo consapevolezza di quale sia il valore che lo spettacolo dal vivo, la musica, il teatro, la danza hanno e possono andare a braccetto con progetti laboratoriali con

63 Il progetto
Questo spazio può ospitare tanti tipi di laboratori e messa in scena dal teatro off al contemporaneo
scopi sociali. Una interazione con Enti, Università, Accademia e tutto ciò che possa avere un’afferenza con quanto qui si studia e si realizza».
E le unità abitative?
«Questo spazio è stato premiato anche da un bando, indetto dal Ministero per le infrastrutture e mobilità sostenibili nell’ambito del programma nazionale della Qualità dell’abitare, che vede coinvolti il Comune di Jesi, insieme ad altre realtà della Vallesina, Maiolati Spontini, Monte Roberto, Castelbellino, per il tramite della Regione Marche, un partenariato che ha per oggetto la “riqualificazione urbana”. Riqualificazione che può derivare anche da un contesto culturale che può qualificare quell’area. Questo bando, cui ha partecipato il Comune di Jesi, darà, se tutto si realizzerà, un volto nuovo, non solo socialmente più valido».
I tempi?
«Si è parlato del 2026, come dead line, la criticità in cui ci troviamo ha portato ad una forte inflazione e ad un aumento del costo delle materie prime, ciò sta mettendo un po' in crisi la previsione economica fatta quando era stato presentato il bando. Il piano di fattibilità prevedeva un importo di circa 3.800.000 euro di spesa. La progettazione è stata ora affidata e mira alla fase esecutiva ma credo che il progetto andrà un po' rivisto, senza che però che lo stesso perda la sua natura complessiva. In sostanza, mireremo a promuovere progetti ambiziosi anche fuori del mero respiro provincia-
le, posizionando Jesi in un asset del centro Italia per lo spettacolo dal vivo, validando l’ibridazione di pubblico e privato, con uno spazio verso la comunità che si arricchisce attraverso quello che i soggetti possono portare, in un progetto che il territorio deve sentire suo ed investirci sopra».

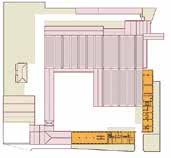
Cosa è significato il Festival 2022 per la Fondazione?
«I numeri sono buoni se paragonati al 2021, non allineati però al periodo pre covid. Oltre 4500 spettatori, l’incasso superiore del 60%, con circa 30 eventi in sessanta giorni. Una grande varietà nella proposta musicale, rivolta a tutti, proprio tutti. Cercheremo, nel futuro, di valorizzare i tanti luoghi di Jesi. Il Festival dovrà riguardare soprattutto la Vallesina ed accogliere, al contempo, un pubblico che viene da fuori. Abbinamento musica - vino, spensieratezza e accostamento col territorio, paesaggi e panorami. Possediamo un valore, prendiamone coscienza, comunichiamolo e promuoviamolo. Anche la crisi non ha aiutato le persone, attualmente il paniere delle famiglie è limitato ed a quel punto è possibile anche che alcuni tirino le somme e si rimettano un po' in riga nell’affrontare la stagione invernale. Ho visto gente che ha dovuto “scegliere” fra un appuntamento ed un altro, anche se magari tutti e due potevano essere di interesse». Restiamo sempre in attesa che la crisi, come diceva Edoardo, “ha da passà a nuttata”. ¤
64 Il progetto
Non solo teatro ma convegni, mostre e spazio-cinema posizionando Jesi in un asset del centro Italia per lo spettacolo
In alto le piantine del primo e secondo piano del progetto relativo all'ex cascamificio di Jesi
Messaggi di pace dal Premio Fabriano
“Èuna delle poche occasioni in cui veramente, partecipando, si impara”. E’ riassunto in questa frase il senso più vero, più profondo del Premio Nazionale “Gentile da Fabriano”, consegnato come è da tradizione, con una grande iniziativa pubblica nella città della Carta La frase è stata pronunciata da Andrea Pontremoli, nel 2020, nel corso della XXIV edizione del Premio. Imprenditore e manager, Andrea Pontremoli dal 2007 è amministratore delegato e socio di “Dallara Automobili” con la quale ha contribuito a realizzare la “motor valley” dell’Emilia Romagna, un distretto industriale d’eccellenza del quale fanno parte marchi prestigiosi quali Ferrari, Maserati, Lamborghini e Ducati.

Non una semplice passerella come ce ne sono tante e come siamo abituati a vedere in una regione vivace

dai mille borghi e dalle mille iniziative con personaggi più o meno noti del panorama nazionale, appartenenti, come si dice in questi casi, al cosiddetto star system. Ma una iniziativa che si è andata caratterizzando nel tempo sul piano scientifico e culturale come una giornata di riflessione, di approfondimento secondo particolari punti di osservazione tenendo conto dei temi scelti per l’occasione e sviluppati poi dai premiati. E si è trattato sempre di argomenti di grande attualità.
Ne nascono così momenti importanti, sicuramente interessanti con spunti particolari per conoscere l’oggi, il quotidiano, ma soprattutto per conoscere quale potrà essere il futuro che ci attende.
E l’argomento di questa 26esima edizione non poteva che essere “Dopo la Guerra”, cioè che mondo possiamo pensare, come costruirlo quando, e auspichiamo il prima possibile, cesseranno i combattimenti che stanno insanguinando il cuore dell’Europa. Insomma, che dopoguerra ci aspetta: un multilateralismo costruito sul reciproco rispetto, lo stato di diritto, l’accoglienza e la solidarietà? Oppure un mondo diviso ancora per “blocchi” contrapposti, dove contano solo la forza delle armi e con un nuovo possibile scontro tra Occidente e Oriente?
Argomenti forti, impegnativi, come di peso sono stati i premiati di quest’anno, come lo sono stati, del resto, quelli delle passate edizioni. Pensare cosa sarà il dopo
65 La manifestazione | 1
“DOPO LA GUERRA”, IL TEMA DI QUESTA 26ESIMA EDIZIONE
di Claudio Sargenti
Nella pagina precedente panoramica del teatro "Gentile da Fabriano" che ha ospitato la manifestazione della 26edizione del Premio nazionale intitolato al pittore fabrianese
Sopra, Giorgia Cardinaletti, fabrianese giornalista e "volto" del Tg/1 che ha presentato la giornata

In alto, Franco Bernabè, economista e manager d'impresa, tra i premiati; l'intervento di Andrea Riccardi fondatore della Comunità di Sant'Egidio e nella foto ufficiale al centro il prof. Galliano Crinella, direttore dell'iniziativa con i premiati e alcuni membri della giuria
la guerra, è già un messaggio di pace. Perché, è la notizia chiara e forte che viene da Fabriano, non dobbiamo e non possiamo perdere la speranza per il futuro.
Del resto, il “Premio Gentile da Fabriano” nasce dall’intuizione e dall’iniziativa di due visionari pensatori, il Rettore dell’Università di Urbino e senatore a vita Carlo Bo con a fianco un altro personaggio di grande spessore, un filosofo illuminato, un grande umanista come Galliano Crinella che ne è ancora l’animatore e il direttore.
Una manifestazione che si avvale fin dalla prima edizione, nel lontano 1997, dell’Alto Patronato della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del ministero della Cultura, insieme a quello della Regione, del Comune di Fabriano e dell’Unione Montana dell’Esino Frasassi.
La Giuria, composta anch’essa da figure autorevoli del mondo della cultura, delle professioni e dell’imprenditoria, le migliori espressioni del territorio è presieduta dall’attuale Rettore dell’Università di Urbino, Giorgio Calcagnini.
Dunque, uno sguardo al presente, pensando al futuro, senza dimenticare però il nostro passato, nella consapevolezza, come diceva un grande del giornalismo Indro Montanelli, “…che senza passato non c’è futuro”.
E il Premio quest’anno, con il tema del “Dopo la Guerra”, non poteva non aprirsi con un ricordo di Piero Angela, un altro grande giornalista e divulgatore scientifico, scomparso di recente e premiato a Fabriano giusto dieci anni fa, nel 2012.

Quel Piero Angela, che ha fatto della ricerca spiegata in maniera comprensibile a tutti, utilizzando il mez-
zo televisivo quello cioè più popolare, quasi un suo impegno civile, sicuramente la sua cifra stilistica e professionale, tanto da voler comunque concludere caparbiamente un nuovo ciclo di trasmissioni, prima di accomiatarsi dal suo pubblico, sapendo comunque che il suo destino era già segnato.
E veniamo al Premio di quest’anno. Sono sei le sezioni in cui si è articolato, per ognuna delle quali sono stati scelti personaggi che hanno “costruito”, realizzato molto e quindi avevano molto da raccontare.
Per la sezione “Officina Marchigiana” la scelta è caduta su Andrea Angeli, maceratese, già inviato dell’Onu, con alle spalle molte missioni di pace che lo hanno visto sempre in ruoli di primo piano in contesti difficili e pericolosi, come possono essere i teatri di guerra.
Per la sezione “Carlo Bo, per la cultura, l’arte e la comunicazione” è stata pre-
66 La manifestazione | 1
(Photo Studio Cico Fabriano)
Il premio si è aperto con un ricordo di Piero Angela grande giornalistica e divulgatore scientifico scomparso di recente
miata Marta Dassù, direttrice di Aspenia”, esperta di politica internazionale e direttrice della Rivista dell’Aspen Institute.
E ancora. Nella sezione “Scienza Salute e Ambiente” il riconoscimento è andato a Federico Rosei, scienziato, studioso di nanoscienze e nanotecnologie, docente all’Università del Quebec.
A Rossella Miccio, presidente di Emergency è andato il premio sezione “Vite di Italiani”. Rossella Miccio, nella Organizzazione non Governativa di Gino Strada dal 2000 ne è diventata Presidente del 2017 al momento della scomparsa del suo fondatore.

Nello schermo, presentando l’ospite, sono scorse immagini molto forti (ogni premiato, lo ricordiamo, è presentato con un breve filmato) quelle girate in uno dei tanti centri ospedalieri di Emergency (ne ha 70 sparsi in tutto il mondo dove sono impegnati alme-


no 3 mila volontari che hanno prestato soccorso a 12 milioni di persone).
Sono immagini dure quella proiettate, a volte anche crude perché raccontano la guerra dal di dentro, dalla parte della popolazione civile, delle donne, degli anziani, dei bambini. E poi quella voce di Gino Strada e quella frase netta … “la guerra è una malattia stupida e folle”.
Nella sezione “Economia, Lavoro e Innovazione”, la scelta è caduta su Franco Bernabè, economista, manager d’impresa che ha avuto incarichi di prestigio e responsabilità in grandi aziende come Fiat, Eni, Telecom Italia.
Si è soffermato sui pericoli che andiamo incontro con la guerra parallela a quella combattuta sul terreno, ovvero la guerra dell’energia con i prezzi ormai arrivati alle stelle e che peseranno sulle nostre famiglie e sulle nostre imprese e sullo svi-
Riconoscimenti assegnati
ad Andrea Angeli Marta Dassù
Federico Rosei
Rosella Miccio e Franco Bernabè
67 La manifestazione | 1
Premio

speciale della giuria ad Andrea Riccardi già ministro e fondatore della Comunità di Sant’Egidio
luppo del nostro Paese
Infine, il premio “Speciale della Giuria” è stato assegnato ad Andrea Riccardi, storico, studioso della Chiesa, già ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione, ma soprattutto fondatore della Comunità di Sant’Egidio da sempre a fianco dei più poveri e degli ultimi.



A lui e alla sua Comunità si devono ad esempio la pace in Mozambico o l’istituzione dei cosiddetti corridoi umanitari che hanno portato in
sicurezza migliaia di richiedenti asilo.
La Giuria appunto.
Ne fanno parte, dicevamo, figure autorevoli esponenti del mondo della cultura, delle professioni e dell’impresa alcuni dei quali sono diventati nuovi e moderni mecenati del territorio della Vallesina e del Fabrianese.
Annunciato al termine della giornata il tema della prossima edizione del premio “La conservazione della terra e i mutamenti climatici.” ¤


68 La manifestazione | 1
Dall'alto in basso e da sinistra a destra: Andrea Angeli, Marta Dassù; Federico Rosei, Andrea Riccardi; Rossella Miccio, Franco Bernabè I sei ricevono il Premio "Gentile da Fabriano" dalle mani del Rettore dell'Università di Urbino prof. Giorgio Calcagnini
(Photo Studio Cico Fabriano)
di Claudio Sargenti
Arte, cultura e imprese occasione di dialogo
TANTI MONDI PRESENTI AL PREMIO GENTILE DA FABRIANO
Il Premio nazionale “Gentile da Fabriano” nasce nel 1997 da un felice incontro tra il professor Carlo Bo, critico letterario, saggista e intellettuale tra i più apprezzati fin dagli anni ’30 del Novecento, Rettore dell’Università di Urbino, senatore a vita e ultimo “duca” del Montefeltro, come veniva chiamato all’epoca, e Galliano Crinella, anche lui docente universitario, fine filosofo, umanista illuminato, appassionato studioso, profondo conoscitore nonché animatore culturale e amante del territorio fabrianese.
Non per niente il Premio, divenuto subito un grande evento nel panorama marchigiano, ha avuto come punto di riferimento non solo Gentile da Fabriano, un grande artista vanto e gloria del nostro Paese, ma ha trovato ospitalità in una delle città a quel tempo tra le più industriali del Centro Italia.
Fin dall’inizio i membri della giuria sono stati scelti tra le migliori espressioni dell’imprenditoria e del mondo degli intellettuali. Solo per citare alcuni nomi: Francesco Merloni, Pietro Zampetti, Valeria Moriconi, Giovanni Bogliolo.
Il filo conduttore del Premio, che è poi proseguito nel corso degli anni e che si è articolato in varie sezioni, è quello di dare vita non ad una manifestazione fine a se stessa, ma ad un’iniziativa che deve servire anche a far riflettere, mettendo in relazione il mondo dell’imprenditoria con quello del lavoro, senza dimenticare sia l’aspetto culturale che l’attualità con uno sguardo rivolto al futuro.
Nelle varie sezioni in cui si articola il Premio, sono presenti tre mondi che possono dialogare e trovare significativi punti di contatto. Tre ambiti: la cultura, l’impresa e le istituzioni pubbliche che, secondo gli organizzatori, potrebbero, anzi, dovrebbero maggiormente interagire creando più ampie sinergie per affrontare con maggiore forza i problemi della società complessa.
Nelle 26 edizioni sono stati assegnati almeno 140 riconoscimenti a grandi personaggi della vita istituzionale (Tina Anselmi e Guido Bertolaso); ai migliori imprenditori, molti dei quali proprio marchigiani (Gennaro Pieralisi, Vittorio Merloni, Orietta Varnelli, Oscar Farinetti, Alberto Ferretti, Piero Gnudi, Fabio Biondi, Iginio Straffi, Enrico Loccioni). Senza dimenticare il mondo del teatro e del cinema (Saverio Marconi, Alberto Ciambricco, Pupi Avati, Monica Guerritore); premi Oscar (Ennio Morriconi e Dante Ferretti); il mondo della cultura inteso nel senso più ampio (Tullio Pericoli, Eliseo Mattiacci, Antonio Paolucci); senza perdere di vista il mondo dello spettacolo e della televisione (Antonio Ricci e Ezio Greggio); medici che si sono impegnati nella ricerca (Carlo Urbani alla memoria); grandi giornalisti che hanno fatto la storia dell’informazione (da Piero Angela a Enzo Biagi, Sergio Zavoli e Ferrucci De Bortoli). Ma anche istituzioni altamente meritorie come la Lega del Filo d’Oro, l’Ordine dei Frati Minori, Medici Senza Frontiere, Emergency. Infine, non si può non citare la pattuglia Acro-
69 La manifestazione | 2
In queste 26 edizioni oltre 140 attestati a studiosi, artisti giornalisti professionisti e personaggi della vita istituzionale
batica Nazionale delle Frecce Tricolori.
Ma è praticamente impossibile citare tutti i premiati. Abbiamo solo voluto nominarne alcuni tra i più conosciuti e popolari al grande pubblico.
“
Il Premio, si legge nel suo regolamento, intende fornire in ogni sua edizione un’ampia e rigorosa rappresentazione dell’operosità e dei valori positivi espressi dalla comunità nazionale e dalle Marche, individuando anche, ove possibile un tema generale al quale ricondurre le figure e le esperienze dei premiati”.
“Credo che il Premio – è il commento di Galliano Crinella, direttore generale e artefice principe della manifestazione fabrianese – abbia guadagnato gradualmente la considerazione e l’attenzione che ne fanno uno degli eventi più significativi del settore, almeno nella nostra regione.”
“Abbiamo cercato – sono ancora sue parole – di fare un lavoro rigoroso, puntuale, non senza difficoltà ed anche faticoso per l’esiguità delle forze in campo. Riteniamo che sia stato e continui ad essere – conclude il direttore del Premio – un segno di vitalità dell’entroterra anconetano e delle Marche della volontà di portare un contributo di ordine culturale, ma che chiami in causa anche gli studiosi impegnati nella ricerca scientifica, economisti ed imprenditori, artisti, operatori della comunicazione e del volontariato attivo.”
Fin qui la storia e le finalità del Premio. Ma ci piace concludere con una frase di Vittorino Andreoli, psichiatra, scrittore e illustre acca-
demico italiano, premiato a Fabriano nell’edizione 2019 che aveva per tema “L’Infinita Bellezza”.
“Bellezza – ha detto - è una delle parole del nostro vocabolario che per quanto la si analizzi, rimane misteriosa. Sembra che vi sia sempre qualcosa da aggiungere e che per quanto la si arricchisca di senso rimanga incompleta. Fedor Dostoevskij – prosegue - mette nella bocca del principe Myskin, ne “l’Idiota” l’espressione “la bellezza salverà il mondo”. Non chiarisce – chiosa Andreoli - quale bellezza.”
Ecco, in uno dei momenti più bui e più difficili della nostra storia recente, con una guerra non molto distante dai confini del nostro Pese e che ci minaccia direttamente, al termine (forse) di una lunga e devastante pandemia che ci ha profondamente cambiati, con rivolgimenti climatici che hanno portato lutti e rovine anche nel nostro territorio, solo la “bellezza”, quella vera e autentica, ci può scaldare l’animo e darci ancora speranza e fiducia per il nostro futuro.
Mentre premi come quelli organizzati a Fabriano ci aiutano a pensare, provano ad indicarci dove possiamo e dobbiamo andare. E intanto il filosofo visionario come Galliano Crinella insieme alla sua squadra con in testa il Rettore dell’Università di Urbino Giorgio Calcagnini e un gruppo di intellettuali e imprenditori, divenuti ormai novelli mecenati, sono già al lavoro per preparare l’edizione numero 27. Perché al Premio, nonostante tutto, non è permesso fermarsi. Mai. ¤
70 La manifestazione | 2
Il filo conduttore è far riflettere mettendo in relazione tante figure professionali con uno sguardo rivolto al futuro
Ventisei ore in coda per un posto a teatro
Settantacinque anni di teatro, un viaggio che dalla Pesaro del dopoguerra arriva all’era digitale. Il Festival Nazionale d'Arte Drammatica toccato i 75 anni di ininterrotta attività, confermandosi la più antica manifestazione teatrale italiana e uno degli appuntamenti culturali fondamentali per la città di Pesaro e non solo.
Si parla di compagnie amatoriali, ma che esprimono tutta la passione di un intero paese verso il teatro. E lo fanno oggi ancora di più, in un’epoca in cui i contenuti video sono alla portata di tutti, on demand, in tv e sui cellulari. Ma lo spettacolo dal vivo appassiona, coinvolge, incolla le platee. E le compagnie che propongono gli spettacoli sono sempre in crescita.
Un percorso attraverso i decenni, a partire dal 1947, raccontato anche da Giovanni Paccapelo per i “Quaderni pesaresi”. La guerra è da poco finita, ma la voglia di normalità è tanta che nasce il Festival che all’epoca si chiamava “Concorso Filodrammatico Interregionale” al quale parteciparono 12 compagnie. L’accoglienza è strepitosa a livello nazionale tale da attirare un pubblico da tutta Italia. Nel 1948, con la prima edizione del “Festival delle filodrammatiche”, i giornali titolano: «Il Rossini preso d’assalto» e narrano delle file per accaparrarsi i biglietti. Oltre alla storia di un “tale” che si era presentato alle 2,30 per essere il primo della fila.
Il Festival cresce e la sua fama è nota in tutta Italia.
Gli anni ’50 sono un successo e stabiliscono il record di attesa degli uomini in fila per i biglietti: 26 ore in coda. E va in scena anche una compagnia di Nizza, il Cercle Moliere. Il Gad diventa internazionale.
I decenni passano e il Festival ormai è un punto fermo per Pesaro e per gli spettacoli teatrali delle compagnie amatoriali. Maurizio Sebastiani Presidente Associazione Amici della Prosa racconta: «La città festeggia le nozze di diamante con il Gad. Nel panorama italiano è il momento più importante per le compagnie amatoriali.
La qualità è altissima e c’è tanto interesse a partecipare alle edizioni. I premi sono molto ambiti e riconosciuti. Questa città fa del teatro amatoriale un punto di riferimento culturale ed è uno dei punti di forza del conseguimento del riconoscimento di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Dopo il Rof e la Mostra del cinema, rappresenta un’espressione artistica notevole. Questo grazie anche al volontariato e al sostegno dell’amministrazione comunale».
Non solo spettacoli e premi, c’è anche dato sociologico. «Il teatro è la vita di una comunità, sin dall’antichità fino ai giorni nostri. Basti pensare che tantissimi giovani frequentano il Gad e partecipano agli spettacoli come attori e spettatori. L'Associazione Amici della Prosa considera centrale nelle proprie azioni l'opera di formazione e di avvicinamento dei giovani al Teatro. Sono tante le iniziative

71 Nozze d’argento sul palco
PASSIONE IMMUTATA PER IL GAD, OGGI COME NEGLI ANNI ‘50
Il Festival nazionale d’arte drammatica nasce a Pesaro nel lontano 1947 ed è la più antica manifestazione teatrale italiana
di Luigi Benelli
messe in atto a tal fine, ad iniziare da un'attenta politica sui prezzi per proseguire con l'attivazione di corsi, conversazioni, laboratori e tanto altro. Tutto lavoro che viene ripagato dai numeri: il Festival GAD di Pesaro vanta una affollatissima presenza di giovani ai suoi spettacoli al punto di potersi ritenere il Festival con il pubblico più giovane d'Italia.

Le compagnie sono impressionate da questo aspetto che si estrinseca anche con il premio della Giuria
della modernità e del digitale perché non vogliamo farne a meno, ma senza trascurare il glorioso passato. L’obiettivo è coniugare i due elementi e il fatto che gran parte del pubblico sia giovane è la dimostrazione della riuscita del progetto. Siamo molto attivi sui canali social e il progetto “Oh My Gad” nasce nelle scuole superiori affinché i ragazzi possano rendersi autonomi nell’organizzazione delle attività di comunicazione di una manifestazione artistica. Gli studenti hanno così dato vita ad una vera e propria redazione interna al Festival per poter promuovere la manifestazione nei canali che più appartengono al linguaggio dei giovani, quello dei video, del digitale e dei social».
Giovani. Questo è importante anche per la preparazione di un futuro pubblico di giovani».
Nell’edizione appena conclusa Pesaro ha ospitato, al Teatro Sperimentale, otto compagnie nazionali in concorso, due spettacoli del GadFestival Ragazzi, uno spettacolo concerto per i 100 anni della nascita di Renata Tebaldi e la messinscena del testo vincitore della III edizione del Premio Drammaturgico "Conti".
Il direttore artistico Christian Della Chiara sottolinea l’evoluzione del Festival nei decenni: «La sfida più importante e affascinante è guardare agli strumenti

Modernità e tradizione che si intersecano. «Anche quest’anno abbiamo avuto 85 proposte di spettacoli da selezionare (erano 130 prima del covid). Negli anni è cambiato il metodo: ora la giuria sceglie le compagnie tramite video di presentazione.
Decenni fa, si girava l’Italia per vedere in loco gli spettacoli. Quanto ai linguaggi, vogliamo abbattere tutte le barriere percepite tra il teatro dei professionisti e non perché sono espressioni dello stesso mondo. E abbiamo accolto anche proposte che in passato non rientravano nelle linee editoriali come spettacoli musicali, monologhi e mimi allargando l’attenzione a tutte le esibizioni dal vivo, segno di un Festival che evolve e sta al passo coi tempi». ¤
72 Nozze d’argento sul palco
La rassegna dal dopoguerra all’era digitale diventa importante riferimento culturale con affollatissima presenza di giovani
In alto, Maurizio Sebastiani Sotto, il presidente con lo staff degli "Amici della prosa" di Pesaro
La rivista Marche ‘70 nasce alla fine del 1967 per iniziativa di un gruppo di giovani intellettuali gravitanti nell’area politica che oggi definiremmo di centrosinistra, nel periodo culturalmente vivace in cui si andava prefigurando il modello della nascente Regione Marche. I componenti del gruppo erano anche definiti “i kennediani”, perché incarnavano quel fervente dibattito che animava il clima politico mondiale: le aperture al confronto tra Usa e Ursstra Kennedy e Krusciov - le novità conciliari di Giovanni XXIII, le prove di dialogo tra il mondo occidentale e la Cina avevano avuto un riflesso anche nella nostra regione. I presupposti culturali del modello sociale si fondavano sull’analisi delle dinamiche economiche e demografiche, su alcuni temi politici e sociologici evidenziati dall’enciclica Pacem in Terris: il diritto per tutti ad avere una vita dignitosa, serena e priva di conflitti in un contesto di pace politica e sociale. La crisi del sistema agricolo, il miraggio di un miglioramento delle condizioni di vita legato allo sviluppo industriale, lo sradicamento delle popolazioni e il loro trasferimento verso quelle aree maggiormente dotate di infrastrutturedunque più consone allo sviluppo economico del settore secondario - stavano impoverendo l’entroterra della regione, che tendeva ad una condizione, si diceva allora, di “meridionalizzazione”. Si stava prospettando l’innesco di quel meccanismo di

squilibrio sempre maggiore nell’assetto regionale, che avrebbe prodotto le conseguenze negative che oggi lamentiamo.
L’intento dei kennediani era quello di porre un freno a questa tendenza, mettendo in campo una serie di contromisure organiche nella programmazione territoriale della Regione Marche in via di costituzione. La misura legislativa a cui, in parte, fare appello era la legge 614 del 22 luglio 1966, finalizzata a realizzare Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, mentre la programmazione delle nuove regioni era stata affidata dal legislatore nazionale ai C.r.p.e. (Comitati regionali per la programmazione economica). Il Comitato marchigiano si avvaleva della principale consulenza dell’I.s.s.e.m. (Istituto studi sviluppo economico delle Marche), emanazione degli enti locali territoriali che, fondato nel 1963, aveva iniziato a operare l’anno successivo con principale riferimento scientifico nella Facoltà di Economia e commercio anconetana, allora sede decentrata dell'università di Urbino. Un ruolo rilevante ebbe anche la sede marchigiana dell’U.p.i., (Unione delle province Italiane). Il dialogo e la contrapposizione di idee fra questi istituti, i partiti politici, i poteri forti - economici e non solo - fu aspro ed emerge chiaramente dalle pagine della rivista.
Il modello immaginato aveva il nome-slogan di “Città Regione” secondo uno
73 Marche ‘70
Il modello immaginato da un gruppo di intellettuali in una storica rivista ipotizzava temi di politica, cultura economia e ambiente
di Luca Maria Cristini
I giovani “kennediani” e l’idea di città regione
VOLEVANO FRENARE LO SPOPOLAMENTO DELL’ENTROTERRA
schema che prevedeva la creazione di «una grande città di 1.400.000 abitanti integrata nel contesto nazionale europeo e mondiale». I cardini su cui si basava l’idea degli intellettuali di Marche ’70 era un’infrastrutturazione viaria a maglia e la costituzione di “Comprensori”, ovvero di unità territoriali omogenee che avrebbero dovuto condividere alcuni servizi non più sostenibili a livello dei singoli comuni. Le principali battaglie sostenute attraverso la rivista, per quanto concerne le infrastrutture stradali, furono quelle per l’arretramento dell’Autostrada del Levante e per la realizzazione di un’arteria stradale di livello interregionale a ridosso della catena appenninica, la “Pedemontana”.
Ma Marche ’70, il cui sottotitolo era “rivista mensile di politica, cultura, economia” non era solo questo: vi si trattavano anche tematiche legate alla modernizzazione delle attività produttive agricole, artigianali, industriali, al vivace mondo dell’arte, all’organizzazione dell’università e della scuola, a questioni relative ai riflessi del Concilio Vaticano Secondo e - in tempi addirittura pioneristici - al rispetto e alla tutela dell’ambiente. Tra le tante proposte per la regione avanzate attraverso la rivista, c’era anche uno schema, elaborato da Luigi Cristini e Alberto Pellegrino sulla base di approfondite analisi, per la riorganizzazione dell’Università delle Marche, con la proposta di ammodernamento dei moduli didattici e la razionalizzazione delle sedi sul territorio, introducendo nel sistema le facoltà mancanti ed eliminando i doppioni. Angelo Antonio Bittarelli, nel 1969, scriveva un illuminante contributo dedicato all’istituzione del Parco dei
Sibillini e Achille Alba aveva lanciato i primi allarmi sugli effetti nefasti dell’inquinamento marino. Memorabili sono poi gli interventi di Alberto Pellegrino sugli esiti conciliari e i ritratti d’artista di Elverio Maurizi e dello stesso Achille Alba.
La “città Regione”
Il concetto di “Città Regione” è stato, come già accennato, il tema chiave di Marche ’70 come è chiaramente enunciato nel lungo editoriale a firma di Luigi Cristini nel primo numero del dicembre 1967, un testo che può essere considerato il manifesto programmatico dell’azione e delle finalità dei redattori e degli autori del periodico.
Cosa sia la Città Regione viene chiarito facendo un parallelo tra Lazio e Marche. La prima, in conseguenza della presenza di una megalopoli come Roma, è costituita da tante più piccole città satelliti gravitanti intorno ad essa, per cui può esser considerata il prototipo di “Regione Città”. Per le Marche - che, al contrario, sono la quintessenza del policentrismo, frutto dei Liberi comuni medievali – va ipotizzato il modello teorico di Città Regione, ovvero di una grande città in termini numerici, spalmata su di un ampio territorio, quasi per nulla storicamente gerarchizzato. Questo antico assetto, nella visione dei collaboratori del mensile, rischiava però di essere sovvertito, dal fenomeno di inurbamento delle popolazioni, attirate da nuove forme di lavoro che, a causa di una più spinta infrastrutturazione, vanno localizzandosi al margine orientale della regione. Come si è detto, lo sradicamento delle persone dall’entroterra verso le zone

74 Marche ‘70
Nella pubblicazione autorevoli interventi proponevano una modernizzazione nella programmazione dei vari settori sociali produttivi e didattici
‘70
marine avrebbe impoverito le aree interne e creato una lunga congestionata conurbazione lungo la costa. Secondo gli intellettuali di Marche ’70 questo fenomeno deve essere contrastato con tutte le forze, se non per arrestarlo, almeno per attutirne gli effetti.
Lo strumento è, nella visione degli autori, un modello di pianificazione territoriale che avrebbe reso indifferente la localizzazione di nuove attività produttive in ogni luogo della regione, in virtù di una omogenea dotazione infrastrutturale. Per ottenere questo risultato si deve quindi creare una maglia stradale efficiente e moderna che copra ogni punto del territorio. Le Marche, si sostiene, hanno una configurazione orografica che la rendono simile a un pettine: l’Appennino ne costituisce il dorso montuoso da cui si dipartono tanti denti, che sono i crinali collinari nei cui interspazi scorrono i fiumi. Le strade che innervano storicamente la regione, per ovvii motivi e salvo l’eccezione della Via Septempedana, si distendono sui fondovalle e collegano i territori in direzione est-ovest. Solo negli ultimi secoli - allorché i territori in prossimità del mare, un tempo malsani e paludosi, furono bonificati - si è avuto un raccordo di queste strade vallive anche in area costiera. Nell’entroterra questo è avvenuto mediante tortuose strade collinari. La grande direttrice costituita dalla via Flaminia - che per la gran parte del tracciato interessato corre in territorio umbro - è il principale collettore a cui le strade vallive si raccordano per raggiungere il versante tirrenico, soprattutto attraverso i valichi più agevoli della catena appenninica. Secondo il modello di Città Regione, la rete stradale
ottimale per uno sviluppo equilibrato delle Marche avrebbe dovuto prevedere una strada “Pedemontana”, in posizione simmetrica, rispetto all’asse della catena montuosa e della via consolare Flaminia, direttrice pedeappenninica occidentale. Alla Pedemontana e a una Pedecollinare - con la medesima funzione e situata nella linea media della regione (sulla direttrice Macerata - Jesi) - si sarebbero dovute raccordare le strade vallive. A completare e razionalizzare la maglia, si prevede un’autostrada più interna rispetto alle infrastrutture già esistenti, ovvero alla Statale Adriatica e alla ferrovia Milano-Lecce.
Per quanto riguarda l’assetto amministrativo, gli intellettuali della rivista propongono e adattano un modello già teorizzato e in corso di studio in alcune province italiane (Bologna, Milano, Trento, Torino, Venezia). Claudio Bisconti per primo analizza su Marche ’70 (n. 1/1967) le problematiche cui devono far fronte i comuni di piccole dimensioni: l’esiguità economica non permette di avere servizi che siano al passo con le aspettative, per cui si verifica uno spreco di risorse con il risultato di avere anche minore efficienza. Si delinea pertanto l’esigenza di consorziare alcuni asset, facendo riferimento a sperimentazioni già in atto in altre regioni. In linea di massima e con le dovute eccezioni, si individua un triplice livello organizzativo: il Comune, unità di base, cui spettano asili infantili, scuole elementari, fognature, strade interne degli abitati, cimiteri. Al livello intermedio è un’Unità insediativa (4/5.000 abitanti) in grado di gestire in modo più razionale ed economico le funzioni di scuola me-

75 Marche
Due immagini di Luigi Cristini uno degli autori della rivista Marche '70 e teorico della "Città Regione"
Tra le battaglie sostenute dalla rivista c’era quella dell’arretramento dell’autostrada e la realizzazione della Pedemontana
dia, stato civile, segretaria comunale, anagrafe, servizio medico di base e ostetrico. L’ambito più ampio (30/40.000 abitanti) è infine costituito dal Comprensorio, al quale competono le scuole di livello superiore, gli uffici tecnici, il servizio antincendio, i servizi di tesoreria ed esattoria, i servizi sociali. Solo per fare un esempio relativo all’ottimizzazione, Bisconti valuta che per i 191 comuni delle Marche al di sotto dei 5000 abitanti, con una popolazione complessiva di 417.000 unità (dato riferito al 1965), possono essere sufficienti dagli 80 ai 100 segretari comunali, dunque quasi la metà di quelli in servizio in quel momento. La stessa cosa si può dire per i medici di base, per le ostetriche e per altri funzionari degli enti pubblici. Tutto questo nell’ottica di una razionalizzazione dei servizi, fermo restando però, precisa l’autore, che queste condivisioni funzionali non devono provocare alcuna fusione d’imperio degli enti locali minori, che possono invece mantenere la propria identità. Scrive ancora l’aurore: «Ogni comunità ha una propria ragione d’essere reale, legata a cause d’ordine storico, sociologico e perfino geografico che non possono essere cancellate o ignorate con atti d’autorità. Sarà compito proprio di questa generazione di amministratori promuovere una nuova realtà istituzionale degli enti locali nel moderno clima di efficienza e produttività, perché l’autonomia non sia una vuota parola». Le basi teoriche dello sviluppo comprensoriale della Regione Marche sono sostenute anche dagli interventi su Marche ’70 di Luigi Mercuri e Guido Bianchini sul n. 10-11/1969 della rivista. Il modello comprensoriale, in qualche modo già
prefigurato dal Crpe, sulla rivista viene approfondito, spingendosi a delimitare gli ambiti di ventuno “macro comuni”, disegnati in base alla contiguità territoriale, alla quantità di popolazione, all’omogeneità storico-culturale. Questi comprensori devono poi fare riferimento a sei unità metropolitane, ridefinite in ragione del nuovo assetto comprensoriale, che avrebbero dovuto comportare il superamento e la modernizzazione degli enti provinciali ancora sclerotizzati sulla matrice napoleonica. Il modello di Città Regione ha, come si è detto, riguarda anche l’organizzazione dei servizi dell’istruzione e delle attività culturali, considerati essenziali per una crescita armonica e partecipativa della cittadinanza.
L'analisi della situazione scolastica regionale è condotta per Marche ’70 da Alberto Pellegrino e restituisce una situazione problematica, con la presenza di pluriclassi e scuole sussidiate, lacune che, rifacendosi al pensiero di Don Lorenzo Milani, penalizzavano le famiglie più disagiate. La soluzione individuata è l'eliminazione delle pluriclassi, la realizzazione di edifici adeguati e l'istituzione del doposcuola che avrebbe aiutato chi sarebbe rimasto indietro. Per quanto concerne la scuola superiore, per evitare la polverizzazione che si era determinata, è necessario, secondo Pellegrino, adottare anche qui uno sviluppo su base comprensoriale, ottimizzando bacini di utenza per poter garantire infrastrutture moderne e qualità dell’insegnamento. Un'efficace modernizzazione del sistema dell'istruzione non poteva prescindere, poi, dalla razionalizzazione a livello regionale del sistema bibliotecario, anche questo pensato nella logica dei

76 Marche ‘70
Qui sopra, la copertina del primo numero della rivista mensile "Marche '70" uscita nel 1967
A destra, il progetto sullo sviluppo diffuso degli insediamenti produttivi nella regione
L’idea chiave lanciata nel 1967 era di “città regione” ovvero un modello di grande città spalmata su un ampio territorio
comprensori. Questo non è più visto nella limitante ottica di un mero sistema di conservazione e distribuzione del patrimonio librario, ma pensato come soggetto attivo nella promozione culturale. È lo stesso Alberto Pellegrino che sulle pagine della rivista affronta, poi, la questione relativa al teatro nelle Marche. Al tempo si contavano poche sale attive e nessuna compagnia stabile, essendo la prosa nella nostra regione per lo più appannaggio del Teatro Stabile dell'Aquila. La proposta è quella di riabilitare e rimettere in funzione i molti teatri storici esistenti nelle città marchigiane - allora per lo più fatiscenti o ridotti a sale cinematografichepromuovere anche nella regione produzioni autonome mediante la graduale nascita di una compagnia stabile e creare un organismo di coordinamento dell'attività, prefigurando, di fatto, la nascita di quella che è attualmente l’Amat (Associazione Marchigiana Attività Teatrali).
L’arretramento dell’autostrada
Uno dei punti qualificanti nella proposta dei pianificatori di Marche ’70 riguardava il posizionamento regionale dell’Autostrada del Levante, come era allora definita l’autostrada A 14. Dopo l’approvazione del primo progetto di massima nel 1959-60, l’architetto Paolo Castelli già nel 1962 aveva segnalato quanto fosse inopportuno relegare l’autostrada sul margine orientale della regione, in un’area costiera dove l’infrastrutturazione era già costituita dalla strada adriatica e dalla ferrovia. La nuova via di comunicazione avrebbe costituito un’ulteriore barriera tra le città costiere e
le loro naturali aree di sviluppo e avrebbe prodotto danni ad ambienti naturali di pregio. Con l’arretramento di alcuni chilometri si sarebbe potuta preservare l'area litorale; la nuova strada avrebbe inoltre portato il suo vitale apporto a un territorio di superficie doppia, che si estendeva simmetricamente al di là e al di qua dell’asse viario. Se si fosse scelta la soluzione costiera, metà dell’area beneficiata da questo contributo sarebbe andata perduta e l’effetto positivo polverizzato. In quel tempo si stava realizzando il primo tratto di A 14 da Bologna alla provincia di Forlì, mentre era già in fase avanzata la progettazione di tutto l’asse autostradale.
Paolo Castelli, uno dei componenti più attivi della redazione, aveva stigmatizzato la scelta costiera sulla rivista Ingegneri-Architetti (n. 10-12, 1962) e le sue obiezioni vengono raccolte e articolate su Marche ’70. Poco dopo l’apertura del nuovo tratto autostradale da Rimini sud a Cattolica, nella rivista (n. 7-8 dell’agosto 1968) l’Autostrada!, nel quale si ricostruisce la vicenda progettuale della strada e si mettono a confronto le ragioni di quanti propendono per il tracciato marino e di coloro che ne chiedono l’arretramento. Tra questi c’è l’architetto Michele Valori, professore ordinario e direttore dell'Istituto Universitario di Urbanistica alla Sapienza, il quale aveva già elaborato una proposta progettuale alternativa mai presa in considerazione dall’Anas.
Le prime critiche, mosse da Paolo Castelli nel 1962, sono rilanciate a più riprese da Cristini in molti convegni che in quegli anni si tengono sull’argomento, a partire da quello del 1963 organizzato a San Severino Marche e dedicato alla

77 Marche
‘70
Lo strumento per evitare l’impoverimento dell’entroterra era creare una maglia stradale interna efficiente e moderna
Qui sopra, la cartina con la suddivisione del territorio in comprensori e sub aree regionali A destra, la griglia di mobilità tra l'autostrada e la Pedemontana
viabilità provinciale maceratese. A seguito delle forti pressioni, che provengono anche dai comuni rivieraschi, l’Unione delle Province fa elaborare una soluzione alternativa che prevede un arretramento del tratto Ancona sud-Pescara (che oggi è invocato a gran voce), considerando che anche l’Abruzzo propende per un tracciato più interno rispetto a quello costiero. Il progetto di massima viene presentato al Ministero dei Lavori Pubblici nel febbraio 1968, ma nessuno dei parlamentari marchigiani lo sostiene: gli onorevoli Tambroni e Foschi presentano anzi delle interrogazioni, affinché si accelerino le procedure per la costruzione della tratta autostradale così come proposta. Ripetutamente l’onorevole De Cocci, sottosegretario ai lavori pubblici fin dal 1959/60, spinge decisamente per la realizzazione del tracciato costiero progettato dall’Anas.
Le critiche mosse dai kennediani partono da precise motivazioni di tipo urbanistico: la costruzione di questa nuova arteria costituisce uno degli strumenti più potenti di cui si dispone per la realizzazione di una regione equilibrata e avrebbe per lungo tempo determinato le sorti di un vasto territorio. Per questo si richiede la massima ponderazione e condivisione. Una posizione più interna del tracciato autostradale avrebbe anche in parte sopperito alle funzioni dell’arteria pedecollinare, così come prefigurata nello schema viario della Città Regione e già indicato dal Provveditorato regionale per le opere pubbliche negli studi preliminari del Piano territoriale di coordinamento. Scrive Cristini: «Non può impunemente e senza enorme aggravio di costi sociali essere aggiunto un elemento
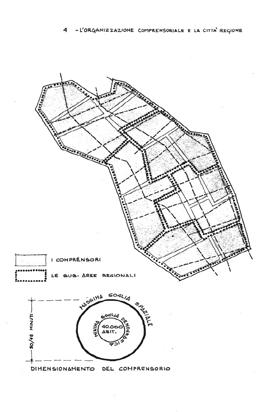
squilibrante della situazione regionale che registra nel suo entroterra paurosi cali demografici e un forte invecchiamento della popolazioni tali da proporre ormai chiaramente un fenomeno di meridionalizzazione all’interno della stessa area». Lo stesso urbanista obietta ancora: «il tracciato marino comprometterebbe irrimediabilmente ogni possibilità di valorizzazione turistica della costa, creando una barriera invalicabile che si andrebbe a sommare alla ferrovia e alla statale […] La realizzazione dell’autostrada accentuerebbe il fenomeno di esplosione demografica a cui sono già soggetti tutti i centri della riviera con l’inconveniente che verrebbero acuite tutte le patologie ormai note connesse al rapido inurbamento». Il risultato di questa scelta errata, secondo Cristini, avrebbe portato ad avere «una Regione ridotta ad un’amorfa striscia urbanizzata lungo tutta la costa».
Tra le confutazioni avanzate dall’Anas, pienamente condivise dall’Issem - da sempre schierato a supporto dell’ente, giudicando inaccettabile il tracciato del professor Valori - vi è la convinzione che l’entroterra sia fatalmente destinato allo spopolamento e che non è opportuno opporsi a questa tendenza in atto. Solo la fascia costiera della regione ha quelle effettive potenzialità di sviluppo che l’arteria è destinata a supportare. Tra le motivazioni ostative addotte c’è anche la convinzione che l’arretramento dell’asse stradale danneggerebbe l’economia turistica della riviera adriatica e, addirittura, l’assurda tesi che l’autostrada avrebbe contribuito a garantire come “una stupenda panoramica sul mare”.
Anas e Issem assumono
78 Marche ‘70
Proposto un assetto amministrativo a vantaggio dei piccoli comuni prevedendo modelli consorziati di alcuni asset
una posizione tetragona, mentre il Crpe, nelle proprie prime indicazioni sullo sviluppo regionale (1968), si limita genericamente ad auspicare “l’eliminazione degli squilibri socio-economici tra le diverse parti del territorio” criticando altresì “l’infelice collocazione delle grandi vie di comunicazione nelle Marche”. Non assume mai posizioni nette sul problema, non perdendo occasione, però, per raccomandare la rimozione di ogni ostacolo che potesse causare un “ritardo nell’entrata in funzione dell’Autostrada a Sud di Ancona”, fornendo un assist fondamentale a quanti propendono per l’autostrada sulla costa.
La questione dell’arretramento dell’autostrada viene affrontato sulle pagine di Marche ’70 (n. 9, 1968) con la testimonianza dell’architetto Walter Martigli di Livorno, che ha combattuto una battaglia contro l’analoga scelta fatta per l’autostrada Sestri-Livorno. Il Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, dopo avere valutato l’errore, stava addirittura pensando di declassare l’arteria per realizzarne un’altra più interna. Scrive Martigli: «Purtroppo interessi settoriali e l’abitudine (o meglio il vizio) di considerare i costi riferiti solo ai dati aziendali, senza gravarli degli oneri sociali, fanno sì che la voce di chi si concede il lusso di studiare i problemi in maniera globale venga sistematicamente disattesa».
Siamo giunti al settembre 1968 e l’aspra battaglia, che è stata strumentalizzata politicamente in modo demagogico da chi vuole conservare lo status quo, ha raccolto molti consensi e adesioni; ma non si sentono ragioni e non viene accolta nessuna proposta di modi-
fica, per cui il tratto autostradale da Ancona sud a Pescara nord-Città Sant'Angelo è inaugurato il 14 marzo 1973, alla presenza del Presidente della Repubblica Giovanni Leone, secondo il progetto costiero dell’Anas.
La Pedemontana Appenninica
Per fare da contrappeso allo sbilanciamento socio economico che la regione stava soffrendo, gli urbanisti di Marche ’70 hanno individuato nella strada Pedemontana appenninica l’elemento di riequilibrio infrastrutturale. Questa viene pensata come un’arteria di respiro interregionale con caratteristiche tecniche pari a quelle autostradali, quindi con adeguati raggi di curvatura e pendenze non superiori al 3,5%. Connessa a nord e a sud con la grande viabilità nazionale, avrebbe potuto avere il tracciato “Cesena - Urbino – Fabriano - Camerino – Norcia –L’Aquila – Sulmona – Isernia – Benevento” e il tratto marchigiano si sarebbe in parte sviluppato in quella anomala vallata nord-sudl’unica nelle Marche - denominata Sinclinale Camerte, che ha ai suoi punti estremi le città di Camerino e Fabriano. Sulle pagine della rivista viene definita come asse portante della “Città Regione” da Paolo Castelli e Luigi Cristini nell’articolo n. 4/1968, nel quale si delineano le linee guida del progetto territoriale per le nuove Marche. Si sottolinea anche la funzione strategica di collegamento che la strada avrebbe avuto tra le due università dell’entroterra, quelle di Urbino e Camerino, anche se, in modo ancora oggi sorprendente, proprio dalla città di Camerino, tuttavia non sia mai giunto un significativo sostegno all’in-

79 Marche ‘70
L’arretramento dell’autostrada avrebbe preservato l’area litorale e portato un apporto vitale alle zone interne
Ma
novativo asse viario.
Della Pedemontana si discute in diversi convegni (Pergola, Fabriano, Matelica) dei quali dà conto Giancarlo Castagnari su Marche ’70 (n. 10/11, dicembre 1968) riportando testualmente l’ordine del giorno che una folta assemblea di sindaci aveva unanimemente sottoscritto il 20 ottobre di quell’anno a Matelica. Nel documento, oltre a fissare un’ipotesi di tracciato in terra marchigiana e le caratteristiche tecniche della strada, si ribadisce «il carattere di assoluta priorità dell’arteria pedemontana quale elemento riequilibrante dello sviluppo delle Marche». A seguito della forte presa di posizione dei sindaci, il Crpe delle Marche, pilatescamente chiarisce che la scelta definitiva delle infrastrutture stradali regionali si sarebbe potuta effettuare solo in sede di definizione del piano territoriale regionale, ma allo stesso tempo «fa voti perché i futuri interventi dello Stato siano orientati prioritariamente verso il tracciato sud della collinare, il tracciato centrale della pedemontana, il tracciato nord della collinare, al fine del conseguimento degli obiettivi del piano regionale specificati nelle prime indicazioni per lo schema regionale di sviluppo». In sostanza il comitato prefigura una soluzione ibrida: invece di privilegiare un assetto viario veloce e capace di funzionare come contrappeso all’attrazione esercitata dall’Autostrada, si propongono tratti isolati di raccordi tra le intervallive su assi diversi.
L’ultimo tentativo di affermare il ruolo e il valore della Pedemontana appenninica, nel quadro della viabilità regionale e interregionale, viene fatto da Castelli e Cristini, che nel numero 3/1969

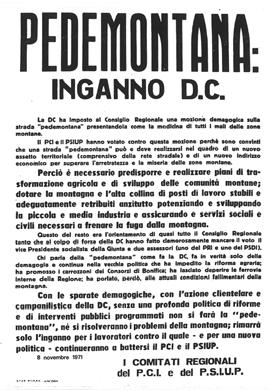
di Marche ’70 pubblicano un documentatissimo studio comparativo delle varie soluzioni elaborate per la viabilità delle Marche. Nella premessa s’intuisce già l’amarezza per quelle che si ritiene un’occasione mancata: «Nel nostro Paese non si programma: si va qualche volta dietro a riparare i danni di una mancata programmazione». Lo studio, affermano i due urbanisti, «vuole offrire un concreto contributo a riparare almeno in parte al più grave dei danni subiti dall’unità d’Italia ad oggi: il tracciato marino dell’autostrada del Levante».
La proposta della Pedemontana, nonostante i grandi sforzi e le attività promosse dal Comitato dei sindaci e dei kennediani, rimane lettera morta nella programmazione regionale. Nell’ultimo articolo di Luigi Cristini, contenuto nel numero 10-11/1969 della rivista, si denuncia apertamente che «se si eccettuano i comunisti di Rinnovamento e i tecnici dell’Issem, non v’è più nelle Marche chi non abbia capito che […] l’unica possibilità che resta alla nostra Regione di sopravvivere è la realizzazione di un’arteria pedemontana con caratteristiche di scorrevolezza e fruibilità tali da costituire un ‘peso bilanciante’ alle infrastrutture marine». Rinnovamento è in quegli anni la rivista del Comitato regionale marchigiano del Pci, che ha sempre osteggiato, in stretta e silenziosa alleanza con l’ala dorotea democristiana, l’asse stradale interno. Il Partito Comunista fa persino affiggere in tutta la regione dei manifesti con scritto a caratteri cubitali: “Pedemontana: inganno DC”. A sua volta il Comitato tecnico dell’Issem boccia lo schema di viabilità regionale con la realizza-
80 Marche
‘70
venne
la modifica del tracciato non venne accolta e l’autostrada sulla costa
inaugurata dal presidente Leone
zione dell’asse autostradale in posizione più interna redatto dal professor Valori, che si dimette dal Comitato stesso in seguito di questa decisione. L’articolo sembra la presa d’atto di una sconfitta perché la battaglia per la realizzazione dell’asse interno è ormai perduta e Cristini scrive quella che appare come una vera e propria profezia della situazione odierna: «Basta esaminare i movimenti interni di popolazione per accorgersi che, se anche alcune città collinari hanno mantenuto o aumentato i residenti, questi nella media hanno subito un invecchiamento preoccupante; a questo seguirà, in tempi non lunghi, un conseguente spopolamento, per volontà di Dio e per insipienza dei pianificatori».
Come è andata a finire?
Lo schema previsto, o meglio, le aggregazioni di comuni in comprensori; ipotizzate per definire gli ambiti ottimali e omogenei di sviluppo sono state in parte riprese come traccia per delineare i confini delle comunità montane e degli ambiti delle originarie Usl, istituite dopo la riforma sanitaria. Tutto il resto (l'istanza di condividere istituti scolastici, aree per infrastrutture produttive, aree per impianti sportivi e strutture sanitarie in bacini tali che i servizi si potessero rendere all'altezza delle aspettative e allo stesso tempo sostenibili) si è scontrato con la voglia di ottusa conservazione del potere ed è stata condizionata dall’inguaribile campanilismo espresso dalle comunità. Ancora oggi, dopo l’ultimo sisma, ogni piccolo comune reclama la propria scuola elementare, che presto non avrà più insegnanti e, temo neanche
più alunni. Paolo Castelli, nel 1977, compie un ultimo tentativo, dando alle stampe un saggio dal titolo: Marche domani? Una strategia per l’urbanistica marchigiana, in questo volume, tra l’altro, riafferma ancora una volta la validità dello sviluppo regionale basato sulla logica dei comprensori e la necessità di una strada pedemontana per riequilibrare il ritardo di sviluppo delle aree interne e il loro calo demografico.
L'autostrada, lo sappiamo, è oggi l’ennesimo nastro infrastrutturale che corre sull'orlo della regione, mentre la cosiddetta Pedemontana in corso di realizzazione nell’ambito del progetto “Quadrilatero di Penetrazione Marche Umbria” è un ectoplasma che ha solo il nome dell’idea originaria. Ne ricalca un solo tratto, progettato e costruito in una forma anacronistica con una sola corsia per senso di marcia e, anche se dotata di svincoli, mantiene le caratteristiche di una piccola e lenta strada per il traffico locale. Le proposte dei kennediani avevano mirato a realizzare un assetto territoriale omogeneo e a fornire delle istanze di modernizzazione come argine allo spopolamento delle aree interne; questo ha avuto il colpo definitivo - forse irreversibile - in seguito alle distruzioni e alle deportazioni di massa verso la costa seguite al sisma del 2016.
Risultato: le Marche sono oggi ridotte a una lunga conurbazione adagiata sulla battigia, quasi senza soluzione di continuità, afflitta dai problemi che tutti conoscono.
Negli anni ‘60 la tendenza si sarebbe forse potuta invertire o mitigare, oggi paghiamo a caro prezzo le conseguenze di non averlo capito o voluto capire. ¤
I principali artefici di “Marche ’70”
Achille Alba
Poeta, critico letterario, impiegato nella scuola secondaria superiore
Guido Bianchini
Avvocato, consigliere e assessore regionale, componente della Commissione speciale per la redazione dello statuto della Regione Marche
Claudio Bisconti
Avvocato, sindaco di Monte San Pietrangeli
Angelo Antonio Bittarelli
Storico, giornalista, direttore de L’Appennino Camerte, insegnante nella scuola secondaria superiore
Giancarlo Castagnari Storico, docente universitario, sindaco di Fabriano
Paolo Castelli
Architetto, urbanista, presidente provinciale di Italia Nostra Macerata, cofondatore del Gruppo Marche
Adriano Ciaffi
Avvocato, consigliere assessore e presidente della giunta regionale, deputato, sottosegretario di stato agli Interni e presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati
Luigi Cristini Architetto, urbanista, cofondatore del Gruppo Marche, presidente nazionale di Federarchitetti, consulente dell’ufficio programma della Regione Marche, consigliere regionale
Elverio Maurizi
Procuratore legale, pubblicista, critico d’arte
Luigi Mercuri Economista, poi dipendente della Regione Marche
Alberto Pellegrino
Sociologo, saggista e giornalista, insegnante nella scuola secondaria superiore e docente universitario
Luigi Sileoni
Presidente della Provincia di Macerata e membro del Comitato Economico e Sociale dell’Unione Europea
A sinistra, due manifesti inerenti alla Pedemontana che tanto fece discutere in quel periodo. Qui sopra, i teorici della "Città Regione"
81 Marche ‘70
Rete Lirica attende di mettere in rete anche Le Muse e il teatro Pergolesi





Nelle Marche, per la gioia dei melomani, c’è anche l’Altra Lirica, che non è quella estiva dello Sferisterio di Macerata o del Rof di Pesaro, eccellenze indiscusse, ma quella che si fa in autunno-inverno nei teatri Ventidio Basso di Ascoli, Dell’Aquila di Fermo e Della Fortuna di Fano. L’Altra Lirica è gestita dalla Fondazione Rete Lirica delle Marche istituita nel 2018, sotto l’egida della Regione, con soci fondatori Comune di Ascoli Piceno, Comune di Fano, Comune di Fermo, Comune di Macerata, Associazione Arena Sferisterio - Teatro di Tradizione, Fondazione Orchestra Regionale delle Marche - Ico, Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Teatro della Fortuna e Consorzio Marche Spettacolo. Soci partecipanti associazione Coro Ventidio Basso di Ascoli, Coro del Teatro della Fortuna “Mezio Agostini”, Orchrestra Sinfonica Rossini di Pesaro, Conservatorio di Fermo e Accademia di Belle Arti di Ma-
cerata. Il cartellone dettagliato della stagione 2022-2023 e i titoli di tutto il triennio 2022-2024 sono stati svelati dal presidente della Fondazione Francesco Ciabattoni, dal direttore generale Luciano Messi, dal direttore artistico Alessio Vlad e dall’assessore regionale alla cultura Giorgia Latini. Dal punto di vista “politico” non sono mancati gli appelli affinché la Fondazione possa allargarsi ad altre città e teatri marchigiani. Ma fino ad oggi tutti i tentativi di mettere in rete, come sarebbe normale e soprattutto razionale, anche il Teatro delle Muse di Ancona e il Teatro Pergolesi di Jesi, sono falliti. Qualche approccio ma nulla di più. Ancona e Jesi continuano ad andare liricamente per la propria strada e la Fondazione Rete Lirica delle Marche rimane zoppa. Chissà se la Regione riuscirà prossimamente a fare il miracolo di unire tutte le realtà liriche delle Marche per costituire un completo sistema lirico sinfonico regionale che

Non solo Rof e Sferisterio
di Franco De Marco
Il circuito regionale gestito dalla Fondazione
Nelle Marche in scena anche un’Altra Lirica
faccia razionalizzare investimenti e garantire qualità. In altre regioni del Nord i circuiti lirici sono consolidate realtà come le Marche “plurali” e companiliste.
A scorrere il cartellone della stagione 2022-2023, dopo la nuova produzione del Macbeth verdiano che vede regia, scene, costumi e luci di quel mito del teatro musicale italiano che risponde al nome di Pier Luigi Pizzi che ha creato numerosi capolavori anche nelle Marche, di scena a Fermo, Ascoli e Fano, ecco la Traviata di Giuseppe Verdi, secondo titolo della stagione 2022-203, che debutterà il 4 febbraio nel Teatro della Fortuna (anteprima giovani il 2 febbraio). L’11 febbraio sarà al Teatro dell’Aquila (anteprima giovani il 9 febbraio) e l’ultima recita sarà il 18 febbraio nel Teatro Ventidio Basso (anteprima giovani il 16 febbraio). Direzione musicale di Enrico Lombardi sul podio dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini con il Coro del Teatro della Fortuna diretto da Mirca
Rosciani. Il progetto di regia di Luca Baracchini, con le scene di Francesca Sgariboldi, i costumi di Donato Didonna e le luci di Gianni Bertoli, è stato il vincitore di un bando internazionale per artisti under 35 organizzato dalla Rete Lirica delle Marche con il circuito Opera Lombardia, Opera Europa e il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Nel ruolo di Violetta il soprano messicano Karen Gardeazabal, in quello di Alfredo Valerio Borgioni mentre Giorgio Germont sarà Andrea Borghini.
Nell’ambito del progetto “Opera Domani”, che si rivolge ai più piccoli e alle famiglie, alla fine del 2022 farà tappa nei teatri della Rete Lirica la fortunatissima produzione di AsLiCo con Théâtre des Champs-Elysées e Opéra de Rouen “La Cenerentola. Grand Hotel dei sogni”, spettacolo che durante il 2021 e il 2022 ha girato i teatri di tutta Italia ed alcuni europei riscuo-

tendo sempre grande successo. L’adattamento musicale e drammaturgico del capolavoro di Gioachino Rossini è curato da AsLiCo e la messa in scena è firmata dal regista Daniele Menghini che trasporta l’intera vicenda in un grande albergo il cui proprietario è Don Magnifico. Il cast vocale è composto dai giovani artisti selezionati da AsLiCo. In buca l’Orchestra 1813 guidata da Riccardo Bisatti. Il 2023 si aprirà, com’è ormai tradizione, con un concerto degli allievi del Conservatorio “G.B. Pergolesi” di Fermo al Teatro dell’Aquila.
Nella primavera 2023 ci sarà spazio per un’altra proposta di ascolto e avvicinamento all’opera con la nuova produzione AsLiCo ideata su uno dei titoli più celebri del catalogo di Mozart, Die Zauberflöte (Il flauto magico) con l’adattamento musicale eseguito dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini e quello drammaturgico ideato dalla regista Caroline Leboutte. Il nuovo allestimento, pro-
83
SUI PALCHI DI ASCOLI, FERMO E FANO, GIOVANI TALENTI ACCANTO A MAESTRI
posto per la XXVII edizione di Opera Domani, sarà al Teatro della Fortuna il 9 maggio, al Teatro Ventidio Basso il 10 maggio e al Teatro dell’Aquila il 12 maggio. Nel 2023-2024 andranno in scena Tosca di Giacomo Puccini in coproduzione con il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona e Norma di Vincenzo Bellini. Nel 2024/25 Rigoletto di Giuseppe Verdi e Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni.

Una bel cartellone, con titoli molto popolari, varato con opportuna pianificazione dopo le difficoltà create dalla pandemia. La Fondazione Rete Lirica delle Marche si è data soprattutto una missione che la differenzia da altri enti lirici: mettere in rapporto grandi maestri e giovani interpreti. Ovvero offrire la possibilità, come ha ben sottolineato il maestro Alessio Vlad, ai talenti emergenti di crescere accanto a maestri offrendo loro di diventare, in tranquillità, protagonisti di titoli complessi. Maestri del teatro e giovani talenti. Insomma la Rete vuole avere anche un ruolo di alta formazione professionale per cantanti, registi e altre figure della macchina teatro musicale. “La Fondazione Rete lirica delle Marche è un soggetto molto importante per lo sviluppo culturale della nostra regione - ha sottolineato l’assessore Latini ricordando la candidatura, avviata dal Mic, del canto lirico a patrimonio immateriale dell’Unesco - Il belcanto è un tratto caratteristico della nostra cultura e del nostro essere italiani. Allo stesso tempo la Regione sta portando avanti anche la candidatura Unesco dei teatri storici marchigiani. In questo
percorso la Fondazione vuole offrire un valido contributo per il raggiungimento di tali obiettivi accrescendo il valore della nostra candidaturۛa”. “Il nostro principale obiettivo è proprio la formazione di nuovo pubblico - ha detto il presidente Ciabattoni - L’opera lirica è il principale veicolo di diffusione e d’insegnamento della cultura italiana ed è riconosciuta ovunque nel mondo come testimone e ambasciatrice della nostra identità nazionale. Vogliamo coinvolgere nel progetto di crescita e di ripartenza, anche le realtà imprenditoriali e produttive».

“Come sottolineato dal Premio cultura di gestione conquistato nel 2018 - ha ricordato Messi - rappresentiamo un esempio di governance pubblica capace di fare network intorno ad obiettivi condivisi e reali istanze del territorio. Si tratta di un sistema lirico regionale integrato (comprensivo di due istituti di alta formazione) che rappresenta ancora oggi un’esperienza unica in Italia. Abbiamo valorizzato i complessi artistici e le maestranze tecniche regionali realizzando oltre cinquemila giornate lavorative annue (di cui 1/3 under35) con risultati significativi anche durante la pandemia. Adesso si può ripartire a pieno ritmo con la produzione di tutto il triennio e anche gli spettacoli per le scuole e le famiglie».
I biglietti della Stagione 2022/2023 hanno un costo compreso fra 25 e i 50 euro. I biglietti per le anteprime giovani saranno fra i 5 e i 10 euro, mentre quelli per “Opera Domani” 12 euro, per gli studenti e di 1 euro per disabili e accompagnatori. ¤

84 Non solo Rof e Sferisterio
Il belcanto è elemento caratteristico della nostra cultura e la Regione avanza anche la candidatura Unesco dei teatri storici marchigiani
Nelle pagine precedenti in alto, Davide Luciano, Diego Carretta Enrico Lombardi e Lidia Fridman A fianco, il teatro Rossini di Pesaro Sopra, Luciano Messi, Alessio Vlad, Giorgia Latini e Francesco Ciabattoni Qui sopra, Pier Luigi Pizzi
Tre eroici pesaresi nel raid dei Dardanelli
 LUGLIO 1912, SPERICOLATA AZIONE ITALIANA NELLO STRETTO
LUGLIO 1912, SPERICOLATA AZIONE ITALIANA NELLO STRETTO
Nel 1487 il portoghese Bartolomeo Diaz, con la scoperta dello Stretto del Capo di Buona Speranza, aprì una via marittima che ben presto spostò l’asse di tutta l’attività commerciale Europa- Medio Oriente sull’oceano Atlantico. L’apertura del Canale di Suez (1869) fece rifiorire il commercio nel Mediterraneo e i vecchi e obsoleti porti ripresero vita, suscitando l’interesse delle grandi potenze europee per acquisirne il controllo. A tale scopo, la Germania si alleò con la Turchia, la Francia invase la Tunisia (1881) e l’Inghilterra occupò l’Egitto (1882). L’Italia, per la sua posizione geografica, non poteva permettere la monopolizzazione dei mercati, per cui decise di occupare la Tripolitania e la Cirenaica, appartenenti all’ Impero Ottomano, ma male amministrate e poco servite, perché lontane dalla capitale turca. Il 28 settembre 1911, l’ambasciatore italiano a Istanbul consegnò al governo ottomano un ultimatum in cui, fra l’altro, gli imponeva “ di dare gli ordini occorrenti affinché l’occupazione militare italiana della Tripolitania e della Cirenaica non incontrasse alcuna opposizione”.
Il termine di accettazione era di 24 ore. Il sultano turco cercò di prendere tempo ma, trascorso il termine stabilito, “ritenendo il ritardo un ingenuo artificio per guadagnare tempo”, l’Italia iniziò le operazioni militari. A tale scopo fu costituito un Corpo d’Armata Speciale, al comando del generale Carlo Caneva, composto di 34.000 uomini, supportati, per la prima vol-
ta, da mezzi d’assalto di ultima tecnologia militare: aerei ( Bleriot, MieuportIVG, Etrich Tombe, Farman), automobili Fiat Tipo 2, motociclette SIAMT. Come mezzo di comunicazione venne costituito un servizio regolare di radiotelegrafia campale affidato all’Arma del Genio sotto la regia di Guglielmo Marconi. Nei mesi seguenti le operazioni militari italiane, nonostante l’appoggio della Marina che con i suoi cannoni preparava gli sbarchi, non ebbero l’esito desiderato. Gli ottomani, pur impossibilitati di avere aiuti da Istanbul, aiutati da alcune fazioni arabe, resistevano tenacemente e a nulla era valso, da parte dell’Italia, l’invio di nuovi uomini e mezzi. Per sbloccare la situazione, il governo italiano decise di portare la guerra anche sul territorio metropolitano turco.
Nell’aprile del 1912 un corpo di spedizione, composto di 8.000 uomini, occupò prima l’Isola di Rodi e, poi, le altre isole del Peloponneso. Questo atto costrinse il sultano a sedersi a un tavolo per trattare la pace ma, di fronte alle richieste italiane, si rifiutò di firmarla contando sull’aiuto della diplomazia della Germania sua alleata. Inoltre aveva ancora integra la sua flotta che contava numerose navi da battaglia anche se ormai antiquate come armamenti, e che aveva prudentemente “nascosto” nella baia di Chanack nello stretto dei Dardanelli. Per costringerlo a firmare, l’Italia pensò di organizzare una azione militare, con lo scopo di dimostrare che, volendo, le navi turche potevano essere colpite e di-
85 L’incursione
di Dante Trebbi
strutte. Per fare ciò era, però, necessario navigare lungo lo Stretto dei Dardanelli le cui acque “pullulavano” di mine e le sue sponde erano sorvegliate da numerose istallazioni militari che disponevano di cannoni di grosso calibro e di accecanti fari d’illuminazione. Dopo aver scartato l’idea di impiegare navi corazzate perché ritenute lente e, per la loro mole, facili bersagli, fu deciso di utilizzare mezzi più piccoli e veloci. La scelta cadde su cinque torpediniere, la Climene, la Perseo, l’Astore, la Spica e la Centauro. Nella notte tra il 18 e il 19 luglio 1912, le cinque unità, al comando del capitano di Vascello Enrico Millo, entrarono nel canale dei Dardanelli. Dopo due ore di navigazione ed aver evitato con abili manovre i numerosi banchi minati e le reti di sbarramento, giunte all’imbocco della baia, le navi furono avvistate e sottoposte a un forte cannoneggiamento. Manovrando abilmente e a tutta forza, le unità fecero marcia indietro non prima, però, di aver sganciato due siluri contro la flotta nemica in rada che sfortunatamente non andarono a segno. Il ritorno in mare aperto fu molto difficoltoso. Tutti i cannoni, posti a difesa dello stretto, sparavano contro di loro senza lesinare i colpi. La fortuna volle che nessuna di esse fosse colpita seriamente. Tutte riuscirono a rientrare alla loro base nell’isola del Dodecaneso, Stampalia. La spericolata azione, anche se non provocò danni, scosse il morale dei turchi che videro in pericolo la loro stessa capitale Istanbul.
Il 18 ottobre firmarono la pace, concedendo all’Italia la Tripolitania e la Cirenaica in cambio del ritiro delle truppe italiane dalle isole del Peloponneso. Tutti gli equipaggi delle cinque torpediniere, per il coraggio dimostrato, ebbero
gli elogi della Marina e il loro comandante Enrico Millo fu promosso ammiraglio. Fra i marinai vi erano tre pesaresi: Emilio Galvani, primo macchinista della Perseo, Ferdinando Donati, cannoniere scelto della Climene e Costantino Roberti, marinaio scelto dell’Astore. Pesaro volle complimentarsi con questi valorosi e premiarli con una medaglia d’oro da consegnare l’11 settembre in occasione della festa dell’annessione della città al Regno d’Italia. Il 12 settembre, il settimanale liberale pesarese “La Provincia”, illustrando la giornata, scrive: … “Fin dalle prime ore del mattino tutte le case della città e del porto erano pavesate ed imbandierate. Alle ore 11 il corteo, dopo aver assistito alla cerimonia che ricordava i soldati piemontesi caduti nel 1860 sotto le mura cittadine, e ascoltato il concertino degli Orfani, preceduto dalla banda cittadina, prese letteralmente d’assalto il Teatro Rossini” dove era prevista la consegna delle medaglie d’oro. Tutti i palchi erano addobbati con le bandierine tricolori e sul palcoscenico sedevano le massime autorità cittadine. Dapprima prese la parola il sindaco Tombesi che, pur festeggiando gli eroi pesaresi, si dimostrò poco entusiasta della guerra in corso. Gli fece seguito il pubblicista anconetano Rodolfo Gabani che invece “ fra croscianti e continui applausi fece un robusto discorso mettendo in bella mostra ogni particolare del meraviglioso ed oramai leggendario raid ed il sublime eroismo dei volontari equipaggi votati alla morte”. Infine - prosegue il giornale- “tra la commozione di tutti, i tre valorosi marinai vennero decorati della medaglia d’oro e tutte le principali autorità cittadine si affrettarono ad abbracciarli e baciarli, mentre la musica del Reggimento suonava la


86 L’incursione
Dall'alto, Giuseppe Sirianni comandante della Perseo e Carlo Penzi, comandante della Climene
In alto a destra, Enrico Millo comandante della squadriglia e sotto due momenti dell'incursione
Medaglie d’oro a Emilio Galvani primo macchinista
Ferdinando Donati cannoniere e Costantino Roberti marinaio scelto
Marcia Reale e dall’alto scendeva una pioggia di cartellini tricolori plaudenti all’armata e all’esercito”. “Terminata la festa e dopo il banchetto offerto dalla Società dei Reduci, il corteo si ricompose e, tutti insieme, mossero verso il quartiere del Porto, dove abitavano i marinai Donati e Roberti. Non una finestra che non avesse, nell’interminabile fila di case, dei paramenti e delle bandiere. Da alcuni balconi si gettavano fiori. Per la via era scesa letteralmente tutta la popolazione, uomini, donne, ragazzi, che applaudiva freneticamente. Poscia il corteo si è riformato e percorrendo diverse vie cittadine e il Corso, tutte ugualmente festanti, si è fermato nella grande piazza dove di fronte al monumento di Terenzio Mamiani (in quel periodo situato nello spiazzo della chiesa di S. Ubaldo), si è sciolto con fervide acclamazioni ai reduci dei Dardanelli, alla Marina, all’Esercito, all’Italia”. Qualche giorno prima, il 7 settembre il giornale cittadino “ Il Progresso” d’ispirazione socialista, nell’annunciare che non avrebbe partecipato alla manifestazione, aveva scritto: “… ci sentimmo commossi ripensando al momento supremo eroico in cui questi giovanissimi sono stati chiamati a scegliere tra la vita e il pericolo supremo e, senza esitanza, con il trasporto che danno i grandi cimenti, si sono decisi al sacrificio…. Abbiamo approvato il voto solenne del Consiglio comunale che, in rappresentanza di tutti i cittadini, esprimeva ad essi sentimenti di alta meritata onoranza …. Ma non partecipiamo alle manifestazioni che si fanno di ispirazione nazionalista…. La nostra opinione è contraria a tutte le guerre che rappresentano l’impero della violenza, non sempre e non generalmente a sussidio del diritto ed è
contraria alla presente guerra in omaggio agli ideali per cui è sorta l’Italia nuova e per ragioni di politica interna le quali ci avvertono l’enorme insidia racchiusa in questa impresa contro il cammino democratico senza che sia dimostrato alcun vero vantaggio nazionale. Questa è una guerra fatta dalla monarchia e dalla borghesia. Con la guerra tutti i valori di violenza e di disuguaglianza si innalzano: le idee di giustizia, di fratellanza fra i popoli, di esaltazione al lavoro, si scoloriscono e si perdono e con essa tutte le ragioni del proletariato”.
Pochi giorni dopo, commentando la cerimonia cittadina, il giornale scrive polemicamente che la manifestazione ebbe uno scarso interesse e alla quale parteciparono poche persone con sei o sette bandiere. “ Il discorso del sig. Gabani - conclude infine- fu così noioso che molto probabilmente la gente se ne sarebbe andata non vi fosse stata la cerimonia della decorazione dei concittadini marinai”.
L’incursione della marina italiana fu l’unica azione militare nei Dardanelli che, nella storia moderna, ebbe un esito positivo. II 18 marzo 1915, infatti, fu tentata un’azione simile. Nell’intento di occupare Istanbul, fu organizzato dagli inglesi e francesi (contro il parere italiano) un corpo di spedizione, supportato da diciassette corazzate, un incrociatore da battaglia e con navi di appoggio ai fianchi. Inoltratasi nello Stretto, la squadra navale si trovò ben presto sopra un vasto banco di mine e fu costretta al ritiro, perdendo due corazzate e l’incrociatore da battaglia.


L’insuccesso portò Churchill, ideatore del raid, a rassegnare le dimissioni dalla carica di Primo Lord dell’Ammiragliato inglese. ¤

87 L’incursione
Pesaro li accolse in festa con lancio di fiori e bandierine tricolori sui balconi accompagnati dalla Marcia Reale
LE CENTO CITTA’ Associazione per le Marche Fondata nel 1995
“L’Associazione si pone lo scopo di promuovere e coordinare studi ed azioni finalizzati a rafforzare l’identità culturale della Regione Marche e a favorirne lo sviluppo economico e sociale attraverso la conoscenza e la valorizzazione delle realtà esistenti, il recupero e la tutela del passato, la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, la partecipazione al dialogo culturale interregionale ed europeo, nonché con le comunità marchigiane all’estero.” (Art.3 dello Statuto)
Presidenti
Giovanni Danieli (marzo 1995 – dicembre 1996)
Catervo Cangiotti (gennaio 1996 – dicembre 1997)
Folco Di Santo (gennaio 1998 – dicembre 1999)
Alberto Berardi (gennaio 2000 – dicembre 2001)
Evio Hermas Ercoli (gennaio 2002 – dicembre 2003)
Mario Canti (gennaio 2004 – luglio 2005)
Enrico Paciaroni (agosto 2005 – dicembre 2006)
Tullio Tonnini (gennaio 2007 – dicembre 2007)
Bruno Brandoni (gennaio 2008 – luglio 2008)
Alberto Pellegrino (agosto 2008 – luglio 2009)
Walter Scotucci (agosto 2009 – luglio 2010)
Maria Luisa Polichetti (agosto 2010 – luglio 2011)
Ettore Franca (agosto 2011 – luglio 2012)
Natale Frega (agosto 2012 – luglio 2013)
Maurizio Cinelli (agosto 2013 – luglio 2014)
Giovanni Danieli (agosto 2014 – luglio 2015)
Luciano Capodaglio (agosto 2015 – luglio 2016)
Marco Belogi (agosto 2016 – luglio 2017)
Giorgio Rossi (agosto 2017 – luglio 2018)
Mara Silvestrini (agosto 2018 – luglio 2019)
Donatella Menchetti (agosto 2019 – luglio 2020)
Filiberto Bracalente (agosto 2020 – luglio 2021)
Fernando Piazzolla (agosto 2021 – luglio 2022)
Filiberto Bracalente (agosto 2022 – luglio 2023)
Le Cento Città

Direttore responsabile
Franco Elisei
Direttore editoriale
Maurizio Cinelli
Comitato scientifico
Marco Belogi
Fabio Brisighelli
Paola Cimarelli
Claudio Desideri
Federica Facchini
Rosangela Guerra
Fabio Mariano
Giordano Pierlorenzi
Claudio Sargenti
Anno XXVII
Coordinamento progetto grafico e impaginazione Prof. Sergio Giantomassi
Progetto grafico
Poliarte
Accademia di Belle Arti e Design di Ancona
Direzione, redazione amministrazione
Associazione Le Cento Città redazionecentocitta@ gmail.com
Rivista riconosciuta come bene culturale di interesse storico dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Presidente Le Cento Città Filiberto Bracalente
Stampa
Errebi Grafiche Ripesi Falconara M.ma
Sede Via Asiago 12 60124, Ancona
Poste Italiane Spa spedizione in abbonamento postale 70% CN AN
Reg. del Tribunale di Ancona n.20 del 10/7/1995
89 L’associazione




78 | 2022














































 ASCOLTAVA, VISITAVA E CURAVA ANCHE CON LE PAROLE
ASCOLTAVA, VISITAVA E CURAVA ANCHE CON LE PAROLE












































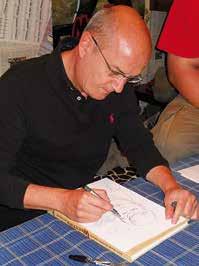






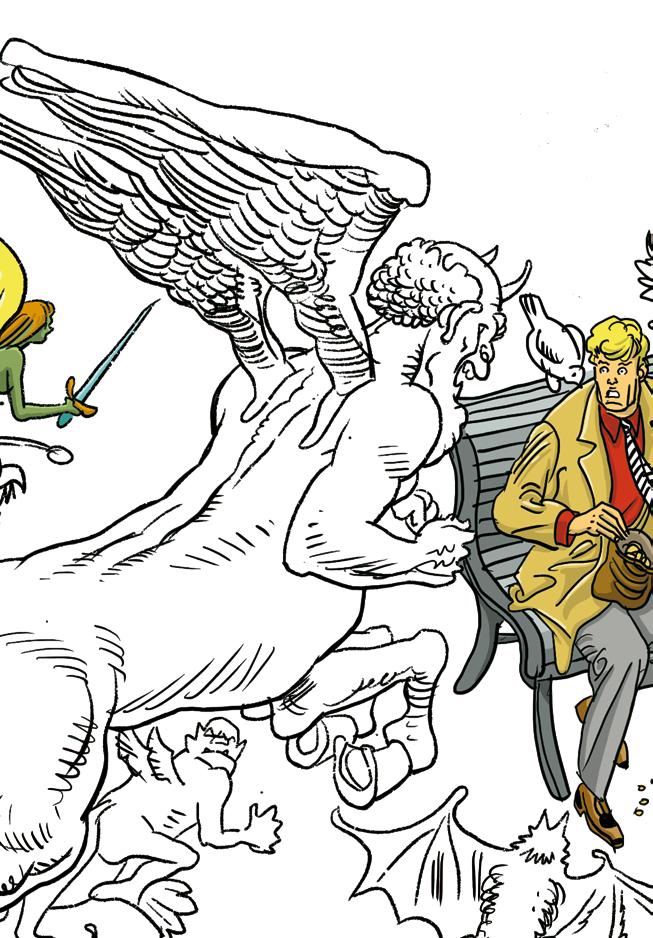







































 EX CASCAMIFICIO DI JESI, FUTURO SPAZIO MULTIFUNZIONALE
EX CASCAMIFICIO DI JESI, FUTURO SPAZIO MULTIFUNZIONALE



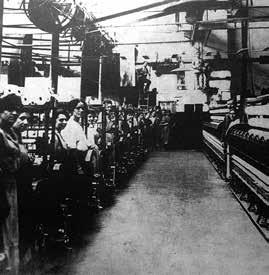


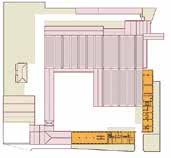





















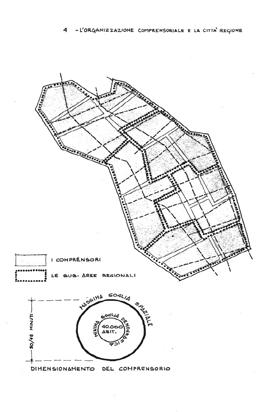


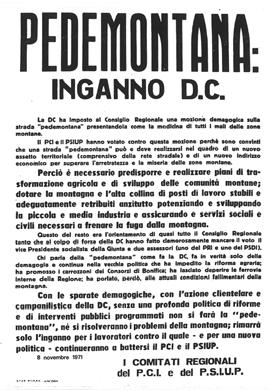










 LUGLIO 1912, SPERICOLATA AZIONE ITALIANA NELLO STRETTO
LUGLIO 1912, SPERICOLATA AZIONE ITALIANA NELLO STRETTO






