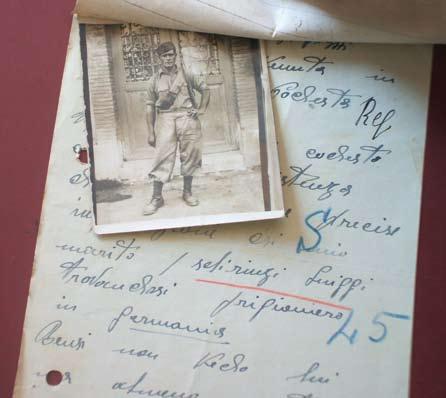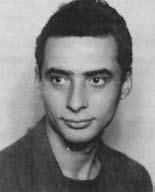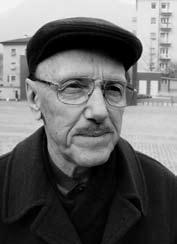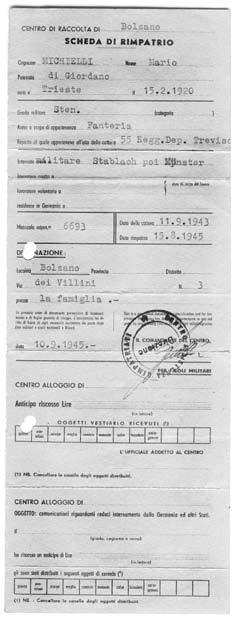Capitolo Secondo
La ricerca è stata svolta attraverso la selezione e lo studio del numeroso ma teriale conservato presso l’Archivio di Stato di Bolzano. Si tratta di mate riale acquisito dall’Archivio attraverso il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano (ex Prefettura 31) in tempi piuttosto recenti. Circa le caratteristiche del fondo vale quanto già riferito dalla D.ssa Armida Zacca ria dell’Archivio di Stato di Bolzano in una relazione pubblicata nell’ottobre 2006 che presentava il fondo medesimo.32 “Il fondo del Commissariato del Governo conservato presso l’Archivio di Stato di Bolzano” – scrive la Zacca ria – “riguarda solo una parte dell’attività dell’ente – l’Archivio di Gabinetto che si trova tuttora presso il suddetto Commissariato – ed è stato versato al nostro istituto a più riprese, a partire dal 1990. Il riordino eseguito nel nostro archivio è una prima e provvisoria operazione, in attesa di eventuali ulteriori versamenti, volta a rendere accessibile il fondo agli studiosi. Si è conservato l’ordine di versamento e si è creato un agile strumento di ricerca: una banca dati che rileva datazione, contenuti, classificazione degli atti (quando presen te), eventuale riservatezza e particolarità della documentazione”.
Il fondo in oggetto comprende due importanti archivi coinvolti nella presente ricerca: archivio IMI (materiale documentario portato in Italia dai sopravissuti); archivio CAR (Centro Assistenza Rimpatriati). Quest’ultima fu un’organizzazione, di cui si parlerà diffusamente tra poco, che ebbe un ruolo fondamentale nell’assicurare la prima assistenza alle decine e decine di migliaia di ex internati che dal Brennero confluivano sul capoluogo altoate sino.33
31 Dopo l’annessione del Trentino/Alto Adige-Südtirol al Regno d’Italia, con regio decreto del 17.10.1922 venne istituita la Regia Prefettura di Trento. Sedi di sottoprefettura in Sudtirolo erano Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico. Nel 1927 venne creata la Regia Prefettura di Bolzano. La figura del prefetto venne sostituita dopo il 1948 dal Comissario del Governo. Inizialmente era previsto un Commissario per l’intera Regione; dal 1972 fu istituito un Commissario del Governo in ciascuna delle due provincie di Trento e Bolzano.
32 Armida Zaccaria (a cura di/bearbeitet von), Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano (ex Prefettura). Regierungskomissariat für die Provinz Bozen (vorher Präfektur), Archivio di Stato di Bolzano/ Staatsarchiv Bozen, Bolzano/Bozen, 2006.
33 Altri archivi presenti nel fondo, non oggetto della presente ricerca: Ufficio provinciale di assistenza postbellica di Bolzano; Ufficio frontiera del Brennero; Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo – Delegazione provinciale di Bolzano e Commissione provinciale di epurazione.
26
Il CAR (Centro Accoglienza Rimpatriati) di Bolzano. Uno studio attraverso la documentazione conservata presso l’Archivio di Stato di Bolzano
2.1 Una descrizione generale del fondo
Il CAR di Bolzano venne sciolto definitivamente nel luglio 1947 e “le restanti attività” furono assorbite dall’Ufficio provinciale di assistenza postbellica. L’archivio dell’ufficio venne consegnato alle autorità dall’allora capo ufficio informazioni, Don Maretti.34
2.2 Descrizione del fondo
Propongo qui di seguito un elenco con una breve descrizione dei principali faldoni consultati presso l’Archivio di Stato di Bolzano. Questo schema può essere uno strumento di lavoro anche per chi deside rasse approfondire e affinare, con ulteriori ricerche, alcuni particolari aspetti della vicenda degli Internati Militari Italiani.
Faldoni nr. 11 e 12
Comunicazioni di morte o dispersi e documenti vari relativi a deceduti o dispersi; liste di caduti secondo informazioni riportate dai rimpatriandi con documentazione allegata per singolo caso;
Faldone nr. 16:
Elenco di ufficiali rientrati in Italia dalla prigionia russa 35, dal maggio 1945 al 30 agosto 1946; Elenco prigionieri italiani rientrati dalla Russia ; Elenco prigionieri italiani in attesa di rimpatrio dalla Russia; Elenchi Alleati (“Evacuation List”) riferiti a decine di migliaia di prigionieri liberati dai campi e in transito attraverso l’Italia;
Faldone nr. 22
“Rubrica generale” (lettere T, V, Z) con nomi di persone morte o disperse per le quali si danno notizie (dati anagrafici, indirizzo, data luogo e causa di morte, nome cogno me e indirizzo del riportante la notizia); “Rubrica generale” (lettere R, S) con nomi di persone morte o disperse per le quali si danno notizie (dati anagrafici, indirizzo, data luogo e causa di morte, nome cognome e indirizzo del riportante la notizia);
Faldone nr. 28
Materiale del fiduciario di Weiden (Arbeitskommando 130 26) con ricevute di avve nuta consegna gallette e latte condensato da parte della Croce Rossa Italiana;
34 Armida Zaccaria, op. cit.
35 Oltre a materiale inerente gli IMI è infatti presente qualche documento relativo a prigionieri e dispersi in Russia. Vi è inoltre il caso diffuso di ex prigionieri dei Tedeschi caduti in mano ai Russi e da questi “libe rati” una volta concluso il conflitto o nei mesi successivi.
27
Registro originale dello Stalag XIII B “Verzeichnis über Wertgegenstände von Ita lienisch Militär Internierten“ con dati riferiti a internati presenti in quel campo e “Paketliste”, ricevute di ricezioni di pacchi per nominativi, con quantitativi (tutte documentazioni originali tedesche); elenchi nominativi completi di IMI in diversi Arbeitskommando;
Faldone nr. 29:
Relazioni dettagliate del fiduciario36 del campo di Weiden sulla situazione nel lager (corrispondenze con il SAI , Servizio Assistenza Internati c/o Ambasciata a Berli no); per questo campo sono disponibili p. es. tutta la documentazione completa del fiduciario e relative corrispondenze, documenti della CRI – Comitato Assistenza In ternati, lettere originali dell’Ambasciata d’Italia a Berlino con richiesta notizie su in ternati, rapporti di fiduciari di altri campo sulle condizioni di salute degli IMI (molto dettagliati), eccetera;
Busta con altri documenti relativi al campo di Weiden; Busta con lista dei comandi italiani in Baviera e Sudeti; Elenco deceduti dello Stalag XIII B;
Faldone nr. 53:
Dichiarazioni inviate da comuni italiani al CAR di Bolzano con richieste di ricerche di IMI dispersi in Germania; Fascicolo con elenchi di IMI rimpatriati dalla Mission française de repatriement;
Faldone nr. 55:
- Busta “Prigionieri Italiani presi in forze allo Stalag VII B”; Elenco con schede personali di IMI compilate al CAR di Bolzano; storie individuali con dati anagrafici, luogo di cattura, tratti essenziali dell’esperienza di internamento e passaggio allo “stato civile” nel 1944; dichiarazioni di ‘non avvenuta collaborazione con autorità fasciste e germaniche durante l’internamento’; schede originali di inter nati compilate dalle autorità germaniche all’atto dell’imprigionamento (foto “segna letica” con lavagna, nome Stalag e numero di matricola, dati anagrafici e di cattura, impronta digitale con inchiostro, date e luoghi di trasferimento in altri lager, etc,; in particolare riferimenti al lager di Memmingen); Elenchi di deceduti nel lager di Memmingen (Stalag VII B) con date cause e luoghi di morte; elenchi con liste di IMI presenti in quel lager; elenchi di deceduti; relazioni in tedesco sulla morte di IMI nel lager di Memmingen; altri elenchi originali del cam po;
Faldone nr. 93:
- Lista completa degli organici del CAR di Bolzano;
36 Come è noto il “fiduciario” era un I.M.I. che fungeva da intermediario (spesso con funzione anche di traduttore) tra i prigionieri italiani e i comandi tedeschi dei Lager. Lo stesso fiduciario poteva operare presso più Lager.
28
Elenchi del personale del CAR (con schede personali o richieste dei singoli dipenden ti);
Elenchi di rimpatriati in arrivo a Bolzano e statistiche giornaliere di arrivo ex IMI a Bolzano con statistica di provenienza regionale e numero complessivo di rimpatriati per giorno; documenti della Pontificia Commissione assistenza; elenchi nominativi di tradotte provenienti dal Brennero; Due libri rilegati con elenchi di italiani (nel caso di morte è specificata la data del decesso) dei campi di raccolta di Lodz in Polonia e di quello di Olesniga (Comando del IV battaglione);
Faldone nr. 94
Materiale inerente vita e organizzazione del CAR di Bolzano; movimentazioni di materiale, presenze di personale, organici di tutte le organizzazioni di assistenza ap prontate a Bolzano (anche presso le FS); rapporti sulla sezione ospedaliera del CAR a BZ; in pratica, tutte le documentazioni circa la gestione del personale e l’amministra zione ordinaria e straordinaria del CAR;
Faldone nr. 170:
Elenchi con migliaia di casi di deceduti per singolo campo (Gusen I e Gusen II, Flos semburg, Holleischen, Norimberga, Bergen Belsen , Berlino, Dresda, Sallinbostel, Hannover, e decine di altre località); Atti del fiduciario italiano del campo di Liegnitz + elenco originale dei deceduti ita liani nell’ospedale di Wasungen con informazioni dettagliate; Elenco ufficiale stilato dal locale comando italiano del lager con i nomi dei 79 IMI fucilati a Kassel dalla Gestapo il 31.3.1945 + vari altri elenchi di eccidi e fucilazioni (p. es “elenco fucilati dalla SS il 23.4.1945 a Trenembrutzen (?) Stamlager III/A”);
Faldone nr. 171:
- Corrispondenza tra il CAR di Bolzano e l’ospedale di Merano dove venivano portati gli IMI malati di TBC rientrati dalla Germania; Faldone con nominativi italiani a Dachau e liste di trasporto in Italia; Informazioni e nominativi sul campo di rimpatrio italiano di Fuerth; Svariati numeri del periodico “Notiziario prigionieri. Bollettino di informazioni sui prigionieri, internati e profughi” (1945-1946);
Faldone nr. 172
Fotografie e certificati di buona condotta di IMI dispersi in Germania, materiale in viato nel 1945/46 al CAR di Bolzano dal Comune di Zola Predosa (BO);
Fotografie e certificati del CLN di Borgo Panigale (BO) inviati nel 1945/46 al CAR di Bolzano per la ricerca di IMI dispersi originari di quel comune;
Faldone nr. 173
Schede lavorative di altrettanti dipendenti del CAR di Bolzano;
29
Faldone nr. 174
“Rubrica generale” (lettera A) con nomi di persone disperse per le quali si danno notizie (dati anagrafici, indirizzo, eventuale data, luogo e causa di morte del disperso; nome cognome e indirizzo di colui che da notizie del disperso al personale del CAR);
Faldone nr. 202
Raccolta di telegrammi ricevuti dal CAR di Bolzano (richiesta informazioni su IMI da parte dei famigliari e altro); Richieste provenienti da tutta la penisola per la ricerca di dispersi nei lager; Relazioni sulla nascita e attività del CAR e in particolare “Atti dell’Ufficio Informa zioni e all’Ufficio Informazioni”; Elenchi di rimpatriandi da vari campi (Innsbruck, Mittenwald, Ulm, etc.); elenchi di ricoverati negli ospedali tedeschi con cause di ferimento e malattia;
- Elenchi con liste italiani liberati dagli Alleati e in fase di trasferimento verso l’Italia;
Faldone nr. 204
In questa cartella (PER LA LETTERA “D”) sono conservati documenti relativi a persone che ancora nel 1946 risultavano disperse in Germania o Russia o non aveva no più fatto ritorno dai lager germanici e per i quali non era possibile documentare la morte; diverso materiale inerente ricerche su deportati nel lager di Bolzano e parti giani deportati in Germania;
“Rubrica generale” (lettera “D”) con nomi di persone morte o disperse per le quali si danno notizie (dati anagrafici, indirizzo, data luogo e causa di morte; nome cognome e indirizzo del riportante la notizia);
“Rubrica generale” (lettere “N”, “O”, “P”) con nomi di persone morte o disperse per le quali si danno notizie (dati anagrafici, indirizzo, eventuale data, luogo e causa di morte; nome cognome e indirizzo delle persone che rilasciavano testimonianze in merito alla sorte dei dispersi);
Faldone nr. 206
In questa cartella (PER LA LETTERA “C”) sono conservati i casi relativi a persone che ancora nel 1946 risultavano disperse in Germania o Russia o non avevano più fat to ritorno dai lager germanici e per i quali non era possibile documentare la morte;
Faldone nr. 209
Elenchi di deceduti in vari lager, documenti di deceduti, atti di morte (tutti materiali portati in Italia direttamente dai campi in Germania); relazioni su incidenti ferroviari delle tradotte tedesche con elenchi puntuali di morti; Elenco con lista morti italiani deceduti nel lager di Buchow; Comunicazioni di morte ricevute da rimpatriandi (comprese numerose denuncie di eccidi compiuti a danno di italiani, p. es. l’omicidio di 4 generali di Brigata e 150 soldati italiani in Pomerania (relazione del 29.10.1945); inoltre molti elenchi di morti italiani nei bombardamenti su città tedesche (p. es. Monaco, 12.9.1944);
30
Faldone nr. 210
“Rubrica generale” (lettere E, F, G) con nomi di persone disperse per le quali si dan no notizie (dati anagrafici, indirizzo, eventuale data, luogo e causa di morte; nome cognome e indirizzo delle persone che rilasciavano testimonianze in merito alla sorte dei dispersi);
Faldone nr. 211
Elenchi nominativi riferiti a tradotte in arrivo dai lager tedeschi, in parte compilate anche da autorità alleate;
Faldone nr. 212
Relazioni alleate sulla situazione e sulle condizioni di vita degli IMI presenti in Ger mania;
Faldone nr. 214
“Rubrica generale” (lettera “S”) con qualche migliaio di nomi di persone morte o disperse per le quali si danno notizie (dati anagrafici, indirizzo, eventuale data, luogo e causa di morte; nome cognome e indirizzo del riportante la notizia);
Faldone nr. 215
Elenco di morti con cause decesso nello Stammlager III; Constatazioni di morte di IMI compilate da medici tedeschi; Dichiarazioni germaniche “Unfall-Meldung” (dichiarazioni di infortunio) relative ad IMI;
Faldone nr. 216
“Rubrica generale” (lettera “M”) con nomi di persone morte o disperse per le quali si danno notizie (dati anagrafici, indirizzo, eventuale data, luogo e causa di morte; nome cognome e indirizzo delle persone che rilasciavano testimonianze in merito alla sorte dei dispersi);
Faldone nr. 217
“Rubrica generale” (lettere “I” e “L”) con nomi di persone morte o disperse per le quali si danno notizie (dati anagrafici, indirizzo, eventuale data luogo e causa di mor te; nome cognome e indirizzo delle persone che rilasciavano testimonianze in merito alla sorte dei dispersi);
Faldone nr. 218
In questa cartella (PER LA LETTERA “M”) sono conservate lettere di famigliari che ancora nel 1946 risultavano dispersi in Russia o non avevano più fatto ritorno dai lager germanici e per i quali non era possibile documentare la morte.
Faldone nr. 219
In questa cartella (PER LE LETTERE “Q” ed “R”) sono conservate lettere di fa
31
migliari che ancora nel 1946 risultavano dispersi in Russia o non avevano più fatto ritorno dai lager germanici e per i quali non era possibile documentare la morte.
Faldone nr. 237
Raccolta di documenti dell’epoca appartenuti a prigionieri italiani (p. es “Arbeitsbuch fuer Auslaender”); schede di deportati politici italiani di Pola condotti a Buchenwald (alcune foto tessera); tessera TODT di lavoratore italiano; vari documenti personali di internati (lettere, foto, appunti, indirizzi);
Faldone della delegazione militare italiana di Zeitz; Liste di internati presenti a Mittenwald;
Faldone nr. 238
Copie originali del dattiloscritto “Gli italiani in Dachau”;
- Condizioni di vita, dichiarazioni di italiani liberati a Dachau e colà in attesa di trasferimento;
Documentazioni, lettere e corrispondenze interne ai comitati italiani presenti a Da chau dopo la liberazione; Materiale del comitato internazionale dei prigionieri di Dachau; Materiale vario originale sul Comitato nazionale italiano istituito a Dachau; Raccolta di giornali di altra nazionalità raccolti nel lager di Dachau; Ampia raccolta di copie del giornale “Gli italiani in Dachau” con materiale di reda zione.
2.3 Gli archivi degli internati.
Il fondo si è rivelato di grande interesse e può essere considerato sicuramente importante per la ricostruzione del fenomeno a livello nazionale. Voglio però anche ricordare che la ricerca archivistica in merito appare ancora ad uno stato decisamente pioneristico. A livello nazionale non esiste un censimento complessivo delle fonti. Non sappiamo dove siano custoditi i grossi nuclei di documentazione utile ad una ricostruzione e quantificazione puntuale del fenomeno.
Lo stesso archivio nazionale dell’ANEI è in attesa di riordino a Roma. Le sezioni locali dell’ANEI vengono progressivamente smantellate e la docu mentazione rischia di andare dispersa. La speranza è che questi materiali non vengano lasciati in balia del destino ma fatti confluire presso archivi pubblici (musei, biblioteche, istituti di ricerca storica) in grado di conservarli, catalogarli e metterli a disposizione dei ricercatori.
Ho scoperto il fondo di Bolzano per caso, grazie ad una segnalazione giuntami da un docente universitario tedesco, dr. Michael Wedekind, durante un convegno trentino. Il materiale che ho trovato è vastissimo; servirebbero indubbiamente molti anni di lavoro per raccogliere, catalogare e studiare tutte le informazioni contenute nella documentazione presente in questo archivio.
32
Un fenomeno, quello degli IMI, su cui conosciamo davvero molto poco. Non sappiamo esattamente, per esempio, quanti furono i morti: ci si accon tenta di stime. Rimangono notizie frammentarie per esempio sulle cause di morte, sui luoghi di detenzione e di lavoro, sui mancati aiuti internazio nali, sul ruolo avuto nell’intera vicenda dalla Repubblica Sociale Italiana e dall’Ambasciata italiana a Berlino. Mancano stime sulle migliaia di persone che morirono dopo la liberazione a causa delle conseguenze subite durante la prigionia. Mancano gli elenchi dei deceduti e dei dispersi, insomma mancano spesso anche i numeri, gli elementi quantitativi basilari per poter completare il quadro della ricerca.
Nella nostra Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in questi ultimi anni ci si è mossi con grande impegno e sostegno istituzionale per salvaguardare la memoria degli Internati Militari Italiani. La presente ricerca, voluta dal circolo culturale ANPI di Bolzano e sostenuta da diversi Enti della provincia altoatesina, oltre che da parte dell’Ente Regione, lo dimostra. In Trentino una ricerca di ampia portata è stata realizzata grazie ad una partnership tra la Fon dazione Museo Storico del Trentino e il Museo Storico della Grande Guerra di Rovereto, con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento.
2.4 ll CAR (Centro accoglienza rimpatriati). Una ricognizione sulla documentazione.
2.4.1 Notizie sulla nascita e organizzazione
Il Centro Accoglienza Rimpatriati (CAR), come già anticipato, era un’orga nizzazione che aveva il compito di sostenere gli IMI che rientravano dalla Germania e fornire loro un primo aiuto, talvolta anche sanitario, prima di consentire loro un rientro verso le rispettive famiglie.
Da Bolzano, provenienti dal Brennero, transitarono centinaia di mi gliaia di soldati, come si evince, ad esempio, dagli innumerevoli elenchi di rimpatriati che accompagnavano le tradotte di passaggio in città; non solo ex internati ma anche, seppur in forma minore, soldati di altre nazionalità e militari italiani che l’Unione Sovietica stava liberando dalla prigionia.
Ci sono comunque diversi documenti che descrivono nel dettaglio il funzionamento del CAR, una struttura che occupava diverse decine di persone. Da una relazione emerge un fatto molto interessante: una struttura di accoglienza era sorta già diversi mesi prima della fine della guerra, mentre Bolzano faceva ancora parte della Zona di Operazione delle Prealpi. Si trattava di un’organizzazione clandestina.
In alcuni documenti del fondo, infatti, ho trovato una relazione che reputo molto interessante. In essa i vertici del CAR ricostruiscono la genesi dell’organizzazione. Emergono dei particolari assai rilevanti: la solidarietà di una
33
parte dei cittadini di Bolzano e di rappresentanti della Chiesa cattolica aveva permesso la nascita di un comitato di assistenza rimpatriati già alcuni mesi prima della fine della guerra. Mi pare che l’episodio, ad oggi non molto noto, possa configurarsi come una delle più interessanti attività clandestine e di solidarietà sorte nel capoluogo all’inizio del 1945. Ecco le parole testuali del documento37: “Avvicinandosi il collasso della Germania e presagendo la catastrofe finale, verso i primi giorni del mese di febbraio [1945] iniziarono ad affluire in que sta città, con ogni mezzo di fortuna, numerosi nostri connazionali, lasciati perché ammalati o perché evasi da campi di concentramento, ritornavano in Patria, ansiosi di raggiungere le loro case, i loro cari.
Poiché questi nostri connazionali convergevano a Bolzano con un ritmo sempre maggiore e venivano a trovarsi in una tragica situazione per la mancanza totale di aiuti e di assistenza, per venire incontro alle prime necessità e alla dolorosa sorte nella quale si trovavano, il 12 febbraio 1945, sorgeva clandestinamente, in seno all’Ufficio della Filiale del Consorzio Agrario di Bolzano il “Piccolo Comitato di Assistenza ex Prigionieri”, allo scopo di assi stere e somministrare nelle modestissime possibilità del Comitato stesso, cibi caldi, denaro e indumenti di vestiario.
Tale attività, manifestatasi poi più apertamente, tuttavia sempre prima della liberazione fu continuata nei locali forniti dai Padri Domenicani della Parrocchia “Cristo Re” Viale Giulio Cesare e con slancio veramente ammire vole si poté assistere, con ogni possibile mezzo a disposizione, quel numero che diveniva sempre più numeroso di rimpatriati dalla Germania.
Pure spesso [da]i Padri Domenicani vennero distribuiti pasti caldi, in dumenti di vestiario, e quanto altro era possibile racimolare dalle offerte in denaro e in natura della cittadinanza di Bolzano.
Personale volontario prestava la sua opera per la preparazione delle vi vande e pure volontaria fu tutta la collaborazione di chiunque volesse tangi bilmente prendersi a cuore il problema scottante dei rimpatriati”.
Con la fine del conflitto le cose iniziarono a cambiare:
“Dopo il 3 maggio 1945, data della liberazione della città di Bolzano, si iniziò il vero e proprio trasporto degli ex internati dalla Germania che, raccolti in concentramento ad Innsbruck, giungevano con macchine italiane a Bolzano.
Con il permesso ottenuto dalla Crocerossina Mac Manara fu iniziato il primo servizio di soccorso; infatti nostre autocolonne con ambulanze si recarono ad Innsbruck cariche di viveri, di materiale sanitario, di generi di conforto messi a disposizione da numerose città d’Italia, specie dell’Italia Set tentrionale.
ASBZ, Archivio IMI/CAR, faldone nr. 221.
34
37
Ritornavano trasportando rimpatriati che, direttamente e con breve so sta a Bolzano, proseguivano per i luoghi di residenza.
Per lo smistamento e il seguente convogliamento per la partenza, prov vedevano, nel piazzale prospicente alla Chiesa di Cristo Re, i Capi Colonna provenienti dalle varie Città d’Italia.
Tali capi colonna, per lo più sacerdoti o incaricati della Commissione Pontificia di assistenza del luogo di provenienza, si suddividevano il non poco gravoso compito di raggruppare quei rimpatriati da poco giunti o comunque già sostanti, provvedendo alla partenza degli automezzi per le varie località di destinazione.
Erano stati issati, su alcuni pali dell’illuminazione pubblica, dei grandi cartelli indicatori in base ai quali i gruppi di rimpatriati avrebbero potuto esse re informati sul loro smistamento”.
Nel frattempo cresceva di giorno in giorno in modo esponenziale il numero di prigionieri che facevano rientro in Italia attraverso il Brennero. Diventava quin di un’esigenza primaria costituire un’organizzazione più ampia e strutturata:
“È evidente e risulta chiaro che per continuare una tale opera, dato l’afflusso sempre crescente di ex internati, era necessaria un’organizzazione… a disposi zione della quale vi fossero:
locali o comunque ambienti adatti ad alloggiare tutti quei rimpatriati che, giunti a Bolzano, non erano partiti in giornata per la loro destinazione;
- servizi sanitari che provvedessero, con un’adeguata tempestività, all’assistenza di coloro che, ritornati in condizioni fisiche non buone o addirittura pessime non erano assolutamente in grado di proseguire il loro viaggio;
- infine tutti quei vari servizi di carattere specifico e generale che assicurassero il buon funzionamento di una tale organizzazione.
Riconosciute queste ragioni della massima necessità, con il concorso del Co mando Alleato della città, della C.R.I. [Croce Rossa Italiana] e del C.N.L. [Corpo di Liberazione Nazionale] locale si formò il Centro Assistenza Rimpa triati (C.A.R.) con il fine parallelo al “Piccolo Comitato di Assistenza””.
Ecco dunque che il prezioso lavoro sino ad allora svolto da un’organizzazione privata di cittadini volontari venne trasformata in una più ampia struttura:
“Pertanto il 18 maggio c.a. [1945] il C.A.R. sistemato nei locali della ex Caserma della G.A.F. [Guardia Alla Frontiera] in via Merano38 , dava inizio a quell’assistenza morale e materiale necessaria e svolgeva su un piano coor dinato il sollecito smistamento dei reduci verso la loro destinazione. Ne fu
38 Oggi caserma Huber, in viale Druso 110 a Bolzano.
35
assunta la Direzione dall’Avvocato Bertoli Bartolo39, da poco liberato dal campo di concentramento di Bolzano, e dal prof. Luigi Pirelli40, in qualità di Ispettore, pure ex internato di Bolzano, i quali organizzarono tra i primi, animati da quello spirito altamente umanitario che li distingueva, la vita del campo di smistamento di Via Merano”. Altra figura molto importante per la risoluzione dei problemi di carattere sanitario e per l’approvigionamento dei medicinali fu la capo gruppo della CRI di Bolzano, Anna Fox (già attiva con il Piccolo Comitato): “La sorella Fox presente ovunque, energica e fattiva collaboratrice, infinitamente generosa verso quelli che chiamava “i miei ragazzi”, fu tanto preziosa nell’opera di organizzazione del campo”. Il 25 maggio 1945 iniziarono ad arrivare dei me dici direttamente da Milano; fino ad allora tutti i casi venivano gestiti da due medici dell’Ospedale Civile di Bolzano: il prof. Casanova e il Dottor Zanoni. Alla fine del mese di maggio si registrò una grave epidemia di tifo esentematico, portato da alcuni sopravvissuti del campo di Dachau, dove la malattia era già presente da alcuni mesi. Fu necessario bonificare tutta l’area del CAR e disinfettare ogni locale con acido cianidrico: ne conseguì un forzato rallentamento dell’attività di accoglienza del CAR per alcuni giorni. Vi fu quindi un ampliamento dei posti letto per ammalati che, entro l’estate, arrivarono a toc care presso il CAR le 120 unità. Furono istituti anche altri ambulatori, reparti di degenza per maternità e infanzia. Presso l’Ospedale Civile della città venne inoltre preparato un reparto apposito (con 200 letti) per le forme morbose più gravi. A volte arrivavano dalla Germania interi treni ospedale (ne arrivò uno da Linz carico di 255 ammalati gravi). In seguito fu creata anche una picco la postazione di pronto soccorso presso la stazione ferroviaria di Bolzano. Quando i malati iniziarono ad essere molti fu lanciato un appello alle provin cie del nord Italia affinché inviassero pullmann o automezzi necessari per il trasporto dei malati negli ospedali delle rispettive provincie di provenienza. La relazione ci dice che le peggiori condizioni di salute si riscontravano negli internati (definite come “scadenti”) ma decisamente “pietose” per i superstiti dei campi politici (Dachau, Mauthausen, Buchenwald). In generale le malattie più diffuse tra i rimpatriati erano: la TBC polmonare, gravi esaurimenti con segni di avitaminosi, forme intestinali acute, malattie veneree e cutanee. Le forme chirurgiche gravi venivano dirottate sull’ospedale civile di Gries.
Presso il CAR venne organizzata anche una struttura con cucine adatta a fornire in qualunque momento del cibo caldo per coloro che continuavano ad affluire in città. Bisognava inoltre creare delle diete personalizzate per i degenti del reparto di Sanità del CAR. Venne messo in piedi pure un gran de magazzino viveri, idem per i vestiari. Uffici appositi dovevano rilasciare documenti di rimpatrio a tutti coloro (ex-internati militari, deportati politici
39 Bertoli Bartolomeo (detto Bartolo), matricola 9938, Blocco E. In Dario Venegoni, Uomini, donne e bam bini nel Lager di Bolzano. Una tragedia italiana in 7809 storie individuali, Mimesis, Milano, 2004, p. 74.
40 Pirelli Luigi, matricola 9981, Blocco A. In Dario Venegoni, op. cit., p. 287.
36
Con questa comunicazione il primo Direttore del CAR, avvocato Bertoli, chiedeva di poter tornare a casa e rivedere la sua famiglia. Dopo la fine della guerra, infatti, con spirito di abnegazione e nonostante le dure peripezie provate nel lager di Bolzano, si era trattenuto nel capoluogo altoatesino proprio per dirigere l’or ganizzazione di accoglienza verso i rimpatriati.


37
e civili, rastrellati, lavoratori coatti o volontari) che ritornavano dalla deten zione. Il Reparto incaricato di quest’ultima attività venne denominato Ufficio Schedario o Matricola o Registrazione e vedeva impiegati più di 20 addetti. All’arrivo presso il CAR il rimpatriato otteneva un documento che serviva anche come foglio di via per poter procedere verso la propria destinazione. I lavoratori e le lavoratrici del CAR spesso non avevano orari o turni e dovevano fare degli enormi sacrifici per tenere in piedi l’organizzazione.
Come dirigenza del CAR fu nominato un Presidente dell’Ufficio Di rezione, Vincenzo Ventafridda41; direttore fu invece prima l’avv. Bertoli, in seguito – a partire dal 16.6.1945 – il signor Roberto Negri di Pavia. Essi lavorarono in ottima sintonia con gli Alleati, in particolare con il Maggiore Geddes e con il Capitano Stevenson. L’ufficio personale era gestito dal Sig. Bruno Gasperini, dipendente delle Acciaierie di Bolzano. Da segnalare che con la nuova organizzazione alcuni dipendenti del CAR erano regolarmente stipendiati, come dimostra l’ampia documentazione a proposito conservata nel fondo. Altri erano decisamente volontari. In particolare erano volontarie le addette del Servizio di Assistenza del CAR: “Grazie all’opera di umana solidarietà svolta dalle addette del Reparto di Assistenza fu possibile aiutare anche in denaro i rimpatriati più bisognosi che, sprovvisti di ogni mezzo, an che limitatissimi, non potevano certo lasciare il Centro senza una pur piccola assistenza sanitaria”42 .
Vi furono giorni con il transito nel CAR di più di 10.000 ex internati. In pochi mesi la situazione provvisoria che era stata allestita davanti alla Chiesa di Cristo Re, veniva trasformata in un’organizzazione molto efficiente. Colon ne di automezzi (all’inizio forniti direttamente dagli Alleati, poi impiegando camion già appartenuti alle forze militari tedesche) facevano la spola tra la stazione ferroviaria e il campo di smistamento del CAR in via Merano 24. Arrivati al campo gli internati ricevevano un buono di prelevamento viveri. Muniti di tale buono venivano immessi in un grande cortile dove veniva di stribuito un primo rancio caldo. Potevano inoltre effettuare una prima som maria pulizia presso alcune grandi fontane a getto continuo poste sotto alcune tettoie di cemento. Mano a mano, venti per volta, entravano poi nell’ufficio incaricato di rilasciare le schede di rimpatrio. A questo punto entravano in gioco i Reparti di Assistenza del CAR che aiutavano i più bisognosi: indivi duavano i bisognosi di urgenti cure sanitarie, chi era bisogno di scarpe perché scalzo o di pantaloni perché sprovvisto… A tal proposito, come già anticipato, era stato istituito un magazzino vestiario (con a capo il Sig. Brazzoli del cal zaturificio “Rossi” di Bolzano): gli indumenti venivano garantiti dal comando Alleato, dalla Croce Rossa e dalla Commissione Pontificia di Assistenza.
Si poneva poi la questione di spedire i rimpatriati nelle rispettive provin cie di residenza. Lo smistamento avveniva nel cortile centrale del CAR sotto
41 Vincenzo Ventafridda fu anche Presidente dell’Assoimprenditori dell’Alto Adige dal 1945 al 1950.
42 ASBZ, Archivio IMI/CAR, faldone nr. 221.
38
il coordinamento dell’Ufficio Trasporti, diretto dall’Ing. Ernesto Pini, genove se, ispettore della Croce Rossa Italiana. Un sistema di autoparlanti permetteva il coordinamento delle partenze. Per le zone dell’Italia centro-meridionale era previsto l’invio a Modena, dove avveniva un ulteriore smistamento.
Il carburante per tutti i mezzi veniva prelevato con appositi buoni rila sciati dagli Alleati. Il rifornimento avveniva al Campo 23, ovvero presso l’ex campo di concentramento di Bolzano. Coloro che non riuscivano a partire durante la giornata potevano fruire di un posto per il pernottamento.
Vi era un Ufficio Amministrazione che sovraintendeva anche agli ac quisti e agli approvvigionamenti, oltre che alla costante manutenzione del Centro. Gli operai in servizio erano stati messi a disposizione dalla Società Acciaierie e dalla S.I.D.A. di Bolzano. Amministratore del CAR fu il rag. Mario Castellani delle Acciaierie di Bolzano.
Venne poi allestito un impianto radio grazie all’intervento di alcuni tecnici giunti appositamente da Milano (su iniziativa dell’Associazione Nazio nale Reduci di Prigionia, Comitato Provinciale di Milano). “Esisteva quindi una cabina radio dalla quale venivano impartiti gli ordini, a mezzo di un impianto di amplificatori, al cortile arrivi per i rimpatriati che sostavano e al cortile partenze per coloro che si accingevano a lasciare il campo sugli auto mezzi. Pure attraverso la radio venivano eseguite ricerche di ex-prigionieri in Germania, con la lettura di elenchi nominativi”43. In seguito avremo modo di parlare ancora di questo servizio.
2.4.2 L’Ufficio informazioni del CAR
L’Ufficio Informazioni venne costituito il 2 giugno 1945 presso il CAR ma era già attivo in precedenza presso il Convento dei Dominicani di Cristo Re. L’ufficio aveva il compito di raccogliere, schedare, catalogare, elaborare statistiche, ordinare informazioni da coloro che rientravano dalla Germania e cercare di dare una risposta alle migliaia di richieste che nel contempo arriva vano da tutta la penisola. Un lavoro che dalle relazioni appare come immane, svolto senza tregua da numerosi addetti il giorno e la notte. In particolare l’Ufficio Informazioni era incaricato di tenere aggiornati questi documenti:
una rubrica di internati ancora in attesa di rimpatrio;a) uno schedario dei deceduti;b) un elenco di messaggi radio alle famiglie, degli internati che attenc) devano il rimpatrio e assicurano di stare bene; un elenco delle persone di cui famigliari stavano cercando notizie”.d)
39
43 ASBZ, Archivio IMI/CAR, faldone nr. 43
All’Ufficio Informazioni del CAR giungevano informazioni dagli internati che erano appena rimpatriati dalla Germania; ad esso si rivolgevano decine di migliaia di famiglie italiane che attendevano con ansia notizie sui loro con giunti.

Le richieste di informazioni venivano evase con uno straordinario, ma non meno difficoltoso, lavoro di coordinamento, svolto senza tregua da diverse decine di persone – molte erano donne – in servizio presso il CAR. Una volta accertato il caso si provvedeva a inoltrare una risposta agli interessati. Nel caso in dettaglio, l’Ufficio Informazioni avvisa i famigliari di un internato che il loro caro sta bene e spera di tornare presto in Italia:

40
Nei giorni successivi alla fine del conflitto iniziarono a formarsi spontane amente, per iniziativa di singoli cittadini o di istituzioni, in quasi ogni città d’Italia dei centri aventi lo scopo di cercare notizie di militari di cui non si avevano più informazioni, perché internati in Germania, deportati o dispersi in Russia. Particolarmente organizzati in questo senso erano diversi comuni dell’Emilia Romagna; nel fondo dell’Archivio di Stato sono presenti numerosissime richieste (con allegate fotografie degli scomparsi) inviate dalle zone di Borgo Panigale, Zola Predosa, Sala Bolognese. Diverse richieste giungono anche dalla Lomellina, in Lombardia.

Ecco di seguito alcuni esempi. In questo primo caso è il CLN di Borgo Panigale che manda delle schede con dati anagrafici di soldati originari della zona:

41
Nel secondo caso che presento è il Comune di Sala Bolognese ad inviare, ancora nel maggio 1945, delle schede con fotografie di internati al CAR di Bolzano. L’unica informazione sulla prigionia riguarda il numero di matricola assegnato nei Lager. Ecco due esempi:


42
Il Comune di San Giorgio di Lomellina, nel pavese, predispone delle schede più dettagliate, in cui vengono riportate informazioni precise sulla prigionia (in particolare l’ultimo indirizzo in Germania dell’internato). Manca però, in questo caso, la fotografia del soggetto:

43
Già nel luglio del 1945, quando venne ripristinata la linea ferroviaria fino a Pescantina, molte tradotte non fermavano più a Bolzano. Fino ad allora, tutta via, erano passate decine e decine di migliaia di persone dal CAR altoatesino. Dal 15.7.1945 l’Ufficio Schedario cessò la sua attività che invece fu continuata da un analogo ufficio installato a Pescantina. A partire da quel momento al cuni reparti del CAR bolzanino vennero smantellati. Il Reparto Sanità portò tuttavia a 500 i propri posti letto: in tal modo potevano essere ancora accolte intere tradotte ferroviarie di ammalati provenienti dalla Germania. Anche per motivi finanziari venne chiusa la sezione sanitaria staccata allestita presso l’Ospedale Civile di Bolzano.
Sempre in quel periodo venne chiuso il posto di ristoro allestito internamente al CAR e riaperto presso la Stazione ferroviaria – in località detta

44
Infine una delle numerose richieste giunte anche dal Comune di Zola Predosa:
“Siberia” – per le tradotte in transito. Anche l’Ufficio Trasporti venne aggre gato al posto ristoro, così come il servizio radio che trasmetteva programmi con ricerca di notizie di connazionali dispersi mentre i treni sostavano sulla banchina in attesa di ripartire verso Pescantina.
Su vagoni improvvisati presso la stazione ferroviaria vennero allestiti anche una filiale della Direzione del CAR, una piccola infermeria, una sezione staccata dell’Ufficio Informazioni. I treni in arrivo a Bolzano erano accolti dal suono dell’“Inno al Piave”, ascoltate “in religioso silenzio” dai rimpatriati, come è scritto nella relazione.
Poi le tradotte ripartivano: “… Verso Verona, verso il Po, verso le case di ognuno, sempre troppo lentamente – povera tradotta – troppo lentamente per chi invece ha troppa fretta”.
Come già detto, il CAR accoglieva chi rientrava dalla Germania, forni va pasti caldi e vestiti, una prima assistenza sanitaria, organizzava un sistema di trasporti dalla stazione ferroviaria alla propria sede e dalla propria sede verso altri centri di smistamento del nord Italia. C’erano degli autisti che ave vano il compito di caricare gli internati provenienti da determinate provincie e condurli a destinazione.
Ma il CAR aveva anche il compito di raccogliere, attraverso il proprio Ufficio Informazioni, notizie sugli internati che non erano ancora potuti rien trare in Italia per ragioni di salute. Inoltre riceveva migliaia di lettere e richieste che arrivavano da tutta la penisola: erano mogli, sorelle, fratelli di interna ti (ma anche di dispersi in Russia o deportati politici e civili) che chiedevano notizie dei propri cari. Talvolta mandavano dei biglietti che i dipendenti del CAR appendevano su una grande parete, davanti alla quale passavano coloro che erano appena giunti dalla Germania, nella speranza che qualcuno potesse dare delle notizie utili per i famigliari.
Ecco l’esempio di una richiesta inviata al CAR di Bolzano da una famiglia veneta: si tratta di un fante che nel settembre del 1943 era stato fatto prigioniero dai tedeschi in Croazia.

45
Tra le altre documentazioni d’archivio inerenti la struttura e l’organizzazione del CAR vi sono anche le pla nimetrie. Questo è lo schema del primo piano dell’edificio sito in via Merano 24: si notano i locali sanitari per le crocerossine, le sale per le radiografie (molti di coloro che rientravano erano affetti da TBC o gravi malattie polmonari).

Un permesso di circolazione sulla tratta Bolzano-Verona-Modena rilasciato al CAR dal governo militare alleato di Bolzano. Senza quest’autorizzazione nessun mezzo poteva circolare.

46
2.4.3 La cartella delle corrispondenze
Tra le tipologie di documenti ricorrenti all’interno dei vari faldoni del fondo, vi sono le “cartelle delle corrispondenze”. La “cartella delle corrispondenze” è una raccolta di documenti usata da gli impiegati del CAR per riportare notizie e documenti su internati in merito ai quali venivano richieste notizie dai famigliari, tramite lettera o verbalmente. Esiste una cartella per ogni lettera dell’alfabeto (in riferimento all’iniziale del cognome di ogni soggetto incluso nello schedario):

Ecco un esempio di richiesta giunta al CAR (nella fattispecie un soldato della Divisione Julia dato per disperso in Russia dal gennaio 1943) e inserita nella cartella delle corrispondenze:

47
Dopo i dovuti accertamenti nella documentazione disponibile, gli impiegati del CAR mandano una risposta negativa alla famiglia del disperso:
Il documento successivo testimonia che tra gli Internati Militari Italiani vi erano anche dei sudtirolesi di lingua tedesca (soldati dell’esercito italiano, non optanti, che non avevano voluto arruolarsi nelle forze armate tedesche dopo l’8 settembre 1943). È il caso di Joseph Niederkofler, classe 1923, di S. Andrea di Bressanone, cercato dalla famiglia:


48
Tra coloro che inviano richieste di informazioni vi sono anche famigliari di deportati per motivi razziali. Nell’esempio riportato il signor Ercole Norzi cerca notizie dei propri cari (tra i quali anche una ragazzina arrestata insieme al padre a Genova nel novembre 1943 e condotta, con molta probabilità, in un campo di sterminio in Germania):
La Pontificia Commissione di Assistenza (comunemente ricordata come “la Pontificia”) era un organizzazione, con presenza in ciascuna delle Diocesi italiane la quale, dopo la fine del conflitto, si prestò con ogni mezzo per aiu tare coloro che rientravano dalla Germania. Tra le altre cose essa forniva ai rimpatriati una cartolina con la quale essi potevano dare notizie su coloro che ancora non erano potuti rientrare dalla prigionia.
2.4.4 I documenti degli Alleati
Nel fondo depositato presso l’Archivio di Stato di Bolzano c’è una quantità in numerevole di documentazione prodotta dalle autorità Alleate, in particolare una quantità davvero notevole di liste con tutti i nomi e cognomi degli internati che da Innsbruck rientravano a Bolzano attraverso il Brennero. Spesso

49
è presente un certificato allegato alle liste nominali: serve a dimostrare che i rimpatriati sono stati sottoposti ad un rigido controllo sanitario e disinfettati con DDT (dicloro-difenil-tricloretano):
Ecco nel dettaglio l’esempio di una delle liste di cui si è appena parlato. Oltre al nome e al cognome degli internati presenti nella tradotta, ci sono anche la provincia di origine e la data di disinfezione e di visita medica (il documento specifico qui riprodotto fu redatto ad Hildenheim l’8 giugno 1945 dall’UNRRA, l’United Nations Relief and Rehabilitation Administration, un’organiz zazione umanitaria internazionale sorta nel 1943 a Washington e finanziata prevalentemente dal governo degli USA il cui compito fu quello di fornire aiuto e assistenza ai paesi più colpiti dalla guerra)

50

51
Presso il CAR in via Merano ma anche presso la stazione ferroviaria era stato allestito un efficiente sistema radio indispensabile per dare comunicazioni di servizio ai rimpatriati di passaggio.
Nel giugno del 1945 viene preparata una relazione, inviata da un certo Santi Vincenti al Comitato Nazionale Reduci di Prigionia, in cui si spiega nel dettaglio il funzionamento della struttura radio allestitita all’interno del CAR:
“… Alla stazione ferroviaria, i reduci provenienti da Innsbruck in tradotta vengono divisi in due gruppi: i diretti oltre Bologna e i settentrionali. Quelli del meridione prendono posto su un autocolonna e partono subito, gli altri vengono avviati al centro di raccolta di Bolzano. Qui lo smistamento si divide in tre ser vizi: arrivo, attesa, partenza. Il servizio è continuativo giorno e notte”.

52
2.4.5 Il servizio radio presso il CAR e alla stazione di Bolzano
Presso il CAR, per comunicare con gli internati, vennero preparati dei mes saggi radio pre-registrati. Il primo era destinato a coloro che erano appena giunti:
“Rimpatriati attenzione! Presentatevi alla porta in fila per due e ritirate il buono per i viveri! Vi accoglie in questo campo il primo saluto della patria! Questo è un campo di transito e smistamento dove resterete per poche ore. Ri ceverete tutto il necessario cioè viveri, indumenti, alloggio e ogni assistenza ma nulla di superfluo. Tutti gli ufficiali si presentino alla Direzione per i buoni mensa. Eseguite con disciplina tutti gli ordini del personale, non affollatevi, non fate confusione! Per la partenza sarete avvisati in tempo”.

Un secondo messaggio è destinato a chi rimane in sosta:

53
“Attenzione! Dovete rimanere in questo campo solo poche ore. Ripartirete al più presto per raggiungere casa vostra. Ora dovete riposarvi, pulirvi alle fon tane, rifocillarvi e in seguito passare all’Ufficio Schedario in fondo al cortile dove vi sarà rilasciato il foglio di viaggio. Quando vi chiameremo salirete sugli autocarri e consegnerete il foglio di viaggio; per ora non consegnatelo a nessun altro, poi partirete per casa vostra. Eseguite gli ordini con disciplina e calma! Sugli autocarri c’è posto per tutti!!!”.
Un terzo avviso radio è destinato a chi sta per partire con l’autocolonna:
Queste le parole che pronunciava lo speaker:
“Attenzione! Tra poco partirete per la vostra destinazione, dovete perciò for mare tre gruppi ben separati sotto i relativi cartelli: il primo gruppo compren de tutti i rimpatriati diretti in Liguria, Piemonte, Lombardia. Il secondo gruppo comprende tutti i rimpatriati delle Tre Venezie. Il terzo gruppo comprende

54
tutti i rimpatriati diretti all’Italia Centro-Meridionale, cioè a tutte le località al di sotto della linea del Po.
Eseguite gli ordini con disciplina e calma, così affretterete la vostra partenza… La precedenza nell’effettuare i carichi dei mezzi di trasporto deve essere data:
1) ammalati; 2) internati politici; 3) prigionieri; 4) lavoratori deportati; 5) lavoratori volontari”.

Col successivo messaggio radio i rimpatriati di passaggio al CAR ve nivano invitati a rilasciare notizie e informazioni e a consegnare documenti collegati alla prigionia o al destino di altri internati:
“Rimpatriati attenzione! L’Ufficio Informazioni comunica:
Tutti coloro che hanno notizie di compagni morti, ammalati, ricoverati all’Ospedale o dispersi favoriscano darne comunicazione esclusivamente agli incaricati. Chi avesse elenchi di morti li presenti in visione. Chi avesse elenchi di compagni rimasti in Germania favorisca presentarli per la trasmissione radio.
Tutti gli ufficiali, Cappellani militari e fiduciari di Lager sono invitati a dare breve relazione sui campi di concentramento. È dovere rassicurare chi attende.
55
Per la tranquillità dei parenti non date notizie di morte a chi non appar tiene all’Ufficio Informazioni.
Attenzione! Se avete smarrito parenti, compagni o bagagli o altri ogget ti, fate avvertire subito la Cabina Radio.
Rimpatriati attenzione!
Notizie sul servizio postale e telegrafico. In tutte le provincie il servizio postale e telegrafico è regolare: potete scrivere, telegrafare, telefonare a pa renti ed amici.
Da Bolzano e Trieste potete soltanto scrivere”.
Un ultimo messaggio, di carattere più generale, informava gli internati circa l’assistenza che si stava organizzando in tutto il Paese per aiutare i rimpatriati:
“In ogni capoluogo è costituito il Comitato Reduci della Prigionia: se non esistesse nel vostro paese, è vostro dovere prendere accordi col Comitato Provinciale presso l’Associazione Combattenti e costituirlo. L’assistenza si divide in tre rami:
Prigionieri di guerra ed internati militari;1) Deportati politici e lavoratori forzati;2) Lavoratori civili.3)
Il governo ha stanziato in bilancio la somma di 47 miliardi per l’assistenza a tutte le vittime della guerra….”.

56
L’ufficio radio allestito presso la Stazione ferroviaria di Bolzano rice veva a sua volta lettere da parte di famigliari di internati che richiedevano la lettura di messaggi alle tradotte di passaggio. Eccone un esempio:
“Roma, 29 settembre 1945.
Gent.mo Sig. Capo Stazione, mi scuserà se la disturbo, ma si tratta di cosa urgente e non so proprio a chi rivolgermi se non a lei.
Ho saputo che nella sua stazione è stato installato un ufficio che a mezzo di un altoparlante domanda notizie di militari ex-prigionieri a quelli che han no la fortuna di rientrare.
La prego vivamente passare la presente all’ufficio competente perché richieda notizie del fante Pacifici Vittorio di Tivoli (Roma) fatto prigioniero nel settembre 1943 a Corfù.

Sono certo che lei mi farà questo piacere, cercando così di alleviare la nostra famiglia di una grande pena…”.
2.4.6 Gli elenchi con le notizie
Credo che tra i documenti più interessanti “scovati” presso l’archivio di Bol zano vi siano degli elenchi, redatti dal personale del CAR, con notizie puntua li su diverse decine di migliaia di internati. Oltre alle notizie viene riportata anche l’identità di chi ha passato le informazioni agli impiegati. Per ogni lettera dell’alfabeto esiste un apposito elenco (la lettera è riferita all’iniziale del cognome dell’internato di cui si forniscono notizie). All’interno dell’elenco gli internati sono poi distinti per provincia di provenienza. Il fondo dell’Archivio di Stato raccoglie molti elenchi ma purtroppo altri sono mancanti.
Le notizie, come può essere osservato negli esempi che seguono, indi cano anche casi di decesso (causato talvolta anche da omicidio) di internati. Elenco relativo alla lettera R; il documento si riferisce in particolare ad internati originari della provincia di Reggio Emilia:
57
Di seguito l’elenco relativo alla lettera S. Nel documento riprodotto, in parti colare, ci si riferisce ad internati originari della provincia di Venezia. Questi elenchi sono utili anche per avere un’idea piuttosto precisa delle principali cause di morte degli internati:

Di seguito l’elenco relativo alla lettera T. Nell’esempio proposto si forniscono notizie su internati originari della provincia di Firenze:

58
Gli ultimi due esempi si riferiscono ad internati il cui cognome inizia con le lettere “V” e “Z”.



59
2.4.7 Gli elenchi dei decessi
Nel fondo del CAR depositato presso l’Archivio di Stato non mancano, e sono davvero numerosi, gli elenchi con deceduti per singolo campo di internamen to. Sono migliaia i nominativi riportati, con luogo, causa di morte e data del decesso. Queste liste dovrebbero costituire una delle fonti principali nel caso in cui si volesse avviare a livello nazionale l’elaborazione di un elenco degli IMI morti nel Terzo Reich. Queste liste erano state compilate da sacerdoti o fiduciari direttamente durante la prigionia e vennero consegnate all’Ufficio Informazioni del CAR durante il passaggio a Bolzano. Si poneva quindi la questione di comunicare il decesso, una volta verificato, ai familiari del caduto. Operazione che talvolta svogeva la Comissione Pontificia, come dimostra l’annotazione sul documento qui riportato:

60
Ecco un esempio di registro defunti (qui riferito allo Stammlager IIIA di Lu ckenwalde, non molto distante da Berlino)… Con un esempio delle pagine interne dello stesso registro. Ci sono tutte le cause di morte e il luogo di sepoltura (tra le cause di morte sono predominanti le malattie polmonari e i bombardamenti aerei causati dagli Alleati):


61
Non meno interessanti – anche se decisamente meno frequenti come tipologia di documenti – sono gli elenchi di coloro che avevano terminato la prigionia in Unione Sovietica e facevano ritorno in Italia. Nel documento d’esempio, datato settembre 1945, sono elencati alcuni ex prigionieri (già combattenti del CSIR, corpo italiano di spedizione in Russia) rilasciati dal campo di Gorky, vicino a Mosca, in transito da Bolzano:

62
2.4.8 Gli elenchi dei rimpatriati dalla prigionia in Russia
2.4.9 Il registro con le comunicazioni di morte

In un apposito registro vengono raccolti documenti e comunicazioni relative ai soli internati deceduti in Germania. Ecco la copertina di uno degli esemplari conservati nell’Archivio:
All’interno si trova un indice con l’elenco di tutti i casi trattati nel singolo fascicolo:

63
Questa è una dichiarazione di morte relativa ad un internato originario della provincia di Bolzano, morto per malattia:

Molti internati arrivano in Italia in condizioni di salute pietose. Qualcuno non ha nemmeno il conforto di poter morire tra le braccia dei propri cari e si spegne nell’Ospedale del CAR. Il documento certirfica la morte di un ragazzo di soli 24 anni:

64
Anche questa tipologia di documentazione è sicuramente molto utile per af frontare la questione delle principali cause di morte degli internati. Ci sono casi di decesso in conseguenza di maltrattamenti:
Da Bolzano passano anche alcuni sopravvissuti all’eccidio di Cefalonia. Un friulano testimonia della fucilazione del proprio sottotenente, avvenuta il 22.9.1943:


65
Nei lager si moriva per nefrite e broncolpolmonite:
Si hanno conferme di morti anche tra i prigionieri dei sovietici (dalla relazio ne le condizioni di trattamento dei prigionieri italiani da parte dei sovietici non sembrano molto diverse da quelle riservate dai tedeschi agli IMI):


66
Ci sono poi notizie sulle migliaia di soldati italiani fatti prigionieri dai tede schi dopo l’8 settembre 1943 sulle isole dell’Egeo e morti durante il trasporto verso il continente perché le navi venivano affondate dagli apparecchi anglo americani.

Nei lager si moriva per dissenteria grave:

67
Per meningite:
Per omicidio causato da una sentinella tedesca:


68
O fucilati per mano di un poliziotto:

Giovani di poco più di vent’anni erano spirati nei lager a causa del tifo addo minale:

69
O ancora a pistolettate durante il trasferimento da una baracca ad un’altra:
I documenti sopra riportati sono solo degli esempi ma aiutano a comprendere come la morte degli internati dipendesse da pietose condizioni igieniche, sa nitarie e, in generale, a causa dei maltrattamenti – talvolta assassini – cui gli internati vennero sottoposti.

70
2.4.10 Alcuni esempi di lettere dei famigliari

Particolarmente toccanti sono le migliaia di lettere conservate nel fondo ar chivistico in oggetto.
Una madre disperata scrive al CAR di Bolzano perché da tempo non riceve più notizie del proprio figlio internato.
71
Un figlio chiede notizie del proprio padre, deportato politico di Bologna e finito a Dachau. Scrivono, seppur di rado, anche i genitori di combattenti della RSI di cui si sono perse notizie. La scrivente in oggetto cerca notizie del figlio inviato nel 1945 in addestramento con una divisione repubblichina in Germania.


72
I parenti degli internati allegano talvolta alla propria richiesta anche una copia dell’ultima cartolina che i loro congiunti hanno inviato dal Lager. Nel settembre 1945 questa donna cerca notizie del proprio marito, di cui non sa più nulla da 13 mesi.

Un ex internato trentino, dato ufficialmente per morto, tramite un sacerdote scrive al CAR per testimoniare che, invece, è sano e salvo.

73
Decine di migliaia di genitori non vennero mai più a conoscenza della sorte dei loro figli, catalogati per sempre nella categoria dei “dispersi”. Un padre cerca notizie del proprio figlio, di cui riporta anche l’ultimo indirizzo conosciuto.
In questo caso la triste risposta del CAR non tarda ad arrivare. Il poveretto era morto per malattia nel gen naio 1945.


74
2.4.11. La documentazione dei campi: Weiden
Con questa ricerca non è stato possibile procedere ad una ‘mappatura’ di tutti i luoghi di detenzione destinati agli IMI; da un lato perché l’universo dei campi è vastissimo e il fondo contiene informazioni solo su una parte dei campi destinati agli internati. In seconda battuta voglio anche ricordare che le informazioni sui singoli campi sono distribuite all’interno di una vastissima miscellanea di documenti che costituiscono il fondo. Fatte queste dovute premesse, ho voluto comun que procedere con un ‘carotaggio’, un piccolo approfondimento in relazione a due Lager dei quali si disponeva di più documentazione: Weiden e Memmingen. All’interno del notevole materiale che all’epoca fu raccolto dagli operatori del CAR e che oggi viene conservato presso l’Archivio di Stato di Bolzano esi stono una serie di documenti portati dai “fiduciari”, i rappresentanti degli IMI nei lager. Per quanto riguarda il campo di Weiden ho rinvenuto numerose carte che testimoniano del tentativo di questi fiduciari di ottenere, anche attraverso l’ambasciata italiana a Berlino, migliori condizioni di vita per i prigionieri.
La documentazione di seguito proposta si riferisce, appunto, al caso dello Stammlager XIII-B di Weiden. Può essere interessante vedere qualcuno di questi documenti in “presa diretta”. Il rappresentante degli italiani, tale Lobba Edo, nell’ottobre del 1944 scriveva ai diplomatici italiani presenti nella capitale del Terzo Reich (SAI, Servizio Assistenza Internati, con sede in Graf Spee Strasse 1/7 a Berlino)44. Nel caso specifico riferiva di un vagone di latte condensato e gallette giunto dall’Italia per gli IMI ma trattenuto dagli ufficiali tedeschi (che, a suo dire, facevano di tutto per impedire che il cibo venisse consegnato ai prigio nieri). Questa era una consuetudine; spesso i vagoni non arrivavano nemmeno ai Lager in quanto se ne appropiavano direttamente le forze armate germaniche:
44 Il Servizio Assistenza Internati (SAI) venne allestito nel febbraio 1944 presso l’ambasciata italiana a Berlino.

75
In tutta risposta, anziché intervenire presso l’Autorità tedesca, pochi giorni dopo l’ambasciata italiana chiedeva al fiduciario di specificare “con sollecitu dine” numero e contenuto dei vagoni pervenuti dall’Italia…

Il 10 novembre il fiduciario riusciva finalmente a comunicare che erano arri vati due vagoni: uno il 18 luglio (!), carico di gallette; l’altro il 12 ottobre, ca rico di latte condensato, medicinali e libretti di lettura. Non sappiamo se alla fine questi elementi di prima necessità furono effettivamente dati in consegna agli internati oppure – come è invece più probabile – fatti propri dai soldati tedeschi.

76
Il servizio assistenza internati, che faceva riferimento alla Repubblica Socia le Italiana, pareva piuttosto interessato ad avere dal fiduciario un elenco di tutti gli ufficiali presenti nello Stalag di riferimento. Forse questo serviva per tentare di arruolare elementi da inviare a Salò, visto che non avevano avuto particolare successo i tentativi precedenti:
Altro documento interessante è il seguente. In esso il fiduciario di Weiden scriveva al responsabile di un campo lavoro (Harsdorf) per comunicargli che la Croce Rossa Internazionale di Ginevra, cui si erano rivolti 4 internati di Harsdorf, dava notizia di non poter fornire alcun aiuto agli IMI:

Nonostante le privazioni e lo sconforto, si registravano tuttavia importanti atti di solidarietà degli internati verso i connazionali sottoposti a duri bombardamenti aerei da parte degli Alleati. Nel caso specifico gli IMI inviano una som

77
ma per i sinistrati di Treviso, città colpita più volte da pesanti e sanguinose in cursioni (l’episodio più grave si era verificato il 7 aprile 1944, venerdì Santo):
Nel gennaio del 1945 il fiduciario di Weiden non aveva più nemmeno materiale per scrivere e per gestire il suo piccolo ufficio. Era costretto a comperare ma teriale di sua tasca perché dal SAI di Berlino non arrivava più nulla: “Figurarsi che come protocollo mi servo di un quaderno scolastico, matite ne ho due, di quelle a colori non ne parliamo, nemmeno una cartella, registri non ricordo nemmeno più come siano fatti, quando devo firmare non mi rimane altro che andare a imprestare una penna, le buste a dire la verità devo rubarle”.

Interessante un concetto che viene ribadito da Lobba nella missiva rivolta al fiduciario di un altro campo lavoro: “In qualità di Internati Militari non abbiamo nessun diritto alla Croce Rossa Internazionale”:

78
Nel documento successivo (datato dicembre 1944) è il SAI a scrivere al fi duciario di Weiden affinché comunichi ad un internato che i suoi famigliari stanno bene e che aspettano sue notizie:

Il 13.8.1944 il Servizio dirama una circolare dattiloscritta a tutti i fiduciari dei lager allegando una lista di internati di cui i famigliari non hanno più notizie, con la preghiera di aiutarli ad individuare il luogo esatto di prigionia:

79
Interessante è anche la documentazione relativa allo Stalag VII B di Mem mingen. Abbiamo tra le altre cose una cartella con l’elenco di alcuni internati presi in forza presso questo Lager:

E per ciascuno di essi i dati anagrafici ma anche informazioni relativi al luogo e alla data di cattura da parte dei tedeschi e altri dati sugli spostamenti e sulle attività svolte durante l’internamento e fino alla liberazione:

80
2.4.12 La documentazione dei campi: Memmingen
Molto importanti sono anche le schede compilate dal personale tedesco del la ger di Memmingen al momento dell’arrivo degli internati nel campo. Ci sono anche le foto, con numero di matricola, dei singoli prigionieri:


81
2.4.13 La documentazione sul Lager di Bolzano
Concludo la parte di questo libro dedicata alla ricerca archivistica, sottoline ando come, di tanto in tanto, si trovino lettere al CAR di congiunti di deporta ti politici nel Lager di Bolzano. Nell’esempio sotto riportato si cercano notizie di un capo partigiano di Milano, Dottor Rino Rodondi, che risultava essere stato imprigionato presso il Lager di Bolzano 45:
45 A titolo di completezza segnalo che il dr. Rino Rodondi, le cui sorti non conosciamo, fu certamente trasfe rito da Mauthausen ad Auschwitz insieme ad altri due medici il 4.1.1945. In: Danuta Czech, Kalendarium. Gli avvenimenti nel campo di Auschwitz-Birkenau 1945, Aned, Milano, 2002, p. 2.

82
Capitolo Terzo
Questo internato di Bolzano ha raccolto in tempi recenti le sue memorie in uno scritto di grande interesse e ricco di dettagli, che ho chiesto di poter pubblicare in questo volume. In appendice a questo racconto Orazio riferisce anche del suo recente ritorno in Germania, ad Amburgo, per rivedere i luoghi di prigionia46 .
“… Sono nato il 21 dicembre 1924 a Padova, ma nel 1933 la mia famiglia si trasferì a Bolzano. Il 21 agosto del 1943 fui chiamato sotto le armi: ave vo 18 anni e 7 mesi, fino ad allora avevo vissuto senza problemi, aiutavo mio padre nel negozio di abbigliamento e sartoria che si trovava in via IX maggio, oggi corso Libertà.
Fui assegnato al 232° fanteria di Bolzano, alle Caserme Vittorio Veneto; lì constatai che le condi zioni di vita erano disastrose: ricevetti una divisa usata, la mia giacca aveva un rattoppo all’altezza della schiena e i calzoni erano più larghi di due misure. E pensare che da ci vile, ero vestito sempre in modo impeccabile! Ci rasarono, anche se avevamo già i capelli cortissimi; mangiavamo il rancio seduti per terra come i barboni e pulivamo le gavette con la terra del cortile. Ero realmente demoralizzato e stanchissimo per le continue, quanto inutili, esercitazioni. Quando suonava l’allarme, e avveniva oramai quasi ogni notte, ci trovavamo già pronti, perché non ci si spogliava più: dovevamo correre affardellati fino al poligono di San Maurizio, dove attendevamo il fine-allarme. Data la mia corporatura esile, i pochi giorni trascorsi in caserma mi resero piuttosto debole, anche perché non ero abituato ai gravami della vita militare; tutto ciò influì non poco sul destino che mi attendeva.
L’8 settembre 1943 sono in libera uscita serale e in piazza Vittorio Ema nuele III, ora piazza Walther. Incontro Pasquali e altri amici non ancora arruolati, perché studenti. Mi informano che la radio aveva appena trasmesso l’an
46 Rispetto al testo originale ho provveduto a effettuare alcuni piccoli interventi di correzione ortografica. Non sono stati effettuati interventi di carattere morfo-sintattico.
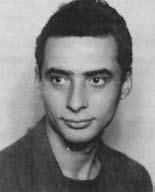
83
La testimonianza di alcuni ex-IMI della Provincia di Bolzano
3,1 La memoria di Orazio Leonardi
nuncio di Badoglio: l’Italia aveva chiesto l’armistizio; la mia famiglia, dopo il primo bombardamento sulla città, si era trasferita sul Renon e fu così che mi trovai solo, senza nessuno che mi potesse consigliare sul da farsi.
Tornato in caserma, l’ufficiale in servizio ci fece scendere in cortile, inquadrati con armi e bagagli, in attesa di ordini. L’euforia che ci prende, viene smorzata dal pensiero dell’immediato futuro, sulle possibili reazioni della Germania a questa svolta dell’Italia. Domande che purtroppo ebbero una risposta dopo poche ore.
Ore 23. Torniamo nelle camerate e ci addormentiamo completamente vestiti. Saranno state le quattro o le cinque del mattino, un boato accompagnato da raffiche di armi automatiche ci riporta alla realtà del momento: un colpo di mortaio era caduto sul tetto del nostro padiglione e i soldati alloggiati sul piano colpito, scendevano a precipizio lungo le scale.
La confusione, la sorpresa e il panico erano accompagnati da urla e spari, che provenivano dalla strada e dal cortile. Nel silenzio che seguì la sparatoria, urla in tedesco tradotte poi in italiano, ci comandano di scendere in cortile, con le braccia alzate, senza zaini o altro, dove, erano schierati una ventina di soldati tedeschi, armati di parabellum, che ci tenevano sotto tiro; un carro armato aveva sfondato un cancello ed era posizionato in modo stra tegico. Siamo prigionieri dell’esercito tedesco. Cosa succederà ?
La domanda, angosciosa, si ripercuote nel nostro intimo senza nessuna alternativa: da come ci trattano c’è poco da sperare, tanto più che con racca priccio vedemmo avvolto nella bandiera insanguinata il corpo della sentinella che montava la guardia questa notte.
Infatti ci fecero sedere per terra, e dopo diverse ore, ci inquadrarono e scortarono nel greto della Talvera. Non avevamo nulla all’infuori degli indu menti che indossavamo. Centinaia, forse migliaia di soldati di tutte le armi erano sparpagliati nella parte asciutta del torrente, mentre i Tedeschi armati ci controllavano dai bastioni e di tanto in tanto sparavano colpi di mitra nell’aria.
Speravo che i miei genitori venissero a cercarmi. Sugli argini della Tal vera si accalcavano persone in cerca di amici o familiari, ma erano tenuti a distanza dalle sentinelle tedesche.
Finalmente intravidi i miei genitori, che gesticolavano con una senti nella tedesca. Corsi verso di loro e ci abbracciammo: è impossibile descrivere l’intimo nostro. Le raccomandazioni di mio padre erano tese alla rassegnazione e mi esortava alla calma e all’ubbidienza. Chiesi loro se potevano portarmi degli indumenti, dato che tutto ciò che possedevo era la divisa e il cappotto militare e mi promisero che sarebbero tornati al più presto. Nella confusione che regnava sulle passeggiate non riuscii più a vedere i miei genitori che, non vedendomi riuscirono a contattare un maresciallo e a lui consegnarono una piccola valigetta: che conteneva un cambio di biancheria, un pullover, una sciarpa e un pezzo di pane con del formaggio. Eravamo a digiuno dall’ultimo rancio del giorno 8.
84
Tutto questo successe il giorno 9 settembre. La notte trascorse tra spari e grida e una leggera pioggia impregnò i nostri cappotti. Dai riflettori lame di luce illuminavano la scena, per noi apocalittica.
L’alba del 10 settembre ci trovò più demoralizzati che mai, non avevamo idea di ciò che ci sarebbe successo. Dalle prime luci del giorno i tedeschi con la forza,e urla per noi incomprensibili, cominciarono a radunare soldati e for mare delle colonne che venivano avviate per dove non si sapeva. Tornare in caserma era pia illusione perché vedevamo i cortei dei soldati che attraversa vano il ponte Talvera diretti verso la città. Erano circa le ore undici. I tedeschi scesero nel greto ci radunarono come fossimo pecore; ai pochi che non vole vano ubbidire erano riservati pugni e calci. Attraversammo le vie della città scortati da soldati, che continuavano a urlare ordini in tedesco, tra gente che piangeva o che ci derideva… … Arrivati in stazione ci fecero salire su carri merci: trenta soldati per vagone. Nell’attesa della partenza, gente comune venne a manifestarci solida rietà, buttandoci tutto ciò che poteva: cibo e perfino indumenti, nella speranza di poterci rivestire in borghese e poter fuggire.
Ore 15 la tradotta parte, comincia a piovere, per fortuna il portellone del vagone rimane aperto e, sotto i nostri occhi, vediamo passare tutti i paesi e i monti conosciuti. Alle 17 siamo fermi al Brennero, al di là dei binari ci sono altre persone che ci rincuorano e ci invitano a lanciare dei biglietti con gli indirizzi dei parenti.
Ci avrebbero pensato loro a mandare alle famiglie la notizia del passaggio del loro caro. Quando la tradotta si mosse con il suo caratteristico sferra gliare, il nostro morale toccò il fondo. Fu così che quando entrammo in terra tedesca, nel vagone calò un silenzio assoluto, ognuno di noi era concentrato nel pensiero dei propri cari e nell’angoscia del futuro che ci attendeva. Qualche singhiozzo represso diede il via a un generale abbattimento.

85
Quando venne la notte, cercammo di stenderci sul pavimento del va gone: non era facile trovare spazio disponibile per trenta persone, ma con qualche improperio e zittio riuscimmo – se non dormire – almeno a riposare.
11 settembre. La tradotta attraversa paesi e campagne coltivate e asso late; vista la nostra situazione, ci sembrava impossibile che esistesse ancora tanta pace. La fame e la sete cominciava a farsi sentire: da quasi tre giorni non mangiavamo e non avevamo da bere. Si cominciava ad essere irascibili con i propri compagni, bastava un nonnulla per generare discussioni e incom prensioni. Il viaggio procedeva con lunghe soste in aperta campagna, così che potevamo scendere per sgranchirci; siamo sorvegliati dai tetti dei vagoni da soldati armati, che non ci lasciano nessun spazio per i nostri intimi bisogni. Finalmente nel pomeriggio, durante una sosta, il treno viene affiancato da un camion militare e ad ogni vagone viene distribuito del cibo: una pagnotta di pane acido, una salciccia di sanguinaccio lunga appena dieci centimetri, da dividere con quattro soldati. Il camion seguente era una cisterna, dalla quale venivano travasati e distribuiti secchi d’acqua. Un’organizzazione veramente teutonica. Non sazi, ma rifocillati, continuiamo il viaggio verso dove non si sa. I pensieri sono angosciosi e il futuro è inimmaginabile.
12 settembre. Sono circa le dieci, la tradotta si ferma in una piccola stazione, linda e fiorita con tanti vasi di gerani e petunie. Tale vista mi rin cuora ma nello stesso tempo mi angoscia pensando a ciò che il destino mi sta riservando. Il benvenuto ci viene dato da un gruppo di civili che, mostrandoci i pugni, ci gridano: «Badoglio, Badoglio». Bambini biondi e puliti ci scherni scono. Questo avvenne nella stazione di Bremervörde, paesino situato a circa 60-70 km da Brema e da Amburgo.
Incolonnati e scortati formavamo un lungo serpentone, che si mise in marcia. Non eravamo per niente marziali. Il sole era alto e il caldo ci face va sudare, attraversammo il paese tra la curiosità e il malanimo della gente, finché giungemmo in piena campagna. La stanchezza era enorme, eravamo sporchi, sudati e trasandati, quel tragitto di 12 km fu interminabile. Non aven do lo zaino, portavo la valigia con fatica e non avendo più forze ero intenzio nato di gettarla quando un vicino di colonna vista la mia difficoltà mi venne in aiuto caricandosela sulle spalle, la solidarietà che conobbi in questa triste situazione mi sollevò lo spirito.
Finalmente apparve la nostra destinazione. Il campo si presentava come una distesa impressionante di baracche, circondate da alti reticolati e da torrette con guardie, fari e mitragliatrici. Fuori dal campo c’era una colonna di nostri soldati, arrivati prima di noi che attendevano il controllo prima di en trare nel campo. Nell’attesa, ci sedemmo a terra e, dato che eravamo su un terreno arido e sabbioso, a ogni alito di vento la polvere si mescolava al sudore. Quando arrivò il nostro turno d’entrata passammo il controllo, che consisteva nell’aprire e rovesciare per terra il contenuto di zaini e valigie e pure delle nostre tasche. Soldati tedeschi, con dei bastoni, frugavano nei mucchietti di indumenti per vedere se avevamo delle armi. Non contenti ci perquisirono,
86
poi ci fecero oltrepassare un grande cancello di filo spinato ed entrammo nel campo, attraversando diversi settori di baracche, sempre suddivisi con doppi reticolati. Dalle finestre delle baracche, visi smunti ed emaciati ci stavano ad osservare: dal loro copricapo capimmo che erano russi. In un altro settore vi erano prigionieri francesi e poi venimmo a sapere che c’erano anche belgi, ben vestiti e paffuti, che al nostro passaggio, deridendoci, ci avvisarono che i tedeschi ci avrebbero conciati per le feste. Entrammo in un settore adiacente a quello francese. Ogni settore era composto da otto o dieci baracche, una baracca era adibita a lavatoio e una a latrina; erano messe intorno a una vasta depressione del terreno di circa un metro di profondità, con le pareti sbieche. Con raccapriccio, a guerra finita, venimmo a sapere quale era stata la loro funzione. Alti reticolati dividevano un settore dall’altro, in più vi era un basso filo spinato - distante da quello alto di circa mezzo metro. La baracca era suddivisa in 6/8 stanze, con letti a castello, un tavolo e due panche, due piccole finestre lasciavano entrare un filo di luce. Affamati e stanchi andammo a dissetarci, il lavatoio consisteva da un tubo metallico con dei fori da cui fuoriusciva un’acqua giallastra e dal gusto sgradevole, imbevibile. Ci sdraiammo sui letti a castello a noi assegnati, che non avevano nulla di letti ma erano scaffali a tre piani, con un tavolaccio al po sto del materasso, trovammo dei recipienti in lamiera e dei cucchiai arrugginiti, non c’era ombra di coperte o altro. Con il calare della sera, il buio riempì la baracca. Non c’era la luce e la disperazione si impadronì di noi. Lunghi singhiozzi accompagnarono il sonno, che venne a sopire i nostri tristi pensieri. Fummo svegliati di soprassalto da urla e colpi di bastone sulle pareti della baracca ci fecero uscire all’aperto. Erano le sei, non era ancora giorno e riflettori illuminavano la scena che sarebbe diventata usuale; la stessa cosa avveniva davanti alle altre baracche.
Ci inquadrarono e cominciarono a contarci non una volta ma due, tre volte. Dovevamo stare sull’attenti, dovevamo avere la divisa in ordine e guai a parlare: erano bastonate con il calcio del fucile. Questo era l’appello del mat tino, che durava circa un’ora; la stessa cosa avveniva alla sera, con la stessa procedura e lo stesso accanimento nel maltrattarci, in questo primo appello venimmo a conoscere le regole del campo, regole severe, che, se non venivano rispettate, eravamo passibili di fucilazione senza preavviso: per chi superava quel basso filo spinato che divideva i vari settori, per chi opponeva resistenza agli ordini dei soldati tedeschi, e infine per chi tentava la fuga.
Ci dettero tutte le informazioni interne al lager: nelle ore diurne era proibito stare sdraiati nei castelli, la pulizia della baracca doveva essere scru polosa, le ispezioni potevano avvenire in qualsiasi ora del giorno, di notte, era proibito uscire dalle baracche, dovevamo organizzare i turni di servizio, ecc.
Dopo questo primo appello distribuirono un intruglio chiamato thè, era amaro e di gusto nauseante, ma era caldo e suppliva all’acqua da bere.
Il pasto che ci diedero verso mezzogiorno consisteva in una brodaglia dove galleggiava qualche foglia di verdura e tre o quattro patate lessate, alla
87
sera ci diedero una fettina minuscola di pane nero un dito di margarina e il solito thé.
Per tutta la settimana continuò l’arrivo di colonne di soldati e ufficiali, provenivano non solo dall’Italia ma dalla Grecia dalla Jugoslavia, molti di questi erano ammalati di malaria; rispetto all’ insufficienza del cibo che ci distribuivano, ognuno cercava di arrangiarsi, dato che il nostro settore confinava con quello dei francesi, i quali, oltre al cibo del campo, ricevevano mensilmente uno o due pacchi della Croce Rossa. Scambiavamo, sfidando il pericolo delle sentinelle, tutto ciò che poteva mo. Fu così che l’orologio che avevo al polso venne scambiato con un filone di pane nero. I lanci attraverso il filo spinato avvenivano verso l’imbrunire, per non allarmare le sentinelle, rimanevamo nascosti dalle baracche, tuttalpiù, vedevano volare alto oggetti vari. Purtroppo, in un caso, la merce di scambio cadde tra i due reticolati e l’interessato che corse a prenderlo, venne colpito al ventre da una fucilata. Venne soccorso e portato nella baracca ufficiali, dove un ufficiale medico gli prestò i primi soccorsi, ma poi arrivarono i soldati tedeschi che lo portarono via e di lui non sapemmo più nulla.
La vita al Lager è disastrosa: le ore non passano mai, siamo sempre nell’attesa spasmodica di quel poco cibo che ci danno, la fame ci torce l’inte stino, di notte le cimici non ci danno tregua, l’acqua è imbevibile, i gabinetti sono immondi.
Gli appelli diventano sempre più stressanti, la pioggia e il freddo ci aggiungono altre sofferenze, senza contare che a turno siamo costretti al ser vizio concimazione: da ogni baracca vengono scelti due soldati, che devono a turno trascinare una grossa botte, riempita con gli escrementi della latrina da spargere nella campagna circostante. Un lavoro degradante, pesante e umiliante, dal quale si torna infangati e spossati. Un piccolo incidente mi ha creato un problema di non poco conto, per un graffio all’alluce, vuoi per la scarsa pulizia vuoi per la debolezza che mina le nostre difese mi si è formata un’infezione che non mi permette di mettere la scarpa per il gonfiore e per il dolore che mi procura, per poter camminare, presi un cartone e lo legai al piede con lo spago, ma purtroppo rimanendo in piedi per ore all’appello – in mezzo al fango e alle pozzanghere – il cartone si bagnava e il piede si gelava tanto da non sentirlo più, tra l’altro non avevo calzetti ma le famose pezze dell’esercito.
Un mattino di metà settembre ci radunarono - soldati e ufficiali - in un grande piazzale saremo stati in tremila. Venne l’ambasciatore italiano Anfuso, accompagnato da ufficiali tedeschi, che ci propose di arruolarci nelle SS tede sche. Nessuno aderì, anzi, ci furono fischi. Le ultime parole che disse il console furono: «Ve ne accorgerete cosa vuol dire essere prigionieri dei tedeschi!».
Dopo un paio di settimane tornarono un’altra volta e ci proposero di aderire alla formazione dell’esercito della Repubblica Sociale Italiana: in que sta occasione aderirono cento o forse duecento soldati, che furono subito spostati in un settore diverso.
88
Noi passammo dallo stato di prigionieri di guerra a Internati Militari Italiani, “IMI’’, ma ne venimmo a conoscenza solo dopo un paio di mesi. Comincia a fare freddo, dormiamo coperti dai soli capotti, il legno del castello diventa sempre più duro, la fame è costante. Molte notti sentiamo il rombo dei bombardieri che passano sulle nostre teste; attraverso le fessure della baracca vediamo in lontananza il cielo in fiamme.
Ai primi di ottobre, poiché servivano scrivani per l’ufficio matricola, mi presentai alla chiamata; lo feci per rompere la malinconia e la noia delle giornate e sfuggire al pericolo di dover fare ancora il servizio di concimazio ne. Dopo l’appello andavamo in una baracca dove, oltre ai dati anagrafici, il grado, il reggimento e il luogo della cattura, dovevamo far dichiarare ai pri gionieri quale era la loro religione, facevamo firmare una cartolina da inviare a casa sulla quale veniva indicato lo stato di prigioniero di guerra, consegna vamo una piastrina metallico con il numero di matricola, in un altro tavolo presieduto dai tedeschi confiscavano la valuta posseduta.
La registrazione dei nostri compagni di sventura terminò verso la fine di ottobre. Fu così che anch’io divenni il numero di matricola 154012 X B.
Per questo lavoro abbiamo goduto di una seconda razione di brodaglia giornaliera e di marchi-Lager [l’unica valuta ammessa per gli IMI ], con cui comperai alla spaccio una saponetta, un rasoio Gillette e due lamette da bar ba. A mano a mano che i soldati dei vari settori venivano schedati, venivano avviati al lavoro coatto: partivano sempre all’alba, non conoscendo quale era la loro destinazione finale, che per molti fu fatale.
Le partenze si susseguivano, finché nel campo di Italiani rimanemmo solo noi scrivani.
1 novembre. Da tre giorni ci hanno spostato in una baracca diversa, siamo un centinaio; questo cambiamento ci fa capire che siamo in partenza: siamo angosciati e in apprensione per il destino che ci aspetta. Dopo averci ordinato di denudarci, ci hanno portati, nudi come eravamo, in una vicina baracca che, con sorpresa, si era rivelata una doccia. Finalmente, dopo mesi, una vera doccia con acqua calda, Tornati dalla doccia, fecero un’ispezione tra i nostri poveri indumenti; poiché dovevamo avere solo un cambio di biancheria, tutto il resto veniva sequestrato, non si potevano avere indumenti diversi dall’uniforme; per fortuna il pullover che mi diede mio padre era verde così che passò all’ispezione in quella occasione ricevetti un telo come asciugama no due calzerotti e uno zaino.
Ci avvisarono che all’indomani saremmo partiti per raggiungere il no stro posto di lavoro; ci lessero le leggi cui noi prigionieri dovevamo sottostare, un’infinità di verboten47 dalle conseguenze molto severe per chi le trasgrediva. Quel che avvenne poi fu decisivo per il mio destino: eravamo un centinaio e ci divisero. Speravo di rimanere con il gruppo con il quale più mi ero legato: c’erano due della Val di Non, un sergente di Riva del Garda, che conoscendo il
89
47 Divieti.
tedesco divenne il nostro interprete, un gruppo di allievi ufficiali di cavalleria catturati a Pinerolo. Io e un certo Fini di Brescia eravamo i più giovani.
2 novembre. All’alba ci inquadrano, fa piuttosto freddo e, dopo avere ripercorso in senso inverso il tragitto arriviamo alla stazione. Ci caricano su vagoni merci, che vengono chiusi e spostati su binari morti. Rimaniamo per ore al chiuso e al freddo. Finalmente il treno si avvia, ma poi fa diverse soste. È buio profondo, quando aprono i portelloni: ci troviamo in uno scalo ferro viario illuminato, dove ci attendono due camion. Il nostro era dipinto di giallo con scritte rosse, che non ci fu possibile identificare. Il viaggio continua nella notte su questo camion scoperto, sorvegliato da due guardie armate. Attraversiamo quartieri abitati, stradoni con grandi edifici e cisterne, transitiamo su ponti grandi e piccoli.
Finalmente il camion si ferma davanti ad una costruzione in mattoni, con strani palchi metallici e diverse tubature da cui fuoriescono nuvole di vapore. Varcato un cancello di filo spinato ci troviamo in un piazzale ingombro di fusti metallici e una baracca illuminata, tutta nuova, con il suo caratteri stico odore di legno fresco, il locale è suddiviso in tre sezioni, entrando troviamo tavoli e panche e, allineate su una mensola, scodelle bianche, bicchieri e posate. Ai lati vi sono due settori con letti a castello, forniti di pagliericci e coperte; poi vi sono due sgabuzzini, all’interno dei quali vi sono dei bidoni con manici per i bisogni fisiologici.
Eravamo esterrefatti dopo tanto squallore. Comparve persino qualche sorriso, poi ci mettemmo a saltare e ci abbracciammo dalla gioia, credendo di essere ritornati alla civiltà. E le sorprese non erano ancora finite. Entrarono due civili con un gran pentolone fumante: assaporammo una zuppa di patate e carote e pasta, leccornie che avevamo dimenticate da mesi e che finalmente riempirono lo stomaco. Vennero altri civili e dissero che era opportuno atten dere un paio di giorni prima di avviarci al lavoro, date le condizioni piuttosto debilitate del nostro fisico. Venimmo a sapere che ci trovavamo ad Amburgo nella raffineria della Shell e che il loro compito era quello di selezionarci per il lavoro, in base alle nostre capacità. Dopo mesi di tavolaccio, stendersi sul la paglia era il massimo! La baracca era riscaldata da tubi in cui passava il vapore, che si scaricava in tre bidoni posti all’esterno della baracca: avevamo l’acqua calda a volontà. Era circa l’una di notte quando il silenzio riempì lo spazio vuoto, illuminato solo da piccole lampade blu. Il mattino successivo svegliandoci, ci accorgemmo di essere praticamente prigionieri nella baracca: le finestre fornite di inferriate, erano chiuse dall’esterno con pannelli in legno così pure la porta d’ingresso. All’arrivo delle sentinelle, un maresciallo molto arrogante con il volto tutto tagliuzzato e un soldato a cui mancava un braccio, ci fecero uscire per l’immancabile appello.
Scelsero a caso quattro soldati per il trasporto e lo svuotamento dei no stri WC, che avveniva in un tombino della fognatura posto sulla strada, poi ci fecero togliere i pannelli rinforzati da spranghe di ferro, che bloccavano le finestre e due altri soldati tornarono dalla cucina con due grandi caraffe metal
90
liche piene di una bevanda calda ma dal sapore amaro che chiamavano caffé. All’esterno vi era una specie di lavatoio in lamiera con diversi rubinetti. Avendo un paio di giornate libere ci dividemmo i compiti per riuscire a convivere: per prima cosa, eleggemmo un capo-baracca nella persona del sergente di Arco, un certo Cagol che masticava un po’ di tedesco, il quale, per prima cosa formò i turni giornalieri per le incombenze della giornata: aprire gli scuri, svuotare i WC e lavarli con una pompa d’acqua, andare nella cucina che si trova all’interno della raffineria per prendere il caffé o quanto altro. I turni cambiavano ogni dieci giorni: eravamo in cinquanta e rappresentavamo tutte le armi; vi erano anche dei richiamati trentenni e oltre. Eravamo liberi di circolare all’esterno della baracca, in quel settore della fabbrica adibito a deposito di fusti, siamo circondati da canali derivanti dall’Elba, che servono per il passaggio delle chiatte che devono caricare o scaricare. Dall’altra parte del canale c’erano capannoni semidistrutti e incendiati; sulle banchine, gru accartocciate erano un groviglio di ferri arrugginiti. La vista si estende sulla città di Amburgo, con i suoi campanili e i palazzi; il canale principale è solcato da navi mercantili e da chiatte trainate dai rimorchiatori. L’altro lato del canale confina con un grosso cantiere navale, con quei caratteristici ponti di gru e grosse navi alla fonda in cantiere.
Sulle divise ci vengono stampigliate a grandi lettere bianche la sigla “IMI” sulla giacca e sui pantaloni per davanti e didietro, inoltre ci misero un numero progressivo,da oggi sono il numero 12, dopo la buona sorpresa dell’arrivo, cominciamo a chiederci come sarà il seguito di questa prigionia. Il terzo giorno, cioè il 5 di Novembre inizia il nostro lavoro coatto a be neficio del ‘grande Reich’. Alle sei del mattino sveglia, dopo l’appello e tutte le incombenze che ci competevano vennero diversi civili con la svastica al braccio e ognuno sceglieva la sua squadra di lavoro: sembravamo pecore al mercato: chi cercava fabbri, chi elettricisti, chi muratori… Fatta la scelta, quelli che rimanevano venivano inquadrati nelle squadre di facchinaggio della raffineria.
Oltrepassato il reticolato, ci troviamo nella strada che conduce al grande arsenale e all’imbarcadero del battello, che collega il centro città; sulla destra si erge lo stabile che tanto ci impressionò quando scendemmo dal camion,alla sinistra, un piazzale con l’odiata bandiera svettante da un alto pennone, da vanti al nostro sguardo si parò l’ingresso principale della raffineria: alte cimi niere fumanti, grandi cisterne nere, costruzioni in mattoni anneriti con grandi finestre, un intreccio di tubi che si sviluppava su ponti aerei, che andavano in tutte le direzioni, bocchettoni che emanavano nuvole di vapore bianco, in treccio di binari, con vagoni di carbone e cisterne che entravano o uscivano da grandi cancelli, visti danni dei bombardamenti che vedevamo dalla nostra baracca pensavamo di trovare anche qui grandi distruzioni, vi era solamente una costruzione piuttosto grande completamente distrutta cosi pure diverse grandi cisterne sventrate.
Il tutto era sormontato da una grande scritta: RHENANIA OSSAG
WERK GRASBROOK. Sarà il nostro datore di lavoro fino alla liberazione.
91
La prima impressione fu di sgomento, lo spettacolo era impressionante e an goscioso. Entrati in un grande antro, ci fecero spostare centinaia di bidoni da un capannone a un altro, poi ci fecero accatastare su tre piani altri fusti che per fortuna erano più leggeri dei primi, lavoro massacrante che durò tutta la giornata, tornati in baracca non avevamo più forze; cominciamo bene, se con tinua così non so come potremo farcela.
Un mattino dopo l’appello, un brigadiere della finanza contestò al mare sciallo tedesco obbligatorietà del lavoro per i sottoufficiali, per tutta risposta si prese un pugno che lo fece cadere per terra, al nostro istintivo movimento di aiuto, l’altro soldato urlando, ci spianò il fucile temendo una nostra reazione, questo fatto, ci diede la conferma della precarietà della nostra situazione. Con noi lavorano prigionieri russi, anche loro vittime della guerra. Solo con lo sguardo ci si salutava; era severamente proibito avvicinarsi o parlarsi sia pure a gesti. Una volta alla settimana ci portavano alle docce all’interno della fabbrica, ma purtroppo non sempre potevamo cambiarci e indossavamo nuo vamente indumenti sporchi.
Le giornate si susseguono con lavori ora pesanti ora leggeri, ma la fame, il freddo, la pioggia gelata e la fatica minano le nostre difese. Mi accorgevo che dimagrivo a vista d’occhio e sentivo, giorno dopo giorno, che le forze mi veni vano meno, il vitto, dopo i primi giorni cambiò completamente, la zuppa che distribuivano a mezzogiorno era senza grassi e con pochissime verdure, due o tre patate completavano il pasto, alla sera ci distribuivano una fetta di pane con un bastoncino di margarina e sanguinaccio o un cucchiaio di marmellata e il solito caffè. Anche le divise che indossavamo divennero sporche e si inzup pavano facilmente sotto la pioggia e la neve. Ci diedero delle manopole di tela, che si ruppero quasi subito e allora, ci avvolgevamo le mani con degli stracci, perché il lavoro consisteva nello spostare bidoni da un posto all’altro.
Quando le chiatte dovevano essere caricate, i bidoni erano pieni di oli o di grassi e diventavano pesantissimi e il ritmo di lavoro era febbrile e non ci si poteva fermare un minuto, per non creare l’intasamento del pontile. La fatica alla schiena, alle mani, alle gambe era durissima. Quando la sorve glianza si allentava, con la scusa della toilette, andavamo dove sapevamo di trovare scarti della cucina o i resti di cibo dei tedeschi. Eravamo come cani che arraffavano tutto ciò che era possibile ingoiare e mettere in pancia. Guai se ci scoprivano: erano pedate e sberle; vivevamo in un degrado, che sempre più ci abbruttiva.
Un giorno, accompagnato da un interprete, venne un civile della Dire zione, il quale – lamentando lo scarso risultato del nostro lavoro – ci comunicò che se non ci mettevamo più impegno, ci avrebbero diminuito ulteriormente le razioni di cibo. Un ricatto abbietto: noi non producevamo perché eravamo stanchi e affamati e il lavoro gravoso ci levava ogni forza residua.
Un mattino ci portarono in un edificio, che si trovava all’esterno del la raffineria, nel cortile di una casa d’abitazione; dovevamo caricare in una chiatta dei barattoli in lamiera, danneggiati e, quelli restanti, dovevano essere
92
accatastati in un ambiente sano. Ricordo che pioveva a dirotto e ogni tanto ci si riparava nell’androne della casa. Con sorpresa, in un piattino, trovai una testa di pesce affumicato che era senz’altro destinato a qualche gatto. Dopo attenta riflessione pensai che il gatto aveva meno fame di me, così che me la mangiai. Non avrei mai supposto di arrivare a tanto.
Scavando tra le macerie trovammo diversi scatoloni semidistrutti, contenenti bottigliette di sciroppo per la tosse. Senza pensarci troppo bevemmo il liquido caramelloso e dolce pensando che ci avrebbe difeso dalle malattie da raffredamento.
Gli operai tedeschi, quasi tutti anziani, dopo i primi giorni di diffidenza, con grande cautela per la proibizione di avere contatti con i prigionieri, ci raccontarono che molti di loro erano reduci della I^ guerra mondiale e reduci della prigionia: chi in Italia e chi in Francia.
Più volte accadde che all’alba ci trasferivano – a piedi, sotto la pioggia o la neve – in altri depositi della raffineria, a chilometri di distanza e anche lì c’erano bidoni da caricare su chiatte, o spalare macerie. Constatammo così che la zona industriale era per lo più distrutta e incontrammo altri nostri compagni, anche loro affaticati e demoralizzati: solo la speranza ci faceva vivere. Il freddo ci tagliava il viso e le mani e la fame era costante; al ritorno, dopo dieci ore di lavoro, eravamo così stremati, che non eravamo in grado di fare nulla, solo stare sdraiati a riposare.
Uno dei tanti lavori che fui costretto a fare era il lavaggio dei bidoni: lavoro sfibrante, che non lasciava tregua, pericoloso per i vapori degli gli acidi che respiravamo, perché tutto si svolgeva in un capannone, illuminato da forti fari. I bidoni venivano privati del tappo, vi venivano infilate delle catene, si versava l’acido e poi dovevamo farli dondolare avanti e indietro, lasciandoli appoggiati a terra su un solo punto. Questo movimento e lo sfregamento delle catene, serviva a raschiare l’unto esistente. Dopo averli capovolti, per pulire l’altro lato, con un sistema di pulegge venivano immersi in un pozzetto pie no di acido: i bidoni, rotolando su se stessi, si autopulivano per mezzo delle catene finchè, ad un segnale luminoso, dovevamo estrarli, levare le catene e lavarli con un getto d’acqua bollente. Venivano poi inseriti in ugelli fissati nel pavimento, da cui fuoriusciva getti di aria calda, il tutto doveva avvenire in perfetta sincronia con i tempi di lavoro e ad una temperatura molto calda e umida. Tornavamo in baracca bagnati fradici, con indumenti e mani bruciati dall’acido e, per mia fortuna, dopo due settimane, cambiarono i turni. Ma la fame era sempre presente, non ci dava tregua: la visita all’immondezzaio della cucina era diventato un pensiero assillante. Un giorno trovai teste e lische di pesci bolliti, resti della mensa degli operai tedeschi, misi tutto quel ben di Dio in un pezzo di carta e appartatomi nella toilette, un capanno con una buca, mi misi a succhiare e mangiare tutto quello che potevo strappare a quei resti di cibo.
Sentivo che le forze mi stavano abbandonando e non sapevo cosa poteva succedermi.
93
Cominciarono anche gli allarmi, di giorno ci rinchiudevano in uno scan tinato della centrale del vapore. Eravamo terrorizzati, perché se venivamo col piti, non avremmo avuto scampo. Di notte invece ci portavano in uno scantina to della zona uffici. Gli allarmi notturni duravano anche per ore e ci toglievano il sonno e il riposo. Per nostra fortuna, i bombardamenti avvenivano soprattut to sulla città: ci dissero che in giugno, in tre giorni, le bombe al fosforo fecero ventimila morti e interi quartieri vennero completamente distrutti.
Con tristezza venne Natale. Il morale, durante queste festività divenne ancor più fragile e i pensieri correvano alle nostre case: non avevamo notizie, le lettere scritte in novembre e dicembre erano ancora senza risposta. In una di quelle sere che seguirono il Natale, in orario insolito, venne il maresciallo tedesco che interpellando Zadra e Bellotti, due allievi ufficiali, li invitò ad uscire all’aperto, dove c’erano dei visitatori in attesa. Quando, poco dopo tor narono, visibilmente agitati, ci dissero che elementi del consolato li avevano contattati per informarli che dovevano partire per l’Italia. Mentre preparavano i bagagli demmo loro gli indirizzi delle nostre famiglie, affinché portassero nostre notizie, ma la loro partenza ci procurò molta invidia e malinconia: per loro l’inferno era finito e, dimentichi di tutto, avrebbero trascorso in famiglia le prossime festività.
Il trentun di dicembre, a mezzanotte tutte le sirene dei natanti, si misero a suonare. Con grande sconforto, piangendo, ricordavo gli affetti e la libertà che avevo perduta e presagivo per me un brutto destino. Ero senza forze, la fatica del lavoro, la fame, il freddo, non mi davano nessuna speranza di farce la. Anche Fini, l’altra recluta, i primi di dicembre si era ammalato e il medico della raffineria aveva pronosticato una polmonite. Seppi poi, con dolore, la fine che fece.
I primi di gennaio del ’44, assieme ad altri quattro compagni e accom pagnati dalla sentinella e da un capo, prendemmo un battello che ci portò dall’altra parte dell’Elba dove, dopo un lungo cammino, arrivammo nei pressi di grandi magazzini e costruzioni semidistrutte. Qui trovammo un vagone ferroviario, che doveva essere scaricato: era pieno di patate gettate alla rin fusa, dovevamo riempire dei sacchi e portarli a spalla in uno scantinato. Non si può raccontare la mia fatica: basti solo pensare che dopo otto ore, senza pausa e senza cibo, ci fecero percorrere la strada del ritorno, gravati da duetre chili di patate che, bontà loro, ci regalarono. Ma la stanchezza era infinita, non ci reggevamo più in piedi e mettemmo le patate tra la camicia e la pelle, perché le mani non riuscivano a trattenerne il peso. Quest’ultimo lavoro mi diede il colpo di grazia. Anch’io mi ammalai, con febbre e dissenteria. Dopo tre giorni, una sentinella mi accompagnò – ancora febbricitante – dal medico, in centro città, potei così vedere con i miei occhi le distruzioni causate dai bombardamenti. Trovai squadre di nostri soldati che demolivano resti di mura pericolanti e che scavavano tra le macerie. Raggiungemmo un quartiere in tegro, senza distruzioni: qui la vita sembrava normale, c’erano negozi aperti, bar, cinema con cartelloni che reclamizzavano film, donne con carrozzine e
94
con la spesa. Noi dovevamo camminare sul selciato della strada, perché era proibito, a noi prigionieri, calpestare il marciapiede.
Arrivammo finalmente in una strada, su cui si affacciavano alte case, immerse in giardini e dove un edificio era stato adattato a ospedale per noi italiani. Un ufficiale medico italiano e uno tedesco facevano la prima visita e decidevano sul caso. Mi ricoverano per la febbre e la per debolezza, pesavo 52 chili. L’edificio era un ex-albergo e la cameretta dove mi avevano ricoverato era zeppa di letti a castello. Eravamo in dieci, alcuni erano feriti sul lavoro, altri bisognosi di interventi chirurgici altri, come me, debilitati. La febbre sparì con qualche compressa e, dopo quattro giorni, l’ufficiale tedesco mi rispedì al lavoro.
Mi ridiedero il solito incarico, ma non ero più in grado di reggermi in piedi. Rimasi nella baracca ancora una settimana ma continuavo a peggiorare, riprese la diarrea e la febbre. Il medico della fabbrica disse all’interprete che mi avrebbero ricoverato in un lazzaretto: mi sentii finito. Ormai non avevo più speranza di tornare a casa, piansi lacrime di sconforto e paura. I compagni di sventura fecero di tutto per confortarmi, ma la mia disperazione era indicibile.
25 gennaio. Parto accompagnato da un soldato armato; dopo il battello prendemmo un tram che ci condusse alla stazione centrale, qui salimmo su di un treno; eravamo in uno scompartimento da soli, io e la guardia. La guardia chiuse lo scompartimento a chiave, non scambiò neanche una parola e si mise tranquillamente a mangiare fettine di pane. La vista del cibo diventava una vera tortura, non solo fisica. Speravo che si commuovesse e me ne desse qual che fettina, ma il soldato, indifferente al mio sguardo supplicante, continuò il suo pasto solitario. Stavo perdendo ogni dignità.
Il treno, dopo aver attraversato quartieri completamente distrutti si mise a viaggiare tra la campagna e piccole foreste di pini. Dopo due ore siamo scesi a Heidikaten piccola stazione senza paese, nei pressi di Kiel. Camminammo per un’ora, tra la campagna arata; faceva un freddo cane, la fame e la stanchezza mi attanagliano le viscere, dato che il mio incedere era lento, la guardia che mi seguiva, continuava a urlare e a strattonarmi perchè camminassi più svelto, le lacrime che mi salivano agli occhi si cristallizzavano nelle ciglia per il freddo intenso, vivevo con angoscia e paura il pensiero ciò che il domani mi avrebbe riservato… Arriviamo finalmente al lazzaretto, che non è altro che un campo di concentramento, una trentina di baracche dai colori mimetici, con alte pareti di filo spinato. Qui trovai altri sventurati, che attendevano di essere internati. Ci fecero spogliare del tutto, facemmo un sacco di tutti gli indumenti, met tendoli dentro il capotto e legandolo con la cintura, gli scarponi li legammo con le stringhe. Ci fecero fare una doccia calda, ci rasarono completamente e ci spalmarono un disinfettante contro pidocchi e altri parassiti, ci diedero una casacca e dei calzoni di tela sdruciti: dovevano essere divise estive, di non so quale esercito e tempo, e degli zoccoli di legno. Attesi assieme ad altri compa gni di essere portato in infermeria, dove c’erano un ufficiale medico italiano e due nostri soldati con la fascia della Croce Rossa. Arrivò il mio turno: pesavo
95
50 chili vestito. La visita si concluse con la diagnosi di deperimento organico, che, a parere del medico, era di non facile soluzione. Il riposo, ma soprattutto il morale, avrebbero dovuto sopperire alla mancanza di nutrimento.
Con fare paterno, vista la mia giovane età, il medico mi esortò a com battere questa battaglia per la vita con fortezza d’animo.
Commosso e impaurito fui portato in un magazzino, dove un maresciallo tedesco mi consegnò dieci strette tavolette di legno, che dovevano servire per creare il ripiano del giaciglio… Oltrepassando i soliti cancelli di filo spinato, fui condotto in una delle numerose baracche, occupate da letti a castello a due piani, dove giacevano poveri esseri scheletrici, con teste rasate, ciondolanti, vestiti anch’essi con divise smesse. Dopo che mi fu assegnato il posto, consta tai che le tavolette atte a formare il letto erano insufficienti a creare il ripiano. Mi spiegarono, che per il freddo ritagliavano i bordi delle tavole, così queste diventavano strette a tal punto che si doveva cercare di posizionarle con ampi spazi vuoti tra loro, in modo da poter giacere al meglio possibile. I ricoverati erano affetti da varie patologie, anche più serie delle mie. Alcuni erano gonfi e trasudavano acqua da ogni poro: la chiamavano ‘malattia della fame’ e purtroppo, non essendoci una cura specifica, il loro destino era segnato.
Come sempre in questi frangenti, fu subito una continua richiesta di notizie sulle esperienze fatte e la situazione del campo. Venni a sapere che Fini, i primi di dicembre era stato ricoverato proprio in quel lazzaretto, dove purtroppo morì, pochi giorni dopo il suo arrivo, non per la polmonite ma a causa della tubercolosi fulminante. L’infermiere me lo disse controllando i miei documenti, poiché provenivo dallo stesso campo di lavoro. Questa no tizia contribuì non poco ad aumentare la disperazione e lo sconforto che mi pervadeva. Una stufa, piazzata al centro della baracca è alimentata a legna; per bere, sul tavolo vi era un secchio d’acqua e un barattolo di latta con ma nico. Nel campo-lazzaretto vi erano anche prigionieri russi e questa è una costante. Là dove ci sono russi vi sono anche gli italiani, perché il trattamento deve essere dei più duri. I primi, perché sono ritenuti di una razza inferiore e noi perché siamo dei traditori. Ci hanno consegnato delle cartoline propagan distiche; ne possiamo scrivere più di una, oltre le solite due lettere concesse.
Il campo si trova in una radura, nei pressi di un vivaio di pini, tutti alti uguali, così da formare una siepe verde. Prima di diventare un lazzaretto, era adibito a magazzino della marina da guerra: siamo perciò a poca distanza dal le basi navali. La bellezza della natura, tutto quel verde, il candore di una nevicata che tutto ricopre, rendeva ancora più stridente il degrado che eravamo costretti a subire. I nostri occhi si soffermavano spesso su queste visioni, che illuminavano la nostra mente, ma la cruda realtà era sempre la fame e il freddo. La giornata era scandita dall’attesa del cibo: anche qui una zuppa acquosa e la solita fetta di pane e margarina, ma tutto era ancora più scarso. Pativamo il freddo così come eravamo vestiti e con le coperte di carta; ricevevamo una razione giornaliera di legna, ma così scarsa che ci bastava solo per sei ore, la razionavamo accendendo la stufa solo due volte al giorno.
96
Altro problema era la toilette: di giorno dovevamo uscire al freddo, per andare nella apposita baracca… Di notte dovevamo usare un bidone all’inter no della stanza, che al mattino veniva portato via. I disagi che dovevamo su bire sembravano fatti apposta per fiaccare non solo il nostro corpo, ma anche lo spirito. Nel nostro settore oltre le baracche di “medicina” vi era la baracca di chirurgia e una per i tubercolotici. Quasi odierno era il passaggio davanti alle nostre finestre di un mesto corteo: il maresciallo tedesco, il nostro medico e i due soldati infermieri, che trasportavano un corpo avvolto nell’imbottita di carta.
Un mattino arrivarono alcuni ufficiali delle SS e un fotografo. Davanti all’infermeria, fecero allineare e denudare una diecina di prigionieri, che ven nero filmati dall’operatore con una lavagna davanti al petto, sulla quale era scritto il numero di matricola. Anche nella nostra baracca avvennero diversi decessi, poveri derelitti che nell’agonia chiamavano la mamma o il nome dei propri cari. Vigliaccamente mi rifugiavo nel mio giaciglio, per non vedere e mi tappavo le orecchie per non sentire. Era la prima volta che ero a tu per tu con la morte, e la conobbi nel modo più inumano e sconvolgente. Mi rifugiai nella fede, àncora di salvezza dello spirito, perchè solo questa poteva darci il coraggio e la speranza, quando intorno a noi vi era solo malattia e morte. Nei mesi seguenti, le morti alle quali fui testimone furono così frequenti che, il mio intimo reagiva oramai con apatia e indifferenza, quasi che fosse ormai questo il mio destino.
Un mattino, assieme al nostro ufficiale medico, entrarono due ufficiali tedeschi che visitarono tre nostri compagni: erano i più gravi e ad essi venne detto che sarebbero stati rimpatriati in Italia. Un misto d’invidia e di rimpianto ci pervase nel vedere i preparativi della partenza,forse in Italia sarebbero guariti, eravamo lieti per loro ma anche invidiosi. Tra pochi giorni loro avreb bero abbracciato i propri cari. Lasciammo gli indirizzi delle nostre famiglie, perché portassero nostre notizie, dato che anche noi non sapevamo nulla delle sorti dei nostri familiari. Purtroppo, dopo tre giorni, li vedemmo rientrare in baracca. Ci raccontarono la loro odissea: partiti dal Lager in un camion militare, adagiati sulla paglia, arrivarono in una stazione ferroviaria, dove trovarono altri infelici in attesa di essere rimpatriati. Erano stivati in carri merci, su castelli forniti di paglia e coperte, una stufa a carbone riscaldava il carro, il freddo di febbraio era inimmaginabile. Avevano detto loro che la sistemazione era provvisoria, che sarebbero stati trasferiti in un vero treno ospedale ma il loro viaggio si interruppe quando – all’improvviso – un bom bardamento aveva distrutto le linee ferroviarie, così il treno dovette tornare indietro. Nell’attesa di formare un nuovo convoglio, riportarono i malati da dove erano stati prelevati; la delusione atroce di questi sventurati, che erano a un passo dalla felicità, si concluse dopo pochi giorni con la morte di due di essi e il trasferimento in un’altra baracca del terzo. Forse l’Italia, non l’avreb bero mai vista ugualmente, la morte sarebbe arrivata comunque a spezzare la vita di quei poveri infelici, ma sarebbero morti senza la disperazione e la
97
solitudine di questo triste luogo; il destino si è rivelato matrigno verso questi nostri compagni di prigionia e sventura.
A metà febbraio avvenne il fatto che forse mi salvò dalla depressione mentale e fisica: cercavano un sarto e, dato che mio padre faceva tale mestie re, da lui avevo imparato i primi rudimenti di questo lavoro così mi presentai al maresciallo tedesco, che mi condusse in una baracca fuori dal settore ospedale. La prima cosa che mi colpì, fu vedere il soffitto della baracca pieno di fagotti: capotti militari etichettati e scarponi a penzoloni; erano gli indumenti che noi stessi avevamo preparato all’ingresso del lazzaretto, questi però erano gli indumenti di chi purtroppo non sarebbe più tornato in Italia. Trovai un altro prigioniero che lavorava da calzolaio e riparava gli scarponi sdruciti dei ricoverati. Mi misi al lavoro. Dovevo fare dei sospensori per chi era stato operato di ernia e mi arrangiai alla meglio; poi dovevo rattoppare le divise dei prigionieri che lasciavano il lazzaretto: un paio di giorni prima di tornare al lavoro venivano spostati in una baracca, dove ricevevano i loro indumenti, così potevano venire nella nostra con gli scarponi o la divisa da riparare. Ciò mi permise di avere una doppia zuppa che, anche se acquosa, era sempre gradita. Un mattino arrivò nel Lager un camion scoperto, chiamarono per nome una ventina di nomi – tra cui il mio – ci caricarono così come eravamo, vestiti del solo “pigiama” e, incuranti del vento gelido che spazzava il camion, ci portarono in un ospedale militare tedesco. Per fortuna il tragitto non fu lungo, ma arrivammo ugualmente intirizziti; un medico ci visitò, ci fecero le lastre ai polmoni, l’angoscia del responso era suffragata dal fatto che ci divisero in due gruppi: chi a destra, chi a sinistra. Il responso lo si seppe al nostro ritor no al lazzaretto. Per fortuna ero nel gruppo dei sani purché, nel frattempo, il freddo preso durante il trasferimento non avesse minato nuovamente il mio fisico. Sembrava quasi che cercassero tutti i mezzi per eliminarci nel modo più naturale. L’allarme aereo veniva comunicato con la sirena e, finché non cessava, non potevamo uscire dalle baracche. La città più vicina era Kiel, ed era questa la meta dei bombardieri alleati. Le loro incursioni, se avvenivano di notte rischiaravano l’orizzonte di rosso fuoco. Arrivò finalmente il mese di marzo: le giornate si erano allungate e il freddo era attenuato. Piansi di gioia all’arrivo del primo scritto da casa. Eravamo rimasti quasi sei mesi senza notizie e, il saperli in salvo e trasferiti nel Trentino, mi diede una carica di fiducia, anche se la fame continuava ad essere una costante in ogni ora del giorno e della notte.
Il magazzino-laboratorio dove lavoravo si trovava in un settore comuni cante direttamente con l’infermeria, l’ufficio del maresciallo e le cucine. Un mattino dovetti portare nella baracca del maresciallo un paio di calzoni, che avevo stirato; guardandomi intorno vidi nel retro della baracca una gabbia con dei conigli. Con sorpresa scorsi un bel pezzo di pane nero, già mangiucchiato. Non ci misi che un attimo, il pane finì nel mio stomaco. Un’altra volta feci una corsa verso la baracca-cucina e vidi attraverso le finestre che era la cucina dei russi.
98
Scorgendomi a gesti mendicare cibo, mi fecero capire che mi dovevo procurare un recipiente. Nella spazzatura, trovai un barattolo e con questo rimediai una zuppa. Un’altra volta, era il tramonto, entrò un carro trainato da cavalli che trasportava una grossa botte per i rifiuti della cucina. Un pri gioniero sbucò dal nulla, non seppi mai da dove era sbucato, si arrampicò velocissimo sul carro e vidi che mangiava il contenuto della botte. Per istinto salii anch’io e mi ritrovai a mangiare con le mani un intruglio di cavoli, patate, sughi vari, pezzi di pane
La festa durò poco perché venimmo presi per la collottola e redarguiti. Stavamo mangiando gli scarti destinati ai maiali. Non so per quale miracolo il nostro organismo abbia potuto sopravvivere, senza patire altre malattie. Arrivò aprile. Cominciavo a non poterne più di vedere tutta la miseria e la morte che giornalmente traspariva dal nostro stato e chiesi al nostro medico, dato che mi sentivo un po’ più in forze, di mettermi in uscita. Era un uomo molto umano. Nei periodi in cui non c’era il controllo dei medici tedeschi, non mandava via nessuno, sapendo che le fatiche cui si andava incontro erano la nostra fine.
Era il 16 aprile quando ripresi il cammino verso la stazione, che mi avrebbe portato ad Amburgo. Eravamo tre soldati prigionieri e la solita sentinella; prima di partire chiesi al maresciallo se potevo sostituire la mia divisa, ridotta a uno straccio e imbevuta di oli e grassi, con quella di un soldato deceduto. Tirai giù dal soffitto diversi fagotti e rovistai finché trovai quel che mi serviva per taglia e conservazione: una strana sensazione mi prese indossando panni che non erano i miei. Quel povero soldato doveva essere deceduto prima di andare a lavorare, perché la sua divisa era ancora nuova e pulita. Cambiai le mostrine e ritagliai la scritta delle sue generalità, impresse nella fodera della giacca perché, se mi fosse successa qualche disgrazia, almeno c’era il mio nome. Il viaggio si svolse come all’andata, scendemmo però a una ventina di chilometri dalla nostra destinazione. In attesa che venissero le sentinelle a prelevarci, ci portarono in un Lager, che si trovava in mezzo a palazzi e abitazioni. Tornato nella mia baracca, ritrovai la sincera accoglienza dei compagni, che mi informarono su ciò che era successo mentre ero nel lazzaretto: per la fuga di un aviere, la Gestapo fece brutali interrogatori sperando di trovare i complici, anche Cagol – il capobaracca – era stato rimpatriato e sostituito dal sergente Magni, trovai quattro nuovi soldati che provenivano da altri Lager. Avevano cominciato a distribuire una zuppa anche alla sera, ci davano due pacchetti di sigarette al mese: era un tabacco formato da bastoncini frantumati, sigarette che scambiavo con qualche pezzetto di pane o qualche patata. Due sigarette valevano un taglio di capelli ma non ne ebbi bisogno perché al lazzaretto mi avevano completamente rasato… … I turni per la cucina erano allettanti; la cuoca di turno alla sera con la scusa di farci pulire i pavimenti ci lasciava mangiare tutto quello che era rimasto nei grandi pentoloni e quelle non erano zuppe acquose, ma minestre di riso, orzo e patate. Finalmente il cuore delle persone si era allentato ma rischiavano grosso, perché era severamente proibito fraternizzare e aiutare
99
i prigionieri. Ci distribuirono anche delle tute da lavoro e delle scarpe con le suole di legno, sempre trattenendoceli dallo stipendio, dato che le divise e gli scarponi che indossavamo, dopo sei mesi di lavoro sotto le intemperie, si erano trasformati in stracci. Tornato al mio lavoro, sentii il responsabile civile che parlottando con i capi nominava il povero Fini e, vista la mia magrezza, forse ebbe pietà di me, e mi assegnò un incarico più leggero. Con raschietti e spazzole di ferro, dovevo pulire le scalette che salivano lungo le cisterne e le passatoie che collegavano uno stabile all’altro. Era un lavoro che mi lasciava anche tempo per riposare qualche minuto, ed ero più libero di spostarmi sen za essere osservato. Il clima che si respirava incominciava ad essere diverso: forse la primavera con i suoi tepori aveva portato una ventata di speranza e i primi giorni di maggio cominciarono ad arrivare pacchi da casa e corrispon denza, ciò contribuì ad alleggerire la nostra condizione di prigionieri.
Le giornate si fanno più lunghe e il tempo è mutevole, piove, viene il sole, poi nevica, l’ora legale viene prolungata e smettiamo di lavorare con il sole ancora alto. Un mattino ci portarono con il camion in una struttura medi ca a Wilhelmsburg, località a pochi chilometri dalla nostra postazione, dove ci fecero una puntura all’altezza del petto, avvisandoci che poteva procurarci la febbre. Era una vaccinazione.
E poi vennero i bombardamenti. Massicci. Un altro pericolo da affron tare. Avevano scavato dietro la baracca una trincea antischegge, che divenne il nostro rifugio durante gli allarmi, sempre più numerosi e lunghi. Una delle tante contraeree era piazzata vicina al cantiere navale, a poche centinaia di metri dalla nostra baracca. Il rumore degli spari, i boati delle bombe ci fra stornavano e la paura cominciò ad essere visibile. Il bombardamento che distrusse mezza fabbrica avvenne il 16 giugno 1944: erano le dieci del mattino, suonò l’allarme, ci condussero nella nostra trincea e subito dopo il caratteri stico rombo dei bombardieri, cominciarono a cadere le bombe. Questa volta vicinissime, sentivamo i sibili delle bombe che cadevano e lo spostamento d’aria che seguiva lo scoppio, l’odore di bruciato e di fumo che ammorbava l’aria. Quella volta l’abbiamo scampata per un soffio, perché le bombe caddero tutte dentro la fabbrica a un centinaio di metri da noi. Lo spettacolo che si presentò ai nostri occhi, lacrimanti per il fumo e la paura, era impressionante: denso fumo nero e lunghe lingue di fuoco fuoriuscivano dalle cisterne, sven trate, coricate, accartocciate.
Uno dei due altiforni era distrutto; binari, vagoni e cisterne erano un ammasso di ferri, accortacciati. Era il finimondo. Arrivarono i pompieri e una compagnia di riservisti, che avevano la caserma a circa cinquecento metri dalla raffineria. Gli operai civili tedeschi si salvarono nei rifugi della direzione. Ci informarono che nella fabbrica dove lavoravano il rame, confinante con un canale della raffineria, le bombe avevano colpito il rifugio dei soldati italiani. La scena fu sconvolgente, qui non ci fu incendio, ma un ammasso di travi, tubi, macchinari, pareti crollate. Ci fecero scavare tra le macerie, per recuperare le salme e i feriti che sentivamo gridare e gemere sotto quella
100
montagna di detriti. Estraemmo diversi morti e molti feriti, uno di questi morì subito dopo. Il loro rifugio era una cantina rinforzata alla meglio con assi e travi e purtroppo il destino infierì su essi. Sistemammo le salme dentro un ga rage, caso strano, qui la morte – diversamente dal lazzaretto – ebbe un diverso impatto in me: nel mio intimo c’era sì il dolore per i giovani strappati alla vita, ma era un destino ineluttabile, che tutti noi correvamo, in attesa della liberazione e uno dei mezzi erano i bombardamenti. Nel frattempo giunsero i ca mion dell’organizzazione TOD con infermiere, medici e la cucina da campo, che distribuì a tutti – civili e non – pane e alimenti vari, scodellando minestre molto sostanziose. Dopo l’affanno e il triste lavoro che avevamo effettuato, ci riempimmo la pancia di tanta abbondanza e nascondemmo nella confusione diversi filoni di pane e altri viveri e per quel giorno non lavorammo più.
I giorni che seguirono ci videro impiegati nel rimuovere macerie per mettere in grado la raffineria di riprendere la produzione. Per accelerare i lavori un mattino vedemmo arrivare due camion di deportati, vestivano casac che a righe, sembravano usciti dalle caverne tanto erano male in arnese, barbe lunghe e visi cadaverici, i sorveglianti avevano sulla casacca un triangolo nero, li frustavano con uno strano arnese di cuoio. Questo spettacolo ci fece inorridire, venimmo a sapere che erano ebrei e delinquenti comuni, vennero essi pure impegnati alla rimozione delle rovine. Noi eravamo dei privilegiati al confronto di questi poveri infelici. Guai a loro se solo alzavano gli occhi. Lavoravano con pale e picconi sempre con la testa bassa e, se per qualsiasi motivo si fermavano, venivano presi a calci e pugni o frustati. Nel tempo che seguì, vennero anche donne, giovani e anziane, con lunghi camicioni a righe, e scaricavano camion di mattoni, travi o tavole. Erano – al pari degli uomini – emaciate e abbrutite, venivano anch’esse maltrattate e costrette al lavoro forzato. La pietà per esse e la rabbia per gli aguzzini ci rivoltava lo stomaco, ma nulla potevamo fare, se non pregare, che l’inferno in cui eravamo precipitati finisse al più presto. Durante la mia giovinezza, ma nemmeno nella mia famiglia, avevo sentito parlare del problema ebraico. Non ne sapevamo nulla ed ora mi trovavo davanti a una realtà che mi riempiva di orrore. Hanno trasferito il nostro Lager in una costruzione di mattoni, a circa quattrocento metri dal posto di lavoro, a venti metri vi è una costruzione ge mella, occupata da lavoratori civili. Siamo vicini a un piccolo bunker in mura tura che, oltre a noi, viene occupato da civili durante gli allarmi notturni. Non siamo tranquilli, perché lo spessore del cemento è esiguo. Di giorno quando suona l’allarme, dopo le distruzioni subite, assieme ai lavoratori tedeschi e alle sentinelle, con i camion ci portano sotto i cavalcavia della autostrada dove almeno non ci sentiamo in trappola e assistiamo in lontananza ai bombardamenti, che diventano sempre più distruttivi. La raffineria, in poco tempo, riprese a produrre nuovamente a pieno ritmo e treni cisterna supplivano alle avvenute distruzioni; il via vai di vagoni e di chiatte era frenetico, i bidoni erano destinati tutti all’aviazione e alla Wehrmacht: lo sapevamo dalle scritte, che erano stampigliate sui coperchi.
101
Vennero squadre di prigionieri italiani che costruirono due giganteschi rifugi in cemento armato all’interno della raffineria, con pareti e solai spessi due metri, porte in acciaio da dieci centimetri: saremmo stati più tranquilli durante i bombardamenti futuri!
La casetta gemella, occupata da civili, venne rioccupata da altri prigio nieri italiani e anch’essa venne contornata da reti e filo spinato, ma loro erano una realtà distinta dalla nostra, avevano altre guardie e lavoravano in un altro stabilimento.
Vennero altre malattie a decimarci: Rossi, un modenese, continuava a soffrire di grossi foruncoli ad una gamba e, dopo vari ricoveri, venimmo a sapere che gli amputarono l’arto; ad un altro gli si gonfiò il collo a tal punto che non riusciva più a respirare e di lui non sapemmo più nulla.
Un mattino dei primi giorni di agosto, ci portarono con il camion della raffineria in un grande piazzale, dove erano già radunati qualche migliaia di altri italiani. Da un palco, con il megafono, ci invitarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana (RSI) e diventare liberi lavoratori. L’offerta di libertà ci divise in due gruppi, vi furono aspre discussioni sulla opportunità di aderire o meno a questa ‘repubblica’: dopo il trattamento subito, dovevamo dire grazie a chi ci aveva trattato come bestie? Come prima conseguenza venimmo separati dai dodici ex-IMI che avevano scelto la libertà. La baracca era suddivisa in sei ambienti comunicanti (oltre alla stanza e all’ufficio della guardia), quattro locali erano adibiti a dormitorio e altri due servivano per i servizi igienici; murarono quindi la prima stanza e aprirono in essa una porta che dava sulla strada, libera da reticolati e inferiate e suddivisero anche i ser vizi. Con malcelata invidia vedevamo questi nostri compagni dopo il lavoro uscire e prendere il battello che conduceva in città e al ritorno ci raccontavano meraviglie di ogni sorta.
I loro pasti erano gli stessi nostri, ma li consumavano nella loro stanza priva di sbarre e reticolati. Siamo stati comunque tra i fortunati, perché non subimmo le angherie di cui furono oggetto molti nostri altri compagni, che erano prigionieri in Lager molto affollati, dove il rifiuto di aderire alla nuova repubblica scatenò il malanimo delle guardie e per questo furono bastonati per ogni nonnulla, nella speranza di fiaccarne lo spirito e la determinazione di non aderire alla RSI.
20 Settembre. Questo giorno segna un importante data della nostra prigionia, vista la scarsa adesione alla Repubblica Sociale, venimmo di fatto trasformati in lavoratori civili. Vennero dei civili che parlavano italiano, ci dissero che dovevamo ringraziare le autorità naziste e fasciste per questo cambiamento di stato e che saremmo restati alle dipendenze della raffineria, mantenendo le condizioni si lavoro assegnatoci, saremmo stati stipendiati con paga sindacale, la direzione ci avrebbe trattenuto dallo stipendio i contributi previdenziali e le tasse, tolto l’importo dovuto per i pasti e l’alloggio, ciò che restava ci veniva dato in contanti.
Tolti i reticolati che circondavano le costruzioni e allontanati i militari
102
di guardia, venne un responsabile della fabbrica, un certo Rasmusser, che si insediò negli ambienti occupati dai militari e divenne il responsabile dell’or dine e il tramite tra noi e la direzione. In attesa del passaporto ci diedero diversi documenti cartacei, nei quali veniva specificato chi eravamo e dove lavoravamo, avevamo il cartellino d’ingresso alla fabbrica, eccetera. Cambiati i pochi Marchi-Lager in veri marchi, tramite il battello di linea che congiungeva la nostra zona con i quartieri della città (eravamo nella zona del porto), anche noi abbiamo finalmente potuto raggiungere il centro. Questa libertà fu un dono impagabile: camminavamo per le strade, liberi, senza timore di essere maltrattati; ci si guardava in giro, quasi timorosi che fosse tutto un sogno. Le strade erano illuminate, le birrerie erano piene di gente, era una babele; ci trovavamo a San Pauli, uno dei più rinomati quartieri del porto. Ci facemmo anche delle fotografie da spedire a casa, ma poi nessu no ebbe il coraggio di spedirle, perché eravamo troppo in male arnese.
Alle ventidue avevamo il coprifuoco e dovevamo essere in baracca; questo obbligo si estinse quando ricevemmo il passaporto. In uno dei tanti pacchi che ricevetti da casa, oltre a generi di conforto, trovai 50 sigarette, che scambiai subito con un operaio tedesco per un paio di scarponi usati. Il lavoro in fabbrica era cambiato: dovevamo innalzare, con scale, corde e tavole, delle passatoie aeree, sulle quali gli operai avevano il compito di isolare le tuba zioni del vapore, dopo aver riparato i guasti. Questo lavoro ci impegnò per diversi mesi, al punto che noi stessi avevamo imparato a fare i lavori di iso lazione. Diventando civili, anche il vitto migliorò ma era sempre scarso; alle nostre rimostranze ci veniva risposto che quello era il trattamento riservato anche ai civili tedeschi.
Venne un altro Natale, ma per fortuna la corrispondenza con casa era frequente e i pacchi continuavano ad arrivare. Gli allarmi erano continui, i rifugi a prova di bomba, il pericolo era quello di non giungere in tempo, perché passavano solo pochi minuti dall’allarme all’arrivo dei bombardieri. Infatti, una notte, correndo verso il rifugio, le bombe furono più veloci di noi e ci caddero a poca distanza: ci buttammo a terra, la paura bloccava le gambe, la strada correva parallela ai binari, dove erano posteggiati vagoni e cisterne. Sarebbe bastato uno spezzone incendiario per annientare tutta la zona.
18 gennaio 1945. Suona l’allarme di primo mattino, ci dirigiamo verso il rifugio, sibili e scoppi scuotono fin nelle fondamenta questo gigante di cemen to armato, capimmo che il bombardamento era diretto sulla nostra fabbrica. Al cessato allarme, il solito spettacolo di distruzione si parò dinnanzi ai nostri occhi: fumo e incendi all’interno della raffineria. Andando verso la nostra ba racca uno spettacolo indescrivibile si presenta ai nostri occhi: il plotone della guardia territoriale, che di solito veniva ospitato nel nostro rifugio era ridotto a una tremenda massa informe di carne, divise e sangue. Vennero colpiti in pieno da un grappolo di bombe: certi si erano nascosti sotto i carri merci e da questi spuntavano, gambe, corpi informi. Una strage, anziani riservisti sacrificati al grande Reich, ma ciò non fu abbastanza. In distanza notammo
103
che la nostra casetta aveva una strana forma, infatti anch’essa era stata colpita da una bomba.
La zona, dove avevo il mio castello e l’armadietto, non esisteva più. Una profonda buca era tutto quello che possedevo, oltre naturalmente a ciò che in dossavo; per mia fortuna era un’abitudine consolidata tenere sempre addosso i documenti. La direzione mi concesse alcune ore libere per rovistare e ritrovare qualcosa delle mie povere cose. Eravamo in dodici a dormire in quella stanzetta: i più riuscirono a trovare qualche indumento tra le macerie, io e il mio compagno di castello invece non trovammo più nulla. Per tre-quattro giorni, soldati della territoriale con una cesta e delle aste di ferro continuavano a frugare nei crateri delle bombe e tra la ferraglia dei vagoni distrutti, alla ricerca di brandelli dei caduti.
Ci stringemmo nelle altre stanze, dormimmo un paio di notti per terra, su giacigli improvvisati, fino a che arrivarono nuovi castelli con pagliericci e coperte. Dopo questo bombardamento non ci fu più acqua, così ci arrangiam mo alla meglio: vicino alla casetta vi era uno dei soliti canali morti dal quale prendevamo l’acqua per lavarci, anche se su essa galleggiavano macchie di olio. Dal Vaticano ci furono inviati indumenti usati: io ricevetti un paio di cal zoni neri a righe, che mi arrivavano alle caviglie, una giacca doppio petto con le maniche così corte, che mi lasciavano scoperti i polsi, un capotto militare e un paio di pullover. Per fortuna nei pacchi da casa, oltre ai generi alimentari, vi erano camicie e biancheria. L’arrivo di questi pacchi era il legame che ci unisce alla famiglia, in essi percepivamo il profumo e l’amore della nostra casa.
Siamo in febbraio, altri due nostri compagni sono partiti per l’Italia con nostra comprensibile invidia. Il lavoro in fabbrica dopo l’ultimo bombarda mento è molto calato, certi reparti sono stati chiusi e si lavora più che altro alla rimozione delle macerie e allo smaltimento delle riserve che ancora esistono nelle grandi cisterne risparmiate dai bombardamenti. La direzione aveva escogitato un sistema per non subire ulteriori distruzioni: dopo il passaggio della prima ondata di apparecchi, venivano incendiati dei bidoni colmi di li quidi infiammabili, così la zona appariva già distrutta alla seconda o terza ondata di bombardieri. Gli allarmi non si contavano più, anche due per notte, dormivamo vestiti e con le scarpe ai piedi. La stufa a carbone non riscalda abbastanza, è freddo, i canali sono ghiacciati e non possiamo prendere l’acqua per lavarci, ci arrangiamo alla meglio in fabbrica.
Sono stato costretto ad andare da un dentista: era da tempo che avevo male, così mi mandarono in centro città. Una dottoressa mi disse che doveva levarmi due denti, perchè non c’erano possibilità per curarli così quella notte ebbi forti perdite di sangue.
Le nostre escursioni serali in città avevano anche lo scopo di procurarci qualcosa da mangiare, andavamo negli ‘Schnellquelle’, piccoli ambienti in cui, per pochi Pfennig, ci davano patate lesse accompagnate da salse di pesce oppure scodelle di brodo di dadi.
104
Per tre o quattro volte l’allarme ci colse in città; i rifugi erano tanti e ben protetti: fu dopo uno di questi allarmi, che si protrasse per alcune ore, che perdemmo l’ultimo traghetto. Così sperimentammo il tunnel sotto l’Elba, che ci condusse fino alla zona industriale, ma per raggiungere il nostro domicilio dovemmo camminare ancora per cinque chilometri, con il timore di allarmi aerei.
Venne aprile, la raffineria era pressoché ferma, ci mandarono a fare barricate anticarro nelle vie di Amburgo
Lavoriamo nei quartieri distrutti, dobbiamo costruire delle muraglie con i mattoni delle case bombardate, e inserire come rostri, diverse putrelle di ferro, sempre raccolte tra le macerie. Terminato il lavoro un cartello avvisava che l’opera era stata eseguita dalla raffineria. Eravamo proprio alla fine ce ne accorgemmo quando tra le macerie trovammo ritratti di Hitler, divise e cami cie brune, bracciali e distintivi con la croce uncinata. Gli operai tedeschi che ci guidavano, scuotendo la testa, ci facevano capire che il loro sogno illusorio era finito.
Siamo preoccupati per l’immediato futuro: l’innalzamento delle barricate nelle strade della città ci fa capire che l’esercito è pronto a combattere casa per casa, solo rifugiandoci nei bunker della raffineria potremmo salvarci dall’imminente attacco. Durante la notte, in direzione di Harburg il cielo è in fiamme; gli allarmi si susseguono ma non vi sono bombardamenti. Ormai dormiamo nel bunker, la notte sentiamo aerei sorvolare il canale a bassa quota e mitragliare il porto, dove sono ancorate diverse imbarcazioni militari.
Un mattino, forse il 27 o il 28 aprile, Rasmusser con nostra grande sor presa e felicità ci lesse un giornale tedesco, che riportava la notizia della morte di Mussolini48 , la guerra in Italia era finita e, con molta probabilità, Amburgo sarebbe stata dichiarata città aperta.
Ciò che rimaneva dell’esercito tedesco, aveva abbandonato la città. Eravamo al settimo cielo. Distribuirono un filone di pane a testa e dei pacchetti di margarina, perché la cucina e la raffineria avevano cessato l’attività in attesa degli eventi.
Era il 2 di maggio; una camionetta si fermò davanti alla baracca, ne scese un ufficiale – credo inglese – con la pistola in pugno. Saputo che eravamo Italiani, ex-IMI, prendendone nota ci disse che l’indomani sarebbero venuti a prelevarci. Quella notte nessuno dormì, cantammo a squarciagola fino all’al ba. L’incubo era finito.
Il giorno dopo, puntuali arrivarono 4 autocarri alleati e con questi la sciammo Amburgo, dopo quasi tre ore di viaggio nel quale attraversammo villaggi completamente distrutti; ci fecero entrare in un ex-campo di concentramento, nella località di Fischbeck ; ci trovavamo in un zona collinosa con campi e boschi di pini, disabituati da lungo tempo allo spettacolo della natura, la vista di tutto quel verde ci dette la vera essenza, della pace.
48 Benito Mussolini morì il 28 aprile 1945.
105
Qui ci fecero fare la doccia e con una pompa ci cosparsero di una pol vere bianca. Ci interrogarono e ci visitarono, ci fecero raccontare la nostra storia, ci diedero dei documenti e, alla nostra domanda di rimpatrio, risposero che ci sarebbero voluti mesi prima di poter tornare a casa poiché la rete fer roviaria era praticamente inesistente. La delusione fu sostituita da una calma rassegnazione: ormai sarebbe stata una questione di qualche mese. Il cibo era buono, mangiammo finalmente perfino della carne, anche se in scatola e altri cibi di cui avevamo ormai dimenticato l’esistenza. Per allietarci, due volte alla settimana venivano compagnie musicali o di varietà; il campo era un ex-lager per ufficiali belgi, i quali godevano persino di una sala teatro con palcoscenico. Trovammo sotto i pavimenti delle baracche scatolette di alimenti, siga rette, corrispondenza, cose abbandonate nella fretta dell’evacuazione, dato che in quella zona passò il fronte. Testimonianza di ciò erano i carri armati sventrati e i rottami di aerei sparsi nella campagna circostante… Il tempo che trascorremmo in questo campo fu un susseguirsi di abitudini ormai perse: il mattino era dedicato alla doccia e per chi lo voleva alla ginnastica. Potevamo uscire dal campo dalle 14 alle 22, così che in gruppetti ci incamminavamo lungo questi sentieri di campagna per assaporare con pienezza d’animo la natura che ci circondava.
30 luglio. Una colonna di mezzi militari entrò nel campo, era arrivato il momento tanto atteso, ritornavamo a casa; dopo averci sistemati sui camion, ci trasferirono in una ex caserma dell’esercito tedesco, eravamo tornati ad Amburgo, scorgevamo le navi che transitavano sull’Elba , ci distribuirono del le gallette, carne e verdure in scatola, e ci diedero il documento di rimpatrio. L’euforia che ci pervadeva non ci fece dormire, finalmente il mattino dopo, raggiunta la stazione che pullulava di soldati alleati e di colonne di rimpa trianti, con una tradotta prendemmo la direzione dell’Italia, tanto desiderata.
Nel lungo viaggio del rientro incrociammo treni ospedali, mezzi militari alleati; nelle soste delle stazioni ci distribuivano cibo, bottiglie di acqua e si garette, nelle stazioni vedevamo i civili tedeschi ammassati nei vagoni merci, ma non sentivamo spirito di rivalsa, avevamo dimenticato tutte le sofferenze patite, andavamo finalmente verso il sole, la nostra casa, i nostri affetti per lungo tempo ardentemente desiderati.
La sera del 3 agosto arriviamo a Mittenewal49, cittadina situata in pros simità del confine austriaco; ci fanno scendere dal treno e ci trasferiscono in una grande caserma, dopo averci nuovamente cosparsi di quella polvere bianca, e averci distribuito zuppa calda e cibi in scatola, ci conducono in camerate vuote di arredi, ci corichiamo sulla paglia tentando di prendere sonno, ma siamo troppo euforici e tesi per poter dormire.
Verso mezzogiorno ci riportano in stazione e riprendiamo il viaggio, siamo vicini a casa, solo poche ore ci separano dal momento tanto bramato di abbracciare i nostri cari e chiudere per sempre questa triste esperienza.
49 Si tratta con ogni probabilità di Mittenwald.
106
5 agosto 1945. Alle ore 3 di notte il treno si ferma, sono a Bolzano; salu tati i compagni di viaggio, scendo dal treno con gambe tremanti per l’emozio ne. In stazione trovai civili e soldati coricati sulle panche nelle sale d’aspetto in attesa della fine del coprifuoco. Finalmente, alle prime luci dell’alba mi incamminai lungo le strade conosciute.

Ma il viaggio non era ancora finito. Dopo avere contattato amici di fami glia che mi accolsero con le lacrime agli occhi, presi il trenino che mi portò alla Mendola, ma non essendoci mezzi di locomozione, mi incamminai verso Ronzone50, dove la mia famiglia era sfollata, camminando di buona lena rag giunsi le prime case del paese, ad una signora affacciata chiesi se conosceva la mia famiglia, questa, comprendendo chi ero, mi fece salire in casa e corse a chiamare i miei famigliari, è impossibile descrivere l’incontro, gli abbracci, le lacrime di felicità che suggellarono questa triste esperienza della mia vita.
In questi sessanta anni, forse per pudore, non raccontai a nessuno – neanche alla mia famiglia – i fatti più dolorosi che mi videro come protagonista. Scrivendo queste mie memorie e avendo poi conosciuto le grandi tragedie che furono perpetrate in nome di una follia, mi sono reso conto che i nostri sacri fici e le tribolazioni patite, furono niente, al confronto di quelle subite da altri. Ho voluto portare questa mia testimonianza in memoria di quei sessantamila (chi dice ottantamila) IMI morti, che con il loro sacrificio contribuirono al riscatto dell’Italia, anche se da questa non sono stati ancora sufficientemente riconosciuti, come meriterebbero.
107
50
Località della val di Non, nel Trentino orientale.
Ritorno ad Amburgo, sessant’anni anni dopo51
Dovrei dire 63 anni dopo, perché il 2 novembre 1943 arrivammo ad Amburgo, dopo aver soggiornato nel campo di concentramento di San Bostel52 ,dal 12 settembre 1943.

…Voglio testimoniare quanto segue: navigando in Internet con Google, nella pianta della città di Amburgo, in Werftstrasse, dove c’era la Rhenania Ossag sede del lavoro coatto per noi prigionieri IMI, vidi che esisteva un’insieme di costruzioni e di cisterne con la dicitura SHELL nel tetto di un padiglione.
Negli ultimi tempi c’era nel mio intimo il desiderio di tornare ad Am burgo per rivedere i luoghi dove avevo vissuto gli anni di prigionia e di lavoro coatto e poter ritrovare nella località di Haidkaten traccia del lazzaretto dove avevo trascorso i tre mesi più tragici della prigionia.
51 Leonardi scrive all’ANPI di Bolzano una lettera il 19 novembre 2006 in cui spiega il motivo del suo ritorno ad Amburgo: “A seguito della mia “memoria” già in Vs possesso, voglio testimoniare ancora quanto sugue. In questo periodo ho sentito molto forte il desiderio di tornare ad Amburgo per rivedere i luoghi dove ho vissuto durante gli anni di prigionia e di lavoro coatto e magari per ringraziare qualche dirigente Shell, nel ricordo di un capo tedesco che, una volta tornato in fabbrica (allora si chiamava Rhenania Ossag) dopo un ricovero nel lazzaretto di Heidkaten, vista la mia debolezza (pesavo 50 kg.), con un gesto di pietà mi salvò la vita, facendomi svolgere un lavoro più leggero. Se questo non fosse avvenuto , probabilmente oggi non potrei raccontare gli avvenimenti successi sessanta anni fa…”.
52 Si trattava del lager X B di Sambostel, situato tra Brema ed Amburgo.
108
Sulla sinistra Orazio Leonardi in visita alla Shell di Amburgo nel 2006.
Per organizzare il viaggio ad Amburgo ho interpellato via e-mail il Consolato Italiano di Amburgo chiedendo il loro aiuto per esaudire il mio de siderio di rintracciare il luogo del lazzaretto e contattare la raffineria Shell per una mia eventuale visita, questi contatti risalivano al mese di agosto 2006.
Il Consolato Italiano, nella persona della segretaria dott.sa Bergamaschi, si interessò al mio caso contattando la direzione della Shell e ottenendo il be nestare per la mia visita; del lazzaretto invece non ne hanno trovato traccia; mi hanno però informato che nei dintorni di Amburgo, nel grande cimitero di Ojendorf, vi è un settore interamente dedicato ai caduti italiani IMI.

Il 29 ottobre insieme a mia moglie e ai miei cognati siamo arrivati all’ae roporto di Amburgo.
Il giorno dopo, contattato il consolato, siamo andati a visitare il sacrario di Ojendorf… È stata un’esperienza dolorosa, vi sono sepolti più di 5800 soldati IMI, nelle lastre tombali vi è inciso il nome, cognome, arma e grado di ogni caduto… Camminando tra le tombe rivivevo come in un tragico sogno, il periodo triste della mia permanenza nel lazzaretto, rivedevo i volti emaciati e sofferenti, risentivo le invocazioni e la disperazione nelle voci senza speran za, nella certezza di non più rivedere i propri cari.
Confesso, che un pianto irrefrenabile ha scosso il mio essere, è stata un’esperienza che non potrò mai più dimenticare. Mi ero portato dall’Italia un tricolore, e in esso ho avvolto dei fiori che ho deposto sul sacello che ricorda i nostri soldati morti nella disperazione, morti di stenti, di fame e di malattia.
109
Orazio Leonardi con alcuni responsabili all’interno dello stabilimento Shell di Amburgo.
Con commozione ho saputo,che tutti gli anni, nella giornata delle Forze Armate, il Consolato Italiano e autorità Germaniche, rendono onore e omag gio ai nostri caduti. Il giorno dopo un taxi ci ha prelevato dall’albergo e ci ha condotto alla raffineria Shell.
Sono stato accolto con vera cortesia e curiosità dall’addetto alle pubbli che relazioni, Ing. Henry Weber che, tramite un’interprete – anch’essa messa a disposizione dal Consolato – volle sapere tutto sulla mia prigionia, il contesto storico in cui mi ero trovato, il lavoro coatto che eravamo stati costretti a svol gere. Il mio racconto lo stupì e lo commosse; si è dimostrato così interessato da condurmi in un archivio, dove giacevano vecchi documenti, ma di quegli anni non esisteva traccia. Dato che mi ero portato da casa i documenti, rila sciati nel settembre 1944 dalla Gendarmeria quando contro la nostra volontà diventammo lavoratori civili e che attestavano che il nostro datore di lavoro e il nostro domicilio era presso la raffineria Rhenania Ossag, l’ing. Weber se li è fotocopiati e ha chiesto all’interprete di tradurgli la mia memoria, per conoscere appieno l’esperienza da me vissuta. Dopo averci fatto visitare i vari reparti dandoci spiegazione tecniche sul lavoro, ormai totalmente computerizzato, siamo stati invitati alla loro mensa. Al momento del commiato mi ha abbracciato con calore e simpatia.
Seguono ora i risultati di alcune interviste condotte nel 2007 a Bolzano ad ex-Internati. Cominciamo con Tarquinio Barbierato.
110
3.2 Tarquinio Barbierato
Tarquinio Barbierato è nato il 21 maggio 1920 a Padova. La sua famiglia si trasferì a Bolzano nel marzo del 1940, quando lui era già stato richiamato al servizio militare. I genitori avevano preso in affitto un maso (che oggi non esiste più) all’angolo tra via Milano e via Palermo. Fu richiamato alle armi il 2 febbraio 1940. Dopo due anni e mezzo di servizio al distretto militare di Pola, venne trasferito al ruolo di istruttore per le reclute. In seguito, contem poraneamente alla sua attività di istruttore, svolse servizio di guardia armata a Pola: presso le scuole della Marina, all’ospedale militare della Marina, alla centrale elettrica della città. Svolse servizio di istruttore per qualche mese anche a Trieste. Poi, con l’armistizio, arrivarono i tedeschi, e ordinarono di consegnare tutte le armi.
Il giorno 30 settembre ci hanno condotti tutti al porto di Pola. C’era la motonave “Vulcania”, adibita al servizio ospedale, dipinta di bianco con una gran de croce rossa, enorme, 22.000 tonnellate… Siamo saliti in 4.000, ci hanno messi dappertutto. Io ho dormito in coperta, mi ricordo ancora, perché era caldo. Ricordo che siamo arrivati a Venezia, siamo sbarcati nell’isola della Giudecca alla sera. Da lì ci hanno fatti scendere tutti e c’è stata la scelta; chi voleva aderire e chi non voleva aderire… Ricordo che nel gruppo c’erano molti avieri e marinai; la metà decise di aderire. Quelli che aderivano potevano subito tornare a casa, a raggiungere le proprie famiglie. I non aderenti venivano invece caricati sui vagoni e messi in viaggio per cinque giorni, quaranta per vagone... Siamo andati attraverso il Tarvisio, poi l’Austria, a Kemnitz, Lipsia e siamo arrivati a Berlino. Da Berlino a Stettino, sul mar Baltico, lì era un grande campo, si stava malissimo. Una squadra di noi, una ventina di noi hanno chiesto di andare a lavorare, subito… Una parte andavamo a montare baracche in legno e un’altra parte a fare degli enormi scavi nelle piazze principali per consentire che si formassero degli accumuli d’acqua quando bombardavano per spegnere gli incendi.
Ad un certo punto ha incominciato a fare freddo, molto freddo, ci hanno fatti rientrare al campo di concentramento e trasferiti a Mannheim, sul Reno. Poi insieme ai miei compagni siamo stati alloggiati presso una scuola e adibiti tutti allo sgombro delle macerie… Poi lì mi sono sentito poco bene e sono stato trasferito in un campo di concentramento; era un campo di smistamento vicino a Düsseldorf, dove c’era un ospedale militare italiano: c’erano metà italiani e metà russi; però era amministrato e diretto da ufficiali slovacchi… Nell’ospedale operavano con le lame da barba, le fasciature venivano fatte con la carta igienica… Dopo in estate facevano i vermi, quando tiravano via la carta igienica sulle ferite c’erano i vermi, no? E lì c’era una media di 10-12 morti al giorno, quasi tutti di TBC.
Lì sono stato due mesi e ho conosciuto il capitano medico Manca e poi un tenente medico trevigiano di cui non ricordo il nome, fumava le foglie di
111
patate, povero diavolo. E lì si doveva lavorare in che condizioni… C’era un capellano militare che dopo la guerra sono andato a trovare a San Giovan ni Persiceto (Bologna); questo qui era riuscito ad ottenere per trasportare i morti uno di quei carretti che hanno i tedeschi con le sponde alte, con due cavalli. Su questo carro vengono caricate le casse da morto. Venivano sepolti umanamente. E questo cappellano era riuscito a farsi autorizzare a coprire il carro con una enorme bandiera bianca, rossa e verde che lui l’aveva sottratta in Grecia, l’aveva nascosta e lì copriva le casse che andavano al cimitero. Mi ricordo che si chiamava don Antonio.
Sono rimasto in ospedale due mesi. Avevo sempre la febbre. Lì ho visto le cose più strane. Gente che… I malati di TBC quando camminavano finiva no uno contro all’altro, non si vedevano neanche… Erano come degli scheletri umani che si spostavano. Ricordo uno di La Spezia, sarà stato alto come lei, che voleva entrare in baracca. Lo sa che non riusciva nemmeno ad alzare il piede per scavalcare lo stipite della porta? E allora io sono andato istintiva mente per aiutarlo, l’ho preso per il polso, ho messo una mano sotto l’ascella e l’ho sollevato tutto… Sarà stato trenta chili… Cose bestiali.
Vicino al campo c’era una fabbrica di benzina. Quando arrivavano i bombardamenti i tedeschi, anziché tenere accese le luci che illuminavano il campo di concentramento, per indicare agli anglo americani la presenza di prigionieri, spegnevano tutta l’illuminazione di modo che gli americani per sbaglio bombardavano anche noi…
Poi da lì sono guarito. Naturalmente i russi avevano un trattamento par ticolare, i russi li seppellivano nelle fosse comuni… Li avvolgevano nei fogli di carta oleata di colore arancione… li chiudevano con un legaccio e poi nella fossa comune, dopo un po’ di terra, c’era sempre la pala meccanica che aspet tava per coprirli…
… Io suonavo la fisarmonica, avevo con me la fisarmonica. C’era un mio amico che suonava il violino, è di Fermo, è stato sindaco di Fermo… C’era un capitano tedesco, che era il responsabile del Lager, il quale ci tolle rava, anche lui stava qualche volta ad ascoltare. A un certo momento hanno detto «Siete idonei». Basta, via.
Siamo finiti a Düsseldorf. A Düsseldorf ci hanno portati in un comando tedesco e ci hanno classificati. Ci hanno chiesto «Tu cosa fai?». Ero con un caro amico che era un maestro di Alessandria, Benzi Giovanni. Mi disse: «Tu cosa dici?». Lui aveva deciso di fare il contadino, «così vado in campagna e sto bene», disse. Dico io «il contadino non lo so fare»… Purtroppo, se ti mandavano di ritorno da dove eri andato a lavorare, dicevano che non eri all’altezza e ne passavi… Ne abbiamo visti noi…
Io e un amico siamo finiti a Remscheim (?), a una quarantina di chilo metri da Düsseldorf, vicino a Solingen, a una decina di chilometri da Wup perthal. Siamo finiti in una fabbrica di utensili che faceva anche parti mecca niche per carri armati… Io me n’ero accorto perché mi erano capitati in mano dei disegni e si vedeva che i pezzi servivano per i carri armati.
112
In questa fabbrica il sottoscritto dopo quindici giorni è stato scelto, mes so direttore del reparto tempere. Il mio capo vero e proprio era un anziano di 65 anni, piangeva sempre perché aveva un figlio disperso in Albania e uno disperso in Russia. Siccome io avevo lavorato i primi quindici giorni con lui, là, e mi ha visto lavorare, mi ha detto: «Te la sentiresti di fare il direttore la notte?». I turni erano infatti di 12 ore. Senonché al sabato loro non lavoravano. E allora il sottoscritto Barbierato si faceva 12 ore + 12 ore che vuol dire 24 ore, sempre in fabbrica… Ero trattato benissimo e infatti lì ho conosciuto cosa vuol dire lavorare seriamente.
Una sera, un sabato sera, sono uscito, sono andato a prendere una birra, io e questo giovanotto del violino. C’era una birreria lì a trecento metri, un viale alberato di tigli, un odore fantastico mi ricordo, e stavamo lì uno vicino all’altro… Ad un certo punto vedo un signore e una signora che venivano ver so di noi, dall’altra parte della strada. Quando saranno stati a dieci metri da noi, lui si è tolto il cappello e ci ha salutati. Era il padrone della fabbrica! Lui mi conosceva, sapeva chi ero io e cosa facevo nella sua fabbrica…
Tre quattro giorni prima della fine della guerra ci hanno concentrati tutti su una collina a Wupperthal. Tutti: russi, francesi… E per una notte e due giorni siamo stati sotto le cannonate degli americani… Tarquinio mi ricorda che gli americani continuavano a sparare verso una montagna e non ne capiva il motivo, che però venne presto svelato quando tutta la montagna saltò per aria: Era piena di munizioni in gallerie.
Con l’arrivo di due “enormi carri armati” americani Tarquinio e compa gni sono finalmente liberi: era il mezzogiorno del 25 aprile 1945.
113
La testimonianza di Bruno Bertoldi è stata raccolta dallo storico rovereta no Nicola Spagnolli. Questo ex internato, di origini trentine ma residente a Bolzano, è anche un sopravissuto dell’eccidio di Cefalonia. Per tale motivo ci è sembrata cosa interessante proporre in Appendice un dettagliato aggiornamento storiografico sui fatti accaduti nell’isola greca nei giorni successivi alla dichiarazione italiana di armistizio.
3.3.1 La guerra di Bruno, di Nicola Spagnolli Riportiamo qui di seguito i risultati delle conversazioni tenute da chi scrive con il sergente maggiore Bruno Bertoldi, reduce di Cefalonia, nel settembre del 2007 nella sua casa di Bolzano. Bruno Bertoldi nasce a Mitterndorf, in Austria, il 23 ottobre del 1918 in un campo di concentramento dove, durante la prima guerra mondiale, erano stati raccolti i trentini che abitavano in ter ritori prossimi alle zone di guerra e che per questo erano stati sfollati dalle autorità austriache.
Nel 1919 torna con la famiglia a Carzano, in Valsugana, dove i suoi congiunti vivevano prima dell’esodo forzato. Dai 15 e i 18 anni fa l’apprendi sta fabbro. Finito l’apprendistato nel 1937, e consigliato da uno zio entusiasta della vita e dell’arte militare, fa domanda per entrare nell’esercito e va a Ve rona al corso per sottufficiali. Bertoldi non aveva un interesse particolare per l’esercito né il fervore bellicista instillato dal regime fascista nei giovani ma, un po’ per spirito d’avventura, un po’ per trovare un’occasione di realizza-

114
3.3 La guerra di Bruno Bertoldi, una vita nei Lager
Bruno Bertoldi sull’isola di Corfù nel 1942, durante un momento di svago
zione in un contesto di povertà e penuria di possibilità, decide di arruolarsi. A Verona è impiegato al Comando Auto. A quel tempo, ci dice Bruno, non c’erano gli autoreparti ma c’era solo un comando auto che forniva mezzi e autieri ai vari reparti dell’esercito secondo le necessità.53
Tra il ’38 e il ’39 viene destinato come autiere con il grado di caporal maggiore al IV Corpo d’armata di stanza a Bolzano. Nel giugno del 1940, quando Mussolini proclama l’entrata in guerra dell’Italia, è a Colle Isarco dove era collocato un deposito di automezzi. All’annuncio della mobilitazio ne, viene destinato al Quartier Generale della Divisione Acqui a Merano, dove svolge servizio per la XVIII legione Camicie Nere d’Assalto.
Partito via mare per il fronte greco-albanese, Bruno sbarca a Durazzo nel dicembre del 1940 dove ritrova la XVIII legione Camice Nere, salpata per l’Albania dal porto di Brindisi.54
Da Durazzo, man mano che le operazione belliche volgono a favore dell’Italia coadiuvata dai tedeschi, egli prosegue a sud via terra assieme al Comando della Divisione Acqui e alle CC.NN. Da Porto Edda 55, nell’aprile del 1941, Bruno parte alla volta di Corfù assieme alla Divisione Acqui. Sull’isola, dove inizialmente era stato dislocato il Comando di Divi sione, rimane tutto il resto del ‘41, dopodiché, dal 1942 fino all’eccidio, è a Cefalonia al seguito del comando della Divisione Acqui. Una volta arrivato a Cefalonia, perde qualsiasi contatto con la XVIII legione CC.NN.56
Il comando della divisione era dotato di otto vetture, in particolare auto mobili Fiat e autocarri Taurus OM, e di quattro motociclette, di cui due Moto guzzi Alce in dotazione del Regio Esercito e due requisite ai civili in Italia.
Questa foto di Bertoldi fu scattata a Cefalonia da un commilitone, poco prima dell’8 settembre 1943

53 Il Reggimento autieri fu costituito solo nel 1942. Fonte: Sito internet dell’esercito, www.esercito.difesa. it/root/Unita2_sez/arma_tramat_index.asp.
54 G. Bedeschi, Fronte greco-albanese: c’ero anch’io, Milano, Mursia, 1977.
55 Già Santi Quaranta, ribattezzato così in onore di Edda, figlia di Mussolini.
56 Nel 1942 non c’era più la XVIII legione CC.NN perché sostituita dal 19° battaglione e 367° compagnia mitraglieri CC.NN. Si veda G. Rochat, op. cit., 1993, p. 33.
115
Dello sbarco sull’isola e dell’occupazione, Bruno non ha ricordi di con trasti o particolari difficoltà, tanto da aver quasi dimenticato di essere in guer ra. Stando a quanto racconta, i rifornimenti di cibo arrivavano regolarmente da Patrasso e venivano scaricati a Sami, il più delle volte, o ad Argostoli. A differenza della truppa, che lamentava scarsità, sia qualitativa che quantita tiva di viveri, Bruno non ricorda problemi di questo tipo. Riusciva persino a regalare ad alcuni bambini del luogo qualche genere di prima necessità.
Sull’isola egli era autiere del generale Edoardo Gherzi, classe 1889, co mandante della fanteria divisionale che aveva combattuto nella prima guerra mondiale.
Sul carattere e l’atteggiamento di Gherzi, Bruno ricorda come il suo obiettivo fosse quello di condurre l’occupazione dell’isola nella maniera più pa cifica possibile. Gherzi, continuali sergente maggiore, pensava continuamente alla sua famiglia in Italia. Quando si trattò di decidere se arrendersi o combattere, Gherzi fu tra quelli pronti a consegnare le armi ai tedeschi pur di ritornare a casa dalla sua famiglia e di far ritornare sani e salvi i propri uomini.
Nel giorno della caduta di Mussolini, Bruno non ricorda particolari episodi avvenuti sull’isola. Viene a sapere della destituzione del duce diretta mente da Gherzi quando va a prendere il generale alla mensa ufficiali. Stando alle sue parole, il sentimento prevalente scaturito dall’annuncio della caduta di Mussolini fu: “tutti a casa”.
Il sergente maggiore non aveva accesso agli uffici del comando di Di visione, per cui non aveva alcun canale informativo privilegiato. Non venne a conoscenza del contenuto dei colloqui fra Gandin e i tedeschi, né seppe che da Brindisi era arrivato l’ordine di resistere ai tedeschi. Egli è convinto, come altri superstiti o familiari delle vittime, che a scatenare il conflitto fu l’ordine di Apollonio di sparare sulle due motozattere tedesche nell’episodio del 13 settembre.
Fino all’agosto del ’43, racconta, il comando di Divisione e il comando della fanteria divisionale erano collocati ad Argostoli; poi, per motivi di sicu rezza, con lo scoppiare del conflitto le sedi dei due comandi furono collocate in due località separate: Gandin si spostò a Razata 57, Gherzi a Kokkolata vicino a Keramies presso la “Casa del Dottore”. Sempre a Keramies c’era il suo domicilio e quello del comandante della fanteria.
Il nostro autiere non è stato direttamente testimone delle trattative tra Gandin e i tedeschi nei giorni successivi all’8 settembre. Nei giorni cruciali ricorda che accompagnava Gherzi ad Argostoli per seguire le trattative tra Gandin e Barge. Con il comandante di divisione, non ebbe praticamente con tatti.
57 Non abbiamo trovato traccia di questa nuova collocazione nei saggi consultati, anche se ,guardando le mappe fornite da Montanari nel suo saggio, si possono osservare gli spostamenti del comando nelle varie fasi del conflitto, prima nelle vicinanze di Razata e, successivamente più a ovest verso la costa, in quelle di Prokopata.
116
Nelle ore finali degli scontri, la sede del comando di Gherzi viene bom bardata da colpi di mortaio e circondata dai tedeschi. Bruno, che aveva ricevu to l’ordine di preparare l’auto andandola a recuperare sotto gli ulivi, incontra i soldati tedeschi che avevano circondato la casa. Un soldato si prepara a fare fuoco su di lui ma, e qui Bruno ha vaghi ricordi, l’arma si inceppa o il militare ha un momento di esitazione. Il sergente maggiore proferisce qualche parola in dialetto che viene capita dal militare in divisa tedesca, suo conterraneo arruolato nella Wehrmacht. Quest’ultimo lo risparmia e lo lascia andare. Fug gendo, Bruno sentirà i colpi dei mitra tedeschi che falciano Gherzi, il tenente colonnello Sebastiano Sebastiani e gli altri occupanti della sede (marconisti, piantoni, attendenti). Secondo Bruno, a rimanere uccisi in quel 22 settembre presso la “Casa del Dottore” furono 14 persone. Lui fu l’unico superstite. Racconta di ripensare spesso al volto di quel soldato e di avere l’impres sione che si trattasse di un suo ex compagno al corso sottufficiali, il quale aveva lasciato l’Italia per seguire in Germania la famiglia che aveva optato per il trasferimento nel Reich.58 Fino a pochi anni fa, racconta, quell’immagine del soldato con il mitra spianato si ripresenterà più volte in sogno. Scampato alla strage della “Casa del Dottore”, dopo alcuni giorni di clandestinità presso Keramies, Bruno va ad Argostoli a costituirsi per il timo re che la famiglia che lo ospita possa subire rappresaglie. Si consegna ai tede schi, rimanendo prigioniero ad Argostoli per alcuni giorni presso il comando della Marina germanica. Posto di fronte alla proposta di continuare la guerra in divisa tedesca, oppone il rifiuto. Per lui la guerra è finita, non ne vuole più sapere. Vuole solo tornare a casa.
Dopo aver atteso la partenza in qualità di prigioniero, ai primi di ottobre del ’43 viene imbarcato ad Argostoli alla volta di Patrasso59. Da Patrasso viene condotto ad Atene da dove, via treno passando per l’Albania, la Jugoslavia, l’Austria, e la Germania, arriva a Leopoli, in Ucraina. Da qui partirà alla volta di Minsk, in Bielorussia, all’inizio del ’44.
A Minsk, il sergente maggiore viene rinchiuso in un campo di prigionia per soldati russi e da lì condotto a est, a Borisov dove, assieme a una quaran
58 Tra il 1938 e il 1939 il governo italiano e quello tedesco si accordarono per affrontare e risolvere la questione altoatesina. Dopo due anni di trattative, il 23 giugno 1939, a Berlino vennero firmato gli accordi, in seguito ai quali, le popolazioni di madrelingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, della zona mistilingue della provincia di Trento, dell’Ampezzano, del Bellunese e della Val Canale (in provincia di Udine), furono poste di fronte ad una scelta: mantenere la cittadinanza italiana, e quindi restare nelle proprie case, ma rinunciando una volta per tutte ad essere considerati tedeschi, oppure optare per la cittadinanza del Reich, accettando il trasferimento oltre confine e la liquidazione dei beni. Si veda L. Baratter, Le Dolomiti del Terzo Reich, Milano, Mursia, 2005, pp. 101-128.
59 Bertoldi non ricorda esattamente il giorno della partenza. Consultando le tabelle dei trasporti marittimi riportate da Schreiber (op. cit., 1997, pp. 376-377), è verosimile ipotizzare che il suo imbarco per il conti nente sia avvenuto o sulla nave Calidon, partita il 13 ottobre, o sulla Gerda Toft, salpata da Cefalonia il 17 dello stesso mese. Bertoldi, però, racconta di essere stato fortunato perché, prima della sua partenza, due navi erano state affondate provocando la morte di centinaia di uomini. Si tratta delle navi Ardena, partita il 28 settembre, e Marguerita, salpata lo stesso giorno della Calidon. Pertanto, è pensabile che Bertoldi sia partito con la Gerda Toft, arrivata senza intoppi a Pireo, sulla costa ateniese.
117
tina di prigionieri (quattro italiani, sei o sette ebrei, sei o sette polacchi, e il resto russi), viene impiegato come meccanico sui mezzi tedeschi in una ex officina che fungeva anche da dormitorio.
Qui c’erano un comandante e pochi uomini tedeschi a guardia di questa squadra di lavoratori coatti. Vi rimane per circa sei mesi poi, con l’avanzata sovietica nell’estate del ’44, i tedeschi, costretti ad indietreggiare, abbandonano il campo. Il comandante, anche se aveva ricevuto l’ordine di uccidere i prigionieri, risparmia loro la vita e li lascia andare. Bruno e gli altri fuggono in ordine sparso nella zona tra Minsk e Borisov.
Catturato dai partigiani polacchi assieme agli altri quattro prigionieri italiani che erano con lui, viene consegnato ai sovietici pochi giorni dopo. Questi, nel frattempo, erano stati informati della resistenza italiana a Cefalo nia e, pertanto, trattano Bruno con un certo rispetto. Il piccolo gruppo di pri gionieri viene condotto a est, a Tambov. In questo campo, siamo nell’autunno del ’44, incontra soldati della ARMIR e militari francesi. Le condizioni di vita nel campo sono durissime per il freddo, le pessime condizioni igienico sanitarie e la fame, a causa della quale, egli racconta, si verificarono ad atti di cannibalismo.
Successivamente viene trasferito nel gulag di Tashkent, in Uzbekistan, dove viene impiegato nella raccolta del cotone.60 Viveva in un sottocampo dove c’erano solo italiani delle armate di Grecia e Jugoslavia. Qui, racconta, incontra anche italiani fuoriusciti dall’Italia per motivi politici che facevano proselitismo in favore del comunismo. Bertoldi era (ed è rimasto) un apolitico, per cui non partecipa a questi incontri. Da Tashkent, a guerra finita, arriva la notizia del suo rimpatrio. Il 13 ottobre del 1945 parte con altri italiani alla volta dell’Italia. Sarà un viaggio durissimo. Per bere si raccoglievano attorno ai bulloni del vagone per raccogliere qualche goccia di condensa.
Dopo aver fatto sosta a Vienna, dove viene preso in consegna dagli americani i quali sottopongono gli ex prigionieri ad un trattamento di di sinfestazione dai pidocchi, il 4 dicembre del ’45 arriva al Brennero. Giunto a Bolzano, dove sosta per una visita medica, viene rimesso su un treno per Pescantina, in provincia di Verona, dove viene interrogato. Qui prende un treno che lo riporta a Castelnuovo, in Valsugana, il 12 dicembre 1945. Giunto in stazione, per la fame e il deperimento fisico, non riesce nemmeno a scendere il predellino del treno. Si lascia così cadere su un cumulo di neve formatosi sul marciapiede del binario, dal quale viene raccolto dal personale ferroviario. Il suo viaggio è finito. Finalmente è a casa.
Nel 1954 Bruno riceve la Croce al merito di guerra per internamento in
60 Bertoldi non sarà l’unico sopravvissuto di Cefalonia a finire nei campi sovietici. Stando al libro di De Negri e Bettini, figlie di ufficiali della Acqui fucilati rispettivamente a Cefalonia e Corfù, altri 870 superstiti saranno fatti prigionieri dai sovietici e sistemati nei gulag. G. Bettini, M. De Negri, La memoria del futuro, Associazione Nazionale Divisione “Acqui” – Consiglio Regionale della Toscana, 2004, scaricabile dal sito http://www.associazioneacqui.it/la_memoria_del_futuro.pdf
118
Germania, assegnata una seconda volta nel 1966. Nel 1977 ottiene dal Mini stero della Difesa il riconoscimento di partigiano combattente nella formazio ne Acqui e, nel 1981, riceve il Brevetto di Volontario della Libertà per aver rifiutato di collaborare con i tedeschi e la RSI.
Dopo aver fatto domanda di risarcimento per il suo lavoro coatto presso i tedeschi e aver ricevuto un primo rimborso, nel 2007 ottiene dalle autorità tedesche, tramite l’International Organisation for Migration (IOM) che si oc cupa di gestire il fondo creato dalla Germania per risarcire gli ex internati, un ulteriore indennizzo. È uno dei pochi ad aver ottenuto un rimborso dall’orga nizzazione sopraccitata. Molti ex internati stanno ancora aspettando.
Bruno ci tiene sempre a precisare che lui riferisce solo ciò che ha visto e vissuto. La guerra da lui raccontata coincide sostanzialmente con quella da lui stesso vissuta.

Si sente fortunato rispetto a quanti non sono tornati da Cefalonia e dalla prigionia, e un po’ si vergogna, si sente in colpa per questo destino a lui fa vorevole. Ciononostante, riesce ancora a sorridere ricordando alcuni episodi, mentre quando ripensa alla sorte degli altri compagni, si fa più pensieroso e sospira.
“Ogni reduce è come un libro con la sua storia da raccontare”, mi ha detto in uno dei nostri incontri. Ha perfettamente ragione il sergente maggio re. Il problema è che questi libri rimangono spesso chiusi e si perdono così occasioni irripetibili perché, anche se le loro pagine sono spesso sbiadite, poco precise nei resoconti, sono delle letture che arricchiscono tanto il ricercatore quanto il neofita.
119
Bertoldi ritratto in Grecia nel 1941, accanto ad un mezzo della “Acqui”
3.4 Mario Comina
Mario Comina è nato a Bronzolo (Bolzano) nel 1924. Lui non è un ex internato ma comunque un testimone diretto di molti avvenimenti che coinvolsero i soldati italiani a Bolzano nei giorni successivi all’armistizio. All’inizio del settembre 1943 era rimasto per diverse ore bloccato sotto il cavalcavia della Stazione ferroviaria di Bolzano in seguito ad un bombardamento anglo ame ricano sulla città.
Lavorando in ferrovia Comina riuscì ad evitare un possibile richiamo militare nell’esercito tedesco, dopo l’istituzione della Zona di Operazioni del le Prealpi.
Infatti quando mi hanno chiamato a fare il militare e han visto che io facevo parte di questa organizzazione internazionale per i trasporti, non hanno avuto il coraggio di obbligarmi a fare il militare… Quindi sono rimasto lì sempre un po’ in bilico e quindi io facevo questo lavoro proprio per salvarmi dal militare.
Io ricordo più che l’8 settembre in sé, che fu un momento di paura e attesa, il fatto che io andavo sui campi del Talvera, dove ci sono gli impian ti sportivi adesso, perché lì c’erano ammassati migliaia e migliaia di nostri soldati. Lì giravo un po’, volevo cercare di aiutare alcuni feriti, i quali… mi confidavano le loro paure, sa io ero giovane e non potevo dare grandi consigli. Però annotavo tutto e sono riuscito ad informare molti genitori. Abitavo vi cino alla ferrovia. Quando passavano questi treni carichi di militari, di nostri connazionali, questi buttavano fuori dai finestrini dei biglietti, ne ho raccolti tanti, ho cercato di darmi un po’ da fare.
Proprio in questa azione dei biglietti una volta mi hanno preso… Le autorità tedesche volevano farmi fare il militare; io ho cercato di dire non posso, sono malato… Alla fine mi hanno dato la divisa della Flak, che era la contraerea, e sono andato a finire sopra a Bressanone, a Sciaves.
Io frequentavo il Liceo artistico a Venezia, quindi dipingevo. Quando sono arrivato su [a Sciaves] ho visto che i pericoli c’erano anche in contraerea. Allora, si costruivano delle baracche, anche quella del ritrovo degli ufficiali. Lì mi sono messo a raffigurare canzoni come Lilì Marleen e [i tedeschi] si sono subito entusiasmati. Allora mi dislocarono a fare il disegnatore in un posto tranquillo, ho fatto un sacco di quadri.
120
3.5 Gioacchino D.
Il testimone in questione è nato nel 1923 in provincia di Belluno, nel paese di Vas (località posta sulla sinistra orografica del fiume Piave, non molto distante da Lentiai). È arrivato a Bolzano nel 1937 (“mio padre era assi stente edile, sapeva che c’era tanto lavoro e quindi aveva deciso di trasferirsi qui”). Prima di essere richiamato militare Gioacchino aveva trovato lavoro presso le acciaierie di Bolzano. Quindi viene richiamato al servizio militare e condotto in zona jugoslava. In seguito viene aggregato alla sua divisione a Bressanone, dove lo coglie l’armistizio.
Io ero nel genio alpini come soldato semplice. La notte dell’armistizio ho cer cato di fuggire, di scappare in ogni modo, ma non ce l’ho fatta. Volevo scavalcare e imboccare le strade che conoscevo, invece ci hanno sbattuti tutti dentro una caserma e il giorno dopo ci hanno portato… Era in centro, ma non so esattamente dove. Era la caserma base, era una caserma grande. Lì ci hanno imbarcato il giorno dopo. Arrivati in Germania sono stato preso e messo in un’officina meccanica vicino ad Amburgo.
Lì purtroppo, senza volerlo, ho fatto un danno di un lavoro. Era un di fetto meccanico che è stato fatto su un pezzo. Mi hanno portato in un posto «assassino», mi hanno buttato in un luogo dove sono rimasto 18 giorni, era un luogo buio in cui non si vedeva niente, come una prigione.
Mi hanno tirato fuori dopo 18 giorni e mi hanno portato in un altro po sto, era una camera a gas… Lì c’era un giovanotto, invalido perché era stato ferito in Russia. Siccome io parlavo un po’ di tedesco, egli dialogava con me e mi diceva qualche cosa. Dice «Stai attento a cosa ti succede adesso… Qui, vedi, vogliono metterti nella camera a gas… Sai cosa fai? Tu ti butti per terra e fingi di essere morto… Ti butti per terra e so io cosa fare».
Ad un certo punto arrivò un superiore che si rivolse immediatamente alla guardia tedesca e gli disse: «Cosa aspetti a buttare dentro questo ragazzo qua?». «Non aspetto niente» – risponde l’invalido di guerra – “perché questo ragazzo qui è morto, non si può assolutamente buttarlo dentro… Perché dob biamo buttarlo dentro? È morto non si può assolutamente buttare dentro… Perché buttarlo dentro se è morto? » «È morto?»
«Si, è morto poco tempo fa»
«Ah si? Va bene. Dopo portalo via».
Mi sono salvato la vita, questa è la cosa che più mi ricordo. La zona ricordo che si chiamava St. Pauli, poco fuori da Amburgo, in periferia. Da lì mi sono salvato perché sono tornato nel mio campo, sono tornato al lavoro e sono arrivato alla fine della guerra.
Si potrebbe dire che non si mangiava niente, un po’ di quelle porcherie di erbe, rape… Non si era grassi!… Sono rimasto ad Amburgo fino alla fine della guerra.
121
Gli inglesi sono arrivati a liberarci… Prima avevo visto tanti bombar damenti, altroché, ad Amburgo. Poverino, uno lo ho salvato io, là nel campo dove ero io. Eravamo sotto a una specie di casa, di baraccone e quando ho sentito i bombardamenti che è venuta giù una bomba, l’ho preso per le gambe e l’ho tirato fuori… Guandalini Nino… L’ho tirato fuori e si è salvato.
A piedi non sono tornato, perché sono 2.000 chilometri! Sono arrivati [ gli Alleati] e ci hanno caricato… Per gli italiani c’erano i treni apposta; ci hanno scaricato a Bolzano. Noi abitavamo alle «semirurali».
La mia mamma e il mio fratello erano al paese. Erano tornati al paese. Quindi sono tornato giù, siccome non sapevo come fare andare ho trovato un posto qui. Ho incrociato un camion che andava giù per la strada. Ho detto: «Dove va per piacere Lei?». «Si va a Feltre noi». «Ma dice sul serio? Potete farmi salire che torno da prigioniero?». «Certo». «E ti portiamo dove?». «A Vas». Da lì mi han portato a Vas, ci siam fermati e lì ho trovato la famiglia.
Nel dopoguerra sono tornato alle Acciaierie dove ho lavorato fino al 1980. Facevo il meccanico. Avevo 24 operai. Nel tempo libero mi occupavo di sport, come giudice/arbitro delle coppe del mondo di sci. Due anni fa mi è arrivato da Roma dal Presidente della Repubblica un attestato di Commenda tore della Repubblica.
122
3.6. Gudrun Giovannini
Gudrun Giovannini è nato l’8 ottobre 1922 a Bellombra, vicino ad Adria, in provincia di Rovigo. Rimane senza papà a 11 anni, con quattro fratelli. La famiglia possedeva un mulino e un forno per la panificazione fino alla morte del padre. In seguito con la famiglia si trasferisce a Bolzano, nel 1938, in via Firenze. La madre aveva preceduto il trasferimento dei figli; da quando, in fatti, aveva trovato impiego alla Montecatini come cuoca.
Poi lei ha trovato casa e siamo arrivati anche noi. Abbiamo proseguito il la voro che avevamo giù, da panettieri. Eravamo ragazzini. Io e i miei fratelli abbiamo lavorato sempre da panettiere presso privati.
Sono partito militare nel 1942. È stata una bella carriera. Sono andato subito in Jugoslavia, lì sono stato ferito ad una gamba.
Ero con il settimo artiglieria Isonzo… Ero a Novo Mesto, in Croazia. Lì sono stato ferito ad una gamba, il proiettile è entrato dal ginocchio ed è uscito dal polpaccio. Al momento non ho sentito niente, solo che dopo dieci minuti avevo tutto il piede bagnato e ho guardato, c’era sangue. Allora sono andato in infermeria, ho detto quello che era successo. L’infermiere mi ha messo un bastoncino di vetro, è passato dentro da un buco e fuori dall’altro. Disse che dovevo andare all’ospedale.
Poi arrivò il comandante, un colonnello, a sentire cosa era successo. Da lì mi hanno mandato all’ospedale, 4-5 giorni, poi sono venuto in licenza. In seguito ho fatto una pleure, allora mi hanno mandato all’ospedale a Novo Mesto, lì ho fatto una trentina di giorni, poi mi hanno mandato in convale scenza e finita la convalescenza mi hanno mandato direttamente al corpo, in Jugoslavia. Allora io mi sono fermato a Gorizia…. Lì ho marcato visita; il dottore mi mandò all’ospedale a fare una visita di controllo. Volevano mandarmi ancora al fronte. Chiesi allora un’ulteriore visita medica.
Intanto è successo il caos dell’8 settembre. Abbiamo sgomberato la no stra caserma e siamo andati al campo di aviazione sempre quella notte. Ab biamo portato via tutto quello che c’era da portare via. Lì sono andato su un apparecchio, tanto [ gli aeroplani] erano lì fermi… Anche i partigiani jugosla vi sparavano contro gli italiani. Allora ho azionato la mitragliatrice dell’aereo e iniziato a fare fuoco. Son venuti subito i comandanti a tirarmi via. I tedeschi hanno circondato il reparto e ci hanno avviati alla prigionia.
Dopo varie traversie venni caricato su un treno a Verona. I treni erano pieni, bisognava salire sul tetto. Anche io salii in cima ad un vagone, sperando di poter saltare giù in prossimità della città di Bolzano. Ma quando arrivai nel capoluogo altoatesino mi accorsi che ovunque era presidiato dalle forze armate tedesche. Non c’era possibilità di fuga né di incontrare la madre che in quei giorni attendeva il mio passaggio alla stazione. Continua così il viaggio verso la Germania.
123
Dopo alcuni giorni di treno, arrivammo a Luckenwald, un campo di smistamento non molto distante da Berlino. Lì abbiamo fatto proprio una cura dimagrante. Durante il giorno prendevano dei nostri e li portavano nei campi a raccogliere delle foglie di barbabietola. Arrivavano alle cucine, buttavano dentro e quello lì era il rancio.
Alla sera ci davano un pane, di quelli grandi, dei mattoni diciamo. Dovevamo dividerlo in 30-32 e anche un pochettino di carne… biancastra, non so che carne fosse se animale o… Per conto mio era, diciamo, di corpi umani, non era carne…
Rimasi lì 40 giorni, arrivai al limite. La fame e le privazioni provocavano dolorose dissenterie con perdita di sangue. Allora da lì mi han mandato a Berlino. Qui ci hanno messi in una settantina in una scuola, adibiti a sgom berare macerie. Un giorno ci hanno mandato a sgomberare sul tetto di un palazzo. Era stata colpita la parte superiore dell’edificio. Nel frattempo suona l’allarme e allora tutti giù. Cercammo di entrare in un rifugio antiaereo ma i tedeschi ci cacciarono, niente italiani!
Sono entrati tutti dentro e noi siamo rimasti nel corridoio. È arrivato il bombardamento e… una bomba si è infilata nel bunker, ci sono rimasti tutti. Abbiamo lavorato dalla mattina alla sera a caricar su morti.
Da lì ci hanno mandato nei dintorni di Berlino, eravamo vicini ad una fabbrica di birra. E lì, anche lì, bombardamenti sempre. Una notte bombardamento, eravamo sotto nei rifugi improvvisati, sentivamo queste bombe che venivano giù… schwhhhhhhhhhh…. È andata bene anche quella volta. Uscia mo fuori, davanti alla porta che dava sull’esterno dell’edificio c’era una bomba inesplosa… E allora il giorno dopo venivano i prigionieri politici, venivano loro a sgombrare e tirare via…
Siamo stati lì un bel po dopo ci hanno mandati a Neumark (?), eravamo un centinaio e dovevamo lavorare in una fabbrica, un gran complesso. Arrivava il carbone dalla Ruhr e tramite un nastro enorme entrava in fabbrica. Con i minerali la fabbrica ricavava diversi prodotti, tra i quali anche la margarina. Insieme ad un amico fui impiegato anche per recuperare dell’olio fuoriuscito da un silos danneggiato durante un bombardamento.
Non si faceva in tempo a riprare un reparto che la notte… tac … bom bardavano. Veniva sempre un apparecchio prima, buttava giù manifestini, « sgomberate che stanotte veniamo». E di fatti non mancavano. Loro avvisa vano prima.
Dopo siamo scappati, in dieci, verso gli americani, perché avevano fatto una puntatina. Noi siamo scappati e abbiamo sequestrato un carro. C’era un contadino con un cavallo, abbiamo preso il carro e il cavallo, abbiamo caricato su i nostri zaini.
All’indomani ripartimmo. Dopo ci siamo rifugiati in un paese che c’era delle saline dove recuperavano il sale da terra, erano profondi seicento metri questi buchi e gli ascensori erano rotti. C’erano due pozzi. E allora sono andato giù un giorno, se non si aveva da bere non si riusciva più a tornare su.
124
Bisognava andare giù con due borracce di acqua. C’era giù tanta roba italiana, casse di stivali, casse enormi di candele (che dopo noi prendevamo per farci chiaro in queste gallerie). C’era nascosta diversa roba in quelle gallerie lì. Insomma un giorno vengo su, porta su qualche cosa che ho trovato… Ci sono tre ragazzine intorno a questo pozzo che piangevano. E allora domando «Perché piangete?». Dice «È andata la mamma giù stamattina e non è ancora arrivata».
Chiesi allora ai miei compagni di avventura se qualcuno di loro era disposto a scendere nel pozzo per cercare la donna. Nessuno voleva andare: «Figurati se vado a rischiare la vita per una donna…». Allora scesi da solo. Quelle bambine mi facevano pietà. Prima di scendere presi con me due bor racce d’acqua e chiesi di poter mantenere un contatto a voce con chi restava su. A metà trovo là en mucieto 61: è la donna raggomitolata, priva di sensi, stesa lungo il ripido cammino a scale che sale a spirale lungo la grande voragine.
Trovo sta signora, era ormai assiderata, le do da bere, è rinvenuta un po’. Lei davanti e io dietro che la spingevo su per queste scale e siamo arrivati su.
Da allora ho vissuto come un nababbo. La signora ha voluto che andassi a casa sua perché le avevo salvato la vita. Ho trascorso lì praticamente quindi ci giorni a casa di questa signora… Ero un pascià… Dopo ci han preso, siamo andati sotto agli americani, sotto agli inglesi, con la speranza di venire a casa presto, invece ci hanno tenuto lì un bel pezzo. Così una sera in due-tre abbiamo deciso di scappare. Abbiamo buttato lo zaino dall’altra parte, abbiamo attraversato l’ostacolo… Appena arrivati di là, tac! Mi hanno preso di nuovo e mi han rimesso dentro!
61 “A metà trovo lì un piccolo mucchio”.
125
3.7 Mantovani Bruno
Bruno Mantovani nasce il 1 febbraio 1922 a Riva del Garda (Trento). Viene catturato a Bolzano mentre si trova lì militare. Era stato richiamato nel 1943 con il primo scaglione 1924, dopo essere stato fatto rivedibile due volte.
Dopo neanche 3-4 mesi di militare mi hanno portato in prigionia. Ho fatto tre mesi il militare a Bolzano, 232° fanteria. Ci hanno fatto prigionieri, ci hanno portati nel Talvera. Di là mi hanno riportato in caserma, caricato su un treno e mi hanno portato a Krems…
Mi trovai in una località vicino a Weidhofen. Appresi nel Lager della rinascita della Repubblica Sociale. Chiesero se volevamo andare volontari, ma io volontario non sono mai andato da nessuna parte, perciò…
Ci portarono in un paese a lavorare, io lavoravo in fabbrica. Il paese si chiamava Amstette, vicino a Mauthausen… In fabbrica facevo le valvole al tornio, lavoravo sulla valvola e dopo un anno mi hanno mandato ai laminatoi e ho fatto un anno di laminatorio… Lì è successa una cosa che non ho fatto apposta – per l’amor di Dio – però c’era il ferro che tornivo che era rovinato e lasciava un segno nella valvola… Hanno detto che il mio era sabotaggio, ragione per cui mi hanno processato, dieci anni ai lavori forzati… E mi hanno mandato ai laminatoi nella stessa fabbrica di prima.
In quella fabbrica eravamo in venticinque di noi [internati], poi dopo ne sono arrivati altri 200 dalla Grecia. Dopo sono arrivati i Russi a liberarci.
A dir la verità non sono uno che mangia tanto. Non ho mai patito la fame. Io sono stato anche una settimana senza mangiare, non soffrivo… Però c’erano quelli… Ricordo un povero disgraziato morto per la fame, era di Belluno. Piangeva sempre, aveva una fame da matti. Noi gli davamo quel poco che avanzavamo perché appena arrivati là, in quel campo, eravamo in 25 ma arrivava il mangiare per 250 persone. Però dopo quando siamo effettivamente diventati 250 le pignatte erano sempre le stesse… Io con la fame, dico la ve rità, non ho mai sofferto.
… Io devo dirle la verità: non ho sofferto la prigionia, ma tanti ne hanno sofferto. Un maestro che è morto, quello aveva paura delle cimici… Quando si spegnevano le luci ti saltavano addosso… Questo maestro non mangiava e non dormiva, si lavoravano dodici ore con mezz’ora di pausa… Ci ha lasciato le penne… Poi ci sono stati tre che sono voluti scappare, sono stati uccisi… Certo che ci cercava guai li trovava… Ma uno che andava tranquillo e beato… Io mi ero fatto prendere in simpatia dal maresciallo… Aveva una bicicletta: io gliela bucavo così poi gliela riparavo e mi dava anche il pane. Ero il suo meccanico personale!
… Dopo siamo passati civili, si poteva uscire, coi soldi che prendevo andavo in un paese a circa 5 chilometri e andavo in un’osteria, coi soldi del campo… Da noi arrivavano anche i pacchi di Mussolini, zucchero e pasta ci davano.
126
Quelli che sono andati volontari con Mussolini sono finiti peggio! Io ho conosciuto uno che era stato volontario nei repubblichini… Quello, dopo, lo hanno portato in ospedale e gli hanno fatto l’appendicite a freddo, porco giuda, ha detto che ha sentito tanto di quel male… Perché lo facevano apposta per vendicarsi contro quelli che erano andati volontari. La guerra è una cosa bestiale.
Poi sono arrivati i russi i quali avevano un buon rapporto con i prigio nieri italiani. In seguito riuscii ad arrivare in macchina fino a Salisburgo; dopo insieme ai miei compagni fui caricato in treno e portato prima ad Inn sbruck, al campo di aviazione; poi a piedi 4/5 chilometri dall’aereoporto alla stazione ferroviaria, scortato dai francesi.
Quando sono arrivato qui a Bolzano mi hanno caricato su un camion e portato alla caserma Huber, al Centro Accoglienza Rimpatriati… Ma io sono andato via subito perché sono arrivati mio padre, mia madre. Mia madre mi ha visto sul camion che mi portava [alla Huber]…
Noi eravamo venuti a vivere a Bolzano nel 1936. Mio papà era venuto da Riva a Bolzano per lavoro. Poi nel ’40 ho fatto la patente. Ho costruito la zona industriale portando materiale, alle semirurali ho portato il materiale, con il ribaltabile, ho portato la ghiaia.
Quando sono tornato dalla Germania ho fatto l’autista, ho sempre viag giato. Autista col camion: facevo Bolzano-Napoli, Napoli-Milano, MilanoBolzano. Una settimana ci impiegavo. Perché le macchine più di 40 km/h non andavano… Poi nel 1948 hanno iniziato gli autobus a Bolzano e io ero autista: facevo piazza Don Bosco – Stazione. Io sono il primo autista di Bolzano… Io ho fatto trent’anni e poi sono andato in pensione. Ho dato il mio contributo a Bolzano, l’ho dato! E come anche! Ho visto nascere la zona industriale e l’ho vista distruggere, ho visto nascere le semirurali e le ho viste distruggere.
127
Giovanni R.
Il signor Giovanni è nato a Venaus (Torino) il 30 ottobre 1922. Si trasferisce con la famiglia a Bolzano quando ha tre anni. “Mio padre era capo cantiere, ha costruito una centrale in Piemonte, una sulla Sila e quella di Cardano”.
Io ho fatto il servizio militare a Torino… Poi in ultimo mi hanno mandato in Grecia perché io ero un radio telegrafista. Sono arrivato ad Atene. Lì ho incominciato a trasmettere… Ad Atene c’è questa montagna dove ci sono delle gallerie, da una parte i tedeschi dall’altra gli italiani… Noi eravamo a disposizione del supercomando. Poi dopo mi hanno mandato a sostituire una persona in fondo al Peloponneso; eravamo in una stazione radio composta da 6 radio telegrafisti.
Tre mesi prima dell’8 settembre 1943, cento metri sopra di noi si è pian tata un’altra radio tedesca. Siccome io ho imparato il dialetto sudtirolese e continuavo a studiare coi libri la lingua ho avuto dei contatti e allora mi trat tavano come un fratello. Il 9 settembre sono arrivate due autoblinde e loro dietro. E noi avevamo capito perché con la radio sapevamo già tutto. Ordini di distruggere tutti i cifrari, rompere la… Quando sono arrivati giù ci hanno preso a calci nel sedere… «Ma come se ieri ero tuo fratello adesso mi prendi a calci nel sedere», no?
E dopo ci hanno fatto fare tutto il Peloponneso a piedi… fino al canale di Corinto. Con i tedeschi coi fucili…Ci hanno messo su dei carri, siamo arrivati ad Atene, lì all’aperto come le bestie che ghe nei pascoli… Siamo partiti da Atene sulle tradotte però aperte, abbiamo passato la Jugoslavia… Il viaggio doveva essere fino a Trieste e da lì mandarci in Italia. Questa era la promessa… Insomma può immaginare: due gallette e una scatolina per alquanti giorni…
Quando si fermava il treno era come con le cavallette: spariva tutto nel circondario per la fame che c’era… Di notte siamo arrivati a Linz, da lì hanno chiuso i vagoni. Arrivati a Vienna ci hanno fatti scendere tutti e tre tedeschi ci hanno portato via tutto quello che c’era negli zaini. E poi siamo ripartiti… Siamo arrivati dopo non so quanto tempo a [?] e lì eravamo 1213.000 militari. C’era un tedesco che girava tra di noi e gridava “Dolmetscher! Dolmetscher!”62 . E io sono andato vicino a questo qui e gli ho detto in dialetto di qua…«Cosa vuol dire Dolmetescher?». Sono parole che uno non ha impa rato… Quello quando ha sentito che sapevo tre parole di dialetto [tedesco] mi ha preso mi ha portato davanti a un capitano… E lì dovevo spiegare [ai prigio nieri italiani] che dovevano aprire gli zaini, che i fascisti dovevano andare da una parte. Dopo da lì ci hanno chiusi dentro… Ce ne avrei da raccontare perché in quaranta dentro un vagone, senza gabinetto senza niente. La facevano nel cappello dell’alpino e cercavano di buttarla fuori, c’erano le inferriate che
62 “Interprete! Interprete!”.
128 3.8
non riuscivi neanche… La disgrazia: un cappello di alpino è caduto fuori ed è rimasto impigliato, sai che ci sono quei ganci fuori… È rimasto fuori pieno di m… Quando siamo arrivati a destinazione c’era un maresciallo che voleva sapere di chi era quel cappello… … Insomma al 6 di ottobre sono arrivato in Boemia, dove c’era una fab brica, c’era una gande miniera di carbone e una grande fabbrica; dal carbone veniva estratta la benzina sintetica… A noi davano qualche pacco di marghe rina e lì c’erano circa 60.000 mila prigionieri che lavoravano… Il peggio di tutto è stato che oltre a morire per dissenteria, per il gonfiore delle gambe eccetera, c’erano i bombardamenti… Io a casa ho delle fotografie dove in un bombardamento sono morti una ventina di miei compagni, li han no messo nelle carte da morto con le corone e hanno detto «questo è quello che fanno gli americani e gli inglesi» e sparavano tre colpi in aria.
Il 20 luglio 1944 c’è stato l’attentato a Hitler. Noi si cantava si rideva. Come guardie tedesche c’erano tutti invalidi e loro dicevano «Ah meno male, chissà che non lo ammazzano…». Anche i tedeschi erano stufi della guerra e della dittatura.
Concludo ricordando che tornando a casa ho incontrato gli america ni che ci hanno chiuso nella fabbrica di birra di Pilsen63. Dentro eravamo 5.000, si dormiva quasi peggio che nei campi di concentramento e per darci da mangiare ci davano ceci, sacchi di ceci, avevano fatto le latrine fuori con delle porte. Eravamo tutti seduti uno vicino all’altro. Per giunta c’era un tubo dell’acqua che usciva fuori, fino a che tutto quell’insieme [di escrementi uma ni] non è arrivato dentro nell’acqua e da lì è incominciato il tifo, tutti dissen terie… Un mio collega di Trieste ha fatto un anno più perché l’han portato col tifo in ospedale… Gli americani ci trattavano come delle bestie.
129
63 La cittadina di Pilsen si trova oggi nella Repubblica Ceca.
3.9. Romeo da Col
Il protagonista di questa intervista non è un ex Internato; però è stato testimone dell’attività del CAR di Bolzano in quanto era uno degli aiutanti incari cati di trasportare i rimpatriati dalla stazione ferroviaria fino alle caserme di via Druso, dove appunto era stato allestito il Centro Accoglienza. Romeo da Col nasce a Domeggie di Cadore (Belluno) e arriva a Bolzano a circa dodici anni di età. “Poi siccome Bolzano c’erano i bombardamenti durante la guer ra ci siamo trasferiti in periferia. Ci siamo trasferiti ad Appiano dove siamo rimasti durante tutta la guerra”.
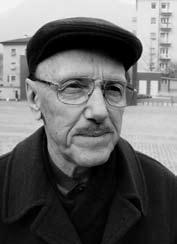
Quando sono arrivati i tedeschi mi hanno anche chiamato ma mio padre mi aveva trovato lavoro nel ’43 alle acciaierie di Bolzano. Ero operaio, un ragazzo, ero lì e facevo il tornitore, lavoravo alle macchine utensili, officina meccanica.
I tedeschi mi chiamano, come hanno chia mato tanti italiani, nel ‘43 o nel ‘44, e sono andato nella caserma a Gries. C’era un tavolo con tutti ufficiali, poi sul pavimento c’era un segno rotondo di gesso. Si andava tutti nudi lì, poi ti facevano girare nel cerchio su te stesso, guardavano poi … Io non ho più saputo niente, non mi hanno richiamato, forse ero troppo giovane e troppo magro per andare lì… Fossi stato in Germania erano mandati in Russia i bòci… Comunque io, lavorando allo stabilimento industriale acciaierie che lavorava anche per i tedeschi (non molto ma faceva anche lavori per le truppe tedesche), avevo una certa possibilità di non andare militare anche se avessi avuto qualche anno in più… Tanto è vero che avevo degli amici di vent’anni che non sono andati, quelli rischiavano di più… Però li hanno trattenuti perché lo stabilimento era mobilitato per una certa produzione… Io ho passato tutta la guerra lì.
L’8 settembre è stata proprio una cosa brutta per me… È stata una cosa brutta perché abitavo alla periferia di Appiano e di notte abbiamo sentito Bem! Bum! Bam! Sparavano col cannone. La mattina dopo c’erano tedeschi d’appertutto perché in paese sopra il paese di Appiano c’era una parte della divisione «Cuneense» che era arrivata dalla Russia e si era fermata qui in Alto Adige. Una parte di questi soldati si trovava su nel bosco a Monte di Appia no. Lì nel bosco c’era qualche battaglione di italiani. I tedeschi invece erano venuti e si erano accampati in paese di Appiano, sotto il paese, andando verso la stazione; dove c’è una falegnameria, adesso, lì c’era un accampamento di tedeschi con l’artiglieria. Sapevano che gli alpini erano su nel bosco: han spa rato su nel bosco ci sono stati almeno 3-4 morti tra gli italiani che li ho visti io. Un tedesco almeno è morto perché l’ho visto io caricare sul camion… Io
130
da bòcia andavo a curiosare, questo è l’8 settembre che ho visto io… Poi gli alpini li hanno catturati, chi non è scappato… Perché da lì, andando su per il bosco, si arriva sul dosso… Bisogna conoscere i sentieri e allora si arriva in provincia di Trento verso la val di Non… Se uno oggi fosse sveglio anche di notte all’alba sarebbe in grado di salire su lì e in un paio d’ore, o poco più, si arriva sulla cresta e dopo vai giù per la val di Non… Allora, finita la guerra già il 27 28 [aprile] i primi prigionieri hanno iniziato ad uscire dal campo di concentramento di via Resia e non sapevano dove andare. La stazione ferroviaria non funzionava. Dal Brennero in giù fino a Bolzano funzionava, a Ora o a Trento forse era interrotta. Questi prigionieri sono capitati in giro per le strade di Bolzano. Le acciaierie di Bolzano e la Lancia si sono prestate a dare da mangiare. Allora io lavoravo lì da bòcia, sui tavoli erano pieno di prigionieri, anche donne, ancora con la divisa da prigionieri e aspettavano per andare a casa giù per l’Italia, qualcuno anche all’estero… Mi ricordo anche dei greci che erano di passaggio. Conclusione, passati due tre giorni, è cominciato a arrivare dalla Germania questa gente e allora hanno organizzato alle caserme Huber, che allora si chiamavano con un altro nome, in via Druso…
La direzione delle acciaierie ha avuto una telefonata da qualcuno e ha chiesto a noi. Mi ricordo di quattro-cinque persone, eravamo amici, il giorno dopo siamo arrivati lì, ci hanno dato la fascia CLN, porto d’armi, però io la pistola non l’avevo… Ecco noi tutti i giorni coi camion andavamo in stazione di Bolzano… arrivavano fuori a migliaia dai treni, gente che non stava neanche in piedi. Dovevamo aiutarli a salire sui camion americani scoperti, su dalle scalette, qualcuno non stava neanche in piedi dalla debolezza, arrivavano dai campi della Germania. Si portavano giù al CAR, poi si aiutavano a scendere, li accompagnavamo dentro… Tutti i giorni avanti e indietro, i camion militari americani erano fermi in fila fuori dalla caserma su via Druso, ogni tanto partiva una colonna… Sono rimasto lì quasi due mesi scarsi per fare questo servizio, anche per le cucine. Poi ad un certo momento arrivava continuamen te gente di tutte le nazioni, greci francesi tutte le razze, donne anche tante.
Gli internati mi raccontavano di quello che avevano visto… Ognuno raccontava la storia del suo campo, io non avevo neanche idea dell’esistenza di questi campi perché non si sapeva quasi… Raccontavano dei campi, dei maltrattamenti, la fame…
131
3.10 Amedeo Bertesina
Nel corso del suo racconto Amedeo ci porta anche la testimonianza del sacrificio di tanti soldati italiani caduti a Dubrovnik – Ragusa il 12 settembre 1943 sotto il piombo nazista della divisione SS-Prinz Eugen. Amedeo Bertesina è nato a Polesella (Rovigo) il 13 ottobre 1923.
Io sono venuto a Bolzano nel 1957. Mio padre era un piccolo contadino, la nostra era una famiglia patriarcale, eravamo 32 in famiglia.
Prima di partire militare facevo il contadino. Mi è arrivata la cartolina in dicembre del ’42. Il 9 gennaio del 1943 sono partito con al 56° fanteria divisione “Marche” a Treviso. Lì è stato fatto un battaglione di reclute. Poi il 20 marzo sono partito per la Jugoslavia destinazione Ragusa via mare, FiumeRagusa, e da Ragusa a Mostar in completamento di una divisione a Mostar.
La situazione di primo impatto… ho trovato gli anziani che… Non avevo ancora vent’anni… Ho trovato degli anziani che mi hanno indicato «stai attento, qua, così» perché ero porta-arma, avevo un fucile mitragliatore. Co munque sparare non ho mai sparato, mai, per fortuna. Sono andato al primo battaglione del 56° fanteria e lì avevamo presidio dell’aereoporto di Mostar, vicino alla città, appena fuori. Dopo sono andato in montagna, sopra Mostar e dopo in Montenegro… Anche là erano ‘puntate’, si partiva il mattino e si tornava la sera.
Poi dopo ci hanno ritirati di là e ci hanno passati presidiari di ferrovia sulla tratta Ragusa-Mostar. Lì si presidiava la ferrovia. Io non ho mai spara to, dico la verità. Solo che sono stato lì fino a un mese prima dell’armistizio. Poi dopo, ad un certo punto, hanno tirato fuori tutti i giovani del 1922 e del 1923 e ci hanno fatto fare il corso di cacciatori anti-carro che dovevamo ad destrati per andare all’assalto dei carri armati per lo sbarco che era stato fatto in Sicilia. Si facevano delle buche per terra e si imparava. Da lì è capitato l’armisitizio.
Allora è venuto il colonnello, ha fatto un’adunata. Disse: «Ricordatevi che i nostri nemici sono diventati gli amici e gli amici sono diventati nemici». In poche parole i tedeschi sono diventati nostri nemici. E alla mattina ci hanno attaccato i tedeschi.
Abbiamo fatto tre giorni di resistenza, ci sono stati anche morti ma solo al momento della resa. La nostra divisione era molto potente senonché già i tedeschi avevano preso la divisione “Messina”; avevamo visto i militari della “Messina” in ritirata verso Mostar… E lì abbiamo fatto la resistenza per tre notti e due giorni. Ci hanno portati alle porte di Ragusa, vicino al mare, lì sono capitati gli ufficiali tedeschi col generale Sandro Piazzoni, comandante del corpo d’Armata, e da lì si sono accordati di lasciar passare i tedeschi per Ragusa mentre noi saremmo partiti con le navi che erano già pronte.
Invece la mattina del giorno 12 settembre ci hanno attaccato che era vamo disarmati; l’artiglieria era stata consegnata la notte ai tedeschi, un tra-
132
dimento del generale Piazzoni… È stato proprio un disastro, i bombardieri tedeschi passavano ormai sopra di noi…
Son venuti una camionetta tedesca con la mitragliera a 4 canne della contraerea, hanno abbassato le canne ci hanno sparato addosso con la 20 mil limetri, un disastro, un macello. Noi eravamo disarmati. Io mi sono salvato perché ero uno dei primi e c’erano una ventina di muli legati alla ringhiera, che c’era un burrone nel mare, e lì ero stanco e ho visto sparare, ho visto un disastro… Sono caduto per terra, non so se siano stati i muli che mi hanno buttato per terra o cosa, mi sono trovato per terra perché i primi otto muli li avevano ammazzati, sventrati diciamo.
… Un duecento morti c’erano, lì abbiamo presi e messi sul marciapiede di qua e di là… Questo fatto è successo tra il porto e la città di Ragusa.
… Siam partiti di lì 7 ottobre da Ragusa, ci hanno portati su treni sco perti perché i partigiani volevano vedere i treni scoperti, perché quelli col materiale li facevano saltare, finché siamo arrivati in Austria, siamo passati per l’Ungheria il giorno 13 ottobre che era il mio compleanno; alla sera erava mo in un campo di concentramento… Lì ho dormito una notte… Al mattino è capitato un tavolino con un ufficiale tedesco e un interprete, ci volevano trenta persone per andare a lavorare, i primi trenta sono capitato anch’io e siamo andati a lavorare nei boschi a 24 chilometri sud ovest di vienna, facevamo i boscaioli, a tagliare le piante.
Non avevamo guardie ma avevamo civili, armati, militarizzati, a con trollarci. Non si poteva scappare. Un anno ho fatto questo lavoro; poi ci hanno tirato fuori in dieci a costruire le scuole per forestali… Il primo anno la fame era forte. Quando eravamo quei dieci ci hanno portato in Comune, ci hanno fotografato, ci hanno dato i documenti da civile… Non avevamo neanche la guardia.. Fino a che sono capitati i russi. Tre giorni prima che capitassero i russi ci hanno detto «Arrangiatevi». Allora un civile ci ha portato a casa sua , dice «invece che stare qua è meglio andare nel bosco», perché i russi – dice – non vengono nei boschi… Siamo andati nel bosco, abbiamo fatto la nostra capanna… La notte del 10 o 11 aprile un acquazzone che non finiva più, e lì abbiamo dovuto tornare nelle case, tornati nelle case alla sera siamo andati in un rifugio… La mattina una gran sparatoria e allora ci siamo nascosti sotto le panchine, che c’erano le donne e i bambini, perché gli uomini non c’erano. È venuto dentro uno delle SS e ha detto “italiani fuori” e ci ha messi al muro. Allora un civile, un contadino insomma che aveva una decina di mucche, ha visto questo, è venuto fuori, ha preso una mitragliatrice e dice «Prima di que sti italiani me e tutta la famiglia».
Poi sono arrivati i russi, ci hanno trattato bene: sono rimasto sei mesi con loro.
133
3.11 Alfredo Conci
Alfredo Conci è nato l’8 marzo 1923 a Roncegno (Trento), arrivato a Bolzano nel dopoguerra, esattamente nel 1954.
Mio papà era lattoniere, vetraio e io ho imparato da lui, io ho fatto l’apprendi sta, andavo a scuola apprendisti a Borgo Valsugana.
Dunque noi realmente vivi siamo in tre fratelli, però eravamo in dieci. I primi due, Luigi e Tullio, sono morti a Mitterndorf durante la prima guerra mondiale come profughi, erano là con la mamma e le nonne. Uno è morto di varicella, Tullio è morto della polmonite doppia, mi sembra. Erano in baracche che non c’era riscaldamento, facevano continuamente cambiare da una all’altra baracca, i bambini avevano un anno e tre anni mi sembra, insomma son restati fuori…
Il papà era stato nella sanità con gli austriaci durante la Grande Guerra, aveva una macchina a vapore che distillava l’acqua potabile. Era in Galizia a Leopoli, lui è tornato nel 1918. Mia mamma e mia nonna hanno fatto un po’ di penitenza fuori, fame e tutto quello che c’era insomma. Come sono arrivato a Bolzano? Nel 1954 dico a mio fratello «andiamo a Bolzano a vedere il giro d’Italia». C’era Coppi ancora. Dico «dato che andiamo su andiamo a vedere», perché avevo trovato sul giornale un’inserzione che cercavano un saldatore un meccanico per impresa edile e dico «andiamo a vedere, curiosare». Son venuto su e non mi han lasciato più andare via, sono venuto a Bolzano. E ho fatto quel lavoro lì, ho cominciato prima come meccanico saldatore poi sono migliorato fino a che sono diventato dirigente, ho fatto 47 anni in questa azienda…
La cartolina per il servizio militare l’ho avuta il 17 aprile del 1943 Mi hanno chiamato nell’aeronautica. È stata una peripezia! Mi hanno vestito qua alla casermetta dell’aeroporto di Bolzano. Sono arrivato su con mio papà e la mattina, verso le 10, abbiamo preso il tram. Siamo venuti su col treno e poi col tram siamo venuti giù a san Giacomo verso Laives. Sono arrivato e ormai li avevano già vestiti, erano tutti pronti… Sono arrivato in ritardo; mi hanno vestito e compagnia bella. Poi la sera verso le 21,30 dovevamo prendere il treno per andare a Gorizia.
Un sergente dice «come faccio io con te, ormai non ti posso mettere dentro nella tradotta. Fai una cosa: io ti lascio libero, se vuoi vestiti in bor ghese, se vuoi resta in divisa». E allora sono uscito con il drappello vestito e i vestiti miei li ho lasciati alla casermetta là a San Giacomo. Poi siamo andati al treno, abbiamo preso la tradotta e siamo andati verso Gorizia e siamo arrivati a Trento. Quando siamo arrivati a Trento io dico «scendo e vado in Valsugana a casa», perché il sergente mi aveva detto che potevo presentarmi lunedì, quel giorno era sabato. E allora giù dalla tradotta a Trento, c’era il controllo milita re, ho attraversato i binari sono andato fuori dalla parte opposta alla stazione, poi ho preso Piazza Venezia, cosa fare? Aspettare cosa? Avevo un vestito da
134
naja, scarpe nuove, ho iniziato a camminare a piedi, dico vado avanti, for se… insomma alle cinque di mattina sono arrivato a Roncengno, cinque ore ho camminato. Ho dovuto levare le calze, le scarpe, poi dopo la mattina, sai com’è in paese, fai il bullo, mi sono vestito da naja e sono… Ho raccontato quello che è successo. Intanto che sono là al bar arriva il maresciallo dei ca rabinieri mi vede, mi conosce, dice «Come mai qua. Sei in permesso? Come mai non ti sei presentato ieri?». «Come non mi sono presentato !?!» e allora ho raccontato. «Ma sei pazzo» ha detto «ma sai che dovrei metterti in prigione». Son dovuto scappare a casa, poi mi sono presentato il lunedì, il lunedì non è successo niente…
Ero al centro di istruzione di San Pietro di Gorizia. Era una zona mili tare, quando si andava fuori la sera bisognava andare in cinque/sei, c’erano gli sloveni, i partigiani. Dopo da là ci hanno aggregati al distaccamento di fanteria a Vicenza, alla caserma Ederle. E allora hanno fatto la divisione antiparacadutisti dell’Aeronautica. E il giorno prima dell’8 settembre ci hanno imbarcati su una tradotta e si doveva andare a Pisa, qui prendere l’aereo e andare in Sicilia, nella piana di Catania, per contrastare gli americani. Per fortuna che non siamo andati perché ci han rimesso la pelle tutti quando sono arrivati gli americani…
… Poi siamo arrivati fino a Campo di Marte, a Padova, e là fermi, non si partiva più… Era l’8 settembre. È arrivato, lo ricordo ancora, il nostro sottotenente e ha detto «ragazzi la storia si mette male, io vi saluto», tutti gli ufficiali se la sono svignata e là da soli non si sapeva cosa fare… C’è stato un allarme aereo, siamo andati via dalla ferrovia, siamo andati in campagna, poi siamo ritornati… Poi la notte ci hanno riportati di nuovo a Vicenza e da Vicenza siamo entrati in caserma poi una volta di nuovo fuori al treno e ci hanno portati a Valdagno, sempre di notte, siamo arrivati a Vadagno circa la mattina alle sette, ci hanno portato in una palestra. Saranno state cinque sei ore che eravamo dentro, poi tutto di colpo un trambusto, hanno iniziato a sparare e sono arrivati dei carri armati che venivano dalla parte di Asiago verso Vicenza e si vede che sapevano già tutto o che c’erano gli informatori ci hanno beccato dentro in palestra… Ci hanno fatto uscire a ‘gattoni’, sparavano ad altezza d’uomo per farci paura… Poi ci hanno caricati su camion e ci hanno portati a San Pietro di Mantova e siamo andati dentro un distaccamento dell’artiglieria di Mantova, era tutto recintato con i muraglioni alti… Dai camion avevamo buttato tanti biglietti per dire «guarda che son passato», per avvisare a casa. Dopo mio papà è venuto a Mantova, ma ormai era troppo tardi. A Mantova abbiamo fatto una settimana di fame, avevamo costruito le tende, e poi dopo tre quattro giorni hanno comin ciato a darci da mangiare… Si faceva la fila la mattina per ricevere il rancio: pagnotta e poi minestra, te la davano alle sei le sette di sera, c’era un sole, caldo, zanzare, una roba pazzesca. Le latrine avevamo fatto un buco con un palo di traverso. Là ci han fatto fare una settimana di penitenza. Mitragliatrici in cima ai muri, tutte SS, poi ci hanno imbarcati. Abbiamo fatto tre chilometri da Mantova siamo andati in stazione a piedi, tradotta, e poi in Germania.
135
C’è voluta una settimana di treno per arrivare in Germania. Io sono stato fortunato perché fra i miei compagni avevo un amico di Bronzolo e quando siamo arrivati a Bronzolo c’erano le donne e lui ha iniziato a gridare per tedesco, allora sono venute le donne… È successo che il papà era un ca poccia dei frutticoltori di Bronzolo. È andato di corsa al comando militare e gli ha spiagato la storia, no? Il treno è stato fermo tre-quattro ore, fattostà che l’hanno fatto venire giù… E sua sorella ha portato per lui zaini pieni di cose da mangiare, mele, pane, vino e dopo Carlo [è il nome dell’amico di Bronzolo] mi ha salutato e mi ha detto «tieniti il mangiare, ciao, ci vediamo»… Sai che poi ho fatto una brutta figura che non sono mai andato a trovarlo?
Poi siamo partiti per la Germania, mi ricordo che ci siamo fermati a Norimberga, in un grande scalo merci, dopo quattro giorni siamo usciti per andare in gabinetto, il gabinetto si faceva dentro un berretto, un cappello, dopo si buttava fuori dal vagone.
Una notte il treno si ferma, in mezzo ai boschi. Madonna che freddo, ci hanno aperti i portelli e ci facevano scendere 5-6 alla volta, dovevi fare delle scalette di legno fatte sul terreno e in fondo c’era una baracca, veniva fuori proprio il vapore dal freddo come d’inverno… Avevo la coperta addosso e là ci han dato la prima volta patate, una zuppa di rape e lì siamo stati fermi tre quattro ore, poi il treno riparte e siamo arrivati vicino a Danzica, ad Ham merstein64, dove c’erano i primi campi che abbiamo visto inglesi, americani, polacchi, russi… Siamo arrivati alla sera, piovigginava, ci hanno messo in un recinto tutta la notte, bagnati e fradici… Il mattino dopo sono venuti e ci hanno aperto tutti gli zaini, ci hanno portato via tutto… Io avevo le scarpe nuove, avevo le vecchie nello zaino, mi hanno fatto togliere quelle nuove e mi hanno lasciato quelle vecchie…
… Ci hanno portato via tutto ci hanno lasciato quel po’ di vestiario, calzetti una maglia, io avevo la divisa d’ordinanza poi avevo quella di fatica, ci hanno portati in un locale, c’erano delle grate, pensi male, cominci a dire qua… ci hanno fatto spogliare nudi, e dopo aprono le porte, le doccie… Fatte le doccie siamo ritornati dove eravamo prima, veniva dentro l’aria calda per asciugarci, poi ci hanno fatto uscire da là e ci hanno portato nelle baracche di legno, soliti tavolacci a due tre piani…
Appena siamo arrivati, il giorno dopo, alla parte opposta da noi c’era altre baracche con la bandiera tricolore… Perché ci han detto «volete andare in Italia? Allora dovete votare per la Repubblica di Salò»… dei nostri almeno non è andato via neanche uno…
Ad un certo punto dei funzionari vennero a cercare tra gli internati chi voleva andare a lavorare. Io finii a pochi chilometri da Stettino, a lavorare per la Mercedes. Cercavano tubisti e saldatori per impianti di riscaldamento, allora ci hanno scelti, ci hanno messo alla prova, non volevano mica prendere
64 Era lo Stalag II B 313 di Hammerstein/Schlochau, oggi in Polonia. Vi erano 99 campi di lavoro che dipendevano da esso. Lo Stalag di Hammerstein venne smobilitato nel gennaio del 1945.
136
degli sprovveduti. Anche nella fabbrica c’erano i lager, c’erano gli italiani, i francesi, i russi, i polacchi… Saranno stati là 2.000 persone. Il mangiare era pessimo: una volta al giorno ci davano un litro, neanche sempre, di zuppa di rape, patate non ne vedevi mai neanche. Poi una volta alla settimana dopo 3-4 mesi ci portavano al magazzino viveri e ci davano un pezzettino di pane bianco, un tanto così di burro… poi davano 2 sigarette al giorno, insomma qualcosa prendevi.
Il lavoro invece era abbastanza buono, non mi posso lamentare… Poi ero volenteroso e capace, dopo 5-6 mesi mi hanno fatto una squadra di 4 per sone, ero il capo squadra, si facevano gli impianti delle baracche. Poi a volte restavo dentro in fabbrica e dove facevano i reparti nuovi preparavo tutti gli impianti per l’aria, per il vapore, tutti lavori di idraulica… Avevamo l’inter prete da campo e poi un interprete in fabbrica; interprete da campo era un im piegato qua del Comune di Bolzano, de Robertis, e invece quello di fabbrica quello è morto due anni fa, una brava persona anche quello.
Alfredo rimase nella stessa fabbrica a lavorare fino alla fine della guerra.
137
3.12 Alcuni documenti di Mario Michielli
In questo caso ho pensato di fare cosa utile riproducendo alcuni documenti messi gentilmente a disposizione presso il Circolo Culturale ANPI di Bolzano dai famigliari di un ex-Internato di Bolzano, Mario Michielli.

Questa è la cartolina (con la dicitura Kriegsgefangenenpost, posta per prigionieri di guerra) che veniva data agli internati in un campo di transito o di smistamento. Il testo è in francese e contiente un comunicato standard per tutte le famiglie: “Io sono prigioniero di guerra in Germania in buona salute. Noi saremo trasportati da qui in un altro campo nel giro di qualche giorno. Non scrivetemi fino a quando non otterrete il mio nuovo indirizzo”.

138
Ecco la piastrina di riconoscimento che veniva data in dotazione agli Internati. Quel la qui riprodotta apparteneva al sottotenente Mario Michielli, nato a Trieste il 15 febbraio 1920, residente a Bolzano. Fu internato a Sta blach e in seguito a Münster. Fece ritorno a Bolzano nell’agosto 1945: Quella che segue è invece una riprodu zione della cartolina utilizzata dagli internati per comunicare con le proprie famiglie:



139
Il permesso rilasciato dal co mandante del Lager di Bocholt a Michielli in qualità di inter prete degli ufficiali italiani in ternati nello Stammlager VI F:
Molto interessante è poi questa scheda: Riproduce il documento, scheda di rimpatrio o foglio di via, rilasciato dal CAR di Bolzano agli internati.
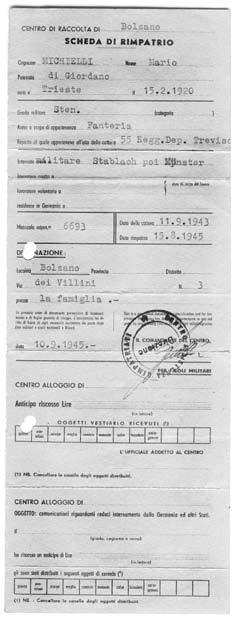

140
Appendice
Memoria e storia sono interdipendenti; nondimeno, non sono identiche. A me sembra che la storia debba essere riflessiva e inevitabilmente discordante e a più voci. Non sto sostenendo che la storia arriva necessariamente ad una conclusione più scienti fica delle memoria... Ma gli storici devono almeno presupporre differenti situazioni di vita; essi ritengono che individui e gruppi portino limitate prospettive in ogni conflitto e, inoltre, devono ri costruire le sequenze causali; raccontano storie del prima e del poi e spiegano gli eventi con i loro antecedenti. 65
Premessa
Sull’eccidio di Cefalonia, uno dei più incredibili crimini di guerra commessi dai soldati tedeschi66 nel corso del secondo conflitto, molto si è scritto e molto si è detto. Rispetto ad altri episodi di resistenza nel contesto bellico grecobalcanico, infatti, Cefalonia ha usufruito di un ricordo privilegiato. 67
Da una tale mole di scritti non è possibile ricavare però un’immagine unilaterale, a tinta unita, bensì poliedrica, multicolore e sfumata in alcuni contorni.
Attorno ad una storiografia accademica sostanzialmente concorde, esi ste infatti un universo (in formato cartaceo e digitale online) di discussioni, dibattiti e pubblicazioni eterodosse ed eterogenee sia nei toni sia nei punti di vista espressi. Si tratta per lo più di testimonianze di superstiti o di ricostru zioni dei parenti di chi, da Cefalonia, non è più tornato.
Per quanto riguarda le prime, è comprensibile che ciascuno racconti la propria esperienza sulla base di personali prospettive sul passato (ma an che sul presente), e di una memoria che nel corso degli anni ha elaborato e ri-elaborato continuamente il ricordo di eventi o dei loro particolari, sino a deformarli involontariamente.
65 C. Maier, Un eccesso di memoria? Riflessioni sulla storia, la malinconia e la negazione, in «Parolechia ve», 9/1995, p. 36.
66 G. Schreiber, I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich 1943-1945, Roma, Ufficio Storico SME, 1997, p. 205.
67 G. Rochat, Ancora su Cefalonia, settembre 1943, in «Studi e ricerche di storia contemporanea», giugno 2005, p. 2.
141
Cefalonia, settembre 1943. Dinamica di un crimine di guerra, di Nicola Spagnolli
Nelle ricostruzioni e ricerche realizzate dai parenti, invece, informazio ni e precisazioni di merito si mescolano spesso con il risentimento personale e con la rivendicazione di una verità che renda giustizia alla memoria del proprio congiunto tragicamente scomparso.68
Tale contesa tra memorie diverse non è nuova nel contesto della storia della seconda guerra mondiale, soprattutto quando si ha a che fare con le rappresaglie naziste.69
Chi scrive non intende, data la natura del presente contributo, ma so prattutto non può, vista la contingente impossibilità di accedere alla docu mentazione ufficiale, aggiungere nulla di nuovo alle ricostruzioni già edite della strage.
In questa sede si è tentato di fare una narrazione il più possibile equili brata, dovendo sorvolare, per necessità di sintesi, su alcuni momenti nei quali qualcosa sembrava non tornare. Va detto che in eventi come questi, è difficile che dalla consultazione delle memorie e testimonianze si possa ricavare una ricostruzione univoca, a meno che non si parta con una tesi ben precisa e, di conseguenza, si pieghino gli eventi e si eliminino le contraddizioni a favore di un teorema. L’obiettivo, ben più modesto ma non meno importante, sarà dunque raccontare, raccogliendo i diversi contributi pubblicati sull’argomen to, quanto è accaduto ad un lettore che ancora non conosca i fatti di Cefalonia, avvalendosi anche del contributo di un testimone che ha avuto la fortuna di sopravvivere a quell’esperienza e di ritornare successivamente all’isola ionica con animo sereno.
A lui è dedicato questo scritto.
Il quadro generale
L’aggressione italiana alla Grecia ebbe inizio il 28 ottobre del 1940 e, grazie soprattutto all’aiuto delle forze tedesche, ebbe esito vittorioso nell’apri le del 1941. Ad Atene venne imposto dai tedeschi un governo fantoccio guidato dal generale Georgios Tsolakoglu, mentre il controllo del paese fu affidato alla IX armata del Regio Esercito comandata dal generale Carlo Geloso.70
In Grecia era inoltre stanziata l’XI armata comandata, dal maggio del ’43, dal generale Carlo Vecchiarelli. Con la caduta di Mussolini e l’assunzione dei poteri da parte di Pietro Badoglio (luglio del ’43), essa venne trasformata in un’armata mista italo-tedesca con comando italiano ma con uno stato mag giore operativo tedesco affiancato a quello del suo alleato.
Alle dipendenze di Vecchiarelli, il cui comando aveva sede ad Atene, c’erano tre corpi d’armata italiani e uno tedesco.
68 G. E. Rusconi, Cefalonia. Quando gli italiani si battono, Torino, Einaudi, 2004, p. 108.
69 A proposito si veda Paolo Pezzino, Anatomia di un massacro, Bologna, Il Mulino, 1997; Giovanni Con tini, La memoria divisa, Milano, Rizzoli, 1997.
70 G. Oliva, Si ammazza troppo poco. I crimini di guerra italiani 1940-1943, Milano, Mondadori, 2006. Va precisato che all’interno del territorio assegnato all’Italia, l’esercito tedesco manteneva varie zone d’occu pazione diretta (campi di aviazione di Larissa e Araxos, le coste dell’Attica, isole di Salamina ed Egina, la parte occidentale di Creta), nonché le aree della penisola Calcidica, Salonicco compresa.
142
Il XXVI Corpo d’Armata, era dislocato nell’Epiro e comandato del ge nerale Guido della Bona il quale aveva la propria sede a Ioannina71 .
L’VIII Corpo d’Armata, dove era inquadrata la Divisione di Fanteria «Acqui», rispondeva agli ordini del generale Mario Marghinotti, il quale ave va la sede del comando ad Agrinion, mentre le truppe era sistemate nell’Arca nania, nell’Etolia, nell’Isola di Cefalonia e Santa Maura.
Il III Corpo d’Armata del generale Luigi Manzi, dislocato in Tessaglia, nell’Attica e nell’isola di Eubea, aveva il proprio quartier generale a Tebe. Infine, per quanto riguarda le forze tedesche, il LXVIII Corpo d’Armata del generale Helmuth Felmy era dislocato nel Peloponneso e inquadrava le Divisioni di fanteria italiane «Piemonte» e «Cagliari». La sede di comando era a Vitina.
In Grecia vi era dunque una notevole integrazione tra unità tedesche e italiane.
Nell’agosto del ’43, l’XI Armata venne collocata alle dipendenze ope rative del gruppo di Armate E del generale Alexander Löhr, il cui comando aveva sede a Salonicco. Al settembre dello stesso anno, le forze tedesche nei Balcani e in Grecia ammontavano a 311.000 uomini, mentre quelle italiane a circa 650.000, di cui 172.000 nella sola Grecia.
Le isole Ioniche, Corfù, S. Maura, Itaca, Cefalonia e Zacinto, furono sottoposte ad un governatorato civile affidato al gerarca Piero Parini.72
Queste isole avevano rivestito nella “guerra parallela” di Mussolini un’importanza sia politica sia militare poiché erano il primo obiettivo dei progetti fascisti di dominio sulla Grecia, sia per la loro posizione geografica che per il loro passato veneziano (dal 1204 al 1797 avevano fatto parte della repubblica di Venezia).
La rilevanza militare di queste isole cambiò con l’evoluzione dei rappor ti di forza nel Mediterraneo. Nel ’41-’42, infatti, la loro occupazione non aveva importanza strategica, salvo che per la protezione dei convogli che dall’Italia raggiungevano la Grecia e poi, in parte, la Libia.
Alla fine del ’42, quando il Mediterraneo divenne il principale teatro dell’offensiva angloamericana in Europa, Cefalonia e Zacinto acquistarono per i comandi italiani una doppia rilevanza. Presidiare in maniera efficace queste isole, in primo luogo, serviva ad impedire o rendere difficile una pene trazione nemica nel golfo di Patrasso; secondariamente si doveva evitare che gli angloamericani le occupassero come base per un successivo sbarco nella penisola balcanica. Evento poco probabile visto che le isole erano sprovviste di campi d’aviazione e piste d’atterraggio.73
71 Qui era inquadrato il 18° reggimento di fanteria «Acqui» e parti del 33° reggimento artiglieria della medesima divisione.
72 G. Rochat, La divisione «Acqui» nella guerra 1940-1943, in G. Rochat, M. Venturi (a cura di), La divi sione Acqui a Cefalonia. Settembre 1943, Milano, Mursia, 1993.
73 Idem.
143
L’8 settembre in Grecia Ricostruiamo per sommi capi gli eventi che in Grecia seguirono alla firma dell’armistizio.
Alle 19.45 dell’8 settembre Pietro Badoglio, capo del governo, lesse agli italiani il comunicato ufficiale dell’avvenuta firma dell’armistizio con le forze alleate:
Il governo italiano, riconosciuta l’impossibilità di continuare l’impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ul teriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate angloamericane.
La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi di qualsiasi provenienza. 74
Il comando dell’XI armata, il 7 settembre, aveva già ricevuto dal Comando Supremo italiano delle indicazioni di massima, molto più precise però del sibillino messaggio di Badoglio, su come comportarsi con i tedeschi. Il Pro memoria n. 2, emanato il 6 settembre dal suddetto comando, iniziava con una premessa generale:
Particolari condizioni di ordine generale possono imporre di deporre le armi indipendentemente dai tedeschi. L’esperienza recente insegna che questi re agiranno violentemente. Non è neppure escluso che possano commettere atti di violenza, indipendentemente dalla dichiarazione di armistizio, per rove sciare il Governo o altro.75
Seguivano poi i compiti particolari a seconda delle forze armate e della loro collocazione sul fronte greco e balcanico. Per la Grecia si comunicava che:
È lasciata libertà al Comando di Armata... di assumere l’atteggiamento gene rale in confronto dei germanici che sarà ritenuto più opportuno... Dire franca mente ai tedeschi che se non faranno atti di violenza armata le truppe italiane non prenderanno le armi contro di loro, non faranno causa comune né con i ribelli né con le truppe angloamericane, che eventualmente sbarcassero.
Le posizioni di difesa costiera in consegna alle truppe italiane saranno mantenute e difese per un breve periodo di tempo... fino alla sostituzione con truppe germaniche, e questo eventualmente anche in deroga agli ordini del Governo Centrale, sempre quando, naturalmente, da parte tedesca, non vi
74 Il testo del messaggio radiofonico è reperibile sul sito dell’ANPI all’indirizzo www.anpi.it/ militari/8settembre.htm.
75 Promemoria n. 2 del Comando Supremo italiano, riportato in E. Aga Rossi, Una nazione allo sbando. L’armistizio italiano del settembre 1943 e le sue conseguenze, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 216.
144
siano atti di forza. Riunire al più presto le forze preferibilmente sulle coste in prossimità dei porti.76
Le forze aeree e della Marina, inoltre, avrebbero dovuto raggiungere imme diatamente l’Italia. All’Aviazione venne dato ordine di distruggere il materia le e gli impianti a terra, alla Marina di autoaffondare le unità che fossero in procinto di cadere in mano germanica. Qualsiasi Forza Armata doveva reagi re immediatamente ed energicamente senza speciale ordine ad ogni violenza armata germanica e delle popolazioni in modo da evitare di essere disarmati o sopraffatti. 77
Il generale Vecchiarelli, la notte dell’8 settembre, inviò un telegramma a tutti i comandi a lui sottoposti con direttive molto precise che ricalcavano il promemoria sopraccitato: se i tedeschi non faranno atti di violenza, non ri volgere le armi contro di loro; le truppe italiane non faranno causa comune né con i ribelli né con le truppe angloamericane eventualmente sbarcate; reagire con forza ad ogni violenza armata; rimanere ai propri posti e con gli attuali compiti.78
Nella notte tra l’8 e il 9 settembre, Vecchiarelli ricevette il generale Lanz del XXII Corpo d’Armata di montagna (Gebirgskorp) per aprire un tavolo di trattative, le quali approdarono ad un accordo di massima, secondo il quale per almeno due settimane i soldati italiani avrebbero continuato a presidiare le opere di difesa costiera per poi mettersi in marcia per l’Italia, portando al seguito solo le armi necessarie per la difesa personale.79 Vecchiarelli non era disposto, in nome dell’onore militare, a procedere al completo disarmo della sua armata. La linea morbida di Lanz era invece in contrasto con quella dei suoi superiori che premevano per il disarmo dell’XI Armata. Conseguentemente, il generale Löhr comunicò a Lanz che gli accor di presi con Vecchiarelli non erano da ritenersi validi e che si doveva procedere al disarmo senza condizioni.
Lanz incontrò di nuovo Vecchiarelli per comunicare che il 9 settembre avrebbe avuto inizio il disarmo dell’esercito italiano. I due si accordarono come segue:
Le truppe italiane il 9.9 consegnano tutte le armi pesanti e automatiche. Pistole, fucili e baionette restano nelle mani dei soldati italiani. I tedeschi opereranno arresti solo se sarà necessario l’uso della forza. Gli ufficiali con servano le proprie armi. 80
76 Idem, p. 217.
77 Idem, pp. 217-218.
78 Si fa qui riferimento all’ordine n. 02/25006, riportato in M. Montanari, Cefalonia settembre 1943: La documentazione italiana, in G. Rochat, M. Venturi, op. cit., p. 97.
79 G. Schreiber, op. cit., 1997, p. 195; G. Lombardi, L’8 settembre fuori d’Italia, Milano, Mursia, 1966, p. 95.
80 G. Schreiber, op. cit., 1997, p. 196.
145
A convincere ulteriormente il comandante italiano alla resa contribuì un telescritto inviatogli dal generale Vittorio Ambrosio, capo del Comando Supremo, alle ore 0.20 del 9 settembre, dove si ribadiva che non doveva esse re presa alcuna iniziativa ostile nei confronti dei tedeschi, ma che si doveva reagire ad ogni violenza volta al disarmo e alla sopraffazione delle forze ita liane.81
Alle 11.45 del 9 settembre, Vecchiarelli emanò un secondo ordine, il n. 02/25026, nel quale invitava i comandanti a cedere le armi ai tedeschi, salvo quelle personali.82 I presidi costieri dovevano rimanere nelle loro posizioni sino al cambio con i reparti tedeschi. Le truppe italiane non dovevano opporre resistenza ad eventuali azioni di truppe angloamericane, ma dovevano reagire invece ad eventuali azioni di forze ribelli. Le truppe sarebbero rientrate in Italia al più presto, lasciando ai subentranti reparti tedeschi le armi collettive e le artiglierie, mentre quelle individuali sarebbero rimaste in possesso degli italiani per permettere loro di difendersi dagli attacchi dei ribelli.83
È un messaggio difforme, per non dire opposto, da quello emanato il giorno precedente. Nel primo, infatti, si ordinava di rimanere ai propri posti, mentre nel secondo si stabilivano le modalità di avvicendamento con i tede schi.
Alle ore 12.00 del 9 settembre, ebbe inizio il disarmo nella zona di Ate ne che non incontrò difficoltà. Costatato però che alcuni soldati italiani vendevano le armi ai greci, il Gruppo d’Armata germanico pretese la consegna delle armi individuali ad eccezioni di quelle in possesso degli ufficiali. La Wehrmacht avrebbe protetto gli italiani durante il loro rientro. Il generale d’armata italiano, messo di fronte al fatto compiuto, non poté fare altro che prenderne atto.
Vecchiarelli, molto probabilmente, decise questa linea in seguito alla pressione dei tedeschi, i quali avevano ricevuto ordini precisi di promettere agli italiani il rimpatrio immediato qualora questi avessero ceduto le armi. Tale atteggiamento è stato duramente criticato, giudicato eccessivamente re missivo o addirittura collaborazionista da parte di alcuni studiosi.84
Più comprensivo ed equilibrato il giudizio che ne dà Schreiber:
È molto probabile che le ripetute concessioni fatte dal generale Vecchiarelli siano da attribuire fondamentalmente alla convinzione che le truppe dell’11 Armata, una volta cedute le armi, sarebbero state rimpatriate. Un’aspet tativa che scaturiva dalle assicurazioni avute da parte tedesca, anche se resta difficile comprendere tanta ingenuità. Nel credere alla parola data dai
81 Ordine 24202/OP, riportato in E. Aga Rossi, op. cit., pp. 219-220.
82 Il testo completo è riportato in M. Montanari, op. cit., p. 99.
83 Ibidem.
84 Si veda G. Lombardi, op. cit., pp. 95-101; L. Viazzi, La sorte delle unità italiane in Grecia ed Albania dopo l’8 settembre 1943, in G. Rochat, M. Venturi, op. cit., p. 231; G. E. Rusconi, op. cit., pp. 10-12.
146
generali tedeschi, Vecchiarelli sarebbe in fondo stato vittima del suo senso dell’onore.85
I tedeschi, infatti, sin dal 25 luglio si erano preparati all’uscita dell’Italia dalla guerra elaborando piani per l’invasione della penisola e per il disarmo del Regio Esercito, operazione quest’ultima che venne elaborata nel piano «Achse», la cui prima disposizione prese vita nei giorni successivi alla caduta di Mussolini.
Il 10 settembre il generale Löhr ordinò al XXII Corpo d’Armata di mon tagna del generale Lanz, il cui comando aveva sede a Ioannina nell’Epiro, di procedere al disarmo totale delle truppe italiane. Il XXII Corpo d’armata concluse le operazioni di disarmo delle unità italiane dell’VIII e XXVI Corpo d’Armata, che si trovavano sul territorio continentale greco, il 13 settembre.
I comandanti italiani, infatti, decisero in larga maggioranza di eseguire l’ordine di Vecchiarelli, ad eccezione delle divisioni «Pinerolo», in Tessaglia, e «Acqui», nelle isole Ioniche.86
Intere divisioni come la «Forlì» in Attica, la «Modena» nell’Epiro, la «Piemonte» e la «Cagliari» nel Peloponneso, si consegnarono ai tedeschi e vennero deportate in Germania. Cadevano in mano ai tedeschi gli aeroporti di Prevesa, Patrasso e Agrignion.87
La topografia dei Balcani non aveva inizialmente offerto alcun vantaggio all’aggressore tedesco e la situazione interna delle diverse regioni aveva comportato numerosi rischi.
Nonostante queste difficoltà, però, le forze della Wehrmacht, approfit tando della mancanza di coordinamento dell’ex alleato, della sua ingenuità, e avendo dalla propria parte migliore organizzazione, determinazione, capacità di condurre l’inganno ai danni delle truppe italiane, promettendo loro il rim patrio e caricandoli invece su treni in partenza per i campi di internamento, riuscirono a condurre con successo l’operazione «Achse».
Soldati ingannati, disarmati, trattati come traditori, catturati quando non massacrati, internati e privati della tutela delle Convenzioni di Ginevra, sono “soltanto” alcuni dei capitoli della tragedia italiana iniziata l’8 settembre.
Una tragedia che ha radici nella scelta di Mussolini di trascinare il Paese nella guerra ma che vede come responsabili diretti Badoglio e il re Vittorio Emanuele III poiché questi, come scrive Aga Rossi:
...si dimostrarono del tutto incapaci di affrontare la situazione, trascinando l’Italia con la loro inazione nel più grave disastro militare della sua storia. Preoccupati del loro destino personale, più che di quello del paese, misero in
85 G. Schreiber, op. cit., 1997, p. 198.
86 Per un approfondimento delle tragiche vicende della divisione «Pinerolo», si veda L. Viazzi, op .cit., pp. 233-239.
87 Idem.
147
secondo piano l’esigenza di prendere le misure necessarie per essere prepa rati al momento dell’annuncio dell’armistizio, si preoccuparono soltanto di mantenere il segreto per non dare ai tedeschi l’occasione di un colpo di stato. Così il re e Badoglio non impartirono alcuna direttiva al Comando Supremo e allo Stato maggiore dell’Esercito per «orientare» i vari comandi sull’even tualità di un armistizio con gli angloamericani, nel timore che i tedeschi ne potessero venire a conoscenza. 88
La divisione Acqui
La XXXIII Divisione di fanteria da montagna «Acqui» era stata costituita il 15 dicembre 1938 a Merano89, riprendendo il nome della brigata istituita nel 1821 dall’allora esercito piemontese e che, dopo un primo scioglimento dal 1871 al 1881, era stata nuovamente smembrata nel 1926 dopo aver combattuto la prima guerra mondiale. Nel settembre del 1939, allo scoppio del conflitto, la Acqui, non ancora completa, fu spostata sulla frontiera francese, in Valle Stura.90 Successivamente, dopo aver passato l’inverno nella zona di Alba, all’ini zio del giugno del 1940 tornò in Valle Stura per bloccare eventuali attacchi francesi.
A quella data la divisione era ormai completa, dotata di comando di divisione e dei seguenti reparti:
17° reggimento fanteria su tre battaglioni, una compagnia di mortai, una batteria da accompagnamento
18° reggimento fanteria con la stessa composizione della 17°
23° Camicie Nere su due battaglioni91
33° reggimento artiglieria
33° battaglione mortai
33° compagnia anticarro
88 E. Aga Rossi, op. cit., pp. 80-81.
89 La data riportata da Rochat, op. cit., 1993, concorda con quanto riportato da R. Formato in L’eccidio di Cefalonia, Milano, Mursia, 1968, pp. 282-283. Sul sito internet dell’esercito italiano la ricostituzione viene datata all’agosto del ’39 (www.esercito.difesa.it/root/unita_sez/unita_div_acqui_sto.asp), mentre il sito dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui riporta la data settembre 1939 (www.associazioneacqui. it/pagine/bandiera.html).
90 Per questo motivo risultano errate le date di costituzione della Divisione riportate nella nota precedente.
91 Da qui in avanti abbreviate con CC.NN.
148
due compagnie del genio (artieri, telefonisti e radiotelegrafisti, fotoelettri cisti)
servizi: sezione sanità, sezione sussistenza, reparto salmerie, autoreparto e due sezioni carabinieri.92
La Acqui era composta essenzialmente da contadini, cosa comprensibile vi sto che l’Italia era allora un paese largamente agricolo.93
A novembre la divisione, rientrata nella sua sede di pace a Merano, ven ne raggiunta dall’ordine di partire per l’Albania, dove arrivò nella seconda metà di dicembre del ’40.
Tra il 1940 e il 1943 la divisione venne riorganizzata e al comando del la divisione si alternarono diversi generali: Adamo Mariotti (’40-’41), Lui gi Mazzini (’41-’42), Ernesto Chiminello (’42- giugno ’43) e, infine, Antonio Gandin (giugno ’43-settembre ’43).
Lungo la linea del fronte greco-albanese, la divisione venne impegnata in una lunga serie di azioni difensive e controffensive fino a quando la pressione greca non cedette e il paese aggredito fu costretto alla resa.94
Il 29 aprile del ’41, il comando di Divisione sbarcò a Corfù per assumere successivamente la responsabilità delle isole Ioniche. Al 1 giugno del ’41 la Divisione, dislocata a Santa Maura, Cefalonia, Itaca e Zacinto, aveva la sede del comando, la 17° fanteria e la 18° legione CC.NN. d’assalto a Corfù, il 18° fanteria sulla costa greca, gli altri reparti divisi tra Corfù e la costa, mentre il raggruppamento CC.NN. da sbarco presidiava l’isola di S. Maura, Cefalonia, Itaca e Zacinto.95
Dopo il consolidamento dell’occupazione delle isole Ioniche nel ’42, nel settembre del ’43 si accentuò il rafforzamento delle difesa di Cefalonia, dove erano già presenti il III battaglione del 17° reggimento, il II gruppo del 33° reggimento artiglieria, un battaglione mitragliatrici e altri reparti per la dife sa antiarea. Un rafforzamento dovuto al mutamento del quadro della guerra nel Mediterraneo, quando le forze angloamericane, nell’autunno del ’42, au mentarono il peso della loro presenza aeronavale. Il generale Carlo Geloso, erroneamente, interpretò questa presenza come la volontà di interrompere i rifornimenti italiani alla Grecia, quando invece gli Alleati avevano obiettivi e una strategia più vasti.96
La sua analisi ratificò quindi lo spostamento del centro di gravità della difesa delle isole Ioniche da Corfù a Cefalonia. Da Corfù arrivarono così il comando di Divisione, una compagnia cannoni, due compagnie del genio,
92 G. Rochat, op. cit., 1993, p. 22.
93 Idem, p. 46.
94 Per un resoconto dettagliato di questi mesi si veda G. Rochat, op. cit., 1993.
95 Idem.
96 Idem, pp. 38-39.
149
una sezione sanità e una sussistenza. Da Zacinto e Santa Maura arrivò il 317° reggimento fanteria, costituito a Merano il 1 novembre 1942.
Oltre ai reparti di nuova assegnazione, arrivarono anche reparti della marina. Nell’agosto del ’43, inoltre, giunsero alcuni reparti tedeschi: il 966° reggimento granatieri da fortezza con due battaglioni (909° e 910°) e una batteria di semoventi che rispondevano al colonnello Hans Barge, il quale era sottoposto ai comandi del generale Lanz.
Tali forze tedesche erano dislocate a Lixuri, nella penisola di Paliki, dove c’era la sede del loro comando. Ad Argostoli, sede del comando italiano, si trovava invece la 2° batteria di cannoni semoventi comandata dal tenente Jakob Fauth e una compagnia del 909° battaglione.
Nel complesso, le forze italiane a Cefalonia contavano nel settembre del ‘43 11.500 soldati e 525 ufficiali, mentre quelle tedesche 1.800-2.000 soldati e 25 ufficiali.97
L’occupazione del territorio delle isole Ioniche si era svolta senza osta coli, a differenza dell’Epiro e delle Tessaglia dov’era intensa la resistenza dei partigiani greci. Questo discorso vale anche per la divisione Acqui. Dai Diari storici della Divisione e dei suoi reparti, risulta che le truppe erano impe gnate con continuità sia in compiti di presidio, vigilanza, perlustrazione e fortificazione, sia in attività addestrative molteplici (conoscenza delle armi, comportamento in combattimento, marce e ginnastica). Assente invece era il peso delle operazioni antiguerriglia.98
Ciò non significa assenza di problemi. Non vanno infatti sottaciuti aspetti problematici quali la stanchezza, comune a tutte le divisioni impegna te in una lunga occupazione ma acuita dal fatto che l’esercito italiano, in tutto il periodo ’40-’43, non riuscì mai a garantire turni di licenza accettabili per gli uomini del fronte africano e balcanico.
In più bisogna tener conto dell’inadeguatezza, sia qualitativa sia quantitativa, del vitto, della presenza della malaria, che ad esempio aveva colpito più del 40% dei 700 uomini del III gruppo della 33° artiglieria.99
L’occupazione italiana delle isole, poi, non era ben vista dalla popolazione greca. Dalle relazioni dei comandi italiani, infatti, risulta che, pur in assenza di atti di guerriglia, sul piano politico la popolazione era profondamente ostile.
Cefalonia, 8-14 settembre 1943. Si negozia, tra incidenti e turbolenze interne
Alle ore 19.00 dell’8 settembre, il Comando Marina di Argostoli captò da Radio Londra la notizia che gli angloamericani avevano accettato la do
97 In realtà, sottolinea Rochat, le cifre sulla presenza italiana a Cefalonia non si appoggiano a un documento, anche se provengono certamente delle carte dell’Ufficio Storico. G. Rochat, Ancora su Cefalonia, settem bre 1943, in «Studi e ricerche di storia contemporanea», giugno 2005.
98 Idem, p. 29; G. Rochat, Le guerre italiane 1935-1943. Dall’impero d’Etiopia alla disfatta, Torino, Ei naudi, 2005, pp. 373-374.
99 G. Rochat, op. cit., 1993, p. 49.
150
manda di armistizio avanzata dall’Italia. Contattato il Comando Marina di Patrasso per una conferma della notizia, a Cefalonia ricevettero la seguente risposta: Aiuto! Siamo sopraffatti dai tedeschi...100
Durante la notte, il Comando della Divisione ricevette da Vecchiarel li indicazioni sul comportamento da tenere.101 Come già sottolineato, queste erano: non volgere le armi contro i tedeschi, a meno che questi non facciano atti di violenza armata, non fare causa comune con i ribelli né con gli an gloamericani eventualmente sbarcati, rimanere ai propri posti con i compiti attuali fino al cambio con i reparti tedeschi, comunicare tali indicazioni ai corrispondenti Comandi tedeschi, dare rassicurazioni.
Sull’isola fu stabilito il coprifuoco e il massimo controllo.102 Alle 0.20 arrivò il già ricordato ordine del generale Ambrosio e alle 03.00 giunse dal Comando Marina di Patrasso la disposizione di partenza per l’alba di tutte le navi per i porti italiani. Sarebbero dovuti rimanere solo alcuni motopescherecci della flottiglia dragamine per usi locali.103 Dall’isola partirono due MAS104, due motovelieri, due vedette della finanza, una nave da carico e due idrovolanti.
Considerato che Cefalonia non aveva piste d’atterraggio e che da lì a pochi giorni gli aeroporti greci sarebbero caduti in mani tedesche, la Divi sione venne tagliata fuori da qualsiasi apporto esterno e poté contare solo sui collegamenti radio-telegrafici.
Il giorno seguente Gandin, dopo aver disposto alcuni movimenti per rinforzare la difesa di Argostoli, incontrò il tenente colonnello Barge per av visarlo delle direttive ricevute. Barge disse di non aver ricevuto ordini precisi ma che era intenzionato a collaborare per evitare qualsiasi situazione spiacevole. Gandin, in segno di buona volontà, dette l’ordine di far ripiegare verso Argostoli alcuni reparti posizionati sulle alture di Kardakata.105 Sarà un er rore strategico perché presidiare quella zona significava controllare le strade rotabili nella parte settentrionale dell’isola e il passaggio nella penisola di Paliki dove erano concentrate le forze germaniche.106
100 M. Montanari, op. cit., p. 96.
101 Ci si riferisce all’ordine n. 02/25006.
102 G. E. Rusconi, op. cit., p. 15.
103 P. Paoletti, I traditi di Cefalonia. La vicenda della Divisione Acqui 1943-1944, Genova, Fratelli Frilli Editori, 2003, p. 27.
104 Motobarca Anti-Sommergibili.
105 G. E. Rusconi, op. cit., p .16.
106 In questa decisione, il ricercatore Paoletti, più che un errore strategico, intravede la volontà di Gandin non solo di cedere le armi ai tedeschi, ma di collaborare con loro manifestando così un atteggiamento proditorio nei confronti del Comando Supremo e del governo Badoglio. Lo studioso ha esposto questa discutibile tesi in due libri: I traditi di Cefalonia. La vicenda della Divisione Acqui 1943-1944, uscito nel 2003 e Cefalonia 1943. Una verità inimmaginabile, edito nella primavera del 2007. L’accusa di tradimento nei confronti di Gandin, è esposta con toni aspramente polemici soprattutto in questo secondo volume ponderoso, ricco di riferimenti a documenti italiani e tedeschi. Rusconi e Rochat sono i due storici che si sono maggiormente preoccupati di rispondere alle tesi di Paoletti, le cui pubblicazioni, in questa sede, ci
151
In Italia, siamo all’alba del 9 settembre, il re, Badoglio, Ambrosio e l’alto comando dell’esercito avevano abbandonato Roma alla volta di Pescara, decidendo così di non difendere la capitale e lasciando i comandi periferici privi di un punto di riferimento e di ordini precisi nella ferma volontà di evi tare uno scontro con i tedeschi.107
A Cefalonia la linea di Gandin fu da subito quella di negoziare. Prima del suo incarico sull’isola greca, era stato ufficiale di collegamento con il Co mando Supremo germanico. Egli dunque conosceva bene i tedeschi, dai quali era stimato, in particolare dal Führer che lo aveva insignito della croce di ferro di prima classe.
Presso le truppe andava invece montando un atteggiamento antitedesco alimentato dalla propaganda greca. Un sentimento non maggioritario anche perché per molti il messaggio di Badoglio voleva dire una sola cosa: la guerra è finita, tutti a casa.
Alle 20.00 arrivò il secondo ordine di Vecchiarelli che, come già ricor dato, era ben diverso dal primo, il quale seguiva la linea indicata dal Prome moria n. 2 del Comando Supremo.
Che fare quindi? Come procedere? A chi obbedire, al Comando Supre mo o a Vecchiarelli? Gandin ne discusse con i propri collaboratori, chiese al VIII Corpo d’armata la ripetizione del messaggio partito dal Comando dell’XI armata e tentò di collegarsi direttamente con il Comando Supremo in Italia.
La tensione nei vari reparti della Acqui cominciò ad affiorare. Da radio Londra arrivavano notizie su cosa stava succedendo sul continente greco; alcuni abitanti di Cefalonia si presentarono al capitano d’artiglieria Amos Pampaloni di cendo di essere rappresentanti della ELAS, organizzazione della resistenza greca legata al partito comunista, e di offrire alla divisione la loro collaborazione.
Il 10 settembre Barge, nominato nel frattempo comandante delle truppe tedesche sull’isola, si presentò a Gandin con le loro richieste: cessione di tutte le armi, comprese quelle individuali, entro le ore 10 del giorno seguente nella piazza principale di Argostoli.108
Le richieste di Barge erano in linea con quanto disposto dal suo superio re Löhr lo stesso giorno sul continente, mentre per Gandin esse non concordavano con le istruzioni di Vecchiarelli, che aveva disposto la consegna delle sole armi di reparto.
sono comunque tornate utili sul piano delle informazioni contenute. Rochat respinge sia il suo il metodo di ricerca che le sue argomentazioni nonché conclusioni, dettate quest’ultime da “smania di protagonismo” («Corriere della sera», 1 marzo 2007). All’interno di un convegno sull’eccidio di Cefalonia, svoltosi a Par ma il 2-3 marzo 2007, anche Rusconi e alcuni superstiti hanno avuto modo di contestare le tesi di Paoletti («Gazzetta di Parma», 3 marzo 2007, articolo reperibile all’indirizzo internet http://cefaloniaparma.net/ articoli.htm). Rusconi, in passato, aveva già replicato alle argomentazioni dell’ex professore di lingua e let teratura straniera. Si veda il suo Cefalonia, sospetti senza fondamento, in «La Stampa», 8 novembre 2005. Unica recensione sinora trovata sulle riviste specializzate dell’ultimo volume di Paoletti è firmata, ancora una volta, da Rochat e pubblicata su «Italia contemporanea», n, 246, marzo 2007.
107 E. Aga Rossi, op. cit., p. 120.
108 M. Montanari, op. cit., p. 100; G. Lombardi, op. cit., p. 127.
152
Il comandante italiano avanzò questa obiezione al suo interlocutore, il quale promise che avrebbe riferito ai suoi superiori. I due si congedarono. Nella stessa mattinata, Gandin ricevette la visita di Andrea Galiatsatos, un ufficiale greco che, a nome del Comando alleato in Medio Oriente, assicu rò l’appoggio aereo inglese e il rimpatrio di tutta la divisione Acqui qualora essa avesse opposto resistenza ai tedeschi. Probabilmente, l’ufficiale greco comunicò a Gandin il contenuto di un ordine rivolto il giorno prima da sir Henry Maitland Wilson, comandante in capo del Medio Oriente, ai reparti italiani nei Balcani.109 Tale messaggio invitava le Forze Armate Italiane, che desideravano combattere i tedeschi, a mettersi agli ordini del Comando Interalleato. Se le forze italiane avessero rifiutato di battersi contro gli ex alleati e non avessero consegnato le armi, sarebbero stati trattati come nemici degli Alleati e come tali attaccati.110
Gandin ritenne tali promesse troppo generiche e preferì proseguire con le trattative, sulla base degli ordini superiori di non fraternizzare con i greci in armi.111
Gandin chiamò poi a rapporto i comandanti di corpo. Edoardo Gherzi (comandante fanteria divisionale), Giovan Battista Fioretti (Capo di stato maggiore della Divisione), i comandanti di fanteria Ernesto Cessari e Ezio Ricci, il maggiore Federico Filippini (comandante del Genio) si dichiarano disposti alla cessione delle armi e a seguire le istruzioni di Vecchiarelli. Il capitano della Marina di Argostoli, capitano Mario Mastrangelo e il colonnello Mario Romagnoli, comandante del 33° reggimento artiglieria, si proclama rono contrari. Gandin, prima di congedare i propri uomini, dette l’ordine di diffondere il contenuto dell’ordine n. 02/25026 di Vecchiarelli.
Durante la notte Gandin ricevette da Barge un’altra proposta: cessione delle postazioni fisse solo al momento dell’imbarco, consegna delle armi pe santi solo al momento del rientro in Italia. Il generale italiano prese ancora tempo per decidere; Barge sembrava tranquillo, tanto che in giornata aveva comunicato al comando del XXII corpo d’armata che le trattative procedeva no bene. I suoi superiori, pur comprendendo la particolarità della situazione dell’isola, premevano per la cessione delle armi, già ordinata dall’XI Armata italiana alla divisione Acqui.
L’11 settembre iniziò con il verificarsi di incidenti tra italiani e tedeschi. In tarda mattinata Barge ricomparve al comando con una proposta che irri gidiva i termini dei precedenti accordi, in ottemperanza alla linea impostagli dai suoi superiori:
il comando supremo delle forze armate tedesche ha ordinato il disarmo delle truppe italiane;
109 G. E. Rusconi, op. cit., p .19.
110 Ibidem.
111 Ibidem. Secondo Paoletti, invece, il rifiuto di Gandin fu dovuto, più che a ragioni tecnico-militari, a ragioni politiche e morali (op. cit., 2007, p. 62).
153
sono esclusi dal disarmo i reparti che daranno garanzie di continuare a combattere agli ordini e al fianco delle truppe tedesche; le armi e tutto il materiale bellico devono essere raccolti dalla divisio ne e consegnati entro le ore 18 del 12 settembre presso la Piazza Italiana di Argostoli;
le truppe italiane dopo il disarmo devono abbandonare le posizioni e acquartierarsi nei tratti di territorio precedentemente occupati, rimanendo or ganizzati in battaglioni al comando dei loro ufficiali;
per quanto riguarda la permanenza e il trasferimento delle truppe italia ne dopo il disarmo si attendono ordini ulteriori.112
A Gandin venne chiesto di dare risposta ai primi due punti entro le 19.00 dello stesso giorno. Da notare che nelle richieste tedesche si parla di “trasferimento” e non di “rimpatrio”.
Gandin obiettò subito che per la sua divisione, la consegna delle armi nella piazza principale di Argostoli avrebbe offerto uno spettacolo indecoroso degli italiani nei confronti della popolazione locale. Inoltre non era chiaro cosa si in tendesse per “armi pesanti”, per “trattamento cavalleresco” promesso nel documento presentatogli da Barge. Che cosa si doveva fare con le armi personali?
Il comandante italiano ribadì che non era materialmente possibile con cludere la consegna delle armi entro i termini previsti, inoltre disse che non avrebbe dato la risposta sui primi due punti senza aver prima sentito i suoi comandanti di corpo, e comunque non entro le 19.00.
Al di là di questi dettagli, nelle richieste tedesche si poteva intravedere i contorni di un ultimatum e Gandin, nel pomeriggio, al Comando Supremo stanziato ormai a Brindisi, comunicò:
Comando tedesco chiede che divisione qui decida subito aut combattere uni tamente tedeschi aut cedere at esse. Mancando ogni… et ignorando situazione generale prego dare urgentemente orientamento…113
Gandin chiese quindi al Comando Supremo come comportarsi davanti a quel lo che in realtà era un trilemma: o cedere le armi ai tedeschi, o schierarsi con i tedeschi, o combattere contro di loro.
Sappiamo che l’11 settembre stesso il Comando Supremo rispose a Gan din che le truppe tedesche dovevano essere considerate nemiche, ma non sap piamo l’ora d’arrivo alla Marina di Cefalonia.114 Gandin, alle ore 17.00, chiamò a raccolta i cappellani militari poiché essi conoscevano, per contatto diretto e quotidiano, quale fosse lo stato d’animo
112 G. Schreiber, Cefalonia e Corfù settembre 1943: La documentazione tedesca, in G. Rochat. M. Venturi, op. cit., 1993, pp.131-132.
113 Riportato in P. Paoletti, op. cit., 2003. p. 320.
114 Si tratta dell’ordine n. 1027/CS, riportato in Paoletti, op. cit., 2003. p. 320. Sull’ora dell’arrivo di questo ordine si veda P. Paoletti, op. cit., 2007, pp. 132-133.
154
della truppa. A loro indicò i tre punti sui quali egli era chiamato a decidere; tutti i cappellani, eccetto uno, consigliarono la cessione delle armi per evitare un inutile spargimento di sangue.115 Alla riunione dei comandanti di reparto, ore 18.00, pur permanendo pareri divergenti, vennero respinte le tre soluzioni proposte dai tedeschi.
Nel frattempo stava montando il malcontento fra i reparti, soprattutto fra gli ufficiali d’artiglieria che erano decisi a combattere contro i tedeschi.
Il tenente colonnello Barge si presentò alle 19.00 per avere una risposta da Gandin, il quale si dichiarò orientato alla cessione della armi con precise garanzie ma, per decidere, chiese ed ottenne una dilazione sino all’alba per prendere contatti con i sottordini. Inoltre chiese che i tedeschi ponessero fine all’afflusso di nuove forze sull’isola e, in compenso, offrì il ritiro del terzo battaglione della 317° fanteria da Kardakata.116
Dopo l’incontro, Barge comunicò ai propri superiori che la maggior parte della divisione Acqui sarebbe stata disarmata il 12 settembre e che la situazione era tranquilla.117
Cosa stava accadendo invece nelle altre isole ioniche l’11 di settembre?
A Corfù, il colonnello Luigi Lusignani aveva ripetuto per la seconda volta nel giro di un giorno ai suoi interlocutori tedeschi che non avrebbe ceduto né le armi né il possesso dell’Isola, presidiata da 4.500 uomini. Due giorni dopo, i tedeschi subirono un insuccesso nel corso di un’operazione da sbarco condotta in maniera dilettantesca.118 A Santa Maura, invece, le unità che avevano ceduto ai tedeschi artiglierie e armi pesanti con la promessa del rimpatrio, erano state completamente disarmate, catturate e inviate nei campi. Tale noti zia arrivò a Cefalonia nella notte dell’11 settembre stesso.119
Da Brindisi, invece, partì un altro ordine inequivocabile (n. 1029/CS): Comunicate at generale Gandin che deve resistere con le armi at intimi dazione tedesca di disarmo at Cefalonia e Corfù et altre isole. 120 Ma quando partì questo esattamente ordine? Esso risulta essere conse gnato alla cifra alla Marina di Brindisi alle ore 9.45 dell’11 settembre, anche se Paoletti, sulla base di un’ulteriore copia dell’ordine sopraccitato conservata
115 Si veda il resoconto della riunione fatto da Don Romualdo Formato, op. cit., pp. 34-39.
116 M. Montanari, op. cit., p. 103. Sullo sgombero di Kardakata, va rilevato che nella letteratura consultata c’è poca chiarezza. Rusconi, e in particolare Paoletti con dovizia di particolari, riferiscono che l’ordine inviato ad alcuni reparti di sgomberare il passo di Kardakata era partito il 9 settembre, come abbiamo già avuto modo di sottolineare nelle pagine precedenti (Rusconi, op. cit. p., 16; Paoletti, op. cit., 2003, p. 102; idem, op. cit., 2007, pp. 54-55). Rusconi stesso, però, conferma quanto scritto da Montanari e qui riportato, e cioè che lo sgombero di Kardakata era stato proposto l’11 settembre per ottenere l’interruzione dell’afflusso di nuove truppe tedesche (G. E. Rusconi, op. cit. p. 30). Di preciso sappiamo che il ritiro da Kardakata fu completato in quest’ultima data (P. Paoletti, op. cit., 2007, p. 228). In ogni caso, questa mossa ebbe conseguenze strategico-militari negative per le forze italiane.
117 G. Schreiber, op. cit., 1993, pp. 133-134.
118 G. Schreiber, op. cit., 1997, p. 209.
119 G. E. Rusconi, op. cit., p. 31
120 Riportato in P. Paoletti, op cit., 2007, p. 511.
155
presso l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito (USSME), è propenso a ritenere che quell’ordine venne consegnato invece alle 9.45 del 12 settembre.121 L’interrogativo più importante, però, è quello che riguarda la data di arrivo ad Argostoli e qui la letteratura è divisa. Rusconi, rifacendosi a studi che tengo no conto delle testimonianze di alcuni sopravvissuti, ipotizza che sia arrivato nella notte sul 14 settembre.122 Una data confermata anche da Lombardi.123 Paoletti, sulla base invece della documentazione dell’USSME, ci informa che l’ordine deve essere arrivato il 12 settembre poiché, alle 14.05 dello stesso giorno, Gandin, con un telecifrato alla Marina di Brindisi, chiese: Prego dire massima urgenza ente mittente et firma telegramma n. 1029 odierno. 124
Gandin, quindi, nonostante avesse ricevuto nel giro di un giorno, o di pochi giorni a seconda delle interpretazioni, per due volte l’ordine di resiste re, proseguì con il negoziare. Perché? Questo è un altro punto controverso ma possiamo provare a spiegare tale comportamento sulla scorta dei diversi contributi consultati.
Egli sapeva, prima di tutto, che in caso di resistenza armata, il contesto geografico, favorevole in quel momento ai tedeschi, non avrebbe concesso un esito positivo per la sua divisione. In più, a proposito degli aiuti angloameri cani, era convinto che se per questi non era ancora giunta l’ora di occuparsi dei problemi balcanici, non sarebbe stata certo la sorte della sua divisione ad accelerare le lancette e a farli accorrere a Cefalonia in loro soccorso.125 Infine conosceva bene i tedeschi e sapeva che, in caso di resa dopo il combattimento, questi avrebbero reagito in maniera violenta.
Alle 4.00 del 12 settembre il capitano Gennaro Tomasi, interprete della divisione, consegnò al posto di comando tedesco la comunicazione che la divisione Acqui era disposta a cedere le armi. Tra i reparti si diffuse la voce che Gandin voleva arrendersi. Il generale venne così tacciato di essere un tedesco filo, un traditore, un vigliacco. Circolavano inoltre informazioni incontrollate e false che aumentavano l’inquietudine: i tedeschi erano stati cacciati dall’Italia, gli Alleati erano sbarcati a Corfù e si dirigevano verso le isole Ioniche.126
I tedeschi si fecero più pressanti. Fauth minacciò di far partire i bom bardamenti degli Stukas visto che gli italiani non avevano ancora consegnato le armi ma Gandin non si lasciò impressionare e ribatté che la cessione delle armi era già stata accettata, per cui non c’era motivo di arrivare a tali intimi dazioni. Nel pomeriggio si verificarono diversi episodi ostili, tra cui il disar mo di reparti italiani sulla Penisola di Paliki e un semovente tedesco che puntò sulla 3° batteria del 33° reggimento artiglieria. Al comando della batteria vi
121 Idem, pp. 270-271.
122 G. E. Rusconi, op cit., p. 24.
123 G. Lombardi, op cit., p. 144.
124 P. Paoletti, op. cit., 2007, p. 271.
125 G. E. Rusconi, op. cit. p. 29.
126 M. Montanari, op. cit., 104.
156
era il capitano Renzo Apollonio il quale, davanti a questa provocazione, dette l’ordine di puntare le armi sul semovente, che a quel punto tornò indietro. Apollonio costituiva, assieme agli ufficiali del 33° reggimento di ar tiglieria Amos Pampaloni e Abele Ambrosini, al colonnello Romagnoli e il capitano Guglielmo Pantano del 317° Reggimento fanteria, un nucleo di uo mini che si opponeva al disarmo. Questi uomini si recarono da Gandin; fu un incontro dai toni accesi.
Apollonio127 e Pampaloni128 , minacciando addirittura l’insubordinazio ne della truppa129, sostennero che i loro uomini non erano disposti a cedere le armi e che erano pronti a combattere. Se la stessa cosa non si poteva dire dei fanti era perché, secondo Apollonio, i loro comandanti, e qui probabilmente si riferì a Gherzi che era presente all’incontro, si erano espressi a favore della resa. Un sentimento che secondo Apollonio non rispecchiava la reale volontà dei soldati.130
Gandin, da parte sua, cercò di convincere i presenti che ogni atto di guerra non avrebbe avuto per gli italiani un risultato positivo perché i tedeschi avrebbero ricevuto rinforzi dalla terraferma e supporto dell’aviazione. Disse poi che nessun aiuto sarebbe arrivato dall’Italia o dagli Alleati.
La riunione evidenziò una profonda differenza di prospettiva tra il ge nerale e gli ufficiali che volevano combattere. Se per questi, infatti, l’onore militare coincideva con la non cessione delle armi, per Gandin lo stesso concetto voleva dire responsabilità verso la vita dei propri uomini.131
Il suo volto bianco e imperlato di freddo sudore - dichiarò successiva mente Apollonio riferendosi a Gandin - rivelava una indicibile sofferenza. L’atteggiamento e le parole del generale destarono in tutti i presenti l’impres sione di avere a che fare con un uomo indeciso e sovraccarico dal peso della sua responsabilità. 132
Il generale chiuse la riunione e si riservò la decisione, dando appuntamento alle ore 20.00 per un nuovo incontro. Chiese ai comandanti d’artiglieria di evitare qualsiasi iniziativa che avrebbe potuto far precipitare la situazione, mentre quest’ultimi rimasero convinti di poter aprire il fuoco qualora i tede schi avessero minacciato di modificare lo status quo.
Furono ore cariche di nervosismo; la macchina di Gandin, che si recava al nuovo incontro, venne colpita da una bomba a mano che non esplose e, suc cessivamente, venne bloccata da un gruppo di soldati che strapparono dalla vettura la bandiera italiana insultando il generale.
127 G. E. Rusconi, op. cit., p. 34.
128 Ibidem; Testimonianza di Amos Pampaloni su Cefalonia, in «Il Ponte», 9, settembre 1954. Consultabile anche all’indirizzo internet //cefaloniaparma.net/pdf/Pampaloni.pdf.
129 P. Paoletti, op. cit., 2003, p. 309.
130 G. E. Rusconi, op. cit., p. 35.
131 Idem, p. 36.
132 M. Montanari, op. cit., p 106.
157
Durante la notte si presentò Barge per comunicare che il Comando del Gruppo di Armate E pretendeva dalla Divisione una decisione definitiva: con segnare le armi o dichiararsi apertamente nemica della Germania. Gandin, ancora una volta, riuscì a evitare una risposta risolutiva sostenendo il diritto alla non belligeranza della sua divisione e a rimanere sull’isola in attesa di istruzioni da parte del suo governo. Tutto era di nuovo rinviato. Alle ore 06.00 del 13 settembre ci fu un altro evento importante ma non determinante. Due grosse motozattere tedesche provenienti da Zacinto doppiarono la punta di S. Teodoro in direzione di Argostoli. Molto proba bilmente trasportavano viveri e materiale vario per la difesa contraerea ma, nel clima diventato ormai tesissimo, tale avvicinamento venne interpretato dagli italiani come un atto ostile.133 Il tenente Apollonio dette quindi l’ordine di aprire il fuoco. Il conflitto durò venti minuti, provocando l’affondamento di una motozattera, cinque vittime e otto feriti tra i tedeschi. L’attacco venne giudicato da questi come un’iniziativa personale di alcuni ufficiali italiani che volevano forzare la mano al comando.134 Pertanto, i negoziati con Gandin non subirono interruzioni e, alle 12.45, Barge comunicò al XXII corpo d’armata da montagna di aver raggiunto con il generale italiano un nuovo accordo, in base al quale la divisione Acqui si sarebbe raccolta, con le proprie armi, ad ovest e a sud di Sami, situata sulla costa orientale dell’isola.135 Nel primo pomeriggio il generale Lanz si recò con un idrovolante a Cefalonia. I tedeschi volevano chiudere la partita viste le difficoltà incontra te a Corfù e l’occupazione di Brindisi da parte degli Alleati. L’idrovolante venne però accolto a cannonate e Lanz dovette tornare indietro ammarando a Lixuri. Da lì telefonò a Gandin ingiungendogli di adeguarsi agli ordini di Vecchiarelli e scrisse il testo dell’ultimatum che più tardi il tenente colonnello Barge consegnò a Gandin. Alla divisione Acqui venne ordinato di cedere im mediatamente tutte le armi, ad eccezione di quelle individuali degli ufficiali, al comandante Barge. Se questo non fosse avvenuto, le forze armate tedesche avrebbero proceduto con il disarmo forzato.136
Nella tarda serata, Barge comunicò al proprio corpo d’armata gli ultimi accordi presi con il generale italiano. La consegna delle armi sarebbe avvenuta in tre fasi tra il 14 e il 16 settembre, data nella quale i militari italiani si sareb bero raccolti, con le proprie armi, nella zona di Sami. Gandin aveva disposto nel pomeriggio la concentrazione dell’intera divisione nella zona compresa fra Phrankata-Sami-Poros. Sembrava tutto risolto, ma non fu così. Gandin era con-
133 Per una difesa di questa interpretazione, si veda Paoletti, op. cit., 2007, pp. 70-71. Lo studioso ritiene che quell’operazione, che precedette di un’ora e mezza l’attacco tedesco a Corfù, aveva come scopo la cat tura del comando della divisione Acqui. In sostanza, sostiene Paoletti, i tedeschi volevano chiudere i conti con Corfù e Cefalonia in un colpo solo. Per una lettura diversa e, a giudizio di chi scrive, più verosimile dell’episodio delle motozattere, si veda Rusconi, op. cit., p. 38.
134 Idem, p. 38.
135 G. Schreiber, op. cit., 1993, p. 143.
136 Ibidem.
158
vinto di aver raggiunto un accordo che avrebbe rispettato l’onore militare, visto che ai suoi uomini sarebbero state lasciate le armi pesanti e l’artiglieria sino al momento dell’imbarco137 o addirittura sino all’Italia, come riporta padre Forma to.138 Non è quest’ultima una questione di lana caprina. Forse, tra Lanz e Gandin, c’è stato un fraintendimento sui termini della consegna o meno di tutte le armi. Con il passare delle ore gli eventi presero una piega negativa per gli uomini della Acqui. Giungeva infatti notizia che i tedeschi si rifiutavano di caricare anche le armi pesanti. Siamo nella notte tra il 13 e il 14 settembre, ore in cui, per alcuni autori, sarebbe arrivato da Brindisi l’ordine di resistere ai tedeschi139, quello che avrebbe convinto definitivamente Gandin a combattere contro i tedeschi. Stando alla testimonianza di Tomasi, sin dal 12 settembre Gandin non era disposto a cedere le armi a qualunque costo, bensì era orienta to a combattere in seguito alle provocazioni tedesche (minacciato bombarda mento dell’isola, disarmo di alcuni reparti nella penisola di Paliki).140 Sempre il 12 settembre, ricordiamo, secondo Paoletti sarebbe arrivato dall’Italia l’or dine n. 1029 di resistere alle intimazioni tedesche. Ciò, però, non ci consente di fare un collegamento diretto tra quanto testimoniato dall’interprete della divisione e quanto scritto dallo studioso.
Gandin, comunque, in queste ore revocò l’ordine di trasferimento delle truppe nella zona di Sami e impartì i primi ordini per sbarrare le provenienze da nord. Durante questi movimenti, Gandin dispose di interpellare gli uomini della Acqui su un quesito che ormai non ammetteva più rinvii: o contro i tedeschi, o a fianco dei tedeschi o cessione delle armi. A proposito di questa consultazione, si è molto discusso e si è spesso parlato di “referendum”, come se la decisione fosse spettata in ultima istanza alla volontà della maggioranza. Leggendo e confrontando le memorie postume, esce una diversa percezione di questa operazione che non fu possibile condurre per tutti i reparti.141 Come scrive Rochat: non fu certo un referendum democratico, piuttosto, una forma di mobilitazione degli animi adeguata al momento drammatico. 142 La maggioranza, non l’unanimità come è stato spesso scritto, della divi sione si espresse per l’azione contro i tedeschi.
137 Questo sarebbe stato promesso da Hermann Busch, tenente colonnello della Luftwaffe atterrato a Cefa lonia nella giornata del 13 per incontrare Gandin. Non vi è spazio qui per ricostruire i motivi di tale visita che interferì con i negoziati in corso: invitare Gandin a partire con lui per raggiungere Mussolini a Vienna o Hitler stesso a Berlino? Sono ipotesi affrontate in maniera diversa dalla letteratura consultata. Si veda Ru sconi, op. cit., pp. 38-39; Paoletti, op. cit., 2003, pp. 54-55. Gandin rifiutò comunque di lasciare Cefalonia e di abbandonare i propri uomini.
138 R. Formato, op. cit., p. 46.
139 Il già citato ordine n. 1029/CS.
140 G. E. Rusconi, op. cit., p. 40.
141 Si vedano a proposito i libri scritti da i due superstiti Olinto G. Perosa, Divisione Acqui, figlia di nes suno (Tipografia Finanzi, Merano, 1993), e Guglielmo Endrizzi, En braghe de tela taliàne : l’odissea di un trentino sopravvissuto all’eccidio di Cefalonia (Biblioteca Intercomunale Altopiano Paganella Brenta, Trento, 2000).
142 G. Rochat, op .cit., 2005, p. 7.
159
Alle ore 11.00 del 14 settembre si presentarono al Comando di Divisione alcuni ufficiali tedeschi con alla testa il tenente Fauth. Il capitano Tomasi, in terprete, consegnò loro una lettera chiusa affinché ne comunicassero subito il contenuto al tenente Barge. Secondo la relazione di Tomasi, i tedeschi vollero conoscere subito il testo del messaggio e l’interprete li accontentò143:
Per ordine del Comando Supremo italiano e per volontà degli ufficiali e dei soldati, la Divisione Acqui non cede le armi. Il comando superiore tedesco, sulla base di questa decisione, è pregato di presentare una risposta definitiva entro le ore 9 di domani 15 settembre. 144
Sono parole che ritornano in molti testi ma, ci dice Rochat, non risultano dalla documentazione scritta bensì dalle testimonianze dei sopravvissuti.145
La documentazione tedesca riporta invece una versione diversa. Il diario di guerra del XXII Corpo d’armata da montagna tedesco contiene infatti un allegato riportante una comunicazione di Gandin fatta pervenire a Barge nella notte sul 15. Il testo è il seguente:
La Divisione si rifiuta di eseguire il mio ordine di concentrarsi nella zona di Sam, perché teme di essere disarmata... Di conseguenza le intese con Lei non sono state accettate dalla Divisione.
La Divisione vuole rimanere nelle sue posizioni fino a quando non ri ceve assicurazione... che può conservare le sue armi e munizioni e che con segnerà l’artiglieria ai tedeschi solo al momento dell’imbarco... Se ciò non accade, la Divisione preferirà combattere piuttosto che subire l’onta della cessione delle armi ed io, sia pure con rincrescimento, rinuncerò definiti vamente a trattare con la parte tedesca sinché rimango al vertice della mia Divisione. Prego darmi risposta entro le ore 16.00.146
Questo è un altro punto controverso, poiché da questo documento tedesco emerge un Gandin al vertice di una divisione che si rifiuta di obbedire ai suoi ordini, mentre nella documentazione italiana abbiamo un generale che si fa concorde portavoce della volontà generale della sua divisione.147 La storiogra fia accademica tende però a non considerare rilevante tale contraddizione.
In entrambi i documenti veniva comunque tenuta aperta un’ulteriore possibilità per le trattative.
Negoziazioni che continuarono anche il 14 settembre. In quell’occasio ne, le due parti si lasciarono con la rassicurazione di Barge che gli italiani
143 M. Montanari, op. cit., p. 111
144 Ibidem.
145 G. Rochat, op. cit., 2005, p. 8.
146 G. E. Rusconi, op. cit., pp. 46-47.
147 Per un confronto delle diverse tesi si veda G. E. Rusconi, op. cit.; P. Paoletti, op. cit., p. 2003.
160
avrebbero ricevuto una risposta, in merito alla loro richiesta di essere rimpa triati, alle 14.00 del giorno dopo.
Furono ancora una volta ore intense e difficili. Nei comandi tedeschi saltarono alcuni anelli della catena informativa e Lanz minacciò Barge di sostituirlo perché la situazione venutasi a creare, l’irrigidimento di Gandin e della sua Divisione, il fallito sbarco a Corfù, la presenza angloamericana a Brindisi, richiedeva una soluzione in tempi brevi. Barge nella notte sul 15 ricevette la comunicazione sopraccitata di Gandin e alla fine, decisosi per l’intervento armato, comunicò a Lanz che alle 14.00 del giorno 15 avrebbe attaccato la divisione italiana. La decisione venne accettata.
I combattimenti, la resa, la vendetta
Il mattino del 15 settembre il generale Gandin si tolse dalla giubba la croce di ferro di prima classe ricevuta da Hitler e diramò un messaggio ai reparti nel quale esortava tutti a prepararsi ad una dura lotta, rendendo anche noto l’atteggiamento tenuto dalle altre forze della Divisione a Corfù. Poco dopo le ore 13, gli Stukas effettuarono il primo bombardamento su Argostoli e dintorni. Il comando di divisione italiano aveva stimato che la presenza tedesca era salita a 3.000 uomini.148
La battaglia, di cui daremo solo qualche accenno, si svolse in tre fasi.
In una prima fase, tra il 15 e il 17 di settembre, gli italiani respinsero l’attacco tedesco, provocando l’affondamento di un natante tedesco e causando così centoquaranta vittime.149 Gandin comunicò al Comando Supremo che aveva dovuto aprire le ostilità contro i tedeschi, i quali sospesero l’attacco a Corfù per concentrare tutte le forze disponibili su Cefalonia.150 Sul continente si radunò un consistente contingente di truppe germaniche che sbarcarono nella penisola di Paliki tra il 16 e il 20 settembre comandate dal maggiore Harold von Hirschfeld.151 Il 16 i tedeschi impiegarono su Cefalonia 127 aerei, partiti dagli aeroporti greci caduti in mano loro dopo l’8 settembre. Ciononostante, un reparto tedesco dislocato presso Argostoli fu sopraffatto con la cattura di circa 450 prigionieri i quali, va sottolineato, furono trattati con dignità e rispetto militare.152 Nella seconda fase, 17-19 settembre, l’iniziativa partì dagli italiani ma il successo fu tedesco. Gandin, infatti, volle riconquistare da sud le posizioni di Kardakata e da est quelle di Ankona ma pesò molto l’assenza dell’apporto dell’aviazione, decisiva per le sorti dello scontro. Gandin chiese a Brindisi aiuti militari ma dal Comando Supremo ricevette solo incoraggiamento a resistere:
148 M. Montanari, op. cit., p. 112.
149 G. Schreiber, op. cit., 1993, p. 167.
150 L’operazione contro l’isola di Corfù, denominata “Verrat” (tradimento), venne rinviata al 24 settembre. Le forze italiane comandate da Lusignani capitolarono il 25 settembre. Lusignani e altri 28 ufficiali furono fucilati subito dopo la cattura. Furono 600 gli italiani caduti o assassinati.
151 Si tratta di due battaglioni e un gruppo di artiglieria della I Divisione da montagna Edelweiss, nonché del I battaglione della 104 Divisione Jäger. Fonte G. E. Rusconi, op. cit., p. 53.
152 P. Paoletti, op. cit., 2003, p. 241; R. Formato, op. cit., pp. 53-54.
161
Da Comando Supremo a Cefalonia: impossibilità invio aiuti richiesti alt infliggete nemico più gravi perdite possibili alt ogni vostro sacrificio sarà ricompensato alt Ambrosio. 153
All’alba del 18 i tedeschi passarono all’offensiva e il primo battaglione del 317° Reggimento venne annientato.
In quello stesso giorno, il Comando Supremo delle forze armate tede sche emanò, in nome di Hitler, la disposizione di non fare prigionieri italia ni a Cefalonia a causa del loro comportamento malvagio e proditorio.154 Un ordine che inaspriva quanto già disposto solo pochi giorni prima155, quando si era stato stabilito che dovevano essere fucilati, secondo la legge marziale, gli ufficiali rei di aver fatto causa comune con i ribelli, mentre sottufficiali e truppa dovevano essere trattati come prigionieri di guerra e utilizzati come manodopera.156
Nella stessa giornata del 18 si verificò quanto disposto da Hitler: mili tari italiani sconfitti in combattimento vennero subito uccisi.157 Il 18 e il 19 vennero lanciati migliaia di volantini su Argostoli e sulle difese italiane per invitare i soldati alla resa in cambio del rimpatrio.
La terza fase, tra il 21e il 22 settembre, segnò la sconfitta e il massacro della divisione Acqui. I tedeschi riuscirono nella loro manovra di accerchia mento di Argostoli. Gandin, ancora il 21, provò a chiedere rinforzi dall’Italia e mandò persino l’ultimo motoscafo di cui disponeva a Brindisi per convincere il Comando Supremo ad intervenire. Ormai era troppo tardi. Alle 11.00 del 22 settembre il III battaglione del 98° Gebirgsjäger entrò ad Argostoli. Gan din, dalla sede di comando che in quelle ore era stata trasferita a Keramies, consegnò la dichiarazione di resa da portare ad Argostoli al maggiore von Hirschfeld, e fece issare bandiera bianca:
La divisione Acqui è stata dispersa dall’azione degli Stukas. La resistenza è divenuta impossibile. Di conseguenza, al fine di evitare un ulteriore inutile spargimento di sangue, offre la resa.158
La sera del 22 settembre, Lanz comunicò al Comando del gruppo di Armate E che la massa della Divisione Acqui era stata annientata e chiese il com portamento da tenere con Gandin, che da Keramies era stato trasportato ad Argostoli, e gli altri ufficiali.
153 Riportato in P. Paoletti, op. cit., 2003, p. 205.
154 G. Schreiber, op. cit.,1993, p. 158.
155 Ci si riferisce a direttive emanate il 10, 12 e 15 settembre, riportate in G. Schreiber, La vendetta tedesca 1943-1945, Milano, Mondadori, 2000.
156 G. Schreiber, op. cit., 1993, p. 157.
157 Idem, p. 158.
158 M. Montanari, op cit., pp. 119-120.
162
A proposito di questa comunicazione, bisogna rendere palese ciò che si nasconde dietro l’espressione “annientata”. In seguito agli scontri, infatti, trovarono la morte tra le fila italiane 65 ufficiali e 1.250 uomini ma, quello che i documenti tedeschi non dicono chiaramente ma fanno intendere, anche involontariamente, è che in ottemperanza all’ordine di Hitler del 18 settem bre, in quei giorni vennero massacrati altri 155 ufficiali e tra i 4.000 e i 5.000 soldati.159 Non è vero quindi che la Divisione Acqui fu annientata in combat timento.
A proposito del conteggio delle vittime, va detto che le cifre divergono nei vari studi e sono spesso oggetto di contesa. Chi scrive è convinto che, come per altri crimini contro l’umanità, il punto centrale non sia tanto il computo esatto quanto l’analisi del principio criminale in base al quale è stato commesso un eccidio. Quello su cui è importante soffermarsi è il modo in cui vennero trattati i militari italiani a Cefalonia. In totale spregio delle convenzioni internazionali, molte unità furono uccise sommariamente dopo la resa a colpi di mitragliatrice. Vennero ammazzati addirittura soldati con la fascia della Croce Rossa, militari feriti e personale sanitario prelevati negli ospedali.160
Agli italiani uccisi non venne nemmeno concessa una sepoltura decoro sa: i corpi furono ammassati e bruciati, gettati in pozzi o cisterne, portati al largo e gettati in mare con delle pietre legate alle caviglie. Diciassette marinai furono prima costretti a caricare su zatteroni le salme dei loro compagni e, successivamente, furono uccisi e sepolti nella fossa che aveva ospitato i cada veri da loro stessi caricati.161 Fino al settembre del 1944 fu impedito di recu perare le ossa dei martiri che affioravano addirittura ai margini delle strade di campagna. Successivamente, furono i cappellani militari Don Ghilardini e Don Formato i primi ad occuparsi di recuperare i resti dei caduti.
Il 23 settembre, Lanz ricevette la risposta al suo quesito del giorno pre cedente. Hitler, forse soddisfatto della punizione esemplare da lui stesso richiesta, ordinò di considerare i sottufficiali e i restanti 5.000 soldati come prigionieri di guerra. Nessuna indulgenza per gli ufficiali. Tra il 23 e il 28 settembre, pertanto, furono uccisi altri 265 ufficiali, di cui 137 in un sola giornata a capo S. Teodoro, presso la tristemente nota “Cassetta Rossa”. Alla fine vennero risparmiati tra i 37162 e i 40163 ufficiali, una ventina perché nativi del Trentino Alto Adige164 o perché vennero riconosciute le loro benemerenze
159 Le perdite tedesche invece furono decisamene più contenute: circa 200 morti e una ventina di dispersi stando alle cifre fornite negli scritti di Schreiber.
160 P. Paoletti, op. cit., 2003, p. 241-242.
161 E. Aga Rossi, op. cit., p. 175; P. Paoletti, op. cit., 2003, pp. 251-252.
162 La cifra è indicata da Formato, presente quel giorno alla “Casetta Rossa”. Nel suo libro egli stila un elenco dettagliato dei nominativi degli ufficiali scampati dalla fucilazione. R. Formato, op. cit., p. 370.
163 Questa è la stima di G. Schreiber, op. cit.,1997, p. 208.
164 Infatti arrivò l’ordine di risparmiare i militari originari del Trentino Alto Adige e del Venezia Giulia, dove erano state costituite due zone di operazioni sottratte all’autorità della RSI e sostanzialmente annesse al Terzo Reich.
163
fasciste, gli altri perché furono accolte le insistenti richieste del cappellano militare che si trovava con loro, perché si ponesse fine alla strage.165
Gandin venne fucilato separatamente, lontano da occhi italiani o gre ci, il 24 settembre.166 A leggere la condanna a morte fu il maggiore Klebe, mentre a comandare il plotone d’esecuzione fu posto il sottotenente Otmar Mühlhauser.167
Venendo così ad un bilancio finale, si può approssimativamente parlare di 3.800-4.000168 o 5.000169 militari caduti in settembre (uccisi in battaglia o fucilati), e di circa 6.000 superstiti sgomberati via mare, di cui 1.300 morirono in seguito all’affondamento delle navi che li trasportavano.
Nei trasporti marittimi, infatti, a causa dell’affondamento delle navi causato da mine, attacchi di sommergibili e aerei delle forze Alleate, tra il settembre del ’43 e il marzo del ’44 morirono tra i 13.000 e i 20.000 internati italiani (a seconda delle fonti). Solo in mare persero dunque la vita il 17% dei prigionieri italiani, contro l’1% dei militari tedeschi.170 Uno squilibrio che si spiega con il fatto che la navi venivano sovraccaricate e le scialuppe di salva taggio erano poche e venivano utilizzate dal personale tedesco a bordo.
La maggior parte dei superstiti di Cefalonia raggiunsero sul continente gli altri italiani raccolti in campi di prigionia, dai quali successivamente rag giunsero i campi d’internamento del Reich o le zone di operazioni dell’eser cito germanico sul fronte orientale. I tedeschi sgomberarono l’isola entro il 13 settembre 1944.171 I prigionieri rimasti sull’isola, 1.300-1.400 uomini nel 1944, vennero rimpatriati nel novembre dello stesso anno da navi italiane e inglesi.172
165 E. Aga Rossi, op. cit., p. 176. Il cappellano cui si riferisce Aga Rossi è Don Formato.
166 P Paoletti, op. cit., 2007, pp. 92-93.
167 Ibidem.
168 È la cifra stimata da Rochat nel 2005.
169 È la cifra per la quale propende Schreiber nei suoi studi.
170 G. Schreiber, op. cit., 1997, pp. 365 e 374.
171 Idem, p. 372.
172 P. Paoletti, op. cit., 2003, pp. 262-263; R. Formato, op. cit., p. 371.
164


165
Due immagini recenti che testimoniano l’esistenza sull’isola di Cefalonia di un autocarro appartenuto alla Divisione Acqui (foto Eugenio Iafrate).
Ancora qualche parola su Cefalonia
Prima di terminare questo mio contributo, ci sono ancora delle questioni da affrontare che riguardano aspetti per i quali questa tragedia non puoi dirsi del tutto conclusa, soprattutto se la si guarda da parte dei parenti delle vittime.
Per questi ultimi mancano ancora delle tessere per ricostruire il mosai co; ci sono delle responsabilità che le istituzioni italiane e tedesche, nel corso degli anni, hanno lasciato impunite o non chiarite. E qui la narrazione storica prende i connotati di una cronaca giudiziaria che arriva sino ai giorni nostri.
Procediamo in ordine cronologico e chiediamoci perché nel dopoguerra non si sia proceduto ad incriminare e assicurare alla giustizia tutti responsa bili dell’eccidio di Cefalonia.
Lo storico Mimmo Franzinelli spiega che, nella seconda metà degli anni Quaranta, a proposito dei crimini nazisti compiuti in Italia prevalse l’orientamento di accantonare i fascicoli processuali contro i tedeschi. Una decisione maturata sotto la pressione di ambienti governativi e influenzata dalla fonda zione della Repubblica Federale di Germania, avvenuta nel 1949.173
Centinaia e centinaia di incartamenti furono così occultati in un armadio della Procura generale militare di Roma, ribattezzato “l’armadio della vergogna”.
Nel 1956 gli allora ministri degli Esteri e della Difesa, rispettivamente Gaetano Martino e Paolo Emilio Taviani, membro quest’ultimo del CLN li gure durante l’occupazione tedesca, fermarono l’inchiesta sulla strage di Ce falonia perché temevano che la celebrazione del processo nei confronti dei responsabili, potesse rallentare la riorganizzazione dell’esercito tedesco e la sua integrazione, in chiave antisovietica, nell’Alleanza Atlantica.
In conseguenza di tale orientamento politico, nel 1960 il procuratore ge nerale militare Enrico Santacroce decretò l’archiviazione provvisoria di 695 fascicoli per crimini di guerra.174 Un’archiviazione durata sino al 1994, quando tale armadio fu casualmente scoperto durante le indagini su Erich Priebke per il processo sulle Fosse Ardeatine.
La tragedia di Cefalonia trovò però posto all’interno dei processi di No rimberga durante i dibattimenti del cosiddetto Caso VII, iniziati nel 1947. In tale processo venne coinvolto il generale Hubert Lanz, il suo superiore, generale Wilhelm Speidel comandante militare della Grecia, e altri dieci uf ficiali.175
Tra i vari capi d’accusa contestati a Lanz, vi fu l’aver dato ordine di fucilare gli ufficiali italiani di Cefalonia. Lanz venne condannato a dodici anni di carcere, anche se ne scontò soltanto cinque. Non venne incriminato
173 M. Franzinelli, Le stragi nascoste. L’armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guer ra nazifascisti 1943-2001, Milano, Mondadori, 2002, pp. 9-10.
174 Il fascicolo riguardante Cefalonia è il n. 1188.
175 P. Paoletti, op. cit, 2003, pp. 292-293.
166
invece von Hirschfeld, riconosciuto da molti come il responsabile diretto dei massacri.176
Il responsabile dell’accusa, il generale americano Telford Taylor, spiegò con le seguenti parole i motivi per cui l’eccidio di Cefalonia doveva essere considerato un crimine di guerra:
Questa strage deliberata di ufficiali italiani che erano stati catturati o si erano arresi è una delle azioni più arbitrarie e disonorevoli nella lunga sto ria del combattimento armato. Questi uomini indossavano regolare uniforme. Portavano le proprie armi apertamente e seguivano le regole e l’usanze di guerra. Erano guidati da capi responsabili che, nel respingere l’attacco, obbedivano agli ordini del mar. Badoglio... Erano soldati regolari che avevano diritto a rispetto, a considerazione umana e a trattamento cavalleresco.177
Gli italiani vennero considerati invece dai tedeschi come traditori, fran chi tiratori, non riconosciuti quindi come belligeranti e di conseguenza non trattati secondo quanto previsto dalle convenzioni dell’Aja (1907) e di Ginevra (1929). Un ragionamento avallato anni dopo anche dal procuratore generale di Monaco di Baviera Stern, il quale nel 2006 ha archiviato il procedimento contro Mühlhauser richiesto da Marcella De Negri, figlia di un caduto a Ce falonia.178 Tale argomentazione, oltre che dai parenti delle vittime, è invece rifiutata dagli storici, come si è detto all’inizio di questo scritto citando le parole di Schreiber.
Dal punto di vista del giudizio storico sui protagonisti della Divisio ne Acqui, la faccenda è invece più complessa. Di Gandin non si possiede che pochissima documentazione diretta. Molte carte sono andate distrutte o sono state eliminate in quei tragici giorni. Ciò che sappiamo di Gandin è quanto viene riferito in relazioni posteriori dei sopravvissuti. Senza entrare troppo nello specifico delle singole accuse, talvolta infamanti179, al generale della divisione insignito nel 1948 della Medaglia D’Oro al Valor Militare, è stata rimproverata la decisiva esitazione iniziale, la mancanza di fermezza nei confronti degli atti di insubordinazione durante le trattative e l’inosser
176 G. Lombardi, op. cit., pp.198-199.
177 P. Paoletti, op. cit., 2003, p. 291.
178 È possibile leggere la sentenza nella traduzione italiana fatta dall’avvocato Gilberto Pagani, legale della De Negri al processo di Monaco, sul sito dell’ANPI all’indirizzo http://www.anpi.it/documenti/cefalonia_ sentenza_monaco.pdf. La De Negri, assieme a Paola Fioretti, figlia dell’ufficiale Giovanni Battista Fioretti anch’egli fucilato il 24 settembre a Cefalonia, non accettando le sentenze di archiviazione di Monaco e di Dortmund (2007) dei processi a carico di sette ex soldati tedeschi, ha consegnato nell’ottobre del 2007 un esposto alla Procura Militare di Roma, chiedendo di procedere contro Mühlhauser. Ringrazio Lorenzo Baratter per avermi fornito il documento, reperibile all’indirizzo http://labos.valtellina.net/gazetin/Cefalo niaEspostoRoma.pdf. Maggiori dettagli sull’assoluzione di Mühlhauser e sui risultati dell’inchiesta della procura di Dortmund sull’eccidio di Cefalonia, si possono trovare in P. Paoletti, Cala la notte su Cefalonia, in «L’Espresso», 27 settembre 2007. Il 15 novembre del 2007 è apparsa su «La Repubblica » la notizia dell’apertura di un’inchiesta da parte del procuratore militare di Roma Antonio Intelisano nei confronti dei sette ex soldati tedeschi assolti dai tribunali tedeschi, tra cui Mühlhauser. Carlo Bonini, Si riapre l’inchiesta sulla strage di Cefalonia, «La Repubblica », 15 novembre 2007. 179 È questo il caso di Paoletti, op. cit., 2007.
167
vanza degli ordini emanati da Badoglio (in conseguenza dell’armistizio), da Vecchiarelli e dal Comando Supremo. A Gandin venne persino rinfacciata la decisione di combattere. L’elenco potrebbe essere ancora più lungo ma, come scrive Aga Rossi:
Il giudizio dovrebbe comunque tener conto della complessità della situazione in cui si venne a trovare e della difficoltà di operare una scelta. Il genera le Gandin dovette «sopportare il peso del pratico abbandono al suo destino con tutta la divisione» e non sarebbe giusto attribuirgli la responsabilità per l’incertezza e il disorientamento determinato dall’improvviso vuoto di potere della latitanza dei vertici... Infine si deve sottolineare che il generale Gandin, una volta presa la decisione di combattere, si comportò valorosamente, eser citando con fermezza il comando e seguendo fino alla fine la via del dovere militare. 180
Risulta ancora più complicato il giudizio da dare sul capitano Apollonio. Fatto prigioniero dai tedeschi e scampato, o risparmiato, alle fucilazioni, proprio lui, che aveva sostenuto l’azione armata contro i tedeschi, riuscì a farsi nomi nare da loro capo interprete dei prigionieri italiani rimasti sull’isola e trasfor mati in lavoratori coatti. Accanto a questa attività collaborazionista, Apollonio riuscì ad avviarne un’altra di stampo resistenziale, mantenendo i contatti con l’ELAS e infor mando le forze partigiane greche dei rastrellamenti. Nell’ottobre del ’43, inol tre, partecipò alla costituzione del clandestino Raggruppamento Banditi Ac qui, che si distinse in operazioni di sabotaggio, con il quale tornerà in Italia nel novembre del 1944.181
Nel 1957 il capitano d’artiglieria, assieme a Pampaloni, a Don Ghilardi ni e ad altri ventiquattro superstiti fra soldati e ufficiali che in quei giorni si erano pronunciati per la resistenza armata, fu denunciato da Roberto Triolo e Bernardino Pugliese, padri di due ufficiali fucilati a Cefalonia, per rivolta continuata, insubordinazione e cospirazione. 182 Il processo ad Apollonio e gli altri si concluse con il proscioglimento.183
I due genitori furono mossi dal principio che, se si fossero consegnate le armi, i tedeschi non avrebbero annientato in quel modo la divisione Acqui.184 Come già scritto nella premessa e visto nella testimonianza di Bertoldi, è un’argomentazione che ritorna quando si ha a che fare con le rappresaglie naziste e che crea lacerazioni nelle coscienze e battaglie delle memorie tra chi
180 E. Aga Rossi, op. cit., p. 179.
181 P. Paoletti, op. cit., 2003, pp. 255-263.
182 Idem, p. 308.
183 Per il capitano d’artiglieria, che fece successivamente carriera nell’esercito, fu proposta nel 1947 la MOVM ma fu rifiutata dalla Commisione incaricata di giudicare. Diniego che si ripeté nel 1962.
184 P. Paoletti, op. cit., 2003, p. 308.
168
partecipò alla resistenza e tra quanti subirono, direttamente o indirettamente, le vendette tedesche.185
Il giudizio negativo di alcuni parenti delle vittime sulla scelta di lottare lo ritroviamo anche in alcune testimonianze. Non tutti, lo ripetiamo, accolsero la decisione di resistere combattere in maniera positiva. Sarebbe ingenuo pen sare che 11.000 persone potessero avere in merito un unanime consenso.186
Questa differenza di posizioni, tra loro spesso inconciliabili, non azzera però il contenuto valoriale della resistenza della Divisione Acqui a Cefalonia.
Il comportamento della divisione durante i combattimenti, e l’atteggia mento di alcuni componenti nei giorni precedenti lo scontro, rientrano infatti pienamente nel fenomeno della Resistenza. Il riconoscimento del collegamen to tra lotta partigiana e quanto successe a Cefalonia fu quasi istantaneo. In una nota annessa al verbale del consiglio dei ministri del 23 maggio 1944 presie duto, si badi bene, da Badoglio, il governo esaltò la Acqui come protagonista della prima azione di guerra di liberazione nazionale contro la Germania. 187 Con il decreto legge n. 93 del 6 settembre 1946 si stabilì che:
La Divisione Acqui quale formazione partigiana, come unità regolare delle FF.AA. ha volontariamente operato nella lotta di Liberazione per la libera decisione dei suoi ufficiali e dei suoi soldati.188
Questo rapporto tra la resistenza opposta dalla Divisione Acqui e il fenome no della lotta partigiana è stato oggetto di polemiche, dovute più che altro all’attuale momento politico. Il Revisionismo all’italiana di questi ultimi anni, ad esempio, ha accusato la vulgata resistenziale e le forze di sinistra di aver oscurato il ricordo della Divisione Acqui.
Basta sfogliare la Storia della Resistenza italiana di Roberto Battaglia, un classico della vulgata resistenziale di matrice comunista edito nel ’53, per accorgersi dell’infondatezza di tali accuse.189 Qui, infatti, l’epopea di Cefa lonia, come la chiama l’ex partigiano azionista, viene narrata e inserita nel fenomeno resistenziale, seppur con toni eccessivi e forzature ideologiche.190
185 Data la vastità e delicatezza del tema, non posso che rinviare ai testi indicati nella nota n. 5 e a S. Peli, La Resistenza in Italia. Storia e critica, Torino, Einaudi, 2004, pp. 238-249.
186 Basta leggere le memorie e le testimonianze dei sopravvissuti per rendersene conto di questa diversità. Si veda ad esempio il Progetto Cefalonia 1943 realizzato nel 2006 dal Liceo G. Parodi di Acqui Terme. I docenti e gli studenti dell’istituto hanno raccolto, sotto forma di questionario, 159 testimonianze di reduci della Divisione Acqui. Il risultato di tale ricerca è consultabile all’indirizzo www.acquiterme.it/liceoparo di/DOCENTI/BOTTO/Cefalonia1943_min.pdf. Il lavoro presenta delle pecche dovute probabilmente ad errori di trascrizione dei questionari compilati e rispediti dai reduci. Ciononostante si tratta di un progetto didatticamente interessante e riuscito. È presente anche una testimonianza di Bruno Bertoldi.
187 G. E. Rusconi, op. cit., p. 96.
188 Citato in P. Paoletti, op. cit., 2003, p. 305.
189 R. Battaglia, Storia della Resistenza italiana, Torino, Einaudi, 1953 [nuova edizione 1964].
190 Battaglia, ad esempio, considera il cosiddetto referendum un plebiscito a favore della lotta e risolutivo per le indecisioni di Gandin.
169
Qualora non bastasse, ecco cosa disse alla Camera dei Deputati, in occasione del quindicesimo anniversario dell’eccidio di Cefalonia, il deputato Arrigo Boldrini, elemento di spicco della Resistenza, membro dell’allora PCI e figura importante dell’ANPI, di cui sarà successivamente presidente onorario:
Noi rendiamo ancora una volta, dopo quindici anni da quella giornata triste, onore e gloria ai caduti di Cefalonia. Essi rappresentano una grande inse gnamento nazionale per tutti noi ed elevano ancora una volta un monito ver so coloro che hanno dimenticato; essi hanno combattuto come noi abbiamo combattuto dopo, per una Italia libera, per una Costituzione democratica, per una paese che finalmente fosse in pace con tutti i popoli.191
Il tono è quello tipico delle celebrazioni, enfatico e con delle esagerazioni, soprattutto quando paragona i motivi della lotta della Divisione Acqui a quelli della guerra partigiana sulla penisola.
La resistenza della Acqui, nota infatti Rusconi, è ben diversa da quella opposta in Italia dalle forze partigiane le quali, come scrive Pavone, combatterono una triplice guerra: patriottica, cioè contro l’occupazione tedesca, civi le, in quanto condotta contro altri italiani, e di classe, in quanto portata avanti, soprattutto dall’ala comunista, contro quei ceti sociali nemici della classe ope raia che avevano permesso e sostenuto l’avvento del regime fascista.192
La liberazione nazionale, sostiene Rusconi, non era, e non poteva esse re, negli intendimenti degli uomini della Acqui.193
I moventi della Divisione Acqui, secondo il tenente colonnello Livio Picozzi che nel 1948 stese una relazione sulla base di testimonianze raccolte tra i reduci, furono la stanchezza della guerra e la voglia di tornare al più pre sto a casa per non dover più combattere né con l’una né con l’altra parte. Le ragioni, quindi, non sarebbero di ordine patriottico né riguarderebbero l’onore militare, incarnato nel motto degli artiglieri “sull’arma si cade, non si cede”. Una volontà di battersi alimentata poi dall’errata credenza di un imminente supporto militare dalla madre patria e dagli angloamericani.194
Per Rusconi, però, l’essenza della vicenda è più complessa e non può ridursi ad un’errata valutazione generale da parte degli uomini della Acqui, secondo la quale bastava resistere, anche momentaneamente, ai tedeschi per poter essere rimpatriati.195
191 Intervento di Arrigo Boldrini alla Camera dei Deputati nella seduta pomeridiana del 24 settembre 1958, reperibile all’indirizzo internet http://legislature.camera.it/_dati/leg03/lavori/stenografici/sed0031/ sed0031.pdf
192 Si perdoni qui l’estrema sintesi dell’elaborata analisi della guerra di liberazione fatta da Claudio Pavone nel suo ormai classico Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri, 1991.
193 G. E. Rusconi, op. cit., p. 113.
194 Idem, p. 99.
195 Ibidem.
170
Se interpretiamo bene la sua tesi, il soldato della Acqui non cede le armi al nuovo nemico nazifascista perché ciò lede la sua dignità militare e impedisce la possibilità di tornare a casa in sicurezza. Con la legittima scelta di combattere, egli ha rivendicato la propria identità di militare e la propria libertà, anche se i contenuti e gli istituti politici di questa libertà sono inde terminati. 196
Nicola Spagnolli
Nato a Rovereto nel 1977. Nel 2004 si è laureato in Storia presso l’Università di Bologna con una tesi in Storia della Scienza e della Tecnica nell’età Moderna e Contemporanea. Ha collaborato con il Laboratorio di formazione storica del Museo Storico in Trento. Dal 2005 è membro della commissione cultura del Comune d’Isera (Trento). Iscritto al secondo anno della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario di Rovereto per la cattedra di filosofia e storia nei licei, attualmente lavora presso il Polo di Rovereto dell’Università di Trento.
Bibliografia
E. Aga Rossi, Una nazione allo sbando. L’armistizio italiano del settembre 1943 e le sue conseguenze, Bologna, Il Mulino, 2003.
R. Formato, L’eccidio di Cefalonia, Milano, Mursia, 1968.
M. Franzinelli, Le stragi nascoste. L’armadio della vergogna: impunità e rimo zione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001, Milano, Mondadori, 2002.
G. Lombardi, L’8 settembre fuori d’Italia, Milano, Mursia, 1966.
M. Montanari, Cefalonia settembre 1943: La documentazione italiana, in G. Rochat, M. Venturi, (a cura di), La divisione Acqui a Cefalonia. Settembre 1943, Milano, Mursia, 1993.
G. Oliva, Si ammazza troppo poco. I crimini di guerra italiani 1940-1943, Milano, Mondadori, 2006.
P. Paoletti, I traditi di Cefalonia. La vicenda della Divisione Acqui 1943-1944, Genova, Fratelli Frilli Editori, 2003.
P. Paoletti, Cefalonia 1943. Una verità inimmaginabile, Milano, FrancoAn geli, 2007.
G. Rochat, La divisione «Acqui» nella guerra 1940-1943, in G. Rochat, M. Venturi (a cura di), La divisione Acqui a Cefalonia. Settembre 1943, Mila no, Mursia, 1993
196 Idem, p. 115.
171
G. Rochat, Ancora su Cefalonia, settembre 1943, in «Studi e ricerche di storia contemporanea», giugno 2005 (edizione digitale scaricata dal sito della ri vista http://users.libero.it/isrecbg/).
G. Rochat, Le guerre italiane 1935-1943. Dall’impero d’Etiopia alla disfatta, Torino, Einaudi, 2005.
G. E. Rusconi, Cefalonia. Quando gli italiani si battono, Torino, Einaudi, 2004.
G. Salotti, La tragedia di Cefalonia: un referendum per un massacro. La ri costruzione dei fatti in un rapporto ufficiale per il Ministero degli Esteri di Salò, in «Nuova Storia Contemporanea», 4/2001.
G. Schreiber, Cefalonia e Corfù settembre 1943: La documentazione tedesca, in G. Rochat, M. Venturi (a cura di), La divisione Acqui a Cefalonia. Set tembre 1943, Milano, Mursia, 1993.
G. Schreiber, I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich 1943-1945, Roma, Ufficio Storico SME, 1997.
G. Schreiber, La vendetta tedesca 1943-1945, Milano, Mondadori, 2000.
L. Viazzi, La sorte delle unità italiane in Grecia ed Albania dopo l’8 settem bre 1943, in G. Rochat, M. Venturi (a cura di), La divisione Acqui a Cefalo nia. Settembre 1943, Milano, Mursia, 1993.
172