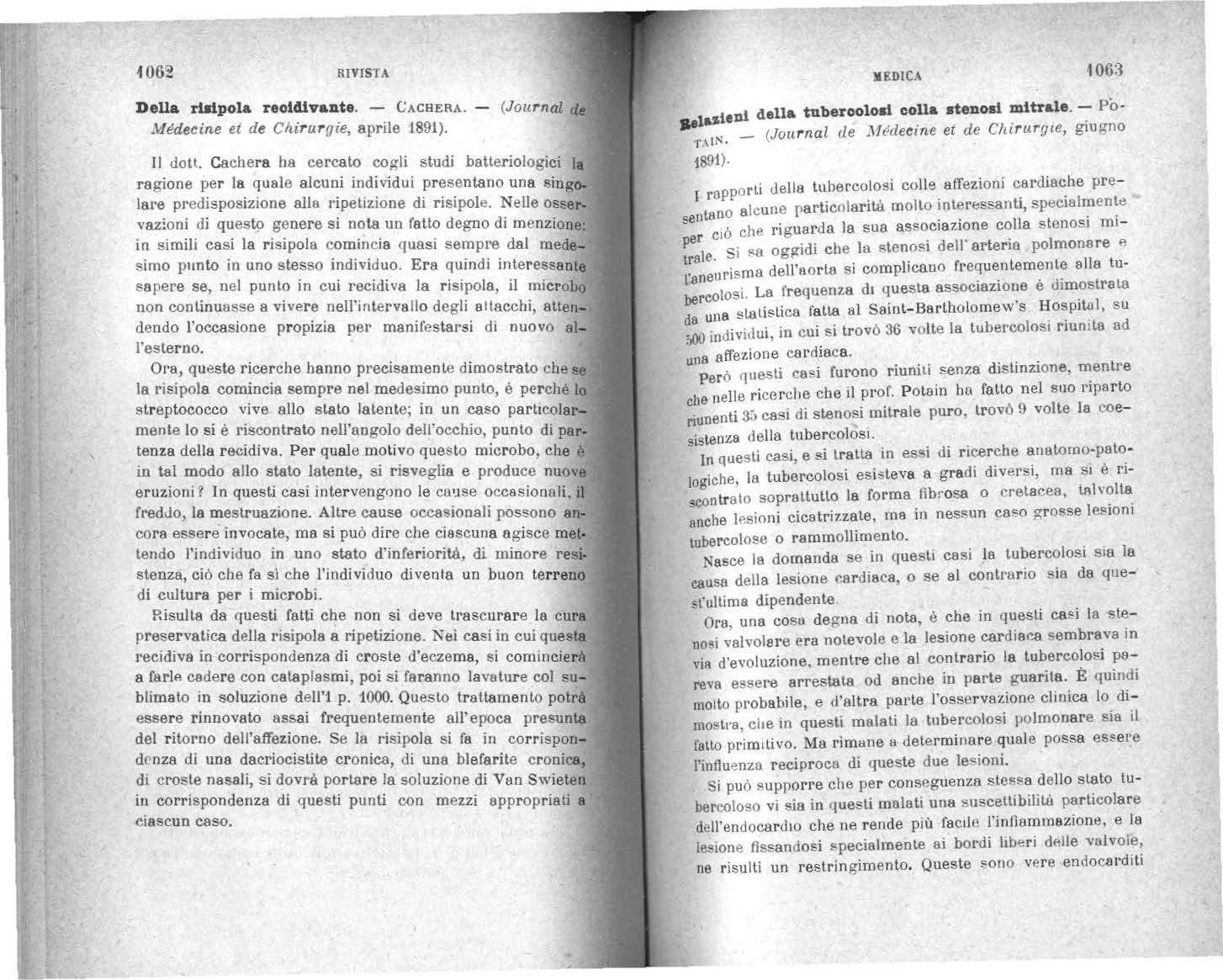
32 minute read
1063 RIVISTA
Della risipola reol41vante . - (;ACHERA.Médecine et de Chi r u r gie, aprile 1891).
Il dotl. Ca.chera ha cercalo cogli studi batteriologici la ragione per la quale alcuni individui presentano una sin golare predisposizione alla ripelizione di risipole. Nelle osse rvazioni di questo genere si nota un ratl-0 degno di menzione: in simili casi la risipola com incia quasi sempre dal medesimo punto in uno si.esso individuo. Era quindi interessante sapere se, nel punto in cui recidiva la risipola, il microbo non continuasse a vivere nell'intervallo degli attacchi, attendendo l'occasione pr opizia per manifestarsi di nuovo alreslerno.
Advertisement
Ora, queste ricerche banno precisamente dim ostrato cbe se la risipola comincia sempre nel medesimo punto, è perché lo str eptococco vive allo stal-0 latente; in un caso particolarmente lo si è riscontrato nell'angolo dell'occhio, punto di partenza della recidiva. Per quale motivo questo microbo, che è io tal modo allo stat-0 latente, si risveglia e produce nuove eruzioni? In questi casi inter veng,mo le ca•;se occasionali. il fredJo, la mestruazione. AHre cause occasionali possono ancora essere invocate, ma si può dire che ciascuna agisce mettendo l'individuo in uno stato d"infer iorità, di minore resistenza, ciò che fa sì che l'individuo diventa un buon terreno di cultura per i microbi.
Risulta da questi fatti che non si deve trascurar e la cura preser vatica della risipola a ripetizione. Nei casi in cui questa recidiva in corrispondenza di croste d'eczema, si comincie r A a farla cadere con cataplasmi, poi si faranno lavature col sublimalo in soluzione dell'1 p. 1000. Questo tr attamento potrà esser e rinnovato assai frequentemente ali' epoca presun ta del r itorno dell'affezione. Se la risipola si fa in corrispondrnza di una dacriocislite cronica, di una blefarite cronica, di croste nasali, si dovrà portare la soluzione di Van Swieten in corrispondenza di questi punti con mezzi appropriali a ciascun caso.
i nl della tubercolosi colla stenosi mitrale . - Po· ..1..,.. . .
_ (Jou rnal de Médecine et de Chirurgie, giugno 'f \lN• 1891 ).
P orli della tubercolosi colle affezioni cardiache pre- 1 rop · · · 1 ente alcune particolarità mollo mter~ssanll, spec1a m gentano . . . . - l · La frequenza d1 questa associazione e ù1mostrala I>erCO OSI. statistica fatta al Saint-Bartholomew's Hosp1tul, su da una · · ·t d · d. · 1u·1 1·0 cui "'i trovò 36 volle la tubercolosi rmni a a 50(} IO JVI{ ' una affezione cardiaca. . . . . . .
· · · clie riguarda la sua assoc1az1one colla stenosi m1 per CIO . le Si !"S ogp:idi che la !'.lenogi delr arteria polmonare e tra · . rna dell'aorta si complicano frequentemente alla tu· raneur1s . .
Però questi casi furono rmmu senza d1stmz1one, ~entre cbe nelle ricerche che il prof. P otoin bo fatto nel suo riparto . t· 3·, casi di stenosi mitrale puro, trovò 9 volle la coe- r1unen 1 • sisteoza della tubercolosi.
In questi casi, e si tratta in essi di ricerche anatoroo-pal~Jogiche, la tubercolosi esisteva a gradi diversi, ma s1 è riscontrato soprattutto la forma fibrosa o rrelarea, lalv~I~ anche lesioni cicatr izzale, ma in nessun caso gr osse Jps1om tubercolose o rammollimento. .
Nasce la domanda se in questi casi la tubercolosi sia la causa della lesione rardiaca, o se al contrario sia da que~t·uJtima dipendente
Ora, una cosu degna di nota, è che in questi casi la sl~osi valvolare era notevole e la lesione cardiar.a sembrava m o • vili d'evoluzione, mentre che al contrario la tubercolosi poreva essere arrestata od anche in parte guarita. È quindi motto probabile, e d'altra pal'te l'osservazione clinica lo_ di~ mostra, che in questi maiali la tubercolosi polmon are sia 11 fallo primitivo. Ma rimane 1:1 determinar e quale possa essere l'influenza reciproca di queste due lec;ioni.
Si può suppo rre che per cons~guenza stessa dello stato tubercoloso vi sia io questi malati una suscellibilit.ù pa rticolare dell'endocard10 che ne rende più facile l'infiammazione, e la lesion e fissandosi specialmente ai bordi liberi df'lle valvole'. ne risulti un restringimento. Queste sono vere endocarditi
MEDICA 4061>
infettive, legate ad una affezione cronica tubercolosa, se che si possa affermare per altro che la lesione endocard i stessa sia tubercolo!:'a.
Prodotta che sia quosta lesione, si stabilisce una specie antagonismo tra le due malattie; perche l'affezione ca rdià ha una tendenza ad arrestare i proi:rressi della tubercolosi questa ragione che le stasi polmonari non sono favorevoli suo sviluppo. Ciò che pare ben dimostrato, è appunto nelle I sioni cardiache producenti l'ischem ia del polmone com e I stenosi dell'arteria polmonare, che si vedono sopraggiunge le grosse lesioni della tubercolosi.
Quando la stenosi della mitrale è abbastanza accentua per produrre i suoi effetti, pare che il processo 1,>olmonare arresti e si ha sotto gli occhi un quadro sintoma tico i ' tratti sono sempre presso a poco i medesimi: i malati so quasi sempre donne, nate da genitori tubercolosi, che, ne loro adolescenza, sono ritenute per clorotiche e sospettate t bercolose; in r·ealtà, esse sono nel primo periodo di qu mall'ltlia, poi si produce la lesione cardiaca; ess1-1 si accent a poco a poco, mentre i fenomeni di lubi!rcolosi dimi,,uisco ed i maiali finiscono per morire nell'asistolia. Si vedo que,;Li falli prodursi co~ì soventi, che si può conchiudere eh la slenosi delta mitrale, così speciale nel suo decorso, co differente nel suo aspetto clinico dalle altre lesioni cardi acb non è che una manifestazione particolare della tubercolosi; diretta o indiretta.
L'associazione della tubercolosi colta stenosi della m i tr11 1 deve quindi essere considerata in rnodo del tut.to differente daì ciò che si osserva nella stenosi della polmonare o nell' a r,eurisma dell'aorta, in cui questa associazione è anche fre.. quenle, ma di naLura assolutamente opposta.
Un'a ltra conclusione, dal punto di . vista terapeulìco, è che nella steno,i della mitrale, almeno nel suo primo periodo, sarebbe piuttosto gi ustificata una medicazione antitubercolare se ne esistesse una, anziché qualsiasi altra.
Ma prodottasi la lesioni, la cura consiste nelradattare J'at • tivita. del malati allo stato d'insufficienza del suo org-a110.
L'esercizio troppo attivo, la ginnastic11 che i tedes~hi eri-
,, no a met•)do generale nei cardiopatici, sono quindi in questi .,o · controindicati. Ciò che devesi dapprima combattere é la cas1 bercolosi polmonare, che quantunque arrestata, può antu · t' ra esercitare una certfi influenza sul cuore; poscia so .ocO rre il malato ad una igiene che può esser e espressa nella r:rmula seg-uente: lasciare il malato all'aria nella tranquilli~; erciò, il soggiorno in un clima dolce, senza essere costretlt a ~forzi musc0lari, è ciò che vi ha di più favorevole. .
La medirazione arsenicale e iodurala può anche essere utile; ;,fortunatamente non si devono fare molte illusioni sul ris~lt to· la stenosi della mitrale non è compatibile con una vita a ' I . molto lunga. perché si riscontra raramente questa estone negli individui attempati.

B,apportl dell'influenza ooll'a.llenazlone mentale.
LEDY - (Jou rn al de Médecine et de Chirurgie, 1~91 ).
- LEgiugno
È interessante constatare che, dal punto di vista speciale della sua influenza sulla produzione dell' alienazione mentale, l'iofhrnnza agisce esattamente come le altre malattie infettive. Leledy, avendo notato nel manicomio di Beaureaard un aumento considerevole nel numero de~Ji entrati al ~omento de!l'epidemia d'influenza, ha cercato di stabilir e i rapporti che esistono tra l'alienazione mentale e le malattie acute, e più specialmente l'influenza. Egli giunse alla conclusione che per lo stesso motivo delle altre malattie infettive, come il vaiuolo , la febbre tifoidea, la difterite, l'influenza può essere l'occasione di una psicopatia, e che riuestA, senza speciale sintomatologia. può assumere tutte le forme del delirio vesanico. La pazzia così prodotta può sopraggiungere nei diversi perjodi della malallia, -ma in nessun caso si può considerare l'influenza come causa patogena; la sua azione è unicamente occasionale o adiuvante ed essa non agisce che !:'ugli individui predisposti.
La durata della pazzia così pr odotta è tanto più breve e la guarigione tanto più frequente, quanto più la predisposi· zione è meno accentuata. Negli altri casi la pazzia può p sare allo stato cronico e diventare incurabile. Un punto interessante della pazzia post- grippale è che · . . h Ul certi casi essa a potuto dar luogo a questioni medico-I ga li in conseguenza della forma omicida del delirio. A q ues riguardo un caso citato da Ladame presenta un grand e i teresse. Un giovane, la cui condotta era sempre stata regolare, ma che però era alquanto ipocondriaco è colpito d . tl ' a 10 .ueoza contem~oraneamente ad una sua giovane s orella; egh la vede morire e ne prova un p r ofondo dispiacer e Egli r1~ane colla madre e lutto ad un tratto una ser a, mentre egh era . solo con essa, Hfferra un a scure e la uccide. Quand~ v1e~e arrestato, egli ha per duto completamente la memoria ò1 questo atto. L'irresponsabilità, manifesta ill:) questo caso, non potè e ssere cosi facilmente precisata irt altri fatti dello stesso ordine. lllanifestaziont polmonari della. gotta . - PoTAIN - (Jour-. nal de J,Jidecine et de Chiru r gie, giugno 1891).

Quantunque ancora discusse da alcuni autori , le manifestazioni polmonari della gotta sono freque n ti.
Quelle che si osservano più spesso sono forse o-fi a ccid~nti asmatici, i cui accessi possono alterna r si cogU a ccessi d1 gotta, per morlo che non .s i può met~er e in dubbio la loro natura . Ma vi sono però individui, nei qu a li !'li osservano bronchiti di forma assa i pa r t icolare co n i car atteri del catar-r~ detto secco, pr esen tantisi sotto fo r ma d i parossismo e particolarmente nel momento delle stagio ni asciutte. Devesi notare che nei gottosi soventi l'asma non si presenta contempor aneamente agli accessi; esso può osserva r s i molto tempo prima e può anche r iscontrarsi in fa nciulli prima chu 1 lo r o genitor i abbiano avuto il loro p r imo accesso di g oUa .
In un malato del r iparto del prof. P otain, gottoso e d in ~r eda. aJ avvelenamento di piombo, esisteva un'a ltra mani1e staz10n e g?ttosa, vale a d ire la congestione polmonar e, ma una congest10ne che d ur ava da tre settima ne ci r ca e pre~en:ava la particolarila di essere compa r sa senza causa ap- ezzabile, mentre il malato teneva il letto e nel momento pr ('Ui la flogosi gottosa del dito diminuiva.
10
Q~este congestioni polmonari, la cui natura gottosa può d'altronde essere difficilmente stabilita, possono presentarsi sotto tre forme abb~staoza speciali.
La prima. la fluss10ne acuta, prende l'aspetlo della splenoolmonite: anche essa è soventi confusa colla pleurite; come ~arattere speciale, essa non presenta che la rapidità colla quale compare e scompare.
10 una seconda forma, si vede stabilir si uno stato conges!i v'o cronico della base del polmone, con iper secrezione leggera e rantoli sotto-cr epitanti fini in ambedue i lati: a questa forma s i possono r iferire quei fenomeni che Colin ha d'lscritto sotto il nome di congestione a r tr itica e caratterizzati dalla presenza di rantoli fini per sistenti per molto tempo nella parte inferiore dell'ascella.
Infine, in una terza fo r ma, si osse1'va uno stato cronico che sopragg-iunge ora di p r imo a cchito e lentamente, ora per attacchi acu ti; ma •questa forma occupa le soromità dei polmoni. Si osser vano infatti, tra i gottosi ereditar ii, individui nei quali si vedono nella gioven lu prodursi fenomeni da parte delle sommità, con espetto r azione sanguinolen ta e con tutti i segni stetoscopici della t ubercolosi al primo g r ado.
A questo momento è ben difficile pronunciarsi s ulla diagnosi: in f!ene r ale que sti feno me ni durano alcune settimane, poi si dissipano, per ripr odursi nell'anno successivo e !iÌ hanno soventi cinque o sei attacchi successivi, finché si vedono sopraggiungere accidenti di tubercolosi incontestabile .
Spumi oloniol della faringe . - Bou vERET. - (Jour nal de J1.édecine et de Chirur gie, luglio 1891).
Bouveret ha des cr itto sotto questo nome un fenomeno singolare da lui osserva to in una isterica e che consiste in movimenti di deglutizione rapidi, convulsivi, accompagnati da rumor i faringei, i q ua li sopraggiungono per accessi e tra ggono nello stomaco abbastan za a ria per produrvi un vero timpanismo. Di quando_in quando un'eruttazione rumor osa espelle
H)68 RIVISTA
una parte dei gas che distendono lo stomaco, di modo che l'a cesso si compone di una serie di movimenti di deglutizione i terrotti da qualche eruttazione. Questi spasmi dei musco dell~ deglutizione sembrano dipendere da un'eccessiva ipe stes1a della muco!:'a della faringe.
. L'affezione si presenta sotto forma di accessi che comi n c'.ano p~co dopo il risvegliarsi ed i movimenti di deglutì z10ne s1 farmo allora 40 a 60 volte per minuto. Ciascu accesso dura due a tre minuti e ciascun movimento di de~l u • t> z10ne e accompagnalo da un rumore sonoro, inteso a di stanza.
La deglutizione dell'aria in grande abbondanza non p esser messa in dubbio e violente eruttazioni espellono quando in quando una parte dell'aria così accumulata. Questi spasmi hanno una grand e analogia con altri fon meni spasmodici dell'ister·ismo, come la tosse, il singhio e lo sbadiglio isterici, e presentano anzi ad un certo grado 1 ritmo e la cadenza che Charcot considera come un caratte proprio ad un gran numero di fenomeni isterici.
Avvelenamento prodotto da.ll'antlpirlna . - B1GGS. - ( zette des Hòpita11x, N. 73, 1801).
Biggs ba riferito un caso d'avvelenamento sopraaaiun • t>t, m un malato molto robusto, di trentacinque anni, ed affet da angina erpetica con febbre elevata. Questo malato pr in 30 ore 4 grammi d'antipirina, a dosi frazionate ogni quat ore. Gli accidenti tossici si manifestarono soprattutto sull' a parato renale: orine verdastre, torbide, contenenti albumi globuli rossi, dlindr-i; queste modificazioni dell'orina che ' , minata poco prima, era stata trovata perfettamente norm ai sembrano dvvuti all 'antipirina. Esse persistettero per quatt giorni dopo la cessazione del medicamento. Un fatto degno nota è che il malato aveva, in varie riprese, preso anlip· rina per emicranie, senza risentire accidenti tossici.
Biggs ha segnalalo varii altri accidenti: eruzioni cutane paresi cardiache, disturbi n~rvosi diversi, prodotti dall'anlipi rina. Questi accidenti "ono talvolta com pa rsi con dosi di 60 cer
Medica 1069
tigratnroi ad t gramma. Talvolla anche, l'antipirina aveva po. tuto essere somministrata per lungo tempo a forti dosi, e 111 entre che la tolleranza sembrava perfettamente stabilita, comparvero bruscamente gli accidenti, senza aumento della quantità di medicamento presa . Biggs crede, con Huchard, che l'antipirina è controindicata ogniqualvolta esiste una lesione renale. È specialmente quando una affezione febbrile (polmonite, febbre tifoidea) sopragoiunge in malati affetti da nefrite o si complica essa stessa a ~efrile, che fa d'uopo evitare di somministrar e l'antipirina ad alte dosi come antipiretico. I reni, sopraccaricati di già dall'eliminazione delle toxine febbrili, resisteranno male a questo aumento di lavoro causato dall'eliminazione del medicamento. secondo Drescher, l' antipirina apporterebbe d'altronde, sempre , una diminuzione della secrezione renale. Io due casi anzi essa avrebbe prodotta la ritenzione. Peter ha riferito una osservazione di febbre tifoidea, in cui la morte pare sia stata causata da accidenti d'uremià, prodotli dall'antipirina.
L'uso troppo prolungato dell'antipirina sarebbe egualmente pericoloso. Portes crede che questo medicamento, continuato per mollo tempo ed a forti dosi, può cagionare degenerazioni grassose del fegato e dei reni.
Della pollaohlurla. psicopatica. - Gu:ARD. - (Journal d e Médeeine et de Chirurgie, giugno 1891).
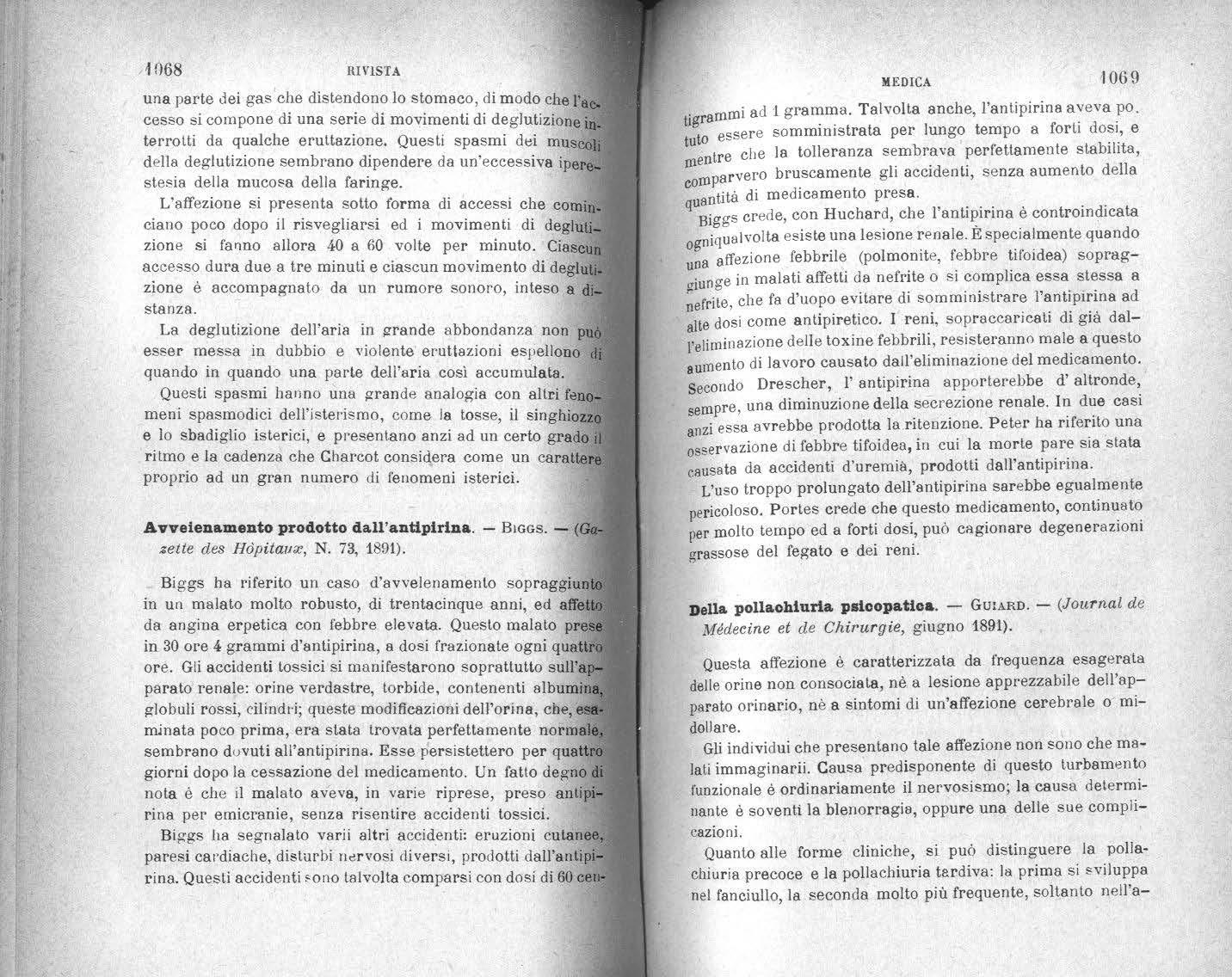
Questa affezione è caratterizzata da frequenza esagerata delle orine non consociata, nè a lesione apprezzabile dell'apparato orina.rio, oè a sintomi di un'affezione cerebrale o midollare.
Gli individui che presentano tale affezione non sono che malati immaginarii. Causa predisponente di questo turbamento funzionale è ordinariamente il nervosismo; la causa determinante è soventi la blenorragia, oppure una delle sue complicazio ni.
Quanto alle forme cliniche, si può distinguere la pollachiuria precoce e la pollachiuria tardiva: la prima si sviluppa nel fanciullo, la seconda molto più frequente, soltanto nell'a- dulto. È quasi esclusivamente diurna e raramente diurna e notturna nello stesso tempo. Non è raro che esso scom · Pilla momentaneamente, quando i maiali sono distolti da un• 0 ,.,. . ""'upaz1one qualunque. Il numero delle emissioni, nelle 24 ore arriva ad una cifra considerevole, 30 e 40 volte e tal v 1•: l .. O oca anc 1e pm.
. La diagnosi è abbastanza facile, ma richiede per altro atte h . . z10ne, pere e quasi s_empre questi malati sono curati lungamente per una affezione della vescica che essi non hann ~uesta ?iagnosi si fonda innanzi tutto sul fatto che nul: spiega la frequenza dell'emissione dell'orina. Le orine sono perfettamente chia1:e; la ves~ica non è sede di alcun dolore, anche _quando la s1 preme direttamente contro il pube colla p~lpaz,one rettale o vaginale, ed infine essa è dilatabile e puo ricevere una quantità considerevole di liquido. Inoltre l'interrogatorio e l'esame fanno constatare che anche i reni sono sani. Viene accertato egualmente che le orine non contengono nè zucchero nè albumina. Non rimane più che a studiar e il malato sotto il punto di vista del sistema nervoso ed a riscontrare se non presènti alcun segno di un'affezione midolla re 0 cerebrale. Se tutte queste ricerche riescono negative, si pu6 esser certi che si tratta di pollachiuria psicopatica.
Vi sono però malati che possono offrire l'insieme di quest s~essi caratteri clinici. Questi sono i prostatici nel primo periodo. Si sa infatti che questi malati emettono orine perfettamente chiare, che la loro vescica non é dolorosa alla pres sione, che essa si vuota e che può, nella giornata, contenere una notevole quant-ita di liquido. Ciò che li caratterizza, è che la frequenza dei bisogni, di cui si lamentano, è unicamen te notturna, mentre che avviene il contrario nei nevropatici. Di più essi sono d'età avanzala, hanno per lo meno 55 anni: quasi sempre i psicopatici sono molto più giovani ed in tutti i essi hanno cominciato a risentire tale disturbo prima di quesl.a età. Infine, nei prostatici, anche nel primo periodo, la palpazione della prostata rivela ordinariamente un aumento divolume della ghiandola.
Stabilita la diagnosi, Guiard combatte questo turbamento puramente immaginario, indirizzandosi, quanto più viva mente
MEDICA 107·1
li è possibile, all'immaginazione, alla ragione del malato. È ~ecessario dapprima dimostrargli che la sua vescica può rice\'ere senza difficolté. un'iniezione di 300 a 400 grammi di una soluzione d'acido borico. Ritirala la sonda, si invita il malato a trattenere qualche momento nella sua vescica il liquido inieUato stando in piedi o camminando. li malato constata che ciò è possibile ed anche facile. Ora siccome la quantità di orina emessa nelle 2i ore non oltrepassa di molto 1200 a 1500 grammi ed egli di ciò può facilmente assi.curarsene su di sè stesso, così il m1:1lato arriva ben presto alla conclusione che nelle 24 ore possono bastare 4 o 5 emissioni d'orina. Ciò dimostrato, si consiglia al malato di trattenere l'orina dapprima per 4 ore almeno, ed in seguito per 5- 6 ore. sarebbe invece imprudente e pericoloso consigliare questa ritenzione ad individui affetti da cistite o da prostatite.
Stato del ouore nell'anemia; origine del soffio polmonare. - HENRY HANDFORD. - (Archives médicales Belges, marzo 1891).
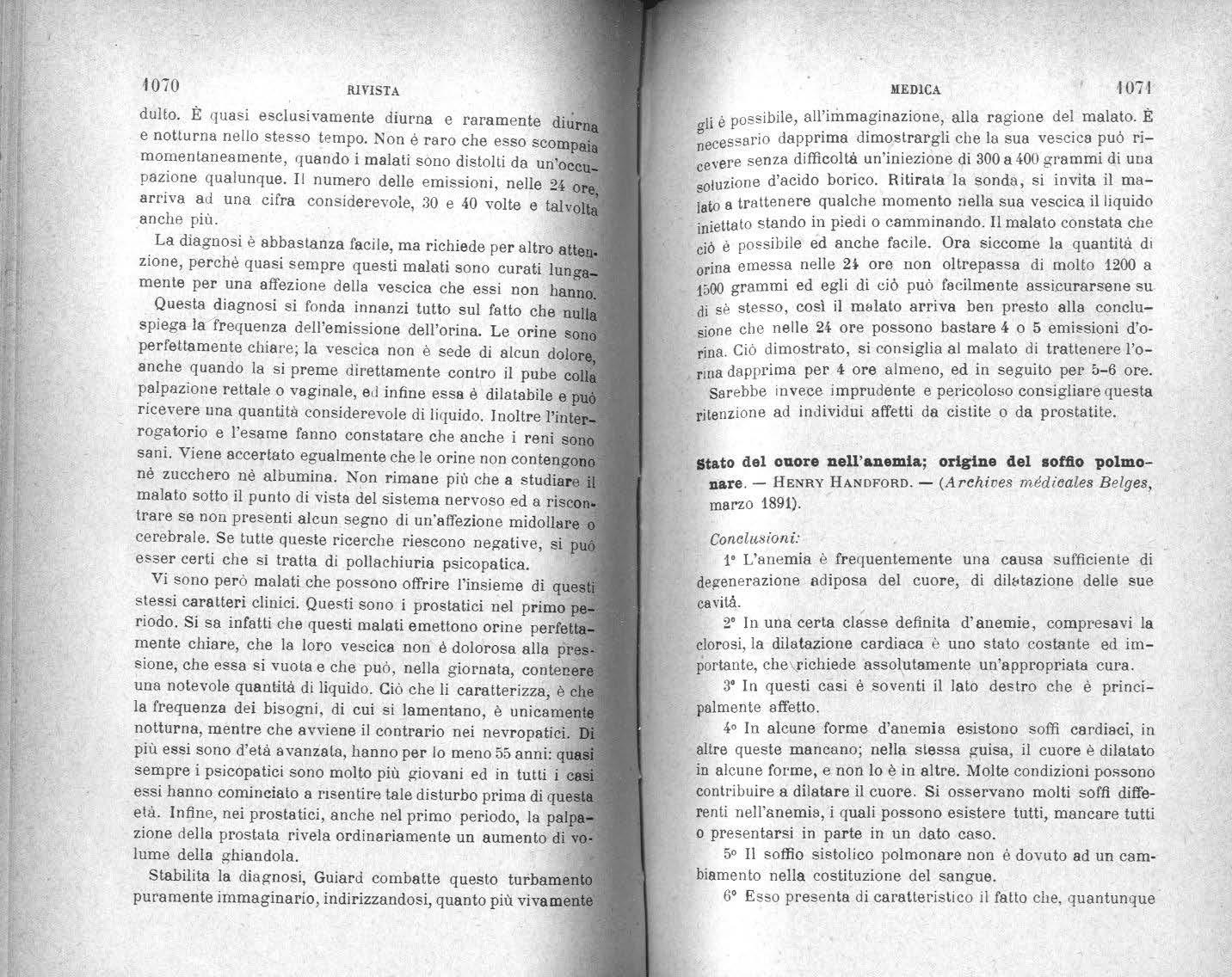
Conclusioni:
1° L'anemia è frequentemente una causa sufficiente di dep;enerazione adiposa del cuore, di dil~tazione delle sue ca vita.
2° In una certa classe definita d'anemie, compresavi la clorosi, la dilatazione cardiaca è uno stato costante ed importante, che\I'ichiede assolutamente un'appropriata cura.
3° In questi casi è soventi il lato destro che è principalmente affetto.
4° lo alcune forme d'anemi a esistono soffi cardiaci, in altre queste mancano; nella stessa guisa, il cuore è dilatato in alcune forme, e non lo è in altre. Molte condizioni possono contribuire a dilatare il cuore. Si osservano molti soffi differenti nell'snemis, i quali possono esistere tutti, mancare tutti o presentarsi in parte in un dato caso.
5° Il soffio sistolico polmonare non é dovuto ad un cambiamento nella costituzione del sangue.
6° Esso presenta di caratteristico il fatto elle, quantunque
11072 lUVJSTA sia suscettibile di esse r e inteso dapperlullo, ha il su0 massimo d'inte nsita nel 3° e s oprattutto nel 2' s pazio di !<inistra, in vic inanza dello sterno ; inoltre esso diventa sempre meno.: forte e scompare soventi del tutto nella posizione eret ta . s• Il soffio polmonare, anche quando fosse molto intenso nelle f}ltre re~ioni nel decubito, pu ò essere facilmente, per questa prova della posiz ione, distinto dai veri soffi d'i nsurficienza dovuti al rilasciamento dei muscoli cardiaci, alla di• latazione dei suoi orifici, alle lesioni valvolari.
7° Il soffio polmonare sistolico è dovuto alla pression sull'arteria polmonare di un cuore dilatato, floscio ed ing randito.
9• Quando esistor.o nell'anemia soffi su tutti i focola i che non sono dovuti a lesioni permanenti, essi scompaiono i un ordine definilo durante la convalescenza, dapprim a il tricuspidale, poi il mitrale, poi l'aortico ed infine il polmonare.
10° È probabile che in alcune dilatazioni origine anemica, quest-1 possano condurre ad fezione permanente del cuore.
L& ep1staBB1 nell& malattia dl Brlght - LA VERNY.(Journal de Médecine et de Chirurgie, luglio 1891).
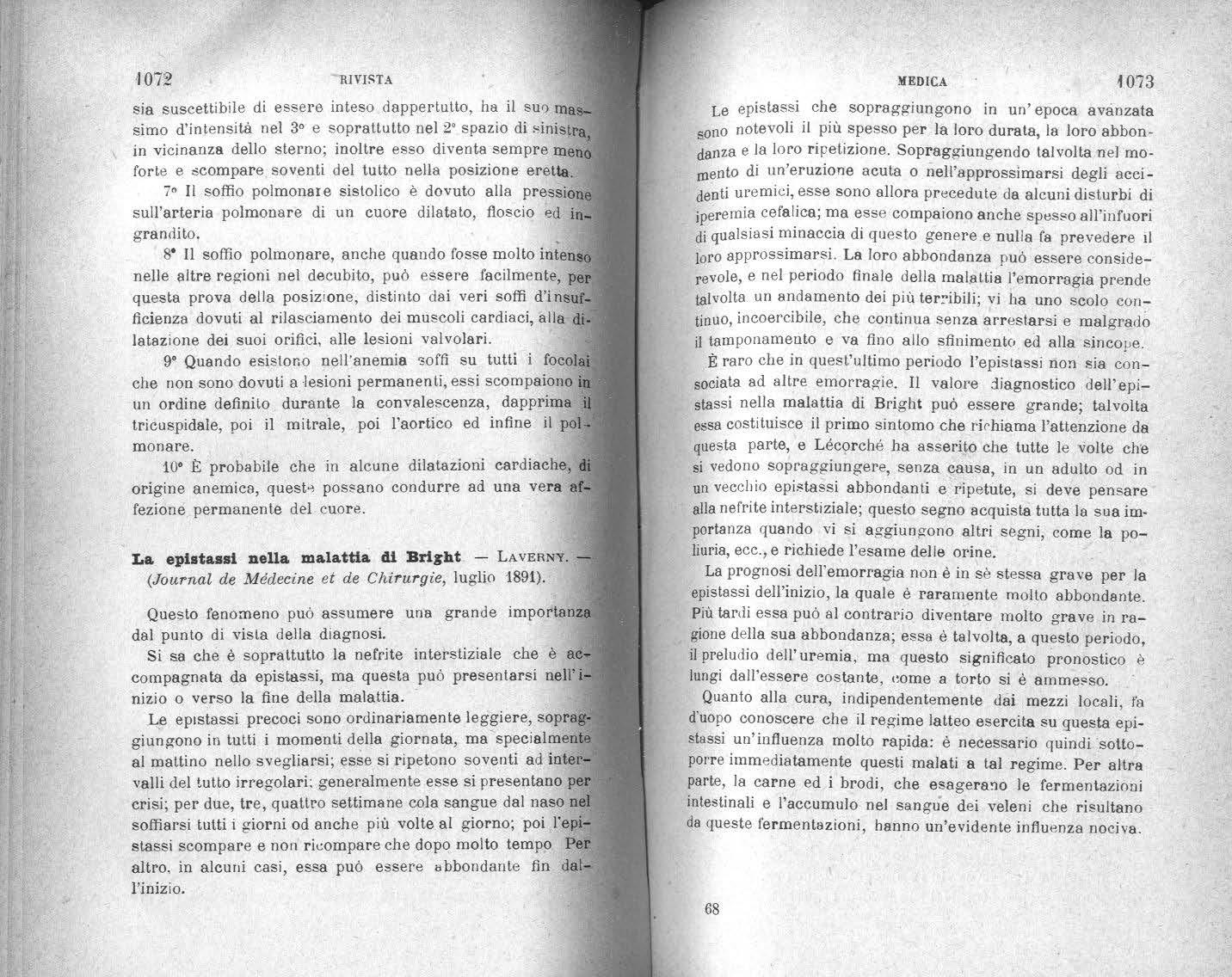
Questo fenomeno può assumere una grande dal punto di vista della diagnosi.
Si s.a che è soprattutto la nefrite interstiziale che è ae..... compagnata da epistassi, ma questa può presentarsi nell' i nizio o verso la fine della malattia.
L,e epistassi precoci sono ordinariamente leggiere, sopr aggiungono in tutti i momenti della giornata, ma specialmente al mattino nello svegliarsi; esse si ripetono soventi ad intervalli del tutto irregolari: generalmente esse si presentano per crisi; per due, tre, quattro settimane cola sangue dal naso nel soffiarsi tutti i giorni od anche più volle al giorno; poi l'epistassi scompare e non rit.:ompare che dopo molto tempo Per altro, in alcuni casi, essa può essere i;bbondanle fin da tl'inizio.
Medica W73
Le epist.a ssi che sopraggiungono in un'epoca avànzata sono notevoli il più spesso per la loro durata, la loro abbondanza e la lo ro ripelizione. Sopraggiungendo lalvolla ne l momento di un' eruzione acuta o nell'approssimarsi degli accidenti ure mic i, esse sono allora precedute da alcuni disturbi di ipere mia cefalica; ma esse compaiono anche spi,s1,o all' infuori di qualsiasi minaccia di questo gene re e nulla fa prevedere 11 loro approssimarsi . La loro abbondanza può essere considerevole, e nel periodo finale della malattia l'emorragia prende talvolta un andamento dei più ter.'.'ibili; vi ba uno scolo continuo, incoercibile, che continua senza arrestarsi e malgradÒ il tam ponamento e va fino allo sfinimento ed alla sinco pe. È raro che in quest'ultimo periodo l'epistassi non sia consociata ad altre emorragie. Il valore jiagnostico dell' epistassi nella malattia di Bright può essere grande; talvolta essa costituisce il primo sintomo che rirhiama l'attenzione da questa parte, e Léc9rch é ba asserilo che tutte le volte che si vedono sopraggiungere, senza causa, in un adulto od in un vecc hio epi:::tassi abbondanti e ripetute, si deve pensare alla nefrite interstiziale; questo segno acquista tutta la sua importanza quando vi si aggiun~ono altri s è gni, come la poliuria, ecc., e richiede l'esame delle orine.
La prognosi dell'emorragia non è in s è stessa grave per la epistassi dell'inizio, la quale é raramente mollo abbondante. Più tardi essa può al contrari0 diventare mollo grave in ragione della sua abbondanza; essa è talvolta, a questo periodo, il preludio dell'uremia, ma questo significato pronostico è lungi dall'essere costante, 1:ome a torto si è amme:::so.
Quanto alla cura, indipendentemente <lai mezzi locali, fa d"uopo conoscere che il regime latteo eser cita su questa epistassi un'in_fluenza molto rapida: è necessario quindi ·sottoporre imme diatamente questi malati a tal regime. Per altra parte, la carne ed i brodi, che esagera!'lo le fermenlazioui intestinali e l'accumulo nel sangue dei veleni che risultano da queste fe r mentazioni, hanno un'evidente influenza nociva.
llota sul ritardo del pols o oarotldeo nell' lnaufflota: a ortl oa . - GASTON Lvo:-.. - (G~ette des Hòpitauz, N. 7 1891).
Il ritardo del polso negli aortici è !:!Lato segnalato nel 18at Mare Despine, e nel 1837 da Henderson, il quale non con sceva le ricerche francesi. Hendc r s on riscontrò cinque ca in cui l'intervallo lra la contrazione del cuore e il polso de arterie periferi che era abbastanza considerevole rerchè pulsazione radiale alternasse con la sistole ventricolare; e diede a questo segno una grande importanza. Nega to Aran, considerato da Requin come puramente fisiologico, Grisolle come non particolare àll'insufficienza eortica, il a, tardo del polso è s tato studiato in modo speciale dal pro sore Tripi er, il quale cercò di constatare il ritardo in un pun del sistema circolatorio mollo vicino al cuore, sulla car otid egli trovò questo ritardo nAll'insufficienza aortica ed io qu malattia soltanto; egli fece noi.are inoltre che l'esistenza questo segno indica che l'insufficienza é grave; esso ma infatti nell'iuizio della malattia, quando l'insufficienza è pronunciala. Fr. Franck volle verificare il ritardo caro· segnalalo da Tripier e formulò conclusioni opposte a que del profes«ore di Lione: per lui il ritardo del polso, nell'i ns ficienza aortica, è, al contrario, minore che allo stato tìsio gico (6/ 100 di secondo invece di 9/ 1~. Rivals, in una tesi so nuLa a Bo1·deaux (1883) si dichiarò dell'opinione di Frank; Ri vals • la di minuzione del ritardo del polso è esagerata l'insufficienza aortica, perchè non solamente, in questo il ritardo prodotto dal tempo necessar io al sollevamento sigmoidi é soppresso, ma anche la contrazione ventr ico essendo più energica e la pressione mediana conse rva l'onda sanguigna si trova lanciata con un'impulsione grande nella circolazione. •
Germain Roque, allievo di Tripier, in una tasi sostenuta Lione nel 1886, ha ripr eso la questione e dimostrato, coll'a poggio di prove cliniche e fisiologiche, che il r itardo caroti segnalato da Tripier esiste realmente ed ha precisato i in cui esso si riscontra. Nel suo lavoro Tripier riferiva che
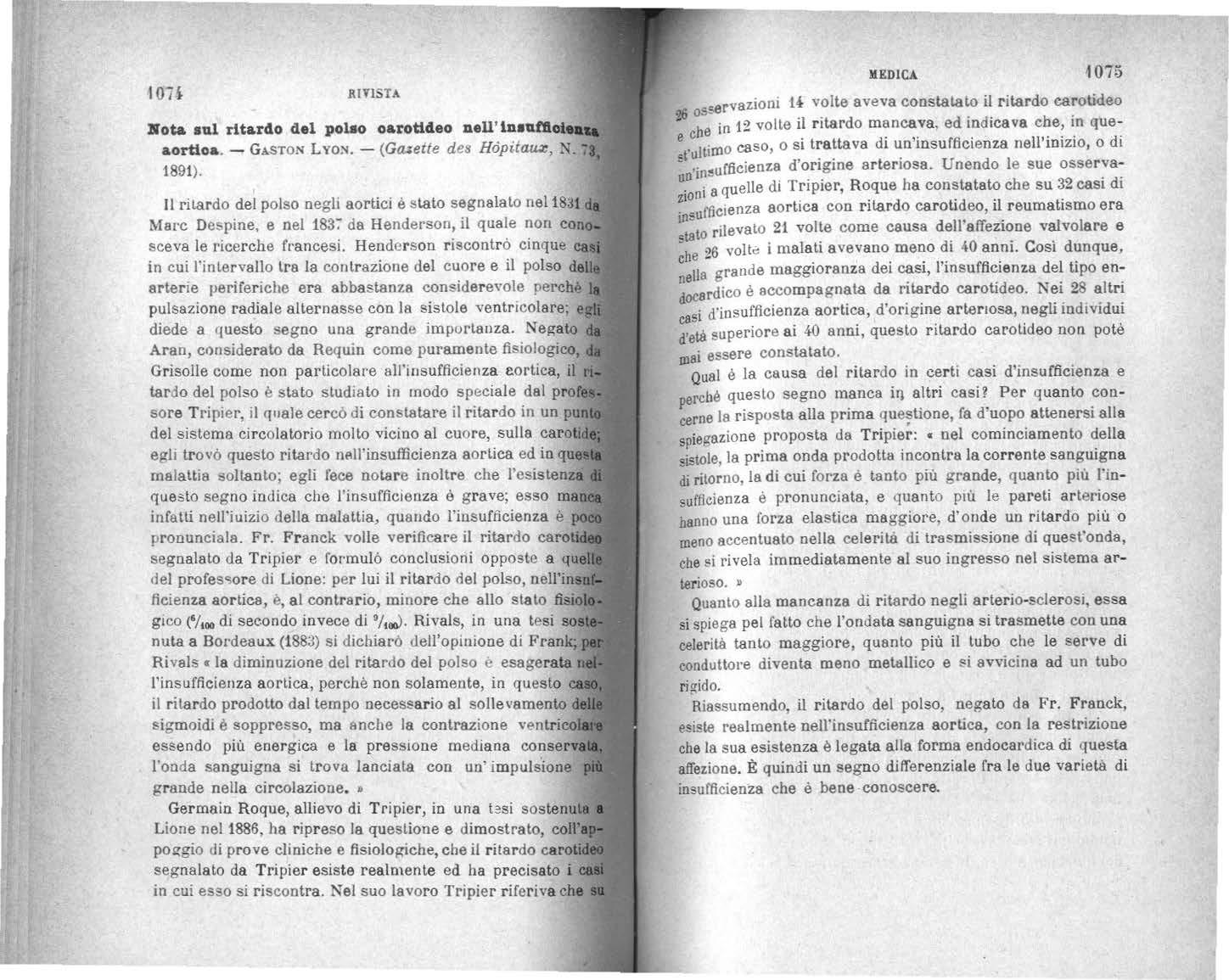
Hed1ca 1075
:Zii osservazioni 14 volte aveva constala lo il ritardo ca~olideo che in 12 volle il ritardo m~nca_va, ed i~dicava c.~e'. 1_n que~ e . ltiroo caso, o si trattava d1 un'msurfic1enza nell 101z10, o d1 ~tu t . u d l ~o·in:iufficienza d'or1gme ar er1osa. nen o e sue o 2 sser:ad~ i 8 quelle di Tripier, Roque ha constatato che su 3 casi 1 zion · ·ta d t·d il t· insufficienza aortica con r1 r o caro 1 eo, . reuma 1smo era 10 rilevalo 21 volte come causa dell'affezione valvolare e s:e 26 volte: i malati a vevano meno di 40 anni. Cosi dunque, c lla grande maggioranza dei casi, l'insufficienza del tipo en~~ardico è accompagn~ta da r!~rdo carotideo. N~i. 28 _ ~ltr~ si d'insufficienza aorllca, d'or1gme arteriosa, negli md1v1dUl :.età superior e ai 40 anni, questo ritardo carotideo non potè lllai essere constatato. Qual è la causa del ritardo in cer ti casi d'insufficienza e perché questo segno m~nca iq a Jtri casi i, Per quanto ~oncerne la risposta alla prima q ue~tlone, fa d uopo attenersi alla spiegazione proposta da Tripier: • nel cominciamento della sistole, la prima onda prodotta incontra la corrente sanguigna di ritorno, la di cui forza è tanto più grande, quanto più l'insufficienza é pronunciata, e quanto più le pareti arteriose banno una forza elastica maggiore, d' onde un ritar do più o meno accentuato nella celeri la di trasmissione di quest'onda, che si rivela immediatamente al suo ingresso nel sistema a rterioso. »
Quanto alla mancanza di ritardo negli arterio-scleros,, essa si spiega pel fatto che l'ondata sanguigna si trasmette con una celerità tanto maggiore, quanto più il tubo che le serve di conduttore diventa meno metallico e s i avvicina ad un tubo rigido.
Ria ssumendo, il ritardo del polso, negato da Fr. Franck, esiste realmente nell'insufficienza aortica, con la restrizione che la sua esistenza è legata alla forma endocardica di questa affezione È quindi un segno differenziale fra le due varietà di insufficienza che è bene conoscere.
Epldemlologla del morbillo .
Hòpitaux, N. 69, 1891).
Conclusioni.:
1• I germi del morbillo hanno du rata abbastanza b perché si abbia a temere l'infezione persistente dei I degli oggelli usati dai malati, e perché i provvedi men disinfe zione alla fine della malattia siano assolularn inutili.
2• Il periodo d'incubazione, calcolando dall'i nfezione eruzione, é di 13 a 14 giorni nella grande m11ggioranza casi, tuttavia esso può abbassarsi eccezionalmente a 12, pure può elevarsi a 18 giorni e ror,se anche a 21, nei ea recellività diminuita da un attacco precedente.
3' Il contagio è possibile 3 giorni, forse anche 4 gi prima dell'eruzione, ma non più presto; nei fanciulli la in contatto durante tutto il periodo preeruttivo, esso av ordinariamente due giorni prima dell'eruzione e le er del con tagionante e del conlagionalo si succedono all 11 giorni d'intervallo.
4• La contagiosità é talmente potente che quando un lagionanle nel periodo preeruttivo è messo con fanciulli coi multipli contatti di una esistenza comune, tutti quali presso a poco, che sono suscettibili di essere attaccati, ::;ooo dal contagion&nte; per modo che, se non sopraggi gono individui nuovi, l'epidemia si arresta il più spesso di se stessa dopo la prima esplosione. Non si osserva ecce · che nei fan ciulli, la di cui r ecetLività è indebolita da un a anteriore, i quali possono sfuggire all'influenza di più co gionanti e finire tuttavia per presentare una recidiva.
5° La bronco-polmonite morbiUosa è una infezione zional1>, indipendente dal virus del m orbillo, che può sop giungere tardivamente come un'infezione secondaria, ma può anche trasmettersi colla malattia principale e dete nare, colla sua a ssociazione con essa, un'infezione misla' primo acchito. In quest'ultimo caso le complicazioni bron polmonari sono precoci; il loro inizio si confonde con qu del morbillo slesso, la temperatura continua a salire dopo
OOlCA 1077
dell'eru zione o per lo meno discende appena e lllP 8rsa de co nei 3 0 4 gior ni che seguono una nuova recrupresenta
~cen;, 8 ·Ls profilassi dal mo~billo é resa d~fficile dalla sua potag iosità preerutt1va; essa puo per altro essere te con . 1en . la da misure d'isolamento e soprattutto di quarante na realizza . . l d . d i dati es posti. Le mi sure sono a ssai comp esse e ·op1rate a , h' . . to 1 • b'll inevitabile un giorno o I altro, pere e s1 S1a auil !llOr 1 O · . d. b'll . d astenersene nelle ep1dem1e I mor I o puro, sorizzati 8 · d · · ni· uutto in eslate, nei fan ciulli al disopra e1 c10que an , prs d vono essere raccomandate, an ch e in questo caso e esse 8 tto in inverno, quando si tratta di fanciulli al disotto ~prattu 1 · do uamento dell'inoontlnensa d 'orina. - V A.~ THIENOVEK
·. t'ets: esse sono rigorosamente obb 1gator1e, quan d1 ques ' l · l'età . lta di epidemia di morbillo mista, qua unqu e sia Ql tra degli iudividui esposti.
": (Journal de Médecine et de Chirurg ie, luglio 1891).
Il dott. Van Thienoven ha proposto un procedimen~ molto ree per combattere l'incontinenza notturna d'or10a nei ~em~ 1 1li Quest'affezione é legata alla debolezza del!o st1n- raoc1u te appena che alcune goccie d1 orma arrivano nella porre, li' . . t ae zione prostatica dell'uretra, il detrusore de o rma s1 con r e 51 ha emissione involontaria dell'orina. . .
Guidato da questo concetto, l'autore ha fatto dormire I fanciul:t, col bacino sollevato, per modo che la vescica potesse ricevere una notevole quantità d'orina prima che 1uesta ra~giungesse il collo vescicale. Sul cadavere di f~nciull~ cosi si: tuati si possono iniettare 600 goccie in un fanciullo d1 tre anm, 1000 goccia in uno di dieci anni prima che il liquido raggiunga l'orifizio vescicale.
Quattordici fanciulli curali in tal modo (13 maschi ed 1 femminaì sono ~ ariti dopo una durata media di 42 giorni. Uno solo ebbe una recidiva.

Gli ablutDl • la te11la mecllo-oaniaellata . - Osserva · e considerazioni del prof. E. PERRONCITO. - (Ga.uetta dica di Torino, 25 aprile, 1891).
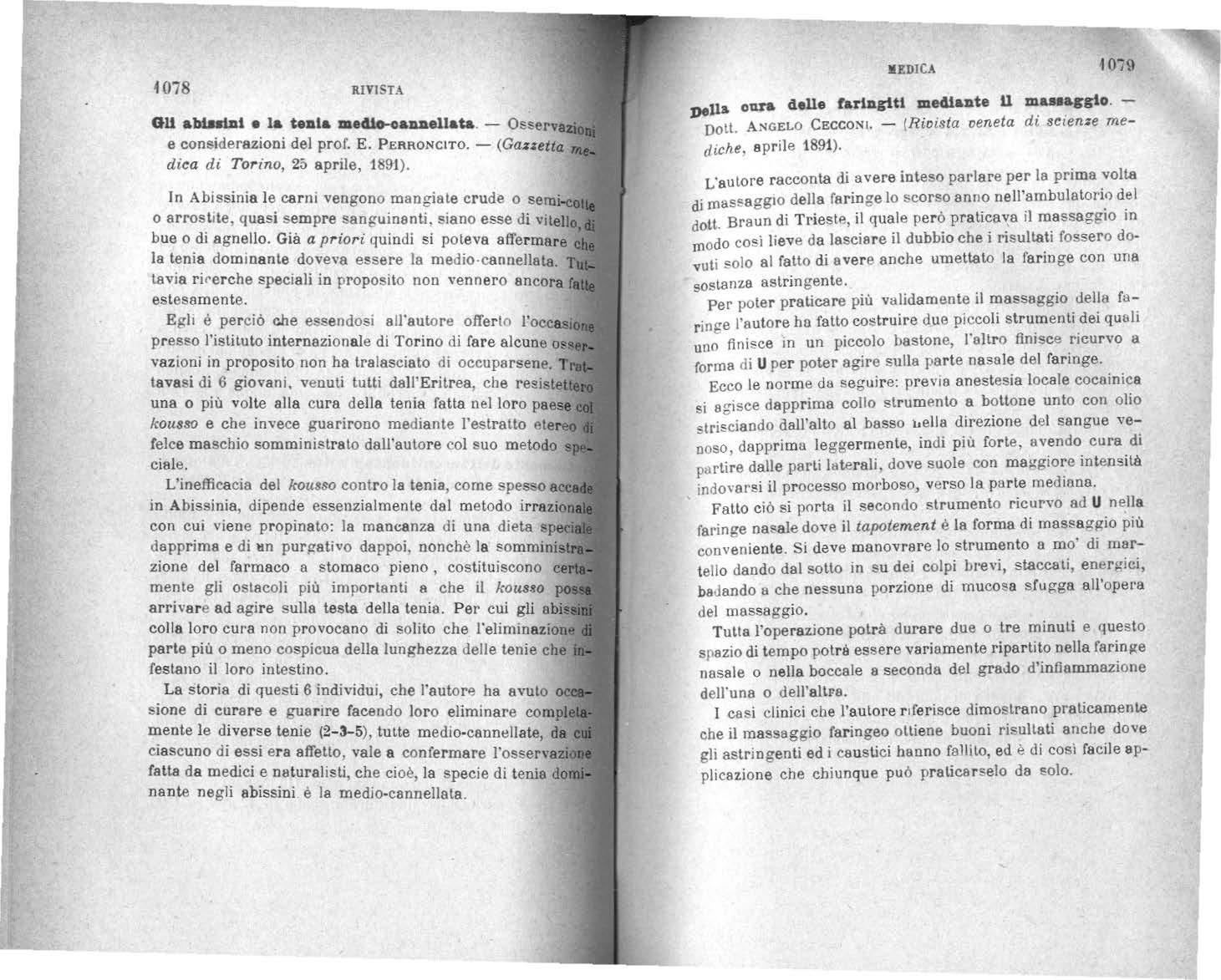
In Abissinia le carni vengono mangiale crude o se m· o arrostite, quasi sempre sanguinanti, siano esse di vitello bue o di agnello. Già a p r iori quindi si poLeva affer mare la tenia domina nte doveva essere la medio-cannellala. lavia rirerche speciali in proposito non vennero ancora ri estesamente.
Eglt è perciò e.be essendosi all'autore offerto l'occasi presso l'istituto internazionale di Torino di fare alcune os vazioni in proposito non ha tralasciato di occuparsene. T tavasi di 6 giovani, venuti tutti dall'Eritrea, che resisle t una o più volte alla cura della tenia fatta nel loro paese kou880 e che invece guarirono mediante l'estratto et ereo felce maschio somministrato dall'autore col suo metodo s ciale.
L'inefficacia del kousso contro la tenia, come spesso a in Abissinia, dipende essenzialmente dal metodo irrazio con cui viene propinalo: la mancanza di una dieta s dapprima e di 'ti.O purgativo dappoi, nonchè la somminis zione del farmaco a stomaco pieno , costituiscono ce mente gli ostacoli più importanti a che il kousgo arrivare ad agire sulla t.esta della tenia. P er cui gli a bi coll a loro cura non provocano di solito che l"elimin az ione parte più o meno cospicua della lunghezza delle tenie c he feslano il loro intestino.
L a storia di questi 6 individui, che l'autore ha avuto sione di curare e guarire facendo loro eliminare co mpi mente le diverse tenie (2-3-5), tutte medio-cannellate, da ciascuno di essi era affetto, vale a confermare l'osser\'azi fatta da medici e nat uralisti, che cioè, la specie di tenia do nan te negli abissini è la medio-cannellata.
J)ell,. oura delle farl11git l me41a nte U managglo .oott. ANGELO CECCONI. - (R ioista oeneta di scien~e mediche, aprile 1891).
L'autore racconta di avere inteso parlare per la prima volta di massaggio della faringe lo scorso anno nell'.ambulatori? d~l dott. Braun di Trieste, il quale però pratica".a 11 massaggio in modo cosi lieve da lasciare il dubbio che i risultati fossero dovuti solo al fatto di avere anche umettato la faringe con una sostanza astringente. per poter praticare più validamente il massaggio della faringe l'autore ho fatto costruir e due piccoli strumenti dei quali un; finisce in un piccolo bastone, l'altro finisce ricurvo a forma di U per poter agire sulla parte nasale del faringe.
Ecco le norme da seguire: previa anestesia locale cocainica si agisce dapprima collo strumento a bottone unto con olio strisciando dall'alto al basso hella direzione del sangue venoso, dapprima leggermente, indi più forte, avendo cura di partire dalle parli h1terali, dove suole con ma~gio~e intensità indovarsi il processo morboso, ve rso la parte mediana.
Fallo ciò si porta il secondo strumento ricurvo ad U nella faringe nasale dove il tapotement é la forma di massaggio più conveniente. Si deve manovra r e lo strumento a mo' di martello dando dal sollo in su dei colpi brevi, staccati, ener~ici, badando a che nessuna porzione di mucosa sfugga all'opera del massaggio.
Tutta l'operazione potrà durare due o tre minuti e questo spazio di tempo polra essere variamente ripar tito nella faringe nasale o nella boccale a seconda del graJo d'infiammazione dell'una o dell'allr.a.
I casi clinici che l'autore rife risce dimostrano praticamente che il massaggio faringeo ollieoe buoni risultati anche dove gli astringenti ed i caustici hanno fallito, ed è di così facile applicazione che chiunque può pralicarselo da eolo.
J>l una lesione dell'aorta come postumo , non ancora regbtratc , della malaria pregreua. - Do lt. Lu1G1 ToBALDO. - (Ganetta medica lombarda, 23 maggio, 1891).
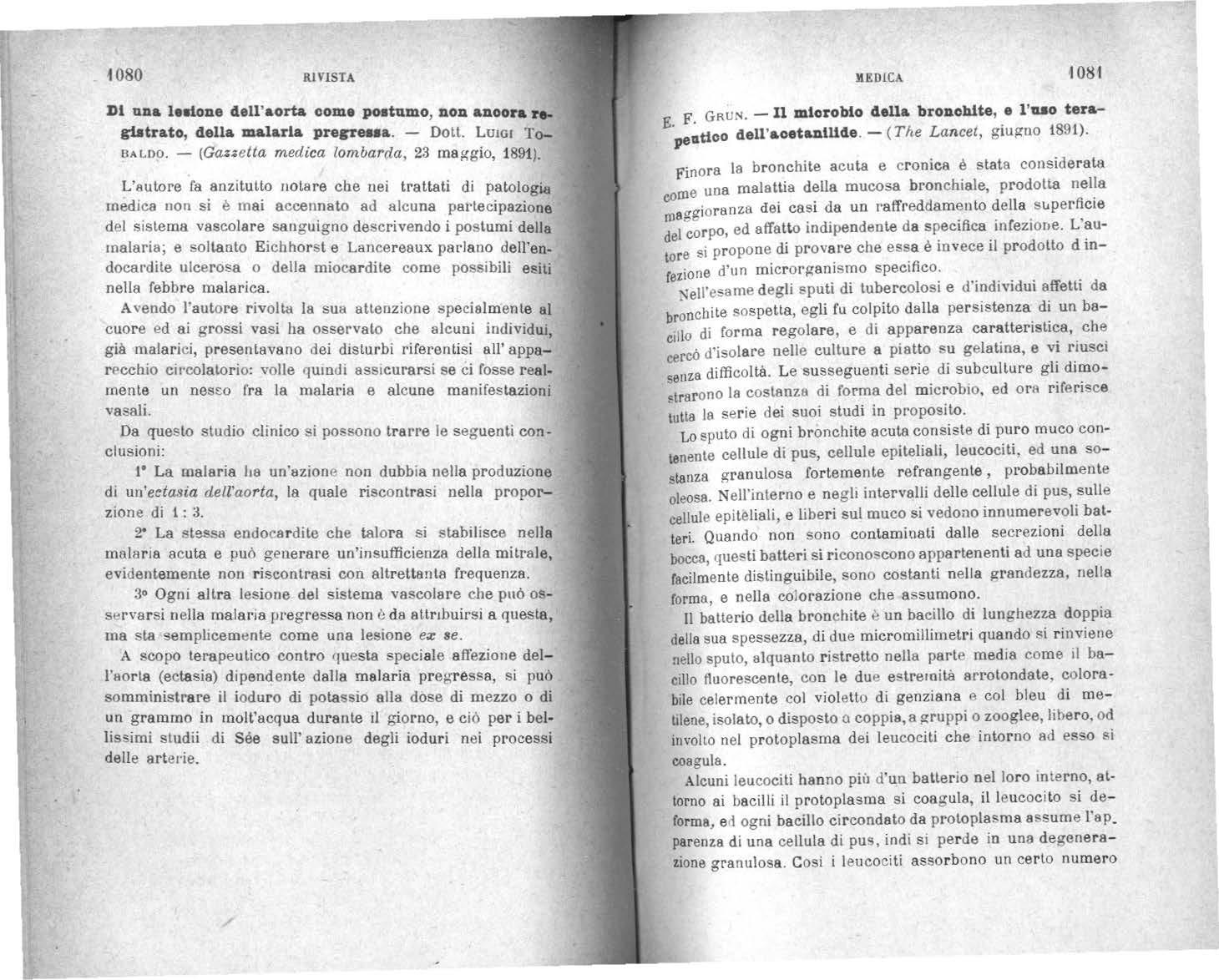
L'autore fa anzitutto notare che nei trattati di patologia medica non si è mai accennato ad alcuna partecipazione del sistema vascolare sang uigno descrivendo i postumi de lla malaria; e sol tanto Eichhors t e Lancereaux parlano dell'endocardite ulcerosa o della miocardite come possibili esiti nella febbre malarica.
Avendo l'autore rivolta la sua attenzione specia lmente al cuore ed ai grossi vasi ha osservalo che alc uni individui, già malarici, presentavano dei disturbi riferentisi all' appar ecchio circolatorio: volle qu10d1 assicurarsi se ci fosse realmente un nesto fra la malaria e alcune manifestazioni vasali.
Da ques to studio clinico si posso no trarre le seguenti conclusioni: li batterio della bron chite ,, un bacillo di lunghezza doppia della sua spessezza, di due micromillimetr i quando $Ì rinviene nello spulo, alquanto r istretto nella parte media come il bactllo fluorescente, con le du e estreroilà arrotondate, colorabile celermente col viole tto di genziana e col bleu di metilene, isolato, o disposto o coppia, a gruppi o zooglee, liber o, od involto nel pr otoplasma dei leucociti che intorno ad esso si coagula .
1• La malaria ha un'azion e non dubbia nella produzione di un'eetasia dell'aorta, la quale riscon lrasi nella proporzione di i : 3.
2" La stessa endoca r dite cbe talora si stab il isce nella malaria acuta e può gene r are un'insufficienza della mitral e , evidentemente non r iscontrasi con altrettanta frequenza.
3° Ogni allra lesione del sistema vascolare che può osservarsi nella malaria pregressa non è da attribuirsi a questa, ma s ta semplicem~nte come una lesione e;r; se.
A scopo terapeutico contro questa specia le affezione dell'aorta (ectasia) dipendente dalla m a laria pregre ssa, si può somministrare il iodur o di potassio alla dose di mezzo o di un grammo in molt'acqua dur ante il giorno, e ci ò per i bellissimi sludii di Sée sull' azione degli iodur i ne i processi delle arterie.
F GRUN. - Il mlcroblo della bronchite , e l'uc ter&F\,e ~tloo dell 'acetantllde . - ( The Lancet, giugno 189 1).
Fin ora la bronchite acuta e cronica é stata considerata e uoa malattia della mucosa bron chiale, prodotta nella c0n;,gioranza dei casi da un raffreddamento de lla s1.,perficie rna,, .fl f L ' 1corpo, ed affatt o indipendente da spec1 ca in ez1orie. aude ,,i pr opone di provare che essa é invece il prodotto d in- tore , fezio ne d'un microrgan_is~o s pecifico: •. . . . .
~ell'esarne degli sputi d1 tubercolosi e d md1v1dm affetll da b · ochile sospetta, egli fu colpito dalla persistenza di un ba. . h 'l di forma regolare, e di apparenza caratterisltca, c e Cli O • • • • rcò d·isolare nelle cu!Lure a piatto s u gelatina, e v1 r1usc1 ce 1· d" 1za difficoltà. Le susseguenti ser ie di subcullure g 1 1mo- se1 ., . ctrarono la costanza di forma del mic robi o, ed orA r11er1sce ;utla la serie dei suoi studi in proposito.
Lo sputo di ogni bronchite acuta consiste di puro muco contenente cellule di pus, cellule epiteliali, leucociti, ed una sostanza granulosa fortemente refrangente, proba bilmente oleosa. Nell'interno e negli intervalli delle cellule di pus, sulle cellule epitel iali, e liberi sul muco si vedono innumerevoli batteri. Quando non so no contaminati dalle secrezioni della bocca , questi batteri si riconoscono appartenenti ad una specie facilm ente distinguibile, sono costanti nella grandezza, nella form a, e nella colorazione che a s sumono.
Alcuni leucociti han no più d' un batterio nel loro interno, attorno ai bacilli il protoplasma si coagula, il leucoci ~o si deforma, e d ogni ba cillo circondato da protoplasma a!>sume rap_ parenza di una cellula di pus, indi si per de in una degenerazione granulosa. Cosi i le ucociti assor bono un certo nume r o
tosz RIVISTA
di bacilli che si distruggono in essi, ma nel coagulo del Pl'O toplasma e con la degenerazione granulosa, s i dislruggon anche i leucociti. Sulle cellule epiteliali essi non hanno alcUfla influenza, e non fanno che aggrupparsi sulla loro superficie.
Montati questi bacilli su coprioggetti con una goccia di vi letto di genziana, mostrano attivi movimenti, consistenti i contrazione eò espansione in varie direzioni, movimenti fluttuazione, con uni:,. estremità fiss~, movimenti serpigmo ed elicoidei.
Le culture di un mese mostrano il bacillo allruanto altera nella forma, come se la cultura foss e inquinata , ma le nuov inoculazioni riproducono la forma originaria che si vede nell sputo, e nelle culture di 24 ore. La deformazione consiste un aumento in lunghezza del bacillo, e nella scomparsa caratteristico restringimento centrale. La reazione d schiuma delle culture è fortemente alcalina.
Il microrganismo della bronchite si sviluppa pr ontamen nella ~elatina e nell'agar ad una temperatura fra i 5• ed i 40• una temperatura superiore ne ritarda lo sviluppo, e verso i esso perisce, mentre al disotto di 5° lo sviluppo si arresta, con la successiva elevazione di temperatura il microbio ri qui,,ta il suo vigoroso germogliare. La pr oliferazione si ma test~ sulle lamine in forma di membranella fioccosa che prea si addentra nello spessore del mezzo nutritivo, la superfl del muco sul qudle il bacillo si sviluppa dà una forte r zione alcalina, sviluppando un gac; di odore acre e pe trante. La germinazione si manifesta già dopo 12 ore dsll'i culazione, nelle culture di qualche giorno si vedono d spore, a sviluppo completo la gelatina si fluidifica.
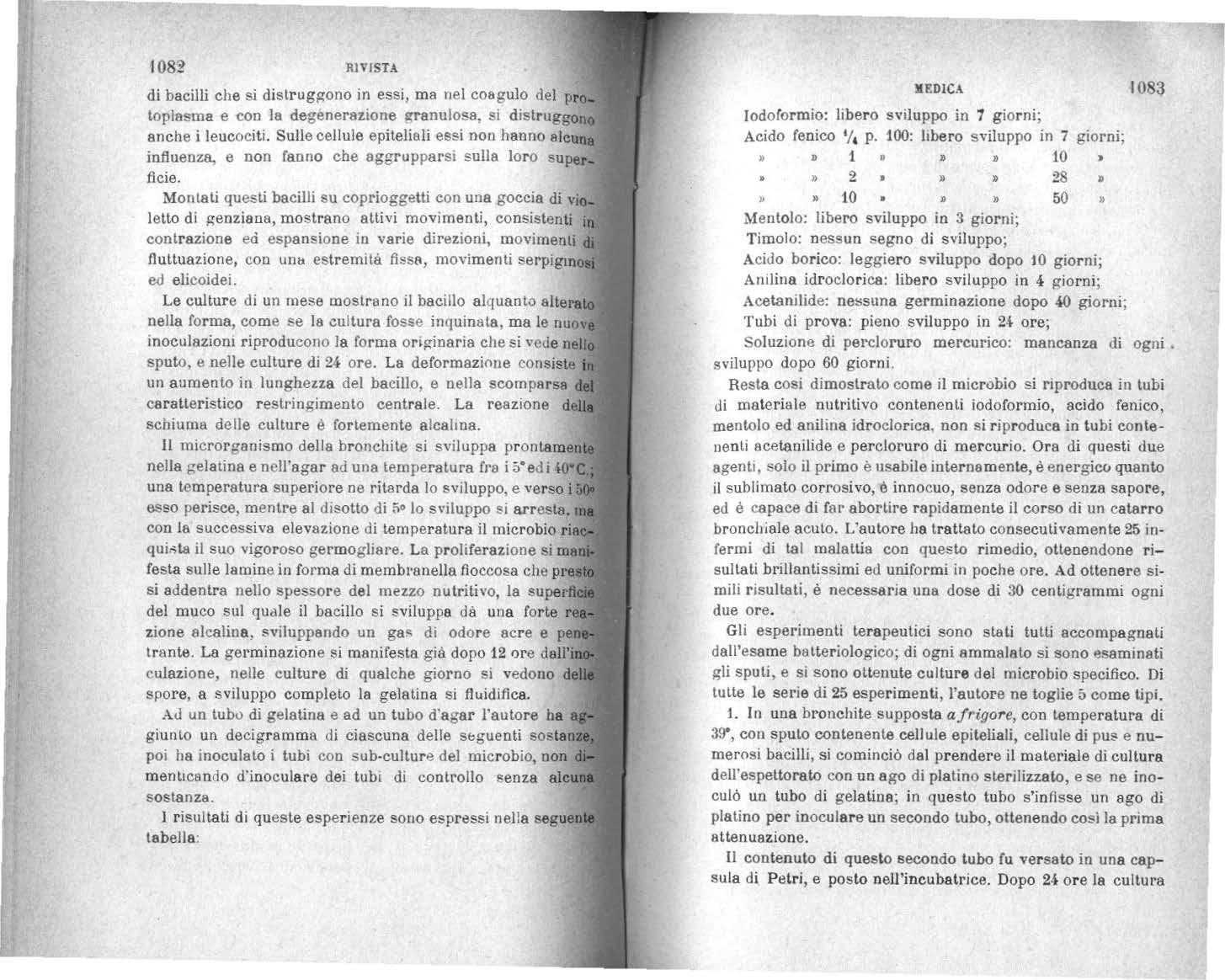
Atl un tubi) di gelatina e ad un tubo d"agar l'autore ba giunto un decigramma di ciascuna delle seguenti sostan poi ha inoculato i tubi con sub-culture del microbio, oon ment1cando d'inoculare dei tubi di controllo senza alcu sostanza.
I risultati di queste esperienze sono espressi nella segue tabella:
11'EDlCA 1083
Iodoformio: libero sviluppo in 7 giorni;
Acido fenico '/, p. 100: libero sviluppo in 7 giorni;
»
•
.Mentolo: libero sviluppo in 3 giorni;
Timolo: nessun segno di sviluppo;
Acido borico: leggiero sviluppo dopo 10 giorni;
Anilina idroclorica: libero sviluppo in 4 giorni;
Acetanilide: nessuna germinazione dopo 40 giorni;
Tubi di prova: pieno sviluppo in 24 ore;
Soluzione di percloruro mercurico: mancanza di ogni . sviluppo dopo 60 giorni.
Resta cosi dimostralo come il microbio si riproduce. in tubi di materia.le nutritivo contenenti iodoformio, acido fenico, mentolo ed anilina idroclorica, non si r iproduca in tubi conteuenLi acetaoilide e percloruro di mercurio. Ora di questi due agenti, solo il primo è usabile internamente, è energioo quanto il sublimato corrosivo, è innocuo, senza odore e senza sapore, ed è capace di far abortire rapidamente il corso di un catarro bronchiale acuto. L'autore ha trattato consecutivamente 25 infermi di tal malaLLia con questo rimedio, ottenendone risultati brillantissimi ed uniformi in poche ore. Ad ottenere simili risultati, è necessaria una dose di 30 centigrammi ogni due ore.
Gli esperimenti terapeulici sono stati tutli accompagnati dall'esame batteriologico; di ogni ammalalo si sono esaminati gli sputi, e si sono oltenule culture del microbio specifico. Di tutte le serie di 25 esperimenti, l'autore ne toglie 5 come lipi.
1. In una bronchite supposta afrigore, con temperatura di 3!r, con sputo contenente cellule epiteliali, cellule di pui, e numerosi bacilli, si cominciò dal prendere il materiale di cultura dell'espettorato con un ago di platino sterilizzato, e se ne inoculò un tubo di gelatine.; in questo tubo s'infisse un ago di platino per inocular e un secondo tubo, ottenendo così la prima attenuazione.
Il contenuto di questo secondo tubo fu versa to in una capsula di Petri, e posto nell'incubatrice. Dopo 24 ore la cultura
RIVISTA si era manifestata alla superficie della gelatina, la quale si rammollì, iudi fluidificò formando schiuma). Appena apparsa la germinazione nella capsula di Petri, ne ha ripetuta la cultura in tubo, e se ne ottenne la prima sub cultura..
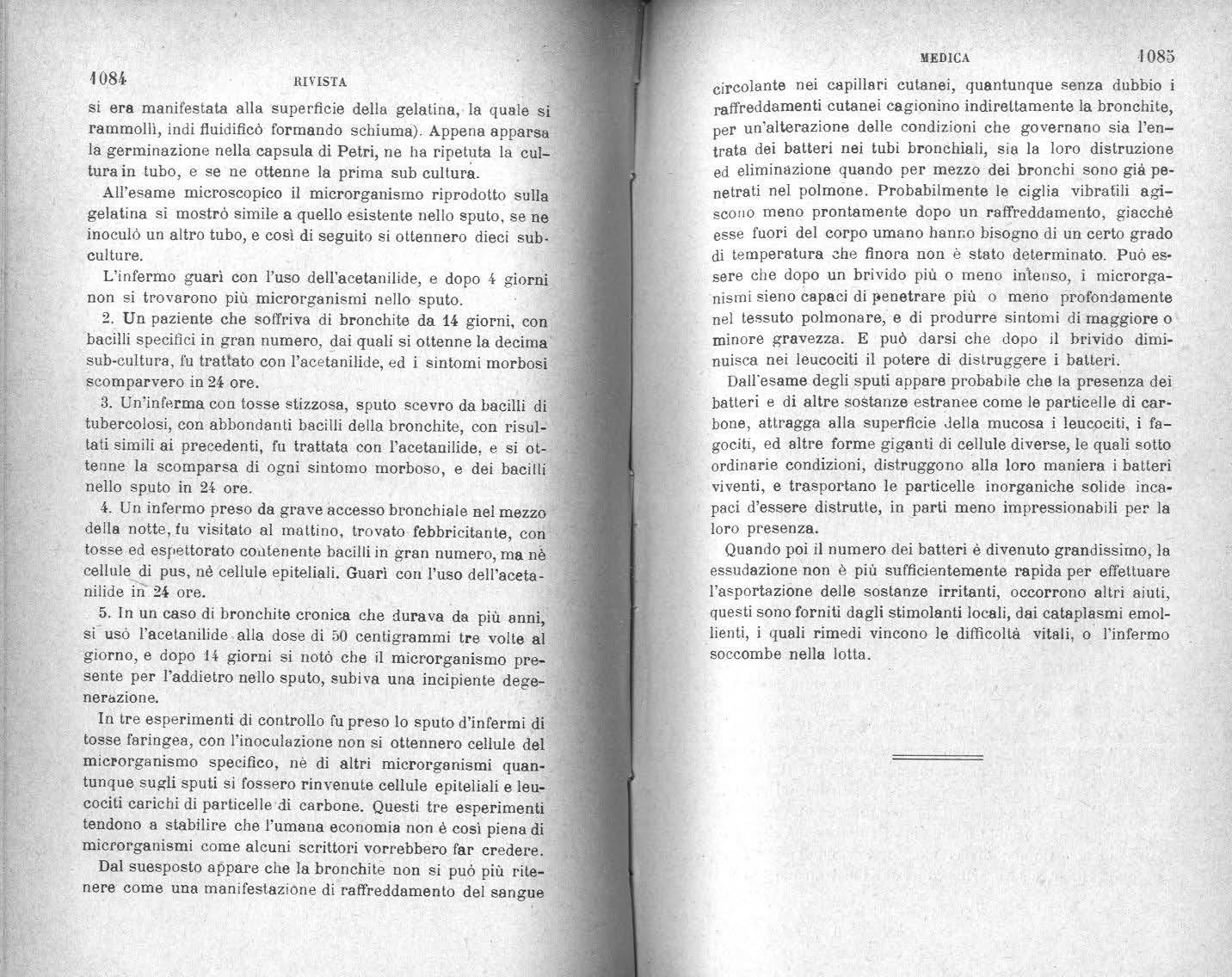
All'esame microscopico il microrganismo riprodotto sulla gelatina si mostrò simile a quello esistente nello sputo, se ne inoculò un altro tubo, e cosi di seguito si ottennero dieci subculture.
L'infermo guarì con l'uso dell'acetanilide, e dopo 4 giorni non si trovarono più microrganismi n ello sputo.
2. Un paziente che soffriva di bronchite da 14 giorni, con bacilli specifici in gran numero, dai quali si ottenne la decima sub-cultura, fu trattato con l'acetanilide, ed i sintomi morbosi scomparvero in 24 ore.
3. Un'inferma con tosse stizzosa, sputo scevro da bacilli di tubercolosi, con abbondanti bacilli della bronchit.e, con risultati simili ai precedenti, fu trattata con l'acetaoilide, e si ottenne la scomparsa di ogni sintomo morboso, e dei bacilli nello sputo in 24 ore.
4. Un infermo preso da grave accesso bronchiale nel mezzo della notte, fu visitato al mattino, trovato febbricitante, con tosse ed espettorato coù.lenenle bacilli in gran numero, ma nè cellule di pus, nè cellule epiteliali. Guarì con l'uso dell'acetanilide fn 24 ore.
5. In un caso di bronchite cronica che durava da più anni, si usò l'acelanilide alla dose di 50 centigrammi tr e volte al giorno, e dopo 14 giorni si notò che il microrganismo presente per l'addietro nello spulo, subiva una incipiente degenerbzione.
In tre esperimenti di controllo fu preso lo sputo d'infermi di tosse faringea, con l'inoculazione non si ottennero cellule del microrganismo specifico, nè di altri microrganismi quantunque sugli sputi si fossero rinvenute cellule epiteliali e leucociti carichi di particelle di carbone. Questi tre esperimenti tendono a stabilire che l'umana economia non é così piena di microrganismi come alcuni scrittori vorrebbero far cre dere.
Dal suesposto appare che la bronchite non si può più ritenere come una manifestazione di raffreddamento del sangue circolante nei capillari cutanei, quantunque senz a dubbio i raffreddamenti cutanei cagionino indirettamente la bronchite, per un'alterazione delle condizioni che governano sia l'entrata dei batteri nei tubi bronchiali, sia la loro distruzione ed elimimtzione quando per mezzo dei bronchi sono già penetrati nel polmone. Probabilmente le ciglia vibratili agiscono meno prontamente dopo un raffreddamento, giacché esse fuori del corpo umano hanno bisogno di un certo grado di temperatura ~he finora non è stato determinato. Può es· sere che dopo un brivido più o meno in'tenso, i microrganismi sieno capaci di ?enetrare più o meno profondamente nel tessuto polmonare, e di produrre sintomi di maggiore o minore gravezza. E può darsi che dopo il brivido diminuisca nei leucociti il potere di distruggere i batteri.
Dalresame degli sputi appare probabile che la presenza dei batteri e di altre sostanze estranee come le particelle di carbone, attragga alla superficie Jella mucosa i leucociti, i fagociti, ed altre form e giganti di cellule diverse, le quali sotto ordinarie condizioni, distruggono alla loro maniera i batteri viventi, e trasportano le particelle inorganiche solide incapaci d'essere distrutte, in parti meno impressionabili per la loro presenza.
Quando poi il numero dei batteri è divenuto grandissimo, la essudazione non è più sufficientemente rapida per effettuare l'asportazione delle sostanze irritanti, occorrono altri aiuti, questi sono forniti dagli stimolanti locali, dai cataplasmi emolli enti, i q uali rimedi vincono le difficoltà vitali , o · l'infermo soccombe nella lotta.










