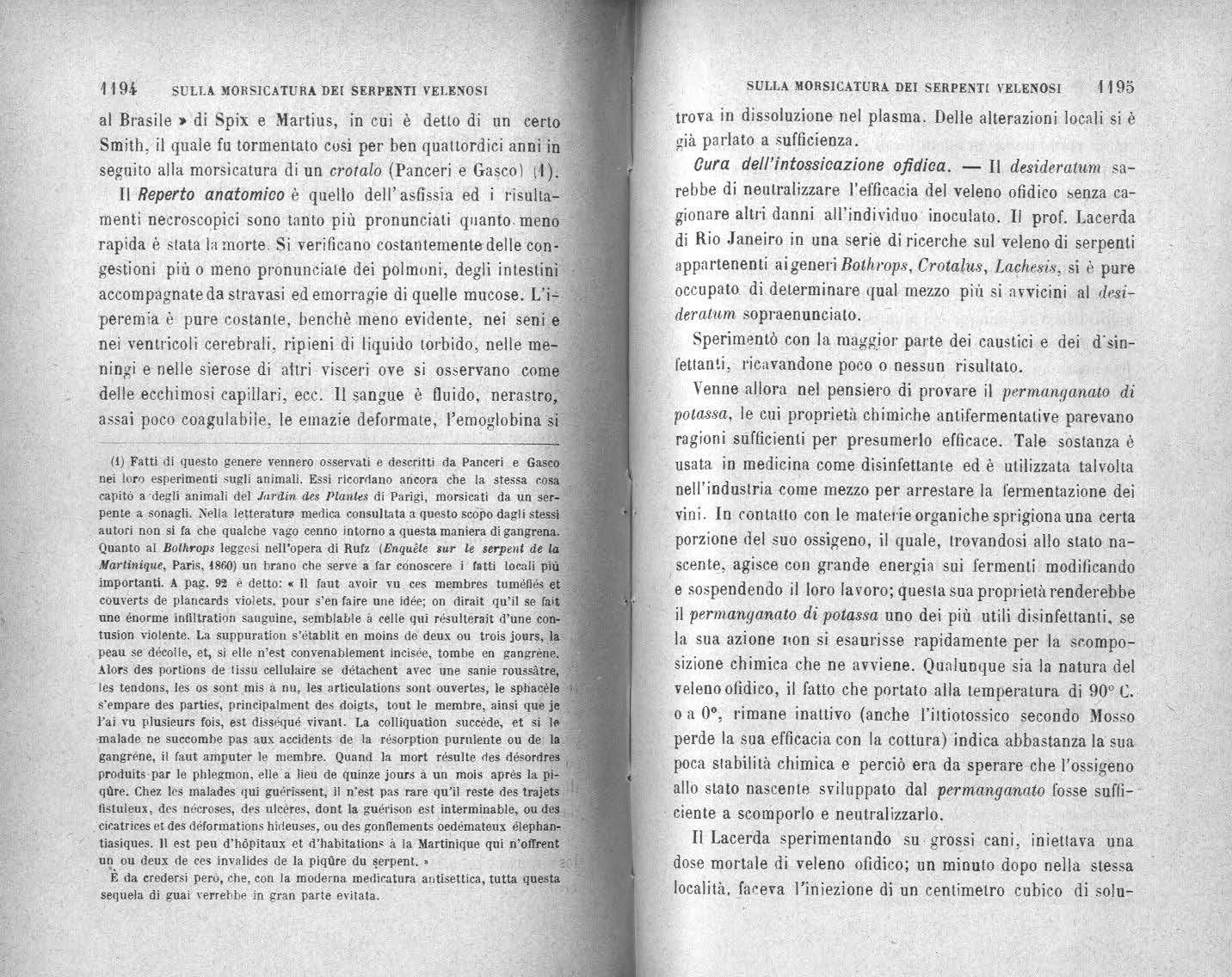
10 minute read
1194 SULLA MORSICATURA DEI SERPRNTI VELENOSI
al Brasile > di Spix e Martius, in cui è detto di un certo Smith , il quale fu tormentato cusì per ben quattordici anni in seguito alla morsicatura di un crotalo (Panceri e Gasco ) 11).
Il Reperto anatomico è quello dell'asfissia ed i risultamenti necroscopici sono tanto più pronunciati quanto . meno rapida è stata la morte. Si verificano costantemente delle congestioni più o meno pronunciate dei polmoni, degli intestini accompagnate da stravasi ed emorragie di quelle mucose. L'iperemia è pure cos tante, benchè meno evidente, nei seni e nei ventricoli cerebrali, ripieni di liquido torbido , nelle meningi e nelle sierose di altri visceri ove si osservano come delle ecchimosi capillari, ecc. 11 sangue è fluido, nerastro, assai poco coagulabile, le emazie deformate, l'emoglobina si
Advertisement
(i) Fatti di questo genere vennero osservati e descritti da Panceri e Gasco nei loro esperimenti sugli animali. Essi rlcorllano ancora che la stessa t>osa capitò a degli aaimali del J,irdin des Plante.ç di Parigi, morsicati da ua serpente a sonagli. Nella letteratura medica consultata a questo scopo dagli stessi autori non si ra che qualche vago cenno intorno a questa maniera di gangrena. Quanto al Bothrops leggcsi nell'opera di Rurz ( Bn9uéte sur te serpe11t de la Martinique, Paris, t860) un brano che serve a rar conoscere i ratti locali più importanti. A pag. n è detto: « Il faut avoir vu ces membres tuméfiés et cou\'erts de plaucards violets. pour s'en faire une idée; on dirait qu'il se rait une énorme infiltration sanguine, semblable à celle qui résulterajt d'une cootusion violente. La suppuration s'établit en moins de deux ou trois jours, la peau se décolle, et, si elle n' est convenablement incisée, tombe eo gangrène. .~lors des portions de tissu cellulaire se détachcnt avec une sanie roussàtre, les tendons, Jes os sont mis à. nu, les articulations sont ouvertes, le sphacèle s'(•mpare des parties, principalment des doigt.s, tout le membre, ainsi que je !'ai vu plusieurs fois, est di;sé'Jué vivant. I.a colliquation succède, et si IP malade ne succombe pas aux accidents de la rèsorption purulente ou de la gangrene, il faut amputer le membre. Quand la mort résulte lfes llésordres produits par le phlegmon. elle a lieu de quinze jours à un mois aprés la piqure. Chez Ics malades 'JUi guérìssent, il n'est pas rare qu'il reste des trajets tìstuleux, drs nécroses, dPS ulcéres, dont la guérison est interminable, ou des cicatrices et des déformations hicleuses, ou des gonnements oedtlmateux élephantiasiques. Il est peu d"hòpitaux et d'habitation~ à la Martinique qui n'olTrent un on deux rte ces inv~lides de la piqure do serpenl. • È da credersi però, che, con la moderna me,Ùcatura antisettica, tutta questa sequela di guai 1·errehbe in gran parte eYitata.
SULLA MORSICATURA. DEI SERPENTI VELENOSI ,t 195 trova in dissoluzione nel plasma. Delle alterazioni locali si è già parlato a sufficienza.
Cura dell'intossicazione ojìdiaa. - Il desideratmn sarebbe di neutralizzare l'efficacia del veleno ofidico !)enza cagionare altri danni all'individuo · inoculato. Il prof. Lacerda di Rio ,Janeiro in una serie di ricerche sul veleno di serpenti appa rtenenti ai generi Both rops, Crotatus, Lachesis, si è pure occupato. di determinare qual mezzo più si rivvicini al de-Siderat1im sopl'aenunciato.
Sperimentò con la magg_ior parte dei caustici e dei d'sinfettanti, ricavandone poco o nessun risultalo.
Venne allora nel pensiero di provare il permanganato di potassa, le cui proprietà chimir.he antifermentative parevano ragioni sufficienti per presumerlo efficace . Tale sostanza è usata io medicina come disinfettante ed è utilizzata talvolta nell'industria come mezzo per arrestare la fermentazione dei vini. In con tallo con le materie organiche sprigiona una certa porzione del suo ossigeno, il quale, lrovandosi allo stato nascente , agisce con grande energia sui fermenti modificando e sospendendo il loro lavoro; questa sua propl'ietà renderebbe il permanganato di potassa uno dei più utili disinfettanti. se la sua azione non si esaurisse rapidamente per la sr.omposizione chimica che ne avviene. Qualunque sia la natura del veleno ofidico, il fatto che portalo alla temperatura di 90° C. o a O°, rimane inatLivo (anche l'ittiotossico secondo Mosso perde la soa eftìcacia con la cottura) indica abbastanza la sua poca stabilità chimica e perciò era da sperare che l'ossigeno allo stato nasceolP- sviluppato dal permanganato fosse suflicienle a scomporlo e neutralizzarlo.
Il Lacerda sperimentando su grossi cani, iniettava una dose mortale di veleno oftdico; un minuto dopo nella stessa località. fa<:eva l'iniezione di un centimetro cubico di sol u-
1196 SUL LA MORSICAT[;RA DRI SERPENTI HLltNOSI
zione di permanganato potassico, all'1 p. 100; gli effetti generali erano nulli, gli eITelti locali quasi null i. Non conte nto di questo, sperimentò su numerosi soggetti, iniettando direuamente nel sangue il veleno, che in tali condizioni agisce con terribile rapidità; iniettati poi 2 3 centimetri cubici della stessa soluzione, le co ndizi oni degli animali rimanevano perfettamente normali. Tali dosi iniettate in animali non morsicati non producono perturbazioni notevoli nelle gra ndi fun. zioni della vita, dunque è indubitato che l'eflicacia del permanganato potassico non può essere attribuita ad un'azione fisiologica antagonista eccitando gli elementi fisiolo~ici le cui funzioni siano state depresse o perturbale, ma consiste in una azione chimica modificatrice del veleno stesso.
Questi esperimenti ripetuti solennemente in pubblico ed~ vulgati in diverse memorie dall'autore, suscitarono arnmir zione ed interesse non solo nei medici e negli scienziati del Brasile, ma d'Europa, d'Asia e del nord America. Le esp rienze vennero ripetute e controllate specialmente dal Ri chards (·1) il quale in India fece numerosissime esperienze cani, polli ed anitre, ed è venuto alle seguenti concl usìon 1
I 8 Nessun sintomo di avvelenamento si manifestò in s guito all'iniezione ipodermica o ìntravenosa d'una sol uzio acquosa contenente 2-7 centigrammi di veleno a cui si era aggi unto precerlentemente I 0-30 centigrammi di permanganato. :Nelle condizioni ordinarie questa quantità di veleno sarebbe bastata per determinare la morte,
(t) Wall e Richards hanno pure constatato in vitro il fatto che il per ganato di potassa distrugge l'efficacia del veleno o1ldico Gautier alTerma e la soluzione all't p. tOO non ra ohe attenuare l'azione del veleno e rende più IPnta. Pero se e vero chP. il permanganato di potassa in contalto con sostanze organiche sprigiona una parte del suo ossigeno, decomponen!losi ter:i in lihertà una certa quantità di potassa, alcali caustico cbe Gautier s ba riscontrato essere con la soda, l'unica sostan1.a atta a distruggere !'atti del principio attivo del veleno anche quando lo si tratti a freddo con soluz allungate al 0,5 p. tOO. KaulTmann cbe studiò il veleno della vipera, prete · · al permanganato che è caustico e determina soventi gangrena !!elle parti inl tate, l'acido cromico all't p. tOO; dice che sopprime i Jisor1ini locali. e attenlll notevolmente gli accidenti generali, insomma avrebbe la s tessa efficacia del permanganato senza averne gli inconvenienti.
2° Lo stesso risultato s i ebbe quando si fern nna iniezione di permanganato, immediatarr.en1e, o quattrÒ min11ti al più dopo l'iniezione del v~leno.
3° I sintomi d'avvelenamento una volta sviluppati, I~ iniezioni ipodermiche o intravenose non poterono nè arrestarli, nè calmarli,
4-0 Il permanganato non gode proprietà profilattiche contro l'avvelenamento,
5° Per essere efficace il permanganato deve essere messo in contauo diretto col veleno,
6° Le iniezioni del veleno e del permanganato determinarono soventi la gangrena della parte iniettata ,
7° Nulla dimostra che il permanganato o altra sostanza medicamentosa, possa neutralizzare gli effetti del te leno e quella dell'agente terapeutico.
Come si vede, non si conosce alcun antidoto fisioloaico del o veleno ; quando il suo etrelto si è manifestato sui centri respiratori, i rimedi sono di un'azione molto debole, se non nulla; ma quando il veleno è penetrato nell'economia io piccola qunotità, si possono apportare dei soccorsi apprezzabili, applicando un trattamento !ocale e profilattico.
L:1 prima e più importante indicazione è di impedire l'accesso del veleno nella circolazione; le altre sono solamente sussidiarie, poicbè il tempo utile per neutralizzare il veleno col criute ri o o co l permanganato, è assai limitato. Quando il velen o penetra in una vena, se il 'ìerpente che ha morsicato evigoroso, il risultato è generalmente fatale. , Il Fayrer, più volte citalo, che per molti anni si occupò di
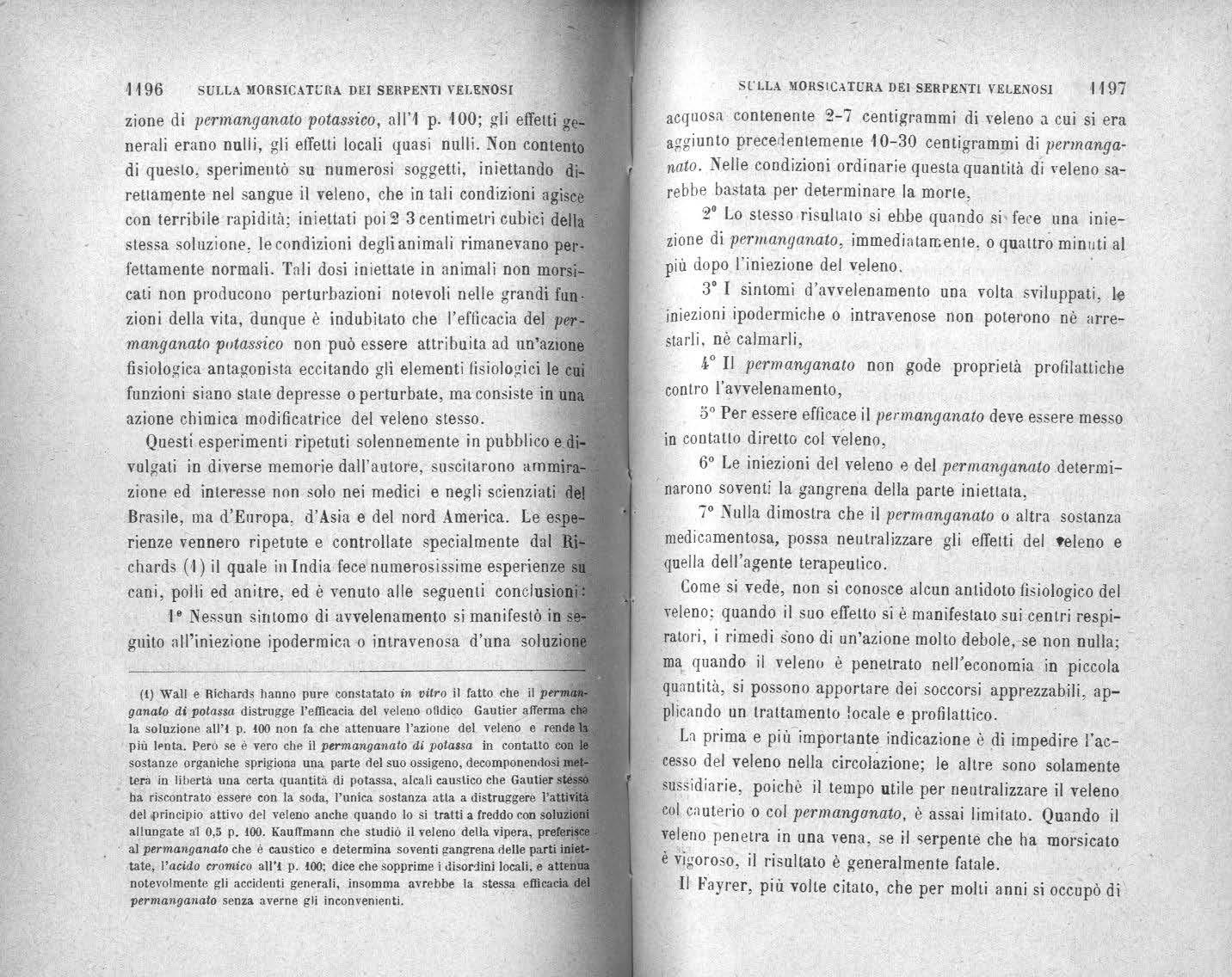
H98 SULLA MORSICATURA DEI SERPE~T! VELENOSI
questo argomento cosi importante per l'lodia, dà questi consigli pratici: Appena avvenuta, la morsicatura :ipplicare il bendaggio di Esmarch, in mancanza di questo, vi può supp!ìre una co~da o qualsiasi altro legaccio streuo intorno all'arto (si tratta quas_i sempre delle estremità) a 8-1 O centimetri al disopra della ferita; passando un bastone fra la pelle e la lega· tura e torcendo si può aumentare la costrizione come meglio si vuole. Ciò fatto, si incide la morsicatura in1 croce, profondamente e per la lunghezza di un centimetro o più lasciando sanguinare liberamente. Nei casi asso i rari in cui la morsicatura sia avvenuta in parti in cui la costrizione è impratica bile, bisognerà escidere la porzione di tessuti dove ha sede la lesione, ed esportarli completamente c9I tessuto cellulare soggiacente. Allora, si applica al più presto possibile, una soh1e zione al 5 p. 100 di permanganato di potassa :ivendo cur: che penetri ovunque si è diffuso il veleno. In ma ncanza del permanganato si app lichi il ferro rovente (color rosso), mao cando anche questo si può ricorrere all'acido fenico o agoti o a qualsiasi caustico che si abbia alla mano. Si amministrano poi al paziente 15 goccie d'ammonia liquida diluita io 25-30 grammi d'acqua, se insorgono fen meni d'avvelenamento si ripete questa do~e, due, Lre, quat volte; si dànno alcoolici se i sintomi di intossicazione conf nuano o s'accrescor:o, se il malato si prostra o ha nausee perde la coscienza; quando la respirazione s'indebolisce e lingua accenna a paralizzarsi si ricorra ai senapismi sulla gione dello stomaco e del cuore, continuando con gli s te s stimolanti . Il paziente déve essere tenuto caldo, ma in un ambiénte fresco e puro . La pralica di suggere la ferita è inu t1lé, senza profitto per il ·malato, e pericoloso per l'operato re.

Appena sopravvengono fenomeni di a~lissia bisogna pralicare con costanza la re.,pirazione artificiale.
SGLLA YQRSICATUR..\ DEI SERP.ENTl VELE~OS! H99
Come giù si è detto, il Mosso riuscì a tener in vita animai i a cui aveva iniettato dosi mortali di veleno, praticando la tracheotomia ed insuffla ndo aria nei polmoni per un tempo più o me~o lungo, cioè fino a completa eliminazione del tossico. Avendone la comodità si potrebbe tentare anche questo mezzo nell'uomo, ed io t:il caso :;arebbe a preferirsi l'intubazione alla tracheotomia.
Come consiglio generale giol'a ricordare cbe si deve ao-ire !'> con prontezza, con qualunque spediente atto allo scopo. e senza metter tempo in mezzo, giaccbè tulio dipende dalla presenza di spirito e dal coraggio degli astanti e del paziente stesso. Panceri e Gasco raccontano di un loro cacciatore di serpe nti, che morsicato da una ceraste ebbe il cor-acrcrio di strapparsi coi denti a brandelli la carne e cosi ebbe salva la vita. Gli stessi autori riferiscono pure il caso di un JOO'ecrnere o del Canale di Suez, che, novello ) Inzio Scevola, scampò a sua volta bruciandosi tosto le carni sulla fiamma di una candela, fino ad avere una scottatura profonda di terzo grado.
Riporterò ancora dal Moore le considerazioni seguenti. che sono nltreltanti consi;?li di profilas:;i pra1ica: « Bisogna rammentare che i ::;erpent.i anche velenosi, raramente attaccano l'uomo se non sono irritati. li n serpente, per regola generale, se può, ~cappa. Ed il follo di tanta gente morsicata durante il sonno non menoma punto la verità. di cotesla as::.erzione. Uu serpente capila, strisciando, a passare sul corpo di un dormente; questi, che sente qualcosa, inconsciamente si muove, ed il reuile allarmnto si avventa e morde in sua legittima difesa . Similmente una persona cammina per un sentiero o allo scuro, un serpente giace disteso a traverso il cammino o sn di un lato, probabilmente immerso nel sonno: esso vien disturbato, spaventato, e forse calpestato dal piede del passeggero e si slancia contro l'intruso importuno.
1.200 SULLA MORSICATURA DEI SERPE~T! \'ELl!NOSI
"Èperciò necessar io, quando i cammina in campag na allo scuro, nei luoghi infestali dai serpenti, di far rumore qunnto piu si può, calpestando pesantemente il suol o o ba1tendol1) con un ramo frondoso. Un cane da guardia pre%o la casa è pure una buona protezione, e megliò ancora è tenere a questo scopo un mungoose (Herpestes?) addomesticato, benchè questo animale non sia, come è staio supposto. insensibile al releno ( 1 ).
« Una su-iscia di acido fenico dd commercio (per il quale le serpi hanno una grande antipatia) davanti alla porta di casa. impedirà l'ingresso a questi ospiti poco desiderali; però, volendo applicare questa m·sura protelliva, bisognerà badar bene di non sbarrare invel:e l'uscita - come una volta capi tò a me - aù un serpente che per avventura già fosse penetralo nell"abitazione
{I/ Come ti stato detto al1rove, Fa~rer con,tatù che l' lltrpult l dell ' Intlia ( llcrpestes malauensis) non 1csi,Lo ·al veleno della l\'oja triputiia11s, mn a Pauccn e Gasco risultò che la specie egiziana (1/trflULts ichne11m1,n) re.,i,te pi>rrettamentc, alle morsicature e all'inoculazione del ,eleoo della Noia hojt e tlel Ctrastes aegypliacus.
Bibliografi A
. Una bibliogratla se non completa, sufficientemPnle es tesa sulle opere che s1 occupano d1 que,to soggetto, sì ba neU.i memoria del:
S0oes111A1i,,. - De la uipere, de son vmin ti de sa morsure, Paris, 1855, nel quale sono raccol.te i58 citazioni di opere e memorie.
PAVL GERVAIS et VAN BENl!D~:11. - Zoologie medicate, Baillieri>, Paris, 1859.
FAYRBR. - The Thanutophidia o( India, Chureill, Londoo, t 87!.
P.1.Nce111 e GAsco - Intorno agli enetti tie! veleno tiella /foia egiziana e della Ctraste. - Atti della R. Ace. atlle Scienze Fù. e 11/at. di Napoli, volume lii, settembre, t8i3.

PANCBRI e GAsco. - l11tort10 alla rés1$1enza dell'icneumom, ecc., al 1Jtltt1o dei serpenti. - Atti atlla R .d ee. delle Scten::e Fis. e Mal. di Napoli, voi. VII luglio, IS74. ' i;:ACPPIUNN. - Dv. vmin de la viptre. - .llnn. tie l'Acad. de mtd. XXXVI, t889.
ORUNTON and FA TREn. - On I~ nature and physiolcgical action o( the poi,on o( Naia lripudians, ecc. - Proe. o( R. S. Lond1m , 1873-74-i5-il.
LACERDA. - V. parecchie memorie inserite negli A11nales do Museo Nacional tie Rio Janeiro, t 8i7-i8.
GAUTIER.-Sur le ven,n tiu ,l"aja tripudia11.s - B ull de l'Acad.demid. Xl, pag. 9~7, 188t.
BADALONI. -La morsicatura della viptra ed il permanganato di potassa. - Arch. e Atti delta Soc. di Chirurgia, ra~c. 1•, t883.
J. WALL. - lndian st1ake poisons their nature a11d etrects, tondoo, 1883. F.nRBR. - 01i the 11ature o( tht make', poison. - A lecture lo Brit. Jled. Journ., rebruary 1881, pag. !03.
R1CRARDS. - On permanganate of polaih in the intoXication by Cobra 's poison. - lu /nctl<ln Med. Caz., et Med. Times alld Gaz., tS jan., 1884.
MooR&. - D11eases o( India. - Churchill, London, fS86.
G. VAt.ENTIN. - l!inlge Beobachtungen ùber dte Wirkungen der Viperergiftes. - Zeilsch r l(t (ii.r biologie, p. I!, 1887.
A. Jito~so. - Il 11elmo dei peaci e tielle vipere - Nuova Ant., o Arch /la liennes de biolog i e, 1888.
.a.. Mosso. - l :n velnw che li trova 1itl sangue dei Alureniti. - Rtnd. iù'1' Acc. dei Lincei, pag. 66.\ 1888, e hione tìsiolo9ica, ecc., ibid., P3:?. 673.
R. BLA1'Ceuo. - 7'railé dt Zoologie medicale, Paris, f890.
•










