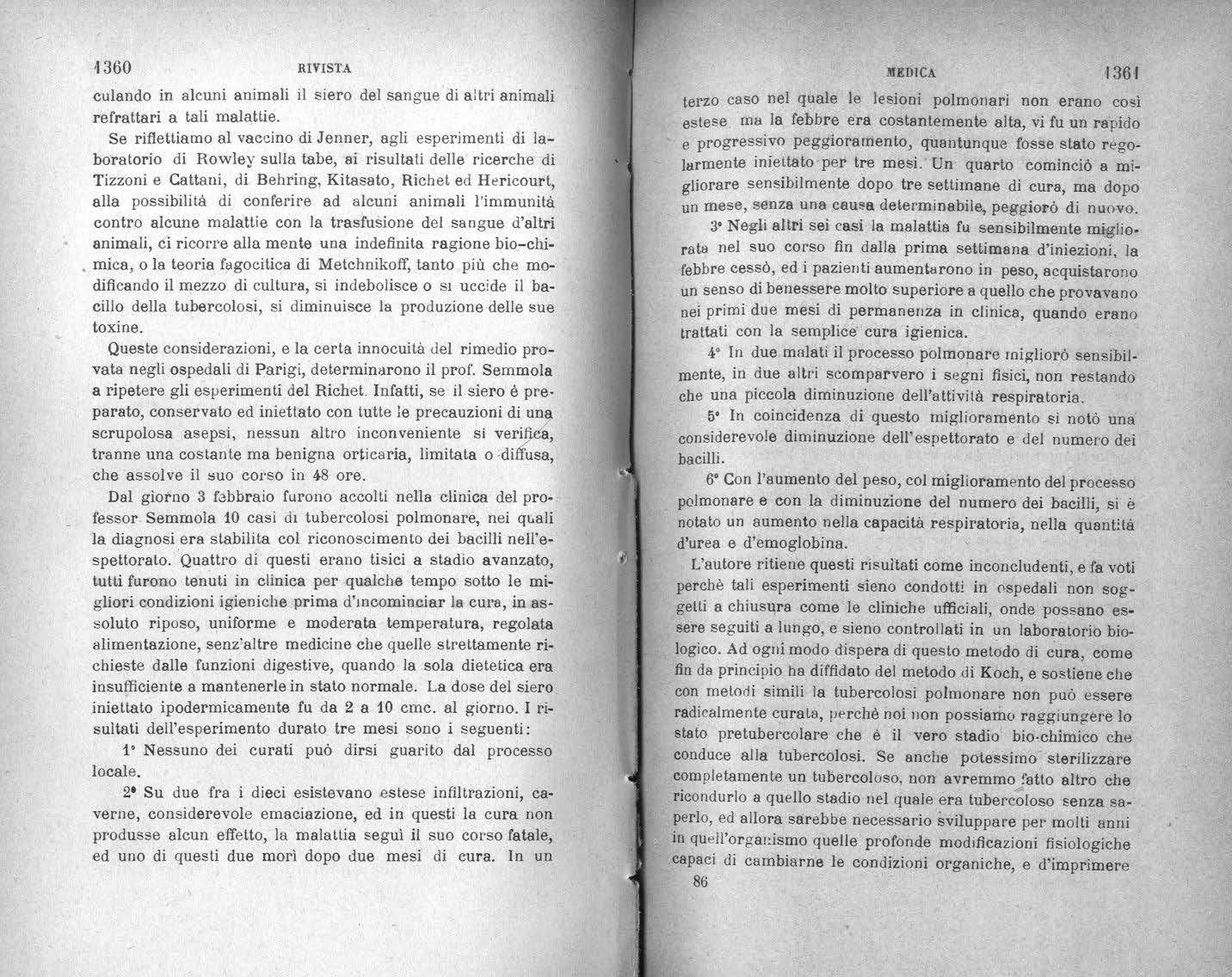
13 minute read
RIVISTA
culando in alcuni animali il siero del sangue di altri animali refrattari a tali malattie.
Se riflettiamo al vaccino di Jenner, agli esperimenti di laboratorio di Rowley sulla tabe, ai risultali delle ricerche di Tizzoni e Cattaui, di Behring, Kitasato, Richet ed Hericourt, alla possibilità di conferire ad alcuni animali l'immunita contro alcune malattie con la trasfusione del sangue d'altri animali, ci ricorre alla ment.e una indefinita ragione bio-chi• mica, o la teoria fogocitica di Metchnikoff, tanto più che modificando il mezzo di cullura, si indebolisce o s1 uccide il bacillo della tubercolosi, si diminuisce la produzione delle sue toxine.
Advertisement
Queste considerazioni, e la certa innocuità Jel rimedio provata negli ospedali di Parigi, determinarono il prof. Semmola a ripetere gli esperimenti del Richet. Infatti, se il.siero é preparato, conservato ed iniettato con tutte le precauzioni di una scrupolosa asepsi, nessun altro inconveniente si veriy.éa, tranne una costante ma benigna orticaria, limitata o -diffusa, che assolve il suo corso in 48 ore.
Dal giorno 3 fabbraio furono accolti nella clinica del professor Semmola 10 casi d1 tubercolosi polmonare, nei quali la diagnosi era stabilita col riconoscimento dei bacilli nell'espettoralo. Quattro di questi erano tisici a stadio avanzato, tutli furono tenuti in clinica per qualche tempo sotto le mig liori condizioni igieniche prima d'incominciar la cura, in assoluto riposo, uniforme e moderata temperatura, regolata alimentazione, senz'allre medicine che quelle strettamente richieste dalle funzioni digestive, quando la sola dietetica era insufficiente a mantenerle in stato normale. La dose del siero iniettalo ipodermicamente fu da 2 a 10 eme. al giorno. I risultati dell'esperimento duralo tre mesi sono i seguenti:
1• Nessuno dei curati può dirsi guarito dal processo locale.
2• Su due fra i dieci esistevano es tese infilLrazioni, caverne, considerevole emaciazione, ed in questi la cura non produsse alcun effetto, la malattia seguì il suo cor·so fatale, ed uno di quesli due morì dopo due mesi di cura. In un
MEDICA terzo caso nel quale le lesioni polmonari non erano così estese mu la febbre era costantemente alta, vi fu un rapido e progressivo peggioramento, quantunque fosse stato r ligoh1.rmente iniettato per tre mesi. Un quarto cominciò a migliorare sensibilmente dopo tre settimane di cura, ma dopo un mese, senza una cau~a determinabile, peggiorò di nuovo.
3' Negli altri sei casi la malattia fu sensibilmente migliorata nel suo corso fin dalla prima setLimana d'iniezioni, la febbre cessò, ed i pazie11ti aumentarono in peso, ai::quistarono un senso di benessere mollo superiore a quello che provavano nei primi due mesi di permanenza in clinica, quando erano trattati con la semplice cura igienica.
4° In due malati il processo polmonare migliorò sensibilmente, in due altri scomparvero i segni fisici, non restando che una piccola diminuzione dell'attivilà respiratoria.
5' In coincidenza di questo miglioramento si notò una considerevole diminuzione dell'espettorato e del numero dei bacilli.
6° Con l'aumento del peso, col miglioramento del processo polmonare e con la diminuzione del numero dei bacilli, si è notato un aumento nella capacità respiratoria, nella quant:ta d'urea e d'emoglobina.
L'autore ritiene questi risultati come inconcludenti, e fa voti perchè tali esperimenti sieno condotti in 0spedali non soggetti a chiusur a come le cliniche ufficiali, onde possano essere seguiti a lungo, e sieno controllati in un laboratorio biologico. Ad ogni modo dispera di questo metodo di cura, come fin da principio ha diffidato del metodo di Kocb, e sostiene che con meloni simili la tubercolosi pol monare non può essere radicalmente cura La, perché noi 110n possiamo raggiungere lo stelo pretubercolare che é il vero stadio bio -chimico che conduce alla tubercolosi. Se anche potessimo sterilizzare completamente un tubercoloso, non avremmo ~atto altro che ricondurlo a quello stadio nel quale era tubercoloso senza saperlo, ed allora sarebbe necessario sviluppare pee molti anni in quell'orgar!ismo quelle profonde modificazioni fisiologiche capaci di cambiarne le condizioni organiche, e d'imprimere
Medica 1363
all'infermo quella tendenza biologica che gl'impedisca di divPnire più tardi un buon terreno di cultura del bacillo d1 Koch . Forse la medicina polra un tempo cambiare questa lPrrib il e prospettiva in molli, se non in tutti i cas i.
Atrofia glan4ulosa ( della membrana muooaa) del veRhioolo . - Prof. NoTHNAGEL. - (Allgem. Wiener niedi.z. Zeitung, N. 21, 1891).
li prof. Nothnagel presentò nella sua clinica di Vienn11 un malato di 48 anni che òa qualche tempo era mollo pallido e dimagralo e si lamentava di continua perdila di appetito. Aveva inoltre un poco di aumento di temperatura, che saliva fino a 39' alternando con temperatura normale. Il numero delle pulsazioui era di 6i al minuto, rarteria radiale era molle, un poco tortuosa, alquanto rigida, l'onda sanguigna mediocremente elevata, la tensione dell'arteria nor~ale. Alle estremità inferiori si osservava un leggero edema. La temperatura che, cl)me si é dello, saliva fino a 39•, dopo la son> ministrazione della chinina (0,25 t re volte al giorno) rientrò nei limiti normali e anche un poco al di~ollo. L'addome era retratto, nella r egion e inguinale si trovavano alcune glandole linfatiche un poco tumefalle. Il fegato era normale, la milza oscuramente palpabile. Nei polmoni non s i riscontrava alcunché di anormale, i toni del cuore e r ano oscuri ma nelli. Nella orina non si trovava albumina, ma piuUosto abbon• danlemente l' indican; del resto l'urina non mostrava al· cuna qualità anormale. A lresam e del sangue si lro'"ò un mecliocre grado di oligocitemia e una leggera leucocilo!!i. Una sola volta furono trovale in due o lre corpuscoli bianchi del !:'angue granuli dì pigmento. li malato vomitava; l'esame del "omilo dimostrò la mancanza dell'acido rloridrico liber o; al contrario riuscirvno i saggi sull'acido lattico; non furono trovale cellule de l lievito nè sardne.
Il prof. Nothnagel fece la diagnosi di atrofia della membrana mucosa ossia glandulosa del ve:1tricolo, e la fondò sulle seguenti considerazioni: da molti anni in questo malato ta mancanza di appetito era l'unico sintomo morboso, ed ora si riscontrava nel contenuto dello stomaco la mancanza dell'acido cloridrico libero. Que!'òlO manca anche nel carcinoma del ventricolo, ma quivi tale mancanza è la conseguenza di un fallo secondario. In certe forme di carcinoma, per es. nello sci rro del piloro, dell'utero. della mammella, atrofizzano le glandole. Quandl) nello !:'tomaco atrofizzano le glandole del presame non può naturalmente nel contenuto dello stomaco trovarsi punto acido cloridrico libero. La mancanza <lell'acido cloridr ico libero non indica rigorosamente la esistenza di un carcinoma dello stomaco, poiché questa atrofia delle g landole del presame può incontrarsi in molte altre ,circostanze e d'altra parte si danno casi di cancro dello stomaco in cui si trova acido cloridrico libero nel contenuto ùello stomaco. La mancanza detracido cloridrico libero non è in alcun modo patognomonica, poichè può trovarsi ovun.que le glandole del presame sono atrofizzate. Ora poichè nel malato del prof. Nothnagel non si sentiva alcun tumore nella regione dello stomaco, poiché nei primi anni non eravi sl8lo vomito, e non vi era dolore, si poteva facilmente escludere l'esistenza di un carcinoma. E particolarmente de· poneva contro il carcinoma la circostanza cbe la malattia ~sisteva già da parecchi anni ; ora un cancro dello stomaco .al più può durare tre a~ni. Era pure da escludersi in questo malato la cachessia malar ica, poiché i fenomeni della mataria, il tumore di milza erano troppo leggeri in confronto della tanto grave emaciazione del malato; non rimaneva altro a cui pensare che una atrofia del ventricolo.
Questa malattia è conosciuta da non molto tempo; anatomicamente i-i presenta in diversi modi. Vi ha una forma di malattia in cui le cellule del presame spariscono CGn la membrana mucosa; queslR forma ~i trova raramente a~sociata con una cirrosi dello stomaco cioè con una iperplasia d el connettivo dello stomaco la quale comprende tutta la parete dello stomaco. Questa forma si potrebbe fllcilmenle confondere con un carcinoma, imperocchè spesso in essa lo stomaco è lanlo ingrossalo da dare al tallo attraverso le pareli addominali come la sensazione di ·un tumore In altre
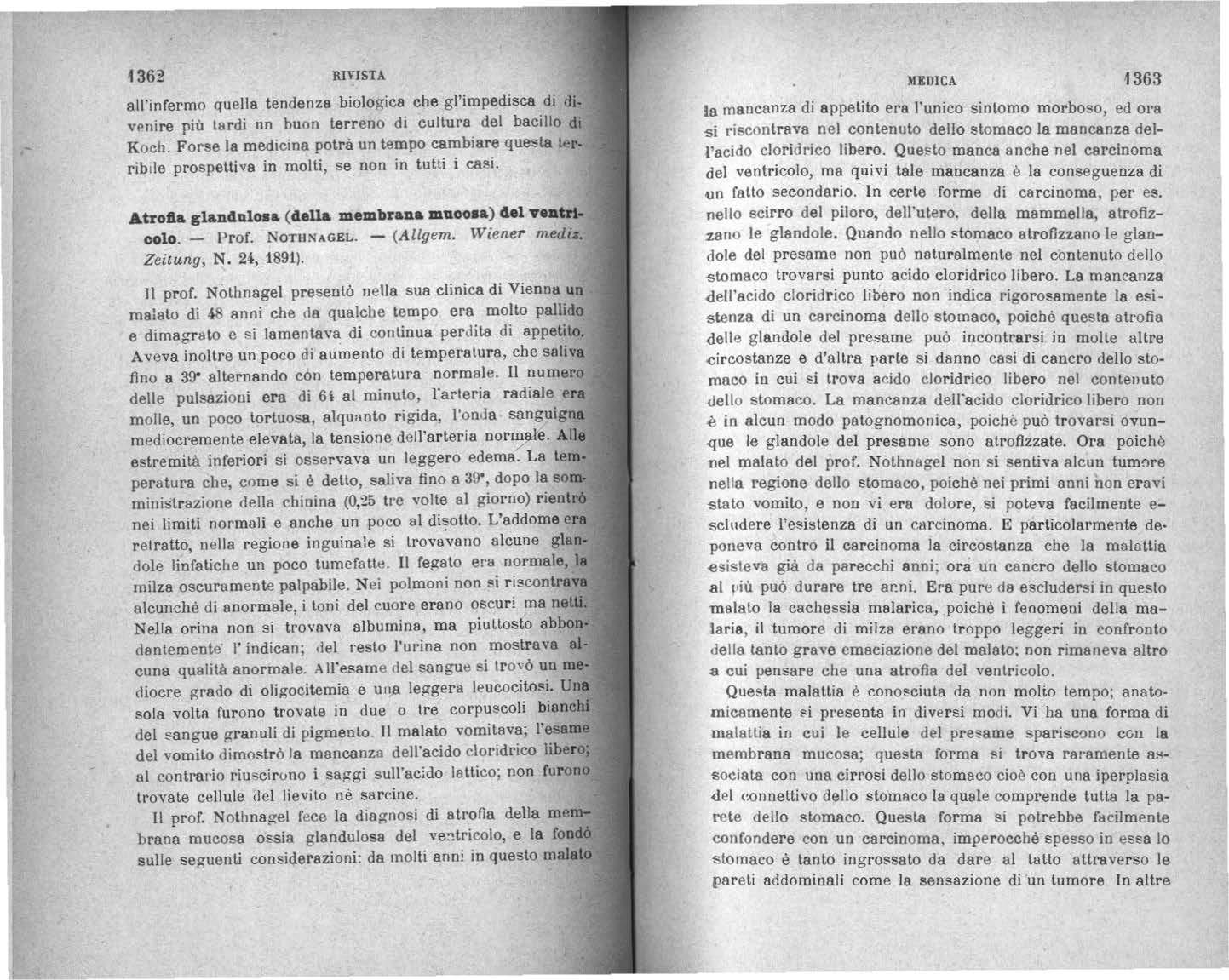
Medica 1365
forme, la parete dello slomnco atrofizza, i malati deperiscono, dimagrano, e si tro va allora alla sezione cadaverica la pare te dello stomaco atrofizzata in tutta la sua estensione, trasparente e sottile come un foglio di carta. La sottomucosa in questi casi é quasi affatto distrutta e la mucosa manca egualmente. Anche in questa forma, come n ella prima, non si può dimostrare il movente etiologico. Nella terza forma, che é la più frequente, si produce l'.alrofia delle glanJole del presame insieme con un cala r ro dello stomaco, nello stesso modo che avviene l'atrofia dell'intestino dopo un catar!'o intestinale. li catarro cronico dello stomaco può condurre ad una proliferazione del tessuto connettivo; il connettivo proliferato al:accia e stringe le cellul e del presam e; e queste allora o atrofizzano o danno luogo a cisti di ritenzione nell'interno della parete dello stomaco. Quindi anatomicamente si dislinguono quattro forme di atrofia delle glandole del presame: primo una forma legata al carcinorn~l ventricolo, una seconda forma legata al catarro dello stomaco, una terza con assottigliamento ed una quarta con ingrossamento della parete dello stomaco, e queste due ultime producentisi senza causa dimostrabile. Il segno decisivo per la diagnosi oei singoli casi è la dimostrazione della · mancanza dell'acido cloridrico libero.
Nel caso· del prof. Nothnagel si trattava probabilmente d i un esempio del terzo gruppo, -quindi atrofia primaria dello stomaco. P oiché nei casi del quurto gruppo cioè con ingrossamento della parete dello stomaco, naturalmente d'ordinario è diminuita la capacità d,,110 stomaco, così la circostanza che un malato prende una gran quantità di alimento senza vomitare depone contro l'ingrossamento dello stomaco, contro la diminuzione della capacità dello stomaco. Poiché questo maiato beveva molta acqua, spesso senza vomitare, cosi doveva ammettersi rassottigliamenlo della parete dello stomaco.
In quanto alla prognosi, essa é naturalmente pessima, poiché non abbiamo modo di porre ostacolo ai progressi del processo. Rispetto alla cura, poichè non è possibile un trattamento causale, dobbiamo limitarci a sostenere con la buona nutr izione le forze del ma lato; dobbiamo somministrargli 11cido clor idrico e pepsina per aiutare la scadente nutrizione; dobbiamo dare con gli alimenti un poco più di farinacei, per rendere possibile una migliore nutrizione, poichè gli idrati "d i carbonio sono principalmente digeriti negli intestini. li Nothnng el prescrive l'acido cloridrico diluito da quattro a sei gocce più volle il giorno immediatamente dopo il pasto. Se la nutrizione per la bocca col tempo diviene iusufficiente, pr ocura la nutrizione per mezzo di clisteri nutritivi; pe r mezzo dei clisteri d i peptone e della carne sciolta nel sugo pan cr eatico;
Sui movimenti pupillari considerati dal punto 41 vista della diagnosi del colera. - M. COSTE. - (Journal de Médecine et de Chiru-r(Jie, giugno 1891).
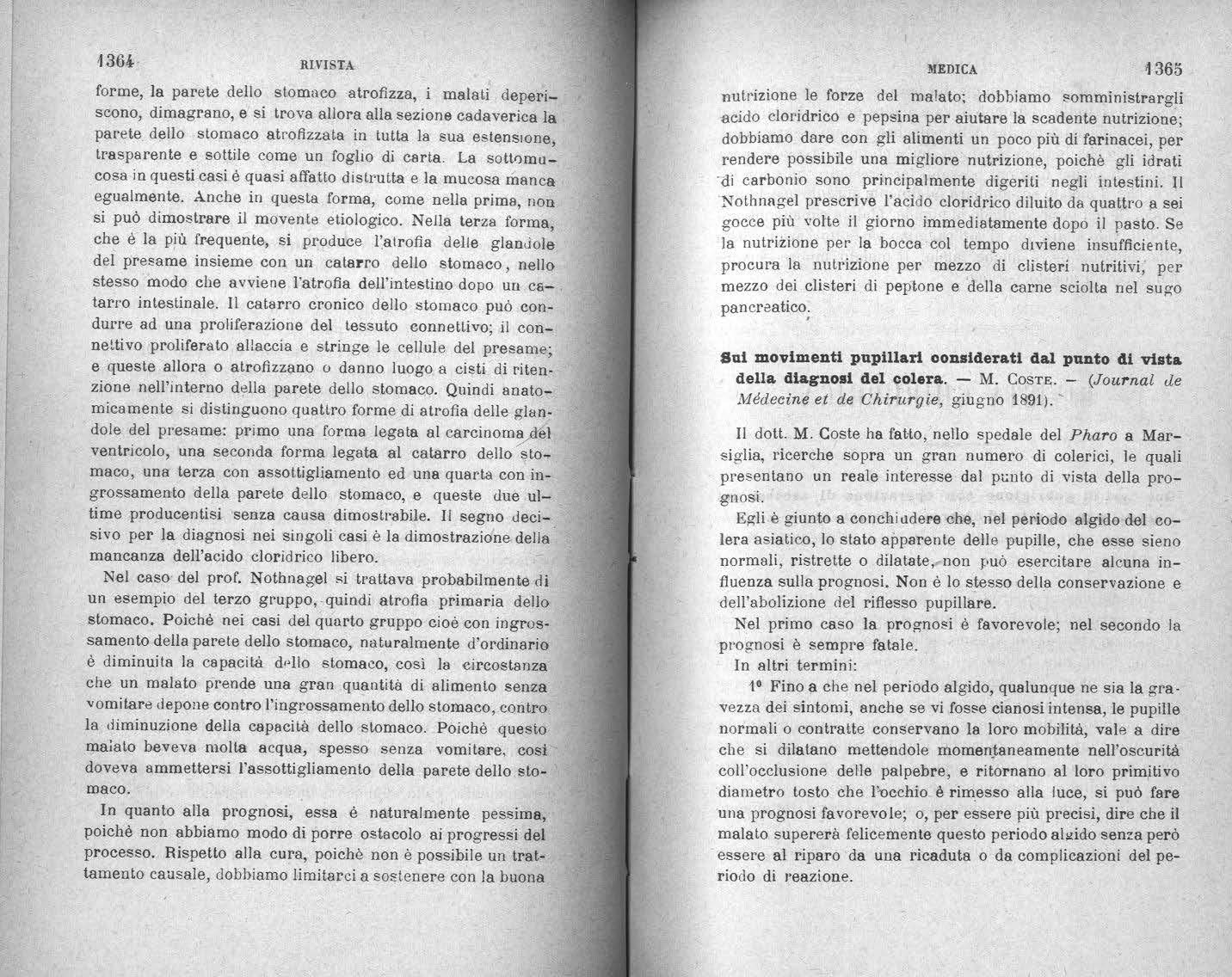
Il dott. M. Coste ha fatio, nello spedale del Pharo a Mars ig lia, ricerche sopra un gran numero di colerici, le quali pres entano un reale interesse dal p;;nto di vista della prognosi.
Egli è giunto a conchit1dere che, nel periodo algido del colera asiatico, lo stato apparente dell e pupille, che esse sieno normali, ristrette o dilatate, non può esercitare al cuna influenza sulla prognosi. Non é lo stesso della conservazione e dell' abolizione del riflesso pupillare.
Nel primo caso la prognosi é favorevole; nel secondo la p ro gnosi è sempre fatale.
In altri termini:
1° Fino a che nel periodo algido, qualunque ne sia la grave zza dei sintomi, anche se vi fosse cianosi intensa, le pupille normali o contratte conservano la loro mobilita, vale a dire che si dilatano mettendole momen_taneamente nell'oscurita coll'occlusione delle palpebre, e ritornano al loro primitivo diametro tosto che Pucchio è rim.esso alla luce, si può fare una prognosi favorevole; o, per essere più precisi, dir e che il malato superer à felic e mente questo periodo algido sema però essere al riparo da una ricaduta o da complicazioni del periodo di reazione.
Rivista Medica
Fin dal momeol-0 io cui nel periodo algido le pupille diventano ristrette ed immobili, vale a dire non si dilatano pi ù colla semplice occlusione delle palpebre, si può essere sicuri~ malgrado che la poca gravezza dei sintomi e la ricomparsa stessa di alcune funzioni possano fa r presagire un esito felice, che il malato soccombera fatalmente durante questo periodo. Se nel periodo algido le pupille dilatate rimangono immobili, vale a dire nc,n si co ntraggono più sotto l'azione della luce, la prognosi è anche fatale. Il malato muore sempr& nel co rso di questo periodo.
IUVIS'l'A CHIHUHGICA
Due oasi 41 go.arigtone oon operazione dl a1oes1l del oervello ln seguito ad otorrea . - PRJTCHARD. - (Zeitsch. f. Ohrenheilk. e Centralb. f. die med Wissenseh., N . 36, 1801).
Il primo caso r iguardava un uomo di 23 anni con otite media purulenta cronica sinistr a. Accessi di perdita della coscienza, contrazioni spasmodiche della metà sinistra della faccia, dolori alla fronte e all'orecchio, passeggera afonia furono i sintomi che consigliarono a fa r e la trapanazione del cranio, prima due pollici sopra e mezzo pollice al davanti del condotto uditivo, e dopo, poiché con le ripet ute punture non uscì marcia, un pollice più indietro. Sulla faccia esterna della dura madre si trovò copiosa marcia, la dura madre però era intatta. I fenomeni cerebrali a poco a poco si dileguarono; la otite media guarì solo dopo un lungo trattamento con alcole, acido borico ed estrazioné di polipi. Nel secondo caso, relativo ad un uomo di 26 anni, i sin-
RIVISTA CHIRURGICA t :l67

· m·inacciosi (brividi vomito, delirio e contrazioni !:>pa- ~m1 , . odiche della faccia) comparvero pure nel corso d1 una. sro · · · l L t l ·te cronica purulenta dell'orecchio medio s 101s ro. a rao I • 'l anazione fu fati.a un pollice e un quarto dietro e sopra 1 :ondotlo uditivo. L'osso e la dura 1nadre parevano ~ompletamente sani, ma pungendo verso l'interno e in avanti venne fuori circa una mezza oncia di m11rcia fetida. Siccome dopo la trapanazione lo stato del malalo poco migliorò , fu fal~ nche la trapanazione del processo mosto1deo, ma non usci a ·1 . marcia. Dopo alcuni giorni, allargando con una sotli e pmzetta 11 tubo del drenai,:gio, si vuotarono circa due dramme di marcia. Allora cominciò il miglioramento che andò proseguendo. La otorrea non 6 an cora gu11rita.
Sul trapiantamento delle 011a - H. Km,fMf.L. - (Deuts. med. Woeh ens., e Cent r alb.J. die med. Wiss ens eh., N. 36, 1801).
secondo l'esempio del Seno, il Kiimmel adoperò esclusivamente ossa morte precedentemente preparate, e le ado · però non solo per riempimento di cavità ossee,. ma a.n~r~ per sostituzion e di ossi completamente mancanti. La l1b1a ù1 un bue o di un vitello è privala del periostio e della midolla, segata in pezzi di varia grandezza e trattala per alquanti giorni con una soluzione al 10-50 p. 100 di acido cloridrico. Quindi questi pezzi si lavano bene nell'acqua, poi si risciacquano con soluzioni di sublimalo e finalmente sono conservati nella soluzione alcoolico-eter ee d1 iodoformio. Secondo lo scopo a cui deve servi re ~i può decalcinare tutto l'osso o lasciare un nucleo interno solido. L'esilo finale di queste ossa preparate dopo il loro innesto non è bene accertato. Esse da ppri ma conservano la forma, come dopo l'innesto delle ossa fresche. All'esame microscopico so no state trovate imbevute di sangue, ma 0011 poterono scoprirsi va~i di nuflvd formazione. Non si è certi se più tardi livvenga una vera organizzazione o una coesione del materiale morto, ma questo non ha pratica importanza. L'innesto di queste ossa preparate
Chirurgica 4369
trova la sua applicazione e pel riempimento di grandi cavità ossee, per esempio dopo le necrotomie e n e lle lacune traumatiche, ed anche per sostituzione di qualche osso completamente distrutto da un processo morboso; e dèi casi tr-Atlati in que$ta guisa offre il Kummel una estesa descrizione.
Sopra un oaso dl gna.dglone d 'un aneurl•ma tra.umattoo dell'arteria temporale profonda anteriore. - J. BRANDT. -(Wiener med. Blatter e Centralb.J. die med. Wissensch., N. 36, 1891).

Un uomo di 37 anni cadendo da una grande altezza riportò una ferita delle parti m o lli del cranio, a sinis tra, della quale presto guarì. Ma già dal secondo o terzo giorno dopo il trauma com!nc_iò a seutire sussurri all'orecchio sinistro e dopo due mesi si poteva anche manifestamente udire con lo stPtoscopio un rumore ::,istolico in corrispondenza della protuberanza del parietAle sinistro, Il rumore si sentiva anchA per propagazione all'orecchio d estro alle oi-;sa d ella faccia ai denti, in diverse gradazioni. Con la compressione della ~arotide comune sinislr,a o dei suoi rami aJl'angolo della mascella il rumore cessava. La compressione digitale della caroti4e e dei suoi rami, alla maniera del Vanzetti, non ebbe alcun effetlo: mentre questa fu eseguita per lo spazio di circa cinque settimane, in tutto 179 ore, si formò un maniJesto gonfiore alla metà sinistra della testti che aveva la ma~~ior prominenza in corrispondenza dell'osso zigotn1tt1co ed 1v1 era anche più manifesto il rumore. Uua energica pressione sull'a r cata zigomatica faceva sentire una mollezza elastica e provocHva un poco di dolore nella direzion e del ~avo temporale, e intanto ce ssava del lutto il r umore. Ugualmente questo spariva facendo pressione con un dito o con un porta-lapis al disopra dell'osso zigomaLico. Dopo cbe si fu assicurato che la compressione per qualche ora del!' arteria temporale profonda, la cui posizione corrispondeva a quel punto sopra l'osso zigomatico, faceva cessare compie· tamente il dolore, il Braodt allacciò quesl& arteria. La op~ r ezione in uno spazio rigido ristretto ebbe tali difficoltà che il Brandt dichiara che in avvenire in simili casi preferirebbe la legatura della carotide esterna.
ScaLEICH. - Sull'anestesia looale ottenuta con la cocaina e con l 'etere . - (Berliner klinisch e Wochenschrift, N. 35, 31 ago sto, 1891).
Co n questo suo particolare processo l'autore è riuscilo ad eseguire felicemente non s o lo più di settanta operazioni chirurgiche variatissime e alcune di esse di grande importanza com e r e sezioni ossee, asportazio ni di tumori profondi, ernioto1oie, ma recentemente anche tre laparotomie per asportazio ne di tumori ovarici e per cancro dello stomaco.
Ecco come si proceòe in questa ane s tesia combinata. In princ ipio si fanno ispirare all'infermo pochi grammi di cloroformio, come nel processo o rdinario, e se 11e limita la dose in modo che rimangano intatti tutti i movimenti riflessi (cornea, pupille, muscoli). Resa quindi asettica la superfi cie del corpo in cui devesi incidere la pelle, per eseguire l'operazione, si nebulizza sopra essa con lo spray del Richardson una miscela di una parte di etere solforico e di quaUro parti di etere di petrolio. Durante l'ett>rizzazione locale si eseguono sulla linea dell'incisione inoculazioni multiple e superficiali di UDI\ soluzione di idroclorato di cocaina in acqua distillota sterilizzata preparata di fresco a 0,75 p. 100, Ta g liata la pelle, se llel penetrare nelle parti profonde si inconlrAno tessuti sensibili, prima di inciderli, se ne può attutire la sensibilità con piccole iniezioni della suddetta soluzione di cocaina. C. S.










