
92 minute read
RIVl STA DI E FISIOLOGIA
Normale E Patologica
Aslone vaso-motrloe del prodotti b&Uerlol. - (Comunifatta aLl' Al!eademia delle Seien;e di Par igi dal BoucnARD, àell' Istituto, il 2G ottobre 1891)
Advertisement
Cohnheim stabili che la diapedesi dei globuli bianchi del eangue i' il fenomeno dominante dell'infiammazione, ritenendola conseguenza di una modificazione vascolare prodotta dall'azione eli cause flogogene direttamente sui vasi. l fisiologi che prima di Cohnheim avevano tentato interpretare con altri fenom eni infiammatori quello della dilatazione vaecolare, continuarono a credere che il sistema nervoso, dalla causa morbifica alle sue estremità perifer iche vasali, subiva o una dei suoi centri vasocostrittori, ovvero una eccitazione di que lli vaso-dilatatori, e che io ambedue i casi la dilatazione riflessa che ne seguiva a livello della irritata , metteva i vasi in una condizione pr op1zia (' sufficiente all'uscita dei globuli bianchi.
Elementi di una novella teoria della diapedesi fornirono MassArl e Bordet, or son diciotto mesi, quando ebber o stabilito che i leucociti possiedono l' irritabilità chimiotassica, già dimostr ata da Pfeffer per alcune cellule vegetali, e per le quale i leucociti, posti in soluzioni contenenti alcune sostanze attrattive e spectalmente le materie batteriche, camminano dai punti dove la soluzione è più diluila verso quelli ove essa é più concentrata. Questi autori ritengono che i leucociti chiusi nell'interno dei vasi sono impressionati dai prodotti batterici esistenh nei tessuti circostanti e superano, in virtù della propria irritabilità, la pare te vascolare per raggmngere le porti ove tale materia batte rica è piu 11bbonùante
. Cosi siamo. or·a in presenza di tre teorie per l'interpretadella drapcdesi: quella che la attribuisce ad una a lterazrone primitiva dei vasi, quella che la fa dipendere da un nervoso che produce secondariamente la dilatazione e quella che la sprega colla attivita propria dt-i leucocrtr.
Tutte tre teorie s'adattano d'altronde alla nozione che riconosl:e l'infezione locale come causa della rmmensa maggioranza delle infìemmazioni. A seconda della teorra o le materie secrete dai microbi ftogogeni, alte r ano l vasr della zoua irrfella, ovvero irritano in quest11 zona le .astremita terminali tlei nervi centr·ipeti i quali prov.ocano u1 questo medesi mo punto la dilatazione vascolore intìne , attirano attraverso la parete vusolo 1 del sa.nguo cl1e circola in questa regione.
L autore amm rso flrr dal principio la realtà di tale ir·r·itabilitù chimiotassica dei leucociti, p e r la quale 1 mrùesimi progrediscono nel tessuto che è sede della inft·zrone locale dai punti periferici, ove le materie batLPriche sou più diluite, verso i punti di maggior conceutrazione lino a con. tatto dei microbi; questa sarebbd una fase p r Pveutiva anterrore al fagoritismo, e solo quando, per·cor so l'indicato cammino, i leucociti sono arri"ati 8 contatto dei botte r·i questi potranno per l' irritabilita tatti le dei leucociti e distrutti.
!'\eli' infiammatione e piu genericamente nella lotta .lelco ntro l'infezione locale vi sono dunque tre atti consecutivi e vicendevolmente legati: t• la che ci venne indicata da Cohnheim ·
2o lo ricurca der batteri la cui intelligenza ci venne' data d n Mas!'ar·t e B or·det;
3o il che ci fu rivelato da .Metchnikoff.
Mossurt e Bordel opinano che le àue prime fasi non 110 costiluic:carro che una sola, bastando l'attrazione ·eserc italH sui leucociti dai prodotti batterici a far loro attraversare la parek A ciò si oppose che nella intìamrnaziont> i Jeueodti non sono soli ad uscire dai vasi, uscendona pure il plasma s a nguigno, che costituiscE> l'edema infiammatorio, che ne sorte con loro, talora prima, e può persino uscirne eenza di lor o; non si può amme t tere che il plasma san8'11gno s ubi s ca l'attrazione dei prodotti batterici.
L'autor e dichiara di aver dimostrato che uno di tali prodotti batte r ici rendP impossibile l'utll) do minante della inftammazi one, la diapedesi. Charrin e Gsmaleia c:tabilirono ehe e '!li si oppone e;ualmente all'usci ta del pl11c:;ma ed alla dilatazioue vascolare infiammatoria; e finalmente Charrin e GJ,.y diede r o l'intE-rpretazione di questi fatti provando che lale !los ta nza paralizza il centro vaso-' lilatatore, rmpedeudo cosi o m oderando la dilatazione vascolare attiva: Bouchard la chiam a anectasina.

L'an ectasina dunque è una sostanzA che paralizza il centro vaso-dilata tor e e per questa ra gio ne imped isco la cungeslione e l'edema infiammatori, e per lo s tesso motivo si opP''ne alla d iapedesi. Herlwi g, e poi Ma!':!'O rl o Bordel ammif; ero a l contrario che tal e so«tanza agirebbe su i binnchi pe r azione attrattiva, attraendo cio!\ i leucociti fuori dar vas i viene secreta dai mic robi nei tessuti, impPdendone i'ul'lcita se iniettata nei stessi; ma le t>sperienze delrautore che vide imped1ta la diape.Jesi in qualsiasi punto lonti\Oo dell'organism o essa. fosse iniettata, al pari che nelle pt'ovano il contrario.
St obiettò 8 f!Ueste esperienze eh<> l'o.,tacolo alla diaprdesi era dov u to all'eccesso !>lesso òelle !>OStanze attratth·e che, troppo concentrate, div engono r epulsi vc, obiezione pure ins u•sis tente e dimostrata erronea da altre esperienze.
L'anectasina oltrecbè al plasma ed a i bianchi, vieta l'uscrta dai vasi anche ai glob uli rO!':"i !>pr·o, della irritabilità chimiotassi ca: essa fa le emo,.ragie e p r oduce remos tasia ischemica. Questo fatto fu dall'autore const11toto nell' uom o i n cinque casi di emotti!> i e tre ros i di onleI'Orrugia .
Co sì l'anectasina non interviene nei processi infiammatori ehe a titolo di age nte inibitore o modet·atore; e so tto questo punto di vista potrà prender posto fra i medicamenti antillogi«tici e per le ma lattie in cui l'infiammazione locale non è una salvaguar dia contro l'infezione gener ale. lnd ipenJentemente dalla febbre, uno degli elementi chiaimpropriamente la reazione della tube r colina, e che pr ova umcamente che il bacillo tubercolare é una di queste materie pi r etogene, vi sono degli effetti locali consecu tivi all'intossicazione generale e che compaiono sovratullo dove vi sono lesioni tubercolari.
Ha vvi un'altra sostanza batterica la cui azione generale è eccil6nte pel centro vaso-dilatatore e che nelle da cui parte una irritazione, produce una congestione rillessa più energica, una essudazione sierosa più abbondantr, una diapedesi più intensa. In certi organi, come i reni, i polmoni, la retina, la sua azion e vaso-dilatalrice può anche manifesta SHnza provocazione.
Questa sostanza che l'autore chiama ectasina é antagomsta della anectasina, e dice averla ::coperta nella tubercolina di Koch fin dal dicembre 1890, Charrin e Gley emit=ero i'opinione che accanto alle sostanze paralizzanti del centro vaso-dilatatore ve ne sarebbero, nei prodotti secreli dnl bacillo piocianico, delle allre che faciliterebb e ro invece le reazioni vaso- dilatatrici, aggiun gen do che l'autore era qualche prim a alla stessa iJea che tra i prodolti secreti da un determinalo microbo a Ialo di sostanze che intralciano la diapedesi possono trova r sene altre che la favoriscono; e ch e anzi più r ece nti et=peru·nze dim ostrano evidentemente ques lo fatto.
L'Arloing (nt'l r end iconto dell'Accademia delle Sci Pnze del 7 settembt·e 1891) confermò queste osservazioni con esperì· menti affa tto diversi e coi prodotti di un altro microbo, lo ma con risultati concot·danti.
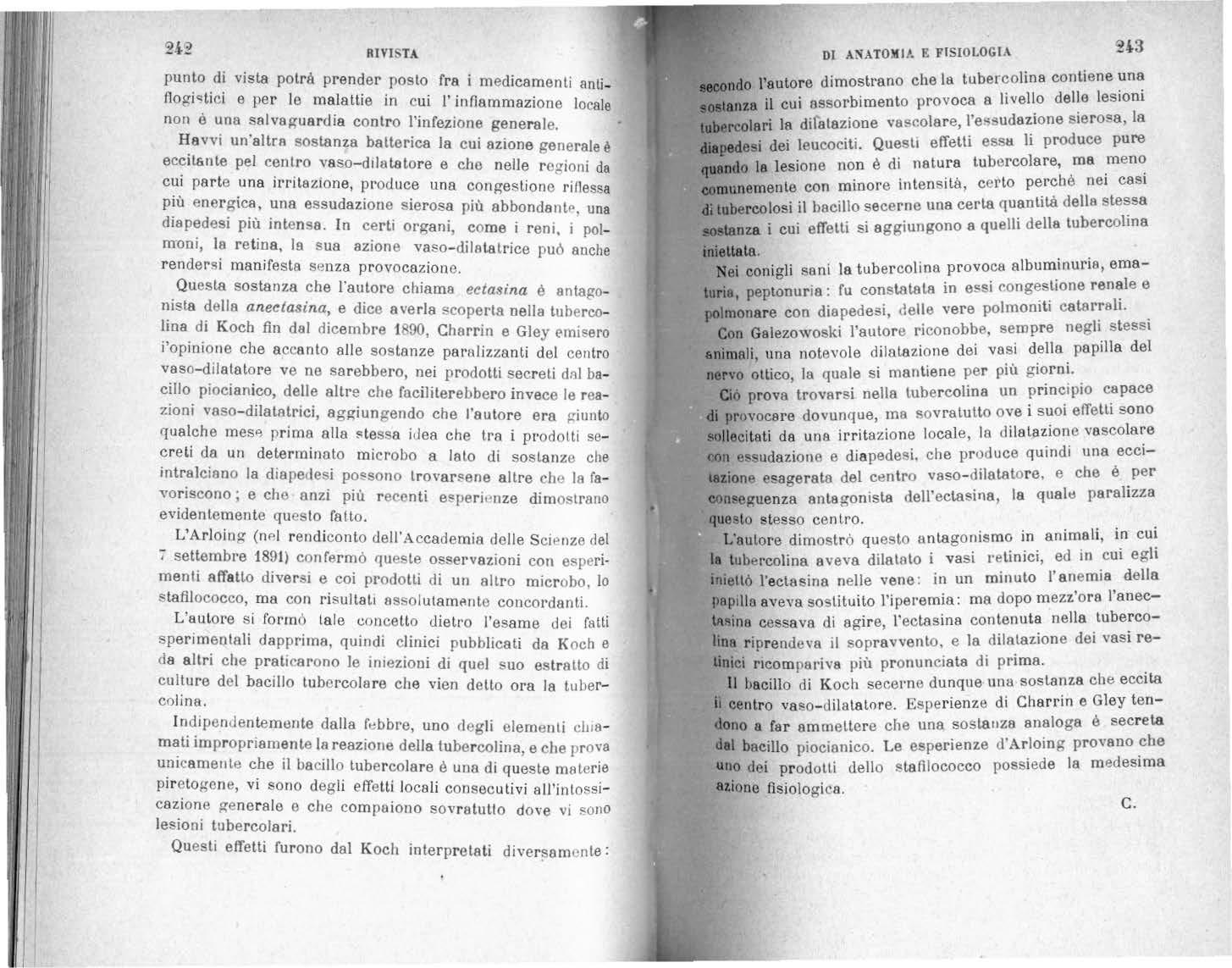
L'au tor·e s i formo tale concetto uietr·o l'esame dei fatti sperimentali dapprima, quindi clinici pubblicati da Koch e da altri che prati carono le iniezioni di quel suo estratto di culture del bacillo tubercolare che vien detto ora la tubercolina.
Qu esti effetti furono dal Koch interpretati diver;samenle :
Di E Fisiologia
ndo l'autore dimostrano che la. tubercolina contiene una 1100 l . . t«l&lanza il cui assorbimento provoca a es1om tubercolari la dilatazione vascolare, l'e!>sudaz!One s1er osa, la diapedesi dei leucociti . Quesll effetti essu. li produce pure quando la lesione non è di natura tubercolare, ma comunemente con minore intensità, certo perché ne1 cast di tubercolosi il bacillo secerne una certa quantità della 808tanza i cui effetti si a ggiungono a quelli della tubercolma iniettata.
Nei conigli sani la tubercolina provoca album10ur1a, ematuria, pepton ur1a: fu constatala in essi congestione e polmonare con diapedesi, delle vere polmonit i .
Con Galezowoski l'autore riconobbe, sempre negh stesst animali, una notevole dilatazione dei vasi della papilla del nervo ottico la quale si mantiene per più giorni.
Ciò prova trovarsi nella tube rcolina un p rin c1p10 capace di provocare dovunque, ma sovratutto ove i suoi effetti s ono sollecitati da una ir r itazione locale, lo dilata zion e vascolare con e!<•mdazion e e diapedesi, che produce quindi una eccitazione esagerala del centro vaso-dilatatore, e che é . per antagonista dell'ectasina, la paralizza ques to stesso centr·o.
L'autore dimostrò questo antagonismo in animali, in cui la tubercolina aveva dilalolo i vasi 1·etinici, ed in cui egli iniettò l'ectasina nelle vene: in un minuto l'anemia della pap11la av eva sostituito l'ipet·emia: ma dopo mezz'ora l'aneclA!\ina cessava di agire, l'ectasina contenuta nella tubercolina ripre ndeva il sopravvento, e la dilatazione dei vasi relinici ricom pariva più pronunciata di pri ma.
Il bacillo di Koch secer·ne dunque una sostanza che eccita ii centro vaso- dilatatore. Esperienze di Chanin e Gley tendono a far ammettere che una sostauza analoga é secreta dal bacillo piocianico. Le esperienze ù' Arloiog provano .che uno dei pr odolli dello stafìlococco possiede la medes1ma 8tione fisio logica.
Balle vle motriol dellingaagglo. - GAL ASSI G.- (R. Ae cademia medica di RomtL, adunanza del27 dicembre 1i<91).
M a r .;hiafava dopo a ver fatta la commemorazione del "ocio doll. Giuseppe Galassi, re ttore nell'Istituto di a natomia patalogica della R. Università di Roma, mancato ai viYi uella fin e di ùtlobr•e p. p., ne presenta un lavoro sventur atamente interrotto dalla morte - Sulle oie motrici del linguayytoma col quale il compianto dott. Ga lassi già era pervenuto a !'tabilire quasi in modo dt>finitivo un tratto d el decor,-o elle hanno le fibre che mettono in comunicazione i centri corti· cali del lingua ggio e le s tazioni bulbari.
Secondo il dott. Gelassi queste fibre sarebber o co!'trtuite da quel fa scio che dal piede del penduncolo cerebrale si solleva penetrando nel lemnisco e per·6 òetto fascio pedun· co lo-tegm Pntale o fascio dal lernnisco al peduncolo (Scllleì · jenbii n del .;um Hirn.schenkel(uss (Obe r stei ne r). Di questo lavo r·o egli non aveva definitivamente che la intr·oduzione e In a coi r epe r·ti anbtomo-patologici macro scopici e rnic r oc:copic i di alcuni casi. Pero, riveden.lo i numero si ap· punti, e g li stud i Svpr'a altri cas i lasciati dal dott. Galassi, si possono riassume r e così le prove che egli dava per attribuire a quel fascio la detta funzione.
l' In quatt r o casi di emiplegia destra con afusia molt'ice egli trovo, oltr e la degenerazione dis1:endente Jelle pi r amidi, quella del fa scio tegmento- peduncolare D i que!'ti quattro casi ve ne ha uno più importante per ché si tratta di emiplegia destra senza contrattu ra e senza segni di paralisi linguale o facciale, mentre l'afa:>ia motoria poteYa d •r si comple ta.
2' In un caso di emiplegia dest ra senza afasia non si ebbe che la degene ra zione del fascio piramidale, rnE:nt re si lro v6 intaUo il fascio tegme n to·penduncolare.
s• In un caso di emiplegia sinistra afasia si trovò dege n erazione di questo fascio a destra.
4• Nei cen tr·i n e rvos i no rma li si tro va dif· fl' ren za di volume di qUI"sto fasc io fra i due lati ; que s ta differeuza è a vanta ggio del fascio di sin istra, notandosi pcr6 differenze note voli individuali e non esse ndo ques to
Di Anatomia E Fisiologia
fascio sempre ben distinto. È degno di menzione un d& emiplegia sinistra con afa sia, nel quale, la m o rte avvenu ta nell'H o giorno di malattia, non trovò uaturR Imente la degenerazione, ma si a che il fascio legrnento· J•eduncolare di destra era piil del sin istro, il contrario cioè di ()Uel che suole avYenrre.
s• Infine tt confortare ridea che quel fasc ro rappresentasse la via m otr ice del il doll GaiOl'-"i si era dalo a sludiarne lo sviluppo. A que"to scopo egli svea d&ato una serie di centri nervosi comp r e"i fra il 5' mese d1 vrla mtr·auterina e il 20' m ese dopo la nascita, ed era grunlo che la rnielrnizzazione del fascio tegmento-pedu1'CO · Jare avviene dopo qut>lla del fascio pir·amidale, c eh.- s'ini · ziava appena in un bambino di venti me"i, il quale pronun· ciavR soltanto poche pa r ole . .
L'insieme di questi fatti, conchiud e il socio Mat•chiafava, ha cosi grande val ore a sostegno de lla tes i sostenuta dopo lavoro dal dott. Gala ssi, da avvi('inarsi ad una dimostrazione compl eta, la quale s arà ve ram ente tale quando in casi di afasia moLr·ice, per lesione limitata al centro cortt· ca'e del lin auaRoio (qu indi senza emiplegia, ecc.) di moo ' . 11trerù la degenerazione discendente i;;olata di C[lrPI 11lS<'IO tegmen to-ped un cola r e .
atoer ohe •alla olrcolazlone cerebrale durante l'attività pelohioa.- Oollori F. DE S.\BLO e C B EHN ARDI.- (Rioista apcrim entale d i freniatria P. di medicina le;a/R, vol. X V Il, rase. 1v, 189t).
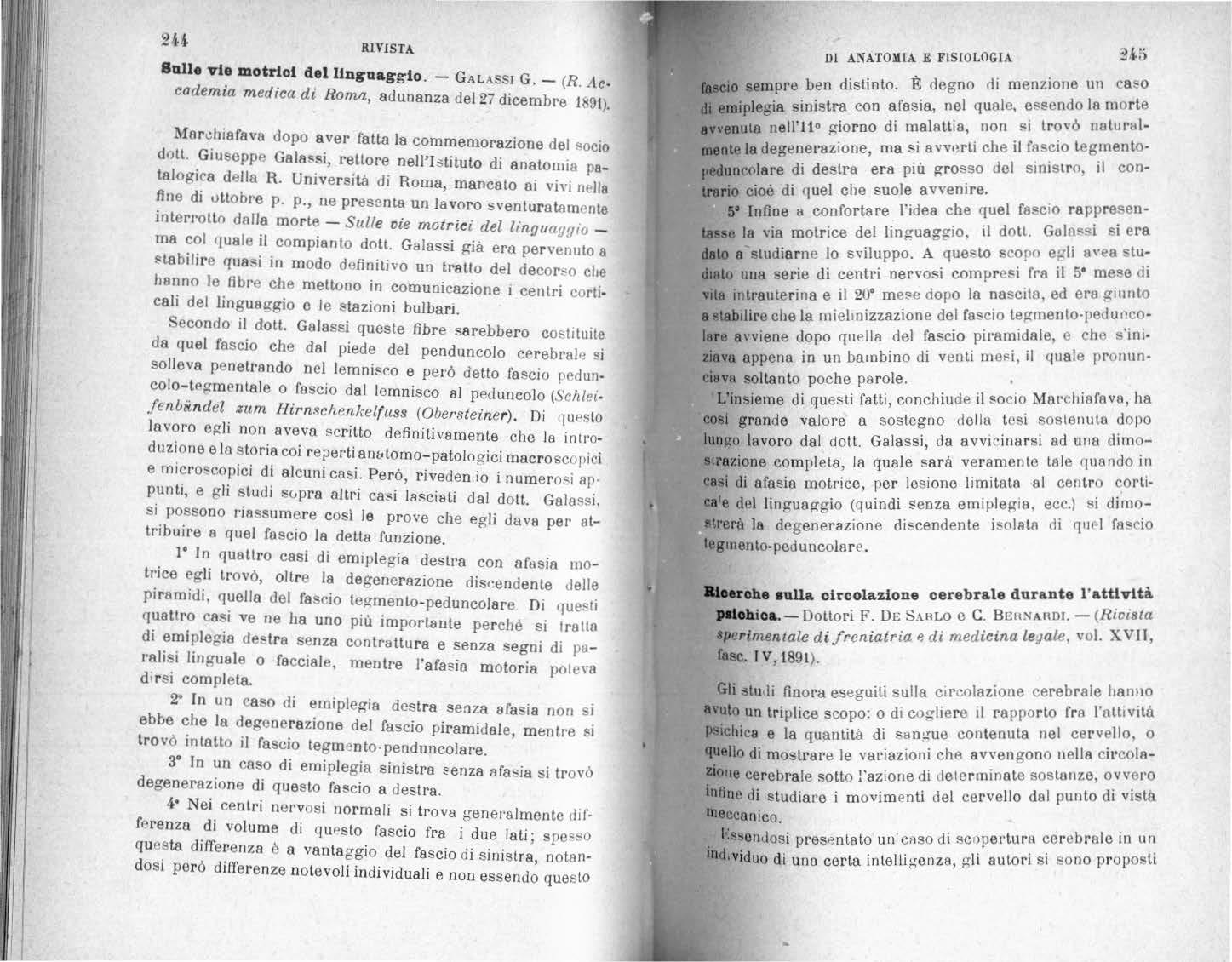
Gli li finora eseguili sulla cìreolozione cerebra le hanno avuto un triplice scopo : o di il rapporto fra l'oltrvi là ps1chica e la quantità di sangue con tenuta nel cervello, o quelli) di mostrare le variazioni che av vengono nella cit•col aziorre cerebral e sotto l'azione di Llelerminate sostanze, ovvet·o intine di studia re i movimPnti del cervello dal punto di vista meccanico.
un cAso di sc!lp et·tur a cereb r ale in un ind.viduo d i una certa intelligenza, g li autori si so no p r opos ti di studiare melodicamente in una . . . le variazioni d l l ' prima serle dJ esper·ienze e c1 rco o cerebrale e pe · . • dell'attività ps· l · rJ e rJco In alcu ne forme . 1C (statJ emotivi) rise r bandosi in . r1cercarne le variazioni "'Otto 1, . . segurto ù1 Dalle esperienze fatte, gl deJ veleni intell etluali. . 1 au o rJ deducono che l' tt" ·
• psrcluca , specialmente nei rimi m . . « a IVJ lé
• rifle t te sui nerv·, vaso . omenlJ, m gene rale SI - cos r1ttor1 · ·
• in molti casi solto co d ' . . ' ma Cio non e sclude che ' n IZIOnJ svariatissime
• alcuna al terazi one va,:;aJ . . • o non si abb1a Un solo fatt e, ovvero dllatazJOne addiri ttu ra. • o appare costante ed è 1 1 1 lungo e reso . t c Je l avoro m entale a m en so mentre a pr· · · minare cosh•izione vasaJe . d mcrplo può dete J•ziOne (ripetizione di c l l,m) uce dopo una notevol e dila toa co o . Pare che le · · nino più spesso e con emozrom determi· Non si può d maggiOr chiarezza costrizione vasale. uoque parlare come re ty 1 gonismo tr a la Cil·colazl·on , b oo a cos tante, di Antae cel'e rale e 1 · · può con fondamento in<lurl'e dali . a perJ erica, n è si quella. Non ò possibile Il o stato dt questa lo stato di . . ne o stato attuale delle · t'v. gn iZIOni lìs!'al'e se i r isultati . . sc1en JtJChe cotale ordine dipendano d . che si ottengono in l' . a az1one de1 vaso dilat t . ISJ dei vasi costrittori· p . t a ori o da pa raaltri. U na cosa sola s/p uòo che Cl entrino gli uni e g li . . u asser1re ed è che le . t r addJz•oni dipendono per . apparenti ro ubilita dei cen tri nervos· d al variO g rado di eccita· . l, e per a tra dalla com r . glOre o mino r e dei r·itlessi P Jcazlon e mag-
Val'lulont numeriche d l blanohlln rapporto o le globuU ro..i e del globuli o paraaslt& della 1 tore AN rO!IiJO DIONLSJ. _ (L S ma aria - Ool· o pertmentale, fase. 3-4 , 1891).
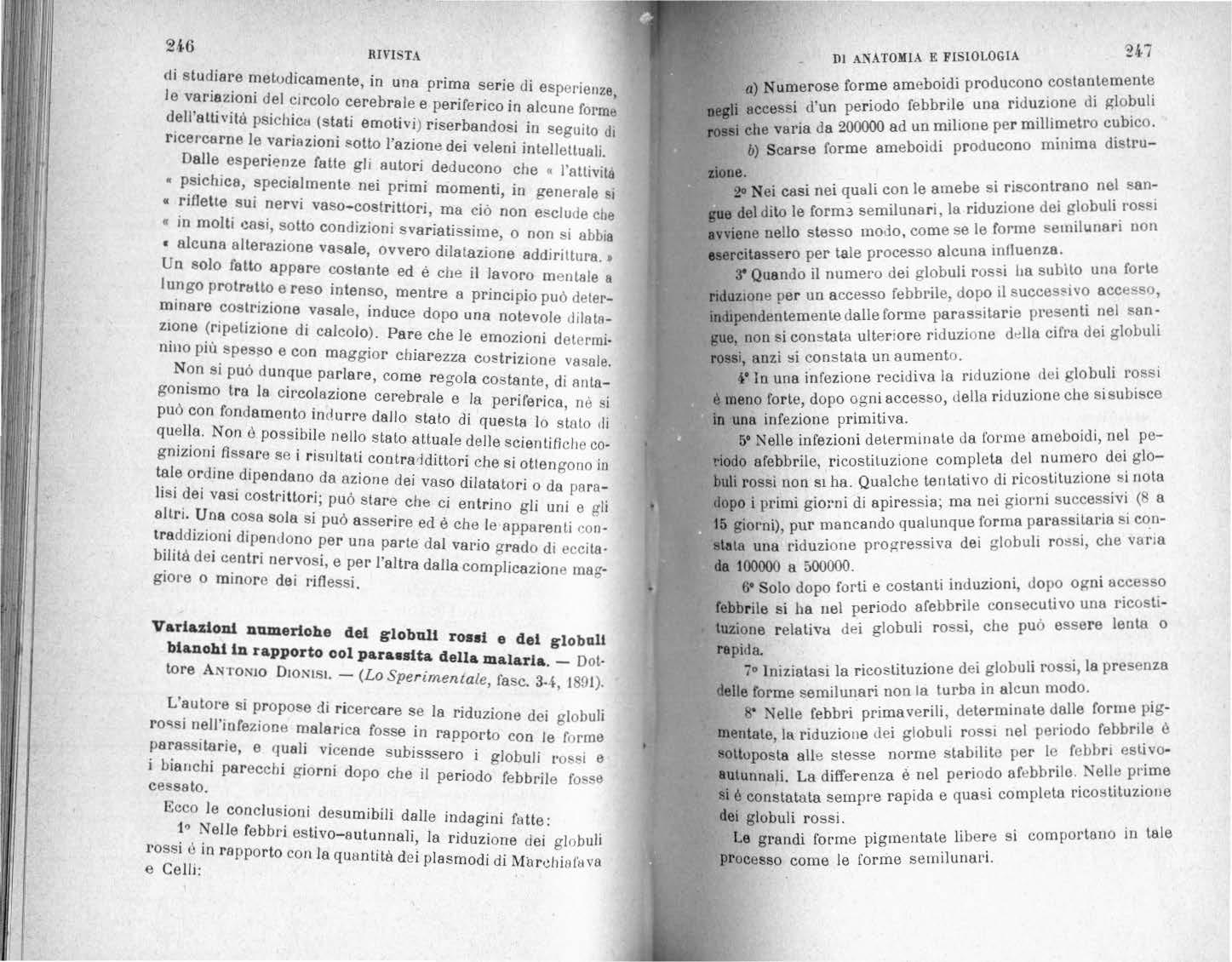
L'aulol·e si propose di r icel·care . . r o'lsi nell'infezione maJa . s.e la riduziOne dei globuli ' r1ca .osse tn r parass1tarie e (I Uali v1 · b. apporto con le forme . . ' ce noe su 1sssero · 1 b . . 1 b1anchi parecch 1 · g1 · 0 d 1 go uiJ l'OSSI e rm opo che 'l · d cessato. 1 perw o febbl'ile indagini fatte: r ossi è in la riduzione dei g lobuli e Calli: n a quanlltà de l plasmodi di Milr...:hiofa va
DI ANATO MiA E FlSlOLOGlA
a) Num er ose for m e am eboidi producono costantemente aegli accessi d'un periodo febbrile una ri duzion e di globuli rossi che v aria da 200000 ad un milione per millimetl'o cubico.
b) S ca r se forme ameboidi producono minima distruzione t'In una infezione Pecidiva la riduzione d oi globuli rossi è meno fo r te, dopo ogni accesso, della riduzio n e che s i subisce in una infezione primitiva. s· febbri primaverili, dete rminate dalle forme pigmenlale, la riduzio ne dei globuli r ossi nel pe1·iodo febbrile è sottoposta alle stesse norme stabilito per le feb bri es tivoautunn ali. La differenza è nel periodo Nelle p1·ime si é co ns tatata sempre rapida e quasi completa ricosliluzioue dei g lo b u li r ossi.
20 Nei casi nei quali con le amebe si r iscontrano nel sangue del di to le form3 semilunari, la riduzione dei globuli l'Ossi avvien e n ello stesso modo, co m e se le forme semilunari non eaerciLasse r o per tale p1·ocesso alcuna influenza.
:r Qua ndo il numero dei globuli rossi ha subito una forte riduz wn e per un a ccesso febbrile, dopo il succeS"I VO acce'-'SO, indipendentemente d alle forme parassitarie presenti nel sangue, non si constata ulter iore riduzio ne de lla cifru dei globuli rossi, an zi si constata un aumento.
5' Nelle infezioni determinate da form e ameboidi, nel periodo afeb b r ile, ricostiluzione completa del numero dei globuli r ossi non st ha. Qualche tentativo di ricos tiluzion e si nola dopo i primi gio1·ni di apiress ia; ma nei giorn i s uccessivi (8 a 15 giorni), pur mancando qualunque forma pat·assitaria si consl.ala una riduzione progt•essiva dei globu li r ossi, che var1a da 100000 a 500000.
6' S olo dopo forti e costanti induzioni, dopo ogni accesso febb r ile s i ha uel periodo afebbrile consecutivo una ricosliluzion e r elativtt dei globuli rossi, che può essere lenta o rapida.
-;o l nizialasi la ricos tituzion e de i globuli rossi, la presen za delle forme semilunari non la turba in alc un modo.
Le grandi forme pigmentate libe r e si compot•tano in tale processo come le forme semilunat•i.
. 9o l bianchi !:ieguono in molti casi la sorte dei g lohuh tanto nel periodo febbrile, che nel pe 1·iodo 8febbrlle
10 q.uest'uHimo periodo fanno il cammino oppo>:to, cioe subiscono mlera riduziorre, mentre i globuli l'Ossi ri:ruaiagnano la loro crfr a no r male.
Rivista Delle Malattie Veneree Edella Pelle
Oaaervaztont a propoatto dell' iDooulaztone dell' uloera aemplloe.- D. COJGNET.- (Lyon mèdical, 6 decembt•e 18!.ll).
Con qurJsla sua comunicazione l'autore mira soltanto a sealcun t pun ti reltttivi all'inoculazione delle ulcel'i, fatti uttiJ a conoscersi in clinica e clte sono dovuti ad indagini falle dal professore Auùerl.
Si sa che l'ulcet·a Jura non può che eccezionalmente (>Ss:re a chi la porta, e ciò solo nei primi d1 sua. esistenza. L'in oculabilità dell'ulcera semphce, che mvece dJ r1•gola succede, costituisce spesso un mezzo prezioso nei casi di diagnosi duhbia.
P e r pratica rla SJ dovono seguire al cune norme: e sseudo bisogna fat• la puntura piccola e superficiale, onde evitar e per quanto è possibile che l'ulcera ragg•unga il de rma profondamente. Essa dovrà pure essere fatta, quauto prù t--J può, lontana dagli organi genitali, neJJa
P_arte sovraombe lrcale del tronco o, per esempio, nelle bruc·
CJa , pe.rchè l' inoculazione è allora meno attiva, e si può spe· rare dt a r rtlslarne pil! presto i progressi il che non è serupre facile '
Fino dal g iorno dopo l' invculazione si pu6 formulare qual-che regola p ratica, vale a di1·e: .
RIVISTA DELLE MALATTit VE!(EREE E DELLA PELLE 249 t• se nel punto inoculato non si riscontra nemmeno la più piccola areola infiammatoria, si può affermar e nulla più si e la prova sar_à
2" s e han-i una piccola zona mfiammatorra un po a rrosNta non dolente, è impossibile pr onunciarsi : l' moculazione potré spar ire completamente, oppure svol:;tersi l'ulce:azione, anche do po essere rimasta per più giorni c:taz1onarra ; a- Fins lmenle, se si ha una vera pustola ben formata, con zontt perrft?rica mollo infiammata, si può dire che l' inoeulazione e pnsiliva: in tal caso e inutile al tendere piu a lun go. perchè ogni istante perm ette all'ulcera di estendersi, e qui ndi è necessario affrelltt rsi a distrugg-erla r apidamente. A tale scopo si leva la ct•osticina o si rompe la pustola; lt1 si locca per 3 o i giorni con 1.:na soluzione alcoolica di acido fenico e si m edica all'iodoformio come viene ra cco mandato da tutti gli autori.
LELOlH. - Cura della atfllide. - (Ga:tette des HOpitauoc, numero 108, 1891 ).

Il pr ofes!<ore L eloir dà i seguenti consigli pe1·la cura dPIIa
Cura locale dell'accidente p rimitivo con preparazioni mercuriali: empiastro di Vigo o l'empiaslr o mercuriale di Unna. Lozioni biquotidiane con una soluzione di bicloruro di mercurio.
Nd specificc. egli dà la p r eferenza alle friZIO ni me r cu riali .
Friz•oni quotidiane con 2 a 4 g r ammi di unguento me.rcuriale per quindi ci giorni consecutivi, poi riposo per qumdiei dopo i quali ripresa delle f1·izioni, e di seguito pe1· d1eci mesi.
Contr o le sifilidi, cura locale colle preparazioni me r curiali: bagni generali con sette g!'ammi di s uLlimato.
Igiene della bocca; igiene generale, tonici, soggiorno in CAmpagna o in riva al mare.
Dopo diec i m esi, frizi oni mercu1·iali pe r· ùieci giorni ogni Illese e ciò sino al la fine del secondo anno. Sudoriferi, qual- che pur gante, e ser cizio .
I n caso di cefalea per sistente, dare 2 a 3 gr·ammi di ioduro e 50 centigrammi ad un grammo di bromu ro pota ssico.
Durante la seconda annata, supponendo anche che il soggetto non presenti alcun accidente, ogni tre mesi, per• dieci giornr, ritornare alle Criz 10n i mercuriali susseguite per Yenti giorni dalramministraz.ione dell'ioduro potassico.
A partu·e dalla te rza o quarta annata, ripetere il trattamento misto due volte soltanto nell'annata.
L'e s11geraz.ione della medicazione mercuriale e iodurata può cagionare disturbi nevrastenici simulanti talvolta la sifilide cerebrale
L'autore non é partigiano del tr attamento mercuri ale interno a cagrone dei disturbi digestivi che esso produce: egl i lo riserva :
1• Alle donne maritale che non conoscono l'ori gine del loro mole;
2' Alle persone che hanno la pelle troppo irritabil e;
3° Alle persone che vogliono dissimulare la cura.
Egli crede dover riservare le iniezioni sottocutanee curiali alle donne pubbliche, che si rifiutano spesso di prendere i loro medicamenti.
MEt..ANDER.- Cara aborUvadei baboni. -(Cent ral blattftlr Chirurgie, N. 26, 1891).
B enché l'estirpaz ione sia ora dalla maggior parte dei pra · tici ritenuta il metodo di cu r a dei buboni più razionale e pril !"icuro, pure cerca continuamente di sostituire a quella una cura più SP.mplice, che, cioe, abbia piuttosto per effetto di prevenire la suppurazione. Le esperienze che il M elande r Cece iniettando nei buboni un nuovo medicamento avrebbero parlato assai favorevolmente per il metodo abortivo o in modo da in coragg1are i pratici a proseguir e negli esperimenti.
L 'autore adoperò per le iniezioni il benzoato di mercu!'io preparato nella quantita di 1 p. 100 con una soluzione acquosa di cloruro sodico a ll' 11 / 2 p. 100 . Di questo liquido ·egli suole
DELLE MALATTI E VENEREE E DELLA PELLE miettare mezzo grammo in uno o più punti, quindi applica la r811ciatm·a compressiva e prescr.ve al paziente la massima . . vescicole semin ali nell'adulto sono for•mate di tubi bea n Li, varicos i, con volu ti, ed a fondo cieco, uniti fra loro do connet· livo che li nvvolge e ne fo rma u na p ira mide di cinque centi metr r di lunghezza e di 3 centimetri di spessore, rivestiti inter namente da Mllile mucosa reticohua. Questi due corpi pi r amrdali Edacc •o no ar la ti della ba se della vescica, fra essa e J d r elto, n e ll'ango lo fo r mato della vescica e la pa r ete pelvica. U na superficie dell e vescico le spermaticlte r esta immediatamente d ie tr•o lo p r ostata , eù il loro corpo, • quando è mod eratamente dis teso dal li quido che contengono, si può $entire con un dito nel retto, speci a lmente se la vescica o r ina r ia contiene dell'orina. Le vescicole sono mantenute ade r euti all'uroci o.::.ti ùa un r obusto strato della fascia rello- vescicale le unisce alla capsula della pr·ostata, e si continua indietro con la fascia posteriore d ella vescrca orinaria; sono quindi in maggior conness ione con la vescica che col r·etto.
Ne i buboni che non erano ancor passati a suppuraz1one, ma che indubbiamente presentavano i caratteri della flogosi suppurativa, l' a utore ottenne 30 volle sopra 33, vale a di re nel !H p. 100 dei casi, una a ssol uta o quasi del proee!I!IO; e ciò in un tempo relativsmente breve (da 10 ad1 m ese), e senza provocare il menomo incomodo.
Se un simile risultato continuasse a verifì!!ars1 in una più grand e c:erie di esperimenti, il nuovo metodo segnerebbe dav\' ero un progresso nella terapia di 11uesta atfezione.
JoHDAN LLOYO. - La apermato- oistlte , o 1nflammas1one 4alle veaoloole aeminalt. -(T!te Lancet, ollobro 189l.)
L'auto r e è spinto ad esporre le sue osservazioni su questa malattia a bbastanza frequente i n complicazione della blenorrea maschile, perché la vede assolutamente trascurata nei libri dr lesto, com'era trascurata la alcuni anni or sono. p r ima che Lawson Tait e la scuola ginecolog1ca dì l'additassero ai chi rurghi.
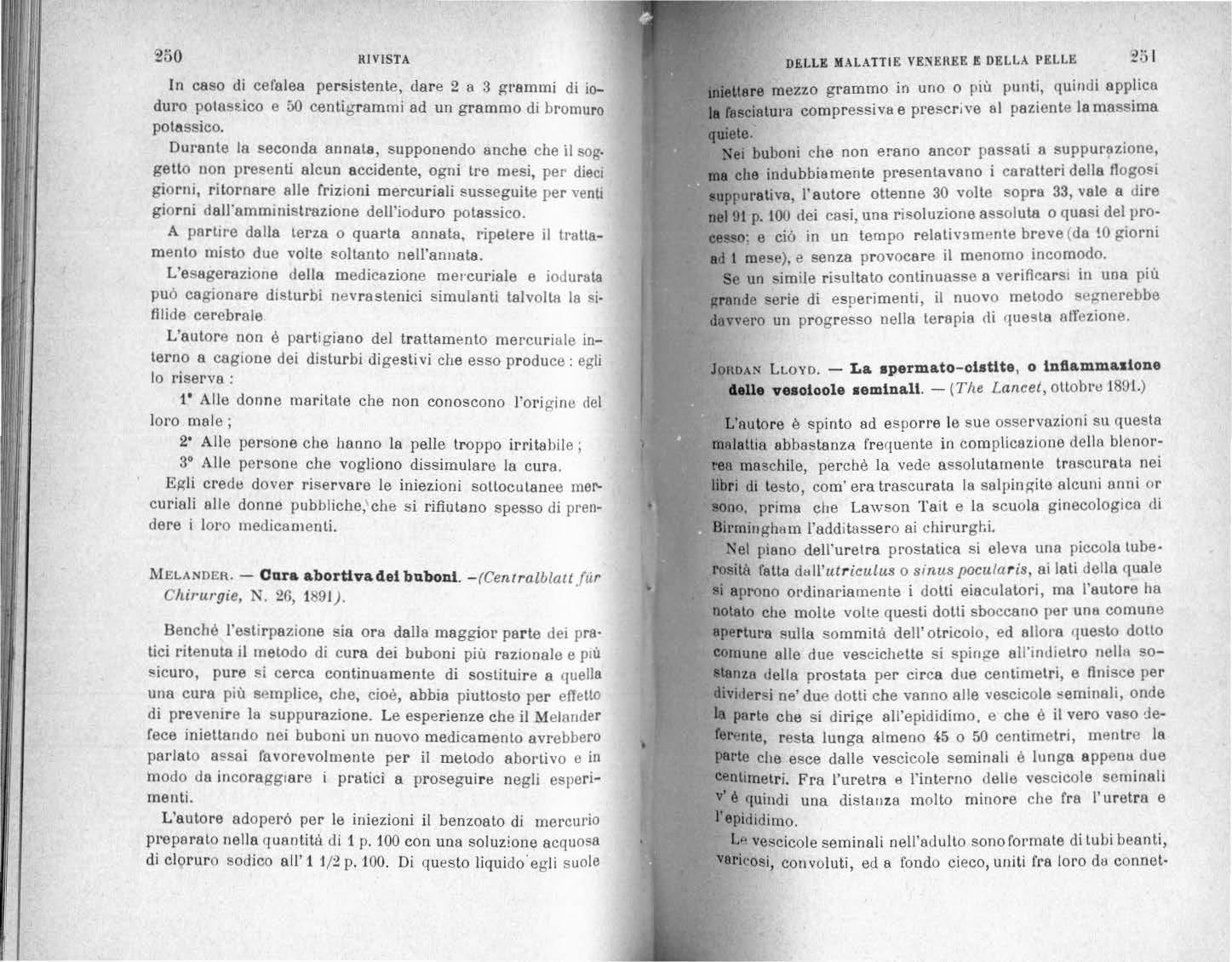
Nel piano dell'uretra prostatica si eleva una piccola tuber osità fetta dall'ut r iculus o si nus pocula r is, ai lati della quale si a prono ol'dinariamente i do tti eiaculatori, ma l'autore ha notato che molle volte questi dotti sboccano per una comune aper tura sulla sommita dell' otricolo, ed allol'a •1 uesto dotto eornu oe alle due vescichetle si spinge al l'Indietro nellll sostanza. della proslata per circa due centimetri, e finisce per divide r si ne' due dotti che vanno alle vescicole onde la par te cbe si dirige all'epididimo. e che é il vero vaso defert• nte, resta lunga almeno 45 o 50 centimetri, mentre la parte che esce dalle vescicole seminali é lunga appentt due centim etri. Fra l'uretra e l'interno delle vescicole seminali v'è quindi una distan z a molto minore che fra l' uretra e l'epidid imo.
P alpaudo le vescichelle seminati dalla r·arle del retto, bisogna r icord a r e che si possono sen ti r e ve r so i lati della pelvi, e n on n ella linea mediana. I lo r o vasi san gu igni sono r·am i della ves1:i c ola infe r iore e dell e emorr oidarie medie, i loro ne rvi p r ovengo n o dal plesso ipogaslr ico del !>impatico.

La spermalo-cistite è qual'l i sempr e secondaria di u r etr rte l'infia mmazione co mincia dal meato urinario. passa ne ll'ure: tr·a a varia distanza, talvolta fino alla fossetta navi col11 r e o poco più giù, tal'altra fìno alla pelvi r enale, e fr·equentemente occupa il tratto genito - u r inario che sta lungo il pas· saggio fr a le vcscichelle seminali e l'epidiciimo, ond e tutLi i pr·atici riconoscono un' opididimite blenorragica, cd attr:buiscono po i ad una p r·osta tit e acuta s ubacu la o cronica od una c is tite ce rvical e, a spasmo riflesso dell' u re t ra i fenorr:eni de lla spe r m ato - cistite; ma un 'i nfiammazione che ò giunta ai condotti eiacula t0ri, si estenderà piu f1.1ci lmeote pel br'P\'e tratto che li separa dalle vescichelle sperma tiche, che non al lungo tratto che conduce all'epididi m o, cosa che puo es · se r e costatata con •lei r elto, in ogni paziente si la gna di fr equente orinazione.
L a spermato-cistite e l'epididimite sono entrambe secondarie d' infiammazio n e ure trale, si prod ucono fr a la terza A qua rta s e t tim a na dell'u r etr•ile, il pr ocesso infia mma to r io col·
DE LLE MALATTIE V.E :"iEREE E DELLA PELLE
t»Jeee in am t•o i ca si il connettivo intertubulare, è carallenzzato da go n fio r e carnoso e r·esistenle che for·ma una m asstt ovoida l·· la '(Ual e r ie mpie met.a dello scr oto nell'orchite, e si eente nellll pa rete anteriore del r·etto nella spermelocistite, al punto da !'Ca mbia rla con un'infiammazione pr ostalica. Nell'epiùiùimite non è il testicolo che si gonfia m a il connetUvo che tiene a ssie me l'epidid imo, nell a sper ru ntocistile no n •\ la pr os tata che s'infia mma, ma il connettivo vescico· lare o pe ri- vescicolare, come si puo rilevar·e con accurata osservazi one; la suppurazione in ambo i casi è un'eccezione. la è la rego la; gli a scess1 che per caso si fo rmano nella profondit à della pelvi, possono aprirsi nel retto, nel perineo, nell' ur etra, nella vP,.crca, ed in rare contingenze è visto il pus farsi stradtt d1Jile ve.scicole nella cavità p!> r ito neale per lo spazio di La sp ermato -cistile si manifesta nell e tre fo r me, acuta, subacuta e cr onica . L a p r ima complica o r dinariamente ltt ve ra go norrea, la seconda si ve r ifica ne ll e uretrili n o n speeillehe, la te r za é u n postumo di una delle due. Siccome è malattia che non uccide, quindi si r 1!\contra sul tavolo an atomiro per puro accidente, ed il J'•·perto anatomo-patologico non può esser completo; ma l'autorP, che ha esaminato le ve'lcicole !'emioali di mo lti C>tdaver·i, ha trovato delle sen&•bili differenze sulla loro strullut·a, forma, volume, ade renze, non solo fra diffe r enti cadaveri, ma fra le due vescicole del individuò, differenze che lo couvincono della realtà della spermalo - cis lile .
l sin tomi della m alat tia in pa r ola identic i a quell i che cara tterizzan o le di ve r se variela di pros tati te, l' irrita bilità della vr '!cira e la cistite del collo, cd una co rretta diagnosi rr. ques ti-' complicanze della blenor-rea può farsi soltanto con un a cco.J r ato ri s cont r o del retto. La p r ostatile é abbastanza rara in confronto della spermato- cislrte; questa si •nanire!!ta nella seconda o te r za settimana dell'urilrite, l'infermo si a principio d'un incom odo, poi d'un dolo r e pulsan te n el prorondo della pelvi e n e l peri neo, con aumenltta (re quen za di Ol'i na zione che giunge finO al tenesmo VC· leieale. Il dolo r e s i acc r esce con la d is tensione della vescica, s' ir1'ud a u lrestl·e mitA del pene nlla fine dcll'orioazione, dopo la quale si calma ulquanto, la defecazione é spesso dolorosa il flusso del pus dall'uretra tliminuisce e può an che parire, l'orina è acida e torbida, contiene corpuscol i di pus e di sangue, lascia un leggier o deposito di muco.
Nel retto si sente col d1to un gonfiore che occ u pa tutta la base delhi vescica, e si estende al di la del punto che il di to può r aggiungere, avve ngono frequenti erezioni, e talvolta eiaculazion e se minale.
La spermato - cistite su bac uta ha gli stessi sintomi improntali di mi n ore gravezza, ed occo rre più frequentemente neJl'uretrite non infettante La cronica 8i distingue per la pertinacia dello scolo che recidiva con facilita, per la faci ie irritabilità della vescica, per l'eiaculazione spermatica di colo r rugginoso, e l'esame del retto in questa forma c1•onica l'ivela una vescicola distesa ed indurita che facilmente si rlistingue dalla prostata, perchè più soffice, e se su questa vesc icola !t'impianta una sirin:;ra e si aspira, il liquido che se ne estrae contiene degli spermalozoi.
La prognosi in ogni caso è favt>revole; lo stadio acuto e subacuto ordinariamente finis ce con la ri soluzione, c, quando avviene la suppur azione, u n' incisi0ne a tempo procura la guarigione. La sper malo-cistite cronica dura per mesi, ma fìni"ce con la guarigione, e raramente si protrae per anni.
La cura ò que lla ste sa della prostat1le; nella sperma locistite acuta giova il rip•>so i n letto, la d ie ta blanda, 110a doz1.ina di sangUisughe al pet·ineo, le fomentazioni calde. i suppositol'i di belladonna e morfina, i !assali vi per mantenere il ven t re obbediente, il cateterismo con candelette di guttaper ca se avvengono i restringimenti. Bisogna invigilare la suppuraz ione con l'esame nel rello, e se si mani festa, esegui 1·e un'incisione con ltt guida del dito, preferibilmente per la via della cute del periretto. Quando l'ascesso si è t'atto slt·ada nella vescica, nel retto, nella fossa ischiorettale, bisogna istituire un drena gg io all'esterno.
Lo fo rma Cl'onica è la meno trattabile, ma se il caso lo richi ed e, si può, con la del dito nel retto, fa re un 'aspirazione con la siringa nel tumore for·malo dall e ve scicole,
DiLLE MALATTIE VK'U ,Ui R DiLLA PBLLR e 88 l'aspirazione non r aggiunge lo scopo, si possono incidere le vescicole dAlla via del perineo. Quella goccetla che sfi auto1•1 ritengono attribuibile ai restringimenli, è guenza d ella s p ermato- cislite cronka.' e non cede alle dtlatazioni, ai cau stici, nè all' uret r otomta, ma può cedere ad un'astinenza dal vino e abusi venerei.
RIVISTA DI TERAPEUTlCA
h1la aslone terape atloa dell'acido borloo . -Dott. JAENICKE.- ( Th erap. Monatshejleund Forts eh r itte de r Meàiz. e Al/g . W ien. medi::. Zeitung., 189 1).
Da speri menti con lo staphylococcus aureus e i bacilli dei car bonchio il J aenick e ha concluso che la forza disinfetta nte dell'acido borico è leggerissima: i primi mic r ornnismi a nche dopo 8-14 giorni di stanza io 4 p. 100 di acido borico, i b a cill i della milza privi di spore anche dopo 24 ore erano se m pr e vivi e capa ci di infettare. È cosi è che una ferita r ect-nte può essere infettata med iante la irrigazione eon una soluzione impurA di acido borico. L'acido bor ico cbe dopo La irr igazione rimane ancora nella fe r ita é presto riassorbito; i germi ch e sono introdotti con la soluzione sono Yivi e possono nella fer1ta stessa moltiplicarsi e IJropagarsi. a vviene della proprietà contr ariante lo sviluppo dei mic roganismi. Non la vita, ma Le manifestazioni della Vita deg li schistomiceti, la lor o m olti plicazion e e la formazione dei loro prodotti vele nosi può l'acido bor ico limitar e ed &rt'es tare. Giù con poca quantità di acido borico (3- 9 p. 1000), la proli fera zione dei più d ivers i rnicroganismi, (stapbylo coccus 11 ureus, streptococcus pyogencs, bacillo del car- bonchio, bacilli del tiro, spit•illi del colera, ecc.) è ritarda ta di molli giomi ed è !:'tentata. l!: provato che nel siero del sangue e nel brodo ogni cottura di batteri è re sa impossibile dalla aggiunta del 2 1/ 1 p. 100 d1 acido borico.

P e r potere al•pll care utilmente que;,ta proprieta alla l•!· rapia, biso gna che l'acido boric:o Sl& fatto agire nella fer ila chè é naturale terreno nutritivo degli patogeni, nelle stesse condizioni con cui agisce nei mezzi al'lificiali di nutl'izio ne sugli scl11zo miceti. La ferita deve esset'e coperta da uua sufficiente quAntità di a cido borico e perman entemente fir.o alla guarigione; in tal modo essa e affHtto inadatta alla moltiplicazione e all'ulteriore sviluppo dPi mi· crorgaoismi Questo scopo non si ottiene con la se:r.plice laVtltu r a della fe r ita con 4 p. 100 di acido borico, quando anche ripetuta più volle al giorno; la piccola quantita che ve ne r esta à ben presto riassOI'bi la. Il miglior método consiste nel cuoprire o r iempire la rer·ita con sl!'iscie di garza impregnata di una soluzione al 4 p 100 (satut·azione a freddo) o 7 p. 100 (saturazione alla temperatura del s an gue) o :?5 p. 102 (.;aturazion e a caldo). Queste rnedicature devono essere preservate dall' con fùgli di gulltlperca .
Per gli o r gaui cavi si può anche raccomandal'e la irri gazione continua o il bagno permanente. Come polvere fina si può usa r e l'addo borico solo dove l'urniJità della fèrila basta ad assicurare la lenta soluzione della poh'er e, mentre uelle ferite relativamente asciu tte può der•ivarne vero dauno a caf!'iOne della meccanica irritazione e della rilenzione della marcia.
In quanto alle indicazioni dell'a cido borico, esso si user'H particolarmente nelle ferile chP. sicuramente o molto probabilmente contengono sch istomice ti nelle quali è già per essi avvenuta la infezione, come lesiOni per di!lgrazie nelle fabbri che, uelle s trade fer•rate, nelle minie re, ulcere, furon coli, cangrena, ecc. E nelle ferite lace r e che sono riempite di acido borico, esso penetl'a a poco a poco in tutte lacune e recessi e nell'inter no dei tessu ti ed anclre ne;.di u mo ri dei tessuti, nelle parli modificate di questi, ove gli schistomiceti trovan o fa,•o revoli Cùndizioni di sviluppo e lr rende terre n o inadatto alla mnlt·plicazione dt!i lnnltre l'a cido bor ico si distingue favorevolmente daglr allr1 anti!"elti ci p e r non avere alcuna azione irritanLP, per la relativa in nocuità e per la sua inalterabile I n adoper ato l'acido borico ha una effìcacra eminen te. 11 Jaen icke non vide mar sotto le umide a ll'acido borico uè infiammazione, nè L8 suppur azione gin formata sparì J't"r lo più mollo me nte. Eg li potè anche usare per la la va tura delle fer1te infdte acqua di fon te. Lo l'viluppo delle g ranulazioni è pi uttosto ritardato che stimolato. L'unico difetto è !>O•'a solubilità dell'acido borico che alla naria è solo di .i, p. 100. Al Jaenickc è per·ò r111scrto medr • ante la union e di parli eg uali di acido borico e di borace alla tempet·atura dell'acqua bollente, di un che pe r sue proprielil antisettiche e terapeutrche non rerisce dall'acido !Jor·ico. È un corpo di reazione neutr·a, cristallizzato e si scrogl ie alla temperatara 01·dinaria nella rroporz ione dt16 p . 100, alla lt•mperatura del calore. sangue di 30 p. 100, e alla tempertttur·a della cbolltziO.Ile 1uantrtè. quasi illimitata (oltre 70 p. 100). rapidame nte le soluzioni sature a caldo formano prccrp1tato solo dO !JO qualche tempo, cosicchè essi' si possono ugar e. in ot•gau i cavi mollo complil:ali. alla dt acrdo borrco al 4 p. 100, questa combinazione neutra dr a c1do borico o borace ha il vantagg io di'Ila maggiore sicurezza della maggio r dt•rata d('lla sua azione, di che le medlcatur e possono 1·innovars i a lun gh i intervalli (di due o tre giorni ) l'A . dice che la prima mira in tale cura deve di dis truggere il cocco piogerto sulla pelle per mezzo dr rrllledi a nlisetllci, pri ma che sopravvt>nga In del auto. E se la necr osi è di segllila, allorn bts(\gn n affrettare quanto più è possibi le la separazione delle m asse necrosale e la esp uls ione del microrganismo: prevenire infine con iniezioni la nuova formazione di ulcere. Insomma il tende uù opporsi a una nuova invasione dt>l micrococco. L'A. dice che é ben difficile raggiungere In prima condizione, P ollora che la invasione del microrgamsmo ha prodotto alterazioni visibili, come l'a r rossimento, il gonfiore o le la necrosi è già seguita, e il dotto é di già occlU!>O dal pu". Consi;zlia perciò di ricorr<>re alla applicazione di antisellici che possano rag-qiungrr<' •l micrococco al fondo della glandola. N'on crede po!>s1bile ottenere buoni ri sultati con la pasta mer•curiale fenicata di L'nna, con le soluzioni alcooliche conc<'nl•·ate di acido borico raccomandate da Lowenberg o con molle alll'e applicazioni. Le iniezioni di soluzione fenicata al tl'e pet• cento e le cau"ticazioni profonde col di nitrato d'argento sono mollo doloroso, e, dopo tutto, di incerto risultato. L'A. raccomanda doci>'amenle l'antico sistema dei cataplasmi caldi, che efrli ritiene come un rimedio che mena prestamE'nte e certamente a buon risu ltato. A pt'ovenire l'infezione dei lf'ssuti vicini egli racco manda d i lavare la pelle con colone impre· g nato di UIIU soluzione eli !<Ublimato all'l p. 100, o, quando la pelle molto sensibrle, con una solu;t.iouc bor·ica al 4 p. 100, prima dell'applicaziorw di cia"cun cataplasma. Alla notte egli consiglia di coprire la lesione cou un paunilino di una pomata a. parli o>guali di zinco e vaselina con il 4 p. 100 d i acido borico. Egli raceomanda anche di aprit·e quelli che non sic>no molto dolenti; rnn crede er1·oneo di spremerli troppo presto. La pomata a protegl!ere le !dandole vicine dall'infezione. Se si fare bagnatu•·e, queste sieno con acqua al ::sublimato: gli infermi sieno nutr·iti convenienll'menle, e, se anemici, ,.;i somministri lo r o qualche p r eparato <li ferro . T. R . . lJna crassulacea comune dei no-.tri giardini, l' Hcheoe rr ia, posta c:otto una campana di vetro bene insegata e aderente, a lato di una capsula rirmpita d'Plere, pt'esenta al termine di un'ora circa le sue fotrlir. <"OpE' rte di una rugiada abbondante: la pionta da turgesrente che et·a, 8i avvizzisce.
'l'rattamento della furunool oal.- VIEL.- (The Lancet).

Meooanl•mo dell 'azione degli anestetici. - (Lyon médical, 6 dicembre 1891).
I l ùotl Raffaele Dubois ha pubblicato sulla Reoue génerale des sciences (fa scicolo del 15 sellembre u. s. ) un articolo o riginale ed importa ntissimo che il dott. P. Aubert riproduce facendolo s ussegui r e da alcune s ue osservazioni.

L'idea fondamentale di questo arltcolo è che l'agPnte aneetelico si so<:lituisce in parte all'acqua nel protopJugma delle manif(•!'lazioni vitali.
La ,Jisidratazione del protoplasrnn deve naturahnente provocare la messa in liberia di una certa quantilù d'acqua : ma si cf)mprende che que!>tO fatto non si può r1velare nellamento né nPgli organismi vegetali a lacune aereo numer se, né vi"entP. Se si prendono al contra•·io certi ve gt> t.. Ji a parenchima den!-'O, certi frulli o certi tessuti e si mettono in presenza di vopot•i anestetici in una boccetta ermeticamente chiusa, può constatare nettamente sia eli goccioliue d'acqua, sia dei movimenti dovuti alla di'-idrlltnzione dei tessuti.
I vegr.t uli n lacune aeree non lasc•ano tr·asiHiare l'acqua, ma posc:ono rassomigliare esattamente a piante gelate: una melararrcia posta nelle medP!"une condizioni a!"sume l'aspelto di un frutt o che ha subìlo l'at•one del gelo. Adunque anche la congeiALi one, che è un mezzo anestetico locate, richiede similmeuto una disid ralazi0ne dei tessuti.
Il freddo e g li anestetici, quantunque mollo dissimili pe r loro natura, possono adunque per questa pr·oprietà com une provocare in cer•ti casi degli effetti analoghi di cui il dotto r Dubois cita parecch i esempi. mento dei picciuòli, e la chiusura delle foglie della sensiliva (il cui meccanismo mtimo è dovuto all'avvizzimento cellule parenchimatose della base dei picci uòli e delle fo g lie) s i produce pet• ozione del freddo e d eg li anestetici a ltr ettAnto bene come coll'urto.
La contrazi one e la proiezione del contenuto dei fruttr del Mom ordica elate ri um è pr ovocata altrettanto sicu ramente all'interno di un tubo pO"'lO in un miscuglio refrige r ante che all'interno d'un tubo ben turato contenente dei vapori d'etere, o di clo••o form io: e in ambo i casi si constala che le grandi cellule suc..:ulente dè!tO strato rneùio hanno pr eso qu ell'aspetto btanco opaco che mdica l'evacuaztone dell'acqua e la penetrazione di aria.
Dei frammeuti di muscolo, delle uova fresch e messe in vasi ben chiusi in va pori !lnestelici, lasctano trasudare dell'acqua: e nell'uovo si può constatare che i vapori anet-totici si vanno a condensa r e sopratutto nel rosso o vitello.
Col m t'desimo fatto deliA disid ratazione il cloll. Dubots spiega pure ropacamento della comea che si può pi'O.Jutt'P nell'uom•1 e nel cane in seguito ati anestesie profonde e proluugate, e l'opacità corneale che !-i produce n ei cani per in!l· laz oni di clorm·o d' etilene.
Se si cerca nei fenomeni fisicochimici qualche cosa di comparabile ai fatti di disidratazione dei tessutt sotto l'influenza degli anestetici, si può trovarlo nei curiosi s t udii dt Graham sulle muterie colloidali m ineral i.
Graham ha dato il nome ùi hydrogèles a delle sostanze colloidali che si ottengono fissando l'acqua sull'albumina o la Un hydrogèle immerso nell'alcool o nell'etere, pet·ùe la sua a cqu a e dtventa un alco ogèle o un ethlrogèle. Cosi pnre un può ritornat·e allo stato di hydrogèle se è immerso in una quantità di acqua sufficiente .
Tutto ciò rassomiglia mollo a quello che succt>de durante l'anestesia, e dopo. L 'agente anestetico si fissa sul protuplasma cacciandone una parte ùell' acqua che l' imbt"ve, poscia il s angue alla sua volla rileva il cloroformiO dagli elementi anatomici e l'ac•rua vi l'iprende il suo posto senza che vi sin stata mai coagulazione o alte1·aziooe di struttura apprezzabile coi nost r i m ezzi di investigazione.
T utte queste esperienze, come pure lo studio teo rico che le ha inspi r ate e che le conferma, sono molto importauti, ma il dott. .Aubert si domanda se indipendenteme nte dall'azione specifica di ciascun anestetico sui tessuti non è necessari o aggiungere la nozione della solubilità a quella ùella aostituzione dell'ugente anestetico all'acqua nei pal•eochimJ.
La cocaina che non è, è vero, un aneste tico gener ale, non !JUÒ essa produrre l'anestesia locale sciogliendosi nell'acqutt dei parenchimi, senza scacciar nela1
11 pro lO'>"ido d'azoto di cui la memoriA dt>l dott. Oubois nnn fA pa r ola, e ùi cui l'acqua ne disriogbe la meta del proprio ,·olume, non può egli agire egualmente !'Ciogliendosi nell'acqua del parench•ma !'enza cacciarla? Sarebb e questa la dl'\1 pronto cessare de' suoi effetti tostochè l'i le inalazioni. L't>trre, chE> è poco !'o lubile nell'acfJua, ma che lo é più del clor oformio, atlinf(erebbe da qUt>!'la pro prt d à lA sua maggioro innocuita? Infatti è più volAtile e più solubile, e quindi si dovrebbt> fissare tn m0do me no tenace analomi,.o.
QueRte sono lA riflessioni che il dott. Auberl al dott. Dubois, e che poh·ebbt>ro es!'.. re il punto l'li par·tenza di nuovi e!>perimen ti.
JoHN CREVAR. - Cura eftloaoe e r a pida dell 'influenz a .( T he Laneet, d1c. 1891).
Kl Pin dicP che un centimetro cubo di urodo po,.to nell'incuba trice alla tem pera lut•a di 38° e •l inoculato con bacilli, molti plica il loro numero 80.000 nelle prime ore, 450 volle nelle e solo 5 volle nella tf' rza giornata, lalchè a misura ehe il loro pabolo diminut!'ce e ct·esce il pr odotto dell'azio ne ferm entatrice, la ripl'Ooiuzione dei bacilli Rcema gradatamente, e final mente cessa. Il bacillo è quinJi ucciso dal suo stesso prodotto, come Burdon-Sander!'on ha dimostr1.1lo.
Ciò che si verifica negli espt'rtmenli da gabinetto, s i avver a anche nel corso biologico dl'lle malo.Ltie, e se fosse possibil i' allPrare talmente lo stato dell'ot'{i(anigmo da renùerl o inabitabi le ai suoi invasori, noi trionferemmo di lutti i contagi.
L'auto r e, nelle epidemie rl'ir flu Pnza del1889-90 e 91, ha aYulo di m ira questi principii, guidato da i quali <\ sempt•e 8 g uA rire i suoi pazienti in bunn tempo. Egli ha procurato di s.ccreRcere l'alcAlinità del sangue per mezzo del bicarbonato òi potasse che hA il vantaggio di non scomporsi ne ll'orga nismo per chè composto stab!le, di essere facilmente u. m1 na to, con che è scon!!iurato il ot>r icolo di un avvelenamento di potassio. Ne ha amu1ini,.:trlllO un grammo e mezzo alla
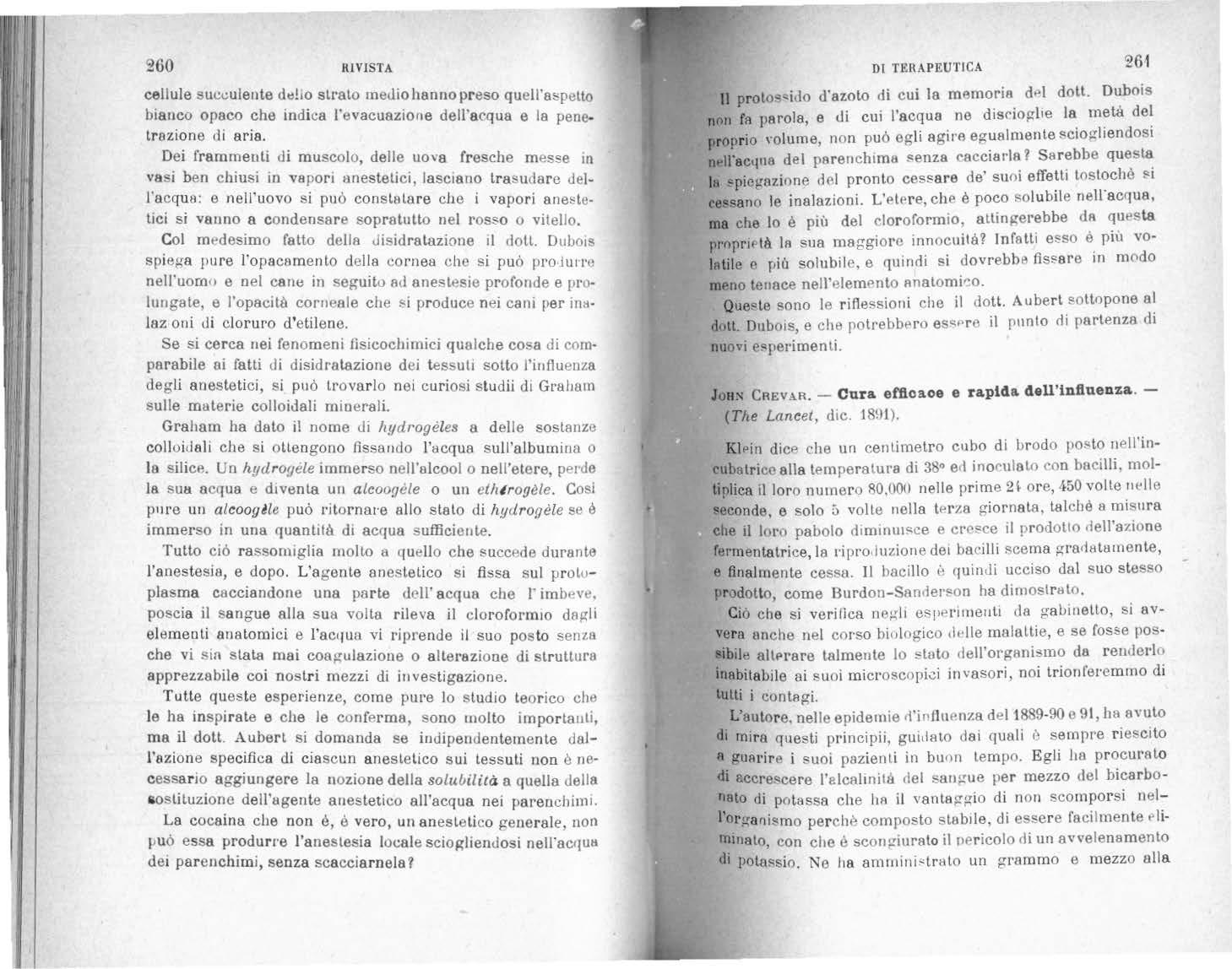
RIVISTA volta in un cucchiaio di latte ogni due o tre or·e, con l'af!'gìuola di poche di tintura di cap!3ico, e solo in due o tre casi ha ,·isto un leggiero indebolimento dell'azion e cardiaca, cot·retto ben tosto cou la dtgilale ed il liquor·e d'ammonio. T alvolta «opraggrunse la diarrea, che :;i a lontana con le polveri Oo wer.
:\'ei casi ù'indt!bolimento per malaltìe. d i maJattte concomitanti, 11i o di puerperio, l'azione lui rimedio fu alquanto ritardata, ma non m e no eflicact>. Se l'ulll· ministr azione del bicarbonato di potassa s'interrom p e, i si ntomi del morbo r·icompaiono, ma 8compaiono di nuo\'0 co n una nuova propinazione del rimedio. 4.
Caso di tetano gaarlto coll ' antitossina del teta n o.Dotl. RoooLFO ScHWARZ. - (Rioista oeneta di seien:'' meriiclte, fa8cicolo IV, ottobre 189i).

L'autnt'e pubblica un cuso di tetano che ebbe l'opportunita di curare nel civico ospedale di Padova e di guarirlo usando dell'antitossina del tetano pr·epar ala dal professor•e Tizzoni e dalla dotlor·cssa Callani, !:ìOSlanza che fu cosi denominala perché ad escoa il siero del sangue immune deve la sua aLJOne anlito::.sica.
La con cu1 andarono scomparendo i d ella malattia dopo la terza rntezione sollocutanea de ll'antito!'<" it .a in 8ClJU()"H (11-25 c gr. in 3 cm. c. di ac rrua di .;;li)lata) pr0\'8110 di pc•r 8e l'azi one da\'vero efficace ch'essa hA dimostrato in questo caso. Siccome i fenomeni tetanici (com e fu riscontrato nei topi), non scompaiono tutti d 1 un tratto, m seguito all'miezione di antitossina, ma lentamente reifrec ltscono flno a scornpal'it·e, è probabile che la terza iniezione fO!i<se gia sufficiente per la guarigione anche senza le due s u e· cessi ve, che si sono praticate.
Allo sbrigliamento della cicatrice ed alla sua disinfezione non può certo attribuir·si in questo caso il miglioramento :;eguilont>, i nquautochè poteva contl'ibuire a non aggt•avure i sintom i in corso, non u1ai a sospenclere e fsr reg r edire, co;, t dr bo tto, quell i g ià esis te n ti.
DI T ERAPEL'TICA
La differ enza degli effetti fr a questa cura e quelle giù praUcale anteceJenlemente sul meùèsimo individuo parlono ancora per· la boota del metodo. .
Questo che rautore pubblica è il secondo caso io cui si fa uso dell'antitossina di e Calta.nt e precisamente dell'antitossina ricavata dal siero di sangue del immune.
11 pri mo caso, egualmente s e guito da e:;ito fu tr·attato dal do tt. Gagliardi nello speùale di Molirwlla pre..,so Bologna. ma non fu finora pubbl icato.
Fo:&MULAmo.
Nuoco mouo di amministrare la mo rfina. - (CARL H. von KLEtN).- (Raccoglitore medico, N. 12, 18DI).
L'autore con sio-lia di f'a r prendere la dose occorrente di o mor!!na n e llo stesso modo del tabacco da fiuto, e r 1l tene questo metodo superiore a quello eli dol'lo per o miez10n e perchè non si sente alcun sapore e Il r tllledto agrl'ce prontamente.
.lliscela utile per l'anestesia 11<91).
Pr. E tere solforico locale.- (Sperìmentalr, N. 17, cenligr. 30
Acido fenico . S. pe r U80 estemo.
Ques to miscuglio viene usalo polverizzandolo con uno Bpruy.
Contr o la forfo r a ostinata del cuoio capelluto.- (STEPHEN).
Pr. Resorcina . .
Olio d'oli va. . .
Etere solrorico
Alcool rettificato .
:! ana gr. IO gr. 200
Da a g it a r si bene e poi applicarlo sul cuoio capel l uto co n una spazzo la ru viua.
Contro la bleno r ragta. - (Gio r nale interna;ionafe delle scien;e mediche, fase. 16. 1891).
F urono sper·imenlato con contro In blPnorragia l t> iniezioni di acqua marina la cui efficacia fu attri buita alla al ca linila e alle sue pt'oprietà antisettiche e toniche . Le iniezioni s i praticano con acqua di mal'e pura, me!.dio se è tiepida, ripetute per:sino 8 volle nella giornatA.
Curo. delle non sijlliliclle dei yenitali(Doltor·es:::a TCHERNOMOHDIK). - (Giornale int c rna:z. scien:ze medich e, fa ...c. Hl, 1891 )
Pr. Osc:idn di piombo . . . . .
Si lavano le vcgetazi()ni (conditomi con un liquido anlic:ellicn, "i ac:ciugano a secco, !'r toccano con un piccolo lampone d'ovatta imbevuto della della soluzione dopo averla bene agitata. l ra capo a cinque minuti le g rauulazit•ui anneriscono e si trasformano 111 urra massa di consistenza muco sa, che si lascia lacilmeute asportare dall'ovatta; la ptccola piaga che ne risullu si m t'dica all'iodoformio. Se le ve· gelazioni sono mollo grosse si può ripetel'e la pal'ecchie volle in una stessa seduta. Il dolore è poca cosa
Pomata contro il prurito cutaneo. - (Ko enNER) - (Rivista
Veneta di scien;e medie/le, dicemb r e
P r·. I Ira lo di cloralio .
Canfut•a polvet·izzata
Vaselina . . . .
M. fa p•>mala.
Si fanno unzioni due volle al specialmente nel pruri to culanl'o che molesta gli erniplef!ici.
Con t ro l'idrope d'o r igine ca r diaca. - (FuROINGER). - (Ri11;1ta Ven eta di scienze mediche, dicembre 1891).

Pr. F oglie rli digitale
Acfjua bollente
Fa infusione e Cttrato di <'affe ma
Tintura di Acetato di pota!'l!'a .
Estratto di liquirizia s. dA a cucchiai11le entro 4R ore.
Contro l'eresipela -(Il Raccoalitore medico, 11, 18\lt).
Pr. Ar.irlo rarbolico
Oli o di tremPnlina . . . .
S. un gere le pa•·ti maiAle ogni ora.
Cont ro l' influ Pnza:
Pr·. Olio d• menta piperila g r. 5.
S. 5 o 10 goc ·ie, tre volle al giorno.
Inoltre:
Pr. S olfato di chinina
B icarbona to di c:oda gr.
Dividi in 4 carte; 1 O!!ni 3 ore.
RIVI ST...L\. D'IGIENE
.&alone del calore aulla fertllità e l& vlrulen.,;& del b&oUU tubercolosi. - (Reoue d'fl!J(JiMe).
I secchi presentano una notevole ma l.!giore : e.sistenza (SI'bill e F isc h er ). Yo rt;;:ch disse di più che l'ebolhzwne anche protratta non rende la materia tube r colare !'lerile ed inerte.
Jersin pero ùimo:,;trava più tarJi che una temperatura superiore a 70' ne distrugge invece in 10 minuti la virulenzfl.
Ora Grancher e Ledoux-Lebard avrebbero dimostrato che a 70' é co m pletamente distmtta anchs m un solo mmuto la virul enza del tubercolo fresco od umido; che se secco realla tem pet·a lUI'O di 100°. Però la stessa cli«-.eccazione attenua pt>l' sé la virulenza che finisce per e>-,.ere distrutta in alcum rne"'i ..... La luce, l'ossi!!euo e ln dr-.;seccoztonE' tìnic;cono cioè per rendere inerle la polvere dPgli sputi dei ti<-ici. H.
Sul modo di dl•por re delle Immondezze d elle case.Dolt GtusgppE RADA r. - (Rioista d'igiene e saniià pub· blica, dic. 1891).
La << Cornpa g uia per l'impiego delle immondezze » da r(IJal· che tempo ha impinntato in Londt•a uno specia le cd inge · stabilimento, del quale l'Autore dà in questa mem or ia una pnrlicolareggiata descrizione. Uno c;tabilirnento sì utile e tanto ingegnoso per il modo di disporre delle immondezze delle case, le quali vi provengono quot1dian"lmente nella quantità di 50 tonnellate, fu ammirato e lodato da qnanti lo visitarono.
L'ec;»me di ha portato l'Autore alle seguenti riflesSIOni d'ordine
Pre mec:c;o chP il siste ma di bruciare le immondezze uon toglie l'incon\•enienle di una ce rta scella la quale, come Yiene falla o rdinariamente, <"Ostiluisce per necessità un io insalubre, mentre il bruciare in blocco tutta !"immondezza costituisco un vero sciupo, SO!l:giunge che: t• Il più importante e primo quesito risolto da qu.. «to stabilimento é stato quello di abolire qualsiasi operazione antiigi eoica; di garantire da ogni conseguenza morbosa gl i addetti alla scelta del poiché, mentre questa scelta si fa con mezzi meccanici, 11.1 polver e che per necessità si solleva col movim ento dei m a teriali viene rimossa da un potente a!:ip iralOJ'O con tanta (lfficacia da mantenere pura l'nt· mosfera ove si lavora;
2" 11 me todo usato della scelta meccanica sal va tutto ciò che può esser e utilizzato dalla immondezza Jt>lle rase eù impiega per alimentare il fu•)CO quella parte del materiale che non può essere venduta, ma che serw bene per combustibtle; dimostrazione della presenza del bacillo del tifo nelle acque, all or chè si può raggiungere , è sempt•e un fallo di importanz a capitale per gli sludii di pubblica, perché ))On(' s icure basi scientifiche alla eziologia e oli a profilassi della febbe e tifoide.
3° _:\lenlre il sistema seguito utilizza tulli i ritìuti , riesce a ma n tenere nella classe delle non insalub ri il modo· di disporre delle immondezze dalle case.
Dimostrazione del b a cillo di E berth n e lle acque potab lll 41 P isa durante l'epid emia di tito nel 18 9 0-91 . - Prof. G. (Rioista d'igiene e sanctà pubblica, dicembre 18fl l).
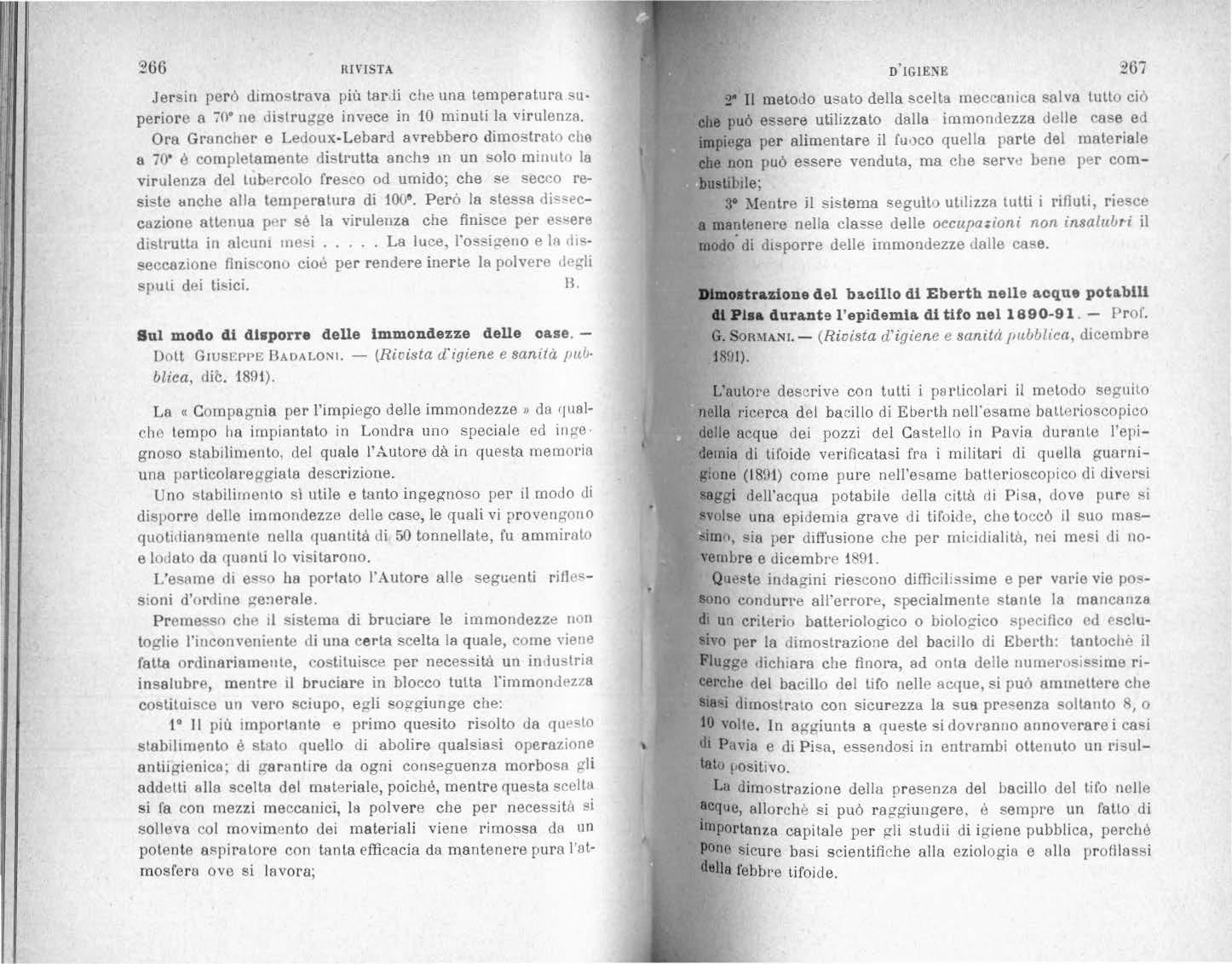
L'au tore descrive con tutti i particolari il metodo seguito nella l'icr r ca del bacillo di Ebel'lh nell"esamo ballPrioscopico delle acque dei pozzi del in Pavia duraulo l'epidemia di lifoide veritìcatasi f1•a i militari di quella guarnig:one (1 8!l1) come pure nell'esame balterioscopico di Jivct•si eagg i dell'acqua potabile della città di Pisa, dove pure !-'i svolse un a epidem ia grave di lifoide, che toccò il suo mas::.lmll, sia per diffusione che per micidialità, nei mesi di novem bre e dicembrr i 89 1.
Qu e!'le indagini riescono difficil issime e per varie vie po..;sono condurt•e all"ert•ore, specialmente stante la mancanza dt un c r iterio batteriologico o specifico cù Pscl usivo per la dimostrazione del bacillo di Ebel'th: tantochi> 11 ,fichiara che finora, ad onta delle ricerch e del bacillo del tifo nelle acque, si può ammettere che stal<i dunostrato con sicurezza la sua. pre--enza soltanto 8, o 10 volle . I n ag-giunta a queste si dovt·anno annoverare i casi dt P avia e di Pisa, essendosi in entrambi ottenuto un risultato posit1vo.
D'IGIENE
che il bacillo di Eberth nelle acque potab ili
•\ la delle epi lemie di febb r e tifoide, le au loril a saranno tPnute a provvedere che le fonti e la distribuzione di ac'{ue potabili nP vadAno certamente e!;enti: ed allora gradatamente !>COmpAriranno dalle citta itAliane epitlemie di febbre tif,,i!fe, che ancora tr·atto tratto le del vtru.s pneumon.tco negU sputi. - Nola del dott. Honoo:-<1-UFPIIEDUzzt. - ( A tti della Reale .lccademia dei Lincei, \'nlume V I li , fa5:cicolo 4\ anno 18!H). l."autor' ha ri cr r cato lii r <'tlam ent.e il di del vit'U4 pncumontco neJ=rli sputi, cosa assai importanlr, r<i11 dal Ialo !'ICienlifìro, perché havvi contradizione, almeno apparento, f1·a i dali che 5:i citano e lo spegne r si rapido d<Jlla virulenza e della vit>ilità dello stesso microq:ranismo nel poi· mone infiammato e nelle cultu r e. sia dal punto di vista pra· tico , per trarne un corollari o util e per l'igiene pubblicfl : prr vedere, cioè, se rosta giustificata, anche per l a pol monite, ]'applicazione di quelle norme dì disinfezione degli ambienti. che si applicano già per allr'e malattie, il cui agente 5:pcrifìco. come si t'> trovato per tubercolosi, a lungo ambit>nti all'azione del dis,.eccamen to e della luce. L'autore ha potuto constata r e che lo sputo pneumoniro, fortemente vi r ulento, fatto disseccare all'aria e alla luce dif· fusa coMer,·a la sua virulenza per 55- 60 giorni, e rhe !"'Poalla lul'e so1ar 1• dir etta, anche dopo 12 ot•e Ji in solazionP continua, mnntiene virult!nlo, mostrando così un grarlo di r t>sisl enza mollo «piccato.

Que'-'li r i"ullnti collimano cnn qu an to era stato osser,alo di re-.ic:;lenza del dtplococco nel sangue dei infelli, m entr e invece male si accordano col rapi lo gncr"i della v1lalila di questo microt·ganismo nelle cullut·e. anche se tenu te in buone cond izioni di temperatura e di nu· t1·izione
Que!>ta differ enza si può sia pel fatto che cu lture pr oducono sustan ze infeste al diplococco, Ria pe1' riò che rw gli !>pulì, come nel sangue, l e sosta nze album i- nol'e che ,.,, costituiscono uno s ll"ato pt•olt:!ltore pei in esse
Ma ciò che più interessa si è che, dopo a vl'r stab ilito che 11 v 1rus pt!eurnonico, ver;,ato cogli pet· opera degìi illrermt nel mondo esterno, si mantìe:!e a lungo v tvo e vit'U· lento, viene anche sp •r imentalrnente dnno.,tr·ata la i">'"· srbilili1 che lo stesso sputo, dissec.:ato e t·rdntln in poi v t> re, ser,a, co1 mez1.0 dell'aria, a diffondere la malollul.
Per la profilassi polmonite, adunque, devH'-'i inc:;istere oon sulla disinfezio ne degli !<putt fr e-<chi, raccolti "-Uil•• pezzuolo e nella sputacchiera, ma anche su quella 8111 · bientt abitali dagli iufermi, pet• di5:leugg re CJUf'l germi che po«,;ono l i'Ovar st negli sputi e;,siccali sul po\·irnento e 5:ulle parell e che quivi si mantengon o ,·ivi e \"irult>nt.
L 'immunità. artlficlale per la pneumonlte oruposa - EMMERICII c FA WJTSKY - (.\1unchner med. 1Vochensch. e CPntralb fii r dLe med. N. 32, 189 1).
Gli sperim enti sulla gnari gione dellt> malattie infettive ar.uto che l'8mrn et•ich co minc.ò su l mal r·os"o del muiule ha egli in union e col F awitzky anche allu SPtticemi» dei conigli prodotta dai pncumococchi dd Frt1nk<'l. parte dal concetto che la im111Unità ar·tdkiale è delermrnata .Ja una 80!'\lanza antt batterica f"orwatasi nel co rpo animale. Comune effetto di tutte le malattie infettive ì• 11 turgore parenchie la gras=-a. L"Emmertch avvisa che tn f(uesta anormale modificazione dell"allJvità cellulare sì producano i corpi testè rammentati. Questr allora tle vono contenuti nel SU.!O dei tessuti esprèsso dalla car·ne e dagh or·gani degli animali r est immuni, il quale sul-{o puo anche essere usato come liquido ri,.analol"e. N ella sellicemta da pueuruococco questo sugo animale spiega az ione diversa secondo il m odo della immunità
Uuo dei m etod i di dare la immunità posto in opera dai summentovati spel" imenta tori consiste nelle ri petute iniezioni 80 ltocutanee di deboli colture i n brodo di pn eumococch i di crescente virulenza. La immunità così olleuuta essi indicano come incompleta. Il li
Sul tema delle b aracche trasportabili Nitnier di P arigi ne tre modelli fr ancesi:
1. Quella di Espit.allier la quale Imballa in colli del peso complessivo di 6,500 chil ogrammi e nello !< paz io di 60 mc., si carica sopra due carri aperti da fe rrovia o sopra 4-f> carri di campagna, ed offre po!-LO per M malat i co n una distanza di 0,85 m tra un !ello e l'altr o, con t9 mc. di spazio. L'inventore ha costruilo un altro modello di min ori dimensioni ma con 1 i) mc. di spazio per ogni Jet&o. H lor o prezzo i• di 8000 fraucht. Il materiale é costituito di cartone compresso, soltanto il suolo é di tavolato.
2. Ln baracca Tollel è di forma ogivale, ha uno scheletro di fe rro eù il pavimento di legno. doppie pareti di carla compre!->'a, il '>UO pe80 é di 7000 clnlog., quando è imballata · ba una c uba tura di 20 mc., il prezzo ò di 8000 franchi.
3. La baracca Olive per IO lelli pes:a soltanto chilogrammi, le sue pareti cù il tello sono di rete metallica incorniciai a nel legno, la quale rete porta un ri,eslim en lo di gelatina indurita nel bict•omalo. Se si vuoi applicare una doppia parete si prende per il tetto la tela, per le pareti il feltro, ti pavi mento è di tavole e può essct·e t·ialzato come quello delle altre baracche.
Demos th éne di Bukarest osserva che nella. guerra tu r corumena in Bulgaria i fe1·iti rumeni erano ricoverati sotto \ende di tela, che nell'inve r no ful'ono r ivestite inter nornenle di paglia dt mais, e in questo modo mantenner o una temperatura s opportabile. RccentPmenle fu adottala una londa costruita in ferro e a doppia pnrete secondo il Tollet; fu sperime ntata ancora una bnt·acca dello stesso inventore, la quale per o, in fallo di lt·asportabilttà lascia ancora qualche cosa n desi.d.t>rare.
Mehlhausen di Berlino parlò sopra l'uso delle baracche di per la cu1•a delle malattie «'pidemiche e ne raccoblan•la r aldamento l' adozione come appendici agli ospedali
Daubler di C hrisliania descrisse una baracca mobile atluallbente in uso nel Zanzibar , fatta con tramezzi eli bambù incorniciati di !'e r ro che possono ven ir fissali in quattro diffel'eoli posizioni, e che nell'interno sono ancora rinforzati da
RIVISTA DI TEC'{ ICA
stuoie r otolabili che vanno fino al tetto, tra le due parti resta uno fo\paz.to dt 30 ctmltmell'Ì, il quale sta in r avporto col tramezzo otturatore interrollo in allo verso il tello. Tra quest'ultimo e,l il tetto vt ò una fessura Jell'altezza di 40 centtmeki che serve di ventilatore. Sul 2' tema, stabilito dal comitato: Può il trattameulo au · ti settico de lle ferì to in guer ra essere r egolato sop ra una nortna unica pt>r tulll gli eserciti, dt modo che 1 medici di un esercito sieno in grado di ollenere un ù ecorso asellico di una ferita anche col mat eri ale dt un ese t·cito st1·aniero: a) Sul nuupo di battaglia (antist!psl primaria); Il) l\ egli ospedali per la cura ·consecutiva. Su quefo\to tema prende primo la parola Mar· person di W oollvich. Anzi tullo egli diMpprova l'istruziouo spe c1ale che s i vuoi darè ai soldall di samla pe1· il pri1110 soc· corso, poichè essi la tendenza di toccat·e le ferite. Iu· vece di questa istruzione sara più che ogni sol· dato sia fallo consapevole del danno che emerge dal toccat·e una fet·ita e che sappia quanto s1a facile domare le emorragie p1·imarie colla fa sciatura compressi va sopra e solto la sede della les1one. Soatanto se il fet·ito è lontano dal soc· medico si ponà nna prima da campo, per la qnale sarti ut ilizzato un pacchetto da medicazione eu· in un posto e perfettamen te puhto, ed esso sarà applicato senza che le dita 'engano m contatto colla ferita. All o scopo di queste cogniz :oni le norn1e suddette devono e!lsere stampate ed ua teli1!JO di pace osleusibili in tutte le camera le dei lJU!lrtieri; do· vranno an cora ess ere stampate s ulla faccia ester·na del pac· chello da meùacazione ed a.lraprarsi di una guer ra 1 medici dovranno raccomandarle ai rispettivi comandanti. Ai medici di prima linea é svecialmente r accomandato: t• C he m generale essi abbiano ad evita re ogni contatto colla fe r ila e di coprire la medesuna semplicemente col ma te rial e de i pacchi da mettere al ferito una tubellina diagnostica colla indicazione: dc. medicarst ài nuo oo ;
2• Se u na fe r ita deve esset·e toccata, sulla ta bellina deve aegue: a) Le mani e le unghie dei chirurghi in una forte l;Oiuzione steJ•ilizzanle. I loro vanno all'm· terno cosparsi di polve1·e antic::ettica inodora come per d'acido borico ;
&) Ras-oio e appartengono al corr edo di ogm e devono essere st>mprE' adoperati;
<') Pri ma ùi toccare la ferita le dita e Hlrumenti dP· vono essere s tropicciati con garza antast>llica dapprima inumidita ;
J) P e r gh strumenti si ra ccomandano quelli a manico metalhco in luogo di quelli fino ad ora in uso; c) Il materiale per legature e suture deve essPre e reetar sempre in s tato ast>ttico. Macporson most1·a un vaf:lello dove è custod1to in soluzione il catgut asettico. L'estremi!!\ hbera del calgut pa!<c:a attra verso il tappo di gomma e fuo ra ; quando abbi;:ogna adoperarlo sa lira !ut•r i il pezzo che occo rre e si vra.
3' I soldati di sanila non dèvono toccare le ferile; tutfal piu appli care, al bisogno, sopra illorcolare o Hop ra )., stecche un materiale antisettico;
Le tasche di sanità rle"ono contenere una sola rtualità di garza antisettica; potJ·anno aver·e in aggiunta una pol v ere antisettica da !:parger e sulla ferila ;
5' Le devono essere abolite da llE' di sanità. un chir urgo possa utilizzare il materiale di un allJ'O ci tu , Macpet'f:\oll raccomanda che si adotti dapertutlo una tola ind it·azione comuue a tutti mezzo delle tabelle d iagnostiche , per esempio: il colone bianco rlella tabella indicherà ch e una fet•tta é g1•ave, il cotone :·osso che i· eon un'.\ si indichf'rit se una ferita è da con B ehe essa fu già medicata; con C che si deve praticare uun operuzio u e Anch e il cotone dei pacchi deve essere il medesimo. ;\1enlre ora in Ge r mania il materiale al sublimalo e la curtu che lo m volge sono di colo r r osso, in Inghillerra é di colore uzzu1·ro. Anche le soluzioni devono essere della atessa CorLa per tultl gli eserciti.

\\·eber di Bec:ançon lll'Csenla i mater iali da medicazione fre ncege preparati col sublimalo all'uno per mtllt· e che !'<ODO ciel tutto simili a quelh dell'esercito germamco. Tra f!Ud m ate r tale anche l'ovalla di to rba, che snrebbe analoga, con qualche pic.·ola differenza, al cartone ol rnu><chio che é in uso nell'eRercito v. Bergmann di Bet·lino fa notare che vi i> snfflcenle con· cordanza ed un ifo rmit à nei vari matet•iali di medicazione dei diversi eserci ti. Colla si è ovunf!UO m di procut·arsi buone medicazioni anche da un catth·o mall•riale; rna oltre all'uniformi la del malertale noi abbiamo lu<>ogno di uniformità nel mo rto d'impiegarlo. Ad ottenet·e rtuesto, Bergmann stabilisce lo• scgu•nti categorie di fertle: l) ferita d'arma da fuoco parli molli pet• le rtuah lesioni convi en e piit dt tullo tene r lontani gli !!genti noctvi;
2) ferita d'arma da fuoco det vasi con emort·agie rPceuti
3) ferila d'11rmll da fuoco delle ossa e precisamente a) quelle con piccole ferito rl'enl r ata e Il) qurlle co n ferita d'uscita più grand e. Por la catego .. ia sat·a da npplicat•:::i la medicaziouc a pe rmanenza associata ad apparecchio od a gtecche. Haccomancia un tecnici!:;rnn re;.rolamenta rrn enle determtn!llo per la rnendicatione ed applicazione d'appar·ecchi sullo pr·una linea. Soltanto nei Jaz;.at•etli sarà permesso individualrzzare i metodi di medicazione. anchr> in quelli stabilimenti l'opparecchio, sr> non vi " mdiraziono iu contrat•io può restare in posto Hnche per un mese s in o a guar·igiono com piu ta cnme gli accadde di sopr a uno dei s uo i feriti ne i balcani con una rot·ita rratLura de 11'o m e r o.
S egue una lettura di sopra le medicazioni sterilizzate nella chi rur gia dt f(Ue rra. Da esperimenti falli in Nancy colla c: Lerilizzaziorw della filaccia risult.. r ebbr> ehe. mentrd dalla filacda greggia «i ebber o nel brodo una gt•ande quantità di collur·r delle vnrie specie di microbi del:aria, nulla di simile OS!'<ervò dalla filaccia sterili zzata. A nche quando si m etteva Mllo la pelle di un conigl io la fìla·cia non sterilizzata non con te n ente che microbi dell'arta uon a lcuna r ea zi one, ma se si introduceva nella li-

E Servizio Medico Militahe
lo statìlococco aureo e quindr Hi inoculava qu ella cute di un coniglio si sviluppava sempr·e flemmone; se poi eterilizzaya filaccia, non seguiva all'innesto alcuna fl e nel brodll non cresCI'\'1:\ pit't alcuna cultura. Gli dinici con co r dono con quelli di Re::rnier.
Renant, ebbe poi a d imostrare che una simile sterilizsem pt•e s ufficiente allo scopo J i ant,sepsi , si può con quulunrtu e stufa.
POPhl (J:>i elroburgo) ha immaginato un pacchetto da meben di verso dagli alLI'i fino ad ora conosciuti. E c: so eonsta di un palloncino di gomma conlr>nente una soluzione di eublimato coll'uggiunla di acido ta rlarico. Il pallone é mvolto in parecchi giri di fa<>cia di garza ed é resistente abbastanza alla ordinaria pressione Il pacchetto si porta cucito DAlla fodera dell'abito. SP lo <>i punge con uno spillo ne eeee la soluz rone Ji sublimato e ne resta imbevuta la fascia, me riman e an cora una certa porte dolla soluzione antisettica per lavare la ferila. La del subl imalo può essere lungo tempo in q u el palloncino andar sog, n ad a llet·ezioni.
Finalmente destò un generale in teresse la discussione sopra Il fr tem a così concepilo: Le relazioni -.aoilarie dei diver"i ll!er citi ,·enir modellati' sopr11 uno schema u n ico allo eeopn di ottener e una s ta tistica che renda possibile dei r·ieeontr i n l !'enso scientifico, delle malattie, delle ferite, dei eserciti :>i a in pact> che in gue1·ra1
Billin g (Washioglon) pa r·agona tra lot'O i modelli di rapporti sanitari di vari eserciti, o viene a ll a conclu sione non propr·iarnenle n ecessa rio di pretendere un' as:wlu la eon cor·dnnzo dei ma piullo-.lo necessita r ender possibile una m1gliore valutazione, un più esatto confronto eolio sLabiht•e dei r apporti più completi vari punti dt lista in riguardo all't>lti, alla razza, alla durata dt servizio ecc. Per le malattie chiru r grche è da p r opor:<i un esatto schem a dt !!iorn a le n0goJogtco nel flll8Ìt' su di uua pagina é do m ettersi il nome, l'età e la natura della lesione, inoltre !'<i risponde a molti altri quesiti ci r ca il trattamen to ed al decorso della. mal attia; sull'altra facciata é stampata una tabrlla lermografica, e vi sono ancora diMgnate in abbozzo tutle le parli del corpo con particolare distinzione del contorno osseo che si riferisce alla lesione riportata.
Da Sarnow di e da K1·ocker di Berlino vien p r epar a to uno di relazion e da sottoporsi ad ec:.perimenlo ed al bisogno, da introdur:;i; e dopo che il Krocher ebbe a proporre che SJ adottasse un sistema unico delle tabelle numeriche per la statistica sanilar:a di guerra fu nominata una commissione solto la pre<>iden:ta di B llhng della qualo devono for parte Noller ùi Nell ey, Schneiùer di Parigi e lo stesso Krocke r.
Questa ha per iscopo di slabi lir·e i criteri sui quali deve esse r fatta la statistica degli eserciti e di additare alle autorità militari delle varie nazioni quello forma di rapporti statistici che si riconoscerà più opportuna. Ques to appt>llo internazionale ci fa sperare che su tale campo scientifico si otterrà certo qualche cosa di positivo. Tutti coloi'O che si sono occupati di lavot·i s tatistici sulle guerre e che furono costretti a confrontare fra loro i quadri compilati dalle ùive1·se na:t.ioni applaudiranno a questo tentativo e faranno voti che la commissione riesca completamente nel suo dirt1cile còmpilo.
RIV ISTA DI STATISTICA MEDlCA
Statlattoa delle oauae delle mortl avvenute nel R egno negli a.nnl 1889-90.
Dall'illustr e prof. comm. Luigi Bodio , direttore generale della s t ati s tica del regno al Minister o di agt·icollura e com· m e rcio, abbiamo ricevuto la bella ed importantissima • Sta-
RIVISTA DI STATISTIC.\ MEDICA 277
dPJI <' cause di morte in lulli i Comuni del Regno, con fr on ti con nlcuni Stati esteri, per gli anni 181-9-90 >>, 1 ua qu nle andava unita la seguente leltPra. <'hP crediamo dove ro•w pubblicare anche per personale allestazione rlella massima nostra osservanza, rkonnscenti in parLicolar modo della ge n tilezza per cui l'illustre statista ci trasmette ogni sua pubblicazione. Vi azgiungiamo alcuni altri imporlandali trntti , appunto dalla sopra a ccennala pubblicazione .
Dott. F. BAROFFto.
Mi pregio di presentare alla S. v. la delle cause di morte avvenute nel Regno nei due anni 1889-00.
Questa statistica, chP fino al 1886 er11 «lata limitnla alle morti av venute nei 28\ comuni di vrovincia, di clrconda r1o e di rlistrello, fu estesa nel 1886 a tutti quanti i comun i del Regno.
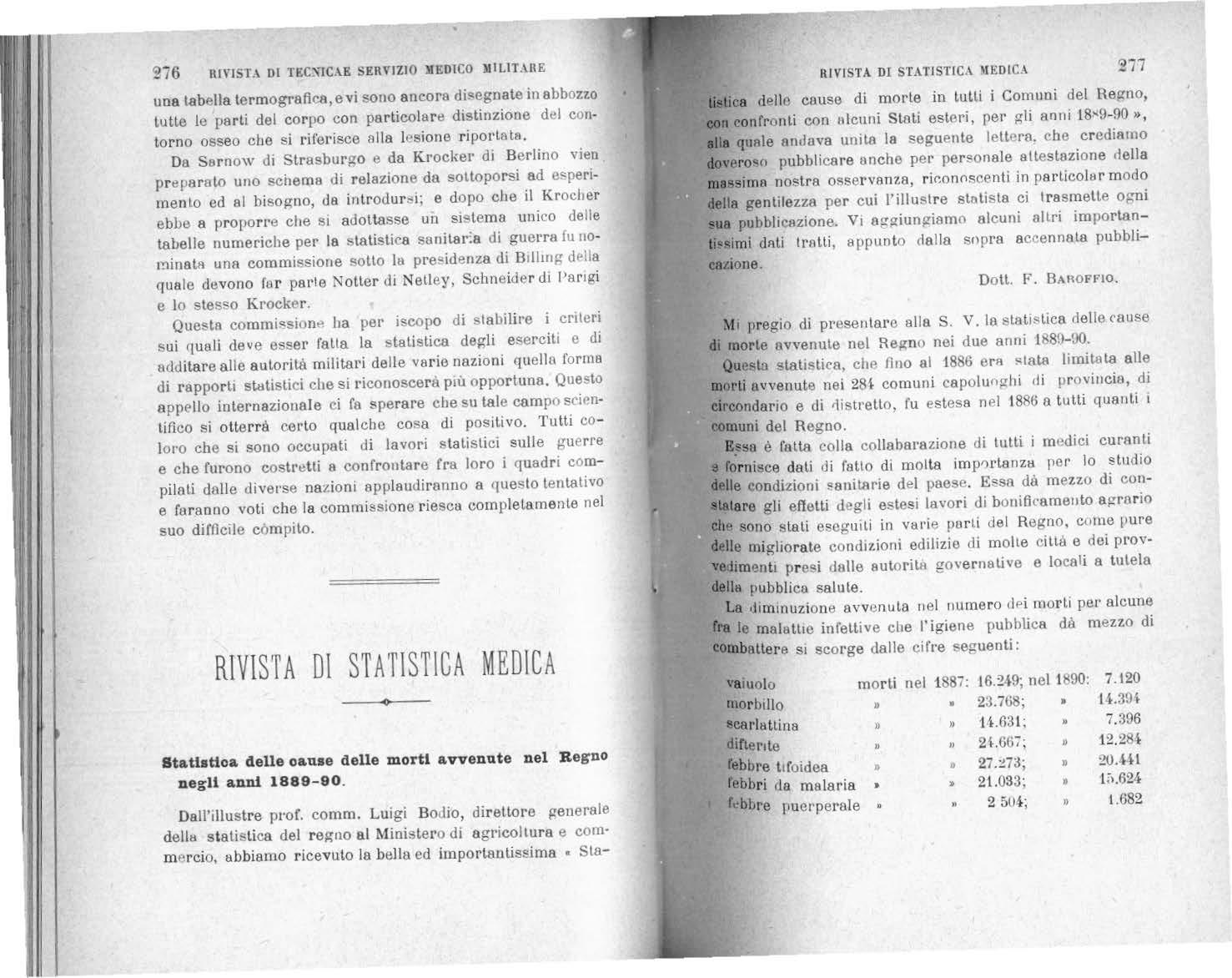
E@sa é fatta colla collabat·azione di tutti i m Pdici curanti 8 d ali di fattO di mOlla imp01'tai1Zii per ]O studiO delle condizioni sanitarie del paese. Essa dà m ezzo di conatatare gli effetti dPgli estesi lavori di b onifkameuto agrario chA sono s tati eseguiti in vat'ie parti del Reg no, come pure delle migliorate condizioni edilizie di molte città e doi prov"Yedimen tt dalle auto rilt1 governative e locali a tutela della pubblica salute.
La ·hmin uzione avv enuta nel numero dPi morli pe1' alcune fra le malatlle infettiv e che l'igiene pubblica dà mezzo di eomballe r e si scorge dalle cift·e seguenti: vaiuolo morti nel 188ì: J6.2 i9; nel1!:190: 7.120 mor bi llo li • 23.768; • 14. 3!.11 ecarl at tina )) H.63 l ; 7.396 difl.e r 1te 2l.6!i7; 12.28! reb bre tifoidea l) » 27.273; » 20.41-1 rebbri ua ma laria 2t.OS3; » 1i•.624 pu erperale » 2 504; )) 1.682
R ima se quasi inva r iata la mot•tali là pet• mu lo.tlie tu!Jerco!.arr e per cancr·o; è aumentala legge r mente la mortalita per sifilide morti nel 1887: 1893; nel 1890: e per alcolismo » 434; » \8-i si sono dale qui sol tanto alcune notizie P pet' gli anni sus:::eguenli si è dovuto r inuuzillt'e tale pubblicazione in seguito alla diminuzione del fondo aseegnalo alla s tatistica. Essendo di venuto necessario abbandonare l' una o !"altra dello due pubblicazioni, convenne sacriftcal'e q uella degli infermi, anzicht> quella de1 morti, perchè la degli ospedali riguarda quasi unicamente individui a.lulli d i condizione povera, o soltanto ctuella ,,arte rli popoluz10 n e chH vive in centri popolosi, nei quali aperl! aetituti ospatalieri, mentre la statistica delle cause di morte mette in evidenza lo stato sanitario di tutte le classi sociali e per tutte le età.
Il volume contiene pure alcuni confronti f1•a l'Italia ed a ltr i paesi.
Simili stuli<>tiche non furono finora tstituilo in tutt1 quanti gli Stati d'Europa. per la Spagna, il Porto gallo, la Gr ecia, In Russia e i PaPsi Salcamci ed anche la Francia f parec.:chi fra gli Stati get·manici non poRsiedono tole statistica per tutte le morti avvenute nella popolazione oello intero Stato, ma limitano a le notiziP delle mor ti causate da alcune malattie inl'ettive nelle città p1ù popolose.
Secondo i confronti fatti, se S<i l'agguagliano i mot•li ad 1 milione di abitanti di ciascun Stato, il oawolo avrebbe causalo nel IH89, 4i.8 morti in l 1alia, "2 1 in Aust r ia, 181- nelle citta fr ancesi che hanno più d t 10,000 abilantt e appena;:, in 2 in Olanda e SveziH, 1 in Inghilterra e in Svizzet·a, in Scozia, in I rlanda.
La febbre hu causalo nello stesso anno per o:;.rni milione di abitanti, 75!1 morti in Italia, =>10 nelle città fran· cesi, 486 in Austi·ia, 210 in Svezia, 2i0 in Prussia , 187 in 163 in Svizze ra, 137 in Olanda.
Le febbri da malaria, che in It.aha causarono 5-1.0 morii ogni milione di abitanti, negli allri Stati sono rappresf'nlate da pr opor zioni m in ime.
Sono invece numerose più altrove che da noi lt> morti per tube r colosi, per alcoolismo, per cancro, per difterite, per causa violenta accidentale e per suicidio.
In appendice alla stù tislica delle cause di morte si è pubblicato nel presente volume la statistica sanitaria degli infermi cu r ali negli O'<pedali civili du r ante l'anno f8f..'i.
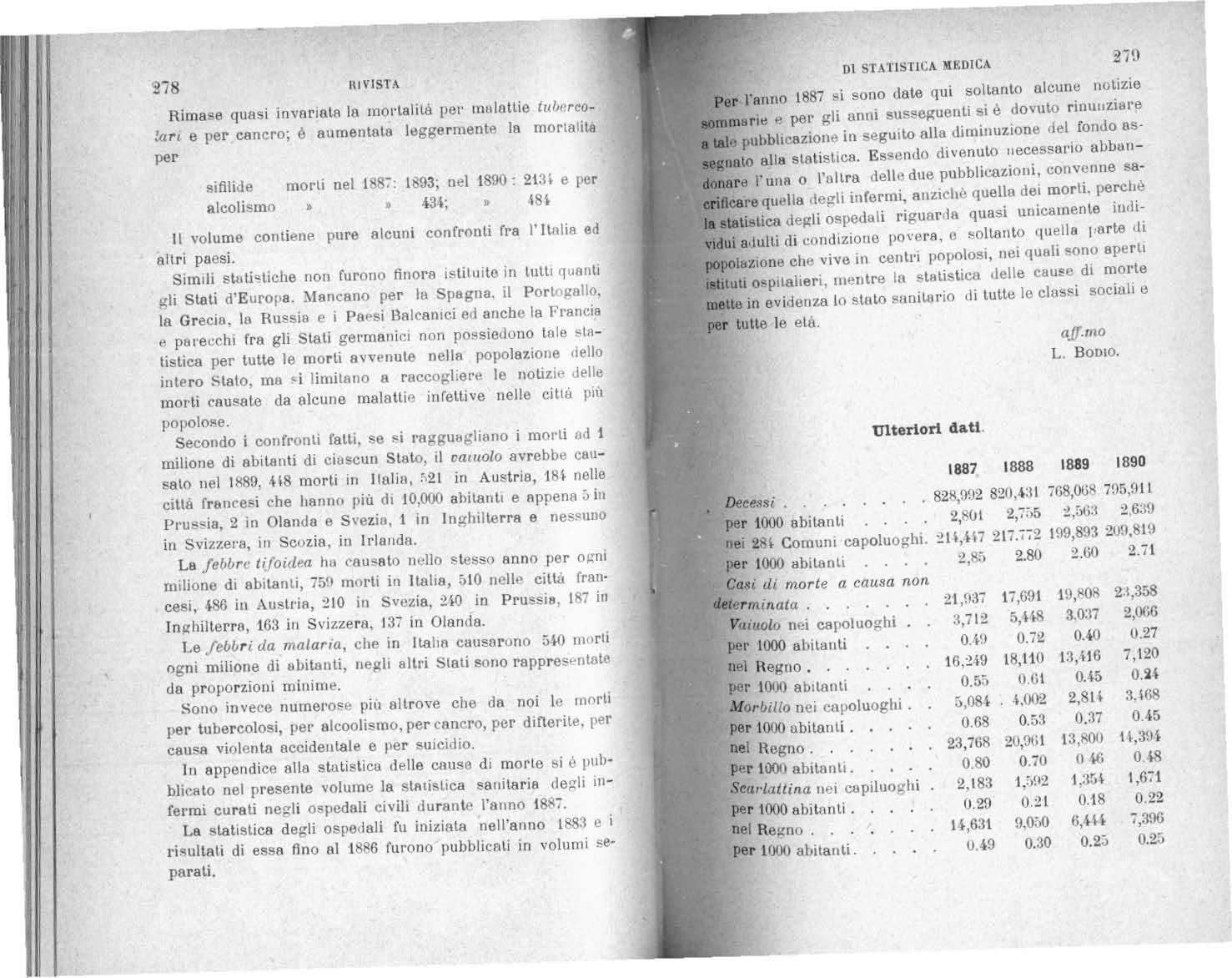
La s ta t istica degli ospedali fu iniziata nell'anno 188:l e i di essa fino al 1886 furono pubblicF1li in volumi separati.
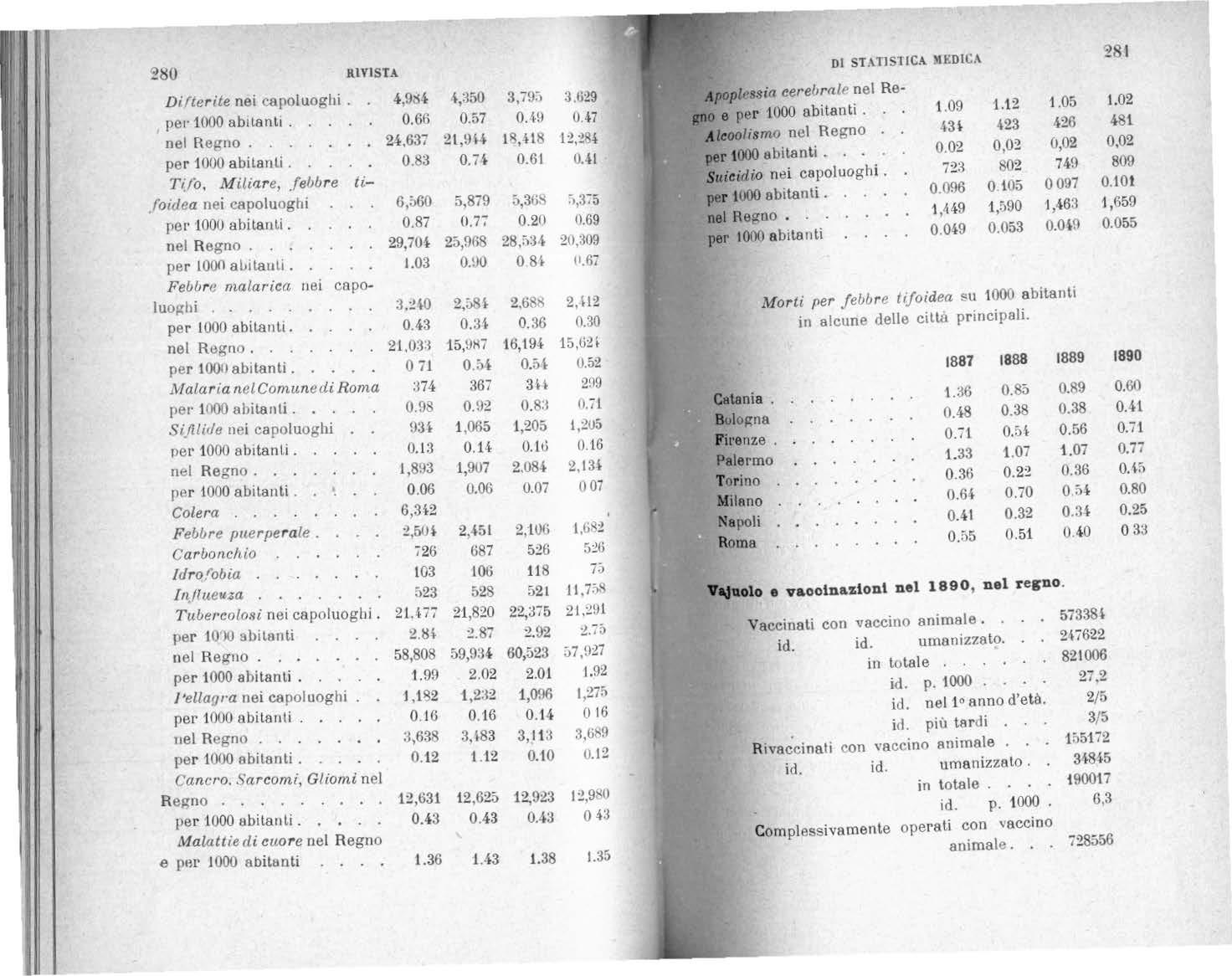
Complessivamente operalt con vaccino umanizzato . in totale . . . . id. p. 1000 id. id. id. umanizzato id. modificati id. animale . id. id. id. umAnizzato
Esiti completi col vaccino animale .
Su 1000 vaccinati
Casi di vajuolo (probabilmente). id. di morte . p. HlOO
Variet
Lega aderente al vetro. - \VALTEn. - (Il Pr ogresso, 15 dicembre 18fll).
Sarebbe composta di 95 parli di stagno puro e rallle, aggiunti allo stagno fuso, agitando il mi scuglio cou un agilato r e di legno, cola ndolo o gt·artulandolo, poscia rtfon dendolo. F onde a cirCH 36•. Aggiungendo ùa 0,5 aù 1 per 1000 di piombo o di zinco la lega può r ende r si più o meno dura e più o meno fusibile. Se ne può servit•e anche pc 1· rt\'el->tirne dei m etall i o fili metallici, con appa1·enza di argento.
Protezione degli tstrumentl dalla ruggine . - (Giornale medico di Colombo).
Immergerli per· qualche minuto in una soluzione di carbonato di R esta no inossidabili pel' degli anni anché se e!.'posli ad una atmosfera umida.
VARII::.TÀ
dei medtot ln Ita.Ua .
Da un bel lavoro dell'egregio dott. RA.SERI:. il llftllll4le r/i nu ooi m edici in Italia, toghamo l seguenti tmportanli dali : Medi ci nel 1885 : Borghesi . . . . . . . . Militari (E"ercito) . . Cì-}2 1832;)... Uno ogni 1\104 abttanlt Id. (marina) 11?1 nei li pNvinc·a (G9} Uno ogni 902 abitanti, negli altri comuni 12517.
GiorMle di malaUia negli stabilimenti di cm·a. .. 8.864,0000i\Iot·li 3:>'i18. nel Regno(per computi,dedolle dai tnor·ti)2000.000.00G
• - Morti 800,000 (c.irca).
• per ogni all'anno al giorno 31. dei medici 1890: 5iG = :3 1,3 per 1000; mentre nfllla popolazione da 25 anni in su la rnortolità ,-. solo di 23,5 pe1' iOOO.
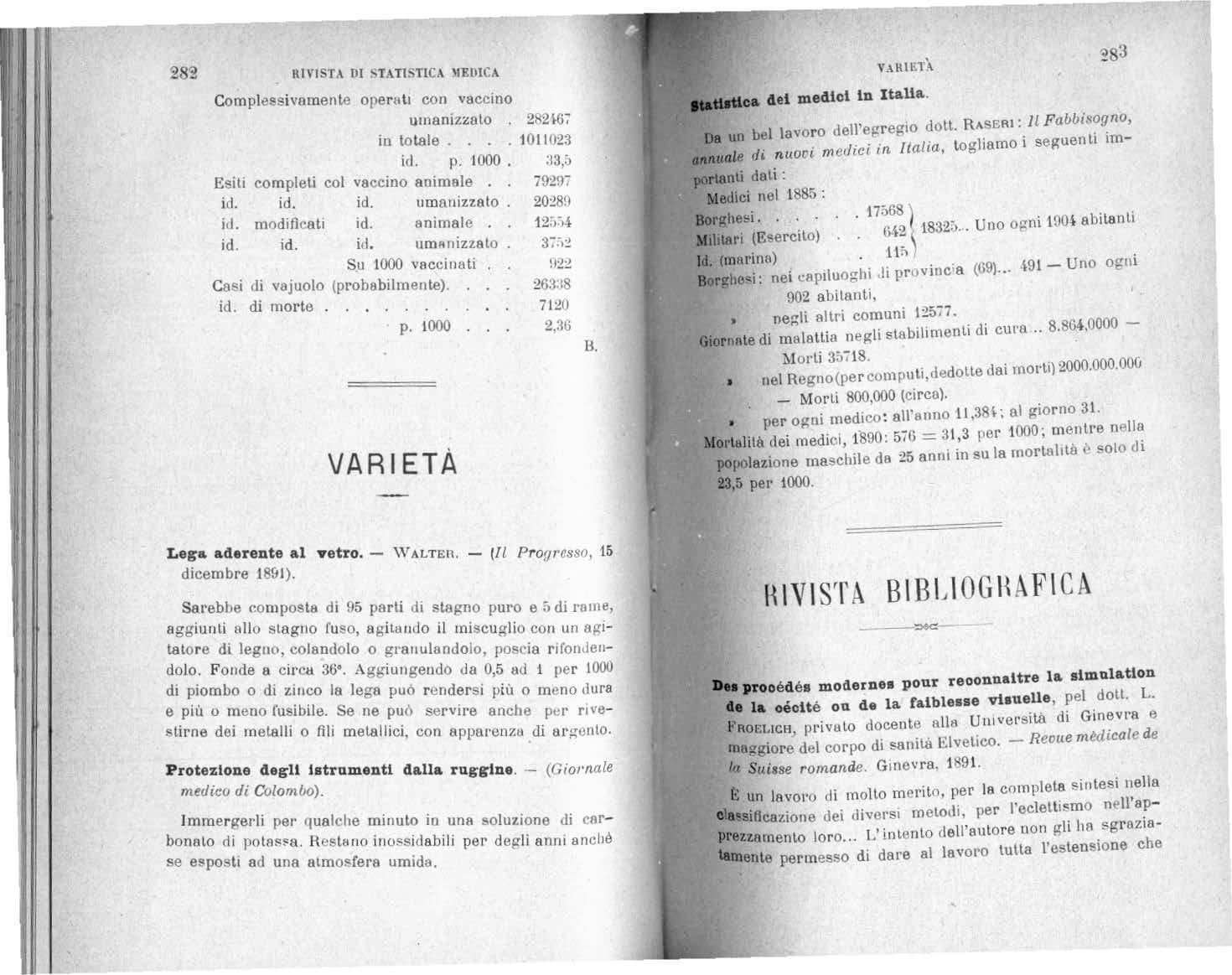
H\VIST A BtBLlOGHAF\ CA
Du prooé d és moderne& pour reoonualtre la slmulatlon 4e la oéolté ou de la falblease vtauelle , pel doll. L. F ROELICH privato docente alla Untver::;ilà di Ginevra e maggior: del corpo di san ila Elvetico. - Reoue de l11 Suisse romande. Ginevra. 1891.
È un la vot•o di mollo m eri to, per la completa siutesi nella dei diversi metodi, per l'eclell t!< mO nell'apprezza mento loro ... L'int e nto dell'autore uon gli ha sgraziatamente permesso di dare al lavoro tutta l'estensione che avrebbe meritato; ma per gli in iziali a simili studi è ve••ameniP prezioso sunto dei numerosi mezzi dell' un roc:e mod r · · ' c nume. . . l •caztonJ dei pt•oced•menli sugo-erir la solu z1one ùbl diWcile tema É un librett'•no - d' ,... •,per · In IS!)Pnsa JiiG a cln s• occupa di «imili ricevute, e oso 111re necesc:a rio ni medici milil.at•i.
P AG.LIAt'\1 r•·of. comm. LUIGI, Direttore fdeiiA <:an là puh bhca. - Vaaohetta a ohluaura ldraulloa. (tipo M ouraa) e di filtro a torba, per le acque luride nel aiatema di fognatura separata tubolare . - (Labo ratort scientifici della rltre:z. di sanità). - ( M111istero dell'interno).
È uno scritto c:uccoso breve ma d'un va l ore t' . . • , pra 1co ecceA l'ontore vi propu:tna la teo:i, che • nelle
• locali tà dove t> m ollo dafìcieute l'acqua e non si pu ò vale r·
• per lo vare almeno ad intormittenza l e In tri ne. o:ono a
• r accomandarsi A p••efer enza di qualunque "istema di ro-
« le fosse m ili; non Ria n o quest"' a !"cpa-
« raziOne delle !'lohde dal le liquide, ma esportino in
« modo completo 1materiali di r•ifìuto dello case. . . Pt> rché
• gravissimo errore il pensa1'e ad avviare in ca·
" quali esc:i ros"ano eso:ere, ')Uei materiali, quando non
" VI è ve1colo acquoso pe r convogliarli ,•omple-
« tamenle n convenient<> distanza dall'abitato.
.• Nel maagior numer·o dei «'asr invecf' in cui tro,·ano
" t centri popol osi òi f(Uklche importanza dove vi é mezzo
« di va l er si dell'acqua o per l avature o con·
* tinue delle latrine. f' più ancora dove l'eccec:so di arqua
• della diRlr1bnzione ciltaiina deve esserP in qun lche modo
« da!le case. mentre po i non !'li hann o a di 5:pO!<' ·
« z•one t lor·r enll d'ac,,ua di cui era pr ovvt>d uta Roma a nlieti
• per i canali a sPzioni gigan tesche, sono pure
• !'empre d1 avv1!"0 che il ,;is temn di fo,.,natura tubolarr che o '
• llene le acqut:1 rli r ifiuto delle da q uelle meteo-
" riche sia eia
• da prefel'i rsi per ragioni i gieniche p<! r ché c' solo con
BIBI.IOGIIAFICA
1 questi tubi di picco lo calilH'P, che si può evitare in modo
1 sicu1·o lu trapelazione nel terreno dei liquidi immondi, e cl' uscita delle loro emana1.ioni putr ide nell'ambiente r e-
• spir11lO.
• È a p1•eferirsi in via economica, perché cos ta molto meno
• di impianto, di manutenzione e di <>ervizio, e pf'rchè da
• mezzo dt valersi dei matet·iali utili 11lla agri co1 turu, senza
•l'in!{ornbro dell'en o••m e quautità di acqua che t> inevitabile
• col t'Jut iJ l'égoiH, e che si fa più grflve appuuto nelle sla•llioui in cui è meno o propizia l'ir•·igazione. 11
Il PagliOtli r·accomanda il suo sistema nel de!<iderio di coneomrr nlla •·isoluzione dei dif'ticili problemi relativi a• slemi •h tubulazioni separal1, ecc.

MorcARI. - Filtrazione delllquidl putreaciblll attraverso la torba. - dell'interno. - Laborato r i della Dire•ion l' di saruta).
Il si-<tema fu immaginnlo dallo f'te!lso direttore della MDità puhblira. L e rleduzioui spe rimentali si cosi:
• La torba naturfl l l', attr·aversata da liquidi delle deiezioni
• animali lascia pa ssare solamente ed anche so lo in parte
•l'urea O•l altr o prodotto nilrogenal o; che f!U &ndo
• e satura, negli struti J'iofilll'alÌone lascia passare anche
• altre sostanze di natura piìt comp lesse; che in queste con-
• diziom rimescolata convenientemente, od anch e falln es-
• riacquisla il primo poter e; che nei liquidi filtrati
1 attravei'SO la torba attiva non si continuano più le fei'men-
1 lezioni putrid e, e che, fina l men te, pet• sè la tor·ba
• ba una nzion e notevole e.J ad un
• tempo.•
I noltre: (( illiquame filtralo (delle cHsse d'escrementi) nou
• mostra tendenza ad uller10ri r.wmentazioni; d1e presenta
• una forte eccedenza di azoto Che quindi la filtraztone
• dei materiali organi ci attr•ave rso alla torba tras formi i me·
• in ler•·eni poco adatti allo sviluppo dei microor-
1 gani!<tni che danno luogo alle fermentazioni putr ide, le quali
• normalmente richiedono nei subslrati di collura una f.{rande
• eccedenza di ca r bo nio. »
Index-Catalogue of the Ubrary ofthe Surgeon-gene ral' 1 oflloe . - V ol. XI l, W a.;;hington, 1891.
A bbiamo ricevuto il XII volume di ques ta f!ran <liosa. pubblieilzione, chfl 1., certamente quAnto di più este"o e dt più accurato sìa stato fln qui opera to in fallo di bibliografi a medica. una di «lUe ll e opt•re di che hanno un valo r P p ra tico superiore a tante opere di concetto. Per rn rr.e comprend•• re la g r andiosità ai nostri lettori basterll che diciamo che nei 12 gro.;;si volumi "in qui pubblicalt si trovano r egis trati H6.855 volumi, e 120,000 opu.,coli di rnedicinll, che vi è dato il tilolo e l'esatta mdicazione òi :l93,80R articoli di giornali. Per dat e un'idea della minuta e della razio nAlità del metodo adottato nella compilAzione ba-<terà che diciomo, est>mp io, che la voce Scarlatinn occupa pngine di fitta com posizione a due colonne, la voce Rh,umaMi pagine. materia un poco es tesa è surldivisa in solto-gruppi per facilita r e le ri cerche; per esempio. pN' la scArlattina, si hanno le indicazioni bibliografic he d1 opere ed articoli: 1. sulla c:ca r lattina in re - 2. sulle forme ano rmali e g ravi - 3. sulln batteriologia o in ocu lazione -

4. cause, contagio e profìla!'si - :>. sulle complicazioni e po5:Lurni - 6. sulla d ia gno"i o s inlomi - 7. s ull e epidemie loca li - R. sugli speciali pE-r scarlaltinosi - fl. s•Jll'anatC'mia patologica - 10. sul periodo d 'incuba zion e e d ' infellivi lé11. "Ulla preven zione pe r mezzo della belladonna - 12. sulla curA - 13 scarlattin a agli anill'tnl i - 14 scar lattina e mo r· billo - sca rlaLtina e vajuolo - 16. scarlattina e trauma· tismo - l i. scarlallinn nella gt·avidanza e nel puerpr.rio.
In somma é un'opera chE> nessuno, che voglia in dagare dettagliatamente la biblio.!Zrafia e la s toria di qualsiasi argom ento dt:llo scibile medico, può lrascur·are di consu1tnr1'
Il XII volume comincia collA voce Reger e termina colla vocP Shcdlleroorth.
Congressi
internazionale di Ginecologia. e Oatetri1' Oongreaao ti& a B ruxelles . .
P regati dal Se (l' reta r io generale, d iamo che per della Sotietà belga di ostelrtcta e gme' . d 1 14 1 19 settembre 1892 la cologia, ;;l te r r·à a a a . . . . . pnma session e di un congresso inlernaztOn&le d t ed
Tre questi oni sono per ora all'ot•dm e dell!torno.
1' Delle suppu r azioni pelviche;
2" Della gravi lanza e"lraulet·ina ;
3' n ella p lacent•• previtt. . . . ' . .
Tassa di amm issione 30 franc·hi, con dtrttto a e! IIOC'.onli del Con "' r es,.o. Le inscrt:tioni per le comuntcaztont, o · d' · t al se- diecorsi dim ostrazioni, e('C., devono essere 111 Jrtzza e !n'etario, gen e t•al e dott. 12, Rlle de P etits - Ca r mes a BruzPlles lfino al 1° o 18!):2). .
Sal'il pure annessa al Conl-!t'esso una mterDal.ionale di s trumen ti eù appa r ecchi di ginecologta ed oste• \neia.
Necrologi A
L1llgi Dompè.
Il gi o eno 2 di marzo 1892 moriva nella nativa Fossano, nell'età di 62 an ni, il chimico fa1·macista ispettor e a l'i poso, comm . Luigi Domp é.
Entt•a to al ser vizio come solùalo di leva della Incominciò 8 servi re negli ospedali militari in dt Uevo far m a cis ta · indi nel 185i fu nominato m!lt, ' ' · · d' della \are dt 3' classe e, percorrendo man ma no 1 vart grA .• carriera, il posto di dircUo r e della farmacta cen- lrale nell'anno 1875 e quello di 1speltore del corpo farmaceutico nel 181'10, rimanendovi s1no al1884, epoca in cui, per sw1 domanda, fu collocalo a r iposo e in:;igmlo della commenda dell'Ordine della Corona d'Italia.

Fu impiegali) intelligente e zelante, godeva lA sllrna dt quanti lo conoscevano e nella sua lunga carriera di :!5 anni ebbe campo di utili servizi all'ammmisteazione mi· lllare.
Notizie
Il generale medico Pec c o.
Con R. D. 28 gennaio il comm. Giacomo P ecco, maggio r generale medtco, Ispettore capo di samlà militare, veniva in seguito a sua domanda collocalo posizione di :st>rviz:o ausiliario.
All'Illustre generale, che per più di 50 ann1 ha militato nei ranghi del corpo sanitario, esempio costante di severa devo· zio ne al dovere, mandiumo il nostro riverente saluto, che è put' quello, senza dubb1o, dell'mlero cor po, eJ auguriamo ancora lunghi anni di prospera vita.
A succedere al generale Pecco fu nominato con R. D. 1ifebbraio il direttore di questo giornale, maggiore medico cornm. Baroffio.
llEL BUtBO OCULA RE
Il Dirct.t.ore l l Collabora t.oc-e per la R • Mar1 n a
Dott. FELICE BAROFFIO generale medico.
D.• TEODORJCO RoSAT I
Il Rcdat.t.ore rn lavoro pubhlicato da Dmlsclwwnn ( l ) sulla UJeningite purulenta determinata dalla enucleazione dà la statistiea rli 27 osservazioni, delle quali 22 segu ite da morte, recale operatori: n eutschmann 2. ll owe l . l'riest ley Smith 3. r ossiu s l.
0.• RIOOL FO LJVI Jledi eo d i t • eloue Capitano medi co.
Mi deciso a rendere di pubblica ragillne una nola IOtla e\ enterazione del bull•o oculare, poichè, avendo avuto opportun ith di eseguire iu questi giorni tale operazione, qtest• , dagli urfìciali meLiici di questo ospedale fu giutlica ta tllima, e per la semplicilit della tecnica, e per i ri,n!tati brillanti in tempo relatiranH•nte breve, e per la buona rintci la dell a E:'porròpure alcuni casi racc·olti al1:1 clini ca '41tnltstrc a di diretta dal m•o illu:>tre maestro il prof. Jlan{Ytr.li , parendomi utile portare ad una operazione hnora po co conosciut a il mio tributo.
Al t:on Ht esso dei tedeschi ten!1tosi in Magdeburgo uel 1 t lfrrdo fhw•fi• proponeva l' esenterazione del bu lho t•ome ;;ostitnti\o dell'enucleazione fino altora praticala, iu tnlli i casi, tranne che nel tuwore endocolare ( 1).
La ragione principale che spingeva Graefe a sostitu ire all'f'nuciE>azione un altro metodo operativo era che l'esperienza di 4.0 anni ave\ a inseJ!nato, non essere l'enucleazion e nn allo operatorio sceVI'o d'inconvenienti.
Uno di questi inco nvenienti si è la piccolezza del montone che si ha in se!.:uito ad es;;a. la mob ilità lim itata di per cui la protesi riesce molte volte imperfetta.
Cn inconveniente poi più grave di tulli è que sto. rhe in nn certo numero di casi, numero se ;;i vuole relat ivan;ente piccolo, f11 osservato svi lupparsi dopo l'enucleazion e una meningite, il piit dello volte con esito let::de.
Alfredo GraCfe 5.
Mahnardt 1 .
11orner 4. .J u:;t 1 . 1 . l .
Leber l .
Ma.' hofer i .
A,..plnnd l.
Schreiher l .
Benson !..
HoiTmann l .
Wecker l.
•JUeste osserv 1zioni :>e n e deve aggiungere un 'altra di Weck ,.r, due di Galez-otcski riferite alla lY riunione della Soc ietit (1886) e due di Dor ( 1).
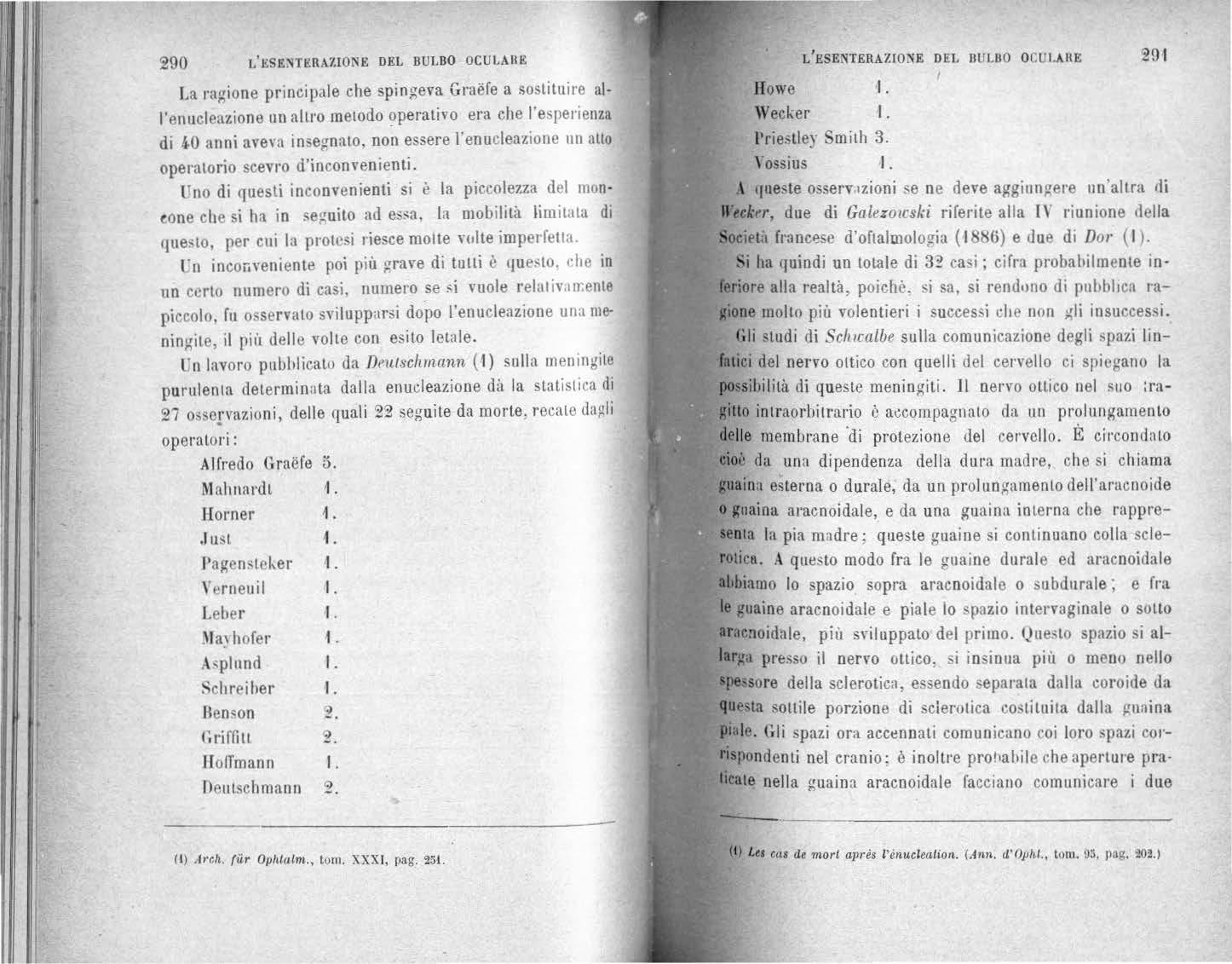
A
Si ha cruindi un totale di 3! casi; cifra probabilmente inferiore all a realtà, poichè. i'i sa, si rendowo di pubblica raJione mollo più volentieri i succesgi t;he non ;,:li insuccessi . studi di Sclw·albe sulla comunicazione degli spazi linfa tici del ner vo ottico con quelli del cervello ci spiegano la possihilità di queste meningiti. Il nervo ottico nel suo :ragitto intra orbitrario è da un prolungamento delle membrane "d i protezione del cervello. È circondato cioè da un a dipendenza della dura madre, che si chiama guaina esterna o durale, da un pro! un:,:amento dell'ar·acnoide o guaina aracnoidale, e da una guaina interna che rappresenta la pia madre; queste guaine si continuano colla sclerotict\. A que sto modo fra le guaine durale ed aracnoidale abbiam o lo spazio sopra arac noidale o subdurale; e fra le guain e aracnoidale e piale lo :>pazio intervaginale o sotto aracnoidale, piir sviluppato del primo. IJuesto spazio si alpresso il nervo ottico, si insinua più o me no nello della sclerotica, essendo separata dalla da questa sollile porzione di scierotica costituita dalla gua ina piale. Gli spazi ora accennati comunicano coi loro spazi corrispon denti nel cranio; è inoltre pro!1ahile che aperture pralieate nell a guaina aracnoidale facciano comunicar·e i due
DEL OULOO OCULARE spazi sopra e sollo aracnoidali. Se dunque si taglia il nerro ottico in vicinanza della sna inset·zione al bui bo, si de,:li spazi linfati ci in comunicazione drretta colle meningr e se si ha una infezione, cosa che può sempre succedere dopo una ope razione. questa può diffondersi attraverso i detti spazi all e menin)!i.
Bensv!l ( l ) anzi =-i meraviglia come una infezrone non insorga più di fretru ente dopo l'enu cleazione , per·chi> per l'atroria del ner' o ottico, ed es.sen1lo la guaina rsterna ti,s,tta alle pareti dei fori •rttrci. questi sp:1zi intrav:1ginali derono aumentar,-i e facilitarne così la tra!\mis:.ione.
Amme;sa adunque questa via di propagazione di un· infezrone post operatorra alle meningi, è evidente rhe, non si ledono le guaine del nen o ottico e non aprono rtuindi gli gpazi linfatici, non si anit il pericolo di una meningitc.
Partendo da conrello . . llfml o Grai{e proponeva appunto come sostitutivo òell'enucleazrone l'esentcrazione del lrul ho, cioè un' operazro ne che, esportando Lullc le parti vascolari del gloho oculare, cioè i tessuti, sede di una infiam· n1:1zione che in ùate ci rco.;tanze può trasmettcrsi all'altr'occlrio. evitava così il pericolo di una oftalmia simpatica e, non ap rendo le guaine linf'atiche, scongiu rava il pericolo di una menin).!Ìte.
Ol trecltè ne i casi di oftalrnia :;rmpatica. detta operazione sarebbe pure applicabile in tulli gli altri casi in cui pratica l'enucleazi one (trilnne nel tumore endoculare). come nel glaucoma assoluto, per lihe ra re il malato da lle nenalgi e, tlt·llo ;;tafiloma totale allo stes,;o scopo, e a scopo co:-metico: infine nell a pa noftalm it e, per liberare il paz ieu te dalle he sofferenz e che dit il flemmone oculare, per evitare le drfTu sioni dell'orhita e la meninl.(ite sncces,;iva Ed i ca:;i di panoft almit c nei quali a questo lìne si era l'enucleaz;one erano quelli eire a'i'e\'ano dato rl m:q.(gtor nnmero di per cui moltissim i operatori consideravano la panoftal mite come una specie di < t w li mt• tll)tyrrt• » per timo re di un e:;i to letale . t 'operazione come venne propost;t dal lha l'{e è la seguente:

Oltre a ,1uesto \'antaggio l'e:'enterazione riparereldlC in parte all'altro inconveniente cioè si '" rehbe un mtmcone più 'oluminoso, più mobi le. e la protesi riusci rebbe quindi molto meglio.
1o s'i ncicle e si :;brigl ia la coni( inntint hulbarc l o 3! mm. dal margine corurale;
:'i demolisce il segmento anteriore dell'occhio a l o 2 mm su ll a sclerotica, con un co ltellino di Gr·ade, il quale si manovra come nel primo tempo dell'operazione di cataratta: rl re,;to si utagliare a co lpi di forhici:
3" si :;vuota il gloho oc ulare con un cucchiaio : l'n' l'.rent cmtio parzinle era in uso nella pratica ocu li stica. Qu(l!Jlino asporta' a la cor nea, tutt'al piìt il cristallino. e chiudeva l'occ hio con un bendaggio. Spesso seguiva infiammazrone, suppurazione, e quondi panoftalmite; nei casi felici un tessuto cicatrizinle, una specie di pseudoeornea , che chiude\a la breccia.
4-" :; i cuce la congiuntiva con ratgut sottile; merlicatura belli ca all'iodoformio.
Questa operazione. in trodotta nella chirurgia or ula re come metodo. non era però in sè stessa cosa nuova.
(l) ,1/eninqite l»>l·telle ci l a suile ole l'énucleatiun {Revu l oé11. cl'ophlalmo· l ooie, t SM. p. 378 e S:!il1
Sirllt'L ( l ), dopo aver amputalo il segmento anteriore, introduceva l'indice nella cavità oculare, e la svuotan1, portando via coll'u nghia le membrane vascolari e nervose.
Frohlich (2) in un caso di panoftalm ite inctptente, per un pezzo di ferro penetrato nel l' intemo dell'occhio. dopo l'estrazione di questo coll'e lettro- cah1 mita praticava immediatamente l'e.renteralio bulb i , nel modo sopra descrillo. facendo !arature del sacco scleral e con so luzioni antiselltche.
.ìoyes (3) nel 1881, lf 11les ( i-) e Londr,bay (5) pr'ma che Graii{t• presen tata quegta operazione. l'avevano gii1 praticata, ed avevano pubblicate osservazioni in proposito.
)1 .1 LYoyes non parla delle precauzioni antisettiche da o.; -
.lfulrs e Landt>sberg praticano l'esenterazi one per Il solo s1:opo di otte nere un llel moncone.
. }l a come gitt dicemmo, spetta ad .t lfmlo (;rai'{r l'aver tn trodouo quest'operazione nella chirurgia oculare. come metodo ::.ostitutivo all'enucleazione. Essa fu benissim o arco lta fin da principio nel campo oftalmologico, nè poteva essere altrimenti, se si considera che era desti nata a far :'parire l'accidente più grave che potesse complicare la più gravo delle op erazioni della chirurgia oculare, davanti al t1uale accidente l'operatore si arre stava. dubbioso, mulgrndo elle e,;istesse una indicazione espli cita all'enucleazione.
Col processo pr imitivo che abbiamo riportato, si verifita- inconv enienti, GroiiJì· non turdò a ricono-
· di demolire il segmento anteriore a l mm . da.lla sderotica. Qui' ì ;;i fer.isce per l'appunto la recili are oltremodo ri cca di vasi e di nervi, e quasi compromessa in modo grave per le afTezioni che rino l' osenterazione. La ima porlione di que:;la 'eresta den tro il globo oculare, e per esportarla occor· stiramenti e per la qual cosa, oltre al non per studi microscopici, :;i hanno dolori acuti e fc rtt gie.
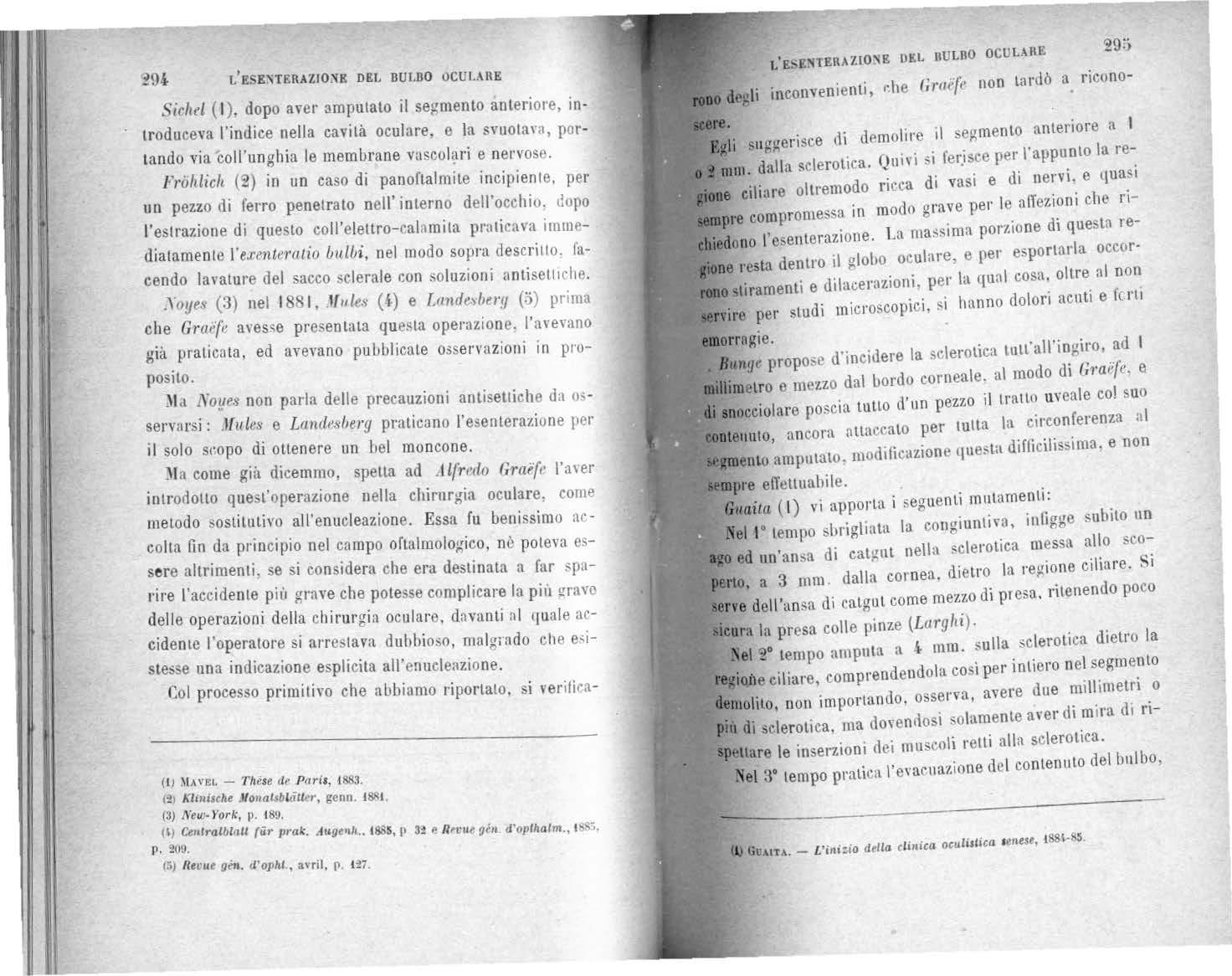
B1m!fe d'incidere la sclerotica tuu'all'i ogiro, ad l e mezzo dal bordo corneale. al modo di Graiife. e snocciol are poscia tutto d'un pezzo il trallo uveule co! suo ancora attacrato per tulla la circonferenza al amputato , modificazione tpte sta diflìcilissima. e non effettuabil e.
Guaita ( l ) vi apporta i seg uenti mutumenti: el '!,0 tem po amputa a \. mm. scleroti ca dietro la ciliare, comprendendola così per inticro nel segmento non importando. osserva, avere due millimetri o piu di sclerotica, ma dovenllosi ave r di mira dì rispellare le inserzioni dei mnsl'oli relli alla sclerotica.
Nel 1° tem po shrigliata la congiunti\' a, infigge subito nn ed un 'am;a di nella sclerotica messa allo ::coa 3 mm. dalla cot oea. dietro la regione ciliare . Si dell'ansa di catgul come mezzo di p1esa. ritenendo poco la presa colle pinze (Larghi).
Nel :3• tempo pt·atica J'e\'acuazione del co ntenuto del bnlbo ,
( l ) MAVBL - Thf&e dP Paril, 48ì!3. llottahb l iitiPr, genn. 181\1.
(3) Neu;- Yorl•, p. 189 Cenlralblatl (U1' pr·ak. Auge'lh .• 1885, (l 3:! (' n fVUC "éll d'oplhalm llic;:; p, 209. . ., ' non mediante il rucchiuio di lraldrw. ma con un a 'Pugna mo n tt:ta sopra un sottile e diritto porta-=>pugna, cliP f<t girare sn se stesso due o tre volte.
15) /lecue f)én. à'ophl, a-ril, p.
Pnhblica tre ca:-.i, in due der qnali ebbe leggiera suppurazione, nel terzo. che operò colle moùificazioni da lu i in tr·odottc, ebbe guarigione per t• in1enzione .
Con qualche modili cazio ne l'exenlerat io si pr.. ti ca nella clinica dell'A badie ( l). e cinquP ca:>i sono pubblicati nella tesi del dott. Jfarl'l che ne agginn;e altri due racculli alle cliniche di Gillt•t dt• Ot·nmu1 ont e JJuplay.
IJ'ecker (3) non ha 111:11 suppurazionc nei ,uoi casi, ed applicò sempre la protesi all'Bo giorno.
Oa due pubblicazioni del dou. ilbini (.l.) !'he •tnest'operazionc fu praticata nella cl in i ca di Torino con un a mod ificazione opposta a t(uella d i Gnaita, cioè (in k casi). si lasciò intatta tutta la sclerotica. I noltre si fece la rur.itura a borsa della congiuntiva. Sn Il casi riferiti si ebbe per tre Yolte leggem suppurazione in individui di condizioni generali pessime. che certamente inllui"cono sul d1 :.!U:lri){ione.
Xella clinica oftalmoiatrica di Pisa il prof. .lfan{recli pratica J'esentcrazione nel !\eguente modo .
Gli strumenti ve ngono messi a bagno in una soluzione di acido fen ico a l 2 p. l 00 un'ora pr ima dell'operazione. L'ammalato viene clo roformizzato, snh o nei casi in cui esistono controindicazioni speciali. Si lava la cute delle palpebre e tlelle t 'ESE"TERAZIO:'i'E DEL DUI.OO Ot:IILARI!: 297 ze d dr!!e n temente, prima co n $apone al sublimato, con sol uzione ùi sublimato 1 1 .ooo· La -.uperlìcie della c della congiuntiva SJ la,ano con -.oluzioni di subli1 ,o ,0 • mediante itTigazione per qualche tempo.
Ap pli•·ato il blefarostato si atTerra la congiuntiva colla pinr.a denti, ad un mm. c.irca dal margine corneale . S'incide tutto 'intorn o della cornea e la si disseca per breve tratto. Si la sderotica a 3 mill. dalla cornea col coltello di , s1 completa l'incisione in giro mediante le forbici. Asporlata così la cornea. esce quasi spontaneame nte la magvior parte del vitreo. Lo S\ uotamento si completa intr.Hlucendo hatuiToli di cotone fenicato imhevuto nella di sublimato '/2000 e. cercando con movimenti di ratt i fregando sulla superficie intea·na della sc lerotiea, d i li ber are questa completamente dalle membra ne vae net·vose, cosa che si ottiene far;lmente. Si cessa da te manovre qu·mòo si vede la supe dicie interna della atrauo bianca e libera di ce ncio uveale. Si n ert t che in queste manone il sacco srlerale te· hen e aperto, e la superficie interna della sclerotica hen perciò conviene che, mentre l'operatore tiene il margin e sollevrrto e lìsso con una pinzetta, J'assi:;tente _ ..._..,.,., ,accia lo dn l la parte opposta. a Cfl'osto hen di vlt r icati e sollevati i margini dell' in ctsio ne, si tu tta la cavitàcompletamenlesott'occhio. S i l'ir-rigazione tl i l[nesta mediante un geuo conliuuo di soluzione eli s uh lim ato 1 ,ooo per un minuto o due. Indi si pratica la satu ra dell a congiuntiva.
(l) Ga:: .1/ rclic. de Pari$, pa;.:. SW, n. 48. (ti Loc. cit.
(3) d'oculi st. Janv. 11!86.
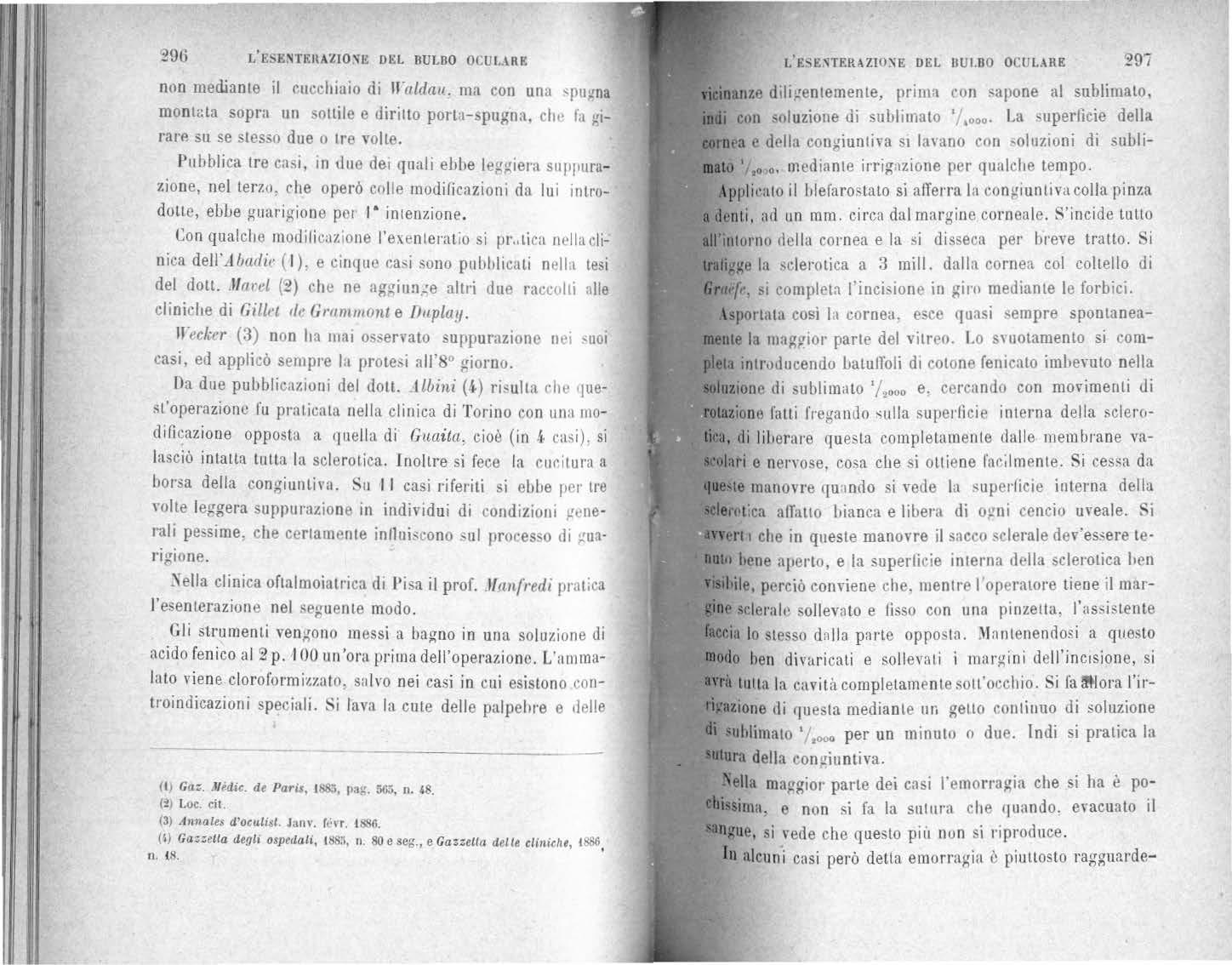
(l) Ga::::etla degli ospedali, II:IS:i, n. 80 e seg., e Gazzetta delle cliniche , !llSO n. t S. '
Nell a maggior parte dei casi l'emonagia che si ha è pochissima. e no n si fa la sutura che 1ruando. evacuato il lingue, s i vede che questo piìt non si riproduce .
I n alcuni cnsi però detta emorragia (' piuttosto ragguarde- vole, tan to che si è obbligati di fare ioterpolatamente ripetute evacua;:ioni, e ritardare così la sutura della congiuntiva, fino al momento che si \eda che l'emorragia è cessata. caso di snppnrazione profonda la lavatura del sacco sclerale fu prati cata con soluzione di sublimato al ' 1 , •••• far ò i casi raccolti alla clinica del mi o illu"lre maestt·o all'o:;servazione sul soldato Cuccurullo, occa,ione alla presente pubblicazione. Non è a dire ch'io mi attenu i scrupolosamente ai dettami della clinica pisana. tormentato tutta la notte - temperatura normalepresenta la congiunti\'a bulbare legge rmente ipercDò un derivativo intestinale, ed ulla sera pare l'ind ividuo si se nta leggermente sollevato. otto/m.>. notte sono aumentati i dolori. Si nola lo stalìloma si è pronunciatoMllll·ina. otrobl'l' . I dolori si fan no sempre più intensi, c lo più propulso. -I niezione pericherati,·a. Si ha pure rossore difi'uso alla regione periorbitale. - Sensazione di e volanti - febbre (39° ). l.o non cagiona alcun disturbo all'amm ,dato. il conserva. la percezione della luce. :\o n essendo \ i alcun a indicazione pet· operazione venà dimesso qua lche gior no , mentre at tende disposizioni per subire la rassegna. l 5 ottobre (non faccio che cop iare il registro noso logi.:o).
Si applica •tuindi la solita io uso io clinica. cioè cotone feni cato imbevuto in soluzione di sublimato '/ ,oc o pei primi strati, cotone asciullo negli altri, fascie di garza.
Osserva=ione l.
Cttccnmllo Francesco , so ldato '27° artiglieria. - Quando mi venne allìùata la direzione del reparto oftalmici, tro vai detto so ldato in queste condizioni: presenta stafìloma opaco all'O , , postumo di una cherato-ir ite che alla sua volla era stata conseguenza di una congiuntivite purulenta.
L'occhio c leggermente propulso in avanti e la corn ea pre · senta aspetto bia ncastro in alto: in un piccolo punto è co nser vata la trasparenza, e si vede alla meglio l'iride aderente alla parte posteriore della co rn ea.
Alla vi sita mattinale si lamenta di cefalea inten sa cho lo ot tobre. I medesimi sintomi con un enorme aurn('nto lo ro intensità. T= + 1 -La sensazione di mosche si l\ prop agata pure a ll'al tr'occhio; cefalea peri orbitali.- Quad ro d'iridociclite con pericolo <li all'altr'occhio. - Domando con!ntllo al signor
•·miii'IUo:re ed ai maggiori medici Panara e D'Andrea e di coaccordo si decide l'eseoterazione .
Jl ottobre. - Si pratica l' csenterazio ne col mesop ra indi cato, previa cloroformizzazione. L'opernzio ne benissim o, e senza co mpli cazi.me alcu na si ese(!ul' in lrh7!ir'liu• minuti; alla sera la temperatura è normale; l'indi\'iduo qualch e dolore, e sensazio ni luminose ottohre. -:- Si rinnova la medicatura; i margini della si vanno riunendo , non si ha ombra di suppu- otto/m•. - J fili di calgut si vanno ri assot·hendo e la 'ce va form ando con buon aspetto. l noPembr e. - l fili di calgut si sono del tutto ed è scomparsa l' ipercn1ia co n- giunti vale; non <>i creòe piit oppor·tuna la fa• l'iat ura e lascia l'ocd1io libero. fi 1Wvt•mf1re. -Si applica l'occhio ar·tiliciale che da principio è tollerato con •1ualche pena: ma poi nei gi orni succes· ,.iti l'ammalato ci addatta henissimo. or'•'. Du ra n te l'operazione si ebbe un'emonagia notc:<Ì che non mai a rC'dere la superficie delia sclerotica scop er ta e bianca. Anche <fuando si prnticò la sutura alia congiun tiva esisle,·a nncorn nel sacco sclerale una raccolta di tantochè il moncone appariva r ilevalo e «<nfio. La sera del giorno dell'operazione la es- • Hodo tutta imbevuta di :;angue, viene cambinta. TI moncone ollera to e si \'ede che nella saccoccia ri"ultante dalla tora ,.i dev 'essere una raccolta notevole di sangue, si che la parte ant eriore di questa saceoccia \'iene quasi a sporgere aella rim a palpe!Jrale. f'amn·ini Esmoil1• - : nni 8 - di :w 1886 si ferisce l'OD con un pezzo di legn o. • i presenta nl l'amhnlatorio della clinica il giomo 21J maggio. Iniezione pericheratira, ferita corneale nmpia, con hene applicati, e'sudato nel campo pupillare ed acqueo torbido, dolore alla pressione, percezione di luce quadro d'irido-crclite infettha.
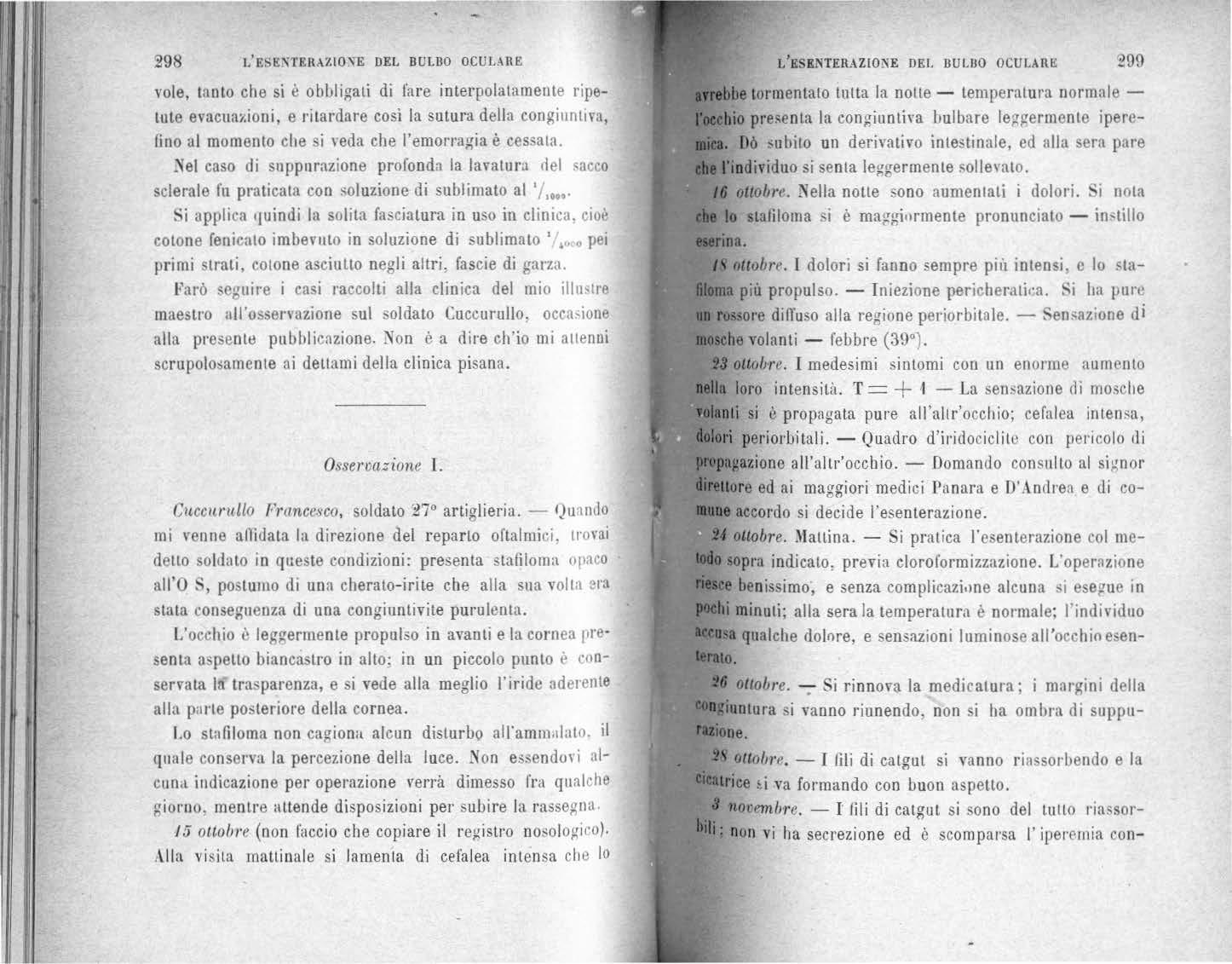
L'apparec<'hio di protesi è riuscito cosi perfeuo. erl i movimenti :-;ono rosi ben consenati. da dure una pl·l ft' lla illusione se l'occhi., >ero od aniliciale.

L'indomani dolori forti, per· cui due giomi dopo. z: ,,io l'ammalato entra in clinica c.on un chemosi per icor- "' , neale ablnstanza rile\ante. hulbo leggermente ma non inchiodato.
·· ' d · ' l ' la··a scler·lio :JO maygw. - os 1 svr uppata un ec • : con l'aspetto di una raceolta purulenta .;ouustante. s' quella col coltellino di Graefe e si ha fuor·uscita di cenci fìbrinosi bianchicci: si applica cat1plasmn per alcunt giorni di nei giorni col cucchiaio di ca ucc iu si r.erca di dar esito nuovamente agli essudati, dopo arer la ferita praticata. n si eh be mai tendenza a pa. e noflalmia vera. Il giomo 12 giugno :;i pratica l'esenterazron servendoci dell'apertura esistente nella sclerotica, s.ulla parte
Nei giorni susseguenti il rnoncone andò man mano ahbas.lllldosi pe r assorbimento del sangue raccolto nella oo vi fu mai 3uppurazione. ma una secrezione citrinn. La sutura si staccò di ·per SÌ' :li terzo
'!5 yiu !Jno. - Scomparsa completamente l'ecchimosi palpebtale e l'e1lema della congiuntiva, si potrehue praticare la persistette i l catarro della congiuntiva per mol to !empn.
Esce l' Il luglio. La protesi t\ riuscita henissimo e perfeua; 11 catarro dell a congi11nt iva è in via di guarigione.
Osserw.:ione 111.
Prtrwl os.\Ì .11'mida- anni 21 - Pisa.
Si ferì l'OD il giorno O g iugno mentre attendeva a l proprio liYoro di Le$sitrice, con una puula melallira. En tra in clinica lo stesso giorno.
Si nota lar ga ferita irrego lare òe ll a a 3 o 4 mm. Galla corn ea, ferita parallela al ed estesa a piit 'di ' a ùella circonfet·enza corneale. Spor;.:e il vilreo che pro - babilm ente è uscito in quantilit rngguardevole as:-;ieme al cri· stallino. L'occ hi o è sempre in forte; la rornea prese un colorito grigiast ro di opacameoto diiTuso. La ferila >de · rale si va riun endo irregolarmente ed è info ssata. 11 l?. essendosi l'ammalata deci sa, si pratica l'esenterazione serdella ferita primili,·a per l'ablazione dell a giorni successivi non si vede traccia della pupilla praticata . L1> stafiloma è sempre molto prominente. Si decide l'esente razione. che vien praticata il :25 giug no. Oecor.;o tipico senz' reazione. \'1en licenziata il giorno 12 luglio. Il rnoocone (·bellissimo. L'occhio sarebbe in buo n issime condizioni per la pr0tesi.
Fn colla cornea anche una porzione d1 ,.,cJe rotica piutlO$lO ampia, ed il corpo ci liare. Nei succe$siv i all'opera.Gione si notò fo1·te edema alla ente tu tt'attorno all'a pertura palpebrale. Del resto decorso tipicc>.
All'S' si fa la protesi.
Si ripresenta ci r ca un anno dopo; il moncone si i• un po' ahha-,;ato; la protesi però è ;;empre perfetta.
Ossl'rt'a:inne IY.
Cttntini lJiulia- anni 16 - P alaja.
Entra il 15 giugno. Stafìloma irido-comeale piuttosto vo· luminoso nii' OD co n una pircolissima stri scia di cornea io alto, che permelle di veder l'iride.
Il H) giugno si fa un tentativo d'iridectomia alla parte superiore, non riuscendosi che a strappare un piccolissimo lembo d'iride.
::ione Y.
.Antrmelli Fortllnato - anni u. - San Prosp ero .
Ent ra in il 16 giugno. O. S. Duii.Jo buftalmico. esito R:",::;;;:...- stalil oma irid ororneale totale. I n hasso si nota un punto dal quale fa ernia un coagulo fibrinoso. L'occhio ta. 1 segni òi una panoftalmite incipiente. L'occ hio è :•--!l.o'I:À:-ft da i- anni . e da un si sarebbero sviluppati sinsi pratica l'esenterazione. Decorso regolare senza ione. ecrezio ne alla congiuntiva che durò 7 od 8 i. Esce il 7 luglio in co ndizi on1 per la

Ossarn:ione TI.
G1·ntilini Cesare- anni Ponterlcra.
Entra il n Oi:;truzione toiale del:a cornea destm ad oftalmia rride e corpo ciliare allo scoperto fanno procidenza. ccgsa ta in parte la ;;ecrezione congiunti val e, il :.> luglio si pratica terazion e. Decorso re6olare senza sup purazione. l :2 luPl'Ote:>i. \'ien licenziata il 17 luglio. Os8errn::ione Yll.
S11m bri Ersil ia - anni :1 - \'ada.
Entra il tR gin;:no. Di=--t ruzione totale della cornea 00 in a ma 1a ·ia comeale. Procidenza molto soll evata del-
3Ui- L'E:-.i':l'ITEHAZI0\1'. DEL llULIJO OCULARE l'iride e del t:or po cilia re. Si furmerl•bbe cer tamente uno staliloma molto per cui ,.i det:idc l'e-ent,r·azione. che vien praticata l'H luglio. tipi co senza snppurazionP. Prote-i. E-c e di clinica il l o agosto.
. Forte inspessim ento della co ngiuntiva bulbare che infiltrata Bu lbo un po' propulso ma non inchiodato.
Si tratta evidentemente di una sn ppurazione profonda ,_llz.a(:nè però :-\i abùia il quadro della panocioè, mancanza di edema palpebrale, di inchioda......,,,. e di chemosi.
Cirmrt lJiagi n - anni 27 - Rou a.
Entra il IO agosto. St1liloma iriLlocome:1le OJ> mollo prominente e .;por).(ente fuon delle palpebre. inten.;e. l l agosto s i pratica l'esenterazione. Decorso tipico senza ,;u ppurazione; po co edema palpebra le cougr untiv ale all'indomani, che sp;nÌ nel periodo di 1- o 0 giorni, tantochL' al / 0 !.! inroo la congiuntiva e le palpel11·e avenu10 nsp(lttO normale . zl agosto protesi. Il ::?3 la:<cia la cliuiea.
Ossl'l'lYtzirme
IX .
JJm:ani Leti.:ia- anni 1.7- Pescia.
Entra il 16 novemùre 1886. Stafìloma irido-corn eah' probabilmente da oftalmia purnlenta , neHa l.: ie Esentera,don e 3 dicembrt>. Decorso tipico E::;ce il giorno .29 dicembre; .;ar·ebbe in condizinni per la prol e;;·.
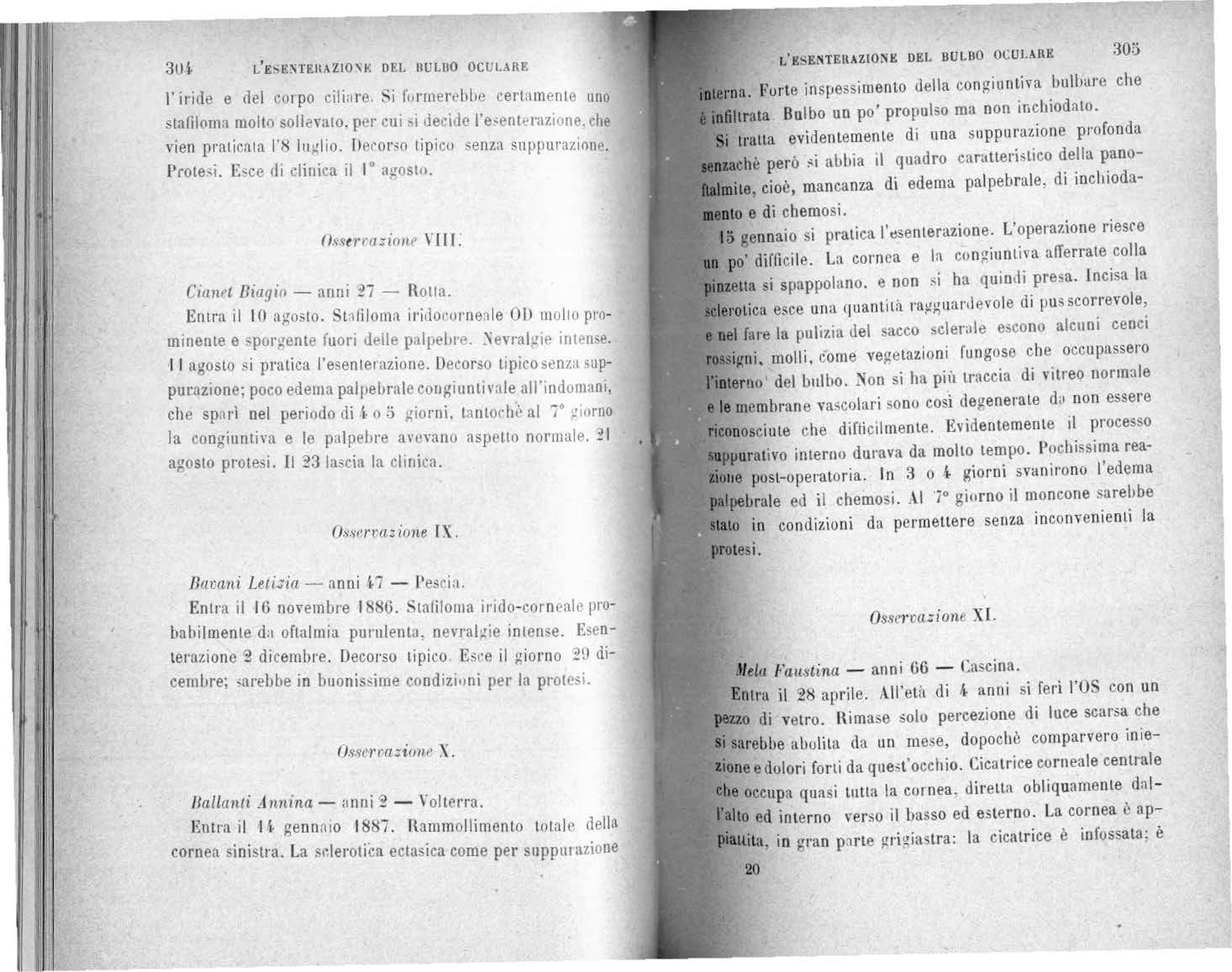
t 5 gennai o si pratica l' "'senterazione. L'operazione riesre po' dirfì cile. La cornea e la congiu ntiva afferrate colla si spappol ano. e non "i ha quio,li presa. Incisa la tcleroti ca esce una quanlitil di rus scorrevole, nel fare la pulizia ùel !iUCCO e:.cono alcuni cenci , molli, come vegetazioni fungose che occupassero l'iotenw del bulbo. n si ha più traccia di vitreo normale e le membrane va..;colari cosi degenerate d•1 non essere riconosciute che difticilmente. Evidentemente il processo 11lppurativo inter no durava da mollo tempo. Pochissima reazioue post-operatoria. In 3 o ,\. giorni svanirono l'edema palpeùral e ed il chemosi. Al 'i 0 giorno il moncone sarebbe stato in condizioni da permettere senza inconv enienti la protesi.
Ossena.:: i one XI.
,tfela Fau stina - anni 66 - Cascina.
Osst'1'ra::imu X.
/Jallanli Annina- :Inni 't - \'olterra.
Entra il 1f. genn aro l 887. Ramm ollimento totale della cornea si ni stra. La :-;r.lerotica ectasica come per suppurazione
En tra il 28 aprile. All'etiL di 4 anui si ferì I'OS con un pezzo di vetro. Rimase :;olo percezione di luce scarsa che si sarebbe abolita da un mese, dopocltè comparvero iniezione e dolori forti da quest'occhio. Cicatrice corneale centrale ebe occupa quasi tntla la cornea. dii'elln obliquamente dall'alto ed interno ' 'er:;o il basso ed esterno. La cornea è appiattita. in gra n p1 rte grigia-,tra: la cicatr ice è infossata: è aderente in tutta la sua all'iride, che pare at rofka, tappczzala evidenlemente alla p 1rte posteriore ùa pseudo membrane. completamente la camera anteriort. l niezione pericheratica spiccata, T + L nerralgie intense.
L'ammalata de"ider.1 d'essere a qualunque costo lib erata dai dolori. Ne:-sun segno d'irritazione simpatica. Esente · razione il l O maggio.
.J l maggio.- Xel cambiare la fas ciatur;l si nol <l edema palpehrale , ecchimosi sulle due palpebre, forte della saccoccia congiuntivale: la s utura si è dista ccala e dei coaguli san).!uigni sporgono nel centro della llo1·sa cong runtivale cosi aperta. Lavature abuondanti.
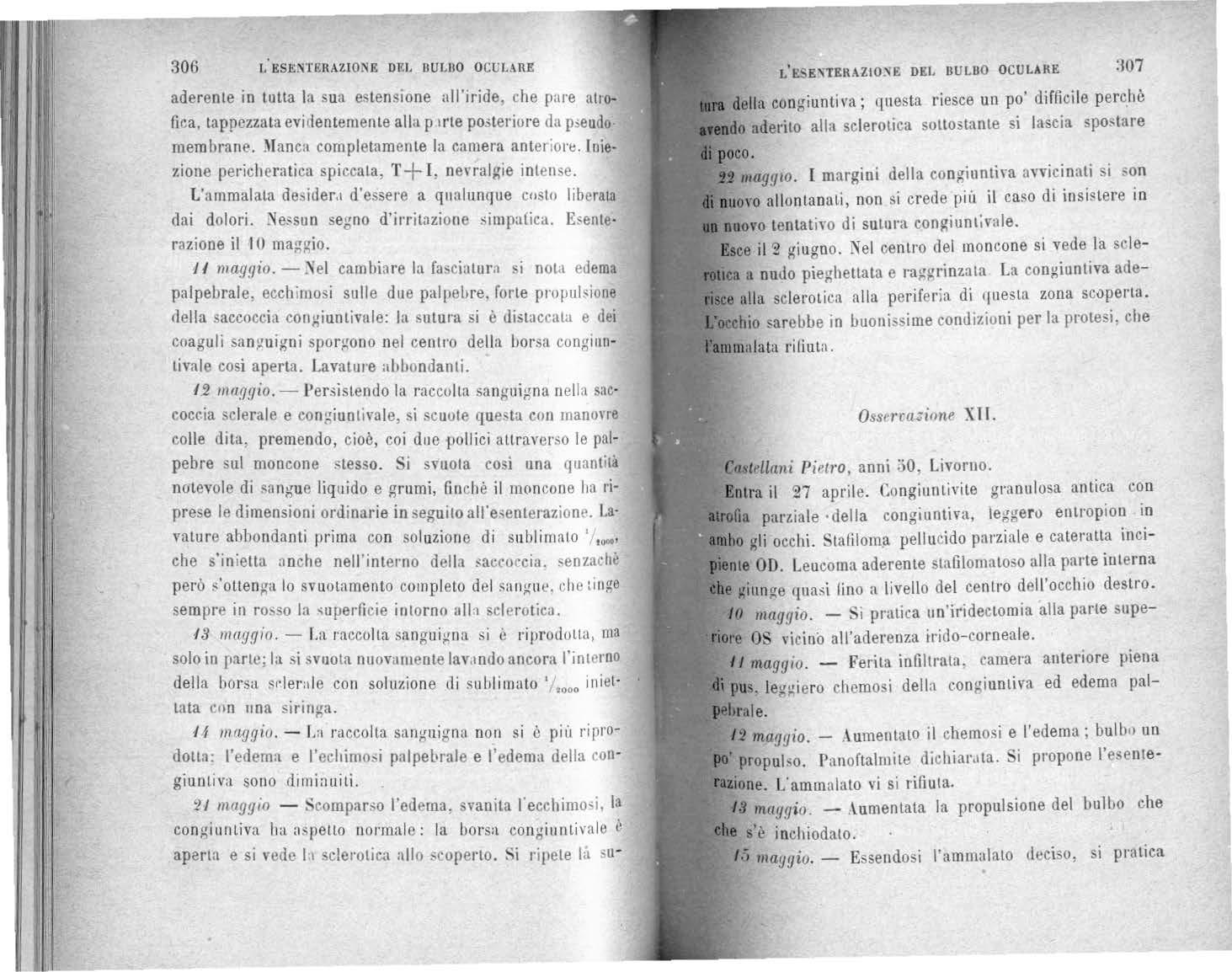
12 maggio.- Per:>istendo la raccolta sanguigna nella sac· cocr.ia iìclerale e congiuntivale, si scuote questa co11 manoHe colle dita, premendo, cioè, coi due pollici attraverso le palpebre sul moncone ,;tesso. Si svuota cosi una quantità notevole di sangue liquido c grumi, finchè il mon co ne ha ri· prese le dimensioni ordinarie in seguito La· vature abbondanti prima con sol uzion e di s nblim ato '; ,..., che s'inietta \l oche nell'intemo della :;eozache però lo svuotarne nto completo del sangue. che tingo sempre in la -;upedìcie intorno alh sclerotica.
13 lllaggio.- l. a raccolta sanguigna s i è riprodotta , ma solo in parte: la si svuota nuovamente lav mdo anco ra l'interno della borsa con soluzione di sub limato ' •ooo illiet· Lata c·nn una si ringa.
14 lllrtggio. - La raccolta sanguigna non si è più riprodotta: l'edema e l'ecilimosi palpebrale e l'edema della ro n· giuotiva sono diminuiti.
':21 llwggin - Sc.ompar=-o l'ed ema, svanita !'ecchimo5i, la congiuntiva ha. aspetto normal e: la borsa congiuntirale è aperta e si 'tede h sclerotica allo scoperto. Si ripete la su· della congiuntiva; (1uesta riesce un po' difficile perchè aderito alia sclerotica sottostante si lascia spostare poco. u maggw. I margini della co ngiuntiva avvicinati si ,;on au oro all onta nati, non ::;i crede più il caso di in nuovo tentativo di sutura congium;vale.
Esce il 2 giugno. Nel centro del moncone si vede la sclea nudo pieghettata o ragj.!rinzata La co ngiuntiva ade-
_. vww alla sclerotica alla periferia di crnesta zona scoperta . hio sarebbe in buonissime co nd izioni per la protesi. che lata rifiuta.
Cthl l'ilfmi P ietro, anni ;jO, Livorno.
En tra il 27 aprile. Congiuntivite granu losa antica con a partiale ·della congiuntiva, legger o entropion in ambo gli occhi. Stafìloma pellucido parziale e cater·atta incipiente OD. Leucoma aderente sta filomatoso alla parte interna the )(iun ge quac;i lino a livello del centro dell'occhio desLro.
IO magyi o. - Si pratica un'il'idectomia alla parte superiore OS vi cino all'aderenza irido-corneale.
I l ma ggio. - Ferita infiltrata, ca mera anteriore piena pus. leggiero chcmosi della congiuntiva ed edema palpehrale.
.. - ....·::··-· 12 ma ggio. - .\umeutato il chemosi e l'edema; bulbo un po' propubo . Panoftalmite dichiaJ\Ita. Si propone l'esentel'azione. L'ammalato vi si rifiuta.
13 rna yg i o. - Aumentata la propulsione del buluo ch e s'è inchiodato.
/ .i mayyiu. - Essendosi l'ammalato deciso, si pratica l'es enterazione. Nelvolgere di una settimana sparirono l'edema e il chemosi. Non vi fu mai suppurazione, ma semplice secrezione da parte della congiuntiva.
Esce il i- giugno, dopo essere stato operato di cantoplastia ed operazio ne di Snelleo a destt·a. Il moncone ha le proporzioni solite di un moncone di esenterazione. CongiU n· tiva bulbare ancora un po' intìltrata. Svanito l'edema palpebrale.
Osserva:ione XIII .
Falchetti Egidio. anni 24, S.
Entm il 13 novembre · 1888 , pf-r staliloma total e de ll a cornea sin istra; buftalmo. Il 27 novembre operato , decorso · tipico. Esce il H) dicembre.
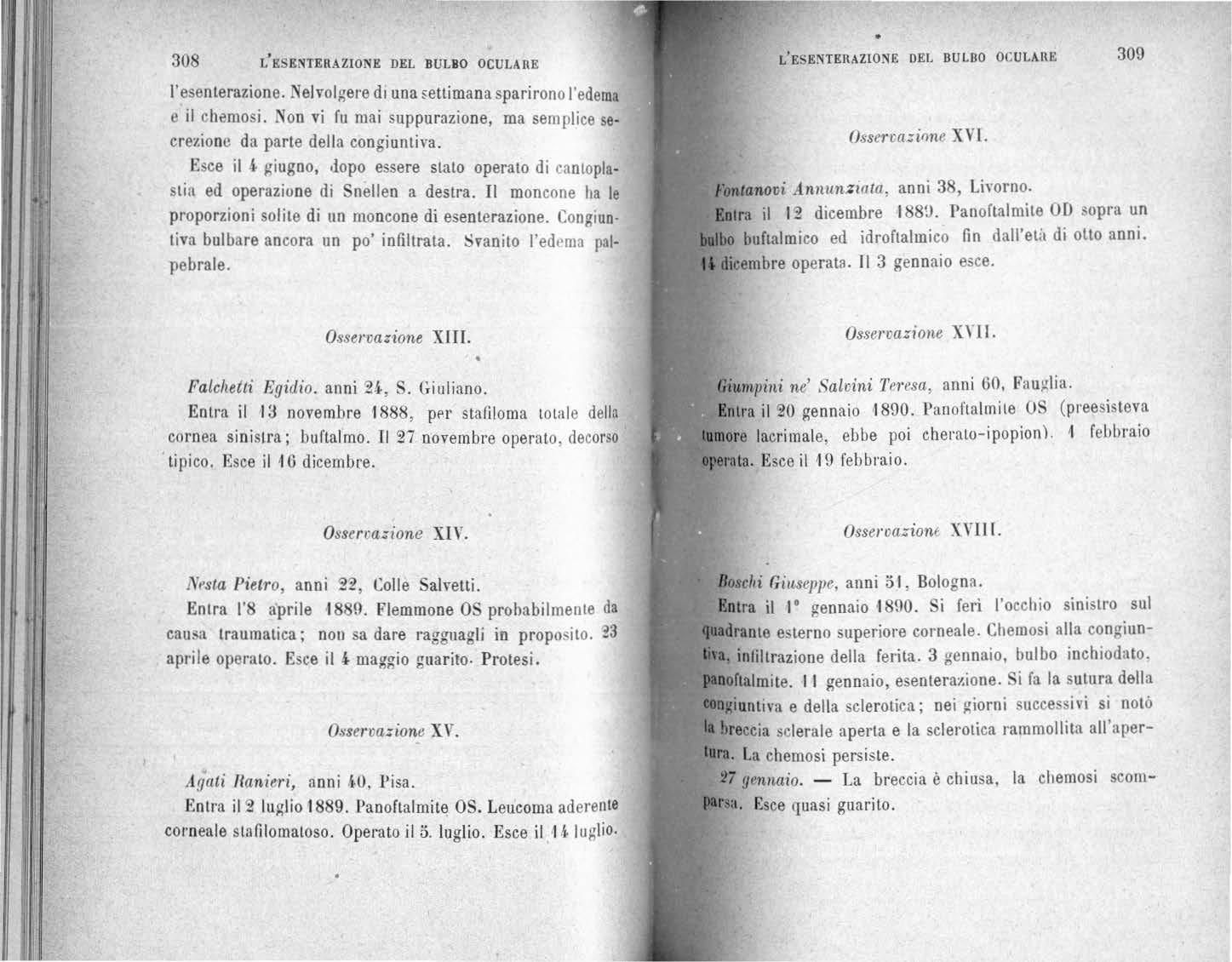
Osserra::ione XIV.
1Yt>st a Pietro, anni 22, Colle Salvetti.
Entra 1'8 aprile 1889. Flemmone OS probabilmente da causa traumatica; non sa dare ragguagli in proposito. aprile oper·ato. Esce il 4 maggio guarito. Protesi.
Oss er ua ::ione XV.
Agati /lanieri, anni 40, Pi sa.
Entra il2 luglio 1889. Panoftalmite OS. Leucoma aderente comeale stnfilomatoso. Operato il 5. luglio. Esce il · 14luglio.
Osserw::irme X Vl.
Fontanoui Annunziata, anni 38, Livorn o.
Entra il 13 di cembre Pan oftalmite OD sopra un lallbo buftalm ico ed idroflalmico fin dall'etit di otto anni. U dicembre operata . Il 3 gennaio esce.
Osserva:ri one X Yli.
Gium pini ne' Salvini Tn·esa, anni 60,
En tra il 20 gennaio · 1890. Panoftalmite OS (preesisteva tamore lacri male, ebbe poi cherato-ipopion). 't febbraio tperata. Esco il 19 febbraio.
Osserva::iont XYIH.
Boschi Giu,seppe. anni 51, Bologna.
Entra il l • gennaio 1890. Si ferì l'occhio sinistro sul quadran te esterno superiore corneale. Chem osi alla congiuntiva, infi ltrazione della ferita. 3 gen naio, bulbo inchiodato. (llnoftalm ite. l l gennaio, esentera1.ione. Si fa la sutura della eongiunt 1va e della sclerotica; nei giorni succes::;i \'Ì si notò la breccia sclerale aperta e la sclerotica rammollita all'apertura. La chemosi persi ste.
'27 gennaio. - La breccia è chiusa, la chemosi scomparsa. Esce quasi guarito.
Osservazione XIX .
Nod Pio. anni 42, Calcinaia.
Entra il l O aprile. Leucoma centrale alla cornea sinistra : l'iride vi i> aderente , la camera anteriore è pi ccolissimn. Viva iniezione pericheratica fotofobia e dolore, leggera linea di ipopion in basso. 12 aprile. I ridectomia a scopo ottico e antiflogistico dall'esterno col cheratotomo lanceolare retto: l'iride è atrolìca e viene estratta a piccoli lembelli senza rhe se ne possa fare l'escisione.
3 maggio . - I eri la cornea anteriore cominciò a farsi ectasica in alto, nella notte l'ammalato ha avuti dolori fortissimi e vomiti (ciliari). Stamani l'ectasia corneale è di molto aumentata. li 7 operato. n ecorso tipico. Il 1 (i maggio esce guarito.
Ossm:a.zione XX.
Cenci Guglielmo, anni l 8, P ontedera. Entra il '27 agosto. tafiloma corneale OS, iniezion e prricheratica, dolori; T==+ 2.

l !l sette mbre, da qualche gio rn o accu:>a dolori al sopraciglio 00 , nel fo ndo n ulla di particolare. Si nota una chiazza biancastra simulante uno staUloma: Y ==' , - :31 ago:,to: tentativo di iridectomia OS in all o a ll'esterno : non si può aiTerrare l'iride che è concresciuta col tessuto corneale.
l :> settembre operazione di estrazione del cristallino med iante taglio linea re col col tell ino di Graefe .
18 ottobre esenterazione. Decorso normale.
21 agosto esce. Sono scomparsi tutt i i dolori aii'OS.
Osservazione XXL
Bianchi Ranien. anni 4-G. Barbaricina. Entra il30 dicemhre 1880. Si colpi l'occhio destro con un di ferr o sporco e rugginoso. Si pr ese nta co n ferila Cèlldell a corn ea destra, della lunghezza di g mm, a bordi i e fr astagliati, e lorda ti di rtì'ggine; tutl' intorno alla flrita man ca corneale: la camera antèriore è piena 1 acq uPo in torhidato, e si vede l'iritle di color verde sporco non reagisce sull'atropina. Vi (• chemosi lieve della conliunti,·a bulbare. che durante la mcùicat ura aumenta sot\'oechio. Yien fatta la cauterizzazione coll'an:>.t galvanica, ed un'in iezio ne di deutocloruro all e tempia. Abbondante latalora e fasciatura.
30 rlicemlm·. - Edema della regione temporale ovc fu filtla l'iniezi one e delle palpebre : il bulbo è quasi fissato, e molto protr undente, chemosi aumentata. Pnrgntivi, sanguiagi all e tempia. cauteriuazio ne galvanica dell'ulcera corueale.
IO ymnaio. - fl flemmone non si è arrestato. Il ye mtaio . - Esenteraziooe; andamento regolare. inc onveniente nell 'opcr<\zione, ness un a complicazione .
Ì'f.(flll.'!ll'...ft il t febbraio.
ora :::.nlla specialmente di queste . i se questa operazione pr esenti vantagg i o svantagg i ....,.,..••. in confronto all'enucleazione. Anzitullo, dal lato operatorio. J'esPnterazione non Ì' mai piU lunga, ne pÌÌI difficile d'una enucleazione: si posso1no dar dei casi in cui quest'ulti ma ri1Hcireuhe più difficile e più lunga. Se per esèmpio esistono aderenze fra la congiuntiva e la sclerotica, é evidente che dovendosi distaccare nel fare l'enucleazione, que.;ta non riuscirà che a !)Lento, e si correr·it il pericolo d'in t;i dere e lacerare la congiuntiva, mentre nell'esenterazione la dissez ione della congi untira,. limitata alla parte più pros,ima del mar,::i ne corneale, se queste aderenze sono rerso l' ec1uatore non ci daranno alcun petfsiero. rn tutli questi casi l'esenterazione sarà un'operazione molto piir spiccia, sicura ed agevole.
Quando si ha a che fare con un bulbo ectasico, o <·on un bulbo dentro al quale esista una raccolta puruleuta ch e tende a farsi strada per qualche punto della cornea o della sc lerotica che. si è per questo assottigliato, riesce fa cilissimo ad una trazione o pressione sul bulbo anche Jeu"iera che . nn il bnlbo si rompa , si vuoti in gran parte il contenulo, il bulbo si fa ccia tlo.>cio, incollasso, e si sa come in queste condi1.iO!li s ia diflicile e luo go il terminare l'enucleazion e.
L'.KSE.NTERAZIONE DRL UULBO OCULAHE 313 del bui bo coi tessuti a muienti. In questi casi il praticare la del bui ho posi ee nel tentare la recisione del nervo ouico in sito rischia d'in cidere la parete posteriore del bulho. ed alsi termina con difficoltitl'operazione.
Di qu esti cast e di questi inconvenienti non ci dobbiamo ùre alcun pensiero , facendo l'esenterazione.
L'emorragia che si suole avere in seguito all' esenterazione, a gmtli care dai casi occorsi, non è certamente più temihile dt quell a che può dare l'enucleazione: che anzi e:-;sa è (JUasi .-mpre ruin<•re, come ci possiamo facilmente immaginare. pensando che i vasi lesi, se più sono di calibro I noltre una emorragia prodottasi in questo modo t.aarà, per così dire, circoscritta dalla sclerotica, e se rilevante potrà rompere la sutura congiuntivale e farsi st rada all'eate rno, ma non infiltrerà mai i in modo da produrre un ' io liltrazione sanguigna tlell'orhiw. che in caso di suppurativo potrà costituire un terreno 111olto pro· pi:r.io alla suppurazione; nell'emonagia dopo l'esenterazionc noi potremo sempre mollo far.ilmente svuotare il hulho e fare òani giorn o lavature del sacco sclerale, come successe appunto in uno dei nostri casi - osservazione \I: - ed llÌiare rosì la suppurazione .
Con chiudo: Da l lato operato1·io l' esenterazione m'n pre:'enta lllll'enurl eazione nessun svantal{gio. nel caso di bulbi atrofici lenza ad erenze della sci erotica di 1essuti ambienti. È in d ileotibrlm ente da preferire nei casi d'id roftalmia e stafilomi, Dei casi delle aderenze sopradette, di suppurazione, di pericoli di rott ur·a della sclera e della cornea, spedalmente poi Della puo oftalmite.
La reazione che tien dietro all'esenterazione, a giudicare dai casi occorsi. non t; mai super·iore in graviti1 a 'luella che suole tener dietro all'enucleazione. T ranne il ca-o drlla panoftalmite dichiarata - Oi'servaziune li : - in tutti gli altri casi spari ogni segno d'irritazione, costituita unkamente da un po' d'edema e congiuntivale, nel di tre o q uattro giorni, e al fine della la se ttimana e rano qua:. i tntti in condizioni òa potersi npplicare ·l'occhio artiltcia le.

I n qualr.he caso si notò nei primi giorni una raccolta considerevole di san!.(ue. che non esisteva finita l'operazione, e che qnincli si produsse dopo, rna se qu esta ritar·dò l' oper·azione gelìnitim di qualche )domo, nel vol,:(er·dei •1na li il si non ebbe però alcun gra\e inconveniente.
J l n umero ristrello d ei casi non permette alcuna r·oucl usio ne s ull 'indicazione speciale dell'esenterazione, che ò q nella di non dar luogo alla rneningite , giacchè anche dopo l'enucleazione il numero dei ca-> i di meningite ò scarsissimo. Se noi sommiamo invere tutti i casi linora puhhli ra ti di e-enterazione, senza che in alc u no si sia verifica ta detta complicazione, :;i ottiene un ri:;ultato abbastanza in coral!:.riante. e che fino a prova co ntrnria ci autorizza a sperare dr e l'ol l'e· senterazione detta complicazione più non si avveri.

E da q:Jesto punto di vista hisogna che oltre al vantaggio a cu i accennammo, di non ischindere la strada a ll 'infezione aprendo le guaine del nervo otti co, gli <'· pu r certo che in caso di suppLu·azione interna si può far e la disinfezione in modo perfello, perchè ci è da to dr portar«> a lh snpel'lìcie d ella scler·otica potenti . l'orne al sublimato 1(1 000 senza alcun ioconveniente. rd i no•tri casi, nei quali. mnlgrado la suppurazionc giit e:-; is tente, non si ebbe t raccia alcuna di suppurazione dopo l'o perazi one. sono a r) &SK'ì TERAZIO'ìE DEL llULRO OCULARE 3 come l'antisepsi non avesse fallito al suo A v:m ta;rgio che siam Yenuti e:;pon endo si può fae un'ohed è che forse in quei casi nei quali in segui to all'enuo si ebbe la meoiogite, non sarebbe rigorosamente. Ed infalli , dopochè l'a otisepsi è ennell 'abitudine della gran maggiorama degli oculisti , il de i detti casi descri tli è sca rsissi mo, ma ciò non tì una mentre ahbiamo d'altra parte il fatto fin ora non si è Yerificaro alnm caso di meningite, dopo ter,tzione, per cui io credo che lino a prova contraria sia d'ogni operatore di sostituire un'operazione che non _:.._., _dato il grave inconreniente che conosciamo, ad un'altra, for·se con date modalità potrebbe nnche non darlo ch o no pos::;iamo avere la certPzza. Venendo ad una questione secondaria, è certo che il che si ot.tiene coll'esentera1.ione è più adallo alla proi ch e non il moncone del!'enuclrazione. Senza voler· esaprare qne:.to poi chè trascorso un carlo tempo :ii moncone si fa p iù per della scler·otica , 1 mo,·im enti di esso evidentemente saran no sempre più pronti ampi che non nel moncone dell'enucleazione. Ciò non bi sognù di illustrazione, poirhi• va da sè che, mantenendo insflr·zio u i dei muscoli sulla sci erotica. questa farà dei moti ablmstanza pron unciati.
Sem pre da l punto di vista della protesi, l'esenlerazione ci ancora il seguente vantaggio. Nell'enucleazione la bulbare viene dissecata completamente dalla ca: :-<e nel fare la sutura o ne afferra un poco io una data direzio n e ovvero si è obbligati (o perchè o perchè recisa troppo in una direzione) nd alTerarla per·ifericamente, stringendo la sutura, questa stirerà la
316 r:.ESENTERi\ZIONE DEl. BULBO Ol.U LAllE co ngiunti va in detta direzione in modo da obliterare il sacco co ngiu ntivale in tal punto, e quindi ostacolerà la protesi. Questo in co nveniente non si ver·ilica nell'esenterazione. perchè resta ndo la congiuntiva in gran pn rte aderente alla sclorotica, col r iu nire co lla sutura il margine r·eso liber·o, la trazione e distensione della medesima si limiterà alla breve porzione che si f> di:>secata e non arriverà mai fino nl cui di sacco obliterandolo in una dat.1 direzion e.
Di fronte a questi \antaggi oltremoJo evidenti dell'esenterazion e sull'enucleazio ne esiste qualche svantaggio?
Adire il vero non no vedo altro che uno d'ordine puram ente scientifico, ed è che l'anatomo patologo potrit rimproverare al cli ni co di distruggere quel materiale scientifico che potrebbe servire allo stud io, od almeno di renderlo in gran par·te inservibile . L a scienza cer tamente ba anch'essa le sue esigenze; 11uesto svantaggio esiste ed è indiscutibile. di fronte ad esso si arre:. terà il clinico quando a\esse la certeua di una garanzia per il paziente , quando cioè fosse certo di assicurarne l' esistenza con una operazi one sostituì la ad un'altra che può comprometter lo?
L' esenterazione è un 'o perazione molto r ecente: solo col moltiplicarsi delle osservazioni in propo&ilo si potrà stabil ire su inconcusse se la medesima destinata o men o a :;oslituire nella maggior parte dei rasi l'enucleazione, e ,-e sia una operazione affatto e sempre innocua. I casi da me raccolti ed esposti a rispondere afferm ativamente.
Posteriormenle all'epoca in cui ebbi a raccogliere i r-asi qui riferiti alla clinica di P isa. il pror. Guaita compilò un lavoro sall'esenter azione, colle osser·vazioni della Clinica di Siena, e coll'illu stra zione di un occ hi o esenterato. Egli propone alcune modifi calioni all'operazione, rnodilicazioni degne di ogni apprezzamento, ed a quella memoria rimando il lellore.
• Roma, 19 febbraio 18n.











