
38 minute read
RIVISTA CHIRURGICA
Rloeroh.e sulla dlslnfezlone e sul nettamente degli stramenti di oh.lrargla . F . A. MALJP.AN, medico militare.(Arehices de M érleàne et de Pharmaeie Milita ires dt' cembre i 89 1.
Gonclusioni:
Advertisement
Lo .streptococcus P!JO[Jenes e lo staphulococcus aureus sono dist r utti in meno di u n minuto coll'a cqua bollente e(! in un quarto d'ora colla soluzione fenicata fcedda al 5 p. 100.
Quando quesli microbi sono inchiusi nelle materi e albuminose essiccate, l'acido fenico diventa inefficace, anche dopo tre ore di contatto.
I germi della sellicemia gangrenosa e del tetano alle diverse soluzioni fenicate, agenti sia a freddo, sia a GW Essi no n sono dist r utti che dalle a lln temperature.
Dei dive r si modi di applicazione del calore, il più sempliCI! è l'acqua bollente: le spore settiche e tetanich e soccombon o in 10 minuti, purché esse si trovino in istrati sottili. Quando questi germi sono protetti dalla ruggine e dall"albumina es siccata, l'ebollizione non agisce che dopo una mezz'ora (vi-· brione settico) c dopo due ore (bacillo del tetano).
Si rende racqua due volte ptù incorporando ad essa 5 p. 100 d'acido fenico, ma questa addizione riman e impotente contro strati protettivi.
Quando l'acqua bollente contiene 1 p. 1.00 di carbonato di soda, essa scioglie la ruggine e l'albumi na e distrugge le spore in 15 minuti (vtbrione settico) e in 18 minuti (tetano).
Questo processo di disinfezione è piu rapido e più pratico degli allri, ma esso non si applica che agli strumenti in tie- mollo facile togliere le sporcizie fresche; il ne>llamento · divi ene impo ssibile quando esistono la ruggine ed il essiccalo.
I coltelli, i bistor i e gli altri strumenti cementati devono esse1' e disinfettali in una mAniera òifl'erentP.; le lame l!Ono steril izzate con un contatto di cinque minuti colla soluzione fen ica bollente; la disi nfezione de'i manici si olliene immer!!endo strumenti per quindici minuti nella solu.:ione fredda.
Ques ta doppia operazione non assicura la distruzione dei g er m i settici c tctanici che potrrbbero aderire ui manici; t 1u es ta lacuna non ha importanza c he per i bistorì se rrati e per i coltelli lavorati a qu adrelli del Yecchio at'Sf'nale; essa scomparil'à col l'ttdozione dei manici metallici.
Devon->i però segnalare due oggetti che non soppo rt.ano l'acqua bollente e che non possono essere da a lc un altro processo: l'ago e lo stiletto di Il m a n ico cementato dell'ago é traversato in tutta la sua lun ghezza da un tubo metallico stre tto che permelle il passaggiO al filo. Le due parti dello sti lello , il fusto e la pallottola di por cellana porosa. sono riunite tinlla colla forte. lo la degradazione che essa fa subire a!Zlt strumenti tag lienti, la disinfezi one completa co l calore si un pont> in certe ci1·costunze (bislorì e coltelli coperti di ruggine e di sangue essiccalo, operazioni in casi di sellicemia gangrenMo e di tetan o, ecc.). Sarebbe quindi utile prevedere le ripa1·nzion i da farsi alle montature come g iù si é preveduto alla ripulitu1·a delle lame.
L a steriltzzazione con il carbonato di soda non esige prece dente netlamento. Al contrario, le soluzioni feni c he fredde o b ollenti non disinfettano ehe gli strumenti guì perfetlamente puliti.
Si evita questo pericolo immergendo gli strum e nti, nell'uscire dai tessuti, in una soluzione tiepida di carbonato di soda elle abbia bollito per dieci minuti: essa sciogl ie l'albu· mina ed il sangue ed impedi sce l'ossidazione.
CHIH UilGICA 403
Le soluzioni fenicato hanno l'inconveniente di coarrulare i liquidi. organ.ici e di produrre strati spessi capaci di gere 1 germ1.
I p1·odoLLi albuminosi stati sciolti, il sapone e la spaz7.ola devono intervenire per togliere ciò che rimane dJ coaguli e di materie grasse. Gli strumen t i ben asciugati sono allora pronti a subire la disinfeziorJe.
Polipi dell'uretra nell'uomo. - HERMANX (Merlical Record), 14 novembre 18!11.
Il caso, importantr per molli punti di vista è il !"eguenle. Trattasi J'un uomo a 36 anni, ammogliato con prole, il quale nella sua prima giovinezza soiTerse va1·ie blenorra,.,ir cucate mollo Da due anni soltanto e"'li ;ominciò ad avvertire non lievi dolori nella minzione, andù mano crescendo e che si esacerbava per gli eccessi del vmo e del coito. Dopo 'Jualche tempo egli cominciò ad avvertire. un vero nell'abbracciamento e una pPnosn sensuz10ne come d1 puntur e di spillo, diffondentesi ai testicoli: sopravvennero frequenti e dolorose polluzioni mal tli capo, e stimolo continuo ad o1·inare. Inollre non poteva p1u vuotare quando ne aveva bisogno la vescica, ma era obbligato ad aspella1·e un certo tempo prima che l'urina compari<:se: il getto ne divenne più sottile del normale e si manifestò una piu o meno abbondante secrez ione uretrale che divenn e pescia il fulto piu tormentoso per il paziente. '
Quando egli presentò la prima volta all'osservazion e dell'A. questi ri sco ntrò una profusa e purulenta secrezione. l sintomi subbieltivi erano tutti divenuti piu gravi. Per tanto era n penc;are che il palicnte, il cruale nnn negava di avere avuti rappor·li fcJSM soffi>rente di una recent e infezione, ed egli infatti et'a stato trattato con iniezioni di di di potassa (l:WO), in seguito alle quah la secrez1one e1•a cessata, uua goccia resiùuale nel urinario al mattino. L'urina si presentava chiara, o. li?eJ•a di .a lbumina e zuccher·o. Esistevano dunque molli sSimi falli d1 traccie di gonorrea. ..
All 'esame del canale anteriore dell'urelra con caudelette olivari, non si rinvennero c !'ondando il tratto posteriore si r iscont1·ò una leggiera rc--i<:tenza, che fu aUr1hui t.a a spasmo del muscolo compresc;or·e dell'urett·a.
L'esam e endoscopic:o, dopo anestesia con cocaina, rivelò alcun e granulazioni nella pal'te bulboc;a, C""endo normale 1! tra lto ante1'10re. L 'o•servazione del trAtto posteJ'iOt'P riuscì difficile a causa rli una r esistenza non supe1·ablle agevolmente costitUJI.a da una massa di polipi, apparenti solo uel cam po illuminato, e che erano localizzati nella parte membran o<:a ed impiantati per mezzo di peduncoh nella parete posteriore. Questa massa eli tre c m. cirro rli lunghezza, due c. m. lal'ga e StJessa uno, si divisa in tre o quattro parti di eguale grandézza, strettamente avvicinale insieme; a mo' di cavc.,l-fiorc, e con una superficie liscia, di colo!' biancastro, come di epidermide, fortemente in contrttslo col rosso infiammato del tessuto circo!".lante: essa era l eggel'm13nle spostabile e facilmente sanguinante .
Fa tta perciò la diagnosi di papillomi l'A. ne decise l'aspor· tazion e servendosi di un metodo da lui teovato mollo utile in un alt1·o caso di polipi dell'urel1'a Hnlcrior e. Esso consiste nel passar e il tubo endoscopi.!O sul polipo, ed iudi !'On un col po impr'O\'viso tagliare long!Ludinalmente la mas;:a col dorso acuto del tubo Il buon successo di questo metodo dipende dall'abilità di tenere ben disle"a l'asta ed aderente alla cannula endoscopica in modo che il polipo possa essere di viso senza ledere 1 circostanti. Riescito vano di aspo r tare il tumù1'e con questo, che dices i rndoscopio ca r uncolotonno, t• A. ricorse alle ordina ri e pinze urctrali per polipi e il tumore fu rimos<:o. L'operazione fu completala con un tampone di Oborlaender, e toccando la parte oper ata con unii soluzione di nitrato 1li al'gento al :W '1• .
Il metodo di Oberlaender e pratico e assolutamente innocuo: esso consiste nell'introdurre attraverso l'endoscopio o due piccoli tatnponi di cotone o uno solo un po' più grosso ben r accomandati ad un filo. porlal'li verso lo. massa papi! · lomalosa spin gendoli in avanti, in dietro e lateralmente in
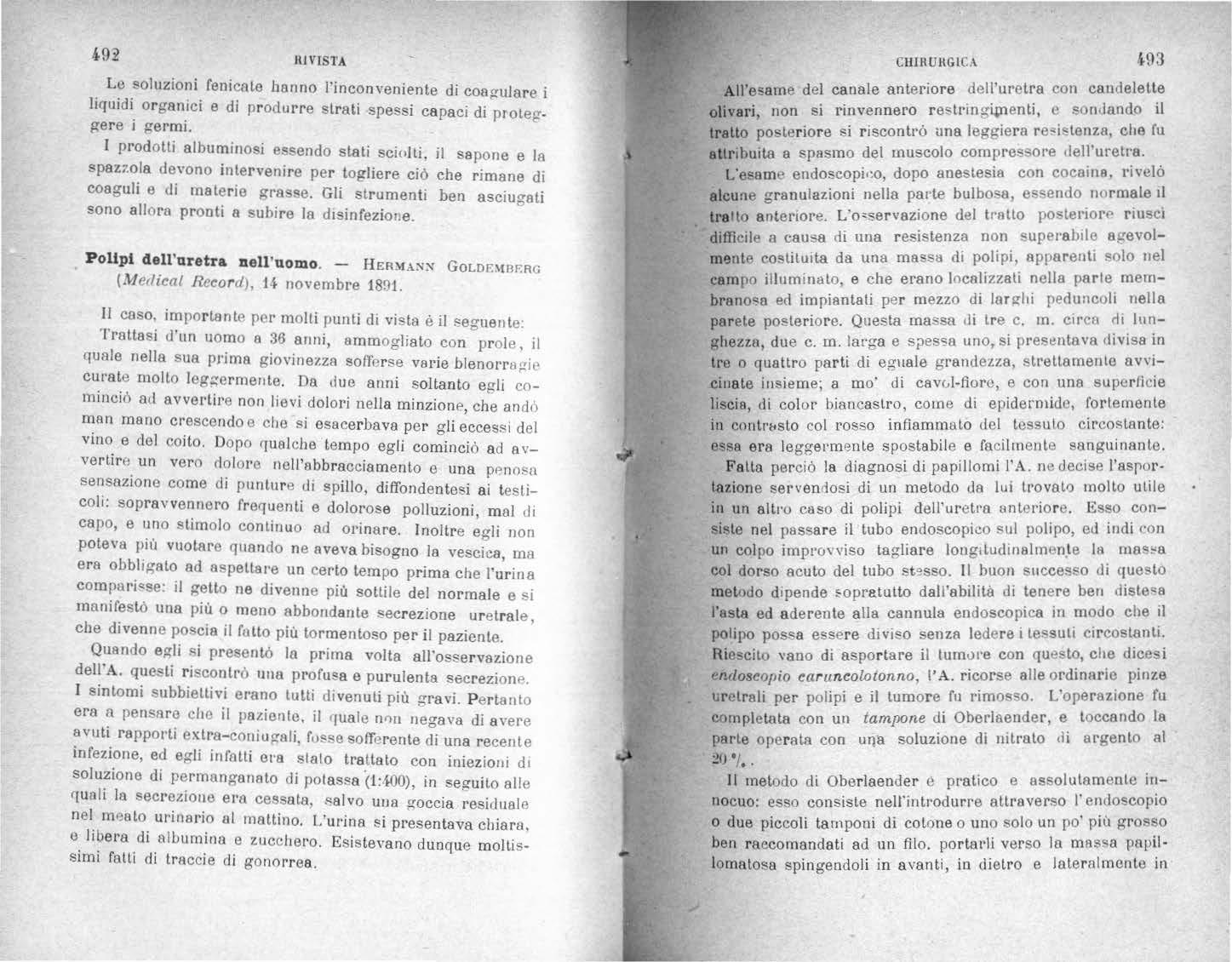
Chir Urgic
modo da isolare le escrescenze dal circostante tessuto, ponendo mente di tenere l'asta ben fissala e stretta sull'endoscopio durante tutto il tempo dell'operazione.
l'A. ebbe agio di r ivedere dopo quattro mesi il paziente e a pp1'esc che l'urinazione e l'accoppiamento si compinwo senza dolore, né s'erano più r ipetute le polluzioni e la suIute generale di lui si presentava eccellente. All'esame endoscopico non si riscontrava traccia della sofferta lesione.
L'A. chiude la sua t•elazione del caso r·accomandando caldamente l'uso nelle malattie uretral i, ritenendolo di un valore indiscut1btle per· la diagnosi e la cura deliA lesioni uretrali.
T. R.
e H .\ RTMANN. - Delle vie di penetrazlone ohirur · glca nel mediastino posteriore. - ( Bull. ct MrJm. de la Soc. cltir de Paris e Celt( r alulatt .fi1r Chir. N. 6, 18!)2).
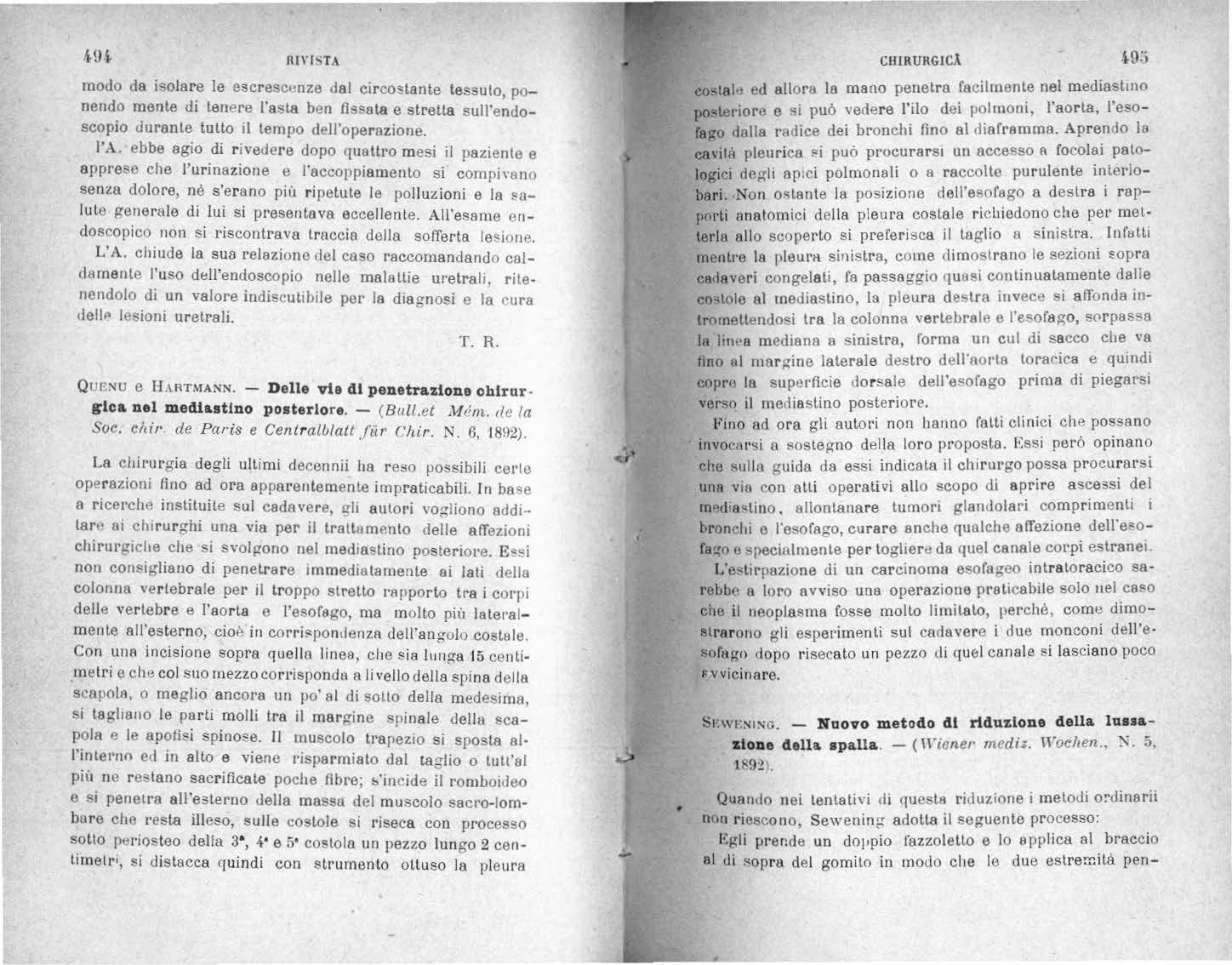
La chirurgia degli ultimi decennii ha reso possibili certo operazioni fino ad ora apparentemente impraticabili. In base a ri ceeche instituite sul cada ve r e, autori vo::rliono additare ai cl11 rurghi una via per il trattamento delle affezioni chirur·g•che che si nel med1a-.tino posterior·e. E"si non consigliano di penetrare immediatamente ai lati della colonna vertebrale per il tr oppo stretto rapporto tra i corp1 delle vertebr e e l'ao r ta e l'esofago, ma m o lto più latel·almente all'ester no, cioè in co•·rispondenzR dell'angolo
Con una incisione sop r·a quell o linea, che sia l unga 15 centime tri e che col suo mezzocorrispondu a livello della spi na d ella scapola, o meglio ancora un po' al di soLto della medes ima, si tagliano le pa r li molli tra il margine spinale della scapola e le apofisi spinose. Il muscolo trapezio si sposta al· l'inte•·no ed in alto e viene •·isparmiato dal taglio o tult'al più ne r estano sacrificate poche fibre; &'incide il romboideo e si penetra all'esterno della massa del muscolo sacro-lombare che r·esta illeso, sulle costole si l'iseca con processo sotto pel'iosteo della 3", 4' e 5' costola un pezzo lungo 2 centi m e tri, si distacca qui ndi con strumen to ottuso la pleura cos ta i•.! ed a llora la mano penetra facilmente nel mediastino e si può vedere l'ilo d ei polmoni, l'ao r ta, l'esofa go dalla radice dei bronchi fino al diaframma. Aprendo la caviiA pleurica !'i può pl'ocura r s• un accesso a focolai patologici ap 1ci polmonali o a raccolte purulente inler·lobari. No n ostante la posizione dell'esofago a destra i r apporti a natomici della pleura costale rich iedono che per metlerla allo scopeeto si preferi sca il ta g lio a s inistra. Inf8tLi mc nt•·e la pleura sinistra, come dimostrano le sezioni cada veri congelati, fa passaggio quasi continuatamente dalle co .;lole al tnediasti no, la pleura destra invece si affonda intra la colonna vertebrale e l'esofa g o, sorpassa la li nl'a mediana a sinistra, forma un cui di s a cco che \'a fino al margin e laterale destro dell'ao1·ta toracica e quindi coprll la superficie do r sale dell'esofago prima di piegaesi ver so il melliastino posterio re.
Fino ad ora gli autoei non hanno fatti clinici che possano invor M<>i a Mstegno della loro pt•oposta. Essi però opinano che sullo g uida da essi indicata il chirul'go possa procur arsi una v1o con atti operati vi allo scopo di aprire ascessi del mPdia slino. allontanare tumol'i glandolari comprim e nti i bronchi e l'esofago, curare anche qualche affezione dell'esoe specialmente per togl ier e da quel canale col'pi estranei. L"es t •rpa;lione di un carcinoma e!';ofageo intra toracico sarebb <' a lol'o avviso una operazione p1·aticabile solo nel caso ch e il neopla.sma fosse mollo limitato, pel'chè, come dimoslraroll o gli espeeimenli sul cadavere i due monconi dell'e· sofago dopo riseca to un pezzo di quel canale si lascian o poco Pvvicin a r e.
,.
Qua ndo nei tentativi d i questa riduzione i metodi o!'dinarii non riescono, Sewenin g adotta il seguen te processo: Eg li pt·er:de un dO J•pio fazzo letto e lo applica al braccio al di del gomito in modo che le due pen - li l VISTA dano posteriot•menle al medesimo. Qu e"te due esh·emilà sono annodale dietro il braccio in modo che il medico possa introdurre il capo tra es"e ed il braccio. Si fa quindi sedere il paziente o in terra o sopra uno sgabellino si fissA la spalla lesa nel solito modo coll e mani 1-\0vrappo"le l'una all'altra. Il chirurgo s'inginocchia vtcmo al paziento, malle il copo nell'aperlu1'a del fazz?lello, afTrr1·a colle mani la parte superio1•e del braccio e SI alza. tamenle colla per;.ona. I n questo movimento il bracc1o v1Pne pure elevato e vien messo in estensione, le mani _applicate,·i sorwa compiono la riduziOne. Questa cura otll••ne meglio se durante l'estensione si compt•ime il rapo lare in basso e ciò tanto nella lussazione in dietro comt> tn avanti od in basso. Il capo articolare in tutte e due le prune forme di spostamento s i avvicina all'apertura per la qual_e é uscito e supera piu facilmente la resistenza che oppone tl margine della cavilli glenoidea. . ..
Il vantaa"'"io p rin cipale di questo metodo sta 111 c10 che . non v'ha bisogno delle mani per operare l'estensione, cosicché esse possono e!;sero utilizzate per la riduzione.
Casi recenti di intervento chirurgico nelle artropatie troftche .- D. CHIPAULT.- (Heoue de Chirurf!ie, tlice mbt·e 1891 1•
Da poco i chit·urgltì <'i occupat·ono delle artropati e trofiche e i pochi casi ù1 inlPrvenlo chi rurgico non furono pet· nnco riuniti. L'autore si pt•opono di studiol'li, e di dedurne com•eguenze terap ..uliche.
Occorre dtstmguere: t•, lA a1·tropotie l!·ofìch r, non romplirate, il etti tipo meglio conosciu to i' l'artro patia tabeti ca, 0 malallia d1 Charcot; 20, quelle più complessi', m eno conosciute, dove all'<'lcmenlo trofìco si sccondar·iam enle un elemento infettivo di v!lria natura.
L e nrlropalie trofiche pure si riscont1•ano una votln su diec1 nella tabe tCharcot) più sposso nella stringO-J(tielite (Mo r v3.n) tal o ra in altre allezioni del midollo o Sono pochi finora i casi pubblicati di intervento ch1rurg1co;
CIIIRURt..II A \.97
e questi secondo il metodo operatorio impiegato possono classificarsi in artrotomie, resezioni e amputazioni.
Artrotomie. - Tre storie di artrotom1e raccolse e riporta l'autore: la 1• di Czerny (1884) con incisione bilaterale dell•arlicolazione, evacuazione copiosa di sinovia mista a conerezioni, raschiamento di frammenti e supc1·flci articolari cariate ; riunione immediata per prima intenzione, pronta riea(lula e r1sult.ato terapeulico nullo.

La 2a di Wolf nel ·1887, con incision n curva so ttorotulea, evaeuazionA di liquido vi..,dùo sanguinolento ron frammenti ossei e cartilaginei, raschiamenlo delle g ranulazioni, esporlezione di osteofiti, lavatura al sublimato, tamponamento, e sutura quattro giorni d opo: alcuni mesi dopo il malato faceva a piedi 10 chilometri di stt'll.da, e il risultato perstste va due an ni più lardi .
La 3' i!';toria si r ferisc:c a un caso di Mull e r, con lorga puntura (col bisturi?), lavatura c dt'enaggio: un mese dopo i l malato usciva dall'ospedale con apparecchio di protezione abbandonato più tat•di, e qualche tempo dopo il risultato persisteva soddisfacente. .
- Furono soventi tentate agli arti superiori dove r isiedono quasi costantemente neg li individui affe tti da siringomielite, ed agli inferiori nei Jabet1ci: (non si conoscono pei primi che duP !'Oie eccezioni: Schullz e Morvan).
All'arto superiore, trovi amo una t·ese;r.ione della spa lla, fatt a da Czet·ny nel i 866 in un atassico, con distruzione notevole d el capo articolare, e numerose neoformazioni pedunculatt ; il risulta to fu .pressochè nul!o.
Sokolof pt•atico nella stessa paziente, a pochi mesi .li inter vallo, la resezi one del gomito e quella dello spalla; al gomiti) ottenne qualche vantaggio, olia spulla pochissimo.
E gli riporta pure un altt•o caso di intervento, resezione del gomito, su un giovane che aveva lesioni distruttive enormi: la guat•igione operatoria fu altraversata dalla formazione di piccoli ascoss i periurlicoluri che lasciarono tìstole permanrnti, e sei m esi dopn operata l'articolazione era cO!II mobile cd impotente come prima.
Per le r csczio:1i p1·aticulo all 'arto inferiore abbiamo: un
4U8 ca">O di r egeztone delranca m un ù1 Relter nel 1x6G: ri unione per prima inlensioue e ri!lullato as'5ai favorevole, p oichè alcuni m esi dopo il malRto camminava bene. Un Hecondo caso lo riporto Schlange all'Accudemia di Berlino, pure di re!;:ezione dull'anca: il malato fu lli'Ont amenle guartlo " polé pre!"to cammmare con un opparccchio.
Al ginocchiO tre cast di :\l uller, e \Volll' elohero r isultato il pr imo !;:egui lo da amputazione e il secondo eia i'ulsn arlicoltJ7.ione, il terzo da amputnz10ne alla coscia.
K trm isson al ront rario ottl'une un t'i!"ullalo notevole in un ca!<o 111 arlt·opalta dPI u:inocchio; e quautut HfUe il malato sia mOl'lo alcuni mesi dopo di malalliu iulc:·corrent t>, si rinvenne r o all' aulop!'<ia le estremita ossee ,..nli la· mente unite f1•n loro da tessuto lìhroso corto ed abbondante con nna mobilità lim itatissimo, e leg-gera incurvalura <'011vessa al capo l'··morale, concava a quello libiale, fav ùrevole alla solidrta della pseudartrosi.
La resezione fu pure tentata Al liYcllo dell' articoluzione libio·tarsea: Holtet• ne ripol'la un senza dirne il talo te•·apeuti(·o: Schlauge porta due r ese1.ioni del pie.le, dt cui una sola con risultato favot·evole. .
Infin e alle a rti colazion i delle dita le rcsezioni ot·lopcdtc hc per artt•opali!' trofìchc con devia7.tonc furono ft•equcttli cd an che con buoni r isultati.
AmpulaAt oni. - .\ lc uni chirurghi han credulo per lesioni trofl chc ar·ticolar i il sacrifìzio
N éla ton nel 18'(8 amputa la cos;(:ia di un tabet1 co dt 51, annt, che rla tre anni porta una art ropatia del ginocchio con mo: vimenti anormali assai este"i. Czorny riporta una storia dJ am putazione RO!H'AmaJieolare, da resipola , melastasi alla spalla e morte dopo \. tnl'!'li. Ch. Auget·, am· putazione li gamba sen z a che no ri«ulli l'esito ùeflrut(\'(>.
Da ll'esame di tulli questi da una che l'operazione non ebbe influenzu !IUII'andamento della t.abc, e dall'altra che i t•isultati locali furono di r ado incora ggrarttt per tre ordini di cause : a) le crisi spasmodiche che spostano le superfici messe a çontallo collA operazione; b) l' estrema faciltlà con cui s i infellano le piaghe ope· Tatoric delle m embra trofiche for'se una asepsi assoluta potre bbe evitare ta:e complicazioni'. e) la distrofia dei tessuti, qualunque ne sia la cau«a. I pr ecetti pratici che l'autor e de luce per la condottn da seguire nelle artropatie trofiche pure sarebbe1·o i :

1· Immobili7.zare sempre l'articolazione in un buon apparecchio o rtopedico é il !"Oio mezzo di e\'ilat•e l'aggravarsi d elle lesioni , lo riaculizzazioni, le lussazioni;
2' e\'acuare, quando è troppo abbondan te, il lh[llido flrticola r e; indicazione fr el'(w>nte nelle artropatie tabeli che, rarissima in quelle della siringomielite;
3• So stituire alla puntura una artrotomia discreta, ris parm iando i legamenti, al solo scopo di evacuazione, quando l'articolazio ne contiene m o lti fr•Ammenti ossei mobi li, e la puntura non diede I'isultati;
4• T entare solo in rarissimi casi un'interven to conservali\'o;
5• Amp utar·e allorché in un individuo ancora val ido, le lesioni articolari costituiscono da sole una infermità che renda la. vita impos,.ibile, ed un interven to consecutivo non ha a lcuna probubililù di riuscita;
6' Qualun que intervento, all'infuori dell'immob ili zzazion e o della punlm•a, sarebbe illogico in caso di stato nera le grave per ca.:hessia midollare od affezione intercorr-ente. t i in ca«o di art r opatie multiple, assai fre<]uenti nei tabelici.
Si può dal suPsposlo vedere come siena poco numerosi i casi da ope r ar e di artropatie tro.flche p ure: l'intervento è più di sovc11te necessario nelle artropatie miste, tro.fo -in.fe /tioe che !li veritì cano per l'infezione !'lecondaria di una art r opatia l1·otlca.
Se ne possono descrivere tre tipi:
L'at·t•·opalia trofica suppurata ncuta, sotto l'influenza dei mic r obi vari della suppurazione sia come localizzazione di u na infezione gener alizzali, s ia per inoculazione dit•e lla;
ClliRURG I C.\ :SO l
L'artropatia ll'Ofica necrolica cronica, risultante dalla intèzione, s;>esso dalla apertura larga e prolungata della ·articolazione troficn;
L'artropatia troficn tubercolare, infezione tubercolare della articolazione tro lìca ronc:lusion i. - l
• T alora in Lutti questi casi l'infezione sopraggiunta non si limita all'at·ticolazlone, ma si mostra lungo il corso dei nervi, già aumentali, I(Uindi luogo di minor resisten..:a, e sovrapponendo alla nevt·ite trofìca una nevrite infell1va .
A. ArtropatiP. tro.fo-inj'ettioe suppurate. - Le articolazioni distrofiche possano sotto tutte le stesse influ enze che le articolazioni sane: ma le osservazioni sono rare e mancano i documenti batlet•iologici. Taluna sembra che suppuri pet• infezione suppul'ativa proveniente da una piaga prossima suppuraute, il più spesso la suppurazione sopraggiunge sotto l'influenza ùi uno stato generale catti vo, perioclo uvauzato di una cac!tessia midollare.

In seguito a numerose relazioni di casi di vtu•i autori, ri· portate, risulta che il più dolle volte trattasi di inlervc uti diretti sopra t utto contro l'e lemento infeltivo della lésione articolare complessa: l'elemento trofico in queste condizioni non si considera che come un accidente dei più fune sti e chr:, impone o le l"emplici opet·azioni evacuanti (artrotomie) o la soppressione d...l focolaio d'infezione e del membro inutile (amputa:tionel o qualsiasi tentatiYo di conservazion e sezione).
B. A rt r opatie lrofo infettive necrotiche. - Questo tipo poco conosciuto, frequente sembra limitarsi allt• piccole articola:tioni della mano e del piede : a questo "Ì riferiscono le artropatie fistolose caralleristiche del 3• peri odo del male perfo r ante, in cui la testa della pt•ima rae del primo metatarseo eliminano in frammenti neerotici. L'aulot·e ne esaminò 5 casi senza trovar mai a\lro che i microbi comuni della suppurazione, ma nulla di interessante dal punto di vista batteriologico n è poi dirtìcile trovare la pot'la d'ingresso e la via di comunicazione con qualche vicina escoriazione o piaga di o ri g in e.
Queste artriti trofo-necrotiche vogliono un traltamento discr eto e conservativo: la pulitura dell'arlicolaziorw con medicazione asetti ca piutlo3to antisettica pel' la suscettibilità lrolica dei tessu t i, basterà a sopprimere l'elemento infettivo locale che prova la necrosi, ed a evitare le complicazioni infelli,•e più grandi.
C.. l rt ropatie t r ofo·iubereolose. - Pu ò succedere che, su individu o predisposto (o per inoculazione), una articolazione troflcn diventi tubercolosa, ma sono casi rarissimt e non se ne raccolse che uno solo pubblicato da Saint· Germain. In tali casi, sarebbe logico usare prima i mezzi palliativi e se questi n on l'iesr.ono, l'amputazione per liberarP il paziente di un mem b r o inutile, e di un foc•>laio di infezione.
•. Per le artropatie trofiche semplici l'evaeuazi one dell'essudato articolare eccessivo d'ordinario e sul'fìciente; la r esezione si potrà forse tentare in qualche ca!lo n le s ione ip ertrofica, l'amputazione l'; di regola nei casi d t importanza assoluta
2o. Per le urtropatie a) so l'artropatia è suppurata; ar·trotomia; se il pus si 1> diffuso e lo stato geuer·ale infettivo è grave, amputazione: b) se l'artropatia é ne<'rotica, la pulitura della arti colazione: c) se l'al'tl'opalia è tube r colare i mezzi palliativi, e se questi non r iescono amputaztone.
Bpttelloma t raumatico per l.nnesto epidermico . - Dollor E. CR tSTJ.\NJ. - ( Rentte de chi r urgie, N. l, 1892).
Molto si è scritto sulla sorte dei tessuti innestati sull'organ.smo anim ale, e pur rimanendo su 4uesto SOA'gelto qualche punto o scu r o, si possono trarre diverse conclusioni dimostrate . Così sappiamo che ' un fra mmento di tessuto innestato sotto la pelle o nel periloneo di un anrmale, allorché l'ope· ra zione è fatta colle debite cautele, attecchisce, ma poi dopo qualche tempo finisce per e ssere riassot•bito.
In a lc uni casi questa disparizionc é lenta, in altri assai r apida: s i conoscono altresì degli esempi in cui tessuti ininvece di essere ria ssorb it i e scompar ir e, vivono nel
Chiiiurgica
nuovo mezzo io cui furono posti, vi prosperano e costituiscono in certo mod o un neoplasma.
L'aulOI'C menziona in pr·opOSllO le esperienze di Kauffm unn su ciò che egli chiama enkatarra.fia d'epitelio, asserisce ave1·e una serie di e!=lperie nze propr·ic di inne-.Li, che pubbl icherà prossimamente, e ricorda che ReveJ•(Iin d esc risse nell'uomo un neoplasmu alle dita che egii chiama cisti epidermica

Questi tumori, ad una cisti sebacea, l'i SYIIuppano alle dita ove non esistono glandole e studiandone l'eziologia il Hever,l in potè stabilir e, che essi insor!..'ono sempre in ses:tuito ad un traumalismo, prodollo d'ordinario con arma ollusa, e ne conclude, con molta ragione che getlo conludente introdusse nella fet•ila un frammento di epitelio del rivrstimento cutaneo, il quale serve di germe della cisti. Questa stessa id>?a era pure già s tata emes:;a da Gross.
Dal canto suo l'autoee osservò in un caso di cisti epidcrmoidea d'un dito, che il contenuto eli tale lumoJ·e, anal o;:o a quello delle cisti sebacee, non ne é però identico: formato in massima parte ùi grasso con cellule epitrholi piatte c cornificate, analoghe a quelle della desquamaziOne della pelle, rav vicinanle:;i per r.onseguenza piuttosto al contenuto di alcuni dermoidi.
Ri pot·ta esteMmente una storia di un tumore estir pato dalla fronte, insorto da tre 5:etlimane in seguito a fedta la · c r esciuto rapidamente, con tendenza alla ulce· razi one ed alla emorragia. All'esame istologico si riconobbi"! consistere in una magc;a di papille con al loro centro l'oco tessuto connettivo, con numer·osi vasi, e il tutto ricope rto da strati epiteliali mollo spessi e ri sullanti dalle stesse strat•ficaz ioni dell'epilellO cutaneo, ma mollo più sviluppate: facile desquammazione delle parli superficiali; fusione delle pat•ti contigue delle papille ravv icina te, ed allora la co rni ficazione Ì' poco pronunciata; molto inYece nelle superfici lib ere L'esame batlet·iologico fu n ega tivo .
E r a dunque uno neofo r mazione papillare da c lassificarsi tra gli epiteliomi. Anatomicamente il tessuto ep iteliale inter- pepillare, che s'insinua e discende piìt m MI livello della cute sana in lica un principio d"invasione del connettivo del dai bottoni epitd1ali, lcc.ione iniziato degli ep1tehom1. Clinicamente il decor:;o rapido. l'e morragia ,. l'ulcPrazrone cost1tuiscono tre cat•atteri d t mulignitù che non sr riscon t rano nei papillomi comuni, benigni, ma in quelh chiamali anche epiteliomi papillari, epile l ror,.a eorneo, o papilloma maligno.
Jn c:orgono soventi tumori consecutivi a traumalismi unici e v1olenli; le contusioni sembrano da cause determinan ti in indiYiùui predisposti. Tali tumor1 sono tl"ordiltar·io di'i Mrcomi. Riguardo ai ch eloidi ed agli epi tolio111i delle cicatrici, non vanno collocati frll i neoplasmi traumutici: essi sono tumori sviluppati su un tessuto patologico creato dal traum atic;mo, la cicatrice; è quindi il che ò tnlllmatico, non il neoplasma.
L'andamento degli epiteliomi 1\ d'or·tlinat'!o Ionli;;sinw; laluni é vero presentano ulcP.raz.ione prcc;oce, ICla in (Juosti ea!-<i h unn0 la forma ulcerosa fin dall'inizio, sono piatti c non papill ori e peduncolali: i neoplasmi che si sviluppano rapidarn t>nte, c volume in poclw >;el· tima nc sono in genere tumor·i sarcomatO!;L
Il tu more ..samioato l· dalla pelle cir·co!:i tnnle. sorte eomc da un foro praticato nella meJe!O;ima; od ha egli sle!=>c:.o la !ltrutlut•a della pelle stessa con propol'lionì può quin li ritenere che sia dovuto ad uno l'viluppo ntipico, nnorma !,P, rapido di un frammento di pelle staecoton ella contu--ione. Questo fi'Ammento fu r·espinlo con tm l'osso mentre i mnrgini della gonfiali per· inflllr1wone emor·r ag ca eJ edt>mntos11 si r icongiunse ro al di sopra: mentr·e avvio•ne lo t·•t.nJonc per sP.conda intenzione, il frammento, rimasto ad erente alla sua base, e m condizioni relalivam••nte buone, s'ac,.resce oltre i l im iti ordinari nei rappo rti reci(WOci dei lel!!'Uti.
P arecchi casi descritti nella letleratur·o medica come tumot·i consecutivi a traumatismo sarebbcr·o !luscellibili di analoga interpre taz ione
CHllWRGlCA
Beatrlng lmentl conse outlvl a lle r o tt u re inc om plete dell'uretra..- GuY0:-1. - (.Jou:onal de Jfédecine el de Chir /1 r gie, f!ennaio
Le complicazioni consecutive alle contusion i del pcrineo, aMhe quando queste sono e d i un pronostico in appat·enza molto beniguo, presentar si con unu grandissima rapidità. Il professore CTuyon ha riferito com<' esempi i seguenti casi.
Un uomo riceve una al perineo il 10 Iuzlio ed enlra all"ospedale il 21 ottobr'e, avendo prPsenlalo Jll'r qualche t.empo r ilenzione d'orina ed essendo affetto da un r eslr ingimento insuper abile.
Un allro malato, dopo un colpo sul l'erineo, emette unm edialamente ssngue per l'uretra ed f' affetto da rilenziotw, alla quale egli r im edia introducendosi da s1\ stesso la !'onda; ma fin un mese dopo l'accidente, egli presen tava un res lrin gimenlo molto p r·on un ciato.
Un terzo malato i· caduto a cavalcioni sulla spalliPra di Ul 18 f'edia a bracciuoli. E f! li ha rmcsso sangue nella !'<Pra e non ha potuto o ri nare nel giol'no s usseguen te ; si do,etle sondarlo e !asciargli in permanenza una sonda. Ciò non ostante, dopo qualche tempo egli presentava gia un restl'ingimcnto trattamento di tre mesi , ma non si oltenn e che un m ediocre risultato. malati furono a bbandonali a lòro stessi ; un altro, più g rave, fu sottQposlo all' urel r olomia esterna, ma il risultato non è stato miglio r e, percltì· la r ecid i va conrparve moll o p r (•slo.
Tutti questi malati non avevano ripOI'lato che una t'Oltut·a incompleta deii\H'elra, pel'ch··· quAndo questa é completa s1 osse1'vano sempre contemporaneamen te i tre sinlomt seg u enti: tumefazione del pet·ineo pr odotta da un'ematoma cho si prende per errore sovertli per un' inlìltrazion e ul'in osa, emorr agia dell'u r elra e rilenzi one d'orina.
In un altro malato gli a cciclf>nli iniziali sono stati ancor meno accentuati; avendo urlato s ulla sPIIa del suo velociquantunque senza gra nde vaoienza, ebbe qualche ora dopo una leggiera emo rragia ; nulla cl' anorm a le present•l nei giorni susseguenti, ma rruiudaci giorni dopo l'orinazi one dtvenne penosa. Fu curalo allora pet• tre mesi e si ottenne un a dilatazione sufficiente, ma questa però non si mantenne.
Ma que ':!li res trin gimenti consPcutiv i p1·esentano inoltre uno !<JHWitJie pe1·icolo : la dilatazione Jegli ureteri e la dis tensione r ena le alla rilenzione d'o r ina.
Ne l t-estr ingirnento ordinario. quello che sussegue alla le alte r azioni avvenftono m olto men te, la vescica si abitua ai distu rbi della ot•inazione e queste cliflìcolta collo sviluppo della sua muscolatUI'a: cosi resiste molto meglio alla dilatazione quando vi ha rilenzione.

Al cont1'ario, •rua ndo il reslt'inf!Ìmento si fa mollo pr esto, la ve!!lcica. s i lascia in qualche modo sorppender·e, la di la taz ione ptoò estenders i a gli ure te r·i ed a l rene; ed Ì.' in tal morlo che si vetlono morire certi malati che sono tullavia rim&!'li a settici.
Lo anatomico di questi casi permette di rend e rei con to del modo con cui le lesioni si p r oducono .
Sop1·a u na cicatrice ur·elrale consecutiva ad un tr·aumalts mo, recentemente da Guyon, si constatò che e s!'a era semi·circolar e ed av e va la forma di una g r ossa ghie ra tra sve r !'\ale, di cui lo spesso r e e la larghezza raggiun gevano ctuasi U(l centimetr o; ciò no n pertan to il tessuto cica triz iale non interessava n r-' il t essuto so tlocutane o , né IB pelle; er·a una cicatr ice puramente urelrale, che risiedeva n el corpo spugnoso e com;>rendeva tutto lo della parete inf... riore, per ché la pare te superio1·e non e r a intessata . Baqa quindi una incompleta dell' u r etra per· protlurr P una lesione cosi 1mpol'lante e con conseguenze che possono PSsere tanto g r avi.
Il trallomen to consecuti'.'O, in simile caso, consiste, in caso di ril t•nzione, ma solamente in questo caso, nel fare il cate teris mo che spesso presenta grandi difficol tà. Si deve cerca l'e, in tutte le m anov1•e, di seg uire, senza ]asciarla, la parete dell'ut·etra che non «., mai rolla. In alcuni non si può penetrare nella ''escica che con una sonda mollo sottile; si può allora far passare su questn tenta ch e serve do conduttore una sonda con punta tagliata, s i lascia in segu lo in permanenza per alcuni giorni. per esetruire questa manovra, i· prefrribile di usare una lenta filiforme munita di una vile alla sua estreruita posll'riore. lotrodottola, si invita su essa una lunga asta metallica che si là allora penetrare facilmente dietro ad e su qu es ta asta si fa scivolare la Mnda n punta tagliata. Si ritira quin:li il conduttore.
Fn po' più tal'òi, quando il I'Pstringimeulo cominl'in a farsi sentire, fa d'uopo CCiminciare la tlilotazione, ch e s o vcn ti non deve più esserfl in l'eguito interl'olta. I n certi co f< i. « \ necessarto ricorrere all'ui'etrotomta, !"ia interna, ci ò c h e é il caso più frequente, fa d'uopo s oggiun !:te re che in questi ultimi casi, per a,·ere un buon risultato, s i ottenet·e una 1·iunione immediata ; ma non «ernpt•e Yi si riesce. Per questi difl'orenlt casi Guyon ha imma g inato di e!':tirpare la cicatrice, e, nelle operazioni da lui falle, h a ottenuto risullali mollo più favorevoli.
Tumori aolldi perlvesoloali - UuvoN.- (Jou r 11al de M édeeine et rle Chirurgie, geunaio ffl92).

I tumot•i solidi pcrivec:cicali sono rari, ma es!':i danno in alcun i casi a diflìcoltà di diagnosi granùi clte è b e ne conoscere in quali condizioni essi possono presentarsi.
In una malata, stata operata di cislolomia, Gu yon ha r·iscontralo il c1eco e ileo-cecale aùerenti alla vescica e nel cieco un adenoma assai voluminoso. In <juesto caso, pareva cl•e il tumore apparlenesse alla Yescica, ma ciò era unicamente per le sue . aderenze, per·ché non esisteva alcuna comunicazione li'a ùi esse, come accade talvolla.
In un uomo arrtvato nella clinica con una enor me distensione ''escicale, si senti va uella foc:sa iliaca silllslra un tumore unito alla vescica. Al pt•imo momento si sarebbe
CfilRURGICA '>07
potu to credere ad un ingorgo fecale; ma, essendo il morto rapidamente, si riscootrorono ader{>nze tra la S 1haca e la vescica ed aderenze colla parete a !dominale. Pare,·a che l'or igine di questo tumore fosse unicamente iufìammatoria.
Gu von ha rifer·ito u•• let•zo caso relativo ad una donna in molto grave, nella quale venne fatta diagnosi di tum ot·e della ,·escica. Ora si é constatalo lra l'utero e la vescica un vero ematoma che vuo tava il suo contenuto nella con la quale essa era in comunicazione, per cui questa malata orinava del sangue, benché la mucosa vescicale non presentasse che le lesio ni comuni di un'antica cistite.
È diffìcll e in questo caso conoscere ec:attamenle come siasi ol'iginAlo l'ematoma, pel'chè gli annessi erano m istato nor male e l'eta della menopausa era pa>:sata, ciò che esclude l'idea di un ematocele. Ma l'appendicfl cecalo era unita al tum ore, di guisa che pare che siavi stata dapprima un'appenJicitc, la quale é stata il punto di partenza di un focolaio infìammator·io, in cui si sottO formate false membrane, lP. quali sono divoulato esse sle-;se, per la loro vascolarizzazioru•, l'origine di quelle emorragie che potevano far credere ad un tumore Jella vescica
In un uomo che orin&va pure del sangue, la sintomatolog ia era alquanto difl'«:lrente. Qu11ndo egli enll·ò nella cii· nica, pr·esentava un vescicale ed emise con l'orina un framm ento che si poteva Cl'edere appartenesse ud un nco plasma vescicale; ma questo frammento. esaminalo al micr oscopio, fu riconosciuto da un adenoma s tinalc. Alcune dopo il tumore era aumentato dJ volume ed il malato emetteva gas e materie con l'orina. Morì dopo alcuni giomi ed all'autopsia ::.i constatò l'esistenza di un tumore intestinale che si era sviluppato nella nello quale era penetrato per perforazione. Esistevan o inoltre numero!':e masse infiammatorie tutto attorno alla vesci ca.
Vi sono anche, in cu1 l'infiammazione intestinale e peri- intestinale è consecutiva alla presenza di un corpo
RII'ISTA CHIRIJRGICA
eslr•aneo nell'intestino. Un malato che vt"nnfl ricoverato nella clinica ha emesso per· J'ureLra una vertebr·a di anguilla, la quale. dopo a'·er p r ovocato la perforazion e dell'inte:;;tino e della vescica, eru penetrata in que!:<t'ullima.
Questo modo di comunicazione non ,.. d'altra purte molto raro ed in generale, quando esso si produce, é dall'intestino che l'ori gine degli accidenti. Lo dicasi per i neoplasmr; et! è molto raro che quelli della vesci ca si portino verso l'intestino.
Ln stessa osservazione può essere fatta per l'utero i dr cui neoplasmi ill\adono soventi la 'escica, mentre 1 tum ori vescicali si propagano più raramente ver·so l' utero.
Dal punto di vista clinico, si può concludere, in un modo genE'rale, che ogni qualvolta c;i sente un tumore \'•)luminoso, il fJUAie sembr·a essere d'origine vescicale, ma che si estende alle parti vicine, t'• mollo probabile che l(twsll' tumol'e abbia un'altra or·igin e c the la vescica non sia stata interessata che consecutivamente.
RIVISTA Dl OCULISTICA
Le nbre nervose dell'occhio studiate col metodo di colorazione dell 'Ehrlloh coll'azzurro di metilene. - F. HoscH. - (v. Graefe's A rch. jù r Oplttalm. e Centralbl. jiir die medie. Wissensch., N. 7, 1892).
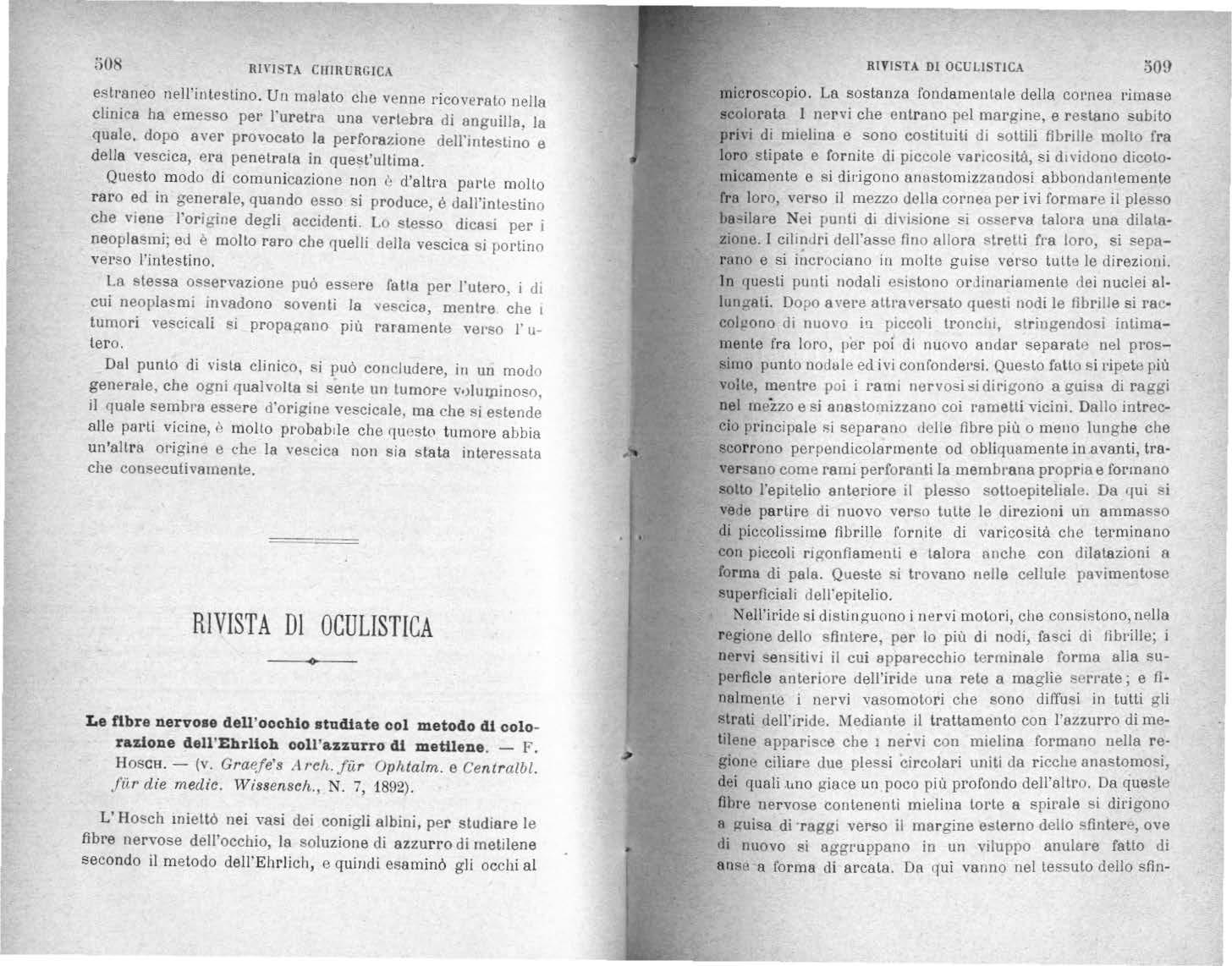
L' Hoc;ch mietlò nei ''asi dei conigli albini, per studiare le fibl'e nervose dell'occhio, la sol uzione di azzu r ro di rnetilene secondo il metodo deii'Ehrlich, e quindi esaminò gli occhi al si dislingucmo i u ervi motori, che consistono, nella r egione dello stìutere, per lo più di nodi, fasci di lìbt•ille; i ner vi sensitivi il cui appa!'ecchio terminale forma alla supel'flcle anteri ore dell'iride una rete a maglie st> rl'ate; e finalm ente i n e rvi vasomotori che sono diffusi in tutti gli strati dell'il'idc l\Iedianle il trattamento con l'azzurro di metil ene apparisce che : n e rvi con mielina formano nella regionP ciliare due plessi circolari uniti da ricche anastomosi, dei quali ttno un poco più profondo dell'altro. Da queste fiht•e nervose contenenti mielina torte a spir·ale s i dirigono a guisa di ·raggr verso il margine esterno dello sfin tere, ove tli nuovo si aggr·uppano in un vrluppo anular·e fallo di an se a forma di arcata. Da qui vanno nel tessuto dello sfin-
RIVISTA DI OCULISTlCA 509 mi croscopio. Le. sostanza fondamentale della cot·nea r·ìmase sco lo rata I nervi che entra no pel margine, e restano subito privi di mieliua e sono costituili di sottili fibrille mollo fra loro stipate e fornile di piccole vari cosi la, si di\ idono dicotomicamente e si dirigono anastomizzandosi abbondantemente f'ra loro, verso il mezzo della. coenea per i vi formare il plesso ba --ilare Nei punti di di\ isione si osse rva talor•a una dilatazione. l cilindri dell'asse fino allora stret ti fr·a loro, si separan o e si incrociano in molte guise verso tutte le direzioni.
I n r1uesti punti nodali esis tono ortlinariamenle dei nuclei allun gali. Dopo avet·e a.tlr·aversato quec;tr nodi le librrlle si l'Se· col!!ono di nuovo in piccoli tronchi, stringendosi intimamente fra loro, por poi di nuovo andar separato nel prossiruo punto nodtile ed iv i confondersi. Questo fallo si ripete più volte, mentre poi i t·amr nervosi si dir·igono a guistt di raggi ne l rn ezzo e si anastomizzano coi ramelli vicini. Dallo intreccio principale separano delle fibre piu o meno lunghe che scorrono perpendicolarmente od obliquamente in avanti, traver;.ano come rami pel'foran ti la membt·ana propria e formano solto l'epitelio anle!'iore il plesso solloepiteliale. Da qui !'ti vede par lil'e di nuovo verso tutte le dit•ezion i un ammasso di piccolissime fibrille fornite di varicositA che terminano con piccoli rtgonfiamenti e talora anche con dilatazioni a fo rma di pala. Queste si tr-ovano nelle cellule pavimentosc superficiali d cii'epitelio.
111\'IST.\ Dl OCUUSTlCA tere fibre prevalentemente pri"e di mtt>lina pet• formar"i u na r icchissima rete di solli li filamenti pttnteggiatt. Qua e là s i tr ovf1no cellule fusiformi o tr•iangolat•i contenenti nuclei e cor puscoli nucleari simili a picr..ole cellule ganglronnri, le quali stanno in r elazione con un prolungamento delle fibre nervose contenenti mtelina.
· 1 ·,,aie motihla. D - •pecifica. dei muscoli che a noli . . . . Calli e g li tr·ovò nnche qui eome p l'HOI;t lll a.lln ut•llo sfìntere esterno dell'ano , una tale mto<:1te P a r aplegie d ' orlglne 1ifllltloa. . -P. Bol LLOCHE. - (Jonrnrtl de M 1l1l. ('{ de Cl!i r ., dicembre 1891 ).
Sulle alterazioni ollDlohe ed Jstologlohe delle ton1llle e del pllutrl aft'ettl da sUlUde . - '\rW MAXX. - ( \Vien er med. Bliilter e Centrai&. (iir die medtc. \Vissensch., 18!12' n. 3).
Il Neumann spiega il fatto frequentemente osservato che le r ecidive della sitìlideanche e particolar•mente del perto,lo terziario occorrono di pr·eferenza nei luoghi che furono già p1•ima sede delle sifìliticho manifestazioni ammettendo che in questi lu ogh i sono rima sti dei prodotti d'infiammazione cho per effetto d i qualche eccitazione sono mossi a proliferare. Egli potè dimo· strare anatomicamente nei luoghi della primitiva sderosi o dell'esantema anche dopo deglt anni sotto l'epitelio apparentemente normale una infillrazione di cellule t•otonde; e questo potè dimostrat•e anche nelle o nella mucosa del palato molle che tanto frequentemente sono la sede di r ecidive locah. Le aderenze cicalrizie che non raramente avvengono in conseguenza dei processi ulcerosi sitìli.lici del palato molle dei pilastri e dell'ugola con la parete posteriore della faringe, ei le attribuisce in gran p a rte a una malattia

L' epoca in cu 1 compare la para plegia sifìlthca è stata m<>lto Òpprezzata. (jilbe 1·t e Lion, in un loro _re_c<>nte lavor o avevan o riuntlu 1:7 casi particolarmente degm dt nola per la' pr ecocilA Pstroma accidenti (;;u I'(Uel. numero, 3i casi nei pt·imi vt>nli mesi). Roulloche ha nella trnale n2 volte ;;u 100 la para s1 l' 1:11zia\a du r ante i quattro anni che su"<>ea:Utrono ali ulcera (8 v{)ltc nel primo È quindr lecito il dire che non solamente le mieliti sifìliliche sono mollo spesso preer>ci ma che esse compaiono sempre nelle prime fHIlell'inretione. La miclito lat'Jiva, che mollo tempo dopo l'ulcera, "-ÌII in a'.' teniarii, sia dopo un lungo periodo s1lenz1oc:;o, e lll::>omma cmm molla rara.
La mielite appartiene ulle sifllidi g1·avi o si nelle sitilidi or dinnriament3 medinne o benigne? .\ questo rtguartlo Il' -,ta tislicho , ariano. Cionon o5<lanle, tenendo solo lo d t quella , sa1·ebbe lecito concludere che acca:le per la m1dolla c1ò c he si osserva per il cervello, val e a d1re che le determinazioni della sifìlide su ol'gani si constutano più spesso nei cas i di infezione leggiera o mediocremente grave. Probabilmente cio d1pende dal fallo che questi malati si curano me no completamente de:.rli altri, ed infatti le cifre P_I'O\'ano anche che gli accidenli midollari sembrano comparu·P due volte meno sovonLi nei silìlitici che hanno fatto una buona cura che in quelli che non hanno preso mei'CUI'io o ne hanno preso in un modo insufficiente.
La sintomatologia di que!'li acridenli presenta la larita che le mieliti sitìliliche sfuggono a qualsiasi descrizione dell'insieme; esse non possiedono alcun car atte r e pro- prio, fuorchò la nozione di causalita, che pe rmelle dt dtshnguerle. sono di due sorta· le une acute si stabiliscono repentinamente, in alcuni giorn/, eon un'corte; di della sensibilità e sopratullo della motillta, generalm ente mollo a ccPntuati; le altre, croniche, insidiose, coma poco a poco; qualunque sia il loro modo di rtre, un fatto domina tutta la loro storia, ed è la par·aplegia che, a flradi diversi, non manca quasi mai.
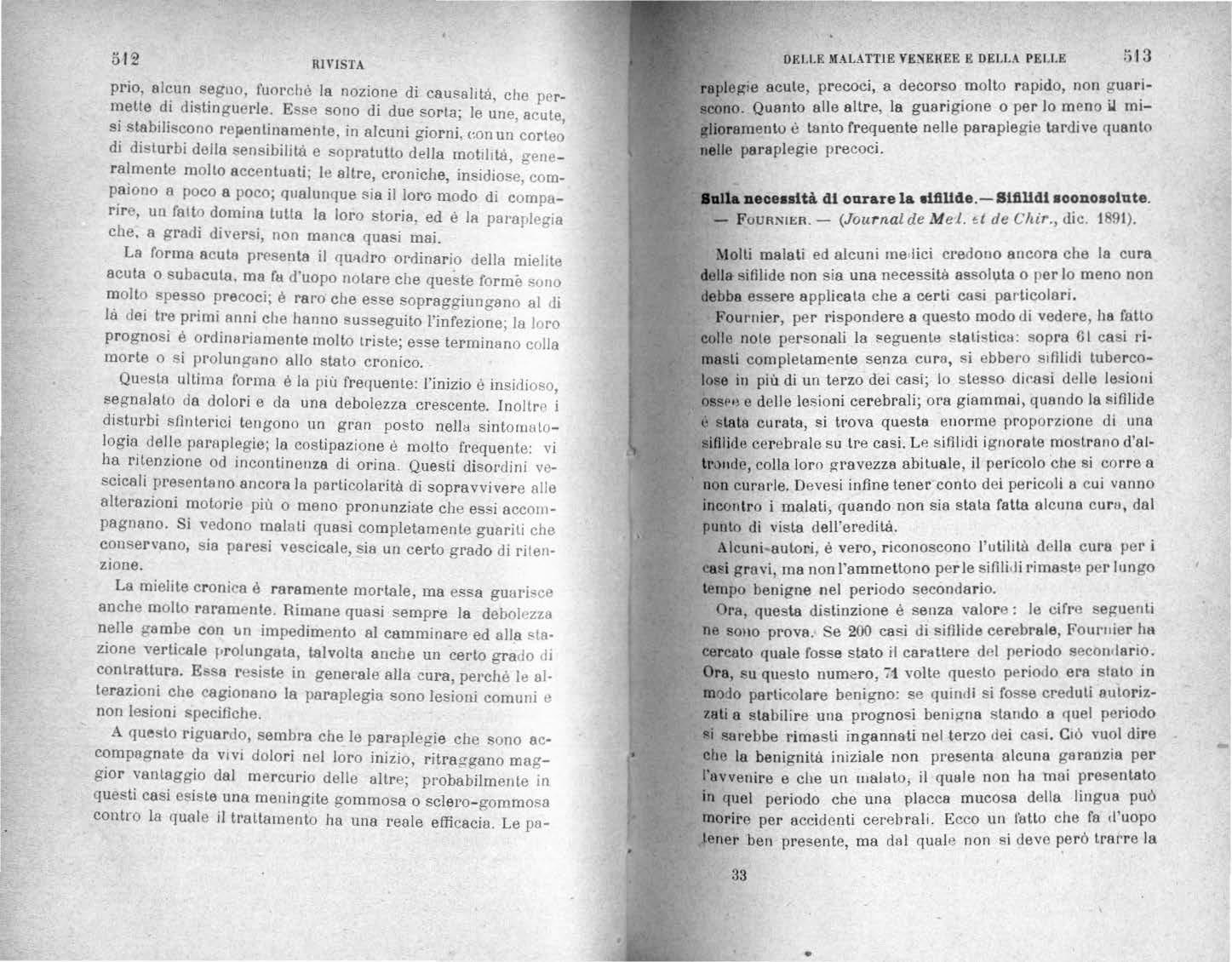
La forma a cuta prPsenta il qu•1cl ro or'dinario della mielite acuta o subacuta, ma f1:t d'uopo notare che queste forme s o no molto spesso precoci; é rat·o che esse sopra.,.giun<Tano al di la dei tre primi anni che hanno susseguito la loro prognosi é ordinat'iamen te molto Lriste; esse terminano colla morte o si allo stato cronico.
QuPs la ultima forma é la più frequente: l'inizio è insidioRo, segnalato da dolori e da una debolezza crescente. In oltre i disturbi sfinlel'tCi tengono un gr·an posto nellll sintonwtologio. dell.e pat'tlplegie; la costipazione è molto fpequente: vi ha rtlenztOne od incontinenza di orina. Questi disot•dini vescicali presentano ancora la particolarità di sopravvivere alle alterazioni moto rie più o meno pronunziate ch e essi accolllpagnano. Si vedono maiali quasi completamente guarili che conservano, ::;ia paresi vescicale, sia uu certo grado di ritenzione.
La mielite cronica é r aramente mortale, ma essa guuri..,c e anche molto raram en te . Rimane quasi semp re la deboll'zza nelle con un impedimento al camminare ed alla zione verticale r•rolungaLa, talvolta anc he un certo grado di contrattura. Essa r esiste in generale alla cu ra, pe1·chè le alterazioni che cagionano la paraplegia sono lesioni comuni e non lesioni specifiche.
A questo riguardo, sembt·a che le paraplegie che sono acda v1vi dolori nel loro inizio, ritraggano maggtor vantaggio dal m e rcurio delle altre; probabilmente in questi casi esiste una meningite gommosa o sclero - gommosa contro la quale il trattamento ha una reale efficacia. Le pa-
OELLE MALATTIE V.ENEHEE E OELLA PELLE !> 13
replcg1e acute, precoci, a decorso molto r opido, non gua riscono . Quanto alle altre, la guarigione o per lo meno i.l miglioramento è tanto frequente nelle pareplegie tardive quanto nelle paraplegie precoci.
lalla neoeaaltà dl ourare la •Ulllde.- SUI.lldt aoonoaolute. - F oURNttm.- (Jou rna l de M el. t t de Chir., di c. 1891).
Molti malati ed alcuni me lici credono ancora che la cura della sifilide non sia una necessità assoluta o per lo meno non debba essere applicata che a certi casi particolari.
F oul'llier, per rispondere a questo modo di vedere, ha fatto colle note personali la sopra Gl casi l'ima sti completame nte senza cura, si ebbero s111lidi tubercolose iu più di un terzo dei casi; lo stesso dir-asi delle lesioui ossr•} e d elle lesioni cerebrali; o r·a giammai, quando la sifilide l' s tata cu r ala, si trova questa eno rme proporzione di una sifilid e cer ebrale su tre casi. L e silìl idi ignorale mostrano d'allNttd e, colla loro gravezza abituale, il pericolo che si corre a no n curade. Devesi infine tener conto dei pericoli a cui vanno incontro i malati, quando non sia stata fatta alcuna cu r o, dal pun to di vista dell'eredità.
Al cu ni autori, é vero, riconoscono l'utilità della cura per i g r avi, ma non l'ammettono p e rle siOlidi t•imastP per lungo tem po benigne nel pe1·iodo seconda rio.
Ora , questa distinzione é senza valore : le cifre ne sono prova . Se 200 casi di sitìlide cerebrale, Fout•nier ha cercato quale fosse stato il carauere dl'l periodo secondario. Ora, su questo numaro, 71 volte questo periodo era stato in moJo particolare benigno: se quiudi si fo sse creduli autorizzati a s ta bilire u na prognosi benigna s tando a quel periodo 11i !laeebbe r i masti ingannati nel terzo dei C1ò vuoi dire che la ben ignità iniziale non presenta alcuna garanzia per l'avvenire e che un il quale non ha moi presentato in quel periodo che una placca mucosa della lingua può morire per accidenti cerebrali. Ecco un t'otto che fa d'uopo tener beu presente, ma dal quale non si deve però trarre la cont:lusiono che lulle le sifilidi benigne terminino con accidcnli gravi.
Non si deve quindt esitare a curlire la sifilide, qualunque sia la sua benignità. La delle sifili<'i ignot·ate che pa!;,ano so,·entt inavvertite a cagiono della lot·o benignilà di()UC!\L!l necessita. Fourmer ha citalo, a questo proposito, il caso di uu individuo affello da enorme tumore alla per il •ruale era c::talo conc::iderAla come necec::sar·ta rampu la7.ione. Hi coveralo nella sua clinica, Fourn ier riconobbe lrallat•si di una ma..,sa gommosa che scomparve colriotluro :\la l'errore era stato commesso, pet•cho· il n1alalo affermava di non aver mai avuto la sitìlide.
Fout·n tct• ha citato pure il fatto di una donna in cui vrnrw constatala uno. sifilide papulosa, la cui origine era dubbia, assct•endo il tnat•ilo fvrmalrnonte di non aver mai avuto alcun accidente venet·eo. Esamiualolo però, si riscontrò in lui una u lcera indurito, con pleiade earallerislica e t•oseola. Quest'in· ùividuo sembrava ignorare di avere la sifilide.
Molle di qu!1<:Le sifilidi ignoralo sono soventi piuttosto HilìHdi dissimulate.
Ma molli di quefiti maiaLi soo di buona fede, e fa d'uopo ancot·u le stfilidi ereditarie cd anche quelle che si trasmettono alla seconda generazione, porchè di..esse e;.istono ora osservazioni iuconteslabili.
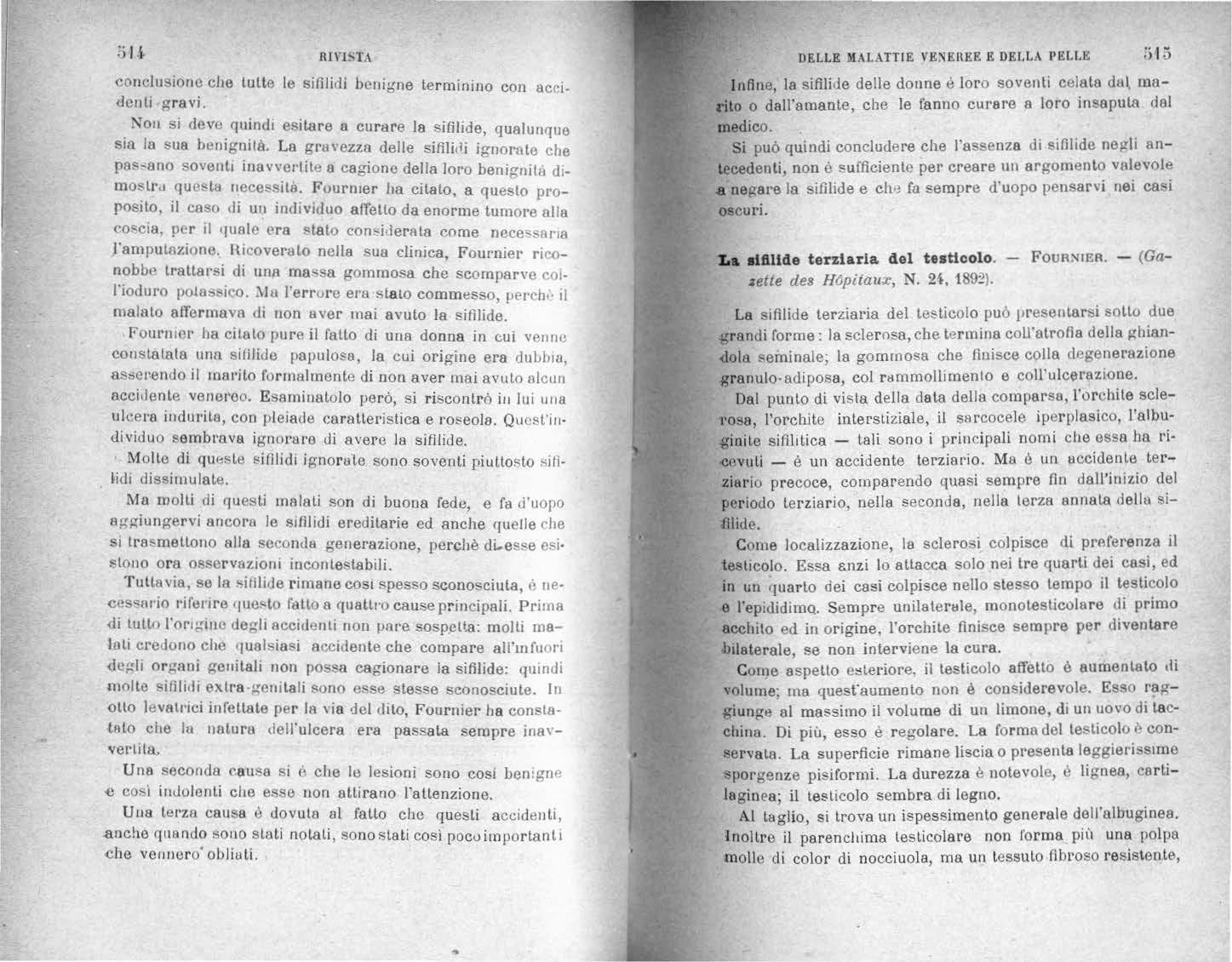
Tull1:1via, se la silìlide rimane cost spesso sconosciuta, è neees..,ol'io rifenre que!-lO f11tto a quattro cause principali. Prima <li tutto de;::ll accidenti non pare sospetta: molli maloti cre,lono che qualsiasi a ccidente che compare all'mfu or1 degli organi genitali non possa cagionare la sifilide: quindi molle silìltdt extra·gerutali sono esse stesse sconosciute. In olto levatl'ici infettate per la Yia del dito, Fourniet· ha constatnlo che lu natura dell' ulcera era passata sempre inaYvet'ltla.
Una seconda ca usa si P. che le lesioni sono cosi e così inJolonli che esse non attirano l'atlenzione.
Uua let•zn causa ò dovuta al fallo che questi accidenti, .anche quando sono stati notati, sono stati così pocvimporlanti ehe vennero ol> liuli.
Infin e, la sifilide delle donne è loro sovenli celala maa-ilo o dall'amante, che le fanno curare a loro insaputa dal medico.
Si può quindi concludere che l'assenza di sifìlide anlecedenli, non è sufficiente per creare un argomento valevole a nega re la sifilide e eh•} fa sempre d'uopo pensarvi nei casi osc uri.
L & sl611de terziaria del testicolo. - - (Ga-
.:ette des H6pitau..e, N. 2i, 189-2).
La sifilide terziaria del testicolo può presentarsi sotto due forme: la sclerosa, che termina coll'alrolla della ghiandola semlnale; la gommosa che finisce colla dl'generazione granulo·adiposa, col rammollimenlo e coll'ulceraztone.
Dal punto di vista della data della comparsa, l'orchite scierosa , l'orchite inlerstiziale, il sarcocele ip erplasico, l'albugioilo sifìblica - tali sono i principali nomi che essa ha rie Pvuli - è un accidente tet·ziario. Ma è un occidente terprecoce, comparendo quasi sempre fin dall'inizio del per iodo terziario, nella seconda, nella terza annata della sifili de .
Come localizzazione, la sclerosi colpisce di preferenza il testicolo. Essa anzi lo allacca solo nei tre quarti dei casi, ed in un f!Uarlo dei casi colpisce nello stesso tempo il testicolo e l'epididimQ. Sempre monolesticolare di primo acc hito ed in origine, l'orchile finisce sempre per diventare b ilaterale, se non interviene la cura.
Come aspello e::stet•iore. il testicolo affello é aumentalo di \'O]ume; ma quest'aumento non é considerevole. Esso ragg iun ge al massimo il volume di un limone, dt un uovo di tacchin a. Di più, esso è regolare. La formo del testicolo'\ conserva La. La superficie rima.oe liscia o pt·esenta leggierisstmc spot·genze pisiformi. La durezza è notevole, c !ignea, cartila g inea ; il testicolo sembra di legno.
Al taglio, si trova un ispessimento generale dell'albuginea . nollr e il parenchima leslicolare non l'orma più una polpa m o ll e d i color di nocciuola, ma un lessulo fibroso resis tente, rMeo, bianco ed anche lattiginoso. Su questo tessuto appaiono raggi tendinei, ipe rtrofla dei tramezzi normali, e tra questi raggi noduli bianchi di apoplessia fib r osa.
Al microscopio, si r iscontra una proliferazione cellulo-fibrosa sovrabbondante. l tubi semin iferi non sono più ta ngenti, ma separati, rinserrali dal tessuto connettivo. La loro tunica esterna è essa stessa ipertrotlzzata, la loro tunica interna si frangia e l'epitelio è degenerato. Gli elementi nobili, soffocati dal lavorio di sclerosi, si trasformano in veri cordoni fibrosi. Le arterie subiscono un lavorio analogo di arterio-scle r osi.
L'esito di sclerosi é, come al fegato, alla lingua. il riassorbimento progr·essivo e l' at1·ofia dell'o r gan o. Nell e sclerosi pArziali quest'atl·ofla può produrre escavazioni. sclerosi totali il testicolo può ridurs i ad un fagiuolo. Istoln· gicamente questo moncone atrofi co non é più che tessuto fibroso puro.
Nella vaginale si può constatare un versamento sieroso o fibrinoso. Ma la lesione più fr·equente é la presenza di false membrMe, sviluppate soprattutto nel cui di sacco inferi o re e che rin chiudo:1o l'epididimo.
L'epididimo 6 interessato in un quarto dei casi, sia che riochiu r<o dalle f'alse membrane diventi rattratto, biancastro, sia che sia affetto da sclero!>i all'infuori di questa peri-epidi· di mite.
Dal punto di ' ' ist.a dei sintomi, l'orchite sclerosa è una intumescenza fredda, aflogislica, indolente, che può rimanel'e latente in consPguenza di questa assenza di reazione. Qua st sempre infatti é il caso che fa scoprire al malato me.nto dei testi col o. Soventi ò il medico che constata quest'orchi le che il malato non sospettava.
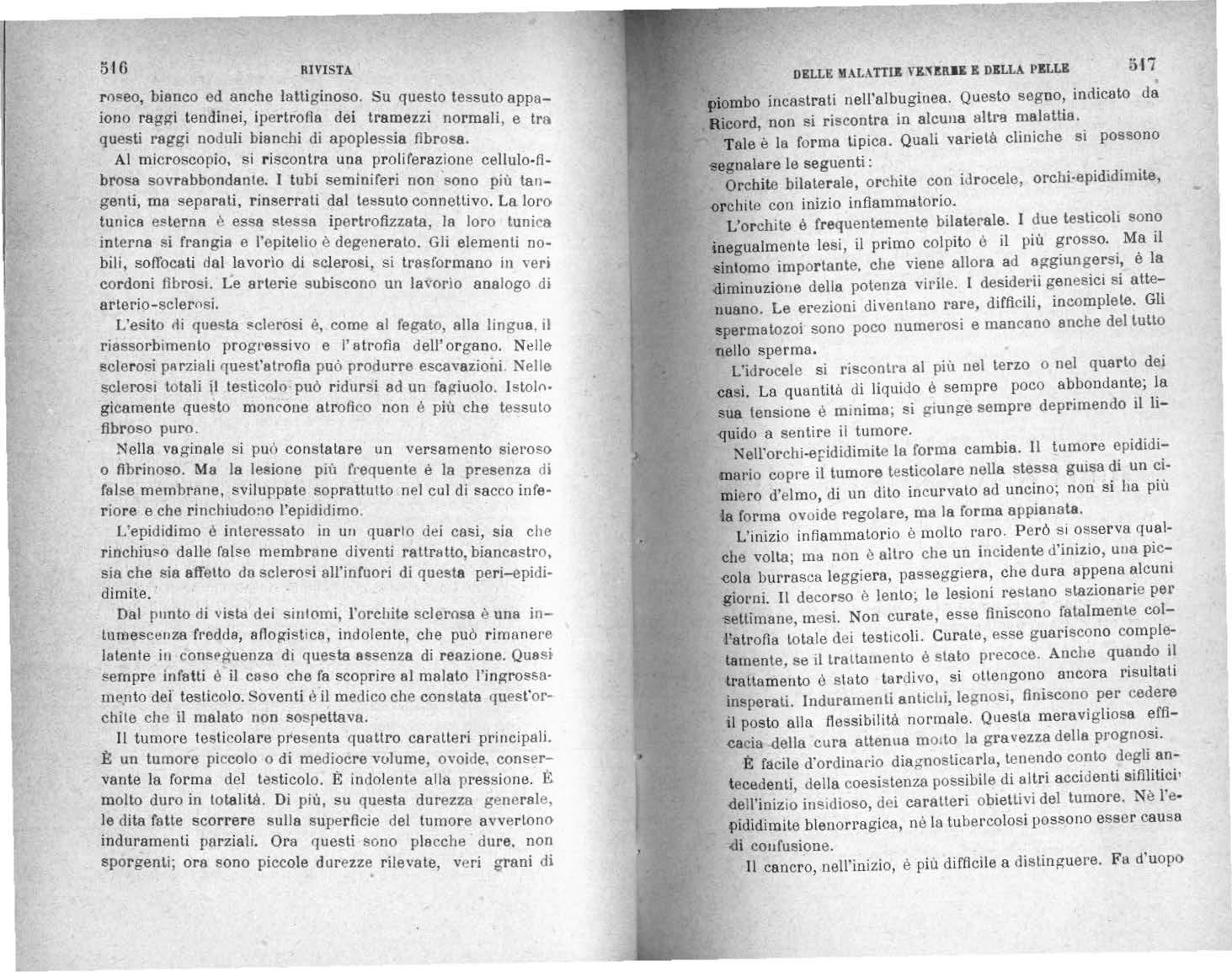
Il tum or·e tes ti cola re preRenta quattro caratteri principali. È un tumore piccolo o di mediocre volume, ovoide, conservante la forma del tasticolo. È indolente alla pressione. È molto duro in totalità. Di più, su questa durezza generale, le dita fatte scorrere sull a superficie del tumore avverton o induramenli parziali. Ora questi sono placche dure. non ora sono piccole d urezze ri levate, ve ri grani di piombo incastrati nell'albuginea. Questo indicato da Ricord, non si riscontra in alcuna aHra malattia.
Tale è la forma tipica. Quali varietà cliniche si possono segnalare le seguenti: Orchite bilaterale, orchile con idrocele, orchi-epididimite, -orchite con inizio infiammatorio.
L'or chite é frequentemente bilaterale. l due testicoli son? inegualmente lesi, il primo colpito 6 il più .. Ma 1l sintomo impor tante. che viene allora ad a::tgiUngersi, é la diminuzione della potenza virile. I desiderii genesici si nua no. Le erezioni diventano rare, difficili, incomplete. Gh spermatozoi sono poco nume1·osi e mancano anche del tutto nello sperma. .
L'idrocele si riscont1·a al più nel terzo o nel qua r to de1 casi. La quantità di liquido è sempre poco sua tensione è m inima ; si jliunge sempre depr1mendo 1! hquido a sentire il tumore. . ...
Nell'orchi-eFididimite la forma camb1a. ll tumore mar·io copr·e il tumore testicolare nella stessa gu1sa ?l un miero d'elmo di un dito in cut·vato ad uncino; non st ha p1u ' . la forma ovoide regolare, ma la fo rma appianata.
L' inizio infiammatorio è mollo I'al'o. Però s i osserva qu.al· che volta ; ma non è aill'O che un in cide nte d'inizio, una eola burrasca leggiera, passeggiera, che dura giorni. Il decorso è lento; le lesioni restano s taz10narte per -settimane, mesi. Non curate, esse finiscono fatalmente coll'atrofia totale dei testicoli. Curate, esse guariscono tamenle, se il trattamento è stato pr·ecoce. Anche tr attamento è stato tardi vo, si ottengono ancora rtsultall insperali. Induramenti antichi, legnosi, cedere il posto alla flessibilità normale. Questa meravrgl10sa e!fieacia della cura attenua m orto la gra vezza della prognos1.
È fàcil e d'ordinaeio diagnosticarla, lenendo t ecedenli della coesistenza possibile di altri acmdentt srfihttci• insidioso, dei caratteri obiettivi del tumore. Nè l'e· pididimile blenorragica, nò la tubercolosi possono esser causa <l i confusione.
Il cancro, nell'inizio, è più difficile a ùislinguel'e. Fa d'uopo
DELLE MALATTI!': E DELLA l'ELLE
ten.e r conto dell 'u.nilateralità, de i dolo1·i laminanti, dell'irregolartlà, della co.nsJstenza dura su alcuni punti, not'male e rammoli tla su allrt, per la diagnosi iel <:ancro. rn tutti · · d bb" · 1 lf · . 1 ca st u 1, m u t 1 cast anche nei quali il cancro paro quasi cet·to sare.bbe u na gt'ave mancanza non tentare il coll:JOduro prima di decidersi alla caslt•azionc. L toduro, la sua d'azione. per la sua effica cia, e un spec1fìco della sciE>rosi sifl litica del tes tiNe t cast molto an t ichi curati taPdivamente é bene assocrat· all'ioduro il mercurio. Come locale venne precontuata un'inti era serie di po mate riso lventi ed anche. la compressione.. consigliarP bagni fr equenlt ed un sospensorw guat•nito con cur·a d'ovatta.










