
45 minute read
EO l NCINEitAZIOl'ìE
JJa;\ti il ricordare che nelle guerre passate per tumulare (e m'l la mente) l 0000 morii si impiegarono sempre non meno di l 0-12 giomi. È qui n li evidente che, costruendo 2 o :l forni nei punti in cui v' è maggior accumulo di cadaveri, il campo ùi ballaglia pot•·euhe essere totalmente ,;gomurato in :;-6 (calcol.mdo pure il tempo ri chiesto dalla costruzione dei crematori). Per s•>prassello sarebhe r·isparmiata alle altre imperiose esigenze della guerra gran parte del personale, che, col sistema delle innumazioni, è indispensabile per· apprestare le fosse.
L'ohbiezione poi, sta la falla all' Heyfeldcr, che coll'incenerimen:o si priva l'agricoltura di un vantaggioso concime, non ha fondamento scientifico, poichè la chimica ci insegna che dai cadaveri in preda alle fiamme svolgonsi cssl'nzialrnPntt• acido carbonico cd ammoniaca e formansi dei nitrati eJ alt ri sali, i quali, se raccolti colle ceneri ed affidati al terreno. restituin•hbl·ro a <JUt'slo, in piccolo volume, i più essenziali elementi pt•r la sua ricostruzione. 1\I a, oltre a non essere esa lta. si può ritenere anche inop portuna. perchè, trattandosi di una nìisura igienico- profilallit•a importante, come sarebbe la cre mazione, e che 1au1o da vi cino la sal ute di intere popolazioni, non mi pare debua il ca:;o di intavolare una questione economi ca, che potreòbe, al postutlo, riuscire di vantaggio a soli pochi la\oratori.
Advertisement
DEl CADAVERI GUEHRA (3 i.3
· una assoluta necessità , poichè le inumazioni non possono esser·e fatte secondo i dellami dell' il!iene. _ 2• Che queste imperfette inumazioni certa dell' inquinamento delle acque e dell'aria, nis$i ma condizione per la mpida diffusione dr terrtbtlr in fett ive. - 3° Che ornai quasi tutti sono co nvinti che i morti oon devono nu ocere ai vivi , e che perciò, qualora si dovesse r icorrere in guerra alla cremazione. non si troverehbero più q uegli ostacoli r.he, nel 181 l , hanno trattenuto il Creteur dal proseguire nella sua praticd umanitaria . lo, come ben avrete notato, non mi sono preoccupato che del lato igi enico della que:>tione, ed ho messo da parte tullo t iò che si riferisce al Ialo sentimentale. D'altronde le buone, to nvincenti arcromentazioni, che abbondano anche a questo c·iguardo, già maestrevolmente svolte ùa altri, fra cui no:iamo specialmente il pl'of. Amato Amatt m 4n suo a rticolo << Sulla cremazione dei cadaveri (l ) :. . n posso però lasciar passare sotto silenzio la considerazione cltc, colla pratica ora da me propugnata , sarebbe assai fa cile, a Jinita, dai vari roghi gli avanzi delle neri lc e rinchiuderle assieme entro un monumemale t he r icordi alle venture generazioni che lì dentro dormono •l sonno eterno mi•,liaia di pmdi. e . .
Esprimo, per ultimo, il voto che quanto. prnna messa dai nostri militari la prau ca della r;lzi one dei cadaveri in guena, e son certo che truesta m1a speranza sarà pure da voi tutti condivisa.
Possiamo, adunque, conchiudere: 1° Che, se Ja trasformnzione ignea dei cadaveri è sempre da preferil'si alla lenta e putrida decomposi zione dei corpi, in guerra poi deve rite-
Uncasointeressante
Probabile Frattura Alla Base Del
Lettura fatta conferenze .scientinche dci mesi di febbrai o c marzo l89i nell ospedale m1lilare principale di Lh·orno dal tenenl!• medico dott. Paolo Pu_eei
Bo sticco Giovanni , soldato del 32° reggimento fanteria , della classe 1870 è un aiovine di 99. an 0 ·, dr· prof · . "' -" , essr one co ntadino. E robusto d'aspetto e di conformazione sch ele trica regolare. Non ha antecedenli nervo si nella famigli a ed ha sempre ndempiuto fin qui benissimo al servizio mil itnre. 1
Nella del :lO dicembre 189 1, mentre, a horù o del l olcerl'ra, SI recava da Genova a Pal ermo, per infort unio di mare dei e delle bolli, travolgend olo e producendogh un'estesa ferita lacero-contusa nel c•entro della par ietal e destra. La ferita a forma d'r. diretta dall'avanti in dietro a ma · · 1 . • · rgtlll mo to contus1 e frast nglw tt, era profonda lino al pericranio e circa 5 cm. J.' ernorl:·'gia fu fortissima e tale da minacciare, nelle prime ore do po l accaduto. la morte per anemia acuta. Non fu subito tentato alcun per liiTestare la pe1·dita del sangue, fino alle l O mattm.o. fermatosi il Polce vem nel porto di Ll vomo, ln1 chramato a bordo a prest are al ferito l'aiut o de ll'arte.
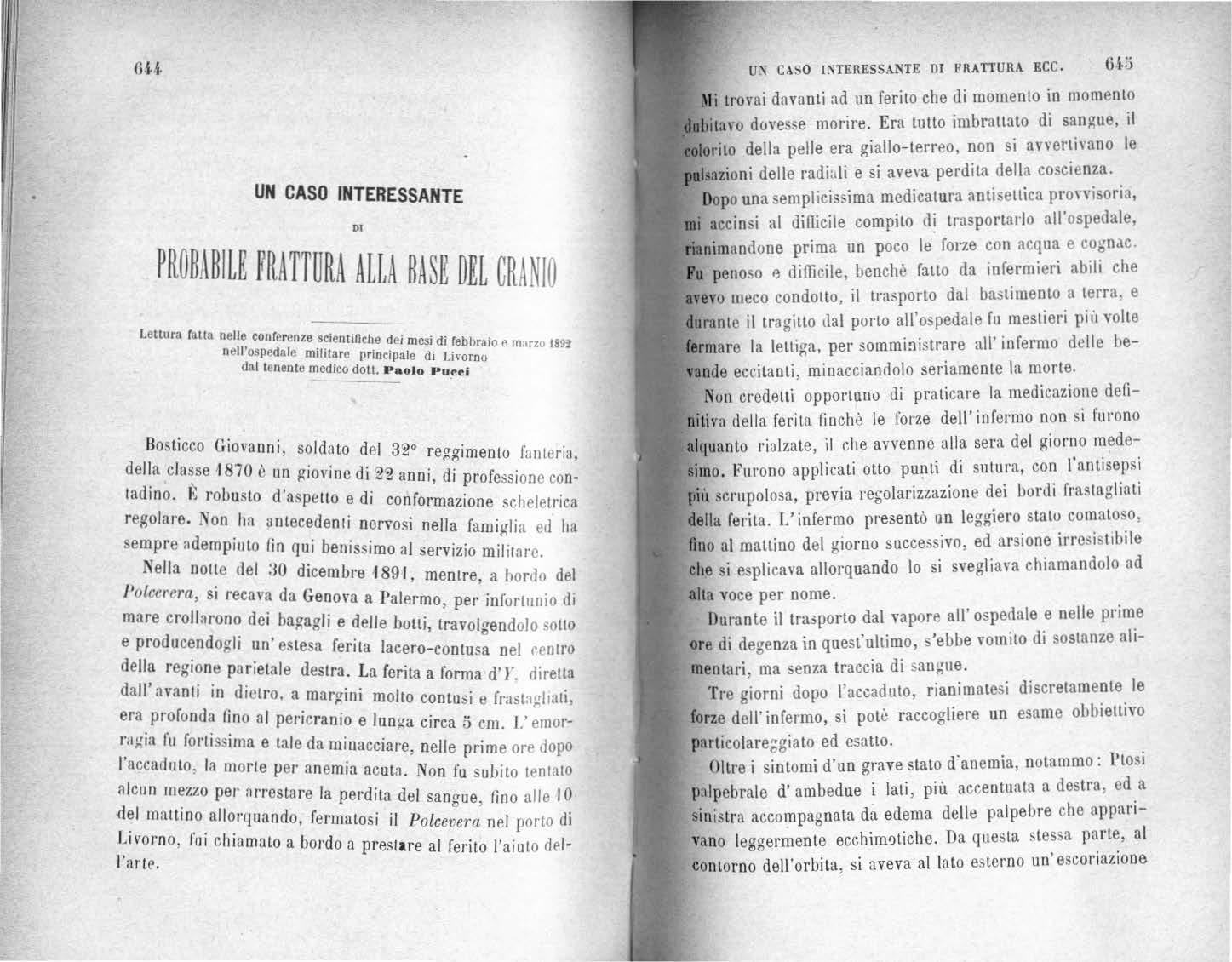
Mi trovai davanti ad un ferito che di momento in momento itavo dovesse morire. Era tutto imbrattato di sangue, il ilo della pelle era giallo-terreo, non s i avvertivano le zioni delle radi ali e si aveYa perdita della cosc ienza.
Dopo una semplicissima medicatura antisettica pro' viso ria, mi accin si al difficile compilo d! trasportar-lo all'ospedale, rianim aodone prim a un poco le forze con acqua e cog nac. ru penoso e diiTìcile, benchè fallo da infermieri abili che avevo meco condotto, il trasporto dal bastimento a terra. e du rante il tragitto Llal porto all'ospedale fu mestieri più volte fer mare la lettiga, per somministrare aH' infermo delle he'ande eccitanti , miuacciandolo seriamente la morte.
Non credetti opportuno di praticare la medicazione deflnitil•a della feriLa fi uchè le forze dell'infermo non si furono alt tuanto riillzate, il che avvenne alla sera del giorno medesimo. Furono applicati otto punti di sutura, con rantisepsi piit scrupol osa, previa rebolarizzazione dei bordi frastagliati della ferita . L' infermo presentò un leggiero stato comatoso, fi no al maLLino del giorno successivo, ed arsione irresis tibile che si esplicava allorquando lo si svegliava chiamandolo ad alla voce per nome.
Duran te il tra5porto dal vapore all'ospedale e nelle p1·ime ore di degenza in quest' ultimo, s'ebbe vomito di sostanze alimen tari , ma senza traccia di sangue.
Tre giorni dopo l'a ccaduto, riaoimatesi discretamente le forz e dell'infermo, si potè raccogliere un esame obbiettivo particolare;;giato ed esatto.
Oltre i sintomi d'un grave stato d. anemia, notammo: l'tosi palpebrale d'ambedue i lati, più accentuata a destra. ed a sinistra accompagnata da edema dclltl palpebre che apparivano leggermente ecchim0tiche. Da questa stess a parte, al contorno dell'orbita, si a veva al lato esterno un'escoriazione su per ficia le. Soll evandogl i le palpebre l'infermo accusava ceci ta completa dall'occhio sinist1·o e quasi completa dal Ùl'stro. Ambedue le pupille non reagivano alfallo allo st1molo della luce. T bulbi erano immobili ed il sinistro alquanto ruotato in fuori. La srnsibilitil generale dell'individu o era molto diminuita, ed egli si mostra,·a continuamente se non si teneva des:o con quaìche domanda. i ave\',1 marcata polidipsia con poliuria e si notava una debolezza dei i ma"ticatori tale da richiellere che gli 'eni ssero somministrati degli alimenti semiliquidi. Nei giorni succe,sivi l'esame obbiettivo ci rivelnva una r.ona analgesica nella met:'1 destra della faccia, in avanti nettamente limitata dalla linea mediana. in bas,;o da una linea parallela al inferiore del mascellare inferiore, a circa poco più di un dito tr.Js\-erso a l disopra di que.:.to mnrgine, in alto estesa lino a tntta In metà destra della regione del frontale ed alln metà anteriore della porzione StJUIIm05a del temporale, in addietro liu11tata da una linea distante quasi un dito lrasverw dal contorno della base dell'orecchio. I n questa zona, mentre il senso dolol·ifico era abolito al punto che si poteva attra\'er·are la pelle con uno spillo, seoz·1 che l' infer·mo sentisse il piil dolore, po1·si$teva il se nso d i pressione pressocht\ normale. Era pure abolito il senso te r mico in qnesta parte. Di più non erano anertiti dalla narice di de"lra i vapori d'etere e Il i ammoniaca , mentre lo erano, e vivamente, da quella sinis trn.
Dello zucchero, dell'aloe e del chinino deposti sulla ruetit destra della lingua non venivnno av,ertiti che dopo un celiO tempo, colla percezio ne del sapo re CUI'alleristico, allorquando mediante la saliva, venivano a co ntatto degli altri punti della lingua. A sinistra, pe1· contrario, si notava ::;quisito il del gusto. La sen3ibilità tauile, dolorifica e term! ca erano af-
Di Fiiattura Alla Oase Del Ih7
abolite nella metà de:>tra della lingua, del palato du r o e moll e e nella ca\ iti1 destra del naso. fari n;;e si avenn o confusi. L'udito era normale in ambedue le part i. Nl' ll a congiuutìva bulbare e pal pehrale e. sulla dell'occhio destro era pure completamente abolita la sensJbilitil tallile e dolorilìca. Era in' cee normale nell'occhio sini:;tro.
Cinque o sei giorni dopo l' accaduto em scomparso de l lullo l'edem'l dell e palpebre a si n:stra e la ptosi, ed il !Julho avev a riacquistato co mpletamente tutti i .::uoi movimenti ; soltanto l' occhio era rimasto completamente amaurotico e con pupill a immobile, le)!germentr dilatatn. Persisterono i?vece a destra la ptosi, la pnralisi completa di tutti i muscol1 dell'nr chi o e l'abolita reazione della pupilla (essa pure legger· mento di latala) allo :;timolo della luce . Mig liorò so lo da que sto occhio la visione. Un ottalmnsr.opico attentamente p111ti calo non ri\•Piò in ambedue gli organi la più piccola alterazi one materiale.
Per la ferita alla testa si ottenne la guarigione di prima intenzione in soli 7 giorni.
Da quell' epor:a fino ad oggi migliorarono grandemente le condiz ioni generali, tanto elle l' infermo p resenta ora un asp etto florido. Persi::;te però sempre polidipsia con poliuria, al grado dn emettere gio r nalmente da i ad 8 litri di or ina, bevendo presso a poco un ' egualé quantità di liquido. Coll 'analisi più volle fatta delle orine mai fu trovata in queste alcuna traccia di zucchero. Per qualità inoltre si r·elativamente ritenere come normali . Coll'o cchio destro attunlmente il Bosticco può distinguere og:gelli minuti, come ad esempio una penna, alla distanza di due metri, e riconoscere una persona alla di stanza di 6 IJ 7 metri.
La pa ralisi dell'elevatore de lla palp ebra è quasi d el tutto risolta e s'incominciano a scorgere dei piccoli movimen ti del bulbo. Ambedue le pupille reagiscono ora agli stimoli luminosi. La zona analgesica si è pure un pochino ristreua. ma soltanto dal lato inferiore e posteriore. È ritornato da molti giorni a de· tra uormale l'odorato, ma persiste l' insensihilitit della schneideriana agli stimoli dolorifici.
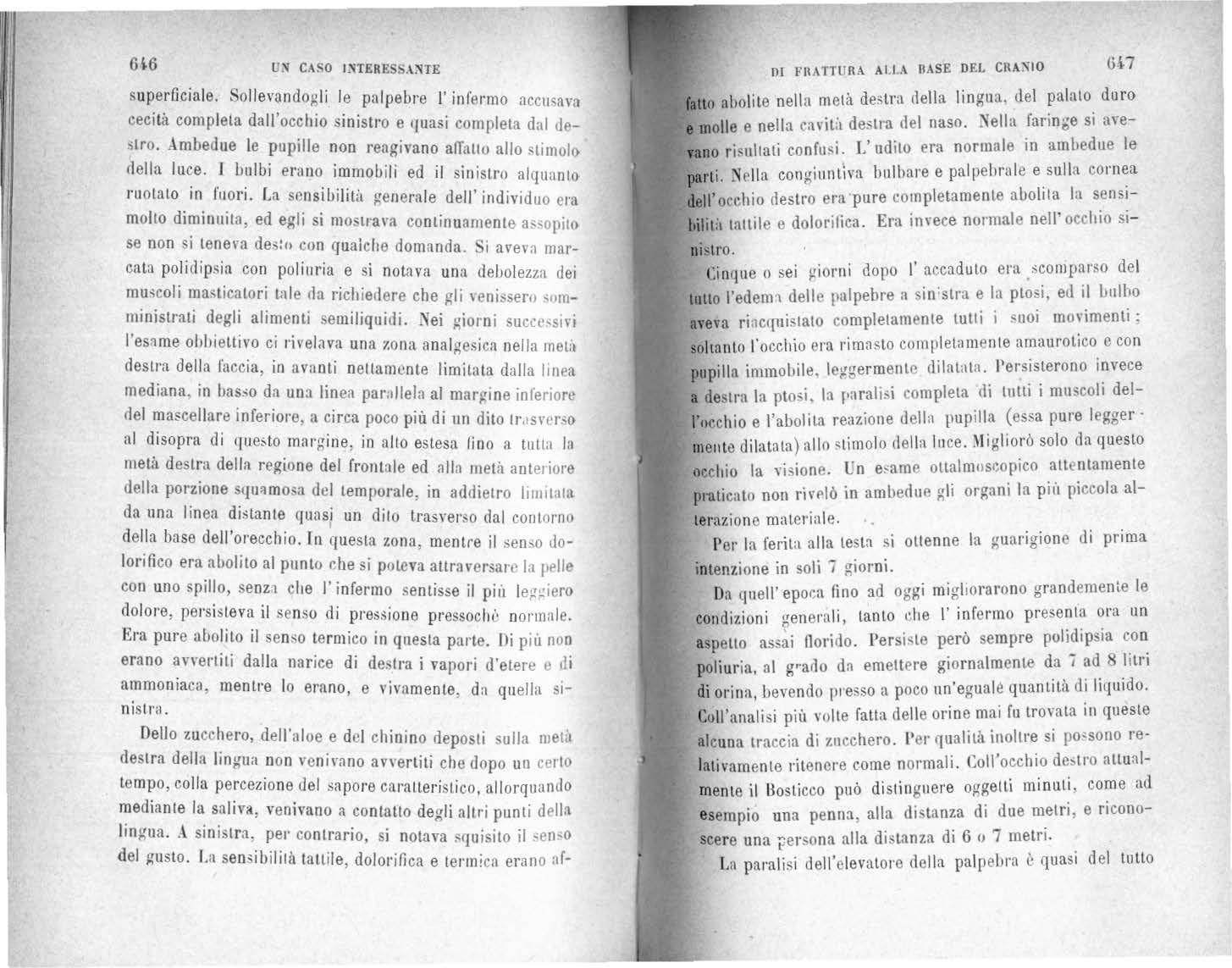
TI gusto è tuttora abolito nella parte a nte riore della metil della lingua. Si notarono nei giorni scorsi dei dislurbi troli ci della pelle e del cellulare sottocutaneo dell a fal'cia dal lato ane;-; tesico. ma sono attualmente scomparsi in se;uito alla cnra stahilitn.
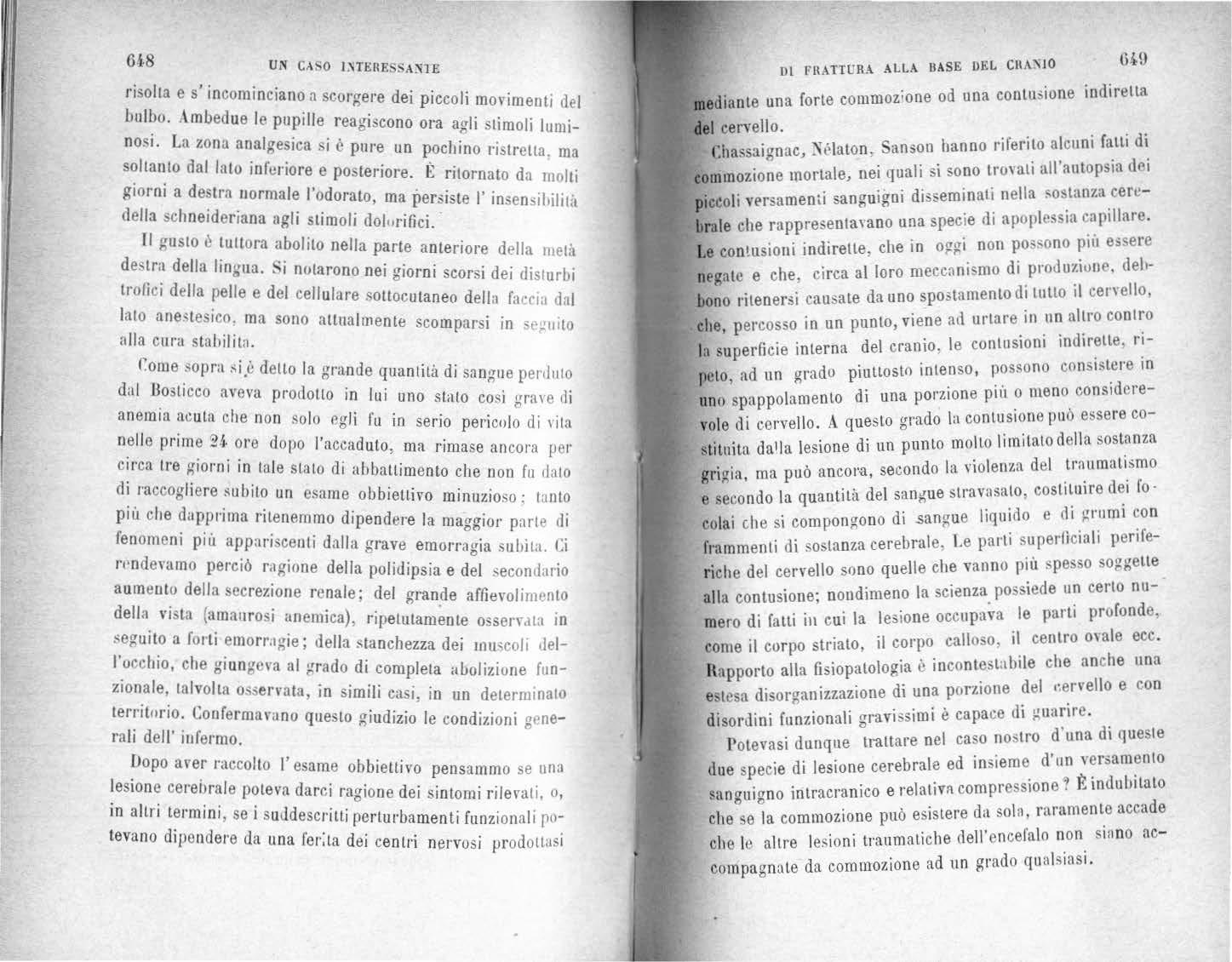
C:ome :;opra -'Ì.c detto la grande quantità di sangue pertl1110 dal Dosticco aveva prodollo in lui uno stato così grlHe di anemia acuta che non solo egli fu in serio pericolo di \ila nello prime 24. or e dopo l'accaduto, ma rimase ancora per circa tre giorni in tale stato di abbattimento che non fn dalo di mccogliere subito un esame obbiettivo minuzioso; tanto p it't che dapprima ritenemmo dipendere la maggior parte di fenomeni più appariscenti dalla grave emorragia subita. Ci rt•ndevamo perciò r<lgione della polidipsia e del secondario aumento della secrezione re naie; del grande affievolimento della vista (amaurosi anemica). ripelutamente osservata in :>eguito a forti emorr..•gie; della stanchezza dei tnuscoli dell'oc chio, che gi on ge ra al di completa abolizione funzionale, talvolta osservata, in simili casi. in un determinalo territorio. Cooferma,·ano questo giudizio, le condizioni generali dell' infer·mo.
Dopo aver raccolto l'esame obbiettivo pensammo se una lesione cerebrale poteva darci ragione dei sintomi rileva ti, o, in altri termini. se i suùdescritli perlurbamenti funzional i pote vano dipendere da una rer:ta dei centl'i nervosi prodottasi t: hassai gnac, Sanson hanno riferito alcuni di. comm ozion e mortale, nei quali si sono tro' ati all'autopsia ÙE'I piccoli versamenti sanguigni disseminali nella .cerebral e che rappreseolaYano una specie di apoplessHt ca p1llare. Le contus ioni indire \te, che io non piir negate e che. circa al loro mecca nismo di dehbono ritenersi causate da uno spo,;tamento drtullo 11 cenello, ch e, percosso in un punto, viene ad urtare. in Ja superfi cie interna del cranio, le contnstonr peto, ad un grado piuttosto intenso, possono consrst:re 10 un o spappolamento di una porzione piit o meno considerevole d i cervello. A questo grado la contusio ne può essere costit uita dalla lesione di un punto molto limitato della sostanza · · p ò ancor·a secondo la violenza del traumatismo gng1a, ma u , . . . e secondo la quantità del sanxue stravnsato, fo · colai che si compongo no di sangue liquido e ò1.gr.umt frammenti di :;ostanza cerebrale. Le parli superficral1 penfer iche del cervello sono quelle che vanno più soggette alla contusione; nondimeno la scienza po5siede certo numero di ratti in cui la le:.ione occupava le partr profonde. come il corpo striato, il cor·po calloso. il centro O\ al e ecc . Rapporto alla fisiopatologia è incontosta hile che anche una disorganizzazione di una porzione del t'.el'\·ello e con disordini funzionali aravissimi è capace ùi guarire.
Dl FltATTURA ALLA BASE OKL CHA'\10 <H9 iante una forte commoz;one od una conllHione indiretta cervello.
Potevasi dunque nel caso no stro d' una di queste ùu e specie di lesione cereb rale ed insieme d'nn Yersamento · · · 1 t' mpt·e'sione È indubilato sangur gno mtracran1co e re a rvn co che se la commozione può esistere da sol n, raramente accade che lo altre traumatiche dell'encefalo non !iin no accompa gna te da commoz ione ad un grado qualsiasi.
Allorquando ai sintomi dell· . . l . . <1 commoz1one ,; 1 aoa· 0 para 1s1, cont 1·ntture conv 1,. • • • nnlun!'l ono ' u ..,lODI ecc. st può dir . ,., che la commozione s·l co l' e In nenerale ' mp rea con un Il . , dell'encefalo :... l a 'o stato moi'IJOso . ' e nos tro caso oltre i . . d' commozione cerehrale . . - l una liere
SI a' e' ano para h- l . . nervnzione eli •· . ::.l ne terr 1IOrto d'in- vali nen l cranici . diagnosi di sempl 1 ·ce .' ' per CIII venne esclusa fa , commozw ne.
D altro ca nto una contusio ne . al non pot ersi ammettere ' - ' la en cefalo. oltre cefalite che si suole e per l.a:.se nza dell'ens mpre man1festare 1 · · . trauma e J' • . a I:UOI g10rn1 dopo il ' per as,enzn d, alcuni sinto m· . · . . . . al cuni patologi. tra cn· N '•l ' rmmedJ.tll ne t filial i ' ' aton, Ban chet S . una grande impol·tnn d' . e anson, I'I[JO'rr·o ' zrt mgnost1ca n · anche pei'Chè la les· d Il ' oo SI poteva amm et tere
, . lODe e 'l SO'l' C b vuto essere tropp , : s a rza cel·e rale avrebb e doo estesa per rntere ·s . . . lutti quei nervi cho 1 . :) nl e 1 centrr di ne nostro 1nfermo ·
[ nfa ti i dali ·• stor ·., SI mostra vane) le:o; i.
• . '" sopra esposta r·- lt l . parai i nel territorio d Il' bU a c te SI ave,·ano e ocnlomotore co d . cente ,, del tro clenr·e ,. d . mune, eli abdu• (l estra· p·• ral . r . olfattivo dello ste " O l· ' lSI unzlonal e del nervo . ' citO C zone a · . rnn ervat i dalle lw•ncl d l . nestesl che nel territori
" Ie e tngem· -
I nollr·e si avev·rno alte . . IDO .--empre a drstra. · • raz10m d' b d . bene. perchè i ··ent . d' . . am e ue ' nervi ottici. Or rJ orwrne tuu· d' _. . stat1 interessati per " 1 1 que::.tr nervr fossero opera de l tr·aum t' , della sostanza cerebrale ._ 0 a ISmo, l alterazio ne avre11 e donllo t d . . . genico lat1 all' · . . . es en ersr a1 rorpr , eminenze '" ''e mme eJ . l . . . che l'icruardava l' ... lte . nf . ar la amr OllJCI, per ciò
" < " r.l la unzrone d . . neno olfattivo E ,. _ ' er nern ottici e df:'l
• • 11:-;petto sempre ni nerv· ..
Levano essere state .· . . , ' otllcJ. non po. 11Spn1 mrate l eminenz n· . . corpt po'cf , l· . .e l;.!'emm e ed 1
' l lC cl retrna nep .. l'impressione lrrm· . pure pm trasm etteva rnosa a questi ce t.· , . . . . . . onde f):tr te l'inl l l · . n n der rrll ess J, l u so costnllorc J 11 . · · l e a puprlla. Oov erano
DI fRA'JTUIIA ALL\ IIASE DEL LRA'HO
Q:j J
lesi i nu clei di sostanza grigia che si trovano scaionati davanti in dietro sotto il 3° ventricolo e sotto uedollo di Silvio, e qu elli che si trovano al disotto dei t ubercoli quadrigemini, verso la ' 'olta dell'acquedotto medesimo, perchè dai primi partono le lilne d'origine dell'ocnlomotore comune e dai seco ndi quell e del trocleare. Dovevansi avere les ioni della protuheranza anulare e dei eo rpi restifo rmi della midolla allungata per il trigemino e le3ioni nel pa,·imenlo del i-0 ventricolo per l'abduce nte. l'na ll'sione co sì estesa, senza d ire che !'arehhe stata acc ompagnata da sintomi diversi , non sa rebbe stata lli certo compatibile con la rila. Si doveva quindi esclud ere affatto una lesion e nucleare. Oltre a ciò in ness un punto della co rona era da pensare che avesse potuto aver luogo un'alterazione della sostnnza nervo sa che si fos se mani fe stata con una simile sintomatologia.
Eliminata l'i potesi d'una lesione cerdbrale avvenuta per commozione o per contusione con secondar ia emorragia. di che cosa dunque si poteva tra Ilare?
L'nnestesia della metà destra della faccia non co n:;isteva soltanto nella diminutione della sen:;ibililit. ma nell'a:-;senza completa di quest'ultima, eò inoltre e:;i ste\'a unn dis soc iazione della sensibilit àsle:>sa. vale a dire che , mentre il se mo latLile era conserralo e soltaulo un poco indebol ito , mancava in ,ece del tutto qu ello dolorifi co . Si co n,.,iù era da mulli fallo come una stimmate i:c-terica. dei se n:;i tro,·ammo ancora qualcosa di più importnnte. L'odorato a sinistra era normale, a de stra non :-i aYVe rtivano 1 vapori dell'etere e dell'ammoniaca .
S'ebbe dunque emianosmia, rarissima fuori dell'isterismo. perchè non è stata o..;servata che in di frattura del frontale e di ncoplnsma riella base. Il gusto prontto co l deporre l'N GASO successivamente sulle due metà d Il r nino o di zucchero . · e a mgua polvere di chi, St mostrava abolito a d t vato a i>i nii>tra . Questa perdita della e conser·· (emiageu.vtia) era aceomp sen:.rbdtta gustati ra . agnata, come suole accad l ,. sterrsmo, da perdit·t della se ··bT . ere ne l tdegli oroani deputa:i Il . n::.t '. tl<t generale della r- ' a n !,ensazJOne oust t' 1 destra n 11 . . . n a tva • ne la meta ' e a stessa gursa che pe l' . . . sensihilitit della . r . st avera in' · nana pet· glt sttmoli fisici

\Il esarne del farin"e s' b•· •
1\' l . . . o e uero sempre risultati cl e fa meta Stn ISlra della f • piit cl 'l , . ' ' aceta SI ave va tperalgesia. Por,o le ' sompltce tatto era percepito dolo:·e. come nn vero
. se mbravano dunque <pwste rslet'tche ? vere st immare sensoriali
Ma. ve n'erano delle altre.
I disrnrhi della muscolatur . forme di d' la de!l'or.chio, le , '' ' s ra tsmo di nista o . e meno caratterist' . . ' omo son o l'ar t ·, ICI. ma pure St possono riscontrare ue.,li accompaguati talora da aresi " modaz 1 one. P 0 paralisi dell 'acro- nostro caso 1 Lt' . . u t queslt dtsturbi esiste,·ano S. . pure amaurosi completa . . . '' a Stnrstra e marcati. · fl' ,. mento della · · »Stmo a te\ o ,_ ' vtstone a destra Or be l' più spesso unilaterale ' · . ne, amaurosi isteriea è soventi ,ofte ' ' ma puo essere ancora bilateral e ed è accompa•rnata come . nel nostro inferm lll')f .' prectsamente si veri finra 0 a a ar.cta da em· · .. soriale L' . ' ranestesra sen sttrvo-sen. es,lme oftalmoscopico non r· l . . . cuna lesione nell'organo . tve a m questi cast al-
Nell'isterismo invltre è cono . . spasmo tonico il q 1 . scmta una spec1e di blefaroua e SI presenta sotto l' . elusione delle palp 1 apparenza dt un'orrospasmo suole e3s:;.r·e: con o fotofobia. Questo hlefae 10 generale accompagnato da disturl1i
DI FRATTURA ALLA RASE DEL CRANIO ():):3
sensibilit i1 . L'occhio suole essere amaurotico e la e la con}(iu ntiva si mostrano beue !<pesso insensibili affatto. Jntom o all'organo finalmente si osserverebbe una zon a circolare di anestesia tegumentaria.
Poichè nel no!'-tro infermo si tali alterazion i, non poterano essere dipendenti da blefarospasmo tonico ed essere anch e questo una stimmate isterica?
E ben vero che le alterazioni de scritte furono troppo immèdiatam enle dipendenti d;d traumatismo u che l'anamnesi remota è prim afTatto"per il nostro infermo di elementi nervosi ma t\ del pari innegabile che uno nervo so fortuito, la commozione provnta per un accidente qualsia si, nn forte traumatismo fh;ico o psichico insomma, può egsere In causa che determina l'i steria in individui per un qualche fallore organi co già predi:: posti alla nevrop:ltia.
Si tmttava dunque veramente nel nostro caso d'isterismo
A prima vista le apparenze c'erano tulle , ma non erano che speciose apparenze: eppure questa fu lfl diagnosi agitata nei primi giorni di degenza dell' infermo all'ospedale. Avevamo pensato ad una le;;iooe non distruttiva emorragica, ma soltanto dinamica. di quelle cioè che l'anatomia non vede, sebbene determinate da un traumati smo.
P rendiamo frattanto in esame ciascuno dei ..;ingoli sintomi raccolti.
È ben vero che, nei casi di anestesia organ ica,' hanno più delle semplici ipoestesie anzichè assenza completa di seosibilitù, come accade nell isterismo, ma in quest'ultimo è caratteristica la distribuzione delle zone ane:;tesiche. che non corrispondono a territori nervosi anatomicamente delimitati. ma sivvero a regioni per cosi dire funzionalmente distinte. Nel caso in discorso era nfTatto completa l'abolizione del se nRo dolorilico , ma soltanto in quelle regioni, co n esaltezza anat on.J ica sta bili te, nelle quali si diram:mo le lre branche IJUinlo, senza che minimame nte l'anestesia avesse inYaso Jl ter r itor.io d'ionervaziooe del nervo grande aurim ed •n. addietro. o quello dei nerri occipitali ma,..gtore e mmore, lll allo. In oltre le anestesie islericlle hanno un 'evol uzione loro propria.
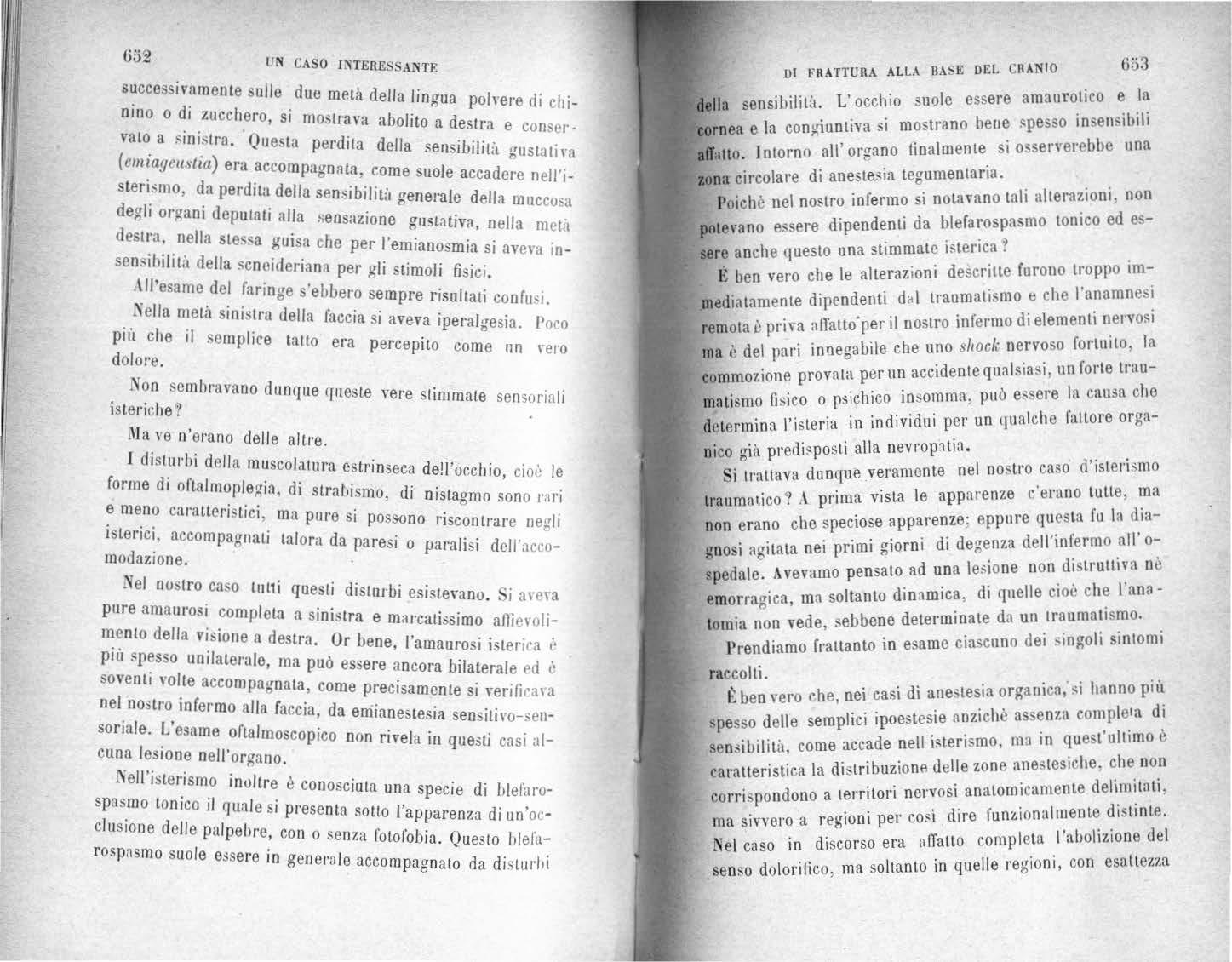
E3se possono manifestarsi bruscameme e cessare del pari come pure bene spesso da un lato passano all o Lempo•·aneamente scompaiono e per un tempo va-
01 FRATTURA ALLA DASE DEL CRANlO ();)i)
oue taltile, men tre i più inLerisi stimoli dolorifici non provano movime nto di sorta, in alcu ni conigli. tagliando la nza bianca del midollo spinale e int:.tti i i posteriori . siringomielia i primi falli mo rbosi in gen erale. prima che si deter mini nel midollo spinale alto na seri a degenerazione. consistono nella perdita della sensiuilitil termica e dolorilica mentre la tallile rimane inta tta.
.
.;'\el la zona anestesica si mostrò per tutti 1 rapporti Ma una delle ca ratteri sti che principali delle anestesre •stenc he è la di ssociaz ione della sensihilitil, che appunto si osse rvava nel nostro caso. Il Bos trcco poteva .quando era to cca to, pr·emendo un poco, non poteva dlstmguere tra il ca ldo ed il freddo e non sentiva nttra\·ersa ndo co mpletamente la pelle con u.no spi llo. l amvava a capire l'abo lizione del senso ùolocon una lesione del trigemioo, ma come si la p ers1s tenza del se nso di pressione?
J n patologia conoscono dei casi di simile alterazione della se nsihilitù. , ulle cica tri ci, ad esemp io , sappiamo che mancano aiTatto i nen ·i sensiti \·i, perchè esse non hanno la str uttura caralte ri ,tica del de r ma, eppure mentre su di es•e man ca no le sensazioni termiche e dolorifiche . il senso Llella pressio ne c conservato discretamente.
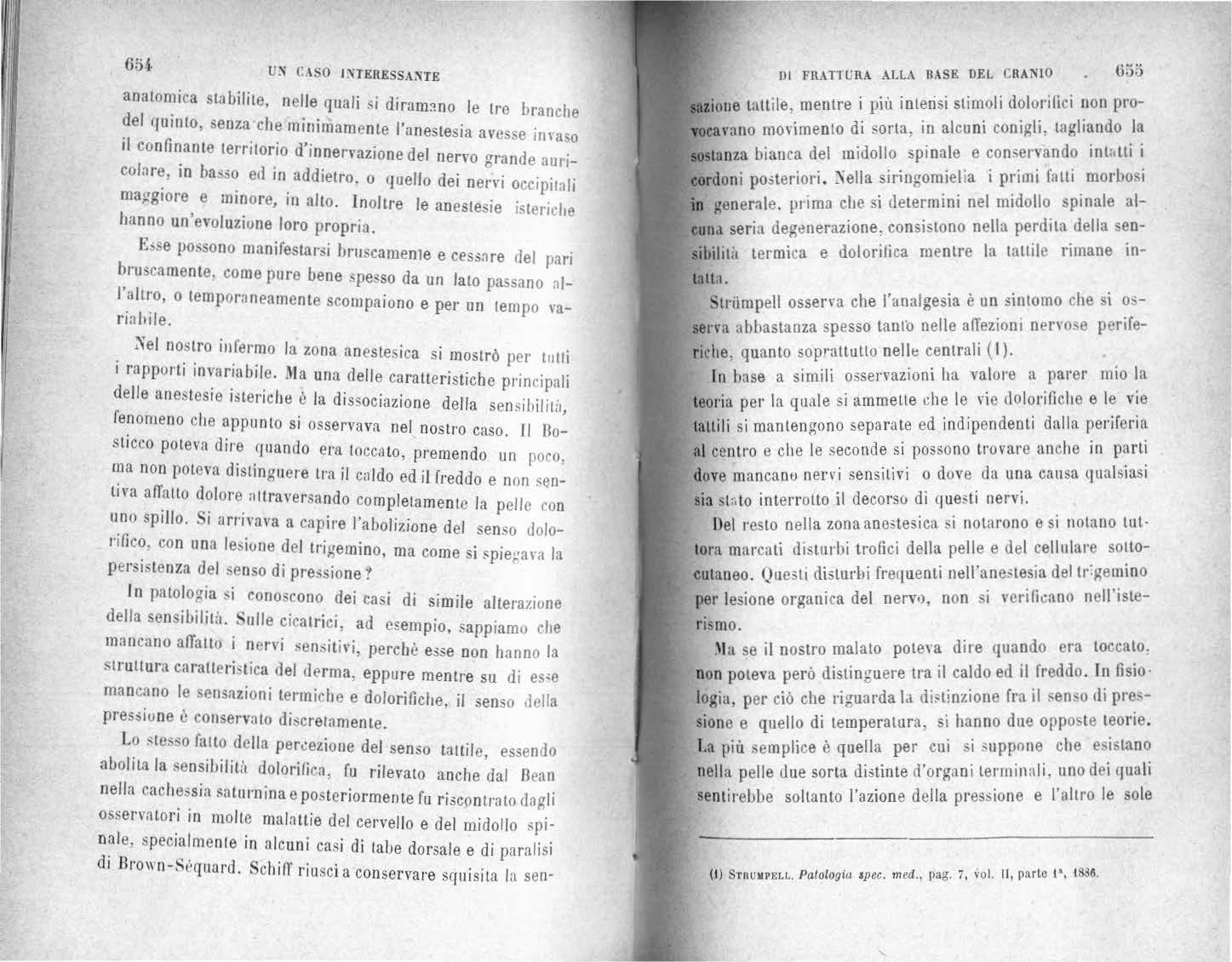
fatto della per-:ezioue del senso tat til e, essendo abolrta la se nsibi litit doloriliea, fu ri levato anche dal Bean nella cac hess ia ::ntu rnina c po$teri ormente fu riscontrato dagli ossen•ator.i in molte mal attie del cerve llo e del midollo spinal e, spec1almente in alcuni casi di tabe dorsale e di paralisi di Br·own-St''qt1a1·cl S 1"Il' · · ' · c li I"IU SCJ a conservare squisita la sen- l.a più semplice è quella per cui si suppone che e:-;istano nella pelle due sorta di3tinte d'o rgani terminali, uno dei quali sentirebbe so ltanto l'azion e della pressione e l'altro le sole
Str iimpell ossena ch e l'analgesia è un sintomo che si ossen·a abbastanza spesso tanro nelle aiTezioni neno-..e perifer khe. quanto soprattullo nell e centrali ( l ).
In base a s imili osserrazioni ha Yalor·e a parer mio la teoria per la qu,tle s i ammelle che le vie dolorifiche e le Yi e tat tili si mantengono sepa r ate ed in dip endenti dalla periferia al centro e che le second e si po sso no trovare anche in parti dove mancano neni seosi tivi o dove da una causa qualsiasi sia stnto interrotto il decorso di nervi.
Del resto nella zona anestesica 5i notarono e si notano tut· to ra marcati disturbi trofici della pelle e del cellnlare sottocutan eo. Questi disturbi freq uenti nell'ane:;tesia del tr:ge mino per lesio ne organica del nerv•>, non si nell'ister ismo.
)l a se il nostro malato potera dire quando era toccato. non poteva però distinguere tra il caldo ed il fre dd o. In fisio· logia , per ciò che riguarda la fra il sen;;o eli pression e e quello di temperatura, si hanno due oppo::.te teorie .
Yariazioni nella temper.Jtura. Cias<"una poi di queste due specie d'orga ni terminali avrehùe lìbre nervee propri e conduurici dell 'im pressione dalla periferia al centro. La seconda teoria, che è stata sostenuta specialmente dal Weber, è rhe gl i stes<>i organi terminali risentano l'azione delle due sperie di stimoli . Il caso nostro starebbe in appoggio della teoria prima in ftH'ore della quale, del resto. nri casi patoloaici \ enuero citati anche dal Brown SéquarJ {1). l') soltanto per la di dati oubiettivi, ci allestino una lesio ne or·;;anica, che i suddescrilli fenomeni acquicarallere di stimmate isteriche. ) la noi vedremo che non mancano nel nostro caso argomentazioni scienlre che ci dimostrano l'esistenza di un ·alterazione orira.
Cosi I'Herzen (t) cita un caso del Cnrpentier nel •rnale, essendo presente il senso tatti le, era abolrto quello dolorilit·o e termi co . Il l andois ed il (3) pure osservaron o in un caso analgesia e mancanza del senso termico, perdurando quello di pressione. Ma il no stro caso tanto piti è interessante in quant o che ta li alteraz io ni si debbono ascri vcr·e a del sistema nervoso periferico.
TI Sothn agcl il Berger (5) , lo Zieh l (6) ed il Pi ck (7) r ipo rta rono c:asi di periferichtl del sistema co n delle se ns ib ilità termica e Lattil e, ed i• appuuto da simi li che si pnò meglio l'esi.;tenza d'organi speciali per il senso Jermico . continuiamo l'esame cr1ti co dei si ntomi L'emianosmia e l'emiageustia da uno stesso lato, se si di frequente nell ' ister is mo. ·possono però anche esser·e determinate da lesi<'ne dei nervi rleputati a que:'ti sensi specific i.
11 mO\'imento oscillatorio dell'occhio ,;inistro in direzioni ·e (nist.1;.:mo), per molti gior·ni. con \Uriazioni rre'l ueut i di grado, poteva esse re determiuato in ma,;sima parte dall' amaurosi completa di quest'occh;o. Lo Zehender (l) riportò un caso di nistagmo unilaterale in un indiYiduo cho aveva dall 'occhio destro un potere visivo normale, mentre dall'a ltro er a divenuto cieco senza cau:;a valutah ilc all' otral·o. Da ques to lato si aveva nistagmo con oscillazione in direzion e verticale. Era questo presso a poco un caso identico al nostro e del genere di quelli determinati dalla grande differenza di potere visivo fra i due orgrni, senza però esc lu · dere che possano pure concorrervi con tempor·n neament e altre cause e-!'enziali, tra le quali. nel caso nostl'o. si potrebbe annoverare la stimolazio ne motrice per dalo e fallo dalla lesione che piu oltre dimo:treremo. t; li altri disturbi della rnuscolatura dell'occhio destro erano Yeram ente dovuti a spasmo puro e semplice O\ vero a paralisi ?
( l ) BROWN·Si:QUARO. J 011r. clt Phys . f,q63, vol. Ili. Arcllives tle Ph!/S 1868, vol. l.

(:t) Pfliigtl·'s A1·c1tiv,
(3) Rèv11e mecl. {r. et ètra uq
(4) Deulsc!us . lrcltl e. f. klln. ,l/ed. 11.
(5) 1\'iener mcd. IVochellschri{t, t 87ll.
(6) Detlluhe mtcl. IVoclten.!chri{t, :-i. 1.7, 1889.
(7) ll'lt11e1· mcd. IVocllen sch i'I(C , X . 18 1888.
Llefaro3pasmo, sia tonico o clonico, la p.tlpebra or,linariamente vibra. quando si tenti d'aprirla. i• fortemente raggrin zata òalla contrallura ed oppone una ·certa resistenza ad inualzata .
Per l'ordinarìo inoltre la contrattu ra dell'oruìcolare t\ ac-
UN CASO iNTERESSANTE
cornpagnata da spas mo dei muscoli dal lato corri:'pondente ,Jclla fa ccia. Charcot ha notato pure che il sopracciglio, nel blefarospa:;mo tonico, appare abbassato rispello al lato ,ano. mentre per l<l ptosi p:u·alitica al co ntrario è innalzato.
Or bene, tulli que:>ti caratteri del blefarospasmo qui fanno difetto, cd invece dell'abbas:>amento del sopraccigli o del lato ammalato. che non lo si trova mai nella plo.;i paralitica. ,j nota uu elevamento del medesimo.
Inoltre le pliche \et·ticali dell'elevatore del sopracci,.dio non si osservano e sono invece più marcate dal lato ammalato le pliclte trasversali della fronte per opera del muscolo frontale.
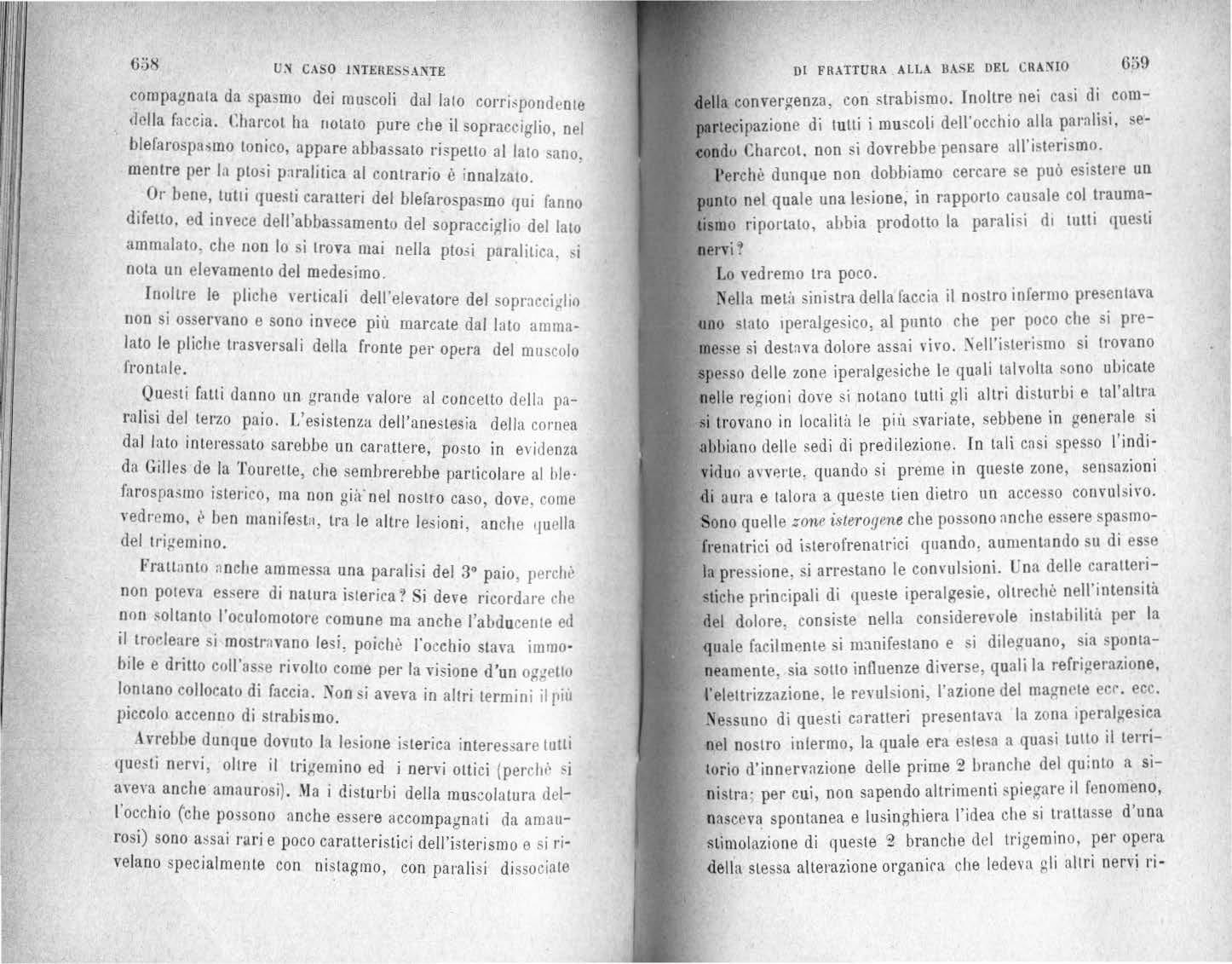
Questi fatti danno un :.;(mnde valore al concetto della para lisi del terzo paio. L'es istenza dell'anestesia della cornea da l lato interessato sarebbe un carattere, posto in eYidenza da Gilles de la 'J'ouretle, che sembrerebbe particolare al hle· farospasmo ister·ico, ma non giiL' nel nostt·o caso, dove, come Yedrcmo, ,; ben manifestil, tra le altre lesioni , anche ,1uella del trigemino.
Frattanto anche ammessa una par-alisi del 3o pai o, percht• non poteva essere di natura isterica? Si dere ricordare dJC non :-.ollanto l'oculomotore comune ma anche l'aùducente ed il lrorleare si mostra vano lesi, poichè l'o cchio stava immo · bile e dritto C(JII'as'e rivolto come pe1· la visione d'un o•• ·,ello(In lontano collorato di faccia. Xon si aveva in altri termin i il più piccolo accenno di strabismo.
Avrebbe dunque dovuto la lesione isterica lutti questi nervi , olt re il trigemino ed i nervi ottici (perrltt'> avera anche amaurosi). ) la i disturbi della muscolatura dell'occhio (che pos so no anche essere accompagnati da amaurosi) sono assai rari e poco caratteristici dell'isterismo o si rivelano specialmente con nistagmo, con paralisi dissociale
DI FRATTURA ALLA llASK DEL CRANIO 659
4Jell a convergenza , con strabismo. Inoltre nei casi di compartec ipazion e di tuili i dell'occhio alla pa1·nlisi, eondu Charcot. non si dovrebbe pensare all'istE'rismo.
l' erchè dunque non dobbiamo cercare se può esistere un pun to nel quale una le:;ione, in rapporto causale col traumatism o riportato , abbia prodotto la dt tutti 11uesti
Lo vedrem o tra poco.
Nella meti1 sinistra della faccia il nostro infermo presentava un o 1peralgesico, al punto che per poco che si presi dolore assai vivo. si trovano delle zone iperalgesiche le quali talvolta !'ono uhicate nell e regio ni dove si notano tutti gli altri disturbi e tal'altra si trovano in località le più svariate, sebbene in generale si .a hbi ano delle sedi di predilezione. In ta li cnsi spesso l'individu o avvP.I'te, quando si preme in queste zone, d i a ura e talora a queste tien dietro un accesso convulsivo. Sono quell e z-ow• isterogme che possono nn che essere spasmofrenatri ci od isterofrenatrici quando. aumentando su di esse la pressione , si arrestano le convul sioni . Una delle caratteristiche principali di queste iperalgesie, oltrechè nell'inte n5ità del dol ore. consiste nella considererole instabili tà per la q uale facilmente si manifestano e si ·ia spontaneamente , sia sotto influenze diverse, quali la l' elettrizzazione. le revul-;ioni, l'a zione del ma:.tnl'le ecr . ecc. di questi caratteri presenta\':\ la zona iperaiJ.!esica nel nostro infermo, la quale era a quasi tutto il tenitorio d'innervazione delle prime 2 brnnche del quinto a sini stra· per cui, non sapendo altrimenti spiegare il fenomeno, na scrva spontanea e lusinghiera l'idea che si trallasse d'una slimolazione di queste 2 branche del tri gem in o, per opera. della stessa alterazione organica che ledeva g li altri nervi ri - cordati, non al grado da produrre una nevralgia, ma soltanti) uno stato eretistico del nervo. D'altra parte non saprt!i qu al valore potesse avere il conceuo che si fos"e aumentata la funzionalità del di sir:i::tra (con aumt>nto della sensibilitil) per il fatto che a dema questa funzione era stata aholita. Si hanno, è vero, pei sensi dei fatt i di campenso da una parte per l'abolizione di nn senso dall'altra. ma io credo che qui :;iamo in no altro ordine di d'idee.
.\ d ogni modo, per concludere, ritengo che notata nel no::.Lro caso non si potesse affatto considerare come stimmate isterica.
Quale dunque dt>veva essere la lesio ne avvenuta nel no,tro infermo ed in qual punto doveva essere Ritenni che si trallasse di frattura, con emorragia secondaria ;dia base del cranio. si permetta no io di questa diagn osi, alcuni ricordi anatomici . .\i lati della sella turca, in corrispondenza del seno cavernoso, l'ocul(lmotore comune iÌ trocleare e l'abducen te, insieme riuniti , penetrano in nn seno della dnr·a matlre e contraggono tutti aderenza colla prima branca del 'luinto (la 'lUale pure viene a r·aggi ungere il seno ca,·erooso) e col nervo gran simpatico . I l chiasma dei nrrvi ott ici poggia sulla lamina quadrilatera, che si trova immetliamente a l davanti della sella turca, ed i suoi tratti ottici passano al disopra del punto in cui il 3°, 4·0 e ()O paio dei nervi cranici sì tro' ano nel seno della dura madre. L'o ri gine apparente del nervo olfattorio è· all'estremità interna della de l Si lvio, co n tre cordoni di radi ci (<ii cui il med ro i• grigio). L'estemo di questi cordoni è in ra pporto col ganglio olfaltivo nella fessura del Silvio, l'interno col le cellule della parte media del cervello, al davanti del chiasma, ed il colla sostanza perforata anteriore. I n virtù di
01 rlt .\TTURA ALLA UASE DEL CR\'NlO d isposizione le tre radici del nervo si. esge pure al disopra del corpo dello sleoo1de eù tam ente al davanti della lamina <ruadrilatera. t o due rad1c 1 del dai lati detl:\ protuberanza anulare, l_a part e di que:;ta , si portano senza unH'Sl, snll'npil'e della rocca del temporale. sulla !'Canalalllr a che ivi esiste. ed arri,'a te sulla faccia superiore della rocrn, In radice sensitiva forma un ganglio (ganglio nare ùi r.asser·) che sta al della dura madr:, mi lil interna della superlici e :.uper iore della p1ramrde. m un o spnio cavo (cnuum Jf eckelii). . .
Premesse queste annotn;,ioni ù'anatomta ved1amo cosa ceder ehbe se una frattura interessasse il corpo dello sfenorde. Per la sporgenza e relntiva co mpressione qualche frammento osseo e per la compressio ni' determmata dallo stravaso sanouicrno si capisce com e facilmente Yerrehbero ad n o , . . · è ·l 1o C) O 30 e!\sere intere ssati ttltLi i ner·vr surncordatr e ero 1 , ... · · ,4.0 e 6°. nonchè la pr ima branca del 5°, che si trovano, con le toro li hre d' origine apparente, come il l o paio. o con la porz ione intracranica, tutti intorno al co rpo della sfeno1dc. Naturalmente la lesione di questi nervi poteva essere prevalente a destra 0 a o soltanto a destra o a !'inistra. a seconda che la frallura estendeva più da una pa:te che dall 'altra. Nel nostro caso avrebbe dovuto estendersr "iormente a destra, e l'emorragia seco ndaria. al disotto della dura madre , avrebbe dovuto esercitare a una com pressione anche sul ganglio di Gasser e sulla .radrce tri ce che si trova al di dietro di questo, l'una e l altro al disotto della dura madre, come sopra si è detto; o 3ivvero la compres-,ione avrt>bho dovuto a''cr luogo su lla 2a e. 3• br.·anca del :)• e sulla radice motrice, in corri!;pondenzn de t fo ri roton do ed ovale, quando l'emorragia si fosse fatta strada, come è logico pensare, nella parte più declive cioi· nella fossa sfenoidale. '
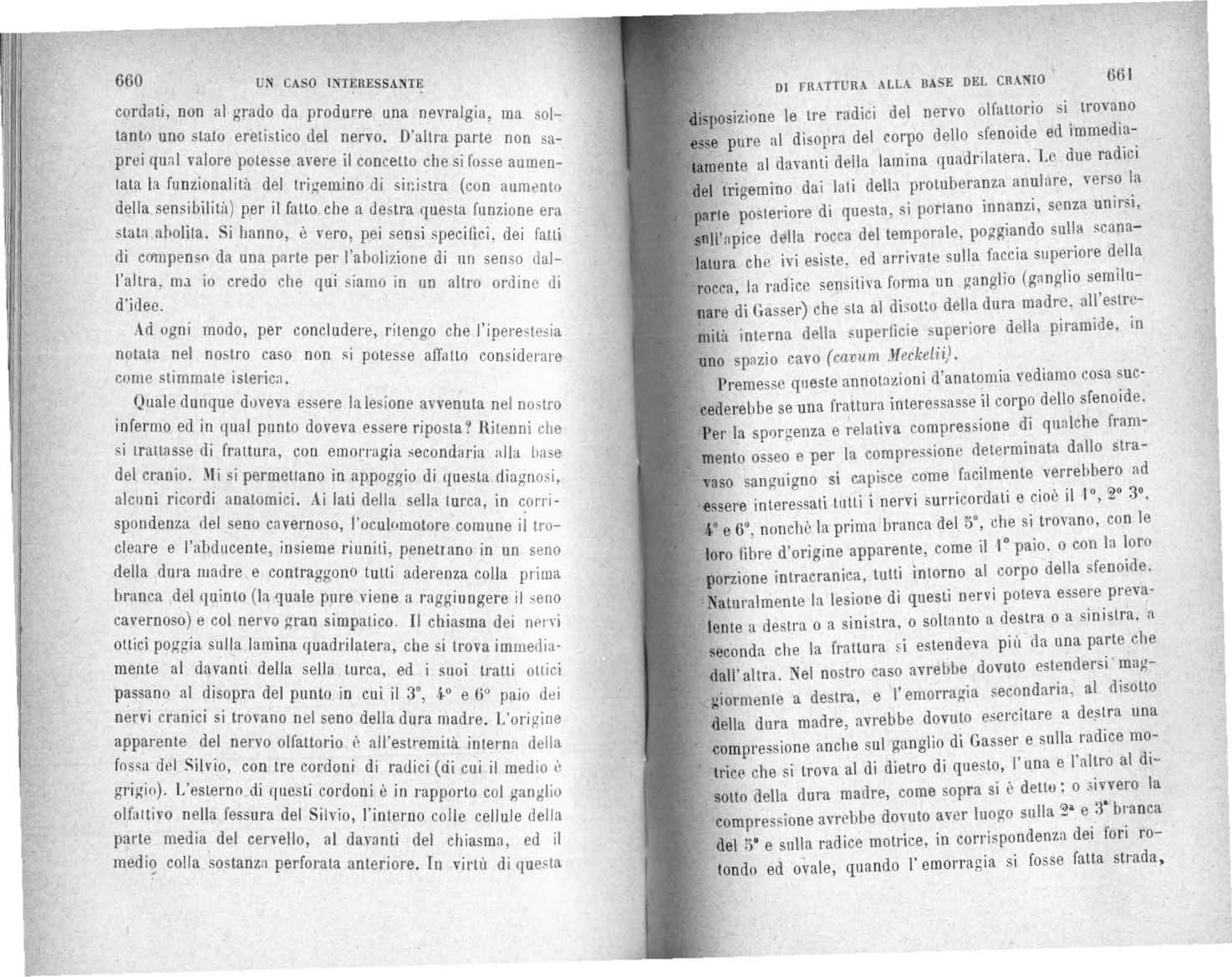
Quali sar·ehbero stati, ammessa questa lesione, i disturbi alla periferia? Paralisi nel territorio degli oculomotori e del trocleare di e ttui n•ii ptosi palpebrale e imm obilità del bui bo e della pupill a destra: perdi la dell'odorato da qot>st. 1 stes:>a parte pc•r· la lesione dell'olfattorio de,.tro. ed totale del trigemino; 'tuindi insensibilità a dewa nelle regioni innervate dal frontale rsterno e dall'epitrocleare (meti1 destra della regione frontale). dal nasale interno (insensiùiliti\ della par·te :;upcriore della cavità nasale e della pelle della punta del naso), dal lacrimale (porzione esterna della c·onbulbar·e), rami lutti della r• branca del quiuto .
Anestesm nella (:Uancia e nell a parte anteriore della re:.: ione temporale perchù in queste regioni si d iramano il nen·o or· hitale (che dtt il ner\'o sottocutaneo della guancia ed il ramo dell' ed i.l appai'Lenenti all<ì - branc,t del qumto. I nsensrbd1ta della muccosa della metà destra del palato duro e molle e della porzione inferiore della cavità nasale, come territori d'innervazione de' r · r · · r amr JarJO,!er, del nervo sfeno-palatino c del nervo palati no, rami sen-iti' i tutti che emanano dal ganglio sfeno·palatino di ) Ieckel. il quale riceve la radice :-;ensiti,·a dalla 3• branca del tri "emino. Si doveva inoltre avere insensibilrtù della metà delh pe:cht' inner·vata dal linguale, e finalmente paralisi o paresr der muscoli masticatori percbè animati dai nervi masseterino, temporali profondi e pterigoidei interno ed che appa r tengono alla 3• branca del quinto ed alla radice l_e q;:;ali, prima di uscire dalla cavità del cranio, s i unrscono 10 un solo fascio eire al punto d' us<:ita si di vii! e in due gr·uppi dei ttuali l'esterno, co ntenente la maggiore copia
DI FHATTURA ALL A BASE DEl. CRANIO
.dei Jilamenti della mdice motrice del trigemino. fornisce a preferenza rami motori, che sono i Or bene: nel nostro caso le regioni colpite erano appunto quell e, e soltanto quelle, nelle quali l'anatomia vann o a dir.1marsi i nervi ramment·.ti, per cui la rlrag no-.1 era pienamente co nfermata dai dati an.rlomici.
Heia ti\ amente al disturbo della vista nei due occhi sr dove' a ch e l'alterazione non dove:,>se intcre,sar e unicamente il tmtto oltico di destra, che altrimenti a' remmo doY uto avere emianop:)ia al lato ma inYece ti chiasma stesso, con alterazione prevalente dt>lle lihre che anda' an o a co5Li tuire il ollico sin i5tro, pro l ucendo l'amaurosi rompl ela soltanto da questo lato.
La pup illa sinistra per·chè dapprima non aiTatlo sti moli della. luce e perchè ora ì• tornata di nuovo a reagire'! Perchè, in principio della malattia.lrt retina , in seguito all' alterazio ne suhita fibre componenti il nervo ottico, 11 011 era più cf.pace eli trasmettere le impressioni luminoso a c1uei centri dai quali parte l'impulso costrittore della pupilla , il che può ora avvenire perchè l'infermo incomincia a ve· dere qualche ombra da que:;t'occhio e ad a\vertire ;!li "tirnoli d"u na luce intensa. come si poteva l'abolizione del del Dtlll a metà destra della lingua? Il glosso faringeo non ar ri,·a alla fossa media della base del cranio. Es;;o. innanzr al fi occo del cervelletto, si dirige rerso la parte anteriore del forarn e lacero-pogteriore. Questo nervo quindi non deve e:-;sere leso nel caso nostro. Secondo Panizza il glo:-;so-farin;.:eo sar·ebbe stato il vero nervo gustativo della ling ua, mentre le r·ice rche di T. e Longet ammettevano che so lo il ramo lin guale del quinto avesse sensibi litit gustativa specilica e cile il glosso-faringeo fos:;e so lta nto un nen•o taltile . .\ nche l'e- sporienze di \ olkman si oppone1•ano all'opinion e di Panizza. :\f uller inoltre riteneva che anche i rami palati ni del quinto fossero capaci di trasmellere impressioni gustative. La attualmente ha slaùilito che il rrfosso-farinrreo fornisce la parte posteriore clelia lingua , ed i; taglio di il gu,;to in quella regione; e che il lingual e drstrllrursce nella parte anteriore , e la sezione di prira questa del Era precisamente quello che ai'I'Pilil·a nel nostro infer·mo. il t[uale aveva spento IJUe;;to se nso specitìro sulla metà destra della lingun in avanti. e svltanto sulla ltase della ste:>sa, co n un hreve ritardo, avvertiva il saport- delle soslao;r.e iv i depo:'te. Si spiega va il ritardo ammetten do d te a for·m_are il senso del gusto concorrono anche i rami pahtini del qurnto che nel nostro caso erano essi pure lesi.
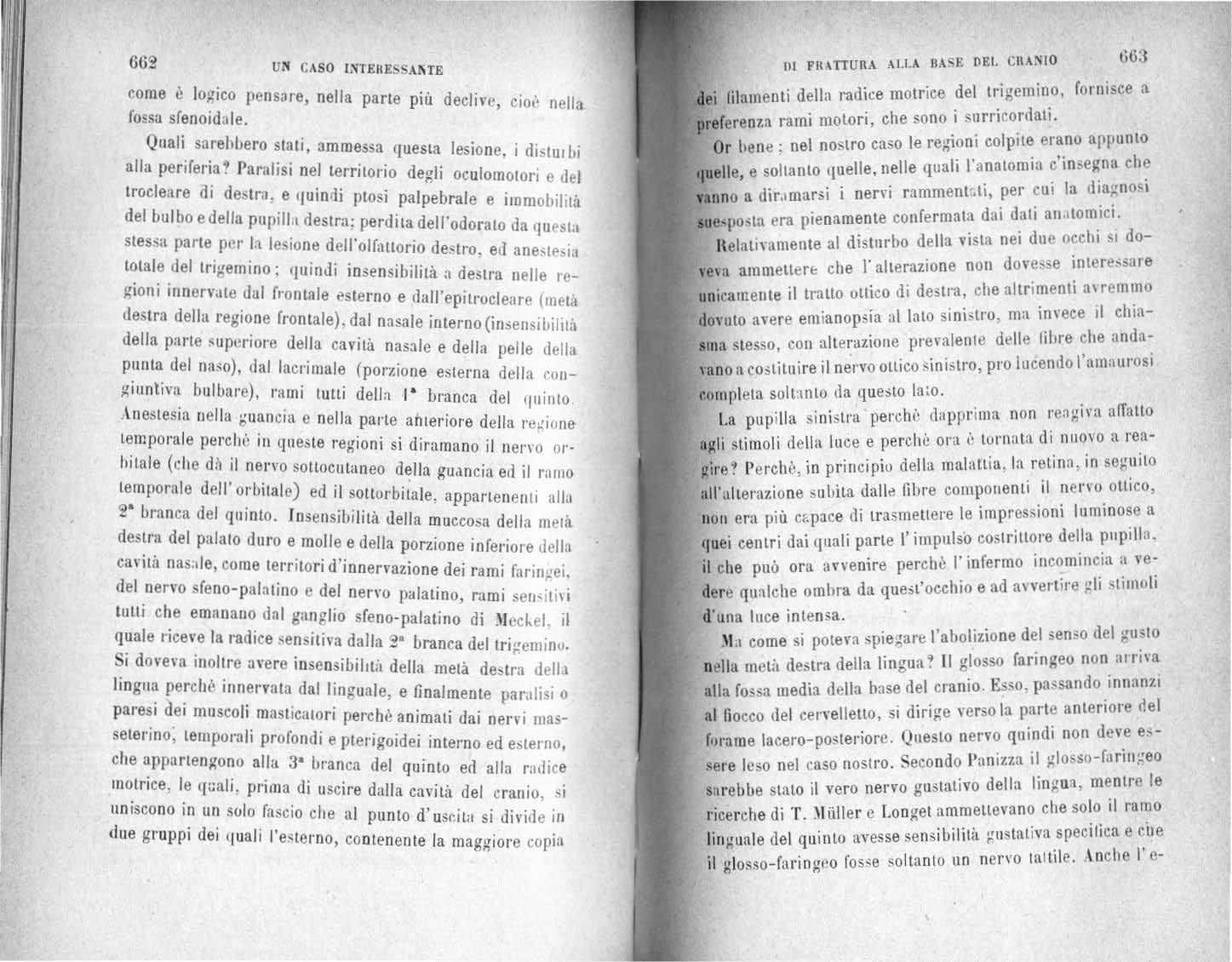
Fu molti suggerito che le fibre gustatorie del lin guale dal chorda-tyrnpani e cbo le fibre del lin ).!ua le che dal I[Uint(' se r·vissero esclusivnmente prr le del tntto. Furono addolli molti ar·gomenti pro e contJ'O queMa opinione. TI nostro è nn caso di più che depone contro lJUesta teoria , dorendo assolutamente escludere una le-ione del facciale.
Come spieg:u·a la poliur·ia ammettendo la le:>ione descritta fn sel-!uito alla nota scoperta di Claudio Dero arcl si venne a co nosr.>re che dopo la puntur·a del 4o venlricolo, allo rquando la punta dello cade fra le ori.,ini degli acustici e t[uclle dei vaghi, l'orina degli animali ;onliene (glicosuria), che quando la pu nta cade un po basso si ottiene una semplice poliuria, e (1uando cade PIU rn alto. albuminuria . Nel nostro caso non si arem zucchero od nlbumina nell'orina, ed inoltre ilovevamo a priori esc ludere una lesione del 'i·0 ve ntr icolo. R itenemmo invece che si trattasse 1·eramente di diabete insipido, a proposito
Dl FRATTUR A ALLA BASE DEL CRA NTO v del ,1uale sappiamo che la sede an:.Lomica della lesione C<'n· è ignota, come pure sappiamo che le sue cause_ sono tuttora qu1=-i del tullo sconosciute. )l a tra quelle che st sCino ri ntracciare con frequenza si annovera no 1 patemi d'animo, le commo1ioni e le in . genere del cervello. I tumori e le e:>ostosi base del cranro pure stati ri conosciuti causa della poliuria. deve duntrue sor · prendere e molto meno deve infirmnre la formulata se non sappiamo dire in qual punto dell'encefalo ha luogo la che dit la poliuria al infermo. Ci basti sapere che fJu esta si verifica con una certa frequenza nei commozione o di lesioni in genere del cervello, e che lesrom di pun ti differentissimi di Cfuest'organo si sono viste dar luo go a modificazioni nella natura e nelb quantitit dell'orina sa .
11 decorf'>o della malattia confermò In nostra
I nn anzi tutto, oltr echè dai sintomi suddescritti, la di fr attura alla veniYa avmloralll dalla conosrenza della causa violenta che aveva un'e:>tesissima ferila laeerocontnsa alla testa nella r egiòoe parietale destra. La della lesi one era tale che questa fu compatibile colla' ita, ma nelle prim r ore dopo l'accaduto dubitavamo che di in mo mento il ferito dovesse morire. tanto Elrano gra\ 1 le sue con tliziooi. Yi furono fenomeni di commozione e polidipsia con poliuritl.
È notevole il falt(•. che allorquando mi recai a bordo del Polcerp1·a per raccogliere il ferito e le medir.ature. sebbene lo avessi tronto tutto tmbt·auato dt sang ue, potei argui r e che non erasi veriOcata emorragia dall'oreccltio, ma soltanto dal naso. Per vari giorni però, dopo l'accadu to, asslli spesso notammo lo scolo di un li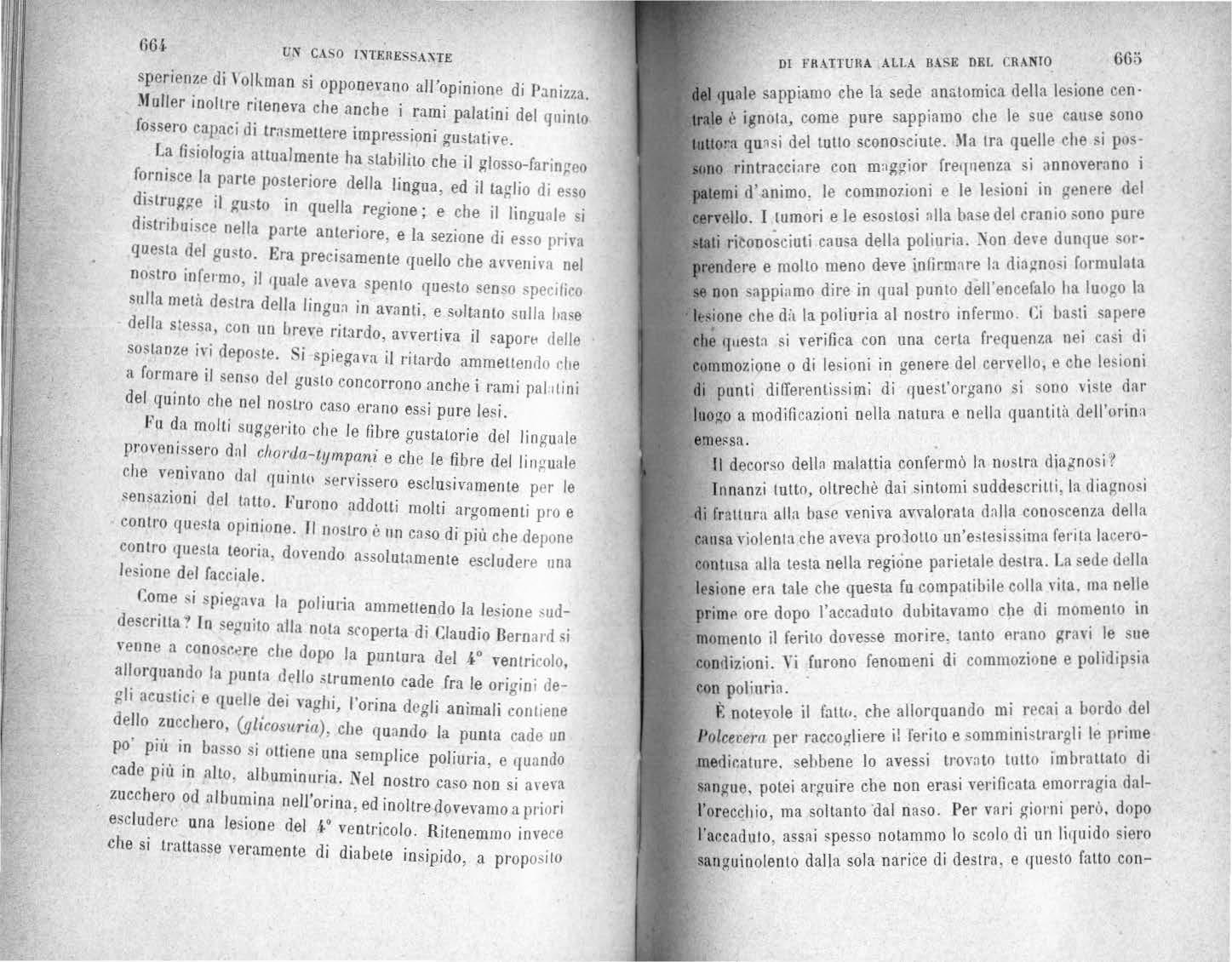
Furono i primi a scomparire i fenomeni di paresi dei muscoli masticatori, perchè la radice motrice del quinto era quella che in ques to caso doveva essere meno delle altre porzioni del trigemino, sia perchè prot etta dal ganglio eli nel cavum Meckelii, sia perchè esce tlal cranio in urr punto più lontano, rispetto alle pr imr due brnnche. dalla sede della fratlura.
Dopo questo sintomo il secondo a scomparire fu J'ernianosmia. ed infatt i le fibre d'origine appar·ente del nervo olfattorio dovevano essere le meno interessate, e sollanto indireltamente, dalla lesione, perchè più in alto ed in avanti deglr altri nervi.
Qu el grado leggiero di ptosi palpebrale a sinistra, notaio nei primi tre di malattia, si doveva attribuire a edema della pnlhehra superiore, secondario a cont usione della parte. perchi'. oltn' ad essere IJuella tumefalla, si vedeva un a piccola e5coriar.ione al contorno e5Lei'Do dell'orbita . .\l a una lieve mat•chia echimotica orbilaria deponera pii! a favore di una fl'Ullura della hnse, sebbene, non app :1rendo il san)?u e :'OliO la co ngi untiva ocu lare, questo segno non avesse un 'alore cerro.

Per molti giorni rima se r<J stazio narie le alternzioni nora rr solo mi gliorarono sempre progressivamente le co nd itioni li dell'infermo. Si notarono nelle regioni anestesiche i di nu trizione e specialmente alla guancia ed al condella narice di dP.slra, ma furono combattute colla corte , 3 1vani ca e con frizioni di azione ,;timolantesnlla pelle. però non si lìnorn disturbi trofiei im portanti nell'occhio destro, nè seg ni di cheratite nevroparal itica. Il visus dell'occhio destro lìno a poter distinguere anche oggetti mmut: e monoaeere le persone. L'occhio sinistr·o, che si era mantenuto lìn qui completamente amaurotico , ma li_h erissi_mo mo.: Timen ti ora incominci:t a percep1re glr strmo\1 rntenl't ' . della l uce e può veder, come ombre, le m_ano._ Quel grad o leggiero di ni stagmo osservato nùt pnmr grornt è attu almente scompar:;o.
Siccom e ritenemmo che il miglioramento essere leg.1 to al riassoruimento dell'essudato crani co sa ngu e stravasatosi. in seguito alla frattura dello sfenoHle, oltre la corrente tra\ vanica e le frizioni surricordate, somministr.1mmo !') • d all'infermo dosi "enerose d' ioduro di potassro e ere emmo d'avern e un certo Yantaggio , percht' t.'OI mi}(lioramento della vista dall' occhio destro, vedemmo as:;ai. speciulmente io basso nella faccia. la senza qui ricordare gli altri sumfentt.
Oa vari criorni le condizioni dell'infermo si sono pres. · n · .. • · d · · relativamente soch e mnurabrh. :'\on luswgan oc1 uoppo ad un ulteriore miglioramento mollo sensiuile, riteniamo verò clte ancora il Bosticco debba souutto per ciò che riguarda l'anestesia della meta della faccia, il visus in ambidue gli occhi e la nutrrzwne delle re).:i oni co lpite.
• Co me poteva prodotta tfnesta frattura alla hase·? La hase del_ cranio si distingue per l'irregolarità della fm·ma e l dtfello d'omogeneità di struttura. Secondo l'antica tutti gli urti che le impartiscono delle VIbraziOni, avrehhero per effello di rompere i ptlnt· . . d h • l !JIU e· IJUCIIi di cui la c·ur·vatura è più pronunziata. Fu dapprrma comhaltuta questa teoria dai lavori d 1 • 'fr ·1 1 d 1· e a e n 11mam ente da quelli di .\ran. in Yirtù dei quali si è riconosciuto che _le pretese fraunre della ba.>e per contracolpo sono qu:lSI costa ntemente delle fratture pel· irradiazione ": .. . ,,on assimilare il cranio ad un ovoide o ad uno percht•. :;e rappre ·enta una por·zione d'ovoide la volla. non i· stesso per la base. Ma pure esistono delle fratture indu:eue della hase per· cadute o per colpi sulla volta.
P1 ' 1mo caso s i può ammettere che la co lonna vertchrale, la qua_le_ rappresenta il peso di tutto il corpo, aumentato clalla rapldttil dP-IIa cad uta , prema sulla base del cranio deterrninand_one la frattur·a, e nel secondo che sotto l'azione di un mto_nnpresso sul vertice la base del cranio venga a rompersr contro la colonna vertebr·ale. Le fratture però di tal '>i può dire che quasi soltanto interessano l'os=-o oc · cr_p•t.ale e cruindi sarehbe male spiegabile con tal meccaOI rno la produzione della frattura nel caso nostro. a me no che non si voglia ammettere che l'effetto del colpo. mt> zzo dell'apofisi basilare dell'occipitale , sia stato ri,enllto sul corpo dell o sfenoide.
Le fratture per irradiazione. cioè quelle com un i alla volr,t ed alla base, nel numer·o dei casi in realtà rappresentano le pr:etese fr;llture per cont raccolpo . In conseguenza della scossa •m pressa a tutto il cr·anio, si verifica una frattura, che dal punto rolpito si proparra , o-en eralmcnte sotto forma r n e tneare, dalla volta alla base, percorrendo, secondo nlrune
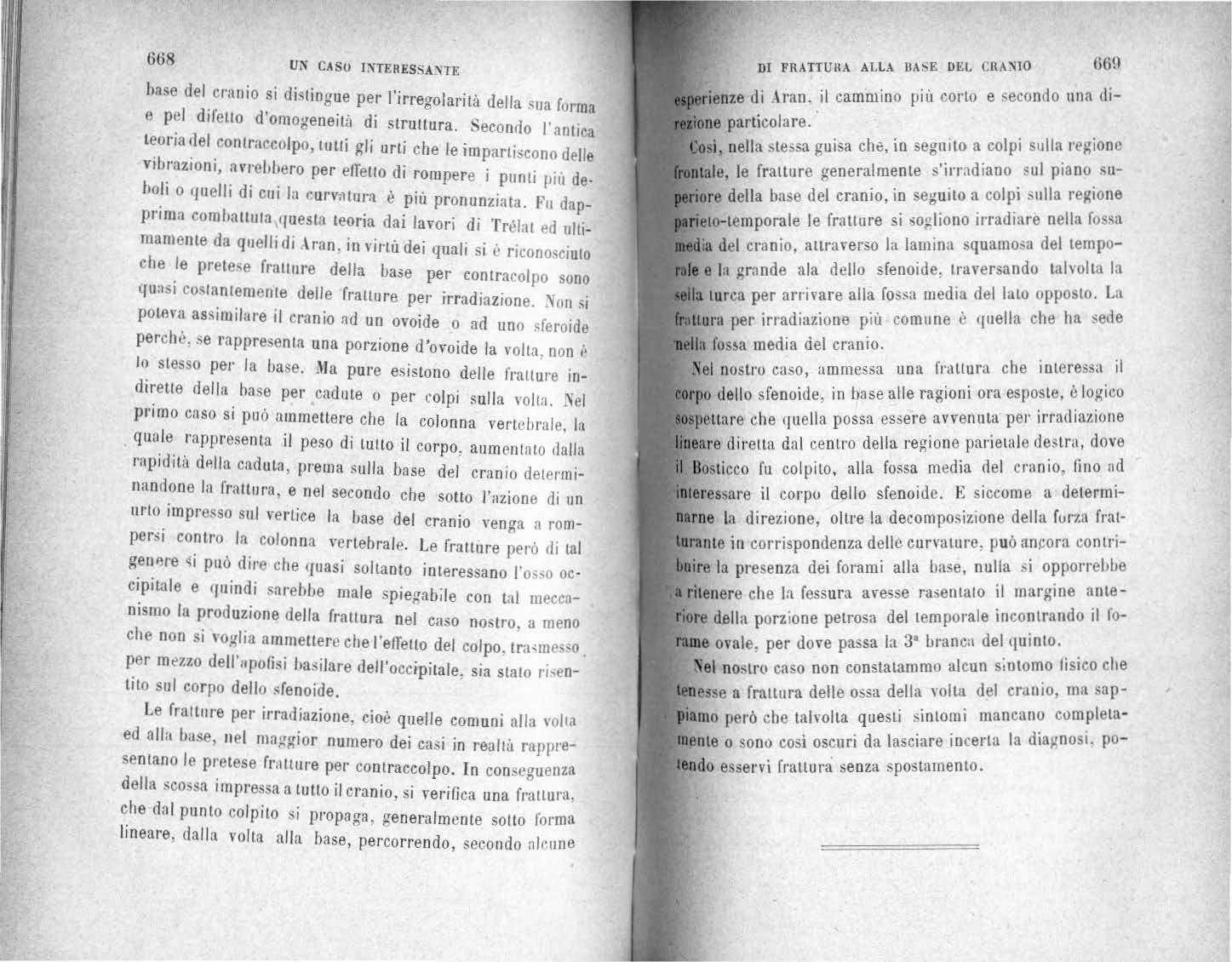
_.,.,,,,.A il cammino più rorto e :'econdo una diparticolare. · nell a stessa guisa chè, in seguito a colpi sulla regione e, le fratture generalmente s'irradiano s ul piano sudella base del cranio, in seguito a colpi $lilla regione mporale le fratture si irradiare nella fossa del cranio, attraverso la lamina squamosa del tempoe la grande ala dello sfenoide. traversando taholta la turca per arri'i'are alla fossa media del lato opposto. La r·a per irradiazione più comune è ljuella che ha sede media àel cranio. nostro caso, ammessa una frattura che interessa il dell o sfenoide, in base alle ragioni ora esposte, è logico taro che rrue ll a possa essere avvenuta per irradiazione diretta dal centro della regione parietale destra, dove Bo5ti cco fu co lpito, alla fossa media del cranio, lino ad ssare il co rpo dello sfenoidc. E siccome a determinarne la direzione, oltre la della forza fratturante in corrispondenza delle curvaLuro. può ans;ora contribuire la presenza dei forami alla base, nulla si opporrebbe a riLenere che la fess ura avesse rasenlato il margine anteriore della porzione petrosa del temporale incontrando il forame ovale , per dove passa la 3• branca del quinto.
:Sei nostn' caso non constatammo alcun s;ntomo fisico che lenes ·e a frallura delle ossa della volta del cranio, ma sappiamo però cbe talvolta questi sintomi mancano cùmpletamente o so nù cosi oscuri da lasciare incerta la diagnosi. potendo esservi frattura se nza spostamento.
Rivista Medi Ca
Segnt obtetttvl dell:J. mearastenta . - L. LoWF.NFELO - ( Munchner med. lVochens. eCentralb.jiir die medie. N. 13, 1892).
Dai sintomi dimostrabili obiettivamente che si in· contrano nei neurastenici ril eviamo che manca in essi il del campo visivo, che le pupille sono per lo Plll dllatate e le differenze pupilla ri sono dJ re aola transitorie. Osscrvausi spesso cont•·azioni fìb ri llari n"ella linrrua d l . " ' c 10 SI most r ano nt!i muscoli di un pollice 0 dell'altr'o. La si effettua imperfettam ente pet• flbrlllarJ, 1 movimenti di convergenza sono deboli. Secondo il L iiwenfeld la mancanza del riflesso r o tuleo non è da aunoYerarRJ fr·a i smtomi della neurastenia. In molti casi dJ neurastenia la eccitabilità meccanica dei ner,·i è aumentata, anche (segnat amente nel nervo ottico) la elettr ica. La r esistenza della con ducibilita elettrica alla testa è diminuila nei malati eccitabili <lisposli alle flussioni verso il_ capo, é Aumentata nej:di a patici, negli anemici. In rari ca"i ll·o,·a un anormale accumulo di eleUricllà sulla pelle srcché St possotoO estr arre scintille dalla superficie del corpo elettrica). Probabilmente questo fenomeno dip t> nde d_a un anor·male perdita di elettl'icita conseguente allo rtmeu to nervo"o. Il r.. richiama l'attenzione ,:ui f.:e 1mi della debolezza nervosa del c u ore, che si manifes ta sotto forma tli tac!Jicaròia o Ji bt·adtCal'dia o di irregolarita dei battiti cnr•diaci, e tante volte si t·iscontra sollanto nel cor·so della osservni'.ione. Merita inoltr·e di essere n o tato l'anorma le la delle arterie letn}'Oroli e la circoscritta dilatazione qu<'Rle arterie nei neurastenici gio"ani; la difelto,:a inner....;,...,., Yasomotor·ia delle pareli vasali sembra la di questo fen o meno. Oltre la pura ne r vosa 11 t ron1uu anche casi nei quali la forza motrice dello stot' o manca la normale acidila dello stomaco. Può la diarreA alleenarc con la costipazion e; frequentemente a ccadono la fo"fatur1a c l'ossaluria. Sedimenti di piccoli-.simi di a cido ossalico non recano alcun di'>lurbo aglt or· gani uro pojetici e della :;renerazione, ma si i copiosi più grossi cr·istallt: anche la ossaluria un della intluonza che lo ::;lato alter·alo det roet•vr e::-ercrla c;ul ricam bio
Della aoleroai a plaoohe ed a particolare del auol fenomeni ooularl.- CHARcor.- (Journalrle Méclecin e et de Chil·urgie, genn aio 1892).
Quando si è in pl'esenza ùi un caso ùi sc lerosi a comple to, la diagnosi é molto l'acile e l'insieme dci_ stn lomt che si r iscontrano permette di riconos'!erla factlmente. Quando inve,·e si tratta di fot·me incomplete, che !'tono molto rref}uenti, e assai dtfficile farne la diagnosi:. solta1: lo la :onoscen :ta ml)llo esalta di alcuni dei suoi suntorm, 8pectalmen te d.,i suoi siulomi oculari, e la loro analisi accu rata po-.souo la natura della maltillia.

1 sintomi della scler osi a placche si clividono in Rintomi spinali e sintomi encefalici. .
Fra i primi, il più importante di tutti è il tremore deglt ar·ti superiort , tre more detto intenzionale nel_ es!:'O nou esiste che quando i muscoli sono mcsst 1n dalla volonla Mentrechè in questi malati, nello sta to d1 1'1la mano re;:ta immobile, toslocht'> e!'sa vien _in movi mento da un' nzion" fJualsiasi, come d1 pot'1a•·e un brcchiel'e alla bocca, avviene una serie di oscillazioni violente e disordin ale che rendono impossibi le l'azione voluta. Questo t remore mollo diffe ren te da quell o della corea o della para· lisi è ora ben conosciu to, e non si spiega guat•i l!EOICA 673 come esso sia rimasto "'Conosciuto p 1 !':Ono però il me . er anto tem po Vi 1 rcur rale eù il IJ•e . · ranno molta rAssom. <YI . more Jc;teri co c he d ,,... ranza col tremo . . non Jrneno, quel"to t re m Ciò , m orno ha un ara d. . gno stico· ma v· "' n tssrmo valo r P dia ' 1 sono pero molli · · .scontt·a o rnerrl ' . . cast In cuJ esso non . . ' o IO 111 CUI é ..1 rJmma il malato. scomparso <Juanù u SJ
Da parte degli arti inrel·iori si . <le nza ella parapleaia spac; d: nota dapprima una lend b o mo ICS Yale ri' m e ol1mento alle .,.8 b 11 Ire che esic;fe un ed "' m e con un certo "' d , una esageraziOne d . 'Il ,..,ro o <l I'Jgide zz!l e1 ,., ess1 La 1 .·g· 1 • pronunciata che il carn . · 1 1 CZ/.Il è talora così minare è r e"o del t . essa pu6 anche present • . utro Hnposs ihile· l BI SI alli' bra c l ' a pos:- ibilità di quals ' . . · cw, a <rual C0>-1:1 e::'dude l rast rnovrment1 remol·e carutteric;tico "' . . > e per· consegu enz a del · nel ca"'' ord na · 1,. e tremolantP mollo d'"" ' rl mcesc;o é titu ba nte d . . ' lu erente dA quell l Il llliii'Ia e dell'alas · · 0 c c a paraple<>in n r• Sia, llelJe quali il Il l ' e mello fntrcosumente m la a.o cammma pr ù o J ' a se<>uendo una r 111 1scorso al con t .1" mea retta; n el r a s o b · ' ' malato c · rrac,, allontananliosi a . , . come un ubT ,. CJascun Jstante dali 1. . n't so no i princip r . . . u mea ùt rn a r·<·1a. l a l SllltOmi Sptnali d lJ J c 'e. l sintomi cefalici rl e a se ér.,si H pine• ' 0 e"'Jc;tono quasi s .rettanta importan za diarr . . , empre hllnn o al · ,.,nostrca e Ch arcot · · mente sui sintomi oculal'i. Jnsrste !"pecllll -
P et• studia r e utilmente i sitJtOmi . a placclle fa duopo confron tarf' oc.ularr della in altre affezioni co Il I quelh che si riscontrano t ' me n e e tabJ e nell'· t . un a malattia essendo d'alt JS erismo, quest a ulafla sclerosi. ' ra parte, molto sovcnti consocia ta
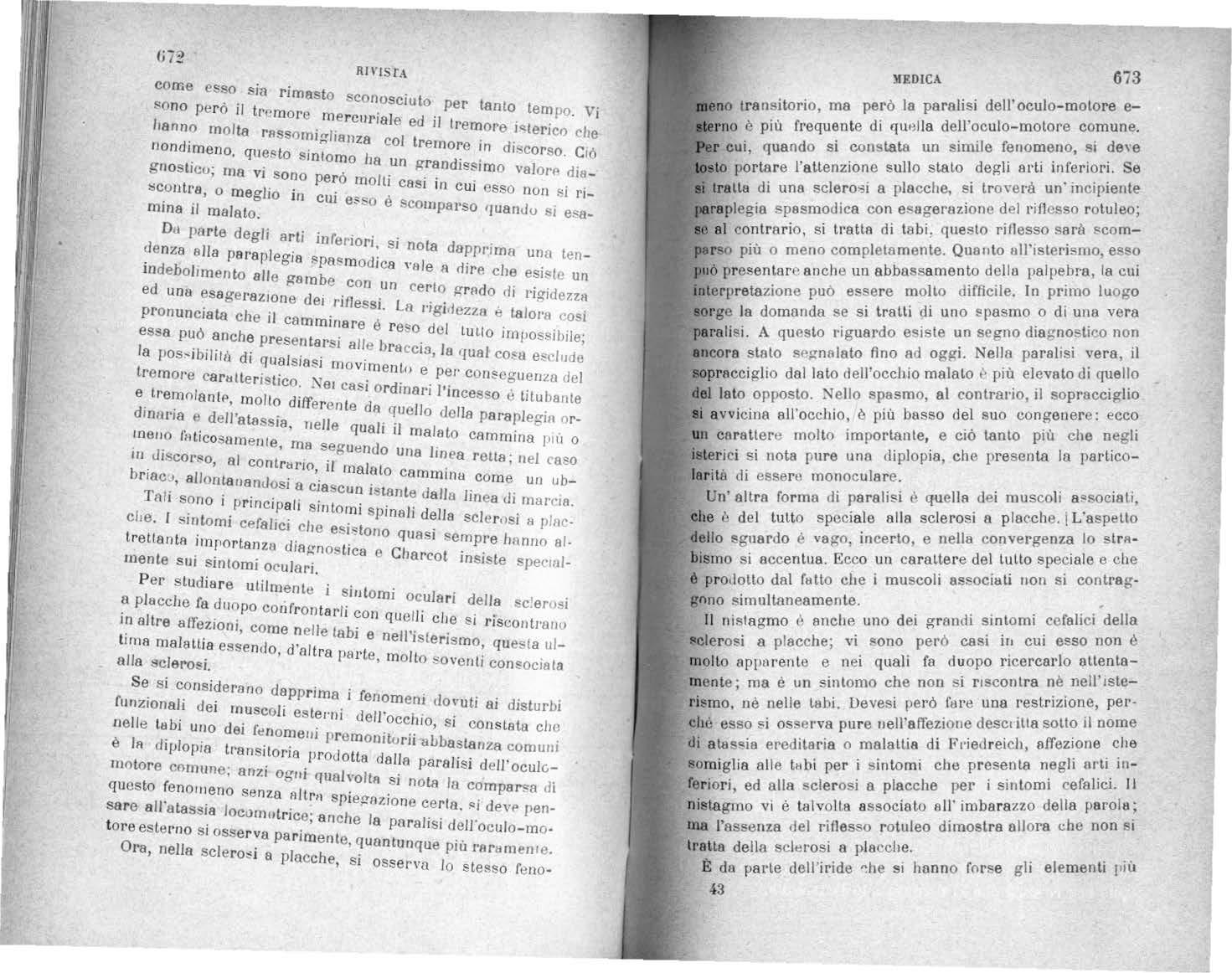
Se si considerano dap · . funz ionali dei rnusc l. p rima. I fenomeni do\·uti ai dist ur bi o ' estet·n, dell' h· . uelle labi uno dei 1 . . occ IO, SI constata ch o t!nomelll premonit .. bb è lA diplopra lt•ansitor·ia l t oru a astanza com uru o ta dalla pa ,. · d motore comune· anzi o . ra ISI ell'oculc,- ' · g'11 quah·olta c::i not 1 questo feno11 1en o senza Alt Il a comparsa rl i rn Spie""nz ionc 1 · sare all'atassi a Jocom l . ,... · cer a. 1>1 devP u rt ce; anche la p 1• tore este1•no si osserva . ara rs1 dell'oculo-m o0 parunente quantun ra, nella sclero:ò i 8 pl h ' . que PIU raramen re. ace e, SI osser\'a lo stesso feno- transitorio, ma per6 la paralisi dell' oculo - motore eè più frequente di qwJJla dell'oculo-motore comune. c ui, quando si constata un simile fenomeno, si de'e portare l'attenzione sullo stato degli arti ini'eriori. Se tra tta di una a placche, si troverà un· incipiente a spasmodica con e"'agerazione del rifl<'sso rotuleo; ee al contrario, si tratta di tabi, questo riflesso sarà scompiù o meno completamente. Quanto all'isterismo, esso puo pr esentarf' anch e un abbassamento della palpebr-a, la cui inte r pretazione può essere molto difficile. In primo luogo sorge la domanda se si tralli di uno spasmo o di un a vera para lisi. A questo riguardo esiste un segno non ancora stato s Pgnalato fino ad oggi. Nella paralisi vera, il eopracciglio dal lato rlell'occhio malato ,.. più elevalo di quello del la to opposto. spasmo, al contrario, il li a vvicina all'occhio, ò più basso del suo co ngenere: ecco un carattere mol to importante, e cio tanto più che negli isterici si nota pure una diplopia, che presenta la particolari tà di essere monoculare. l:n' altra forma di paralisi è q-uella dei muscoli a !'sociali, che t\ del tutto speciale alla sclerosi a p lacche. ! L'a spetto dell o sguardo P vago, in certo, e nella convergenza lo str llb is mo si accentua. Ecco un carattere del tutto speciale e che é prodotto dal rutto che i muscoli associuli non si contra ggo no simultaneamente.
Il nislagmo t> anche uno d ei si ntomi cefalici della flclerosi a placche; vi sono però casi ir. cui esso non è molto apptlrente e nei quali fa duopo ricercarlo attentam e nte; ma è u n sintomo che non Bi r1scontra n è nell' isterismo, nè nelle labi. Devesi per6 ftu·e una restrizione, per· ch è esso si osserva pure nell'affezione descc illa solto il nome d i ata sc;ia eredita ria o malallia di Ft•iedreich, affezione che somi glia alle tHbi per i sinto mi che presenta negli or·ti inreriori, ed alla !>Clerosi a placche per i sintomi cefalici. Il n is ta gmo vi è tal volla a ssociato all'imbarazzo della parola; ma l'assenza del riflesso rotuleo dimostra allora che non "'i lralla della scle1·osi a p la cche.
È da parte dell 'irid e si ha nno rorse gli elementi più importanti per una diagno!'i differenziale. Accacle infatti frequenleménle che nelle tabì le pupille sieno ineguali P che runpressione della luce non le modifichi e sì pos:;n fa re agire sopra dì esse un focolaio luminoso intenso senza che si Se, a l conlrtmo, si presenta al malato un oggetto che ogl i sia costretto a gua rdnJ•e tanto da vicino da dover r.ouvergere occhi, le pupille sì contraggono. Accade so vcnt1 per o che nell'atassia le pupille non s iano ineguali.
Sì osserva frequentemente la mìosi, e la pupilla iu ce1·tì ca"-i è punlifo1·me; ma anche in questi sì può ancora la contraz•one coll'accomodazione. Questo fallo , d'altronde, può r iscontJ•arsì nella paralisi gene1·ale, mn mai nell'isterì-;rno, n ò nella a placche. In quest'ultima affezione l'iride non presenta alcun fenomeno ptlt'licolare: ha tal volta una miosì spasmodi ·a; ma malgrado ciò 1 moVIm enti d•• Ila pupilla subiscouo ancora l'influenza delln luce. Da parte del nervo ottico, le differenze sono an cora più pronuncia te Nelle labi la papilla é bianca, mndrPp erlncea, con contorni ben marl'nti, coi assottig liati o scompur:si.
)iella sclerosi a pla cche, la colorazione della papilla ,. gial· lastra e so prattutto i co ntorni so no dìffuRi ed essa ;wmbra coperta da una nebb1a. :\:Ia é sopl'allulto nel della leswne ch e la differenza. Nelle tabi la cecita è fata le e le lesioni sono sempre progressive, quando esse cominciano a presenLAr!'lt. Nella sclerosi a r•lacche la cecila può esiste r e, può per sister e per alcuni m esi, ma non ò m ai delìnitìva, giacché la distruzione el e menti ue•·vo:;i non é mai completa o può pr odu r s i una
Infìo P nell'isterismo può notursi eguairnenle l'am aurosi, ma senza alterazione della papilla. Lo studio delle nllel'azioni del campo visivo e d«>lla visione dei colori dù nr1che indi ca zioni importanti. L'amaut•osi tabeti ca, infatti, sì annunzia con un t·estringimtl nto d e l campo visivo tutto speciale; que!'<to r estrìngìmento e irrego lare, ineguale, solto fol'ma di t e la. Nell'isterismo, al coutl'ario, il r estrin gimonto é co ncentrico. Quaulo alla sclerosi a placche, essa non pre!'<enla all razi oni dì questo gen e r e, e se esiste J'estringimcnto, sì può essere certi che vi è consocialo l'isterismo.
Medica
egualmente un manifesto contr asto per l'act•o ma: il labetico perJe dapprima la noz10ne de.l e r osso e continua n vedere più lun ga m ente li e r o.' al contra r io, J'ulluno é color 1.05150 • Nella scler osi a placche non SI nota. l · a. Vi sono ìnoiLre nella sclerosi a placche dd'ferenll Ln,nrr>P.ni cefalici importanti per la Vi ha l'im pedimento della parola, che ò lenta e scendimenlo é e differente dal si osserva nella paralisi generale, in cui la parola e piU e sono moltiplicate le l e le r in un speciale: ma essa si riscontra pure nella malallta d• ich.

re11omeni cArebrali poso:;ono mancare t0talmeute; ma, l'arlare de<Tii nltacchì apoplettiformi, vi ha gener aistato assai speciale, specie d• stato bealo, , per cui il malato non s'inqu ie ta a.fTatto .della sua e nè dei pt•ogressì del .:;uo m ale ; VI ha Ul.'-Omma verso la demenza, eon un pò' •. e crò una ras"om iglianza di più con In parahs1 ge-
Nella. sclerosi a placche, dal punto eli vista della d iagnosi si devo tener mollo conto ùell'_,voluzJOOe della malattia.' Si notano infatti dello alLPrnative, dei di arresto mol lo n otevoli: la para lisi. il tremore, la cectlà, tr.eompa rire complelarnenle e vi sono che slall in tal m 0do paralitici fino a cinr{ue o con mlervalli di ripristinamento completo dei mo,·tmenlL . . Si osse rvano pet·ò casi in cui si p r esentano anormali· i distu rbi LJ'ofici, ad esempio sono eccezJOnah, ctò. ' . 1 , dì atrofie muscolari nonos tante s• può notare a compatsa e di d•<;turbi della sensibilità. Questi falli entr·ano allora nella · · 1 forme cerlR.- catego t•ì& dplle sclerosi incomplete, eL1ptc te, . . l . anca 1·e molli eleme nll m ente fr·er1 uenti , n e lle qua 1 m ' Ilo del quadro sìntomntico ordu1arJo e che sono percJO mo piu difficili a diagnos ticare.










