
16 minute read
EMIPLEGIA RIFLESSA
Da Taenia Mediocanellata
CONTRIBUTO AUO STUDIO DEUE PARALISI RIFLESSE
Advertisement
<lottor liRrio t ondore lli Franea• i g lia . ,;o ttotcnPnte mMico di complrmenlo
Il cap·lolo delle paralisi dopo la pnhblkazi one del Leyden ( l ) . ha perduto un po' del suo yaloro, tend endo i recenti st ud i clinici dei nevrologi a riferire ogni combina zi one più o meno cornp li cnta di sintom i a lesione di una det erminala parltl del si3tema nervoso centrale o periferico. Pu rnondimeno occorrono dei ca:;i che, ove si studi con attenzione la etiologia e il modo d'insorgere del loro compl esso sintomatico, det..bonsi ritene re di nat ura funzionale.
Comunico, com e con t ributo allo studio di tale spec•e di parali.:>i. il seguente caso di Em iplegia riflPssrt da 1'aen ùt me· diucmll'llata
Il ) - Sulle paralisi ri(leue. - RnccolL;t eli cd1 1<l d:J. lltt'ca t·tiO Vo lkmann, N 7 Trar!. rlel pror lle t'tt•. An. 1875. lhccol•i la Jlrt•scnle storta clinica nel ginj!no del t8Si. "\on pullllicai s_ubtto 11 l:t\'Oro perclw, Imitandosi dell:t illustr:tzionc <li un caso dt par.11tsi tn rui gli effetti curativi v<•ngono valuta ti in distanza, ct·etletli opport uno far ((Ualthe tempo e tener sotL'o«hio il paziente, )fa ,oprav· v_enutom t,_tlopo presa la laurea, l'obbligo del servizio 111ililare, di tntMa·o;:at·;> e vi,it.'lre l'indi\ irluo l'ebbi 'OIIanto nel seUNnbrc ulti mo scor'o; e da cio I:J. causa del lungo ritardo nella pubblicazione. (.Y. 6 . .-f 1
E\I II'LEGI-\ lllfLESSA DA 'IAF..NIA
Paolo .\ ., muratore, di anni nato e dom iciliato in ianco . ha padre, fratelli e sorelle di ollima S<tl ute . e in ge nere. olTre a ricordare nel ge11tilizio.
BamlHno sofTI'i la febhre tifoìde .
la più perfetta salute, St•nza cnu:;a apprezzabile, a ùimagrare: e ciò ;H molto appetito. e quindi più del
Vn ;!Ìoro o. in ::.egnito ali di molla frulla . fu colpito da violenta col ica intestinale a lutto l'addome.
1 \'O III IlUI'azio ne e ahhondauti detezio ni alvine , costituite da resillui alimentari indige,ti e da fecce llllich e e puzzolenti.
Non ri fu ri..;e ntunento febbrile.
Prese un fot·te purganti', e dopo 24 ore si Jeyò da letlo .
L'app etito ritorn ò subito, ma si residuarono dist ur bi diti : pti al ismo. se te urcnte, lieve diarrea alternantesi a osti nata. Le fec ce, sia liquide che solide, con-
I_,L , tene\'an o muco, raram ente sang ue: il quale, qttalch e \ Olia, :;ollo forma di stri:;cie rosse tingeva i duri iorlri fecali.
CoutC'mp oraneamente all'apparizione dei primi dis turb i, cenn ati. eompar:'a una tie\e cefale:. frontale l' na. matri na, si ap par ecd1iava ad :wdare al laloro , venn e improvvi.;amente colto da gravi òist urhi nervosi: uppres.,ion e all'epi,.:astrio, ansietà di re.;piro. ronzio agli orec chi, allu cinazioni vi,;ive. formicolio al la melit sini stra del corpo. principalmente alle dita de61i arti dello stesso lato.
Il dolore, di cara ttere cupo e g ravativo, era accessio nale prin cipio; in :;egnilo divenne conti n uo, e disturbò tanto Il mo rale del paziente eia renderlo facilmente eccitabi le e di malunwrr.
0.\ TAENJA MEOTOCANELLATA 321
senso di profonda debolezza alla gamba sinistra tanto da non potersi r eggere in piedi. Adagiato sul lello, acc·orse di aver perduto l'u so degli arti di ::inistra , e che questi gli erano divenuti insensibili come di sughero.
Dopo circa dieci minuti i movimenti incominciarono a ritornare, e, scorsa mezz'ora, erano completamente riacc{Uistali. anche gli altri disturbi funzionali, che accompagnarono l'accesso, tanto che il paziente , sentendosi p ene, :mrlò al lavoro, e vi accudì, come al solito. l'intiera giorna ta.
Per mezzo di domande, convenientemente falle, mi sono assicuralo dell'integritil della coscienza, della parola, della funzione degli arti di destra e dei nervi facciali durante l'accesso: non che dell'assenza di schiuma alla bocca e di co n vulsion i cloniche o toniche. Non vi fu paralisi degli slinteri, non emis:;ione di 111·ina abbo ndante dopo la scomparsa dell'accide nte. Anzi, a questo proposito, posso aggiungere che ulteriormente ebbi occasione di esaminare per due volte l'urina eliminala dop(l l'accesso , e la riscontrai normal e sotto il rapporto lisico, chimico e microscopico.
Tali accessi, sempre colla medesima intengità, si ripeteitaro dopo di allon, ad intervalli di tempo più o meno lo ntani dai dieci ai quindici ai venti giorni; la durata osci llava dai dieci minuti alla mezz'ora, la modalità sempre la stessa e a sinistra.
LI paziente, preoccupato per la malattia in sè, e. più che per essa, per il pericolo cni continuamente andaYa esposto, dove ndo lavorare, a cagion del proprio mestiere, a allezza dal snolo, e sopra ponti di tavola non sicuri, ricorse all'opera di disti ntissimi medici; ma non ne ebbe alcu n buo no risul tato.
Nel marr:1io scorso ve nne a chiedere il mio co nsiulio. t)!) v la storia llella sua malallia, nella maniera come sopra sta ta e. parlando dei disturbi digerenti, nggiunse aver trovato talvolta iu mezzo alle mutande. r più spesso 10 mezr.o alle fecce, dei corpicciuoli hiand1i ,;e mo' enti, simili per forma a semi di zucca.

Sta to attuale lraccolto il ?5 giugno 188i). - Temperamento •rvo,o. Statura bassa , normale lo sviluppo e la costituzione IChde Lrica, muscol<l tnra medi ocra con pann'kolo adipo:;u: pallore del volto e delle mucose t 'addome è depresso ed indolente alla pressione. La col lipazione è la regola. ma vi ha talvolta diarrea: nell'uno e nell'altro caso le fecce con tengono sempre muco denso ed
Si laJ.!_na di dolore ottu.;o non molto forte alle hozze fronlali, el i inòeh olimenlo della memoria, di un senso eli malesaere ge nerale. che io ren(le eccitabile; ed inoltre di deuoler.za •Ile che si stancano dopo breve pa.,seggiata. Dorme bene, ma ngia con appetito, digeri3ce male. Non ha febbre.
In nessuna parte del corpo sono se nsazioni anormali, nt'l fenomen i di pare si o paralisi. I movimenti degli arti si fanno rapidi a dest1·a & a sinistra, la forza ne1·veo mulleulaJ·e è un po' indebolita in ambo i lati. La sens ihilitit non mostra modifi cazione degna di nota : l'ecc tlahilit it elettroè lisioloJ!ÌC:l.
Gli altri ed apparecchi sono allo stato fisio-
Uri na. Normale per qu alità e quanlitil. f'rrce. Contengono numerosissimi corpu scoli di muco e mu co- pus, nc.n che abbondanti uova di Ta enia mPdiocanellata e qunl cu no di Trich oce phalu s dispar.
E)fiPI.EGIA lltFLESSA
In tale stato trovai il paziente all"etto da due malallie: da catarro intestinalt cronico e da distm·bi del sistrma 1urroso centrale.
Per fare della all'ezione, certo sarebhe stato desiderabile aver presenziato r inferm o durant e uno dei tanti accessi avuti: ma ciò. per una rn gione molto facile a compre ndersi. non fu mai Bel resto non credo 'che, stando alla relazione fa tla con una certa esattezza dall'ammalato intelligente, e controllata mecliante l'in· terro,:ntorio dei pa1·enti. non si venire alla diagnostica; specialmente quando l'uno e gli nltri sono stati edotti dal medico inlonw ai principnli fenomeni da doversi ricercnre durante l'arcesso.
Esclusa, per la modalitit cli nica ogni forma di epilessia sintomatica o idiopatira, di convu lsi oni celapsiche où epileuiformi riflesse, eliminato il tiuhb io dell'uremia coll'esame delle urin e e con quello dell'apparecchio urogenitale, che trovai sanissimo; il mio Sf)Spetto fu di aversi da fare con disturbi paraliti ci della metà sinistra del corpo, esclu ·a la faccia, cioè a dire di rmiple_qia 8in i stra.
Circa poi la natura della duplico affezione. non tronu1tlo altro momento etiQlogi:o nllre 11uelto dell'elmintiasi inte,tinale, la cons'derai dipendente da es,;a.
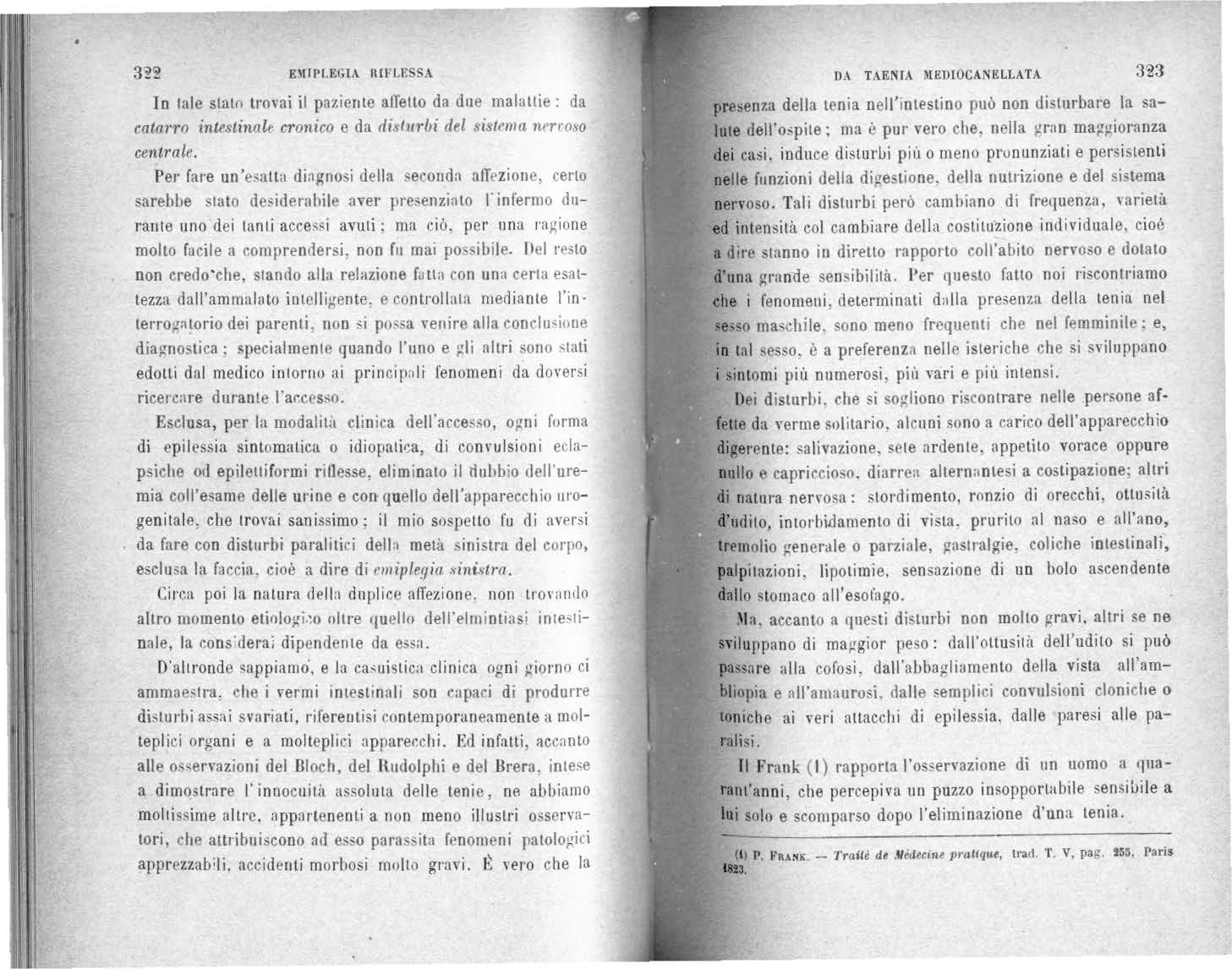
O'altrondc sapp iamo, e la clinica ogni giorno ci ammae,;lra. che i vermi intestinali son rapaci di produrre di,;turhi assni sva r iati, riferentisi contemporaneamente a molteplici organi e a molteplici apparecchi. Ed infatti , accanto alle os.;ervazioni del Bloch, del Rud olphi e del Brera. a dimostrare l' innocuilà assoluta delle tenie, ne abbiamo molti ssime altre, appnrtenenti a non meno illustri osse rvatori, che attribuiscono ad esso para--sita fenomeni patologici apprl.'zzab;li, accidenti morhosi molto gravi. È vero che la
DA TAENfA l!EDIOCANELLATA
presenza della tenia nell' intestino può non disturbare la salute dell'ospi te; ma è pur vero che, nella dei casi. induce disturui più o meno pronunziati e persistenti ne lle funzioni della digestione. della nutrizione e del sistema ner voso. Tali disturbi però cambiano eli frequenza, varietiL ed intensità col cambiare della costittfzione individuale, cioé a dire stanno in direlto rnpporto coll'abito nervoso e dotato d'una gra nde sensibilità. Per questo fatto noi 1·iscontriamo che i fenomeni. determinati dalla presenza della tenia nel se-so so no meno frequenti che nel femminile: e, io tal è a preferenza nelle isteri che che si sviluppano i sintomi più numerosi, pirì vari e pill intensi.
Dei disturbi. che si sogliono risco ntrare nelle affett e da verme Sl)litario, alcuni sono a ca ri co dell'apparecchio digerente: salivnzione, sete nrdente, nppetito vorace oppure nu llo e caprircio::;o. diarrea alternantesi a costipazio ne; altri di natnra nervosa: stordimento, ronzio di orecc hi , d'ud ito, intorhi.damento di vista. prurito al e nll'a no, trf'molio ge nerJie o parziale, gastralgie, coliche intestina li, palp itazioni , lipotimi e, sensazione di un bolo ascendente dall o stomaco nll'esofago.
accanto a qnesti disturbi non molto gravi , altri se ne svilupprmo di maggior peso : dall'ottusità dell'udito si può alla cofosi. da\l'aiJbagliumento della vista all'ambli opia e all'amaurosi. dalle l"emplicì convulsioni cloniche o toni ch<l ai veri attacchi dì epilessia, dalle paresi alle parali si.
li Fraok ( l ) rapporta dì un uomo a quaran t'anni, che percepiva nn puzzo insopportabile sensibi le a lui solo e scomparso dopo l'eliminazione d'una tenin.
E)flf'LEGIA RIFLESS.,
Lo stesso autore (1) rifet·isce la storia clinica di tre indiviclui colpiti da amaurosi: in due, madre e figlia, bilat era le. ma momentanea; nel tòrzo al solo occhio sinistro e per un tptarto d'ora. I di..,tnrhi visivi si rinnovellavaoo iutenalli più o meno lontani: e scomparvero, per non più ritornare, dopo che i tre individui ehbero eliminata una tenia ciascuno.
,\ ndré Peti t {3) ha ossen·ato, parecchi anni a i dietro, alla un infermo che emetteva sei ad otto litri di nrrna al giorno. L'analisi non dava altro che un aumrnto dell'nrea. Si osservò che l'ammalato emetteva pure pezz i di tenia; si so mmini strò un anlelmintico, e della tenia fu dalla scomparsa della po!iuria. La presenza della tenia nell'intestino avea adunque u11'inOuenza patogena su !illesra poi iurin in si pida.
ln un nomo a quaranlacinque anni, raccon ta Quetti er (3), una tenia, che fu poi espulsa co l rimed io di Bourdier (etere solfo ri co), produceva un tremore periodico straordinario di tutta la persona e della durata sino a selle ore.

Il Lero ux ( i.) parla di a{{'e;;ione sviluppalasi in un gi<H·ine a diciannove anni, consistente nella subitanea ed involontaria contrazione tonica dei muscoli llessori dPIIa testa per la durata da un minuto a mezz'ora. Tale disturbo. una -vera aiTezi() oe ner\'osa, fu curala per qualche tempo, senza con le emissio ni sang ui gne dalle apo· fisi mastoiùee, colla doccia fredda, coll'uso intern o degli antispasmodici; finchè, riconnsciula la natura parnssitaria, fu sommini strato un tenifugo. Dopo l'cspulsiùne del parns-. si ta non si ripeteUero più le co nvulsioni.
.\ ccessi epilettiformi, per tenia, io un bambino a nove anni, sono stati osservati dal Bremser (l): e casi analogh i di v10lenti e frequenti attacchi epilet tic i hannn ri co rdato il Dickinson il Berte! (3). Più rec enlem ente ancora il prof. Gra ssi (4-), e dopo di lui il doli. Comini (:j), dirertore e • medico primano del civico di \ hanno contr iuuito, con l'es!JOSizione di parecchi cnsi. alla cl inica dell'epilessia riOessa (òa nana).
I l doti. (.trch. Gén de lf éd., dicembre 18!11) ha potuto riunire 1!2 casi di attacchi epilettiformi, dovuli alla presenza della tenia. Egli considera questi c·asi non eome rapp resentanti la forma essenziale dell'ttfl'ezionE', ma pinttosto com e casi rli pseudo ·epilessia verminosa, fondandosi essenzi almente sul fatto che l'eliminazione della 1eni:1 fa cessare Per altra parte, i caratteri di attacchi differ iscono parecchio da qut>lli idiopati ca. L'acnon ha quella -repentinitil brusc:1 dell'epilessia vera e lip ira: il malato inYece ha tempo a prend ere le suo precauzio ni, a getta r;;i sul letto e a domandar soccorso: e per tale appunto le cadute e le feritr sono in 'luesti casi alT •tto eccezionali. La dur.1 ta del periodo co n,ulsivo e co -
1t l - lcones Mlminthum, p. 3H, YlennaP, t8:U - Cases o( epilep•y i11 cllildretl l'tht•fd by lh.t exp ul.,ion o( (l'nder the case or Oicb.inson); in: !led 7'in. n naz. 1863. l . tl!l-ltl.
(l ) l'. FRANK. - 011. cit. Tom. V, pag, 383.
(2) L i' ll•(orma mediw. Anno VI (1800), N. 295, pag. t76S (5ocieta degli di Pal'igi. Seduta del !8 novembre i890}.
(3) '/hese de Paris. N. 97, pag. t 3, an. t808.
(·l) J. J . 1.1 1\0tiX. - Cow·s sm· les gm. dc la med. prat. T. l\·, p. 316, Pal'io, 18':!6.
(3) HERTET.- Observation d'ep•lepsi e pa1·l'up •dsion d'un Taenia; in: Union Mraicale. N. Sér. T. :t3. i8G3. pa;:. 13i-140, f5) COMINI. - Epileuia ?'i{lessa da tenia nana. - Gaz::etta degli Os}litali. An. 1887, n. 8 pag 59. ma loso (• p iù lunga che non nella epile ss ia idiopatica, e gli accessi hanno una certa te n denza ad assumere la forma periodica (1).
(IJ CnASsa. - Cenno preven!ivo itJlorno ad una nuova malaWa 11arauil<t· raa dell'uomo Gazzella degli Ospitali. n. 57. l.88G.
11 Kendricb.. ha pubblica to un'importante nota circa la della presenza della tenia con la parnp le).(ia e l' epilessia; ed il (3} afferma che uno dei sintomi st ranissimi, che, per azione i vermi intestinali possono provocare, è la emip!egifl.
I summentov.•ti disordini funziorl'lli. coin cide nti colla presenza della tenia, so n dispar:-.i, com e abhtamo dello, coll' elimiuaziono di e tale coinridenza, da guarigione completa e permanente. dopo elimi nato l'int iero p arassita, no n lascia nes<> un dubbio sul momento eti ologico.
Ciò av venne anche nel caso da me riferito: il pazi ente, c he, per più di un anno, aveva cercato invano il t·imedio ai suoi mali, fin:llmente lo tro,-ò in pochi grammi di estrallo etereo di felce maschio. L'espulsione completa d'una Ta enia mediocnnrllata fece cessare rapidamente e per sempre tutt i i disturbi.
Sino ad ogg i, son giiltrascorsi qnallro anni, la g u'lrigione si è mantenuta perfetta. HQ rivisto pochi me si fa, al mio paese nativo, ov'egli abita: è ammogliato, h 1 due lìgli, ed è di ottima salute.
Pe 1· il rap porto esistente fra ca usa ed non vi ha du bb io che la dup lice affezione ha avnto per origine la pre-
(t) AltaccM epiletlitormi legali alla p1·uen::a àelltt tenia.- Guzzetta àtgU Ospitali. l'i 5, t &.li.
(!/ R&:-iiJRICK. - Connexion o( the pruence o( Tamla wil paraptegia a tpitepsy. - Lancet. 11. p. 2SG-28i.
(3) .\JOYNAC _.. Jffallttale di Polol ogia e di Clinica tneatca. Traduzioue del dott. llar01·a Oomenì"O. Pag. 21 i

OA TAKNIA "EUI OCANELLAT.\ senza nell'intestino della Tamia mediocanellallL. pnr nondimen o si può obbiettare: . .
L' emiplegia è dipesa da ecdtazionc r ifie<;sa penfc•:tca della tenia sulle fibre nervose centripete della tnteslinale; oppure è stata l'effetto d'una nevrite intloua dal catarro intestinale cron ico. e provoca nte 10 condo tempo un'infiamm.•zione del midollo? t un'emiplegia r ifle ssa o un'emiplegia
La comparsa dei dislurui nervosi quasi qu elli dell'apparecchio digerente, escltule la <h tlualunque filiazione patogenetica t1·a gli uni e gli altn: ma, astrazion facendo da ciò, si può venire alla meùe,;ima conclusi one a fonti più attendi hili .
I n :.eriuito ad all'ezioni tle\1' apparecchio digerente ed_ nro: possouo stabilir,;i dell e paralisi limitate agl1 a_rtt in feriori ed estese talvolla ai superiori; parali:;i seconrlane, ch e come hanno Jimo:;lrato le ri ce rche cliniche e piche di Gull ( l ), Kus,;manl (2). (3) e Hema!' (4.), non le ùi r ,e;;ler (:>), e_ sono do' a. n eurite che, dai net·vt òtstnbuenl i:,i all'org 1no primitivamen te afTetlo, si tr npianta al spinale. Esse , es.5endo devolute nd una le;;ione anatom1ca, che non si in un momento, si manifestano pure lentamente e proorediscono col progredire dell'aiTezione, l • della q uale sono l' eiTetto. Egualmente lenta è hl loro guarigi one. la quale del resto si ,-erilica assai di rado. I noltt'e le
( l) r.uL. - .!led Cltir. Voi 39, !836.
-=- \Vur.::b. mtd. Z ei tstlt IV. P- 5G-G3.
(3) - Lot;, Clt. , • • !;t' 1 J1 'l c4} 1\KMA._ _ Mtd. l.'enlrat. Ztg. 1800, n. ':li e Oester Ze1tsch . f. pt a 1sc tt tilc utldt. ISGO, n. 45 e 48. • (5J - l'eber Neunlis. - K•ulut>berg, 1!!69, p. '!a. pamli;;i secondarie interruzione sino a che dura la causa che le ha prollolfe. tutt'al più po:;sono »uhire, d urante il decorso, delle oscillazion i in migl ioramento o io p('ggioramento; e non t' r.u·o il caso tli os:;enare la loro persi:;tenza, anche dopo rimo::sa l'affezione, rho n'è st:1L1 la origine.
J,er converso le pnralisi r illc·;sl' so n co ntraddistinte dalla istanta neità del principio e da ll a repentina; e si riproducono ogni \'o lta che l'eccitazione periferica si rinnora con tale veem enza da illanguidire le funzioni della midolla spinale.

La prova clinica di tali disturbi funzionali l'abbiamo in quei cas i di par·alisi delle estremità t:l)ll principio repentino e rapida scompar,;a, in Sf')!Uito n forte diarrea, a ''iolenti t•olirhe inte:;tinali, ad attacchi d'isterismo; la prova sperimentale nelle esperienze del Lewisson (1) che, eccitando (con la co mpr·essione o la lcg.1tura) i nervi dell'utero , dei reni o di intestinale nrlle cavie e nei conigli, ha visto in sorgere paraplegia arti inferiori. chP t; scomparsa con rapiditit ug uale a quella con cui si è prodotta.
Ciò dello chiara l'analogia fra e quella nel caso da me e!!pnsto: è fra esse adunque che la medesima devesi collocare.
.\la perchè i disrurbi nervosi si ripeterano co, tantemente al lato sinistro e non in Se l'os3e plausibile- In teori.t formulata dal De Fleul') per spit>gare la prt>\'nlen?.a dell'emiplegia isterica sulla destra, pntremmo acçettarla anche pel nostro cnso, rientrando entrambe nel wuppo delle paralisi funzionali.
( l ) -. L'eber lfernmung der Tha'ti!Jhtll dtr motorischm 1\'frvl'n· ctPIIrm dllrch Rfi::"'Jg wuiiJitr Ntrvtn ( Dub U?ld Reich Arch. 1860, lleft. '! p. i
11 Briq uet, nt>l =-uo di' asse t·isce che negli isterici i disturui di moto e di senso sono più frequenti alla parte sini,tra del1·orpo. Il De ( l ) pensa che la sede di tal e preòilezio nl' degli accidenti si possa attribuire ad una debolezza abit uale dell 'emisfer o dest r o del cervello in con fronto dell'emisfero si nist•·o. « le impressioni aiTettive. « esagerate e ripetute affiuiscono dalla periferia a tuili i centri «cerebrali, con intensità speciale nell'isterico. Ogni focolare « !'E'rehrale ne sopport:t quanto può; il più n ebole r naturale mente il primo a sopraccaricarsi. e se, nella emiplegia iste« ri ca, è quasi se mpre il lato sinistro del corpo ed r sensi di « questa parte che wno colpiti, è d'uopo veùervi soltanto una c pron dell'inferiorità dinamica del me.:::o cerrrllo destm c io confronto del me.:.:o Cl' rallo sinistro, in virtù ef' fcui crocinti l>.
Tale inferiorità dell'emisfero destro sul sinistro Lrorerehhe, sero ndo il Oe Fleur) prove:
1° abituale. che tutti i popoli fanno a preferenza della mano destra;
2" Nella. va.ria1.ione doll'ematosi cerebrale in vanta)!'gio dPII'em isfero si nistro, a causa dell'emergenza differente delle due carotidi primitive;
3" Nel la imperfetta fi.;iologi ca dell'emisfero quando esso, per aHenute alterazioni anatomiche, non è più in grado d i funzionare, ùa parte dell'emisfero
\l a tal i pr·etese prO\'e non sono che delle pure ipotesi. f: erroneo credere che, perrht\ la carotide sinistra iJ più pro -
ElfiPLRGIA RIFLESSA
fonda e rellilinea della destra. l'ematosi cerebrale si avveri megl io nell'emisfero si nistro; se fosse la pressione sangu igna sarebbe d is ugua le due carotidi primitive , più a sin is tra e meno a dest ra, la q ual cosa non è, almeno nei mammiferi superiori. E poi. anche esistendo lale disuguaglianza lungo il decorso delle carotidi, non ne deri\·erebhe. come variazione nella ematosi a favore di uno degli emisferi; a ciò si opporrebbe il circolo arterioso di Villis, il quale, stabilendo, mediante la comunicazione delle arterie comunicanti posteriori con profonde del cervello, un'impot·tante anaslamosi fra le caNtidi interne e le vertehrali. provvede esallamentc alla uniform e dlslribuzione del sangue nel cervello .
li De Fleury ammette inoltee , iu sosteg no della teoria predetta, che l'emisfe ro si nistro non possa che imperfettamente supp lire il destro . Egli, in ciò dire, dimostra piena fiducia nella credenza della teoria del:e supplenze cerebrali. la quale è messa in dubbio, anzi negata aùdu·itlura, da Carri lle . Duret, Luciani, Tamburini ed altri.

La possibilità della guarigione dei disturbi di molo. conse · cuti vi a les ione d istruttiva dell a zona mo trice, ha gi ustamen te fallo pensare che, f{U ando ce rte parti de lla corlecr.ia cerebrale vengano meno per malaltia o per lesione distruttiva, altre parti del cervello possano rimpiazzare la funzione degli organi distrulli e su pplirh fisiologicamente. Cosi è sorta la teoria delle supplenze ce rebrali, la quale e stata in· terpre tata d iversamen te dai var i autor i.
Dopo gli studi di Hitzig, Fritsch c Ferrier sulle localizzazi oni cerebrali. è in utile in sistere sulla del Flonrens, il quale considera il cen ello come un orga no fnnziunale omo · geneo, di cu i ciascuna parte, r imasta intatta, può rimpiazza:·e le fun zion i di a ltre parti a llerate o distrut te . Ciò. colle cono- allual i sui ce ntri cortico-motori, è evide ntemen te as-
Seco ndo Hi tzig, quando, dopo la distruzione di un organo
•....-..-::....... si ve rifica la restituzione db ll e funzio ni primi livale pertl utc. ciò avviene non perchè un altro organo del ..•.,..,.,.,,. ,lo supp li 5cc la parte distruua, ma perché esso organo Don è stato distrutto totalmente, e il residuo ha subito uu'iperallir ità fun zionale capace di alla funzione della parte distrutta.
Ma Alb er lofli e )l ichieli, Lussana e Lem<)igne, Goltz, Luciani e Tamuurini hanno dilnostrato non vera la teoria di Hitzi(! . Difatti sperimentando sui cani, hanno visto cbe ti r itor no fu nzionale s i verifica nel caso, in cui la zona asportala è più estesa della zona eccitabili?, e che non ricomp., risce la paralisi, gi(L scomparsa, asportando la sostanza cerebrale vi cin a a 11ue ll a asportat<l.
Il Soltmann ha immaginato un'altra teoria di supplenza eerebrale, ed ha dello che, quando una data parte di un emiarero \'i ene distrutta. la porzione simmelrica dell'altro emiarero ne di simpegna la funz ione normale . Se cosi rosse, alla distruzi one simul tanea dei d ne centri cortica li simme trici, per esemp io, ll egl i arti superiori, dovrebbe necessar1amente seJUire para lisi inguaribile di quesli; come anche della pat·alisi dovrebbe ver·ificarsi allorchè, guarita la paralisi lperim entale consecutiva all'ablazione del centro corticale cordi un emisfero cerebrale. si distrugge il centro COrti ca le om ologo del l'emisfero opposto . Ora le esperienze ratte su tal proposito da Carville e Du ret, Goltz. Luciani e THtnhu rini dimostrano che ciò non avviene· e però hisocrna • r> r.rnun ziare alla teoria dell a supplenza runzionale rra organi sunmetrici dei du e emisferi cArebrali.
Ma com e ad un11ue si veri fi ca la guar igione dello pa-










