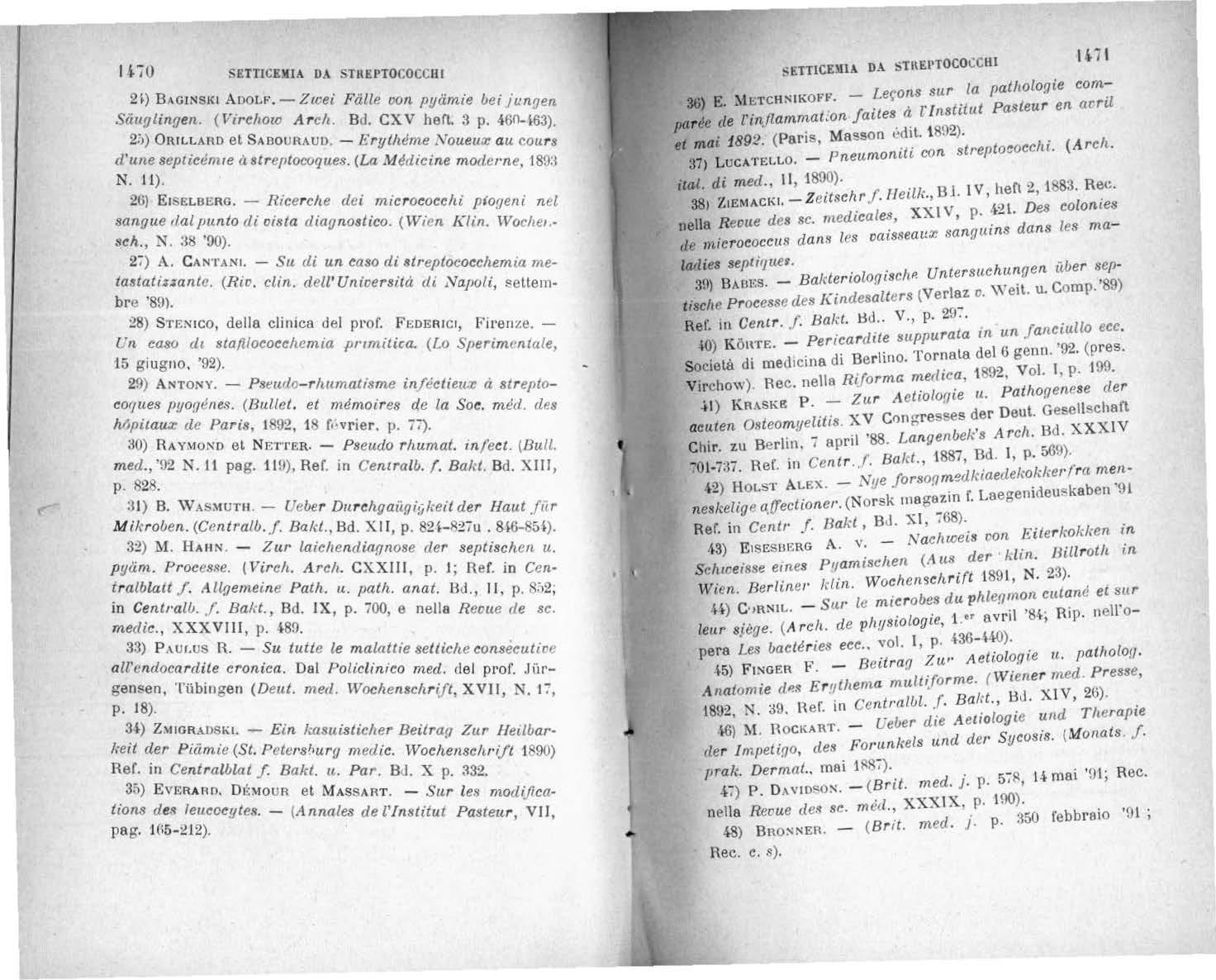
25 minute read
SETTICElUA DA STK EPTOCOCCB I
2t) B AGINSJO A DOLF -Ztoei F alle P!Jiimie bei jungen Siitl[llingen. ("Virchow A r e/t. Bù. CX V befL 3 p. 460-i63).
2:J) 0 1\ILLA!lD eL - Erglhéme .Voueu:.c au cou r s d'une septicémre àstreptoooques. (La Médicine modern e, 189:{ N Il).
Advertisement
26) EtSELBERG. - R ice r ch e dei mic r ococchi piogeni n el sangue dal punto d i vista diagnostico. ( Wi cn Klin. Wo clw.sch., as 'DO) sETT I CEYlA DA
27) A. C ANTANI. - Su di un caso di streptococchem ta metastatiuanl e . (Riv. elin. d e ll ' Università di Napoli, settemb r e '89).
28) della clinica del pt•of. FEDERICI, Fil'enze.L'n caso d1 stafllococcltemia pnmitica. (Lo Sperimentale, 15 giUgno, '02).
29) ANTONY. - Psewlo -rhumalisme inféctieu:.c à streptocoques pyoyr>nes. (Bullet . et mémoires de la So c . m éd. des Mpilau:.c de Paris, 1892, 18 p. 7-;).
30) R A YMOND eL N ETTER. - P s e udo rhumat. infect . (Bull. med., '92 '. 11 pag. 1 1!1), Ref in Centralb. f. Bah t. Bd. XIII, p . 828.
!3 1) B. WASMUTII - Uebe r Drt r chgaitgi<jkeit de r Haut .fiir M i/{ r oben. (Centralb .f. Bakt., Bd. XI I, p. 82i-827u. 846-SM).
32) M. Ihu N. - Ztlr laichendiagnose der septisclwn u. p uiim. Processe. (Vi r eh. A rch. C XXI II , p. J; Ref. in Cent r alblalt f. Allgemeine P ath. u. path. anat. Bd., Il , p. 8i>2, in Ce ntralb . .f. Bal.-t., Bd. IX , p . 700, e nella Reoue de se. medie., XXX V III , p . 489.
33) P A ut.us R. - Su tutt e le malattie setliche consectlti C'l' a ll'e n doca r dite cronica. Dal Pol!:clin , co mecl. d el p rol'. .Jiir·gensen, Tiibingen (D eut. med. Wochensch r ijt, X V II , N. r:, p. 18).
34-) - Ein kasuislicher Beitrafl Zur Hel.lbarkeit de r P iii.mie (St. Peters!•urg medie. Wochensch r ift 1890) R ef. in Ce n t r alblat f Baki. rt. Par. BJ. X p. 332.
35) E vE RA RO. et M ASSART . - Sur l es modijications d e .'! leucocgtes. - (Annales de l'Institut Pasteu r , VII, pa g. 1H5- :2 12). ..
.. n- - Le{·ons sur la patltologie
36) E. • 't . l'lnstitut Pasieu r en arrtl pa r ée cle l'in fl ammat;on fat es a . g 9 ' ( P · Masson •;rlil. 18\l2). et mat 18 -· a r Js, ' t . con streptoeocchi. ( A rch.
37) LucATELLO. - Pneumont L ilal. di m ed., Il , 1 80?)· ( lleilk Bl. IV, hefl 2,1883.
38! ZtEMAC Kt - Z ettsch_r • • p. 421. Des colonies nella R eotle des se. ntedtcale::s, , , . s dans les mal sangurn l · r o cocctrs dans es oat t e mr c · · larlies s epttquer. . l . l P. Untersuchttnr;en. ti.ùer sep3!\) BAtms. - Bakte r w ogtsc t. \ ' ' 'l u Co m p. '89) •. d lterslVerlaz o. ,, et • • tisclt e Pr ocesse des Atn. es a _ Rei'. rn Ce n t r . f. Bakt . Hù_.. V., p. in un {ancitlllO ecc .
K ònTE. - Pericardrte srtpptlr . . '9•2 (pres . 1. T nata del 6 genu. · · · S . là di meò,cina di Ber IliO. o r JW oc re 'fir ma medi c a Vol. l , p. , V irchow ). Ree. nella 0 . ' P athogenese der p zu r Aetwloqte u. · l, f . Cent r f Bal.:t.' 18 ' . ' . "e. 111 •. • di ·aeclel·okker(r a men· . Nye jorsoqme ,r ' n ella Revtle d e.i se. med., · · · '. febb r aio '()1 ; (Brit. m ed J· P· · 48) B RONSER.
41 ) K R,\SKe · - • der D eut GesellschafL ·t · xv Con"r esc::es · aetlien Osteomyelt rs. " , A 1 B J X X X I V ' l '88 Langenbeks re t. l.' Chir. z u Berlin, 7 aprr · 87 Bd 1 p 56!1).
42) H OLST ALEX, f LaegenideU!'kaben '!H l ·el'op a ff'ectioner. (Norsk msgszm . n es t ·"' • X l 768).
Ref. in Centr .f. Bakt' BJ. l\'' l weis von Eile r /wkken in E ·oAv- a ct .
43) 1S E:SUbR · : n A der . h.lin. Bill r otlt rn S c h tf'e isse et nes Pt! a mtsche ( l ·rt 189 1 N 23). . / ·1· Woehen.s c t r t, , • · W ie n . Be r ltn e t · • ttt. . ù d phlerrmon cutane et sttr H ) C ·IRNI L. - Sttr le t .. '84; R ip . nell'os iège. ( A r ch. de p!tystologce, "') voi l p {36 - hv . pera Les ùacté r tes ecc.. 'Z A etiolon i e rt. pa t holof! F F _ Bet tr a(l - u• " i-5) tNGER · . ( Wiene r m.ed. Presse, A n a to mie dP.il E r !!lh ema mttltt.formBe.l t t.> J X l V 2()). . . c nt ·albl r a ( .• u • ' 189Z, N. a9. Rei. tn e .' b d·. . Aetiologi c und T/terapie \6) M . ROCKART. - ue ce d der Sycosis. l M onats. J. de r l mpeli(IO, cles Forunlce s un pra k. D e r mal .. mai l S-:-).. d . 57 R, 14 mai 'fH; Ree. r ) p D AVIOC::ON. - (Br et. me J· p. ' . · X X X I X p. 100).
Ree. c. s).
Hì2 S&TllCE lll \
·Hi) FOCBIER... D.\ STRKPTOCOCCBI
. é T hr'ro p eul' (Lyon m ·)· des infections ' s e . m M XXX . ed., • .l aottl 9 1· R f1)0{lenes 50) T. ' lX p. :WG) ' ec. ll t>ll a Ree/le dPs
IIIERRY T con la fo rma; rattam. della setlicemia mai '92) . . t ascessi ipodermici. g r aoe 51 ) M X and<e med., l"
• • IB!LI ,\ - A.;-i ru:azio11e nelle one le r apeutica rfe li OBpitali .. . (orme mala rirhe ribetr g """''di de· ò2) >Ì. "93) e BibHografia !Gazzella degli -nMAN.- De l'. , Il articolo. ze r rain 0 . w., uenee de 1 n ales de 8ur l'a c tion cles oariflt/Ons du fl3) M m • ns !tut Pasteur, T V 9 es (AnO. SIEBER "c • p. • i3-25()) pto COtfUC - - - Ro l . '· s pathuglmes. (A r e l te r cltes les sl "ourg 1 · G e se bt'ol . re- • "·, , p. . de S PJ ji) F RANK S · . · eters- urla 1· dans t'o r l tspartlion cles b.a p. 726) gan,.me uninoal. ( Rei. in Ce ni eharbonn""' - - r alb.j. Baf..·t '88 l '
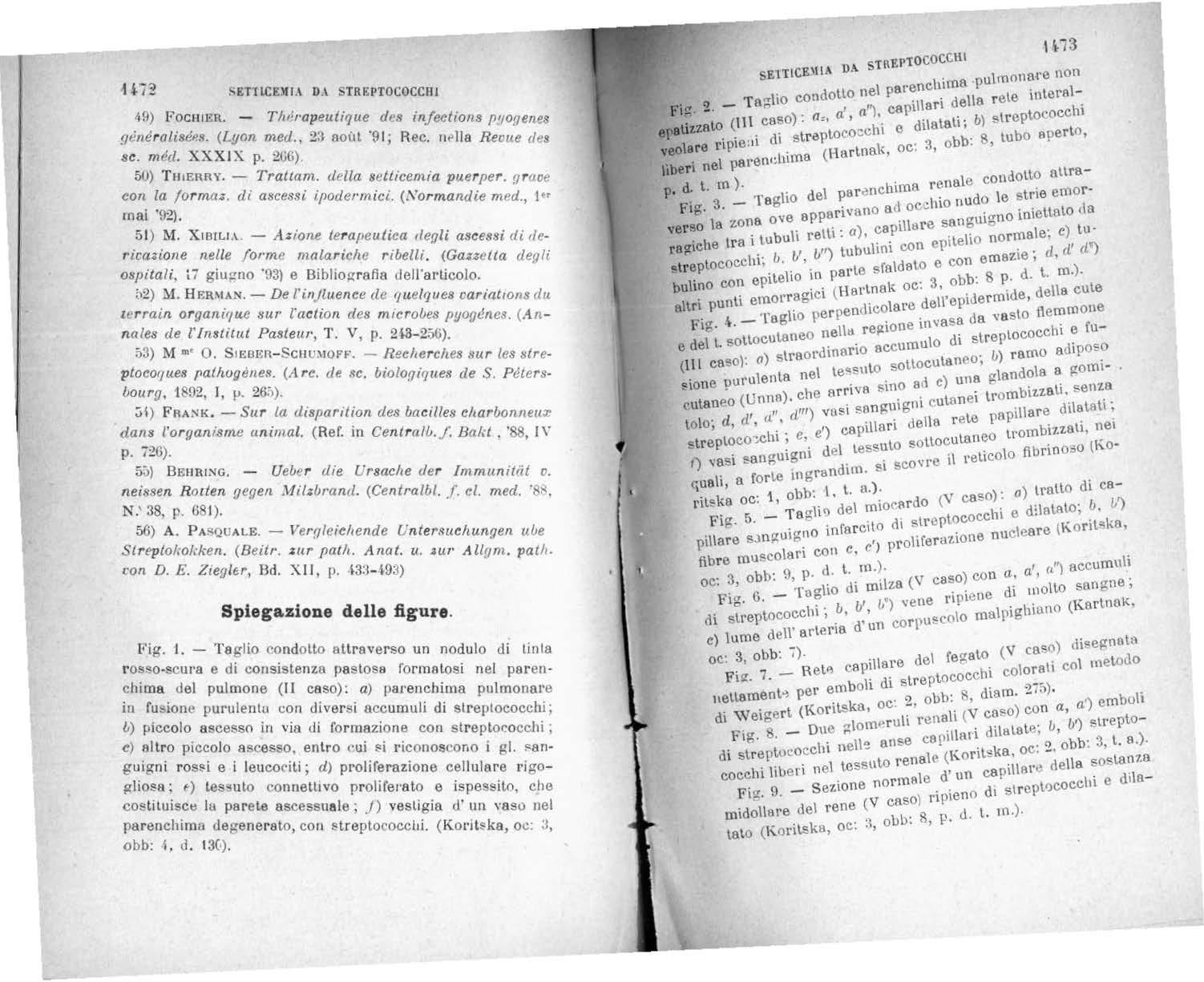
<>·>} BE HRI NG ' ' \ ' · Ueb e ,. nei.<t .se n R o rlen r l 'e Ursache de r N ' 38 gegen (C t l mmunilril o . . r . 68 1). en ralbl. r. cl. med .,
56) A p · ":--; ' A!'QU ALE V ' St rep lol.okken (B ·_t- eraleichende llbe {'On D et r . .a ttr patlt A " E. Zteglu, Bd. XII , p. u . .aur All[!nt. pat/t.
Spiegazione delle fi . gure .
Frg. 1. - Ta glio co nd r os"o-scur•a e d' . ollo attraverso un c hiroa ù el li c onslslenzo. paslo"a ro di tinta . pu m one (Il rmatos 1 n e l m fu s ion caso): a) a . paren- ') . e purulent u con . • . . p J e nchlma pulmon • v plCCOIO • uLve r Sl accum !' . at e c) alt . a scesso rn via ùi fo r m . u l di str eptococchi. " r o p 1 cco l azJOne c ' goigni ' ossi .. i•,:cosso •. enl'o <·oi >i ) u CO<'Ill; d) proli' te .o 1 gl. !':an-
• t- tes'lul razione celi l la a o connettivo prolifel·ato . u rigop areocl p r e te ascessual e. /) e tspessllo, che 11mn deg ' . vest1g1a l' obb: i, ù t 3C•) ene ra to, co n s trep lococclli ( K< Ya so ue l · · 0 11Lska oc· 1 ' . ,
SEl TlCE'IIA D. ' STI\ErTOCOCClll
2 . - T a;:;lio condotto nel parenchima pu]motH\I'e non aratiuato (111 ea•o) o a, 0, <>'1. earilla 'i deli O ,_le inle>·al•
""''"" ri pie"i di ''"ptocoeeh i o dilatali; bl '' ' optorneehi liberi nel parend\ima ( Ha rtnal<, oc: obb: S, tubo aperto, verso la zona ove apparivano a ti oc.;hio nudo le strte en1or· ""ieh• lca i tub uli ,elli' a), eapill.re sangui•no ioiellnto ola IJ. 1/, IJ") tubulini con epitelio normale; c) tu· bulino eon epitelio io parte ,ratdalO e con emazie; d, <i' d') oltri punti emorragici (Hartnak oc: 3, obb: 8 p. d. t. m.).
Fig. 3. - Taglio del renalc condotto attra- p. d. l. m).
Fi g. -\ .-Taglio per pentlicotar·e dell'epiJermtt\e, della cute e del l. sottocutaneo ne\111 invasa da. va sto 1\emroone (lll eo.ato a) ,tra••'"""''" accumulo di '''eptoeoeehi o ruEion e put•ulenta n el te"suto sottocutanC'o; b) ramo adiposo cutanPO (Unna). che a rr ivA r--ino ad e) una glandola a ::tomitolo; d, tl', a", d"') v usi san F(uigni <·uta.nei tro mbi-z.zali. !':enz.a ; e, e') capillari llella r ete p8pi\lare dilatati; o) '"' ' •enguigni do! """'o solloeutoneo to·ombi<Z&li, nei ,uali, a '"'" iogrondioo. '' scoHe il reticolo fibdoo" (li.O · o c: 1 , obb: l, l. a .) .
Fif:C. 5. - Ta gH9 del miocB r do (V c aso) : o) tratto di capili•'• """"'""" iofat"Cilo d• e d;tnlalo; b, L1 fibre mu!"colari con e, r') prolirer<lzione nuc-leare oc: a, obb: 9, p. d. t . m.).
Fig. o. - Toglie di milza (V e'"o) eon o, a', «1 accumuli 1li stt·eptococchi; b, b', li') vene ripiene d1 n)olto sungne; e) lume de H' arteria d'un cor puc:colo rnalpighinno (Ka.r tnaR, oc: 3, obb: i'). F ist. 7. - R ell'l capillare del fegato (V caso) per emboli ùi streptococchi colorali col metallo di W eigPr t (Korit.ska., oc· 2. obb: 8, diaro. '275) .
Fo g. S. - Due ,tom"'uli ,.uali ( V eo") con a, •1 emboli di str eptococchi n ell'! anse capillat i ù, ù') su·eptococchi liberi nel tes!"ltto renale ( Korit-:ka, oc: 2. obb· :3, l. a.).
F i!I. 9. - Sezione normfll e d'un capi\larè <Iella sostanza. roidollere ùel rene (V caso) ripieno dt st r epl')cocchi e ò.ilalalo ( K Qritsks, oc: :\, obb: 8, p. d. t. 111.).
Fig. lù. - T.a;:h•l normale del periostio della doccia biripitale (V l caso) molto a)vac:;o con emazia con molli leucociti c con slreplococchi; l.) fu,.ione put·ulenta dd pe•·1o<>tio •spe:;stlo, con grande quan•ilu di streplococchi (Zeiss, oc: 2, obb· DD)
Fig. li. - Breve catena di cocchi ro11 un tratto di ùi,·isione nel mezzo . Dall'essudalo pericardico del conig:ho clw fu oggetto del g• espe r cmenlo. Colorazione sul 1 al biP.u di melil ne carbolico (Leilz, oc: J , obb: 16).
Fig. 12. - di feguto tlt'l cltt• ru og:gellu dell'S' espcrime1tlo o) parencluma e patico deg:enerato, con molti streptococchi: L.) mi!?razioHe cellulat·e; c) connett1vo fibroso; d) parenchima epatico n o rmal e nettamente limitato dal L fibroso e nel quale non s1 scorgono mic roo r gani!"rn (Hartnak, oc: 3 , obb: Q)
Fig. 13. - Taglio nella spessezza dd diafrttmma del comgho che fu ogg:etto del 0' esperimento . . l ) fACC18 l01'8Cica; Bl farcia aJdommule: a) di slrept.ococchi e fuc:;ione purulenta: b) attiva proliferazione cellular·e; c, c', c•' fibre mu.:;colart; l') lume di un'arte1·ia con d) migt•azione cellulare into rn o ( Korilska, oc: 2, obb: L. alzato).
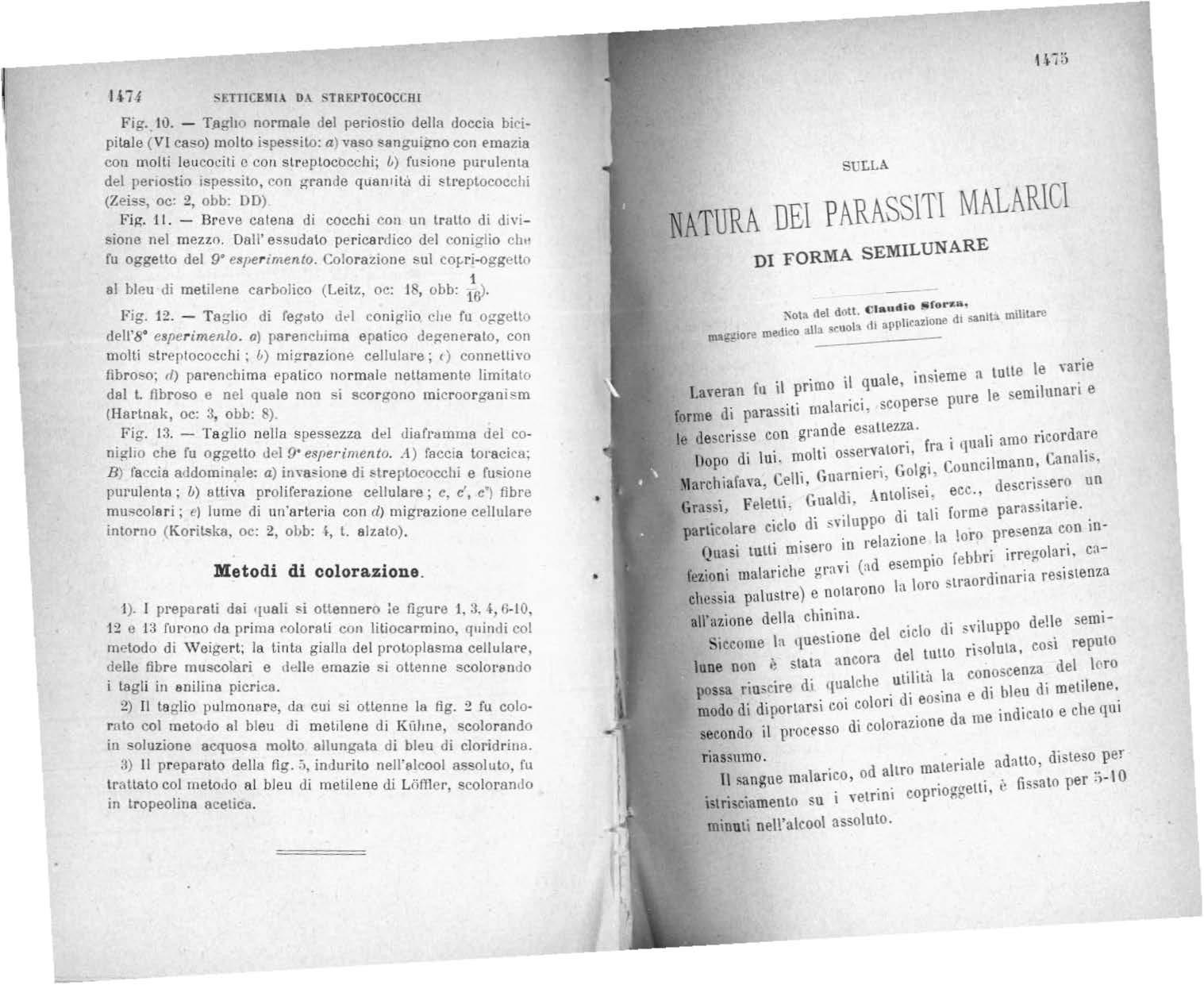
Metodi di colorazione .
l) I preparati dai •(U &Ii si ottennero le figure l, a. 12 e 1:3 fut•ono da prima rolorali con liliocarmino, quincli col rn•·t.odo dt 'Veigert: la tinta gialla del protoplasma cellulart', dellu fibre muscolari e cld le em azie si ottenne scolol'& ntlo i tagli in anilina picrica.
2) Il lag lio pulmonare, da cui si ollenne la fig. 2 fu coloralo col metodo nl bleu di met1lene di K itlme, scolorando in soluzione acquo<>a molto allungata di bleu di cloridrina.
:i) Il p r epai·alo della indurito nell'alcool assoluto, fu trattato col metoclo al bleu ili melilene di LiifTie r·, scoloranJo in lropeolina
NATURA DEl PARASS\11 MALARlCl
Di F Orma Semilunar E
C l odio lifor7-"•
;\Oli\ ciel doli. • e dc sanlta militare . • alla di nf1phr:t.l101l au;;:tore medc• o l ,·arie . . il uale, in sieme a lotte e . Lareran fu ti pnmo q ·e le .;;emilu nan e · · perse pu• · for me lli parassiti ma\:\flcl' sco .
. n arande esanezza. . d '<' le ùe"cnsse co n • { · uali amo n cor nt . \t' os'ervaton, ra • Il l' llop o di lut. mo • :; . . • l . ,,ouncil mann, C.ana t:i, Il. (' arnten Go g•. '-Marchiaf;wa, C.e 1• ' 11 ' • . descris6ero un . C.ualdt , Antoh<;et. ecc ., . . Feletll. . l' r ·me di :-viluppo d• ta • Ol - a con in. . . . . relazione la loro . Ouast tutti mtse• o •n . febbri irre"o\an. ca. \ .,ravi (ad esempto "" . fez io ni malanc te ,.. . l .traordinaria reststenza ) tarono ht oro pa l ustre e no all' azione della chinina. . 1 li "'"iluppo delle semiSiccotue la l\uestione del cl C o t .• - l la cosi reputo . de\ tutto u ' \une non stata ancOta . . . ·cenza del \ero d. l he ultltla In cono:. . possa riu;c\re • •1ua c . . .· di hleo di mettleoe. · · colon dt eo 1nn e · modo di diportnn• co• . ·ndicato e che qnt d. loraztone da me 1 second o il processo 1 co ' riassum o. d d. ·teso per . d ltro materiale a t:; . i vetrini dall'alccol e disseccalo il materiale, :.i immergono i preparati per 2i ore ed alla temperatura 1li 3i° C. (te rmo stato) nella seguente mescolanza:
Il san gue malanco, o a . . ., {l -salo per :1-1 O · · copnoggetll, t :;. su i yetnn• minuti nel\'alcool assoluto.
S•1luzione acquosa concentrata di hleu eli metilene · t'c.
Soluzione di (eosina centigrammi venticinque, alcool a iO cc. cento) » 20
Acqua dbtillata 4-0 lo grazia del materiale favoritomi da cr!l!eglli romani, e in p:1.rticolare dall"egregio doll. Giuseppe Bastinnelli, Ilo potuto eseguire no certo numero di colorazioni. o:>senazioni mi hn nno dato sempre gli ri sultati , ci oè colora.: ione ros1•a, a%ai 71allida, di q t11 tto il corpo mnilunarr in modo da farlo rassomigliare alla so.;tanza dE'Il'emnia in via di disfacime nto: nel centro (oppure assai r·arnmenle in altra sede) grossi grani di melrlnina in num ero oscillante da 16 a :H, sparsi in mezzo a piccoli spa:: i chiari non colorati ( l ).
Dopo ore i \ etrini sono dalla soluzione colorante, lavati io acqua distillala, di;;seccali, nettati e mon tali con del Caoadà.
I globuli rossi sono colorati in rosa, i nnrlci dei leucociti io bleu earir·o. f!li sporozoari 1lPIIa malaria in ltlPn pallido.
Come risullato generale ho veduto che mentre i pnras::;iti delle \arie forme malariclte (fel.Jbri terza ne. quartane, perniciosP) si sono eolorati regolarmente iu hl eu pallhlo, f/lll'lli del/l' mnilunl' non si sono rolorati aflatto in !Jl1' 11.
Cl) L:\ colornzlonc sebbene pRllldis5ÌIIIA. offre però dlvrrse gradaziom secondo il relnth·o grado tli disfadmenlo delle sem•lunP. Gli spazi chlnri corrispondcrehllero aii.L >ede •Id paraò,it.:l.
DI f'Oil MA SgM II.U\ARF. 1477 ri ,ultato si ùifl"ereozia da lutti gli altri. Di fallo aella sostanz·• cerehralc corticale di un iniliviùuo morto dae an ni fa. tanto i pnrassili racchitt!'i nello emazie libere, qu :wto quelli delle emazie contt>nute nei vnsellini cerebr.•li, :>i sono benissimo colorati.
Nelle emaz ie lilt ore sono rlistinti;;sime tre cosf', c1oe: l o la par te colorata in rosa che corriall'l ponione di emazia conscnata: il parassita che, secondo il grado dr sviluppo, ocin rnedia rla un decimo a•l un quarlo del ---•v•'" '• •·olorato in bleu pnll1do; a• entro il i finissimi granuli di riun it! in blocchetto unico, altre volte in cerebrali, io cui rruasi ovni emazia un benis;;imo il rotore IJleu quP,;tu, i hloccltrtti rli pigmenlo etl il colore roseo ciel o ro sso, co lore che si ,·ede diiTuso per ,.._-,.. r ..... utinarnenlo delle emazie. che durante il loro ri•·lo di sviluppo in'adoo o tutta l'emazia, della terzana e della 'luarlan:t di lo sporozoa1·io in tullo il suo cirlo di luppo ed anche nE'Ila fa5e ùi segmentazione si colMa aempre in hlen.
Se aduOIJIIe su i risultnti di tale colorazione potesse un giudtzio, Lisognerehhe concludere che nd/1' lemilun •· tratti di degenrm.:ionl' di alwni para,m"li a 'flltlla rm·irtrì, lrt qut:le durantP il suo intil'l"ll tlct., 1li s11il1tppn non invad1• clw in parte il corpuscJJ{O dd sangw· t' cht• la r)()r.:ione maggiori' del cm·po non. sin altra cosa che lu stt·ssa ema::ùt in ,.,a di
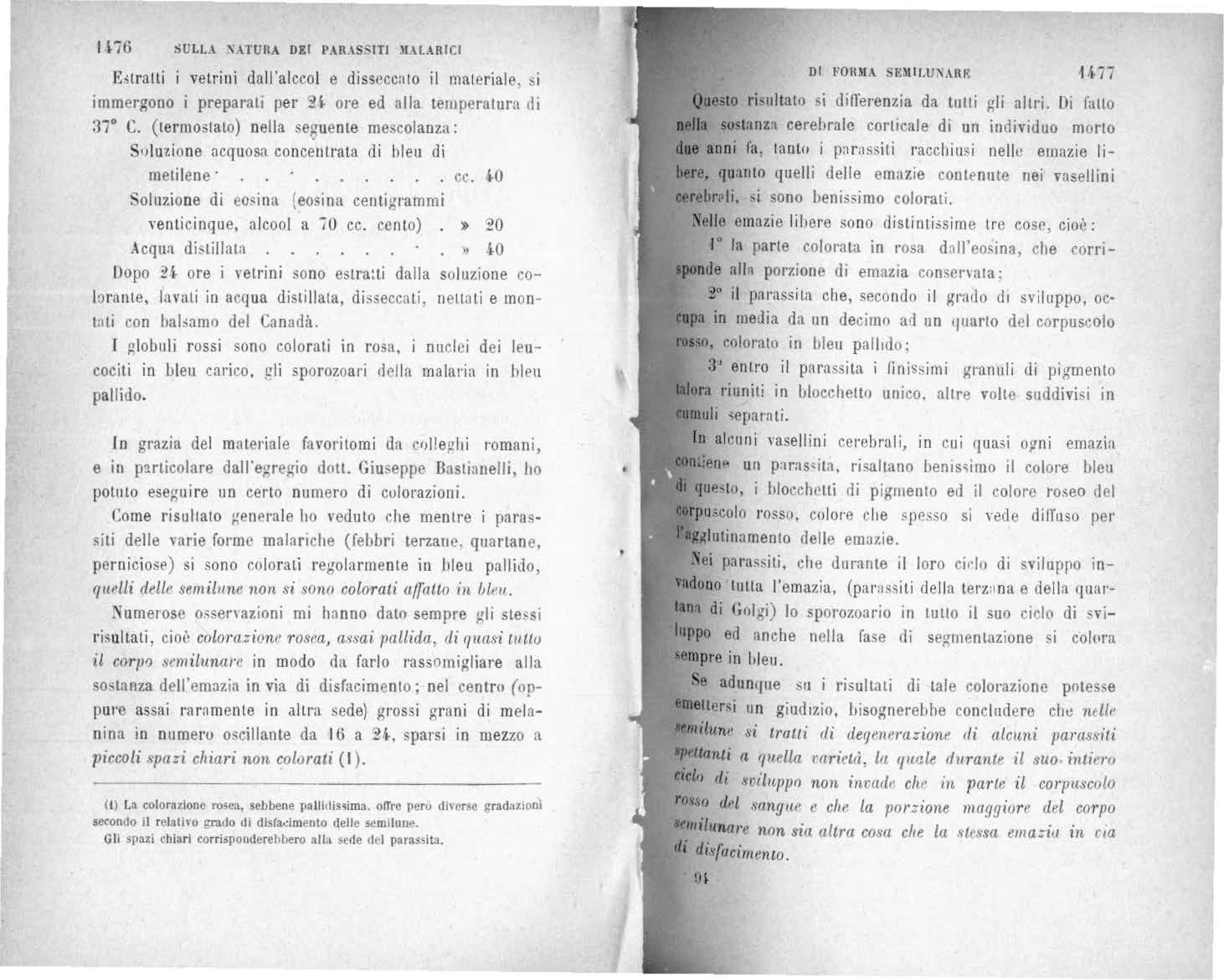
Oppure hisognt'rebbl! ritenere che si tratti di malarici 1 quali, a differenza di Lulte le al(re ,·arielà, non l'i colorino col bleu di metilene, ma con l'eosina. il che non semhra pun to arHmissiuile.
Da ultimo deside ro notare cbe il materijlle della perniciosa coma to:;a è , lat o colora to circa due anni clopo rac· colto. mentre quello delle semilune fu da mfl ollenuto :n Homn all'o:>pedale di S. Giovanni in Laterano nel clecor o e colorato pochi giorni dopo co n :;oluzioni re-
SULLE 01 SUBLIJIATO LORRfiSI Y ll
CONTRO LA S I FIL ID E
Firenze, 20 ouollre 1893.
S t oria del metodo .
Fino a qua lche addietro la iniezione tli liquidi ent ro i va si san)!uigni si intrapre nde va con molta ri luttanza. Il timor·e del!'3 embolie gnsRose, nei libri come ordinariamente fatali. il pratico dall'interven it·e co n que:;to presidio terape utico, che pure era stato l"i co nosri uto ef!ìcncissimo iu alcune condizioni morbose. Contribuivano inoltre a togliere favore a questo metodo di cura la difficoltà della tecni ca, per cui erano stati propo.;ti molti apparecchi speciali complicati e r.ostosi. e le minutissime cautele consigliate dagli fautori delle in iezioni endovasali, riguardanti l'atto ope,•ativo. la preparazione dell'ammalato edelle vene da incidersi. In questi llllimi anni. scemato il timore delle emb olie gassose. se mplificato l' appa recchio strum enta le e generalizzata la lìducia nel metodo asettico, furon o eseguite spesso le iniezioni endove nose di liquidi, se nza andare incontro a gnlVI mcidenti, tan to che esse in qualche clinicn so no di venute al•i lu:\1 i ( 1) .
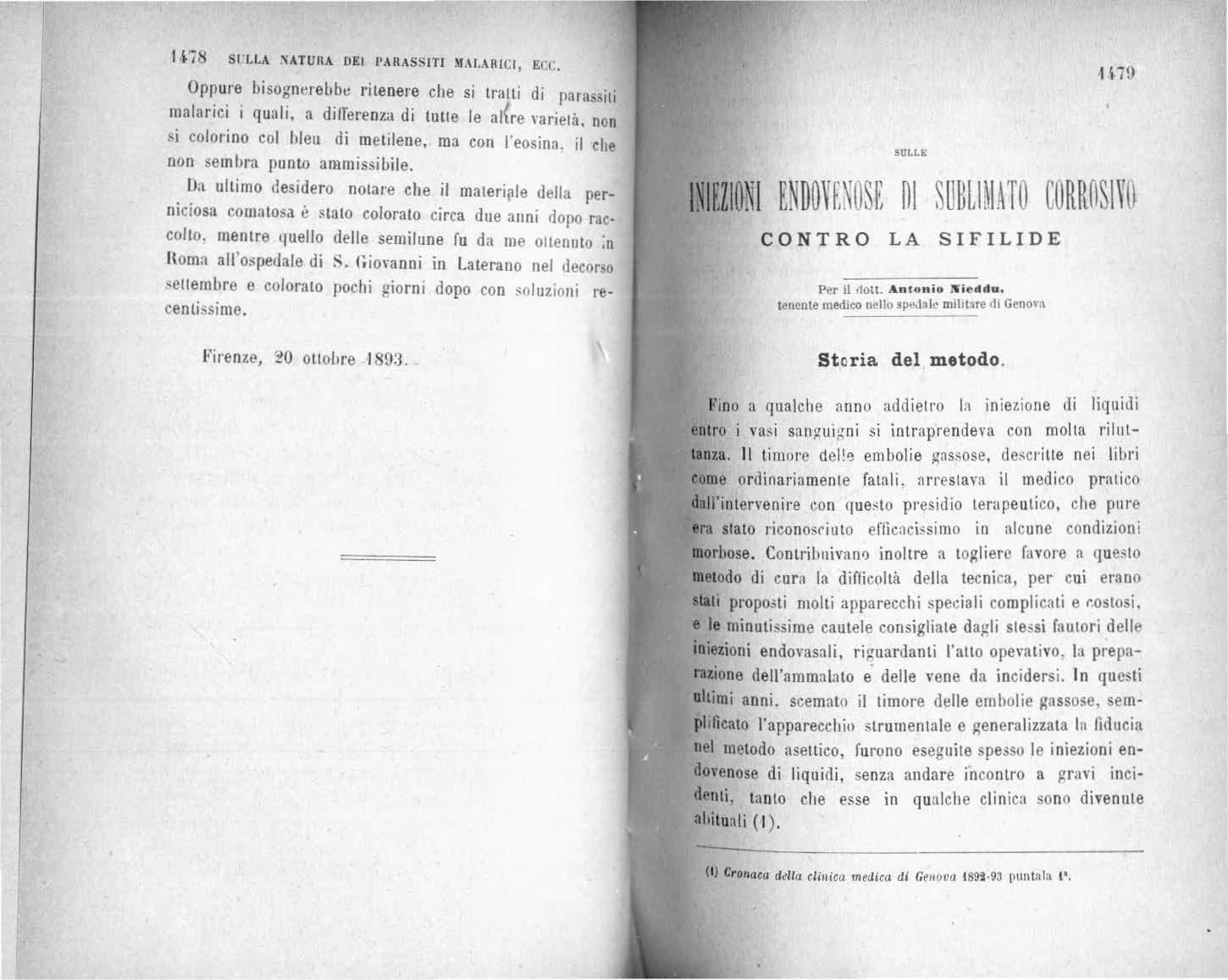
. sin qui. crasi. lrallalo della intro•luzione nel Ctrcolo dt soluzio ni di clo ruro e di clodi sod.io e bicarbonato di :;oda, le qua li erano state dimostrate mnocue .al. dalla chimica e dagli rimenti. La somm tntstrazwne endavenosa tli medic111ali ben altri pericoli. prtncipali fra la possJbiltta. dt lndurre la coagulazione del sangue e quella di col farmaco un'azione troppo dirella e troppo energtca.
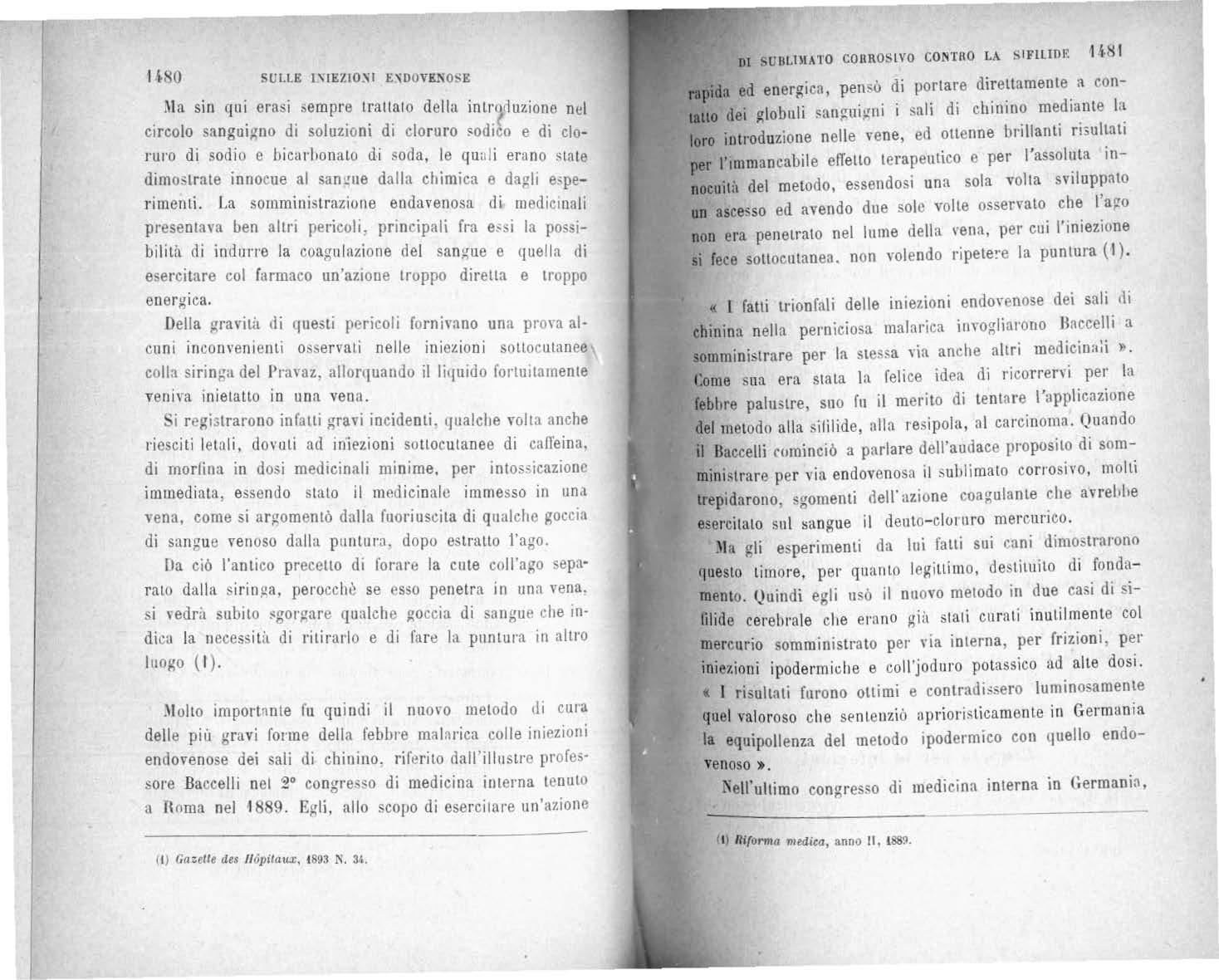
questi pericoli fornivano una proYa al· cunt mconventtlnlt osservati nelle iniezioni sottocutanee colla siringa del Pra\az, allorquando il liquido fortuitamente veni\a inietatto in una vena.
. Si. infatti gravi incidenti. qualche volta anche "'.oscttt letali, dovuti ad miezioni sottocutanee di caiTeina. dt morfina in dosi medicinali minime, per inlosoicazionc immediata. essendo stato il mP.dicinalc immesso in un.t come si argomentò dalla fuori uscita di qualche goccia dt sang ue venoso dalla puntura. dopo estratto 1'atJO. fla ciò l'an.tico precelto di la cute sepa· dalla Stfln.aa, perocchè se esso penetra in una vena. SI vedrà subito $gorgare qualche goccia di san"ue che m· dh:a la necessitil di ritiral'lo e ùi fartl la in altro luogo ( 1).
import,nle fu quindi il nuovo metodo tli cura delle più gravi forme della febbre malrtrica colle iniezioni endovenose dei sali ùi chinino. riferito dall'illttstt·e profes· sore Bacce lli nel 2° congre.;;.;;o di medicina iutema tenow n Hnma nel 1889. Egli, allo scopo di esercitare un'azione rapida ed energica, di portare direttamente a conllllO dei globuli i !ìa li di chini no mediante la loro introduzione nelle vene, ed ouenne brillanti risultati per l'tmm ancabile effetto terapeutico e per l'assoluta innocuitil del metodo, essendosi una sola volta sviluppnto on ed avendo due solo volte osservato che non era penetrato nel lume della 'ena, per cui l'inieziCine si fece souocutan ea. non volendo ripete;e la puntura (1) . l fatti trionfali delle iniezioni endovenose dei sali tìi ehininn nella perniciosa malarica iuYogliarono Bnccelli a somm inistrare per la ,ja anche altri meòicinaìi )).
Come sua era stata la felice idea di riconeni per la febhre palustre, suo fu il merito di tentare l'applicazione del metodo alla sililide, nlla resipola, al carcinoma. IJoand o il Baccelli cominciò a parlare dell'audace proposito di somper via endovenosa il sultlimato corrosh·o, molti trepidarono. sgomenti dell'azione coagulante che avrehl•e esercitalo sul sangue il deuto- cloJuro mercurico. esperimenti da lui falli sui rnni dimostrarono IJuesto timore, per quanto legi llim o, destituiLo di fondamento. IJ uindi egli usò il nuovo metodo in due casi di sifilid e cerebrale che erano giit stati cu rati inu tilmente col mercurio somministrato per \'la interna, per frizioni. per inie1.ioni ipodermid1e e co ll' jodnro potassico ad alte dosi. • l risultati furono ottimi e contradi:;sero luminosamente quel valoroso che sentenziò aprioriiìLicamente in Germania la equipoll enza del metodo tpodermico con quello endovenoso-..
Nell'ultimo di medicina interna io Germani 11, te nuto a \\' ie5bade n dal l O al 15 aprile di quest'anno, il prof. che le aveva viste a Roma,( parlò delle iniezioni endove nose di sublimato . seduta del ;) giugno 1893 della R. accade min medico- chirurgica di f:enova il doLI. .lemma riferi\'a intorno ar buoni effeui a' uti colle iniezioni endovenose in quattro ammalati affetti da sifilide, mentre esponeva come fosse precoce il trarre all'una conci usione sull'erli cada del metodo nel!e altre malattie in cui era stato 1la lui Psperime ntato. e che erano 6 casi di tifoidea, l di poliartrite reumatica. l di r·e:>ipola. l di ..\ oche il pl'of. Milragliaoo, nel discorso di chiusura dei corsi eli· nici dell'istituto di clinica medica a accennava alle iniezio ni endovenol>e di snhl imato corrosiro. dal do tt. J emma so tto la sua direzio ne. t:ome per le iniezio ni di cl tinioo, il Baccelli si serve di •na com une 11 dott. .lem ma usa pure una comu ne siri nga dèl Pravaz, ehe dice ri spondere he nissimo allo scopo. . .
11 nuovo metodo di cura ed i risultnti co n esso olleouti fu r ono ver balmente comunicati dal Baccelli al prof. raglia no, il quale incnricò l'egregio assistente dott. .Jemma di continuare le ricer·che.
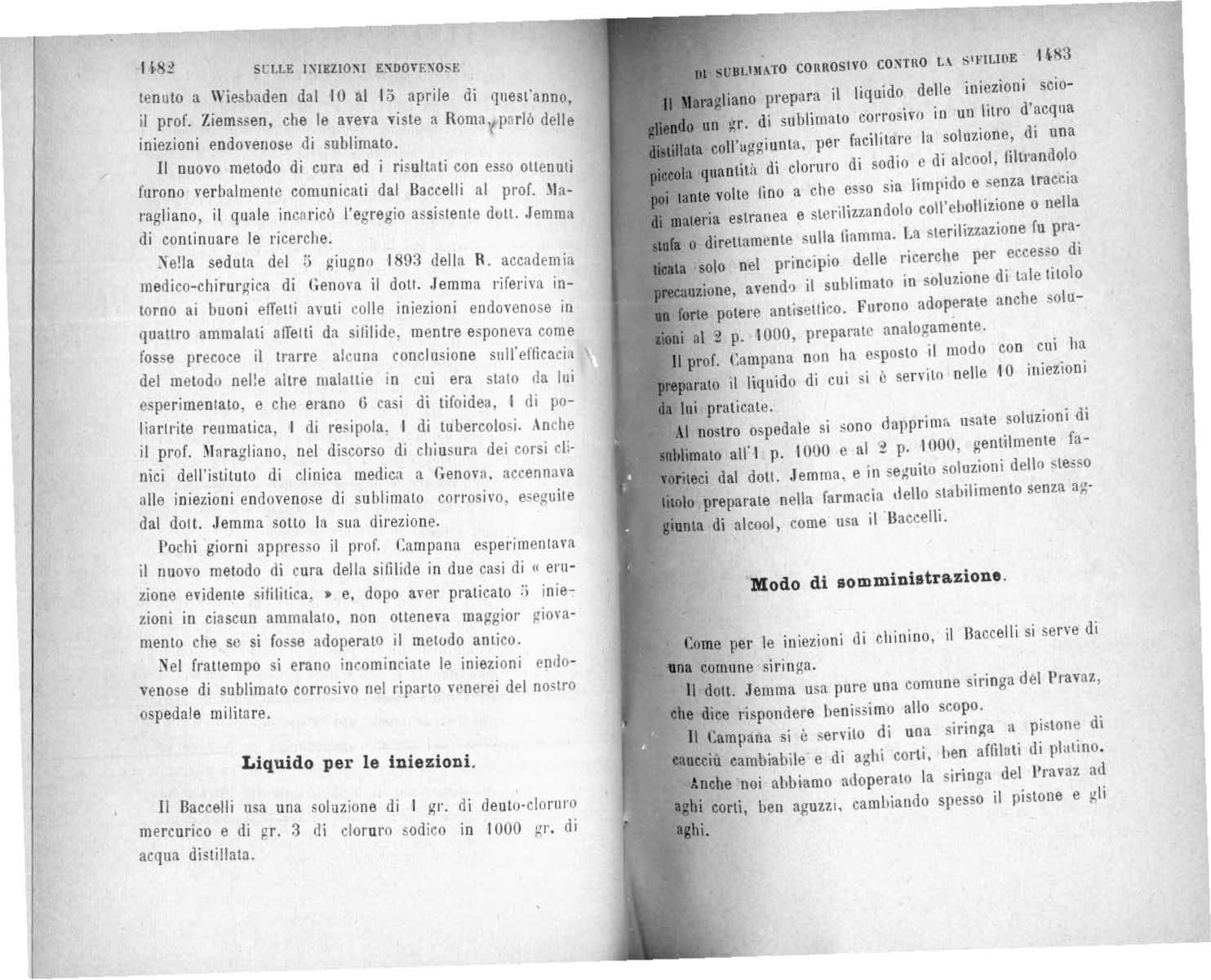
Pochi gio rn i appres:>o il prof. Campana esperimenta\'a il nuovo metodo di cura della sifilide in dne casi di « eruzione evidente sifilitica. • e, dopo av er praticato i1 iniezioni in ciascun ammalato, non olleneva maggior gio,•amento che se si fosse adope rato il metodo amico. frauempo si erano incominciate le iniezioni endovenose di sublimato corro;;ivo nel l'iparto vener·ei del no;;tro osp edal e militare.
Liquido pe1· le iniezioni.
J l Baccelli usa una soluzione di l W· di deulo·cloruro merc urico e di gr. 3 di sodico in l 000 gr. di acqua distillala.
Il prepara il liquido sciod •rr di subl imato corrosivo tn un lttro d acqna .... o un n • • • • d' na iialillata co ll' ugg iu nta. per fac lltta_r·e In _sol uziOne: . 1 u 'eeola di cloruro di sodto c d•. alcool, ftltt pl. tante volte lin o a che esso sia limptdo e senza tracr.ta estranea e stcrilizza ndolo coll'ehollitione o nella t ·1· · e fu pra- slofa o direttamente sulla tinmma. La ,zzazton . licala solo nel pr·incipio delle ricerche_ per dr NW'..auzione, avend•> il suhlimato in sollr7.rone dt tale titolo r· P. doperale anche ;;olu- to fort e potere anttsett rco. rurono a lion i al 2 p. 1000, preparate annlo',\amente.
Il prof. Cam pana non hn il modo con cui ha · Ile 1O iniezioni Jreparato ti liq uido di cui si è ser vtto ne da lui prati cate. . · d· Al no.,tro ospedale si dapp r imr. usate _soluz•ont t anblimnto all' l p. l 000 e al :2 P· l OOO, genttlmente faloriteci dal do tt. J emma, e"' se,:uito soluzioni dello lilOlo preparate nella fa r macia ,!ello stabilimento senza giun ta di alcool, come usa il Baccelli.
Modo di somministrazione .
Il Campana si è :.ervito di una si ringa a. dl eaoeciù cambiabile e di aghi corti, he n affìlalt dr platmo.
An che noi ahbiamo ado perato la "irioga del Pravaz aghi torti, ben aguw, camhiando spesso il pistone e glt agh i.
Le vene scelte furono generalmente quelle dell· . del · 1 .1 Jl'e"a gom,to e e superficiali delle nvamur.tccia. inoltre queue della gamba dal .dott ..Jemma e quelle del dor.'"> della mano dal .e da n.oi.. t urgo re di esse 'iene prodoti o per mezzo d, alcun' 1-:11'1 di fascia ''PP',·c"l·, al L . • · • u • eJZO 111ler10re del lm1ccio.
I l pun to per l'iniezione si disinfetta srrupolosameute con soluzJOno di suul imato all',! p l 001) d' 'l f . .. · o 1 ac1c o 61JICO al.) p 100 :'\oi ,', 'l d . . . • Sl.llllO USI avare apprima con olio <h trementina per togliere l' ontume della pelle, poi con acqua calda snponata e infine c 'la :.oluZione an t l i dotL Jern ma introdu · J' · ..
. Per Baccelli la sicurezza che si è nel lume della vena VIene data dalla perfella mancanza tli qualunque dolore durante l'iniezione e d·lll'a.. d' . . . . · ' ssenza ' quals1as1 tumclazJOne soltocutanea che nccenni al deporsi del rimedio la pelle.
1 . ce ago. Innestato alla smn;a.
0 IUIIquamente verso il cuore e dit•e che« neorlj
« che h 'l · · · " . anno ' Sistema venoso heo sviluppato si
« rap1ta con molt C· ··1·: 1 1 a .1c1 1t.t ne urne del vaso, quaudo iorere
« la ''ena è di p·c, 1 l'l 1 · . ' co o ca 1 n·o 11sogna usare molta at1enzione
« sta perchè il vaso può sfuggire e sia perchè si possono fo-
« rare LuLLe e due le pareli della vena e r1ui ndi si
• farebbe nel connettivo inlersl iziale. Se avviene ciò il IJle-
« dico si a rvede facil mf'ntc pe1· la hozza che si va
« il dolore che accu:>a l'infermo, ed allora bisogna ri·
« hrare l'ago e scegliere 1;n nltr·o punto ( 1).
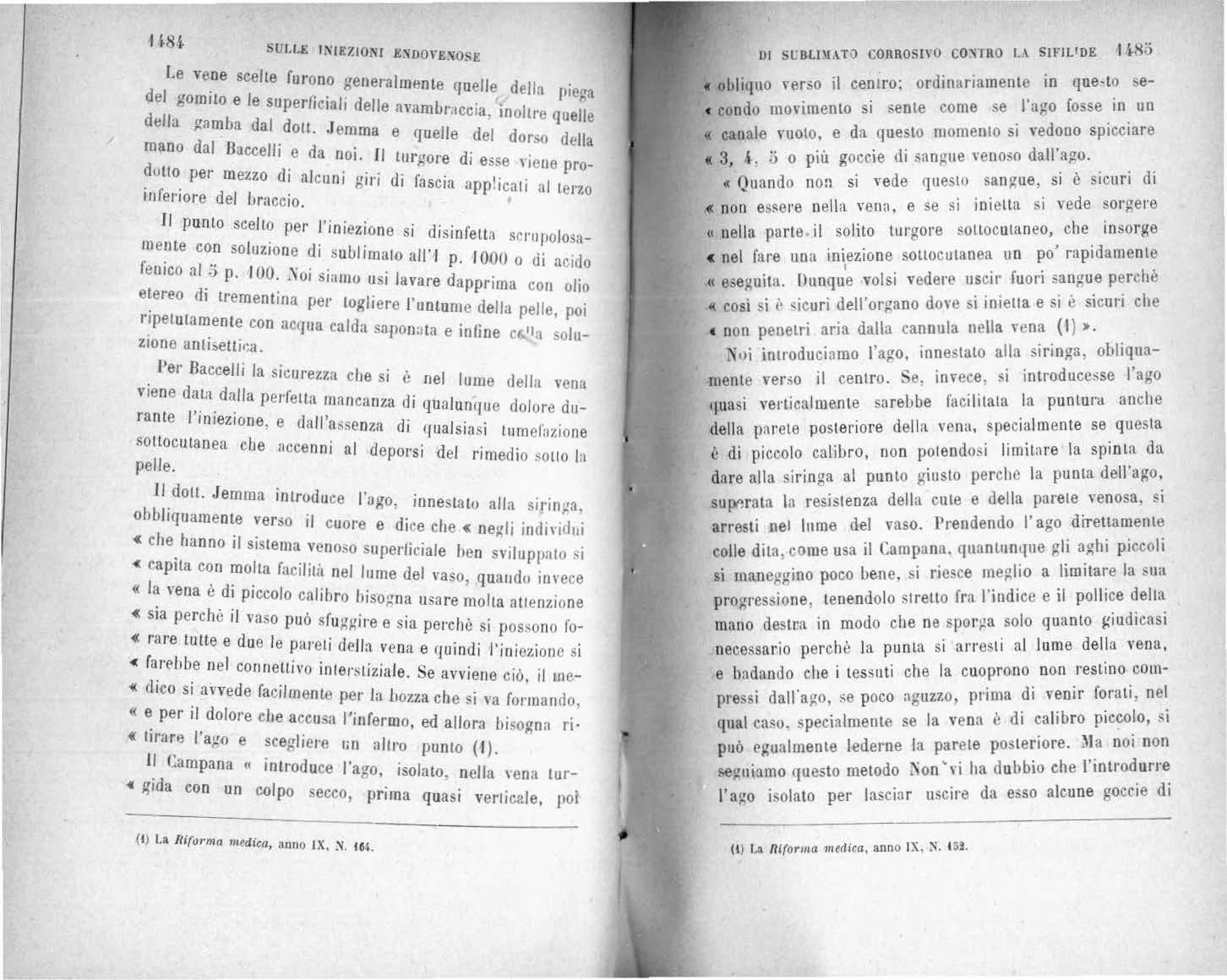
1! Campana << introduce l'ago, isolato, nella 'ena tur-
• a,da co n un colp , · · . .., o secco, pr1ma quast verllc?.le, c obli <plO verso il centro; ordinariamente io que-to ec condo movimento si come se l'ago fosse in un « canale vuoto, e da questo momenlo si vedono spicciare (( 3, 4. ;.) o più goccie di sangue ,·enoso dall'ago.
(t) La Riforma medica, ilnno IX, :'i.
« (j uando non si vede questo sangue. si è sicuri di «non nelht vena, e se si inietta si vede sorgere 11 nel la parte il solito turgore che insorge c nel fare una iniezione sottocutanea un po' rapidamente << eseguita. lhmqn'e volsi vedere uscir fuori sangue perchc « cosi è ,jcuri dove si •niella e s1 è sicuri che c non penetri aria dalla cannula nella vena (1) ».
\1 >i introduciamo l'ago, innestato alla siringa, obliquamente il centro. Se. invece. 5Ì introducesse l'ago 11 uasi verticalmente sarebbe facilitata la puntura anche dell a parete posleri ore della vena, specia lm ente se qu esta è di piccolo calibro, non polendosi limitnre la spinta da dare alla si rin ga al punto giusto percile la punta dell'ago, In resistenza della cute e della parete venosa, arresti .nel lum e del vaso. Prendendo l'ago direttamente colle dita. come usa il Campa na. quantunque gli aghi piccoli si maneggino poco bene, si riesce meglio a limitare la !'>U<l progressione. teoendolo slrelto fra l'indice e il man o destt•a in modo che ne spol')!a solo quanto gmù1cast necessario perchè la punta si arresti al lume della vena, e badando che i tessuti che la cuoprooo non restino com· pressi dall'al-(O, se poco :1guzzo, prima di venir forati, nel qual caso. specialmente se la vena è di ca libro piccolo, può t>gualmenle lederne la parete posteriore. noi non se:,:niamo questo metodo ·,i ha dubbi o che l'introdurre l'ago i:>olato per lasciar uscire da esso alcune goccie di
SUI,LE lNl.EZIONI RNDO\'ENOSE
->angue venoso dù la maf:(giore sic urezza che si è penetrati nella vena. auhiamo timore che il sangue contenuto n_el lume de/lago poss1 coagularsi e che venga spi nto in cu·colo coagulato e crediamo utile uon farlo venire a conLalto coll'ar·ia esterna.
La che avverte la mano dell'operatore. come _l'ago fosse in un ca nale vuoto, ci fu generalm ente suf lrcrente per renderei sicu ri d'essere penetrati nella vena del che la prova veniva for·oita indirettamente dal non ger·e alr.un :-;ottocu taneo nnche inietlaodo l'apidameote e pe.rhno senza toglier·e il ci ngolo al braccio e sen ·azione dolorosa. e direuamente da che alla punta ago estratto nderiva una goccia di sangue e se si lasciava un ce rto tempo fra l' in fissione dell'ago e la sp 1n1 a dello ·1 . · , o, 1 sangue r·wlll'"Ìtava entro. In s iringa. Dohhiamo però avvertire che n:i
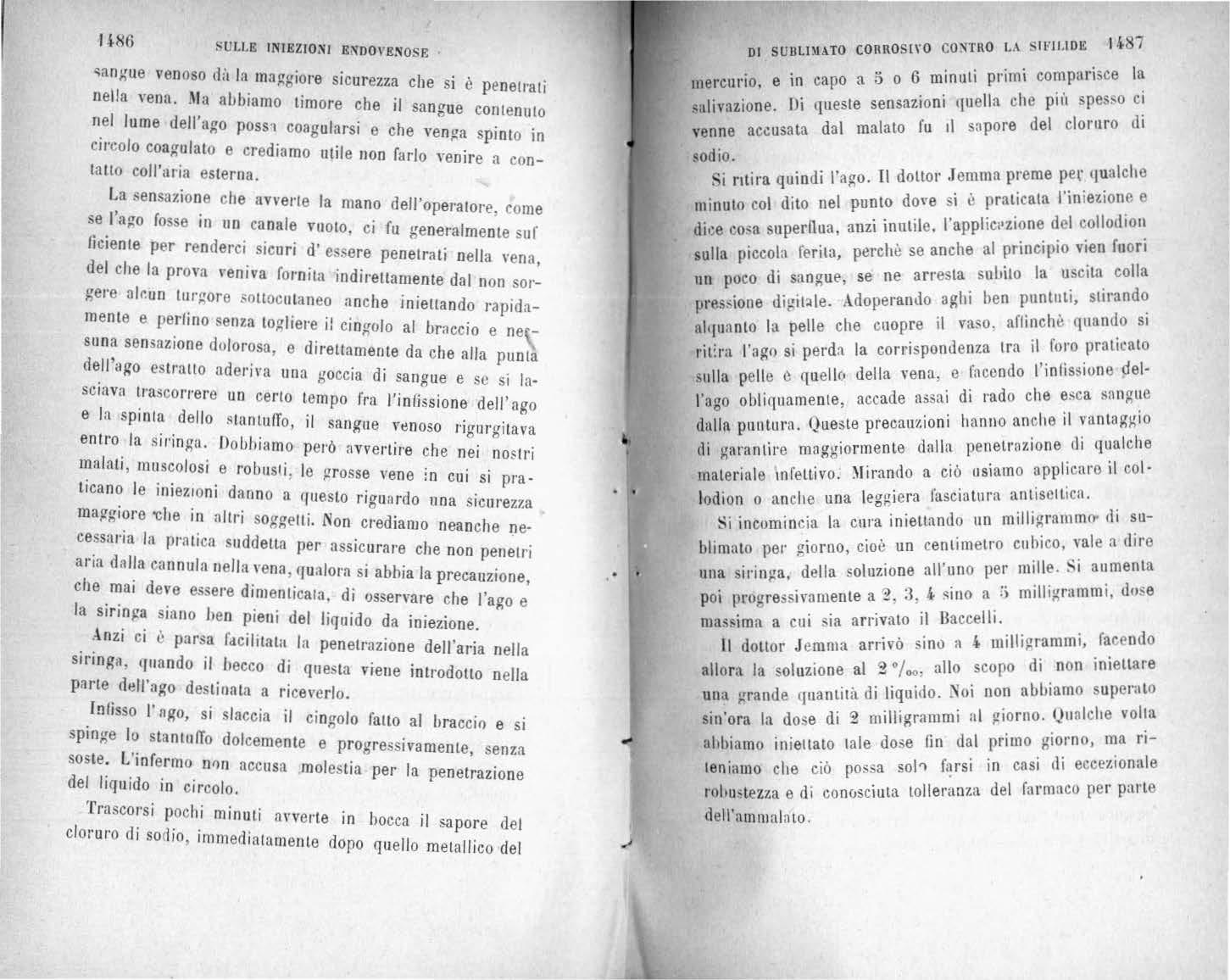
.e rouusri. le vene in cui si prale llllOZI OD I danno a questo rigua rdo una !\icurezza poc hi minuti ll\'verte in hocca il sapore del clorur·o ù l' · ,.l· l SO( IO, lmm e.,ratamente dopo quello metallico del mercuri o, e in capo a. 5 o 6 minuti primi comparisce la sali,azione. Di queste sensazioni quella che pii1 ci venne accusata dal malato fu 11 del clor uro di , i ntira qui ndi l'ago. 11 dottot· Jemmn preme per () Uniche minuto col dito nel punto dove si è praticata l'inietione e di l·e co'a superflua, anzi inutile. l'applicnione del collodio n sulla piccola ferita, perchè se anche al principio vien fuori 110 poco di sangue, se ne arresta suhito la uscita colla ùigit:tle. Adoperando aghi ben altfiJanto la pelle che cnop re il vaso. aflinchè quando sr rit:ra l'ago si perda la corrispondenza tra il foro pratirato wl/a pell e c quello della Tena, e facondo l'infis:;ione dell'ago obliquamente, accade assai di rad o che esca snngue dalla puntura. Queste preeau'l.ioni hanno anche il vantaggio eli garantire maggiorm ente da ll a penetrnzione di qualche 111aleriale 1nfettivo. )J irando a ciò usiamo app licar·o il co l· lodion o anche una fasciatura antiseltica.
'Che in altri soggelli . crediamo nea nche nela pr·atica suddetta per assicurare che non penetri arlll dal!a cannula uella ' ena, q ualora si abbia la precauzione , che ma1 deve e··er·e d'n 1· d' . . . ' Jen rcara, l 'JsserTare che l'ago e la SH\no heo pieui del liquido da iniezione.
. :.\n zr cr è parsa facilrtata la penetrazione dell'aria nella Sll'l nga. quando il hecco di questa viene int•·odotto nella parte dell 'ago destinata a •·iceverlo.
Inlisso l'ago, si slaccia il cingolo fatto al braccio e si spinge stantutTo dolcemente e progressivamente, senza soste: L _ Infermo Mn accusa molestia per la penetrazione del lrqu1do in circolo.
Si incominr. ia la cura iniettando un milligrammo- 1li sublimato per gio rno , cioè un centimetro cubico, vale a dire una della !!oluzio ne all'uno per mille. Si aumenta poi a 2. :3, 4- "ino a :; milligrammi, duse a cui "ia arrivato il Baccelli .
11 dottor J emma arrivò sino a 4 millif:(rammi, facendo allora la sol uzione al 2 °/00 • allo scopo di non iniellare un a grande •rnantilil ùi liquido. non abbiamo superato S111'ora la dose di <2 milligrammi al j!ioruo. Qu nlcl1e volta ahbiamo iniettato tale dose fìn dal primo giorno, ma riteniamo che ciò possa so/'l farsi in casi di eccezionale e di conosci uta tolleranza del farmaco per parte dell'nmm nlnto.
Inconvenienti.
Gli inconvenienti orr.orsi sin'om nel praticare le iniezioni endovena ·e di suulimnto furono di poca entitil:
1° .\ lcune volte accadde cb e oon si penetrò nel lume della vena o perchè essa sfuggi o, più dr rado, perchè se ne allra\ersù tutto lo spessor-e. 11 fatto sarebbe avve nu to in circa il 30 "/ o delle iniezioni praticate dal doUot· J emma, mentre al Campana non è mai occorso, in grazia della precauzione da lui consigliata, <lhe dii una sicurezza assoluta. A noi è occorso quattro volte. !.'iniezione è allora semplicemente sollocutanea e rome tale poco pfficace per l'psiguita della dose.
2° Può succedere che un po ' ti i sangue str·avasato si spanda nel tessuto cellular-e sollocuraneo che ci rco nda la vena. La pelle assume allora un colorito azzurognolo. rhe pre:cto passa al giallo, liuchè scomparisce completamente senza che l'infermo si sia risentito di alcun di$turho. 300 iniez ioni praticato da l douor .Jomina , il fallo è acca· duto appena 20 volte; nelle pmti cate da noi solo tre volte. Riteniamo che usando aghi sottili. questo inconveniente è rat·o. Aù ogui modo esso ha poca importanza.
3" l n alcune condizioni morbose può nccndero che, in causa dell'edema degli arti, le vene ·superficiali delle avambraccia e della pieg·1 del gomito sia no cosi poco apparen.,.; che riesca imp ossibi le praticare le iniezioni endo· veno!>e. Possono allora farsi al dorso delle mani, la quale cosa non ci fu neanche essa poss ibile in un caso di pemligo sililitico. L'i nconveniente potrit forse accadere pure in condizioni lor.ali non patologiche, come negli individui adiposi e nelle donnt>.
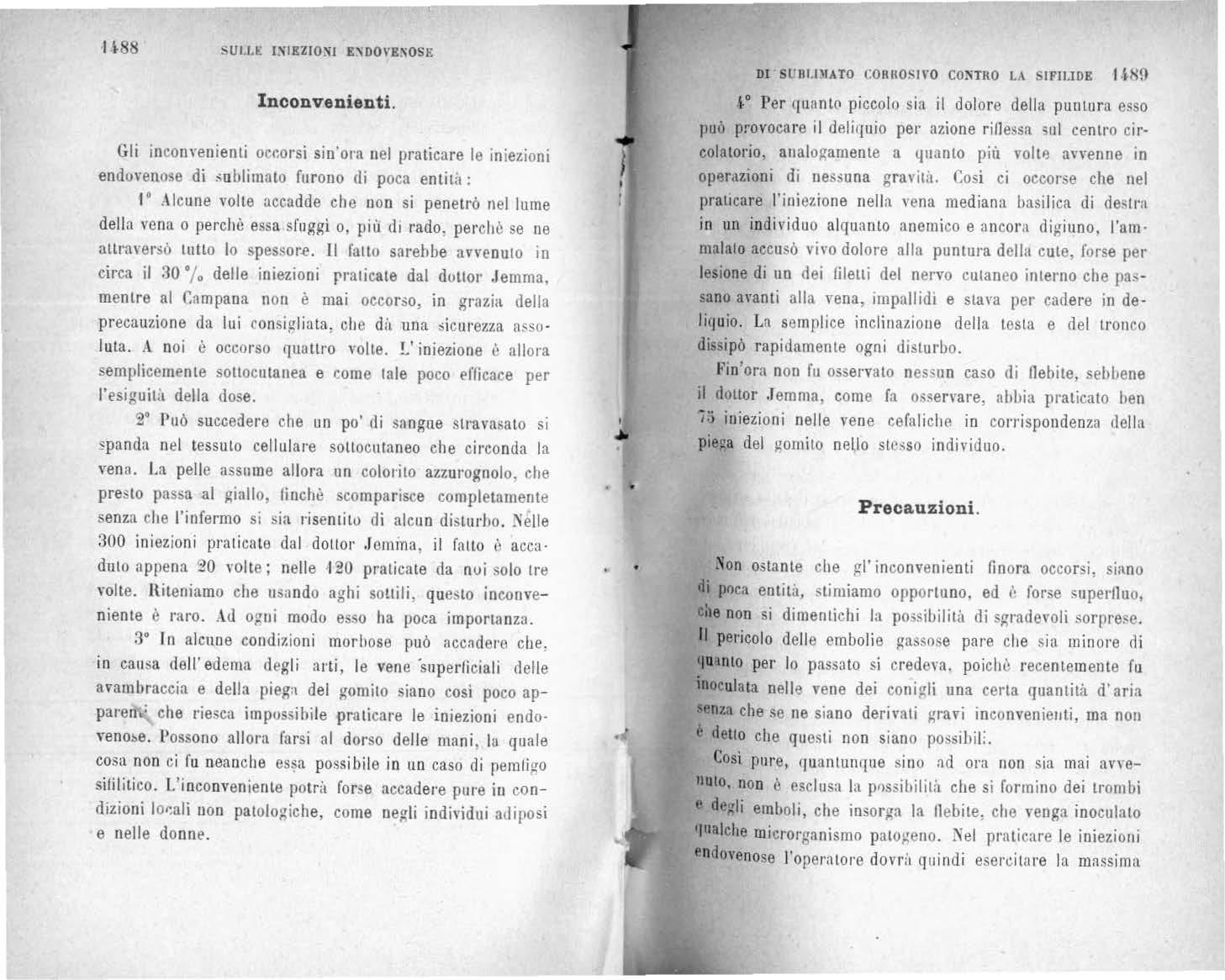
DI SUBJ.I'IATO COl'iTRO L.\ SIFILIDE li-H9
i- 0 Per quanto piccolo sia il dolore della puotura può provo care il deliljnio per azione sul centro cit·colatorio. a llllanto più avvenne in ow•razioni dt nessuna gra vttit. Così ci occorse che nel prallcare l'ini ezione nell a 'ena mediana basilica di deslt·n in un indi viduo alquanto anemico e ancor·a digiuno, l'am · malato accusò viro dolore alla puntura della cute. forse per lesione di un dei filetti del nervo cutaneo interno che pn,-sano avanLi alla vena, impali idi e stava per cader·e in deliquio. Ln semplice inclinazione della Lestn e del tronro dissipò rap idamente ogni disturbo.
Fin'ora non fu osservato caso di flebite, sebhene il Òllllor .J emma, come fa osser\'are, ahl>ia pr·aticato hen i:) iniezioni nelle vene cefaliche in conispondenza della pie:,:a del gomito nello stc:;so individuo.
Precauzioni .
o.stante rhe gl'inconvenienti finora occorsi . siano di poca entità, stimiamo opportu no , ed '' forse superfluo, cile non si dimentichi la di sgradevoli
Il pericolo delle embolie gas!'\ose pare che ll ia minore di per lo passato si credeva. poichè recentemente fu inoculata neii P vene dei coni)!li una certa quantità d'aria senza che se ne siano derivati inconvenieuli, ma non e detto che qu es ti non siano possihil:.
Cosi pure, IJuantunrrue sino ad ora non sia mai avvell Uto, non {• E'sclusa la P'>Ssihilitit cl1e si formino dei Lrombi e dt';!li emuoli, che insorga la llebite. che venga inoculato ' llla(che mi crot·ganismo patogeno. Nel pmticare le iniezioni tt ndovenose l'operatore dovr i1 quindi eserdture la massima










