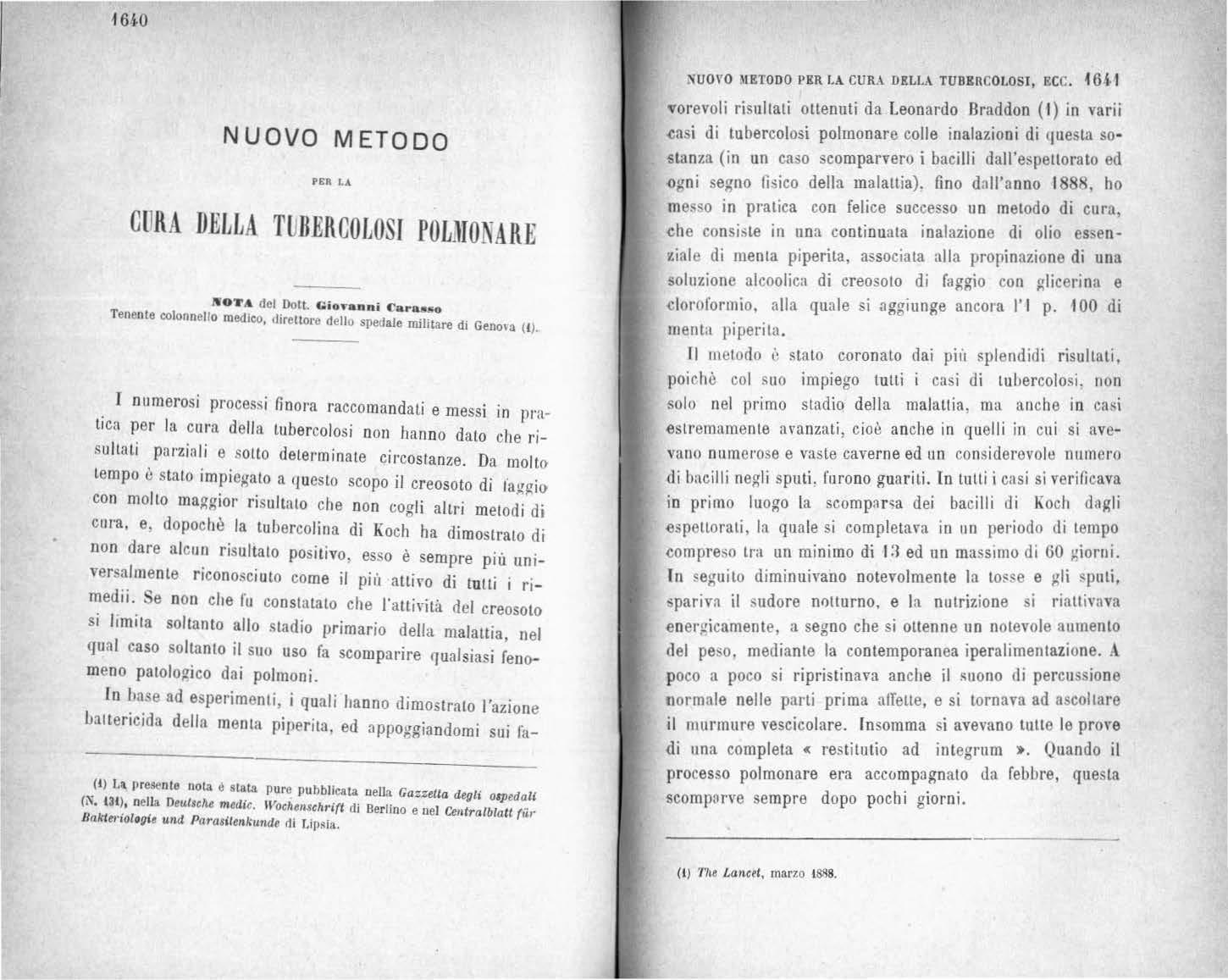
27 minute read
CURA DELLA TLBERCOLOSf
. I num erosi processi finora raccomandati e messi in pmtlcn per la cur-a della tubercolosi non han no dato che risu ltati parziali e sotto determinate circostanze. Da molt(} tempo è stato impiegato a q uesto scopo il creosoto di fa.,"io con molto maggior risul tato che non cogli altri cura, e, dopochè la tubercolina di Koch ba dimostrato di non dare alcun risultato positivo, esso è sempre più universalmente r iconosciuto come il più atli>o di tulli i rimedii.. e non che fu constatato che l'atti,·ità del creosoto si llm1ta soltan to allo stadio primario della malattia nel qual caso soltanto il suo uso fa scomparire qualsiasi fenomeno patologico dai polmoni.
In hase ad esperimenti, i quali l1anno dimostrato l'azione !Jattericida della menta piperita, ed appoggiandomi sui fa-
Advertisement
464.1 vorevoli risultati ottenuti da Leon ardo Braddon ( l} in vari i easi di tubercolosi polmonare colle inalaz ioni di I{Uesta so · stanza (in un caso scomparvero i bacilli ed ogni segno lìsico della malallia). fino dall'anno 188 , ho in pratica con felice successo un metodo di cura, che consiste in una contin uata inalazione di olio es:;enziale di menta piperita, associata alla propin azione di una soluzione alcoolica di creosoto di faggio con glicerina e c loroformio, alla quale si aggiunge ancora l' l p. 100 di menta piperita.
'iUOVO METODO PKR
.(
1) La presente nota è stata pure pubblicata nell'l Gazzella degli OI]JedaU (l'i. t3l), nella medie. IVocllanschri(t di Ber lino e nel Centralblatt r-. Baktm ·iologl e und Parasllenkullde Ili J,ipsla. ut l ()4,2 NUOVO METO DO PBR LA CURA UKLL.\ TUnERCOL OSJ, ECC.
TI rnetorlo 1\ stato coronalo dai più !\plendiùi risultati, poirhè col !iliO impiego tutti i casi di tubercolosi. non :;olo nel primo stadio della malattia, ma anche in casi estremamente avanzati, cioè anche in que lli in cui s i avevano num erose e vaste caverne ed un considerevolu numero di bacilli negli spu ti. furo no guariti . In tutti i casi si verificava io primo luogo la scampana dei bacilli di Koch dagli In quale si completa>a in un periodo ùi tempo eompreso tra un minimo di l :J ed uu mass1mo ùi 60 giorni. l n diminuivano notevolmente la tosc:e e gli sputi, spariva il sudore nollurno. e In nutrizione si riattivava e neq.!icamente, a segno che si oltenne un notevole aumento del peso, mediante la co ntempo ranea iperalimentazione. A poco a poco si ripristinava anche il suono di percussione normale nelle parti prima aiTeLLe, e si tornava ad a:;coltare il murmure vescicolare. rnsomma si avevano tutte le prove di una completa < restitutio ad integrum ». Quando il processo polmonare era accompagnato ùa febbre, questa scompnrve sempre dopo pochi gio mi.
Questi splendidi r1sultati sono stati constatati in non me no di :19 cn:.i di tubercolosi in tuili gli stadii. però sempre in casi in cui la tubercolosi era limitata ai soli polmoni. Ua quanto precede ri sulta che la menta piper.ila. introdotta nell'organismo mediaute l' inalawm e, eserc1 tn un'aziont• halloricidn immediata sui bacilli tll'lla tubercolosi. u.na indireua mediante !"introduzione Pl'r lo Stomaco. ) I l l'l SOrÙO di comunicare in serruito maorg1ori d l. l " euag 1 su la casu istica.
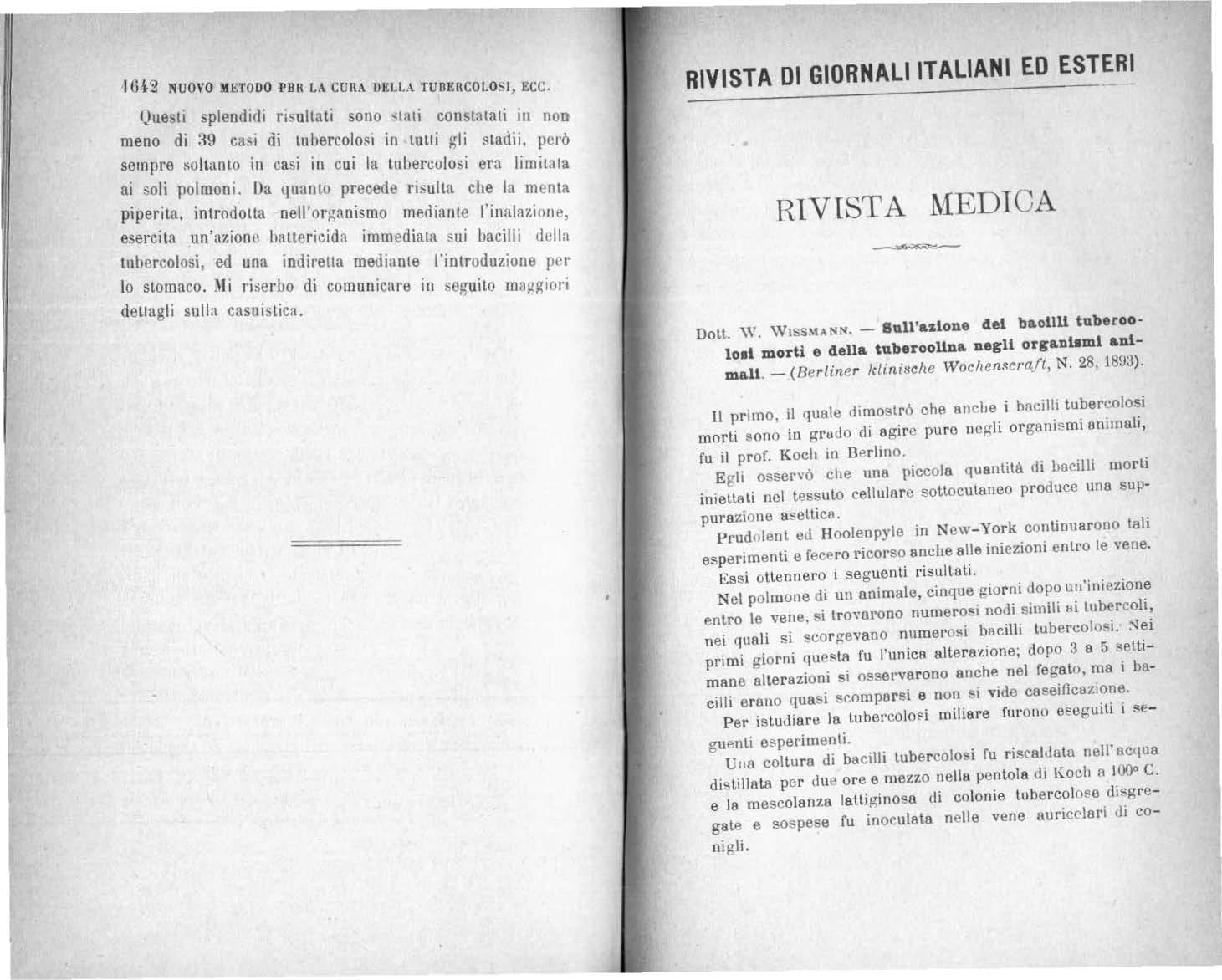
Rivista Di Giornali Italiani Ed Esteri
Ri V Ista Medi Ca
Dott. \\'. \Vtss:-.u NN. - Sull'azione del b a oUU tubeco olo•l m orti e della tuberooUna. negll orga.n l•ml anlma ll . - (f1erliner klin.isclle Woch en.scra/l, N. 28, 18!13).
Il primo, il f]U&Ie dimostro che anrl1e i bncilli tubercolosi morti so no in grudo di agire puro negli animali, fu il prof. Koch in Berlino .
E gli osset•vò che una piccola quanlilà di bacilli morti iniettati nel tessuto cellulare sotlocutaneo produce una suppurazione asellica.
Prudnlenl eù H oolenpyle in New- York continuarono tali esperimen ti e fecero ricot·so anche alle inieziom entr o le vene.
Essi ottennero i seguenti risultati.
Nel polmone di un animale, cinque giorni dopo u11'iniozione entro le vene. si trovarono nume r osi noùi simili Ai tubercoli, nei (]Uali si scor s::evan o numerosi bacilli tuberco losi. primi giorni quPsta fu l'unica alte r atione; dopo 3 a 5 1-leltiman e alterazioni si osse1·varono anche nel fegato, ma i bacilli erano quasi scomparsi e non s1 vide caseificaz10ne.
P e r· istuùiare la tube 1·colo!'i miliare fut'OIHJ eseguiti 1 seg u Pnli esperimenti.
li nn coltura di bacilli tube r colosi fu riscaldata nell' ac'lua distillala pe r due ore e mezzo nella pentola d1 Koch A 100° C. e la mesco lanza lalllginosa di colon ie lubercolose disgregale e sospese fu inoculata nelle vene auricclar1 di conigli.
35 giorni dopo l' inoculazione si trovarono nel polmone e Jr el fegato numerosi noduli simili ai tubE>rcolosi, il cui centi·o era co!llituito da cellule epitelioidi Amma!:.sute, fra le quali , qua e là era mescolata qualche cellu la gifttmte. Attorno al detto c<>ntro giacevano numerosA c ell ule r·otonde; i bacilli tubercolo'li er·ano rarissimi ed in g ran parte degenerali.
.Ancl.e le pa r e ti vasali erano Misai alterale; in alcune E'rane irl'iconoscibili e fortemente infìltrate con cellule rotonde, che si vano w gran numero an rhe nel tessuto peri vascolat•e.
Oltre •1ueste alter•a zioni nel polmone e uel fegato si trovarono pure pa recchre piccole emol'ragre n ei t·eni. stadi ullel'iol'i aumerrlarono sempre piu glt elementi epìl••liali rotondi tant <) nei noduli del polmone e del fegato, quanto nelle pareti arteriose. I n luogo delle cellule si videro in appresso formszioni tibrùse, 111 c ur dopo 15 settimane lutti i noòuli erano trasformati; lo slesso avvenne nelle par eti vaf<ali.
Buchrrer dimost r ò che mediante colol'i basic i dr anilina i germi pol monite ed allri microt•ganisrni patogeni perdono la loro azi'>ne piogena, era quindt interessa nte di conoscere l"e la cosA avveni sse pt'i bacilli tubet·colosi. l risultati furo no eguali u quelli ottenuti cot ba c.Ui non colo rati.
Siccome in ues:sun caso fu risco utr•ata metamorfosi cao grussa, una serie di animali dopo il trattamento ron bacilli, con i f]uali erano stati te nuti pt'r 50 o re nelrapparecchio u vapore dr KocL o wo• C nel lor•o proprio liquitlo di condensazione, fu inoculata con Luber•colina.
Le dos1 Ilei diver·si anima li oscillarono fra 0,005 giornalmente. 0 ,01 g r . ogni l rt> giorni e OOi gr. ogni gior no. Gli anim ali stetter o beui.:,simo e n o n ditna!!t'arono.
lo alt-uni aOJrnah s i o.:;servn iperplasia dei folliroli della mtlza .
N EUMANN. - Sulla tuberooloal delle glandole bronohlall e aulla aua relazione oon la tuberooloal dell'lnfanzt& . - (Ce ntralblatt ,{lìr Bala e r iolouie ttnd Parasilenl>uTule, vol. XIV , N. 7, 18U3).
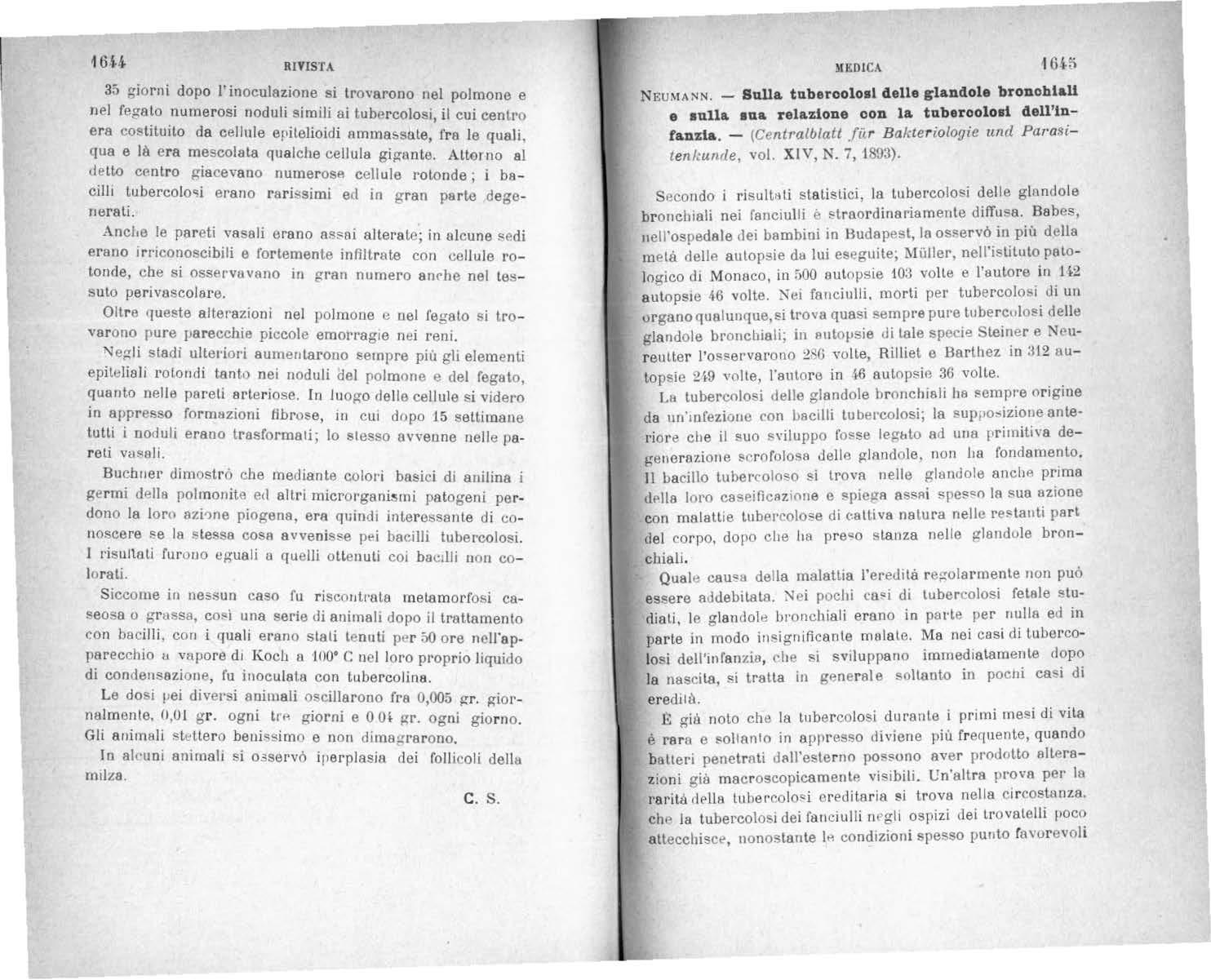
S econdo i ris ultllli statis tici, la Lnbercoloc;i delle glandole bronchrali nei fanciulli è t>lrao r dinariamente Bab es, nell'ospedale Ilei bambini in Hudape s l, la osservò in più della metà autopsie da lui eseguile; t\liHier·, nell' islllulo patologico di Monaco, in 500 autnpsie 10:l volle e l'autore in H2 a utopsre 46 volte. fanciulli. morti pet• tubercolosi ùi un urgano qua lunque, si trova quasi sempre pure luberculosi delle glandol e bronchiali; in antopsie di tale Ste111er r euller l'osservarono volle, Rilliel e Barth ez in :H2 autop sie :H9 volle, l'autore in '1-6 36 volle. t 11 tubercolosi delle glandole hronch1sli ha l"Cmpre origine da un'mfezioue con hRcilli lubet·colosi; la sup,,o ...izione anteriore che il suo ad una prilll itiva degenerazione srrofolosa dello glando le , non ha fondamento.
11 bacillo tul>ercolo«o si trova nelle glandole anclJ A pr1ma ùPIIa loro caseifìc11z on e e assai spes"o la sua azione con malattie lubE'Pcolose di <'attiva natura nelle r el"lanti pa rt del rorpo, dopo che ha p r e"o s tanza nelle jrlandule bronchiali.
Qual , cauo:a della malattia l'et'etltlà r e!!ola rmenle non può essere addebitala. i pochi ca"'i di tubercolosi fetale dia li, le glandoltJ i.J1·onchiali erano in parte per nulla ed in parte in modo inl'<ignificanle malate. Ma nei casi di Luber·colosi dell'tnfanzia, t'lte si svtluppan o immedratamerrle dopo la nascila, si tratta in generai e Mllanto in pochi ca,i di eredità.
cria noto che la tubercolosi durante i pruni mesi di vila è ra;o e sollanto in appresso diviene più fr equente, quando b alleri penetrati d111l'esterno po<:sono ave r prodotto allPt'az ioni già macroscop icamenlP visibili. Un'altra pt'ovn per la rarità dt>lls tuherrolo"'i ot·editar ia si trova nella ci r costanza. cht> la tubercol osi dei fanciulli n cg:lt ospizi 1lei lrovatelli poco attecchisct>, nonos tante condizioni spesso punto favorevol i
liEDlCA 161..";
per uuo sviluppo normale d... i poppanti; manifestamente perchè i lattanti là non sono esposli all'infezione di parenti lubercolo::i, ecc erl el:!c:;i non contr ag{{ono facilmente la mnlaltia da altri tubercolosi poppanti, poiché i fanciulli hanno costume d'ingoiare l'escreato infe:tioso e perciò non lo diffondono ad altri. Nt>ll'osptzio dei trovatelli in Pt•aga, 1n cu• le madri luberco\oc:;e sullilu dopo il loro ingt'esso nello >-labi!i. monto sono riu1andate, Epstein in circa 200 autopsie osservò in total e H casi di tubPrcolosi; 2 dei fanciulli relativt et'ano Rlali ricondntti allo rlall'ollevameoto esterno, e s i osser'ò cùe una balia era tubet'colosa, l'altra poi uon fu esamintlta; gli altri selle poppanti erano stati rinviati, perché le madri erano state trasportate in un ospedale per li si . Nell'asilo pe i trovaLelli in Pietroburgo, chi' non SI trova m buone coudizioni seC'ondo la relazione di Fro\lbellus, lo media per cento dei cast di morle per tubPrcoJoc:;i nel pPJ'ioJo 18ii-189:l, su 71370 bambini, giunse c:;olo a U,} ' / , mentre queBa della morlalilù in genc1·ale fu ùi 27,7 ' /: Fra i trovatelli tubercolosi !'e ne tt·ovarono in media 67 "/., che erano stati acculli entro il primo seltenario di vita, adunqu e chP vet·os imilmenle erano già maiali quando ent1·arono, o erano nati già tubercolosi, o che nei primi giorni di vila avevano co ntralto la malattia col lalte di madt•i lubercolose. Il maggior numero di essi mor1 nei primt c:;ei me"'i di v1la e soltanto il 20 'lo più tardi, ma questi ultimi nei primi dieci mesi di vita. Da CIÒ deriva, che la <lei fanciulli, tanto ereditata quan to acquisita col !alte conduce rapidamente a mot·te e cho una tubercolosi, la quale si sviluppa negli ulteriot•i mesi di vita, può difficilmente essere addebitata all'eredità.
Se adunque nella tubercolosi felalo regolat·men te non s i tratta di malatlte cons1dcrevolt delle glandole bronchiah e se d'altra pane la tubercolosi che si manifesta dopo ltl nascita in gene1•ale non é da addebitarsi alla a questa non può ascriversi una ettologica importanza nelle malattie tubercolose delle g lando le bronchiali. Anche la sede anatomica delle glandole, la quale corris ponde molto p1ù ad uno tubercolosi da inalazione, depone contro tale etiologia. L'o b- biezione, sollevata prima contro una tale che nella tube r colosi delle glandole bronchiali spesso i polmoni furono trovati sani. mentre i hacllli inspirati per giungPre alle glandole ovrebbero dovuto iu primo luogo malattie del tessuto polmonare, è caduta dopochè Buchner e 'Vyssokowitsch con le loro l"ice r che banno dimostrato, che le spore di diverse specie di inspirate · gere alle glun<.Jole, ::-enza prima attecchir!' nel tessulo polFrancameule !l fallo rmeraenle oell 'ohbiezione sopra citala, in unione alla g rande frequenza ed e-tensione della malallia delle glandole bronchiali n<'i fanciulli depone pet• la grande importan za, '!he sopratwllo possiPde In tub,rrolosi delle f!lanrlùlf' bronchiali per l'oriaine e 11el tif•lla tub•rcolosi tlei fanciulli. Può ammellersi, che in un grande. forse nel mttl'lsimo numero dei ct•l"i, nei qu<tli la tubet·colo""'i dei fanciulli non fu causola dal Jalle, il primo atleccltimenlo de1 bactlli tubercolocoi sia da ricet·carsi nelle glandole Lroncbiali. Qui i bacilli possono rimanPre per lungo locaizzali, ove o possono e!:'sere dislt·utli, oppure per determinale cause (malatti e d'infezione, ad esPmpio rno1·bi1lo, OYve t·o calarri di vario forme delle vie aerPe) guadagnar lf'rren o ed a cc<'lerare dill"ereuli malattie, a meuoché una considerevole ricettivila dell'individuo non permetta la posstbililA di una rapida mnnit'eslazione Lubercolosa.
Le oie, per le qualt la iltbereolosi si estende e/alle glandole broneliiali sono di vat·ie specie. Con la fusione delle capsule glandolari possono inf!:'ltarsi e forma r si pacchetti glandolat•i; In caset•sa dopo il disfacimento delle può eslendet•si agli o raan1 vicini, principalmente anche ai pol m oni.
Per la via clelia corrente linfalira po,.,scno i IJactllt ragaltrH glandole linl"oLiche, specialmente quelle del collo e della nuca ; finalmente i bacilli pos..ono pr·orlurre malattie delle vasali sanguigne, pet' questa via arrt v are nella cMrenle !"angui!!na, essere trasportati in differenti o prod urre miliare. Secondo "\Vdgert, è speciAlmente la tubercolosi polmonare di uno malattia penetrata ùaUe glandole linfaliche intrapolmonari nelle vene del polmone. l ge1•ml coleroRi erano viRibtli nelle feci al più presto al 5• giorno di malallia e al più tardi all'&- giorno di una volta fu1·ono con !"icurez7.a nelle feri figurate.
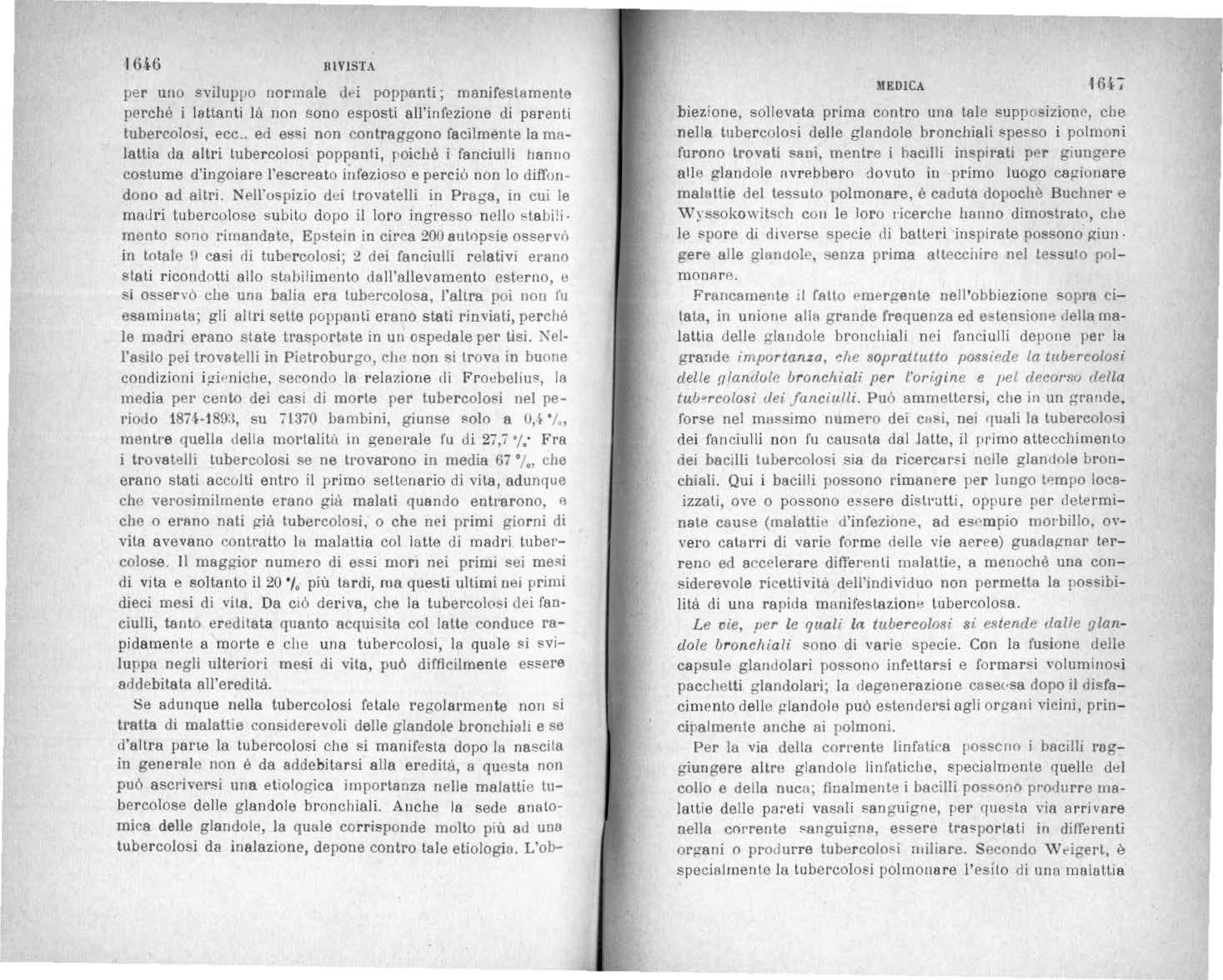
La profilassi della tuber.:olosi dei fanciulli è basala sulla patogenesi della tnlllatlia ed ha per cardine fondamental e la separ·azione der fanciulli dai tisici adulti C. S.

CANON , LAZAIWS e P1ELICKE. - Relazione aulle ric erche batterlologlohe nel oolerosl e nel malati sospetti dl oolera in Berlino durante l'anno 1892 . - (Centralblatt fii. r Ha/.:leriologie und Parasit enku ntle, XIII volume, N. 7, 1893).
In totale furono esaminali 80 casi, di cui 30 di colera ac:iat ico. In tutti furono rrsconlratt i bacilli del C(llera. Oltre l'e!>ame microscopico furono sempre fatte anche le colture in fle lallna (colture in lamine a C.).
Come altri auto r i, pure i I'elatori osservarono nel contenuto intestinale bac il!i a quE>IIi del colera, ma i pl'imi si differenziarono da fJUesti, per·rhè n on si svilupparono nella gelalinn.
La quanlita dei vibri oni del colera nei preparati del contenuto intestinale non i• in relazione certa con la f:!ravità della malallia.
Nei casi di colera asialico la ricerca batleJ·iologtca delle dejczioni fu nel della e nella convalescenza ogn t 2-:l giomi, per determinare. quaado i bacilli scompartvano dallo dejezioni. Siccome però i pnr.ienli solfrivano di coslipazione, cosi non fu possibile una ricerca in tutti i casi.
:\ledicamenti disinfettanti (calomelano, creolina, salolo, cresolo), pr·esi intel'namenle, non ispiegarono alcun'azione determinabile su l numero o sulla vitalità di detti germi.
All'incontro in una dejeztone, av\'enuta 5 o re dopo un'abbondante unlet·ocl isi tan uica, i vibr·ioni del coler·u e1·ano consi.terevolmeute diminuili. C S.
L UIG I FERDINANDO, principe di Baviera. - Sulla etiologia e patologia della pleurite. - (Centralblatt fiir Ba.kterioloqie und Pa r asill'ftkunde, vol. XII l, N. i, 18!J:l).
Il relatore ha esaminalo batteriologicamente 23 casi dt versamenti pleuritr ci nella clinrca del prof. von Ziemssen, di cui si riassumono i risultati
O deg-li e!'sudali o!'<servati erano sierosi; 2 di essi contenevano s lafìlo cocchi, 2 pneumococclti, 5 erano privi di batteri; di quec:ti ultimi 4 erano tubercolosi, il 5' si e ra maniin ad influenza. tutlavtu anch e in e'-SO fu pr.-sa rn consHierazione la tuuercolosi.
Un essudalo cl'a esso contenev a pneumococchi. 12 essudati erano purulenti; di t>ssi 2 contenevano pneumococch i, 5 sl!'eptococclti, 2 bacilli tubercolosi, 2 d iplococchi e str eplococchi, 1 slalìlococchi e Rlreptococchi.
Un sanioso-purulenlo presentava, oiLre proteus e sarcine, stalìlococchi.
Conclusioni.
1' La maggio r par te degli essudati sierosi è pr rva di batteri ;
2• La magg tor parte degli essudati privi di battPri è di natura lubE't'colosa;
3' S'incontrano ess udati sierosi, i quali contengono germi genuini della suppurazioue, ma nonostante riman gono si erosi, t,o Ques ta legge però non ho valore per gli essudali da streptococclti;
5' La pat·te degli empiemi è prodotta dallo streptocoecus pyogenes, ma anche g e rmi della supput·azione possono essere la caus11 di un empiema; s· L'infezione delle pleure nel maggior numero di casi è con giunta ad una lesione del tessuto polmonare, la quale rende possibile l'ingresso, nella cavila pleurale, di ge1·mi clte p r oducono lA maiAllra od accompagn ano quelli palogeni. E anche pos!:'ibile lA manifestazione di pleurii.e e;osudaliva per azione Lossictt o meccanica. c. s.
Dr. F. PFUIIL. - Sulla etiologia del tifo . - (Zeilschrt.fl (tir 1/y{/ienr unrl lnjectionskrankheilen, fasciscolo 1•. volume XIV, J8!1:J).
L'aulor·e l1a sludralo accuralarneole, sul luogo, le cause che nella prima\'era del 1892, una epidemia di tifo in una colonia ugricola nel territorio di Landsber·g e giunse alle seguenti conclusioni i modi dell'infezione non fu diflicile prescl'ivere appr·opriate norme sanitarie . accuramente disinfettate furono alloutanole entro adatti bottini. c. s.
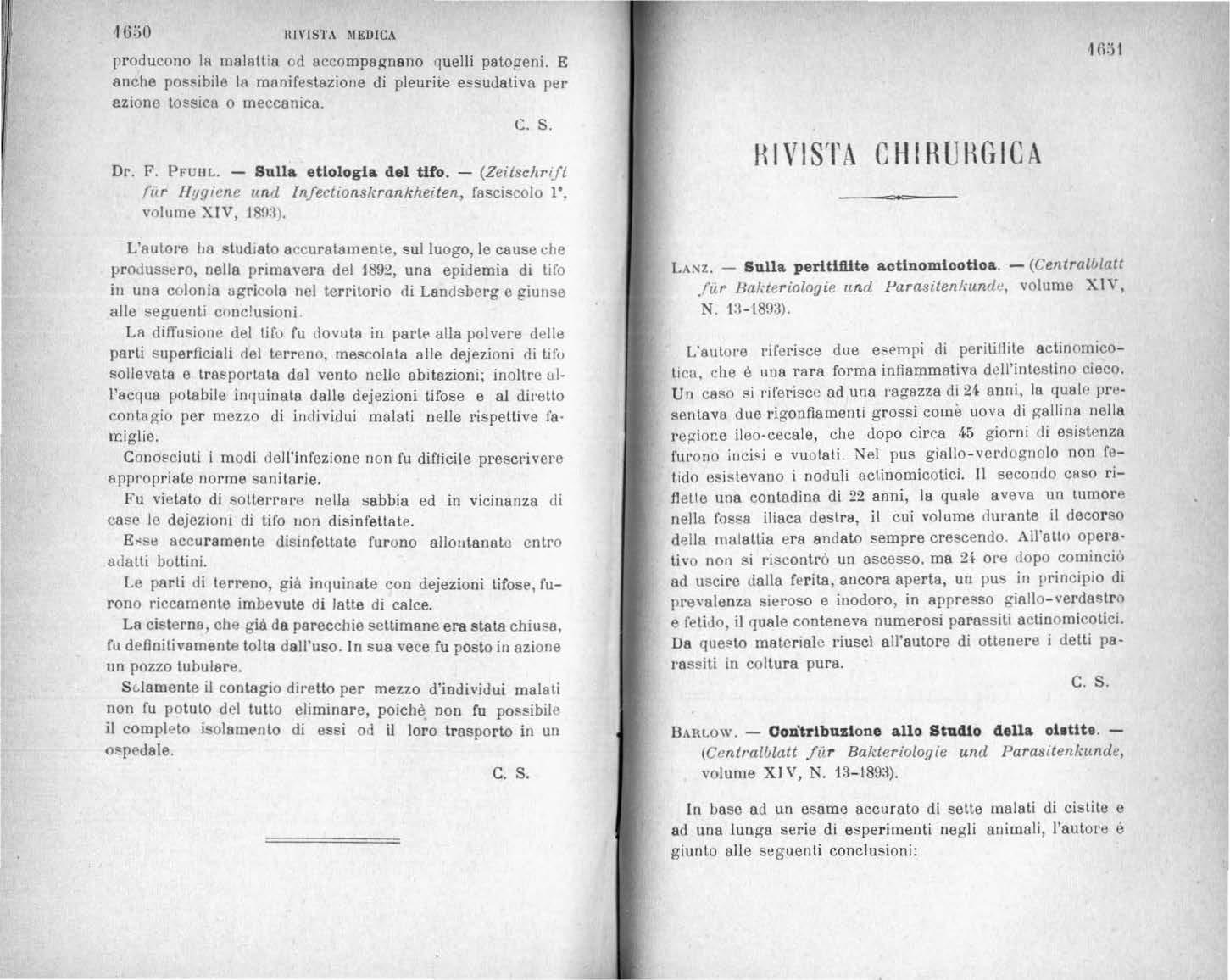
LA dllfusionc del tifo fu dovuta in partt' alla polvere delle parli supe r ficiali rlel terreno, mescolata alle dejezioni di tifo sollevata e lraspor·tala dal vento nelle abitazioni; inoltl·e ul· l'acqua potabile inquinata dalle dejezioni tifose e al dir·etto contagio per mezzo di i11dividui malati nelle rispettive fa· rr.iglie.
Fu vietato di sotter•rare nella sabbia ed in vicinan za di case le dejezioni di lifo 11011 disinfettale.
Le parli di terreno, g ià inquinate con dejezioni tifose, furon o riccamente imbevute di latte di calce.
La c isterna, che già da parecchie settimane era stata chiusa, fu definitivamente tolta da ll'uso. In sua vece fu posto in azione un pozzo tubulare.
Sdamente il contagio diretto per mezzo d'individui malati non fu potuto del tullo eliminare, poiché non fu pol'sibilt:> il completo isolamento di essi od il loro trasporto in un Mpedale.
Hivista Chir Urgica
LA:-iZ. - Sull a. peritiftlte aotlnomiootloa . - (Cent ral&latt fur Bakteriologie und JJarasitenkunr(l>, volume Xl\', N. l:l-180:l).
L'aulot•e r·tferisce due esempi di perìliHile a c tin ornicotrr n, c·he è una rara forma infìarnmatiw1 dell'intestino cieco. Un caso si r·iferisce ad una ragazza d1 :H anni, la quale> pre · sentava due rigooflarnenti g rossi comè uova di gallina nella t·egioce il eo-cecale, che dopo circa 45 giorni di esistenza fur·ono incisi e vuotati. Nel pus giallo-verdognolo non fetido esistevano i noduli acl.inornicotici. Il secondo cAso riflette una contad ina di 22 anni, la quale aveva un LUmore nella fossa iliaca destra, il cui vo lume dur·ante il deco r so d ella malattia e ra a ndato sempr e crescendo. All'etto opere· livo non si t•isconlrò un ascesso, ma :'H ot·e dopo comincw ad uscire dalla ferita, aucora ape rta, un pus in princip10 di prevalenza sreroso e inodoro, in appresso giallo- ,•erda'!tr o e feti Jo, il quale conteneva numer osi parassiti aclinomicoticr. Da questo maler tale riuscl a ll'autore di ottenere i delli pa· t'assili io col tura pura.
c. s.
BARI..OW. - Con'tl'lbuzlon e allo Studio della olltlte .(CI'Tllralblatt fti r Bakt eriologie und Parasttenkunde, volume Xl v, N. 13-1893).
In base ad un esame accurato di sette malati di cistite e a d una luoga serie di espe rimenti negli auimali, l'auLor·e è giunto alle conclusioni:
1. _Nella i batteri patogeni possono da !"Oli produrre tnfiammaztOne nelrorgano sano;
:2. Le cosidde tte cause concomitanti (ritenzioM, Pcc.) possono rendere agevole at balleri di spiegare un'azione più fot·te nel ter1•eno nutritivo ùa prepar ato;
3. La decomposizione dell'urina non é una condizione necessaria della cistite.
I noltre l'autore riferisce due ca<>i di cistite, tn c 11i non si trattò d'inft>zto11e mista, ma di un'infiammazione della ves cica cagionala da gonococchi.
EtiolOtJirr. t!Pl/a cistite. - Lo cause della malallia sono sudd ivise in tre cla.. si:
J. Chimica (Cantaridt);
:2. Bacillogena: a) Bacilli tu bercolosi; b) Bacterium coli communc, urobacillus li'luefaciens sepiicus (Krogius-Schnitzler), coccobacilli
3. Coccogena: a) Gonococchi; b) Stafllococchi, streptococchi, diplococchi. c. s.
Prollla s.<>i. - Nect-!"sarissima è la disinfezione del catete1·e. Dalle numerose ricf'rche dell'autore r isulta che la stertllzzazione del ca tetere può ottener si o tenendolo esposto per :{5 minuti ai vapori di acqua bollente, o per 15 minuti in una soluzione di nitra to d'argento all'uno per mille oppu re, e per trenta minuti in una sol uzione al sublimato all'uno per mille.
KIRCHN ER MARTINO. - Un ouo di meniDglte purulenta d a otit e medi a te rminato rapidamente con la mort e.
- (Cent r alùlatt (ur Bakte r iolo{Jie und Parasitenlmncle, volume XIV, N. 8-1893).
Un fuciliere si ammalò di rneningite acuta purulenta e mot·i dopo 32 ore. Il decorso, tanto dal lato clinico. quanto da quello batleriologico, differiva dalla meningile cerebro-spinale epidemica. P oiché, mentre nella meningite si trova quasi sempre un diplococco identico al diplobacillo capsu lato di
Chiru Rgica
A. Fraenkel (meningococcus), l'auto re osservo mvece nelle coltm·e sulraga r glicerinato a 37' C. lo sviluppo dello staplr!J· lococr.us puoqenes au r eus e dello sta[JII!Ilococcus pyogenc8 ciireus. Delle t r e vie, per le quali questi g-ermi potuto giungere ol cervello, cioè o per le fenditure della volla ossea della cavité. del timpano, o attt·averso •l laberinto e luogo i nervi acustici, oppUI·e attraverso il prore!'I!"O mastoidfO, fu scelta m questo coso la seconda. Nell'orecchio medio giunser o gli stafilococchi attraverso la tromba di Eustachio e vi produssero processi in!ìammativi, 1 quali dul'arono per· lungo tempo e lìnollllenle si diffusero ulla base del cranio . C. S.
La teoria 1ull& guarigione delle ferite . - Cenni 1torlol . Stato attuale. - Dott. E. PICCOLI. - (R10ista ..eneta, fascicolo s· del 1893).
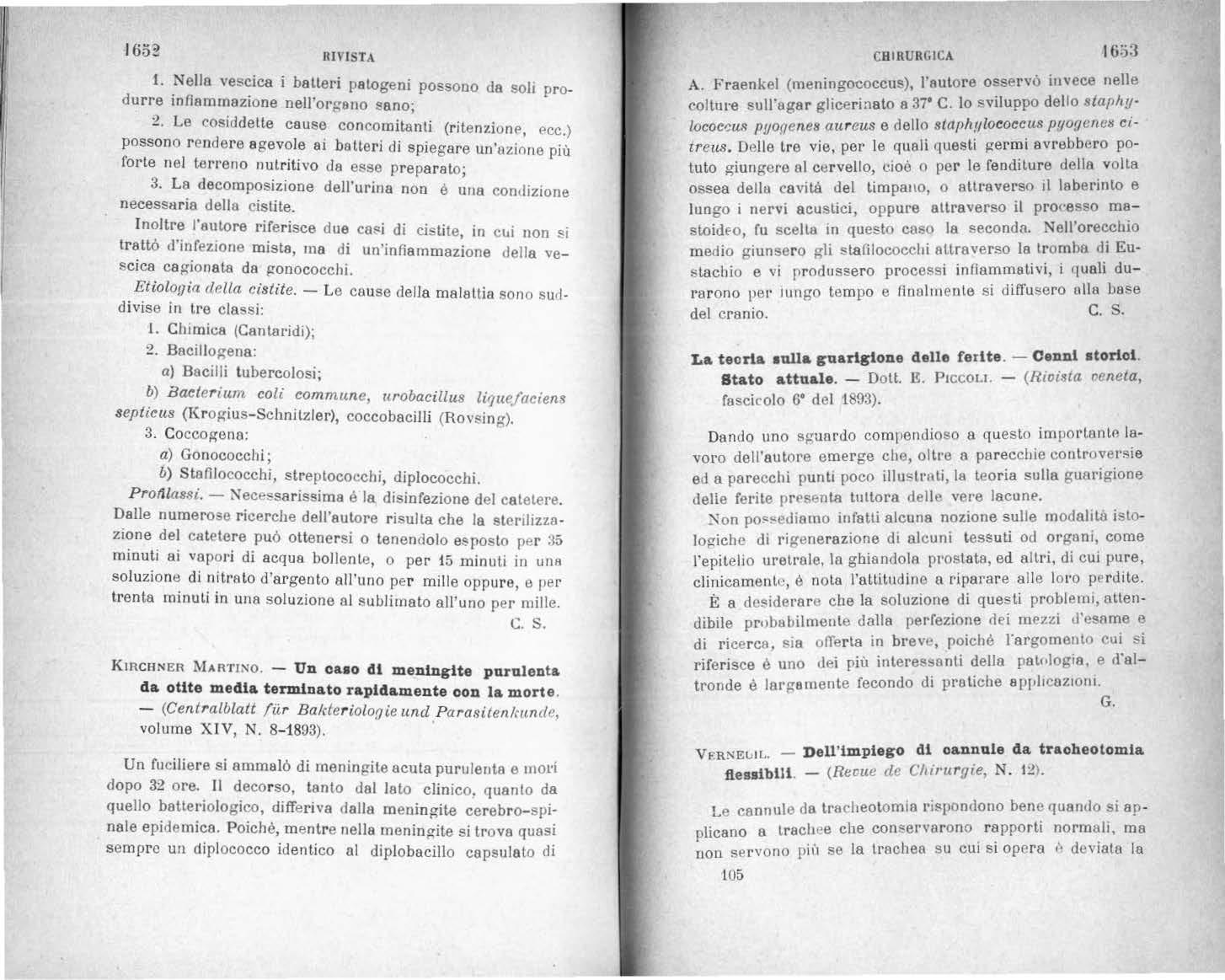
Dando uno sgua rdo compendioso a questo importantfl lavoro dell'autore emerge che, ollt·e a parecchie conlrove 1·sie ed a parecchi punll poco illu<:tl'l\li, la teoria sulla guat•igione delie ferite prE'se-nta tuttora dellt• vere lacune.
po<:'-ediamo infaLli alcuna nozione sulle modalità i!llolol!icbe di r igenerazione d1 alcuni t essuli od organi, come l'epitelio urett·ale, la ghiandola p1·ostata, ed alll'i, di cui pure, clinicamentt>, é nota l'altitudine a l'iparare alle lot·o pe r dite . È a desiderare che la soluzione di questi pr oblenu, attendibile probabilmente dalla perfezione dei mezzi tl'e..nme e di ricerca, ofTerla in brevt•, poiché rargomeuto cui :;:i rife r isce è uno tlei più intere!'lsanti deUa patologia, e d'altronde è fecondo di pra tiche applicaZIOni.
G.
LP caonulo da lracheotomìa bene quarl<kJ si applicano a trach,•e che con!'lervarono ra pporti ma non servono pil't se la trachea su cui si opera duviata la l05
CKlRURGICA
toralrn r>nle dtl un lurnore o all'indi ett·o da un flemm one !!TIWf' collo: .allora la curva fh•!"a diventa una difficoltà p e rOno
Verneu il ebbe l'idea di costrurre una canula lulbt fuorché nel traLlo che r egge il padiglione, diec 1 a unt fa m un caso d t pet· enorme gozzo softn cui colla percussione c t·a riuscito a stabilire lo devtAZione della trachea incurvata atto rno al tumore: la ca nula lles!"ibile s'tntrodusse fac ilmente e fu ben e tollerata. Recentemente r tch iamo quella idea un nuovo caso di un IZ1'0 S"O lt r o ideo maligno con accessi solfocativ1: la pmguudtne permeUev11 di riconoscet·e la laringe non la trachea : .l'apertura cui let•mocautet•io ed applicala la CHnnula d t il malato non t·e,pira ,.a, sostiluitala pot canula ll cs!'l t btle potè subito compier·si la r e$p irazi one.
L. tclea delln lle<:sibiltlà della canula da lra tbeotomia t- motto
A!tlt ca . solo Lutle le ca nule costruite fino ra non e r ano fle ;ostbt li clte all'estrernllà, quella di Vern e uil ha il vantagaio di e::;se t• tutta flessibile, quiudi ancl1 e nella curva. t"'
RA YMONn. - Jpertrofla considerevole della milza; laparatomia esplorativa ; gnar lgione . - (Reoue de Chir urf!ie, N. 12).
Una donna di lr en lo lto anni, clte ebbe febbri malariche nell'infanzia è denutrita e cachetti ca ed ha , da due anni a scite, per In quale fu ripetulamt>nte fatta la paracentesi: in una di que<:le si polè ril eva r e una ,·oluminosn iper trotìa splenica. Ra ymond volle tenta r e un 'opera z ione, la Japa r otomia esplo.che condu rrebbtl ad una splenec tomia SP ciò fos;:e possll>.tle: uperto il ventr e :;i ti'Ovò infatti una milza assai la cui ostir·pazione per ò era impossibile pe r le ader·enze con tutti gli organi.
Lava! •l abbonda ntemente il po rito neo si richiuse il ventre: il rni gl to r amento era manifesto: si ebbe pohurtu c·on<:rdr>revolo; l'edem a antico deg li arti infe rio ri scompat·ve: clue lll fiSt dopo la rnllla era notevol me nte r·itlolla, l'ascite n u n Cl'lt r icompar•sa.
L'autore su due punti: modo d'in le r veuto, risultati ottenu ti. Le stalbtiche ili splenectomie pet• milza tpertro fka d'origllle leucenica o pulustr e danno una mortalila spave ntosa. D'altro lato la laparatoroio esplorativa die!IP a Ra.vmond un successo molto incoraggiante· È irnpossibilt· l'mdicare per quale meccanismo siasi o tte nuta la guarigione.
La gastro -en tero s tomi a 1n F rancia ed l s uo i ri s ul tati .
- THOGNON. - (Ga;ette des H òpilau.c, N.
- Delle diverse ope raziom proposte pet· r·r· alla stenost Jel piloro, la gastr·o-<>nlerostomin è quella cltl' è la più ra zionale ed ha le inùicaztoni più este,..e. È un'ope r azione palliativa nei casi di cancro, curativa nei <'O!;i di restringimenlo fibr·oso del p il oro.
La gastro-e nter·oslomia, nei cance r osi, deve essere praticata il più pr·esto possibile, p rima che i pt·ogressi dell'afl'ezi one abbiano messo il malato in uno s tato di indebolimento vicino alla cachessia. La maggior parte de!!li in successi osser•vali fino ad oggi sono dovuti al fallo che questa eonùt.zione indispensabile non è s tata r·ispe llata. l n Franc1a !'i ttl>nuo indifferentemente il metodo di Von Hacker e quello di W oelftt>r. La scella del processo é lega ta sop raltulto allo stato anatomo-palologico della r·egione.
Il processo di Seun non è stato an co ra impiegato in Francia. Fa d'uopo apri r e i visceri il più ta r di possibtle. Il proce s!':O di T l> rrier é, secondo l'autore, quello che pct·rnetto dr ottenere questo risultato con maggi or g a r a nzia di s u cce"!"O.
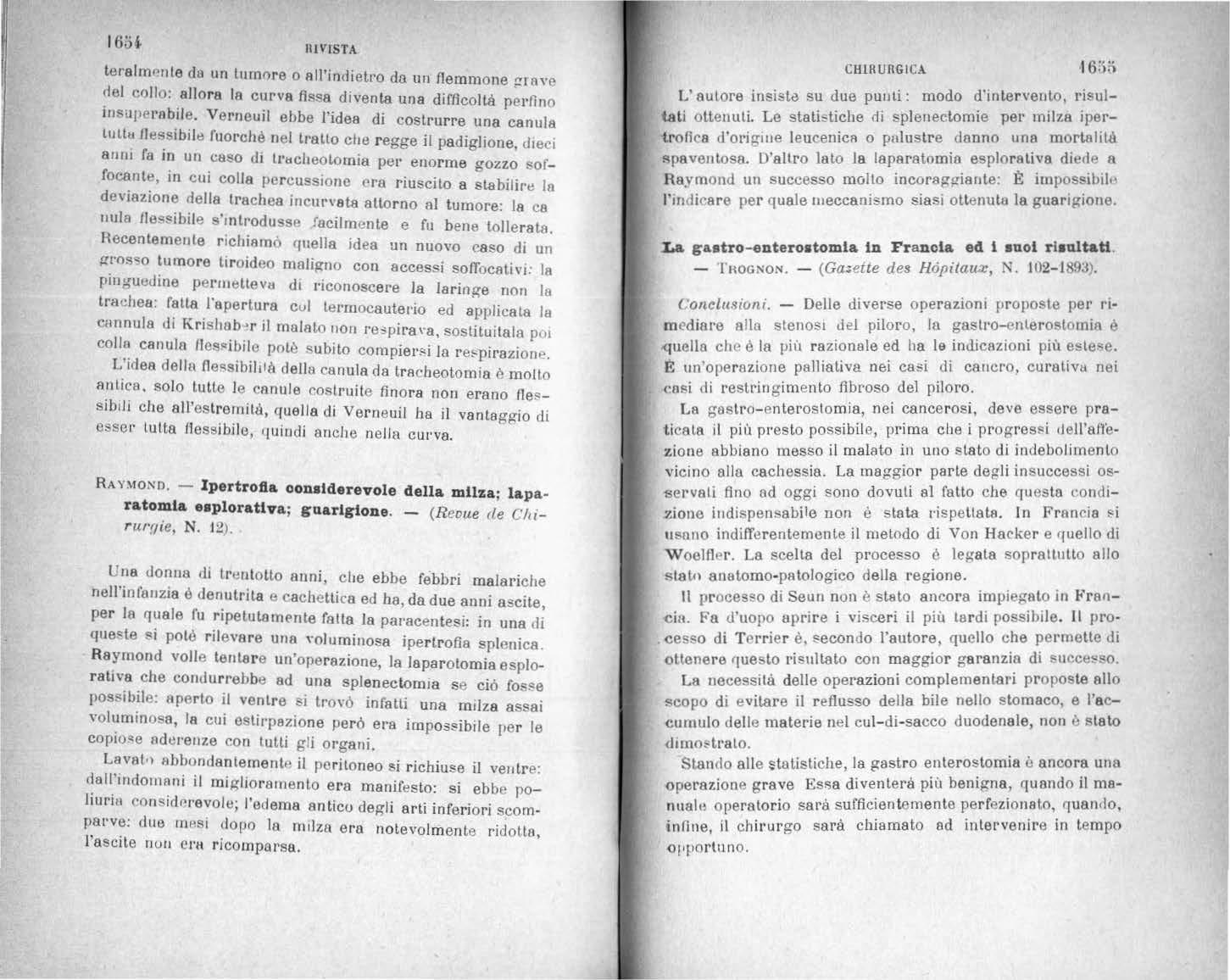
La necessità delle operazioni coroplementat•i propos te allo scopo di evitar e il r eflusso della bile nello s tomaco, e l'accumulo delle materie nel cui - di- sacco duodenale, non è stato
Stando alle statistiche , la gastr o en terostomia ò ancora una oper•azioaP grave Es!;a diventera più benigna , quando il man uale oper ato rio sar·a sufficien temente perfPzionat.o, l'fUando, infin e, il ch it•urgo sarà chiamato ad inlet·ven ir•e in tempo <>J'portun o.
L'artrotomia nel reumatbmo blenorragico. - CutuSTEN.
- (Journal de Médecine et de Ch.irurgie, agosto 18!)3).
Si sa che uno dei più gravi inconvenienti delrartr-ite ble· norragica é di lasciare spesso come postumo un'aochilost che, in certi casi, pu6 diventare assolutamente compleltL Il dottor Cbristen dimostra, in uua sua tesi, citando uu certo nume ro di osservazioui inedite, e di casi d'artrotomia gia pubblicati, che l'aper·tura dell'a rticolazione è il metodo di elezione per far cessare i dolori dell'at·trite per una parte, come per evitare l'anchilosi per a ltra parte; egli conclude che quando si avra a curat·e un'al'trile acuta riconosciuta d'origine blenort•agica, si ùovrà dapprima ricorrere a gli analgesici , rna quando si sarà ben sicur·i che non s i tralLa della forma ar·tralgica, quando ci si tr·overa in pr•esenza di un'articolazione rossa, goniìa, dolente, sarà necessa rio intervenire senza esitazione fin dal primo settenario o np, i primi gior ni del secondo. Quando la flemmasia avra colpilo successivamente un gran numero dì giunture per venire detìnJtivamenLe a lo calilzarsi sopr·a un'articolazione, non si tlO\' r& insistere sui mezzi medicamentosi, nè attendere che la tem· peralura si elevt o che lo stato generale si aggr:lV i, fara d'uopo egualmente operare il più presto possibile. Se, in· vece di una sola g iuntura, due o tre restano gonfie, se, in una invece di una monoartrite, si tratterà di una poliartrite, rton si dovra esitare a prendere il bistm·i, poiclré, per una parte, uon si avra mai ad aprire un gran numero di articolazioui, la delerminazione definitiva r estando generalmente olìgo-arlicolare, e, per altra parte questa asserzione è appoggiata dalle osservazioni di chirurgi, i quali hanno aper to in una sola uta due o lre articol azioni s ul medesimo malato. ln un caso di questo gener·e, Potberat, dopo aver peati ca to l'artrotomia nello stesso giornÒ, snl medèsimo malato, nelle ar·ticolazioni del gomito e del pugno, non ebbe a lodar·si dell'astension e a riguardo della tibiotar•sea che pa· reva in via di miglioramento, pArchè fu la sola giuntura che conservò la rigidezza, quando il malato uscì dall'ospedale.
Cidrurgica 1657
È difficile stabilire per l'operazione un matematico, ma Christen crede che quanto più sarà pre. oce tanto migliori saranno i risultati consecuttvr . c • · 'd te Agendò in tal modo, si faranno scomparu•e rapt ameu . i dolori atroci che torturano i malati e loro tolgono ri poso. La febbre cadrà ben presto, lo m1g1iorera rapidamente, ed il sonno e l'appetito_ Infine si eviterà rJuasi sicurament& l'anchilosi, tmpedendo che le aderenze si cos tituiscano e si organizzino.
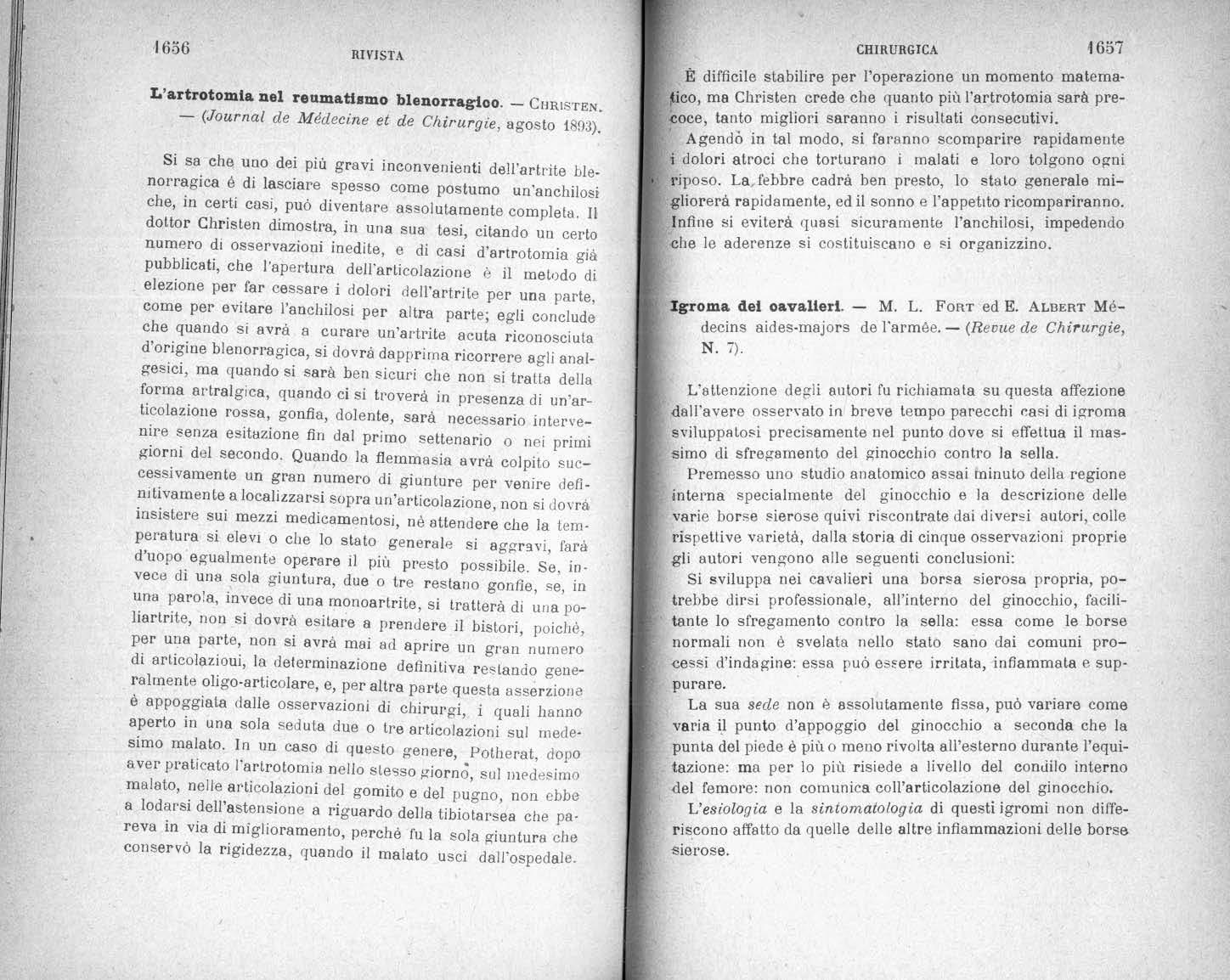
Igroma del oavallerl. - M. L. FoRT ed E. decins aìdes-majors de l'armée.- (Revue cle Chtrurgte, N. 7).
L'attenzione degli autori fu richiamata su dall'avere ossenalo in breve tempo parecchi cas1 d1 sviluppalosi precisamente nel punto dove si effellua il massimo di sfregamento del ginocchio conlt•o la sella. .
Premesso uno studio anatomico assai minuto regwne interna specialmente del giuocchio e _la_ delle vari e borse sierose quivi riscontrate da 1cirvers1 rispettive va rieta, da lla storia di cinque proprte gli vengono alle seguenti conclus.wm: .
Si sviluppa nei cavalieri una borsa p.o.lrebbe dil'si professiona le , all'intemo del gmocc!uo, facthtante lo sfregamen to contro la s ella: essa _come le_ borse normali non è svelata nello stato sano dai comum processi d' indagine: essa può irritata, infiammata e supp ur are. .
La sua secle non e assolutamente fissa, può vartare come varia il punto d'appoggio del g in occhio a seconda t del piede è più o meno rivolta all'esterno durante l eqm- pun a 1 · t tazi one: m a per lo più risiede a livello del conu.• o m del femor·e: non comunica del L'esiologia e la sintomatologia dt questl non d t/feriscono affatto da quelle delle altre infìammazwm delle borse sier·ose.
lllVISTA CIIIRURr.tCA
La diagnosi è facile: mn dimenticando I'Psisteuza di quel"te bor·se, sono facih ei'Nr'i diag:nos•ici !rravi e dannosi J>CI' la cu r a e i.
Occorre distinguere l'ultczione iu dalla idrartro d l h' 8t gmocc IO. dall'i!ll"oma delltt borsa. sierosa della :r1mpa rl pure da altre Aflezioni più r are ma egualmente m Pegione, quali gli ascessi ossUiuenti, di .caso 11 Duplay, l'cmaio11W, lo spanrlimento primd,oo dt stero nelle descl'iLte da Mor·ei-Lavttllée ovvero tl ganglio Pl't>a r Licolar·o, le {lOmr,<e sifllitieft,•, il J!bropla.stico jusicolato, come i tumori a mielop{a.-; 111 • mfioe ti lipoma. '
.Il. è bPnigno: non "ODO da temersi 1... alrl•fi c ciel lrtctptte frequenti dopo I'irl:·ar·lr O!';i: f-olo se acuto I'I"ro ma porto l'improvvisa impotenza o la limitazione funzton;IP, .,e crontco esso permette Lutti i movrmenti, e pet•tìno il cavalse non é sviluppo Lo: il poco distUt·bo che genero ques:a fot'ma sptega la t·ar•itli dei casi r·egislrati, ma la for·rna crontca devtJ essere as!iai frequente.
. l.n al tralLAmenlo il metodo tla impiegarsi non drve da rruello degli alki igromi: nel periodo dell'ocuw• ti l'tpns? é necessario: in qualche caso la compression e dwtl e un raprdo l'applicazione di un vescicanle cond us:;e uua volta. a rapido miglioramento: la puntura segUita eia compr·esswne si reputa Il m etodo migliore.
RlVISTA Dl OCU LISTICA
Contributo alla. rloerca. delle lndlo&zlonl , ln tera.peutlca oculare , delle lulezloul aottooougluntlvali 41 subllmato - 0. GRANOCLE ME NT - (l gon Médica/, '>. li; 18!J3).
Gtà da rJUIIlche nnnn alcuni • culisli hunno osato praticare iniezioni di >-ublimato "otto lu congiuntiva bulbare e anche nf'll'inlerno comballel'e alcune afTezioni gravi o irrirnecliabili di orl{ano.
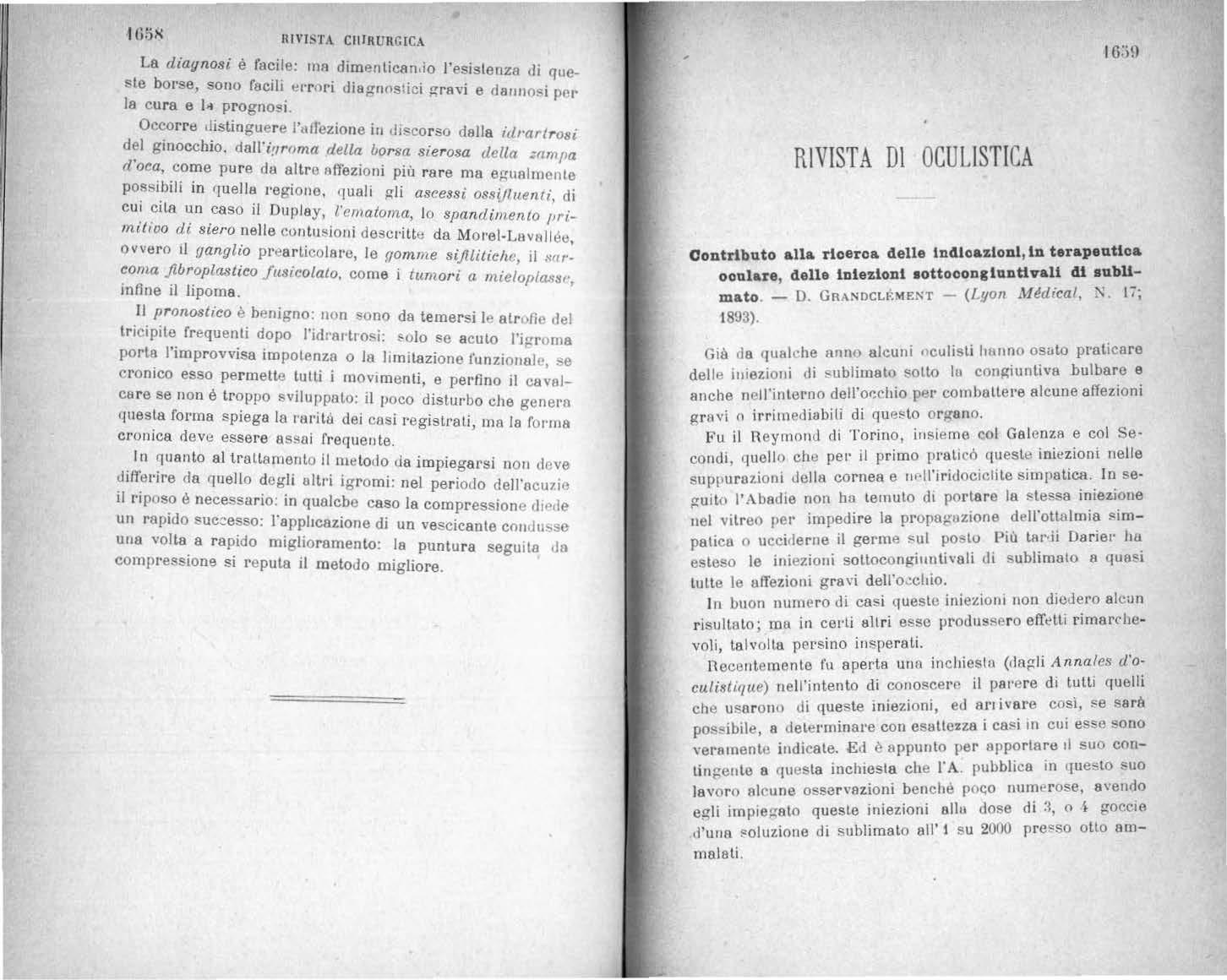
Fu il fl<>ymonll di To r ino, insieme co l Galenza e col Secondi, quello che pet· il primo pt·allcò ' lu eslt! iniezioni nelle supl'ura1.ioni della cornea e nt>ll'rridociclite simpatica. In sel'A badie non bo temuto d t portare la :"te:<sa iniez1one nel vitreo per· impedire la propaguztone dt>ll'ottalmia !'i mpatica o uccitlerne il germe po..,lo Ptù tAr'•ii Dariet· ha esteso le iniezioni sotlocongiunlivali di "ublimalo a qua"i tutte le uiTeziom gra\i d ell'o •chio.
In buon numero di casi queste inieziout non dioùet'O alcun risultato; ma in cer·li alt r i esse elfelLi rimarrltevoli, talvoll.a persino insperali.
necontt>mentc fu aperta una inchiesto A nnaiPs rl'oculiiJtique) nell'intento di conoscer r il pat·Pre di tutti quelli che U"ar onn ùi queste iniezioni, eù art ivare cosi, :"e sarà pos"ibile, a ùelet·ulinat·e con esattezza i cal'i ut cui sono Yeramente indicate. .Ed è appunto per apportare ti suo contingeute a questa inclnesta che l'A. pubblica in que:;to suo lavoro alcune osservazioni benchè poc::o numt'rose, a'endo egli queste iniezioni allu dose di o } d'una !>Oiuzione di Rnblimalo all' 1 l'U 2000 pre!"SO otlo ammalali .
LI:' conclusioni che l'A. desume da questo suo studio sperimentale sono le segueuti: to Queste iniezioni sono poco efficaci ne ll'affezioni per infiltra1.ione della corn ea.
2• Molto più efflcaci nelle malallie dell' iride e della coroicle.
:3• Affutto ineffica ci nelle malattie degli str ati interni dell a r etina.
Egli che la fisiologia gli nveva fatto prevede re queste conclusioni pratiche. È nota infatti, dopo le curiose espet·ienze eli Pfiuger colla lluoresceioa per svelare appunto il modo d t pen.etrazione e il percorso nelrinlerno dell'occhio delle iniel.i ()ni congiunti vali, che ill ifJUiùo cosi iniettato penetra dapprima nella co rnee, poi specialmente nelle camet•e anteteriore e posteriore del globo e nello spazio sov racoroideo, e infine nnche periferiCI del cristallino e del vitreo, ma giammai ed in nessun modo nella r etina .
NienLo quindi di sorp r en dente che le ma lattie micr obiche od orga11iche Aventi sede dove può giunge re il sublimato iniettato sotto la congiuntiva, di fronte a I(Uesto la loro essenza c incompatibile colle sue proprietù balle1·icide o antisettiche.
Si comprende poi egualmente beue elle esso r esti impotente co11tro 1.: affezi oni della r etina colla rtuale non può in contatto diretto pe1' mancanza di spazii linfati ci che lo trasportino fino ver so questa rnemhraoa. Si infatti dopo le memorabili r it•erche di Schwalbe che la 1·ettna si trova affatto nll'tnfuori delle corre nti linfaticbe dell'occhio: è un Ol'$!800 nobile clte non cnnserva relazioni dirette cù intime che coi ceotl'i uervosi di cui è una emanazione.
L 'autore da ultimo che egli ritiene mollo probabile che queste tniezi o ni soltocoogiuutivali tli sublimalo agiscano non solo stet•ilinando e pas(eurisant il terreno co r neale e ut•eale co n tro i microbi o lox ine cile lo visitano cosi di sovente; ma anche producendo una ve1·a rivulsione locale e per conseguenza una rostr1zione vasale enerj:ricS sulle stas1 sangui:zne intraoculat·i.
Si ottengono di fatti dei buoni ri sultati anche dagli antichi applicati all'inlomo dell'orbita: mosche eli Milano, vesci•!anti, setoni nelle sopracciglia, o ancora iniezioni perio r hilarie d'antipil'ina che l'aulol'o consigliò e che da piu anni danno dei risultati t&lvolln rimarchevolissimi nelle a ffezi oni gravi, profonde ed oslinale dell'occhio.
Sembra dunque probabile che le iniezioni di sublimsto sotto la congiuntiva bulba1•e producano degli effetti simili a quelli delle rivulsioni , ma ancor·a più rapidi e intensi in ragione della loro prossimila più grande e della loro azione piu d1relta sulle s ta<>i vascola1·i inlraoculari.
RIVISTA DI E FISJOJ;OGIA
Normale E Patologica
L a. aeorezlone dello stoma.oo del Suooi , il digiq,oa.tore .
- Do ll L - (Giornale della R. A ccc.demia di medicina di Torino, N . 5}, 189:3).
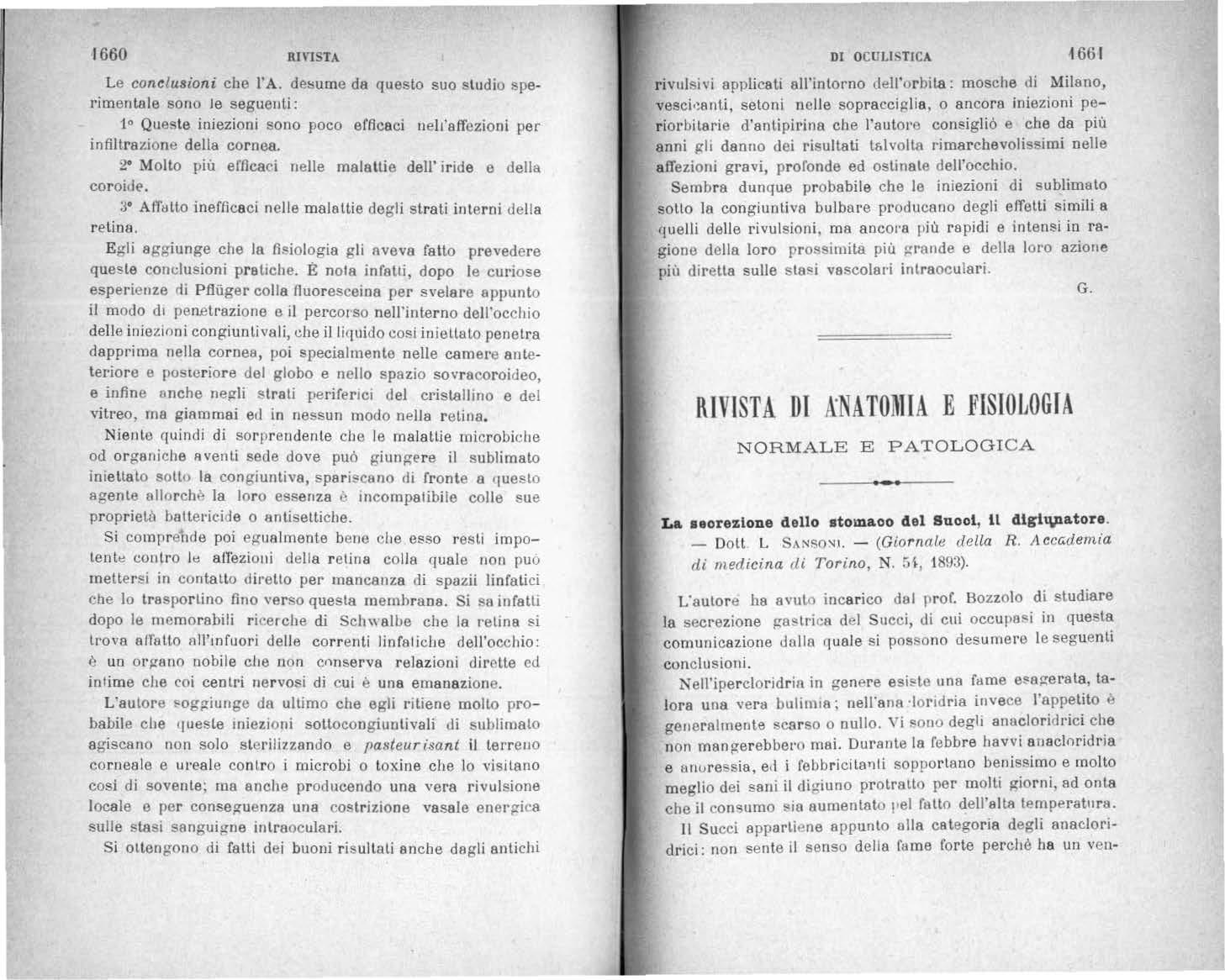
L'autore ba avul•1 incar ico dal pror. Bozzolo di studiare la secrezione del Succi, di cui in questa comuni cazione ùollo quale si desumere le segu enti conclusio ni.
Nell'ipercloridrin in genf're esi s t e una fsme talora una ver1:1 bulim•a: nell"ana ·loridria invece l'appetito tl aenernlrnente scar so o nullo. \'i deglt anacloridrici che mangerebber·n mai. Dut•anle la febbre havvi a naclnrid ria e uuuressia, e,l i febbricilartli soppo rtano e mollo megli o dei sani il digiuno protratto per molti ad onta che il !<18 aumentato pel ft\llo dell'alta
11 Succi apparlit>n e appunto alla categoria degli anaclori· drici: non sente il senso della rame forte perché ha un vcn- tr1colo che non secerne t:ucco o meglio acidn cloridri co , e questa potrebbe una rag10m della re!'til'lenza al dei celen.i con la bile. - Risulta dalle l'icerch e di un g-ran numero di fl"-iolog-i cbe si possono riscontrare in questo liquido 1 di l'ama, d1 ferro, eh mercurio, d1 manganese, tl'antimonio, LI' argento, di zinco: che vi può vedere passare il fer ro vianuro di potassio, 11 !'8liciluto di soèa, diveri>e mAtt-rie coloranti come la fuC!':IIIfl e la rlo1·ofìlla, l'acido feuico, la trementinA, gli zuccheri, l'albumina, la slricnina, il cu1•aro. 'l'l'Il le sostanze che non "l Plimiuano con questo liquido si annoverano il calomeluno il o n1t1·ato pota::sico, l'a cido benzoico, la chinina, la nicotina. lt.:ione del .fegato suyli alcaloidi oegetali. - I la,•ori di ll éger, Schifi' e di molt1 altri ti iologi hanno stabll1lo ello il fl'galo anesta la maggio1' parte degli alcaloidi che lo lraver,.ano; ciò che si può dimo11ll-are con tre mezzi: t• Sludinnclo comparativamente il deco1·so dell'intossicazione in un animalo normale eù in un animale al quale e stato estirpato Jl fe gato (batracio), o al quale è stato legata la vena porta;
Azione del fegato aul v e leni . - RoGER. - (Journ.al de Médecin e et de Clururgie, setLembre 189:J).
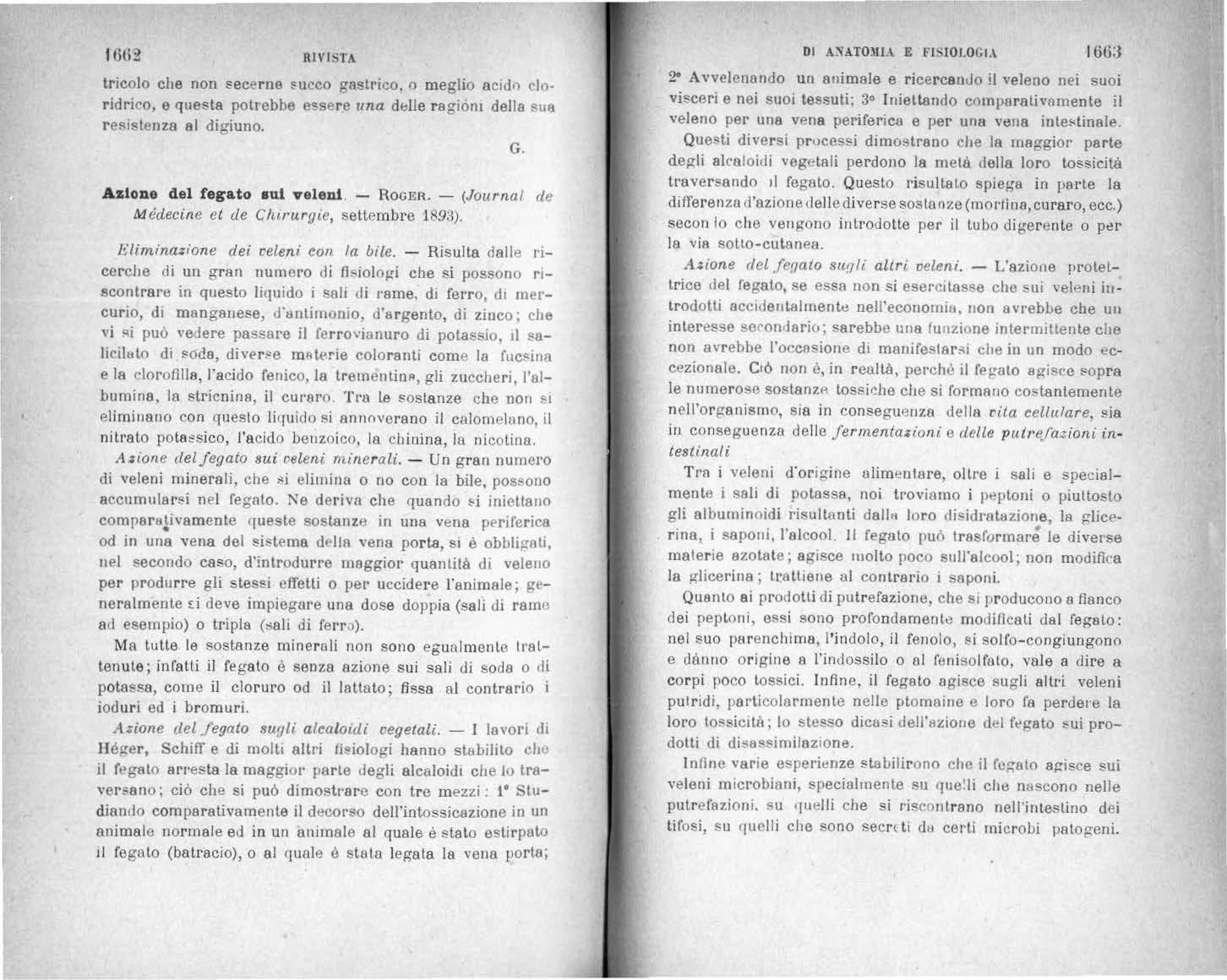
A.aione deljegato sui oeleni minerali. - Un gran nulllero di veleni minerali, che ,.i el imina o no con la bile, accumularsi nel regalo. Ne deriva che quando inieltano comparu1ivamente queste sostanze in una vena pt>riferica od in una vena del sistema dPlJn vena porta, s1 è nel secondo caso, d'introdurre maggior• quantità di veleno per produ rre gli stessi effelli o pe1· u ccide re l'anima le; generalmente d deve impiegar·e una dose doppia (sali di ra1M ad ese111pio) o tripla (,;ali Ji ferr0).
Ma tutte le sostanze minerali non sono egualmente trattenute; in falli il fe g ato e senza azione sui sali di soda o eli come il cloruro od il latta lo; fissa al contrario i ioduri ed i bromuri.
2" Avvel ena ndo un auimale e ricercando !l veleno nei suoi visceri e nei suoi tessuti; 3° Iniettando comparativamente il Yeleno per una vf'na periferica e per una inte!<linale. Qu e'"h prucesl'i dimostrano che la maggi01' parte alraloidi veg<,tali perdono la mela ùella loro lossicita tt•aversando 11 fegato. Questo risultato spiega in porte la differenza d'azione delle diverse sostanze (morliua,curaro, ecc.) secon lo c h e vengono introdotte per il tubo digerente o pèr la via solto-cuLnnea.
Azione del.feaato sua/i aUri veleni. - L'azior1e pl'olellrice del regalo, se essa non si eser·rito.sl'e che velPni introdotti acc1dentalmenlt! nell'economia, non avr·ebbe che un interesse scron lario; !"arebbe una funzione ìntermiltenle che non avrebbe l'ol"cosione d1 che in un modo eccezionale. C•ò non è, in realtà, pe1·ch<'• il !'Opra le numero-.r soslanzP Lossicbe che si rormar10 co"tantemenle n ell'o r gan isnw, sia in conseguenza della r:ita cellttlare, sia iu conseguenza ùelle fermentazioni e delle putre.fazioni intestinali ln lìne varie e"perienze stabilirono che il agisce sui veleni m1crobinni, specialmente su que:lì nuscono nelle puLrefazioni. "u quPJii che si r·isronlrano nell'intestino dei tifosi, su quelli che sono secrc li dtt certi microbi palogeni.
Trn i veleni d'origine alimenlar·e, oltr·o i sali e specialmente i sali di potassa, noi lroviumo i peptoni o piuttosto gli albuminoidi risultnnti dalltt loro di!o;id1·atazione, la glice· r ina, i sapouì, l'alcool. Il fegato può trasformare le dive1·se materie azota te; agisce molto poco sull'alcool; non modilka la glicel'ina; trat11ene al contrari o i saponi.
Quanto ai pt•otlolli di putrefazione, che SI producono a fianco dei pt>ploni, essi sono profondamenlu modiOcati dal fegato: nel suo parenchima, l' indolo, il fenolo, si solfo-congiungono e Jànno o rigine a l'indossilo o al fcnisolftllO, vale a dire a co r pi poco tossici. Infìne, il fegato agisce sugli alll'i veleni putr1di, pa1·ticolarmenle nello plornaìne c loro fa perdere la loro to'"sic1tà; lo stesso dicasi dell'llzioue dd ft>galo ;,ui prodotti di di"u"sim ilazione.










