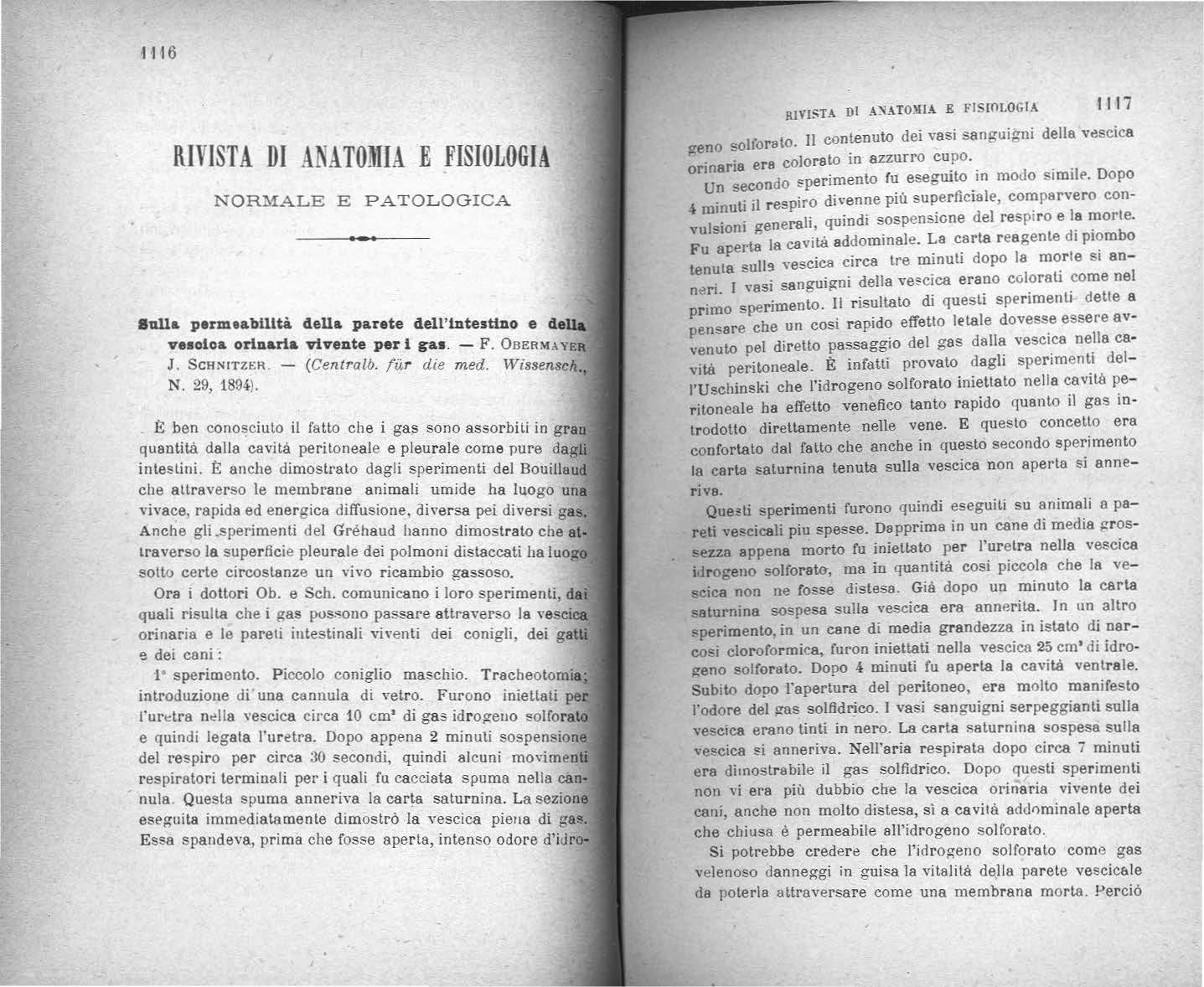
10 minute read
RIVI STA DI E FISIOLOGIA
N"ORMALE E PATOLOGICA
Sulla permeabllltà della parete dell'intestino e dell& vesoloa orlnarla vivente per l gas . - F. 0BERMAYEI\ J. ScHNtTZt-:R. - (Centralb. fu r die med. Wissensch ., N. 29, 1894)
Advertisement
1!: ben conosciuto il fatto che i gas sono assorbiLi in g ran quantità dalla cavità peritoneale e pleura.le come pure intestini. È anche dimostrato dagli sperimenti del Bouillaud che attraverso le membrane animali umide ha luogo una vivace, rapida ed ener gica diffusione, ai versa pei diversi gas. Anche gli .sperimenti del dréhaud hanno dimostrato che at· traverso la superfici e pleurale dei polmoni distaccati ha solto certe circostanze un vivo ricambio gassoso.
Ora i dottori Ob. e Sch. comunicano i loro sperimenti, dai quali risulta che i gas possono passare attraverso la ,·escica orinaria e le pareti intestinali viventi dei conigli, dei g atLi e dei cani:
1• spe rimento. P iccolo coniglio maschio. Tracheotomia; introduzione di una cannula di Yetro. Furono inieUali per l'urdra vescica circa 10 cm• di ga s id r ogeno solfo rato e quindi legata l'uretra. Dopo appena 2 minuti sospension e del respiro per circa 30 secondi, quindi alcuni movimenti respiratori terminali per i qua li fu cacciata spuma nella can· nula. Questa spuma anneriva la saturnina. La sezione esE'guita immediatamente dimostrò la vescica piena di gas. Essa spandeva, prima che fosse aperta, intenso odore d'id ro· ll·orato II contenuto dei vasi sanguigni della vdscica so · . r·a era colorato in azzurro cupo. orwa 1 • un secondo sperimento fu esegwto _1n modo similE'. Dopo 4 minuti il respiro divenne più superficialE', com parvero conl · · generali quindi sospensione del respi ro e la morte. VU SIOOI > ••
F erta la cavità addominale. La carta reagente d1 p10mbo u ap . . 1 . tenuta sulla Yescica circa tre mmull dopo a SI anneri. I vasi sanguigni della ve:;:cica erano colorah come nel primo sperimento. Il risultato di questi spE'rimenti dette a pensare che un cosi rapido effetto letale dovess.e esse1·e avvenuto pel diretto passaggio del gas dalla vesc1ca nella cavità peritoneale. È infatti provato dagli sperimenti deiI'Uschinski che l'idrogeno solforato iniettato nella cavità periloneale ha effetto venefico tanto rapido quanto il gas intr odotto direttam ente nelle vene. E questo concetto era confortato dal fatto che anche in questo secondo sperimento la carta saturnina tenuta sulla vescica non aperta si anneriva . sperimen ti furono quindi eseguili su animali a pareti vescicali piu spesse. Dapprima in un cane di media g r ossezza appena morto fu iniettato per l'uretra nella vescica idrogeno solforat.G-, ma in quantità cosi piccola che la vescica non ne rosse distesa. Già dopo un minuto la carta saturnina sospesa sulla vescica era annerita. In un altro ;.peri mento, in un cane di media grandezza in istato di narcosi cloro formica, furon iniettati nella vescica 25 cm• di idrogeno solforato. Dopo 4 minuti fu aperta la cavità ventrale. Sub1to dopo l'apertura del peritoneo, era molto manifesto l'odore del gas I vasi sanguigni serpeggianti sulla vescica erano tinti in nero. La carta salurnina sospesa sulla vescica si anneriva. Nell'aria respirata dopo circa 7 minuti e r a dimostrabile il gas solfidrico. Dopo questi sperimenti non vi e1·a più dubbio che la vescica orin aria vivente dei cani, anche non molto distesa, sì a cavità addt)minale aperta che chiusa è permeabile all'idrogeno solforato.
Si potrebbe credere che l'idrogeno solforato come gas velenoso danneggi in guisa la vitalità della parete vescicale da poterla attraversare come una membrana morta. Perciò
Ht8 RIIISTA
fu fallo uno sperimento con l'acido carbonico. Gatto di medtocre grandezza. Narcosi cloroformica; nella vescica vuota furono iniettate circa 5 cm• di anidride carbonica; e l'uretra legata. La vescica posta in un ,·aso pieno di ossigeno puro. Dopo 10 minuti in questo vaso era chiaramente dimostrabile con l'acqua di .calce la presenza dell'acido carbonico. In un secondo gatto fu eseguito lo stesso sperimento pochi minuti dopo la sua morte. Lo stesso risultato positivo. A simili sperimP-nti fu sottoposto il tubo intestinale: a un gatto ucciso da cinque minuti, essendo aperta la cavità addominale fu iniettata per l'ano una piccola quantità di gas solfidrico. Fu dilatata solo una piccolissima parte evitando la soverchia distensione. Tirata fuori un'ansa intestinale di circa 20 cm, fu introdotta in un vaso di vetro in cui si trovava della Clp'la saturnina umida. Questa in capo a 5 minuti si annerì. In un altro sperimento a un gatto in istato di narcosi cloroformica fu per mezzo di un catetere iniettato per l'ano nell'intestino dell'idrogeno solforato. Dopo 3 minuti si fece la laparotomia. Nessun manifesto odore di idrogeno so lforato. La ca rta reagent_e tenuta sopra il cieco annerì intensamP-nte. Fu aperta la cavità pleurale destra. In questa non era dimostrabile l'idrogeno solforato. Anche in questo sperimento la tensione dell'intestino era molto piccola . In un altro sperimento ancora, ad un gatto narcotizzato con l'etere fu introdotto per mezzo di una cannula nella ca,;ta ventrale una asperaione di magistero di bismuto, evitando la introJuzione dell'aria. Quindi furono iniettati pel retto circa 20 cm• di idrogeno solforato. DopJ 30 secondi, il gas solfidrico era dimostrabile nell'aria espirata. Dopo un minuto convulsioni e respiro affannoso. Dopo 5 minuti sospensione del respiro. Subito apertura della cavità addominale, mentre ancora il cuore batte va con forza. L'intestino non era gonfio .
MAnifesto odore di idrogeno solforHto , la aspet•sione del bismuto era annerita. La carta reagente di piombo tenuta al disopra dell'intestino subito annerì.
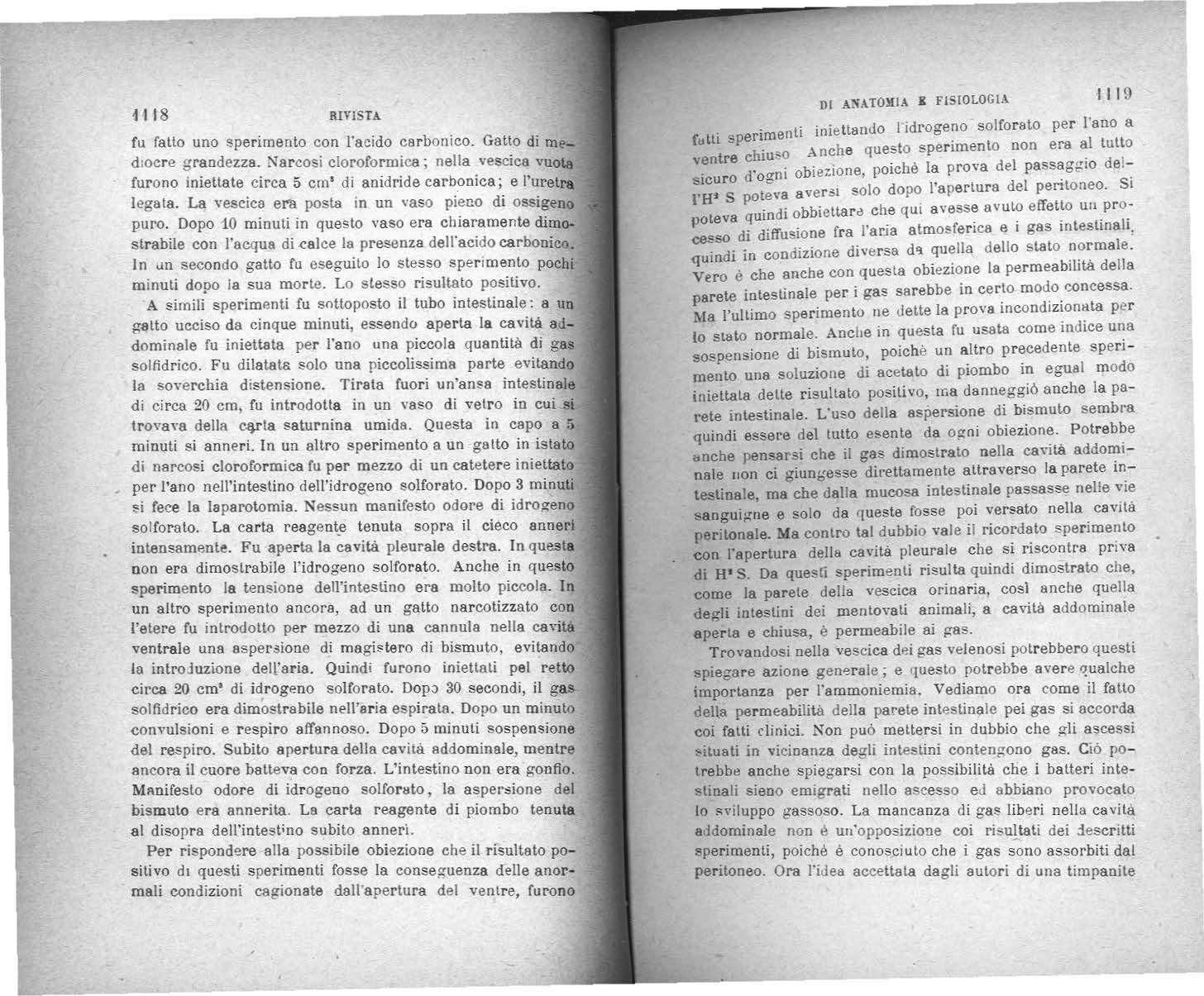
Per rispondere alla possibile obiezione che il risultato positivo dt questi sperimenti fosse la conseguenza delle anormali condizioni cagionate dall'apertura del ventre, furono
DI & FISIOLO GIA
1119
. t't ,·n·tetlando l'idrogeno solforato per l'ano a f tr spertmen 1
A nche questo sperimento non era al tutto obiezione, poiché la prova del passag!_!io pot;va ave r5 i solo dopo l'apertura del peritoneo. S1 d. obbiettard che qui avesse avuto effetto un pro· poteva qutn l r di diffusione fra l'arja atmosfertca e l gas tntestma ' , . d. · condizione diversa d'i quella dello stato normale. qum 1 10 b·l"tà d Il Vero è che anche con questa obiezione la permea l • e a parete intestinale per i gas sarebbe in cer_to Ma l'ultimo sperimento ne dette la prova per lo stato normale. Anche in questa fu usata come tndtce sospensione di bismuto, poichè un sperimento una soluzione di acetato di piOmbo m egual modo iniettata dette risultato positivo, ma danneggiò anche la parete intestinale. L'uso della aspersione di bismuto sembra quindi essere del tutto esente da .. pensarsi che il gas dimostrato nella caYllà nale uon ci giun"esse dil'ettamente attraverso la parete tntestinale ma che 0 dalla mucosa intestinale passasse nelle vie e solo da queste fosse poi versato nella. cavità perilonale. Ma contro tal dubbio vale il con l'apertura della cavità pleurale che s1 rtscontra prtva di H' S. Da quesri sperimenti risulta quindi dimostrato che, come la parete della vescica orioaria, cosl anche degli intestini dei mentovali animali, a cavità addommale aperta e chiusa, è permeabile ai gas.
Trovandosi nella vescica dei gas velenosi potr ebbero questi spiegare azione e questo potrebbe avere t;!ualche importanza per l'ammoniemia. Vediamo ora come il fatto della permeabilità della parete intestinale pei gas si accorda coi fatti dioici. Non può mettersi in dubbio che gli ascessi in vicinanza degli intestini contengono gas. Ciò potrebbe anche spiegarsi con la possibilita che i batteri intestinali sieno emigrali nello ascesso eJ a bbiano provocato lo Rviluppo gassoso. La mancanza di gas liberi nella cavità a.idominale non è un'opposizione coi risu!tali dei jescritti sperimenti, poiché è conosciuto che i gas sono assorbiti dal peritoneo. Ora l'idea accettata dagl i autori di una tirnpanite
1120 peritoneale senza lesione di continuo dell'intestino, dopo gli sperimenti dei dottori Obermayer e Schnitzler, non sem bra più cosi insostenibile come ora si è inclinati a ritenere.
Imlerva.zlone 4el cuore.- Ta. W. ENGELMAN.- (Pflùger's Are/t. e Centra lb.fù.r die J1:edie. W issensch.,N. 24, 1894).
L'antica dottrina che la causa della intrinseca attività del cuore e del ritmo cardiaco sia da ricercarsi nel nervoso proprio del cunrè é stata da qualche tempo scossa da diverse osservazioni :
1• i movimenti r•erio<.lici dell' uretere avvengono per la eccitabilita automatica delle fibre muscolari e non sono cagionate da gangli ; .. -
2' la contrazione del cuore, eccitandolo artificialmente, comincia sempre nella parte direttamente eccitata. Tagliando il veotricolo cardiaco in tanti pezzi, ogni pezzelto !>i comporta sostanzialmente verso la eccitazione artificiale come H ventricolo intero ;
3o la eccitazione e anche l' ')nda di eccitazione elettrica si propaga nel cuore dal luogo dell' eccitazione verso tutte le direzioni. Questo non potrebbe spiegarsi per via dell'eccitamento nervoso, ma solo ammettendo che la eccitazione si comunichi da cellula muscolare a cellula muscolare.
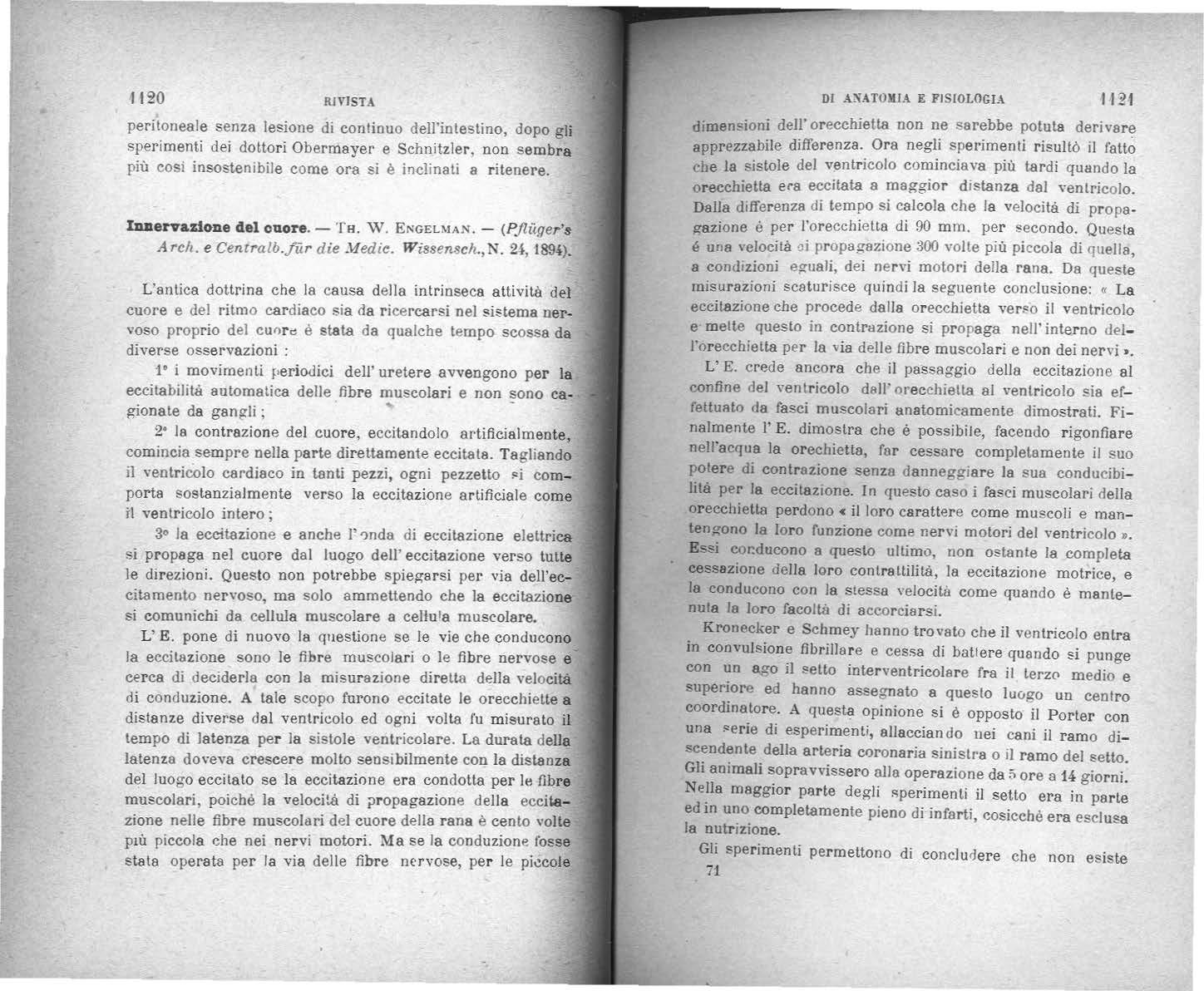
L'E. pone di nuovo la questione se le vie che conducono la eccitazione sono le fibre muscolari o le fibre nervose e cerca di deciderla con la misurazione diretta della velocità di conduzione. A tale scopo furono eccitate le orecchiette a distanze diverse dal ventricolo ed ogni volta fu misurato il tempo di Jatenza per la sistole ventricolare. La durata della latenza doveva crescere molto sensibilmente con la distanza del luogo eccitato se la eccitazione era condotta per le fibr e muscolari, poiché la velocità di propagazione della ecciW!zione nelle fibre del cuore della rana è cento volte p1ù piccola che nei nervi motori. Ma se la conduzione fosse stata operata per la via delle fibre per le dimen!'iooi dell' orecchietta non ne sarebbe potuta derivare apprezzabile differenza. Ora negli sperimenti risultò il che la sistole del ventricolo cominciava più tardi quando la orecchielta era eccitata a maggior distanza dal ,·entricolo. Dalla differenza di tempo si calcola che la velocita di propagazione è per l'orecchietta di 90 mm. per secondo. Questa é una ,·elocità oi propagazione 300 volle più piccola di quella, a condizioni dei nervi motori della rana. Da queste misurazioni scaturisce quindi la seguente conclusione: cc La eccitazione che procede dalla or ecchietta ver!'>O il ventricolo e mette questo io contrazione si propaga nell'interno delrorecchietta per la "ia delle fibre muscolari e non dei nervi •.
L'E. crede ancora che il passaggio della eccitazione al confine del venlricolo dall' orecchietta al ventricolo sia effettuAto da fasci muscolari anatomicamente dimostrati. Fil'E. dimostra che è possibile, facendo rigonfiare nell acqua la orechietla, far cessare completamente il suo potere di contrazione senza danneggiare la sua conducibilita per la eccitaziOne. I n questo caso i fasci muscolari della orecchietta perdono c il loro carattere come muscoli e mantengono la loro funzione come nervi motori del ventricolo ». Essi a questo ultimo, non ostante la completa cessazaone della loro contrattilita, la eccitazione motrice, e la conducono con la stessa velocilil come quando é mantenuta la loro facolta di accorciarsi.
. Kronecker e Schmey hanno trovato che il ventricolo entra m e cessa di battere quando si punge con 11 setto mterventricolare fra il terz() medio e ed hanno assegnato a questo luogo un centro coordinatore. A questa opinione si è opposto il Porter con una !'erie di esperimenti, allacciando nei cani il ramo didella arteria coronaria sinistra o il ramo del setto. Gh ammali alla operazione da 5 ore a 14 giorni . Ne!la magg1or plirte degli sperimenti il setto era in parte ed w completamente pieno di infarti, cosiccbè era esclusa la nutr1z1one.
Gli sperimenti permettono di concluiJere che non esiste alcun centro di coordinazione, nel senso ordinario di un ristretto accumulo di cellule nervose sia nel setto, sia in qualun'jue altra patte della parete ventricolare.
Ol A:\ATOlllA E FISIOLOGIA l rincipio la struttura, questa lesione basta per determi11 p tro· r.a nelle fibre sensitioe originanti da essi nella nare a . . midolla spinale, nella midolla allungata ed alla perijer ta · rincipio nei loro punti terminali; quest'atrofia ascende znp .. l . . di mano in mano, cioè si aoanza smo at gang t sptna t,nalmente inoade anche questi, almeno le fibre int r aganglionari. se il processo dura lungo tempo anche nelle cellule possono tro,·arsi i segni della degenerazione. delle -cellule ner·vose del gauglio (pigmentazrone, mtorbtdamento e spesso anche corrugamento) furon o tanto dagli autori, quanto dal Wollember·g corJsiderate come. passeg.giere ed associate alle j!ravi alterazioni delle radrcr poster1ori e della midolla spinale.
Controversa era l'opinione che le primitive lesioni della tabe. sede nei gangli spinali. N el i885 riusei al S1emerhng e ali· autore di os:servare in tre cas:i di tab dorsali importanti alterazioni nei gangli spinali. Da lali cerche t·isultò che non solo era atrofica la radice posteriore ma le :>lesse fibre midollari di sostegno nel ganglio quas1 del lutto degenerate.
Perci ò fu dimostrato che il processo di degenerazione dell a tabe non era limilato al ganglio spinale . .
M?lti .moderni come Leyden, Redlich, Pierre Marie, Rabmskr, Marrus Carré ed altri concordano in generale nel che le lesioni dei gangli e S!)ecialmenle di quelli spinali, s1eno la sede morbosa primari a della tabe dorsale.
. L fino dal de!:crisse un caso di tabe dorsale, m CUI. cons1derevoli disturbi sensili vi nel campo del lrtgemmo ed oltre l'or,Jinaria derrenerazione della radice posterior e del detto nervo, osserv ò :trofia tanto fibre quanto delle cellule del ganglio di Gasser. Ciò é d1. grande importanza, perché la radice del trigemino denomwata ascendente, realmente é discendente ed ha oriaine dal ganglio di Gasser. "'
Le cognizioni acquistale in questi ulti mi anni dimostrano . la. tabe. oper a quale aaente gene r atore sopra i gang l; spmalt erl l lo r o omologhi, nuoce ad essi, senza modificare
Rivista Oelle Malattie Veneree Eoella Pelle
<:ura del bnbbonl uloeratl col ra•ohlamento e la 1utnra tmme41ata . - - (.1. rch. géné r. de Mé decine, 5, 1891 e Ujf. Sanitario, luglio 1894).
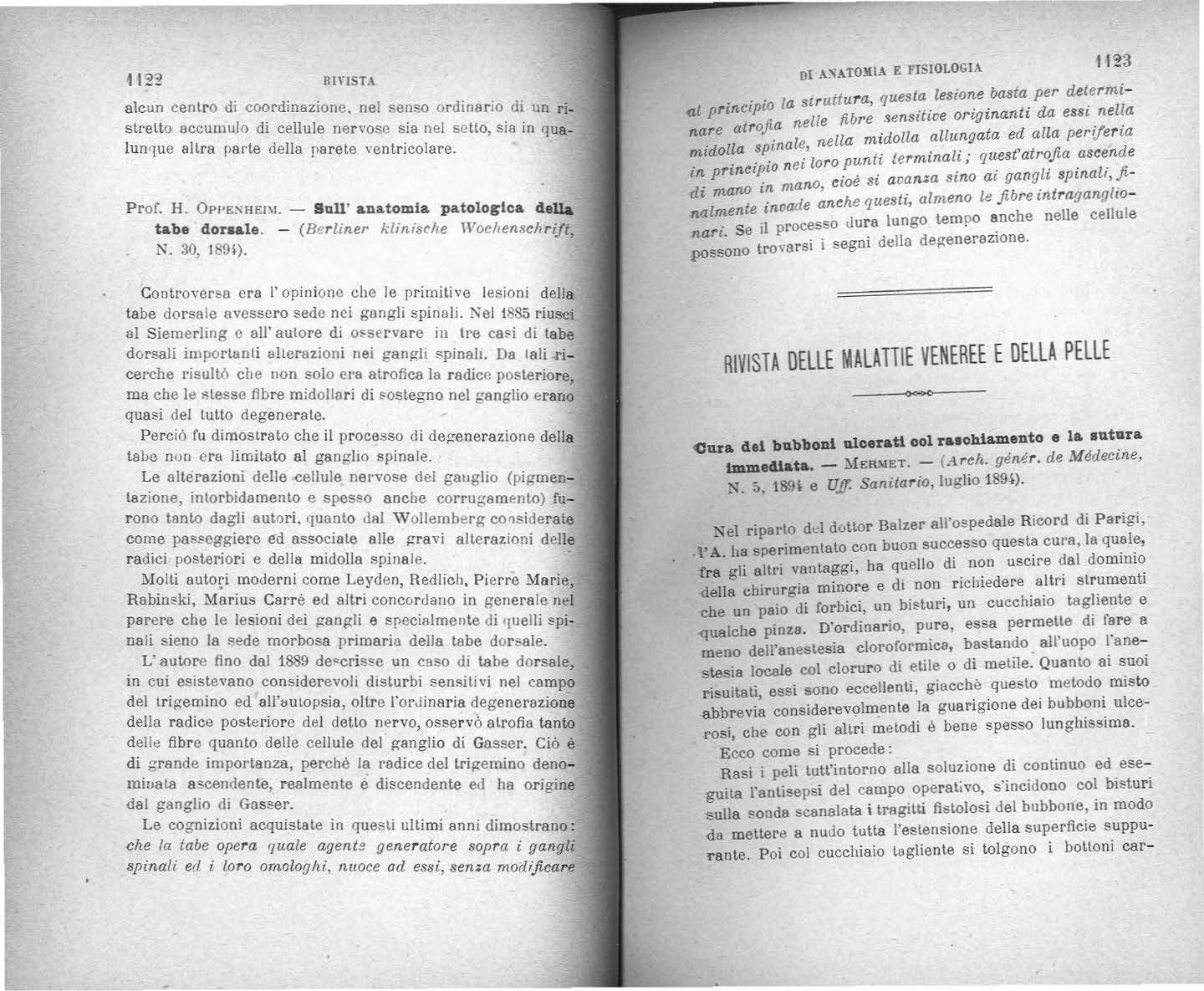
Nel riparto dd dottor Balzer all'ospedale Ricord di Parigi, .\' A. ha sperimentato con buon successo questa cura, la quale, fra gli altri vantaggi, ha quello di non uscire dal dominio della chirurgia minore e di non richiedere altri strumenti che un paio di forbici, un bisturi, un cucchiaio tagliente e -qualche pinza. D'ordinario, pure, essa permelLe di fare a meno dell'anestesia cloroformica, bastando all'uopo rane-stesia locale col clorur o di etile o di metile. Quanto ai suoi risultati, essi sono eccellenti, giacchè questo metodo misto -abbrevia considerev<;>lmente la guarigione dei bubboni ulcerosi, che con gli altri m etodi é bene spesso lunghissima.
Ecco come si procede:
Rasi i peli tuU'intorno alla soluzione di continuo ed eseguita l'antisepsi del campo operativo, s·incidono col bisturi -sulla sonda scanalata i tragitti fisLolosi del bubbone, in modo mettere a nudo tutta l'estensione della superficie s uppurante. Poi col cucchiaio tagliente si tolgono i bottoni car-










