
61 minute read
4464 RlVlSTA
CANTLIE: - n b&ctllo della peste. - (Brit .•1\fed. 18 agosto 1894).
II D. CanUie, l'epidemia di peste che ha infier ito a Hong Kong, ha fatto dei preparati che ha fatto esaminare del D. Woodhed, il quale ha redatto il seguente r a p . porto: a Gli *'sernplari mandati mi in esame sono preparati croscnpici del fegato e della milza d'un topo inoculato col sangue dalla parte centrale d'un bubbone femorale . Uno di essi è già stato GO!orato con soluzione acquosa di v1oletto di genziana: gli aiLri lo sono stati da me con soluzione glicero- alcoolica di fucsina. Ilo ·trovato organismi, i qu ali all'obbiettivo 8 Zeiss e all'oculare 1/u ad immersione ad olio Leitz rassomigliano a diplococchi inclusi in una delicata capsula ed a corti bacilli ad estremità arrotondate: nel loro centro esiste un tratto o spazio chiaro: mR la forma predominante è un diplococco o corto bacillo La g randezza loro var·ia considerevolmente a seconda del ". ·- --- ..... ............... di colorazione impiegato: ess1 sembrano più piccoli in una soluzione acquosa di violetto genziana che in quella gli cerinica di fucsina. Nel preparato fatto colla polpa splenica si ha una cultura quasi pura del bacillo; le poche cellule sparsevi sono più fortemente colorate e sembrano cun poco gonfie: ciò però dipende evidentemente dal modo della prepar&zione. f: evidente che il diametro della capsula e la sua capacità ad esser e colorata varia molto ed è perfettamente possibile che quest'apparenza di capsule ras somigli a quella che alcune volte si vede attraverso bacillo dell'antrace quando è colorato con speciali soluzioni, oppure può essere semplicemente una retrazione dell'albumina do· vuta al ragg r inzamento del bacillo determinato dall'essiccamenLo o da altr i processi di preparazione ».
Advertisement
I n una seduta dell'Accademia delle Scienze di Pa r igi, il Duclaux comunicò una lettera del D. Yersin assistente di Pasteur, il quale ai principj di giugno fu inviato a Hong Kong in missione scientifica del Ministero delle colonie. Il D. Yersin afferma di aver e isolato nei tessuti degli a ppestati un piccolo bacillo difficile a colorarsi coi comun i reat-
MEDICA 1465 th·i ma facile ad essere coltivalo su agur a:rur. Que:::to microrganismo abbonda specialmente nelle 1dandole inguinali, iJ cui ingorgo forma le lesione caratteristica della malallia. Il bacillo è facilmente inoculabile nei ratti (le mortalità di questi rosicanti è stata notevole durante l'epidemia) nei topi e nelle cavie: tutti questi animali muoiono rapidamente in seguito all'inoculazione.
L'alimentazione falla per mezzo di parti d'organi tolti da individui morti di peste è anche rapidamente fatale.
Il D. Chantemesse annunziando al Comitato di I giene le scoperte di Yersin, fece noto che questi ha spedito al dottore Roux dell'Istituto Pasteur un certo numero di preparati e di sezioni rappresentanti il bacillo descritto.
G. G.
D el fattori dell'anemia nelle malat tie delle vle respiratorie. - DrJtt. FELICE CHABORY. - (Pro,qrès médical, K. 24 del 1894).
L'autor e, stabi lito che l'appar ecchio respirato r io quale organo dell'assorbimento dell'ossigeno, ne fornisce srno la quantità indispensabile alla completa evoluzione del globulo r osso, e constatato che nella maggior parte delle m alattie delle vie respiratorie si riscontra una anemia evidente e costante, cerca di analizzarne le cau"'e che la determinano.
Fattòr i principali di questa anemia sarebbero secondo l'autore. i seguenti:
La diminuzione del calibro delle oie conduttriei dell'a r ia.
_ Questa causa è dimos t1·ata da lla anemia dei fa nciulli che hanno l'ipertrofia del e amigdale palatine: i fibromi nasofaringei che riempiono la faringe l'ipertrofia tonsillare chfl diminuisce la cavità della fa r inge retro ·bucca le, lo stringimento dell'orificio superiore laringeo, le stenosi della glottide, la diminuzione di calibro trachea e dei bronchi, soo tutte cause che riducendo la quantità d'ar ia portata a contalto della massa san:zuigna polmonare finiscono col determinare più o meno prontamE'nte l'tmemia. Anche se la. res!)irazione buccale supplisce alla r espirazione nasale, l'eiTetto, la conseguenza sarebbe la medesima, poicM l'ttt·ia portata ai capillari deìla piccola circolazione vi giunge troppo bruscamente, troppo fredda, troppo sacca, troppo carica di pulviscolo, determinando\i fenomeni spasmodici e conessendo inliue un alimento mal preparato.
Le, diminu;ione della superficie d'assorbimento dell'aria e i disturbi nella piccola eireoltUione. - Diminuisce la quan. tità di che penetra nel sangue, se si trova diminuita la d'assot·bimento, se il filtro è inspessito 0 modificato nella sua struttura, o se ne P. disturbata la cir co.
!azione dP.i capillari: agiscono io ta l guisa la bronchite coll'infiltrazione della mucosa, e la secrezione che la rive!':te l'asma coi suoi di!'tUJ·bi vaso-motori, la e colla compressione degli alveoli, e tante altre affezioni che si localizzano nell'apparato respiratorio, ma più che tutte la ti si comune, la tisi ulcerosa che riunisce a ..:<>termina quasi tutte le ultre lesioni.
Tutte le mazattie delle oie respiratorie sono a ccompaguate o seguite da una anemia più o meno g r ave e prolungata in rapporto colla intensità e la durata della febbre, si11tomo della i!dezione. La bronchite infettiva specitlca del morbillo, del grippe, ecc. sono focolari infialllmatori e di infezione che aggravano l'anemia dipendeute da queste malattie Nella tubercolosi il pronostico è più grave e mollo piu pronunciata nelle forme febbrili che in quelle apirettiche, e la composizione del sangue è diversa e assa: piu alterata in quelle che in queste.
Le neoplasie sia benigne che maligne delfapparato resoiratorio. - Qualuuque specie di tumore, prOYOC8 dim inuendo il calibro delle vie respiratorie, ed il campo delrematosi.
Le emorragie c1elle vie respiratorie sono, come qualunque altra emorragia, causa di anemia di gravità proporziona ta alla perdita avvenuta.
Le patologiche della mifcosa respiratoria .Questa membrana di rivestimento, che dalla pituitaria si estende fino all'epitelio Jelle maglie esistenti fra i minimi del piccolo circolo, è di una grande estensione e le
Medica 1467
sue secrezioni, minime stato normale, si fanno abbondantissime in taluni stati patologici, in cui essa diventa una vasta raccolta purulenta oltre che focolaio d'infezione per se stessa, sorgente d'impovf\rimen lo e spogliazione per tullo l'o rganismo. Ogni suppurazione è accompagnata o seguita da anemia tanto più pronunciata quanto più e la super fi cie suppurante.
Secon do Lépine e Hamburger il peso m e dio d ell 'essudato nella polm o nite sarebbe in media di 600 gr , in certe forme di bronchiti purulente si ha talora una espe ttorazione, quasi purulenta, Iii mezzo litro nelle ventiquattro ore.
Distu r bi negli altri Or[Jani, prooocati da offe;ioni delle rie :--espiratorie e cause d'anemia. - Le malettie croniche dei polmoni, enfisema, asma, portano la dilatazione del cuore destro, la sua degenerazione grassa, disturbi cireolato ri e conseguente modificazione nella composizione del sangue. I disturbi digestivi, complicazioni frequenti ed osti nata delle affezioni delle vie come i fenomeni nervosi, tosse, cefalea, insonnia, depressione, ipocondria snno del pari imporlanti di anemia.
Dalle ricerche eseguite da va!'i autori nelle diverse affezioni poimonari é dimostrata l'alterazione della composizione del :oangue, specialmente la notevofe dell'emoglobina.
H lavoro è chiuso dall'autore col riportare di,·erse analisi di Quinquaud, Lasègue, Ha yem, fatte sul sangue in varie croniche polmonari, ed in particolar mo.fo nelle forme tubercolari, ed in cui le evid en ti fa,·orevoli modifìcazioni risullanti da un trattamento coll'ossigeno vengono in· direttamente ad !"idea delraneroia pe1· difetto di ossidazione del sangue. A. c.
P arAlis i r eoldt v a nte del terzo palo . - P. DARQUJER. _ (Journal de Mèdeeine et de Chirurgie, luglio, 1894).
Questa affezione singolare, che Chat·col 1Hl chiamata anche emicrania ottalmoplegica, è mollo rar·amente osser,•ata in Francia poichè Gli'infuori di una prima osservazione dovuta a Gubler, non ne esistono che due, una di Parinaud e Marie, e raltra di Charcot. L'Autore, avendone osservato un caso, ha fatto su questo argomento uno studio molto interessante in cui ha riunito tutte le osservazioni conosciu te, in numero di ventiselle.
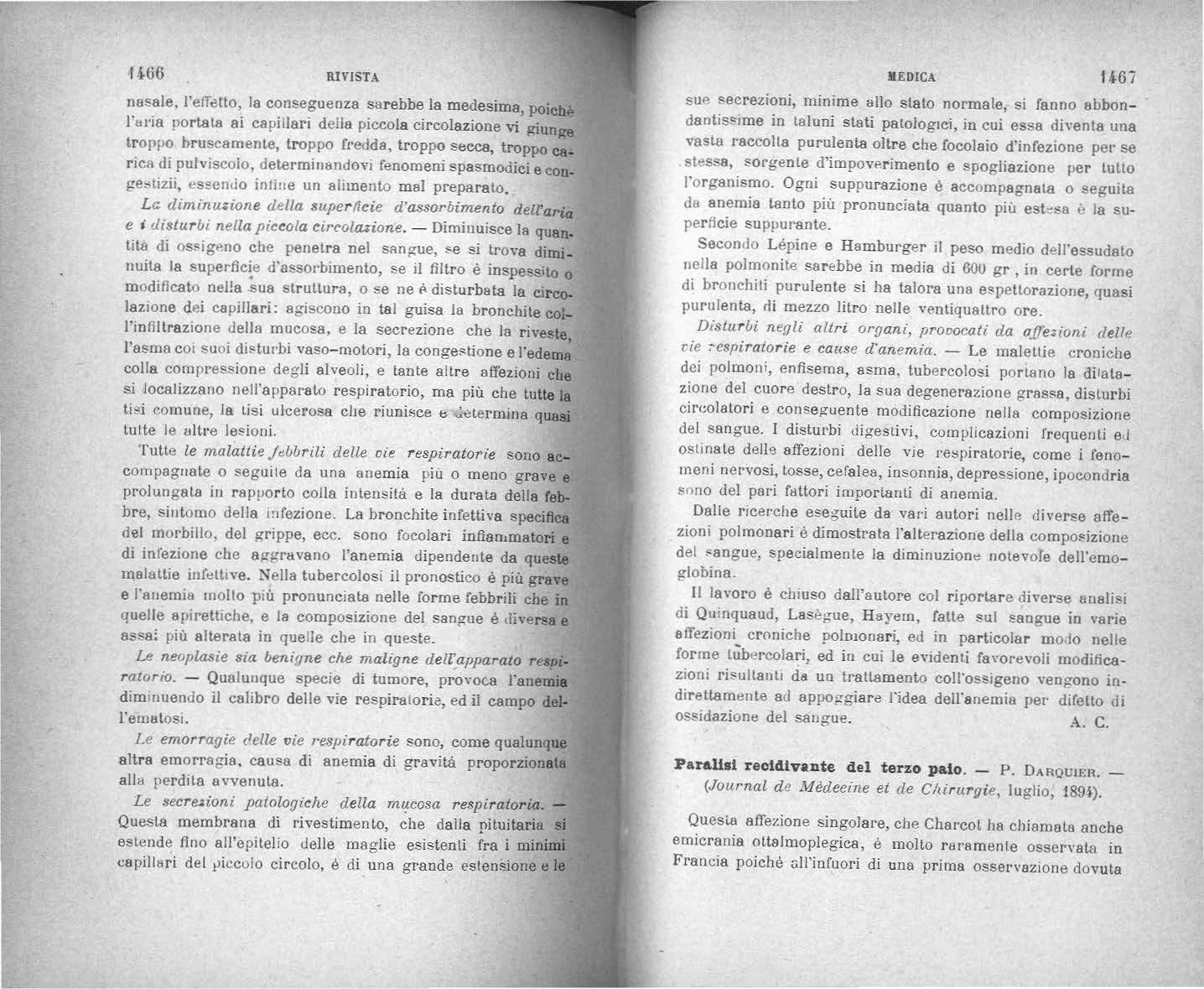
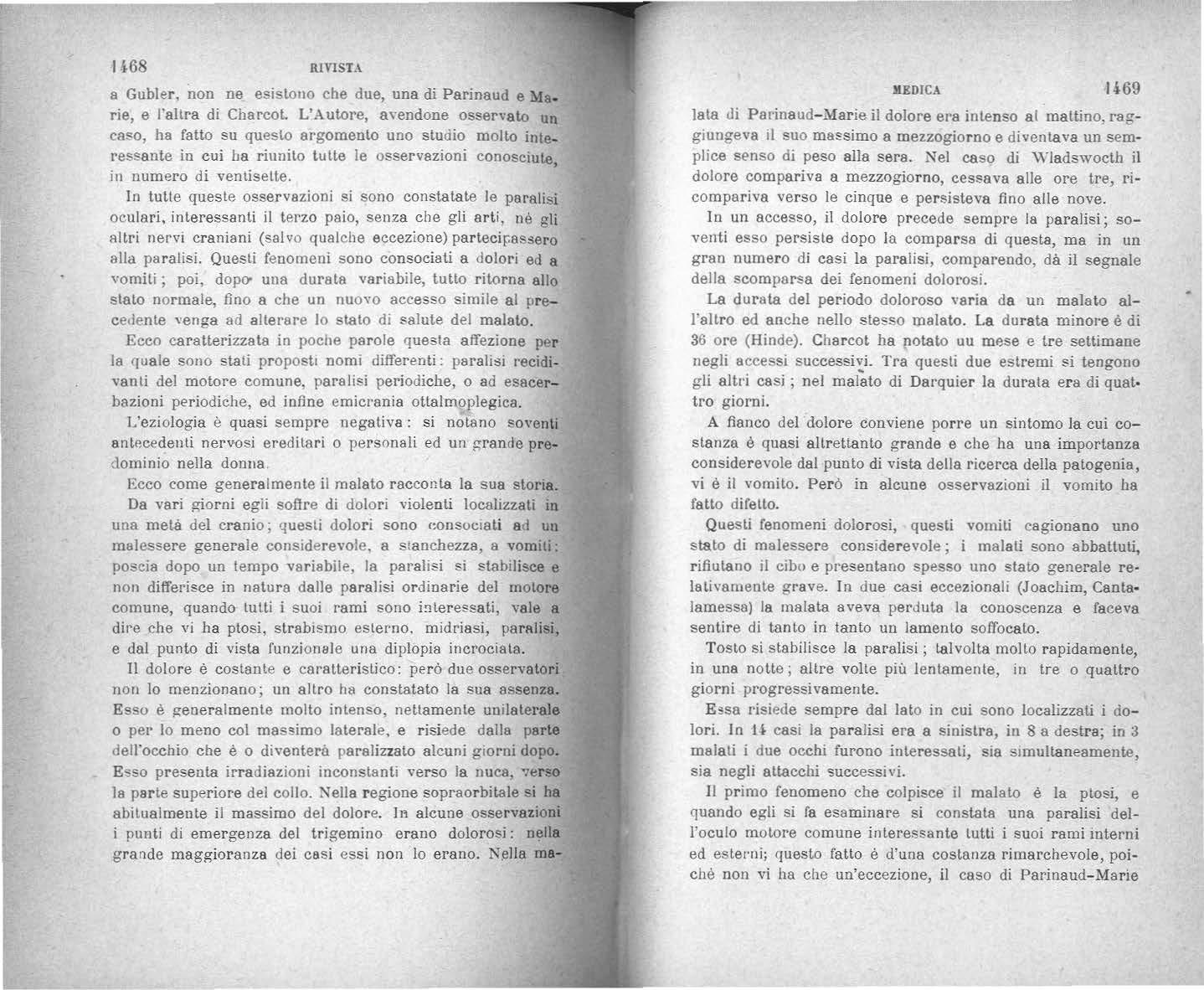
In tutte queste osservazioni si sono constatate le paralisi ocula ri, interessanti il terzo paio, senza che gli arti, né gli Altri nervi craniani (sal v o qualche eccezione) partecipas:>ero alla paralisi . Questi fenomeni sono consociati a dolori ed a vomiti ; poi, dopO' una durata variabile, tutto ritorna allo stato normale, fino a che un nuovo accesso simile al precede nte venga ad alterare lo stato di salute del malato.
Ecco caratterizzata in poche parole questa affezione per la quale sono stati propostr nomi differenti : paralisi recidivanti del motore comune, paralisi periodiche, o ad esacerbazioni periodiche, ed infine ernicr·ania ottalmoplegica.
L'eziologia è quasi sempre negativa : si notano sovenLi anteceden ti nervosi ereditari o personali ed un grande predominio nella donna .
Ecco come generalmente il malato racconta la sua storra.
Da vari giorni egli soffre di dolori violenti localizzati in una meta del cranio; questi dolori sono eonsociati ad un malessere generale considerevole, a s tanchezza, a vomiti: poscia dopo un tempo variabile, la paralisi si stabilisce e non differisce in natura dalle paralisi ordinarie del motore comune, quando tutti i suoi rami sono i!lleressati, vale a di1'e che vi ha ptosi, strabismo esterno. midriasi, parAlisi, e dal punto di vista funzionale una diplopia incrociata .
Il dolore è costante e caratteristico : però due osservatori non lo menzionano; un altro ha constatato la sua assenza. Esso è generalmente mollo intenso, nettamente unilaterale o per lo meno col massimo laterale, e risiede dalla parte dell'occhio che è o diventerà paralizzato alcuni giorni dopo.
Esso presenta irrad iazioni inconslanli verso la nuca, ·:erso la parte superiore del collo. Nella regione sopraorbiLale si ha abitualmente il massimo del dolore. In alcune osservazioni i punti di emergenza del trigemino erano dolorosi : grande maggioranza dei casi ess i non lo erano . N.ella ma- l!BDICA 1469
!ala di Parinaud-Marie il dolore era intenso al mattino. raggiungeva il suo massimo a mezzogiorno e diventava un semplice senso di peso alla sera. Nel caso di Wladswocth il dolore compariva a mezzogiorno, cessava alle ore tre, ricompariva verso le cinque e persisteva fino alle nove.
In un accesso, il dolore precede sempre la paralisi; soventi esso persiste dopo la comparsa di questa, ma in un gran numero di casi la paralisi, comparendo, dà il segnale della scomparsa dei fenomeni dolorosi.
La durata del periodo doloroso varia da un malato all'allro ed anche nello stesso malato. La durata mino1·e è di 36 ore (Hinde). Charcot ha notato uu mese e tre settimane negli accessi successivi . Tra questi due estremi tengono gli altri casi ; nel mal"àto di Darquier la durata era di qual· tro giomi.
A fianco del dolore conviene porre un sintomo la cui costanza é quasi altrettanto grande e che ha una importanza considerevole dal punto di vista della ricerca della patogenia, vi é il vomito. Però in alcune osservazioni il vomito ha fatto difetto.
Questi fenomeni dolorosi, questi vomiti cagiona no uno stato di malessere considerevole ; i malati sono abbattuti, rifiutano il cibo e presentano spesso uno stato generale relativamente grave. In due casi eccezionali (Joachim, Canta· Jamessa) la malata aveva perduta la conoscenza e faceva sentire di tanto in tanto un lamento soffocato.
Tosto si stabilisce la paralisi; talvolta molto rapidamente, in una notte; altre volte più lentamente, in tre o quattro giorni progressivamente.
E:>sa risiede sempre dal lato in cui sono localizzati i dolori. Io 14 casi la paralisi era a sinistra, in 8 a destra; in 3 malati i due occhi furono interessati, sia simultaneamente, sia negli attacchi <successivi.
Il primo fenomeno che colpisce il malato è la plosi, e quando egli si fa esaminare si constata una paralisi dell'oculo motore comune interessante Lutti i suoi rami interni ed ester·ni; questo fatto è d'una costanza rimarchevole, poiché non vi ha che un'eccezione, il caso di Parinaud- Marie
Rivista
nel quale l'elevatore della palpebra era intatto. Si dovran · d" no qutn 1 constatare plosi, slrabi!':mo esterno, midriasi, e dal punto di vista runzionale disturbi nei movimenti di addu• zione, di abbassam e nto, di elevazione, infine una diplopia incrociata.
Il più spesso la paralic:i é incompleta; i movimenti non sono totalmente aboliti; la mo tilita dell"occbio è oote'-'olmente diminu ita; mA i movimenti sono ancora abbozzati.
Tali sono i tre più costanti dell'affezione; a fianco di essi si possono porre altri segni meno frequenti, ma che furono riscontrati in alcune osservazioni: tali sono certe alterazioni del fondo dell'occhio; pupilla mal limitata, vasi ùi· latati; l'>Oventi diminuzione dell"acutezza visiva del Jato maJato; restrigimento del campo visivo ecc.
Pare che la malattia si inizii fra i cinque ed i dodici anni. Un fatto degno di nota é che in un gran nuffiv"!'o di casi si é visto çer molto tempo esistet·e il dolore ed essere consociato a vomiti senza alcun fenomeno oculare.
Dal punto di vista della ri produzione degli accessi e degli intervalli che li separano vi sono tante variPtà quanti sono i malati: si può anzi dire che nello stesso soggetto non si constata periodicilà. Un !'tOlo caso, molto notevole, q uello di Von Hasner, sembra offrire una base alla pretel'la che avevano certi autori di chiamare queste paralisì per iodiche. Gli accessi cominciarono a 13 anni, prima della mestruazione, furono mensili prima della sua comparsa e contmuarooo ad el'lserlu in È quasi sempre lo stesso occhio che e preso negli acce!:si successivi.
Pare che la malallia, se si omettono alcuni casi eccezionali, duri tutta la vita e che l'infermo sia dt>slinalo a con intervalli più o meno eguali, riprodu 1·si !lli accessi. Per allt·a parle l'affezione è sopportata molto bene; i malati soffrono, sono in uno stato rei ati vam ... gr·avè, nel periodo doloroso; ma negli i!llervalli la mag-gior parte deglì hanno notato che la salute del loro soggetto era fiorente, l'Appetito eccellente, e che lo stato generale non ne risentiva per nulla del periodo acuto.
liEDICA 14-71
E siccome sulle 27 osservazioni pubblicate, tre soltanto hanno avuto esito letale (tra esse, un solo dece!':so deve essue attribuito direttamente alla_ malattia), il pronostico può essere considerato come benigno.
Resterebbe a determinare la natura di questa sinaolare ma lattia: Charcot la considerava come un'emicrania. s;nator ammetkrebbe: to un gruppo in sarebbe nettamente emicranica, d namica; 2<> un gruppo in eu e!:'iste· r e bbe un tumore, una neoplasia qualsiasi, e che simulerebbe io una maniera qua!;i perfetta l'affezione emicranica.
La cura ha consistilo soltanto Of!JI'uso dei calmanti (iniezione di morfina) e del bromuro o del joduro di potassio.
UNSCHuLo. - Diabete. - · (Brit. M ed. Journal11 agosto 1894 e Berl. Klin. W oeh, luglio 1894).
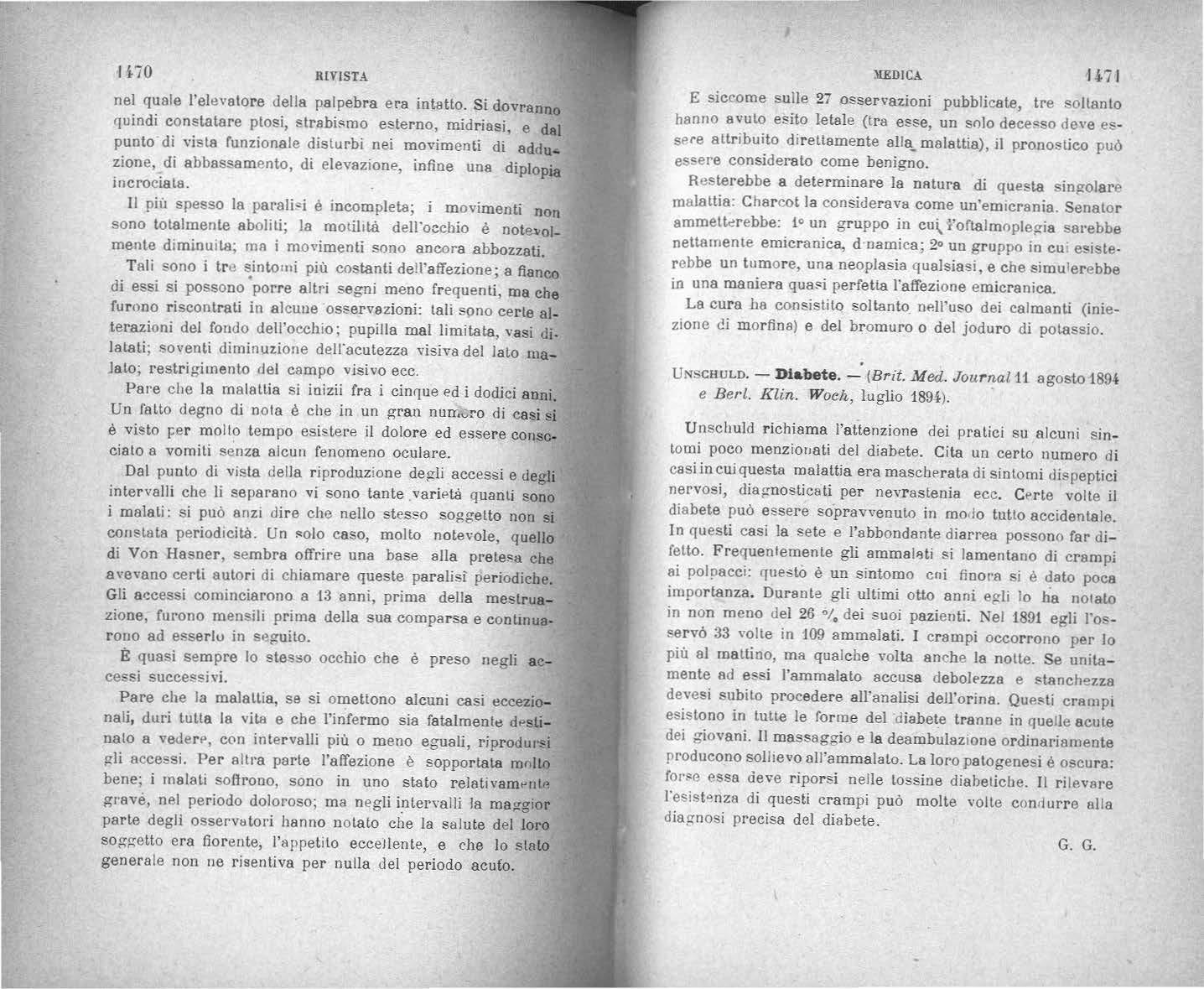
U nschuld richiama l'a ttenzione dei pratici su alcuni sintomi poco menzionati del diabete. Cita un certo numero di casi io cui questa malattia era maschPrata di sintomi dispeptici nervosi, per nevr astenia ecc. Ct>rte volte il diabete può essere sopravvenuto in modo tutto accidentale. In questi casi la sete e l'abbondante diarrea possono far digli arnmall3li si lamentano di crampi a1 polpacc1: questo è un sintomo cni finora si è dato poca importanza. Durante gli ultimi otto anni egli lo ha notato in non meno del 26 "/• dei suoi pazienti. rei 1891 egli l'osservò :33 volte in 109 ammalati. I crampi occorro no per lo più al mattino, ma qualche >olta anche la notte. Se unitamente ad essi l'ammalato accusa debolt-zza e stanchezza de_vesi su_bito procedere all'analisi dell'orina. Questi cramp1 eststono 10 tutte le forme del diabete tranne in quelle acute dei giovani. Il massaggio e la deambulazione ordinariamente producono sollievo oll'ammalato. La loro patogenesi è oscura: for1>e essa òeve riporsi nelle tossioe diabetiche. 11 rilev11re l"esist"'nza di questi crampi può molte volle condurre alla diagnosi precisa del diabete.
G.
NISSf:N. - Valore dia.gnostioo della reazione dlazotc-.. (Brit. M ed. Journal15 setteu1bre e Jahr. jur /(indheilk. Bd. 38", 2 e 3 fase.).
Nis!'en ha studiato questa reazione in 462 bambini etl'etti da diverse malattie per determinarne il valot·e di agnostico. Egli ha trovato che essa esiste sempre nella febb1·e tifoidea , nel morbillo e nella tubercolosi miliare. Occasionalmente tro,·asi anche nella polmonite acuta e cronica, nella pleurtte, laringite, difterite, er1s1pela, carie delle costole e nella metà circa dei casi è fre>quente nei primi due giorni della scarlattina. Egli opma che nei casi dubbi la sua presenza debba decidere in favore del morbillo, poichè essa non é stato mtti notato al di la del terzo giorno nella scarlattina. Quanto alla febbre tifo1dea, egl1 stima che la r eazione può menar·e alla diagnosi di casi nei quali i sintomi non sono ben chiari. S e, .in un caso dubbio, essa non si ba alla fine della prima o tutt'al più al pri nciiJiO della seconda settimana, o probabilmente non di tiCo oppure è un tifo molto Jeggiero. Durante questa malattia la reazione persiste finchè la temperatura è elevata. In caso di cronica infiamma. zione polmonare, nascendo il dubbio della tubercolosi, la reazion e milita iu favore di questa e quanto più essa è persistente tanto più acuto ed esteso è il processo tubercolare. Molto valore le attribuisce anche il Nissen per la diagnosi della meningite. Se la diagnosi non è sicura tra la meningite e la febbre tifoidea, la reazion e deve far decide re per quest'ultima. Se il tifo devesi assolutamente escludere, allora si deve ammettere una meningite tubeecolare e la prCIgnol:;i è cattiva. La mancanza della reazione in una malattia che ha tutto. l'andamento della meningite non deve rar escludere alcune forme anomale di questa: ad ogni modo essa forma un .elemento di favorevole prognosi.
G. G.
Hivista Ch Ihuhgica
Elettrolisi del oalooll udnari. - M. YvoN. (Progres Médical, N. 24 del 18!H).
L"autore riuscì a completare una esperienza, già da lui ideata dieci anni or sono, e che permette d1 disciogliere un calcolo urinario mediante la co r rente elettr·ica. Se mediante elettrodi in platino si fa passare una corr ente voltaica in una soluzione aquosa di solfato di soda si sviluppa, al polo positioo, acido ed ossigeno e, al polo negatioo del sodio che per azione secondaria gener a soda caustica ed idrogeno.
Su una placca di rame in rapporto col polo positivo di una batteria Trouvè di 6 elementi al bicromato, l'Yvon pose una capsula di contenente un piccolo Cttlcolo di acido Ul'ico immerso in soluzione aquosa satura di solfato di soda: su questo calcolo poggiava il filo di platino che agisce da elettrode negativo. La resistenza <:Iella soluzione è grande, la distanza fra gli slettr"Odi é la massima sul principio, per cui la corrente passa con difficolta: ma appena la superficie del calcolo comincia ad intaccarsi l'azione si fa più rapida, il filo di platino, su cui deve esercitarsi una pressione leggie1·a ma coclinua, si affonda, ed in un'ora o due, secon?o il volume del calcolo, questo è r·idotto alla sempltce coccta, e quasi interamente disciolto: lo stesso si ottiene sui calcoli di fosfato semplice o lerroso, solo mverlendo la sede dei poli perché la venga disciolta dall'acido solforico nascente.
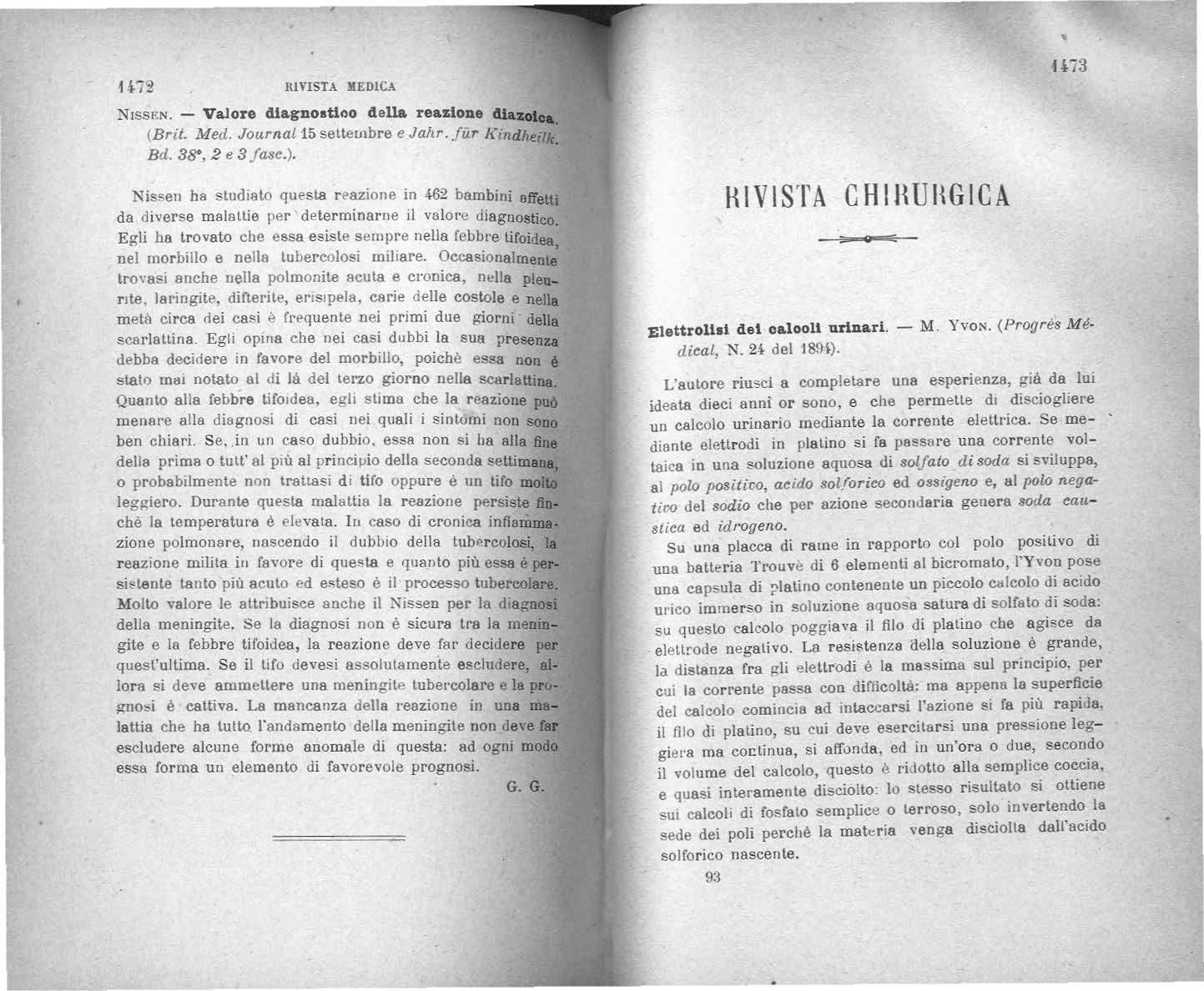
riconosce gli ostacoli che si presentano, (irrita. zione della vescica pel calore sviluppato, e pei caustici prodotti dall'azione elettrolitiC8) ma nutra la speranza <!he il metodo possa riuscirsi a d applicare anche all'uomo . Mediante una specie di litotritore appositamente da lui costruito l'esperienza fu ripetuta in 1·ecipiente di vetro chiuso, e riuscì completa, sebbene più lentamente. Egli lascia ad altri la cura di applicare, se possibile, l'elettrolisi al trattamento della pietra; avendo solo voluto dimostrare col suo la possibilità <li sciogliere con essa i calcoli urinari .
CHIRURGICA u.75
sintomi differiscono secondo che si tratta degli uni o degl i altri. . . .
GU asoeast del setto delle fosse nasall. . - A. MoaAN. (Journal de Médecine et de ·chi r urgie, luglio 189}).
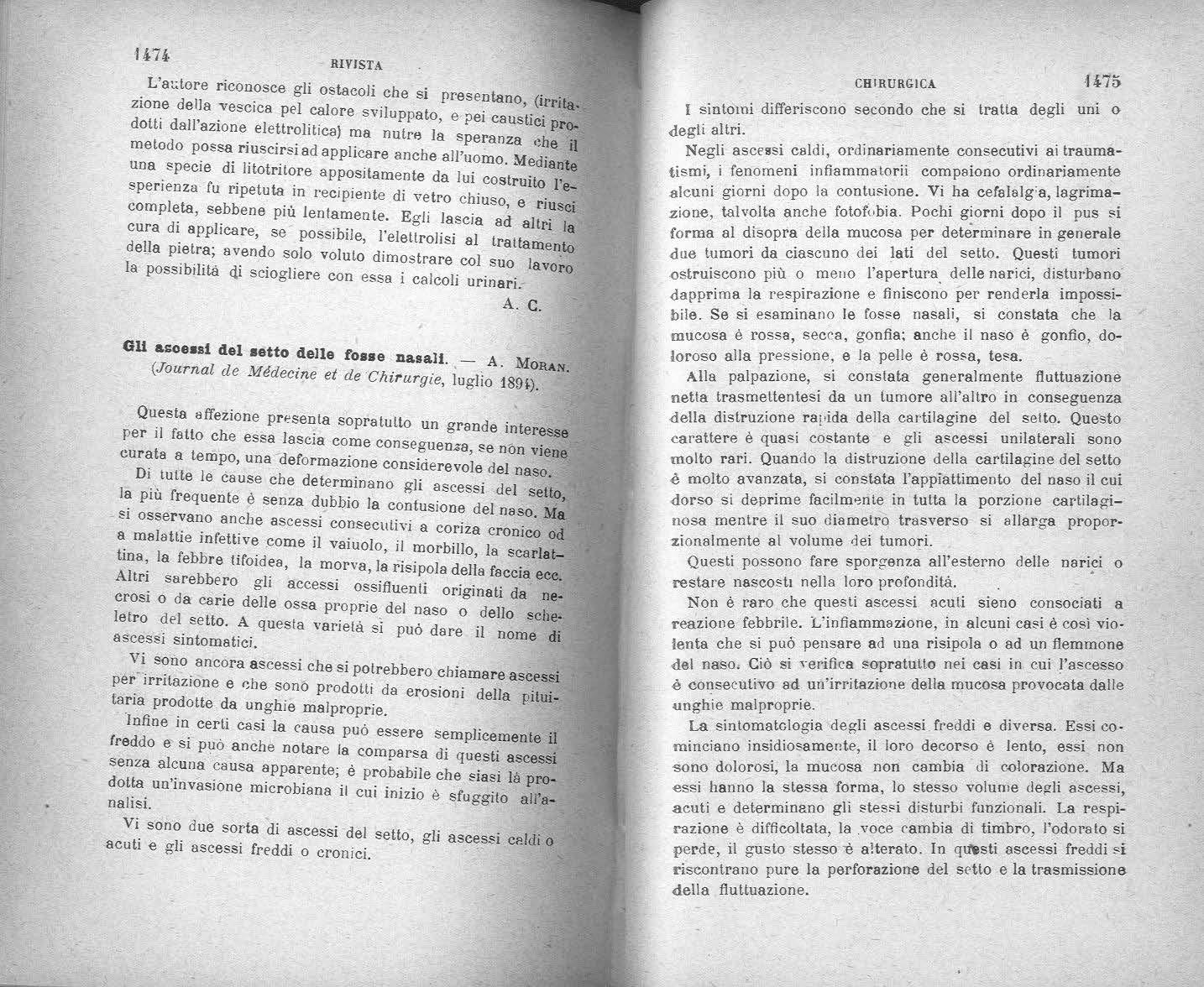
Questa affezione sopratutto un grande interesse per il fatto che essa lascia come conseguenza, se n6n viene curata a tempo, una deformazione consiàerevole del naso. Di tutte le cause che determinano gli ascessi ùel setto la più frequente è senza dubbio la contusione del naso. - si osservano anche ascessi consecutivi a coriza cronico od a malattie infettive come il vaiuolo, il morbillo, la scarlattina, la febbre tifoidea, la morva, la risipola della faccia ecc. Altri sarebbero gli accessi ossifluenli originati da neerosi o da carie delle ossa proprie del naso o dello sche· letro del setto. A questa ''arietà si può dare il nom e di ascessi sintomatici.
Vi S<>no ancora a scessi che si potrebbero chiamare ascessi per· irritazione e 0he sono prodoiti da erosioni della pituitaria prodotte da unghie malproprie.
'Infine in certi casi la causa può essepe semplicem ente il freddo e si può anche notare la c.omparsa di questi ascessi senza alcuna causa apparente; è probabile che la prodotta uo'invasiòne microbiana il cui inizio è sfuggito all'analisi.
Vi sono due sorta di ascessi del setto, gli ascessi cP.Idi o acuti e gli ascessi freddi o cronici.
Negli ascessi caldi, ordinariamente ai - · · '"enomeni infiammalorii compaiono ordwarJamente t tSIDJ, l l< • l · lcuni giorni dopo la contu>':ione. Vi ha cefalalg·a,. .a. e tal volta anche fotofobia. Pochi giorni dopo 11 pus ZIOO , · • · • l f l disopra della mucosa per determmare m genera e o rma a . . due tumori da ciascuno dei lati del setto. tumori .ostruiscono più o meno l'apertura. delle nartcl, d pprima la l'espirazione e finiscono per renderla lmposstSe si esaminano le fosse nasali,. si che la mucosa è rossa, secca, gonfia; anche ti naso e gonfio, doloroso alla pressione, e la pelle è rossa, tesa. .
Alla palpazione, si constata fluttuaziOne etta trasrneltentesi da un tumore ali altr o m conseguenza ; ella distruzione rapida della cartilagine del .setto. c arattere è quasi costante e gli ascessi sono molto rari. Quando la distruzione della carhlagme del è molto avanzata, si constata l'appiattimento . del naso.•l dorso si deprime in tutta la p?rzwne cartllagtnosa mentre il suo diametro trasverso s1 allarga proporzio nalmente al volume dei tumo!'i.
Questi possono fare sporgenza all'esterno delle na rici o restare nascost1 nella loro profondità. . . . .
Non è raro che questi ascessi acult sren? a · febbr1·le L'infiammazlone, i.n alcum è cosi VIO· reaz•one · l ta che si può pensare a d una risipola o ad un flemmone naso. Ciò si '"eritìca sopratutto nei casi in cui fasces s o è ad un'irritazione della mucosa provoC8ta dalle unghie malp r oprie. . . .
La sintomatologia degli ascessi freddt e dtversa. cominciano insidiosamente, il loro decorso è lento, _essi non d loros i la mucosa non cambia di c.olorazione. Ma sono o , r · essi hanno la stessa forma, lo stesso t . e determinano gli stes;<i disturbi funzwnalt. La respiacu J . • b l' d to si razione è difficoltata, la .voce ca mbia dt tlm r o, ora . d ·1 crusto stesso "è alterato. In qJ.Nsti ascesst freddi s t per e, 1 "' riscontrano pure la perforazione del setto e la trasmiSSione della fluttuazione.
Ad ogni modo, sieno acuti o cl'onici quec::ti asces · h • ' SI ann la stessa sede che e la parte anteriore ed inferiore d 1 ° . e setto c1ò che é dovuto senza dubbio alla lieve aderenza d 11 . ' l l e a Pl· UI1.<1r1a m que punto, eJ al fatto che io quella po · .. . rz1one é om esposta del r1manente ali e contusioni ed irr·•- · . . esterne, e ne risulta frequentissimamente non solo 1 1i • a per. orazione, ma anche la distruzione del setto c1·6 eh . ' e pro- duce la deformaz1one consecutiva.
E quindi mollo importante di farne presto la diag · d. . h . DOSI, _1agnos• c e è. sovent• mollo delicata, perchè questi ascessi Si possono confondere coi polipi, una pericondrite v a, un tumore ImfatlCO od un ematoma. Non si deve dim enticare che si un eccellente mezzo di diagnosi nella puntura esploratrice con un trequarti fino o con la siringa di Pravaz. la presenza del pus é constatala fa d'uopo e\acuarlo: m generale, l'incisione unilaterale può essere da recidiva (salvo nei casi rari di ascesso parimenti umlaterale), !llentre che l'incisione bilaterale è segui•A ' ...., soprattullo. quando é precoce, da guarigione rapida e radicald.
Tuttav1a quando comunicazione fra i tumori é larga, e per consegueuza il pus dell'uno può evacuarsi mente per l'apertura fatta all'altr•o, l'incisione unilaterale é suf'iciente per portare la guarigione.
Si faranno pure lavature ed iniezioni con insuffiazioni di iodoformio , di resorcina ecc; e nei casi di ascesso freddo si curerà pure lo stato generale del malato.
I. HABAIIT - n piccolo oallbro ed u trattamento d ell e ferite per armi d& tuooo sul campo dl battaglia. - (Das A"leinealiòer und die Behandlung der Schusswunden im Felde. - Wien 1894).
Di questo lavoro, presentato alla XlV sezione dell' Xl congresso medico interqazionale in risposta ad uno dei tedati dal comitato ordinatore, furono già pubblicate le conclusioni nel nostro gio l'nal e (1).
Nondimeno per l'importanza della pubblicazione del p:or. Habart nella quale sono contenute idee e proposte mertte- ' . voli di essere prese in serio esame da chiunque SI occupa di chirurgia di guerra, reputiamo opportuno farne un bl'eve sunto riporlandone integralmente le conclusioni.
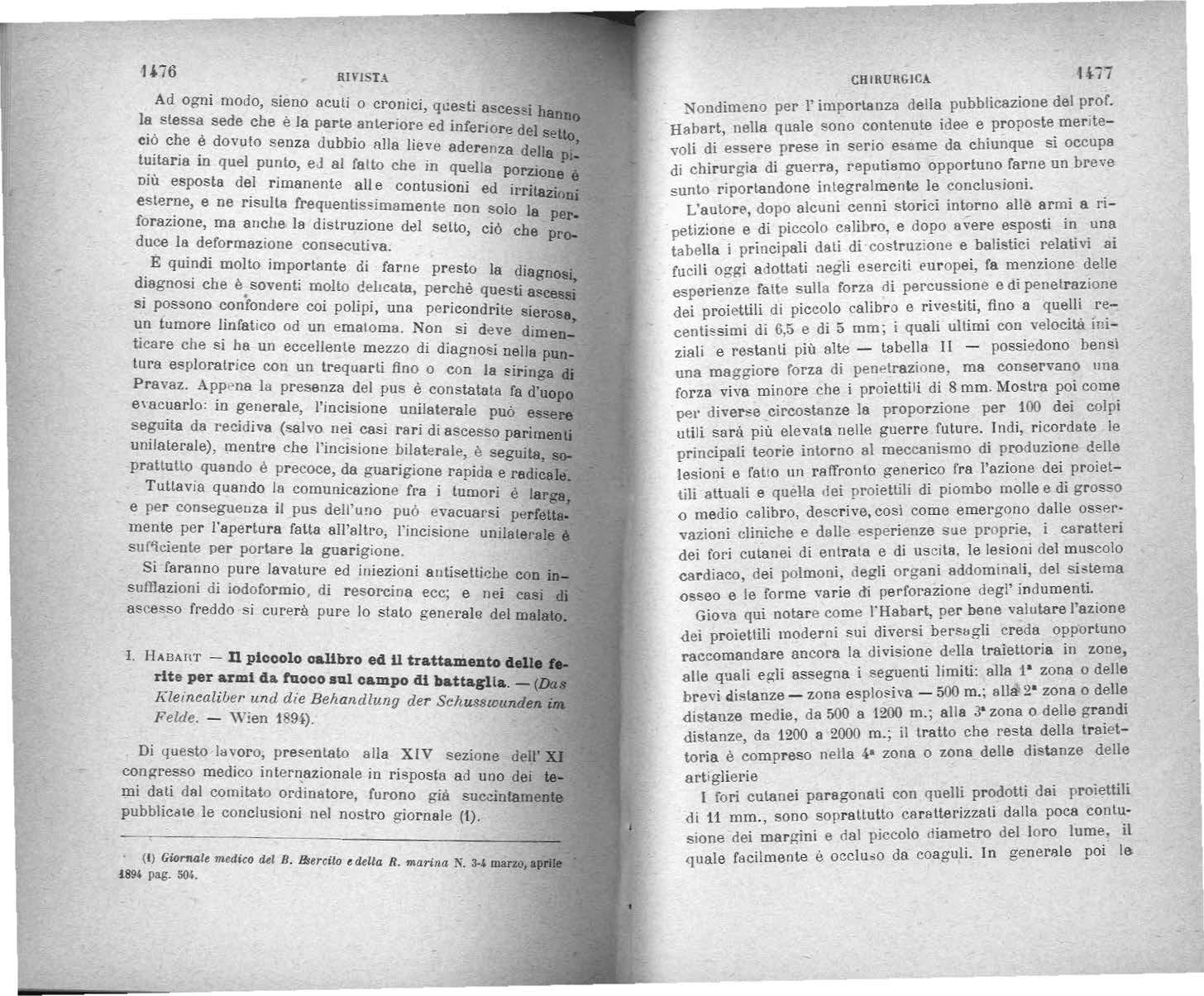
L'autore, dopo alcuni cenni storici intorno alle armi a ripetizione e di piccolo calibro, e a vere. tabella i principali dali di costruztone e bahstlct relat1vt a1 fucil i O"'gi adottati negli eserciti europei, fa menzione delle fatte sulla forza iii percussione e di dei proiettili di piccolo calibro e rivestiti, fino a cenlissimi di 6,5 e di 5 m m; i quali ultimi con velocità Iniziali e restanti più alte - tabella Il - possiedono bensì una maggiore forza di penetrazione, ma una forza viva minore che i proiettili di 8 mm. Mostra pot come pe1• diverse circostanze la proporzione per dei colpi utili sarà più elevata nelle guerre future. Indi, rteordate le principali teorie intorno al meccanismo di lesioni e fatto un raffronto generico fra l'azwne de1 prOiettili attuali e quella dei proiettili di piombo molle e di grosso 0 medio calibro, descrive, così co me emergono dalle osser·· vazioni cliniche e dalle esperienze sue proprie, i caratteri dei fori cutanei di entrata e di uscita, le lesioni del muscolo cardiaco, dei polmoni, degli organi addominali, del si:>_lema osseo e le forme varie di perforazione degl' indumentl. Giova qui notare come l'Habart, per bene valutare l'azione dei proiettili moderni sui diversi bersagli raccomandare ancora la divisione della tra.JeLtoria m zone, alle quali egli assegna i seguenti limiti: alla t• zona o delle brevi distanze - zona \'8. - 500 m.; allà 2• zona o delle distanze medie, da 500 a 1200 m.; alla J• zona o delle distanze da 1200 a 2000 m.; il tratto che resta della tr aiettoria è nella 4• zona o zona delle distanze delle artiglierie . . .. l fori cutanei paragonati con quelli prodotti dat proietbh di 11 mm., sono sop rattutto ca r atterizzali dalla poca sione clei margini e dal piccolo diametro del loro lume, Il quale facilmente è occlu,;o da coaguli. In generale poi dimensioni di questi fori non permettono alcun r e tto l appl"eJ,. zamento c1r.;a a quahtà e gravezza della lesione fonda. PI':O-
Contrariamente a quanto si era creduto sino a poco te fa, cioè che i canali ciechi siano in avvenire da f l . . di . ' l' an. ra e pm gran rarita, autore deduce da moHeplici 0 · · d . s s er- vaztooi e esperienze come, oltreché nei colpi lon tani · ltT t 1· ' 1
1e 1 1 a tua 1, potendo attraversare più individui dello stes come p. es. nei tiri contro grandi masse di ca vaS::. ler1a, rimangono non infrequ entemente nel corpo. P arimente possono pet'venire con facilità nel canale della fe r ita pe · d" ZZI
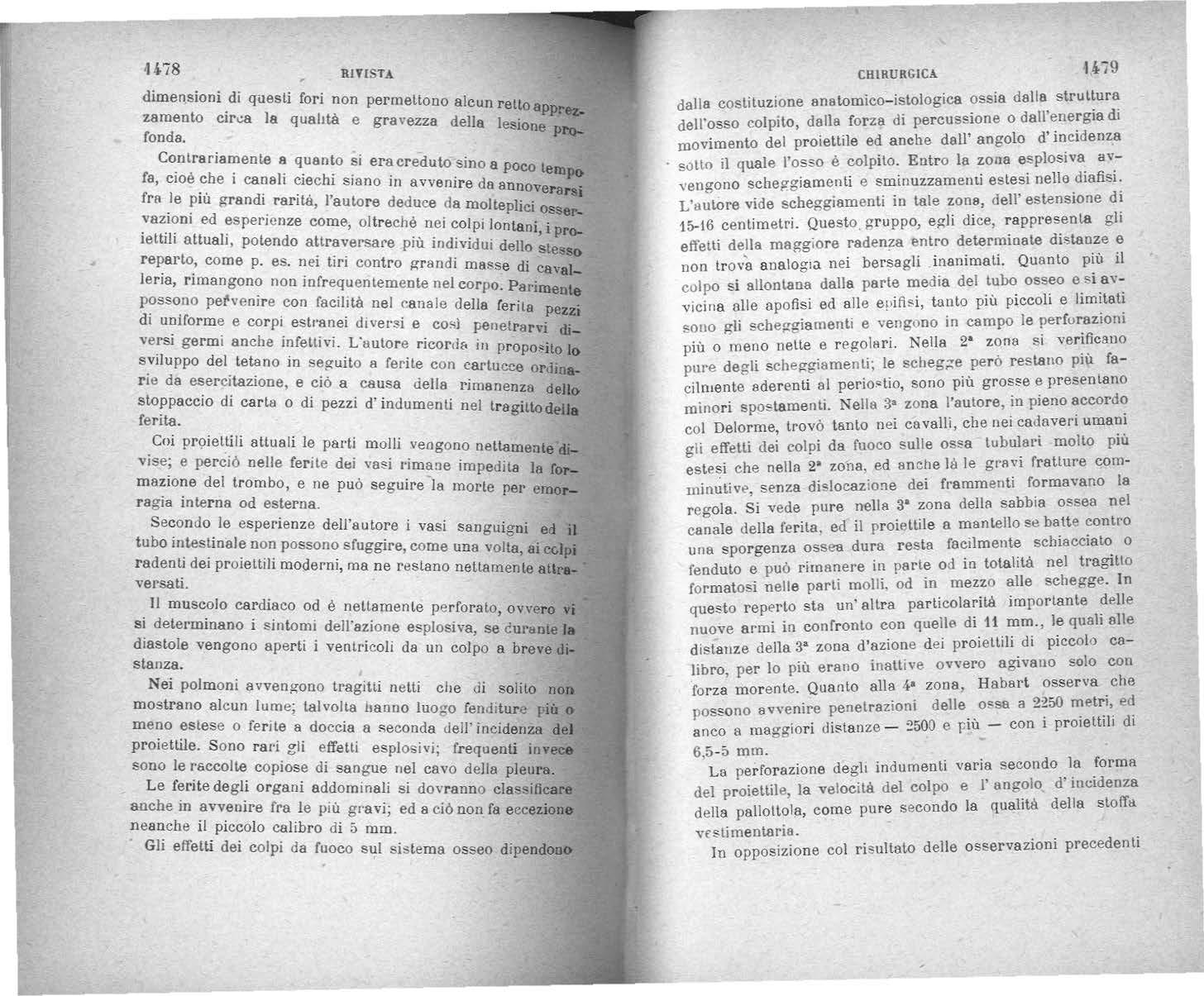
1 e corpi estl'anei dive1·si e così penetrarvi dive:sJ germt anche infettivi. L'autore ricord& in lo del tetano in seftuito a ferile con cartucce or dinarie da esercitazione, e ciò a causa della rimanenzu dell di ca rta o di pezzi d'indumenti nel tr agitto ferita.
Coi pr<;>ieltili attuali le par·ti molli vengono nettamen te divise; e perciò nelle ferite vasi l'imane impedita la formaz ione del trombo, e ne può seguire la morte pe 1• e morr agia inter na od esterna.
Secondo le esperienz e dell'autore i vasi sangui a oi ed il tubo intestinale non possono sfuggire, come una ai e<.lpi r adenti dei proiettili moderni, ma n e restano nettamente aUraversati.
Il muscolo cardiaco od é nettamente perforato, o v vero vi si determinano i sintomi dell'azione esplosiva, se èurlj nte Ja diastole vengono aperti i ventricoli da un colpo a bre ve distanza.
Nei polmoni avvengono t1·agitti nelli che òi s olilo non mostrano al c un lume; talvolta banno luogo fenditur e o meno estese o ferile a doccia a seconda dell'incidenza del proiettile. S ono ra1·i gli effetti esplosivi; frequen ti i nvece sono le raccolte copiose di sangue nel cavo della pleu ra.
L e fe ri te degli organi addominali si dovranno c lassi ficare anche in avvenire fra le più g1·avi; ed a ciò non fa e ccezione neanche il piccolo calibro di 5 rom.
Gli effetti dei colpi da fuoco sul sistema o s seo dipendono
CHIRURGICA. 14i9
dalla costituzione anatomico- istologica ossia dalla. dell'osso colpito, dalla forza di percussione o dall energ1a d1 movimento del proiettile ed anche dall' angolo d'incidenza sotto il quale l'osso é colpito. Entro la zona av_venooono schejlgiam en li e sminuzzamenti estesi nelle dtafisJ. vide scheggiamenti in tale zona, dell'estensione di 15-16 centimetri. Questo . gruppo, egli dice, rappresenta gli eft'etli della maggiore raden?a entro determinale distanze e non trovà a nalogta nei bersagli .inanimati. Quanto più il colpo si allontana dalla parte media del tubo e_si a '": vicina alle apofisi ed all e epifi s i, tanto più piccoh e sono gli e vengono in campo le più o meno nette e regolari. Nella 2• SI pure degli le scheg;e pero restano PJU faciln1ente aderenti al perio,.tio, sono più grosse e presentano minori spostamenli. Nella 3• zona l'autore, in pieno col Delorme, trovò tanto nei cavalli, che nei gli effetti dei colpi da fuoco sulle ossa mollo p1u estesi che nella 2• zona, ed anche là le gr11v1 fratture comsenza dislocazion e dei framm en ti formavano la regola. Si vede pure nella s• zona deliA sabbia ossea nel canale della ferita, ed il proiettile a mantello batte contr·o una sporgenza ossea dura resta facilmente o fenduto e può rimanere in parte od io totalità nel tragitto formatosi nelle parti m olli, od in mezzo alle schegge . In questo reperto sta un' allra particolarità importante nuove armi in confronto con quella di 11 mm., le quali alle distanze della 3a zona d'azione d ei proiettili di piccolo calibro, per lo più erano inattive ovvero agivano solo con forza mor ente. Quanto alla 4• zona, Habart osserva che possono 8 v'\"enire penelrazioni delle ossa a anco a maggiori dista nze - ::!500 e più - con 1 pr Oiettili d t 6,5 - 5 mm.
La pe r fo r azione degli indumenti varia secondo .l.a _forma del proiettile, la velocità del colpo e l'angolo d· mc1denza della pallottola, come pure secondo la qualità della s toffa vrslimentaria. .
In opposizione col ris ultato delle osserva zioni precedenll
CHIRUl\GICA u.st
intorno alla penetrazione dei corpi estranei nei ca 1- d Il . . na 1 stretti e e ferite da arm1 da fuoco mod e rne, l'autore · b Il . gmnse 111 ase a e propr1e espe rienze, alla conclusione eh "L t d" l" e un trag_I .o l ta ferit e affatto l! costituisce una grande rarità e c h e m batte riOlogico ferite veramente n Lt . l . 'fì e e •n genera e non st veri caoo, sempre quando sono colp 't · t''l · 1 e dal pro•e •• e part1 del corpo coperte dall'uniforme.
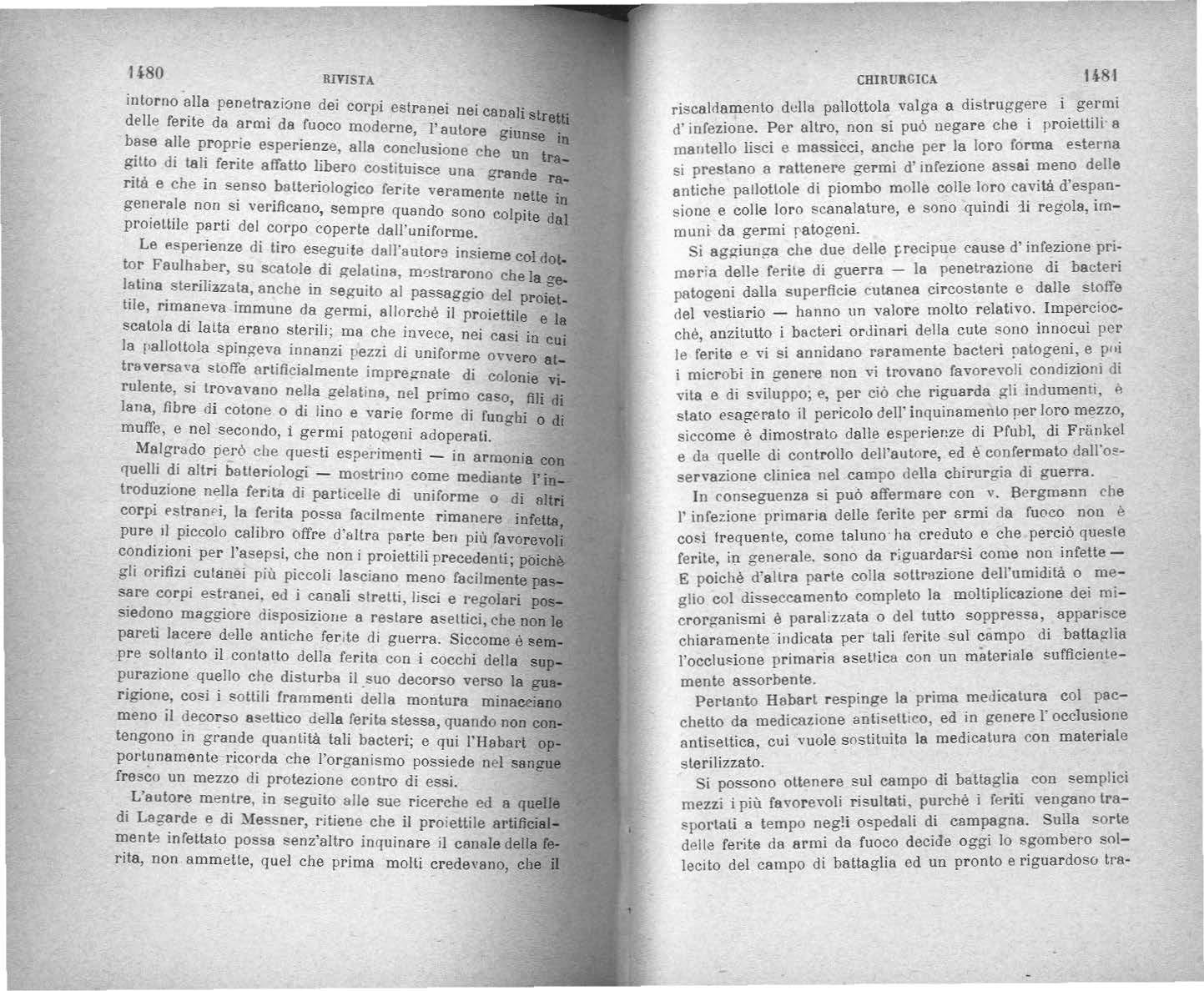
Le esperienze d i tiro esegu ite d all'a utor9 insieme col d tor Faulhaber, su s catole di gela tina m " slrarono eh 1 ot- 1. .. •- ea:zeatma s tertllazata, anche in seguito a l passag"'io del r1 · · o proJetI e, Immune da germi, all orché il proiettile e la scatola dt latta erano sterili· ma che invece ne1 · ca · · . • . ' ' SI IO CUI la pallottola spmgeva Innanzi pe z zi d i uni'orme 0 , 1 ·vero attraversava stoffe a rtific ialmente im pre"'nate d1 · col · . ,... onte VIrulente, SI nella gelatina, nel primo caso, fili di lana, fibre d1 coton e o di lino e varie forme di funghi 0 di muffe, e nel secondo, i germi patogeni adoperati.
Malgrado però c he que!:'ti espe t' imenli - in armonia Il . d. l . con que 1 . 1 a trt batteri ologi - m ostri no come mediante l'introduzione ne!Ja fe rita di parti celle di uniforme 0 di lt · . . a n corpi t>slran PI, la ferita possa fa c ilmente rimanere infetta pure 11 piccolo calibro offre d'altra parte ben più favo revoll per l'asepsi, che non i proiettili precedenti; p<>ich& gh or•tìz1 cutanei più piccoli lasciano meno facilmente pascorpi est:anei, ed i canali stretti, lisci e regolari posmaggiore disposizione a restare asettici, che non le pareti lacere delle antiche fer ite di guerra. Siccome è sempre il contatto della ferita con i cocchi dell a suppurazlone quello che disturba il suo decorso verso la guarigione, cosi i s o ttili frammenti della montura minacciano meno il decorso ase ttico della ferita stessa, quando non contengono in grande quantità tali bacteri; e qui I'Habart opricorda che l'organismo possiede nel sangue fresco un mezzo di protezione c ontro di essi.
L'autore mentre, in s eguito alle sue ricerche ed a quelle di Lagarde e di 1fessoer, ritiene che il proiettile artilìcialinfettato possa senz'altro inquinare il canale della ferita, non ammette, quel che prima molli credevano, che il ris caldamento della pallottola valga a distruggere i germi d'infezione. Per altro, non si può negare che i proiettili a m antello lisci e massicci, anche pe r la loro forma estema si prestano a rattenere germi d'infezione assai meno delle antiche pallottole di piombo mo lle colle loro cavità d'espans ione e colle loro scanalature, e sono quindi :ii regola, imm uni da germi patogeoi.
Si aggiunga che due delle cause d'infezione primaria delle fe ri te di guerra - la penetrazione di bacteri patogeoi dalla supe rficie cutanea circostante_ e dalle stoffe del vestiario - hanno un valore molto relat1vo. Imperctocchè anzitutto i ba cteri ordinari della cute sono innocui per ' . le ferite e vi si annidano raramente bacteri patogem, e pot i microbi in genere non vi trovano favorevoli condizioni di vita e di sviluppo; e, per ciò che riguarda gli indumenti, i>: stato esagerato il pericolo dell'inquinamento per loro mezzo, siccome è dimostrato dalle esperier.ze di Pfubl, di Friinkel e da quelle di controllo dell'autore, ed è confermato servazione cliniea nel campo della chirurgia di guerra.
In conseguenza si può affermare con ,. . 1;3c rgmann che l' infezione primaria delle ferile per srmi da fuoco non è così frequente, come taluno· ha creduto e che perciò queste ferite in O'enerale. sono da r;guardarsi come non infetteE poiché :l'altra parte colla sottrazione dell'umidità o meglio col disseccamento completo la molliplicazione dei cror()"anismi è o del tutto soppressa, appar1sce chia;amente ·indicata per tali ferite sul campo di battaglia l'occlusione primaria asetlica con un màteriale sufficientt>mente assorbente.
Pertanto Habart respinge la prima medicatura col pacchetto da medicazione antisettiCO, ed in genere r occlusione antisettica, cui vuole sostituita la medicalura con materiale sterilizzato.
Si possono ottenere sul campo di battaglia con semplici mezzi i più favorevoli risultati, purché i ferili vengano trasportati a tempo negli ospedali di campagna. Sulla sorte d e lle ferita da armi da fuoco decide oggi lo sgombero sollecito del campo di battaglia ed un pronto e riguardosv tra-
4482 Rivista
:;;porto dei ferili negli ospedali di campagna provvisti di tutti i mezzi moderni per l'asepsi e per l'antisepsi. Epperò lo studio di ogni amministrazione sanitaria militare deve mil'are a ch e questo tra:;;porto indie tro sia reso taci! e e spedito mediante un p e rsonale q"alìtativamente e quantitativamente a deguato al bic;ogoo, mediante mezzi di trasporto di ogni specie, aume ntati secondo i l tempo; e rnèdiante l'installazione di ospedali da campo in 1" linea, secondo la fo rza ossia secondo il numero presumibile di fe riti.
Negli ospedali di campagna l'opera c hirur·gica assume la più g1·ande importanza. Quivi richiedono uil intervento operativo senza indugio tutte le ferite penetranti del ventre con emorragia minaccia nte la vita e con apertura ovvero prolas:;oo di anse intestinali; le lesioni del cranio con partecipazione del cervello ed emorragia intracranica; fa parziale o totale divisione di vasi o di nervi con grave pericolo di emol'ra)!ia o con sintomi di paralisi; infine tutte le lPsioni in cui si prese ntino/ segni di soffocazione imminente o di minacciante sepsi.
Dopo ciò l'autore viene alle seguenti conclusioni.
1° Le ferite cagionate dalle nuove armi da fuoco portatili presentano di regola piccoli oritìci e canali lisci; perciò si a vvici nano alle lesioni sottocutanee e si possono considerare nella maggior parte dei <'asi come asettiche al mom e nto di loro produzioni:'. Quindi in campagna si deve anzitutto procurare la loro guarigione sotto una CJ'osta a· selli.ca.
2o È . dubbiO se sotto l'azione delle armi a ripetizione si possa la prima medicatura sul C<tmpo di battaglia; perciò conviene a doperare la più grande cura durante le sospensioni del fuoco a mettere in salvo ed a trasportare rapidamente i feriti ai posti di medicazione (alle ambulanze), ove saranno provvisoriamente medicati da mani e!<perte. L'applicazione di medicature non sarà permessa al personale ausìliario che in casi eccezionali ed urgenti: emorragie, procidenza dell'intestino, fratture, -per r·endere possibile il trasporto. A questo personale dev'essere insegnato che è pe-
CHIRURGICA •J483
ricoloso toccare le ferite colle mani non pulite e ricoprirle con oggetti di medicatura sudici.
3° Poiché un gran numero di ferite da armi da fuoco sono asettiche e restano tali durante tutto il loro decorso, la medicatura occlusiva sterilizzata è qui bene a posto. Per poter poi provvedere alle grandi masse di feriti si racco• mandano dei modelli di medicalu.ro già preparati, di 'differenti di mensioni, analoghi ai campioni pre.sentati nel 1890 da v. Bergrnann al X Congresso medico internazionalE'. Essi si sterilizzano con facilità e sicurezza e contengono il necessario per nna medicatura inJividuale. Tenuti in istato di moderata compressione, occupano poco volume e possono essere trasportati in gran numero dai portaferit.i, $;ulle ba· relle, nel!e vellure dei oorpi, ed in quelle delle ambulanze divisionali - sezioni di sanità - sono inoltre semplici, solidi, di poco peso, poco costosi sterilizza bili, a più riprese, senza danno; forniscono dei pezzi di tarlatana che oltre a poter esser advpe1·ati in una medicazione protettrice o compressiva. sono utilizzabili per la fognatura in seguito alle operazioni come éompresse per garentire il campo operativo ed anche come tamponi. Sono inodori, non irritano la ferita, non provocano secrezioni esagerate e non disturbano il pro· cesso di riparazione; possono essere introdotti nelle cavilà del corpo senza pel'icolo di intossicazione. Sono pure adatti a formare pacchP-tti da medicazione.
4o Oggi le rnedicature composte di tarlatana con o senza l'aggiunta di di legno del Bruns -e di fasce di tarlatana o di mussola, r.orrispondono benissirno alle esigenze dell'asepsi, perché offrono il materiale piu assorbente, che senza difficoltà si sterilizza e si conserva immune da germi nel cartone, in scatole di latta, ovvero pe1' le ferite estese e gravi (del torace, del ventre, delle ossa) in convenienti involucri metallici; e cosi possono esserò anche impaccate in grandi' quantità nei depositi degli ospedali di campagna. Per la loro semplicità ed l!niformità. sono benissimo adatte per una medicazione di campagna, internazionale.
Questa di medicalura può essere preparata con i
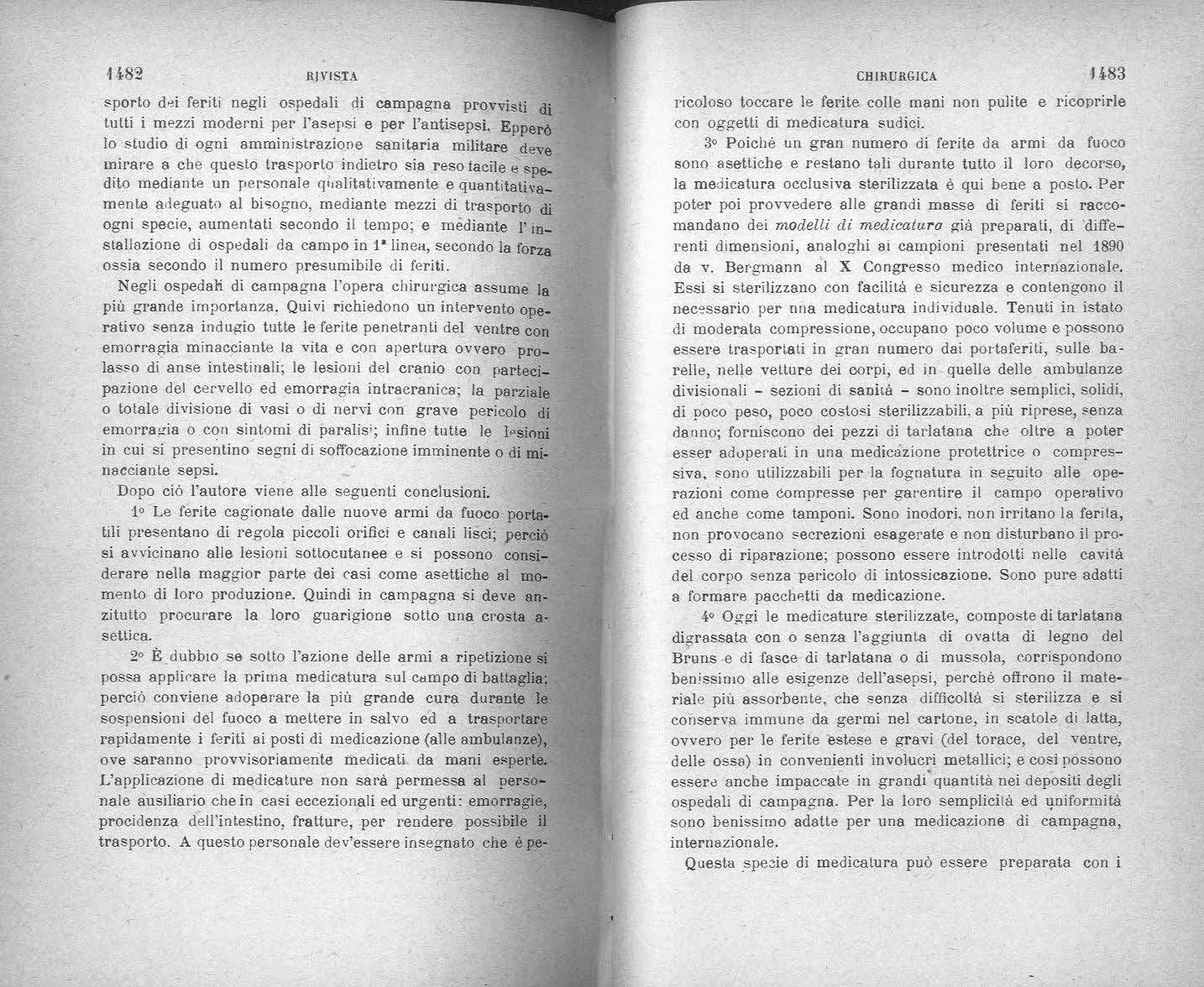
H84- RIVISTA
mezzi più semplici in ogni tempo e luogo, malgrado le necessità della j:tuerra, pur rappresentando una medicatura di fatta a regola d'arte.
5° Poichè il materiale preparato per l'antisepsi primaria sul campo di battaglia, al momento del bisogno non possiede più che un'azione bactericida problematica o nulla ed ba perduto anche nella pratica di pace la fiducia che aveva inspirata , sono sufficienti le unità di medicazione sterilizzate nelle formazioni. sanitarie riù avtinzate, anche per le fe r ite sudicie e sospettE', la cui disinfezione ai luoghi di cura situati più indietro - sezioni di sanità ecc - non pr esenta alcuna diflìcolta; :riacchè tanto nei reparti di medicazione quanto in quelli di operazioni, oltre il sapone e le spazzole, non manca una pentola per la sterilizzazione degli istrumenti ed un recipiente colla soluzione di sublimato per disinfettare 'le mani degli operatori ed il campo d'operazione. In questi casi si può anche cospargere la ferita di polvere di iodoformio, che è una sostanza antisettica adottata ormai in lutti gli eserciti.
6° T ranne per le emorragie e l'asfissia minacciose, non vi hanno allre indicazioni operative ai posti di medicazione ed alle ambulanze. Invece si dovrà ivi concentrare l'attenzione sulla cerna dei feriti, l'applicazione di medicature provvisor-ie, l'immobilizza"lione delle fratture ed i soccorsi da dare ai feriti gravi; cos1 si favorisce l'asepsi 111!eriore delle ferite e si prPdispone bene il lavor o dell"os pedal e di campagna. Un clinico esercitato può in queste formazioni sanitarie, se il numero dei feriti che vi affluiscono è piccolo e le alt.re condizioni sono propizie, procedere eccezionalme nte anche alla laparotomia.
7° Per il sollecito ricovero ed il trattamento efficace dei feriti, gli ospeòali di campagna devono essere sempre in contatto colle ambulanze per sostituirsi ad esse all'occorrenza, od accogliere e curare i feriti prov enie nti direttamente dal campo di battaglia. È necessario che queste mobili formazio ni di 1' linea si3oo dotate di tende per fe r iti e d1 baracche che sermono le truppe combattenti, massime in quelle regioni che non offrono a ffatto o
Chirurgica 1485
soltanto manchevoli risorse. Quì sta il più proficuo campo di atlivita per le società di soccorso, di cui oggi npssun esercito in campagna potr ebbe far senza.
s• Negli ospedali di campagna può essere praticata l'antisepsi nel senso clinico. Dovranno quindi essere adoperate le debite cure per l'attuazione di essa, come per lo sgombero dei ferili, affinché questi raggiungano l'ospedale abbastanza in tempo pet• potersi in molti casi continuare con successo il trattamento asettico, ovvero secondo le condizioni della ferita rendere più completa ed avvalorare l'asepsi con mezzi antisettici od {!<.!dirittura soslitui r vi l'ao tise!Jsi. Questa pratica combinata presterà notevoli servigi negli stabilimenti sanitari di 2• linea, come pure in quelli della base delle operazioni e dell'interno del paese. Essa rich iede rinvio di apparecchi di sterilizzazione agli ospedali di ca mpa gna ed alle grandi formazioni sanitat·ie de l raggio ùi ripartizione dei malati.
9° Negli ospedali di campagna sotto la protezione dell'asepsi e dell'antis.epsi e con una r igoro sa osservanza norme igieniche di guerra, sara esercitata in larga estensione la chirurgia conservativa. Nei colpi da fuoco del ventre, nelle lesion i della testa con sintomi di compressione è imposto urgentemente l'intervento attivo. La presenza di corpi estranei in grembo alls ferite per armi da fuoco non esercita sempr e e costantemente un'influenza noch·a, ed airiosorgeoza la raiva di CC'mplicazioni si può ovviare coll'antisepsi. I modelli preparati di asettica in combinazione coll'ovatta di legno o la polvere di torba come medicatura durevole, e col concorso di farmaci tratti dal gruppo degli antisettici, possono in ogni caso offrire la ptù s icura garanzia per il conseguimento di fav orevoli risultati nella cura delle feri te e nelle operazioni chirurgiche.
100 I fucili a lunga gittata nelle mani di mi lioni di uomirÌi motiveranno sostanziali modificazioni così nel campo della lattica come in quello del soccorso e del trattamento dei fe riti in guerra. Pt>r poter soccorrere a tempo le villime delle battaglie è in dispensabile una direzione autonoma de l servizio sanitario in guerra, alla quale fosse subordinato
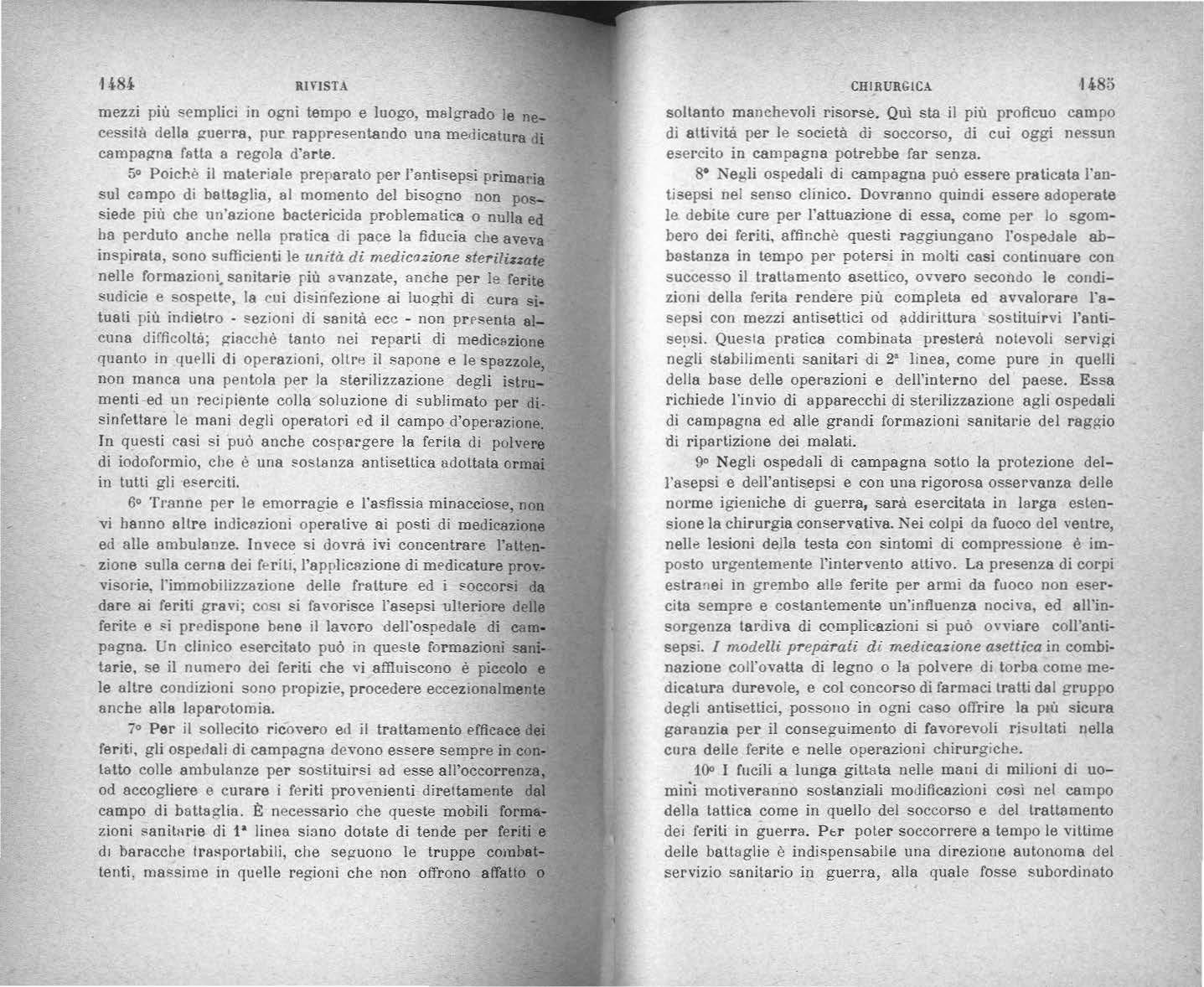
li86 !li VISTA
tanto il socrorso ufficiale, che il volontario. La revtstone della convenzione d1 Ginevra nel senso di Birr.her; l'illuminamento del campo di battaglia secondo Mur.dy, e la cremazione dei morti sul campo secondo le basi stabilite dal Virchow per le epidemie, sono problemi che meritano la pi ù accurata disamina.

P. IMBRIACO.
La Chirurgi& eli guerra. in rapporto al nuovi prole«Ul cll plooolo callbro. - Dott. LU •GI FF RRERO m CA VALLERLEONE, maggiore medico.
Fra i saggi di chiru r gia pubblicati per le onoranze al pr of. Lorenzo Bruno nel suo giubileo di lau rea fu compreso • anche questo pregievole lavoro del maggiore medico Ferrero di Cavall .. rleone, il quale ila voluto molto opportunamente dimostrare in ta l modo la stima e l'affetto che conserva pel suo illustr·e maestro.
Prem esse alcune noziont rli balistica, tralLa dettag-liatamente degli effetti dei proi,.ttili sui varii tessuti ed organi. P e r quello che t'i)::'uarda l'a dozione dei fucili a piccolo calibt•o ed a ripetizione l'A. ritiene che avremo:
1° celerità di tiro più che raddoppiata;
2o traiettoria più tesa e perciò più estesa la zona battuta;
3• tiro efficace a distanza molto maggiore potendo riuscire mortali anche i colpi oltre i :2500 metri;
4• di rnc'l!lgior dotazione ai soldati di proiettil i per il loro minor peso, e quindi aumentato di molto il numero dei colpi in una giornata campale;
5• IPsioni gravi, specialmente delle ossa, assai più numero;<e anche a di--lanzE>;
Go più e più imponenti o meno frenabili.
L'autore c d"Avvi"O che il tempo impiegato dai portaferiti a medicare malamente unA ferita va lutto a scapito d t>l lavoro di trft!>pnl' tO.
Tranne cAsi eccezionali in cui il soccorso si impone imm .. diato pe r parte di chiunque, come nelle gravis,.ime emor-
Chirurgica 1487
ragie, o in mancanza di medici, il portaferito traspo r ti 1l fe rito, il medico lo medichi.
E pt-r ciò occorre ch e il medico sia fra le linee dei combattenti il suo soccorso deve tornare efficace.
Così i med ici potranno a nche sorvegliare e dirigere meglio essi stessi il servizio dei portaferiti e impedire che si facciano tt·asportare ferili che sono in grado di recarsi essi stessi alle sezioni di sanila. Ai portaferiti basterà insegnare a mettere un lat:cio nei casi di emorr agie, e impr ovvisare apparecchi di immobili zzazione delle fratture, mai toccando la ferita.
L'opera stessa del medico sul ca mpo di battaglia non dovrà essere del resto che più attiva sotto l'aspetto chirurgico. Il numero dei feriti che do vrà soccorrere sarà tale che egli dov rà astenersi in modo .assoluto da q ualu nque atto operativo, tranne da quelli eccezionalmente richiesti da pericolo di vita e da necessità di trasporto.
Anche nei casi di emorragie per ferita di grossi vasi egli non dovra tentare l'allacciatura sul sito dei capi recisi, prat icare legature nella continuità _del vaso, ma semplicemente applicare un laccio od un torcolare e fare uu opportuno tamponament o.
Di tutte le ferite egli farà una semplice medicazione per occlusione col materiale prepa r ato asP.ttico ed bOli!i'ellico, Iavandole soltanto quando esse saranno sporche di ter ra od altro, e solo quando ne avrà l'agio completo.
E non di,·ersamente agiranno i medici nei fOSh di medica:oio ne reggimentali se questi sa ranno mantenuti, o non subiranno quelle m odificazioni di materiale e personale che sono richieste dalla nuova tattica come venne per l'appunto proposto dal colonnello medico Tosi al congresso internazionale di Roma.
Questo sarà il modo migliore per fare dell'asepsi o dell'an tisepsi. .
Più che l'opera de l chirurgo, sul campo di battaglia avrà impo rtanza l'opera dei pertaferili pel trasporto immediato dei col piti ai posti di medicazione reç!gi menlali occorre, e da questi alle sezioni di sani la. Disgraz"iatamen te ciò ogg1dì colle
1488 Rivista
nuove armi sarà cosa ben difficile a ra ggiuogersi. Mentre prima infatti si calcolava cbe la sezione di sanità in massima. per trovarsi al coperti) del tiro della fucileria, dovesse essere posta a 1500 m. all'incirca diell·o la p1·opria linea di fuoco, ora colla portata di gran lnnga maggiore dei fucili a piccolo cal ibro dovrebbe, per raggi un gere lo s tesso intento tenersi probabilmente una distanza di 2500 m. od più, 3500-ltOOO m. secondo il Demoslhen, a meno di rrpar i naturali od a ccidentali, per cui il luogo di stazione dei carri che secondo le vigenti prescrizioni deve ess.we in un punto intermedio tra la sezione di sanità e la linea del fuoco, verrebbe così a trovarsi a 1(;00 m. all'incirca da questa. Calcolando pertanto che occorra all'incir·ca un'ora pel trasporto su barella di un ferito dal campo di battaglia alla stazione dei car·ri a simile distanza, e pur supponendo appena la percentuale 3 °/o di colpiti per ogni ora Ji fuoco, si comprende quanto tempo e quanti uomini sarebb ero necessari per eseguire il trasporto dei feriti grav di una divisione impegnata, che sarebbero non meno di 200 per ogni ora, eliminandone altrettanti fra morti e feriti leggeri-. Indispenl'abile dun1ue di aumentare quanto più !'arà possibile, compatibilmente colle esigenze dei combattimenti, i mezzi di trasporto ed il numero dei portaferiti, e cercare di mobil izzare molto più le stesse sezioni di sanità in modo da portarle quanto più si pot rà presso alla linea di fuoco, dividendole e suddividendole secondo il bisogno così da sosliluirle quasi ai di medicazione reggimentali.
L'autore poi é d'avviso che le laparatomie sono da condannelle sezioni di sanità, in quanto che le statistiche anche più recenti e quelle raccolte dal Nimier sul Tookino dimostrano come nelle ferit e dell' a ddome il trattamento aspetwote é forse ancora preferib rle al trattamento operativo, e il Richter osserva per di più giustamente che sarebbe un Yero delitto il voler sprecare con danno non piccolo due ore in una laparatomia, mentre nello stesso tempo si po!'ta aiuto ad una serie di feriti e si possono salvare le !or vite.
Al più, queste operazioni, come tulte quelle in genere che
C:.HIRURGICA 1489 si praticano oggidì sui visceri dell'addome, quali gastrotomia, gastr oenter ostomie, ileocolostomie, resezione dell'intestino, colecistetenrostomie, ecc. ecc., si potranno eseguire negli ospedali da campo, quando questi potranno venire piantati in ottime condizioni ed i feriti non saranno troppo numerosi; ed è perciò che si deve cercare di portare queste unità sanitarie quanto più sar·à possibile vicino al campo di battaglia, mobilizzandole maggio rmente, in modo che possano coadiu,•are validamente le sezioni di sanità fin dalle prime orf>, du ra nte l'azione stessa, nel soc'!Orso de i feriti .
L'autore pr·opone infine di aggiungere nei nostri p acchetti di m edicazione fatti con garza al sublimato, oltr echè l'occorren te per ùue medicazioni anzichè per una, come il colonnello Tosi, anche pochi grammi di iodoformio per spolverare legp;er mente la ferita, conservandosi la sua azione antisettica maggior tempo che non quella del suhlimato, come è oggi riconosciuto quasi universalmente. Per queste prim e medicazioni l'inconveniente che giustamente si riconosce alla polvere di iodoformio di formare crosta cogli essuriati delle pisghe diventa esso stesso un vantaggio, poiché si avrebbe cosi più facilmente 'la guarigione per prima , s otto crosta, delle ferite.
G.
BERGMANN. - Sulla. tra.pa.n&zlone nelle ferite cl'arma. 4& fuoco. - ( Deutsehe _V:edicin. Wochenschrifl, N. 27).
Sotto questo litolo troviamo r ipor tata sul rapporto di una seduta alla società medica di Berlino una renza del prof. Bergmann, in relazione ad un caso 'Qperato da lui stesso di trapanazione per ferita d'ar ma da fuoco del cranio e presentato alla società 14 g ior ni dopo l'operazione. Secondo l'opinione d el chiaro professore, le ferite da r evolver meritano in modo speciale la nostra attenzione non solo in causa della loro frequenza, ma anche perchè la costruzione del revolver è presso a poco analoga a quella
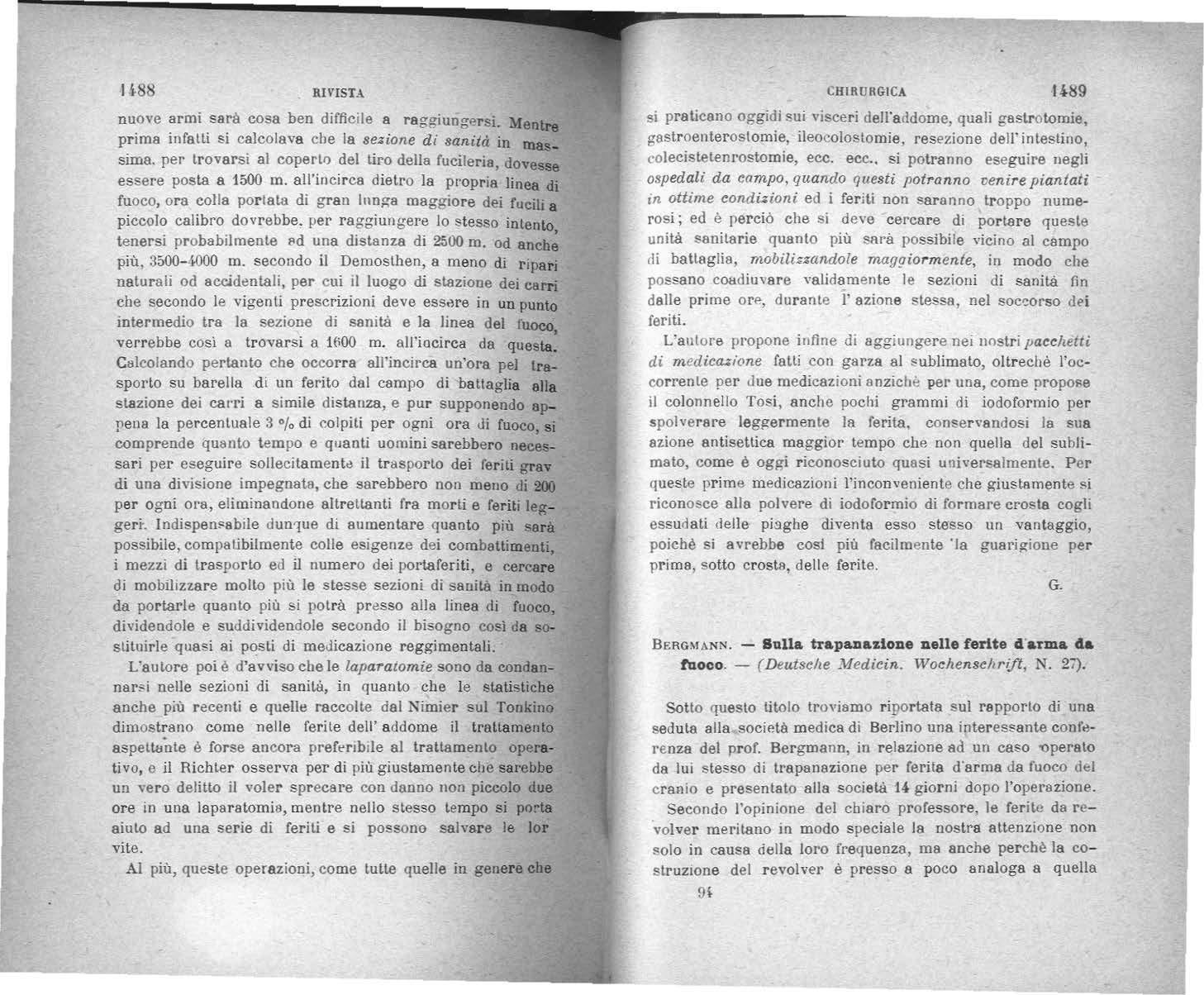
Rivista
delle altre armi portatili da guerra, epperciò noi ci trovia in g rado di applicare alla chirurgia di guerra quella rienza e dottrina che acquistiamo colla pratica · t di ra m empo p11ce prendendo pure in considerazione la differenza della celerita del movimento del proiettile del fa e della sua fisica costituzione.
Egli ricorda come degne di menzione 25 osservazioni ratte ultimi 9 anni, di ferite d'arma da fuoco del cr·aoio, e su dr esse le seguenti considerazioni; pr·ima categoria trattasi per r egola di lesione dei ventricoli laterali con stra vaso di sangue nelle meningi Secondo poi che questi stravasi coprono gli emisferi o sono semplicemente localizzati ai ventricoli, si regola il pronostico. Nel secondo gruppo vi è semp r e una lesione della corteccia -davanti o di dietro del solco centrale. Nel terzo gruppo esiste lesione del lobo fro ntale o parietal.e dei quali posson o andare perdute porzio ni più o meno grosse sen za un ragguar-
Il quadro cli.llico offertoci dalle ferite d'arma da fuoco del cranio può esser differenziato secondo una migliore direzione. Ad una prima categoria appartengono quei pazienti che vengono portali all'ospedale privi di coscienza e di movimento, di modo cJre non si può conoscere se esistono pa· ralisi.
Questi pazienti soccombono s otto crescenti feno meni di compression e cerebrale, per lo più coi s in tomi della r espir azione di Cheyne-Stokes, oppure sin dal giorno successive si stabilisce un miglioramento contrassegnato dal ritorno della coscienza. Molti di questi feriti si salvano.
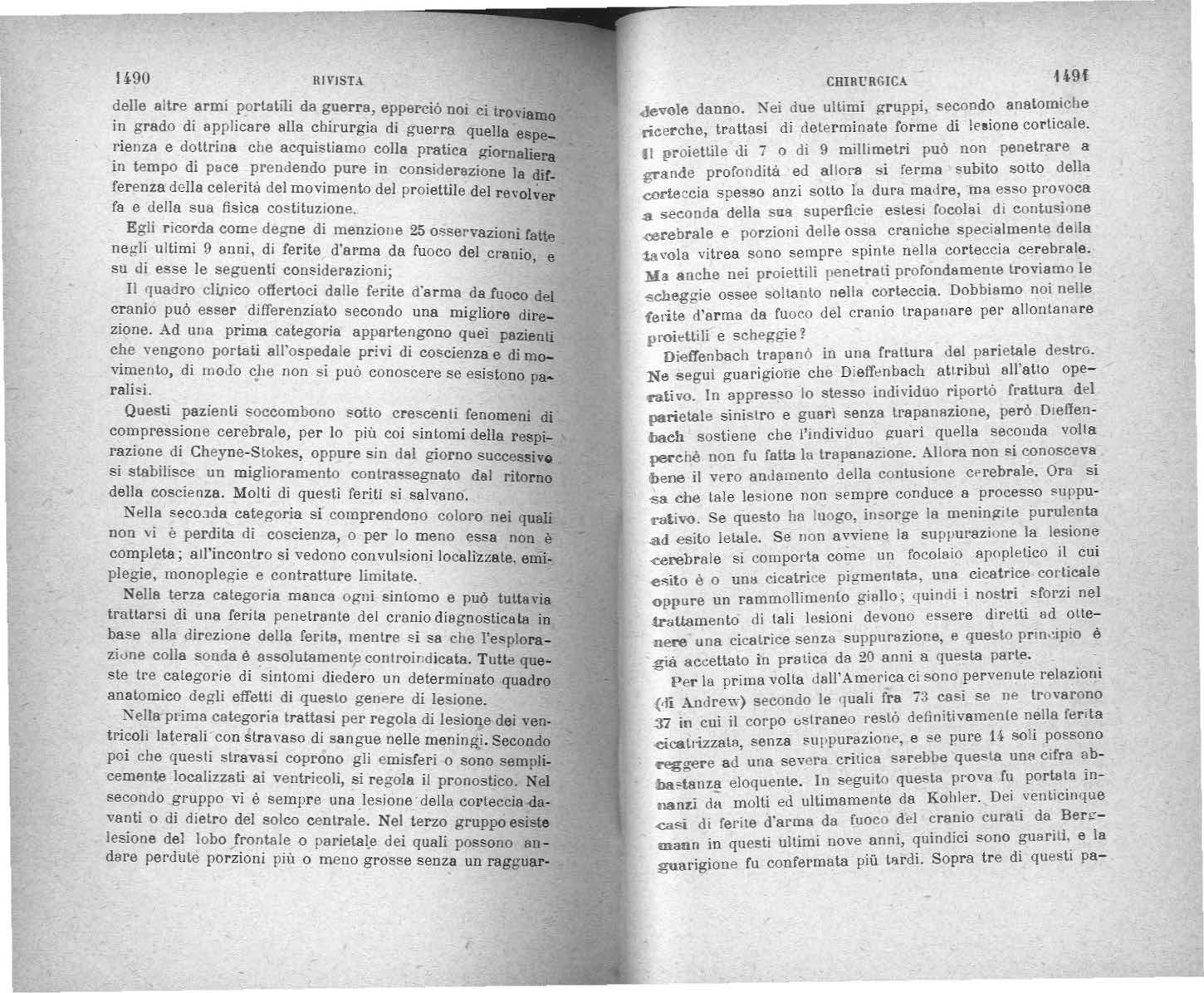
Nella seco.1da catego ria s i comprendono coloro nei quali non vi è perdita di coscienza, o per lo meno essa non è completa; all'incontro si vedono convulsioni locali'zzate, emiplegie, monoplegie e contratture limitate..
Nella terza categoria manca ogn i sintomo e può tuttavia traLLarsi di una ferila penetrante del cl'anio di ag nosticala in base alla direzione della ferila, mentre si sa che l'esplorazi<Jne colla sonda è controind icata. Tutte queste tre categorie di sintomi diedero un determinato quadro ana tomico degli effetti di questo genP.re di lesione.
CHIRl'RGIC.4. H9t
devole danno. due ultimi gruppi, secondo anatomiche ricerche, trattasi di dete rmi nate fo r me di !eaione cor ticale. 11 proiettile di 7 o di 9 millimetri può non penetrare a .grande profondità ed a llora s i ferma subito sotto della spesso anzi sotto la dura madre, ma esso provoca .a seconda della saa superficie estesi focolai di contusione e porzioni delle ossa craniche specialmente della 1.11 vola vitrea sono sempre spinte nella corteccia cerebrale. Ma anche nei proiettili penetrati profondamente troviamo le scheggia ossee soltanto nella corteccia. Dobbiamo noi nelle ferite d'arma da fuoco del cranio Lrapanare per allontanare proiettili e scheggie? .
Dieffenbach trapanò in una frattura del parretale destro. Ne seguì guarigione che attribui all'atto open.ti vo. I n appresso lo stesso individuo ri portò frattura del parietale sinis tro e guarl senza trapanazione, però D1effenmeh sostiene che l'individuo guari quE'Ila seconda volta perchè non fu fatta la trapanazione. Allora non si bene il vero anJamento della contusione Ct>rebrale. Ora st sa che tale lesio ne non sempre conduce a pr ocesso !'Uppurat ivo. Se questo ha luogo, insorge la meninp:ile purulenta .ad esit o leUile. S e non avvie ne la suppurazione la lesione <erebra le si com porta come un focolaio ap<lp\etico il cui e:';ito è o cicatr ice pigmentata , una cicatrice corticale oppure un rammollimento giallo; quindi i nostr i . sfor·zi nel trattamento di tali lesioni devono essere d1reU1 ad ottenere una cicatrice senza sup purazione, e questo pr in.:Jpio è cià accettato in pr atica da 20 anni a questa parte.""' Per la prima volla dall 'America ci sono per venute relazioni (<Ji Andre"") secondo le quali fra n casi se ne trovarono .37 io cui il corpo ostraneo restò definitivam ente nella fe r •ta -cicatrizzala senza suppu razione, e se pure H soli possono .reggere a d' una severa critica serebbe una cifra ha<>tanz!!- eloquente. In seguito questa pr·ova rnda m olli ed ultimamente da Kohler. De1 vent1crnque -casi di ferite d'arma da fuoco del c ranio curati da Bers=maon in questi ultimi nove anni, quindici sono e la guarigione fu confermata piu Sopra tre dr questr pa-
H-92 RIVISTA
zienti fu praticata la trapanazione si tratta , · . . . . 1 . . . • \8 tn ess1 dt . vtsstme es10m; cmque pazienti morirono e t g,a . . . . . ,n ro 1 prmu cm gtorm; m esst st è trovata l'apertura de · l . . que U 1 ven ucoh late r r no mort per ascesso di un lobo rr0 ntale. 8 1 l primi progressi nel trattamento delle ferite d' fuoco in generale datano dalla f.{uerl'a f<>70-71 !arma _da T o e·J a med mt ttare Wurtemberghese Otl andiamo debitori dell •co che le ferite d'arma da fuoco delle parti moli" p r ova . 1 . . 1 guarivano se l oro fort vemvano ben chiusi.
. Il dott. Ott guari re senza suppurazione 1596 ferile delle partt molb. Come c'inseoonano le mod . 11 . " erne dottrme su a suppuraz!One, secondo le quali il processo sup t' st;rebbe prodotto da qualche cosa che viene tvo o . . d" sservaz1om 1 Ott ;sono · d ' d l - ' ne eve sorpren e r e a cuno, poichè ap punto la stessa piccolezza d . <ielle moderne ferite costituisce una protezione dagl· e t . r o o l agen ti m ettvt estranet. Una infezione primaria delle •ert"te , i tr . ,, non t• m a ' COSJ frequente, altrimenti neanche prima d"o mai ottenuto una guarigione per prima sa· Ctò che non è vero· l'infezione era per lo .ù d" nzJone, . ' pt t natura s econdaria e precisamente per la manovra che era tanto comandata, d'introdurre le dita e gli strumenti nelle r, .rlacscopo d" 1 . . erte a I esp orazione ed estrazione di proiettili e d" b . P tì l I se eggte. er no e_ più gravi ferite arti colari possono g uari re senza Il prof. Bergroann ha pnbblicato una memoria sulle ferite d'arma da fuoco del ginocchio osservate guerra e da essa risulta che sopra fS cast solo uno termmo colla tnorle in c:egu 1 "to d . . , a ampusecon•IAt'ta. Due di quei pazienti morir·ono per dis· senter1a alcune settimane dopo che erano guariti delle 1 rer'te r t o d" vr o . ' e au opsta tede a constatare la consolidazione di tutti J e di un legamento crocialo senza suppu ra zione. Le fer1te del cervello adunque per la piccolezza dei l or o fo ri :;ono suscettibili dello stesso trattamento come le fi ·l d 1 . 1 . er1 e e g:tnocc uo, trattamento che deve consistere essenzialmente esse ferite dall'azione nociva deali auen ti mfett1v1. "' ...,
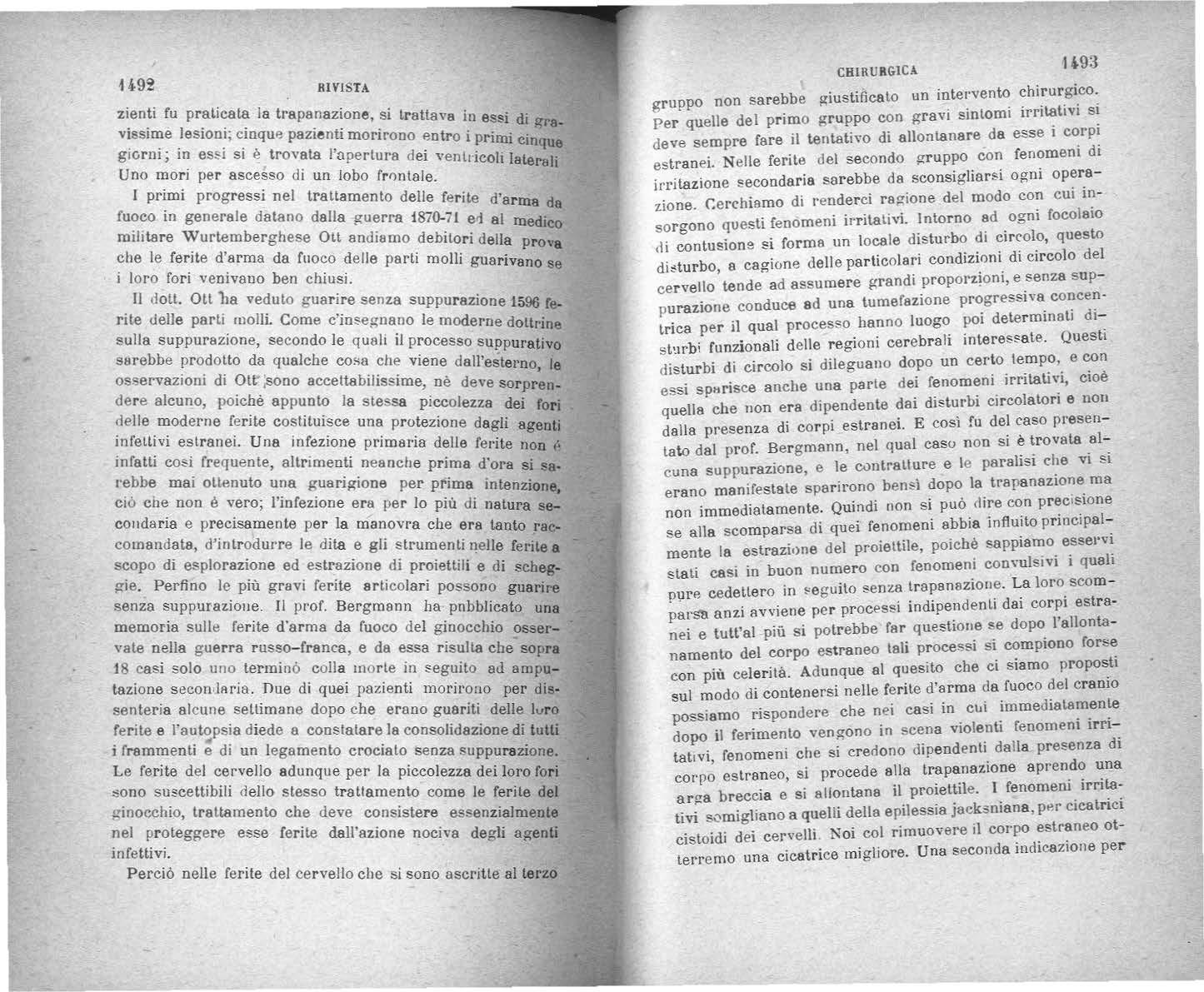
Perciò nelle ferite del cervello che si sono al terzo
CHIRURGICA U-93
gruppo non sarebbe giustificalo un intervento chirurgico. Per quelle del primo gruppo con gravi sintomi irritativi si deve sempre fare il t.entatiYO di allontanare da esse i corpi estranei. N elle ferite del secondo gruppo con fenomeni di irritazione secondaria sarebbe da sconsigliarsi ogni operazione. Cerchiamo di r·enderci ragione del modo con cui insorgono questi fenomeni i1•ritativi. l ntorno ad ogni focolaio <li contusione si forma un locale disturbo di circolo, questo di:>turbo, a cagione delle particolari condizioni di circolo del cervello tende a d assumere grandi proporzjoni, e senza suppurazione conduce ad una tumefazione progressiva concen· Lrica per il qual processo hanno luogo poi determinati difunzionali d elle regioni cerebrali interessate. Questi disturbi di circolo si dileguano dopo un certo tempo, e con essi spnrisce anche una parte dei fenomeni irritativi, cioé quella che non era dipendente dai disturbi circolatori e non dalla presenza di corpi estranei. E così fu del caso presentato dal prof. Bergmann, nel qual caso no n si è trovata alcuna suppurazione, e le cvntrallure e le paralisi che vi si erano manifestate sparirono bensì dopo la trapanazione ma non immediatamente. Quindi non si può <lire con prec1sione se alla scomparsa di quei fenomeni abbia influito principalmente la estrazic>ne del proiettile, poiché sappiamo esset•vi slali casi in buon numero con fenomeni conYulsivi i quali cedettero in !:'eguilo senza trapsnazioue. La loro scomparstl anzi avviene per processi indipendenti dai corpi estranei e tutt'al piu si potrebbe far questione se dopo l'allontanamento del corpo estraneo tali processi si compiono con più celerità. Adunque al quesito che ci siamo proposti sul modo di contenersi nelle ferite d'arma da fuoco del cranio possiamo rispondere che nei casi in c1.1i immediatamente dopo il ferimento vengono in scen a violenti fenomeni irritattvi, fenomeni che si creclono dipe ndenti dalla presenza di corpo estraneo, si procede alla trapanazione aprendo una breccia e si allontana il proiettile. l fenomeni irritativi somigliano a quelli della epilessia jacksniana, per cicatrici cisloidi dei cervelli. Noi col rimuovere il corpo estraneo otterremo una cicatrice migliore. Una seconda. indicazione per
'Un intei'Vento pratico ci è offerta d ,. a un esteso 1 u l ossa e di parti molli Qui abb" l o arneot& d · Iamo spesso d . elle operazjooi plastiche In tutt' l" l . . a pralieal'e 1 .. · · • f! 1 a lr1 cas1 <>i a .erJta astenendoci da ogni inte t . prot egg& rven o attivo.
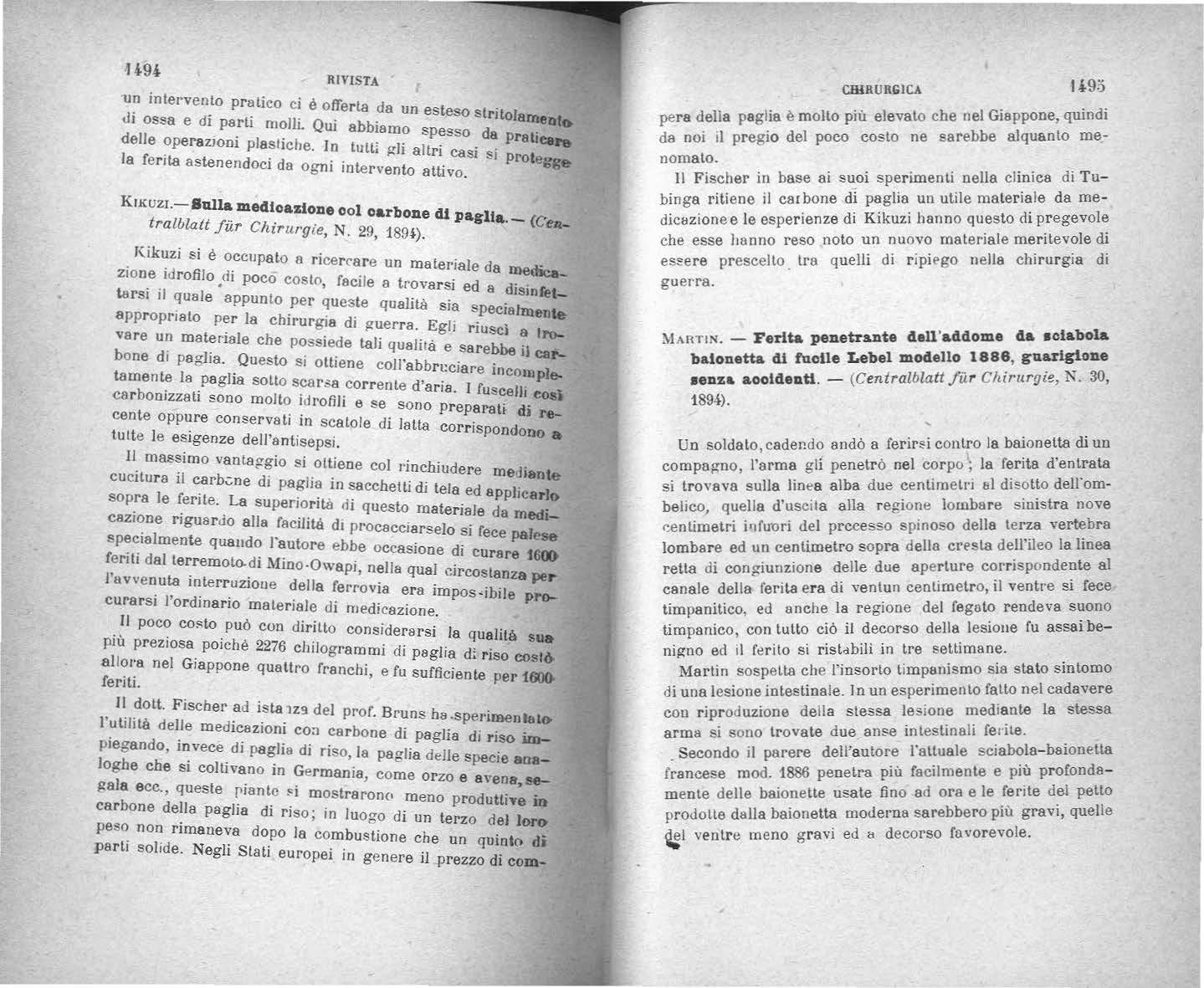
Kuwzt.- me4l_cazlone col carbone eU paglia.tralblatt jur Chlrurgie, N. 29, 189i). (Ct>A-
Kikuzi si è occ11 pat · o a ricercare un m l · 1 ziooe idrofilo di poco costo facile t a er_'a e da med;ca_ ta ..1 • ' a rovars1 ed 8 dis· le rs• l quale appunto per queste qualità sia s . Jn tappropriato per la chirurgia di f!uerra Egl · vare u , · 1 · l rtusc• 8 1__ n ma.eria e che possiede tali quart. • .,_ bo d" l" I a e sarebbe H ca ne l pag Ia. Questo si ottiene coll'abbrcc·a . 1'tamente la paglia sotto scar:.a corrente d'a l te carbonizzati sono molto idrofili rJa. fuscelli eosi e se sono preparati- d. cente oppure conservati in scatole di latta . J retolte le esigenze dell'antisepsi corrispondono a massimo vanta§.!gio si ottiene col l'inchiudere d" cucttura il carkne di paglia in sacchetti di tela e me. l&nte sopra le ferite. La superiorità n· . d applicarlo · 1 questo matertale d . cazlone riguardo alla facilita d . . a medt1 procacclarselo si re J specialmente quaudo rautore ebb . . ce pa ese .. . . e occasiOne d1 cura 11u•n. .erlh dalterremoto. di Mino-Owap· Il . re VUU' 1• , . r, ne a qual circostanza av\enuta mterruzioue della ferrovia e . . . per cura · l' d. ra 1mpos-rbrJe rsl or mario materiale di medicazione.
. Il cogto. può con diritto considerarsi la qualità s p.!ù prezrosa poiché 2276 chilogrammi di paglia d' . ue nel Giappone quattro franchi, e fu
Il dott. Fiscber ad ista 1Z9 del f l'utilità d li . . . pro. Bruos ha.speriroenlal& . e e medtcazrom carbone di paaJia d " . . ple"'aodo j d " r "' l TIS() .un1ogb h' l te di riso, la paglia delle specie aoae c e SI col!Jvano m Germania come or oaJa 8 ' zo e a vena se., cc., queste J'liantc mostraron • carbone della pagiÌa di . . . 1 C• _meno produttiYe in . rtso' ID uogo dt un terzo del lo
CHIR URGICA 1.495 pera della paglia è mollo più elevato che nel Giappone, quindi da noi il pregio del poco costo ne sarebbe alquanto menomato.
11 Fischer in base ai suoi sperimenti nella clinica di Tubinga ritiene il carbone di paglia un utile materiale da medicazionee le esperienze di Kikuzi hanno questo di pregevole che esse hanno reso noto un nuovo materiale meritevole di eseere prescello. tra quelli di ripiego nella chirurgia di guer·ra.
- Ferita penetrs.n.te dell'addome da sctabc.la baionetta eU fucile Lebel modello 1888, gnariglone senza aoctdentl . - (Centralblatt fii,r Chirurgie, N. 30, 1894).
Un soldato, cadeP.do endò a ferir:> i contro la baionetta di un compagno, l'arma gli penetrò nel corpo; la ferita d'entrata si trovava sulla linea alba due centimet1·i al disotto delrombelico, quella d'uscita alla regione lombare sinistra nove i'lfuuri del prccesso spinoso della terza lombare ed un centimetro sopra della cresta dell'ileo la linea retta di congiunzione delle due aperture corrispondente al canale della ferita era di ventun centimetro, il vent1·e si fece timpanitico, ed anche la regione del fegolo rendeva suono timpanico, con lutto ciò il decorso della lesione fu assai benigno ed il ferito si ristdbilì in tre settimane. Martin sospetta che l'insorto timpanismo sia stato sintomo di una lesione intestinale. In un esperimento fatto nel cadavere con ripr oduzione della stessa lesione mediante la stessa arma si sono trovate due anse intestinali ferite.
. Secondo il parere dell'autore l'attuale sciabola- baionetta francese mod. 1886 penetra più facilmente e più profondamente delle baionette usate fino ad ora e le ferite del petto prodotte dalla baionetta moderna sarebbero più gravi, quelle ventre meno gravi ed 1:1 decorso favorevole.
PLACH.- L 'operazione r&dloale dell'ernia Jngllbaale condo n metodo BaulDl nell'oapedale mUltar ....
Yeredo.- (Wiener MP.d. Woehens., e Centr 8oChir. N. 30, 1894). a · fù,.
Delle nove Opèrazi oni che furono eseauite su quell' d l 'l't · " ospe- a e mr 1are, cmque furon praticati sopra ernie . d . . . . congemte ue su erme volummose, ant1che m"uino-scrotal' 1 ' • "' 1• e altre su erme p1u o meno recenti. Si ottenne la <>ua ri.,.ione 1 · 'to • • t> e n o. cas1, sett1 soldati guarirono riacquistando l'attitud' ,· 1 J me al ser\JZro m11tare. Nel nono caso la operazione ru se 'ta . . gu1 da morte, ma md1rettamente (delirium tremens) ''e 1· · · · · . . . ' · g ! es1t1 fehCI la guar1g10ne !'l stabili fra i dieci ed i venl' · . . . tcmque !!'rornr tra le comphcanze degne di menzione va notata una ro:te aderenza del l>acco ernario, un diverticolo della veSCICa ed un lipoma.
Oltt·e a queste praticate sopra soldati l'auto bb re e . e occas1one esegui rn e altre cinque nella sua pratica privata, alcune dt queste anche in condi zioni esterne as!lai e non ebbe a deplorare che un deces!!'o, in una ve<'chra dt 83 anni con ernia strozzata.
Per le ernie crurali nelle quali non è punto facile la sutura del del Pupa1·zio colla fascia ilco:pettinee il metodo di Bassini e meno appropriato. Qui l'esti r pazione del sacco erniario dovrebbe avere gli stessi vantaggi.
ALLEN STAR. - L 'aneateda looale come guida 41 cUagnod nella luione dell ' eatremttà. interiore del midollo sp1nale . - (Centralblatt fii.r Chirttrg., N. 12, 189•).
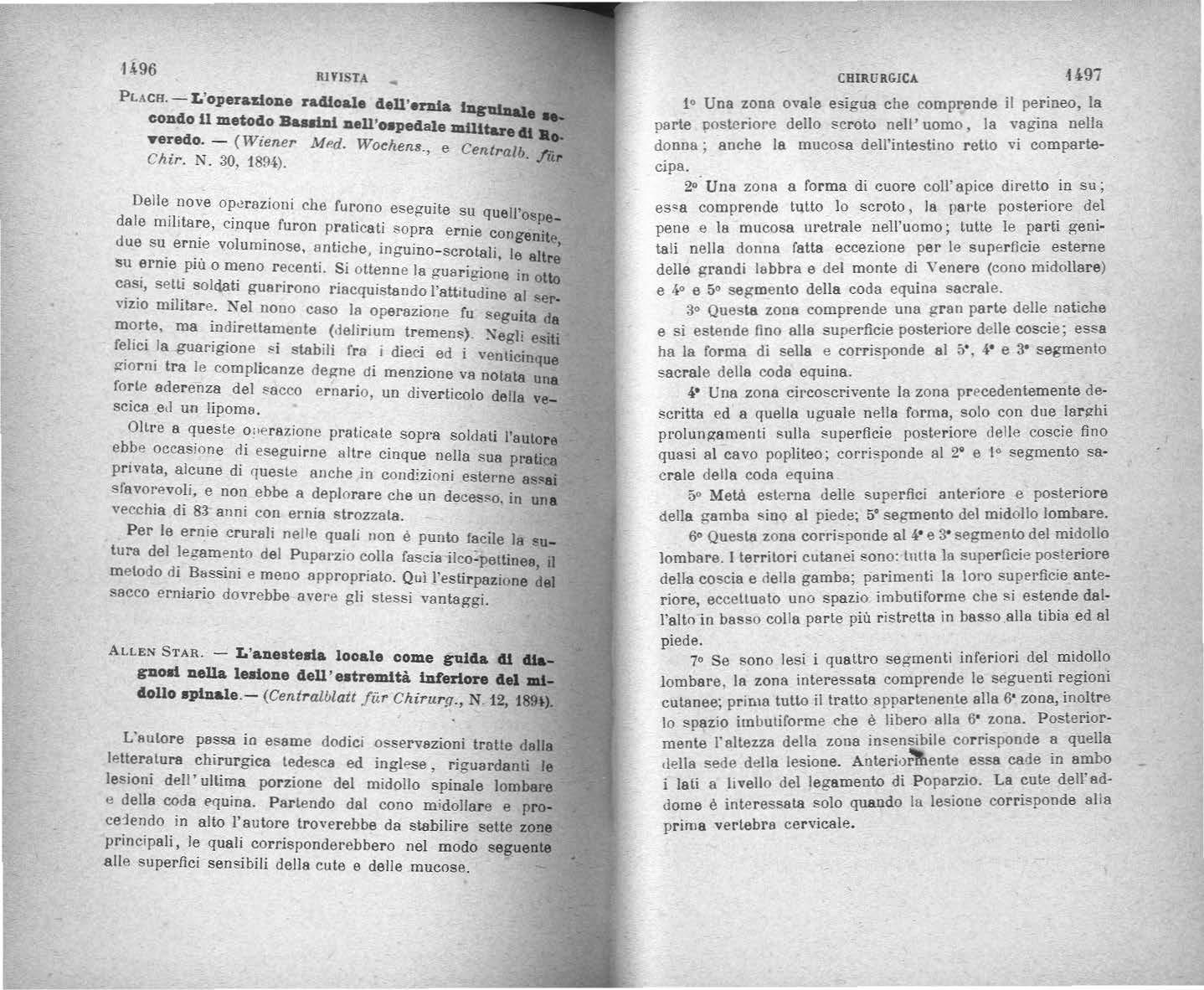
L'Autore passa io esame dodici osservazioni tratte dalla letteratura chirurgica tedesca ed inglese, riguardanti le lesioni deli' uUima porzione del midollo spinale lombare e della coda equina. Partendo dal cono midollar e e pro· ce:lendo in alto l'autore troverebbe da stabilire sette zo!le principali, le quali corrisponderebbero nel modo seguente alle superfici sensibili della cute e delle mucose.
Chirurgica H97
1° Una zona ovale esigua che comprende il perineo, la parte posteriore dello scroto nel!' uomo, la vagina nella donna ; anche la mucosa dell'intestino retto vi compartecipa.
2o · Una zona a forma di cuore coll'apice diretto in su ; comprende Lutto lo scroto, la par·te posteriore del pene e la mucosa uretrale nell'uomo; tutte le parti geni· tali nella donna fatta eccezione per le superficie esterne delle grandi labbra e del monte di Venere (cono midollare) e 4o e 5o segmento della coda equina sacrale.
3o Questa zona comprende una g r an parte delle natiche e si estende fino alla superficie posteriore delle coscie; essa ha la forma di sella e corrisponde al 5' , 4• e 3• segmento sacrale della coda equina.
4• Una zona circoscrivente la zona precedentemente descritta ed a quella uguale nella forma, solo con due larghi prolungamenti sulla superficie posteriore delle coscie fino quasi al cavo popliteo; corrisponde al 2° e 1° segmento sacrale della codA equina
5o Metà. esterna delle superfici anteriore e posteriore della gamba 8ino al piede; 5• segmento del midollo lombare.
So Questa zona corrisponde al 4• e 3• segmento del midollo lombare. I territori cutanei sono: tutta la superficie posteriore della coscia e della gamba; parimenti la loro superficie anteriore, eccettualo uno spazio imbulHorme che fii estende dall'alto in basso colla parte più ristretta in basso .alla tibia ed al piede.
7o Se sono lesi i quattro segmenti inferiori del midollo lombare , la zona interessata comprende le seguenti regioni cutanee; prima tutto il tratto appartenente alla 6' zona, inoltre lo spazio imbutiforme che è libero alla 6• zona. Posteriormente l'altezza della zona insensibile corrisponde a quella della sede della lesione. essa cade in ambo i lati a livello del legamento di Poparzio. La cute dell'addome è interessata solo quando la lesione corrisponde alla prima vertebra cervicale.
CHIRURGICA 14-99
l.i98 RIVISTA
ANNEQUIN.-Aooldentl prodotti dal fulminato dl meroul'l.o. - (Arch. di med. e Cen.tralblaftjilr Ghi r ., N. 36, 1 894).
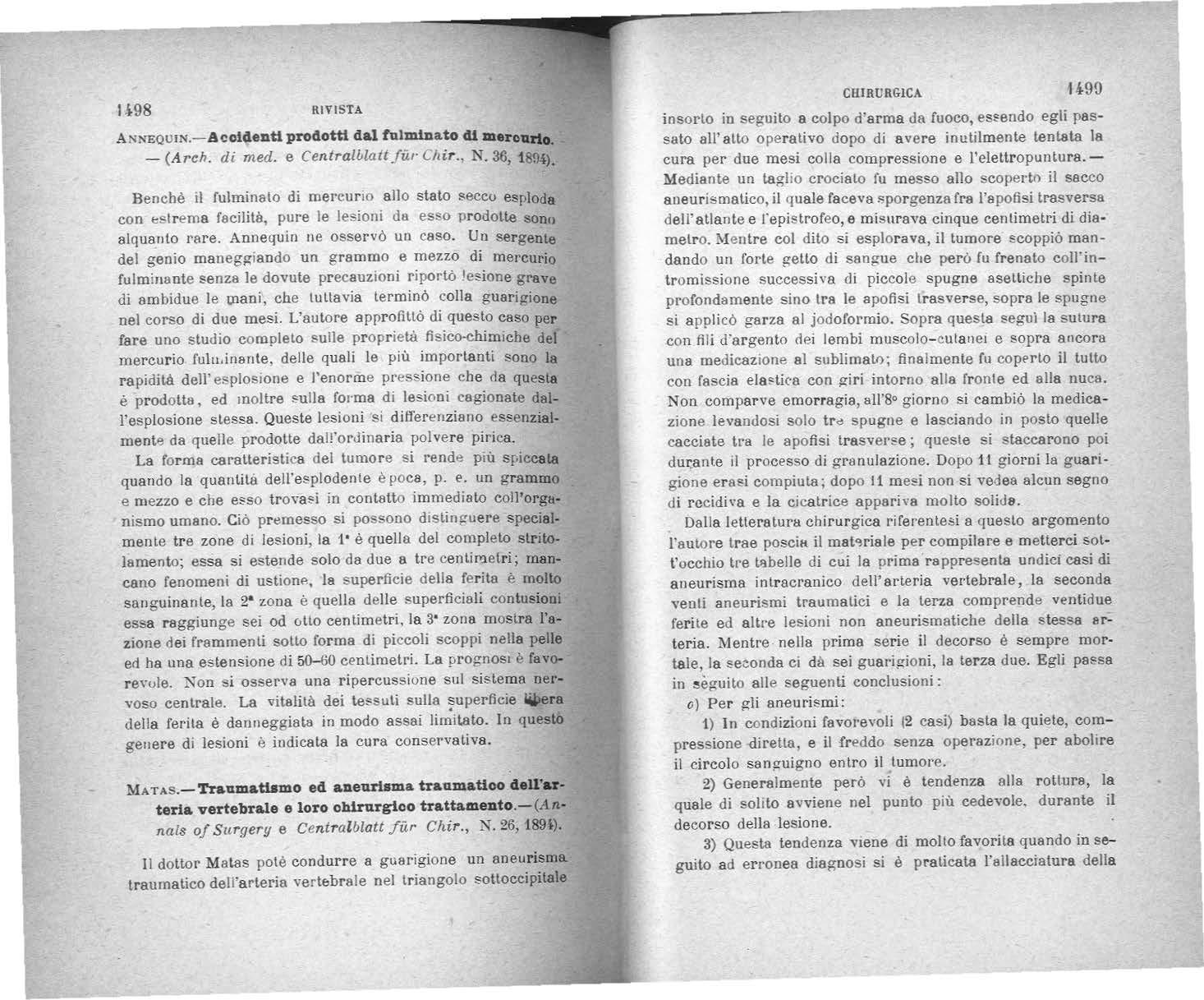
Benché il fulminato di mercurio allo stato secco esploda con estrema facilità, pure le lesioni da esso prodotte sono alquanto rare. Annequin ne osservò un caso. Un sergente del genio maneggiando un grammo e mezzo di mercurio fulminante senza le dovute precauzioni riportò lesione grave di ambidue le 01ani, che tultavia terminò colla guarigione nel corso di due mesi. L'autore approfittò di questo caso per fare uno studio completo sulle proprietà fisico·chimiche del mercurio fulu.inante, delle quali le più importanti sono la rapidità dell'esplosiOne e l'enorme pressione ch e òa questa è prodotta, ed moltre mlla forma di lesioni cagionate dall'esplosione stessa. Queste lesioni si differenziano ess enzialmente da quelle prodotte dal!"ordinaria polvere pirica.
La forma caratteristica del tumore si rende più Spiccata quando la quantiti.l dell'esplodente è poca, p. e. un g rammo e mezzo e che esso trovasi in contatto immediato coll'organismo umano. Ciò premesso si possono distinguere specialmente tre zone di lesioni, la 1• é quella del completo stritolamento; esSa. si estende solo da due a tre centimetri; mancano fenomeni di ustionP., la superficie della ferita è molto sanguinante, la 2" zona è quella delle superficia li contusioni essa raggiunge sei od otto centimetri, la 3• zona mostra l'azione dei frammenti sotto forma di piccoli scoppi nella pelle ed ha una estensione di 50-60 centimetri. La prognos1 è favor e,·ole. :Non si osserva una ripercussione sul sistema nervoso centrale. La vitalità dei le$suli sulla superficie lijlera della ferila é danneggiata io modo assai In q uestò genere di lesioni è indicata la cura conservativa.
MATAS.- Traumatlsmo ed aneurisma traumatloo dell"arterla vertebrale e loro ohlrurgtoo trattamento.-(An.nals oj Surgerg e Centralblatt filr Chir , N. 26, 189\).
Il dottor Malas potè condurre a guarigione un a neurisma. traumatico dell'arteria verlebrale nel tr iangolo insorto in seguito a colpo d'arma da fuoco, egli passato all'atto operativo dopo di avere inutilmente tentata la cura per due mesi colla compr essione e l'elettropunlura.Mediante un taglio crocialo fu messo ano scoper·to il sacco aneurismatico, il quale faceva fra l'apofisi trasversa dell'atl ante e repistrofeo, e misurava cinque centimetri di diametro. Mentre col dito si esplor ava, il tumore scoppiò mandando un forte getto di sangue che però fu frenato coll'intromissione successiva di piccole spugne asettiche spinte profondamente sino tra le apofisi lrasverse, sopra le spugne si a pplicò garza al jodoformio. Sopra questa seguì la sutura con fili d"argento clei lembi muscolo - cutanei e sopra ancora una medicazione al sublimalQ; finalmente fu coperto il tutto con fascia ela!'ti<-a con p:iri intorno alla fronte ed alla nuca . Non comparve emorragia, all'So giorno si cambiò la medicazione levandosi solo trd spugne e lasciando in posto quelle cacciate tra le apofisi trasverse; queste si staccarono poi dur;ant.e il processo di Dopo 11 giorni la guarigione e r asi compiuta; dopo 11 mesi non si vedea alcun s egno di recidiva e la cicatrice appariva molto solida. Dalla letteratura chirurgica riferentesi a questo argoml3nto l'autore trae poscia il per compilare e metterei solt'occhio tre di cui la prima rappresenta undici casi di aneurisma intr acranico dell'arteria vertebra! e, la seconda venti aneurismi traumatici e la terza comprende ventidue ferite ed altre lesioni non aneurismatiche della stessa a rteria. Mentre nella prima serie il decorso é sempre mortale, la ci dà sei gua rigioni, la terza due. Egli passa in alle seguenti conclusioni: o) Per gli
1) In condizioni favo1·evoli (2 casi) basta la quiete, compressione diretta, e il freddo senza operazione, per abolire il circolo entr o il tumor•e.
2) Generalmente però vi è tendenza alla rottura, la quale di solito avviene nel punto più cedevole, durante il decor so della lesione.
3) Questa v1ene di mollo favorita quando in s eguito ad erronea diagnosi si é praticata l'allacciatura della
1500 RlYlSTA carotide; l'errore si può evitare facilmente comprimendo ad intervalli la carotide.
-i) I tentativi di legare l'arteria nel sito dell'aneurisma andarono sino ad or·a falliti, un caso solo eccettuato (Fenzer ) e ciò per effetto dell'imponente e minacciosa emorra gia che obbliga !"operatore a tamponare immediatamente il s acco.
5) Ma il tamponamento dà buoni risultati se si pratica dopo di avere sufficientemente dissecato e messo allo scoperto il tumore.•
6) Le iniezioni con le sostanze coagulate sono da rigettarsi.
7) Nei var• casi di idiopatici e negli aneurismi traumatici situati molto in allo, colla legetura dell'a rteriA afferente secondo Hunter· coadiuvata dal freddo e dalla compressione si può sperara in un buon effetto. potendo il contenuto dt>l sacco prima che s i fo rmi il circolo collaterale per mezzo del circolo del Willis, il che pero potrebbe anche farsi con molta celerita .
R) Negli aneurismi situati profondamente il metodo di Hunter, se si tenta di praticarlo in uno dei pnnti cla ssici, dovrebbe cambiarsi con quello di Antillo, perchè sarà impossibile raggiungere il tronco arterioso senza compr endere il sacco nell' incisione.
9) Se l'aneurisma giace molto in alto e se si adotta il metodo di Antillo, che è anche più sicuro, si fara bene di legare 1'ttrteria vertebrale sotto il tubercolo anteriore della sesta vertebra cer·vicale e farla comprimere da un a!>sistente immediatamente prima òel suo ingresso nel forarn e , e CIÒ .pet· diminuire !"emorragia quando si apre il sacco, senza i pericoli secondarii ai una allacciatura. In ogni ca so sarà bene asportare collo scalpello le apofisi trasverse di una o due vertebre cervical i per poter poi os:;ervare l'a rteria sul punto del suo ingresso nel sacco.
IJ) Trattamento di una ferita d'arteria recente.
1) Anche qui sarà necessal'io procedere alla diret ta r icet·ca ed allacciatura della verlebrale sul sito della lesio ne, nello stesso modo ora descritto per gli aneurismi .
2) Tal volta questa ricerca é im possibile, specialmen te nell e
Chirurgica
t ferite per arma da fuoco quando il proiettile é penett·ato per la bocca ed il sangue fluisce nella faringe e nello spazio retrofaringeo. Spesso sono lesi insieme rami della o la stessa carotide ln\erna, ed allora l'emorragia è rapidamente mortale. In ogni caso non è opportuno indugiare per fare una diagnosi differenzi!tle e si farà bene inv ece ricercare l'in aresso della vertebrale nel sesto forarne trasversale e co;primer l'arteria come pure la carotide comuue e quindi alla legatura dell'un vaso oppure di entrambi se si trova necessario.
3) Nelle ferite alla sezione superiore della faringe lesione della "'iugulare interna, l'emorragia è sempre rapi• t> • • damente mortale, e parimenti nella ferila della sez10ne rnferiore dinnanzi all'ingresso del sesto forarn e vertebra le, doTe appunto possono esseee facilmente lesi contemporaneamente gli altri grossi vasi che scorrono a ridosso di quel punto.
MEYER.- I pertrofi& della prostata. - (Brit. M ed. Journ. 18 ag. 1894 e Annals oj Surgery, luglio 1894).
Meyer descrive un caso _d' iperlrofia in cui allacciò le due artede iliache interne (metodo di Bier). Trallavasi d'un uomo di 55 anni il quale da più di quattro anni soffrh·a di disturbi urinari e la cui urina era purulenta. Dodici ore dopo l'operazione ì'ammalato orinò spontaneamente, cosa che non gli era avvenuta in sei mesi. E::.isteva notevole atomia vescicale. La pro<>tata diminuì di volume e la lunghezza ruretra di 23 tr2 cm. s'abbassò a 211(2 cm. nello spazto dt sei mesi. Fremont-Smith (ibid.) l'i ferisce un grave caso d'ipertrofia ch' curò col metodo della castrazione precon1zzato da J. W. White. Nella settimana che segui l'operazione l'ammalato fu cateterizzato due volte al giorno: alla fine di questo tempo egli potè orinare e il catetere fu usato più volte la settimana, solo allo scopo di determinare la quantità dell'orina residua. Scomparve la febbre, ritornò l'appetito e il peso aumentò. Non si ebbe più
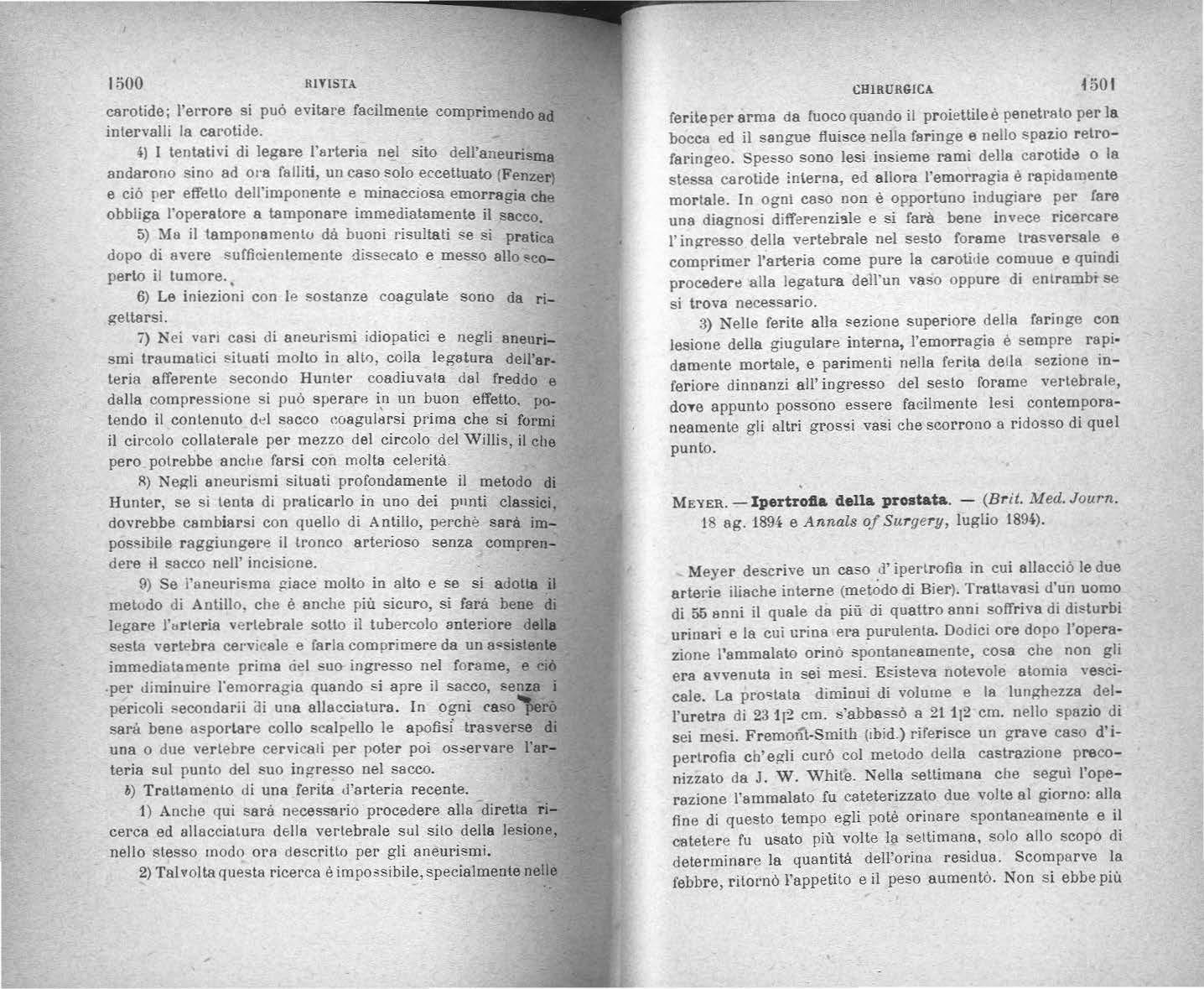
RIVISTA
ritenzione d'urina nè attacchi di cistite acuta. La quantita d'urina residua diminuì gradatamente e quindici settimane dopo l'operazione, l'ammalato stava bene. G. G.
EASTMANN. - S terUlz zazlone d el oa.tgut. - (Annals oj Surgerg, luglio 189i).
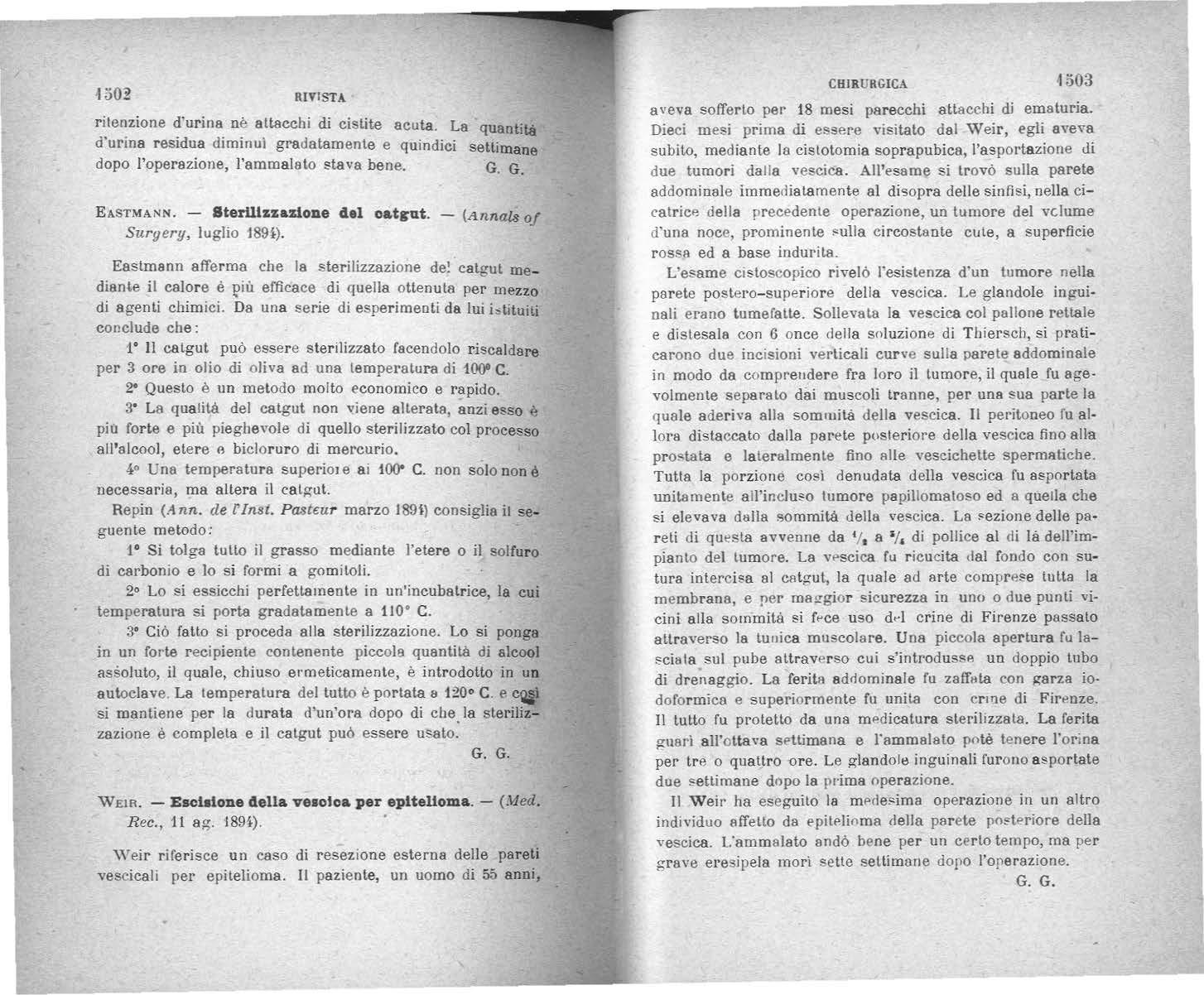
Easlmann afferma che la sterilizzazione de! catgul mediante il calore è l>iù efficace di quella ottenuta per mezzo di agenti chimici. Da una serie di esperimenti da lui i:.tituili conclude che:
1' Il catgut può esser e sterilizzato facendolo riscaldare per 3 ore in olio di oliva ad una temperatura di 1000 C.
2- Questo è un metodo molto economico e rapido.
3• La qualità del catgut non viene alterata, anzi esso è più forte e più pieghevole di quello sterilizzato col processo all'alcool, etere A bicloruro di mercurio.
4o Una temperatura superiOJ e a i 100' C. non solo non é necessaria, ma altera il calgut.
Repin (A nn. de r Inst. Pas tw r marzo J89i) consiglia il seguente metodo:
1° Si tolga tutto il grasso m ediante l'etere o il solfur o di carbonio e lo si formi a gomitoli.
2o Lo si essicchi perfettamente in un'incubatrice, la cui temperatura si porta gradatamente a 110• C.
3• Ciò fatto si proceda alla sterilizzazione. Lo si ponga in un forte recipiente contenente piccola quantità di alcool assoluto, il quale, chiuso et'meticamente, è introdotto in un autoclav e. La temperatura del tutto è portata a 120° C. e CQIÌ si mantiene per la durata d'un'ora dopo di che. la sterili zzazione è completa e il catgut può essere usato.
G. G.
WEtR. - Bscl•lone della ve aotoa per epitelloma.- (Jded . Ree., 11 ag. J89i).
\Veir riferisce un caso di resezione esterna delle pa r eti vescicali per epitelioma. Il paziente, un uomo di 55 a nni,
CHIRURGICA 1503 aveva sofferto per 18 mesi parecchi attacchi dì ematuria. Dieci mesi prima di essere visitato dal Weir, egli ave'\'a subito, mediante la cistotomia soprapubica, l'asp01·tazione ùi due tumori dalla vescica. All'esame si trovò sulla parete addominale imme<i iatamente al disopra delle sinfisi, nella cicatrice della precedente operazione, un tumore del vcluroe d'una noce, prominente circostante cute, a superficie rossa ed a base indurita.
L'esame cistoscopico rivelò l'esistenza d'un tumore nella parete postet·o- superiore della vescica. Le glandole inguinali erano tumeratte. Sollevata la vescica col pallone rettale e distesala con 6 once della soluzione di Thiersch, si praticarono due incisioni verticali curve sulla parete addominale in modo da comprendere fra loro il tumore, il quale fu age· volmente separato dài muscoli tranne, per una sua parte la quale aderiva alla sommità della vescica. Il pet•itoneo fu allora distaccato dalla parete posterior·e della vescica fino alla prostata e lateralmente fino Alle vescichelte spermatiche. Tutta la porzione così denudata della vescica fu asportata unita mente all'incluso tumore papillomatoso ed a quella che si elevava dalla !'!Ommità della vescica. La delle pa· reti di avvenne da 1/ 1 a 1/, di pollice al di là dell'impianto del tumore. La vPscica fu r icucita dal fondo con sutura intercisa al catgut, la quale ad arte compr ese tutta la membrana, e rer ma!!gior sicurezza in uno o due punti vicini alla sorrimità si ft'ce uso d..-1 crine di Firenze passato attraverso la tunica muscolare. Una piccola apertura fu la:;.ciala sul pube attraverso cui s'introdussA un doppio tubo di drenaggio. La ferita adriominale fu zaff»la con garza io· doformi ca e superiormente fu unita con cru1e di Firt:>nze. II tutto fu protetto da una mPdicatura sterilizzata. La ferita guarì all'ottaYa st-ttimana e rammalato potè tenere l'orina per tre o quattro -ore. Le glandole ìnguinali furono a sportate due settimane dopo la pt·ima operazione.
11 Weir ha eseguito la m Pclel'ima operazione in un altro individuo affelto da t-pilE'Iioma della parete posteriore della ''escica. L'ammalato andò bene per un certo tempo, ma per grave eresipela mori sette settimane dopo l'operazione.
G. G.
1504 Rivista
fuEDEL. - Edema ed elefantiasi penistenti In "gulto aU'eatlrpaztone 41 glandole Unfatiohe. - ( Arclt. f. ktin. Chi r. vol. 47, p. 3 e 4).
Riedel fa nClù:rre come raramente si sia fatto menzione di casi in cui all'estirpazione di glandole tinfatiche siano seguiti edemi ed elefanti asi permanenti. Egli opina che queste successJOui morbose non siano molto rare, poiché egli lillesso le ha osservate tre volte. Una prima volta le osservò in· un ragazzo di 12 anni, in cui l'edema di -lutto il braccio e della mano tenne dietro all'estirpazione delle glandole soltascellari eseguita tre anni prima.
Il secondo paziente fu un giovane di apparenza robusta dell'età d'anni 30. Alcuni anni prima egl i contrasse un'ulcera molle, cui seguì suppurazione delle glandole dell'inguine sinistro. Da allora le glandole rimasero molto cagion evoli sJcchè si gonfiavano dopo aver cam minato e per ogni escoriazione del glande.
Riedel estirpò le glandole e le trovò corrose di piccoli ascessi. La ferita operatoria guarì bene per st::conda intenzione, ma osservato due anni dopo, il paziP-o te fu trovato affetto da elefantiasi della cute tli entra robP- le cosce e della parte inferiore del tronco: pure ingrossar?ento delle glan dole della ascella destra.
Il terzo paziente fu un giovane robusto di 30 anni. Una ulcera molle contratta nove mesi prima suppurazioni e seni fistolosi ribelli nd ogni trattamento. Riedel estirpò le glandole inguinali siniske e sei mesi dopo si sviluppò un'elefantiasi della cute Jella coscia. Tanto nel secondo quanto nel terzo infermo l'elefantiasi era associata • attacchi di eresipela. I n seguito a questi fatti li Riedel ritiene per lo meno dubbia l'utilità dell'estirpazione completa delle glandole inguinali in simili casi.
G. G.
OGILVIE. - Divisione della scapola oon un colpo 4l solabot&. - (Brit .•Ved. Journ., 9 giugno 1894).
Il dott Ogilvif', tenente medico nell'esercito indiano, riferisce il caso d'un sepoy il quale ebbe divisa la scapola da
Chirurgica
1505 un colpo di sciabole, infer tagli da un ghazi (fanatico rosomettano). 11 sepoy usciva dal corpo di guardia, la eu! porta un po' bassa lo obbligò a curvarsi un poco. Il gbaz1 stava a destra dalla porta e a t r e o quattro piedi da essa. Il fenden te cadde sulla spalla destra e dopo aver reciso lo spesso panno della tunica, il panciotto di lana, e la camicia produsse una ferita che si estende>a nalla spina all'angolo della scapola. 11 dott Ogilvie visitò il paziente. minuti dopo .l'accaduto e trovò che il fendente aveva diVISO la scapola nel mezzo dall'incisura soprascapoiare all'angolo. A causa della contrazione muscolare tra le due metà dell'osso esisteva una distanza di circa un pollice. L'emorragia era ab· bondante ma non tanta quanta poteva aspettarsi in una l'egione vascolarizzata. Essa fa domata colla pressione senza alcun altro adiuvante . La ferita guarì pe r seconda intenzione ma il braccio rimase inutilizzato. Al ghazi fu immediata'mente tirata una fucilata. Il proiettile penet rò giusto dietro il gran trocantere sinistro eù uscl un pollice al disopra della spina destra del pube. L'articolazione co:xofemorale sinistra fu frantumata, l'intes•ino tenue fu perforato e questo unitamente all'omento protruse dalla. ferita
Oltre a ciò un po' di fango pen etrò nella cav1 tà addommale perché il ghazi dopo la ferita cadde a.l ed in questa posizione ricevette ancora pa r eccht tolp• d1 Mal trrado tutte queste ferile egli per molto tempo contmu ò a e a parl are con molta vivacità senza dar segni di sofferenza alcuna. Trent.asei ore dopo ea;li mor i in seguito a peritonite settica. Il colpo fu sparato con un fuci le Martini- Henry alla distanza di circa 13 metri.
JAcoor. - L& orantectomta nella mtcrooefalla. - (Brit. Med. Journ., 9 giugno 1894).
Il Jacobi (N. Y. Med. R ee. 19 maggio 1894) u.na stica di 33 casi iu cui fu eseguita la craniectom•a m md•vtdu• affett1 da idiozia o microcefalia. In tutti egli eseguì curala inchiesta sugli operatori, sulle condizioni prima dell'operazione, i risulta li e sulla opinione de• var1
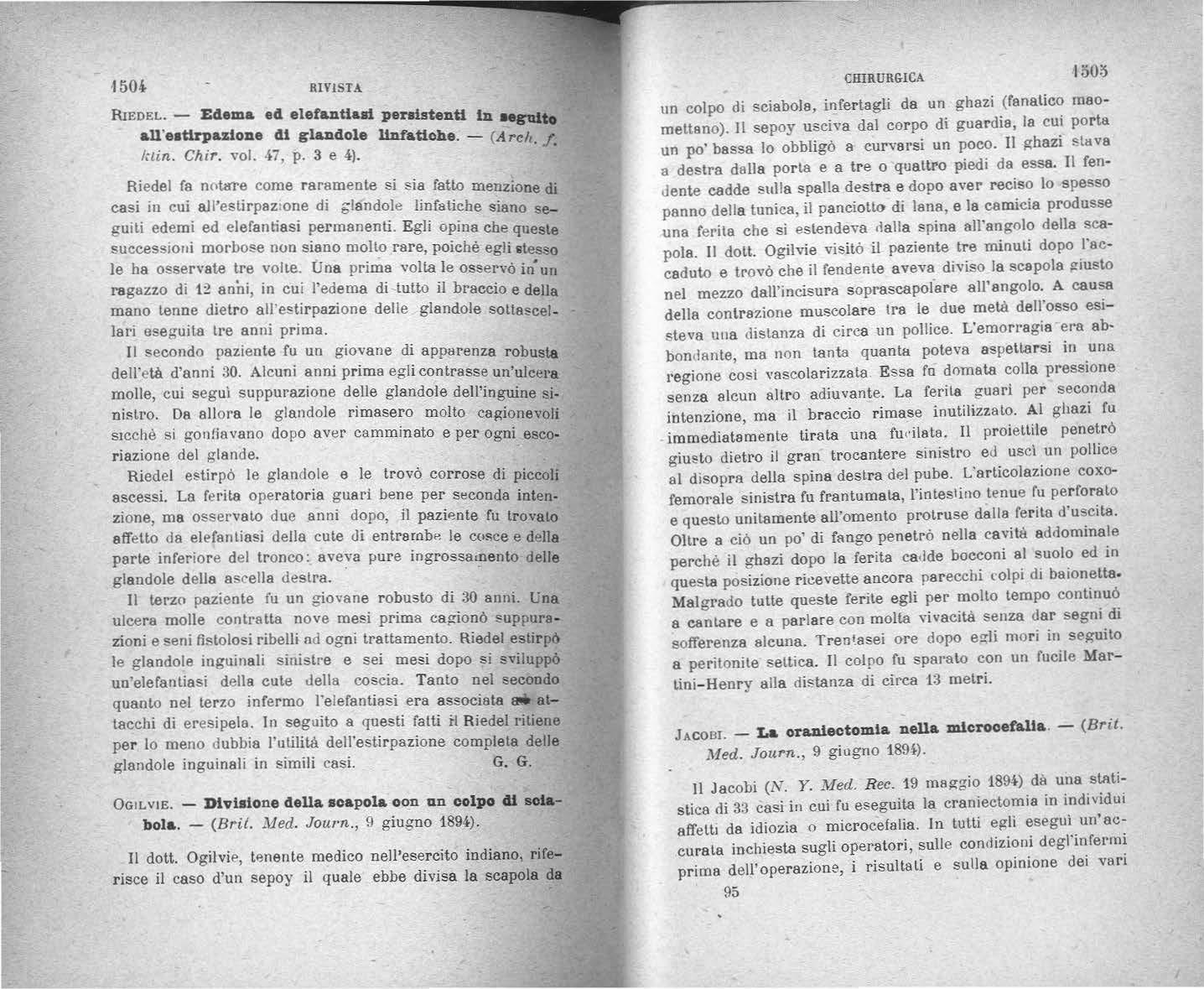
4506 Rivista Chirurgica
chirurghi circa il valore di quest' opet•a zìone. Nei 33 casi furon praticate -i t operazioni : 14 operati morirono, 19 guarirono . La morte avvenne per lo più subito dopo l'operazione in sei operati nel primo giorno. La causa d'essa non sempre fu dichiarata: in un caso essa fu dovuta all'anestesia Su alcun i <'pera ti la temperatura si elevò fortemente io modo inesplicabile anche quando la dura madre non fu lesa. Altri mo1·irono in seguito a shock poche ore dopo l'operazione. Il risultato finale fu il seguente: ignoto 1, nessun miglioramento 7, lieve miglioramento 7, qualche miglioramento 1, gran miglioramento 2, incerto 1. Il prof. Keen da una esperienza di 14 casi ha potuto constatare che la mortalità è molto elevata e il guadagno molto lieve. Il Wyetb, il quale ha eseguite 8 operazioni, dice che esse sono cosi pericolose che solamente possono esser giustificale quando esiste un alto grado di microcefalia e non dubbi segni di comp1·essione ce1·ebrale. Jacobi conferma l'opinione di Bournevìlle che la craniectomia può produrre eventualmente una rid!lzione e non già un ampliamento della capacita cranica. In un caso in cui la morte seguì alla seconda operazione, tutta la superficie inferiore della prima era inspessita da un tessuto di nuova formazione duro e resistente che comprimeva il cervello. In questo caso la morte avvenne 67 giorni 4opo l'operazione. Sulla q1.1istione quando l'operazione è giustificata, il Jacobi espr1me il parere essa può eseguirsi solamente nei casi di ossificazione prematura senza compi cazioni delle suture e delle fontanelle. In un caso tipico di questa specie lo sviluppo del bambino é no1·male tanto psichicampte quanto somaticaroente per i primi m esi della vita. La chiusura del cranio succede tra il 5° ed il 10o mese invece del 150 e il bambino di'·enla cosi proclive alle c<1nvulsioni che possono riu!'cir fatali, a contrazione delle e!'tremità e ad altri sintomi d' irritabilita. In molti di tali casi la tendenza alla ossificazione prematu ra può osservarsi anche in Altre ossa. Il bambino può slare nella posizione eretta precocemente e la mascella superiore specialmente affetta.
I denti possono nascer molto per tempo e nella mascella superiore per la prima.
G. G.
RIVISTA Dl OCULISTICA
JUteta.?iloni del corpo olllare dopo la puntura della o&mera. anteriore. -R. GREEF.- (Arch .fur Augenheilk. e Centralbl. fu r e m ed. W issensch. N. 1 i, 189i).
!ncontransi nell'occhio due specie di umore acqueo; la prima la normale, non contiene albumina né fibrina, e non è la seeonda, che producesi dopo la. della camera anteriore o una perforaztone co. tiene molta albumina e fibrina e si coagula subtto dopo l e· vacuazione in una gelatinosa; somiglia molto per le pr<'prietà e per la sua composizione al siero sangue. Da ciò d +>riva la conclu;:ione che dopo l!l d .e la ra pida sostituzione dell'umore net luoghi ID cui l'umore acqueo è separato si costitUiscono delle auor· mali condizioni per cui una materia, che prima sepa. dell'umore acqneo era trattenuta nella hnra, dopo raz101e . . · d. passa nPII'umore acqueo. Questa e strata dalla osservazione s.ub1lo che in un occhio è aperta la camera s1 formano in tutto il tE>rritorio del processo c1ilare g rosse vescic·he che avvenl!:ono pel sollevamen.to del rtveepiteliale del processo. le vesc1che $lanno delle masse coagulate, come più tardi dopo la puntura se ne tl"ovano nell'umnre acqu<>o. Le vesciche sono dalla COl"t'ente del liquido che si >'epara, la qua.le 11 vuotam",.nto è aumentata dalla pressione negativa eststente. nella camer11 ; finalmente le si aprono e versano ti loro contenuto nell'umore acqueo. La formazione della flbr.na .e la coagulazione _acqueo accadono pure perche.
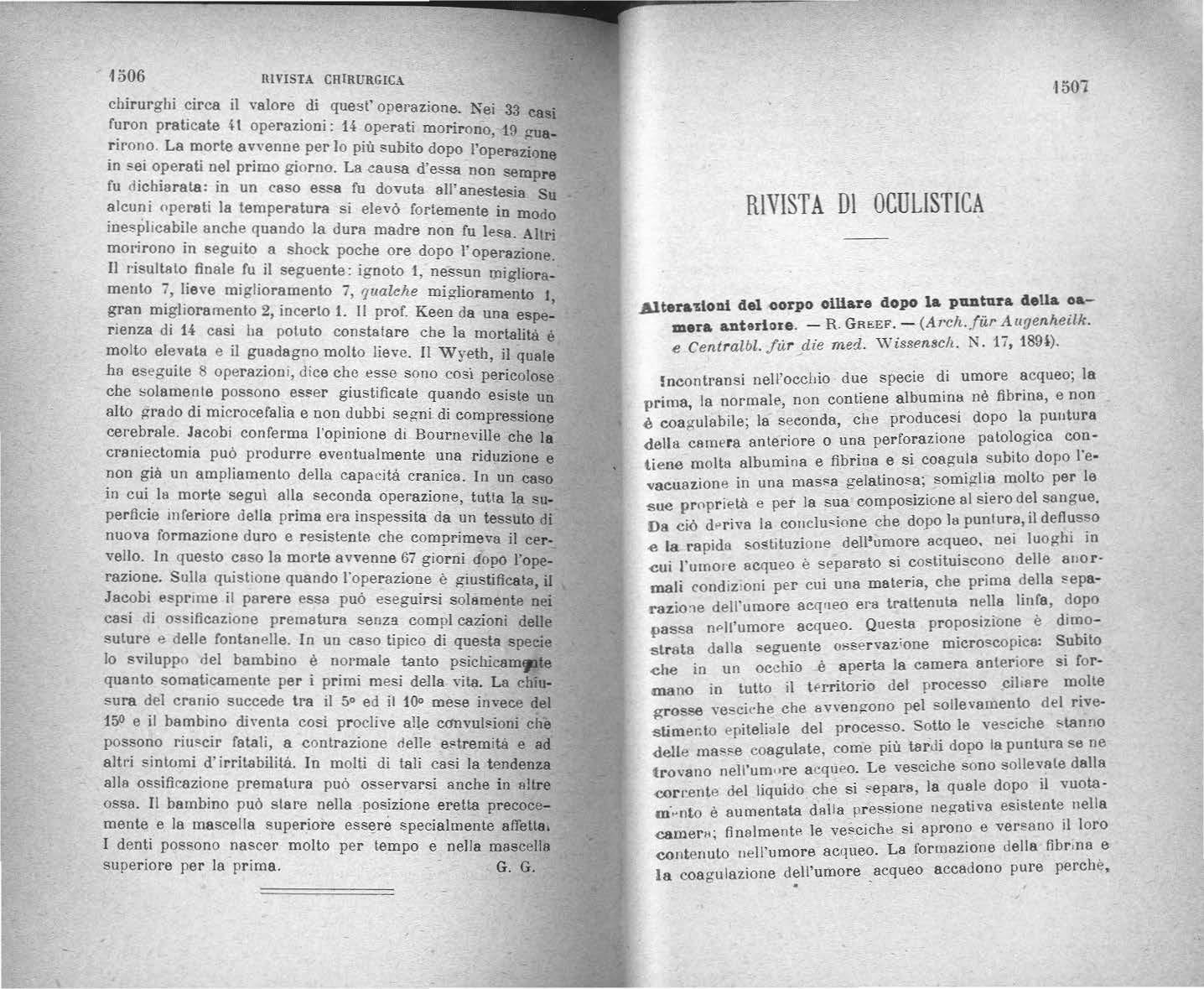
1508 RIVISTA DI OCULlSTICA dopo l'alterazione dell'epitelio nel luogo del! . . . a secrez1oll sono portali d1reltamente dal sangue nell'urno e re acqueo rn teriah albummoidi e i generatori della fìbr· h &t l . . ma, c e a e . e lO mtatto, sono da questi trattenuti. ' P•-










