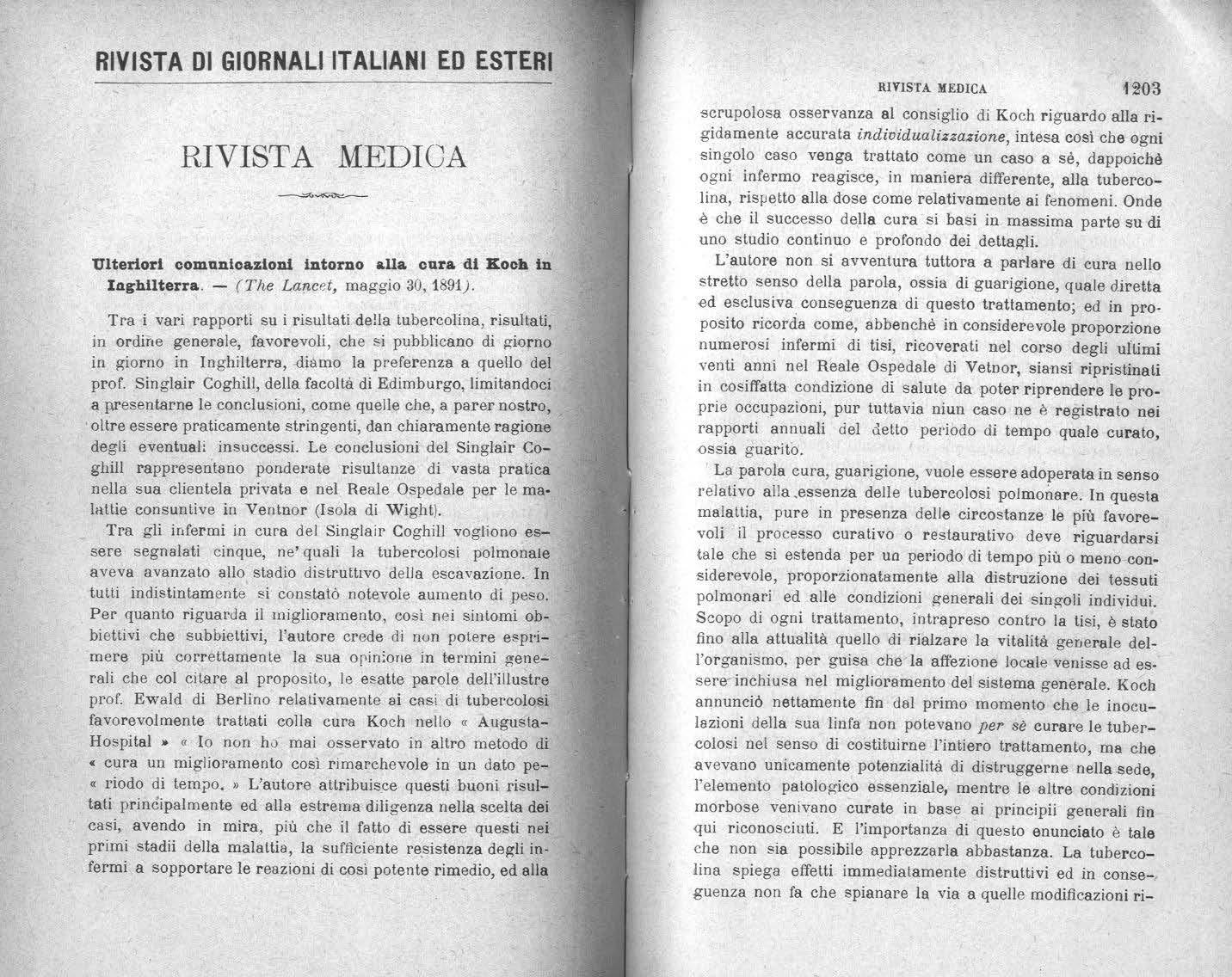
18 minute read
RIVISTA MEDICA
Ult e riori c omanl oazlonl i ntorn o alla cara d i Kooll in I4gh1lterra . - (The Lanc et, maggio 30, 1891).
Tra i vari rapporti su i risultati della tubercolina, risultati, in ordine generale, favorevoli , che si pubblicano di giorno in giorno in Inghilterra, -diamo la preferenza a quello del prof. Singlair CoghiJI, della facoltà di Edimburgo, limitandoci a nresentarne le conclusioni, come quelle che, a parer nostr o, oltre essere praticamente stringenti, dan chiaramente ragione degli eventuali insuccessi. Le conclusioni del Singlair Coghill rappresentano ponderate risultanze di vasta pratica nella sua clientela privata e nel Reale Ospedale per le ma• lattie consuntive in Ventnor (Isola di Wight).
Advertisement
Tra gli infermi in cura del Singlair Coghill vogliono essere segnalati cinque, ne' quali la tubercolosi polmonale aveva avanzalo allo stadio distruttivo della escavazione. I n tutti indistintamente si constatò notevole aumento di peso. Per quanto riguarda il miglioramento, così ne i sintomi obbiettivi che subbieltivi, l'autore crede di non potere e$pt·imere più correttamente la sua opin:orie in termini ~enerali che col citare al proposito, le esatte parole dell'illustre prof. Ewald di Berlino relativamente ai cAsi di tubercolosi favorevolmente trattati colla cura Koch nello « AugustaHospital » « lo non h0 mai osservato in altro metodo d i e cura un miglioramento così rimarchevole in un dato pe« riodo di lempo . » L'autore attribuisce questi buoni risultati prinéipalmente ed alla estrema diligenza nella scelta de i casi, avendo in m ira, più che il fatto di esser e questi nei primi stadii della malattia, la sufficiente resistenza degli infermi a sopportare le reazioni di cosi potente rimedio, ed all a scrupolosa osservanza al consiglio di Koch rig uardo alla rigidamente accurata individualizzazione, intesa così che ogni singolo caso venga trattato come un caso a sè, dappoichè ogni infermo reagisce, in maniera differente, alla tubercolina, rispetto alla dose come relativamente ai fenomeni. Onde è che il successo della cura si basi in massima parte su di uno studio continuo e profondo dei dettagli.
L'autore non si avventura tuttora a parlare di cura nello stretto senso della parola, ossia di guarigione, quale diretta ed esclusiva . conseguenza di questo trattamento; ed in proposito ricorda come, abbenchè in considerevole proporzione numerosi infermi di tisi, ricoverali nel corso degli uftimi venti anni nel Reale Ospedale di Veloor, siansi ripristinali in cosiffatta condizione di salute da poter riprendere le proprie occupazioni, pur tuttavia niun caso ne è registr ato nei rapporti annuali del detto periodo di tempo quale cu r ato, ossia guarito.
La parola cura, guarigione, vuole essere adoperata in senso relativo a lla .essenza delle tubercolosi polmonar e. In questa malattia, pure in presenza delle circostanze le più favorevoli il processo curativo o restaurativo deve riguardarsi tal e che si estenda per un periodo di tempo più o meno considerevole, p r oporzionatamente alla distruzione dei tessuti polmonari ed alle condizioni generali dei singoli individui. Scopo di ogni trattamento, intrapreso contro la tisi, è stato fino alla attualità quello di rialzare la vitalità ger,erale dell'organismo, per guisa che la affezione locale venisse ad essere-- in chi usa nel miglioramento del sistema gener ale. Koch a11nunciò nettamente fin dal primo momento che le inoculazioni della sua linfa non potevano per sè curare le tubercolosi nel senso di costituirne l'intiero trattamento, ma che avevano unicamente potenzialità di distruggerne nella sede, l'elemento patologico essenziale, mentre le altre condizioni morbose venivano curate in base ai principii generali fi n qui riconosciuti. E l'importanza di questo e nuncia lo è tale che non sia po~sibile apprezzarla abbastanza. La tuber colina spiega effetti immediatamente distruttivi ed in conseguenza non fa che spianal'e la via a quelle modificazioni ri-
1204- RIVISTA
costituenti, la cui azione sta nel restaurare i tessuti ipotrofici a que l grado di vitalità che li m etta in condizione di resistere all'a g ente in fettivo , al bacillo del tubercolo, a ppunlo in atto nello sviluppo della affezione specifica locale. La tubercolosi deve riguardarsi quale una malattia essenzialmente parassitica.
L'autore, di fronte ai favorev oli risultati da lui ottenuti, nella pratica dell' ospedale non meno che nella privata, in virtù della linfa Koch confessa d i. non sapersi spiegare gli insuccessi, e fino i disastri, eh~ da taluni le si attribuiscono, cosi che le esperienz e, riferite da Parigi e da altre città, siano a lui semplicemente inesplicabili. Potrebbe, per avventura essere il caso di una d ecomposizione della linfa iotalun/ elementi tossici. Egli stesso ha osservato come l'attività della tubercolina varii talvolta nelle diverse bottiglie.
Quanto al modus ope r-andi del rimedio l'autore è inclinato a credere che la distruzione del tessuto tubercolizzato, così come viene enunciato da Kocb, si d etermini per la accresciuta energia dei fagociti, eccitati dallo stimolo della tubercolina introdotta nel circolo. Siffatto modo di vedere è giustificato dal risveglio e dall'energia, quasi costanti e spesso i•imarchevoli dali alla nutrizione dalle inoculazioni, siccome è dimostrat; dall'aumento dell'appetito e del peso in molti casi, ne' quali e ra p recedentemente in campo completa anoressia.
L'autore concbiude coll'esprimere la sua ferma credenza che la scoperta di Koch risorgerà presto èal mom~ntaneo minore favore, nel quale é caduta per una sequela di circostanze singolarmen te disgraziate; che il valore suo terapeutico é unico. Ma avverte che debba venire adoprata con la dQvuta cautela e solto condizioni chiaramente a ccertate perché possa esser le riconosciuto l'inappr ezzabile valor e, che I~ spetia, quale parte essenziale del tra ttamento della tubercolosi polmonale. F. S.
Il colpo dl calore od insolazione (der Bltzsohlag), del do tt. A. HILLER, Slabsarzt a n.
li numero X dell e pubblicazioni falle per cura d el ripart,> medico del ministero della guerra prussiano s opra le storie c liniche e le necroscopie negli ospedali di presidio, redatto dal doll. A. Hiller, si riferi s ce a 20 casi di colpo di calore seguiti da morte stati curati nei detti . ospedali tra il 1° mag gio 1881 ed il 31 dicembre 1887; ed in vista dell'importanza medico militare del soggetto diamo un ampio sunto di q uesta inleressante memoria.

Tutti i 20 morti appartenevano alla fanteria o d all'artiglieria a piedi, i casi si verificarono tra il maggio e l'agosto cioè in maggio 4, in giugno 8, in luglio 5, in agosto 3; per lo più n elle ore antimeridiane tra le 10 ant. e l'una . pom., e solamente pochi casi nelle ore del pomeriggio, ne$suno avvenne p r ima delle 10 ant.
I. CAUSE DELLA MALATTIA.
A . Caus e che aumentano l' introduzione di calore nel corpo.
t. Aumento della produzione di calore per il lavoro muscolare. F atta astrazioM di un caso, pel quale non fu indicata la causa, in tutti gli altri avev& preceduto un lavoro muscolare, 18 volte una marcia collo zaino, ed una. volta il lavoro da contadino durante la mietitura.
A dimostrare l'influenza della fatica durante una marcia basta il fatto che il colpo di calore avvenne sempre soltanto al termine di essa.
2. Irradiazion~ solare. L'azione dei raggi solari è duplice: da un lato essi riscaldano immediatamente la pelle ed il sangue che circola in essa; da un altro lato, riscalda ndo gli abiti , diminuiscono la dispersione del calore.
Le parti superiori del corpo e specialmente la testa, il collo e le spalle sono le più colpite dal sole, si può quindi dire con fondamento che nelle marcie in e state ed a cielo sereno il capo é la parte del corpo che si risca lda maggiormente.
In ciò concordano pure i dati delle autopsie. Sopra 20 casi in 17 si trovò una congestione sanguigna al capo più o meno notevole specialmente alle meningi; ed in tre di essi era avvenuto un trasudamento tra le meningi ed il cervello, ed in un altro gli indizi di una incipiente meningite come nel colpo di sole (S onnenstich)
B. Cause che diminuiscono la dispersione del calore dal corpo.
1. Temperatura elevata dell'aria. Come si è già detlo tutti i 20 casi d'insolazione avvennero non solo nella stagione più calda, ma anche nelle ore più calde del giorno . In due casi, nei quali venne indicata la temperatura dell'aria, essa era di 20• e 20,5° R. In 17 casi raccolti da Iacubasch (Sonnestich und Hitzschlag, Berlin 1879) l'insolazione avvenne tra 19,2' e 24,4• R, e quindi con una t11mperatura che in estate non é straordinaria. Si deve da ciò conchiudere che la temperatura non è sempre la sola causa dell'msolazione come prima si credeva.
2. Maggiore umidità dell'aria . Le storie dei malati danno pochi ragguagli su questo punto; in parecchi casi si dice che l'aria era afosa e pesante In un caso l'umidi-tà relativa è indicata di 72 p. 100.
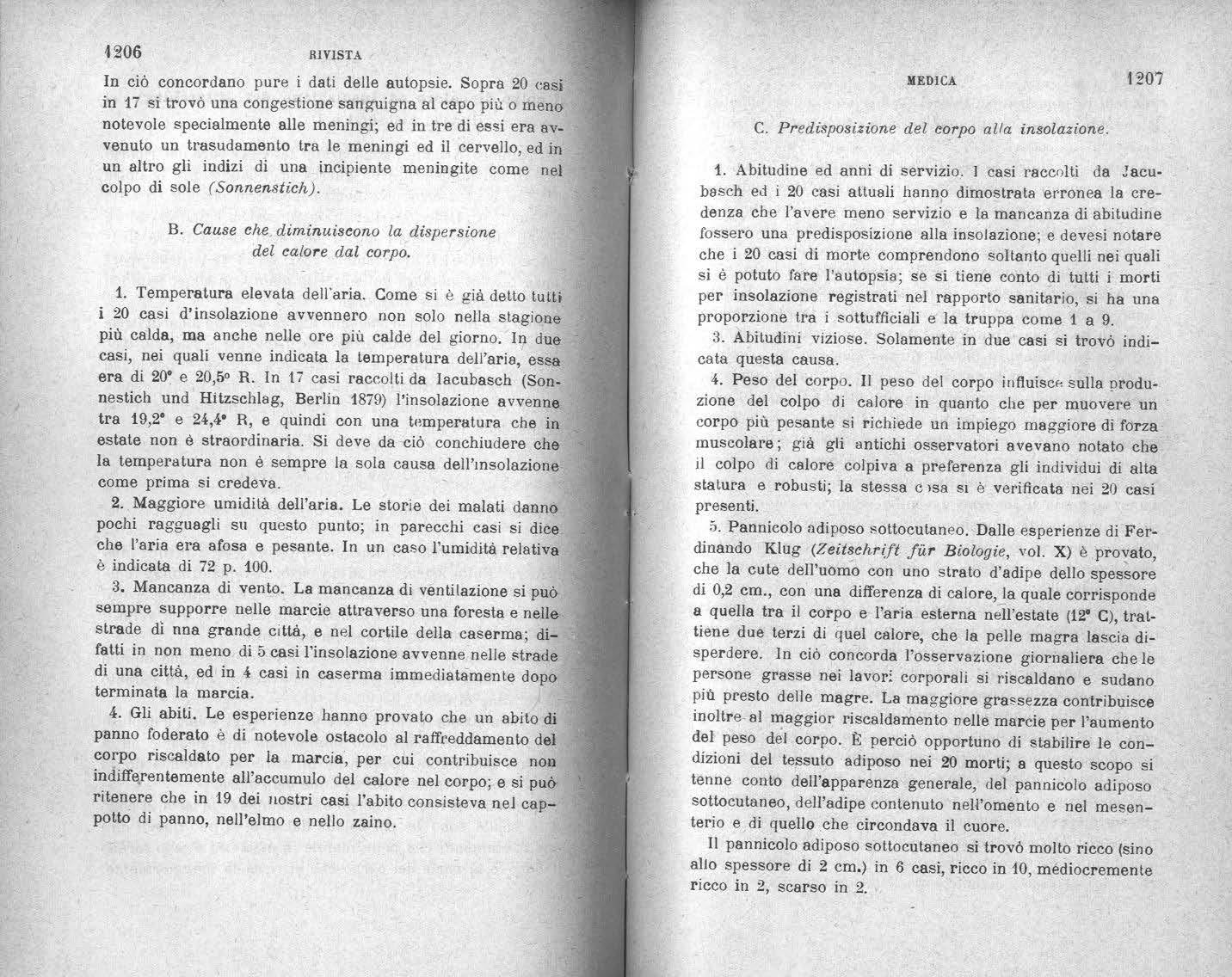
3, Mancanza di vento. La mancanza di ventilazione si può sempre supporre nelle marcie attraverso una foresta e nelle strade dì nna grande città, e nel corUle della caserma ; difatti in non meno di 5 casi l'insolazione avvenne nelle $lrade di una città, ed in 4 casi in caserma immediatàmente dopo terminata la marcia.
4. Gli abiti. Le esperienze hanno provato che un abito di panno foderato è di notevole ostacolo al raffreddamento del corpo riscaldato per la marcia, per cui contribuisce non indiff~rentemente all'accumulo del calore nel corpo; e si pu& ritenere che in 19 dei nostri casi l'abito consisteva nel cappotto di panno, nell'elmo e nello zaino.
MEDICA 1207
C. Predisposiz ione del corpo alla insolazione.
1. Abitudine ed anni di servizio. I casi raccQlti da Jacubasch ed i 20 casi atluali hanno dimostrata erron ea la credenza che l'avere meno servizio e la mancanza di abitudine fossero una predisposizione alla insolazione; e devesi notare che i 20 casi di morte comprendono soltanto quelli nei quali si è potuto fare l'a utopsia; se si tiene conto ~i tutti i morti per insolazione registrati nel rapporto sanitario, si ha una proporzione tra i sottufficiali e la truppa come 1 a 9.
3. Abitudini viziose. Solamente in due casi si trovò indicata questa causa.
4. Peso del corpo. I l peso del corpo influiscf, sulla produzione del colpo di calore in quanto che per muovere un corpo più pesante si richiede un impiego maggiore di forza muscolare; già gli antichi osservatori avevano notato che il colpo di calore colpiva a preferenza gli individui di alta statura e robusti; la stessa c >sa s1 è verificata nei 20 casi presenti.
5. Pannicolo ndiposo sottocutaneo . Dalle esperienze di Ferdinando Klug (Zeitschr(ft fur Biologie, voi. X) è provato, che la cute dell'uomo con uno strato d'adipe dello spessore di 0,2 cm., con una differenza di calore, la quale cbrrisponde a quella tra il corpo e l'aria esterna nell'estate (12' C), trattiene due terzi di quel calore, che la pelle magra lascia disperdere. In ciò concorda l'osservazione giornaliera che le persone grasse nei lavori corporali si riscaldano e sudano piu presto delle magre. La maggiore gra~sezza contribuisce inoltre al maggior riscaldamento nelle marcie per l'aumento del peso del corpo. ii: perciò opportuno di stabilire le condizioni del tessuto adiposo nei 20 morti; a questo scopo si tenne conto dell'apparenza generale, del pannicolo adiposo sottocutaneo, dell'adipe contenuto nell'omento e nel mesenterio e di quello che circondava il cuore.
11 pannicolo adiposo sottocutaneo si trovò molto ricco (sino allo spessore di 2 cm.) in 6 casi, ricco in 10, mediocremente ricco in 2, scarso in 2.
Rivista
Quindi in non meno di 16 casi si può rilP.nere una influenza del tessuto adiposo sottocutaneo nella produzione del colpo di calore. ·
Attorno al cuore si trovò (fatta ecce1ione di 5 casi pei quali mancavano indicazioni in propos ito) uno strato adiposo molto ricco in 3 casi, ricco in 6, moderato o lim.itato in 5, nullo in uno. Così nei primi 3 casi si può ritenere verosimile un impedimento al mag-izior lavoro richiesto dal cuorP, e nei secondi 6 questa causa non è da trascurarsi rlel lutto.
6. Alleraz:ioni morbose negli organi l'espirator ii. È noto come in chi porta un peso o sale un'altura la respirazione si fa più profonda e pi~ frequente fino a produrre l'affanno; contemporaneamente i movimenti del cuore si tanno mollo più frequPnti e le onde del polso più elevate. Secondo quanto insegna la fisiologia ciò dipende da che per il lavoro muscolare I' ori;ranismo consuma più o,:,.si1<eno e produce più acido carbonico, il quale ullimo, circolando col sangue, irrita ed eccita il centro nervoso dei movimenti respiratorii. Ne consegue che il lavoro muscolj:!re nelle marcie collo zaino aumenta il bisogno dei movimenti respiratorii e che se la funzionalità è menomata, ne viene pure cEminuito il ricambio dei gas nel pol.mone, cioè ne consegue un minore assorbimento di ossigeno nel sangue e l'aumento in esso di acido carbonico.
Ma la respirazione, durante la marcia, è ancora modificata in un altro modo, cioè per l'aumento della temperatura del corpo. Ackermann e Mertschinsky hanno dimostralo che negli animali, nei quali, mediante il riscaldamento della carotide, messtt allo scoperto. si fa arrivare al capo il sangue riscaldalo alla temperatura febbrile, si produce una modificazione particolare della respirazione, la così detta dispnea da calore, simile alla respirazione febbrile; gli atti respiratorii si fanno notevolmente accelerati e superficiali fino alla loro cessazione (apnea) con menomati sforzi respi ratorii. Questa dispnea f' es~enzialmenle diversa dalla sopradescritta da acido carbonico per ostacolo della respirazione, nella quale l'atto inspiratorio é poco accelerato ma notevolmente p r ofondo ed ;;ccompagnAto da visibi li !-'forzi dei muscoli rlella
Medica 4209
fa ccia, del collo e del torace. Tutte due queste forme respiratorie si trovano fra i sintomi del colpo di calore tanto separate, quanto unite insieme ocl a:vvicendantesi.
Mentre la dispnea da calore nell'insolazione si spiega senza difficoltà, i fenomeni non meno frequenti della dispnea da acido carbonico inducono a ricercare nei nostri 20 morti gli ostacoli alla 1·espirazione, tanto p;ù che generalmente fu attribuita una influenza essenzi ale sulla produzione del colpo di calore aUa alterazione nella composizione del sangue associata a questa dispnea. Difatti le ricerche fatte in questo senso nei r eperti .necroscopici hanno dato un risultato sorprendente.
In 15 dei 20 morti si trovarono alterazioni morbose degli organi respiratorii le quali possono considerarsi come d'imped imento allo scambio gasoso nei polmoni in una r espirazione forzata , e cioè:
12 volte aderenze dei polmoni colle pareli toraciche,
1 volta aderenza del diaframma col fegato,
1 volta indurimento interstiziale di ambedue gli apici polmonari (per bronchite),
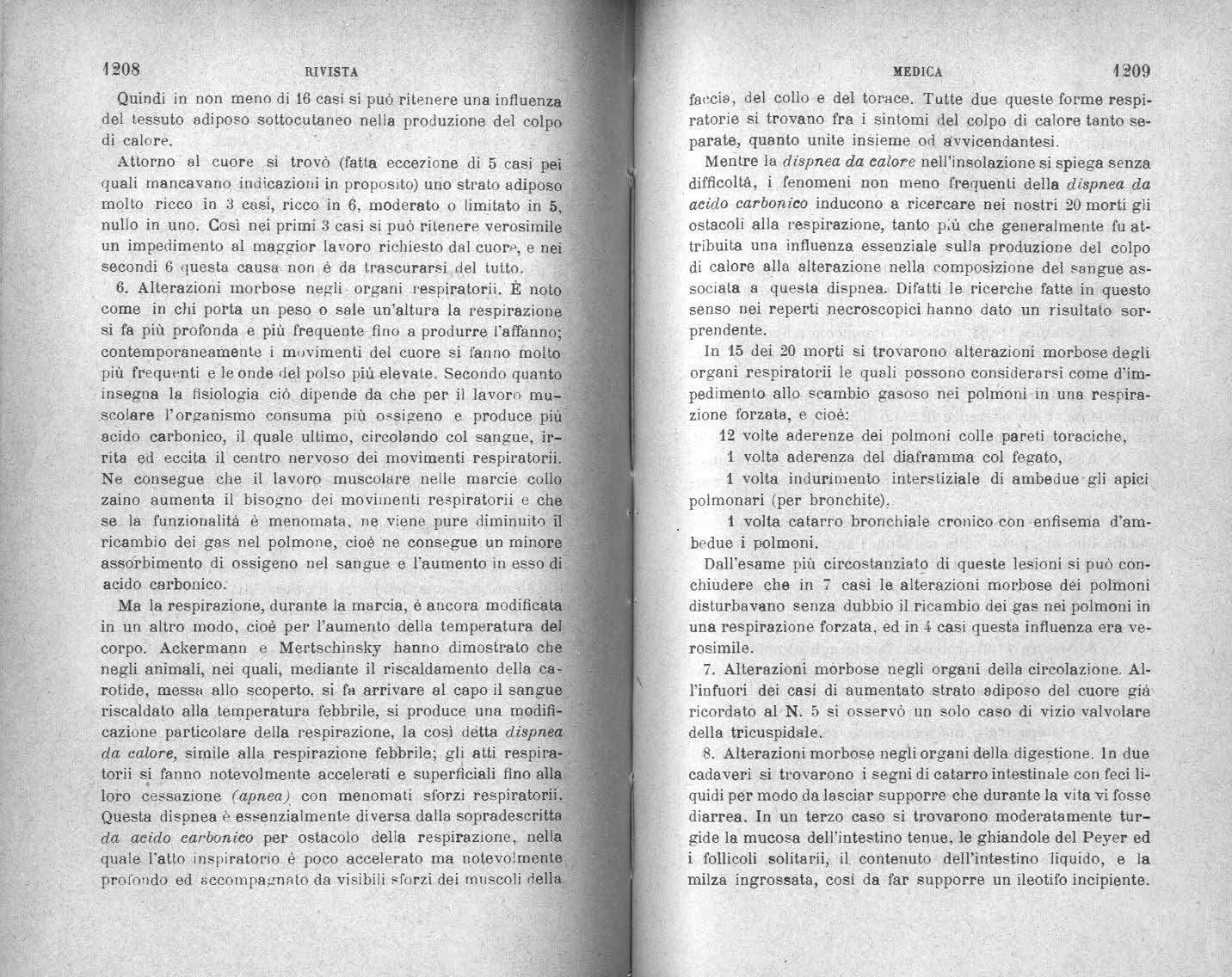
1 volta catarro bronchiale cronico con enfisema d'ambedue i polmoni.
Dall'esame più circostanzialo di queste lesioni si può conchiudere che in 7 casi le alterazioni morbose dei polmoni disturbava.no senza dubbio il ricambio dei gas nei polmoni in una respirazione forzata, ed in 4 casi questa influenza era verosimile.
7. Alterazioni mòrbose negli organi della circolazione. All'infuori dei casi di aumentato strato adipow del cuore gia ricordato al N. 5 si osservò un solo caso di vizio valvolare della tricuspidale.
8. Alterazioni morbose negli organi della digestione. In due cadaveri si trovarono i segni di catarro intestinale con feci liquidi per modo da lasciar supporre che durante la vita vi fosse diarrea. In un terzo caso si trovarono moderatamente turgide la mucosa dell'intestino tenue, le ghiandole del Peye r ed i follicoli solitarii, il contenuto dell'intestino liquido, e la milza ingrossata, così da far supporre un ileotifo incipiente.
RIVISTA
Considero.noni. - Le cause descritte in A e B, che innalzano la temperatura del corpo, sono comuni a lutti gli individui di truppa; ma il mo tivo per cui è sempre colpita dal!' insolazione solo una piccola parte di essi, e pochi ne muoiono, non può spiegarsi che colla predisposizione individuale. Non sarà quindi senza interesse di con frontare per ciascuno dei 20 morti le disposizioni fisiche alla malattia.
N. 1. Statura 1•,80, robusto.
N. 2. Statura t•,72, molto robusto. Pannicolo adiposo abbondante. Aderenza di tutto il polmone sinistro alla parete toracica. Catarro intestinale (ileo- Li!o incipiente).
N. 3. Statura 1m,68, robusto. Pannicolo adiposo abbondante. Aderenze sotto forma di briglie di ambedue i polmoni.
N. 4. Statura 1111 ,75, mollo robusto. Pannicolo adiposo abbondante. Fitte ader enze di Lutto il polmone destro al torace ed al diaframma.
N. 5 . Statura 1•,68. Pannicolo adiposo molto abbOndante. cuore molto ricco di adipe. Apici polmonari inspessiti e raggrinzati.
N. 6. Statura 1"',65, robusto. Era stato comandalo all a cucina fino al giorno della malattia. Pannicolo adiposo e cuscino adiposo del cuore mollo abbondanti. ·
N. 7. Robusto. Pannicolo adiposo e cuscino adiposo del cuore mediocremente abbondanti. Aderenze complete ed aponeurotiche dei polmoni.
N. 8. Statura 1m,6l, robusto. Dedito agli alcoolici da alcuni mesi. Pannicolo adiposo ricco , cuscino adiposo del cuore discretamente abbondante. Aderenze fitte del lobo polmonare superiore des tro.
N. 9. Statura 1•,64, mediocremente robusto. Pannicolo adiposo abbondante. Cuscino adiposo del cuore discreto. A· derenze fitte, aponeurotiche <li tutto il polmone destro.
N. 10. Statura 1m,60, robusto, molto corpulento. Cuscino adiposo del cuore abbondante. Aderenza Jel diaframma col fegato (individuo richiamato per l'istruzione).
N. 11. Statura 1•,60 1/ ., mediocremente robusto. Cute molto Lesa.
N. 12. Statura 1m ,69, robusto. Pannicolo adiposo abbondante (colpito dalla malattia mentre attendeva al lavoro della me8se).
N. 13. Statura 1•,67. Aderenze del lobo superiore del polmone destro.
N. H. Statura 1m,6-2. Catarro cr onico della laringe, della trachea e dei bronchi con enfisema polmonare. Catarro intestinale .
N. 15. Statura 1•,60. Polmone sinistro aderente posteriormente alle coste.
N. 16. Statura 1•,75, molto robusto. Pannicolo adiposo e cuscino adiposo del cuore molto abbondanti. Aderenze fitte dei ìobi superiore e medio del polmone destro Dedito agli alcoolici.
N. 17. Statura 1• ,62, molto robusto. Pannicolo adiposo abbondante. Cuore abbondantemente ricoperto di adipe, vizio valvolare. Aderenze all'apice del polmone destro (sottufficiale richiamato per l'istruzione).
N, 18. Statura 1m,69, robusto. Pannicolo adiposo molto abbondante. Aderenze laterali del polmone sinistro e del lobo inferiore destro.
N. 19. Statura 1m,68, robusto. Pannicolo adiposo e cuscino adiposo del cuore straordinariamente abbondante. A· derenze isolate del polmone destro.
N. 20. Statura 1•,60, robusto. Pannicolo adiposo ben sviluppato. Diarrea.
Il. SINTOMI DELLA \f AL-l TTIA. A. Prodromi.
Si trovano indicati solamente in due casi. li primo si lamentò di stringimento al capo e cominciò subilo a barcollare. Nel secondo caso ha precedulo un vaneggiamento. In tutti gli altri casi la malattia insorse repentinamente senza che i circostanti se ne a ccorgessero. ,
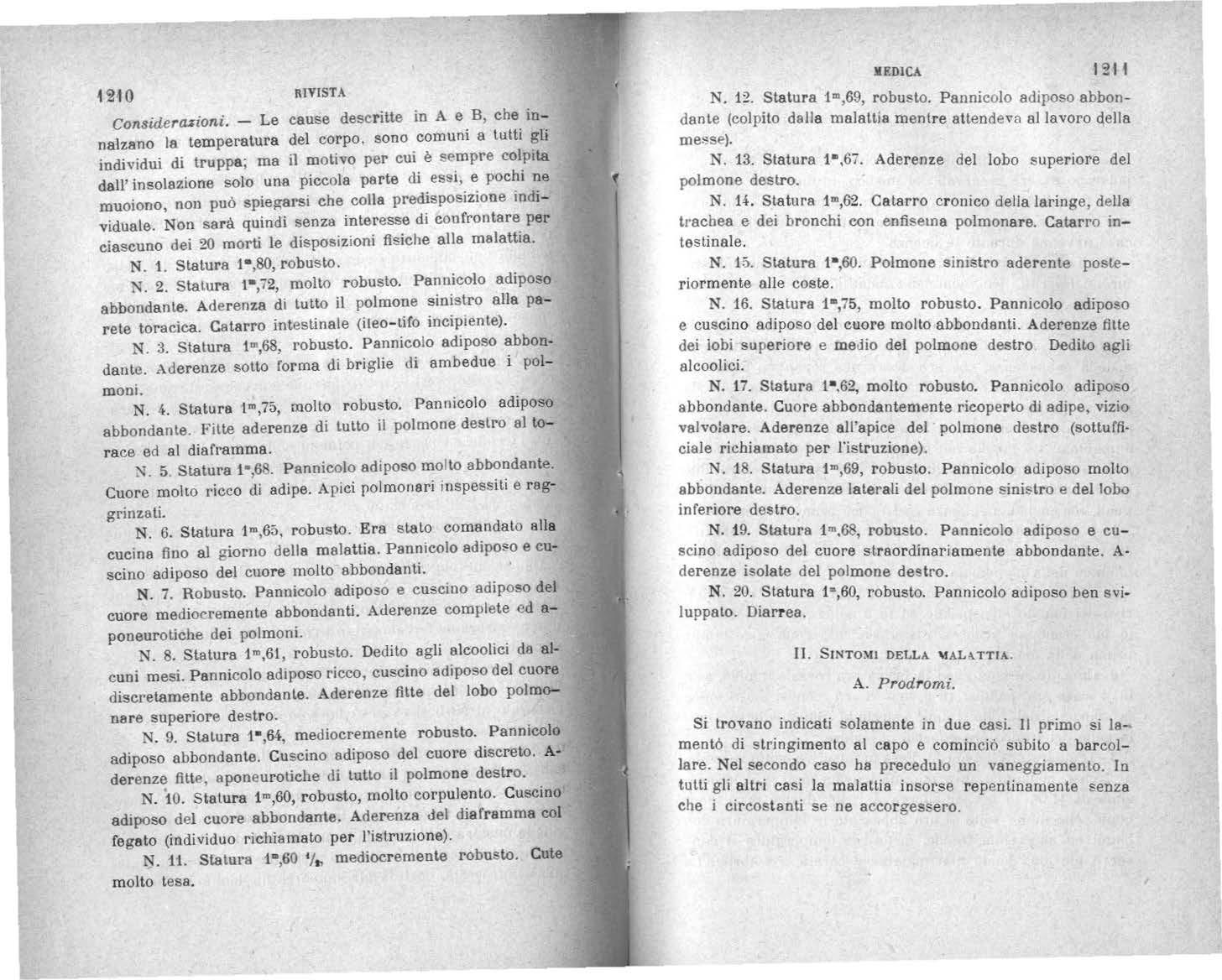
Medica 1213
B Sintomi proprii della malattia.
Io 3 casi il corso fu cosi rapido, che i sintomi morbosi non poterono essere osservali <lai medico, in due altri <!asi, nei quali il medico militare non giunse io tempo, si può supporre che la morte fu pronta, cioè nella prima ora; finalmente un caso avvenne durante la licenza.
Negli altri 14 casi, che furono curati in un ospedale militare, furono descritti i fenomeni della malattia, che si possono rias-. sumere cosi:
1. Condizioni gene:-ali (sistema nervoso). In tutti i 14 casi il primo e più importante sintomo fu la perdita delle forze e della conoscenza, che produceva una repentina caduta.
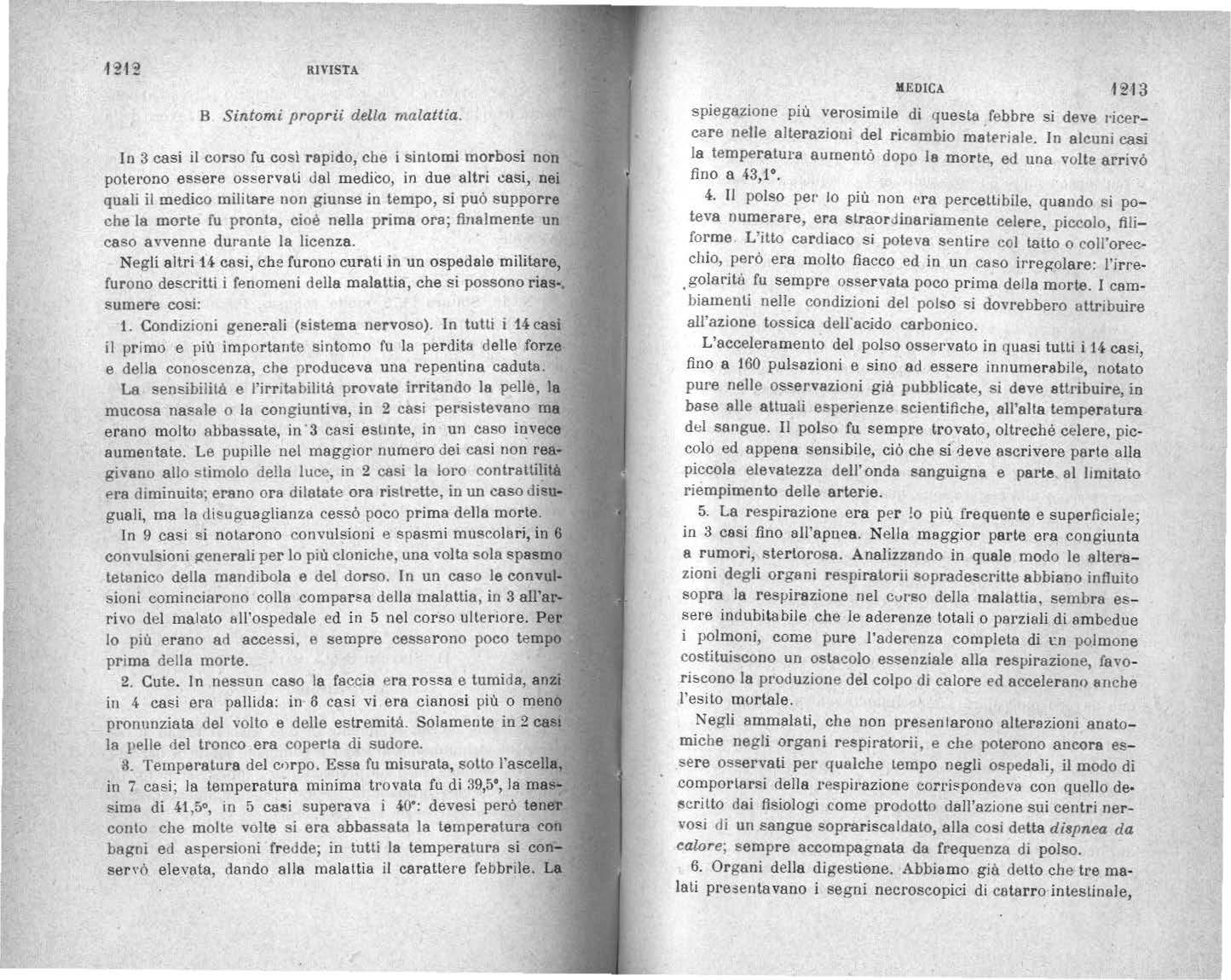
La sensibilità e l'irritabilità provate irritando la pelle, la mucosa nasale o la congiuntiva, io 2 casi persistevano ma erano molto abbassale, in ·3 casi estinte, in un caso invece aumentate. Le pupille nel maggior numero dei casi non reagivano allo stimolo della luce, in 2 casi la loro contrallilità era diminuita; erano ora dilatate ora ristrette, in un caso disuguali, ma la disuguaglianza cessò poco prima della morte. In 9 casi si notarono convulsioni e spasmi musr.olari, in 6 convulsioni generali per lo più cloniche, una volta sola spasmo tetanico della mandibola e del dorso. I n un caso le convulsioni cominciarono colla compar,:a della malattia, in 3 all'arrivo del malato all'ospedale ed in 5 nel corso ulleriore. Per lo più erano ad accessi, e sempre cessarono poco tempo prima della morte.
2. Cute. In nessun caso la faccia era rossa e tumida, anzi in 4 casi era pallida: in 8 casi vi era cianosi più o meno pronunziata del volto e delle estremità. Solsmeote in 2 casi la pelle del tronco era coperla di sudore.
3. Temperatura del c•>rpo. Essa fu misurata, sotto l'ascella, in 7 casi; la temperatura minima trovata fu di 39,5°, la massima di 41,50, in 5 casi superava i 40°: devesi però tener conio che molte volle si era abbassata la temperatura con bagni ed aspersioni fredde; in tutti la temperatura s i conser"ò elevata, dando alla malattia il carattere febbril e. La spiegazione più verosimile di questa febbre si deve 1-icercare nelle alterazioni del ricambio materiale. In alcuni casi la temperatura aumentò dopo la morte, ed una volte arrivò fino a 43,1°.
4. Il polso per lo più non na percettibile, quando si poteva numerare, era straordinariamente celere, piccolo filiforme L'illo cardiaco si poteva sentire col tallo o col/orecchio, però era molto fiacco ed in un caso irregolare: l'irre_golarità fu sempre osservata poco prima della morte. I cambiamenti nelle condizioni del polso si dovrebbero ttltr1buire all'azione tossica delracido carbonico.
L'acceleramento del polso osservalo in quasi tutti i 14 casi, fino a 160 pulsazioni e sino ad essere innumerabile, notato pure nelle osservazioni giA pubblicate, si deve attribuire, io base alle attuali esperienze scientifiche, all'alta temper atura dt:I sangue. Il polso fu sempre trovato, ollrechè celere, piccolo ed appena sensibile, ciò che si deve ascrivere pa rte alla piccola elevatezza dell'onda sanguigna e parte al limitato riempimento delle arterie.
5. La respirazione era per !o più frequente e superficiale; in 3 casi fino all'apnea. N ella maggior parte era congiunt-a a rumori, stertorosa. Analizzando io quale modo le alterazioni degli organi respiralorii sopradescrilte abbiano influito sopra la respirazione nel cv1·so della malattia, sembra essere indubitabile che le aderenze totali o parziali di ambedue i polmoni, come pure l'aderenza completa di rn polmone costituiscono un ostacolo essenziale alla respirazione, favoriE>cono la produzione del colpo di calore ed accelerano anche l'esito mortale.
Negli ammalali, che non presenlarono alterazioni anatomiche negli organi respiratorii, e che poterono ancora essere osservati per qualche lempo negli ospedali, il modo di comportarsi della respirazione corri$pondeva con quello de, 15crilto dai fisiologi come prodotto dall'azione sui centri nervosi <.li un sangue soprariscaldato, alla cosi detta dispnea da ca/,ore; sempre accompagnata da frequenza di polso.
6. Organi della digesli0ne. Abbiamo già dello che tre malati preaenta vano i segni necroscopici di cata rro intestinale,
Medica
12H, RIVISTA
2 coo diarrea ed uno con sospetto di incipiente ileotifo, nel primo di q uesti malati si ebbe emissione involontaria dì feci liquide, nel :,,:econdo vomito frequente, nel terzo ventre gonfio e più tardi vomito ed emissione di feci liquide con odore di putrefazione.
Il vomito si trova indicato in otto maiali, il più delle volte comparve tardi, anzi poco prima della mo1-te. Verosimilmente esso si deve attribuire alla irritazione del cervello nello stesso modo -.che le convulsioni e gli spasmi mu- . scolari.
Considerazioni. - Come sintomi morbosi proprii del colpo di calore sono da annoverarsi i seguenti: perdita della coscienza, deliquio, cian~si, temperatura elevala del cor po, mancanza del polso, mancanza della respi"razione, o respirazione molto frequente, convulsioni e spasmi mu:scolari, più tardi vomito. È questa l'immagine della asfissia (eccettuata l'alta temperatura ), come si mostra in qualunque specie di soffocazione, tanto da insufficiente introduzione di ossigeno per ostacolo alla respirazione, quanto da respirazione in ari a povera di ossigeno.
La mancanza d'ossigeno nel sangue può ancora dipeade re dalla diminuita capacita dei globuli rossi di fissarlo. Di queste 3 cause di asfissia n~l colpo di calore si deve escludere la seconda (respirazione in aria povera di ossigeno): le altre due all' incontro trovano sufficiente spiegazione nelle presenti , 20 osservazioni.
· In 9 casi fu constatato anatomicamente un impedimento all a respirazione: in essi se il bisogno di ossigeno era aumentalo (lavor o muscolare) l'impedimento veniva compensat o da una respirazione più profonda e fo r zata.

Ma se -la forza muscolare per ciò necessar ia viene per qualche motivo diminuita (sforzi eccessivi, debolezza generale, mancanza di esercizio), oppure se per causa centr ale dovuta ali' elevata temperatura del sangue (dispnea da calore) la r espirazione si fa superficiale, è chiaro che l'introduzione d'ossigeno nei polmoni diventa insufficiente; insufficienza cbe viene favorita dal rallentamento del circolo sanguigno nei polmoni per indebolito impulso del cuore. Anche il no- tevole aumento nella frequenza del polso, dovuto parimenti all'alta temp eratura del sangue, é già di per se solo causa di impedimento nel corso e nella distribuzione del sangue. Ma anche quando non esista un ostacolo anatomico visibile alla respirazione si può supporre che la notevole freq uenza e superficie.lita della respirazione in seguito alla elevata temperatura del sangue (dispnea da calore) che può giungere fino all'apnea, insieme al contemporaneo indebolimento dell'impulso cardiaco, può produrre un impoverimento d'ossigeno nel san g ue più o meno rapido, ed un relativo aumento di acido carbonico.
Circa la seconda causa dell'asfissia, cioé la diminuita capacita del sangue di assorbire ossigeno, esiste già presentemente una serie di esperienze cbe provano una diminuzione di quésta capacita nella temperatura elevata del sangue come avviene nel colpo di calore.
Se noi raccogliamo ancora una volta le cause dell'asfissia, che caratter izza la forma morbosa del colpo d1 calore, noi yeniamo al risultato che un impedimento al ricambio gasoso dei polmoni deve essere consider ato come la causa essenziale di tutti i casi di colpo di calore. Questo impedimento é in parte meccanico, e cioè in un numero di casi prodotto da ostacolo anatomicamente constatabile, ed in un altro numero di essi dovuta ali' accelerarsi e rendersi super ficiale della respirazione fino alla sua sospensione in seguito alla alta temper atura del san g ue (dispnea da calo r e), sempre congiun ta còn disturbi della circolazione (acceleramento del polso sino alla sua sospensione, debolezza del cuore). D'altra parte l'ostacolo al l'icambio gasoso polmonare probabilmente nel maggior numero dei casi, è nello stesso tempo anche chimico, in quantochè, stando alle nostre cognizioni attuali, con una temperatura elt>vata del sangue diminuita la proprietà dei globuli rossi di fissare l'ossigeno.
C. Corso ed esito.
Nei casi che non terminavano subito colla morte, si aveva ordinariamente medianle la cura intrapresa un leggiero e transitorio migliorRmento, in quanto che il polso e la respirazione si sollevavano alquanto: però lo stordimento, la cianosi e la temperatura elevata del corpv rimaneva110 quasi invariati. In molli casi nell'ulteriore decorso comparivano contrazioni muscolari , le quali però cessavano sempre col cominciare del periodo agonico. Sopravveniva allora perdita completa del senso e del moto, e la morte coi fenomeni di una paralisi centrale. In alcuni casi la paralisi era preceduta da fenomeni di irritazione, delirio, vom;to, spasmi muscolari. ln 5 casi l'edema polmonare fu indicato come causa propria dellH morte, od almeno come causa concomitante ed acceleratrice; in :3 di questi casi esistevano aderenze polmonar i.










