
20 minute read
1460 STUDIO ETIOLOGICO .E CI.INICO
~el periodo d'invasio ne della febbre possono anche moslrarsi nausea e vomiLo di sast1 n1.e alimentari non digerite: queslo dilfi cil mente si ripresenta durante il decorso della malattia.
La lingu a è umida, coperta da una patina biancastra non molto spessa, arrossita ai margini e alla punta, ma non sempre. L'addome è cedevole, piuttosto depresso; non vi è noLevole meteorismo. Sollo la palpazione non si risvegliano dolori lo· calizzati, anzi spesso si cal mano quelli che ~ià spontaneamente si sentivano. Si avvertono Lalvolta borborigmi e gorrrorrlio nella fossa ileo-cecale. Spesso accade di palpare ca l- o I') coli fecali, e di constatare con la percussione una dilatazione dello stomaco, non mollo pronuoz:ata.
Advertisement
Non si ha mai, per effetto di queste febbri, un notevole tumore di milza, come riscontrasi in Lulte le infezioni acute; tullavia spesso si nota che l'ottusità splenica va leggermente aumentando verso l'acme della malallia, ma non si da superare di molto l'ascellare media nel suo limite anteriore , nè la 9• costola superiormente, nè molto meno il bordo costale in feriormente. Questo leggiero ingrandimento della milu, nei casi in cui si nota, va poi gradatamente scomparendo co l cessare della febbre: a quanto pare, esso sta in rapporto con la stasi fecale.
Piu notevol i sono le variazioni dell'aia epatica, inquantochè, sopra;tutto nei casi d'intensa coprostasi, essa mostr asi a bbastanza ingrandita, massime nell'ala grande, che talvol ta de· borda perfino di 5 centimetri.
Le feci sono dure, d' un colorito bruno più o meno oscuro, spesso circondate da muco, che può presentare anche qualche piccola striatura di sangue. I risultati dell'esame microscopico e batteriologico sono stati già indicati nell'elioJogia.
L'esame dei reni nulla fa rilevare di notevole. La quantità giornaliera dell'urina solo di rado scende in sotto _di 900 g_r., per lo più mantiensi fra 1200 e 1,i.OO gr. La reazr~ne è acr~a iù O meno pronunziata. Il peso specifico molto dr rado drpcende in sotto di '10·1O o sale in sopra di 103,i., d'ordinario s f . roantiensi sempre fra i 10115 e i 1025. Il colorito varia ra , N. 2, 3, ,i. e 5 della tavola di Yo~el. ~folla di notevole presenta l'esamedei sedi menti , che talvolta nell 'acm e della febbre si depositano sotto forma di polvere rosso-manone (urati). Cosi neanche alcun dato speciale si rileva dall'analisi dei pigmenti. I cloruri e i solfati per lo più predominano durante il periodo febbrile, mentre il fosfato di calce è in difetto. Di elementi eterooenei solo in due casi ho riscontralo il 0,5 p. 1000 o di albu mina, ma per 1 al massimo due ~ioroi; nell'un caso s1 era presentato un intenso di~turbo circolatorio, nell'altro not:::vansi edemi alle pal pebre inferiori, che beli presto scomparvero. L'esame microscopi co e la ricerca bat~eriologica nienle dimostrano di ,speciale.
Fra le secrezioni i sudori non si pronunziano mai notevolmente, a causa forse della loro rapida evaporazione. Spesso si nota la tinta itterica delle sclerotiche, mai però molto intensa, e del resto essa è frequente· ad osservarsi anche nei sani: la pr~senza dei pigmenti della bile nelle ur ine indica sempre una diffusione di catarro alle vie biliari .
Qiiadro generale di queste febbri. ·- A pa r te i leggieri e transitori stati febbrili, indicati in principio della sintomatologia , le febbri da raffreddore o febbri comuni continue sono ca ratterizzate da una rapida viol.:inta invasione, che spesso ragoiu nge e sor passa i ,i.0° C., senza prodromi, senza brivido in;enso; durano con Linµe, con Iievi r emissioni per lo più mattin ali al massimo per 3 giorni, e terminano per crisi . Si accompagnano spesso a leooier i disturbi locali. i;ome erpete labiale o diffuso ~o r . a tutta la faccia (febbre erpetica), leggi ero catarro alle aucr o al naso (febb re catarrale ), sensazi oni dolorose molto intense ai bulbi oculari e alle articolazioni (febbri reumatiche), le"gieri disturbi gastrici o intestinali ({ebbri gastriche). Sopra~tutto queste ultim e due lievi compli canze, o isolatamente ovvero concordemente in grado più elevato, forse in dipendenza dell'alta temperatura a mbiente, possono aggravare e prolungare il decorso di q ueste febbri perfin o oltre il 9° giorno, nel q ual caso può presentarsi anche una quasi intermittenza, ma di brevissima durata. Maggiore gravezza può venirne per fatti riflessi sul cuore dalla presenza di elminti intestinali, che si r_iscontrano fre quenti volte. Guadagnata la convalescenza. perlievi di sturbi dietetici o pel ripetersi di cause perfrigeranti ovvero per avere troppo presto abbandonato il letto stan ca ndo la persona con fatiche mu scola ri o intellettuali, queste feb bri pos sono r ipetersi a brevi intervalli difficilmente con la stessa violenza del primo attacco , in modo da simulare una febbre intermittente atipica. I fenome ni ner vosi, che acco mpagnano ~ueste fe~bri, si riducono alla cefalalgia fron tale più O meno mten sa, a1 dolori negli arti , nei lombi, nei bulbi ocula r i e an_che i~ altri siti, ai disturbi d'innervazione cardiaca, per azione nflessa, che per ·altro non sono frequenti. La milza pu~ mostrarsi lievemente· ingrandita nell'acme de)la febbre, mai notevolmente. Invece più frequente e notevole può presentars i l'ingrandim ento del fegato in r apporto coll 'atonia intestinal e, coprostasi, che solo eccezionalmente non si riscontra : Nessun 'al terazione renale, o speciale delle urine, tranne 11 caso rarissimo di qualche tracc ia di a llmmina.
Di~gn ~si . - Se pur troppo spesso non è possibile pronunz1ars1 sulla diagnosi, prima che la febbre non assolva il s.uo _deco_rso, non è men vero che, tranne in presenza di quei l~e~1 s~a t1 _ s~bfebbrili , i quali potrebbero far crede re al pri nc1p10 10 s1d1oso d'u na febbre tifoidea, in tutti gli altri casi
DELLE MALATTIE FEBBRILI PIÙ CO)IUNI A MASSAUA 1463 pos~ono escludersi fin dal principio coi;ì il tifo come tutte le febbri co::.iddette flogistiche locali zzale (pulmonite, pleurite, angina e,~c.)
Se la febb re è accompagnata da erpete mollo diffuso, potrà la malattia portare all 'idea di un a febbre eruttiva, ma la mancanza di a ltri fa tti concomitanti, qua li lacrimazion e, fotofobia, angina, ecc . ; il modo di !)ronunziarsi dell'esamema, la sua diffusione, il suo aspetto, che lo svela hen tosto come una er11zione erpetica, sono altrettante buone ragioni che obbligano per lo meno ad esser ca uti nel pronu nziarsi, mentre il decorso della febbre farà escludere completamente la diagnosi di morbo eruttivo.
Da ultimo anche il fatto che Massaua non può ritenersi sede d'i nfezio ne malarica, per ragioni che risultano dall 'i nsieme di questi miei stud i e che riassumerò in ultimo, potrà allontanare il sospetto che s'abbia a trattare di una febbre miasmatica, al che co ncorrono anche l' assenza del tumore di milza ,d egli ematozoi specific i, nonché la nessuna efficacia del chin ino.
La ricorrenza, diciamo epidemica, diviene inoltre un buon dato da mettersi a profi tto nel formulare la diagno si.
Prognosi. - Favorevole.
('onwlescenza . -- Un po' lunga: l'infermo non può riprendere i suoi abituali lavori fisici o intellettuali, se non dopo alcu ni gio rni , e a grado a grado .
Profilas;i . - Dacchè l'ig ien e privata è stata meglio conosciuta e più osservata, i casi di queste febb ri sono di gran lunga scemati, e in generale si sono mostrati sotto una forma più mite.
Nelle attua li incertezze in co i tuttora resta avvolta la quistione etiologica, le indicazioni profilattiche non possono uscire da ciò che la pratica ne ha insegnato.
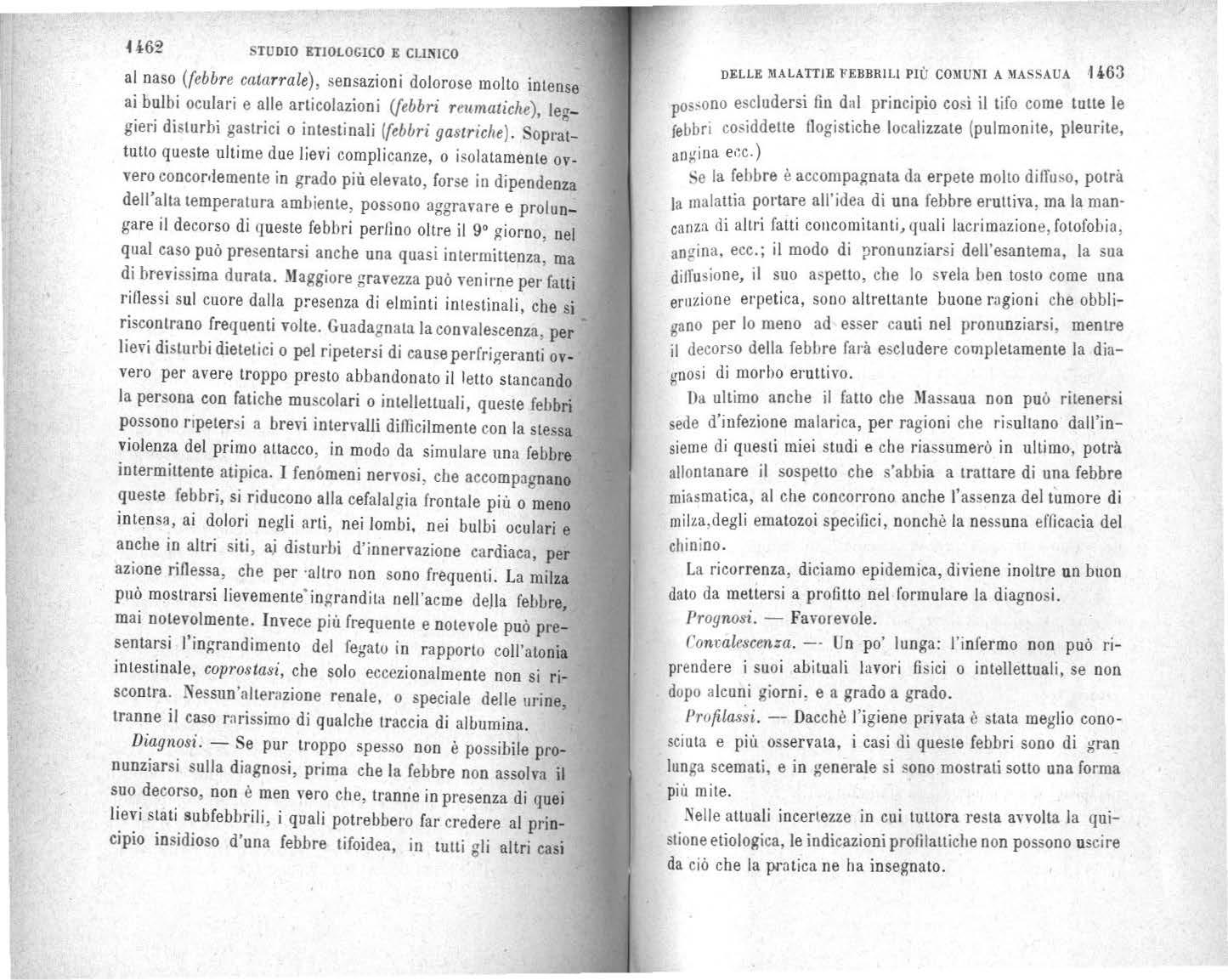
U~ p~i~o ?roblema a risolver~ sta certamente nella scelta degl 1nd1v'.dm da de.,tinarsi a Massaua: in ciò è uopo dare la maggiore 1_rnpo~tanza _alle conòizioni dell ' apparecchio digerente. Cosi tutti quelh che hann o sofferto catarro di sto ,. . , maco o dell intestino e non ne siano compl erarnente "nariti O h n , c e mostrino grande disposizione alle ricadute, in breve tutti quell i ch_e ~offrono di disturbi digestivi, dovrebbero essere risp'lrm1at1 a quella destinazione ; imperocchè, se pure questi sfu _ gono alle febbri, ed è ciò molto raro a verificarsi, diffict mente saranno risparmiati &.i catarri cronici dell'intestino 0 dello stomaco, che li obbligheranno più o meno sollecitamente iii rimpatrio , con non lieve dispendio dell'erario, e con ness un guadagno nè pel servizio nè per la propria salute.
In generale è uopo tener presente che il clima di iUassa ua favorisce le affezioni croniche delle mucose.
Come un bagno caldo o a vapore, mal fatto, può aggrava re un r~um~tismo. o riacutizzarlo, così il cl ima di Massaua, può favorire il manrfestarsi delle affezion,i reumatiche, ove no n si osservino tutti quei precetti igienici, cui da noi si <la una gra~{ie importanza , e cola si tenderebbe a non darne al cuna.
L'osservanza di questi precetti permetterebbe anche, fin o ad un certo punto, di trarre partito dalle condizioni clima tic he di Massaua per la cura di determinate affezio ni, qual i in "8· nerale i reumatismi cronici, le dermatiti croniche,i sifilode~i tardivi ecc.
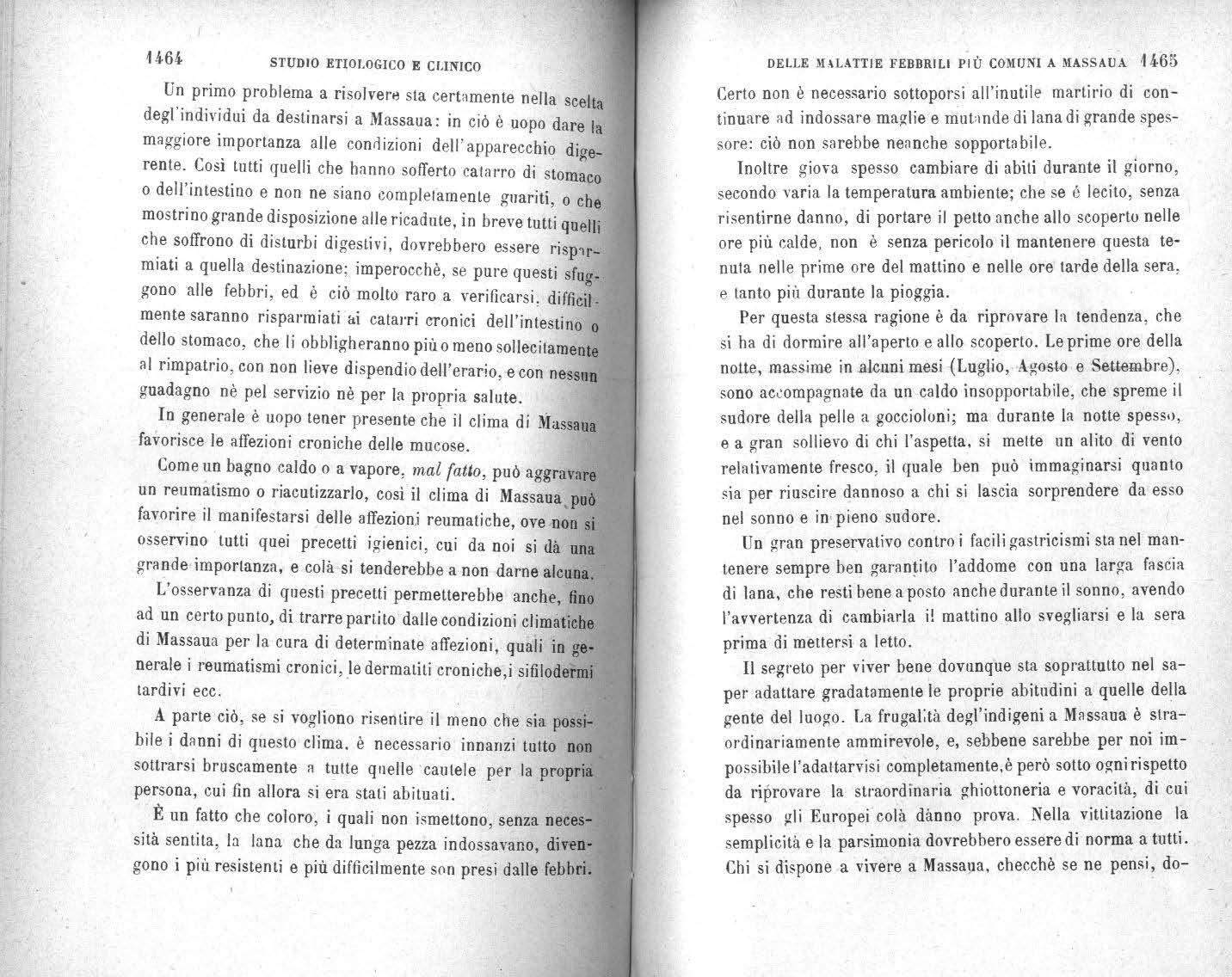
A parte ciò, se si vogliono risentire il ~eno che sia poss ibile i danni di questo clima. è necessario innanzi tutto non sottrarsi bruscamente ::i tutte qnelle cautele per la propria persona, cui fin allora si era stati abituati.
È un fatto che coloro, i quali non ismettono, senza necessità sentita, la lana che da lunga pezza indossavano, dive n· gono i più resistenli e più difficilmente son presi dalle febb ri.
DELLE MALATTIE FEBBRILI PIÙ COMUNI A 
In quanto alle ore, si potrebbe seguire, con lievi modificazion! i_n rapporto alle stagioni, il seguente orario: .5 '/, antimeridiane, levata, funzioni corporali (1 ), lavande fresche leg~ier~ colazione. Dalle 6 '/, alle 11O'/, antimeridiane occu~ paziom professionali. Alle ,J0 '/2 o alle 41 leggiero pasto, riposo e sonno. Dalle 3 o 3 '/ , pomeridiane fino alle 6 occupazioni professionali. Alle 6 lavande fresche e pranzo. Alle 1OO 1O'/. pomeridiane riposo.
L'uso del ghiàccio dovrebb'essere moderato. tanto più nelle ore fuori dei pasti. ,
Infine tutti quegl'individui, che hanno una volta sofferte qu~ste febbri a tipo protratto e con notevoli complicanze gastriche, dovrebbero essere rimpatriati ovvero mandati per i (fJ È possibile obbligare l'intestino ad una certa regolarità . nelle sue funz onr.' e 10 Sbarazzarlo di buon mattino dei materiali escrementizii apporla un relauv~ benessere rlurante tutto il giorno, e fa risentire molto meno gll e~etti danno,s, ~ella luce e del caldo sulle funzioni cerebrali. Quando viene a mancare I :~1tua.le defecazione mattinale, giova prendere verso le 9 antimeridiane un leg.,1ero mruso di sena, graduandolo secondo i casi.
DELLE MALATTIE FEBBRILI PIÙ CO)IUNI A lIASSAUA 114-67 qualche tempo in convalescenza all'interno (Keren, Asmaraj; per vero la·pratica dimostra, che per lo più tutti i ricoverati in ospedale per gravi malatti e (tifo, dissenteri a ecc.) vi erano già stati precedenti volte sofferenti di febbri ~omuni conti nue.
Cnra. - Condizione indispensabile è che l'ammalato resti ih letto ben cautela to, e, se vi esistono dolori reumatici, anche sotto una coperta di lana, massime durante la notte: in tal caso egli si gioverà pure delle cartine di salicilato di soda e chi nino.
Prima cura del medico in ogni caso è di vuotare l'intestino. A tal uopo io mi sono giovato moltissimo dell'olio di ricini (25-35 grammi) in unione coll'olio di mandorle (25 grammi), segu ito nei giorni consecutivi dagli enteroclismi di acido borico (2 p. '100) o di acido tannico (1-2 p. ,1000). Se non vi è alcun disturbo gastrico, ma solo atonia int~stinale, giova ugualmente e preferibilmente l'infuso di sena.
Constatata la presenza di elminti intestinali, bisogna procurarne l'espulsione. Trattandosi di ascaridi, 11O centigrammi di santonina (1 ), seguiti dall'amministrazione di un purgante (olio di ricini o calomelano) sono più che sufficienti. In caso di tenia, preferibile alla pellietlerina ho trovato l'olio etereo di felce mas~hio,somministrato, dopo aver vuotato l'intestino, a digiuno nella dose di ,15-20 grammi . Ugualmente ~fficace questo farmaco si è dimostrato per l'espulsione delle larve di ditteri, che possono a caso trovarsi n~ll'intesti no. Contro la trichina intestinalis sono bastevoli, a quanto pare, le somministrazioni ripetute di glicerina. Pei tricocefali il Sonsino (Rivista generale italiana di clinica medica ·1889), che non li
,1lcun1 giorni: ciò deporrebbe contro l'azione elmintlcida di questo crede indifferenti, propone gli enteroclismi di timol; ma io non ue ho esperienza propria.
È superfluo il dire che, in casi di complieazioni catarrali n.ell~ vie _respir~to:ie, gioveranno, secondo i casi, i gargar1sm1 astrmgent1, r decotti o gl'infusi caldi, e anche i cataplasmi caldi.
Se la cefalea è intensa, varranno a calmarla le bagnature fredde o la vescica di ghiaccio sul capo, ovvero anche le somministrazioni di 0,5-1 , 0 grammo di antifebbrina o dianti . pirina.
Ove la febbre si elevasse oltre i 40°C., nessnn antitermico è _di ~n'azione tanto sicura quanto le spugnature d'acqua ·ghiacciata, o le fregagioni fatte direttamente col ghiaccio per tutta la persona. su.Ila possil.JiliLà del manifestarsi di un'inf~zione tifica a Massaua (,1).
Durante ·il corso della ·malattia si daranno pure bibite raffreddate, acidulate o alcalinizzate, a seconda dei casi.
. Cess~ta la febbre, è necess~rio r,he l'infermo non si esponga · 1m~edratamente alle influenze esterne , nè si rimetta subito al regr~e ordinario e ai suoi abituali lavori, m~ che vi arrivi a gradi, dopo 4, 5 ed anche 7 giorni, a seconda principal mente dei disturbi, che accompagnarono la febbre.
C~nside:ando le condizioni speciali del clima,, è necessario che 11 medrno dia alla convalescenza una maggiore importanza, che non altrove.
Etiologia ·i:omune. - L'azione debiliLanle del dima ed una v,ttitazione incongrua, frequente causa di catarri g2strointestin~li, stabilisce una grande di:;posizione a contrarre questa infezione, e, se i casi non sembrano numerosi, deve pur ammettersi, che una parte di essi, massime quelli a breve e favorevole decorso (typhus abortìvus e typhus Le-ois di Liebermeister) siano passati e passino tuttora inosservati.
Uno straordinario mezzo di propagazione del virus è dato da.1;1" indigeni, che nella loro vita e nei loro costumi tanto si allontanano dai precetti igienici; intendo parlare massimamente della numerosa classe dei cosiddetti mtschini o famelici, fra i quali ogn'infezione trova buon terreno per attecchire e facile via di diffusione.
Un altro veicolo non indifferente è dato da uno stuolo ste rminato d'insetti e massime di mosche, che in dati mesi pullulano prodigiosamente, in modo che non vi sono mezzi bastevoli per difendersene.
Febbri tU'oldee .
Credo non dovermi molto trattenere su quest'ar"omento a~endone già '.atto oggetto di una comunicazione a ;arte (V'. Giornale Medico del R. Esercito e della R. Marina. ann o 189·1), con la quale è stato ormai eliminato qualsiasi dubbio ..
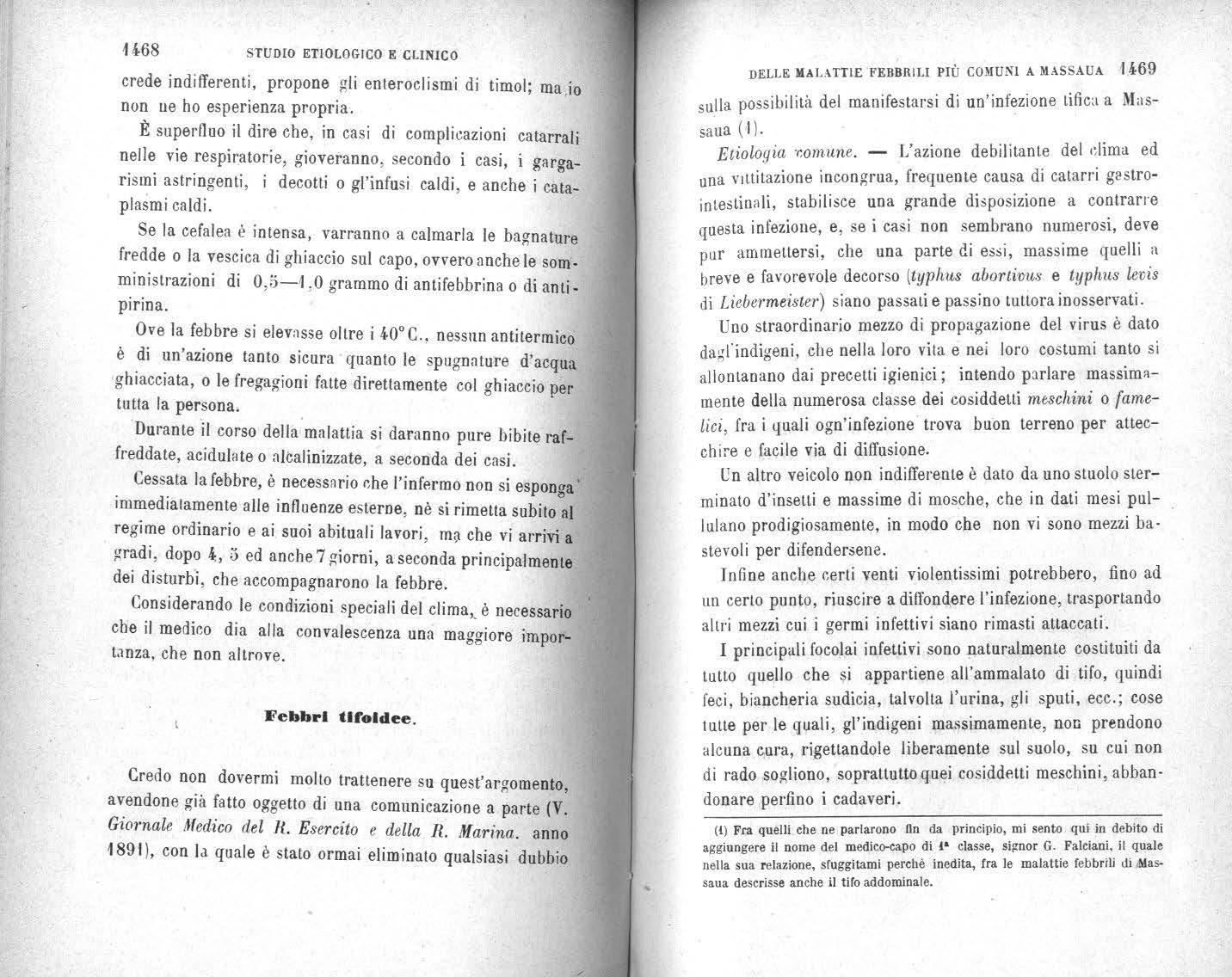
Infine anche r.erti venti violentissimi potrebbero, fino ad un certo punto, riuscire a diffondere l'infezione, trasporlando altri mezzi cui i germi infettivi siano rimasti allaccati. I principali focolai infettivi sono naturalmente costituiti da tutto quello che si appartiene all'ammalato di tifo, quindi feci, biancheria sudicia, Lalvolta l'urina, gli sputi, ecc.; cose tutte per le quali, gl'iodigeni massimamente, non prendono alcuna cura, rigettandole liberamente sul suolo, su cui non di rado sogliono, soprattutto quei cosiddetti meschini, abbandonare perfino i cadaveri.
(l) Fra quelli che ne parlarono On da principio, mi sento qui in debito di aggiungere ìl nome del medico-capo di t• classe, sip:nor G. Faleiani, il quale nella sua relazione, sfuggitami percllè inedita, fra le malattie febbrìli ui Massaua descrisse anche il tifo addominale.
STUIHO ETIOLOGICO E CLl'.'\ICO
Il suolo, in generale, per la sua poro:;ità si prei-ta bene ad essere impregnato dalle materie infette: in esso i bacilli del tifo, garantiti in qualche modo contro l'azion e sterilizzante della luce e del calore solare. possono perpetuarsi in una vita saprofitica e, in date circostanze, altaccare l'uomo. Sotto tal rap porto certe localitit, abbastanza circoscritte, continuamente ombreggi111e e per lo pii1 umide, come le aree di terreno chiu ·e dai tugutli o souoposte alle baracche. naturalmente trovansi nelle più favorevoli condizioni . Del resto non bisogna dimenticare che i bacilli del tifo sperime ntalmente si sono mostrati vivi anche dopo essere stati mantenuti per 5 mesi allo stato di secchezza ( Fliigge).
Al presenle noi non sapremmo spiegarci questa infezione, se non ammettendo che il virus da una delle suindicate sedi, in un modo qualunque, facile a concepirsi. sia arrivato cogli alimenti o con le bevande , massime con l'acqoa , fin nello stomaco, e, superata questa barriera, si sia soffermato nell'io· testino, dove sviluppandosi abbia determinata l'infezione. Se pure si v_olesse ammettere che anche l'aria vi potesse concorrere, nell'attuale stato delle nostre cono ~cenze non si saprebbe supporre . che il virus si vada a localizzare altrove o per altra via nell'intesti no
Etiologia specifica. - L'indagine batteriologica indica come age nte di questa malattia il bacillo di Eberth , da me isolato non solo dalle feci, ma in cultura pura da quasi tutt i gli organi e perfino dal sangue in vita; raccolto dal polpastrello del dito di un tifoso tre giorni prima della morte.
· Questa prova, del resto non necessaria, depone semp re più a favore della specificità di q uesto bacillo nell'infezione tifica.
Pare intanto accertato che vi siano varietà di bacilli del tifo, che si difTeriscono fra loro solo per caratteri secondari.
Il Babes ( I ) di queste ne aveva già descritte quattro, le quali nel fallo potrebbero ridursi a due : le mie ricerche a Massaua ne stabilirono appunto due , che differisco no fra loro principalmente per un diver30 potere riducente proprio a ciascuna varietà. È molto probabile che, queste, come il Babes ha accennato , stiano in rapporto con un diverso grado di virulenza di tiuesto microrganismo, ma un tal fatto non è abbastanza provato.
Una particolarità morfol ogica dei bacilli del tifo, da me dimostrata , è la presenza di ciglia anche ai poli, con che verrebbe ad essere spiegato il movimento rotatorio intorno ad un assA trasversale, di cui spesso son dotati parecchi di questi llacill i.
Sintomatologia. - Qui io mi limito a rilevare solo alcune particolarità clini che del modo di decorrere delle tifoidi a Massaua; imperocchè sarebbe superfluo il riprodurre dai libri di patologia tullo il quadro nosologico di queste febbri, e sarebbe anche in oppo rtuno.
Tutte quelle febbri , le qnali non esordiscono bruscamente co n alla temperatura, che si mantengono conti nue e progressive nei primi giorni, rag~iungendo verso il quarto una temperatura non]inferiore ai 30°,5C., debbono richiamare l'attenzione del medico, inquantochè quasi sempre esse s'appoggiano ad un'i nfez ione tifica: in tali casi questa deve ammettersi, se pure tutti gli altri dati clinici non possano essere accertati.
Adunque un primo fatto, eh.e bisoi,ma bene indagnre, è il modo d'invasione della fellbre; imperocchè non è raro il caso, che l'infermo nel presentarsi al medico non si sia nemmeno accorto di portarl a da più giorni , ovvero che la febòre tifoidea sia preceduta da una delle ordinarie comuni con tinue, tanto frequenti a ;\Iassaua.
(i) COIINIL et DA BES, - Les Bactéries, 3m• édition, I, Il, {890

STUUIO ETlOLOGICO E CLl:ilCO
Inoltre è uopo tener presente che dillicilmente si osserva co là l'evol uzione tipica della febbre tifoid ea; le oscillazioni giornaliere sono mollo irregolari, nè si presentano uniformi e costanti; i periodi della cu rva termica , pirogenetìco, fastigio, anfibolo e del decremento, non ;;i possono neuamente di:-Linguer e. Deve riLenersi come fr eq 1!ente il fallo che alper iodo pfrogenetico segua quello del decremento: so no ques ti i casi di tifo abortivo o leggiero, i quali spesso vanno a conto della cosi ddetta febbre climatica.
I l deco rso della febbre può presentarsi come quello di una intermillenle quotidiana, possono cioè aversi ogni giorn o, per lo piu ti ma ltino. vere intermittenze seguite da temperature serotine non molto alte , e può an che accadere c he succeda no alcuni g1orni di completa apiressia, e poi. per una ca usa non sempre apprezzauile , la febbre ripigli lo stesso decorso torpido, co me si era presentato in pri ncip i1.1. O infin e quest'ultimo fatto può costituire un cosiddello periodo di ritardo di una febbre tifoidea, che abbia avuto un piuttos to grave decorso.
Tu tte queste varianti della curva termica tipica della febbre tifoidea, le qua li del resto so no contempl ate aoC"he nei libr i di patolo~ia, debbono aseriversi alla lenta risoluzione di lesioni interne , della mucosa intestinale o delle glaodole mesenteriche. Tenuto presente che il tifo è un'infezione, ch e attacca principalmente il sistema gla ndolare (adeno-tifo), non ~ara ditlicile l'ammettere ciò, se si consideri q uello che tulli i giorn i cade sc,tto i nostri occhi, cioè la grande diversità, che presentano le glandole sollocutanee in singoli ammalati nel modo di reagire all e infezioni più comuni.
I sintomi nervosi sono poco o niente pronunziati al princ ip io e lungo il decor so della mal attia: difficilmente si ravvisa il cosiddetto stato tifoso, lo stupore; spesso lutto si riduce ad un'espression e di apatia, che colpisce subito alla sempl ice ispezione gene rale. Solo nei casi gravi, verso il termi ne della malattia, il tifoY> suol prendere la sua caralleri::;tica fisonomia pel pronunzia rsi d'intensi distu rbi nervos i, quali sopore profondo, deliri mormoranti, ed inoltre sussulti tendinei , carfologia. coma e collas so.
È freque nte la bronchite senza notevole espettorazione, in cui i fenom eni acust ici si riducono sem pl icemente ad asprezza nel mormorio vescico lare, senza rantoli umidi , ma solo con sibili molto diffusi e pe r lo più limitati nlle parti posteriori.

È un fa tto tJ uesto così comu ne, che buona parte dei clinici hanno voluto ravvi sa re in esso un sin tomo caratteristico del tifo addomin ale .
I disturbi circo lato ri si riducono al dicrotismo del polso, che può trasformar si in bigemin ismo. Non mi è occorso mai di ns~e rvare la caratteristica ro~eola.
Da parte cleg li or~ani arldominali è da notare che il met eorismo in sul prin cipio e nei casi leggieri non si pronunzia affa tto . Il tumore di milza, che per altro in condizioni speciali può an che non rendersi palese, e la dolorabilità all 'ipo · condrio sinistro so no sintom i di grande importanza. Può manca re, nel decorso dell a malauia. il go rgoglio alla fossa ileo-ceca le, ma risalterà subito all'esame il dolore, che in e:-sa risveglia la palpazi one anche leggiera, e quale non si r i~con tra nella fos sa iliaca sinistra." Tranne in sul prin cipio della ma lattia, non vi ha mai coprostasi, e se, co me spess o acc,,de nei casi leggieri , le feci non presentano l'aspetto caratte r istico di quelle da tilo, pure è notevole il fatto che le cracuazio ni sono spo ntanee e frequ enti.
~ on biso gna dimenticare le forme di cosiddetto tifo ambulatorio e quelle altre di cosi ddello tifo apireiico, le quali, pur permellendo all'infermo di attendere alle pro pr ie occu-
STCDIO t:1101.u1;1cu I!: LLl:-i[CO pazioui, possor,o improvvisamente insorgere ~on accid~nti gravissimi (enterorragia , peritonite ecc.) e termrnare rapidamente con la morte. Oa. me non sono stati osservati casi somiglianti: ma io credo, che devesi appunto alla maggiore con~iderazione in cui sono state prese le leggiere iufermita di natura non abbastanza mauifesta, se non si sono avuti più a rP-gistrare casi cosi rapidamente letali, come quelli veri licatisi in sul principio dell'occupazione.

Complicanze. - L'angina catarrale è una delle più frequenti complicanze, che sogliono manifestarsi per lo più nel primo periodo del tifo anche in casi lei~ieri. Jla, soprattullo in indiv1dui predisposti per non buona costituzione, possono aversi fatti molto notevoli da parte delle tonsille (tonsillo tifo) .
Cosi a me è occorso di osservare un'angina flemmonosa molto pronunziata, che minacciava di asfissia l'infermo pel consecutivo edema della glollide, pericolo che fu scongiurato con la fuoriuscita della marcia.
~ei casi gravi non mwcaoo complicanze da parte dell' intestino , dei reni, dei pulmoni e del cuore .
Il peri colo dell'enterorragia è quello, che più minacc:a la vita dell'infermo; essa per lo più è seguita da un abbassamento termico, che farebbe credere ad una favorevole risoluzione della malattia, ma presto può intervenire la periton ite da per/ora::ione dell'intesLi no, che porta l'infermo irremiss ibilmente a morte .
Sia per localizzazioue, comprovata dalle ricerch~ da me fatle dei bacilli del tifo nei reni, sia per l'avvelenamento generale del sangue da parte delle toxiue circolanti, nell'ultimo periodo può aversi nefrite (parenchimale e intersti.:iale), la quale, se non è una complicanza tale da co mpromette r e la vita dell'infermo, è certamente molto grave.
Fra le più frequenti co mplicanze dell'ullimo per iodo è da ascriversi la pulmonile ipostatica o pulmonite flaccida. A me è ri11scito isolare , in un caso letale, dal succo del pulmone leso, oltre il tf . tetragenus {Koch. G·affky). tre streptococchi • fra loro affini, ed un quarto, il quale per tutti i suoi caratteri morfologici e biologici poteva dirsi identir.o al FraenkelWeichselbaum. Ora è possibile che tali fJulmoniti siano don1te appunto all'azione combinala di lutti questi microrianismi, i quali, localizzandosi a piccoli focolai nel pulmone, trovino in questo favorevole condizione al loro sviluppo, in seguito alla diminuita resistenza vitale del tessuto pulmonale per parte sia dell'infezion e generale, sia anche delle notevoli ipostasi in esso stabilitesi.
Un'altra grave complicanza, che spesso decide della vita dell'infermo è la miocardite e la pericardite, le quali, se non ~piegano il consecutivo marasma cardiaco (Striimpell}, rendono r.ertamente il cuore più suscettibile all'azione dirett,t delle toxiue elaborate dai bacilli del tifo, stabilitisi nel mio· cardio. Quest'ultimo fatto , già ùimostrato da Chantemesse e Yidal (1) in due casi, è stato recentemente confermato anche da me a )Jassaua.
Infine, tra le più gravi complicanze del tifo deve ora ascriversi anche l'insorgere di veri attacchi epilettici, quali sono stati da me osservati, che sono da mettersi in rapporto dell'azione irritante delle toxine del tifo, sia sul midollo all ungato (Schroeder van der Colk, ~othnagel), sia sulla zona motrice della corteccia cerebr,1le con o senza partecipazione del midollo ( Luciani , Chirone).
· Oi altre complica nze descritte dai patologi, quali le tr ombosi venose, non m1 si è presentato alcun caso nel corso di queste mie osservazioni.










