
43 minute read
RIVI STA D'IGIENE
h11a lltrulene 4e1 ltquaml p•tresolblU attraveno la torba - Ricer che chimiche del dott. ADOLFO MONARI.(Rtoista d' igiene e sanità pubblica, novembre, 1891).
La torba é già adottata con indiscutibile vantaggio per lelliera ad a nimali da stalla, per allevamen to dei bachi da seta, per purifi caz ione di gas illum in ante, per spur go di fo· gne cloacali e per molli alt ri u si; m er itereb be sopr a tutto di di essere maggiorme nt e a pplicata agli scoli dfllle lat r•ine obbliga ndo le m aterie di dei ezione a rim escola r si colla to rba ehe ne a ssorbe i ga s p utr idi e le spoglia in par i tempo di altri elemen ti p utrescibili.
Advertisement
L'autore ha già tra ttato nel 1889 del poter e asso r bente che le torbe han no per l'acqua, pei ma teriali or ganir.i. e pei prodotti gassosi della putr efa zione. Ora s i é proposto d i studiare alcu ni r isullati dei pr ocessi di scomposizione che si !volgono solto l'influenza degli o r dinari agen ti delle fe rmentazion i putr ide.
na ques to studio sper imentale !:i può rbe la torba na turale dai liquidi delle deiezion i ani m ali, lascia passa r e solamente e parzialmente l'urea od altro prodotto nitrogenato; che qua ndo è satura, negli strati d' infiltrazione la scia pa ssa r e a nche alt r e sostanze di natu r a più complesse; che in queste condizioni rimescolata convenienteme nte, ed anche fa tta essicare, riacquista il primitivo potere ; che nei li quidi filtr ali att rave r so la torba a ttiva non si continuano più le fe rmen ta zioni putr ide ; finalme nte, che per se stessa la to rba ha u n' azione notevo le, deco m ponente ed ossidante a d un tem po.
suddette deduzioni sperimentali risultano a seodati due fattJ Importanti, cioè che il liquame fillrato non mostra tendenze ad ulteriori fermentazioni, e che questo liquame stesso pre;::enLR una for·le eccedenza di a zoto. Si può quindi affermare che la filtrazione di materiali organici attraverso alla tor·ba lr11sf'orma i medesimi in ter-reni poco adatti allo sv·lupp·o· dt>i micr·organismi che danno luogo alle putr' 1 • 1 e, le 1IU8li normalmente richiedono nei substrati di cultura una {lrande eccedenza di carbonio.

Bioeroa del baoUlo del tifo nelle aoque . _ CHARLES l. Foon: M. D. - (J1'edicat Record, ottobre 1 91).
La del bacillo del tifo nelle acque richied e un metodo dt esame possibilrnente pronto, perché esso si ritrnva .dopo settimttne dalla data della infezione (1)
La prt ncrpale dtfflcolla nello scop rire il bacillo tifoso nelle presenza di una grande quantita di altri che sr sviluppano assai rapidamente nell'acqua, i la A"elatina p r ima che il ba cillo del tifo abbia Jl. tempo dJ svilupparsi. A tale difficolta si è cercato di ovVIare fin.ora diluendo l'acqua sospetta con acrlu a sterilizzata esa mmanrlo poi la miscelA; con l'uso di alcuni antisettici i r è . . . •, opuuone, t>sercitano una mag-giore influenza eli sul.lo sviluppo degli bacterii delle acque che non del l1fo, e per la proprietà che ha il bacillo del dr svo.lgt3r·s.i ad alta temperatura, mentre che il crescer e bactert dell acqua é ritat·dato da un elevam e nto termico d1 35•-4o• c.
. Tra gli impiegati sono l'acido ca r bolico (2 p. 100)
10 gelatma, l ac1do 1droclorico (075-1 p. 100), e l'acido borico
D' IGIENE 1.35 (l p. tOO). Essi sono stati tutti usati e d'ordìurio eou dubbio successo 11).
Rodol, per dislrul!gere i batterii dell'acqua, é ricorso con qualche successo al mantenere il brodo l bntlt>rii u"ati come mezzo di comparazione con il bacillo tifogeno furono due specie di verde-fluorescente, lique - fscienti molto comuni nell'acqua che fu scel ta per l'esame, e si sviluppano cosi rapidamente, e liquefanno così presto la gelatina che la loro presenza è uno dei principAli ostacol i alla ri cerca in acqu a del bacillo del lifo.
IOflpetl.8 ad una temperatura di 40•·45,a0 per alcum g10rm; ma pere che anc he questo metodo non sia semp•·e col·onalo da felice successo.
L'A. avendo ttvuto occasione di esaminare un'acqua soapett.a, ed avendo incontrate mollissimo difficoltà nel fare un esame soddil'facente, penl'ò di stucliare esperimenlalmente i metod1 .li ricerca del bacillo del tifo nelt'ac•1 ua. prima pr(lvando 11, del bac1llo del tifo e di alcuni comuni bal&erii dell'a cqua in varie f.(elatint> anlls.-lliche e alla temperatura dP-1 laboratorio, e poi in piastre di agar alla temperatura ,fi :n•-10• c.
Il melo lo dell'A. di prova1•e gl i antisettici consiste nel pre· parare una gel a tina antisettica di uno cer ta consistenza, farne delle pial'lre, e in ciascuna di dopo che la gelolina si sia brme in du rita, praticare tre inoculazioni per infissione, pa · rallele fru loro e alla distanza d• un pollice circa l'una dull'altra. L11 moculaziooe rli mezzo fu fslta con cultura di ba· cillo del t•t'v, e le latet·ali con due di tler·enti balterii dell'acqua. l di questo meto.lo, s"conclo l'A., sono iu ciò che essendo i batler·i• sotto le med t:!sime condizioni, ciò perrnelle di comparare p•·ontamenle la rap1dità dello svolgersi <!elle clitlerenlt colonie di batterii. Oltr e a ciò questo me lo lo nvvia alla nece ssità di dover far rip etute cul lu•·e delle colonie t.lel bacillo del tifo in palat'3 pot• essere si..:uri che non si tratti di aiLr·o bacillo che lo ras so migli.
(l) Karlinski vuoto una cons'd 1 ti( 1 1 erevo e Quantità dt cultura pura di bacilli del pozzo. del .de ll'Istituto d ' igiene di Mo naco, e dopo due settiJJakt io/n fu POSSibile eli scoprire il bacillo nell'acqua (Centralblalt fur tr O og1e, IJd. VI, p, 671).
Ili {l•l con q ne< li anti,ellici si riscontrino: Ctuxe VIllA l. (llattltlgrtrten'$ Ja/u·ullericlit, IS$7, p. ISl); KITASHO (Zeillerifl fur llygieru, Dd. 111. p. 104); llEt\1 (tft·briten aus àem Kni$er·lichm GeDr!. V, p. 303); (Crntralblrttt fii t· Bakt eriolog it, lld. VI , p. \66); THORNOT e Sorn t Ba"mgflrlen's Jallresbn·icht, 1887, p, U 9).
Nei p rim i due esperi m en ti le soluz ioni antisettiche usate dall'A. furono fat.te in acqua quando ciò fu possibile; uegl i ca si in alcool o in glicerin a. In tutti gli Altri casi in cui gli anti setti ci non erano sol u bili ìn acqua, l'A. li mescolò con una cJuentittì eguale d i go mma e aggiungendovi dell'acr1ua tlno a manlenerne il potere antbettico, ne fece une emulsione. Egli però avverte che faceudo piccole quantità di gelatina antisettica è tsssai difficile poter ottenere un'assoluta esatt ezza nella forza, la ,quale per ò egli potè conservare abbastanza bene pe r i va r ii antisettici. Questi tutti, eccetto il B - naphthol e la creolina , danno una gelatin a uniforme non cagionando un precipitato apprezzabile, nè ave,ndosi una magp-ior rnccolta di antisettico in vari punt i della piastra. La solu zione a lcool ica di B-naptho l con la gelatina forma però un prl'ciprtato spesso, bianco duro, che, dice l'A. egli evitò servendosi nei successivi esperimenti della emulsione invect> che della soluzione alcool ica. L a creolina, dagli esperimenti dell'A., non si m isch ierebbe bene alia gelatina, e si raccogliet·ebbe in globuli alla supe r ficie della piastrA.
Dai vari espet•imenti eseguili e dall'A. riporlAlì in tan ti quadri che noi pt> r brevita omettiamo, r isulla chia ro che l'us0 degli antisettici nella ri cer ca del bHc ill o dol tifo nelle acque ha un valot·e affatto neg-ativo o quan to meno non ha altro interes5e se non nel mostrare l'effetto che possono ave re gli antisettici nello svil uppo del bacillo del tifo.
Dagli stessi esperimenti poi risulta che soltanto l'alcool e il fiuosilicato di sodro hanno un certo val01·e nel proteggere, direbbesi, il bacillo del tifo, difa tti l'A. dice che avendo ripetute volte esper•iml'nlato aggiungendo 1; , c. c. di a lcool in (i c. c. di ebbe ad osservare che lo sviluppo def!li altri baltet•ri era notevolmente t·itardato in con fronto di quello de l bacillo del tifo. I n generale poi lo svolgersi di tutti era considerevolmente ritnrdato , né g li uni 11 ò gli alt ri ess endo
D'IGIENE _ , appersi pr ima òi otto giorni. Lo osservò l'A. con la p latina al tluosilicato di sodio all'i p. 600-1000, e dai mo ti esperimen ti da lui !a lti con questi due antrMtlici per provare la ricerca del bacillo del tifo rn un'acqua p r ecedf'ntemente inquinata con esso, egli trae la conclusione che sifrauo metodo no n ha un valore pralico.
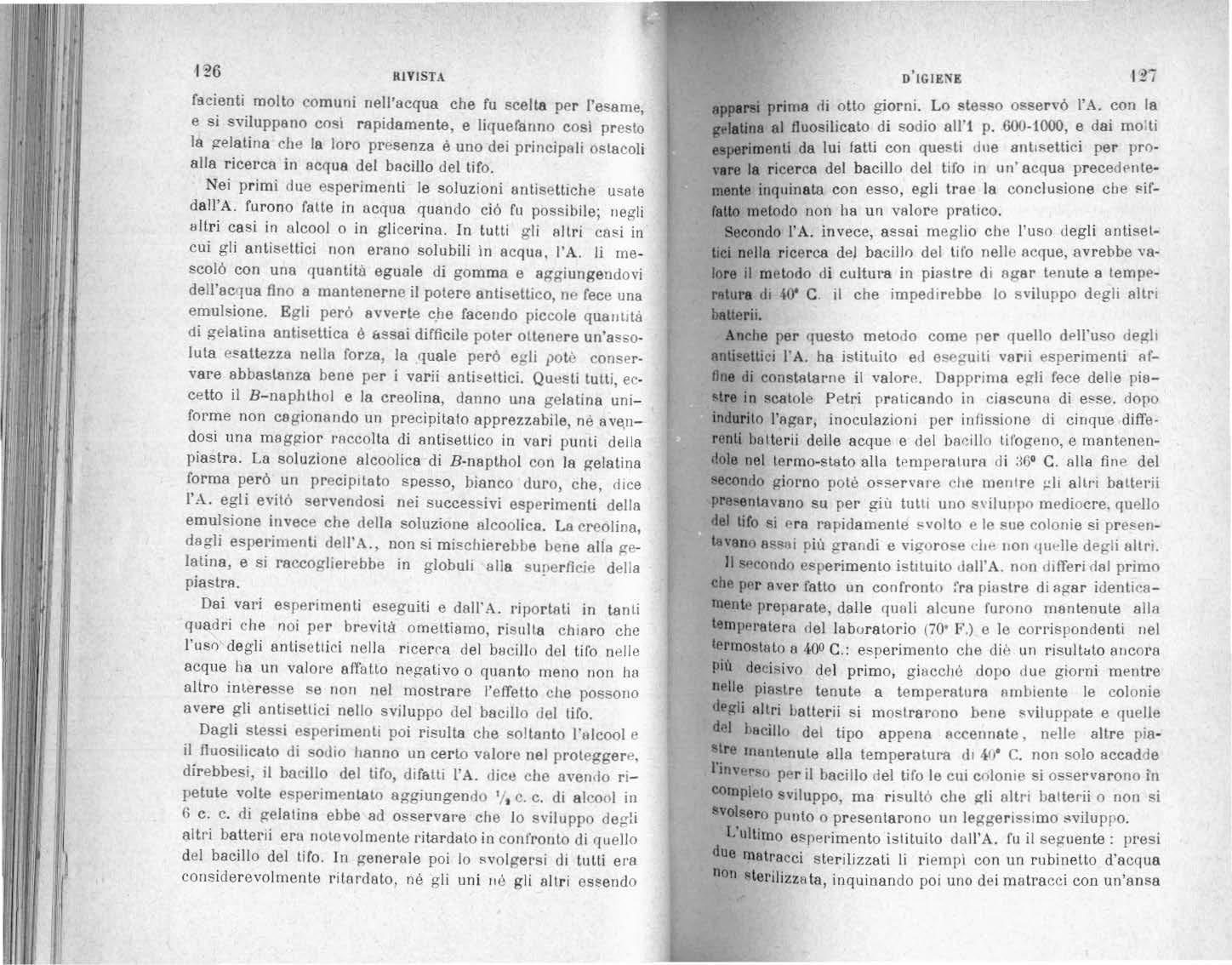
Seeondo l'A. inve ce, assai meglio che l'uso degli antisettici nE'Ila r icerca del bac ill0 del li l'o nellr acque, avrebbe valore il m t• todo di cultura in p iast r e di agar tenute a temperatu ra dr w• C il che impedirebbe lo sviluppo degli allt•t belterii.
Anche per r1uesto metodo come per qut>llo dt>ll"uso deglr l' A. ha istituito ed va r ri esperimenti affine di constatarn e il valorE>. Dapprrma egli fece delle piaP.tre in scato le P e tri praticando in ciascuna di esse. dopo indurito I'Agar, inoculazio ni per infissiono di cinque ditrerenti hotter ii delle acqu e e del bAcillo t ifogeno, e mantenendole nel termo-stato alla trmper·aturn d i :l(i° C. alla fin E' del seeondo giorno potè o;:servar·e che mentre al tr-i balterii presentavano su per giù tulli uno f'\ mf'diocre, quello del liro !'li Pra rapidament e !-'VOlto e le sue colonie si pr e;:entavano A<: <:ai p iù e vil:{oro:,e drt> non qtwlle allrr. Il ""condo esperimento istrturto dall'A. non diffe r ì òal primo ehe pPr Aver fallo un confronto fra piastre di agar identirarnentt> preparate, da lle quali alcune furono mantenute alla tempet·ateru del labora torio (70• F.) e le corrispondenti nel termostato 11 400 C.: e sperimento che cliù un ar1cora più decisivo dE'l primo, g it1cch0 dopo duE' giomi mentre nelle piastr e te nute a temperatura tllnhiente le col onie degli altri batterii si mostrat·ono bene sv iluppate e quelle dP.I hucillo del tipo ap pena Accennate, nelle altre piastre tnantenu te alla temperatura dr 411• C. non solo accadde l'inveri<r, il bacillo del tifo le cui colonre si osc:ervarono in com pleto svtluppo, ma ri sultò che e;li altt·i batlecii o non si evolser o punto o presentarono un $Viluppo. L'ultimo e spel'imento istituito dàll'A. fu il seguente: presi due rnatracci ste r ilizzati li ri empi co n un rubinetto d'acqua non lllerilizztl la, inqui nando poi uno dei matracci con un'ansa di p ura di bacillo tifogeno. l nJ1 fece due pia stre di agar (n u m e rate I e Il) in ciascuna delle quali inoculò un r . c. di acqua i n fetta con il bacillo del tifo; e a ltr·e due piastr•e di aga r (nume r ate II l e I V) egli preparò inoculandole di un c. c. dell'acc rua contenuta nella bottiglia non inquinata del bacillo d e l tifo. Tu tte queste piastr e fu r ono mantenute neltermost.ato a lla tem peraturtl di 40' C., ed e gualmente altre quattro che l'autore numer·ò I, II, II I, IV, egli ne fece in gelatina, mante nendole aiJa temperatura dE'l laborato r io (iO' F., 21• C.)
Dopo due gior·ni egli potè osservare che molte coloni e fluidificanti si erano sviluppate in tutte le piastre di gelatina, ma che p2l'Ò non ra<>somigllavano a quelle del bacillo del tifo; men t re era assai diffe r entemente seguito delle piastre di agar. Infatti nelle pia stre I e II si osservavano molte colonie compatte, tr asparenti, della grandezza all'incirca di una tes ta di spillo, le quali dallo sviluppo che ebbero poi in gelatina e in p a tate non lasciarono dubbio che non fossero di bacillo tirogeno; nelle piastre II I e I V invece non si svolsero colonie di so r ta in fino al termine del secon do giorno.
Q uesti esperimenti semb1•ano alrA. assai concludenti e tali da a ve rlo con vinto del g r ande valore del metodo. V'ha se· condo l' A. una cautela a r1guardare, notata anche da Ha zen e White, e si è di badare di non mischiare l'acqua sospetta con l'agar• fino a che questo s ia completamente r affreddato e di mischiare e versare sulla piastr a rapidamente in m odo da espor r e il bacillo il meno possib1le al cahlo dell'agar.
A vantaggio del metodo descritto é anc11e p r oposto di a ggiungar e a c iascuna piastra di aga r venti gocce di !'O· luzione acquosa ùi fucsina, dacché stato aflPrmato che le colonie di tiro, al contrario di quelle di altri batlerii, scolo· r a no l'ogar che le ci r cond a ; però l'A. in seguito a molti esperimenti dicesi autorizzato a non siff'alto van· taggio, chè se spesso ha potuto ossl•t'vare una be n legg• e ra decolorazione dell'aga r all'intm·no delle colonie del tifo, es!:'a è assa i fr equentemente appena apprezzabile. T. R.
F. W t.LZ. - B l oeroh e batteriologi c he nell' atmosfera 4i J'Hlbvg. - f. Hg[Jten e und heiten, l fa s ci colo del volume Xl, 1891).

Le rke r c he balteriolog:iche furono e,.eguite dall'autore nel giardino dell' I!';Lituto botanico, in una stanza di abita zione priva ta posta qua ::>i r:el centr·o della città, in due sale d'ammalali dell'ospedale cli nico ed m una mon tal-{118 vicina alta 738 m. Le ricer che dut·ar ono un anno intero, e si osservò che fr·a le condizioni Atmosferiche, lo stnto nebbioso aumentava assai il numero dei germi. Un aume11Lo di questi 5;i ebb,. pure in estalè ed una diminuzione in inverno, come si scor·g:e nel seguentt> !lpe cchietto, in cui sono ind1 catc per mesi le colonie che in m edra s i svilupparono da u11 litro d'aria.
Maggio 17 colonie Novemb r e 28- 30 col.
Giugno . 32 n Dice mbre. 15
Luglio. 48
Gennaio . 20 »
Agosto. 50-70 » Febbt•aio . 25
Settelllbre » M11rzo. 20- 30 •
Ottobre 35 n Apl'ile . 30- 35
La ucbbia ebb e tale i nfluenza sul numero del le colonie, che queste ad un a tem peratura di 10'- 15' C e con un'umiditù media di 80 a 95 p. 1110, a 1500 !Wl' litro .r aria. Però neiiP nl' bbie dei giorni freddi di novembre con la temperatura a -IO e - 12 il numer·o delle colonie eh e si svilupparono cla un lih·o d'aria ru minimo , da 3 ad 8.
Le fatte in Rosskopfe a 738 metri s•1l livello del mart>. non dette r o risultati molto dive ..si per qualilà e quantitù di ge r mi da quelle eseguite nella pianura. Come già 8 ''evu Ot>tnto Fr·endenreich nell'aria di m ontagna. si ri "COntrarono pure in Rosskopre un numero di muffe ossai minore, che nell'aria della c i ttà
:Selle sale di ammalati raulore troYo spesso lo stapltilocoeeus pyoy rn es act r eus ed un nurner·o d i colonie superiore a quello dell'abi tazio n e privata.
Per la 'tuali là di è da notare che raut.ore isolò vf'nlitrè sp.-cie di m icr ococchi de1 quali iO fiUJdificantl la l{elatina; lt'e di re rmenLi; venti specie di bal'illi, dei quali 12 fluid 1fi · canti la g elatina e due specie di bacilli non ancol'a descritti.
Fra 1 ger mi patogeni non trovò che lo slaphiloco ceu;; fJ!JO · genrs attreus nelle sale dell'ospedale clinico.
Come già ers noto, nell'aria, il numero di gPrmi per quantità e qualità ò molto inferiore a quello del terreno e dell'acqua.
C S
CoR:-:eT. - L& tubercolosi nelle prigioni.- (ZeitscJ.rijt j. H ygiene, 111 fascicolo, 1891 ) .
L'auto r e, nel suo studio, ha pr·eso ati esame i detenul• det:a Germania nel periodo 187;)-76 sino al 1889-90 e che rrman· gono ch iusi noi rispettivi penitenziari òa 1 a E> anni o per tutta la vita.
In detto periodo mOI'irono i11 trentatre stabilim e nti di pPna della Germanra 7029 uomini e 906 Degli uomini, 3:!21, cioè p. 100 di tutti i morti, socc0mbeltero pe1· e delle donne 4-H, cioè 49,33 p. 100 di lutti i mo rti, pure b er colosi; mentre n ella Geemaniala mortalità media per ce nto di tube r co losi fu di 23,78 p. 100 di tutti i m o rl i.
RelativAmente al l'età è d1fficile il coof'l'OJJLo di mo1·ti per tube rcolo si f't·a i earcerati e la popolazione libera; c tale per deficienza di dt\li non è possibile che per· per1odi abhastanza lunghi , C()me s i scorge nel seguente specchietto.
Dal soprsripor lato specchietto, anche falle alcune riduziOni relative al modo diverso di cla:3sificazione delle malattie tube reoloee, re;u lta chiara mente co•ae tanto la mortalità in nle, quanto quella per tubercolosi, sia as3tli magg101'0 ne;.:li • &abili menli di pena, anzicb è nellR popolazione borghese libera.
Nelle pri g1oni, cause della maggi ore morlalilti in gene r ale e della tube r colosi in particolarè !'Ono l'Alimentazion e uuiforme t' povera dì grasso, la perdita della liberlìt, illirn1tato movimento all 'aeia libera, la respirazione di aria 1mpura e la poca nettezza de l c orpo. Queste unite al patema moral e della prigionia, conducono più rapidsmenle a mo1·tc color·o che erano ma lati, quando entrarono in prigtone, e determinano facilm e n te in alt r i la malattia.
In ogni modo la lisi è determinata dall'introd uzione nell'orgar.i!l rnO di bac illi t ubercolosi, e cosi nelle p r igioni, per le loro condizioni speci al i, la ma lattia si propapa più facilmente e la contrag go n o anche un considerevole nume r o di colo r o ehe erano s an i, q uando furono chiusi in esse. E contraggono più facilmente la malattra n!li laboratori, ove i detenu t i rimangono chiu si moite ore del giorno.
Come misur e profilatti che per la dunhuzione d r lla lisi l'autore con siglia una regola re ventilazione dc!!li ambienti, la disinro:>z iooe specialmente degli !'put1 de' ti ... ici, la nettezza e dl!linrezione dei locali di lavoro e delle celle dei detenuti, il possibile isolamento, o almeno la separaziont> dei tisi ci dai La disinf'Pzion e e la netlezza devono ess,.,t·c samonte cu r a te parlieolarmeute nei lo cali, in cui molti deteft uti si trovano r iuniti du1·ante il !Ziorno.
L'au to re proporrebbe che, a d1agnost1 ro, nei detenu ti sos pelli al lot•o inoculata una minima do ..e oli tu bercolina, con tutte le necessarie cautele, per isvelar., la tub e rcolosi fin•l dal principio, in c·ui so.1o maggiori Il! eporan ze di g ua r·igioue e divien" quindi pos!libile la is ollecita separa zione dei malati dai sani.
La mortalità gener a le da l 1875 al 1890 fu, in Ge r mania, nella popolazion e libe r a, per gli uomi n i, di 14,27 p. 1000 viventi, e per• le donne di '13, 48: mentre pe r i d e tenuti, nello stesso

D'IGIENE 133
perioclo di tempo, fu di 29,8 per i primi e di 20,9 per le c:;e. conde.
P er la tubercolosi. nello stesso periodo di tempo, la mortalità media per mille viventi fu di 3,41 per srh uomini e di :2,81 per le donne: mentre per i detenuti fu di 13,6 per i prim i e di 14,7 per le seconde.
Per ò in questi ultimi anni si è notata una diminuzion e pei detenuti tanto per la media della mort.alita in generale, 1uanto p er quella della tubercolosi i n particolare, e ciò si deve non solo alle cautele igieniche, ma ancora alla rnigliorat.s nulrJZione
Da nllimo l'autore fa notal'e che la vita media n ei detenuti della Germania è di circa 43 anni, ma egli non si na!'lconrle che questa cif•·a, pel modo con cui fu1·ono raccolti i dati stati· stici, non ò molto sicura.
D. R. Iler.nwAGEN. - Mortalità per valuolo e vaoolnazlonl gratuite t n R iga. - (Zcitschrift f. li!J{JiPne. - Il I fa !'leicolo, 1891 ).
Riga Ila una popolazione di circa 180,000 abitanti, fra cui un f.!ruppo di vecchi credenti russi, in cifra tonda 6:>00, i quoh, io base alle l<• r o credenze religiose, non si lasciano va cc inal'e. Circa trl' quarti di questi settari, la maggior pal'te de'qual• a p· partengono alla cJac:;se infima della popolazione, abitano 111 uno stesso quartiere della città.
Sebbene in Russia non esista alcuna legge sulla zione obbligatoria, tuttavia s1 può riteneru che della r estante popolazione adulta di Riga solo pochi individui non sieno vaccinati. La vaccinazione gratuita di bambini all'incontro uella dasc:;e povera, nella prima metà dell'attunle decennio, fu assai traRcut·ata; però in questi ultimi anni que!>l'inconvenienle è andato diminuendo.
Dal 1882 esiste un materiale statistico da consultare sulla mortalità per vaiUolo. Fino al 1887 si ebbero in media, Og"n i anno, 108 mo r ti per vaiuolo. Nei quattr o mesi dal dicembre ul marzo 1886- 87 furono registrati 155 modi; si t1·att6 adunque d• un'epidem ia. Di questi 155 morti spettano ai oecchi credenti non vaccinati 71 = 109 per 10,000, mentre a tutta la restant e popolazione, che non ha obbligo di vaccinazione, = 4,8 per fO,OOO abitanti.

L'epidemia ebbe principio in quel quartiere della città, in cui dimo ra no i vecchi credenti russi. Per questa perLe dello citta la mo r talita per vaiuolo si elevò a a7 per 10,000 abitanti; il quartiere vici no ne ebbe soltanto 6; nelle d•verse cont rad e la media di mor ti per vaiuolu andò assai diminuendo e discese in alcune fino a zero.
Nel triennio 1882-84 ebbe la citt.il di Riga 312 morti per vaiuolo, nel triennio 1885-87 335 e nel triennio 1888-1890 solamente 22 morti. Dunque la mortalità per vaiuolo nell' ultimo triennio si ridusse ad un quinrlicesimo di quella ante-
Le vaccinazion i gratuite pei rispettivi anni, poste a riscon tr o con le mortalità, sono indicate nel seguente specchie tto : Vnccinazioni Morti grnluile per Yaluolo
Da ques to specchietto si scorge che la cifl'a dei m or ti io Riga fu g rande finché rimase piccola quella delle vaccinazioni gratuite ; che nel 1886, sebbena le vaccinazioni fos ser o alla cifra di 2186, non poterono impedire che nell'f,lnno la cifra dei m orti per vaiuqlo salisse a 190. Ma nel 1887 quando le vaccinazioni grat ui te sa lirono alla cospicua cifra di 8188 ( l) e nei successivi anni si mantennero in meda a circa 2 700, la mortalità per vaiuolo !'Ì riduss e al minimo. Anche da questo studio statistico si scorge chiaramente quale be:1efica influenza abbia la vaccinazione per la p1 ofilassi del vaiuolo. c. s.
Azione del suolo sul germi del oa.rbonohlo . - DoTT. EuGENIO FAZI O. - (Rioista d'igiene, N. 6, anno 189L
L'autore da queste sue rice r che spfrimentali deduce che i germi carbonchiosi capitati virulenti nel suolo, perdurando per mesi ed anni nel nuovo ambiente , si trovano in condizioni affatto anormali e sfavorevoli. Deficiente il mater iale nutritivo, esposti continuamente all'Azion e combinata e disassociata di potenti agenti naturali quali la luce, le tem peratura esteriors, l'ossigeno libero dell'aria e l' umidita var iabile, a lungo andare debbono inesorabilmente subire una profonda modifìcttzione nell' 11 ndatura morfologica e biologica epperò nella loro virulenza o nella loro effìcienza patogena .
Sicché i germi del carbonchio. nel suolo finiscono col menare una vita puramente saprofitictt ed appena l' esame microscopico può r ammen ta r ne l'origine.
DuJAROIN- BEAUMF.Tz. - lll!aure da prendersi contro l& febbre tifoidea. - (Annales d' Hygiène publique et de médecine légale, dicemb r e 1891).
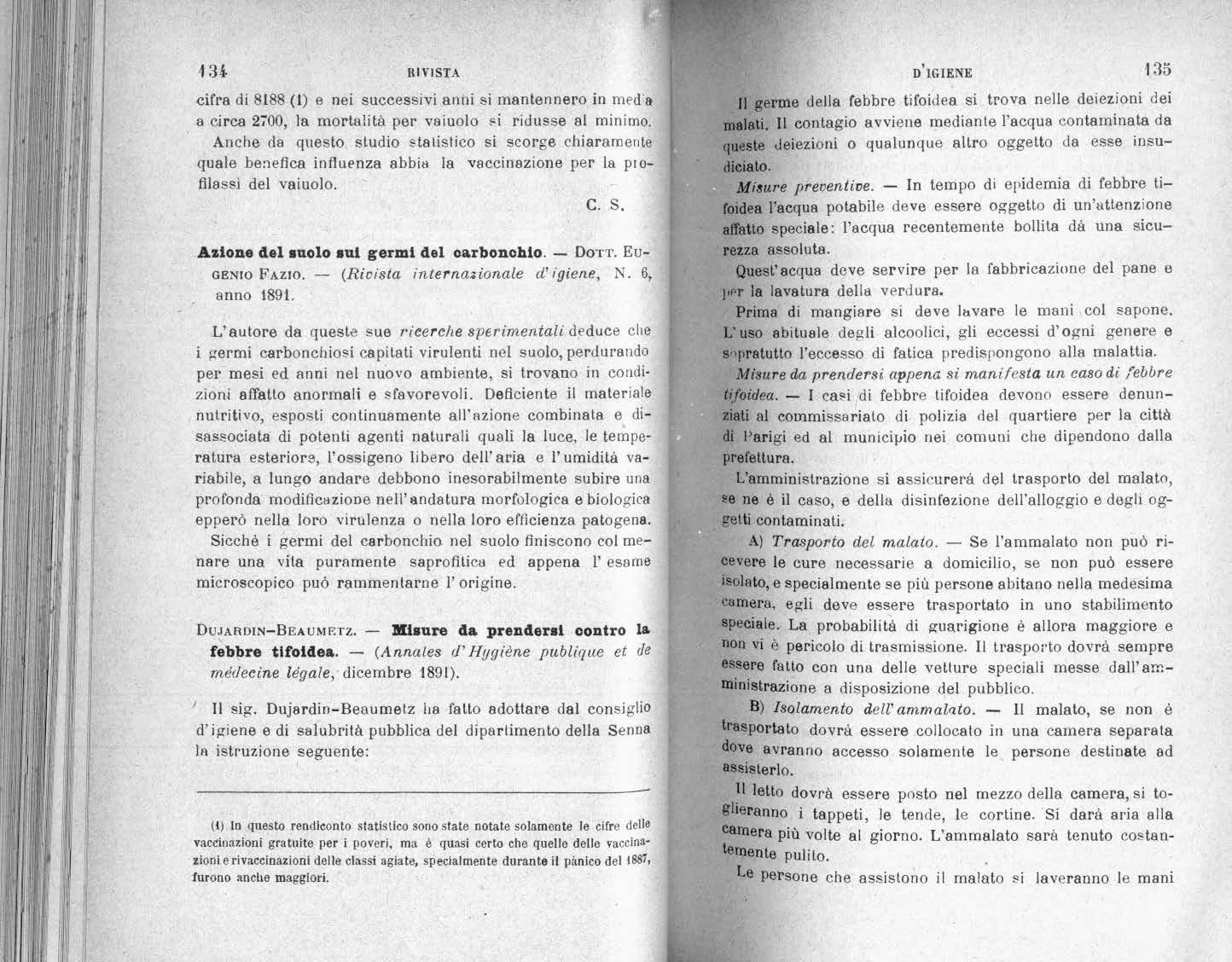
1 li sig. Dujardio - Beau melz ha fallo adottare da l consi glio d' e di salubri là pubblica del dipartimento della Senoa
In ist J'uzione seguente:
(l) In questo rendiconto statistico sono state notate solamente le cifre delle vacctnazioni gratuite per i poveri, ma è quasi certo che quelle delle vaccina· zioni e r ivaceinazioni delle classi agiate, specialmente durante il pànico del l88i, furono anche maggiori.
o' IGIENE 1::l5
11 germe del la febbre tifoidea si trova nelle deiezioni dei malati. Il contag io avviene mediante l'acqua co ntaminata da queste Jeiezioni o qualunque altro oggetto da esse insudiciato.
Mi3ure pr eventioe. - In tempo di epidemia di febbre tifoidea l'acqua potabile deve essere oggetto di un'attenzione aft'a\to speciale: l'acqua recentemente bollila dà una sicurezza a sso luta.
Quest'acqua deve servire per la fabbricazione del pane e J• Pr la la va tura della verdura.
Prima d i mangiare si deve le mani col sapone. L'uso ab ituale degli alcoolici, gli eccessi d'ogni genere e S<l pratutlo l'eccesso di fatica predispongono alla malattia.
Misr.tre da prendersi appena si manifesta r.tn caso di febbre tifoidea. - I casi di febbr e tifoidea devono essere denunziati al commissariato di polizia rlel quartiere per la città di Parig i ed al munici!JÌO nei comuni che dipendono dalla prefettura.
L'ammi nistrazione si assicu r erà del trasporto del malato, f!e ne è il caso, e della disinfezione dell'alloggio e degli oggetti contaminati.
A) Trasp orto del malato. - Se l'ammalato non può ricevere le cure necessarie a domicilio, se non può essere isolato, e specia lmente se piu persone abitano nella medesima camera, deve essere trasportato in uno stabilimen to speciale. La pr obabilità di è allora maggiot·e e non vi è perico lo di trasmissione. I l traspo1·to dovrà sempre essere fa llo con una delle vetture speci ali messe dall'an:mi nistrazi one a disposizione del pubblieo.
B) I s ola mento dell' ammal'lto. - II malato, se non è trasportato dovrà essere collocato in una camera sepat·ata dove avran no accesso solamente le persone destina te ad assisterlo.
Il letto do vrà essere posto nel mezzo della camera, si tog lier ann o i ta ppeti, le tende, le cortine. Si dara aria alla camera più volte al g ior no . L'ammalato sarà tenuto costantemente pulilo.
Le persone che assistono il malato s i lave ranno le mani con una debole di solfato di rame (12 gr. per litro d'acqua) tutte lfl volte che avranno toccato il malato o la biancheria insudiciata. Dovranno pure sciacquarsi la bocca <'On acqua bollila. Esse non mangieranno mai nella camPra del malato. autore ha pubblica to questo elaboralo resoconto in r·usso ed in fra ncese, diet r o i più d ili genti e sicuri dati ufficiali.
C) delle mate r ie. - È dt-lla massima importanza che le deiezioni dell'ammalato e j:tli oggetti dA insutflciati siano disinfettali.
Le dismfezioni della biancheria e delle mani si far •anno colle soluzioni di solfato di rame. Queste saranno di due Rpecie: le une furti, contenenti 50 gr. di solfato di per litro, le altre deboli contenenti 12 gr. per litro. Le soluzioni forli »erviranno a la biancheria in»udiciata, quelle deboli a lavare le mani e la bia ncheria non l rommissar1 di polizia te r ranno gratuitamente a ùi spos i· del pubblico dei pacchetti di 25 grammi per le solu:doni. Si due pacchetti io un litro d'acqua per fare le sol uziom forti ed un pacchetto in due litri d'acqua per le soluzioni deboli.
Per• disinfettare le deiezioni si metterà mezzo litro dell a soluzione fo r te nP.I vaso destinato a riceverle.
Si laveranno con rtuesta soluzione le latrine e tutti i dove le deiezioni saranno state getta le o spar se.
Nessu n oggetto di bianchet·ia, insudiciata o no, deve es· s ere lavato in un corso d'acqua. La biancher ra insudiciata cti in una soluzione forte nella rtuale rimarrà due ore. La biancheria non insudiciata sar·à immersa nella Juzione debole.
Gli abiti, le lettiere e le coperte saranno portati alle stufe m unicipali pubbliche di d isinfezione.
D) dei l()calè . - La disinf(>zione dei locali è fatta gratuitamente da persone specialmente incaricate . Per ottenere questa disinfezione a P arigi basta indirizzarsi al commissario di polizia de l quartiere.
U n medico delegato è incar icato di verificare delle misure qui sopra presc r itte.
D ECLAT - K&nuale dl medlclna antlaetttoa.- Tradotto dal - Città di Castello.
Veramen te si tra tte r ebbe quasi esclusivamente delle applieazion• mecl icativn dell'acido fenico e dei suoi componenti. Il libro fu tr'adotlo e ne é propugnata rutililà da un profano all'arte. Tu llavia considerato appunto come una compiuta muoografia d ell' a cido fenico come mezzo curativo, ha un realu valore e del vero merito. E sor disce con uu lungo cenno storico sull'acido fenico e sue appl tcazioni alla modicina; vi Caono seguito l e s intetiche regole gener ali re iati ve pet• l'apvlieazione s ua, e finalmente sono individualmente indicate le malattie nelle il preconizzato mezzo può utilmen te invocars i, coll 'aggiunta di un fo r mulario relativo.
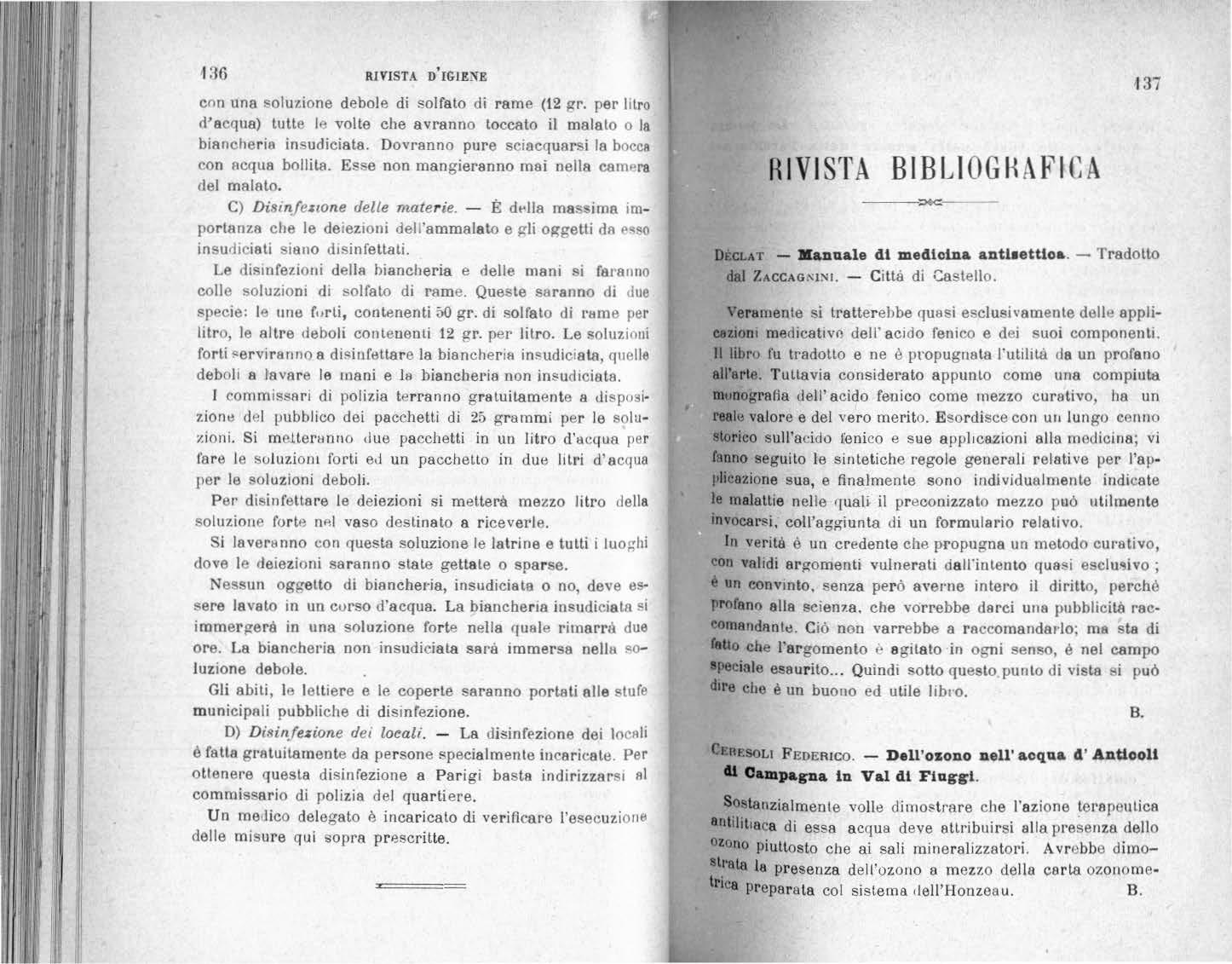
In verità è un credente che propugna un metodo curativo, eon val1di argo ment i vulnerati da ll'intento quasi esclu'!ivo; é un eonvm to, senza pe r ò aver·ne intero il diritto, perché profano alla sciema. che vorrebbe darci una pubblicità rac· Ciò non varrebbe a raccomandar·lo; ma sta di retto che l'argo mento i> a gita to in ogni senso, è nel campo Speciale esa uri to.. . Quindi sotto questo punto di vista si può dare che è un buono ed utile lib1·o. B.
Sostanzialm ente volle dimos t rare che l'a zione terapeutica antilit1aca di essa a cqua deve atlt'ibuirsi alla presen za dello ozono piuttosto che ai sali mine r al izzatori. A vrobbe dimostrata la pres e nza de ll'ozono a mezzo de lla ca r ta ozonometrica prepara ta col s istema dell'Honzoau. B .
KosTOFF, m edico generale russo. - Le p e rdite dell' eaerclto russo nella guerra della Turo:bia 1111 1877 - 1878.

La mortalità d ell'esercito del Danubio, in 28 m esi, dal novemb r e 1876 al mano 1879, fu, su d'un effèllivo metlio di 592,000 uomini, di l :1,905 uccisi, 5,t21 sco mparsi, 44, i31 deceduti per malattie, 4,673 in seguito a ferite ed a lraumatism i. 479 pe r accidenti di versi, 744 morti s ubitanee e 137 suicidi.
F urono inoltre 35.:105 uom ini consecutivamente
La perdita gener ale fu quindi dt 102,799 uomini, vale a dire del l i ,:l6 p. 100 dell'effet.ti vo.
Il tìfo occasionò 10,08 1 mor·ti, e nella proporzione del 40 p. 100 dei co lpiti; la dissenteria cagionò 9,5i3 decessi.
Le fe1•ite occasion arono in confronto alle malattie e proporzionatamente solo il decimo di mo rti. Le rerile portato vero della guerr a non diede r o che l' 8,36 p 1000 di morti, cioè 1 caso di m o r ' le per 120 ferili .
Ora giove ra notare che g li eserci ti americani nella guerra di secession e in quattro anni per dettero per malattia il 23,3 p. 100; l'esercito francese nella guerra di Crimea 21,6 p. 100: e l'ingl ese 18,7; l'esercito russo del Caucaso in 2G mesi 14, 3 p. 100; quello de l Danu bio 7,5 p. 100: in questa si ebbero in compl esso 919,315 malati, e quindi ogni indiv iduo amma lò un po' più d' una volta e mezza in 28 mesi . B.
BIANCHI GrNo, tenen te m ed ico di com plemen to. - Ct•d ematloa del mesentere .
Alla breve, ma importante illustrazione del caso , fa segui r& alcune consider·azioni general i s ulla prognosi, in genere inrausta, sul me tod o operativo (puntu ra . marsu pializzazione - es tirpazione). Pu r ammettendo i van ta g gi della e s tir pazione vorrebbe però nella maggi o r anza dei casi pre fer•b•le la martupializzazione, vale a dire la laporotomia con sutura dei margini della sacca al la parete a ddominale. B.
Dlslourio Pollglotto dl tarmacla, ollnloa, terapeutloa l4rologi& oolle formole , slnonlml, caratteri, uat, dod, tariA, ecc. -P el dott. SILV IO PLEV ANI. - Milano.
L'autore dice che non è un lAvoro di concetto ma <li pazienza ... Non è vero però, perchè il senso r <> tlo che lo ha gui· da to è prova di un concetto giusto e p r atico. degno 'di eneomio
In il libro è utile, e nello !'volgimenlo del vasto intento il s uo autore !"eppe co ntenersi in quei limiti pratici ehe sono ap punto il Yero m(>rito di simili lavori.
B.
-..n.UD lnttrnattonal des Socl é tés de la Crolx Bouge. S . 88 e 89. - Genève, octob r e 189 1 Janvie r 1892.
Fra la dive r se notizie che dà dell'ope r·a, sciegliamo le seguenli, degne di spe ciale interesse:
Auoeiazione degli infe r mieri nolontari. - Nella Germania del Sud, l'associazione conta 36\7 membri, rlei quali !136 ono· rari e straordinari , 727 compiutamente istruiti in ogni ramo del servizio sa nitario militare, 135 1 avendo ottenuta una istru zione preparatoria, 630 non aventi avuta alcuna zione.
A Tempe lhof (Be r lino) fu in s tituito un lazzaretto di baracche, che r este r à in funzioni G mesi (ne sono già tr asco r si 3) esperimentarvi i dive r si modelli di premiati o con menzi one onorevole alla espos izione del mtller•ale di arredamento degli ospedali, dal punto di vista de;la durata e val ore pra tico
Le ass ociazi oni a ustriache possiedono un capitale nello di milioni di fìot•ini ed un m ate r ial e stima to più di 8 1i llllla fiorini. Hann o o r ganizzate 30 colonne dit rasporto; po - trebbero nei loro ospedali e nei locali offerti dal clero e dAi privati ricoverare 1,273 ufficiali, 18,423 soldati.
Il personale a disposizione enume ra 401 medici , 5C! farrn apiil di iOO infermif•re r eligio!'le, 143 infermiert· il clero poi disporrebbe pei suoi locali di w; mediCI, 321 7 2-2 infermi6ri. 40 novizi pel servizio d• aH ri 97 in(Prmieri sono a disposizione de lla <>ocielll di dome bo<>me e moravP. Dalla lanrl.,turm sono già a<>q•· gnati Alla MciE'tà di s occorso 1753 porta feriti. La !"Ocie' delle dame triestine ed istriane sta organizzando una ambulanza navale. La società vor r ebbe preparare e distribuire alle truppe all'atto della mobilitazione 700 mila pacchetti òa medicazione.
La Bavier·a ha 47 colonne sanitarie di tr asporto, con 2,:100 a scritti. La società bavar ese ha un capitale offetlivo di 5R6 mila marchi.
Socie tà Ungherese - Membri 50,038 - Mezzi peruuiar• F. 1.!) 10. 735 .

Società Sassone - Me:nbri 1,748, 19 colonne di po rta feriti; capitale H .556 ma r chi
Società di Lipsia - 230 membri, 20 790 marchi di capitale.
Utw abusioo del segno della Croce Rossa. - La que<>tione dovendo esse•·e riproposta alla V conferenza - Rom a - s domanda qual seguito fu dato al relativo voto formulato nel !8 7 a Carlsruhe ... Il comitato inter·nazionale sollecita una risposta, pregando gli sia fa tta pervenire pr1ma del3 1 gennaio
Impiego del F oNDo AuGUSTA, per onorar·ne la memor1a Ascende a circa 49 mila lire. Si domandano propost<', ne llm1te di tempo fino al p r imo febb r aio.
A tlante della Croce R ossa. - Traendone ar·go m ento una car ta pubblicata da l sotto-comitato di Milano, il Coro•· Lato inter nazionale ha composto un Aliante i ndicante la pa rte alti va pr esa fino a d ora dall a a ssociazione e la sua nizzazione in tempo d i pace. Al Bolle ttino é anne<>sa uns ca rla, che s arebbe la 3\ • , de l Dorui nio della Convenzione di Ginevra e du li a Croce R ossa nel 189'1.
BIB LIOGl!AFI CA u.J
Cen n o sulla e sposizione degli oggetti di ar r edamento di un oaiHMale tras po r t a bile. - L a relazione passa iu rivista ad una ad una le diverse fo r me di baracche,dtJI punto d i v1sta delle esigen&e del servi zio: temperatur·a, umidit.à, conservazione, facilità di fabbt•icarle, costo, ecc. Si progeller·ebbe un ospedale di 400 letti pe r ogni corpo d'armata (quindi 20 in totale, con uoa ape!!a com plessiva di 4 milioni di marchi pel ricovero dr 8000 malati. È fatto cenno d ella r da t1va o rganizzazione, pPI maLE> r ia le d'ordinamento, il personale super•or·e ed inferrore.
del professor e Billroth sulle esigen.:e del serr:i.:ro Mnitario militare in gu e r ra. - Speci<dmente vi accennn alla neeessilà di un ingente numero di portatori e me:.:::l.i di tra!!porli. - ull'i llum inazione eletll'ica per la rice•·ca dei feriti CHmpo. - a ll' ordintJmeuto di una accademia milita.ee di medicina. B.
nY&lore d e lle sostanze ga..ose lmplegate nella dlslntlstone deg ll amblentl.- del dott. G•ust::PPB SASAVF:LL I. - (Giornale della R. Società d'Iniene).
Latte di ca lce. - È in rnolti casi mal s icu r·o SuLii mRto corrosivo ed acido fenico. -E sigono precauZioni d.frlcil i, cos tose.
Anidrite solforo!'a. - È d'azione fallac<>. - Non offr·e runzie .
Gas clor o. - Ancora meno emca ce e promettente. lpoazo ti le. - Efflcacra in costante. - n·azione eccessivamente corrosiva (dando, in contatto di oggetli umidi, luogo alla rormaz ione d'a cido nitroo;o e nitri co). - Sca1·so poter·e d• penetra zione.
b Conclu de : a deplorarsi che ad onta del facile uso e del 8680 prezzo, qnesti gaz non possa no uvi:!J'c una util1tà pratica rna è a deplorarsi an cora marzgior•mente che 1
C')ncetto de ll a lor·o efficiicia illusOI'ill non abbia ancora augger•to il d fi · · ' un e ru t1 v o abbandono di essi come agen ti di 8 ser•a disinfez ione.
Dunqu e ) S t t . · .... g r azw amen e non lo d ree! B.
Bollettino dell' assooh.zlone della Croce B ?ssa I taliana, N. 8. - Decembre 1891.
Il Rendiconto comprende anzi tutto alcune « notizie sulla attività e lo sviluppo delle principaìi società estere; alcune notizie necrologiche (Ungheria: conte Karo lyi - Olanda : Gori - Italia: Di Ferie, Famiano Fabio:1i, Palasciano); una bibliografia speciale delle pubblicazioni che vtlnnero ad arricchire nell'anno il patrimonio letterario della Croce R ossa (Haase: li ricove ro dei feriti e malati sul teatro della guerraIgiene militaN nelle Colonie, pubblicazione del comitato portoghese - At'redamenlo interno d'un lazzaretto portalìle, dei dott. \Verner e Schiitte, pubblicazione del co mitato germanico - Soccorsi d'urgenza, del dott. Cslliano - Sulle necessità d'introdurre nelle scuole second&rie l'insegnatpento sui ;::occorsi d'urgenza, rlott. Pelleg rini - La Croce Ross a, capitano medico Galli - doveri e la capacità dell'infermiere , pel dott. Ballario - Conferenze sulla Croce nossa, Moynier, Segre, Facch i ni).
Nella 2' parte conliensi il Rendiconto morale e,J economico pel i890 .
Degui di special nota r·isultano in essi i seguenti obbietti: La prova del treno- ospedale nel ìungo tragitto R oma-Na· poli-Potenza-T aranto-Ancona-Foligno-Roma; coll' e'fJerimento inoarè del materiale d ospedale, attuatosi in Na poli, e l'altt'O pel materiale di montagna (50 lelLi) a Genova, ed ancora a Napoli.
I corsi d'istruzione teoulisi a Torin0 (s ull'arredamen to tre ni), ed in diverse sedi di soltO- (:Omitati pel personale di assistenza.
L' ospe lale pella mat·ina di 250 le tti scindibile in due di 125.
Dal Resoconto am'llini stra tivo risulla che:
Bibliografica
Seguono i Bilanci - Preventivo pel i891 - L'annuario del personale (comi tato ce::!lrale - Commiss ione superiore dell' Unione delle Dame - Ruo lo generule del personal" di rettivo).
Le Relazion i sugli esperimenti di mobilitazione eseguitesi nel 18!J l cnn ospedali di g u erra someggiabili - (CosenzZappelli - Gorzor1i - Miniscalchi - Biasi).
Interessan te é il cenno della nuova costituzione delle Un ità spedalie r e da montagna, e i risultati delle modifi cazion i g gerit.e dai medici militari Guida e Mendini ; e l'altro sulla formazione dei treni-ambulanza coi carri merci delle società det tram.
Delegazi oni all'estero - Contribuzioni - Circoscrizioni te rritoriali - Dipartimenti marittimi e sotto-co mitato del Verbano -Appendice - Indirizzi dei comitati esteri. Estrazioni del pr estito.
Notizie
l trent santtal'i In Franc ia.
Uno speciale treno sanitario tra Parig i e Dieppe fu attualo nel lu glio scorso; coll'intento di esperimentare i diversi sis tem r d i sospensione e di sostegno dei lettucci e delle bareli e.
La qu estione d ei treni sanitari, ha in Francia avuto divers e fa si:
. t • Prescrizioni militari del luglio 1874, ;;ui tras por ti : ms tallazion i sommarie attuate al momento del bisogno.

·
2• Prescr izioni 1884: a) T reni improvvisali: b) Tren i pe r man e uti , ver i ospedali r·otabili.
3' Riconosciuti insufficienti, a meno che per e necP!;Sit.il i primi, impossibile organizzare in g-rande, eftlcAcemente i secondi, si organizzarono semi-per·manenti, da nel periodo di preparazione alla guerra. Si usano merci, con lucernario, por te alle estremit8. finP"t re nelle porte ruotanli laterali, con botole nel pa ''imento n me fogna.
Un trdno al completo consta d'un vagone pei me.jici , uno per gli istrument1, apparecchi, farmacia; uno per mieri (8 letti); uno per le provvisioni; uno pel e le sudicie; da 9 a 12 per gli infermi.
Ma lo stato maggiore calcolando, per un'armala di 600,000 uomini, nPces"al'i 450 tr eni di 128 malati, di 7500 vagonr (calcolando necegsario lo sgombro di 1/ dell'effettivo) necessitereLbero 40 milioni; che il materiale dell e compal-(niG san\ quasi intero necessario pei trasporti per l'esercito.
F.t quindi deciso che i treni di lusso sono da lasciare alle società e che il militare si debba limitare all'uM·dei treui merci e spec ialmente a quelli di ritorno di veltovagliamento, e1·c. In questo intento non resta va quindi che determinare i mezzi di trasformazione e specialmente di sospension".
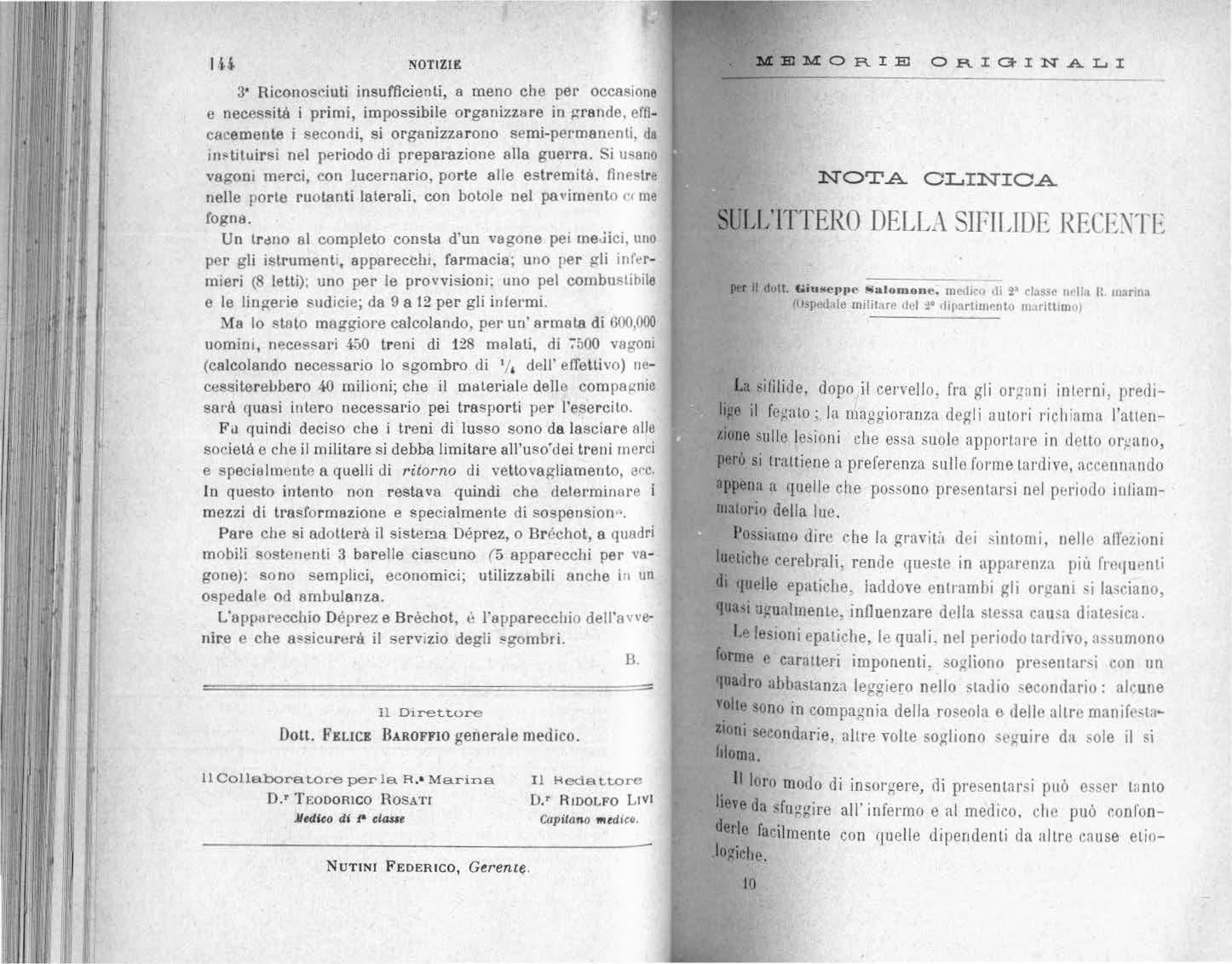
Pare che si adotterà il sister!la Déprez, o Br échot, a quadri mobi!i sostenenti 3 bsrelle ciascuno (5 apparecchi per vagone): sono semplici, economici; utilizzabili anche in un ospedale od ambulanza.
L'appttl't!cchio Déprez e Brèchot, è l'apparecchio dell'a H en ire e che a.;;sicurerà il servizio degli !'gombri . B.
Il Direttore
Dott. FELICE BA ROF FIO generale medico.
11 Collaborat.ore per la R .• Marina.
D.• T EODORICO Ros.a:n
Jlt dieo di t• elau e
Nu TrNr F EOER rco , Gerente.
Nota C L Inica
SULL' ITTERO DELL\ SlfiJJOE RECE:'\TE
Il Hedat..t..orc-
D.• RJOOLFO Lrvr Capitano tlltctìco.
La sifili de, dopo il cervell o, fra gli interni, predilige il fe;.:ato; la degli autori richiama l'all enzione sulle lesioni eire essa suole apportnro in detto organo, però si tt·a tti ene a preferenza sulle forme tardive, accennando appena a quelle che possono presentarsi nel p€:riodo inliammatur·io dell a lue.
Possitww din• rhe la gravitù dei sintomi, nell o all'ezioni lueticlr e cerebrali , rend e ttne..;te in apparenza piit fn.Jqu••nti di •ru ell e epatiche . iaddove entrambi gli or!.(anr si la..;ciano. quasi ug ualmente, influenzare della cau:-a li Gub ler (2) nel 11853 , per il pr imo, cercò dimostra re come l' iLLer izia no n fosse un'accide ntale complicazion e, ma un fenomeno parz iale della sifilide ; ne fece notare la coincidenza con le pr ime eruzioni cutanee o con le recidive, e la considerò q11ale effetto d' iperemia epatica.
L" lesioni epatiche, le quali. nel periodo tardivo, assumono rorme c caratteri imponenti, so:,diono con un quadro abbastanza leggiero nello : akune sono in compagnia della roseola (}delle altre manifp,;t.tZtoni :;econdarie, altre volte sogliono seguire da il si hlo ma.
Il loro modo di insorgere, di può l:tnto lieve da all'infermo e al medico. che può r,o nronderle fa cil mente con quelle direndenti da altre cause etiologiche.
'\Ton i· quindi per le loro graviti! che meritano tutla l'attenzione. ma per la loro importanza prognostica, poichè il loro sollecito manifestarsi dinota la poca re5ist<>nza dell'organo in presenza dell'infezione gener.1 le e la facile predisposizione di questo a sul1ire graYi e importanti alt<>nwoni consecutive.
L'itterizia, lluasi sempre, suole accompa!!nare le altf'razioni della sililide nel fegato; e mentre nel periodo secondario dinota leggiere altemzioni, nel periodo tarùiro annunzia i gravi danni che sono avvenuti nello stroma glandulare.
Quella che notasi nei primordi della 5itilide acquisita, nei giovani e negli adulli, non è da considerarsi più quale asse rto di semplice curiosità clinica, ma so lenne avviso pel medico e per l'infermo, r.ome si esprime il Cardarell i ( l).
Seuhene su tale forma precoce di sifilide epatica discordi no gli autori (3), non conoscendosi sulle anezioni secondar1e del fegato nulla di positivo, al dire del Lesser· (4), pure li criterio curativo che si deduce resta sempre come un ' im· por·tanto ragione per so.stenerne la causa Sia che essa dipenda da probabile stasi biliare per tumefazione della muco:;a inte5Linale e del dotto coledoco (Lesser), sia cht> di· penda da co ngestione reale e temporanea del fegato. nou si

(i) C\RDAilnLI. A l at<lttie del (e(Jato.
(2) de la Soc. de Biologie, i8:;3. Gazz. méd. de Paris, 185'•·
(3) Il Oaumlcr la ritiene <rual<l semplice itterizia catll!'ral0, i l T.anccrau' l\ ra deriVtl rO da possibile ingorgo dello gtandule liuratiche intorno la vena porta. LEssen. Jlfalallie della pelle e de(Jii organi sessuali.
SULÙTIERO DELLA SI FILIIJR RECE'<TE li-7
pa6 certamente negar e che la sifilide possa indurre tali altPruiODi nell' organo . e nel mentre sulla pelle si manifesta un eMDtema speci lico , ritrovar5i uno stato analogo nelle mucose iatestinal i e nelle vie bi liari.
Con ciò non voglinmo negare la possibilitit di un catarro duoden ale. di una calcolosi hiliare concomitante a fatti si fil itir i, senza alcun rapporto di dipendenza. Possono sassistere ins ieme entrambe le forme noso logiche, senza alcuna relazrone di causa ed etTetto, ma possono essere tra loro in compl eta òipende nza, come dimostrano i sintomi e gli en·etti eonsecut iYi all a specifica terapia.
Certaml3nte , perchè la sifilide nella sua estrinsecazione colpisca il fegato a preva lenza di un altro orgnno. vi debbono essere delle cnuse predisponenti ed etiolog iche le quali . preesistendo nell' organ o, ne determ ini no seco ndariamente la facilità 11d an11ualarsi .
E t{ uin òi tutte q uell e ca use cl1e concorro no a determinare disturbi circola tori i e funzionai i ne l fegato, h:wno gran parte Dell'etiol ogia dell' ittero sifìlitico : la ma laria , l'alcoolismo, i eatarr i agiscono come Yere e notevoli cause Predisponenti: e, l'infezio ne generale, !'orp oo in discorso . già precedentemente disposto nd ammalare, diYientl rneno adauo e incapace a resistere.
D'ord inario , risco ntrando le storie degli infermi, si tro\a qQasi sempre che in epoca anteriore patirono malaria o furono alcoolisti.
Cosi ancora le varie condizio ni individuali. il l'età. la eostituzione, le abitudini concorrono in gra n parte alla eomparsa dell ' iltero sifìlitico, il quale seco ndo gli autori si Presen ta a prevalen za negli ad ul ti e nel sesso maschile .
Come già di ce mm o, l' illero può ave rsi in compagni a de ll a roseola e delt' adenopalia ge nerale, e può compari re dopo la filo-sclerosi iniziale, senza che a questa segua altra manife · stazione. i• inqnieto, non sa darsene ragione e si preoccupa vedendo le restanti funzioni che si compiono in un decorso qua,, normale. l.e forme gravi si riso l vono più lentamente> sempre che non insorgano serie complicanze da parte del parcnchima epa·
La sifilide si annunzia con un illero che r icorda l' iLterizia catarrale, Ad i fenomeni che l'accompa gnano :.ono di pochis:;imo conto . I fatti gastrici ed intestinali n5coutrano leggi eri e di piccolo ril ie vo, il fega to è poco o uientP inf{randito, spor·ge appena al disouo dell'arco costale. ed è qna:.i indolente alla pressione. Snole presentar,;i an··lie la fchbre che oscilla l'ra i :38° e i 3H 0 , 5. dura due o tre giorni e poi rimette per lisi, senza alcun fenomeno d'importanza.
Però a falli si accompagna uno stato di male••ere c di depressione marcato, cosa che non si b. nel ittero catan aie. L'infermu. avanti I]Ul,;to suo stato peculiare.
<]ue:>to modo di procedere dt>lle forme leggi ere è ben differente da •ruello che assumon o le gr·aYi, nelle quali i sintomi collaterali si pre,;entano impnuenti e min acciosi. Difatti notansi serii di:Httrbi gastro enterici, tumido, con asci te più o meno notevole , diarrea piilllosto profu-;a e non rar l'albumina nell e urine.
Jlelle formo sono di pin difficile diagnosi. e comport;lllil quindi grande accorgimento nel ricercare l'anamnesi, e nell'osservare l'infermo (Cardarel li).
La durata dell' iuero slfilitico. nelle sue formo leggierc non olt: epassa le due o tre settimane, in elasso di tempo. i fenomeni vanno man mano perdendo d' intensiliL, a misura che la cura spet:ifica risolve il proces:'o. l' inft'rmo migliOri nel suo stato psichico e somatico.
SUt L'JTTimO llELLA SIFILIDE RECENTE ueo, per le qu ali questo venJ.ta compromesso e complicato iD modo duraturo con esiti più o meno funesti . Il Jde (t) descriv e un caso di atrofia acuta. del fegato i n u giovane a !O anni, due mesi dopo il contagio. contemporaneo alla
L•esito dell e fo r me di tale manifestazione sifilitic·a, oella gran maggioranza dei casi è faYorevole: possono aversi le recidive , le q uali naturalmente peggiorano di piu le con d z ooi epatiche .
Ed ì· per (jU es to che la progno' i dovrà sempre risenata non per la vita, ma per IH restilutio ad inle!JTIIm della parte lesa, stante il riconosciu to manco di resistenza dell'organo, in rispetto all' inrezione contratta: poichè questi fatti ript>tu ti fi niscono col determinare reali e persistenti alternioni an che nel connettivo e quindi tutte le eonsegu enze inevitabili.
La coin cidenza dei sintomi di sifilide recente, quali la polradenopati<\ e le manifestaz ioni cutanee od osteo-periostee, la po<'a o partecipaziOne da parte dello stomaco e degli intestini , l' asse nza di calcolosi biliare. lo stato di marcata prostrazi one generale e In breve durata dell' ittero quasi tutte condizioni indispensal.lili per la tliagnosi.

[a cnra non dere rivolgersi alla sola produttrice, 111t an cht> a r egolarizzare la disturbata funziona liti1 del fep to. fjuin di nel me ntre coi le)!gieri e ripetuti purganti. colla dieta lattea, coi lavaggi asellici dell'intestino s i cerca d i ottenere l 1 re,:tolarizzazione di con l'attiva cura mercuriale ai Yince la diatesi sifrlitica.
A qu esto scopo corrisponde benissimo. a preferenza deg li altri metodi, l'uso delle frizioni di pomata mercul'iale, praticate in modo allemo 3J.!li archi plantari, da seguitar:-i anch t doro la completa scompar·sa dell' itle1·izia, secondo il speciale, onde maggiot·mente combattere la causa genetica . novembre dello stesi:o anno. si contagiò di ulcera 1e· nerea e blenorragia e venne perciò rico-remto in quest"ospedale, con ndenite ulcorosa suppurata all'inguine destro. Du· rante la sua permanenza in sala, comparve una marcata ilteri:.:ia con modica febhre, la qnalc dopo qualche giorno rimise.
Storia 1•. - 11 marinaiv N. A. di lmona costituzione, si contagiò nel marzo 00 di ulcem dura, rui ;<egui poliadeDite e roseola. J>ralicando la l:lll'a mercm·iale per via ipodermica si manifestò un :,ililoderma bolloso, del quale an•·ora" osservano le vestigia .

All 'osservazione il fegato si presentava leggermente io· gros:.aLo, tanto ùa palparsi al disollo dell'arco costale. hscic e levigato a ll a superf icie, per nulla dolente alla pressione. Il bordo anteriore della mil:.:a, ingrandita per m.1· !aria, si riscontrava nella linea ascellare media. Le funzioo gastro-intestinnli, salvo lcggiera st ipsi, erano norm ali; le urine di colorito giallastro.
L'infermo accusava una grande prostrazione di forzr, che non sapeva spiegarsi, e circa le notizie anamnestiche da,·a solo di aver soiTerto febbri malariche, stando nel Veneto.
Oietro attiva cura mercuriale per frizioni, dieta lalte3· leggiere dosi di rabarbaro e irrigazioni intestinali, l'anormale pigmentazione cessò in Lreve elasso di tempo.
Stm·ia .2'. - Il marinaio N. S., di poco valida costitu· zione, venne ricoverato in questo Ospedale nel novembre 90 per ulcera dura e blenorragia int ensa a scolo sa nguinolenro
St:I.I.'ITTERO DELLA SlllLIDE RRO;Nn: 151 con febbre. Dopo una ventina di giorni, comparsa la roseola, la iniziata la cu1·a mercuriale, pratkando la quale si presentò uo'iott>nsa itterizia.
Notavasi il fegato poco ingrossato. sporgente appena al disotto dell'arco costale e niente doloroso alla pressione: la mil1.a era leggermente ingrandita, le funzioni gastro-intestinali si comportavano normali, le l'eci scolornte e le urine di colorito l{iallastro.
L'infermo mostravasi mollo depresso nel generale.
Spes.;e volte. interrogato circa i dali anamnestici. assicu rò sempre di non aver mai :'OITerto calcolosi biliare e coliche epat id1e, di non aYer abusato tlellt' bevande alcooliche, di aver per lo passato, ahi lato paesi malarici.
Con h cura mercuriale {rrizione), la dieta lattea e i lavaggi l' illerizia in hreYe scomparve.
Storùt 3'. - L'inrermo R. S. non ebbe a soiTrire malattia di sorta alcuna sino all'età di anni 18 , epoca nella quale contrasse le febhri malariche, lavorando nei dintorni di anni successivi fu colLo da febbre tifoidea.
Entrava in questo Ospedale il 16 settembre del corrente anno e veniva 1·i coverato nella Venerei per sifilide costitui.JOnal e recente e itterizia.
Osservando l' inrermo notasi un generale colorito itlerico le cougiuntive sub-ilteri che, le altre mncose piuttosto pallide: nel solco balano prepuziale si rinviene un' uleera dura ìn via di riparazione. i gangli ingninali, epitrocleari e et>rvicali so no duri, ingrossati e nmigda li formi, le superfici anteriori dell e tibie sono dolorose a lla prel'sione.
All'esame il fegato si presenta ingrandito, pm· consenando i suoi limiti fi sio logici in alto, si palpa al disotto dell'arco costalt• in e quivi 1\ doloroso al tatto: la milza è nnche essa ingrand ita. L'addome è trattabile e le funzioni gnstro- intestinali si compiono non vi è anores,ia, 011 p irosi.
L'infermo non si lamenta di alcun disturbo particolare da partt> delle vie digerenti; richiama l'attenzione sui dolori notturni e su uno stato di generale e mancanza di forze.
:\on c :stato mai alcoolista, n<\ sa dare spiegazioni circa l'origine dell' illero.
Storia 4". - L'infermo A. 1'. ricorda di essere andato incontro a fehbri malari clto e ad itterizia catat·rale.
Due mesi fa si di ulcera. a cui segui poliadenite, senza ahma manife;;tazione: venne rico\ erato in que,..t'Ospedale, e qui vi co minciò a notare, senza cau:>a d' importanta alcuna. la sua colorazione itterica, seguita da leggi ori disturbi gastro-enterici e lieYe dolenzia alla regione epatica.
All 'esame questa si presenta quasi normale; la milza c ingrandita. Salvo un generale malesset·e non viene dal malato accu:-;ata altra sofferenza.
UtERHI UNE
Per Trauma Al Perineo
per il dott. Gittsc-J•P f' n o,...i, nd 61° faotelia
Mentre di r igevo l' infermet·ia di presillio di Fenestrelle nel dicembre t X90. ho avuto occa::ione di curare un grave caso di rottura traumatica dell' uretra nella sua porzione prrineobolbare, in un soldato del 6 l" fanteria.
Quantun que il caso che sto per esporre non sia certamente nuoTo . l' espo,.izione non ne tornerit forse affatto inutile, concorrendo ad illustrarr l)uella parte della chirurgia che riguard a le in dicazioni di urgenza a cui si rleve sfare in si mili congi u nture.
Difatti nessuno può disconoscere l'importanza che ha l'intenento dell 'arte in qnci;le lesioni che prendono posto fra capitoli piil della patologia delle vie urinarie . Ecco la storia :
Soldato Bonot'a Romolo, 61 o fanteria. c\a-;se
486U, distt·etto di \l antova .
.!9 dicnN lir e 1890. I ndividuo di costituzione robusta.Verso le ti po m. nel discendere in posizione laterale una llretta scala d i legno posta in una camera buia, non avver- tendo la mancanza di un gradino, precipitò colla gamba destra nel vuoto del solloseala, scivolando contemporaneamente colla sinistra lungo la gradinata . .\ questo modo il perineo venne ad urtare violentemente, s peci alm ente con la sua metà sinistra, contro il sostegno verticale del grad mo mnncante.

81 ebbe immedi atame nte una imponente uretrorra;.;ia.
11 paziente si quasi subito alla v isita e. raccontate le parti col aritit del fatto, di:>se che pochi minuti arant" aveva orinato provand o un acuto dol ore, che paragonava al passaggio di un ferro incandescente at traverso il canale uretral e.
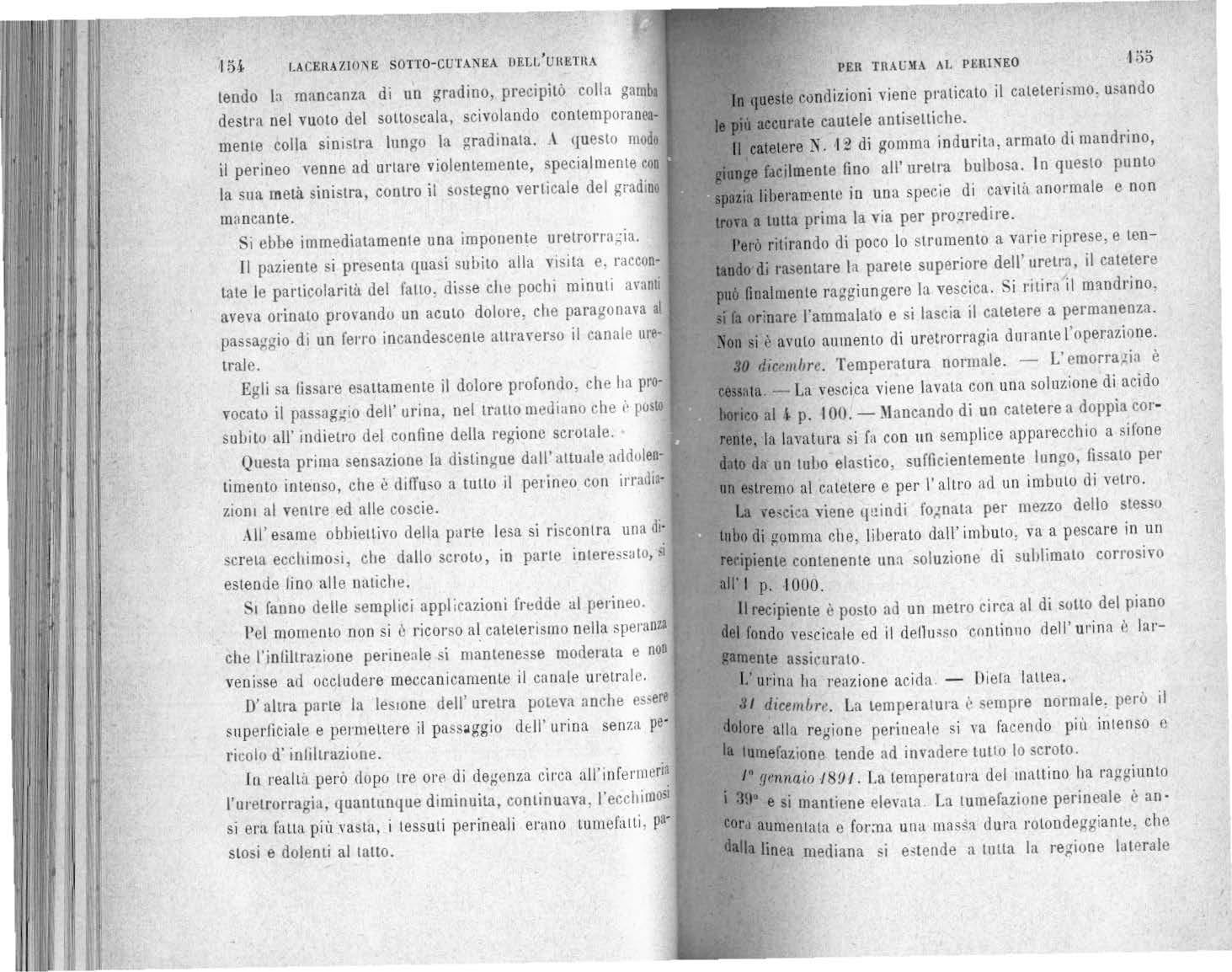
Egli sa lis:oare esatlamente il dolore profondo, che ha provocatù il passaggio dell'urina, nel tratto meùiano che t'posi( subito all' inùietro del co nfine della regione scrolale.
Questa prima sensazion e la distingue dall'attuale arldolentimento intenso, che è ddTuso a tullo il perin eo con irratlJa· zion1 al ventre ed alle coscie.
Al l'esame obhiettivo della lesa si ri scontra una d1 · ecchimosi, che dallo scroto, in parte intere:'sato, s1 estende lino all e naticl1 e .
S1 fanno delle se mpl ici applicazioni frt::dde al peri neo.
Pel mo111 e nto non si è ricorso cateteri smo n ella speranza che l'i nlill ra7.ione perin ea le :.i moderata e non venisse ad occ ludere meccani camente il canale uretral c.
D'altra parte la les10ne dell' uretra pott::va and'e es,ert snperfìcia\ e e permettere il dE: ll ' urina senza pe· ri colo d' inltltrazione.
In realta però dop0 tre ore di degenza circa l'uretrorragia, quantunque diminuita, co ntinuava. l' ecchimosi si era fatta più vas ta, i tessuti perineali emno tum efalti . pa· stosi e dolenti al tatto.
Per Trauma Al
quesle condizioni viene praticato il cateteri:-mo .
Je p;u accur.lle cautele antisettiche. . .
11 1z di gomma armato d1 mandnno, ;unge fclcilmeot c fi_no all' urelt.'a In punto spazia liberaiP-entt' t n una spec1e d1 ano1 male e non trova a tutta prima la via per re.
Però ritiran do di poco lo strnmento a varie riprese, e tentando di ra:;entare h parete superiore dell' urctrn, il catetere può finalm ente ra ggiungere la vescica . Si ritira il mandrino , si fa orinare l'am malato e si lascia il catetere a permanenza. Non avuto aumento di uretror-ragia durante l'operazi one. 30 dic••mbr e. Temperatura normale. - L ' è cessata. - La vescica viene lavata con una so luzione di acido borico al i- p. 100.- )l ancando di un catetere a doppia corrente, la ln\'at ura si fa co n un semplice apparecc hio a sifone dato da un tubo elastico, sufficientemente lun go, fissato per un estremo al catetere e per l'altro ad un imbuto di vetro.
La ·:t Yi ene tJ'! indi per mezzo dello stes;;o tubo di ch e, liberato dall'imbuto. va a pescare in un retipiente contenente un a sol uzi one di suhli mato corrosivo all' l p. l 000.
Il recipiente è posto ad un metro ci rea al di sotto del piano del fondo vescical e cd il dellu;;so ('onlinno dell'urina ò largamente assicurato.
1.' ut·ina ha rea zione acid a - Di eta lalLE'a.
31 d1cemlm•. La tempetatu l'a t' :;empre norm al e, però il dolore alla regi one perineal r si va f'a ce ndo più intenso c la tumefa1.ione tende ad invadere tut to lo ·eroto.
1• [Jmnaio 1801. La temperatura del mattino ha ra)!giunto i 3\t• e si mant iene elevata La tumefazione perin eale è anaumentata o for;n a una dura rotonde ggianhJ. che dalla linea mediana si e;;tende a tnlla la rer(ion e lateral e sinistra del perineo. vi è traccia di fluttuazione. quab.i<l'i scn'o di elasticità del sulla re,:ionr. mediana . mentre lr.tera lmente si ha alla palpazione un cer to senso di impastamento. Lo stwoto ,., in islato di forte edema infìarnmatoritl. Si decide di ,-enire senz'altro ad un allo operativo. l' n centimetro ci r·ca all'esterno del primo taglio vi i· un certo nso di elasticità. l n questo punto s'imme r ge il bis iuri ed all a pr ofond itiL dì dne centimetr i fLtOr('i'ce un getto di pus fetido. icoroso. misto a bolle d'aria .
Il paziente c messo ne ll a come per la litotomia. Rnso i! perineo e disinfettato largamente il terrE:no operatorio, viene un'incisione sulla linea mediana. collo scopo rli giungere alla supposta raccolta purnlenta profonda per la \i a seguita nell'operazione dr li' uretrotomia esterna.
.\ tJ Ue:>to modo. ricordn ndo il dello: in medio il1is, si segu iva la strada più classica, ma che pe l momrnto era più lunga e lliflicile.
I nfalli, praticati i primi tagli nei tessuti superficiali profonda mente in fil tra ti. esplorando la frrita, si sconeva sopra un tessuto sempre ugualmente indurito, senza avere naturalmente alcuna sensazione della siringa di gomma indurita che era giu n ta in vescica .
In tanto le labbra dell'incisione mancavano assistenti che le divarirate) addos5andosi, a' rehbe ro obbligato a p rocede re cecame n te fino ad un a scono · sciuta profondità.
Per· queste considerato che il centro del tumore era a della lin ea media na, che pe l mome nto l' IOdicazione d' nrgenza Pra quella di aprire l'ascesso prù far ilml'nle raggiungibile con un' incisione alq uanto a sinistra del rafe. si alJba nd ona la p rima strada.
Si irrigano generosamente le parti co n :;o luzione di snh· ltJimaLO corrosi vo all' l p. 1000. Coll'indice della mano dtstra nella ca'\'ilit deJI';lscesso si giung(' alla sede della lesione uret rale. In corrispondenza della po r·zione bu lbosa si rinviene un a penlil':t di sostanza cl1e intcrrssa Lutto il 'iuento laterale ed inferiore. I molto irregolari tlrlla lacerazio ne si adag iano per cosi dire sul catetere. che deve e'sere j.!Ìunto in vescica la parete ;;upenore iiiP;;a Si fa una medrcazione nnti:;ellìca, si colloca il pazientt• nel rlec uhi to dorsa le e si fog-na la 'escicn. j gnnwin . La temperalur'<t è al normale. Tanto l'emis.;ionr dell'urina quanto la lavarnr,1 della ve,;cica si eseguono tlinicilm ente per un impedimento meccanico nel lume del catetere dato dall'accumulo di muco Yisciùo traspHente. i estrae rl e si f,l passare :.enza alcnn inconveniente la siringa .:\'. l i- con cui si estrae l'urina. Qne,ta ha reaz'ooe a•·i-la, t'· leg!.!enuente inlorhitlata e. filtrata. contirne searsi\ tjnantitit dì albumi na. Il paz.ienre dei leggeri dolor·i intermiltentì nella regione \'('sricale e prova frequen t i stimoli alÌ urin are .:\'on ostante que.;ti sintomi ohiJietti' i e :mbbienhi tli un leggiero rat.uTo ve:.cicale, si lascia il catetere a permanenza clti udeudone con un piccolo turacciolo la estremità e--terna e trala:.ciando di fognare la \'escica per evitare ana po,izion e da lungo tempo troppo incomoda all' infermo. t 'esame ctell'u1·ina dimostra che il catnrro s i mantiene sempre leg!!ierissimo.

!!io r ni 3. i- e ?) gennaio 1.1 yescica tollera hene il cateter·P. Le cond izioni generali sono eccellenti. S' insigte come fin dal principio dPIIa cura sulla dieta lattea, sulle sommin ,-;trazioni generose di salicilato di soda e sui lala,!gi \'esc ica li .










