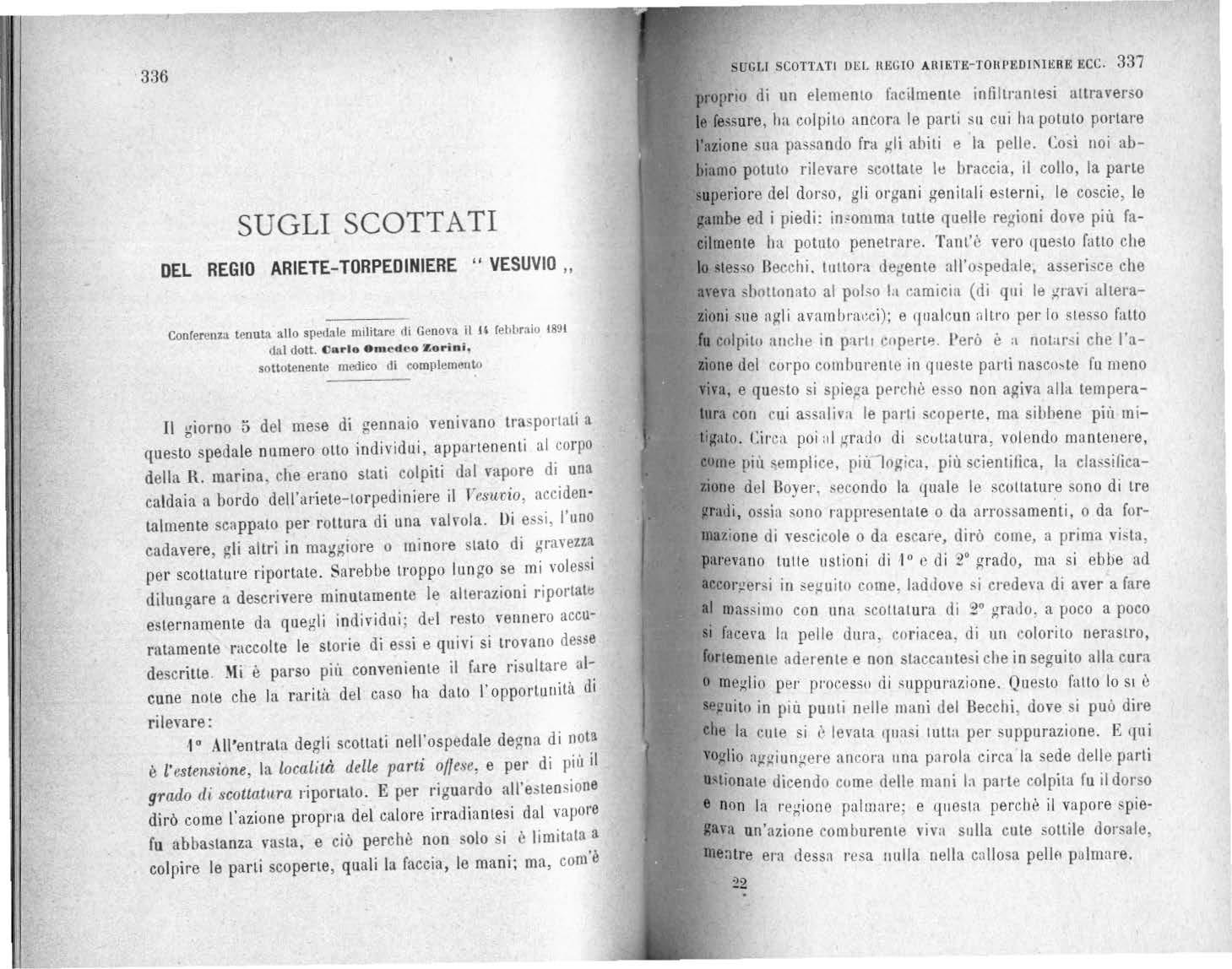
9 minute read
SUGLI SCO TTATI
DELREGIOARIETE-TORPEDINIERE"VESUVIO ,
Conferenza allo spt>tlalc militaro eli Genova il t4 fehltraio 189 1 clal dott. CJ11 r l o Ootedco Zorin i, sottotenente di
Advertisement
Il giorno 5 del mese di gennaio venivano tra"portati a questo spedale numero oLto individui, appartenenti al co rpo della R. marina. che erano stati co lpiti dal vapore di una caldaia a bordo dell'ariete-torpediniere il T't'Stttio , accidentalmente sca ppato per rollur·a di una valvola. Oi essi. l' uno cadavere, gli altri in maggiore o minore s tato di gravezza per scouature riportate. Sarebbe troppo lun go se mi dilun gare a descrivere minutamente le all er·azioni esternamente da quegli del resto vennero accuratamente raccolte le storie di e:-s i e qn ivi si trovan o desse descrille . 'l i è parso piit conveniente il f,tre ri sultare alcu ne nole che la rariti1 del caso ha dato l'opp ortunità di rilevare:
·1° All'entrata degli scotta ti nell 'o sp edale degna di nota è l' estensione , la località delle parti ofleM, e per di piir il grado di scottatura riportato. E per ri guardo all'estensione dirò come l'azione propl'la del calore irradinntesi dal vapore ru abbastanza \'asta, e ciò perchè non solo :;i •' limitata a colpire le parti sco perte , quali la faccia, lo mani; ma, com'è proprro di un elemento fncìlme nt(' infìltruntesi attraverso le ha colpilo ancora. le parti ::; u cui ha potuto por tare l'azio ne sua passando fra gli abiti e la pelle. Cosi noi abbiamo potuto rilevare scottate lt: braccia, il colto, la parte superi ore del dorso, gli organi genita li es terni, le coscie , le gam be e<l i piedi: in,omma tutte qu elle regioni do\'e piu facilmente ha p otuto penetra re. Tant'è vero questo fatlo che lo Bete h i. tu !tora degente all' o;;pedale, che a,·eva sbottonato al pol;;o !.t eamic1a (di qu i le alterazio ni sne ngli e tfnalcun nl tro per lo stesso fallo fu anche in p·1r11 cnpérL"'. P erò è a notarsi che l'azi one del corpo comh urent o in queste parli fu meno viva, e qu es to si sp iega pt>rchè non agiva alla temperatura con t•ui assaliva le parti scoperle, ma sibben c più mitigato. poi al 1-:l'<ulo di vol endo mantenere, cume più semplice, piit logica. più scie ntifi ca, la zion e del Boyer, secondo la qual e le scollature so no di tre jlradi, ossia sono rappresentate o da arrossamenti, o da rorma t.•one di vescirole o da esc are, dirò come, a prima vi :-.ta. parevano tutte ustioni di l o e di i. 0 grad o, ma si ebbe ad accor·).!'er.si in sef.! uito come. laddore si credera di aver a rare al co n una scollatura di 2° grado. a poco a poco si l'aceYa la pelle dura. co riacea . di tlll t'O iorito rrerastro, fortemente aderente e oon st nccan tesi che in seouito alla cura " o meglio per proeesso di s uppurazione. Qneslo falto lo sr è se).!'nito in più punti n d le mani del Becch i. dove si pu ò dire che la cute si ì• leva ta IJlWSi lutta per sup purazio ne. E <fUi voglio ancora una pnrola ci rca la sede delle parti U'tionat e di cendo co me delle mani la pa rte co lpita fu il dorso e non la reg ion e pnlma re; e ques ta perchè il vapore s piega,·a u n'azi one comb urent e \'i\•a su lla cute sotti le dorsale, me :1 tre era dess a re sa nulla nella callosa pellfl p almare. t 0 Un altro fallo degno di nola c che si ritiene di valore granrfj-;<;imo r questo: in toLti i !ratlati :-i ammette com e la morte in primo per·iodo negli scotta ti o per 8/w k o per i interni, o per lesioni di visceri. La morte in cin que degli indiYidui colpiti non poteva certamente :n venuta per slwk perchè mancarono io essi affatto i sintomi proprii •li accidente morboso; non •lireuamente per IP.sioni di Yisceri. perchè il vapore non ha att1crato molto profondamente le parti sn r ui ha agito; piuLiosto si può dire che la mor·te fu uuicamente cau:;ata dalla ronl-(estione ed edema bronchiale e polmonare. E difatti le le:>io ni gr·avi esterne non potevano essere la r::usa della sospensionr della vita, perchi• in Ciaramitaro, in ed in (}esnalclo non erano molto e.;tese - non lo shok perchè il traumat ismo non fu eccessivo; tutt'a l più si trattava di scottalllra non approfondentesi oltre il derma. Invece le autopsie hanno chiaramente dimostralo come l'iniezion e, la causticazione laringea le, la congestione ed edema dei polmoni furono la sola causa della morte in lutti qnelli che socr.ombellero •rni all'ospedale e in quelìo che ci \·enrw p •rlato cadavere dalla torpedi niera. Di tre è :>l.•ta falla l • se zion e cada,•erica, ma in lulli si sono rimarcati i fcrHHHe nl bron co-polmonari: anzi in Ge,;ualdo. nlla base di uno de i polmoni. :-i not ·l\a l'inizio di una pneumonile reattiva. 1li p;it il cuore destro ripieno di il cervello pure mollo ·onge,tionato, i sen 1della dura madre tur E questo t' inter essante a perchi· il vapore ha agito intern amente piìt co me un .-c1 lidu comburente localmente, che come un ;:a:;: ma mentre l'azioni'\ sua locale fu vasta e solto un certo punto di vista limitata in profonditù, fn sntJiciente per produrre morte . penetrando attraverso la lari nge nei bronchi r polmoni. E tho si <lehha a que;;to sol? l'esito fu nesto di quelli
DEL REGIO « \'&SUVIO »

do,eae ro so:rgiacere lo prova ancora il fatto che il i. il quale, pur·e esse ndo fra i più offesi 'pst erno. si è salçato perchè, usando l'accortezza di tumrsi t.occ'l . ha risparmiato, almeno profondamente, t.:h organi "ra to r i1 . quantunque è a dire che non andò rmmune aftl i fenomeni fari ngo lari ngei. a \'endo presentato durante la cura nn bre\e periodo di reazione al11 Cosi l'ebbe non che, accorto, si mautenne la testa tmm er,;a quasi nel carbone - nella carboniera.
Il decorso della malattia preseulato da quelli che banno lasciato la vita, come d .1 quelli che soprav vissero è inte ressan tissimo. Il decorso dei primi fu molto breve e molto graYc. Presentarono subito fenomeni allarmanti - una agitazio ne specia le e generale, elevamento febbri le, sete viva, disfagia dolo rosa, vomito auche sang uigno , come d Gesualdo ( per cui probauililtt di alteraz ioni ga6triche) - polso fre •prenti ssimo e piccolo, tosse con espettorniono muco-sauNon si poterono apprezzare i fenomeni Lorn cici, pt>rch è non si vollero i malati nei brevi momenti di vita toro concessi. Le scotta ture esterne non poterono modilic::rsi: si notò soltanto che le si cr nno sYuotate: l'e tema , il cu tan eo t>ra diminuito. si i· potuto accer tart> il delle srotta ture. perché, com ' è ben accennato nel Folli n, nel suo trauato di ch irurgia est••tn a, quand o trattasi di 4-", ::>o !.!rado, solamen te il depuò accertarne il limite e ::.uccede benissimo che la scottatura. la al t o dì Ila tutte l'apparenze del 2° grado; al al 5°, al G 0 giorno rli,·enta profonda e roo.;tra la mortifi cazione di più tessuti. Quindi di es,;i è da os>crvar,..i so lo che il decorso fu fatale e che l'arte salutare non po tè che atle,•iare le soiTerenze troppo gravi degli infermi. 11 Gesua ldo , che sopravvisse pil1 di tntti que lli cui toccò l'esito letale, ai primi di non manifestò tosto fenomeni mortali. come gli altri; fu soltanto al o t • giorno di degenza nel riparto che si fecero imponenti i falli da parte dell'apparecchio respiratorio ; quando . cioè l'edema della glottide ha suhito portato la minaccia 1li del po\·ero malato. Si manifestarono i car·atteri della cianosi in volto e della congestione polmonare con paralhi laringea e infine la morte.
Venendo ora a trattare dell'andamento di coloro che :-opmvissero e chP ormai si contano guariti, si può di\·idere esso in tre periodi. come o,.rni trattatista divide il decor·,;o dell e scollature che hanno esito beoizno. Nel 1° periodo ,j carntterir.zarono i fatti irritati vi. ossia irrequietezza dell'indi· vid uo, clolor e \'ivi:;sinw alle parti scottate ed in J.!lll't i non sco ttate, sintomi di disfagia, di cata rro gastrico, di di frequenza di polso, ecc., fotti tutti questi che trovano una spiegazio ne nelle alterazioni locali cut<1n ec estrrne etl interne, ed anche in parte nell'impressionE>. moral e, nell' eccitahilitil dal traumatismo, dalla vista di coluro che giorno per 'enivano a mancare nei letti vicini. E tanto è vero que, to fatto che il Lamarra stesso era ai primi di, anzi il giorno alla morte del Ge· snaldo, de;.:ente al letto vicino, più di ogni altro si mo<;trò irrt'IJnieto. per modo che due iniezioni di mortìna non al·eyono che un o :;rarso e questo si può ripet('re pt>r il Pilie,go e per il Be cch i.
Tn questo periodo ancora a notarsi due fenomeni. i quali sono all'atto per i casi ri coverati nel spedale. l 0 quello che . mentre gli autori dinotano negli scollati una partecipazione ai sintomi morbosi da parte dell'inLE\s tin o con una diarrea qui invece si è se mpre avuto a combattere per più tempo la stitichezza o:> tinata;
OEL REGIO « VESUVIO » 341 fatt o e che è perdurato a lungo drl di freddo intensissimo avvertito da tutti gli scottatidi freddo che non è ;;comparso colla medicatura delle ustionate.
La spiegazion e di quest'u ltimo fenomeno non è troppo fape rchè bisogna dire abbiano contribuito una serie di · a promuoverlo ed a mantenerlo: "ia che lo si YOglia atllì!Miet::ere in relazione colla irr.1d iazione calorica cutanea auta, sia colla sensibilitt1 ner\'o'a squisitamente a che dipend a. da qualche elemento specifico nelle ,arti scottate. A questo periodo 1.• succeduto quello della :lllppurazione. La febbre si è mantenuta durante questo tempo ahb,lstanza accentuata fino a salire ai :19"5 ed anche 11 gr·adi ascellari. È qui che andarono via le escar·e, che le mani, la faccia de;jli scollati si fecero abllondant emente suppuranti , tanto che si era ùhbligali a venir a r.rre due medicazioni al giorno. [n Lam [U'I'a e Pili ego •uesto peri odo non ebbe un decorso lungo, circa otto giorni, e lo si de vo al fatto elle le scotta ture da essi riportate furono latte di 2° grado: non cosi nel Becchi in cui si mantenrHI molto lan;:o perrh è fu intaccato anche abbastanza vivamente il derm a: per questi ebbe la durata di quasi quindi ci giorni. la rea1.10ne febbrile però si mantenne per pochi ginrni. ces lindo affauo in seguito alle medicazioni ripetute ecl alle abbondanti !arat ure.
Il pet·iodo di cir.alrizzazione fu abbastanza breve: e questo per due ragion i - primo perchè il processo di riparazione ai fare va sopra tessuti giovani e. pieni di vitalitit rigeneratrice, - sero ndo perchè, fatta eccezione per taluni punti uel Becrhi , 11 0n si ebbero a lamentare ustioni oltrepassanti il derma, cosicchè i tessuti perduti si riparavano per epidermide di neo furmazione- mentrechè nel Becc hi, là dove vi fu pe rdita totale del denna (do:-so della mano. collo, palpebre inferiori. padiglioni delle orer.chie}. la cicatri ce, quantunque rapidamente formata, pure si è dovuta fare per bottoni di granulazione e br·iglie
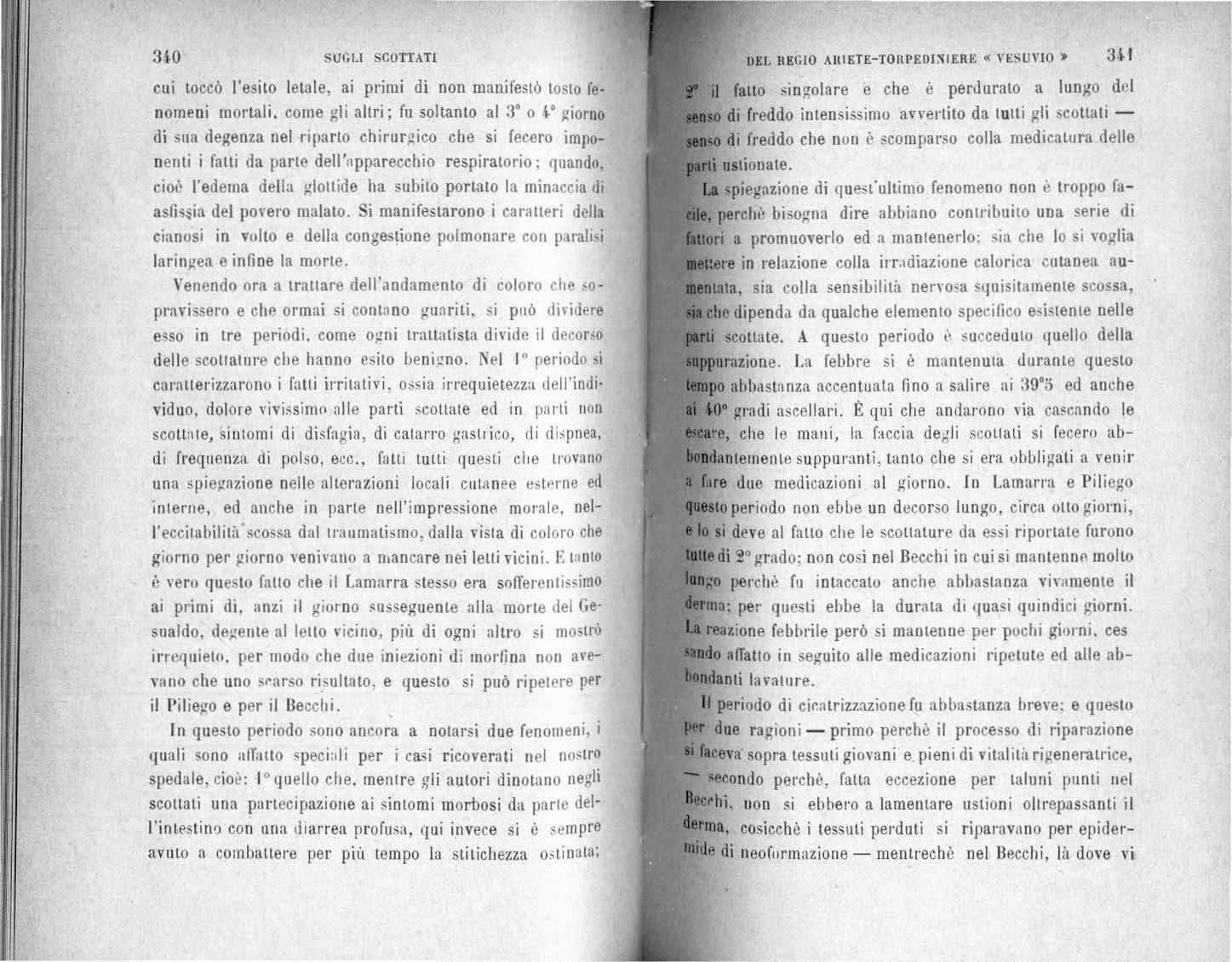
1-0 Perciò che riguarda il trauameoto curativo ·li 1'nlorn che si sono devo nggiungere che a principio fu per l'una parte per l'altra dep rimente o me.!l io narcotizzante, e crò per sostenere le forze e nello tempo per dim inuire la ipPreccirah rlità e òolorahi litit dei ferrt i. Fu qui appu nto che f\ osservato un fallo abba sta nza cu riww e che forse trova la s•1a rag•one nell'a1.ione eflìcace del n me l ro. Il sig. maggiore Oe Prati, vedendo che anche dne iniez io ni di ci<Widrato di rnorflna nel Becchi non ollenevano alcun eiTetto per conciliar>tli il sonno notturno, e di più ved endo che Il' forze dell'individuo erano alquanto abbassatA; ha pensato di far precedere alla ioie1,ione di morfi na una di citrato di caffeina; cosi ottenne magnificamente la scopo. E,( lr allo ra ha spiegato que,to fenomeno di per se elidentesi nell 'eiTelto, nmmetle ndo che la caffeina predisponeva i centri sensoriali a risentire dell'azione della mor·fina, che in linea I l tr,, Ltamento cunsecutivo generale fu toni co, ricostituente. Localme nte si (• curata perfettamente l'igien e, la pulizia: togliendo tutto ciò che si mortificaYa man che la s uppurazione distingueva la parte sana dalla malnta , facendo abbo ndanti lavature boriche, ricoprendo con imhevuta nella soluzione di sublimato le parti suppuranti, mentre si ricopri vano le parti no n suppura nti con compresse spa l· maLe di vaselina borica. Questa è la cura raziona le ch e si è in tutti e tr e gli ammalati salvati, facendo rn moJo che le pa rti sco ttate ven issero alleviate dal dolore. difese dal· l' aria e nello ste;;so tempo sub issero una certa com-
_pression e, a lla quale ha attribuito immen si vantaggi nelle scollature il Yelp eau.
Volen do ora fare un lìnall' si de' e dir·e che, dopo pochi gio rni di degenza all'ospedale , il Lamarra. ed il l 'ili ego _ poterono perfettamente !{Uariti tornare alle proprie case, quantunq ue il primo ave:-.se dato serie apprensioni sul suo stato J!enerale e su lle località oll"ese. Del Becchi non :>i può dire che le cose sieno anda te così perchè, tjuantunqu e egli pure sia in 'i a di guarigione prossima, pure - essendo stato il più e profondamente leso- non si è potuto avere in lui in o; ni parte la riparazione per neoformazione di epidermi!le- restitntw ad incegrum di tessuti - per modo cl1e al co llo , al dorso delle mani, alle palpebre inferiori, ai pa liglionr delle orecchie, rimarrtl un po' d i deformità per le cicatrici retmeutesi.
In ogni modo però sono questi risultati buonissimi, viste le :.:ravi alterazioni riportate. e se questo si deve alla resistenza e riaLLiviLit organica individuale, lo si deve ancora alle pazien ti e continuate cure tlel maggiore medico De Prati.











