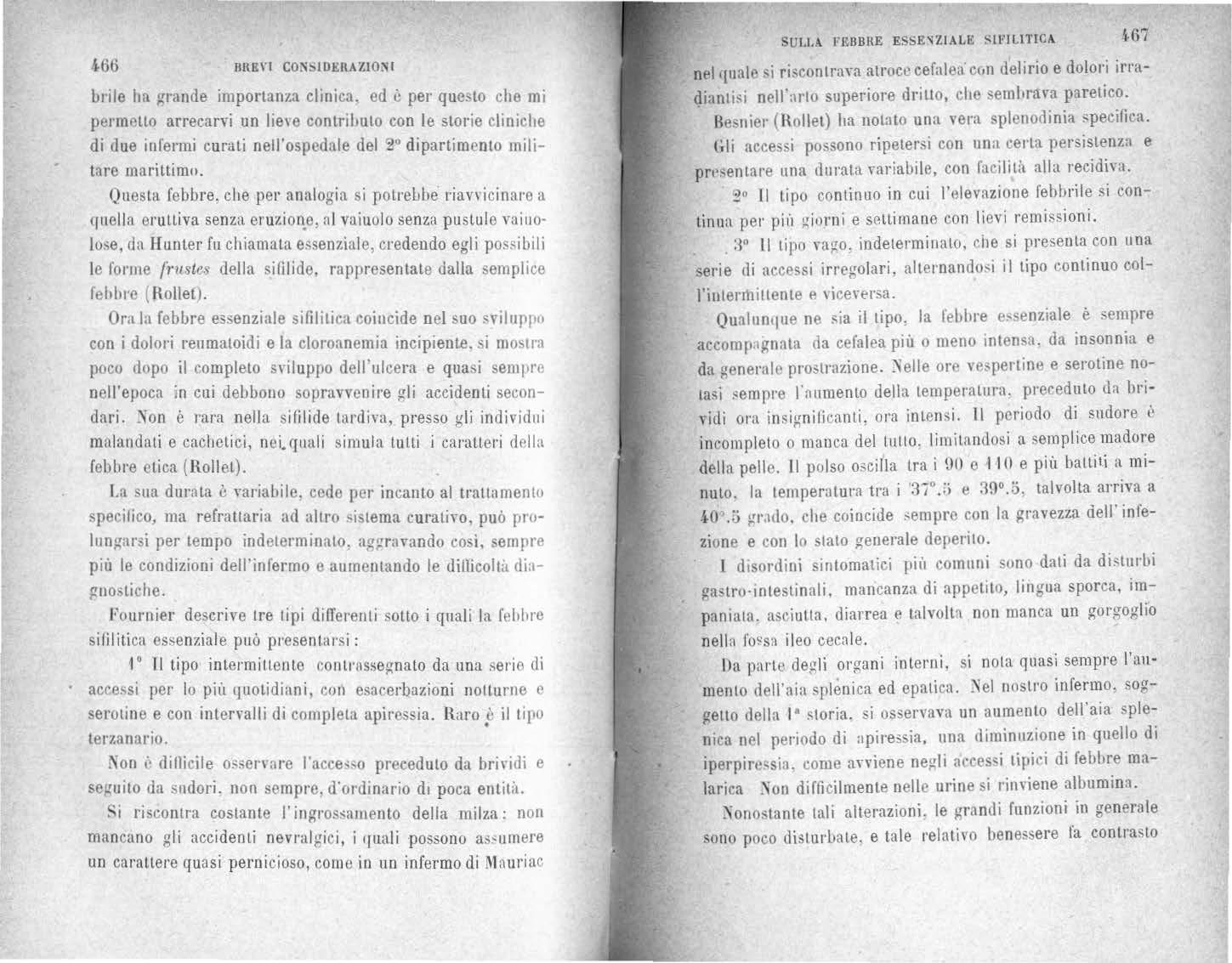
6 minute read
CONSIOERAZlON I
brìle ha grande important.a clinica. ed è per questo che mi permf"lto arrecarvi un lle\e contributo con le storie cliniche di due infermi curati nell'ospedale del 2° dipartimento militare marittimo.
Qnesta febbre. che per analogia si potrebbe riavyicinarc a q nella eruttiva senza eruzione. al vaiuolo senza pustulo vai noIose, da Hunter fu chiamata essenziale, credendo egli le forme f'ntsles della !';ifilido, rappresentate dalla semplice fehbrc 1 Rollet).
Advertisement
Or.tla febbre essenziale sifllitica roincide nel suo :;viluppo con i dolor·i reumatoidi e la cloroanemia incipiente. si mos1ra poco dopo il completo sYiluppo dell'ulcera e quasi sempre nell'epoca in cui debbono sopravvenire gli accidenti secondari. è rara nella sifilide tardiva, presso gli individui malanda ti e cachet ici, nc i.quali simu la tutti i ca ratteri drlla febbre elica ( Roll et).
La sua durata è variabile. code per incanto al tratlamento specilico, ma refrallaria ad altro !-istema cu rativo, può prolnngarsi per tempo indeterminato. cosi, sempre più le condizioni dell'infermo e aumentando le dillicoltit dia-
Fournier descrive tre tipi differenti sotto i quali la fehhre s if ilitica essenziale p uò p i'esen larsi: l\on l' dillicile o:;serTare l'acce,,.o preceduto da brividi e seg-uito da sudori. non sempre. a·o,·dinario d1 poca entità.
'1° Il tipo in termillento con trnssegnato da una serio di per lo più quotidiani, con esarerbazioni notturne e serotine e con intervalli di completa apiressia. B.aro è illipo • terzanario.
Sr riscontra costante l' della milza: non ma ncano g li acc identi nevra lgici, i quali possono as_:;umere u n cara ttere q uas i pe r·ni cioso, come in un infermo di Mnuriac
SULI A l'EBBRE ESSE 'i ZIALE
nPi t[nale si cefalea c1,n deli r io e dolori irranell'arto superiore drilto, che semhrava pa r etico.
Besnie1 ( Hollet) ha notato una vera splenoòinia accessi possono ripetersi con una certa persistenza e una durata ,-,wiabile, con facililit alla recidi \ a .
:,?o I l tipo eontinuo in cui l'e levazione febbrile gi continu a pe r più giorni e settimane con lievi
:lo Il tipo vago, indelerminalo, che si presenta con una serie di accessi inego lari, i l tipo continuo coll'inlermi!lente P \ icen·rsa.
Qualunque ne sia il tipo. la fehhre è sempre accomp1gnata òa cefalea più o meno intensa. da insonnia e da genemle prostrazione. ore H:-pertine e serotine notasi l'aumento della temperatura. preceduto da hri,·idi ora insignilicanti, ora intensi. Il periodo di sudore t' in co mpleto o manca del 1utl o, limitandosi a sempl ice madore dell a pelle. 11 polso oscilla tra i HO o Il O e più batti ti a minuto. la temperatura tra i 3/".:) e 39°.5. talvolta arriva a l!r.1do, che coincide :'empro con la gravezza àell' infezione e con lo stato generale deperito.
I disordini sintomatici più comuni sono dati da mancanza di appettto, lingua sporca, imp aniata. asciutta, diarrea e talvolta non manca un gorgoglio n ell a ileo cecale.
Da pa rte degli organ i interni, si nola quasi sempre l'a umen to dell'aia splenica ed epatica. nostro infer mo . soggetto della 1• storia. si osservava un aumento dell'aia splen ica nel periodo di apiressia, una diminuzione in quello di iperpiressia. come an-iene negli acces'i tipiei di febhre mala r ica difficilmente nelle urine si 1·inYiene tali alterazioni. le gra ndi funzioni in ge nerale sono poco disturbate. e tale rei ati\ o benessere fa con t rasto con l'elevazione termica e con la generale prostrazione. r·esa più appariscente dnlla specifica cloro anemia
Quando a! tipo febbrile eollliouo remiLLente, al tumore sp lenico si aggi ungono i disturbi gastro enterici ;;ua,·cennali e lo stato di generale deper·irnento, non .è diflicile confondere la febbre essenziale sililitica con una tifoide incipiente.
I n tali circo>tanze come cnr·attcro ditrerenziale impot'tantissimo re;;ta sempr·e il compos .\·ui delle facoltà mental1 nel caso di febbre sifilitica.
Dal complesso dei fatti ;;uaccennati , chiaramente appare come non sempre riesca facile in primo tC'mpo diagnosticare la natura di della forma fehln·ile. Poichè la mancanza d1 segni specifici apprezzabili, la il differente tipo febbrile. simulando talora l'intermittente malarica , talnltm la tifoide. tr·aggono in errore. E a rendere più malage' ole tal fatto concorrono ancora le complkanze degli organi interni. non mancanrlo il tumore di milza e di fegato, associati a di;;turhi gastro enterici più o meno marcati, come si o.;ser·va in altre l'orme morbose.
Ora in simili c:lsi di difficile dimostrazione, l'esame ,;crnpoloso dell'infermo. la minuziosa indagine delle notizie anamnestiche, la ai comuni rimedi terapcutici, n oncl11\ la possi hile mo1lificazione del tipo febbrile per· la loro somministrazione ( l ) potranno in certo modo giovare alla diagnosi. Principali dati, sui IJOali bisogna fondarsi sono: i po5tumi del sililoma iniziale, non sempre facili a r·iscontrar:;i (2). la poliadenite specifica, i leggieri dolori
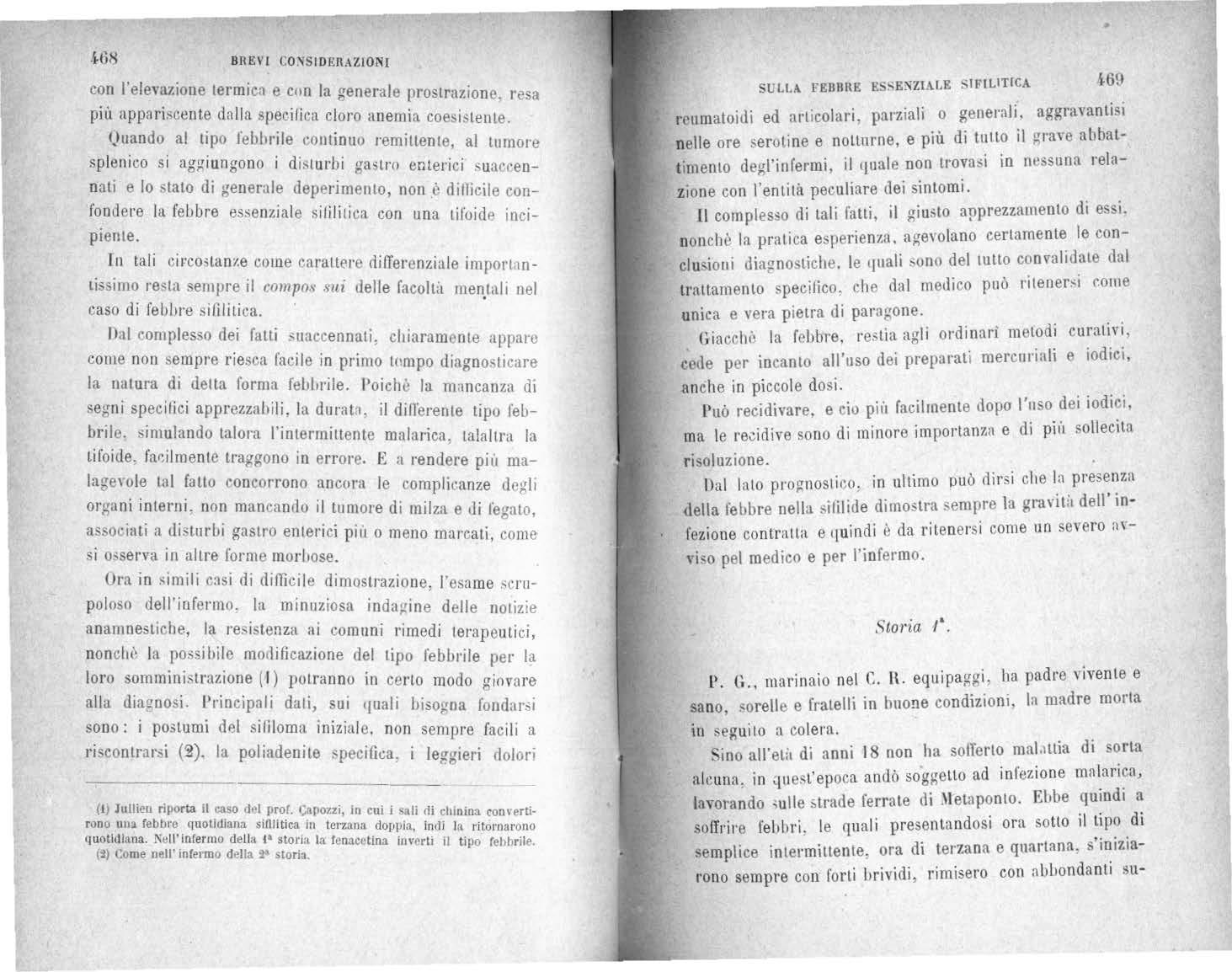
SI:Lt.A. rEDDI\E SIF!LlTICA
reumatoiùi ed articolari, parziali o generali. aggravantisi n elle ore serotine e notturne, e più di tutto il gra'e ahbatt imento degl'infermi, il ttuale non trovasi in tlt'ssuna relazi one con t'entità peculiare dei sintomi.
Il complesso di tali fatli, il giu:>lo apprezzamento di essi. nonchè la pratica esperienza, age\'olano certamente le concl usioni diagnostiche. le tjuali :-.ono del tutto convalidate dal t rnttamento specilico. che dal medico può come u nica e vera pietra di paragone.
Giacchò la fchbre, r·estia agli ordinarì metodi curativi, p er incanto all'uso dei preparati mercnriali e iodici, a nche in piccole dosi.
Può recidivare, e cio più facilmente dopo l'uso dei iodici, ma le re.;idive sono di minore importanza e di più sollecita r isoluzione.
Dal lato proj!nosrico, in ultimo può dirsi che la presenza d ella febbre nella si lilide dimostra semp re la graviti! dell ' infezi one contraila e t[ uindi è da ritener·si come un se\'ero rn' igo pel medico e per l'infermo. Storia t'.
(l Jullieo riporta il caso 11"1 pror. Capozzi, in cui i \ali di chinina con,•erti· rono una febiJro quolidiana s ifllitica in terzana dopr•ìa, Indi la ritornarono quotidiana. l'icll'infermo della t• storia la renacNioa inverti il tipo rehbrile. (:l) Come nell' infermo della !' storia
P. (} ., marinaio nel C. 11 . equipaggi. ha pad r·e vi ve nte e sa no, sorelle e fratelli in huone condizioni, la madre morta in :e:eguito a co lera. ino all'etit di anni 18 non ha soiierlo mal.1ttia di sorta alcu na. in quest'epoca andò soggetto ad in f'ezione malarica, la\ orando mlle strade fer rate di )l etaponto. Ebbe quindi a so ffr ire fehhri, le qua li presentandosi ora sotto il tipo di se mplice in termittente, ora di terzana e quartana. s' iniziar·ono sempre con forli brividi, rimisero con nbbonda nti su-
470 BREVI t:ONSIOEIUZIONI
dori, e cedettero dopo il lungo uso dei sali di chinino. l>erò al dire dell'infermo. da quel tempo sinora, ogni anno si presentate nella stagione estiva, e ancom nel passato anno.
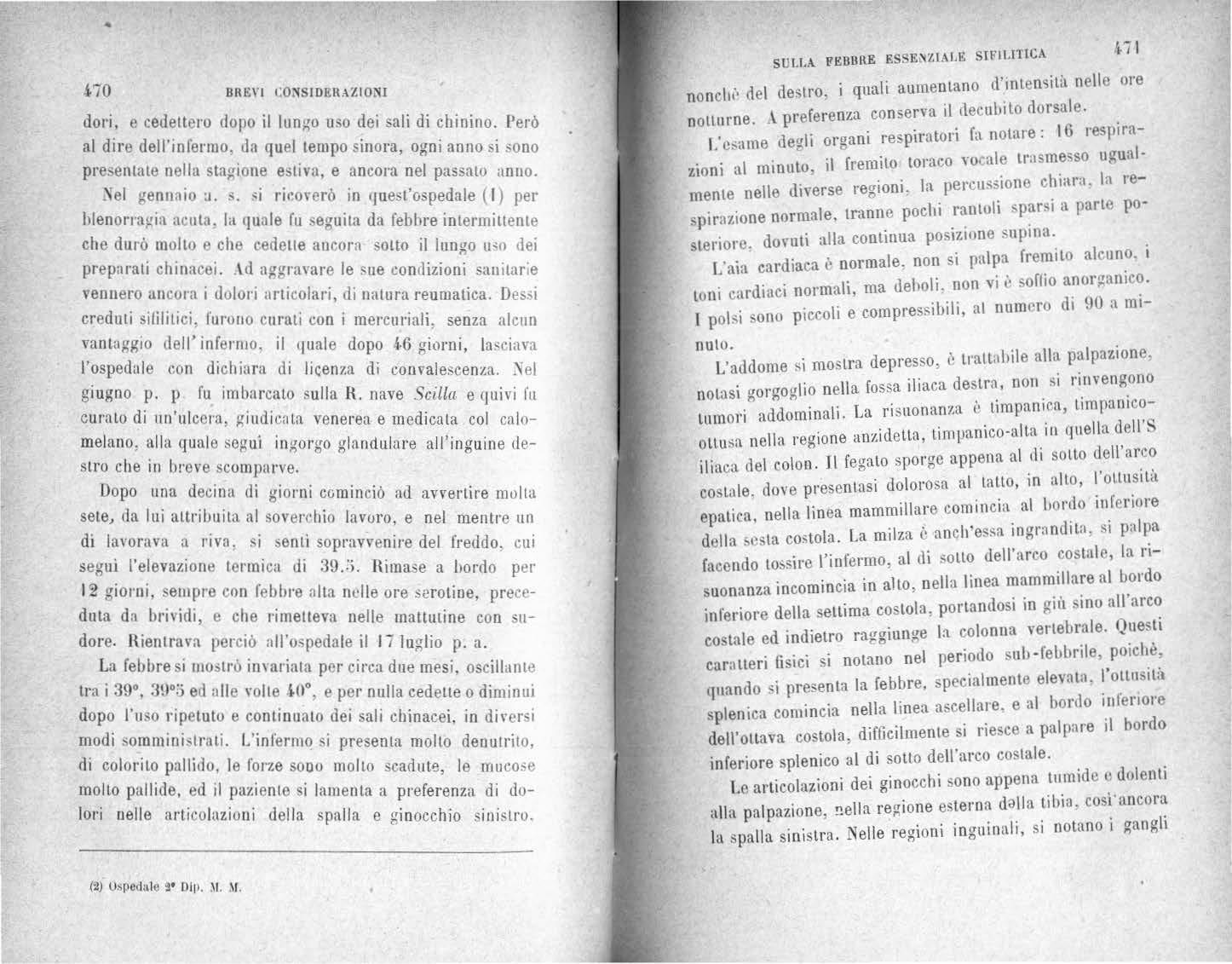
Xel a. :-. si ric·overò in lJ Ue:>t'ospedale ( l ) per hlenorraj.!ia acuta, la quale fu seguita da febbre intermillente che durò mollo e che cedette ancora sotto il lungo ll'O dei chinacei. Jd aggravare le sue co ndizioni sauitar·e vennero ancora i dolori articolari, di natura reumatica. creduti sifilitici, furono curati con i mercuriali , senza alcun vantaggio dell'infermo. il quale dopo giorni, l'ospedale con dichiara di licenza di convalescenza. giugno p. p fu imbarcato s ulla R. nave Scilla e quivi fu cu rato di un'ulcera, g iudi cnta venerea e medicata co l calomelano, al la qua le seguì ingorgo glandulal'e all' inguine destro che in hl'ove scomparve.
Dopo una decina di giorni cominciò aù av ,•ertire molta sete, rla lui attribuita al soverchio lavoro, e nel mentre un dì lavorava a riva. si sentì sopmvvenire del freddo. cui seguì l'elevazione termica di :39.:;. Rimase a bordo per 12 giomi, se111pre co n l'ebbre alta nelle ore serotioe, preceduta da bri,idi, e che rimetteva nelle mattutine con sudore. Rientra,·a perciò all'ospedale il l/luglio p. a.
La febbre si mostr·ò invariata per circa due mesi, oscillante tra i 39°, ed alle volte .i-0°, e per nulla cedeue o diminuì dopo l'uso ripetuto e conti n uato dei sali chinacei, in di,·crsi modi so mmini strati. L'infermo si presenta molto denutrito, di colorito pallido, le forze sooo molto scadute, le mucose molto pallide, ed il paziente si lamenta a preferenza di dolori nelle arlil'Oiazioni della spalla e gi nocchio sinistro, non cht'• del destro, i quali aumentano d'rntensita nelle ore notturne . \preferenza con serva il <lecubilo dorsale.
J.' c,ame degli organi respiratori fa notare: 16 zioni al minuto. il fremito toraco yocale Lt-.rsme:;so ugual· mente nelle diverse regioni. la percns,.ione chiara. la respirazione normale, tranne pochi rantoli sparsi a parte posteriore. dovuti alla continua posizione s upina.
L'aia cardiaca è normale. non si palpa fremtto alcuno. i tont cardiaci normali, ma deholi. non vi è soffio l pol si sono picroli e compressibili, al numrro dr \lO a mrnuto.
L'addome si mostra depresso , 1\ tmttnbile alla pulpazione, notasi gorgoglio nella fossa iliaca destra, non si rinvengono tumori addominali. La risuonanza i• timpanira, timpanicoottusa nella regione anzidetta, timpanico-a lta in quella dell'S iliaca del colon. Jl fegato sporgo appena al di sotto dell'arco costale. dove presentasi dolorosa al tatto, in alto, epatica, nella linea mammillare comincia al bordo inferiore della La milza è anch'essa ingrandita, si palpa fa cendo l'infermo, al di ::otto dell'arco costale, la ris uonanza incomincia in alto, nella linea mammillare al bordo inferiore della sellima costola. portandosi in giù sino all'arco costale ed indietro raggiunge 1:1. colonna vertel.lrale. Que:;ti caratteri fisici si notano nel periodo s uh-febhrile , poichè. quando ::i presenta la febbre, specialmente :>plenica comincia nella linea ascellare, e al bortlo t.nlerrore dell'ottava costola, diffìcilmente si riesce a palpare tl hordo inferiore splenico al di sotto dell'arco costale.
Le ar ticolazioni dei ginocchi sono appena tumide t'dolenti alla palpazione , nella esterna dalla tibia, così ancora la spall a sinistra . Nelle regioni inguinali, si notano i gangli










