




Flavio Ru sso Ingegno

Trenta secoli difortiflcazùmi in Italia
Volume secondo L'etit medievale
Roma 2005

Tutti i diritti riservati Vietata anche la riproduzione parziale senza autorizlaZionc
© Ufficio Storico SME - Roma 2005
Codice ISBN : 88-87940-55-X
N. Cat. 6648
Socie t à Ed it rice Ima go M edia s rl 81010 Dragoni (CE) - lei. 0823 866710 www.unagomcdia.it - email: info@imagomcdia.it

La prematura scomparsa di Alarico non provocò automaticamente l'eliminazione dei Goti. Altri condottieri ed altri innumerevoli scontri si avvicendarono, inframmezzati da ulteriori calate di orde barbare, fra le quali spicca quella degli Unni ' 1> Nel 476 l'ultimo imperatore romano, dal fatidico nome di Romolo Augusto , prigioniero di Odoacre, capo degli Eruli, si spense a Napoli fra le rovine di quella che era stata la splendida villa di Lucullo e che, in seguito, sarà il Castello del1'0vo (2) Odoacre, invece, divenne re d ' Italia , tentando, per quanto era nella sua capacità e possibilità , di ripristinare una parvenza di legalità e di
stabilità, in quel ribollente calderone, che però , solo nel 493 , sembrò guadagnare una insperata nonnalità , dopo la sua sconfitta ad opera di Teodorico (3J; il vincitore fu sole nnemente acclamato sov rano dei Goti , con ampio dominio s ull ' intera penisola , Sicilia compresa, previo il consenso, più o meno forzato, dell ' imperatore d ' Oriente.
Da quel momento e pe r circa trentatrè anni, quanti durò il suo potere, il martoriato regno conobbe un iITeale periodo di pace e di pro s perità. Rapidamente i costumi e le abitudini dei conquistatori s i ingentilirono nel costante contatto con la s uperiore cultura dei Romani, che purtroppo, a loro volta, non disdegnarono di adeguarsi a11e rozze consuetudini barbariche . Nonostante
c iò le due etnie rim asero sempre nettamente di sti nte senza mai in tegrarsi. giunge ndo persino a stabilire un tacito accordo per cui alla prima fu riservata ogni funzione amministrativa e cultural e ed alla seco nd a ogni attività militare. E proprio Teodorico s i prodigò per mitigare le res idu e astios ità, pon e ndo un freno alla tradizionale aggressività d e i s uoi guerrieri, ed indu cendoli ad accettare norme comportame nta li imp rontate al diritto ed alla civi ltà.
D ifficile accertare co n esattezza, quanto di t a nta meritoria o pera fosse in concreto realizzato , in specie ne ll e regioni perife1iche del regno, dove qual s i asi controllo diretto risultava impo ssibi le. In ogni caso quella singo lare aggregazio ne : " ...dei Goti e dei Romani avrebbe potuto fissare per secol i la passeggera felic ità d'Italia e la reciproca emula z io ne d e ll e l oro v irtù formare gradatame nte un nuovo popolo di s udditi liberi e d ' illuminati so ldati, c he avesse il primato fr a l e nazioni. M a il m erito sublime non e ra ri servato al regno di Teodorico; g li mancò il geni o del legislatore, o non ne ebbe 1 ' opportunità Seguendo l'esempio degli ultimi imperatori, Teodorico sce lse l a residenza di R avenna [ma] ogni vo lta che la pace ... era minacc iata dai barbari, egli tra sfer iva la sua corte a Verona alla fron t ie ra settentrionale... Queste due ca pitali, come pure P avia, Spoleto, Napoli e l e altre c ittà d'Italia ebbero durante il s uo regno utili o spl endid i ornamenti... il benessere dei s udditi e r a più manifesto nel movim en tato s p ettaco l o del lavoro e del lusso, ne l rapido a umento e nel libero godimento della ricchezza nazionale... Furono ripristinat e ed estese le libere comunicazioni fra le provinc e, p er ten-a e per mare, no n s i c hiudevano mai, nè di giorno nè di notte, le porte delle c ittà e il detto c omun e che s i poteva l asciare tranquillamente una bo rsa d'oro nei c an1pi es prime va come g li abitanti fossero co i1 sc i della loro s ic urezza. " < 4 >
In estrema sintesi, quindi , appare innegabile c he i Goti co n t ribuirono , ad onta delle ini z iali d evastazioni, a prolungare il c re pu sco lo dell ' Impero; e, forse, ne avrebbero finanche potuto avviare la ripresa, non difettando , per quanto detto, tutt e l e indispensab ili premesse. Disgraz iata m ente, però, in quel quadro di vaste e sos tanziali co ndi vi s ioni g i ocava un ru olo scard in a nt e e
disgregante il duali smo in sormontabile del credo r eligioso. Tanto T eodo rico quanto i Goti erano ariani < 5 ), laddove la stragrande maggioranza degli Italiani osservava il c redo n iceno: ma mentre i primi si mostrarono sem p re ampiamente tolleranti in materia di fede, i second i rivelarono una ben diversa di s po s izione. ln breve, l a ces u ra interetnica si trasformò in un a incolmabile os tili tà fra le due distinte compagin i socia li del regno, che le mire bizantine tese alla sua riconquista, molto verosinùlm ente, fomentavano ed aizzavano s ubdolamente
Di certo allorquando a Costantinop oli si promulgò un a legge persec utoria nei confronti dei re si denti ariani, recepita da Teodorico quale esplicita provocazione, la situaz io ne precipitò. Il sovrano, infatti, non poteva in alcun modo ass istere in erte alla vessazione dei s uoi correli gionari dopo aver garantito, in qualsiasi modo e circostanza, la massima Jjb ertà di cu lto a i s udditi c ristiani. TI rigetto della s ua ragionevole ri c hiesta di una simmetrica tolleranza innescò il repentino aggravarsi delle contrappos izi oni in Ita li a, con uno strasc ico di abiette rappresagUe c he macchiarono gli ultimi anni di vita di Teodorico. Di Jì a breve in fatti, nel 526, morì e le sue spog li e finirono nel famoso mausoleo di Ravenna'6 ) Quale fos se onnai l 'odio c he lo circondava l o tes timonia la leggenda , fatta c ircolare dai cristia ni , secondo cu i la s ua estrema dim ora, in realtà, stava nel c rate re dello Stromboli , fra le c ui fiamme avrebbe dovuto esp i are in eterno la divina condanna!
Nel se ttimo anno del re g no di Giu stiniano , il 533, l a tanto ausp icata, e paventata, riappropriazione bizantina d e ll ' Italia passò dalle schennaglie prodronùche alla g ue rra s ul campo, co n un rilevante esercito agli ordi ni di B eli sario. La prima fase della campagna ve nn e indirizzata al rec upero del Nordafrica, da tempo dominato dai Vandali: il 15 settembre fu espugnata Cartagine. Ne i mesi successiv i anche l'intera Sicilia rientrò sotto la sovrani tà di Bi sanz io e nel 536, superato l o stretto, l ' armata impe1iale assicuratasi R eggio , iniziò l a risalita dello stivale, seguendo un itinerario costiero. L' avanzata di Belisario non trovò alcuna significativ a resistenza poichè: " tutti i
 INGEG NO E PA U RA TRENTA SECOLI or fORTIFI C AZJONl JN ITALIA
INGEG NO E PA U RA TRENTA SECOLI or fORTIFI C AZJONl JN ITALIA
luoghi che per via incontrava, spontaneamente g li si rendevano. Prende pertanto senza molto contrasto i Bruzi, l a Lucania, la Puglia, la Calabria ed il Sannio: Benevento, e quasi tutte le città principali di queste province a lui si rendono per lo terrore delle sue armi, e molto più per spavento de' Goti La Campania solamente contrastò per q uanto le sue forze poterono " <7> No nostan te ciò, e nonostante L e sue poderose fortificazioni, in poche settimane, forse graz ie ad un tradimento, Napoli fu costretta a capitolare. I1 te mp o di raggi un gere Roma ed il IO dicembre del 536 anche la metropoli spalancò le porte a Belisario acclamandol o liberatore. Seguì una serie di scontri che non riuscirono comunque ad arrestare il dilagare bizanti no : R avenna venne espugnata nel 539.

Purtroppo le crescenti ge losie sollevate i n patria dai travo lgenti successi costrinsero il generale a lasciare L'Italia 1'anno successivo, senza aver potuto ultimare la sua missione e senza aver nemmeno potuto stabilizzare le recenti conquiste, soffocando definitivamente ogni estre-
ma sacca di resistenza gota. Come facilmente prevedibile, non trascorse molto tempo che la reazione dei superstiti si scatenò, avviando sotto il comando di Totila una spietata riconquista<sl _ Per Costantinopoli fu giocoforza allora rispedire il vecchjo Belisario a fronteggiare i bellicosi Goti, sebbene la forza militare concessagli fosse sensibilmente inferiore alle necessità, e perfino a quella, già esigua, della campagna precedente ascendente ad appena 7500 uomini, mentre per contro quella del nemico andava di giorno in giorno accrescendosi.
Senza dilungarci eccessivamente sulla questione, ricorderemo soltanto che l'interminabile guerra gotica pervenne alla fase co nclusiva sono il comando dell 'eunuco Narsete, a partire dal 549l9> , allorquando Giustiniano l o inviò in I talia con 35.000 uomini. Stando alla tradizione, il celebre generale, in quella circostanza, espresse il parere che lo 'stivale' andava calzato dall'alto: infatti le sue operazioni presero l'avvio affrontando
i Goti del nord. Più che una sce lta strategica sembrerebbe essere stata una nece ss ità tattica , poich è al momento una gravi ss ima cri i travagliava la flotta imperiale rendendola incapace persino di trasbordare l 'esercito in Puglia. Per contro, l 'avanza ta attravers o i Balcani pennise di arruolare preziosi co ntingenti di mercenari, provenienti dagli ultimi sbanda ti Unni, dai Longobardi, dai Gepidi, dagli Eruli, come pure dai Greci e dai Persiani: un'accozzaglia indisciplinata di criminali feroci, motivati soltanto dal miraggio del bottino. Nel 551 s ul campo di Gualdo Tadino, in Umbria, Narsete , sc hierando una inedita formazione mista di arcieri e di fanti armati di p icca, antesignano archetipo dei tercios rinascimentali , sbaragliò ed uccise Totila110' Tra gli ultimi episod i cruenti della terribile campag na, rima se memorabile lo scon tro avvenuto nel territorio comp reso fra le pendici del Vesuvi o e quelle dei prospicienti monti Lattati nel 553. Comandava i Goti il loro ultimo sovrano, Teia , c h e s i battè co n disperato valore finchè: " ... un giavellotto lo uc c ise . I romani mozzarono il capo al cadavere, lo infil zarono s u di una lancia e lo iss arono in a l to perc h è tutti lo vede ss ero, dall'una parte e dall'altra ... Ma n ea nche allora i goti s i arresero. Fino a n otte continuaro no a combattere, benchè sapessero che il re era morto ... alle prime lu c i del nuovo giorno ripresero g li scon tri che si protra ssero fino a notte Finalmente i barbari inviarono a Nar sete alc uni dei loro u omi ni più in vista e g li fecero saper e che si erano resi conto di combattere contro la vo l ontà di Dio lper cui] erano pronti a deporre le armi a patto di poters i ritirare indi s turbati Narsete accettò [e] gli ultimi mille co mbatt e nti non disarmati si ritirarono "( 1 ' ' ·
Contrariamente alla loro tradizionale prassi bellica, i Bizantini, nel corso de l lun go confli tt o, n on si avvalsero del s upporto di so fisticate fortificazioni, scag li onate n ei punti nodali d ella P e ni so la. 11 p erchè dipese probabilme nte da: " ... una serie di ragioni conco mitant i. ln prim o luogo i l processo di riconqu is ta del terri torio non fu nè rapido n è lin eare come inv ece era accaduto in a ltri casi: la forte re s iste nza opposta dagli O s trogoti e l a oggettiva difficoltà da parte imp eriale di

m ettere in campo un co ntingent e militare adeguato determinarono il prolun garsi dell e ostilità e le alterne fortune di una guerra che terminò proprio nel momento in c ui le prime avvi s ag l ie della c risi lung o le frontiere balcanica e orientale richiedevano lo spostamento di uomini e risorse verso quei quadranti ritenuti vitali per l ' impero. In secondo luogo i Bizantini co n se r varono il totale controllo della penisola so lo per po co più di un decennio: l'invasione longobarda iniziata nel 568 dete rminò ne l giro di po c hi ss imi an ni una frammentazione del territorio italiano e a ll a fine del seco lo sott o il contro llo imperiale rimanevano so lo l'E s arcato, alcune regioni costiere ( Liguria, parte del Ven e to , della Campania e for e dell'Abru zzo , Pu g li a e Calabria) e le isole di Cors ica, Sardegna (annessa ammini s trativamente all'Africa) e Sic i lia. In que s to quadro il problema della difesa del te rritorio italiano dov e tte quindi pors i essenzialmente in termini di fortificazione dell e città principali e di controllo sulle vie di comunicazione e s u ll e istallazioni portuali. " 1111
La lun g hi ss ima guerra s i ri ve lò la più atroce delle catas trofi abbattutesi in tutta la s ua st oria s ulla Penisola. Tanto i barbari quanto gli imperiali si abbandonarono ad ogni so rta di deva s taz ioni e di e fferat ezze pro vocando un dra s ti co abbrutimen to della soc ietà coev a.
I Goti, in definitiva, tra la prima conq ui sta di Roma e l'e s trema di sfatta su i monti L attari, erano rimasti in Ital ia pe r cir ca 140 anni , periodo, e non ecce ivo, certame nte s uffi c iente a permettere loro di fondare qualch e nu ova città munendola d i idonee fortificazioni. Ma i barbari in generale, ed i Goti in parti colare, non erano dei costruttori . Nella loro tradizione nomade iJ rad icamento al territorio, precipuo dei villaggi in muratura , non rientrava assol utam e nte , per cu i è pressochè inutil e ricercarne s ignificative tracce. Di sc orso sostanzialmente analogo va fatto per le fortificaz ioni, esulando l'adozione di opere fisse da ll a loro prassi bellica. È e mbl emat ico che in tutte le operazioni o ss idionali da essi compiute, s ia
dall'interno delle città in qualità di difensori sia dall'esterno, in veste di attaccanti, le murazioni fossero sempre quelle già precedentemente esistenti, e mai, in nessun caso, ascrivibili alla loro iniziativa. Inutile, pertanto, tentare di individuare una particolare concezione architettonica, sia pure rudimentale , di matrice gota.
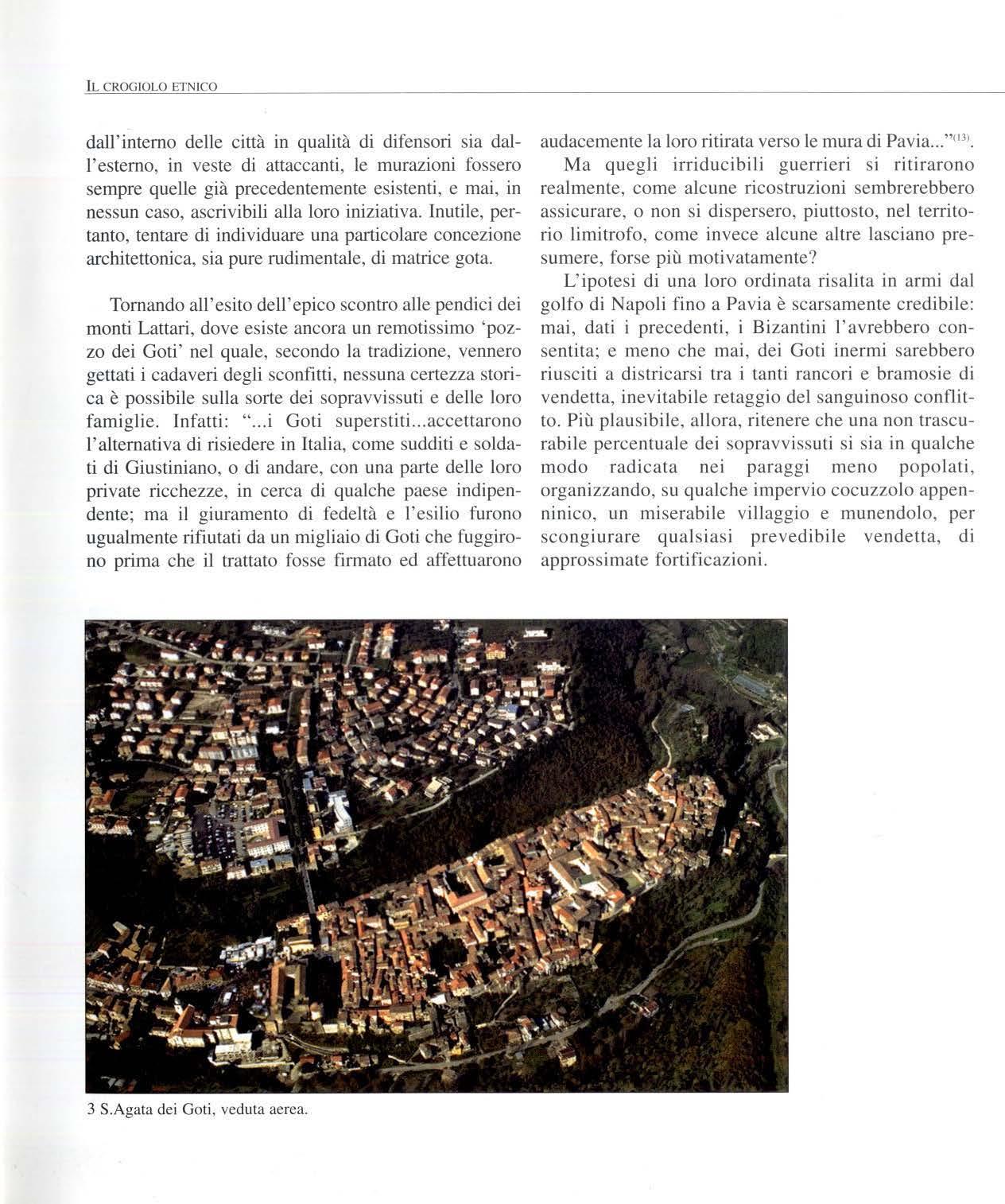
Tornando all'esito dell 'e pico scontro alle pendici dei monti Lattari, dove esiste ancora un remotissimo 'pozzo dei Goti ' nel quale, secondo la tradizione, vennero gettati i cadaveri degli sconfitti, nessuna certezza storica è possibile sulla sorte dei sopravvissuti e de1le loro famiglie. 1nfatti: " ... i Goti superstiti ... accettarono l 'alternativa di risiedere in Italia, come sudditi e soldati di Giustiniano, o di andare, con una parte delle loro private ricchezze, in cerca di qualche paese indipendente; ma il giuramento di fedeltà e l 'esi lio furono ugualmente rifiutati da un migliaio di Goti che fuggirono prima che il trattato fosse firmato ed affettuarono
audacemente la loro ritirata verso le mura di Pavia
Ma quegli irriducibili guerrieri si ritirarono realmente, come alcune ricostruzioni sembrerebbero assicurare, o non si dispersero, piuttosto, nel territorio limitrofo, come invece alcune altre lasciano presumere, forse più motivatamente?
L'ipotesi di una loro ordinata risalita in armi dal golfo di Napoli fino a Pavia è sca rsamente credibile: mai, dati i precedenti, i Bizantini l'avrebbero consentita; e meno che mai, dei Goti inermi sarebbero riusciti a districarsi tra i tanti rancori e bramosie di vendetta, inevitabile retaggio del sangu ino so conflitto. Più plausibile , allora, ritenere che una non trascurabile percentuale dei sopravvissuti s i s ia in qualche modo radicata nei paraggi meno popolati, organizzando, su qualche impervio cocuzzolo appenninico, un miserabile villaggio e munendolo, per scongiurare qualsiasi prevedibile vendetta, di approssimate fortificazioni.
Signific ativamente si ritrova a bre ve distanza da Napoli un centro, S Agata dei Goti, indubbiamente alto - medievale che sembra attagliarsi perfettamente a quanto delineato , a partire dal suo singolare toponimo che ci cos tringe ad un approfondimento.
L'intitolarsi a S.Agata non costituisce una straordinaria singolarità in ItaJia: ben diciannove paesi, infatti, condividono tale denominazione , per lo più in Sicilia, dove il culto della Santa è fortemente sentito. Al contrario lo specificativo ' dei Goti ' , è privo di quaJsiasi analogia: indiscutibile conferma questa, per molti illustri storici, della primitiva fondazione. Agli inizi del ' 600 il dotto sacerdote Vincenzo Ciarlanti scriv e va al riguardo:
" I G oti par, c he a ta nta crudeltà have ssero co ngiunto pure una co sa di buono; pe rch è furono as sai devotj di S .Agata Ve rgin e , e Martire, c he come loro Padrona riverivan o . e adoravan o, e pe rc iò in più luoghi l' e ressero Chi ese ...e dal s uo nome ancora edifi carono una Cit tà ne l S an ni o, anc he og gi chiam a ta S .Agata de Goti. come affem1a Mi che le Monaco ne l Sant uario d i C a pu a, ove tratt a di S .Offa di C a pu a.' ' '"'
Nessun dubbio, quindi, per gli antichi autori, che proprio i Goti, in epoca imprecisata, ma compresa fra il 489 ed il 553 si accamparono e , magari , si radicarono sull ' impervia lama di roccia, alta 159 m, con pareti pressochè a picco, ed isolata alla base dal c orso dei torrenti Isclero e Martorano. La singolarità dell ' insediamento avrebbe favorito la sopravvivenza toponomastica. Quanto alla dedica essa, per altri studiosi, è da riferirsi alla presenza di una cappella votiva intito l ata alla Santa di cui i Goti erano indubbiamente devoti <15 > Tuttavia: " ... l'ipotesi d i « una prima chie s a eretta dai Goti» è ardua da verificare, addensandosi un buio quasi completo s ulla presenza gota nel Sannio, a ll o stesso modo che so l o frammentari squarci illum i nano l ' incipiente dominazione longobarda, di cui è un'eco nelle righe d i Gregorio Magno Anche perchè le testimonianze più propriamente artistiche, per i l periodo che va dal Vl al X sec., si riducono ... [alla] l astra di San Men n a, e ad un capitello altomedievale (fine VI - VII sec.) nella cripta del duomo .. . È c ert a c omunque l'e s i-

stenza di una o più chiese a S.Agata fra il VI e il X s e c ... ."(1 6).
Di sicuro le prime fonti attendibili che attestano l'esistenza del borgo rimontano al IX secolo, in piena età longobarda, allorquando rientrava nel Ducato di Benevento. Ne11 ' 847 lo ritroviamo sede di gastaldato, insieme a Telese e ad Alife, dettaglio che lascia s upporre la non completa estinzione della vita in tutte quelle pic c ole cittàl171 • Ed , indirettamente, suggerisce che, come loro, anche S.Agata doveva necessariamente disporre d i una fortificazione perimetrale , più o meno rabberciata e raffazzonata ma indispensabile per proteggere l'abitato. Credibile, pertanto, che un gruppo di Goti, ormai privo della originaria tracotanza ed isolato in un territorio sempre più ostile, tentasse di trovare un minimo di protezione , accampandosi su quella inospitale altura ed integrandone 1' arroccamento con modestissime opere difensive, sec ondo tecniche apprese durante le passate conquiste.
L' annosa diatriba degli storici locali si dipana proprio da questo punto, poichè sulla origine gota de l centro non si registrano soverchie divaricazioni. Che cosa, in effetti, realizzarono i Goti e quanto ne è sopravvissuto nelle epoche posteriori? Data la sostanziale affinità etnica tra Goti e Longobardi, ai quali , però , viene ascritta una discreta capacità edilizia, quanto pervenutoci è fatto risalire in blocco ad essi, reputandos i oziosa, e gratuita, qualsiasi distinzione. Sicuramente l 'i nsediamento originario doveva risultare estremamente modesto e limitato, nella migliore delle ipotesi, alla frazione sommi tale de ll a l ama di roccia, dove ins iste la parte più arcaica de ll 'attuale centro storico. P er la na tu rale impervietà del sito non occorse una fortificazione perimetrale continua, bastando il saldarsi delle case fra loro in maniera da precludere qualsiasi varco d'accesso, ad eccezione di un paio di porte, caratteristica a nche questa tipica dell ' urbanistica longobarda. È, in sostanza, la riproposizione della disposizione dei carri intorno a l bivacco, con ar1damento curvi l ineo e chi uso.
Circa le porte, va osservato che: " ... si co nse r vano a nc ora oggi in ottimo stato ... [e] si aprono entrambe
INGEGNO E PA URA TRENTA SEC OLI D1 FORTIFICAZlONl lN ITALIAsul lato sud-est, dove lo strapiombo riesce ad essere maggiormente abbordabile ... sono costituite da una serie di archi che in ripida ascesa introducono al centro fortificato. Una volta, se si può prestar fede al Viparelli, sulla chiave dell 'a rco esterno di una di esse si leggeva la scritta:
Hic sunt Portae Gothorum Autem Pectora Civium"08 >
Più in dettaglio, la porta volta a mezzogiorno appare ricavata nel corpo di una torre a pianta quadrata, con base scarpata. È , in ogni caso, la principale e più arcaica fortificazione della cittad ina. Ma a chi si deve attribuire? La sua configurazione non risulta di per sè sufficiente a ll 'accertamento, sebbene una vaga rassomiglianza con le torri della cerchia aureliana di Roma conforti la suggestione che ad edificarla siano stati proprio i primi vio latori delle mura dell'Urbe!

Al seguito di Narsete. durante la terribile riconquista dell'Italia, combattè anche un con ting ente di circa 5.000-6.000 uomini , provenienti da un esiguo gruppo etnico, i Longobardi, otiginario del basso Elba, di stirpe germanico-sassonen9 > _ Le prime notizie circa quei barbari rimontano al 4 d.C. quando il loro aiuto risultò determinante p e r la riuscita dell'agguato nella selva di Teutoburgo. c he portò all'eccidio di tre intere legioni romane agli ordini di Varo. Intorno al 165 i Longobardi si s postarono verso la Pannonia, quindi verso l'Ungheria per tornare ancora in Pannonia, intorno alla metà del VI secolo. In tale scorc io storico entrarono in contatto con i Bi za ntini, prestandosi a contenere la pericolosa invasione dei Gepidi, che, dopo la morte di Attila, premevano s ul corso inferiore de lla Sava. L'operazione avvenne quasi certam en te in aHeanza con gli Avari che, in segu ito al s uccesso, nel 567 dil agare-
5 S.Agata dei Goti: lat o sud -est.
no ne lla Pannonia orientale e ne ll a Dacia. È probabile che, proprio allora i Longobardi, sentendosi dircuamente minacc iati da quegl i inrtdi alleati, iniziassero a migrare verso l'It a li a.
La direttrice meridiona le, del resto, era 1' uni ca poss ibile poichè proprio Giu tiniano. poc hi anni prima della sua morte, avvenuta nel 568, aveva provveduto a precludere massicciamente la frontiera bizantina. che correva da Belgrado a Costantinopoli, mediante lre ordini di linee difen s i ve. delle quali la più meridionale raggi un geva l'Adriatico. Stando alle scarse fo nti disponibili, nella circostanza ben 600 fortezze vennero erette o, almeno, rico struite e poste in co ndizioni di resistere. Tuttavia " ... l 'e fficacia di que sto elaborato s istema di fortificazion i è discutibile. Il sos petto c he, come è sta to pure per a ltri elementi del programma militare di Giustiniano, l e sue fortezze non fossero
costruite per durare, è confermato dal ritmo crescente e dal s uccesso delle in vasioni barbariche n e ll a seconda metà de l secolo ... " 1201 • In ogni caso, se mbrerebbe che la maggior parte di tali s trutture altro non fosse che " ... un a torre d i pietra o di mattoni, po sta nel mezzo d'una piazza quadrata o circolare, circo nd ata d a un muro e d a un fosso, c he in m omenti d i pericolo offrivano qualche dife sa ai con tadini e al bestiame dei vicini villaggi " 12 11 • Considerate sia l 'estrema diffusione , che la grande emplicità di tali fortificatio ni , è cred ibile che persi no i rozzi Lon gobardi ne recep issero perfettamente le caratter is ti che sa i ic nti , architettoniche e funzionali , tenendone debi to conto, tanto più che per le loro indisciplinate forze s i dimostrav ano com unqu e impre ndibili
L'adozione di un torrione costituì da allora l'elemento caratterizzante della fortificazione medievale


più arcaica, destinato a persistere a lungo anc he nei caste lli In essi siffatti e lementi. notevolmente eccedenti le altre torri per le dimen ioni in pianta ed in aJtezn, assolsero preminentemente alla funzione di dominio e di estrema resistenza. Costituirono infatti , di regola, la residenza abituale de l feudatario, completamente isolata dal resto dell'intera fortificaz ione circosta nt e, quasi una sorta di castello nel ca tel10. Tale supremazia è ben emblematizzata dal nome che li de s ignò: mastio o maschio. Non rara, inoltre, anche la definizione di 'torre mastra', termine Linguisticamente diverso, ma co nce ttualm ente identico e sottintendente, comunque, un ruolo difensivo predominantemi _
Il mastio rappresentò perciò la so lu zio ne precipua del l'incastellamento altomedievale acquisendo, nel corso dei quattro seco li che lo videro protagonista, tutte le possibili confi gurazioni trutturali, da quella c ilin drica a quella poligonale, dalla parall e l epip eda quadrata alla prismatica triangolare. Per molti aspetti potrebbe reputarsi la premessa del dongione normanno o della residenza fortificata sveva. Come pure se mpre in esso è ravvisabile l'arche tipo della casa-torre dei comuni medievali e delle torri-masseri e rina sc imentali , tutte soluzion i difensive di modico costo e di modes te pre tazioni, ma validiss ime contro investimenti scoordinati, quali so mmo sse, fa id e ed assalti briganteschi. In definitiva fun zionali a re s pingere iniziative offensive simili agli assedi dei Longobardi, guerrieri se nz a dubbio bellico i, ma assolutamen te incapaci di condurre raz ionalm e nte un assedio quand'anche conlro la più scalcinata delle fortificazioni.
C he i L ongobardi fossero be ll icosi gue rrieri i Bi za ntini lo sapeva no da tempo ma, nel co rso della guerra gotica, ebbero anche modo di constatare che, a ca u a della loro indol e feroce e refrattaria a qualsia i disciplina militare, non ne tornava attuabile alcuna irreggimentazione. Pertanto, conclusa la campagna, congedarono il cont igente rimpatriandolo. Disgraziatamente l'all o nt anamento avvenne troppo tard i: a que l punto molti di loro avevano già avuto modo di reali zzare co n grande precisione, la debolezza e la ricchezza dell'Italia.

Dalle scarne fonti de11 'epoca apprendiamo che Narsete, esaurita la riconquista, per frustrare qualsiasi sgradita futura penetrazione, in sediò in alcune fortezze del Nord e dell'interno dell'Italia, alquante guarnigioni. Ne derivarono a lm e no quattro Ducati, oculatamente di s locati lungo le frontiere, ciascuno comandato da un magister militum. Geograficamente vennero così ubicati: uno nei pressi di Cividale, due in prossimità de i laghi Magg iore e di Como ed un altro in corri s pondenza dei valichi delle Alpi Graie e Cozie. Secondo la prassi bizantina, è credibi l e che il reclutamento e l 'addestramento dei relativi soldati, definiti limitanei, fosse effettuato direttamente in ciascun d istretto. A quei particolarissimi militari veniva fatto obbligo soltanto della difesa delle fortezze in cui erano di s tanza, castra, e delle città di frontiera limitrofe, civitates In ogni caso si trattava di contingenti non inquadrati neJl'esercito mobile e non idonei al combattimento campale. Significativamente però, nessuna fonte, menziona l ' esistenza di: " .. .limitanei dell ' Italia bizantina, cosa che lascia supporre quanto il loro ruolo militare... [fosse irrilevante]: fu così che Alboino nel 569 entrò senza difficoltà in Forum Julii (Cividale) prima fortezza che gli si parò davanti ... " <23 > ,
Per l a s tori a, il 2 aprile del 568, lunedì di Pasqua, una moltitudine variegata e rumorosa formata da in tere famiglie , seguita da stuoli di sconfitti ridotti in schiavitù, dal bestiame e da traballanti carri su cui erano st ipati i poverissimi averi, valicò le Alpi, suddivi sa per clan, farae (24l _ Alla sua testa, un g io va ne condottiero , Alboino, le cui indubbie capacità guerriere avrebbero consentito, con una rapida campagna, di conquistare in pochi anni tutta l' I talia sette ntri onale, prima di cadere vittima, piuttosto ingloriosamente, della celebre Ro smunda125J _ 11 richiamo in patria di Narsete , avvenuto poco tempo prima su istanza di Giustino Il, diede ad ito alla diceria che l ' invasione l o n gobarda dovesse ascriversi ad una sua trama ve ndicativa, maldicenza peraltro mai sme ntita. Di cert o l 'esercito bizantino non bloccò l'avanzata deJla miserabile orda penetrata dal Friuli, riuscendo soltanto , e ste ntatamente, a deviarne il deflusso ver so località
d i secondaria rilevanza strategica Si osserva, anzi, che alla caotica e disorganica conduzione della calata, propria dei barbari, si opponeva un ' ancora più improvvisata e scriteriata contromanovra imperiale, inficiata forse anche dal reputare quell'inva s ione non divers a dalle molte analoghe precedenti, risoltesi spontaneamente in pochi mesi. Non si può comunque, in linea di principio, escludere che i Bizantini , c olti del tutlo di sorpresa, abbiano evitato di battersi a fondo contro una minaccia destinata, sempre a loro giudizio, a dissolversi nelle inospitali regioni melidionalì.
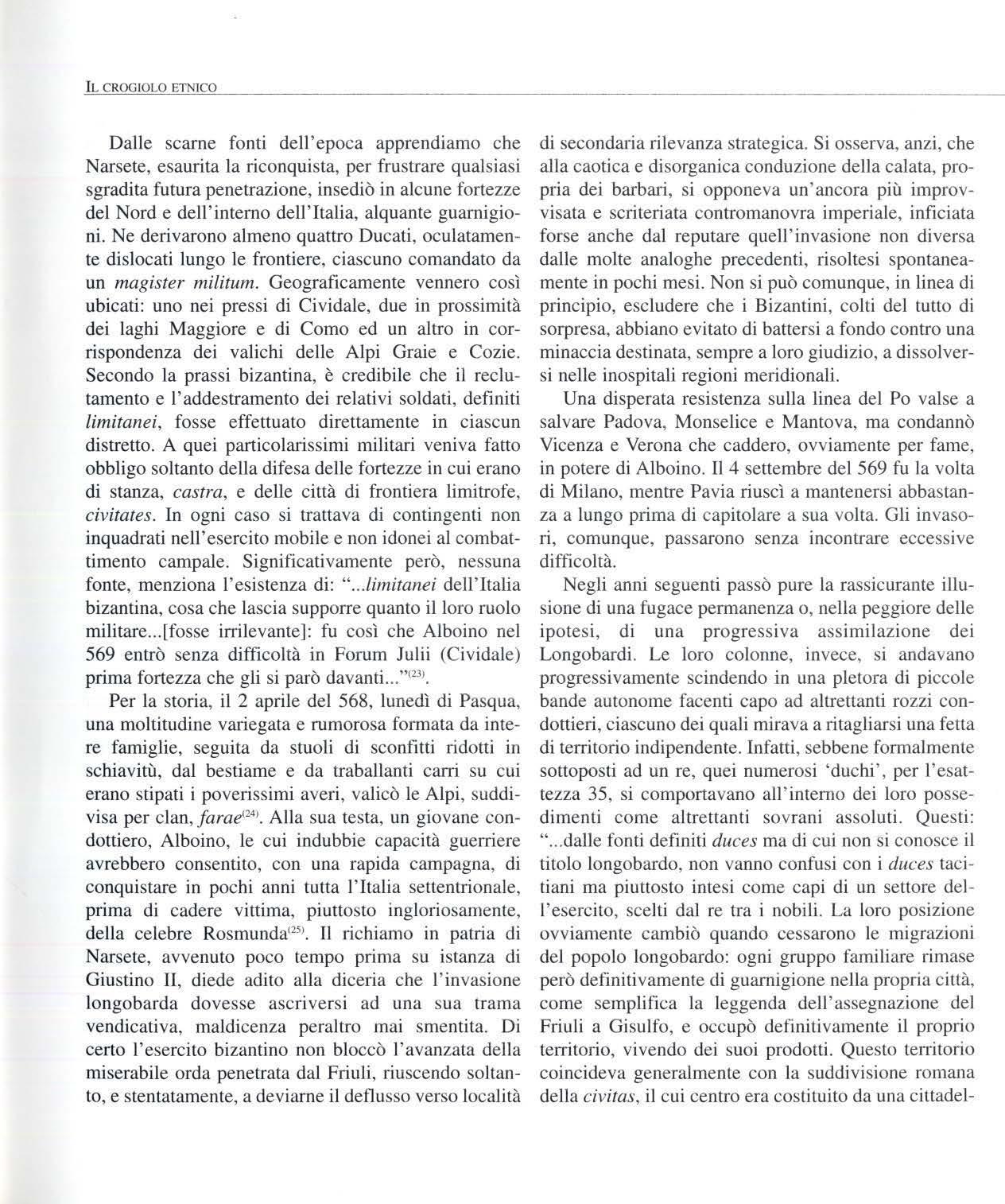
Una disperata resistenza sulla linea del Po valse a salvare Padova, Monselice e Mantova, ma condannò Vicenza e Verona che caddero, ovviam e nte per fame, in potere di Alboino. Il 4 settembre del 569 fu la volta di Milano, mentre Pavia riusci a mantenersi abbas tanza a lungo prima di c apitolare a sua v olta. Gli in va s ori, comunque, pas sarono sen z a incontrare eccess ive difficoltà.
Negli anni seguenti passò pure la rassicurante illusione di una fugace permanenza o , nella peggiore delle ipotesi, di una progres s iva a ss imilaz ione dei Longobardi . Le loro colonne, invece, s i andavano progressivamente scindendo in una pletora di pi c cole bande autonome fac enti capo ad altrettanti rozzi condottieri, ciascuno dei quali mirava a ritagliarsi una fetta di territorio indipendente. Infatti, sebbene formalmente sottoposti ad un re, quei numero s i 'duchi ', per l ' esattezza 35, si comportavano all'interno dei loro possedimenti come a ltr ettanti so v rani assoluti. Ques ti: " dalle fonti definiti du ces ma di cui non si conosce il tito lo longobardo, non vanno confusi con i duces tacitiani ma piuttosto intesi come capi di un settore d e l1'esercito , sce lti dal re tra i nobili. La loro posizione ovviamente cambiò quando cessaro no l e migrazioni del popolo longobardo: ogni gruppo familiare rimase però definitivamente di guarnigione nella propria città, come semplifica la leggenda dell ' assegnazione del Friuli a Gisulfo, e occupò definitivamente il proprio te1Titorio, vivendo dei suoi prodotti. Questo territorio coincideva generalmente con la suddivisione romana della civitas, il cui centro era costituito da una cittadel-
la fortificata. Probabilmente le città servivano dapprima come stazioni di vettovag liamento , ges tite in modo più o meno regolare, a volte forse imponendo il pagamento di un terzo de11e rendite agli agricoltori del distretto; ma dovette trattars i di uno s tato di tran s izione, che preparò la via all'insediamento definitivo ... " (26> L' intera penisola conquistata finì , perciò, s partita in una costellazione di potentati , sos tanzialme nte coincidenti con i vecchi municipi romani. A tale de sti no scamparono soltanto le città costiere, validamente dife se sia dal1a flotta bizantina che dalle poderose fortificazioni di cui erano munite s ul front e a terra , assolutamente esulanti dalle capacità ossidionali longobarde ad onta della loro preponderanza numerica. Tuttavia, per alcuni illustri storici , deve essere considerevolmente ridimensionata la consistenza degli inva so ri, in particolare, di quelli che si diressero verso l ' Italia centro-meridionale, residuo della originaria orda progressivamente assottigliata dai tanti sta nziamenti. I Longobardi, infatti: " ... arrivarono certamente nel Mezzogiorno con una parte ristretta del loro già modesto contingente demografico: non più di due o tre de ci ne di migliaia di persone in tutto, fra guerrieri e rimanente popolo, nella più generosa de11e ipotesi. Il successo di questo così esiguo inserimento è, tra l 'altro una controprova del grande vuoto umano che esso dovè trovare sulle montagne del Me zzog iorno , alle quali , altro elemento s ignificativo, sostanzialmente s i arrestò, senza avere la forza di andare oltre i margini delle aree contigue (campane, pugliesi, calabresi, lucane) dove il popolamento precedente era ancora relativamente consistente o i pre s idi bizantini erano più fortemente attestati " <21 >
interessante ricordare che all'epoca la popolazione presen te nell 'ltalia meridionale non doveva sup erare il milione di abitanti, compresa l'aliquota sc hiavile , ancora di notevole rilevanza percentuate <28 > Tale entità agevola la comprensione non solo della disomogenei tà della diffu sio ne longobarda ma , sopra ttutto, di talune s ue altrimenti in sp iegabili anomalie, quali la prefere nza iniziale per le poveriss ime aree collinari ed appenniniche da sempre evitate per la notoria scar s ità delle

risorse. La conquista del Sannio ad opera di Zotone, compi uta intorno al 570, anno in cui Alboino veniva dichiarato re d'Italia , con Pavia per capitale , creò, la premessa dell ' in sediame nto del sec ondo grosso nucleo longobardo che Autari , figlio del successore di Alboino , coagulò intorno a B enevento. Rappresentò, dal punto di vista stori co, la più longeva delle loro aggregazioni, so prav vivendo lungamente alla caduta del regno sette ntrionale provocata dai Franchi nel 774: proprio in que g li stessi anni il ducato beneventano attinse il s uo apice.
Sotto l ' aspetto politico lo Stato lon go bardo poteva definirsi una so rta di mo narchia in cui il sovran o era primus inter pares almeno nella fase ini ziale, protrattasi fino al 570. La intrinseca in stabilità di un tale sistema s i manifestò in tutte la s ue drammatiche conseguenze ne l decennio s ucce ss ivo. Incessanti , quanto violente , dispute si s usseg uirono , infatti, sca tenate dall 'anarchia e dall'insaziabile ambizione dei duchi, ai quali il re s iduo benessere tro vato in Italia consentiva un 'ampia irresponsabilità. La situaz ione , ovviamente, non durò all'infinito esaurendosi contestualmente al1' esaurirsi delle risorse s accheggiabi1i. Da quel momento , scartato il rientro ne11e regionj d'origine, fu giocoforza anche per i bellicosi Longobardi trovare un modus vivendi con gli sco nfitti , in maniera da poter sopravvivere insieme sullo s tesso territorio. Il che significò, innanzitutto , il ripristino di un minimo di legalità e di ordine amministrativo, con la certezza della proprietà e dei confini. I ducati acquisirono così un assetto geografico stabile, sebbe ne di disparatissima grandezza e densità demografica. Al vertice dello Stato fu co11ocato un re, liberamente scelto dall'assemblea dei membti dell 'esercito, ma privo di capacità dinastica. Il suo potere non ebbe alcuna restrizione, almeno formalmente , pur affiancandolo nelle decisioni il cons1glio dell ' assembl ea . In breve tempo la cari ca da elettiva s i trasformò in ereditaria, finendo per concentrare nella persona del sovrano, oltre ad una autorità ormai assoluta, ingentiss ime ricchezze. E, per meglio garantirsi contro qualsias i in subordinazi one , i re lon g obardi pretesero dai s uddi -
ti il giuramento di fedeltà, mentre preclusero ai duchi ogni diritto di tipo ereditario, facendoli per g iunta sorvegliare attentamente dai gastaldi, rappresentanti reali in ogni ducato.
Nel 636 i Lon gobardi elessero a loro sovrano Rotari, duca di Brescia, capo di indiscussa personalità ed acuta intelligenza. Tra i suoi primi provvedimenti si ravvisa l'accentuazione della repressione del l'insubordinazione ducale e la promulgazione di un editto, in lingua latina, che forniva la codificazione dell'ordinamento giuridico consuetudinario longobardo, tramandato fino ad allora se mplicemente per via orale. Pur confermandosi, rispetto al sofis ticato diritto romano un terribile regresso, rappresentava, con i suo i 390 capitoli e ad onta delle sue numerose in congruenze, il concreto tentativo di porre ordine nel nuovo Stato. Liutprando, in segu ito, si fece carico di ampliarlo ulteriormente aggiungendovi altri 153 capitoli ed emendandolo, per quanto possibile, delle peggiori intolleranze. Inizia così a trasparire l'influsso che la superiore civiltà romana esercitò s ui suoi rozzi dominatori, lasciando presumere una contestuale, progressiva, integrazione fra l e due componenti sociali. E grazie al ruolo fortemente propiziatorio giocato dalla Chiesa, gradatamente si intrecciarono fra le opposte etnie numerosi legami di amicizia e di parentela che mitigarono e quindi annullarono le durissime condizioni degli sco nfitti.
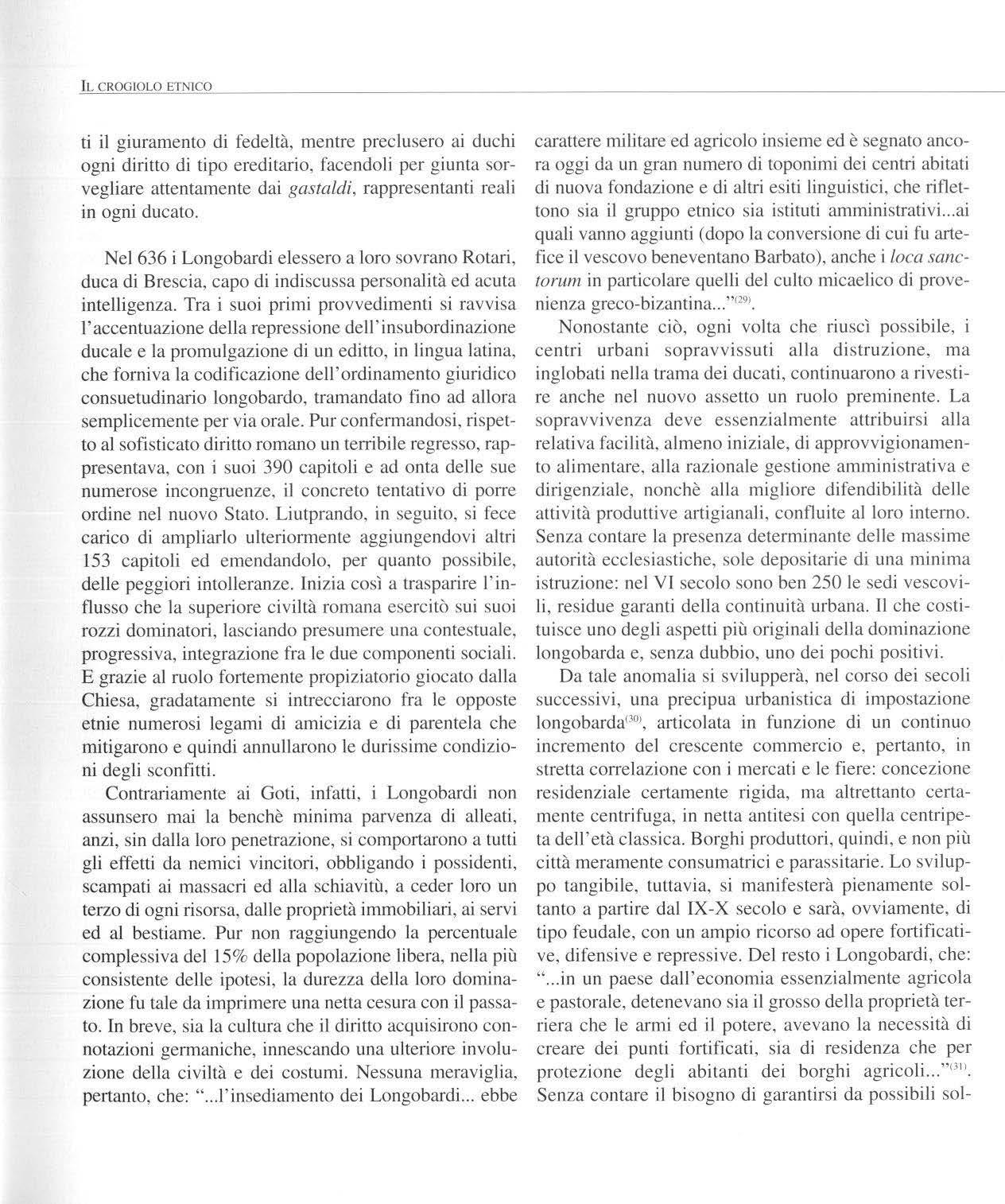
Contrariamente ai Goti, infatti, i Longobardi non assunsero mai la benchè minima parvenza di alleati, anzi, sin dalla loro penetrazione, si comportarono a tutti gli effetti da nemici vincitori, obbligando i possidenti, scampati ai massacri ed alla schiavitù, a ceder loro un terzo di ogni risorsa, dalle proprietà immobiliari , ai servi ed al bestiame. Pur non raggiungendo la percentuale complessiva del 15% della popolazione libera, nella più consistente delle ipotesi, la durezza della loro dominazione fu tale da imprimere una netta cesura con il passato. In breve, sia la cultura che il diritto acquisirono connotazioni ge rmaniche, innescando una ulteriore involuzione della civiltà e dei costumi. Nessuna meraviglia, pertanto , che: " l'insediamento dei Longobardi ebbe
carattere militare ed agricolo insieme ed è segnato ancora oggi da un gran numero di toponimi dei centri abitati di nuova fondazione e di altri esiti linguistici, che riflettono sia il gruppo etnico sia istituti amministrativi ai quali vanno aggiunti (dopo la conversione di cui fu artefice il vescovo beneventano Barbato), anche i loca sanctorum in particolare quelli del culto micaelico di provenienza greco-bizantina... " 1291 •
Nonostante ciò, ogni volta che riuscì possibile, i centri urbani sopravvissuti alla distruzione, ma inglobati nella trama dei ducati, continuarono a rivestire anche nel nuovo assetto un ruolo preminente. La sopravvivenza deve essenzialmente attribuirsi alla relativa facilità, almeno iniziale, di approvvigionamento alimentare, alla razionale gestione amministrativa e dirigenziale, nonchè alla migliore difendibilità delle attività produttive artigianali, confluite al loro interno. Senza contare la presenza determinante delle mas s ime autorità ecc l esiastiche, sole depositarie di una minima istruzione: nel VI secolo sono ben 250 le sedi vescovili, residue garanti della continuità urbana. Il che costituisce uno degli aspetti più originali della dominazione longobarda e, senza dubbio, uno dei pochi positivi.
Da tale anomalia si svilupperà, nel corso dei secoli successivi, una precipua urbanistica di impostazione longobarda(3°>, articolata in funzione di un cont inuo incremento del crescente commercio e, pertanto, in stretta correlazione con i mercati e le fiere: concezione residen ziale certamente rigida, ma altrettanto certamente centrifuga, in netta antitesi con quella centripeta dell'età classica. Borghi produttori, quindi, e non più città meramente consumatrici e parassitarie. Lo sviluppo tangibile, tuttavia, si manifesterà pienamente soltanto a partire dal IX-X secolo e sarà, ovviamente, di tipo feudale, con un ampio ricorso ad opere fortificative, difensive e repressive. Del resto i Longobardi, che: " ... in un paese dall'economia essenzialmente agricola e pastorale, detenevano sia il grosso della proprietà terriera che le armi ed il potere, avevano la necessità di c reare dei punti fortificati, sia di residenza che per protezione degli abitanti dei borghi agricoli ... " <> 1 l Senza contare il bisogno di garantirsi da possibili sol -
levazioni dei vinti, di gran lunga più numerosi, dalla conflittualità endemica interetnica e da una nuova minaccia che di anno in anno si confermava più terribile e devastante: quella dei saraceni e delle loro razzie. Avviatesi, verso la fine del VII secolo, a danno delle fasce costiere, in breve volgere si incunearono sempre più nell 'e ntroterra , inarrestabili ed efferate.
In linea di ampia schematizzazione, relativamente all'architettura militare, si osserva che: " ... nel primo periodo della dominazione longobarda non era stata attuata ancora quella massiccia costruzione di opere fortificate dovute sia alle discordie sorte tra i vari duchi longobardi che alle sopravvenute scorrerie dei Saraceni. Un documento dell'epoca, infatti, ci testimonia che [nella Longobardia meridionale] i castelli erano rari mentre 1' intero territorio era punteggiato da villaggi e da chiese...Da allora, per fronteggiare i pericoli che si susseguivano, le te1Te soggette ai Longobardi assunsero un aspetto ostile caratterizzato da rocche, torri, castelli, terre murate e fortificazioni varie dovute a conti, gastaldi e abati che agivano, in primo luogo, per la comune sicurezza ma, anche, per raggiungere i fini delle loro ambizioni personali. A questo stato di cose è dovuta la creazione di buona parte degli insediamenti militari che... ci testimoniano ancora oggi il loro primitivo impianto."(32 >
Più in dettaglio: " .. analizzando la grammatica costruttiva altomedievale bisogna considerare che in quel periodo esisteva ancora una forte tradizione tecnica che, per quanto decaduta, era sempre di aiuto nei programmi costrutti vi. A tal proposito dobbiamo notare che la mancanza di opere di particolare interesse artistico non può essere imputata ad una deficienza tecnica ma proprio al grado di civiltà del popolo longobardo. Infatti , una architettura non può essere improvvisata, poichè essa è dovuta ad un fatto di cultura oltre che di organizzazione di cantiere, perizia di maestranze e materie prime, tutte cose che, in fondo, presuppongono un livello di civiltà ben lontano da quello longobardo ...da quanto sopra detto è evidente che il problema tecnico viene subito eliminato e possiamo dire che la produzione di età longobarda (VI-IX
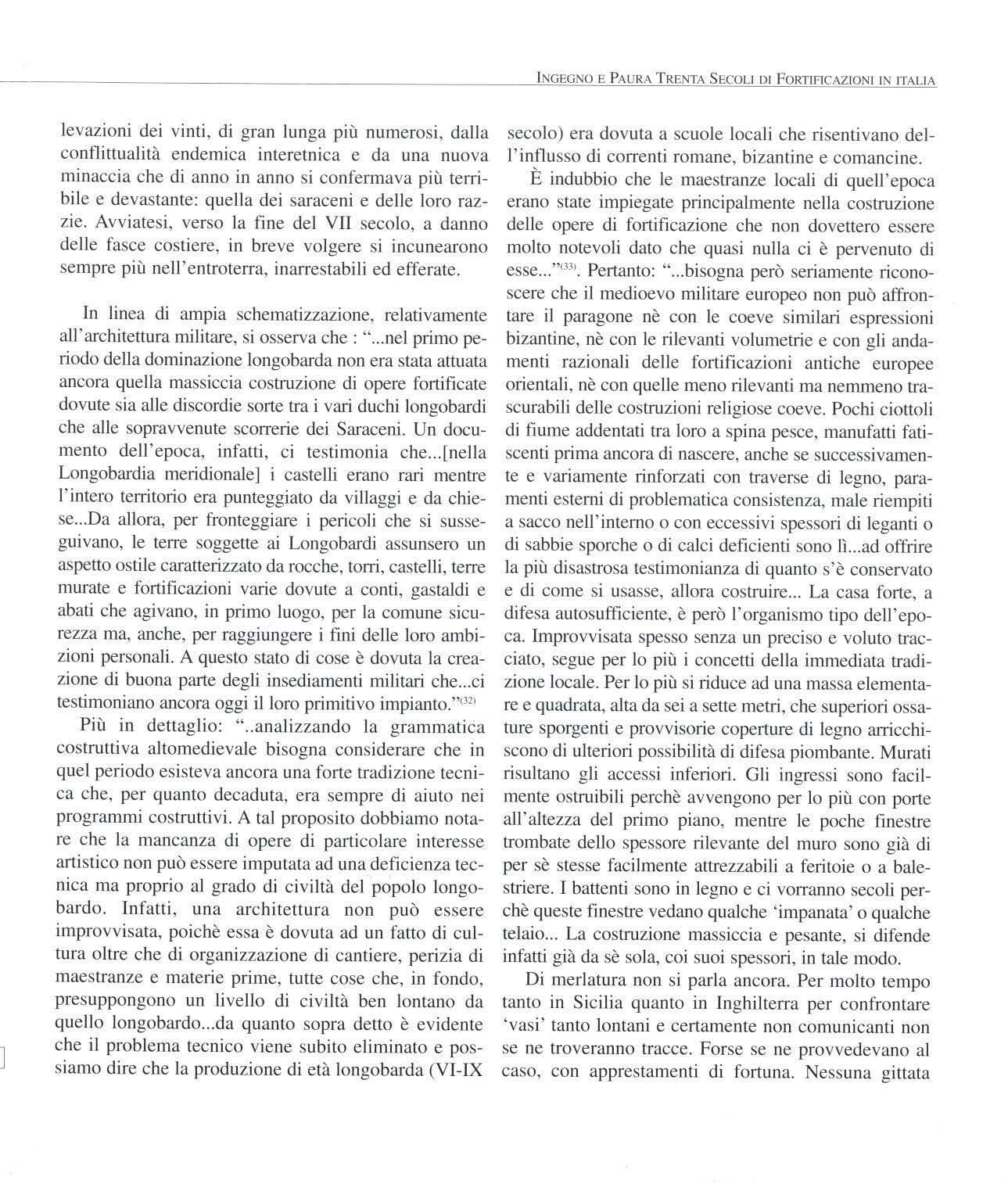
secolo) era dovuta a scuole locali che risentivano dell'influsso di con-enti romane, bizantine e comancine.
È indubbio che le maestranze locali di quell ' epoca erano state impiegate principalmente ne11a costruzione delle opere di fo1tificazione che non dovettero essere molto notevoli dato che quasi nulla ci è pervenuto di esse... " <331 _ Pertanto: " ... bisogna però seriamente riconoscere che il medioevo militare europeo non può affrontare il paragone nè con le coeve similari espressioni bizantine, nè con le rilevanti volumetrie e con gli andamenti razionali delle fo1tificazioni antiche europee mientali, nè con quelle meno rilevanti ma nemmeno trascurabili delle costruzioni religiose coeve. Pochi ciottoli di fiume addentati tra loro a spina pesce, manufatti fatiscenti prima ancora di nascere, anche se successivamente e variamente rinforzati con traverse di legno, paramenti esterni di problematica consistenza, male 1iempiti a sacco nell'interno o con eccessivi spessmi di leganti o di sabbie sporche o di calci deficienti sono IL.ad offrire la più disastrosa testimonianza di quanto s'è conservato e di come si usasse, allora costruire ... La casa forte, a difesa autosufficiente, è però l'organismo tipo dell'epoca. Improvvisata spesso senza un preciso e voluto tracciato, segue per lo più i concetti della immediata tradizione locale. Per lo più si riduce ad una massa elementare e quadrata, alta da sei a sette metri , che superiori ossature sporgenti e provvisorie coperture di legno arricchiscono di ulteriori possibilità di difesa piombante. Murati risultano gli accessi inferio1i. Gli ingressi sono facilmente ostruibili perchè avvengono per lo più con porte all'altezza del primo piano, mentre le poche finestre trombate dello spessore rilevante del muro sono già di per sè stesse facilmente attrezzabili a feritoie o a balestriere. I battenti sono in legno e ci vorranno secoli perchè queste finestre vedano qualche 'impanata' o qualche telaio... La costruzione massiccia e pesante, si difende infatti già da sè sola, coi suoi spessori, in tale modo.
Di merlatura non si parla ancora. Per molto tempo tanto in Sicilia quanto in lnghilten-a per confrontare 'vasi' tanto lontani e certamente non comunicanti non se ne troveranno tracce. Forse se ne provvedevano al caso , con apprestamenti di fortuna. Nessuna gittata
arriva infatti a preoccupare il difensore che sta, molto in alto, ben riparato dalla copertura... " <34> .
Come già accennato, è estremamente probabile che quelle prime realizzazioni difensive altro non fossero che un grezzo ton-ione, un mastio, impiantato sulla sommità di un ' altura, circondato da un recinto, spesso una semplice palizzata. corrente lungo il suo ciglio. In definitiva, una riproposizione, magari ulteriormente sempl ificata , dell'archetipo bizantino. Una serie di interessanti esempi di tale tipologia fortificatoria è ancora possibile osservarla soprattutto in alcuni castelli dell'Alto Adige, pred sando che già all'indomani della penetrazione longobarda, nel 568, Trento divenne ducato, il più settentrionale del regno, forse in sos tituzion e del precedente omonimo bizantino. E come quello, per la sua strategica ubicazione, subì vicende storiche particolarmente tragiche. Infatti: " ...il ducato trentino non ha vita molto facile: lotta con i Baiovari per il possesso della contea di Bolzano , respinge le scorrerie, quasi azioni di assaggio, dei Franchi i quali compiono nel 590 ... [unaj violenta azione di disturbo. Nel 774 Desiderio viene sconfitto da Carlo Magno; nel 778 la s tessa sorte è subita da Tassilone, Duca cli Baviera e genero cli Desiderio. L'impero carolingio riunisce sotto il suo scettro l'intera regione tridentina, ma rispetta la struttura che vi trova. Così Trento rimane Ducato " 135>
Dalle pagine di Paolo Diacono apprendiamo di una calata compiuta nel 590 dai Franchi, che, penetrati dalle Alpi orientali, si spinsero fino a Verona. Nella circostanza vennero conquistate, stando allo stesso autore, parecchie fortezze fra le quali quella di Tesana, cli Maleto, Sermiana, Appiano, Fagitana, Cimbra, Viziano , Brentonico, Volene, Ennemase, ed alcune altre ancora<361• Ovviamente identificare con esattezza quei toponimi è estremamente improbo, se non impossibile, proprio per l'inconsistenza deJle fo11ificazioni relative: è probabile comunque che in Tesana si possa ravvisare Tésimo, in Maletum Meltina, in Sermiana Sirmiano ed in Appiano Appiano. Il grande

fu racchiusa da una cinta che le è tangente ... Un tipico manufatto quindi di natura prettamente militare... LLa toITe èJ alta 19 m. e ha muri di 2 m. di spessore per l'intero svi lupp o ve1ticale. Internamente iJ diametro è di m. 4,5. Alcune file di fori per l'alloggio di travature determinano un a divisione in tre piani. La porticina d'accesso è a circa sette metri dal terre no, a tutto sesto co n la cornice mi sta di granito e di arenaria. Solo due feritoie con strombatma inclinata verso il basso all'i nt erno, prendono luce da ovest, aperte c io è sul co1tfle, cosicché agli assal itori la torre presentava una muratura compatta e continua. Ln cima termina piatta e senza segrti di merlature, c he sono assenti a nc he sul bordo della ci nta... " 081
l3 Val Venosta, castel Frolich: planirnet1ia.
numero, d el re sto , delle pres unte fortezze è una ulteriore confe1ma indiretta della loro modestia struttw·ale che almeno in Val Venosta trova espliciti riscontri architettonki. In particolare per quanto riguarda il caste llo di Appiano se mbrere bbe trattarsi originariamente dj un recinto iITego lare: " ... c he abbraccia un a stretta lingua di ten-a in leggero pe ndio , precipite su tre lati in ripidi scosce ndimenti rocciosi, è distin g uibil e quind1 come più antica la zona delimitata dall'ingente mole 30 metri di altezza del mastio pe ntagonal e ... " t371 _

Sempre nella stess a valle si può osservare Tschengelberg Castello, impiantato a quota 1250. n: "... segno distintivo del venostato castello Tsc hen gelsberg è il mastio c ircol are che s i aggiunge ai pochi esemplari di toITi di tal forma prese nti in territorio ates ino ma be n quattro in Val Venosta tutte rite nute solo pe r questa loro caratte1istica morfologica di origine romana. L'assunto è possibile, anche perch è l e rovine mos trano chiaramente che la torre so rgeva ini zialmente isolata e so lo in un seco ndo tempo
Analogo al precedente anche il castello di Fro li c h, sem pre in Val Venosta , l a cui cos truzione primi ti va era: "composta dalla toITe, isolata e libera, all'in te rn o di una cinta... si deve ammettere che datare la costruz ione, su ll a scelta della soJa tecn ica costru tt iva, come probabile del 13 ° secolo non è sufficiente per considerare risolto il problema. Nell'impianto, del tutto anomalo per l'architettura fortificata di quel pe1iodo in questa zona, si deve infatti ravvisare una destinazione d'uso strettamente militare una sede di guarnigione cioè o un acquartierame nto fisso poichè sol o con l'ipotesi di un uso del ge ne re si può giustificare la scelta di una zona che mai un signorotto dell'epoca avreb be e le tto a sua dimora e rifugio. Nè d'altra parte Malles aveva in sè le caratteristiche di fa r nascere nel s uo interno un caste ll o urbico. Ne deriva che i] disegno costruttivo va fatto risalire ad una matrice senz'altro precedente ...La torre è alta 33 metri e per la s ua forma è sta ta più volte parago nat a a quella detta di Druso alla periferia di B olzano ... Il coro namento merlato, segnato da pochi sassi emerge nti a intervalli re go lari , è mancante da secoli ... Lo spesso re del muro alla base è di 2 metri, alla sommità di m. 1,60... La porticina di accesso è ve rso oves t e d a lta d a te1Ta circa sette metri. A metà a ltezza una seco nda po rta p ennetteva l ' uscita s u un ballatoio li g neo che girava tutto at torn o all'inte ro pe1imetro. I fori non passanti c he ospitavano le travi sono di dimension i eccezionali: rettangolari e alti sessanta ce ntim etri. Si deve s uppoITe una costruzion e a s balzo di du e o tre
travi sovrapposte di notevole robustezza. Fo,i più piccoli, e sovrastanti di circa quattro metri , servivano per l'ancoraggio del tetto che proteggeva il ballatoio ... Le mura del primitivo recinto sono in parte crollate...La cinta che corre ad una distanza variabile tra gli otto e i dieci metri dalla torre aveva l'accesso ad ovest come indicano tracce di un portale ad arco pieno ... " (19 • n criterio info1matore di tali elementari fortificazioni, pienamente recepibile nelle opere descritte e riproposto in altre ancora, non è una peculiarità nordica, poichè , anche molto più a sud, se ne rintracciano di si.miliari sebbene in numero di gran lunga minore. Un esempio del genere, ancora pertèttamente identificabile, è quello che si staglia al dì sopra dell'autostrada A3 , nei pressi di Pontecagnano, in provincia di Salerno. Si tratta anche in questo caso di un tonione cilindrico, un mastio, impiantato all'interno di un recinto murario approssimativamente quadrilatero. li che induce a ritenere tale soluzione tipicamente etnica, circoscritta cioè cronologicamente
ma estesa geograficamente an · intero territorio conquistato , caratteristica che cont1ibuisce a rendere la datazione meno arbitraria. In ogni caso il mastio recintato emblematizza pe1t'ettamente la miseria e lo stallo culturale della società altomedìevale in cui la quasi totalità dei feudatari non disponeva delle risorse , economiche, tecniche e militari , per difendere i propri averi e la propria vita senza doversi rinchiudere in quelJa sorta di sarcofagi cilindrici, e. soprattutto, nessuno degli stessi aveva la capacità di distruggerli. Ovvio che appena possibile si riadattasse una qualsiasi struttura romana, dalla torre semaforica aJla tomba nobiliare , a siffaua destinazione.
Intorno alla seconda metà o, più verosimilmente, verso la fine del 600 i Longobardi riuscirono gradatamente a maturare strutture difensive meno approssima-
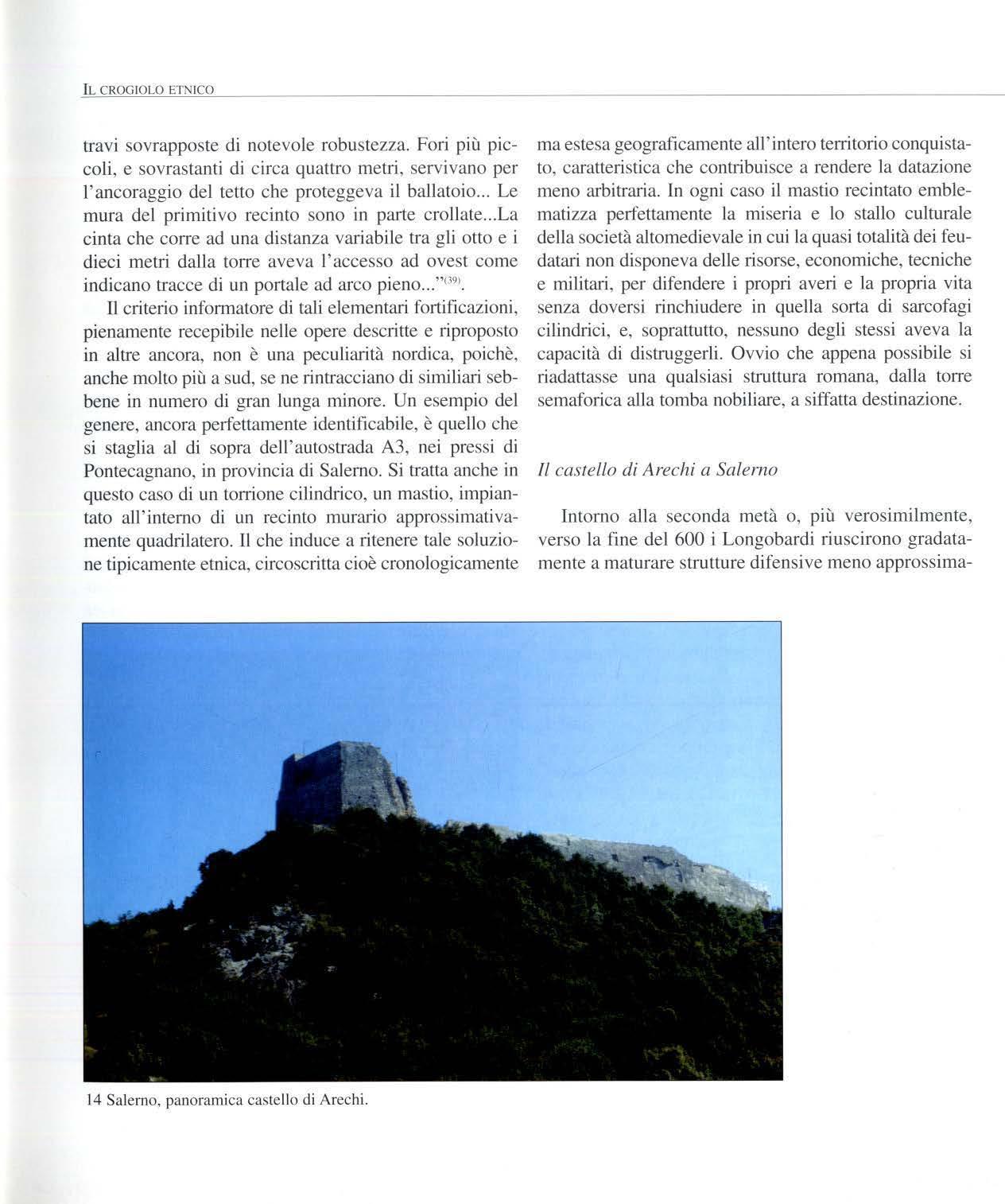
te delle descritte che, sebbene di modestissima aiticolazione e consistenza, meritavano più propriamente la definizione di castello. Disgraziatamente, però, quasi tutte quelle costruzioni a seconda che il sito d'impianto godesse di rilevanza strategica, o, al contrario rivestisse assoluta marginalità finirono ripetutamente aggiornate o radicalmente disgregate, impedendoci così una sia pur schematica descrizione tipologica. Soltanto i brandelli risparmiati ed inglobati nelle successive riqualificazioni consentono una vaga valutazione di tale evoluzione, come nel castello di Arechi che sovrasta il golfo di Salerno. Al riguardo va osservato che per la sua arroccatissima posizione, di per sè di straordinai'ia valenza ostativa, conservò, molto probabilmente, sostanzialmente inalterata la sua configurazione fin quasi al XV secolo, senza nemmeno allora perderla del tutto.
Dal punto di vista storico nel: " 640 inizia la dominazione longobarda che segna la rinascita e il rapido ripopolamento di Salerno, dapprima parte del ducato di Benevento e poi principato autonomo.
Salerno crebbe s icura nelle fortificazioni longobarde arricchita da un « palacium» che il «Chronicon >> , citando i versi di Paolo Diacono, definisce mirabile e decorato.
Il circuito delle mura longobarde che doveva restare quasi intatto fino al XVI secolo , nasce e muore a ridosso del castello con uno svolgimento triangolare ... " 140 > _ lo dettaglio il perimetro murato si originava dal castello , in posizione vertici s tica ed apicale, ed era costituito da due lunghe cortine rettilinee che scendevano, divaricandosi, sino alla riva del mare. La soluzione appare di notevole semplicità e non priva di analogie locali, come ad esempio a Castellammare di Stabia' 4 1 , e doveva essere conclusa da una murazione corrente lungo la linea di costa , magari potenziata da due torri alle estremità. Non può escludersi che le rimarcate somiglianze derivassero da pree s istenti caposaldi bizantini , disposti in tale maniera per interdire l'itinerario litoraneo, evitando qualsiasi penetrazione al]' interno della penisola sia dal versante sorrentino che da

quello amalfitano, ambedue territori longobardi. Quanto alle permanenze s trutturali l'analisi: " ... della muratura della torre «Mastra>> che presenta precise analogie con coeve murature di fortificazioni beneventan e, fa ritenere necessaria una più accurata datazione ...
La muratura della enorme massa trapezoidale (ambiente della Torre Ma stra) ad un esame accurato della tecnica costruttiva, presenta grossi blocchi tufacei, provenienti chiaramente dalla parziale distruzione della muratura a filari squadrati.. .immessi a funzione statica nella massa più minuta, determinando una tecnica longobarda di cui abbiamo vasta documentazione. Chiari esempi di tale tecnica sono rilevabili a Benevento, dove le mura urbane e la torre della Catena, presentano grossi blocchi calcarei provenienti dalle parziali distruzioni di edifici classici.

Re stringendo l'area della fo1tificazione pre]ongobarda alJa so la zona sottostan te la «Comanda», situata nel punto più alto della collina, si può avanzare l' ipotesi che la cortina longobarda si estende dalla zona più a nord del castello fino alla grande massa rocciosa che delimita il «cacumen montis» disponendosi come un aggere naturale verso oriente
Duran te la dominazione longobarda il Castello di Salerno ri s ultò una rocca im prendibile, non solo per la cura dedicata al miglioramento delle s ue postazioni, ma anche per la s ua posizione naturalmente inaccessibile.
Il disegno dell'accesso sv iluppa un percorso lungo un'ascesa ripidissima e facilmente ostacolabile dall'alto , con tiri piombanti, scagliati dalla sovrastante torre «Pentuclosa» . Il percorso , obbligato, fino all'ingresso è serrato in una vera e propria tenaglia di tiri radenti, provenienti sia dalla «Pentuclosa» che dalla torre di «Mezzo»
Tale funzionalità planimetrica offrì una tenace re s istenza al conquistatore Normanno. Il castello non capitolò ma i suoi occupanti furono presi per fame e per patteggiamenti nel 1077:«Coepit Gisulfum principem qui fame coactus se eidem duci tradit, atque turrim maiorem in qua se rutabatur» ... "142 )
Il trascorrere del tempo ed il radicarsi della prese nza longobarda non determinò soltanto un evolversi dell'architettura militare, ma innescò , come accennato, soprattutto un sistematico rifiorire della vita civile. E proprio le tante fo1tificazioni , che si ergevano sulle cime delle colline , assursero a nuclei di condensazione dei nascenti borghi, che per intuibili esigenze di protezione vi si addossarono il più possibile. Per meglio avvalersi dell ' impervietà del sito e per se ntirsi più s icuri, gli spamiti abitanti finirono per edificare le loro miserabili stamberghe s trettamente connesse fra loro , secondo circuiti concentrici progressivamente degradanti, scanditi da strettissimi vico li anulari. Giustamente un s iffatto impianto viene atn1alment e definito a 'pigna', 1icordando ogni casa una squama del noto frutto e la rocca il suo apice.
In breve alle cittadine pianeggianti ed ortogonali romane, ormai deserte e fatiscenti, s ubentrarono i borghi collinari e conoidi longobardi. Alcuni autori hanno ravvisato nell 'av volgimento c ircolare delle abitazioni la riproposizione della disposizione dei carri dei nomadi adottata nel corso della notte: a nelli chiusi con al centro il bivacco, facili da organizzare e facilissimi da difendere, nei quali ogni s ingolo elemento è essenziale per la s icurezza collettiva. Logico, infatti, che ciascun membro del gruppo , tentando di salvaguardare la sua proprietà, finisse col proteggere stren uamente anche l'intera comunità. L'osservazione non è priva di sensatezza specialmente per i coevi insediamenti di pianura, certamente meno frequenti, ma di identica impo stazione sebbene scev ri da qualsiasi condizionamento orografico. Del resto, come già ribadito dagli urbani sti greci, la trama viaria curvilinea ed angusta fungeva da deterrente contro gli assalti dei predoni.
Di que s ta elementare impostazione difensiva , che poi sarà quella medieval e per antonomasia, ci sono pervenuti alquanti esempi, in particolare nella Longobardia meridionale , scampati più che altrove alla distruzione per il minor benessere degli abitanti, ma , per lo stesso motivo, quasi mai alle riqualificazioni

delle epoch e successive. 11 grado di s icurezza che quel tipo di disposizione urbanistica poteva garantire , tuttavia, restò sempre modestissimo, ed il trascorrere dei secoli, se rese a sud la dominazione lon go barda più stabile, non significò au tomati ca me nte 1' esau rirsi delle scorrerie e della co nfli ttualità minore. Di anno in anno, infatti , le in c urs ioni saracene non si esaurivano più a pochi chilometri dalla riva ma penetravano sempre più profondamente nel territorio , a vol te persino per un centina i o di chi lometri, con razzie e saccheggi spie tati . Lun go l e coste tirrenica ed adriatica l'abbondanza d elle prede favor1 l'insediarsi di alcuni caposaldi musulmani c h e vaname nte le forze lon gobarde tentarono di annientare o rigettare in mare. In seg uit o al1' ampliarsi del raggio d ' azione dei predoni ed al co nsegue nte in cre me ntar si dell'insicurezza, gli sparuti abi tati di pianura s i spopo la ron o ed i terrorizzati superstiti fuggirono verso le montagne, i n ce rca di scampo. L 'i n gen uo dispositivo difensivo dei borghi a quel punto non forniva alcuna protezione, e la stessa rocca non sempre riusciva ad accogliere al suo interno, in tempo utile, i disgraziati abita nti. assaliti nel corso della no tte . Fu necessario perciò condu n- e int o rno alle case più basse un a di s tinta cerch i a con molte to rri e poche porte. La desolazione e l 'ab bandon o instauratis i lungo le marine divennero da que i g iorni assoluti l a d esert ific az ion e totale, ad eccezio ne d elle c ittà bizantin e, vere iso le murate , che a ltre ttanto vana m e nte e reiteratamen te i Lon gobardi continuarono a tentare di conquistare, ricavandon e so ltanto una co ntroffensiva deva s tante.

N e l fratte mpo con Arechi, che s ucce sse a Zotone, il ducato di Benevento raggiungeva una : " ... notevol e espansione: confinava a nord col Garigliano, l'a lt o Sang ro , la Maiella ed il Pescara, compreso Chieti , a s ud con la penisola Salentina , poichè l e città di Brindi s i e Taranto riman ev ano in possesso d ei Greci, e con la Calabria Meridionale e s ui due versanti marittimi il confine longobardo era continuo salvo i porti di Cuma, Napoli , Sorre nto ed Amalfi col retroterra ... " 143 >
Ad onta dei reciproci sfo rzi: " ... .i duchi Lon go bardi non riescono a venire a capo de i pochi generali bizan -
20 Salerno, panoramica della città
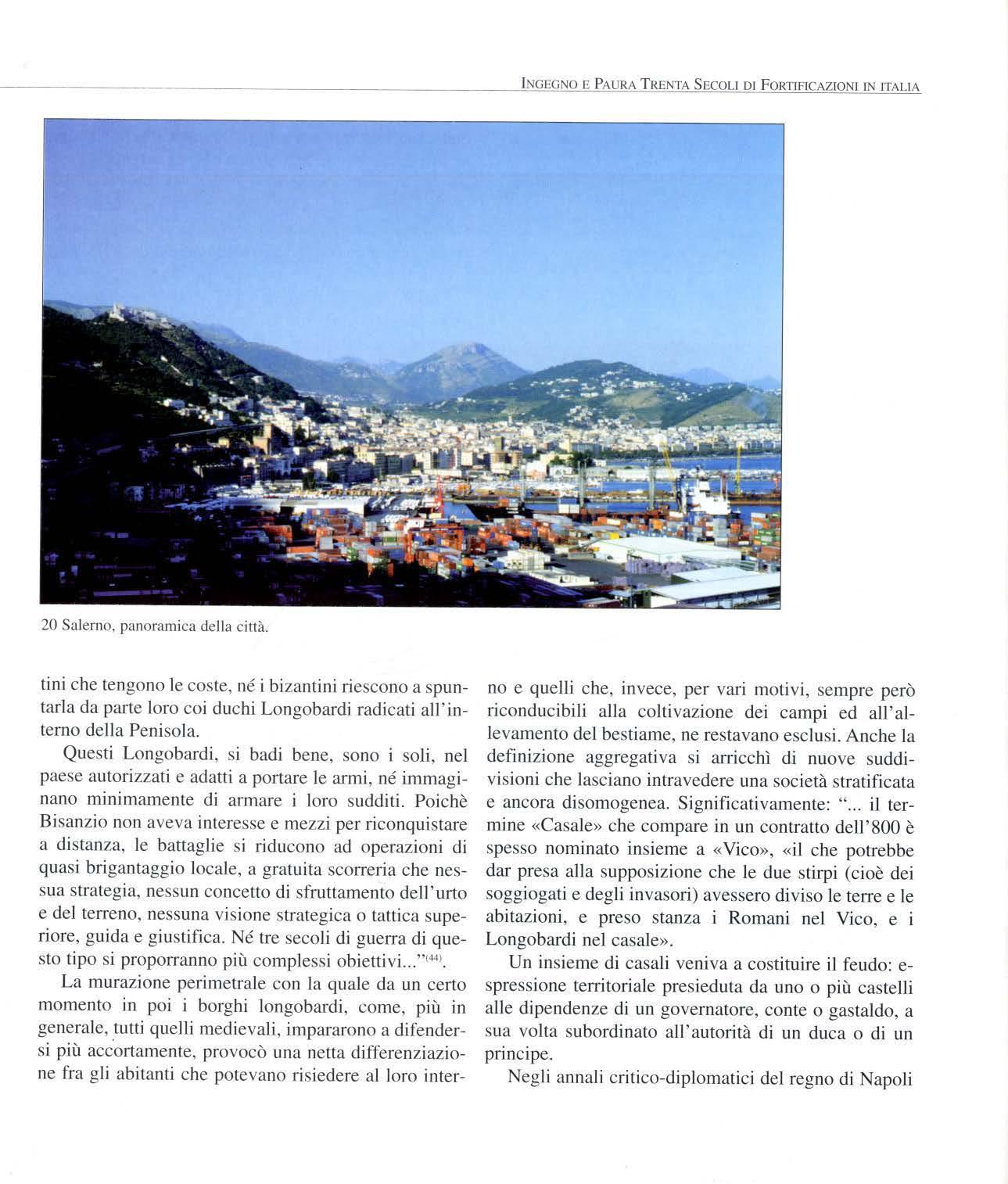
t ini che tengono le coste, né i bizantini rie scono a spuntarla da part e loro co i duchi Longobardi radicat i aJl'interno della Peniso la
Questi Longobardi, s i badi bene, sono i soli, nel pae se autorizzati e adatti a portare le armi, né immaginano minimamente di armare i loro suddi ti. P o ichè Bi sanzio non aveva i nteresse e mezzi per riconquistare a di s tan za, le battaglie si riducono ad operazioni di quasi brigantaggio l ocale, a gratu ita scorreria c h e ness ua strategia, ne ss un concetto di sfruttamento dell'urto e de l terreno , ne ss una visione s trategica o tattica superiore , guida e gi u st ifica. Né tre secol i di g uerra di qu esto tipo si proporranno più co mple ss i obiettivi .''144 1 •
La murazio ne perimetrale con la quale da un certo momento in poi i borghi longobardi , come, più in ge nera le, tutti quelli med ievali, impararono a difenders i più accortamente, provocò una ne tta differenziazione fra gli abitanti c he potevano risiedere a l loro inter -
no e quelli che, inv ece, per vari m otiv i, se mpre però riconducibili alla co ltiva zione d ei camp i ed all' a llevamento de l bestiame, ne res tavan o escl usi Anche la definizione aggregativa s i arricchì di nuo ve s uddivisioni c he lasciano intrav edere una s ocietà s tratifi cata e ancora di somogenea. Sign ificati vamente : " ... il termine «Casale» c h e compare in un contratto dell'800 è spesso nominato insieme a «Vico», « il c he potrebbe dar presa alla s uppos izion e che le du e stirpi (c io è dei sogg io gati e d eg li inv asori) avessero divi so le terre e le a bita zion i , e preso s tanza i Romani nel Vico, e i Longo bardi nel casale>>.
Un in s ieme di casali ve niva a cos tituire il feudo: espress ion e territoriale presieduta da uno o più castelli alle dipendenze di un governatore, co nte o gas taldo , a sua volta s ubordinato a ll 'a utori tà di un duca o di un principe.
Negli an nali criti co- diplomatici d el regno di Napoli
I NGEGNO E PAURA TRENTA SnCOLI Dl FORTIFICAZIONI IN ITALIAsi legge: «I Longobardi intendevano per castello ' l' arces' dei latini, ossia le rocche. Qui credo che per castello si intendono paesi forniti di rocche, o queste con molte abitazioni ad esse congiunte o in poca distanza Nelle opere dei giuristi tale significato è confermato, ma talora essi serbano il nome di Castrum con preferenza alla terra principale, dando a tutti gli altri castelli uniti e soggetti piuttosto l'appellazione di Casale» ... " <4 5 > _
Dalla evidenziata confusione tra definizioni difensive ed urbanistiche è facile ricavare la connotazione dei ducati longobardi, in cui non era più distinguibile il civile dal militare, la pace dalla guerra. È indubbio che l'introduzione nel repertorio fortificatorio di espedienti tanto elementari, quanto arcaici, nel mentre ne confem1a indirettamente la validità. testimonia l'insufficienza perdurante dell'apparato milita.re, incapace di reperire i mezzi e le forze per averne ragione. Unica contromisura per incrementarne se non altro gli organici, peraltro stentatamente elaborata ed ancora più stentatamente applicata , I' obbligatorietà di una esplicita autoiizzazione reale per l'edificazione di una qualsiasi fortificazione (l 'heribanno regio) subordinandone la concessione ali' accettazione del servizio militare. La sicurezza del singolo in cambio di quella dello Stato, fingendo di ignorare che con tale facoltà si sarebbe piuttosto incrementata l'impunità dei feudatari: ma è anche probabile che si stimasse quel rischio meno grave delle scorrerie saracene. I documenti, infatti: " ci informano su moltissime concessioni date per l a costruzione di casteJli da innalzare in luoghi opportuni ... Si iniziò, così, ad intendere le fortificazionì come un insieme organico per la difesa di interi territori contro i saraceni e non più come singoli posti muniti ... ''<461 • È probabile, però, che in realtà tale esito fu conseguito casualmente, riuscendo difficile credere ad un piano difensivo organico prestabilito in un contesto tanto arretrato ed anarchico. Qualcosa del genere, del resto, era avvenuto già con i nuraghi, e poi con le cerchie sannite, ed ancora si sarebbe verificato nel XV e XV l sec. con la proliferazione delle masserie fortificate, opere tutte erette autonomamente e per finalità
difensive familiari. ma nel loro insieme cooperanti alla interdizione del territorio nei confronti di un aggressore esterno.
Circa le connotazioni difensive attive di tali fortificazioni, va ribadito che contemplavano esclusivamente il tiro piombante, ovvero il lancio di dardi, di massi o di liquidi ustionanti dall'alto delle cortine, senza un consapevole ed accorto ricorso al fiancheggiamento, peraltro scarsamente conciliabile con l'impianto apicale. Pertanto: scansione rada delJe torri, prive per giunta di una razionale configurazione geometrica, lungo il perimetro dei borghi; tracciati estremamente irregolari con mura di modesto spessore , erette con i materiali più disparati, spesso cavati da costruzioni monumentali romane senza alcun discernimento; approssimata merlatura con rudimentali e sporadiche bertesche; rari fossati.
Disgraziatan1ente, come già precisato per i protocastelli longobardi e per l'edilizia dei borghi, anche quelle cerchie, pur sopravvivendo in discreto numero, raramente scamparono alle successive ristrutturazioni che comunque ne conservarono sia la concezione d'impianto sia il tracciato e sporadici episodi costruttivi originali. Fatte salve tali limitazioni, un interessante esempio tipologico, lo si può individuare nel borgo di Vairano Patenora, in provincia di Caserta.

Secondo la tradizione il nome del piccolo centro deriva da un antichissimo possidente romano, tal Vario, sebbene il nucleo abitato originario risulti ancora più antico, rimontando all'iniziativa dei Sidicini, che per primi fortificarono la sommità de l colle. Da allora, attraverso continue trasformazioni ed adattamenti, il centro si ampliò, differenz iandosi ed articolandosi, mantenendo immutato soltanto l'impianto an·occato e la sua propensione difensiva. Nonostante l'ininterrotta sequenza di distruzioni - ricostruzioni, le diverse impronte architettoniche, di volta in volta avvicendatesi, non sono scomparse integralmente, sovrapponendo-
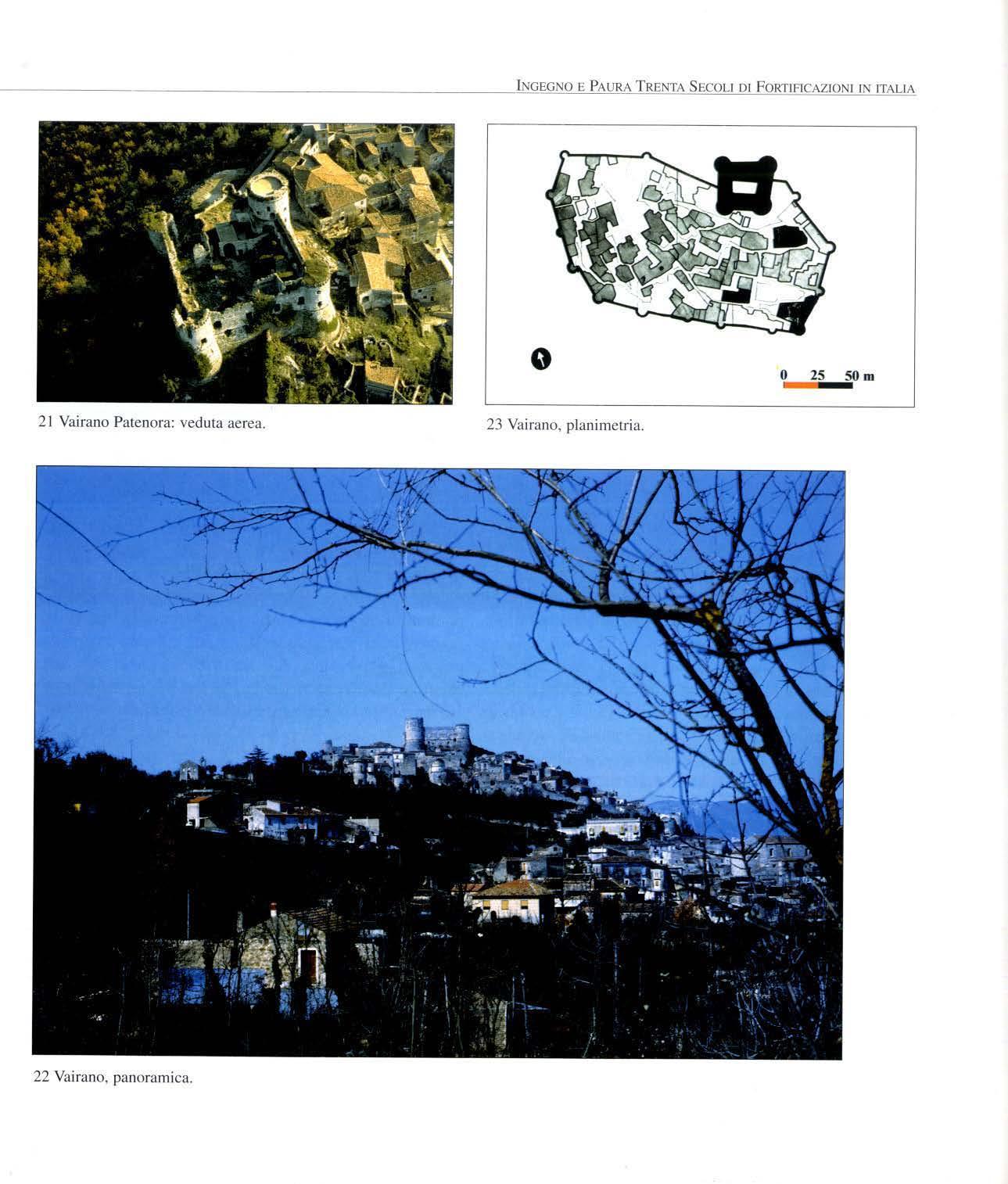 LNGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIA
O 25 50m
2 1 Vairano Pate nora: veduta aerea.
o23 Vairano, planimet ria.
22 Vairano. panoramica.
LNGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIA
O 25 50m
2 1 Vairano Pate nora: veduta aerea.
o23 Vairano, planimet ria.
22 Vairano. panoramica.
si e fondendosi fra loro in un pittoresco aggregato. In dettaglio, al: " primitivo insediamento sulla collina deve essersi aggiunto, o sostituito nel periodo romano, un nuovo insediamento con caratteri edilizi ed urbanistici meno strategici, e più adatti all'agricoltura ed al commercio. I ritrovamenti e la vicina via Patenaria lo dimostrano ampiamente; purtroppo di questo primitivo insediamento in pianura non rimane alcuna vestigia nè edilizia nè urbanistica.
Nel medioevo si verificò il fenomeno opposto: guerre, invasioni e scorrerie, da una parte, ed il contrarsi delle attività economiche, dall'altra, dovettero far sì che gli abitanti di Vairano abbandonassero l'insediamento in pianura per tornare sulla cima della collina ed ivi fortificarsi. A tale epoca risale l'originario castello e la primitiva cinta delle mura, probabilmente molte delle costruzioni all'interno del pe1imetro fortificato hanno la loro remota origine in questo pe1iodo. Non è facile però individuare le più e le meno antiche, cioè detenninarne la stratificazione. Infatti l'omogeneità quasi assoluta del materiale impiegato ed il perdurare di certi tipi e tecniche di cosu·uzione, hanno reso l'ambiente medievale piuttosto uniforme; in ogni caso il suo carattere risulta chiarissimo sia nell'ambiente edilizio che nel tessuto urbanistico delle strade. Ad ogni modo dobbiamo tener presenti le complesse vicende dell'alto medioevo in Campania per poter valutare il significato di questo insediamento difensivo il cui nucleo originario sorse, probabilmente nel IX secolo e cioè quando Vairano apparteneva ai conti longobardi di Teano " <41 >
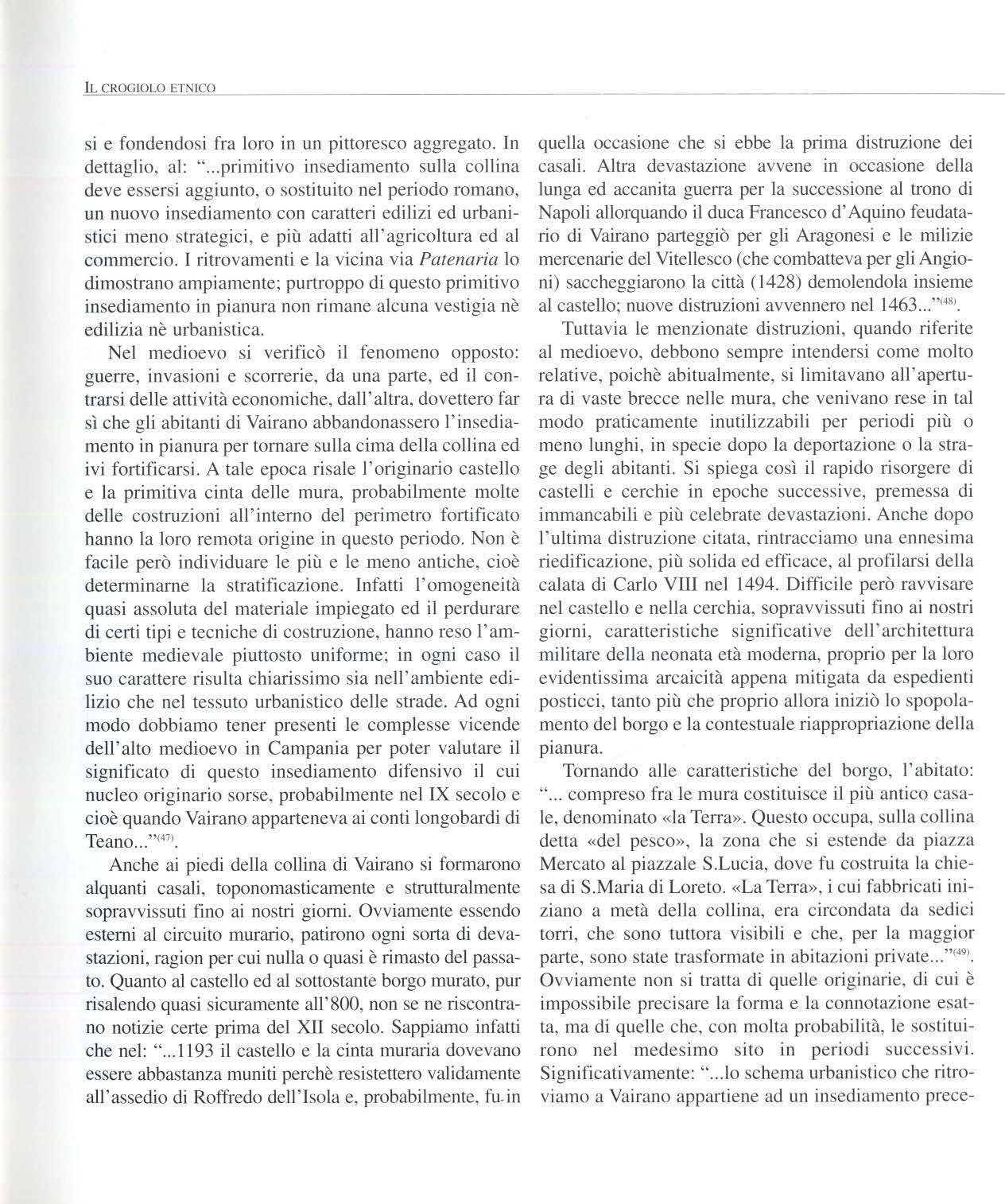
Anche ai piedi della collina di Vairnno si formarono alquanti casali, toponomasticamente e strutturalmente soprawissuti fino ai nostri giorni. Ovviamente essendo esterni al circuito murario, patirono ogni sorta di devastazioni, ragion per cui nulla o quasi è rimasto del passato. Quanto al castello ed al sottostante borgo murato, pur risalendo quasi sicuramente all '800, non se ne iiscontrano notizie certe prima del Xn secolo. Sappiamo infatti che nel: " ... 1193 il castello e la cinta muraria dovevano essere abbastanza muniti perchè resistettero validamente aU'assedio di Roffredo dell'Isola e, probabilmente, fu in
quella occasione che si ebbe la prima distruzione dei casali. Altra devastazione avvene in occasione della lunga ed accanita guerra per la successione al trono di Napoli allorquando il duca Francesco d'Aquino feudatario di Vairano paiteggiò per gli Aragonesi e Je milizie mercenarie del Yitellesco (che combatteva per gli Angioni) saccheggiarono la città ( 1428) demolendola insieme al castello ; nuove distruzioni avvennero nel 1463 " (4si Tuttavia le menzionate distruzioni, quando riferite al medioevo , debbono sempre intendersi come molto relative, poichè abitualmente, si limitavano all ' apertura di vaste brecce nelle mura , che venivano rese in tal modo praticamente inutilizzabili per periodi più o meno lunghi. in specie dopo la deportazione o la strage degli abitanti. Si spiega così il rapido risorgere di castelli e cerchie io epoche successi ve, premessa di immancabili e più celebrate devastazioni. Anche dopo l ' ultima distruzione citata, rintracciamo una ennesima riedificazione, più solida ed effo.:ace , al profilarsi della calata di Carlo VIIJ nel 1494. Difficile però ravvisare nel castello e nella cerchia, sopravvissuti fino ai nostri giorni, caratteristiche significati ve dell ' architettura militare della neonata età moderna , proprio per la loro evidentissima arcaicità appena mitigata da espedienti posticci, tanto più che proprio allora iniziò lo spopolamento del borgo e la contestuale riappropriazione della pianura.
Tornando alle caratteristiche del borgo, l ' abitato: " ... compreso fra Je mura costituisce il più antico casale, denominato «la Terra». Questo occupa, sulla collina detta «del pesco» , la zona che si estende da piazza Mercato al piazzale S.Lucia, dove fu costruita la chiesa di S.Maria di Loreto. «La Tena» , i cui fabbricati iniziano a metà della collina, era circondata da sedici torri, che sono tuttora visibili e che, per la maggior parte, sono state trasfom1ate in abitazioni private ... " <49 > Ovviamente non si tratta di quelle originarie, di cui è impossibile precisare la forma e Ja connotazione esatta, ma di quelle che, con molta probabilità, le sostituirono nel medesimo sito in periodi successivi.
Significati vainente: " .lo schema urbanistico che ritroviamo a Vairano appaitiene ad un insediamento prece-
dente a quello deJla trasformazione del d' Avalos; quel feudatario , infatti, si limitò a ricostruire, con i nuovi criteri del suo tempo, il castello e la cinta muraria, senza alterare il primitivo impianto planimetrico.
La morfologia del luogo aveva dettato queUa disposizione ... irregolare che noi oggi notiamo e che non fu alterata; essa doveva adattarsi al terreno per la più efficace difesa del luogo già strategicamente forte per condizioni naturali ... " c5oi _
Più in dettaglio: " la cinta difensiva , che si concludeva nel castello posto nel punto più alto, allineava tratti rettilinei e torrette cilindriche su un perimetro murario a doppia s carpa tipico dell ' architettura militare meridionale del XVI secolo. In essa si aprivano tre porte: porra Oliva a ponente, porta di me zz o a mezzogiorno e porta S.Andrea (ora porta Castello) a levante. Le ultime due rivestono un normale carat-
tere difen s ivo, mentre la prima presenta la caratteristica di e ss ere rinserrata tra una cortina muraria che s i allunga ortogonalmente di fianco, ed una toretta cilindrica
All'esterno delle mura ebbero vita gli altri tre raggruppamenti di case: «Greci », << Piazza » e «S.Maria a Fratta» che formavano i casali della Vairano medievale e che si s tendevano, più a valle, sulla stessa pendice della collina " 15 11 • Quanto al castello, nonostante la presunta e radicale ricostruzione della fine del '400, è ancora perfettamente riconoscibile nella sua architettura il criterio informatore s quisitamente medievale, e nella s ua ubicazion e la remota origine longobarda.
Simile , sotto il profilo storico e struttural e, anche il centro antico di Monresarchio che ulteriormente conferma il dipanars i cronologico dei borghi longobardi.
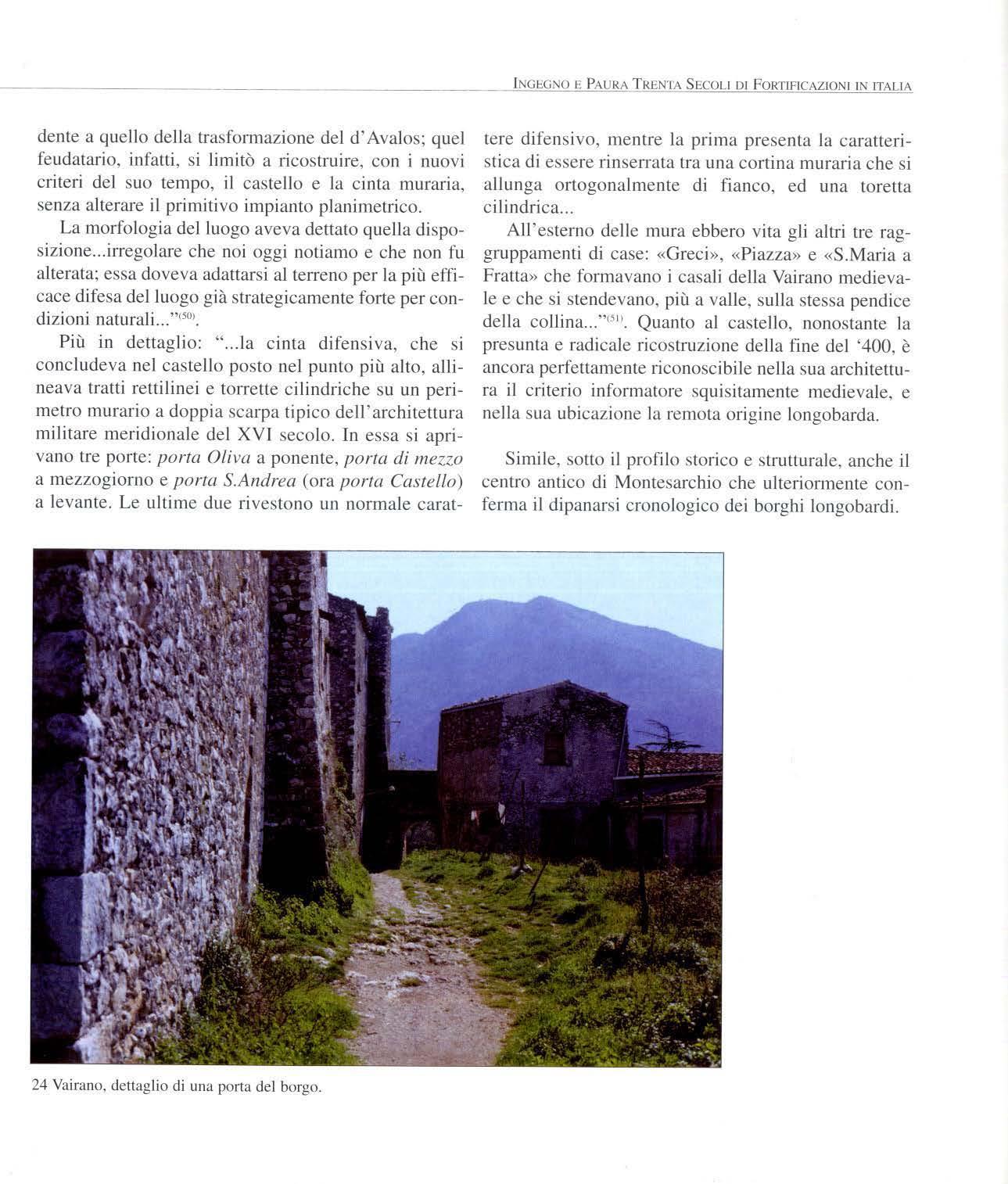 24 Yairano , dettaglio di una porta ciel borgo.
24 Yairano , dettaglio di una porta ciel borgo.
Anche in questo caso troviamo co m e nucleo 01iginario un massiccio torrion e cilindrico eretto su preesistenti fortificazioni italiche , nella fattispecie sann ite . Quanto però s i mostra oggi ai nostri occhj è l 'esito delJa ristrntturazione aragonese, che trasformò quella elementare fortificazione in due e laborate torri cilindriche coassiali, sol uz ione che, quand'anche non rara , è priva di analogie limitro fe .
Dall e sc arn e fonti apprendiamo che un ta l Arcole , vassallo di Arecbi II , s i fece carico, a ridosso del 700, di rifortificare la s ommità del Mons Arcis, in previsione di un imminente attacco dell'esercito di C arlo M agno proveniente da Capua. Te nendo presente la logica insediativa longobarda è estremamente probabile c he , allorquando si pro s pettò il potenziamento, sul cocuzzolo già
svettasse un so litario torrione, con il s uo immancabile recinto. La novità , pertanto, sa rebb e consistita nell 'affiancargli una seconda opera, magari più massiccia, una rocca per quanto rudimentale. Le solile laconiche fonti, infatti, ci informano che, ne l periodo dell 'affem1azio ne normanna, il 'castello' di Montesarchio subì danni gravi, particolarmente ne l 1073, quando l' erede a l tron o beneventano cadde combattendo contro i Normanni 152 ' E c he si trattasse di un cas tello e non di una sem pli ce torre lo confermano ancora le fonti, precisando che nel 1137 i militi di Ruggero II iiuscirono a conquistar lo, a1Tecandogli però numerose e più gravi devas tazioni. No n ricevette negli anni seguenti l'abituale 1ipristin o, o almeno non se ne trova riscontro fino alla prima metà del XUI secolo, allorchè la fortificazione fu res taurata per ordine di Federico II di Svevia. La riqual ifi cazione dovette conseguire un es ito Lalmenle efficace che il

O 5 10 m
26 Montesarchio, planimetria.
rinato complesso entrò a far parte dei possedimenti deHa corona, sino a quando Manfredi non lo cedette ai d' Acquino, nel primo dei tanti passaggi di proprietà che da allora lo videro protagonista.
I ricordati episodi bellici provocarono un esodo in massa della popolazione del borgo, aggregatosi nel frattempo alle pendici del castello, che tornò indietro soltanto dopo la conclusione degli scontri. Di tale vicenda permane memoria nella bipartizione del borgo stesso, nel quale la: " ...zona più antica ... detta ancora oggi Latovetere, sorse presso ]a torre, sul colle roccioso, secondo una conformazione che, senza assumere un andamento planimetrico propriamente radiocentrico, denuncia tuttora chiaramente la tendenza ad una concentrazione delle fabbriche nei pressi dell'opera fortificata; è chiara la subordinazione, in egual misura, di tutte le parti 1ispetto all'episodio saliente costituito
dalla torre e dal castello, con evidente riferimento alla tradizione instaurata dal feudalesimo.
lJ nucleo medievale doveva presentare già nel Xll secolo, una s is temazione organica. Il caste11o con la sua torre di avvistamento. separata, si affacciava verso la valle, mentre sui fianchi sorgevano le due borgate protette da mura. L'espan sione che l 'a bitato ebbe nei secoli s ucces s ivi si sviluppò verso il basso permettendo la conservazione del profilo antico di Montesarchio che ci è pervenuto fortunatamente intatto .. : '<531 •
Il borgo era racchiuso dalla solita muraglia di modesta fattura scandita da torri circolari di ampio intervallo , diverse delle quali, sebbene tra s formate in abitazioni , son giunte sino a noi.
Dal punto di vista architettonico il castello e la torre, pur formando un unico episodio, non sono strutturalmente altrettanto coesi, mantenendo anzi ben distinte le rispettive peculiarità, al di là dell'immancabile leggenda di camminamenti sotterranei di incerta memoria. li castello infatti: " occupa sulla preminenza roccio sa la parte opposta a quella prospiciente la valle e sulla quale la torre si ergeva [isolata]. La primitiva fabbrica è stata quasi del tutto di s trutta; sulle sue rovine nell'Ottocento, fu costruito un grande edificio adibito a carcere fino al 1936 Qualche Lraccia del1'originaria opera fortificata la notiamo solo nel basamento di grandi blocchi , squadrati e ben disposti a filari paralleli con una sp artizione di ordini sovra pposti, a risalti torici " <54l _
Ampie analogie con i descritti castelli e borghi apicali di origine longobarda, immancabilmente costituiti, o dotati , di un mastio, si rintracciano pure nel pittoresco abitato di Casertavecchia , l'antica Case Herte di longobarda memoria. Essa costituì infatti, con buona probabilità, il centro della conlea istituita ne]l ' VIII seco lo , e rappresentò con le sue fortificazioni , in particolare il castello eretto nel IX secolo, il principale caposaldo difesivo dell'intera regione. Per meglio valutare quanto precisato , basti considerare che le strutture che attualmente sco rgiamo nei pre ss i del borgo non hanno avuto bisogno di

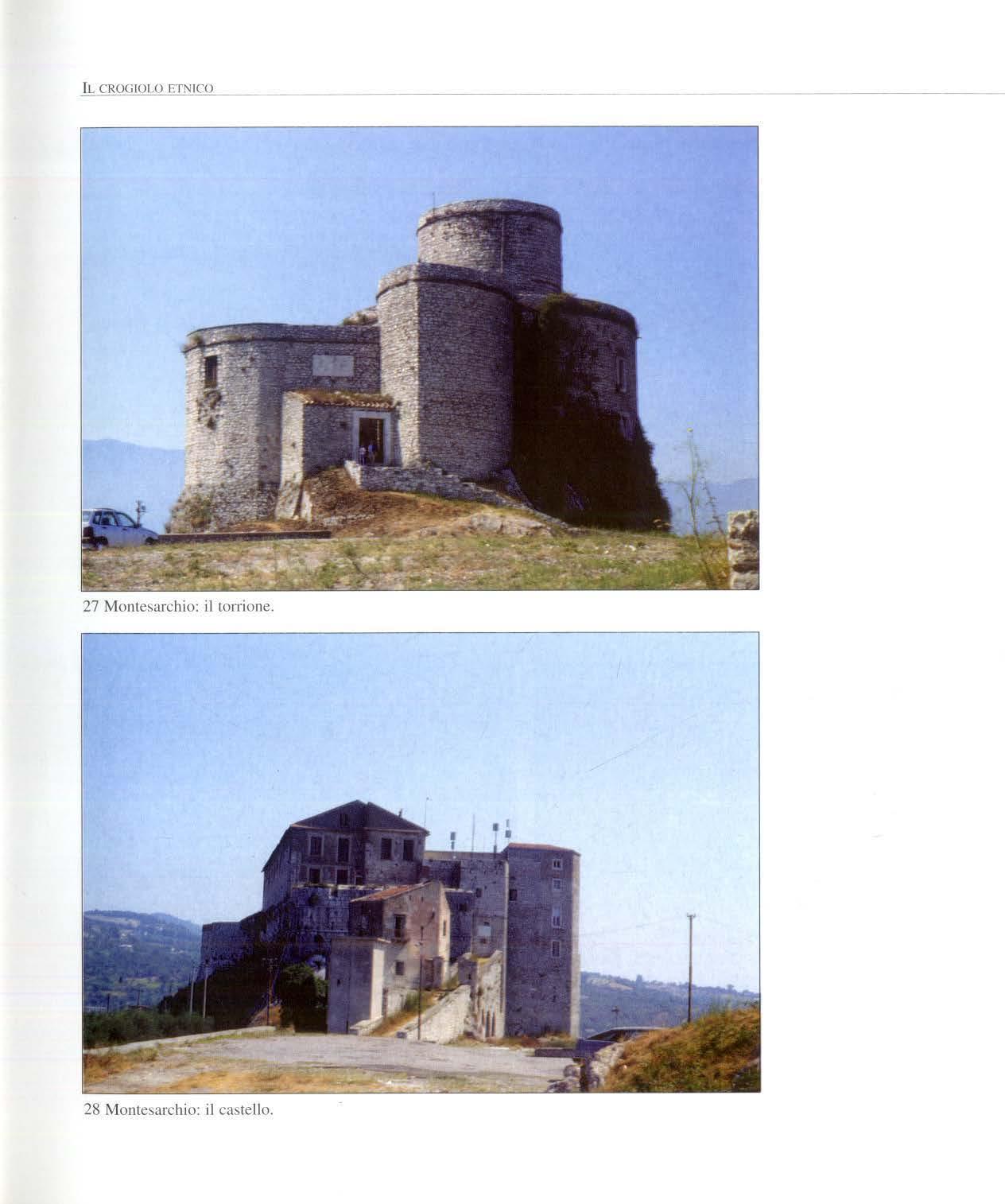

subire: '· modifiche al tempo degli Aragonesi, cioè quando l'impiego delle artiglierie modificò in maniera notevole l'architettura di[ensi va medievale. Articolato con sei torri ed un mastio .il castello assolveva al duplice compito di difesa e di residenza del feudatario. Non siamo in grado di poter definire quale potesse essere la sua completa configurazione spaziale, ma alcuni particolari ci permettono di inserire questo episodio in quella continuità espressiva che caratterizzò l'architettura civile e militare del Medioevo ... " ' 55 l
loro approssimata tecnica edificatoria e roaezza concettuale, mai sopravvissero alle dinastie successive ed alla dinamica evolutiva delle fortificazioni. Complice anche il vistoso incremento demografico , finirono infatti radicalmente ablase, ad eccezione di una unica rappresentante, quella di Benevento loro capitale meridionale. li suo singolare destino dipese dalla marginalizzazione geografica e politica della città, dopo il suo fagocitamento nei possedimenti pontifici, avviatosi nel I 05 I' 5 " e conclusosi con l'Unità d'Italia.
La cerchia urbica di Benevento
La conflittualità incessante con i Bizantini, la percezione della loro superiorità culturale e la indifferibile necessità di concentrare in precisi centri l'autorità politica ed economica, costrinsero, nell'arco di pochi anni, i nuovi dominatori a rivalutare, a pieno titolo, le città. Pertanto il: " cemro urbano acquista .. . nel diritto pubblico longohardo, una speciale consistenza giuridica di fronte a tutti gli altri centri, sì che, sia pure involontariamente il legislatore longobardo, viene a convalidare in modo mirabile il concetto giuridico della città, e le antiche tradizioni, che rendevano le mura cittadine oggetlo di un vero e proprio culto ... "'5 6i La città, da quel momento, superate ]e iniziali difficoltà, continuò ad èsistere. spesso immutala nel suo assetto. Come già nel contesto gotico, le st rutture presenti, appena rimaneggiate e riattate, apparivano infatti assolutamente congrue ai bisogni, ad eccezione delle fonificazioni perimetrali, per lo più gravemente danneggiale nel corso delle guerre pre cedent i o da secoli di assolula incuria. E, per la prima vol ta nel corso della loro sloria, i barbari guerrieri dovettero farsi carico di costruzioni difensive relativamente imponenti nonostante fossero estranee alla loro tradizione.

Oltre ai torrioni isolati ed alle piccole murazioni d ei borghi, i Longobardi eressero, perciò, anche cerch i e urbiche di considerevole estensione, che per la
Tralasciando di riassumere il glorioso e movimentato passato sannita e romano dell'antichissima cillà, impiantata su di un colle alla confluenza dei fiumi Sabato e Calore, è fuor cli dubbio che, allo sfaldarsi dell'Impero, disponesse di una Ji~creta cerchia urbica, sulla cui natura ed elltità tuttavia sus si s l0110 considerevoli incerteae. Probabilmente intorno al 490, Benevento cadùc sotto il Jominìo th::i Goti e si innescò così una sciagurata sequenza di 'passaggi di proprietà' tra essi ed i Bizantini. Nel 536, infalli. Belisario riconquistò la città , pa perderla nuovamente. appena nove anni dopo, ad opera di Totila. Stando alla testimonianza di Procopio di Cesarea, a quesl'ultimo deve imputarsi la distruzione radicale delle mura urbiche: I' ipotesi è, però, ancora una volta poco convincente, per la difficoltà di portare a termine tale impresa in tempi ristrelli. Più plausibile, invece. che si trattasse della solita demoliLione partialc , con apertura cli alquanle brecce, in sezioni già compromesse dal tempo e dai terremoti. Nel 555 Narsete 'liberò' la disgraziata Benevento, facendosi carico nella circostanza, sempre secondo la tradizione, della ricostruzione della cerchia. Ma anche in questo caso la notizia appare scarsamente credibile: si trattò, quasi certamente e più semplicemente, di una modestissima riparazione, forse proprio delle tratte danneggiate dal goto.
Di sicuro dopo: " .. .il loro arrivo i Longobardi compirono diversi interventi. Crearono nuovi quartieri e ricostruirono le difese distrutte durante la guerra goto-bizantina trasformando in parte l'assetto della città romana ... Per quanto costoro, a conoscenza del
fenomeno urbano dal1'epoca dello stanziame nto sud-danubiano, riutilizzarono edifici romani, dovettero adoperare anche abitazioni più semplici, molto simjli alle capanne in legno e paglia Un rinvenimento beneventano di alcuni anni fa purtroppo non compreso potrebbe aver 1iguardato prop1io una costruzione del genere " 1581 •

Nel 571 Benevento è uno dei maggiori ducati longobardi stabi lmente retto da Zotone, che per la sua 1ilevante dimensione, nonchè per la distanza dalle sede del potere centrale, gode delle più ampie libertà, almeno relativamente ai coevi.
Forse proprio per tale ragione, le condizioni in cui versano gli abitanti ri s ultano tra le peggiori della loro storia, vittime come sono di spietate repressioni e di massacri indiscriminati perpetrati dai barbari conquistatori per cancellare irreversi bilmente ogni loro residua identità sociale. Scriveva S.Gregorio Magno allo stesso Zotone:
" Ubique fuctus auspicimus, undiqu e gemitus audimus. Distructa e urbes, m •e rsa, sunt castra, depopufari agri, in solitudi11em terra redacta est. ·• , 59 ,
Nonostante quel tragico preludio, Benevenlo in pocru decenni iniziò a prosperare. attingendo sotto il lungruss imo regno di Arechi II, l'apogeo del s uo splendore , d egno della cap itale della Longobardia meridionale. Assurto a principato indipendente, s i estese fino ad includere tra i suo i possedimenti anche le città di Taranto e di Brindisi, con un contestuale evolversi ed ingentilirsi dei costumi longobardi , favorilo dalle massicce conversioni al cristianesimo. Ma la prosperità incrementava pure le mire stran iere che s i materializzarono in incursioni, assedi e campagne militari , tutte per lungo tempo vanificate, tangibile certificazione dell'esistenza di una valida fortificazione perimetrale.
In larga approssimazione, per quanto consentito dagli attuali resti: '' la cinta, che racchiudeva l'anli-
33 Benevento, planimetria cerchia longobarda. INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZJONI I N ITALIAco centro romano e la successiva espansione longobarda, si articolava con l'alternarsi di torri, quadre e cilindriche, in saliente sulla cortina muraria; è presumibile, però, che in origine le torri fossero tutte cjJindriche secondo la tecnica costruttiva altomedievale che presentava manufatti con superfici alquanto rozze e con impiego di materiale di spoglio ... Tra gli elementi salienti del perimetro difensivo sono stati individuati il castrum sorto sulla preesistente aree romana, la Porta Arsa e la Torre Catena; quest'ultima venne eretta in un punto strategicamente molto importante tra i lati occidentale e meridionale " <60 Circa l'andamento delle mura partendo lungo la via S.Filìppo e: " procedendo in direzione dei due monumenti romani [teatro ed edificio termale] è dato di vedere una sorta di terrapieno che muove dall'area di Porta S.Lorenzo. È molto probabile che le mura della città siano state dove si trova ora la struttura di contenimento ... Dopo questo tratto, con
un andamento che è solo possibile indicare perchè manca qualsiasi resto, le mura si spingevano fino a Porta Rufina. che era sensibilmente arretrata rispetto all'omonima porta moderna ... Da Porta Rufina le mura risalivano a Porta Somma lungo il costone meridionale della collina della Guardia ove ne restano lunghi tratti articolati da torTi a base quadrangolare. Anche Porta Somma nei primi secoli della dominazione longobarda... doveva sorgere più a occidente e anche la cinta non doveva spingersi sul lato orientale fin dove oggi se ne vedono i resti o se ne ricostruisce il percorso ... la prosecuzione dopo Porta Somma doveva portare le difese alla prima torre rilevabile lungo il tratto orientale della cinta ampliata ... quella che è circa all'altezza dell'ex Palazzo De Simone, oggi Conservatorio sull'attuale viale dei rettori. Come la successiva torre a sezione circolare segna la conversione delle mura verso ovest, in direzione dell'arco di Traiano trasformato

nella Porta Aurea delle fonti medievali, analogamente questa torre a base quadrata e a sezione circolare nell'alzato doveva essere il punto di svolta delle difese verso nord . . . Dopo l'arco ... le difese proseguivano lungo il costone della collina in direzione ovest, poi volgevano verso nord e infine piegavano a sud-ovest per aprirsi a Porta S.Lorenzo. Come nella sezione precedente, ben conservata . anche in questa. che è molto danneggiata, erano varie le torri due delle quali so no tuttora visibili ... Nel tratto da Porta Aurea a Porta S.Lorenzo, oltre ad una posterula cli cui è problematico determinare l'epoca si apri vano la Porta Gloriosa sul Ponte di S.Onofrio e forse la Porta Rettore di incerta datazione ... Entro l 'a mpia muraLione di m 2750,50 di lunghezza, realizzata fra la seconda metà del VI e gli inizi del Yll secolo, vennero a trovarsi il tratto maggiore del decumanus maximus della citt~l romana, parti di alcuni cardine.,· e numerosi isolati " 10 1>.

Un particolare interesse riveste la tecnica muraria con cui venne edificata la cerchia, chiaramente molto arcaica ed affrettata. Infatti, i: ' ' ... notevoli avanzi delle cortine longobarde denunziano i molti rifacimenti dovuti alle iniziative, anche private, che si sono succedute nel tempo e che hanno contribuito all'alterazione e al decadimento dell'opera tanto che in alcuni tratti si è arrivati perfino ad includere le mura nelle nuove costruzioni. La tecnica di esec uzione della fabbrica ci permette di individuare lungo le mura i tratti originali di pietra e ciottoli, posti senz'ordine uno sull'altro, misti a resti di colonne, lastre di marmo e frammenti di sculture inseriti liberamente nel tessuto mura1io .. .' '<62>
La cerchia: " proteggeva l'abitato e . si ch iud eva in alto nel punto di uno degli accessi alla città, e cioè alla porta Somma. Qui vi era probabilmente solo un nucleo. maggiormente difeso, dell'intero perimetro e tale considerazione deve ritenersi valida per tutto il periodo antecedente alla costrn7ionc della rocca. Solo
35 Benevento. basamento di una torre quadrata. lNGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIAnel medioevo l'opera fo11ificata si trasformò assumendo i caratteri difensivi peculiari di quell'epoca e cioè il palazzo con l'annessa torre costituente il mastio per l 'estrema difesa, circondati da mura e fossati con i relativi ponti levatoi. Di tali opere, che più non sussisto no è rimasta la citazione in documenti, mentre il pala zzo ha un aspetto comp letamente diverso dal la forma originaria.
L a sola torre, l'attuale rocca, ci è pervenuta, anche se trasformata, quasi integra ... Riteniamo che questa sia l a parte superst ite del fortiJjzio costruito dal Rossemanno e destinato allo smantellamento per ordine del papa; evidentemente ne rimasero alcune strutture che costituisco no, oggi, il nucleo primitivo di tutto il castello. La più antica fabbrica è individuabile all'esterno in quella parte scarpata c he rivela differente tecnica costruttiva e numerosi frammenti di materiale di spoglio provenienti da fabbriche romane " 163 •
Tornando alla cerchia urbica la grande fortificazione fu costruita: " .in opus incertum con riuso di pezzi antichi in funzione di sostegno e forse anche di ornamento , [e] va detto che la tecnica è più accurata nelle ton-i. In queste i blocchi romani sono impiegati come elementi portanti agli angoli. Lo s i riscontra molto bene nelle due toJTi a sezione quadrangolare del lato nord-oc c identale, la terza e la quinta dopo Porla Somma.
Il riuso di frammenti scu ltore i è particolarmente vistoso nel fortilizio che muniva la più recente Porta Somma e nella torre che seg na la svo lta della c inta verso nord-ovest dopo questo accesso. Sia nell e mura, s ia nelle torri, soprat tutto dove non sono s tati eseguiti restauri , si nota la presenza di fori a distanze regolari s u file parallele. Dovreb be tra ttars i di ancoraggi dell'impalcatura. Nono stante la distruzione dei coronamenti e la sopre levazione del piano di campagna, il più delle volte ri scontrabili insieme, è possibile indicare in circa 12 m lo sv iluppo verticale della cinta.. . Le uniche porte superst iti ... a parte l'Arco di Traiano<64 >, sono l'Arco del Sacramento e appunto Porta Somma. Non s i sa se in origine gli accessi alla ci ttà sia no s tati tutti quelli prima enumerati "c 65l


Dopo una strenua opposizione alle mire dei Franchi prima. e dei Normanni poi, nel 1077 la città passò sotto il dominio della Chiesa che, con alterne vicende, si sarebbe protratto fino al 1861 <M,> L'ampiezza di tale lun ghissimo arco storico garantì. senza dubbio , una stabile tranquillità a Benevento ed ai suoi abitanti, ma finì per emarginarli dalla c irco stante dinamica socio-culturale. Per le fortificazioni, tuttavia, ciò significò se non proprio l'abbandono, la scelta di una semplice attività di manutenzione, non ritenendos ene indispensabile l'aggiornamento. In data 23 agosto del 1597 la Camera Apostolica , tramite il s uo rappresentante beneventano di stanza a Roma, diffidava i consoli della città dal consentire, o tollerare, che lungo la cerchia. che era regalia Longobarda , si aprissero finestre o vani luce, altrimenti: " ... le signorie Vosn·e ne haveriano scorno et danno" "''\ fornendoci così una indiscutibile testimonianza della menzionata opzione puramente conservativa nei confronti di quel cimelio difensivo.

A contendere ai Longobardi il possesso della Peni so la, in pa1iicolare nel Meridione, fino alla conclusione della loro vicenda sto rica, come abbiamo più volte evidenziato, furono i Bizantini. In particolare all'epoca: " ... della sua massima espansione, la provincia bizantina in Italia è delimitata a Nord e ad Ovest dai principati longobardi di Capua-Benevento e di Salerno, a est dal mar Adriatico, a Sud dallo Jonio, a Ovest dal Tineno. La frontiera bizantino -logobarda, spesso non ben determinata e non di rado superata dal1'uno o dall'altro degli Stati confinanti, non ha mai dovuto oltrepassare il corso del Fortore: essa, seguendo il crinale dei monti Dauni , passava tra Bovino e Ariano per raggiungere il corso superiore del!'Ofanto a Ovest di Melfi; quindi aggirando il monte Vulture. correva a Est di Potenza e poi raggiungeva il Tanagro non lontano da Polla; infine costeggiando la Valle di Diano. discendeva a Ovest di Lagonegro per sboccare
probabilmente nel Tirreno col corso del Noce ... " 168 > La Sicilia, invece, restò, almeno fino all'arrivo dei Musulmani, interamente bizantina, per cui all'assoggettamento longobardo di gran parte della Penisola e all'insediamento a Ra venna della capitale, fece da contrappunto , nell'isola, l'ascesa di Siracusa a metropoli primaria dei domini imperiali occidentali. La c itt à divenne, per conseguenza, la base navale avanzata di Bisanzio per antonomasia, dotandosi di tutte le necessarie strutture, marittime e militari. Una conferma di quanto accennato può essere colta nel trasferimento operato, intorno alla metà del VII seco lo , da Costante
Il figlio di Costantino III ed imperatore dal 630 della sua corte proprio a Siracusa, nel quadro di una vaghegg iata ennesima riconquista dell'Italia.
Lo straordinario, quand'anche transitorio, 'trasloco' della sede imperiale, non rappresentò, purtroppo, il maggior evento del suo regno. Pochi anni dopo la sua ascesa al trono. infatti , per l'esattezza nel 632, si mate1ializzò sullo scenario mediterraneo un imponderabile avvenimento , destinato a sconvolgere, in pochi lustri, tutti g l i equi I ibri così faticosamente conseguiti: in una remota località mediorientale moriva Maometto Sino ad allora quel nome risultava assolutamente ignoto alla quasi totalità delle cronac he occidentali , per cui nulla lasciava presagire la travolgente ava nzata islamica che di lì a breve si sarebbe scate nata<69i Del resto, è a ncora oggi difficile realizzare la subitanea vio len za della espansione araba, proiettatasi contemporaneamente verso l'Asia e verso l'Europa. Indubbiamente lavorava a favore dei fanatici eredi del profeta un particolarissimo contesto sto rico , caratterizzato dalla inusitata, reciproca spossatezza dei due grandi imperi persiano e bizantino, entrambi incapaci di valutare e, meno che mai, d i stroncare la perniciosa potenz ialità emergente. E se nell'inarrestabil e espansionismo arabo, s i possono, con sufficien te aderenza, cogliere strette analogie con l 'effimero dilagare delle orde di un Attila o, più tardi, di un Gengi s Kan , di ben più tenace natura s i dimostrò il radicamento del dominio e, soprattutto, del credo islamico nei tenitori conquistati, tanto da sopravvivere

quasi inalterato fino ai giorni nostri. Giocò un ruolo basilare al riguardo la perfetta calibrazione della precettistica coranica, alla tradizione araba ed all ' indole orgogliosa e bellicosa delle instabi Ii tiibù. Nessuna invasione barbarica , nell'ambito socio-economico dell'Impero romano, aveva mai avuto lo stesso impatto scardinante sul suo tessuto sociale, proprio perchè mai erano state messe in discussione la superiorità culturale e morale dei s uoi cittadini, cosa che accadde, invece, con l'avvento dell ' I slam. Il Mediterraneo, quindi, da crogiolo di civiltà ormai sos tanzialmente omogeneizzate ed amalgamate, si tramutò in una so rta di frontiera fra due universi profondamente antitet1c1 ed irriducibilmente ostili fra loro. Nessun tipo di rapporto, al di fuori dello scontro armato, sarebbe stato perci ò possibile per il futuro, fra i due blocchi incomunicanti, almeno a livello ideologico.
Il ritrovarsi geograficamente ubicata lungo la direttrice di massima sollecitazione , implicò per la Sicilia la immediata sperimentazion e dell'aggressività musulmana e della sua brama di conquista. Per quanto c i è dato conoscere dalle fonti, l a prima incursione araba si abbattè sulle coste dell'isola g iu sto vent'anni dopo la morte di Maometto, nel 652 , gettando nel terrore gli abitanti, completamente ignari dell'esistenza del nuovo feroce nemico. La base di partenza per quel1' iniziale raid non fu la prospiciente costa nordafricana, ma quasi certame nte la Siria, vanamente difesa dalle truppe di Bi sa nzio nel biennio 634-635, e sottratta all'Impero, integralmente ed in-eversibilmente, agli ini zi degli anni '40.
Secondo altri autori, invece, quella remota incursione, foriera di infinite sciagure per l ' isola e per le coste peninsulari in genere, si originò dalla Pentapoli170> Resta comunque significativo, ed emblematico, che capofila dei bersagli oltremare dei musulmani s ia stata principalmente la Sicilia. Con due immediate conseguenze per gli attaccanti: 1a verifica di una capacità nautica, affatto sco ntata e sperime ntata per l'innanzi, e, cosa ancora più grave per gli Occidentali, la constatazione dell'inimmaginabile inettitudine bizantina a salvaguardare quell'estremo quanto strategico lembo
INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIAdell'Impero.
L'invio da parte di Roma, tenuta alla salvaguardia dell'isola, formalmente patrimonio di S. Pietro 0 1l, di un contingente agli ordini dell'esarca Olimpio, nel 649, testimonia , indirettamente. l'abnorme protrarsi nel tempo del drammatico contesto. Per giunta, allorquando, finalmente le truppe entrarono in contatto con i predoni, non riuscirono a ributtarli a mare, nè quelli, a loro volta, ad annientarle. Il tragico stallo si risolse soltanto con la morte, di peste, di Olimpio e con il reimbarco dei musulmani, resi pavidi dal diffondersi di voci circa un imminente sopraggiungere dei dromoni di Bisanzio. La squadra imperiale, disgraziatamente, non comparve mai nè ali' orizzonte nè sulla rotta di rientro delle imbarcazioni arabe cariche di bottino e di prigionieri, incrementando così negli aggressori la presunzione di impunità e la certezza di ingentissime prede. Le razzie iniziarono da quel momento a succedersi incessantemente con andamento stagionale, e quella che si abbattè sull'isola nel 699, ricordata dai memorialisti come la seconda, in realtà fu tale solo relativamente alle maggiori. In quella circostanza, una poderosa formazione, forte di 200 vele, attaccò la stessa Siracusa, devastandola atrocemente. Gli abitanti, che nel frattempo avevano avuto modo cli apprendere le caratteristiche delle scorrerie, in buona parte riuscirono a scampare alla cattura rifugiandosi, al profilarsi della sciagura, nelle tante fortificazioni limitrofe che, in quei frenetici anni, erano state rapidamente erette, o riattate, soprattutto sulle impervie cime interne dell'isola. Il che non impedì ai razziatori di trarre alle loro navi, dopo un mese di permanenza, oltre ad una ingentissima quantità di oggetti preziosi, alcune migliaia di disgraziati siciliani da vendere schiavi.
Fino a quel momento, però, pur osservandosi una progressi va dilatazione dei tempi di durata delle razzie, e, per contro, una netta riduzione degli intervalli fra le stesse, non si ravvisavano nei musulmani nè un esplicito disegno nè la forza sufficiente per una conquista permanente. Manifestatasi, senza la benchè minima attenuante, 1· inadeguatezza bizantina a contrastare le
incursioni, la sopravvivenza degli abitanti dipese esclusivamente dalla loro capacità di sottrarsi alla cattura, ovvero daJla disponibilità di fortificazioni. Anche la più scalcinata recinzione, infatti, si dimostrava per i predoni praticamente inespugnabile, in assenza della competenza tecnica e del tempo necessario all 'espugnazione nonchè dell'interesse a cimentarvisi.
Stando alle cronache, in quei terribili anni i Siciliani cercarono salvezza: " . .. fuggendo per munitissima castra et iuga montium, come ripetono le fonti latine che hanno tramandato ricordo del1' episodio. Si tratta evidentemente di un ' espressione fin troppo generica e ricorrente, il cui uso appare ancor più topico in fonti non contemporanee ai fatti narrati. Si può però almeno ipotizzare che antichi centri della Sicilia sud-orientale, come Mineo, Lentini, Akrai, Caltagirone, per la loro stessa posizione topografica e per la soprav viven z a probabile di fortificazioni d ' età indigena o greca , abbiano potuto offrire un minimo di protezione a chi cercava scampo allontanandosi da Siracusa espugnata e dalle coste aperte e indifese " C72•

Nel mentre le navi bizantine e siciliane si logoravano in estenuanti ed inconcludenti crociere costiere, nella vana illusione di contrastare i raid corsari arabi m' , sullo scenario internazionale l'avanzata islamica terrestre non concedeva tregua. La Siria non era stata ancora completamente conquistata, che già le armate musulmane, scavalcato Suez, dilagavano nella valle del Nilo. Alessandria capitolò nel settembre del 642, Tlemenc nel 677, e, tra il 680 ed il 683, caddero Tangeri ed Agadir. Allo scadere del VII secolo l'intera fascia litorale nordafricana era quindi saldamente nelle mani musulmane. Le conseguenze per la Sicilia, come per la Spagna, non si fecero attendere<74 J _
La dinamica espansiva islamica, infatti, lungi dall'essersi appagata dei tanti successi, si cimentò in una nuova strabiliante impresa, avviata agli albori del VIII secolo: la conquista della penisola iberica. I prodromi consistettero in un grande assalto anfibio, condotto da un contingente berbero di 7.000 uomini sbarcati. agli ordini di Gebel el Tariq, da cui lo stretto trarrà
il nome di Gibilterra, nella baia di Algesiras nel 711. In pochi mesi Cordova e Toledo capitolarono e nell'anno successivo, sopraggiunti i rinforzi dall'Africa, Ja conquista si ampliò rapidamente per poi stabilizzarsi per i successivi sette seco li.
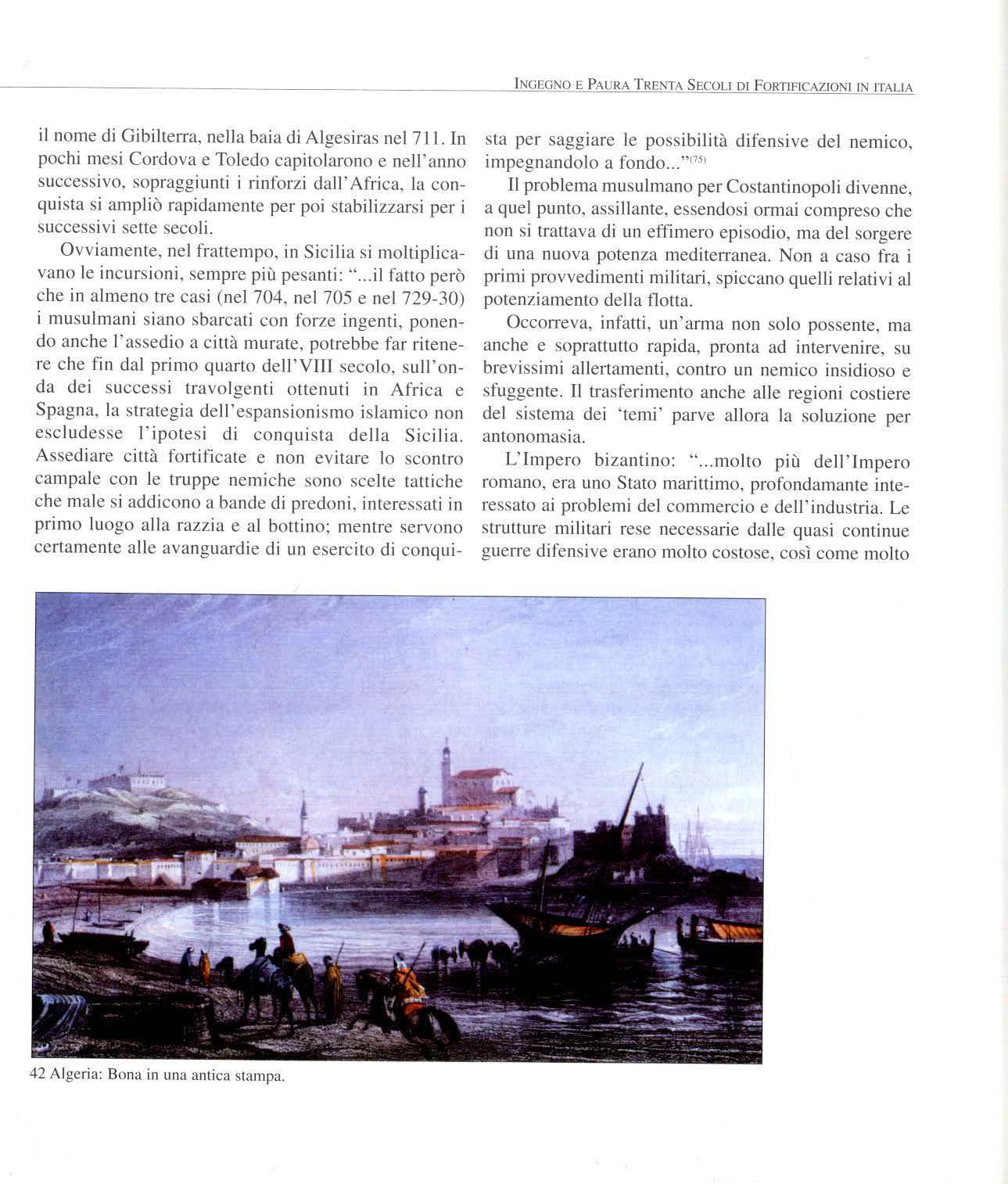
Ovviamente, nel frattempo, in Sicilia si moltiplicavano le incursioni, sem pre più pesanti: " .. .il fatto però che in almeno tre casi (nel 704, nel 705 e nel 729-30) i musulmani siano sbarcati con forze ingenti, ponendo anche l'a ssed io a città murate, potrebbe far ritenere che fin dal primo quarto dell'VIII secolo, sull'onda dei successi travolgenti ottenuti in Africa e Spagna, la strategia dell'espansionismo islamico non escludesse l'ipotesi di conquista della Sicilia. Assediare città fortificate e non evitare lo scontro campale con le truppe nemiche sono scelte tattiche che male s i addicono a bande di predoni , interessati in primo luogo alla razzia e al bottino; mentre servono certamente alle avanguardie di un esercito di conqu i-
s la per sagg iare le possibilità difensive del nemico, impegnandolo a fondo ... " 17si
Il problema musulmano per Costantinopoli divenne, a quel punto, assillante, essendosi ormai compreso che non si trattava di un effimero episodio, ma del sorgere di una nuova potenza meditenanea. Non a caso fra i primi provvedimenti militari, spiccano quelli relativi al potenziamento della flotta.
Occorreva, infatti, un'arma non solo possente, ma anche e soprattutto rapida , pronta ad intervenire, su brevissimi allertamenti, contro un nemico insidio so e sfugge nte. Il trasferimento anche alle regioni costiere del sistema dei 'temi' parve allora la soluzione per antonomasia.
L'Impero bizantino: " molto più dell'impero romano, era uno Stato marittimo, profondamante interessato ai problemi deJ commercio e dell'industria. Le strutture militari rese necessarie dalle quasi continue guerre difensive erano molto costose, così come molto
42 Algeria: Bona in una antica stampa. INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONl IN JTALIA
costose erano le esigenze della corte imperiale e della burocrazia e, infine, della diplomazia bizantina
L ' importanza del commercio spiega l 'interesse dedicato ai problemi della marina. Compito della marina imperiale era quello di vigilare non su grandi territori ma su importanti centri commerciali bizantini e sulle rotte che li collegavano con aree commerciali straniere. Ciò significava il controllo, diretto o indiretto, della costa della Crimea, dello s tretto di comunicazione, vitale tra il mar Nero e il Mediterraneo , delle città portuali dell'Adriatico
Nell'ottavo seco lo l 'estensione dei temi alla marina diede al sistema navale bizantino la sua forma finale. La marina permanente contava allora cinque flotte: la imperiale di base a Costantinopoli, e flotte provinciali di stanza sulla costa meridionale dell'Asia Minore, a Ravenna, in Sicilia e nelle isole dell'Egeo. Come nei temi terrestri, ogni distretto navale, comandato da uno strategos, pagava la maggior parte dei costi della flotta assegnatagli " <161
Quest'ultima precisazione mette a fuoco un altro grosso problema bizantino: l'esasperato ed inumano fiscalismo, che pur inad eguato a reperire le enormi ri sorse monetarie necessarie ad alimentare un insipiente quanto costoso apparato difensivo , alienava definitivamente le residue simpatie imperiali. In ogni caso la fonnazione ufficiale del tema di Sicilia, che fra il 692 ed il 695 finì per comprendere anche una parte del meridione continentale, segnò l'abbandono bizantino del Nordafrica e l'avvento di una strategia navale centro-occidentale.
In effetti la logica i s titutiva dei temi marittimi rispondeva ad un criteiio di decentramento delle forze, per meglio adeguarle alle diverse esigenze dell'Impero.
Pertanto , per concretizzare l ' intento , il: " ... comando unico della flotta fu soppresso e si crearono i comandi marittimi regionali indipendenti, ma che dipendevano da Costantinopoli nelle regioni minacciate dagli Arabi. Si tratta della flotta dei temi, di stinta da quella di stanza a Costantinopoli. Ogni flotta reg ionale è sotto il controllo dello stratega del tema , se questo è unicamente marittimo (flotta tema-
tica), o di un ufficiale subalterno, il drongario, che dipenderà in questo caso dallo stratego del tema (flotta provinciale). Le flotte tematiche per la maggior parte sono equipaggiate e mantenute (uomini e denaro) dalla provincia, mentre le flotte provinciali, meno importanti, sono essenzialmente a carico del potere centrale.
Questa riforma modifica quindi la struttura della marina bizantina di fronte alla flotta araba:
a) la flotta imperiale , composta di navi pesanti, è riservata alle spedizioni lontane e al controllo delle vie marittime internazionali;
b) la flotta provinciale, costituita da battelli leggeri, è addetta alla guardia delle coste;
c) la flotta tematica che comprende navi di ogni sorta, armate di fuoco greco, protegge il proprio paese d'origine e attaca il nemico in largo raggio d'azione ... " (771
In virtù del dispositivo citato, e forse addirittura prima della sua effetti va e piena attuazione, intorno alla metà dell'VHl secolo, la Sicilia sembra disporre di una sua considerevole flotta , di tipo tematico. La soluzione , tuttavia, valse appena ad alleviare l'offensiva musulmana di tipo incursivo ma nulla potè contro quella invasiva. Infatti nell'827 si ebbe il primo poderoso tentativo di conquista dell'isola: gli aggressori, favoriti forse da un alto ufficiale bizantino, sbarcarono a Mazara, dirigendosi verso Siracusa.

Per una serie fortuita di circostanze, almeno per quella volta, la città scampò all'attacco. Ma, diversamente da quanto avveniva nelle tradizionali scorrerie, i musulmani non ripresero il mare, preferendo accamparsi in una vasta testa di ponte, da dove, sopraggiu nto un secondo cospicuo contingente, nella primavera del '30, avviarono sis temati came nte l'assoggettamento della Sicilia, prendendo innan zitutto Palermo.
Tralasciando di addentrarci ulteriormente nei dettagli della travol gente avanzata, ricorderemo soltanto che ne11'843 capitolò M essina e nel1'859 Enna. Siracusa riuscì a re sistere ancora per altri diciannove anni. Taormina, ultima sp lendida capitale bizantina, si arrese nel 902; nel 965 la conquista di Rometta, estre-
mo lembo cristiano sull'isola ne sancì il completo assoggettamento dominio musulmano.
L'arco cronologico schematicamente ricordato fu caratterizzato da una straordinaria proliferazione delle fortificazioni. lnfatti il disperato tentativo di: " ... consolidamento del potere imperiale di Sicilia passava ... obbligatoriamente attraverso il rafforzamento della potenza militare del thema: e questo si concretizzò in primo luogo con un grande impegno di fortificazione del territorio cui fu abbinato anche un tentativo, rivelatosi alla lunga fallimentare di maggior controllo dei mari siciliani.

Di contro al silenzio delle fonti bizantine ed occidentali, le testimonianze di parte araba sulle misure difensive allora adottate dai rum sono estremamente vivaci. Secondo lbn al Athir, storico musulmano vissuto fra il XII e XIIJ secolo, i bizantini, approfittando della rivolta berbera I metà dell'Vlll secolo] e quindi della stasi nelle incursioni, «ristorarono ogni luogo dell'isola, munirono le castella ed i fortalizii e incominciarono a far girare ogni anno nella stagione intorno alla Sicilia delle navi che la difendevano».
Un altro scrittore musulmano del Xlll secolo, An Nuwayri, con toni ancora più incisivi riferisce che «il paese fu ristorato d'ogni parte dai Rum i quali vi edificarono fortalizi e castella, nè lasciarono monte che non v'ergessero una rocca».
L'esagerazione è probabile, ma al di là dei toni iperbolici emerge ugualmente in maniera drammatica l'immagine di un grande e precoce fenomeno di incastellamento originato da una situazione di conflittualità mediterranea che la deflagrazione araba aveva innescato. E di cui lo scontro musulmano-bizantino duramente combattuto in Sicilia rappresenta un grande e tardivo episodio.
Questa realtà è confermata senza incertezze dagli avvenimenti degli anni successivi. L'armata musulmana condotta da Asad ibn al Furat iniziò nell'827 la conquista di un paese notevolmente diverso dalla terra impunemente saccheggiata dai primi incursori nel corso del VII ed V III secolo. La Sicilia è ora difesa da decine di abitati fortificati che i musulmani dovranno
assalire e conquistare o costringere alla resa uno per uno, durante una serie di campagne protrattesi complessivamente per più di settant'anni... " 08 •
La proliferazione delle fortificazioni bizantine in Sicilia, come già a suo tempo osservato, non derivava dalla tardiva constatazione della loro efficacia, ma dalla comprovata incapacità degli aggressori ad averne ragione. Logicamente, con il trascorrere dei decenni e con il molti pi icarsi dei confronti ossidionali, tale inettitudine scemò, fino ad esaurirsi del tutto, vanificando l'apporto delle opere meno elaborate.
Da quel momento i musulmani, ormai edotti dall' esperienza acquisita nel settore, mentre decurtavano sensibilmente i tempi di resistenza degli ultimi caposaldi, iniziarono ad erigere anche loro nuove fortificazioni, o a riattare quelle conquistate, per meglio radicarsi in Sicilia. Qualche secolo dopo, di fronte ali ' intensificarsi della riconquista cristiana il ricorso alle strutture difensive attinse il suo acme. In molti casi ciò equivalse alla semplice riparazione delle sezioni danneggiate delle più antiche fortificazioni, o alla costruzione di modestissime opere su alture naturalmente impervie, ma non mancarono in alcune circostanze apporti originali attinti dalla tradizione etnica araba. Ma i bizantini prima, e i musulmani dopo, edificarono quelle strutture, in contesti di estrema contingenza per cui esse raramente sopravvissero; le poche rimaste in piedi, d'altra parte, in epoca posteriore, finirono per lo più ridotte dai locali a modestissime cave di pietra o disgregate dalla natura. Pertanto è possibile fornire su di esse appena alcuni ragguagli tipologici, estrapolandoli dalle più emblematiche.
Tra quelle di matrice bizantina:
Cefal ù fu a lungo una delle loro principali piazzeforti è descritta dagli autori arabi come città dotata cli mercati, bagni, mulini e di una grande rocca, ovvia-
mente installata sulla singolare formazione rocciosa che sovrasta l'abitato. In patticolare secondo un autore arabo coevo, di origine andalusa, la rocca in questione era talmente fonnidabile, nella sua quasi assoluta inviolabilità , da non trovare equivalenti. Di certo: ·'.. .il castrum di Cefalù continuò ad essere uno dei più importanti fortilizi demaniali dell ' isola fino al XV secolo. Sorgeva sulla Rocca: attualmente sopravvive in parte la grande cinta muraria che chiudeva tutto il vasto terrazzo superiore del rilievo seguendo il ciglio delle pareti. Rimangono inoltre tratti delle mura che cingevano la vetta della Rocca e alcuni avanzi del mastio , sempre in cima. Questi pochi re sti architettonici non sono databili con precisione. " 09 )
Taormin a fu descritta dai geografi arabi come una importantissima fortezza e città bizantina, operando una puntigliosa differenziazione fra la sua fortificazione perimetrale e la rocca. ln dettaglio: ·'.. .il castello di
Taormina, conservatosi in discrete condizioni, sovras ta la città dalla cima del monte Tauro (rn. 398), tradizionalmente identificato con l'acropoli della città antica. Nella sua configurazione attuale consta di un ampio cortile cintato a pianta irregolrumente rettangolare e di un mastio articolantesi i.n vari ambienti. Il complesso non presenta parti che po ssa no essere attribuite con certezza ad età normanna e per la sua persi ste nte rilevanza subì ce1iamente ripetuti interventi di modifica e restauro .'''~0 ' Più in dettaglio la fortificazione bizantina era ubicata in modo da poter controllare il valico s tradale fra la valle dell 'Alcantara e la costa 01ientale, e probabilmente si disponeva su diverse quote. La più bassa coincideva con l'attuale abitato, J' intermedia, in grado di dominare la precedente, corrispondeva al caste1Jo ed ai suoi dintorni, mentre la sommitale va identificata con l'odierno Castelmola, picco quasi inaccessibile la cui interdizione difensiva può ascriversi so ltanto ad una fase di e~trema res istenza.
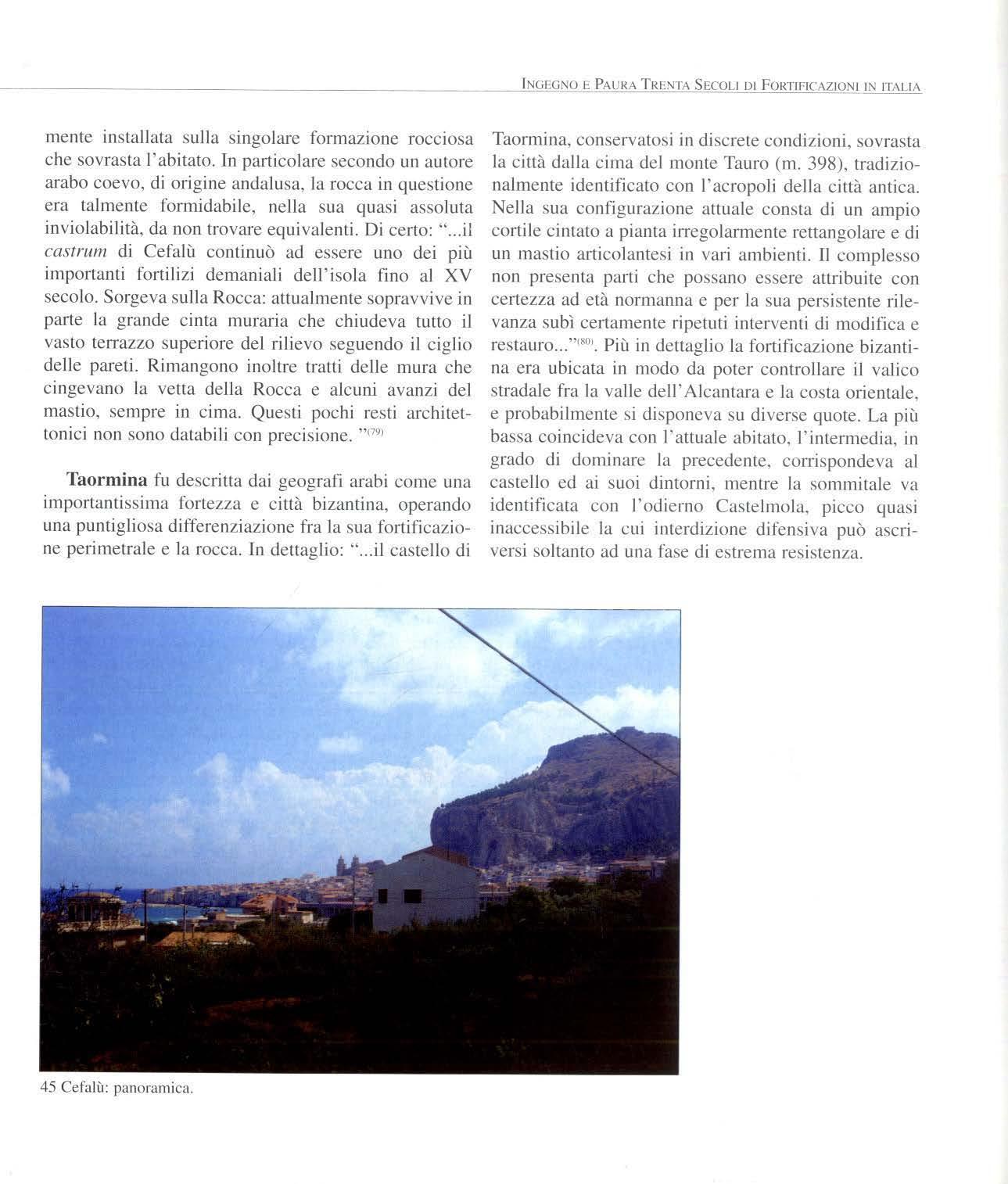

Castrogiovanni i suoi iuderi si rinv e ngono impiantati a circa 1000 mdi quota, non lontano da Enna. Per quanto s toricamente accertato fu la: " roccafo1te della resis tenz a bizantina e quindi fortezza mu s ulmana [e] continuò ad avere una notevole impo,tanza militare anche in età no,manna. L e s ue poten z ialità difen s ive e strategiche erano ben evidenti ad Idri s i che cosl la descrive: «c ittà posta s ulla sommità d ' una montagn a, racchiude un forte castello e saldo f01tilizio . .. insomma il più forte dei paes i. » ... Ha pianta irregolarmente poligonale, mw-a esterne che s i s nodano per ca 500 m. ed è s uddiviso da mura interne in tre grandi coitili per una superficie complessiva di quasi 30.000 mq. Cinque ton-i proteggevano la cinta esterna ed altre cinque sono disposte s ui punti più rilevanti delle mtu-a inteme " (8 1> Sebbene non se ne conoscano con certe zza le caratteristiche difensive, è assodato che l 'abitato ris ultava nettamente se parato dalla rocca, al punto che essa, nell'837 , co ntinuò a resistere a lungo dopo la conquista del borgo.
Monte Cassar so pra Castronovo di Sicilia, ad onta del toponimo da] chiaro significa to arabo qasr, (castello ) conserva rud e1i che so no con-entemente attribuiti a ll e dife se bizantine. In particolare nella murazione che s i s noda s ulla s ua so mmità: " .. .il muro , che prese nta lo spessore costante di ca. 3 rn ., è costitu ito da due paramenti di spezzami di calcare locale grezzi o solo parzialmente sgrossati, di piccole e medie dimens ioni , po s ti in opera a filari sen z a molta regolarità. Le pietre del paramento esterno, inoltre, laddove l'assenza di interramento permette l'o ss ervazione, appaiono prevalentemente disposte di taglio, in senso ortogonale ri spetto ali ' andamento del muro s tesso. La malta adoperata, piuttosto friabile, è s tata in gran parte asportata dagli eventi atmosferici Di una prima toITe esistente su questo tratto iniziale di muro esistono solo scarsi ss imi resti.
A questo primo tratto segue una seconda torre assai ben conservata; a pianta rettangolare , essa aggetta totalmente dal muro per ca . 5.80 m. ed è lun ga ca. 8.60 m. Le cortine della toITe s i so no conserva te in alte zza nel punto mas s imo per più di m 1.50. Anche la tone presenta
 48 Taom1ina , scorc io de ll e fortificazioni.
49 Taomiina, dettaglio Iso la Bella.
ING EGNO E PAU~A TR ENTA SECOLI DI FORTIFICA Z IONI IN JTALIA
48 Taom1ina , scorc io de ll e fortificazioni.
49 Taomiina, dettaglio Iso la Bella.
ING EGNO E PAU~A TR ENTA SECOLI DI FORTIFICA Z IONI IN JTALIA
riempimento di emplecton e paramento esterno realizzato in filari di blocchetti calcarei più sgrossati di quelli messi in opera nelle cortine del mmo. Da questa torTe la muraglia prosegue per ca. 65 m. con andamento simile ad una doppia curva assai larga [quindiJ un 'al tra torre o meglio una sot1a di bastione lungo apparentemente ca. 18 m. ed aggettante per 6. Il muro pro seg ue per altri 60 m Si incontra quindi una qum1a torre dalla pianta difficilmente precisabile, ma forse poligonale o semicircolare. Da questa il muro prosegue per ca. 50 m. fino ad una quinta torre molto rovinata Seguono altri 120 111. di muro ... e quindi una sesta torTe apparentemente rettangolare, lunga quasi 10 m. ed aggettante per 7. Ancora un tratto di murario di ca. 80 m. e ancora una setùma torre ... Da que s to punto il muro si inerpica bruscamente ... per uno sviluppo lineare di ca. 80 rn ... Superato il dis livello, il muro si ripresenta in tutta la sua evidenza e segue per più di 100 111., con due t01Ti molto rovinate. Dopo la seconda di esse la cinta compie un'ampia cu rva e quindi tira dritto in dire z ione N per ca. 120 m., andandosi a saldare ad un massicc io torTione quadrangohu-e (10 m. xll). Dallo spigolo opposto di questo un altro tratto di muro rientra in direz ione S, correndo parallelo al primo alla distanza di ca. 20 m È ques to il tratto meglio conservato della fortificazione ed anche il più particolare, presentando una struttura di versa da quella già descritta. Il muro, il cui spessore è costantemente di 3 m., presenta anche qui due paramenti e riempimenlo interno. La particolaiità sta, in entrambe le cortine, nell'impiego di grossi monoliti grezzi messi in opera verticalmente o di pilastri formati di alcuni blocchi più piccoli sovrapposti: si fomiano così specchiature di paramento lunghe in media 3 m. 1iempite con pietre e spezzami di dimensioni diverse e alcune volte sommai·iamente sbozzate "•&2 )
La singolare tecnica appena descritta somiglia moltissimo a quella utilizzata dai Fenici, quasi un millennio prima, sempre in Sicilia. Tuttavia la: " struttura muraria a telaio trova un parallelo immediato in quella utilizzata nei paramenti di alcune fo1tezze bizantine d'Africa, come Teboursouk. ..Tifich o Timgad, in Numidia. Si tratta, com'è noto, di una tecnica costruttiva rapida ed economi -
ca, molto diffusa in ambito punico, quindi passata nell ' architettura dell'Africa romana, fino ad età esai·cale (o pus africanurn) [Nel caso in questioneJ è da segnalare l'utilizzazione come rinzeppamento... dei soliti frammenti di tegole a superficie esterna sedata , tardo romane o bizantine. Questi elementi pennettono di propoffe ragionevolmente c he la cinta del Cassar sia in effetti una realizzazione di età bizantina... [forse] la località fo1tificala bizantina chiamata da Ibn al Athir qasr al gadid ('castello nuovo' ) da cui Ca,tronovo "(83 ,.

I ruderi delle fortificazioni edificate dai musulmani in Sicilia , nel corso della loro relativamente lunga dominazione, appaiono ancora più incon s is tenti di quelli bizantini. Infatti, evitando di dilungarci in tentativi di identificazioni eccessivamente ipotetich e, s i deve: " ... escludere che la lunga guerra di conquista inziata ne11'827 abbia provocato in gran numero distruzioni ed abbandoni completi di centri abitali rilevanti e comunque caratterizzati. in età tard o antica o bizantina, dallo s1a1us di città o fortezza. Un invasore relativamente numeroso. deci so ad impadronir si di una terra p er insediarvisi e colonizzarla, non n e sconvo lge le strutture portanti dell'in se diamento, accanendosi contro le città conquistate spianandole ed arando le rovine .''<~4>_ Ne deriva che la maggior parte dei centri s iciliani di epoca musulmana continuò ad avvalersi delle precedenti forlificazioni, non subendo alcuna sensibi le alterazione d'impianto. Senza dubbio furono erette anche nuov e strutture difensive ma è credibile che per lo più si attenessero alla tipologia locale, reputata motivatamente superiore. In un caso almeno, però , è possibile, con tutte le dovute riserve, individuare in una enigmatica fortificazione sopravvissuta un criterio inforn1atore di tradizione squisi t amente araba, per quanto di remota matrice romana nella cosiddetta 'fortezza araba' di Mazzallacar, ubicata s ulle s ponde del lago ai·rificiale di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento.
Jn dettaglio s i trarra di uno s trano: " ... recinto quadrangolare (5 I .60x 54.20 m. ) con agli spigoli quattro toITette c irco l ari (diametro m. 5) ad un so lo vano coperto da calotta mascherata ali' esterno dalla muratu-
ra. Nelle torrette si aprono alcune feritoie circolari intagliate in blocchi di pietra, sfr uttabili evidentemente solo con armi da fuoco e certamente non con archi come ritenuto da chi per primo s i è occupato del munomento. Il muro di cinta è, a tratti, molto rovinato, ma doveva presentare un'altezza di ca. Sm: lo spessore e di 1.1 O m, ma si riduce a m. 0.76 nelle quattro torrette. Al recinto si accedeva mediante due porte aprentesi sui lati Ne S: al s uo interno non esistono tracce apprezzabili di edifici, se si esclude un ambiente rettangolare addossato all'angolo SE. La coJlocazione cronologica del recinto di Mazzallacar è piuttosto problematica ... " <ss > .
L'anoma lia rappresentata dalle feritoie per armi da fuoco, che potrebbero però essere s tate inserite successivamente, ed ancor più dall 'i ns ignificante spessore dei muri porterebbe ad escludere un'origine medievale e quindi musulmana della costruzione. Altri fattori, per contro, sembrano inve ce confortarla, in spe-
cie se la si colloca nella fase ini ziale della conquista, quando la :fluidità degli scontri e la necessità di disporre sull'isola in tempi necessariamente brevissimi di basi s ia pur blandamente fortificate, costrinse senza dubbio gli invasori a reaJizzare un 'opera del genere di quella in esame attingendo alla loro esperienza in materia. Nessuna meraviglia allora, che il recinto appena descritto ricordi , in maniera estremamente significativa, i tantissimi e ben noti ribat: " fortini la cui costruzione accompagnò, in età abbaside, la progressiva conquista e l'assetto territoriale dell'Africa settentrionale. Le loro guarnigioni pare fossero formate da volontari a forte ispirazione religiosa, organizzati in una disciplina di vita paragonabile a quella degli ordini monastici , o, meglio ancora, degli ordini cavallereschi occidentali. Tale organizzazione appare rifle ssa dall'articolazione interna dei ribat ... La più ampiamente motivata proposta di datazione riferisce il ribat di Susa ancora all'VIII seco lo , segnatamente agli anni

775-788, quando in nome dei califfi abbasidi, governava l a ffriqiya l 'e nergico Yazid ben Hatim, ricostruttore anche della moschea di Kairouan, mentre alla iniziati va di Ziyadet Allah, che in una iscrizione a11 ' ingresso dell'alta torre di guardia, insistente sullo zocco l o quadrangolo che prende il posto della torre rotonda nell'angolo sud - occidentale, si proclama costruttore dell'edificio nel1'821. viene attribuita solo la costruzio ne della torre medesima, primo rimaneggiamento di molti c he hanno adeguato la forma e le caratteristiche del ribar al vari are delle funzioni "(86>
Simili ai ribat sono, del resto, anche le qala: " villaggi di 50-100 meni di lato, cli pianta quadrata, con torri di difesa agli angoli. Le celle di abitazione so no addossate alle mura, mentre nello spazio interno si trovano i magazzini, le stalle, i recinti per l a raccolta del bestiame. Nel complesso possono far pensare a dei fortini come quelli diffusi in tutto il mondo arabo-romano, oppure a caravanserragli . Molti dei loro caratte1i snutturali e difensivi derivano sicuramente dai castra romani. Si situ ano prevalentemente nelle piane aperte, nelle aree pedemontane, attingendo l 'acqua per l 'irrigazione delle oasi circostanti dalle falde alla ba,:;e dei ri liev i attraverso i qanat, i canali sotterranei <81> Dal punto di vista difensivo sono organismi fragili cons iderando il l oro rifornimento idrico dall 'es terno e la precarietà della costruzione fatta di argilla impastata . .. " ( 88 )
A differenza della Sicilia, irrimediabilmente persa per Bisanzio già nel X secolo , la Puglia ed alc uni centri costieri campani e calabri rimasero ancora a lungo fra i suoi possedimenti , nonostante i ripetuti attac c hi lon gobardi e sarace ni , g razie so prattutto alle loro fortificazioni . Si trattò , indubbiamente, di una sovranità eminentemente formale e quasi mai s upportata da una precisa guida p o liti ca, c he rimase quindi dovunque più o men o autonoma, a] punto di dare origine, in un caso almeno, persino ad una si ngo lare repubbli ca marinara, quella di Amalfi. La collocazione di 'frontiera' di quest'ultima finì

col renderla un rarissimo esempio di sintesi storico-culturale delle maggiori civi ltà del Mediterraneo.
La prima occasionale menzione di un borgo marinaro, insediato in una piccola insenatura della frastagl iatissima pen isola che delimita a nord il golfo di Salerno, risa le a l 596 . Oltre un seco l o dopo le fonti, includendolo fra le dipendenze del ducato di Napoli, ne rico rdano anche la cerchia muraria. Stando alla tradizione più acclarata:
" .i Romani vennero ad abitare in questi luoghi per la fortezza del Sito ne' tempi, che Roma stava sossopra dagl'insulti de ' Goti. Li quali per s icurtà della lor vita abbandonando la propria patria sù questi monti , ricov e roron s i: cosa che viene approvata da molti Scrittori, e tra gli altri dal Surnmonte, il quale in far parola delle guen-e di quei tempi. così scri sse Per raggiane delle suddette guerre ira ' Goti, e Imperiali essendo Roma di amhe due gli eserciti, h or perdura. e hor recuperala, non potendo i Romani far più le loro abitazioni in Roma, molti d'essi come vuole l'Ammirato ad abitare nelle nwrine di terra di Lavoro ne vennero, che da una parre di costoro ebbe origine la piccioi,a Republica Amalfitana, sincomè quella di Aquilea fecero di Venezia. Con tutto ciò !'eruditissimo Dottor Francesco di Pietro dopo aver riferito dietro ciò varj oppinioni, mosso dall'autorità di a ltri scrittori, questo istesso viene a confitmare: Stabilendo che in niun altra parte d'Italia il sangue de' Romani se hà possuto conservare salvo in questa Costa " ,891_
Così scriveva, al la fine del ' 600, il sacerdote Francesco Pansa, riproponendo una leggenda o rmai scontata in Amalfi, c he però, ad una più attenta analisi, non risu lta destituita di c red ibilità storica. È molto probabi le, infatti, che un gruppo di atterriti fuggiaschi difficilmente cittadini di Roma ma più verosimilmente c ittadini romani abbandonata l a pianura campana, dove imperversavano implaca bili orde barbare cli ogni risma, cercasse scam po inerpicandosi sui mon ti Lattari . Guadagnatane fati cosamente la cresta, ai loro occhi apparve allora, al di là dello spartiacque, il ripidissimo versan te me ridi o nale , ricco di piccole cale, angusti fiordi e capaci anfratti: rifu gio ideale per superare quei terribili momenti . Qu anto alle risorse, il mare avrebbe compensato in abbondanza quelle che l a terra les ina va. Per l'inaccessibilità dei luog hi , sinonimo di s ic urezza e u·anquillità, l'asilo da temporaneo s i trasformò in definitivo , determinando la fo1mazione di un borgo e, forse, la c osll1lzio ne di alcune fo1tificazioni. Qu est'ultime
di sicuro, comunque, vennero erette dopo la conqujsta longobarda di Salerno. Nel Pacrum. Sicardi dell'836. un accordo di non aggressione tra Amalfi ed il principe dj Benevento Sicardio, si fa infatti inequivocabile riferimento aJI 'esistenza di un castello. Nè patti nè difese valsero però a rispaimiare all'abitato amalfitano l'assalto dei bellicosi vicini, che si concluse con l'immancabile distruzione del castello.
Significativamente, tuttavia, proprio a quel medesimo scorcio storico rimontano le prime informazioni sull'organizzazjone politica della cittadina: dal Chronicon Salemùanum, infatti, risulta che, all'indomani del rapidissimo recupero deJJ ' indipendenza, venne eletto suo capo, con il titolo di comes, un tal Petrus. La vicenda conferma esplicitamente l'affrancamento di Amalfi da ogni residua sudditanza aj bizantini cli Napoli conseguenza forse della mancata protezione militare ed implicitamente, la già rilevante potenzialità economica degli ainalfitani, unica spiegazione del ritiro longobardo. In ogni caso, a partire dall'896, si avvicendarono
alla guida di Amalfi, prefetti di estrazione ereditaria, i quali dal 957 assumeranno il titolo di duchi, ulteriore riscontro della maturata autonomia.
Da un punto di vista aggregativo la cittadina, nel frattempo, si era articolata in una serie di insediamenti satelliti, quali Atrani, Minori, Maiori, Ravello, Scala e Positano, assetto logicamente imposto dalla paiticolarissima conformazione geomorfologica dei luoghi che. impedendo l'espansione urbanistica, costringeva al decentramento residenziale ed alla compartimentazione difensiva. Nello stesso periodo, nonostante la ricordata autonomia amministrativa raggiunta, non si coglie alcuna interruzione dei rapporti con Bisanzio, sebbene sulla base dei pochi documenti rimasti, sembrerebbe che: " ... si svolgessero sul piano privato anzichè su quello istituzionale " <9<'). Si spiega così l'utilizzazione di una monetazione occasionale, inizialmente longobarda e successivamente siciliana, ma mai bizantina, fino alla coniazione di una propria moneta. Del resto anche nelle questioni internazionali, Amalfi ostentò

sempre una non allineata scelta di campo, spesso diametralmente opposta a quella imperiale. comportamento precipuo di uno stato sovrano. È emblematico che nella sua opera, il già citato geografo arabo Ibn Hawqal, descrivesse Amalfi come la città:
" più prospera di quelle abitate della Longobardia, la più nobile, la più illustre per condizioni, la più ricca. la più opulenta. Il territorio di Amalfi è vicino a quello di Napoli. che è una bella città ma non importante come Amalfi ... " '" ''.
In verità. se rapportato alla rilevanza economica di Amalfi, esito dei lucrosissimi traffici fra i suoi innumerevoli scali commerciali, disseminati lungo le coste del Mediterraneo, in regioni sia cristiane che musulmane, il teffitorio che la piccola repubblica, gradatamente, riuscì a ritagliarsi e, soprattutto, a rendere inviolabile appare inusitatamente risicato. Si trattava, in estrema sintesi, di una frazione della già strimenzita penisola amalfitana, stretta per giunta a nord-ovest dal ducato di Sorrento ed a sud-est dal principato longobardo di Salerno. Nel periodo della sua massima espansione, infatti, Amalfi si estendeva sul versante

costiero della catena dei Lattari, da Cetara a Positano, compresi gli inospitali scogli dei Galli e la splendida, e semjdeserta Capri, mentre su quello campano si arrestava alle loro basse falde, inglobando i villaggi di Lettere, Gragnano e Pino.
Nonostante l'evidente modestia del] ' espansione territoriale, per rendere inattaccabile quel!' enclave occorse una catena di massicci caposaldi che vennero impiantati proprio nei menzionati villaggi pedemontani , trasformati così nel fronte a terra della Repubblica. Per la loro ubicazione essi vennero definiti correntemente castelli stabiensi, senza però che se ne conosca con certezza, antecedentemente al Mille, nè i I numero nè la dislocazione. Più precise informazioni, invece, si rintracciano per il periodo successivo, anche sulla scorta di permanenze architettoniche: il che ci consente di analizzare, con sufficiente attendibilità. non solo la concezione di tale sistema interdittivo concatenato , ma anche quelJa fortificatoria dei singoli casteJli che lo costituivano.
Sebbene la nostra analisi si limiti ai soli castelli di Pino e di Lettere , è comunque sufficiente per comprendere il disegno strategico complessivo e le caratteristiche strutturali dei suoi caposaldi , sostanzialmente simili fra loro.

In base al1e fonti disponibili , dovrebbe es sere stato il più antico, rintracciandosene menzione già nel 940: in ogni caso rappresentava il caposaldo nodale verso settentrione , al quale mai si lesinarono aggiornamenti e guarnigioni. Persino dopo la perdita delJ'indipendenza del ducato, conservò a lungo la sua importanza, venendo abbandonato soltanto in età vicereale, quando ormai la logica difensiva era diventala as solutamente diversa. Da allora subì la devastazione del tempo e degli uomini. con esiti immaginabili.
D suo sito d'impianto si conferma di straordinaria validità, consistendo nella sommità di una collinetta di circa 570 m. appena di s taccata dalla catena principale e pertanto al riparo da possibili attacchj dal1'alto. Da lì si riusciva perfettamente a controllare l'adiacente valico Pino-Agerola, uno dei due acces s i montani alla costiera amalfitana. Del castello propriamente detto non rimane quasi nulla , mentre è invece ancora possibile identificare le sezioni basamentali della murazione turrita del borgo, che gli si addossò secondo la prassi dell ' epoca
In dettaglio: " .. .l'andamento del circuito murario è anche ricostruibile nel lato occidentale della collina dove, adattandosi alla morfologia del suolo. segue le curve di livello.
Nel lato orientale le mura sono conservate fino ad una torretta pentagonale .T n questa zona, immediatamente all'interno del circuito muratio , si notano i resti di una robusta struttura nel punto più elevato della collina e che potrebbe essere identificata con il torrione o il mastio del castello.
Di questo edificio resta, parzialmente conservato in alzato , solo l'angolo occidentale e parte dello zoc-
colo perimetrale, su cui sono nati molti alberi e una rigogliosa vegetazione, che rende impossibile una più accurata valutazione.
Si tratta di una struttura realizzata con pietre calcaree spaccate, cementate con una malta grossolana ma piuttosto resistente. Il paramento è stato realizzato in maniera irregolare utilizzando pietre di circa 20x30 cm., miste ad altre di minori dimensioni, con rari tentativi di regolarizzare il piano di posa ... La pianta di questa struttura è in parte ricostruibi1e ... [e] mostra un impianto poligonale, con almeno tre ... [puntoni] terminanti ad angolo acuto ... " '92 '
Il sito d'impianto del castello di Lettere già all'epoca della sua primitiva edificazione era probabilmente occupato da una precedente fortificazione, forse di origine romana, con un adiacente villaggio di modesti ssi-
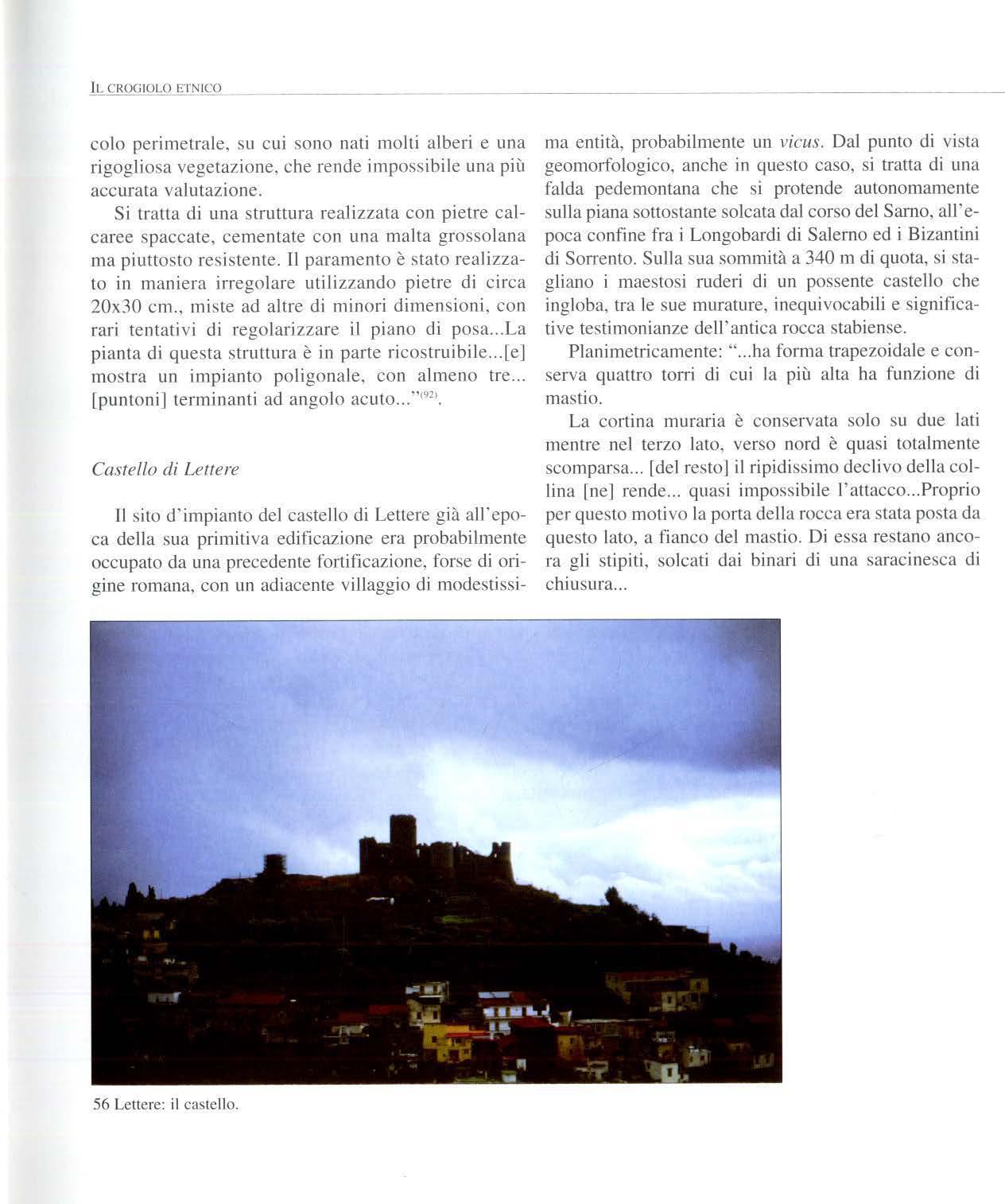
ma entità, probabilmente un vicus. Dal punto di vista geomorfologico, anche in questo caso, si tratta di una falda pedemontana che s i protende autonomamente sulla piana sottostante solcata dal corso del Sarno, all' epoca confine fra i Longobardi di Salerno ed i Bizantini di Sorrento. Sulla sua sommità a 340 m di quota, si stagliano i mae stos i ruderi di un possente castello che ingloba, tra le sue murature , inequivocabili e significative testi monianze dell'antica rocca stabiense.
Planimetricamente: " ... ha forma trapezoidale e conserva quattro torri di cui la più alta ha funzione di mast io.
L a cortina muraria è conservata solo su due Jati mentre nel terzo lato , verso nord è quasi totalmente scomparsa ... [del restoJ il ripidissimo declivo della collina [ne] rende ... quasi imp oss ibil e l 'a ttacco ... Proprio per questo motivo la porta della rocca era stata posta da questo lato, a fianco del mastio . Di essa restano ancora gli stipiti. solcati dai binrui di una saracinesca cli chiusura...
57 Lette re, planim etria del cas tell o.
Un secondo ingresso è presente nella cortina fra il mastio A e l a torre B, ha dimen s ioni più limitate ed è oggi ridotto ad un semplice varco ... Lungo il lato meridionale l a cortina è stata rifoderata con un paramento a sc arpa di pietre calcaree spaccate, me sse in opera con molta malta ed in maniera piuttosto irregolare ... Lun go tutto il perimetro della rocca è possibile individuare, oltre alla fodera di cui si è detto, complesse stratificazioni e ripetute sopraelevazio nj della cortina muraria , c he corr is pondono a divers i momenti ili evo lu zione e restauro deJla struttura
Uno degli elementi più antichi delJa rocca è il mast io ... [che] presenta una base poligonale a scarpa con cornice in tufo nel punto d'attacco fra la scarpa e la parete verticale .. ."c 9~i
Logicamente que s te ultime connotaz iom rappresentano g li adeguamen ti apportati alla s truttura dopo l'avvento de ll e artiglierie, e , non a caso, trovano significative so mi g lian ze nell e mastodontiche falsebrache d e l Castelnuovo di Napoli, edificate nello stesso periodo. Circa le alt re tre toni, di dimensioni considerevolmente minori , la prima ha una pianta semicircolare allungata, ed è inn estata aJ vertice di un angolo molto ottuso, in posizione mediana alla cortina, mentre alle estremità le restanti due sono circolari.

Ovviamente , o ltre alle fortificazioni del fronte a tena, Amalfi disponeva di difese anche lungo la costa e s ulle isole di Capri e dei GaJJi, certamente di minore e ntità, non fosse altro che per la presenza de lla s ua battagliera flotta, ma non per questo in s ignificanti.
In particolare s ulla s plendida isola: " ... si conservano .. .i due castelli di Capri (Castiglione) e di Anacapri (Ca s tello Barbarossa). L'o pera fortificata sul monte Cas tiglione [mantiene quaJe] unico elemento originario l ' impianto planimetrico con torri quadrate innestate nella cortina setten trional e [mentre] del Castello Barbarossa, costitui to dal corpo centrale ...è ancora visibile un 'a lta torre quadrata. e ... una cortina esterna ad a ndamento planimetrico irregolare ... " 194 > Anche a Capri il borgo , aggregatosi nei press i del castello, ru s poneva di una s ua cerchia turrita di cui rimangono ridottissirru avanz i. L'es igenz a per gli Amalfitani di fo rtifi care un ' iso la, praticamente di sabitata e forse inabitabile per gli enormi rischi delle incurs ioni saracene, s i spiega con la nece ss ità de l controllo marittimo della zona ad occidente del loro territorio e dello stretto che immetteva al golfo di Napoli. Per gli s tessi motivi anche gli iso lotti dei GaJli r icevettero, intorno all'XI secolo, alcune difese, forse tre torri , menzionate in epoca successiva, di cui sopravvivono oggi scarsissimi ruderi. Le fortificazioni di Amalfi dislocate lungo la costa, oltre ad un numero imprecisabile di strutture minori, per lo più torri. consistevano essenzia lment e nel castello di Pogerola, nel fortil i zio di Santa Sofia e nella rocca di San Felice, ed , ovviamente, nelle mura urbiche correnti lungo la riva del mare e radicalmente schianta te dal catastrofico maremoto del XIV secolo( 9}>. A testimoniare tanta produzione restano .i ruderi del torrione dello Ziro, che sovrasta il centro urbano , e all'estremità meridionale della in senatura quello di S. Francesco, entramb i ripetutan1ente e vistosamente trasfom1ati dagli Angioini prima e dag li Aragonesi poi. Altre fortificazioni vennero erette a Mai01i , come l'imponente castello di S. Angelo, so rto nell'VIU secolo, forse in abbinamento con un tonione distaccato posto in luo go più elevato e come il baluardo
di S. Sebastiano, sorta di sbm-ramento lungo circa 300-400 m e munito, lungo la cortina. di ben sei torri cilindriche, nonchè di un fossato antistante. n castello fu demolito alcuni secoli dopo, ufficialmente per far posto alla erigenda chiesa di S. Maria a mare, ma molto più verosimilmente perchè ormai giubilato e cadente, per cui nulla più se ne rintraccia. Del baluardo, invece, sopravvivono alcuni estremi segmenti, mentre le toni so no state trasformate in abitazioni. In epoca più recente, fu costru ito, sul co lle retrostante il piccolo centro, un nuovo castello, detto di S. Nicola de Toro Plano, capace di ospitare all' interno della sua cerchia, in caso di emergenza, tutta la popolazione, oltre 7000 abitanti. Di esso permangono cospicue rovine.
Che l'intero dispositivo difensivo amalfitano, appena riassunto, vantasse una ragguardevole validità lo dimostra non tanto l'incapacità longobarda ad averne ragione. quanto la lunga resistenza che fu in grado di opporre anche ai più evoluti Normanni. Tuttavia , agli inizi del XII seco lo Amalfi dovette cedere ai loro attacchi, ma solo perchè i suoi castelli investiti contemporaneamente da mare e da terra finirono col cedere uno ad uno alle soverchianti forze.

A brevissima distanza da Amalfi, quasi sulla montagna che ne sovrasta l'abitato, sta insediato Scala, piccolo paese le cui origini sembrano contemporanee a quelle della più celebre Repubblica marinara. Al riguardo, di recente, è stata formulata una interessante tesi che consente una suggestiva interpretazione dei resti delle sue fortificazioni. In particolare: " si ritiene che Amalfi e poi gli altri centri della Costiera siano stati fondati da Romani che qui naufragarono; cosa possibile ma che non spiega perchè poi Scala viene considerata come il più antico insediamento della zona. Le due tesi possono essere ritenute valide se consideriamo come Amalfi abbia avuto una direttrice di arrivo dal mare, mentre a Scala ci si sia arrivati da terra ...
L ' analisi dei manufatti murari del Castrum Scalae maio,;s avvalorerebbe l'ipotesi di uno stanziamento di genti che erano state a contatto c on i Bizantini e che
co struivano secondo i loro sistemi. L'osservazione poi di stanziamenti difensivi (con caratteristiche analoghe a quelle di Scala) da me notati a Cipro (rocca di S. Hilarion) e , ancor più, in Turchia (cittadella di Ankara) , dovuti ai Bizantini, induce a considerare come Scala possa aver subito una notevole influenza bizantina (non determinata da via marittima) di diretto contatto con i dominatori delle Terre del Mezzogiorno prima delle guerre contro Goti e Longobardi.

Se l'impianto su terreno roccioso e scosceso, in vista del mare, trova riscontro neJl'insediamento di Cipro, un particolare maggionnente emblematico è dato, invece, dal lisalto del muro sulla cortina, che presenta notevole analogia con simili risalti ancora presenti sulla cortina difensiva della cittadella di Ankara.
Queste sono osservazioni basate sulla forma (connessa a relativi s ignificati) di ciò che ancora rimane; una conferma potrebbe scaturire dopo aver eseguito ~m e s atto rilievo, con opportuni saggi, contemporaneamente a ricerche storiche mirate in tale direzione. " <%)
1 Così è sintetizzata la loro vicenda storica da G.C.KoHN, Dizionario delle guerre, Milano 1989. p.628: ..Gli Unni. un popolo nomade asiatico, discesero dalle steppe del nord del Mar Nero per invadere e saccheggiare l'Impero Romano. dove rimasero per circa 80 anni prima di tornare verso nord . Nel 375 si batterono contro i Goti e sconfissero gli Ostrogoti (Got i dell'est) cacciando i Visigoti (Goti dell'ovest, ariani , cristiani) sempre più verso oves t, avvicinandosi alla loro base danubiana. In seguito gl i Unni assoggettarono altri gruppi barbarici e gradualmente svilupparono il concetto di re come unificatore tribale. Attila (406 ?-53), il loro capo più famoso ... [attaccò1quando i compensi monetari non bastavano. Nel 441-42 -47 devastarono le province balcaniche... Ad ovest... Attila attaccò la Gallia sacc heggiando Metz e alcune città in Belgio, quindi si diresse verso Orlean s. Nel 451 le sue orde vennero bloccate da un'armata alleata di Romani della Gallia. Visigoti ed Alani al comando di Flavio Ezio ... Gli Unni si dires se ro in Italia e saccheggiarono Aquileia [i cui] fuggiaschi fondarono Venezia Ne l 452 gl i Unni misero a sacco Milano e Pavia; per evitare la distru1,ione di Roma. papa Leone I ·i] Grande'(390? -461) capeggiò una delegazione che si recò da Attila; non è noto cosa si siano detti in quell'occasione. ma gli Unni risparmiarono Roma e, carichi di bottino, attraversarono le Alpi. Nel 45 I Attila morì. I suoi figli furono battuti da tribù di Germani ribelli nel 454 fla sconfittal causò la ritirata degli Unni verso le loro terre di 01;gine.''
2 Per ulteriori notizie sulla vicenda cfr. E.PrROVINE, Napoli e i suoi Castelli, Napoli 1974, pp.JJ - 24.
J Ricostruisce la vicenda H.SCHREIBER. /goti.Milano 1981 , p. 199, in questi te1mini: "Poichè Odoacre 11011 cambattè mai contro l'impero d'oriente. non fu facile trovare un pretesto per orchestrare una campagna militare contro l'Italia Ma Teodorico era vissuto abbastanza a lungo a Bisanzio [e] conosceva il mondo di intrighi e di sca ltrezze in cui era immerso , tanto che con l'imperatore Zenone e un principe rugio scacciato da Odoacre racimolò abbastanza cavilli da ottenere che lo stesso imperatore d'oriente gli ordinasse di conqu istare la penisola italiana.. :·.
1 Da E.GIBBON. Storia della decadenza e caduta dell'/111pero rvnul!w, rist.Torino 1967 , voi.I 1. pp.1441-1443.
5 H.M.GwATKJN, L'aria11esi1110 , in Storia del Mondo Mediem/e , Milano 1978, vol.l, pp.143 e sgg così sintetizza le caratteristiche dell'arianesimo: "La controversia ariana prese spumo dalla conv inzione di un Dio puramente trascendente , che da tempo s i faceva strada , sia pure in modo diverso. in Grecia ed in fsraele Poichè i c1;:,Liani accettavano qualsiasi c redo che non fosse in palese contradd izione con la dottrina dell'incarnazione storica, s i può Jire che, verso la fine ciel 11 secolo. si era raggiunto un accordo generale sulla trascendenza ... La controversia ebbe inizio intorno al 3 18. Ario non era un fanatico, ma un serio e irreprensibile presb itero della chiesa di Alessandria, discepolo del dotto Luciano di Antiochia; solo, non era in grado di riconoscere una metafora. Come poteva un figlio non essere posteriore al padre e non essergli inferiore? ... lper cuij egli concluse che: il Figlio di Dio non poteva essere nè eterno nè eguale al P adre ed era quindi so ltanto una creatura, indubbiamente elevata. creata prima di ogni tempo per essere a sua volta creatrice di ogni altra cosa. ma che, essendo creatura, non poteva manifestare la pieneu.a della divinità ... Ario non intendeva iniziare un'eresia ma cercava solo di dare una risposta sensata al fatto che se Cristo è Dio, è un secondo Dio Cercando una 11ia media tra l 'i nterpretazione c1istiana e quella unitaria del vange lo , Ario dalle due prese tutte le diffic o ltà se111.a !-.frullarne i vantaggi. Se Cristo non è vero Dio. i cristiani sono colp evoli di idolatria: se non è vero uomo. le prete se degli unitari sono infondate. In entrambi i casi per Ar io c·cra la condanna ".

• Circa il mausoleo di Teodorico va ricordato che il monolito che l o ricopre in fom,a di cupola schiacciata ha un peso di oltre 300 t., con un diametro di circa 9 m., e non si ha nessuna informazione in che modo sia stato trasportato per o ltre un centinaio di chilomet,i , dall ' Istria, e soprattutco come sia s tato issato e posLo in opera.
7 La citaz io ne è tratta da P.GJM'NONE, Istoria civile del Regno di Nopoli, rist.Como 1970, vol.l.p.243. Circa l a penetrazione nella città attraverso l'acquedotto cfr. B.M1 cc10. U.POTENZA. Gli acquedotti di Napol i. Napoli 1994 , p 28.
Precisano R .FOLZ, A.G u tL LOU . L.MUSSET , D.DOURDEL. Origine e formazione dell'Europa Medievale. Bari l 975. pp.94-95: "Se Teodori co aveva rispettato con convinzione e scrupo lo i quadri dell'Italia romana. la stessa cosa non puè) dirsi degli ultimi re goti. Stretti in una situazio ne senza uscita dagli eserciti « romani» ancor più barbari dei loro, Totila... e poi Teia... accum ul arono rovine intorno a loro Roma privata dei s uoi acquedotti, non era più che un campo di rovine dove vegera,,a il papato, la classe senatoria era dispersa , l 'esercizio delle principali magistrature interrotto .''.
Q Cfr.B.MONTGOMF.RY. Storia delle guerre, Milano 1970, pp. 138 - J 41.
10 Della avveniris tica istituzione se ne ravvisano i criter i in formato1; già in un rapporto di Belisario a Giustiniano. Ricordano , infatti, R.A PR..ESTON. S.F.W1SE, Storia sociale della guerra, Verona 1973. p.69, che: il grande generale così si espresse a l rigurado: "«La principale differenza che ho trovat o u·a i goti e noi consiste nel fatto che i nostri cavalieri romani e i nostri foederati unni sono Lutti esperti arcieri a cavallo, mentre il nemico ha scarsa conoscenza di tutto quanto 6guarda il tiro con l'arco. I cava li eri goti usano infatti so lo s pade e lance, mentre i loro arcied a piedi vengono sempre in retroguardia. Così i loro arcieri non possono c~&ere usati con cffi -
cacia finchè non si arriva alla battaglia corpo a corpo e possono essere colpiti facilmente quando si presentano schierati per la ballaglia fino al momento del contatto». Nello schieramento bizantino gli arcieri a cavallo erano appoggiati dalla fanteria pesante e dai lancieri di cavalleria: ma era proprio l'arciere a cavallo a costituire la differenza p1incipale tra l'esercito imperiale e gli altri eserciti.".
11 Da H.SCHREIBER, / Goti , cit., pp.235 -23 6.
12 Da E.ZANINI, Introduzione all'archeologia bizantina, Roma J 994. pp.196- I 97.
11 Da E.GIBBON. Storia cit.. voi.I I, p.1642.
1 • Da G. V.CIARLANTI, Memorie istoriche del Sannio, rist. 1992, voi.III. p.57
1 ' Da D.MARROCCO, Sull'origine del nome di Sani "Agaw dei Goti, in La rassegna storica dei Comuni, anno II, num.2, Piedimonte Malese 1970, pp.4-8.
11 Da L.R.CIELO, Monumenti romanici a S.ARata dei COii, Roma l 980, p. I 7.
17 Cfr.A.MEOMARTINI, / comuni della provincia di Benevento, rist. Benevento I 970, pp. 3 I 7-325.
1 • Da M.COLETTA, Il Sannio beneventano, Napoli 1968. p. JOl.
1 • Cfr D.OBOLENSKY, li Commonwealth bizanti110 -L'Europa orientale dal 500 al 1453, Bari 1974, pp.61 -64.
20 Da D.OBOLENSKY, li Commonwealt.... c it. , p.67.
21 Da E.GmBON, Storia , cit., voi.li, p.1493.
22 Ricorda al riguardo G.CACJAULI , Il cas1ello in ltalia, Firenze 1979, pp.82 -88: "fl ma~tio così chiamato da maitre francese, nel significato di padrone (donde il tedesco meister), o da maschio, per indicare la tone più alta e robusta, è da considerarsi il primo e più importante e lem ento architellonico del castello, anche se proprio per questo il piL1 soggetto a trasformazioni o restauri. Altri nomi per questo elt:mento architettonico sono torrione, o torre-maestra (dei ivando l'aggettivo di nuovo dal francese «maitresse», oppure cassero per l'o riginaria funzione di vedetta. o per la sua diretta derivazione dalle torri di legno costruite appositamente durante le operazion i belliche e che. particolarmente in Toscana, presero nome in diretta analogia con le gabbie di vedetta sugli alberi delle navi. CoJ11unque venga chiamato, il mastio consiste in una torre che, pur i11 seguito a successive elaborazioni, rimane la più massiccia e la più alta dell'intero complesso. Più alta per mole ed anche per dislocaL.ione in quanto situata nel punto più sopraelevato del rilievo s u cui poi è stato erecto il castello, nell'interno del quale il mastio ha continualo a rappresentare il baluardo estremo, il simbolo concreto dell ' autorità ivi dominante, la sua conquista decretando il decisivo possesso dell'intero fortiliL.io. Nei tempi più remoti il mastio costituiva scolta avanzata ed in s ieme abitazione, si cchè propose subito la necessaria sohtL.ione di importanti esigenze logistico -militari. Perciò era suddiviso, già allora, in vani sovrapposti. con scarsi disimpegni oriaontali, che comun icavano fra loro per mezzo di botole in colonnate ... " .
23 Da A.GUILLOU, Aspetti della civiltà bizantina in Italia , Bari 1976, p.90
24 Cfr.P.DrACONO, Storia dei Longobardi, a cura di F.Roncoroni, Milano 1974. p.50. Il tennine/ara è una tran sletterazione latina di un termine germanico derivante a sua volta dafaran,fahren, che significa «v iaggiare » «s postarsi », e si riferiva pertanto ad interi gruppi dotati di mobilità e di comandanti, completi di guerrieri e relative famiglie. In essi possono ravvisarsi, perfettamente definiti, i singoli presidi di ogni futura guarnigione.
25 Cfr.P.DJACONO, Storia , cit., pp.41-43.
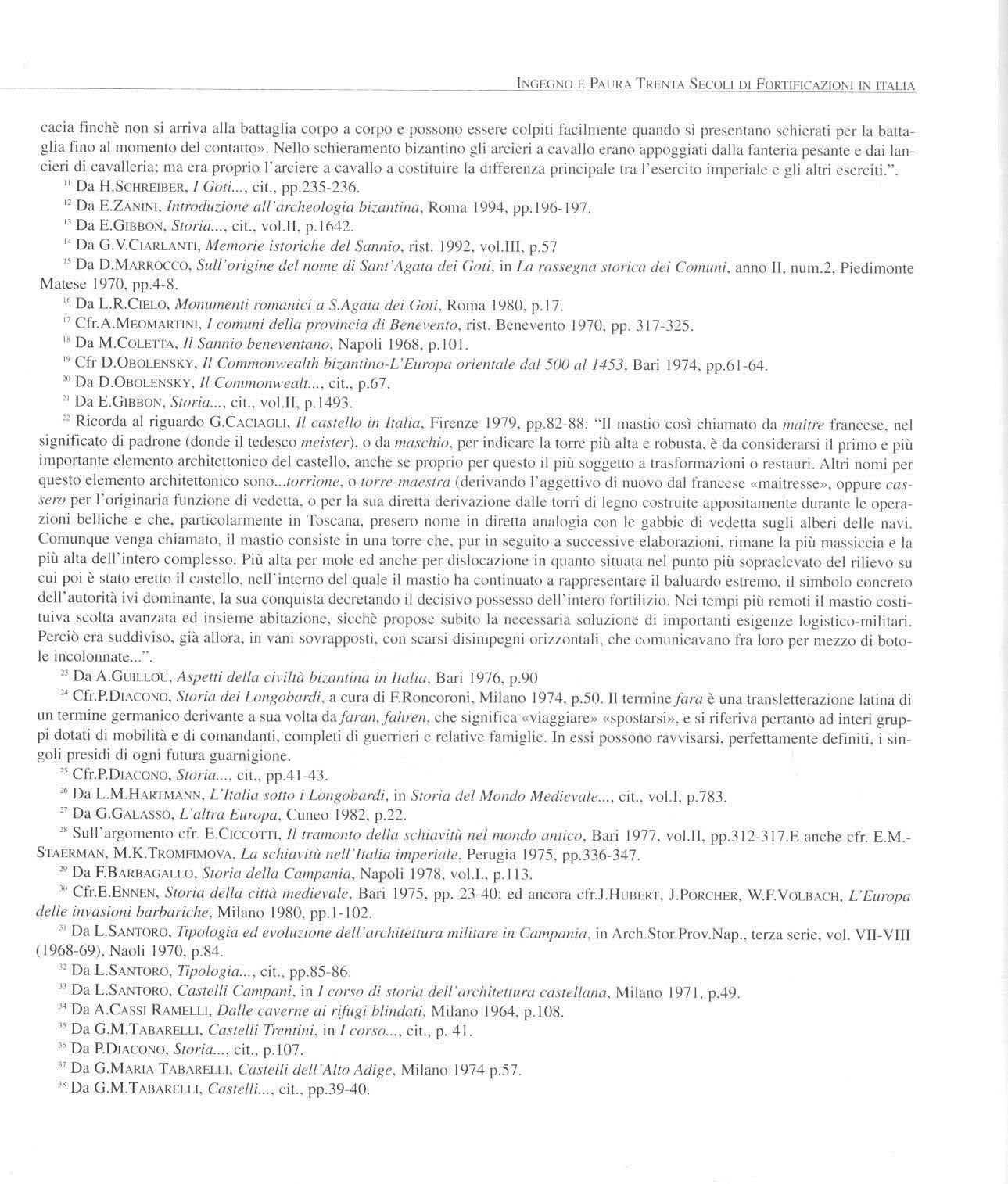
26 Da L.M.HARTMANN, L 'lraliu sotto i Longoba rdi, in S10ria del Mondo Medievale c ii., voi.I, p.783.
17 Da G.GALASSO, Ca/tra Europa, Cunei) I 982. p.22.
'" Sull'argomento cfr. E.CiccoTn, li tramonto della :,chiavitù nel mondo antico, Bari I 977. voi.li, pp.312 -3 17.E anche cfr. E.M.STAERMAN, M.K.TROMFTMOV/\, La schiavirù n ell'Italia imperiale. Perugia 1975. pp.336 -347 .
29 Da F.BARBAUALLO, Storia della Campania, Napoli 1978 , voi.I., p. I 13.
1° Cfr.E.ENNEN, Storia della c ittà medievale. Bari 1975, pp. 23 - 40; ed ancora cfr.J.HUBERT, J.PORCHER. W.F.YoLBACH, L 'Euro pa delle invasioni barbariche, Milano 1980, pp.1 - 102.
·'' Da L.SANTORO , 1ìpologia ed evoluzione dell ' architettura militare in Campania. in Arch.Stor.Prov.Nap., terza serie, voi. VII-VHI (J 968 -69), Nao li 1970, p.84.
12 Da L.SA NTORO. Tipologia , cit., pp 85 -86
n Da LSANTORO, Castelli Campani, in/ corso di storia dell'architettura castellana, Milano 1971 , p.49.
34 Da A.CASSI RAMELLJ, Dalle caverne ai rifugi blindar i, Milano 1964, p. l 08.
35 Da G.M.TABARELU, Castelli Trentini, in/ corso , cit ., p. 41.
36 Da P.DIACONO, Storia , cit., p.107.
37 Da G.MARlA TABARELLI , Custelli dell 'Alto Adige. Milano 1974 p.57.
3
• Da G.M.TABARELLJ, Cas,elli , cit.. pp.39 -40.
3 • Da G.M.TABARELLI, Castelli... , cit.. p.43.
40 Da M.DELL' ACQUA, Salerno il castello, Salerno 19[?], p.1.
41 Cfr.GENUINUS, Il castello a mare di Stabia, Napoli 1970. pp. 9- 12.
42 Da M.DELL.ACQUA, Salerno , cit., p.4.
43 Da HIRSCH, Il duca/o longobardo di Benevento, Torino 1890 , pp.23 -24. La citazione è tratta da M.COLETTA, Sannio , cit., p. 47, nota 38.
44 Da A.CASSI RAMELLI, Dalle caverne . .. , cit., p.88.
15 Da M.COLETTA, Il Sannio , cit., p.54.
46 Da LSANTORO, Tipologia ... , cit., p.94.
• 1 Da L.SANTORO, Vairano Patenora borgo fortificato della Campania: ipolesi di restauro. Roma 1979, pp.8 -9.
48 Da L.SANTORO, Vairano ... , cit., p.11.
49 Da L.SANTORO, Vai rano , cit., p.16.
so Da L.SANTORO, Vairano ... , cit., p.23.
51 Da L.SANTORO, Vairano , cit., p.23.
52 Cfr.A.MEOMARTINI , l comuni della provincia di Benev en10, rist. Benevento 1970, pp.75-87. Circa l'episodio della morte di Pandolfo, erede al trono così la cronaca coeva redatta da un monaco di S.Sofia di Benevento: "Pando(fusfìlius eius Occisus est a Mormannis ad montem sarchum VII die infrante mense februario ann. dom. 107J."
53 Da L.S ANTORO, La torre e il castello di Montesarchio, in Napoli Nobilissima, voi.V, fase.IV. luglio-agosto 1966. Napoli , pp.139 - 140-
54 Da L.S ANTORO, Le opere forrificate della Campania, in Le opere di fortificazione nel paesaggio e nel contesto urbano , Conv.Naz.Napoli 25-27 aprile 1969, n ediz. Napoli 1972, pp.19-20.
55 Da LSA NTORO, Il recupero di Casertavecrhia: analisi dei significali e indiriz.z,i di conservazione, in Tavola Rotonda 28.2.1987, Caserta, p.11.
56 Da M.COLETTA, Il Sannio , cit., p.50.
51 Cfr.G.VERGINEO, Storia di Benevento e dintorni. Benevento 1985, pp.190 e sgg.
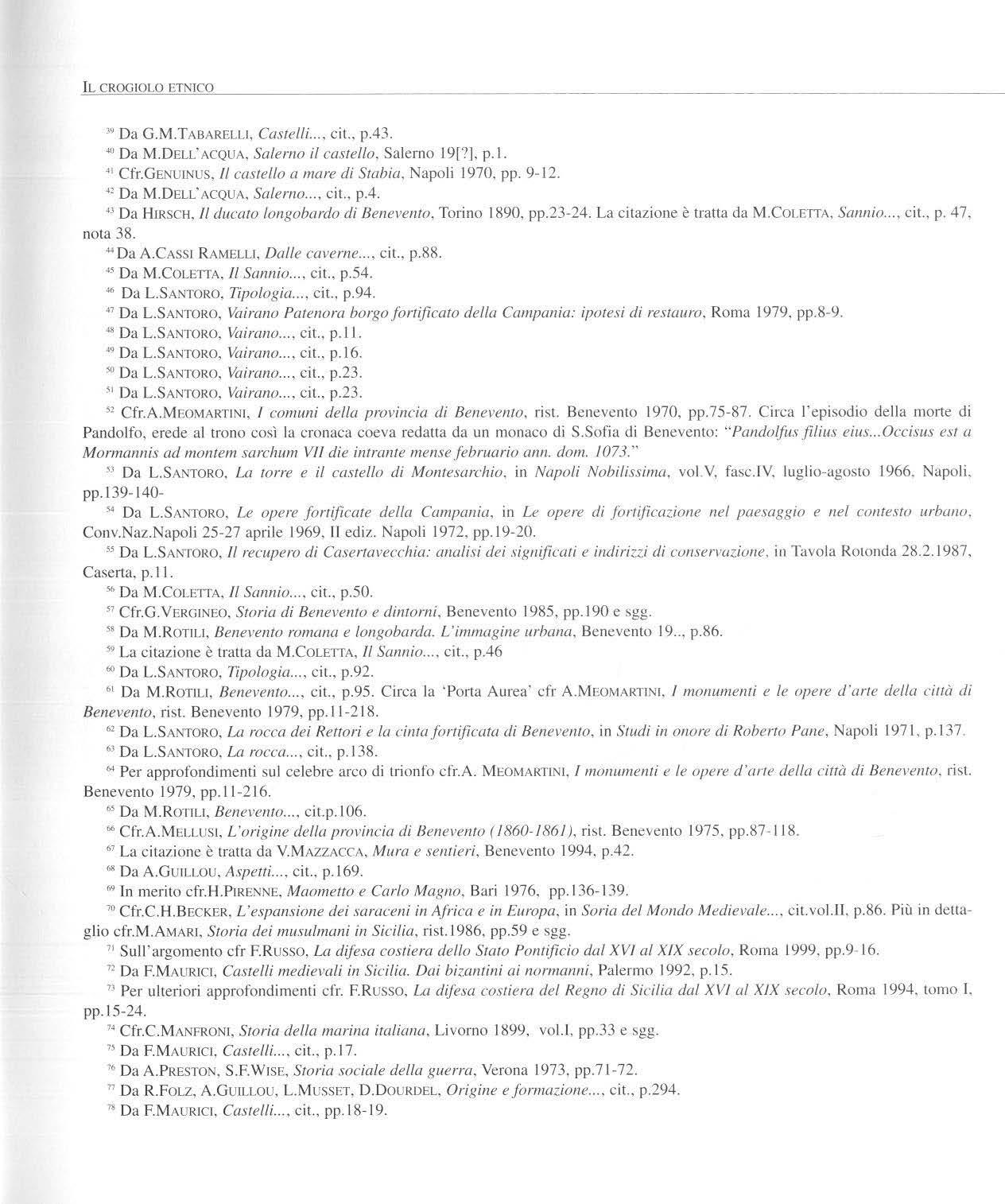
58 Da M.ROT!Ll, Benevento romana e longobarda. L'immagine urbana. Benevento 19 , p.86.
19 La citazione è tratta da M.Cou:TTA, Il Sannio ... , cit., p.46
00 Da L.SANTORO, Tipologia .... cit., p.92.
6 1 Da M.ROTlLl , Benevento ... , cit., p.95. Circa la 'Porta Aurea' cfr A.MEOMARTINI, / rnonumenti e le opere d'arte della cit tà di Ben.evento, rist. Benevento 1979, pp. 11-218.
62 Da L.SA NTORO . La rocca dei Rettori e la cinta fort(fìcata di B eneven10. in Studi in onore di Rob erto Pane, Napoli l 971 , p. 137 .
63 Da L.SA NTORO. La rocca cit., p. 138.
64 Per approfondimenti sul celebre arco di t1ionfo cfr.A . MEOMARTtNI, I monumenti e le opere d'arte della città di Benevento , rist. Benevento 1979, pp.l l -2 16.
M Da M.Rcrnu, Benevento , cit.p.106.
66 Cfr.A.MELLUSI, L'origine della provincia di Benevento ( 1860-/861 ), rist. Benevento 1975, pp.87 - 118.
67 La citazione è tratta da V.MAZZACCA , Mura e sentieri, Benevento 1994, p.42.
6 ~ Da A.GU ILLOU. Aspetti , cit., p.169.
119 In merito cfr.H.P JRENNE. Maometto e Carlo Magno , Bari 1976, pp.136-139.
7°Cfr.C.H.BECKER. L'espansione dei saraceni in Africa e in Europa, in Soria del Mondo Medievale , cit.vol.11 , p.86. Più in dettaglio cfr.M.AMARl, Storia dei musulmani in Sicilia, rist.1986, pp 59 e sgg.
71 Sull'argomento cfr F.Russo, La d(fesa costiera dello Stato Pontificio dal XVI al XIX secolo, Roma 1999, pp.9 - 16.
n Da F.MAURICT, Castelli medievali in Sicilia. Dai bizantini ai normanni, Palermo 1992, p.15.
73 Per ulteriori approfondiment i cfr. F.Russo. La difesa costiera del Regno di Sicilia dal XVI al XIX secolo, Roma I 994. tomo I , pp.15 -2 4.
74 Cfr.C.MANFRONI, Storia della marina italiana, Livorno 1899, vol.l, pp.33 e sgg.
75 Da F.MAURIC!, Castelli , cit.. p.17.
16 Da A.PRESTON, S.F.WrsE, Storia sociale della guerra, Verona 1973, pp.71 -72.
71 Da R .FOLZ, A.GUILLOU, L.MUSSET, D.DO UROEL , Origine e formazione , cit., p.294.
7 ij Da F.MA URJCI, Castelli... , cit.. pp. 18-19.
1<i Da F.MAUR 1c1, Castelli... , cit., p.287.
8/.J Da F.MAURICI, Castelli cit., p.373.
~ , Da F.MA URICI, Castelli , cii., p.282.
Rl Da F.MA UR1c1, Castelli cit.. p.41.
RJ Da F.MA UR1c1 , Castelli. cit.. p.4 l.
Il, Da F.MAURIC I, Castelli cit., p.48.
85 Da F.MAURICI, Castelli ... , cit., pp.84-89.
86 Da A.CADEI, Architellura federiciana. La questione delle componenti islamiche, in Nel segno di Federico Il, Atti del IV Conv.lnternaz. Fondaz. Napoli Novantanove, Napo Ii 1989 p.150.
ll1 Jn merito ai qanat cfr.F.Russo, Faicchio fortificazioni sannite e romane, Piedirnonte Matese 1999. pp.137-152. Ed anche M.A.Burrt.ER, lrrigation in Persia by Kanat s, in Ci vi i Engenering, 33, 2. I 933. Ed ancora H.E.WtJLFF, / qanat dell'Iran, in Paleontologia e Archeologia dal Paleolitico all'Amichitù Classica. Milano 1973, p.114.

88 Da E, TURRl, Fortifica zion i e nomadismo. in Castellum riv. lst.lt. dei Castelli, n° 24, 1984, pp.69-86.
89 Da F.PANSA, Istoria dell'antica Repubbli ca d'Ama(fi, Napoli 1724, p.8.
'IO Da V.VoN FALKENHAUSEK, Il ducato di Amalfi e gli Ama(fìtani fra Bi-;.antini e Normanni. in Istitu zioni civili e organizza:-,io11i ecclesiastica nello stato medievale amalfitano, Atti Conv. Intem.Studi Amalfitani 3 -5 luglio 1981, Amalfi 1986, pp.15-16.
91 La citazione è tratta da R.S.LOPEZ, J.W R AYMOND, Medieval Trade in rhe Mediterranean World, New York 1955, p.54.
92 Da D.CAMARDO, / castelli stabiani dal ducato indipendente alla dominazione angioina. Amalfi 1995, pp.47-49.
9 Da D.C AMARDO, / castelli , cit .. pp.57-58.
90 Da L.SANTORO. / castelli del ducato ama(fitano. in Studi in onore di Pietro Ga-::,zo la. Roma 1979 , vol.2, pp.4-6.
91 l n quella tragica circostanza, secondo la tradizione Ja parte più bassa di Amalfi finì sommersa. Al 1iguar<lo G.GARGANO, La città dal'Gnti al mare. Aree urbane e storie sommerse di A11,aljì nel Medioevo, Amalfi 1992, pp.177 e sgg .. precisa: ·'Nel tentativo di verificare la valid i tà dcli' antica tradi.lione popo lare. fu organizzata, nel corso <lei I 970, una campagna di ricerche archeologiche nello specchio d'acqua antistante la città ... fchel permisero la scoperta di una specie di 'arco', probabilmente in muratura, s ituato a circa 50 m. dalla riva, ad una profondità di quasi 6 m. , in direzione dell'antica foce del fiume A nove anni dalla prima esplorazione subacquea, furono organ izzate nuove ricerche archeologiche lungo la costa da Maiori a Positano [ej nell'area portuale di Amalfi, furono individuate due interessanti stru tture ... ". Ma tali rimlvamenti non confermavano alcun fenomeno cata~Lrofico od improvviso, ma semplicemente, la lenta sommersione del litorale che si sarebbe peraltro verificata prima del 1343, molto probabilmente tra il XII ed il Xlll secolo, tant 'è che se il celebre maremoto riuscì a distrnggere Je mura della città fu proprio perchè queste erano ormai lambite dal mare!"
116 Da L.SANTORO, Le fortificazioni di Scala nel contesto dell'arrhitettura difensiva del territorio amalfitano, in Scala nel Medioevo, Atti Conv.Stud. 27 -28 ottobre 1995 Scala, Amalfi 1996, pp.258-262.
Intorno all'VIII secolo, mentre nelle regioni rivierasche del Mediterraneo la sovranità dell'imperatore bizantino, significativamente definito 'dei Romani', costituiva la tangibile conferma della continuità dell'Impero, quasi più nulla ne sopravviveva nelle restanti aree continentali. In particolare, nelle immense pianure dell'Europa centrale, aleggiava soltanto la suggestiva memoria di quella grandiosa realtà, entrata ormai nel mito col suo retaggio di vestigia architettoniche imponenti quanto fatiscenti.

Dovunque, infatti, i ruderi delle città, dei loro acquedotti, delle loro fortificazioni testimoniavano gloriosi ed inimitabili splendori, dovunque gli eruditi rievocavano la civiltà romana, dovunque la Chiesa ne riproponeva la lingua e il cerimoniale.
Paradossalmente i più affascinati da tali reminiscenze apparivano proprio i massimi artefici di tanta devastazione, ovvero gli innumerevoli capipredoni che erano riusciti violentemente ad accaparrarsi qualche brandello del lacerato impero, spesso definendolo enfaticamente 'regno'. La facilità dell'impresa li aveva indotti ad interpretare delle semplici scorrerie come vere e proprie conquiste; la totale ignoranza della complessità organizzativa ed istituzionale dell'estinto impero li aveva portati a sentirsene in qualche modo 'eredi', essendo l'elemento territoriale l'unica connotazione per loro comprensibile. Per molti aspetti ricordavano i tanti miserabili precariamente insediatisi negli anfratti delle rovine dei grandi edifici romani. Anche quelli, infatti, si erano battuti con i vicini per l'appropriazione della maggiore porzione possibile di macerie, tentando, una volta assicuratasela, di ripristinarne l'antico splendore, ispirandosi unicamente ai frammenti ancora visibili. Difettandogli, però, oltre la
capacità culturale, la potenzialità economica e tecnica i risultati si confermavano sempre grotteschi.
In realtà la stragrande maggioranza dei capi barbari non giunse mai ad equiparare, persino quando si definirono pomposamente re, il ruolo e l'importanza neppure dell'ultimo proconsole romano, propriamente detto. La loro autorità, infatti, non disponeva, ad eccezione del territorio, di nulla che lontanamente somigliasse all'organizzazione che supportò quella carica. Non un esercito regolare, non un diritto codificato, non un apparato amministrativo, non una rete logistica: soltanto una primi ti va corte , il cui effettivo potere non eccedeva l'orizzonte. A dimostrarlo basterebbe la necessità del continuo errare di tali assemblee , da un punto all'altro di quegli evanescenti aggregati , cercando di sopperire direttamente alle peggiori carenze di sicurezza e di giustizia e ammantando spesso i propri membri di tronfie designazioni gerarchiche prive, però, di qualsiasi analogia con le omonime imperiali. Ed è senza dubbio in quello scimmiottare un mondo, di cui subivano il fascino , l'inequivocabile conferma della incessante aspirazione dei Germani alla sua ricostituzione. Il che determinò, sistematicamente, il progressivo rigetto del rozzo diritto consuetudinario in favore delle leggi di Roma ed il ripristino, o addirittura il mantenimento, di tante sue istituzioni.
In pratica, come già accennato, nonostante la fin troppo rapida confusione delle due società, i vincitori avevano compreso immediatamente i vantaggi della superiore civiltà romana al punto che: " ... nella fretta di goderne, ne hanno preso i vizi e i Romani, non più tenuti a freno dalla mano dello Stato, hanno imparato la brutalità dei barbari. È uno scatenarsi generale delle passioni più grossolane e degli appetiti più bassi, con le perfidie e le crudeltà che necessariamente ne conseguono.
Ma per quanto decadente, per quanto barbarizzata, l'amministrazione resta tuttavia romana. Solo a nord troveremo ufficiali regi dai nomi germanici ... Le finanze, anche quelle, restano romane. Il patrimonio privato dei re è nettamente separato dall'erario. Il sistema monetario e fiscale è sempre alla base della potenza regia. Ovunque viene mantenuto in uso il soldo d'oro. Anzi si continua a battere moneta d'oro " 1 11 • Va tuttavia osservato che se ciò accadde , non fu solo per una passiva imitazione dei modelli precedenti, che indubbiamente esercitavano le loro suggestioni, quanto piuttosto per I' inesistenza di soluzioni altrettanto valide. Del resto, ancora oggi, la maggioranza di quelle istituzioni permangono sostanzialmente immutate: magari adottiamo un supporto monetario elettronico , ma si tratta, in ultima analisi, di un più pratico trasporto dell'oro di cui siamo detentori. Analogo discorso va fatto in materia di diritto, di tributi e di difesa, sistemi in cui, al di là degli ovvi aggiornamenti, ben poco è mutato rispetto all'impostazione romana confermatasi finora la più efficace e razionale possibile. Logico, pertanto, che: " tutti i regni barbari che si spartiscono l'Impero d'Occidente presentano una serie di tratti comuni che fanno di loro non Stati barbari, ma regni romani barbarizzati. Tutti hanno abbandonato la propria lingua nazionale e i propri culti pagani. Una volta diventati cristiani, sono per ciò stesso diventati sudditi fedeli della Chiesa , che trasuda civiltà romana. Ma, come l'impero, questi regni sono sostanzialmente laici ... Questi regni sono romani non soltanto perchè la civiltà romana ha dato loro strutture nelle quali e grazie alle quali banno potuto formarsi, ma anche perchè vogliono essere romani ... " 12 i Ed infatti , malgrado la loro: " origine teutonica, i primi re merovingi erano disposti a considerarsi generali o magistrati romani. Usavano le insegne e le monete romane e, con vero spirito imperiale, rifiutavano di riconoscere frontiere ai loro domini ... " <1 >
Disgraziatamente le connotazioni statuali derivate

dall'ispirarsi, e dall ' aspirare, ad un modello tanto complesso, senza disporre dei mezzi congrui per rigenerarlo , determinarono , nell'inevitabile confusione con seguente, l'alienazione dei precipui e basilari criteri di stabilità di successione. Si avvicendarono, perciò, dinastie sempre più effimere , minate dall'anarchia interna e dalle dispute fratricide, causa ed effetto del1' assenza di un potere centrale solido e chiaramente distinto da quello puramente personale del sovrano di turno. Persino i re merovingi, senza dubbio i più ambiziosi al riguardo: " non avevano la più pali ida idea di quella che fosse la responsabilità politica o la tradizione storica e applicavano alla monarchia franca i princìpi che nella società teutonica governavano la proprietà privata. L' eredità era divisa tra i figli , e poichè i figli invariabilmente litigavano , il paese fu per cinque generazioni tormentato da inutili guerre civili ... " H•.
Nono s tante ciò , fu proprio la dinastia dei Meronvingi quella che si protrasse più a lungo, riuscendo ad ampliare a dismisura il suo regno, fra il V e l ' VIII secolo. Rappresentò, perciò, se non la prima in assoluto, di certo l'unica che si cimentò, non del tutto utopisticamente, nella ricostituzione dell'Impero. Le già ricordate offensive franche, abbattutesi sul ducato longobardo trentino , ne costituirono, per molti aspetti, i prodromi estrinsecativi espliciti , reputandosi , infatti, indispensabile, per l'ambizioso obiettivo , in virtù della sua valenza politica la conquista di Roma. Ma quelle premesse non ebbero ulteriore seguito, esaurendosi rapidamente l'offensiva lungo la direttrice mediteITanea.
E mentre i Longobardi si radicavano nell'Italia meridionale, i re merovingi, e s autorati dalla nobiltà e dai suoi massimi rappresentanti, i cosiddetti 'maggiordomi', iniziarono a brillare per impotenza, scadendo la loro autorità a vuoto formalismo. La sopraggiunta, ed imprevedibile , espansione islamica compromise irrimediabilmente il disegno di un ' avanzata verso sud, obbligando Dagoberto, ultimo rappresentante della dinastia , ad una netta diversione. Da quel momento, pertanto , le sue iniziative militari si spostarono ad est, verso la Germania ed il Danubio, dove ottennero
alquanti successi. Disgraziatamente essi non bastarono a conservare quella rudimentale monarchia e, del resto, non bastarono neppure a cancellare l'idea di uno Stato indiviso di grande estensione.
Per la storia, quel mesto tramonto fu provocato dalla comparsa di Pipino II di Héristal ( +714), nipote per parte materna di Pipino di Landen (+639) e per parte paterna di Ansegiso di Metz (+685), già maggiordomo dell' Austrasia nel 681 e padrone della Neustria nel 687. Da lui trarranno origine i Carolingi ed il loro Impero: dinastia nuova e miraggio vecchio! Per il resto del mitico capostipite sappiamo soltanto che si battè valorosamente contro i Frisoni, le cui incursioni martirizzavano il Nord del paese, che ebbe un figlio illegittimo , di eccezionali capacità militari, Carlo Martello (+741), e che lo incoraggiè) ad incrementare la guerra contro quei barbari pagani.
Quanto al giovane Carlo, grazie alle innumerevoli vittorie conseguite, ben presto si guadagnò un ruolo di netta preminenza nell ' ambito della dirigenza del regno, assimilabile, secondo diversi studiosi, ad una reggenza. A distanza di pochi anni la sua rinomata esperienza militare si dimostrò provvidenziale, permettendogli di selezionare un contingente di guerrieri temprati , mobilissimi e disciplinati , perfettamente idonei ad impieghi antincursivi, proprio al momento opportuno. I Musulmani di Spagna, infatti, dopo un decennio cli piccole razzie a ridosso del versante francese dei Pirenei , cominiciavano ad ampliare il loro raggio d'azione spingendosi, con crescente violenza, verso la Francia centrale, inequivocabile premessa di una loro imminente ulteriore espansione.
Se è fuor di dubbio che l'irruzione dei Musulmani sul teatro europeo stroncò sul nascere i tentat1v1 merovingi di aggregazione imperiale, peraltro embrionali ed approssimati, è altrettanto assodato che, proprio la crescente minaccia, da essi rappresentata, svolse un ruolo coagulante intorno alla dinastia carolingia. Era ormai perfettamente risaputo che le conquiste islamiche si differenziavano nettamente
da quelle di matrice occidentale per la serie di irreversibili sovvertimenti che comportavano ed, in particolare , per la non integrabilità dei vincitori. Infatti per gli assoggettati che fossero sc ampati agli abituali massacri e brutalità che la guerra dell 'e poca implicava, le possibili opzioni contemplate, nella migliore delle ipotesi, si riducevano a due: o rinunciare alla propria fede o rinunciare alla libertà. Di fronte a siffatta prospettiva, ovviamente, le contese intestine decaddero e, quando nel 732 una grossa formazione musulmana , valicati i Pirenei e sbaragliati gli scarni contingenti cristiani che avevano tentato di resisterle, fra la Garonna e la Dorgona, puntò verso Tour s, le forze occidentali si coalizzarono e si aggregarono agli ordini di Carlo. La reazione vio lentissima si manifestò poco dopo sui campi di Poitiers '5 \ dove, in una domenica di ottobre, la leggendaria ed inarrestabile cavalleria leggera dell 'em iro Abel al-Rahman, si imbattè nei corazzati guerrieri cristiani in assetto da battaglia e ben decisi a non indietreggiare di un palmo.
Dispostisi in formazione quadrata, i fanti ge rmanici attesero l'impatto dei nemici, trafiggendoli e disarcionandoli. Secondo le risicatissime cronache coeve, l'epico scontro si protrasse per alcuni giorni, in un susseguirsi di ondate di cavalleria, sistematicamente schiantatesi su quella muraglia d'acciaio , finchè, costretti i Musulmani ai ferri corti, la superiorità tattica occidentale potè imporsi pienamente. I fanti, infatti, a quel punto, abbandonato l 'ordine chiuso si gettarono sugli appiedati attaccanti sbranandoli con le grandi spade e le pesanti asce, perfezionando così la procedura già impiegata, con successo, contro i Mori a Toulouse nel 721. Alla fine i:" ... teutoni ... vinsero questa battaglia non soltanto grazie alla loro indole, ma anche per la loro superiorità fisica che si affermava sempre nei combattimenti corpo a corpo. Quando, dopo l'ultimo giorno di lotta, in cui i musulmani avevano perso il loro capo , i teutoni cercarono di riprendere il combattimento si avvidero che gli arabi erano fuggiti, abbandonando l'intero campo, con tutto il materiale bellico ... " 16 )

L'esito della battaglia fu epocale sotto il profilo morale e sotto quello strategico. I Musulmani, reputati sino a quel momento praticamente inarrestabili, erano stati, invece, massacrati ed i pochi malconci superstiti costretti ad un precip itoso sganciamento. La loro iniziativa infranta sangu in osamente, la loro tatt ica di combatti mento annientata, l'orgogliosa destrezza dei cavalieri trasformata in estrema risorsa per la fuga dei fortunati. Carlo, proprio per la dimensione schiacciante della vitto r ia, ricevette l'appellativo di 'Martello'. Restava, pur sempre sotto il dominio islamico la cittadina di Narbonne, ma pure da lì, nel 759, i Musulmani sarebbero stati sloggiati dall'esercito di Pipino il Breve. Per l'Occidente continentale fu l 'inizio della rinascita. Disgraziatamente qvello straordinario successo ebbe anche una seconda, e negativa, conseguenza.
Carlo Martello, divenuto l'indiscusso signore del regno, trasse le debite conclusioni istituz ionali dalla nitida constatazione dell'immenso potere che derivava dal disporre di una forza armata regolare, addestrata e fedele.
Fino ad allora, qualsiasi sovrano aveva potuto disporre soltanto di truppe raccogliticce ed eterogenee, composte da uomini liberi arruolati nelle contee in occasione, o al profilarsi, di una campagna. Per la modestia degli scontri e del sistema di reclutamento, ne risu ltava, in pratica, una formazione di fanteria approssimativamente armata, essendo l'equipaggiamento a spese dei combattenti, e per nulla addestrata essendo la prestazione limitata alla sola buona stagione e ad un preciso obiettivo. Senza co ntare che, per le medesime ragioni, la manovra di radunata si confermava inevitabilmente complicata e di esasperante lentezza e pertanto inidonea a fornire qualsiasi certezza preventiva sull'ammontare degli uomini e sulla loro concreta operatività. Uno strumento militare del genere, quindi, riusciva utile, nella migliore delle ip otesi, per ridurre alla ragione un vassallo ribe ll e. M a anche in
tale contesto quelle sgangherate formazioni, non incutevano eccessivo terrore ai riottosi e, meno che mai, li dissuadevano dallo sperimentarne l'offesa, per c ui più che limitare l'insubordinazione sembravano l'ideale per in crementarla(7) .
Il trionfo di Poiters, come accennato, convinse Carlo Martello ad istituire una forza armata permanente e regolare. Emblematicamente la s trutturò fondendo insieme la saldezza della fanteria pesante franca e la manovrabilità della cavalleria leggera musulmana. Ne scaturì, perciò, un esercito di cavalieri catafratti, mobili ss imo e micidiale, capace di raggiungere in breve tempo ogni punto del regno e di schiacciarvi ogni resistenza In: " ... verità i Franchi già impiegavano la cavalleria pesante in modo diverso. Invece di armarsi d'arco, i Cavalieri della Cristianità latina, preferivano il combattimento ravvicinato con lancia, mazza e spada, distaccandosi dalle tattiche orientali, quasi omericamente disdegnando l'uso di arco e frecce. La tecnica differiva però dall'evidente irrazionalità dell'uso del carro in tempi omerici nel senso di una netta superiorità tattica, giacchè la carica di cavalleria medievale, lanciata al gran galoppo concentrava tutto l'impeto su lla punta delle lance. E soltanto una formazione identicamente equipagg iata poteva sperare di rintuzzare tale concentrazione di forze ... " < 3 > _ L'utilizzo ottimale della suddetta modalità di combattimento fu però possibile soltanto dopo il genera li zzarsi dell'uso della staffa, introdotta in Europa dalle invasioni mongole del V-VI seco l oC9> , ma diffusasi solo a ridosso del Mill e Senza quel se mpli ce dispositivo, mai un cavaliere avrebbe potuto rimanere in sella dopo l'urto della s ua lancia!
Al di là della pura fattibilità, una manovra di unità del genere implicava un costante addestramento dei suoi membri ed un omogeneo armamento, dai cavalli alle corazze alle lance, tutti costos iss imi . In particolare, in: " ... uno sco n tro tra forze montate così come più tardi fra carri armll-ti oppure in una battaglia naval e la superiorità si otteneva combinando ins iem e gittata, protezione e velocità. La gi ttata dipendeva dalle lan ce più lunghe e quindi più pesanti. La protezione e ra assi-
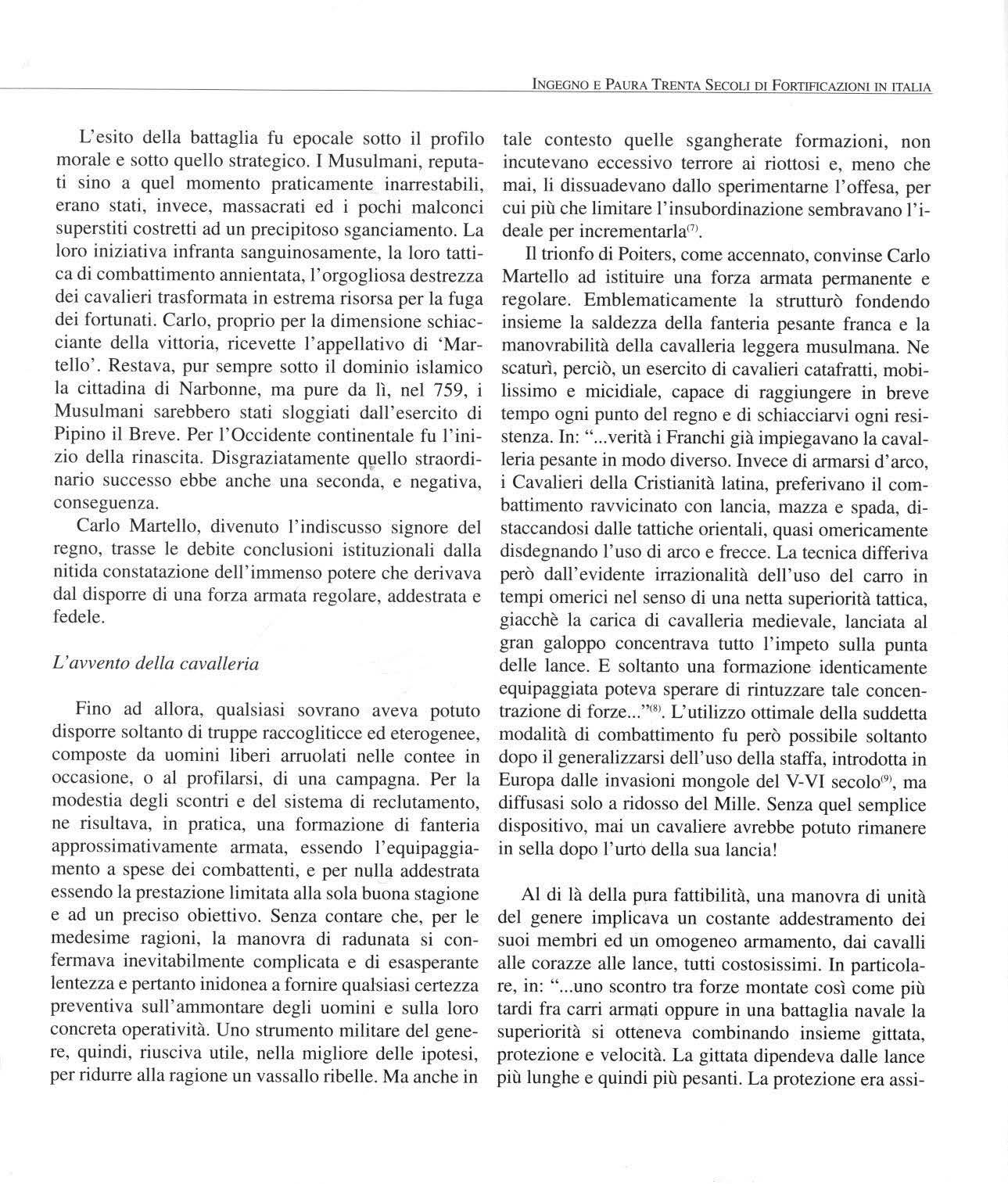 INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLJ DI FORTIFICAZIONI IN ITALIA
INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLJ DI FORTIFICAZIONI IN ITALIA
curata dalle armature, rappresentate in un primo tempo da cotte di maglia, lunghe dal collo alle ginocchia: un articolo di equipaggiamento molto costoso e, dopo il cavallo, l'oggetto di maggior valore che il cavaliere possedeva .. . " <10l Per farsi una vaga idea di quale fosse lo sforzo economico richiesto per una simile dotazione basti pensare che ancora due secoli dopo: " ... l'allevamento ... dei cavalli, è poco svil upp ato. In Francia, nell'XI seco lo, un cavallo costa 100 sous; un contadino servo vale 38 sous. Una corazza ha un prezzo pari al reddito annuale di un terreno di media grande zza... " <1 1l
Occorreva, inoltre, risolvere il problema del mantenimento di quegli uomini che, proprio perchè imp egnati a tempo pieno, non potevano più espletare alcuna attività remunerativa. Ovvio quindi che l'aspetto finan ziario complessivo apparisse, se non l'unica, la principale difficoltà del progetto. Soppesata la questione, rifacendosi alla tradi zio ne germanica, Carlo Martello istituì una apposita classe di guerrieri, scelti fra i s udditi più prestanti. Ad essi ve nn e affidata una propri e tà terriera, in genere ricavata dai possedimenti della Chiesa, il cui reddito avrebbe dovuto consen tire a ciascun membro di provvedere all'armamento e alla sussistenza. Non si trattava ancora di un fe udo nella pienezza del termine, ma di un beneficio personale, in cambio del quale il designato accettava l'obbligo della prestazione , o servizio , militare ogni qualvolta il sovrano lo avesse ri c hie sto, con la dotazione e l 'equ ip agg iamento d'ordinanza. A rendere ulteriormente vincolante l'accordo fu imposto il giuramento di fedeltà. In pratica nella : " ... prima età feudale, col termine «cavaliere» s' indicava, anzitutto, talora una condizione di fatto, talaltra un vincolo giuridico, ma puramente personale. Ci s i diceva «cava]jere» perchè s i combatteva a cava l10... "<•2> .
Le conseguenze, come era avvenuto già 1800 anni prima con l 'avve nto del carro da guerra, furono ril evanti e, paradossalme nte, no n tanto s ul campo di battaglia quanto nella socie tà. Infatti: " .. .ogni volta c h e una forza s uperiore finisce nelle mani di un gruppo di individui complessamente equipagg iati e addestrati,
diventa difficile per il potere centrale impedire a queste persone l'intercettazione della maggior parte delle eccedenze agricole per il consumo sul posto. La conseguenza di tale situazione è il 'feudalesimo' " <13 l Quanto all'ambito militare, e sempre per i cospicui oneri che tale istituzione comportava, anche lo sfruttame nto del successo subì vistose modifiche poichè: " ... all'ucc isione del nemico subentra la cattura. Ora interessano il prezioso cava ll o, le armi, gli ornamenti dell'avversario, e poi anche il denaro per il riscatto del prigioniero. La massa armata non nobile , gli avversari di stirpe e di fede diversa e di origine diversa, vengono abbattuti o impiccati come i contadini del proprio paese... " <14l

Il che, implicitamente, significò un diverso valore della vita a seconda della classe di appartenenza, disparità peraltro già esistente nella normativa legale vigente all'interno della società, e che trovava la sua ragion d'essere originaria nella dissimile esposizione ai rischi bellic i e nei relativi obblighi comportamentali , supposti ineludibili. Infatti, la preminenza accordata ai guerrieri era in una certa misura, una sorta di compenso per il potenziale estremo sacrificio che implicava la loro attività a difesa della comunità. Da quel momento, invece, i privilegi di classe si confermarono anche sul campo di battaglia, dove chi rischiava maggiormente la vita era appunto il non •professionista! Progressivamente l'intero Occidente adottò tale differenziazione sociale, anche se in tempi diversi: in Francia può ritenersi esaurita già intorno al 1100, allorquando il feudalesimo divenne ereditario.
Ad una più accorta analisi risulta inne gabile che l'espan sio ne is lami ca in Europa non fu arrestata dalla vittoria di Poitiers, o alm e no non soltanto, ma piuttosto dal ven ir meno della concordia fra Arabi e Berberi. Pur avendo scatenato la violenta scorreria del 732, i Musulmani di Spagna, in realtà, non disponevano delle forze suffic ienti per co nqui stare, e mantenere, altri territori senza l'ulteriore apporto dei Berberi, per cui:
" il saccheggio delle città della Gallia meridionale non si sarebbe certo tramutato in un ' occupazione permanente della Gallia ad opera dei saraceni ... " ('5l
Pochi anni dopo , infatti, il Nordafrica si affrancò dalla dominazione araba, dando vita ad una miriade di potentati, la cui capacità offensiva si dimostrò soprattutto di tipo incursivo navale. Da quel momento, mentre l'aggressione terrestre dei Mori spagnoli fu definitivamente stroncata in Francia, quella marittima dei Berberi nordafricani, prendeva l'avvio ed avrebbe portato in breve volgere alla conquista del]' intera Sicilia(16' Per ironia della sorte sarà proprio un pugno di avventurieri della Francia del Nord a restituire l'isola alla cristianità, alcuni secoli più tardi!
L'assurda condominianza di sovranità, instaurata da Carlo Martello, si accentuò con suo figlio Pipino il Breve (+768). Ufficialmente a regnare sui Franchi provvedeva un legittimo ma impotente sovrano, ufficiosamente però governava un potente ma illegittimo reggente. Che la situazione fosse, a quel punto, paradossale lo conferma la missione diplomatica inviata a Roma, nel 751, dallo stesso Pipino per ricevere, al riguardo, il consiglio da papa Zaccaria. In pratica si trattava di stabilire: " ... se fosse giusto o no che un uomo portasse il titolo di re mentre a regnare di fatto era un altro ... " n 11 • La questione, in realtà, era probabilmente molto più capziosa e tendenziosa di quanto possa sembrare, poichè anche il papa governava di fatto uno stato di cui non era il legittimo sovrano. Ovvio, quindi, che entrambi mirassero a ricevere da quel chiarimento un reciproco riconoscimento , una sorta di 'tienimi che ti tengo ' !
Purtroppo non si conosce con certezza la risposta del pontefice: per contro è talmente noto ciò che accadde da lasciarcene ipotizzare la sostanza. Il sovrano Merovingio e suo figlio, vennero scacciati e costretti a ritirarsi in un monastero, mentre Pipino fu solennemente incoronato nel mese di novembre del 751. Il che non significò affatto la restituzione alla Chiesa della piena proprietà sulle teITe le cui rendite erano state destinate dal padre al mantenimento della cavalleria, ma soltanto l'avvento di una nuova dinastia.
Pipino morì nel 768: secondo la prassi vigente l'intero regno avrebbe dovuto spartirsi fra i suoi due figli, ma la prematura morte del minore, Carlo Manno , nel 771 evitò quel nefasto smembramento. Entrambe le porzioni finirono perciò concentrate nelle mani del primogenito Carlo, poi detto Magno, allora ventiseienne restandoci per i successivi 43 anni. Di spirito avventuroso e semplice Carlo si sentiva pienamente responsabile della difesa della Chiesa e della religione cattolica, per cui, quando si verificò una ennesima penetrazione longobarda nel territorio pontificio, rispose prontamente alla richiesta papale di aiuto, scendendo in Italia nel 773. Sconfisse Desiderio e ne acquisì il trono nel 774 , divenendo così, oltre che re dei Franchi, anche sovrano dei Longobardi. Seguirono decenni di campagne militari, cui la storiografia successiva ha attribuito una antesignana motivazione crociata, sebbene, ad un meno apologetico esame, esse risultino orientate al ben più prosaico e terreno obbiettivo del consolidamento dinastico. Infatti la: " ... spinta all'espansione del potere carolingio non fu certo la religione, bensì un ideale secolare: la lotta per il potere che sempre ha dominato uomini e nazioni. L'ideale cristiano rimase perciò subordinato e spesso nobilitò o mascherò tale brama di potere. Solo più tardi ebbe un ruolo essenziale nella fondazione dell ' impero che portò a compimento il processo di affermazione di un'autorità universale in occidente " (18)
11 perchè di tale tardiva ortodossia è abbastanza semplice da spiegare: reputando che la sua sovranità provenisse direttamente da Dio , l'essere infedele significava automaticamente non riconoscerla, esentando perciò dal vincolo di obbedienza e fedeltà. A questo punto per gli assoggettati non cristiani restavano due sole alternati ve, ancora più spietate della consuetudine islamica: o accettare la conversione con il battesimo, senza però alcun tentennamento futuro in materia di credo e di pratica, o l'eliminazione fisica. Tra i primi a sper1mentare siffatto integralismo furono i Sassoni a nord, subendo spaventosi massacri. Seguirono gli Avari ad est, che si erano insediati nella valle del Danubio: la loro fiera resistenza valse solo a provoca-
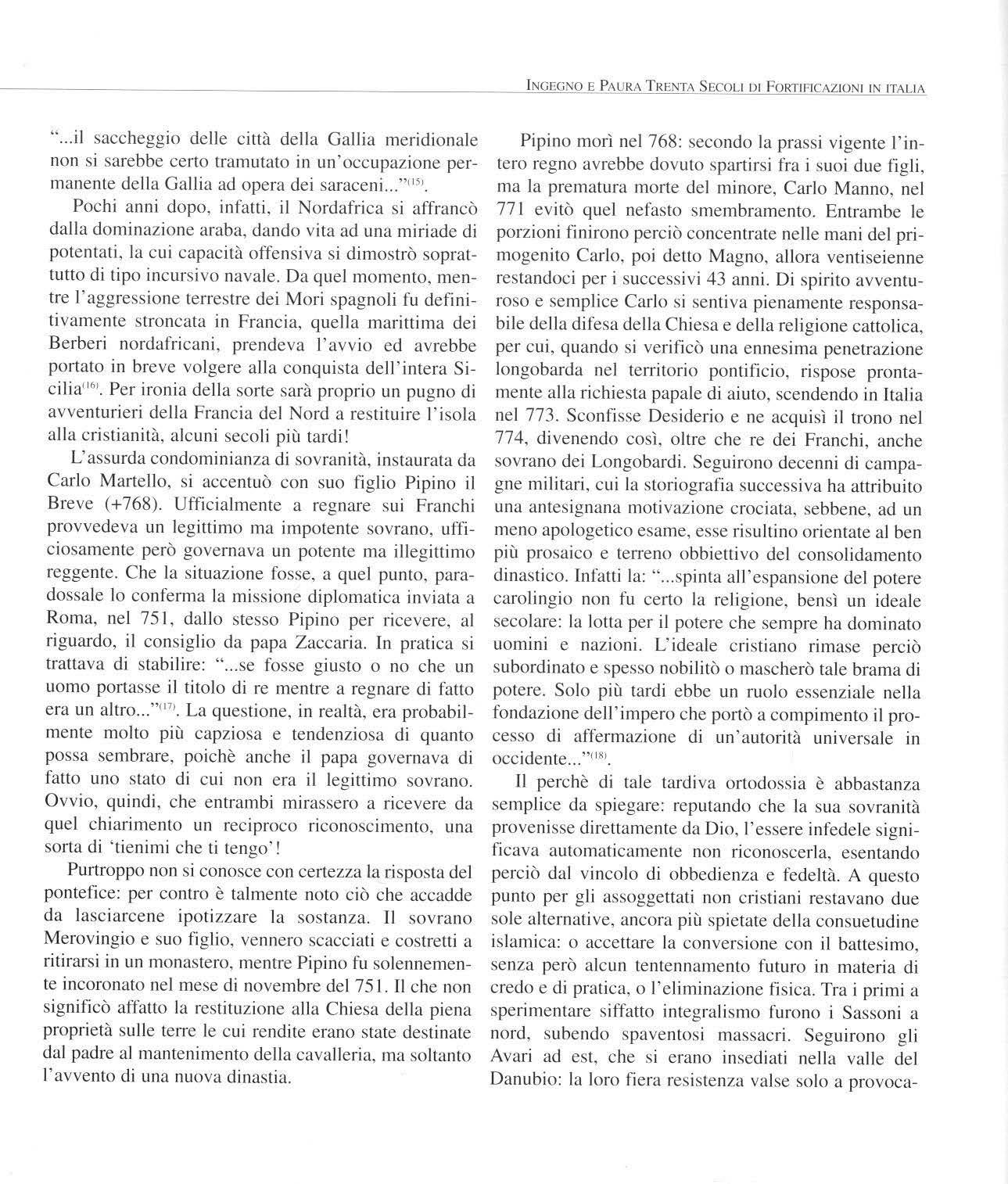
re il radicale sterminio dell'etnia, che scomparve così dalla storia. Per rendere la situazione irreversibile Carlo istituì nella regione una marca, ovvero, un ben definito territorio, posto a guardia della stessa, sogge tto ad una amministrazione militare: era in sostanza una riproposizione dell'antica concezione romana delle colonie, appena aggiornata dall'adozione della cavalleria. Nella fattispecie fu la premessa istitutiva dell'Austria , coincidente appunto con la marca orientalis: negli anni seguenti altre analoghe 1'affiancarono.

Anche contro gli Slavi Carlo Magno condusse una gueITa spietata, durante la quale i prigionieri, sistematicamente venduti come bestie, furono talmente numerosi che dall 'e timo di slavo derivò quello di schiavo. Dal canto loro: " ... gli slavi cominciarono a considerare il Cristo come un teutonicus deus e il cristianesimo come una religione estranea impo sta loro sulla punt a della spada. Per i tede sc hi le spe dizioni di saccheggio contro gli slavi assunsero il carattere di crociate: ai vantaggi materiali poteva combinarsi la salvezza delle loro anime, poichè le gesta perpetrate contro un nemico pagano sa rebbero state ben accette agli occhi di Dio. Nel corso di due o tre seco li, i tede schi, aiutati dai missionari della Chiesa , riuscirono ad imporre la loro religione agli slavi ... " u9 > _
Ovviamente gli infedeli per antonomasia stavano ad occidente, al di là dei Pirenei, ed anche in quella direzione l'offensiva di Carlo Magno si estrinsecò con l 'ormai sperimentata efficienza. Ma , proprio quella campagna dimostrò quanto lontana fosse la motivazione religiosa dai campi di battaglia. li pretesto scatenante, ammesso pure che ce ne fosse bisogno , fu la richie sta di aiuto fatta pervenire a Carlo Magno, nel 777, dal governatore di Barcellona e di Gerov , lbn-Arabi incapace di ridurre all'obbedienza il califfo di Cordova. Nella primavera seguente un grande esercito franco, strutturato s u due distinte di visioni , valicata la formidabile catena, penetrò nella Spagna s imultaneamente da est e da ovest. Contrariamente a quanto era logico aspettarsi, la prima città ad essere investita con la massima violenza cd espugnata d ' impeto fu la cristianissima Pamplona. Del resto anche gli altrettanto cristiani
montanari baschi, durante il supera mento dei Piren ei, era no stati considerati, e trattati, alla stregua dei più iITiducibili pagani s ubendo le abituali strag i.
Con altri assedi e con altre conquiste l'avanzata proseguì fino a Saragozza s ull 'E bro, che riuscì però a re sis tere , dimostrando, se non altro, l'inutilità e il velleitari s mo dell ' intera operazione. L'armata di Carlo Magno , in quella stessa estate, abbandonò le inviolate mura della città s pagnola per rientare in patria. Agli inizi di agosto le anguste valli dei Pirenei furono nuovame nte attraversate, senza eccessive difficoltà. Il giorno 15, mentre anche le sa lmerie lentamente s uperavano la gola di Ronci svall e, un manipolo di Basch i , decisi a vendicare le recentissime violenze, piombò loro addosso all'improvviso. Nella scara muccia intervenne il comandante della retro g uardia , Orlando , prefetto della marca brit annica, restandovi ucciso. L a morte non ebbe alcuna ri sonanza al di fuori dei suoi con terranei n el paese di Coutances: biso g na attendere il furore retorico della prima crociata affinchè quelI ' insi g nificante episodio trovi un'epica riproposizione assurgendo ad eroico sacrificio ne ll 'a mbito della imman e lotta condotta da Carlo Ma g no contro l'Islam.
Nei decenni s ucc ess ivi tuttavia si ebbero altre ini zia tive di Carlo a sud dei Pirenei che si conclusero nel 795 con l ' istitu zio ne di una ennesima marca , quella di Spagna, estendentesi dalle montagne all'Ebro. Di lì a breve anche le iso le Baleari gli si sottomisero spo ntaneamente.
Allo sca dere del l' V I li secolo, la ricostitu z ione dell'Impero romano ad opera di Carlo Magno, almeno p e r i più ottimisti, non è ormai un irraggiungibile miraggio ma un'imminente realtà In effetti: "allargata dalla conquista a est, fino all'Elba e al Danubio , a sud fino a Benevento e all ' Ebro , la monarchia franca ingloba pressappoco tutto l'Occidente cristiano Non ci si può quindi stupire, in que ste condizioni, che alle
deliberazioni del papato si sia presentata spo ntaneamente l'idea di approfittare di un momento così favorevole per ricostituire l ' Impero romano, ma un Impero il cui capo, incoronato dal Papa in nome di Dio, dovrà il proprio potere solo a ll a Chiesa e vivrà so l o per aiutarla nella sua missione; un Impero che, non avendo origine laica, non dovendo niente agli uomini, non formerà uno Stato nel vero senso del termine, ma si confonderà con la comunità dei fedeli di cui sarà l'organizzazione temporale, diretta e ispirata dall'autorità spiri tu ale del successore di san Pietro ... " '20'
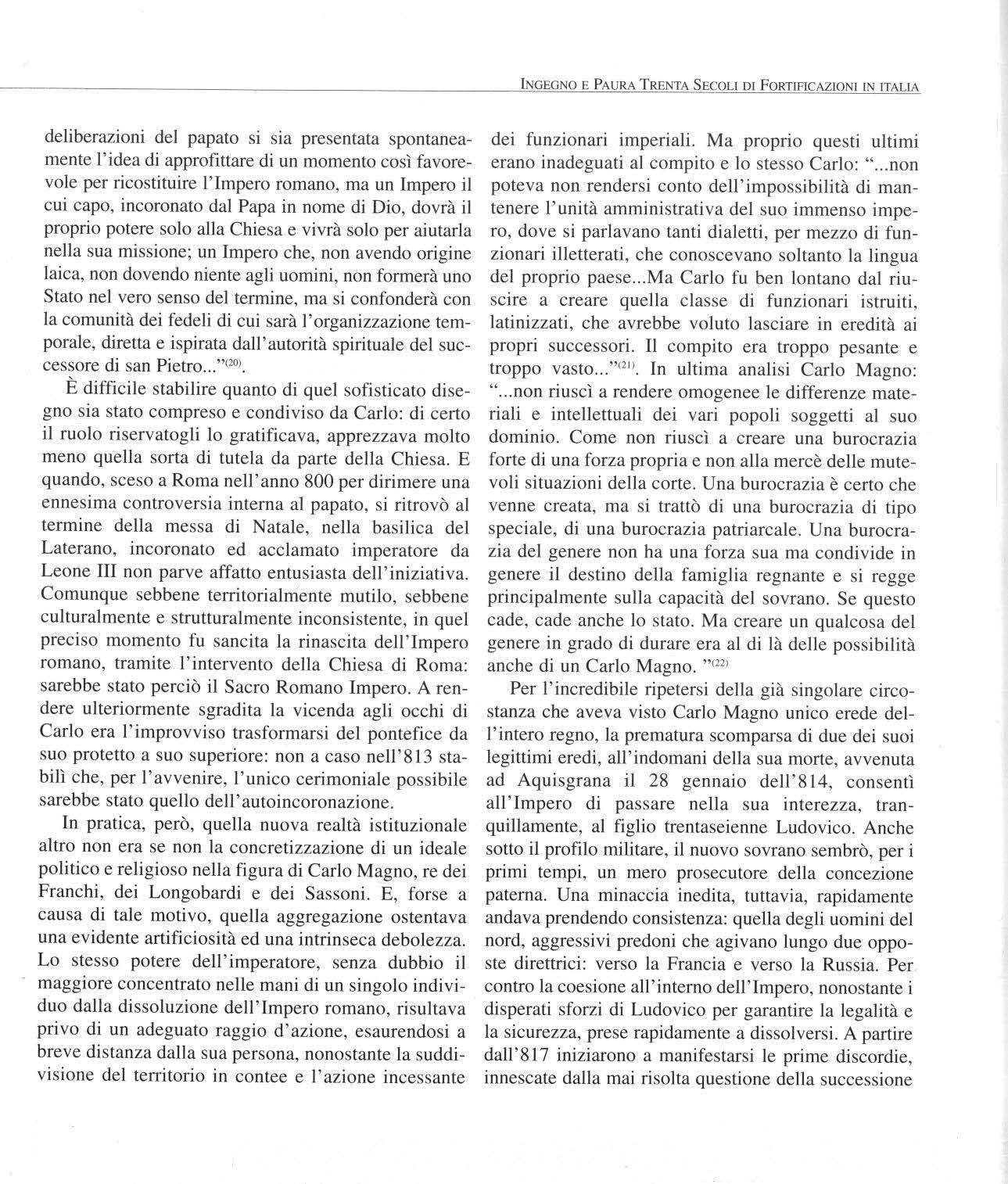
È diffici l e stabi lire quanto di quel sofisticato disegno sia stato compreso e co ndiviso da Carlo: di certo il ruolo riservatogli lo gratificava, apprezzava molto meno quella sorta di tutela da parte della Chiesa. E quando, sceso a Roma nell'anno 800 per dirimere una ennesima controversia interna al papato, si ritrovò al termine della messa di Natale, nella basilica del Laterano, incoronato ed acclamato imperatore da Leone III non parve affatto entusiasta dell'iniziativa. Comunque sebbene territorialmente mutilo, sebbene cu ltura l mente e s trutturalmente inconsistente, in quel preciso momento fu sa ncita la rinascita dell ' Impero romano, tramite l'intervento della Chiesa di Roma: sarebbe stato perciò il Sacro Romano Imp ero. A rendere ulteriormente sgradita la vicenda agli occhi di Carlo era l ' improvviso trasformarsi del pontefice da suo protetto a suo s up eriore: non a caso nell'813 stabilì che, per l 'avvenire, l'unico cerimonia le possibile sarebbe stato quello dell 'a utoincoronazione.
In pratica, però, quella nuova realtà istituzionale altro non era se non l a concretizzazione di un ideal e politico e religioso nella figura di Carlo Magno, re dei Franchi, dei Longobardi e dei Sassoni. E, forse a causa di tale motivo, qu ella aggregazione ostentava una ev id ente artificiosità ed una intrinseca debolezza. Lo stesso potere dell'imperatore, senza dubbio il m aggiore concentrato nelle mani di un singolo indi viduo dalla dissoluzione dell'Impero romano, ri sultava privo di un adeguato raggio d 'az ione, esaurendosi a breve distanza dalla sua persona, nonostante l a sudd ivisione del territorio in contee e l'azione inces s ante
dei funzionari imperiali. Ma proprio questi ultimi erano inadeguati al compito e lo stesso Carlo: " non poteva non rendersi conto dell'impossibilità di mantenere l'unità amministrativa del suo immenso impero, dove s i parlavano tanti dialetti , per mezzo di funzionari illetterati, che conoscevano so ltanto la lingua del proprio paese ... Ma Carlo fu ben lontano dal riuscire a creare quella classe di funzionari i struiti , latinizzati, che avrebbe voluto lasciare in eredità ai propri successori. Il compito era troppo pesante e troppo vasto ... " ' 2 1 J In ultima analisi Carlo Magno: " non riuscì a rendere omogenee le differenze materiali e intel1ettuali dei vari popoli soggetti al suo dominio. Come non riuscì a creare una burocrazia forte di una forza propria e non alla merc è delle mutevoli si tuazioni della corte. Una burocrazia è certo che venne creata, ma si trattò di una burocrazia di tipo s peciale, di una burocrazia patriarca l e. Una burocrazia del genere non ha una forza s ua ma condivide in genere il de s tino della famigl ia regnante e s i regge principalmente sulla capacità del sovrano. Se questo cade, cade anche lo stato. Ma creare un qualcosa del genere in grado di durare era al di là d elle poss ibilità anche di un Carlo Magno. " <22>
Per l' incredibile ripeters i della già singo lare circostanza che aveva visto Carlo Magno unico erede dell'intero regno, la prematura scomparsa di due dei suoi legittimi eredi, all'indomani della sua morte, avvenuta ad Aquisgrana il 28 gennaio dell'814, consentì a ll 'Impero di passare nella sua in terezza, tranquillamente, al fi glio trentaseienne Ludovico. Anche sotto il profilo militare, il nuovo sovrano sembrò, per i primi tempi , un mero prosecutore della concezione paterna. Una minaccia inedita, tuttavia, rapidamente andava prendendo consisten za: quella degli uomini del nord , aggressivi predoni c he agivano lungo due opposte direttrici: verso la Francia e verso la Russia . Per con tro la coesione all 'interno dell'Impero , nonostant e i disperati sforzi di Ludovico per garantire la legalità e la sicurezza, prese rapidamente a dissolversi. A partire dall'817 iniziarono a manifestarsi le prime discordie , innescate dalla mai risolta questione della successione
INGEGNO E PA URA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI I N !TALIAered itaria: la soluzione da lui escogitata di favorire il primogenito dei suoi tre figli non incontrò, ovviarnpnte, il gradimento di questi ultimi. La nascita, dal suo secondo matrimonio, di un altro maschio e le trame della madre tendente a garantirgli la maggior quota ereditaria possibile, determinarono la formazione di due fazioni con la conseguente rovinosa contesa fra padre e figli e fra fratelli che fin) per scol volgere 1' intero Impero. Dopo la morte di Ludovico, nell' 840, e dopo una serie di battaglie, finì diviso in tre unità distinte, ciascuna retta da un re di pari dignità: fu quella l'origine della Germania, della Francia e dell'Italia. L'Impero, nell'arco di meno di un secolo e mezzo, era già scomparso e le incursioni vichinghe infersero i colpi decisivi alla sua disgregazione. Le scorrerie di anno in anno divennero più violente e devastanti spingendosi sempre più verso l ' interno e dimostrandosi imbattibili.
anche misere: qualche recinto, qualche torre , caseforti ormai sparite Ma l'incastellamento di quasi tutta l'Italia settentrionale [avvenne] al tempo del regno italico indipendente, e soprattutto degli Arduinici: seconda metà del X secolo. Si sommano in questo periodo tre element i concorrenti: instabilità e lotte di potere interne ed esterne, quindi frammentazione politica e necessità di difendere in proprio domini continuamente insidiati; invasioni esterne devastanti (Saraceni e U ngheri) cui il potere centrale non era in grado di opporsi, quindi richiesta di potersi difendere autonomamente; debolezza regia, quindi difficoltà a negare privilegi e concessioni ...Tra il 1000 e la metà del XIV secolo la topografia castellana del territorio assume quasi la s iste m azione attuale, per stratificazioni successive ... " <24) _ Il fenomeno descritto, in ultima analisi, non differiva, sostanzialmente, da quanto già si era verificato nell'Italia meridionale, con fasi ancora più violente ed instabili, dalle quali sarebbe scaturito
A quell'epoca il regno d'Italia, già longobardo, si anche in quella zona il primario reticolo fortificatorio , riduceva alla parte settentrionale e ce ntral e della destinato a permanere fino al1 ' avvento dell'età moderPenisola, ad eccezione di Venezia sempre bizantina. na.
Da quel momento subì per oltre: " un secolo, il più tempestoso destino. Più Case si disputarono la corona: i duchi di Spoleto e, soprattutto, i signori di quei Il Sacro Romano Impero Germanico colli delle Alpi donde era così facile e allettante piombare sulla pianura: marchesi del Friuli o d'Ivrea .. .Molti di quei pretendenti si fecero, inoltre, consacrare dal papa imperatori: giacc h è dopo la prima spartizione dell'Impero sotto Ludovico il Pio, il possesso dell'Italia ... [e il] dominio su Roma ... sembrava la condiz ion e necessaria di tale prestigiosa dignità .. . Già nel 894 e 896, Arnolfo, forte della sua origine carolingia, v i era disceso e si era fatto riconoscere re e vi aveva ricevuto l'unzione imperiale " <21>
Quel cruciale sno do storico, dal punto di vista fortificatorio, ebbe no tevo lissime ripercussioni nell 'Italia del nord Con la cessazione della dominazione longobarda e con l'avvento dei conti franchi: " .il territorio riceve quella divisione in comitati che doveva durare fino all'XI-XII secolo ...Pare comunque probabile che scarse fossero le fortificazioni di codesti comitati. E
Per la stor ia, la dinastia caro lingia si esaurì nell ' 888 con la morte dell' ultimo legittimo discendente, Carlo il Grosso. Appena un paio di anni prima, dal 885 al 887, i Vichinghi avevano vanamente stretto d'assedio Parigi, con una forza di 40.000 uomini e 700 navi. La scomparsa del sovrano ne riacutizzò l'offensiva e, so lo nell'892, il nuovo re Arnolfo riuscì a sco nfiggerli su ll e rive del Dyle in Germania. Per molti aspetti, però, quel successo g iun se troppo tardi: già da anni, infatti , gli uomini del Nord si erano sta bilmente insediati nella Francia settentrionale. Falliti tutti i suc cess i vi tentativi di sloggiarli condotti da Carlo il Semplice, ma anche g li sforzi degli stess i Vichinghi di ampliare ulteriormente la loro enclave, nel 911 a:" Saint-Clair-sur-Epte s i convenne di lasciare agli scand inavi parte del bacino della Senna comp rendente le provincie di Rou en,

Lisieux e Evreux, nonchè la regione che s i stende tra il Bresle , l'Epte e il mare, a patto che ess i difendessero il regno contro qualsiasi attacco, ricevessero il battesimo e rendessero omaggio a Carlo. Oltre a questi territori nel 924 gli scandinavi ebbero i distretti di Bayeux e di Séez, e nel 933 quelli di Avranches e di Coutances, arrivando così proprio al confine bretone. Con la creazione della Normandia, i vic hin ghi praticamente cessarono ogni loro attività nel regno franco " <251 _
Sempre nel 911 si estinse pure il ramo germanico della dinastia carolingia e, secondo le consuetudini locali, i grandi del regno sce ls ero quale erede un nobile franco ad essa imparentato: Corrado I. Il sovrano, a sua volta, designò a succedergli il duca di Sassonia Enrico, che, nono s tante la ostilità del suo rivale il duca di Baviera fu accettato senza difficoltà. D a allora: " ... mentre il regno d'Occidente si dibatteva in una lunga controversia dinastica, i sovrani della casa sàssone si sussegu irono , per più di un secolo (919 -1024) , di padre in figlio , financo di cugino in cugino. L'elezione, che continuava a venir effettuata regolarmente, non sembrava che confermare l'eredità. " <26>
Se nel regno franco furono le incurs ioni vichinghe a destare le massime apprensioni, ed a infliggere le peggiori devastazioni , nel regno germanico furono in vece quelle deJJe orde magiare. Ancora una volta una stirpe di origine mongola premeva su JJ e frontiere orientali deJl 'E uropa ed ancora una volta le popolazioni locali dovettero farsi carico della sua eliminazione. Non diversamente dai loro lontani antenati: " i membri deJle tribù germaniche di Sassonia, Franconia e Svevia si mantennero nello stato di liberi contadini usi a combattere a piedi con ascia e picca corta finchè nel X secolo, non si rovesciò sulle loro terre l'uragano delle incursioni magiare: orde di arcieri a cavallo dilagarono , verso ovest, attraverso le pianure deJJa Germania settentriona le. Anche se un pò tardi, i germani si affrettarono a ll ora a coJlegarsi con i loro cug ini occidentali, organizzando una cavalleria e il sistema sociale capace di sostenerla e infine, guidati da Enrico ed Ottone di Sassonia, ottennero a M erseburg nel 933 e a Lerchfeld nel 955 quelle vittorie c he permisero alla dinastia degli
Ottoni di succedere ai Carolingi e aJJo stesso Ottone di cingere la corona imperiale. Una parte della nuova nobiltà feudale seguì i propri signori imperiali nelle loro disastrose avventure in Italia. Altri si unirono al nuovo ordine crociato, i Cavalieri Teutonici, alla ricerca di avventure, terre e salvezza per la propria anima a ll 'est, fra le pianure e le foreste di Curlandia, Polonia e Prussia, dove le loro rapine e i loro massacri furono santificati da una Chiesa indulgente. " <27 >
Ottone I era sceso già nel 95 l nella Penisola, dove aveva ricevuto, a Pavia, l'acclamazione a re d'Italia, ma fu solo il 2 febbraio del 962 che venne incoronato a Roma imperatore dal pontefice Giovanni XII, avviando una nuova fase del Sacro Romano Imp ero, quella germanica. Pertanto: " da allora in poi , salvo che in brevi periodi di crisi, l'Italia, così intesa, non avrà, sino al cuore dei tempi moderni, altro monarca di diritto che quello di Germania. " 128> . I n ogni caso la sua concezione imperiale era sostanzialmente simile a quella di Carlo Magno, ma i centossessantadue anni trascorsi dalla notte di Natale dell '8 00 avevano accentuato le diversificazioni fra il coacervo di popoli che componevano quella compagine. La sua visione fu perciò anacronistica ed inadeguata, eminentemente restaurativa e conservativa, a differenza di quella dei suoi eredi, che iniziarono a perseguire traguardi più co n soni ad un impero propriamente detto. E quando quel sogno , con Ottone III , sembrò ormai a portata di mano, svanì miseramente con la s ua mo1te nel 1002, rientrando nel tradiziona le ambito di un regno italo-tedesco. Il nuovo sovrano Enr ico II (1002-1024 ), ultimo imperatore di stirpe sassone, non potè far altro che preservarne l'ideale.
Con l'avvento dell'anno mille, in Occidente e nella cristianità, si registrò dopo oltre sette seco li , una improvvisa esplosione di benessere. E ssa viene fatta discendere da varie cause, prima fra tutte la diminuzione dell'insicurezza. Il fenomeno a sua volta, forse, non

fu altro: " che una conseguenza del desiderio da parte di larghi strati della società cristiana di salvaguardare il progresso nascente. «Tutti erano sotto il terrore delle calamità dell'epoca precedente e attanagliati dal timore di vedersi portar via in avvenire le dolcezze dell 'abbondanza» ... La protezione accordata soprattutto ai contadini, ai mercanti, alla soccida, alle bestie da soma e da tiro è significativa: la pressione esercitata dal progresso economico fa indietreggiare le armi, impone un disarmo limitato e controllato ... " <29 > _
Ma una società intrinsecamente violenta non poteva in pochi anni trasformarsi nel regno della pace. Non a caso la: " ... violenza era nell 'economia: in un'epoca di scambi rari e difficili , quale mezzo migliore per arricchire del bottino o dell'oppressione? Tutta una classe dominatrice e guerriera viveva specialmente di ciò La violenza era nel diritto: a causa del principio consuetudinario che, alla lunga, conduceva a legittimare quasi ogni usurpazione La violenza era, infine, nei costumi: perchè gli uomini erano proclivi a mettere il loro punto d'onore nella manifestazione quasi animale della forza fisica ... " <30l
Il contrarsi dell'insicurezza potrebbe anche spiegarsi come esito del rigido controllo del territorio imposto dal feudalesimo e dal reticolo di fortificazioni conseguenti. La trasformazione del feudo, da beneficio personale ad ereditario, aveva comportato una proliferazione di residenze fortificate. Infatti: " ... nell ' istituzione o nel consolidamento di quelle dominazioni, di titolo e di raggio d'azione variabili, risulta una caratteristica comune: l'azione esercitata, come punto di cristallizzazione, dai castelli ... C' era sì la torre , a un tempo dimora del signore e ultimo ridotto della difesa; ma intorno a essa, uno o più recinti circoscrivevano uno spazio abbastanza vasto, dove si raggruppavano gli edifici ri se rvati sia agli alloggiamenti delle truppe, dei servitori, degli artigiani, sia ai depositi di censi o di provviste e mai, in seguito, l'idea che il diritto di fortificazione era, nella sua essenza, una prerogativa della potenza pubblica scomparve interamenle ... Fatto ancora pili grave: i re e

i principi, impotenti a impedire la cost ruzione di nuove fortezze, non riuscirono meglio a conservare il controllo di quelle che, dopo aver costruite essi stessi, avevano affidato alla guardia di fedeli, a titolo di feudi " < 3 1)
In quel contesto il processo di trasformazione dei rozzi Vichinghi insediatisi in Normandia, e definiti ormai correntemente Normanni, fu straordinariamente rapido. Basti pensare che, abbandonato il paganesimo per il cristianesimo ed il danese per il francese , già intorno al 940, tutti professavano il monoteismo e quasi più nessuno parlava la lingua originaria: per il resto l'intera loro soc ietà appariva rigidamente feudale. Unica connotazione residua la permanenza nei comportamenti, pubblici e privati, dell'atavica intraprendenza ed aggressività. Ovvio , pertanto, che riuscissero ad unire:" ... alla abilità marittima degli scandinavi ... quanto allora si conosceva di arte di guerra della cavalleria e di arte poliorcetica ... Nessuno, tra i suddi ti nominali del re di Francia, era potente come il capo di questa razza forte e assimilatrice ... " m) _ Nessuna meraviglia, quindi, che in meno di un secolo il ristretto territorio della valle della Senna fosse ormai insufficiente per le ambizioni dei tanti rampolli delle casate normanne. Ben presto molti di quei giovani, ampiamente dotati di capacità combattive, approfittando dello stato endemico di belligeranza della cristianità iniziarono ad offrirsi come mercenari sia ai potentati occidentali sia ai bizantini, cercando di rHagliarsi fortune e feudi sotto il caldo sole del Mediterraneo , in particolare in Italia.
L'insediarsi dei Normanni in Italia ebbe un andamento talmente dissimile da tutte le precedenti penetrazioni nordiche , da non potersi in alcun modo equiparare ad un'ennesima invasione. Non consistette, infatti, in una calata in massa, nè in un unico episodio, ma si attuò attraverso modestissime infiltrazioni, numericamente insignificanti, in un arco temporale di circa mezzo secolo e, per giunta, interessò soltanto il Meridione prima e la Sicilia poi. In particolare s i trattò di: " gruppi d 'in dividui d 'ogn i
età e co ndi zione, che abbandonavano alla spicciolata il loro paese, troppo povero e angusto, e s i tra sferivano nel no stro, attratti dalla fama della fortuna che vi avevano trovato passandovi e s tabilendovi s i , molti loro conterranei. Vi emergevano i cadetti di casate feudali, bramosi di posizioni economico-sociali che in patria non potevano raggi un ge re. fn terzo luogo , la fecondità, il dolce clima e le altre attrattive delle terre della Campania e della Puglia, e, per dippiù , le guerre locali che domandavano di continuo uomini d'arme , bastavano per accendere l a fantasia, l 'a mbizione e l 'av idità di quei discendenti dei Vichinghi, che per due seco li avevano vagato, in cerca di sedi confacenti, per i mari e per le terre de l nord. " <33 >
Secondo una prima ricostruzione , all'origine della migrazione c i fu la funz ione di caposcalo per la Terrasanta<34> soste nuta da i porti pugliesi, tappa obbligata per i guerrieri delle potenti dina st ie dei conti d'Angiò e dei du ch i Normanni <35 > _ All'epoca le cond izioni politiche in cui versava il Mezzogiorno erano quanto mai frammentate ed in stabi li : " .la frontiera dell'Impero bizantino uffi cia lmente andava da Terracina ... a Termoli; ma all'interno di questi confini so ltanto le province di Puglia e di Calabria, abitate in prevalenza da greci, erano sotto il governo diretto di Bi sa nzio. Sulla costa occidentale c'erano le tre ci ttà-stato mercantili di Gaeta, Napoli ed Amalfi, nominalmente vassalle dell'imperatore... L' interno del paese era in mano ai principi longobardi di Benevento e di Salerno .. .! mu s ulmani dominavano a ncora la Sicilia nonostante i molti tentativi dei bizantini per riconquista rl a; e le incursioni che partivano dall ' iso la e dall'Africa contro le coste italiane aumentavano il caos nel pae se In queste regioni erano arrivati in gran numero avventurieri normanni dalla Francia settentrionale, in viaggio come pellegrini per Gerusalemme molti di loro erano so ld ati di ve ntura che rimanevano al se rvi zio dei principi longobardi .. .Il di sordine del paese offrì loro un ' occasione favorevo le. " <36>

Nelle pagine di Guglielmo di Puglia, lo storico dell'epopea normanna, si trova conferma esplicita di
quanto delineato, allorchè si narra di quaranta cavalieri normanni , pellegrini verso la Terrasanta . Contattati da un nobile, pugliese, che ne sollec itò l'aiuto per abbattere il g iogo bizantino, essi avrebbero acconsentito, rinviando però l'impresa a dopo il loro rientro. Curiosamente, anche in una tradizione sa lernitana, si parla di un gruppo di quaranta cavalieri normanni che, appena tornati dalla Terrasanta, riuscirono con il loro provvidenziale intervento ad infrangere l 'assedio saraceno alla città. In alcuni memoriali francesi, invece, s i tramanda di un g ruppo di cavalieri normanni , che es pulso dalla propria regione, per gravissimi mi sfatti, si diresse verso il Sud!
Quale che s ia la verità in queste sos tanzialmente concordanti leggende, è certo che la presenza normanna, sporadica e di scars iss ima entità , a partire dal 1015-16 tese rapidamente ad incrementarsi nel meridi one italiano. È pertanto possibile individuare, negli ste ssi anni, due distinti nuclei in sediativi, s ignificativamente a Salerno il primo ed a Bari il sec ondo , entrambi confluiti al serv izio di Melo, eroe dell'irredentismo pugliese<31> Intorno a l 1030 i membri della famiglia di Altavilla rappre sentano ormai in Campania ed in Puglia una realtà sta bile e potente, capace di fondare pers ino nuove città, quali Aversa nel 1047. Sterili, a quel punto, i tardivi tentati vi di estrometterli con le armi, come quello es ploso nel l 050, antesignana sommossa popolare contro i brutali dominatori che lo stesso pontefice non disdegnò di appoggiare, intervenendo militarmente.
L'incredibile scena di Leone IXC38> , prigioniero dei Normanni, in quanto capo di un eserc ito sconfitto, nella brulla distesa del Tavoliere, dopo la battaglia di Cividale il 18 giugno del 1053, ma, al contempo riverito dai vincitori, umilmente genuflessi al suo cospetto, in quanto capo spirituale della cristian ità, fa da prologo alla nascita del primo grande stato peninsulare. Nonostante ciò, la bramosia di conquista dei guerrieri del nord no n era affatto placata, provocando, anzi, la loro in gerenza in ulteriori belligeranze intestine.
In Sicilia, da seco li ormai is lamizzata, divampava
INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTrFICAZIONl IN ITALIAuna violenta contesa fra i diversi pasc ià e l'emiro , pedissequa replica della più remota contrapposizione tra i baroni bizantini e l'imperatore , che era stata astutamente sfruttata dai s araceni per so ttrarre l ' intera isola ai due conten d enti. E così nel 1030 , ripercorrendo quel dimenticato copione, l 'e miro, di s perando di ridurre all'obbedienza i s uoi riotto s i vass alli, s ollecitò a Bisanzio l'invio di un corpo di spedi zione che lo aiutasse a riaffermare la sua compromessa sov ranità<39> _ D opo breve tempo un esercito imperiale, agli ordini del generale Maniace, s barcò a Messina , accolto, se non amich evolmente di certo non ostilmente, dagli estemporanei a ll eati musulmani. Tra le s ue file , o ltre ai militi della guardia varega, spiccava un con tingente di indisciplinati me rcenari dai biondi capelli : i Normanni. Stando alle fonti, essi non eccedevano le 500 unità; era infatti la prima vo lta che Bisanzio arruolava, per una s ua ca mp agna medi terranea, tra quella genia di rinomati razziatori.
Alcune sag he vichingh e ri evoca no co nfu sam e nte l 'e pi so dio , tramandando che un celebre m e rce nari o, di nom e Harald, nel 1034: " ... con un seg uito personale di cinquecento guerrieri, s i re cava a Bisanzio ed entrava nel se rviz io imp eriale Era un profess ionista che combatteva s u qual s ias i teatro di operazio ni do ve lo mandasse il s uo datore di lav oro [e] l ' imperatore .. .lo inviò con la s u a compagnia in Sicilia perchè l 'esercito bi zantino stava conduce nd o una guerra in quell ' is ola . Ed egli vi andò e fece posse nti imprese ... "<40> . Anche il fratello di Harald seguì la mede s ima strada c he così ricordava: " ... anch ' io combattei per l'imperatore . ..appena raggiunta M ess ina... [fui nominato ] 's patharokandates ' [condottiero] ... " <41 l
Ov viame nte, come era g ià accaduto ai loro predece ss ori arruolati dai bizantini , nell'occa s ione oltre a spe rim e nta r e l ' inconsistenza difen s i va dell ' iso la ebbero modo di valutarne anche le immense ricchezze, ulteriormente acc resc iute s i durante la dominazione araba Nessuna meraviglia, quindi , se una volta radicatisi n e l Me zzogiorno, non più di trent 'a nni dopo , alcuni ~ormanni , al comando di Ruggero di Altavilla , fratello del più celebre Roberto, detto il
Guiscardo, furono indotti, dal ricordo della non lontana esperienza a tornare a Messina per intraprendere, in propri o la co nqui sta d ell' iso la.
Il giorno di Natale de l 1130 la temeraria i mpresa dei due frate lli attingeva la sua impre ve d ibile concl usione: il loro di sce ndente Rug gero II s i proclamava so lennemente re di Sicilia, d e finizione geografica c h e in realtà includ eva anche buona parte d e l M ezzogiorno penins ulare , l'altra Sicilia. Qu e llo che , pur se tra a lterne vicende, s i sarebbe affermato per i s uccessivi sette seco li come il magg iore Stato italiano , il R egno appunto delle Due Sicilie, assumeva, così, il s uo originario stabile assetto. L' intraprend ente ed ambizioso sovrano iniziò se nza indugi a cementare quel disomogeneo Stato, assicura nd o, inn anz itutto, l 'ordin e pubblico ed organizzando un credib ile e poderoso apparato militare. La validi tà della sua visione politica è tangibilmente testimoniata dall 'estendersi delle conq uiste: un a ven tin a di anni dop o l'incoronazione, infatti , anche il Nordafrica, d a Tripoli a Tunisi , era sotto la sua sovranità<42>
Tuttavia l 'eso rdi o del nuo vo regno fu caratterizzato da incessan ti ribe lli o ni feudali, c h e ne ritardarono la normalizzazione. Molti Normanni, dei tanti nel fratte mpo so prag giunti, n on riconoscevano 1' as setto monar c hico. Motivatamente s i reputavano comunque " ... uguali fra loro [po ic hè ] ... so lo per motivi conti ngenti ... nel 104 2, nel corso de11a lotta co ntro i Bizantini , s i ... [erano convinti] ad eleggere un co n te nella p e r so na di Gugl ielmo d'Altavilla. Questi fu considerato, e in effe tti era, so lo un primus inter pares e tale gli altri capi normanni tesero se mpr e a co n s id erare i s uoi s u ccesso ri anche quando, attraverso qu e lli c h e so no s tati defin i ti colpi di s tato costituzion ali, R oberto il Gui scardo p rim a e Ruggero II poi trasformarono il loro titolo di c onte in quello di duca e di re ... " <43l _
La log ica delle armi, cos trin se in breve tempo anche i più recalcitranti d ei capi norm a nni a11a totale obbedien za; non marginal e fu, in tale contesto il ricor s o alla fortificazione, che ini z ia così ad esercitare a pieno titolo la s ua altrimenti margi n a le fun-
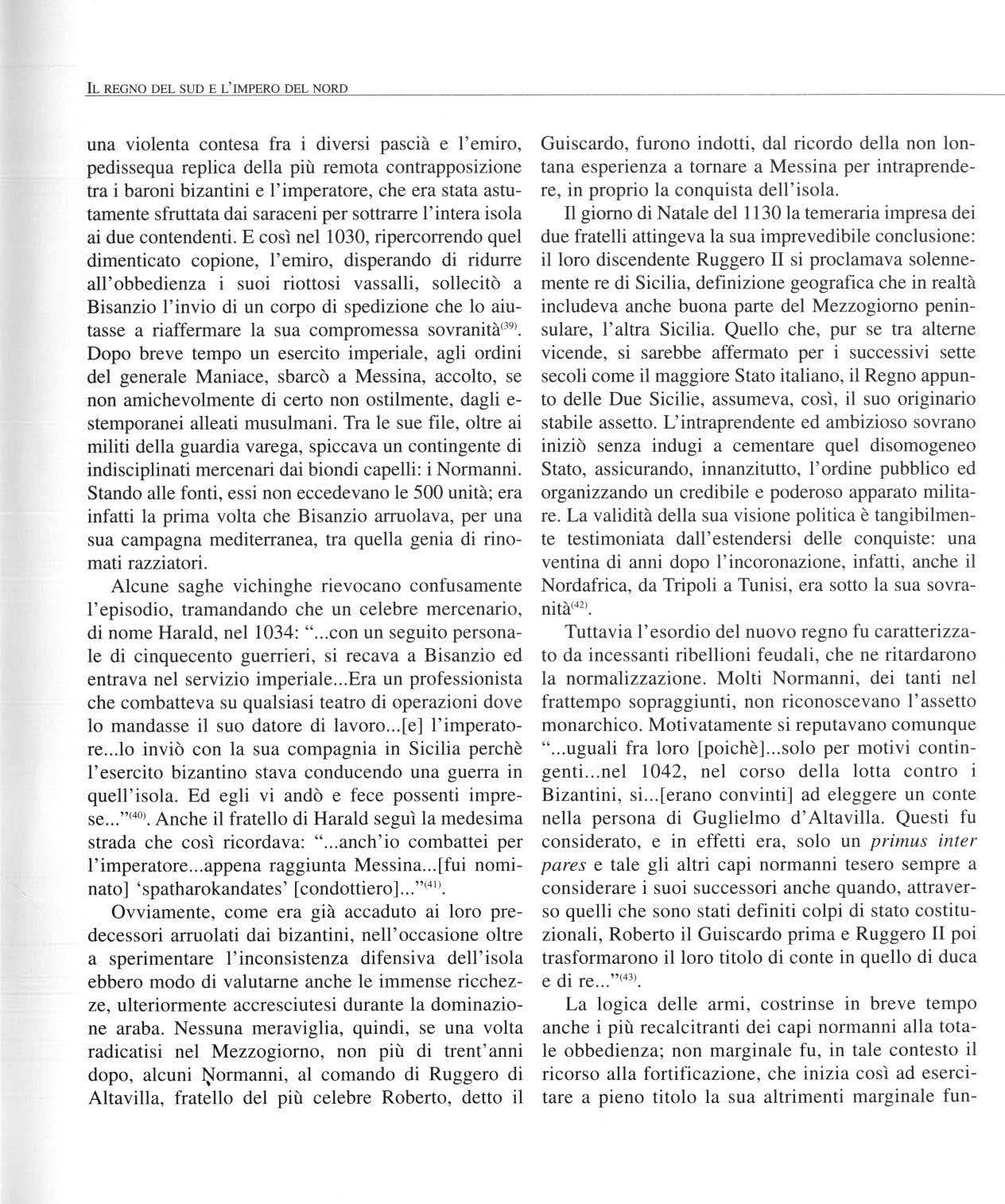
zione repressiva. Non a caso : " ... cronache dell 'e poca ... riportano che i Normanni , soprattutto Ruggero II , fecero edificare numerose fortezze, sia torri che castelli, man mano che occupavano nuovi territori. Studiosi che citano cronisti tedeschi, contemporanei alla campagna dell'imperatore Lotario contro i Normanni, accennano al considerevole numero ed alla grandezza degli impianti difensivi normanni Gli stessi autori, trattando della tipolo gia costruttiva normanna, citano alcuni esempi costituiti da semplici torri isolate «non di rado con la forma dei donjons patri » " <44 >
La concezione di tali modeste fortificazioni introdotte dai Normanni, sebbene fosse di tipo ancora estremamente rudimentale, rappresentava , comunque, già una rilevante rielaborazione dei loro più grezzi archetipi, spesso addirittura in legno. Si trattava, infatti , di appross imate strutture utili soltanto nell'ambito del loro primitivo contesto di provenienza, basato sulle razzie e s ulle sopraffazioni. Furono infatti: " .. .le scorrerie normanne a far sorgere dovunque dal!' Adriatico alle pianure dell'Inghilterra settentrionale .le fertès o fortezze rurali ... Le guerre intestine non tardarono a moltiplicarle Ri spondevano a bisogni elementari , spo ntan eamente se ntiti e soddisfatti . Un agiografo lo ha sp iegato con molta esattezza, se pure senza simpatia: «Per quegli uomini se mpr e impegnati in ri sse e in massacri, ripararsi dai nemici, trionfare degli eguali, opprimere gli inferiori » ...

Generalmente erano edifici di tipo assai semplice. Il più diffu so, a lungo, almeno al di fuori dei paesi mediterranei, la torre di legno ... [al suo interno] al primo piano, una sa la dove il «potente», «con la sua masnada , viveva, conversava, mangiava, dormiva»; al pianterreno, il celliere per le provviste. Ordinariamente , ai piedi della torre era scava to un fossato. Qualche volta, una cinta di pali e di terra battuta, c ircondata a sua volta da un altro fossato ,
correva a una certa di s tanza. Essa permetteva di mettere al sicuro vari edifici e la cucina, che il pericolo d 'i ncendi consigliava di collocare in di s part e ; serviva al bi so gno di rifugio ai dipendenti ; evitava alla torre di essere investita s ubito e rendeva meno facile , nei confronti di tale ridotto, il mez zo d 'a ttacco più efficace: il fuoco Torre e cinta sorgevano, infine , abbastanza di frequente s u di una altura, talvolta naturale , talaltra, almeno parzialmente, opera dell ' uomo [detta motta] ... " 145l _
Agli inizi dell'XI seco lo , tuttavia , i Normanni le impiegavano ormai sporadicamente, forse s olo come opere campali nel corso di scorrerie più prolungate. L'ampliarsi del loro raggio d ' azione li aveva, senza dubbio, posti di fronte alle fortifica zioni in muratura, delle quali immediatamente recepirono i vantaggi e le caratteristiche fondamentali , adattandole al poveri ss imo repertorio tradi zionale. Sorsero allora i primi dongioni in pietra, che s pess o sosti tuivano qu e lli lignei s ulle medesime ' motte'.
Molto probabilmente anche iI Meridione conobbe siffatte fortificazioni lignee, almeno durante i prodromi della penetrazione normanna, ma la loro estrema deperibilità ne ha impedito la conservazione. È emblematico, al riguardo , ricordare che anche il te rmine 'motta' è scomparso da secoli dall ' italiano corrente, contrariamente alla voce verbale derivata, 'smottare', che definisce , appunto, il disgregarsi di una modesta altura. È pertanto credibile che, conclusasi la fase pioneristica e consolidatasi stabilmente la conquista, anche a s ud i Normanni iniziassero a sostituire le prime effimere difese con altre più evolute e resistenti, sebbene strutturalme nte e concettualmente simi li. Comparvero allora i menzionati dongioni in pietra , massicce torri quadrilatere di discreta superficie i nterna, case-torri parallelepipede che vantavano all'epoca una collaudata esperienza. Poichè l ' assemblaggio dei tronchi di legno co nsentiva so l ta nto stru tture quadrilatere, la predilezione per i dongioni in pietra della planimetria quadrata deve imputarsi soltanto alla estrema conservazione di tale tradizione , non manifestandosi alcuna valenza difensiva a s uo carico.
Sembra che il più antico dongione sia stato innalzato dal conte d'Angiò, verso la fine del X secolo, a Langeais.
Da allora, in sequenza accelerata, ne sorsero innumerevoli, tutti fra loro sostanzialmente simili. In dettaglio si tratta, abitualmente, di un edificio: " ... a pianta rettangolare ... con un grande stanzone per piano e altezza di due, tre o, più raramente, più piani. Scale retrattili, o più comode scale fisse, garantiscono i collegamenti verticali. L ' altezza può raggiungere dimensioni imponenti, dell ' ordine dei 30 m. Di solito l'accesso avviene al livello del primo piano: il piano terra viene utilizzato come magazzino, cantina, deposi to , ed è accessibile solo dall'alto, sotto il controllo del proprietario della fortificazione .I modi in cui questo accesso sopraelevato può essere raggiunto sono notevolmente variati .IJ sistema più semplice consisteva in una ripida rampa di scalini di pietra, larghi a sufficienza per lasciar passare solo un uomo, cosicchè i difensori della porta potessero essere impegnati da un solo nemico per volta, il cui cadavere, poi creasse un ulteriore ostacolo alle forze attaccanti ... Dongioni di pietra erano, nell'XI secolo, piuttosto
rari ... poichè richiedevano l ' impiego di esperti ... muratori professionisti e un largo uso di pietra da taglio Tuttavia, con il passar del tempo, sia le maestranze sia la pietra divennero meno difficili da ottenere e le fortificazioni di legno vennero sostituite da più solide e durature strutture di pietra ... " (46 )
In ogni caso, anche nella tipologia in muratura , i dongioni rappresentavano fortificazioni primordiali, di elementare concezione e di rapida costruzione, e pertanto perfettamente idonee a fornire, nel contesto estremamente fluido della dilagante occupa z ione, la soluzione per antonomasia ai problemi cli difesa avanzata, derivanti dalla astiosità degli asserviti e dalla rissosità dei conquistatori! Essi, però, se tecnologicamente rappresentano un piccolo passo in avanti della fortificazione medievale, richiedendo una indubbia capacità costruttiva, sotto l'aspetto militare non ostentano alcun significativo progresso rispetto ai masti longobardi dei quali riproducono, inalterati , connotati residenziali ed espedienti difensivi, di tipo sempre eminenteme nte passivo.
In lin ea di larga schematizzazione, un'idea : " ... sia pur approssimata, dell'architettura militare normanna ci è data dalla torre fortezza che costituì il tratto caratteristico di alcune costruzioni sacre di Sicilia, quali le cattedrali di Catania, di Cefalù e di Palermo. Qui la torre fortezza si inserisce nell'organismo architettonico come strumento di difesa e, solo in via eccezionale, è stata trasformata in torre campanaria. L'esempio di Catania dimostra come l'impianto di possenti torri quadrate, poste a protezione dei lati più vulnerabili, doveva corrispondere, quasi ce rtamente , ad un concet-

to normativo l a rga me nte applicato nelle costru zioni militari de l tem po. Si tratta , co munque , di ri cost ruzioni approssimative, anche se possiamo affermare che la torre s u pianta quadrata è se mpre prese nte nelle opere di impianto o rifaz ion e normanna... " <41> .
La dominazio ne normanna nel Meridione si protra sse p er oltre un seco lo, favorendo il radicarsi del feudalesimo. In pochi dec e nni anche qui i dongioni s i moltipli caro no , presidiando ogni sia pur modesto ce ntro abitato.
In seg uito molte di tali fortificazioni si trasformarono in caste lli propriamente d etti, altre finirono di strutte ne l corso delle co ntese fratricide, altre ancora vennero abbandonate o ri s trutturate: pertanto quasi ne ss una ci è pervenuta integra, il che non esclude c h e sia possib ile di sporre di significativi esemp lari , appena mutilati in altezza.
U n interessante esempio di dongione , in discrete condizioni di conservazione , è quello che s ovras ta il centro antico di Pi e tramelara , in provinci a di Caserta. Dalle fonti stori che si apprende c he, dopo una piima fase di possesso longobardo , 1'intera co ntrada passò al monastero di M o ntecassi no in virtù di una donazione<48> . Poss iamo quindi motivatamente pres um e re l' es is tenza di un borgo cintato , d el tipo di qu e lli lon go bardi innan zi de scritti, caratterizzato dalla so lita prees is ten za di mura poli go nali sann ite e so rmontato da un a modesta rocca.

Il Muratori, infatti, nel s uo R e rum ltali ca rum scripto res<49> , riferi sce, s ulla base di autori medievali , che Petra Mellara nel 900 era inclu sa nel Principato longobardo di Capua, come c ittà fortificata. È tuttavia estremamente probabile che la co nqui sta normanna si fos se estrinsecata anche lJ con le immancabili distru-
z ioni e deva s tazioni, obbligando i successivi feudatari
64 Pietramelara , viab ili tà medi eva le. a rico s truirne le fortificazioni. Da altre fonti apprendiamo dell'esi ste nza di un tal:
INGEGNO E PA URA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZ ION I IN ITALIA 63 Pi etramelara, panoramica.·•... Va seo capitano famoso, c he con buon numero di cavall i, di Francia passò in I talia co n il Conte Guido [Filippo n. d. A.] da Monforte, l'anno 1265 , all'acquisto del Reg no di Napoli per Carlo figliuolo di Luigi Re di Francia contro Manfredi, il qual e prese una grossa terra , e forte. detta Pietram elara , lontana da Napoli trenta miglia , e cinque da Calvi, e da Theano in Terra di Lavoro , res tand ovi Capitano , e per gratitudù1e del Re avendone avuto in do no alcuni be ni , c he p1ima erano de' baro ni che seguitavano Manfredi, vi fondò la Ca sa Vasea .. . " t!IO ,.
Quindi, tanto nel 900 quanto nel 1265 , Pietramelara dispone di una fortificazione di discreta consistenza, molto verosimilmente una rocca con relativo borgo cintato. Fra le due date va ipo tizzata una sua distruzione , operata da Ru ggero II nel 1229 e una successiva ricostruzione, ovviamente seco nd o schemi e concez ioni normanne. Di certo il 13 marzo del 1496 il piccolo centro fu nuovamente attaccato, per ordine di Federico d'Aragona , e bestialmente devastato con l'eccidio dei s uoi difensori e la deportazione dei pochi sopravvissut i. Il legittimo feudatario, Federico di Monforte, costretto ad a ss istere impotente alla tragedia, non più tardi di un anno dopo , però , riuscì a ricostruire quanto distrutto , a cominciare dalla grossa torre quadrata sommitale .

Ma, come più volte ribadito in circostanze analoghe, è più plausibile che, in rea ltà, proprio: " .. .la torre s ia il re s iduo del precedente nucleo ... rnentre il conte di Moofort e ne avrebbe attuato so lo il restauro La s ua base a 's carpa', mo stra , nel taglio delle grosse pietre, la robustezza di [un fortilizio] tuttavia giudicato non 'abbasta difeso' ."<rn.
L'appare nte paradosso di una robusta opera difensiva valutata, però, di scarsa re s istenza, è facilmente spiegab ile qualora si riguardi una so lidi ssima fortificaz ione del XII-XIII seco lo alla luc e della poliorcetica maturatasi alla fine del XV, dopo il petfezionamento delle artiglierie!
Di certo il torrione di Pi e tramelara conserva ancora , e ben evidenti , le caratteristiche dei dongioni normanni, nonostante le tante alterazioni e mutilazioni successive. In dettaglio alla base, che insiste su di una piccolis sima scarpa, mi s ura m 9 per lato , con uno spessore murario di circa 2 m che si riduce in
sommità, alla quota di m 15, a m 1.7. Quanto all'altezza , in origine, doveva attestarsi intorno alla trentina di metri, caratteristica che conservò fino al I 800 , con una suddivisione interna su due piani: è credibile, tuttavia , che impalcati lignei intermedi ne formassero di ulteriori , serviti da scale volanti.
in Puglia si incontrano alquanti dongioni in discreto stato di conservazione; in particolare ricordiamo quelli di Deliceto , di Bisceglie, di Conversano, di Ceglie Messapico, tutti ovviamente inglobati in altr~ttanti castelli di epoca posteriore, ma sempre perfettamente identificabili'52>
Una fortificazione sostanzialmente simile alla precedente, e ad essa abbastanza vicina, si ritrova pure a Caiazzo. Si tratta, infatti , di un altro torrione a pianta quadrata anch'esso su base leggermente scarpata e con ingresso soprelevato , tuttora esistente, anch'esso sicuramente mozzato in altezza ed affiancato da un più recente castello che domina il sottostante borgo.
Stando alla tradizione, la costruzione del torrione di Deliceto deve attribuirsi ad un tal Tristai nus, signorotto normanno del seguito di Roberto il Guiscardo, che intorno al 1073, lo edificò a quota 621, su di un picco dell'estremo contrafforte del subappennino Dauno, ad una trentina di chilometri da Foggia. Consiste in un massiccio corpo quadrato , alto 30 metri, diviso in tre piani, fra di loro comunicanti.
L'accesso situato al livello intermedio , avveniva originariamente tramite una rampa di gradini in pietra ed un ponte levatoio, al presente tramite una snella scala di ferro. Il dongione è forato da diverse sottili feritoie e da alquante piccolissime finestre. Anche il coronamento, in leggerissimo aggetto su aTchetti e beccatelli, è di epoca posteriore , lasciando ipotizzare un intervento più consistente a carico della sommità del torrione.
Simile per molti aspetti si presenta la vicenda del dongione di Bisceglie, eretto intorno al l 060 da un tal Pietro, vassallo di Roberto il Guiscardo. Di pianta quadrata raggiunge l'altezza di 24 metri: in epoca sveva, dopo la costruzione di un adiacente caste1lo, finl aggregato allo stesso tramite un ponte levatoio. Anche in questo caso sono presenti diverse sottili feritoie e poche finestre: l'ingresso, ancora perfettamente visibile, è ad una decina di metri da terra.
Come in precedenza accennato , i prodromi dell'epopea normanna ebbero per teatro la Campania e, soprattutto, la Puglia, regioni che, nonostante i successivi riassetti difensivi , hanno conservato un gran numero di quelle primitive fortificazioni. Soprattutto
A Conversano i Normanni eressero la loro tipica fortificazione impiantandola, intorno al 1054, sui ruderi di una più antica opera bizantina, probabilmente del VI secolo. Di certo il primo ad esserne signore fu un tal U mfredo al quale successe, poco dopo, lo stesso Roberto il Guiscardo. Attualmente può identificarsi abbastanza chiaramente tra le strutture che costituiscono il raffazzonato castello aggregatoglisi intorno a partire dal XIII-XIV secolo.
 67 Caiazzo, veduta aerea del Castello, ben evidente il dongione.
ING EGNO E PA URA TRENTA SECOLI DI fORTIFTCAZIONI IN ITALIA
67 Caiazzo, veduta aerea del Castello, ben evidente il dongione.
ING EGNO E PA URA TRENTA SECOLI DI fORTIFTCAZIONI IN ITALIA

A Ceglie Messapico, su uno de i due colli che sovrastano l'abitato si sco rge un ennesimo dongione, innalzato agli inizi del1'XI seco lo da un normanno di no me Sirepagano. Di pianta quadrata, raggiunge 34 metri d'altezza ed ostenta un evide ntissimo apparato a sporgere, in forte aggetto. L'anacronistica agg iunta deve ascriversi a Francesco Sanseverino, e risale a dopo il 1361.
In merito alla configurazione geometr ica dei dongioni va osservato c he, sebbene p er quella quadrata s ia indubbia una matrice normanna, essa non pu ò au tomat icame nt e escluders i in presenza di conformazioni di verse<53> . Secondo a ut orevo li studi osi, infatt i, in numerose circosta nze i Normanni non disdegnarono la pianta circo lare con a lzato c ilind rico . Ciò forse avvenne ogni qualvolta che capitò loro di co nqui s tare un mastio longobardo particola rm e n te soli do , che necessitava so lo, e non sempre, di un miglioramento della trama muraria dell 'es tradosso.
La supposizione trova si gnificativa conferma nella disposizione interna di questa ano mala tipologia, perfettamente anal oga al la precedente appena de scritta , nonchè nella documentazione sto ri ca e, soprattutto, archeologica.
Senza contare c he i dongioni ci lindri ci non so l o co ndi vidono la logica insediativa apicale dei coev i parallelep ip edi, cosa abbas tanza ovvia, m a persino l'adozione di un recinto murario a pp e na più re go lare , spesso quadr i latero, di costruz io ne vistosa ment e meno arca ica. Per una vasta serie di concause, di s iffatti dongioni sono sopravvissuti solta n to sparu ti esempi, che rivestono p erta nt o un indubb io interesse tipologico, tale comunque d a giust ifi care una meno schematica esposizione
L o mb ard i ', non implica alcun preci so riferimento crono lo gi co ai Lon gobardi ma ri e ntra nella mi gl iore definizione d ei toponimi adottata dopo il 1862 per evitare ogni omonimia fra i tanti paesi italiani. Quanto alla fortificazione in esame, che sov rasta il piccolo centro avellinese, si tratta di un torrione di forma: " ... cilindrica, privo di sc arpa , fondato s ul ban co di arenaria e s ui terreni (11] donjon è costruito in opus caementicium e ntro cortine in conci di calcare ad opus incertum, seco ndo la tecnica di tradizione romana; letti di posa e g iunti hanno lo spes s ore da 1 a 4 cm. La s truttura ri s ponde al modello del donjon residentiel ... " <54 > _
E, come già nei casi innanzi descritti , anche in quest'ultimo alla s truttura cilindrica si affiancò, in epoca posteriore, un corpo di fabbrica abitativo for tifi ca to. In parti co lar e la: " ... costruzione del palatium, nel XIV-XV seco lo, indica l'instaurarsi di una dinamica re si de n ziale de s tinata a svo lger s i per qualche tempo s u due poli int egrat i ; tuttavia il palatium i ncorporò il donjon e s' impose come residenza abituale .. .Come nel caso di Mont e lla ciò integra, in base a li ' esperienza archeologica, la tesi dell 'i mpiego secondario dei torrioni ri s petto al palacium castri, c h e co n serv a la propria validità.
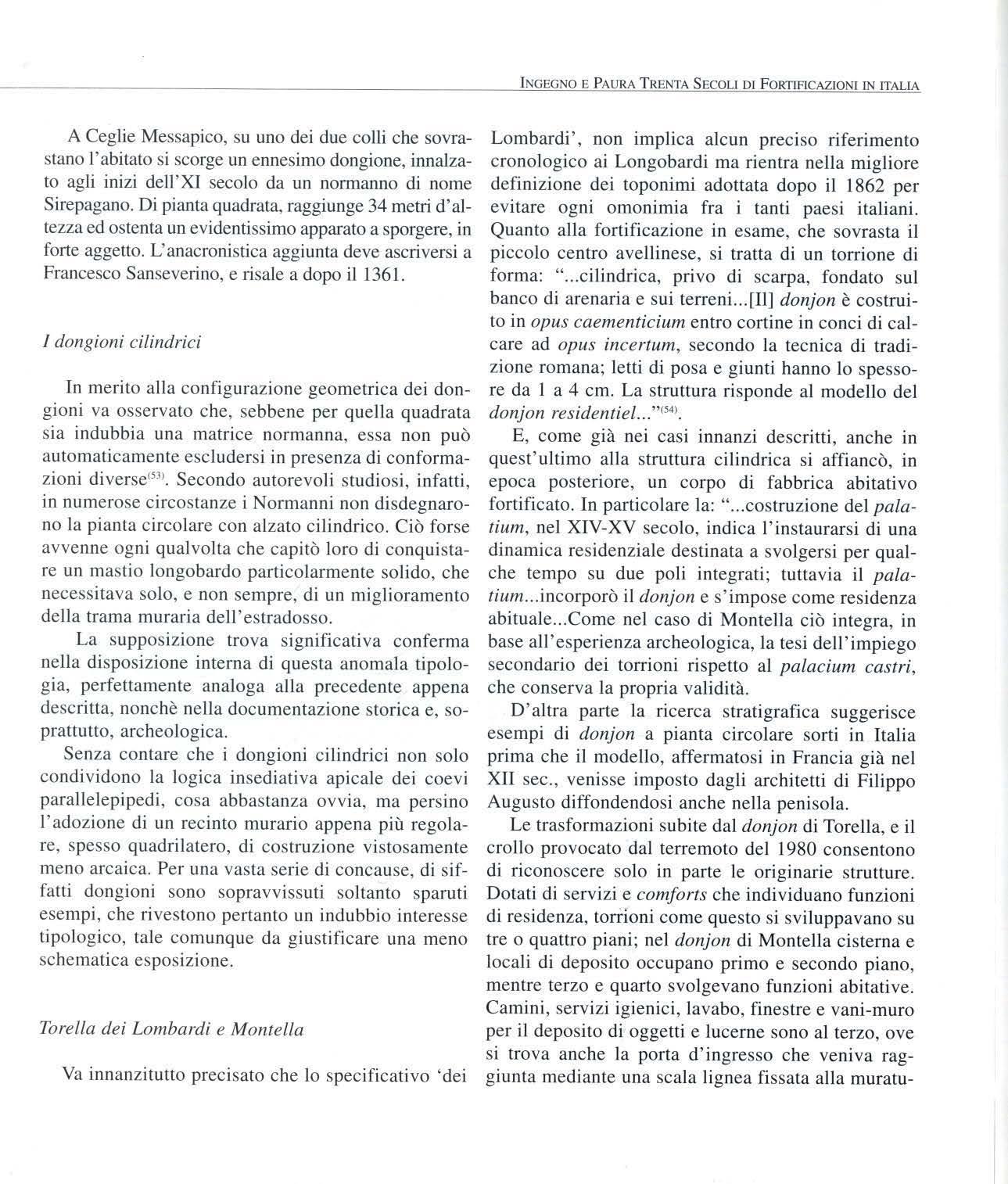
D 'altra parte la ricerca s tratigrafica s uggeri sce esempi di donjon a pianta circolare s orti in Italia prima che il modello , affermatosi in Francia già nel XH sec., venisse imposto dag li architetti di Filippo Augusto diffondendo s i anche nella penisola.
Va innanzitutto precisato che lo spec ifi ca ti vo 'dei
Le trasformazioni s ubite dal donjon d .i Torella , e il crollo provocato dal terremoto del 1980 consentono di riconoscere s olo in parte le originarie s trutture. Dotati di servizi e co mfor ts che individuano funzioni di re s idenza, torrioni come questo s i sv iluppavano s u tre o quattro piani; nel donjon di Montella cisterna e lo cali di depo s ito occupano primo e secondo piano , mentre ter zo e quarto svolgevano funzioni abitative. Camini, serv izi igienici, lavabo, finestre e vani-muro pe r il deposito di oggetti e lucerne sono al terzo , ove s i trova anche la porta d'ingresso che veniva raggiunta mediante una sc ala lignea fis sata alla muratu -
ra o grazie ad una passerella poggiata sulla so mmità dell'ambiente più vicino, come attestato nel castello di Rado presso Gattinara.
Un mensolone di pietra, tuttora in situali' esterno , insieme ad altro frammentario sosteneva il ballatoio di accesso ... Il forno da pane è al quarto piano, con pavimento battuto di malta s u s olaio ligneo soste nuto da un duplice ordine di travi. llluminat o da due finestre e dalle monofore relative al ballatoio che conduce alla sca la in spessore di muratura mediante la quale vi si accede, il locale è dotato di scala a chiocciola per salire su lla copertura s u volta ribassata di cui s i rileva l'imposta.
Vani e servizi lasciano disponibile l'intera s uperficie degli ambienti al terzo e quarto piano , essendo ricavati tutti in spessore di muratura; que s ta era rivestita di intonaco che occludeva i fori pontali , nei quali , peraltro , potevano essere innestati divi s ori per la migliore articolazione dello s pazio interno Il prelievo dell'acqua avveniva dal terzo piano , in pross imità del camino maggiore.
In maniera analoga era s trutturato il donjon di Rocca San Felice, che richiama per le proporzioni quello di Torella più che il torrione di Monte11a, dotato di minor slanc io vertica le a causa del diametro maggiore: 14 m contro i 10 di Rocca San Felice e di Torella.
Nel donjon di Rocca cisterna e deposito occupavano il primo piano; al secondo, illuminato da due monofore , erano il forno-camino , scaffalature a 70
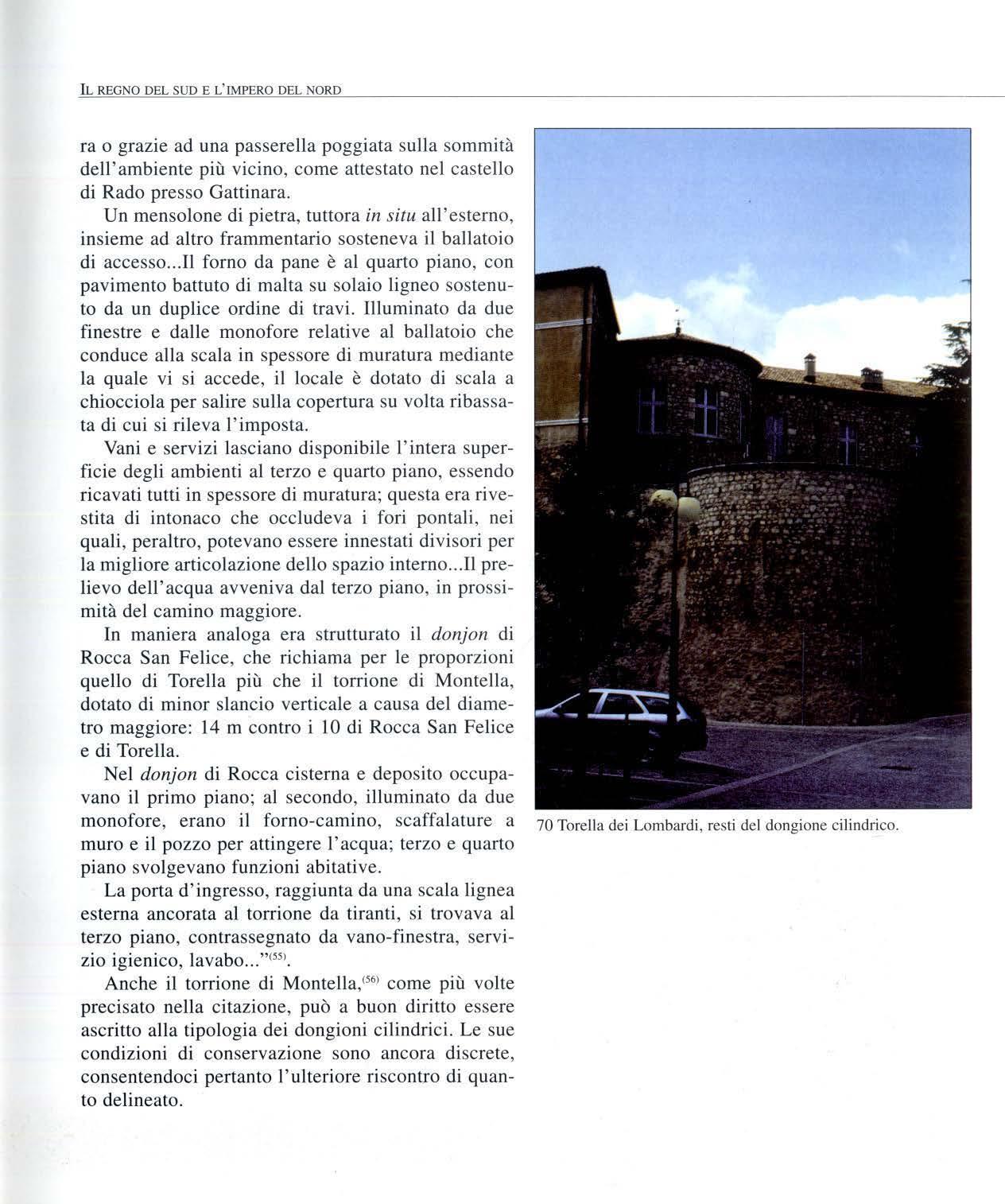
muro e il pozzo per attingere l ' acqua ; terzo e quarto piano svo lgevano funzioni abitative.
La porta d'ingresso , raggiunta da una sca la lignea esterna ancorata al torrion e da tiranti , s i trovava al terzo piano, contrassegnato da vano-finestra , serviz io igienico, lavabo ... "< 55 i_
Anche il torrione di Montella , <56 ) come più volte precisato nella citazione, può a buon diritto essere ascritto alla tipologia dei dongioni cilindrici. Le sue condizioni di conservazione sono ancora discrete, consentendoci pertanto l'ulteriore riscontro di quanto delineato.

Un cospicuo numero di dongioni , in discrete condizioni di conservazione, conseguenza forse del loro sovradimensionamento, si rintraccia in Sicilia. La vistosa maggiorazione deve, probabilmente , ascriversi alla tenace resistenza opposta dai Musulmani alla conquista, che costrinse i Normannj all'adozione di più massicci caposaldi, i soli capaci, durante i loro reiterati contrattacchi, di sostenerne a lungo i violenti investimenti ossidionali. Al di là de11a grandezza la principale d ifferenza tra i dongioni siciliani e quelli continentali consiste in una più articolata e complessa suddivisione interna, ulteriore risultante di quella precisa opzione architettonica: la configurazione parallelepipeda, comunque, permase immutata. Un primo significativo esempio è offerto dal castello di Burgio, eretto a quota 317 in provincia di Agrigento, di cui restano consistenti rude1i, sufficienti a consentirne l'esatta interpretazione strutturale e difensiva.
In dettaglio: " .. .il castello ... è in realtà un saldo palazzo parallelepipedo (spessori murari ca. m. 2 , base m. 20x12 ca ... ) impiantato direttamente su una sporgenza rocciosa, in posizione elevata ed isolata rispetto all'abitato ...L'aspetto esterno è caratterizzato dall'uso di pietra da taglio unicamente nei cantonali e quindi da un'apparecchiatura di pietrame calcareo e tufaceo di piccola pezzatura per le pareti.
In corrispondenza del piano te1Ta non esistono aperture ad eccezione di tre strette feritoie esistenti sul lato di NO ad una altezza di ca. 3 m. dal piano di calpestio, altre quattro sul lato opposto e un angusto e basso ingresso aperto in epoca imprecisata su lato S, vicino lo spigolo SO. La prima elevazione è invece animata sul lato N da un bellissimo portale archiacuto con cornice a doppia ghiera in pietra da taglio, molto simile al portone del piano terreno ... AI portale si perveniva grazie ad una scala appoggiata alla parete ad E della porta stessa: la scala è scomparsa completamente ma le tracce del suo addossamento alla muratura sono evidentis-

o 5 10 m
73 Adrano , planimetria del dongion e.
sime. Sempre s ul lato N e se mpre al piano nobile si ap re, a O della porta, un a finestrell a rettangolare con archìtrave in pietra; un 'altra doveva aprirsi verso E , in corr ispo nde nza di un 'amp ia lacuna nel muro.
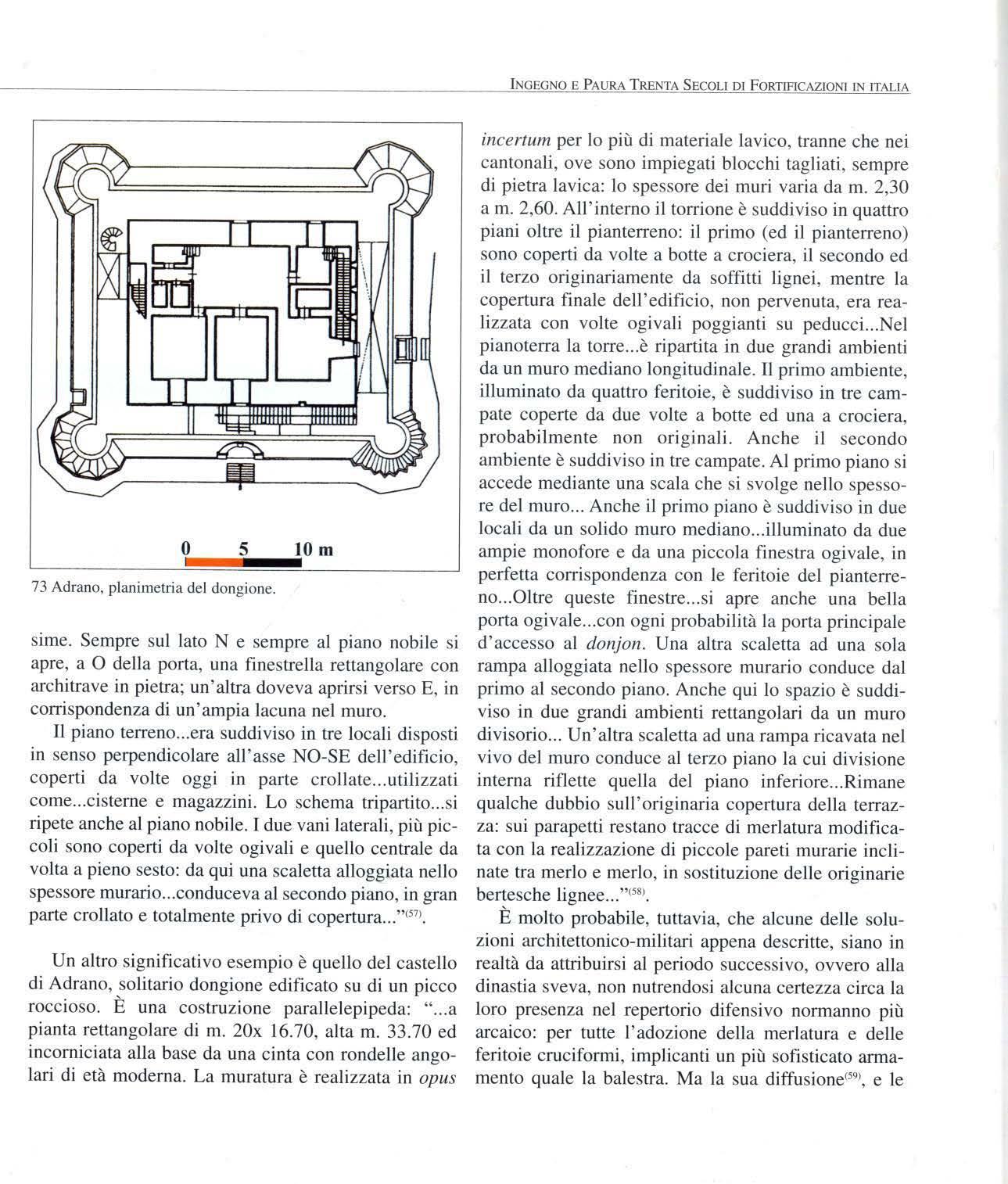
Il piano terre no ...era su ddi v iso in tre loca li disposti in senso perpendicolare all'asse NO-SE dell'edificio , copert i da volte oggi in patte cro ll ate ... utilizzati come c is te me e magazz ini. Lo sc hema tripartito s i ripet e anche al piano nobile . I due vani laterali , più picco li s ono cop er ti da volte ogi va li e quello centrale da volta a pieno ses to: d a qui una sca le tta alloggiata nello spessor e murario ... co ndu ceva al sec ondo pi a no , in gran parte crollato e totalmente privo di copertura ... " <51> .
Un altro sig nifi ca tivo esempio è qu ello del castello di Adrano, s olitari o don g ion e edific a to s u di un picco roccioso. È una cost ru z ione parallel ep ip eda: " ... a pianta r etta ngolare di m . 20x 16 .70, alta m. 33 .70 ed incorniciata alla base d a una cinta con rondelle angolari di e tà moderna. La muratura è realizzata in opus
in certum per lo più di materiale lavico, tranne che nei cantonali, ove sono imp iegati blocchi tagliati, sempre di pietra lavica: 1o sp essore dei muri varia da m. 2,30 a m. 2,60. All ' interno il torrio ne è suddiviso in quattro piani oltre il pianterreno: il primo (ed il pianterreno) so no coperti da volte a botte a crociera, il secondo ed il terzo originari ame nte da soffitti lignei , mentre la copertu ra finale dell'edificio, non pervenuta , era reali zzata con volte ogivali poggianti s u peducci ... Nel p ianoterra la torre .. .è ripartita in due gr a ndi am bi enti da un muro mediano longitudina le. Il primo amb ie nte, illuminato da quattro feritoie , è s uddiviso in tre campate cop erte da due volte a botte ed una a crociera, probabilmente non originali. Anche il seco ndo ambiente è s uddi viso in tre campate Al primo piano si accede med ia nte una scala che si s volge ne llo spessore del muro Anche il primo piano è suddiviso in due locali da un solido muro mediano illuminato da du e ampie monofore e da una piccola finestra ogivale , in perfetta corrisponde n za co n le feritoie del pianterreno ... Oltre queste finestre . ..si apre anche una bella porta ogivale ... con og ni probabilità la porta principale d'accesso a l donjon. Una a Jtra scaletta ad un a so la rampa alloggiata nello spessore murario conduce dal primo al secondo piano . Anche qui lo spaz io è suddiviso in due grandi ambienti rettango lari da un muro divisorio ... Un'altra sca letta ad una rampa ricavata ne l vi vo del muro conduce a l terzo piano la cui divisione interna riflette quella del piano infer iore ... Rimane qualche dubbio s ull 'o ri g inari a copertura della terrazza: su i parapetti restano tracce di merla tura modificata co n la realizzazione di piccole pareti murarie inclinate tra merlo e merlo, in sos titu zio ne dell e originarie bertesche lign ee ... "1581 •
È molto probabil e, tuttavia , c he alcune delle so luz ioni a rc hitetton ico- militari app e na descrit te, siano in rea ltà da attri buirs i al periodo success i vo, ovvero alla dinastia sve va , no n nutren do s i alcuna certezza circa la loro prese nza nel repertorio difen sivo normanno più
arcaico: p e r tutte l 'ado zio ne d ella me rl a tura e delle feritoie c ru c ifonni , impli canti un più sofi sticato armam en to quale la bal es tra . M a la s ua diffu sione<59 > , e le
I NGEGNO E PAURA TRENTA S EC OLI DJ FORTIFI CAZ IONI IN ITALIAconseguenze strutturali , pur essendo senza dubbio cronologicamente congrue, non trovano però, nella prassi bellica normanna, riscontri sufficienti a ritenerle effettivamente avvenute. Pertanto, dal punto di vista operativo , anche i grandi dongioni siciliani appaiono fortificazioni prevalentemente passive , fatta salva una maggiore attenzione per l'ottimizzazione della difesa piombante effettuata dalla loro sommità e, marginalmente, di quella ficcante dalle feritoie. Nell'ipotesi della presenza di merlature esse sarebbero state a filo con le cortine, senza il minimo aggetto: niente del genere però ci è pervenuto.

Va infine osservato che la ricomparsa di una architettura militare realizzata con pietra da taglio e secondo canoni precisi, rappresenta il primo esplicito riscontro del ricordato miglioramento delle condizioni sociali, presupposto ineludibile della fotmazione di un artigianato specializzato e competente.
E fu quasi certamente proprio grazie alla disponibilità di manodopera qualificata e di risorse economiche più consistenti che i Normanni, dopo appena mezzo secolo dalla formazione del regno di Sicilia , poterono cimentarsi in realizzazioni difensive meno elementari dei dongioni. Per gli stessi motivi , del resto, si era già notevolmente evoluta anche la loro procedura ossidionale consentendogli di espugnare fo1tificazioni del genere in tempi brevissimi. Il che, implicitamente decretò il definitivo abbandono dei torrioni isolati, equivalenti a mastodontici sarcofagi. Ma, prima della capacità di costruire strutture più complesse, occorreva disporre della indispensabile conoscenza tecnica per concepirle, esulando il più elementare castello propriamente detto, dalla tradizionale esperienza dei mastri muratori. Ma, appunto in quegli anni, una travolgente iniziativa, la crociata, fornì straordinari stimoli culturali ai principali artefici della coeva architettura militare.
Da tempo la Chiesa si era resa perfettamente conto che la sua predicazione pacifista non riusciva a scalfi-
re minimamente le bellicose consuetudini della società scaturita dalle invasioni barbariche. Tentò allora di canalizzare , e coalizzare , que11e energie aggressive verso finalità che, s e non altro, sarebbero tornate a suo vantaggio. Prese così concretezza il concetto di:
" ... guerra santa , cioè la guerra condotta nell ' interesse della Chiesa, [che] diventò lecita anzi perfino desiderabile. " <60J
Le prove generali della inedita manifestazione polemologica si effettuarono nella penisola iberica, ovviamente contro i Musulmani , a partire dall'avvento del s econdo millennio. Ben presto intervennero direttamente gli stessi pontefici e papa Alessandro II giunse a promettere , nel 1063 , l'indulgenza per tutti coloro che avessero combattuto per il trionfo del cristianesimo nella Spagna. Dal canto loro i sovrani garantivano ai partecipanti il possesso delle terre conqui s tate. Pertanto, attratti dalla duplice ricompensa, innumerevoli diseredati cors e ro ad arruolarsi . Grazie alla incessante disponibilità umana le campagne s i susseguirono, da quel momento , senza soluzioni di continuità, ed alla: " ... fine del secolo XI l'idea della guerra santa era stata così messa in pratica. Cavalieri e soldati cristiani venivano incoraggiati dalle autorità ecclesiastiche a lasciar da pa1te le loro meschine dispute per andare a combattere sulle frontiere della cristianità contro gli infedeli " < 6 1>
La grande ·epopea si concluse nel 1096, ma fin dal 27 novembre dell'anno precedente Urbano Il aveva iniziato a predicare la necessità di indirizzare la guerra santa ad Oriente, per liberare dai Musulmani la mjtica Gerusalemme. E nella primavera seguente la grande orda si mise in moto, senza alcuna precisa meta se non quella di raggiungere, via terra , la biblica città, che nel 1099 fu finalmente, ed atrocemente, espugnata. Pochi anni dopo, con i l rientro dei tanti reduc i, iniziarono pure ad affluire le informazioni sulla cultura degli orientali, sulle loro modalità belliche, sulle loro evolute fortificazioni , e , soprattutto, sui modernissimi castelJi appena ultimati in Terrasanta per radicare la conquista.
È difficile valutare: " quanto i costruttori di castelli crociati abbiano derivato effettivamente dalle
forme orientali e quanto invece sia frutt o di una logica e naturale evoluzione int erna, determinata dalla necessità di fronteggiare ostacoli e pericoli incombenti ... [ di s icurol i primi insediamenti militari crociati utiliz zarono fortificazioni preced en ti, da quelle ebraiche, fenicie e romane a quelle bizantine e arabe, c he adattarono o ri ed ificaron o seg uendone l'andam ento d e ll a cerchia co n torri sporgenti agli angoli e lungo la co rtina ... [inoltre] sappiamo con ce rtezza c he i crociati, così come gli Arabi s i servirono di ingeg neri militari bizantini ed armeni " '"!'. Si trattò,
comunque, di un gra ndi o o addestramento c h e, per la molteplicità delle s ugg estio ni e per l 'i mp e ll enza dei bisogni tattici, dovette formare un considerevole numero di spec iali sti fra i Norma nni Non a caso, co n l'avvento del XII secolo i riferimenti delle fonti a castelli propriamente detti divengono ri corre nti e continui.
Di g raziatamente anche di questa fase, es tremament e s ignifi cat iva della sto ria delle fortificazioni, scarseggiano g li incontrovertibili riscontri materiali, poichè: ·'... per quanto riguarda .. .i cas telli che vanno sotto il nome di « normanni », po ss iamo preci sare che s i tratta , per la quasi totalità dei casi, di attribuzioni destituite da ogni fondamento, dovute, forse, alla g rand e suggestione che l 'avve ntura normanna, protrattasi nel tempo determinò nelle tradizioni popolari " 1631 • Il perc h è di tanta carenza deve ri cercarsi più c h e nella scarsità o ri gi naria di tali co truzioni, nella loro siste mati ca riqualificazione in epoca sveva, co nserva ndo anche a distanza di un seco lo , a differenza degli e lementari dongioni, a n co ra notevoli pot enz iali tà difensive e vale n ze strategiche. D alla sovrappos izion e, in tanti casi talment e ravvicinata cronologicamente che le m edesime ma estranze lav oraro no , sotto entrambe l e din a tie, s ull a stessa co truzion e, derivò una particolare a rchitettura militare s ignifi ca tivamente definita normanno-sveva. Di certo: " .. .i Normanni eressero fortificazioni anche più gran di [dei dongioni], come a Melfi <<>l 1 , dove sorse un a costruzi one a quattro torri , naturalmente di forma ancora molto irregolare ... " <65J ed, altrettanto naturalmente, di ssolta s i nel castello federiciano!

Sebbene operare una distinzione fra le parti normanne e quelle sveve in uno stesso castello risulti, pe r quanto deno, prati camente impo ssi bil e, si posso no veros imilmente attribuire ai Normanni le sez ioni più approssimate e rozze della costruzione che tradiscono un ampio utilizzo dei materiali di spog lio e una minore regolarità
geometiica. E sse, pe11anto , costituiscono, s ia pure con le dovute ampie riserve , un plausibile campione per la nos tra ricerca. Tra gli esempi, senza dubbio più rappresentativi e d emblematici, va annoverata la struttura basamentale del Castello delle Pietre a Capua.
Il curioso nome, infatti, gli derivò dall 'essere stato e dificato co n i grossi blocchi di calcare tratti dal vicino anfiteatro romano, se nza alcuna ulteriore lavorazione al di fuori dell'approssimata posa io opera, prass i que s ta tipicamente barbara; l'impianto planime trico. inve ce, a ppare di gran lunga più complesso ed articolato di quello dei dongioni: entrambe le caratteristiche

sembr ano attag li arsi perfettamente ai primi enigmatici castel li normanni .
DeJl ' intera costruz ione, a l prese nte , co nservano siffat ta con notazio ne so l o il piede di un a cortina ed il co rpo di una torre: su fficienti per ricavare l'adozione di un impianto ortogona le, con ril evante aggetto delle torri quadrate dal fi lo delle cort in e. Tutto il resto deve ascrivers i a i rifacimen ti uccessiv i
P er la s toria la pri ma città che i Normanni fondarono fu Aversa, dove sicuramente av ranno eretto un do ngio ne, magari partico larm e nte e l aborato dal m ome nt o c he le fon ti parlano di un 'castell o'. In r ea ltà, però , il vero caste ll o fu cos truito , alcuni secoli dopo, dagli Arago nes i, e, stando se mpre a ll a tradizione , esattamente al posto de lla fortificaz ione normanna. L e s ue vetuste str utture finirono quindi s pianate o inglobate in ess o , impedendoci ogni ulte riore accertame nto
Non può escluders i, però , c he s ta bili zzatasi la loro presenza s ul territorio i Normann i abbiano ve ramente ed ificato un cas te llo, m agari in ad iace nza del primitivo torrione . Parim e nti probabile è che l o ab b iano e r etto ne i p aragg i, per l ' id e n tica ragione: di sicuro a Casa luce, non l on ta no da Aversa, s i rintracc iano i ruderi di un cas tello c he vie ne a ppunt o fatto risal ire all'in iz iativa normanna , a lmeno ne ll a s ua orig in ar ia impo staz ione e sempre co n le g ià es poste ri serv e. Stando alla tra di zio ne, p eraltro non priva d i fo ndame nto, i me rcenari no rmanni innalzarono una fo rtifi cazi one, nel casale denominato di Casa]uce, cedutogli probabilm e nte quale com pe nso.
P er il re sto, poichè: " ... poco o null a s i sa de l Caste ll o normanno di Av e rsa no n è poss ibile far e raffronti tipologici verifi cando un' eve ntu a le affinit à cos truttiva fra le du e re alizzazioni .! rim a negg iame nti de i seco l i s uccess ivi poco consen to no di definire , relati vame nte ai cara tte ri arc hite tto n o n ici certa m e nte ascrivi bili a i signo ri normanni 11 Cas te llo d i Casa lu ce è .. .s u pia n ta ri gidamente quadra ta, co n un a struttura
molto poderosa rafforzata da q uattro grosse torri angolari anch'es se quadrate , ancora vi s ibili.
L ' orientamento è Nord-S ud e parallelo ai tracc iati della ce n t uri azione s ul cui limite orie nt ale v iene a trovarsi ... In torno al cas tello , in gran parte seco ndo l ' andam e nt o de l perimetro della centuri a, si sv iluppa una seco nda ci nta muraria a protezione dell'in se diamento agrico lo , me no poderosa ma a ncor oggi perfettame nte legg ibil e. Attualmente una de lle s ue porte, molto rimaneggiata , dà ancora accesso a ll 'area del castello.
D opo la distruzione d e l 1135 il Caste11o rimase a l ungo in stato di abbandon o ... "l66> .
In base a ll e struttu re s up e rs titi è difficile ascrivere il ca te Uo a Jl a prima fase dell 'e popea normanna: i rud e ri se mbrano infatt i attribuibili a un rifacimento molto tardivo della p rimi ti va fortificazione, c he potrebbe essere a ddirittura una ri costruzio ne sveva d i c ui prese nta tan te ana logie arc hitett onic he .
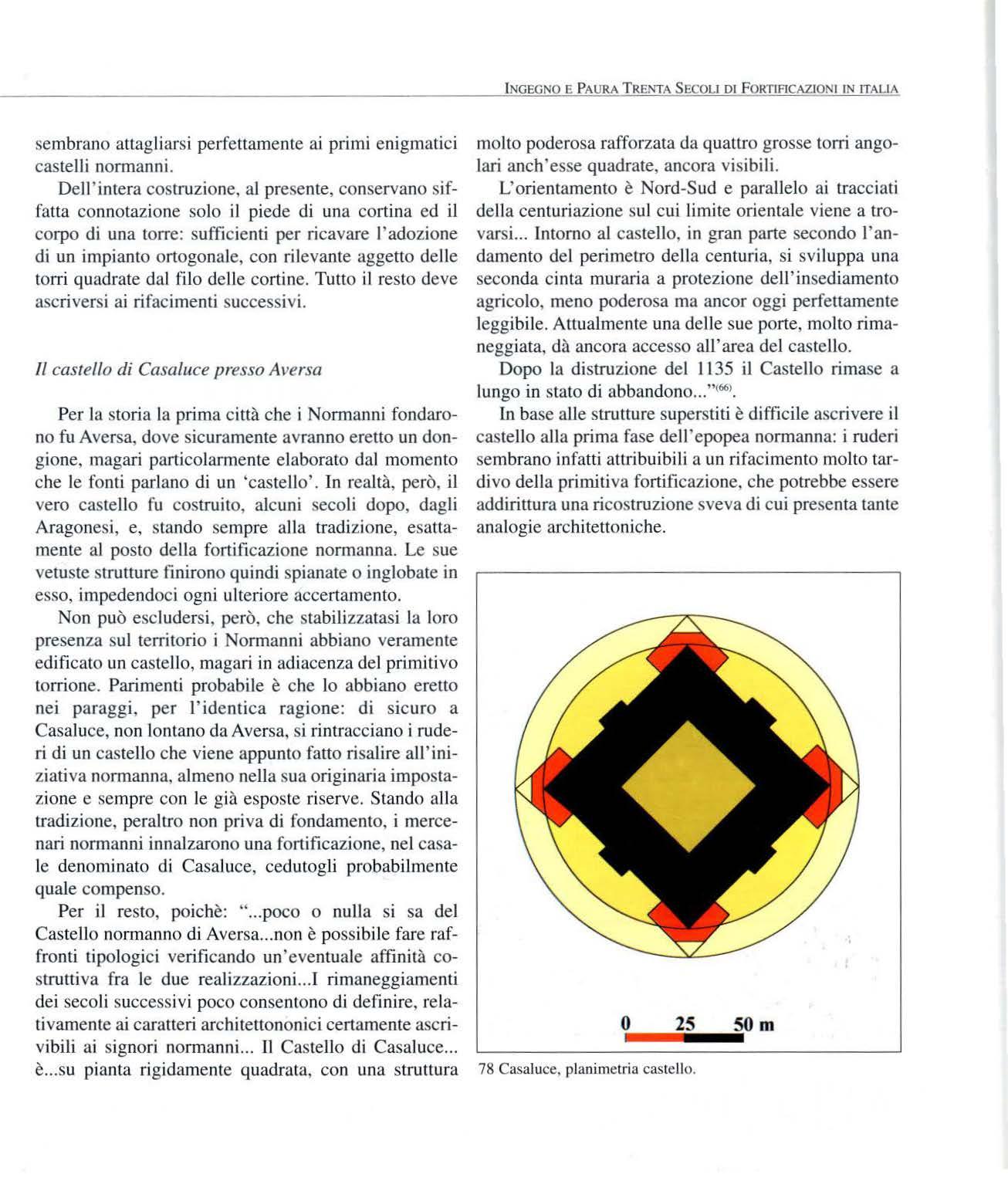 lNGEGN O E P AURA TR ENTA S ECOLI DI F ORTIFICAZI ON I IN ITALIA
lNGEGN O E P AURA TR ENTA S ECOLI DI F ORTIFICAZI ON I IN ITALIA
Ne l frattempo es tintas i la dinastia sassone, su bentrò in Europa central e con Corrado II, pro nipote di Ottone I per linea femminile, quella salica che si protrasse fino al 1125 co n a l tri tre imperatori , dei quali l'ultimo fu Enrico V, ch e reg nò tra il 1106 -1125. Dopo l a s u a morte , quando la s uc cess ion e e red itaria se mbra va orm a i definitivamente a ttecc hita anche in Germania, quella elettiva eb be un v i goroso ritorno, portando al trono Lotario di Supl imbu rgo, strettamente imparentato con la famiglia dei W elf da c ui i Guelfi preferendolo a Federico di Svevia, a sua vo lta co n sa n g uin eo del defunto imperatore , non chè suo esecutore testamentario e d e re d e d e i po ssed ime nti privati. Ovvi amente ques t ' ultimo, spalleggiato dal frate llo Corrado, non accettò p ass ivam e nte tale designazione ed i mpug n ò ]e arm i contro l 'e le tto in una guerra s pietata, guerra che s i concluse, n e ll a s ua prima fase, co n il successo di Lotari o. Le ostilità, però , non cessaro no , sebbe n e per lun go tempo, nessuna delle due casate di sponesse de11e forze s uffi cie nti ad e liminare definitivamente quella rivale.

Ancora dopo l'ascesa a l tro n o di Corrado III (1138-1152), fi g lio di Federico dj Svevia, quel tragico s tallo permase immutato, co n i Sassoni fortemente attaccati al partito guelfo ed altrettanto irriducibilmente o s tili agli Svevi.
Nel 1142, fina lmente, tra le oppo s t e fazioni fu raggiunto una so rta di accordo per impedire il protrarsi delle ostilità fratricid e che, in pratica, so ltanto l'a scesa al trono nel 1152 di Federico I, meg lio n oto c ome Barbarossa, valse a dirimere. Quel felice, quanto ormai in s perato , esito dipese dal semplice motivo che il nuovo so vrano e ra di sce ndente , per parte materna, dalla famiglia guelfa, consanguineità c he g li consentì, grazie anc he alla lunghi ss ima durata del s uo regno , ben 38 an ni , di riunificare il re s iduo e dilaniato Impero. A contendergliene, però, 1' in co ntra s tato dominio restavano disgraz iatamente ancora almeno tre grossi nuclei di re s iste n za, emblematicamente tutti concentrati in Italia: a nord i liberi Comuni lombardi , al centro lo Stato pontificio e d a sud il Re g no normanno.
Quanto fosse temibile tale avvers ione eb b e modo di sperimentarlo nel 1155, a ll 'indomani della sua incoron az ione in Roma , allorquando l'intera popolazione gli s i scatenò co ntro. Tre anni dopo, fu la vo l ta di Milano e dei co muni lombardi. La reaz io n e imperiale fu v i olentissima e brutale. Cre ma dopo un assed io, protrattosi p er sette mesi, fu d ata alle fiamme nel 1160. Milano resistette più a lungo, ma nel 1162 dovette capitolare, co n la pop o l azione decimata dalla peste e dalla fame . Le s u e mura ve nn ero sp ianate, gli abitanti dispersi: secondo la tipica prassi medievale, però, appe n a cinque anni dopo, erano di nuo vo in grado di difendere la c ittà, minacciata dal poderoso esercito co n cu i Federico era ridisceso i n Italia, deciso a farla finita una volta per tutte con i s uoi irriducibili nemici, in particolare co n R o m a perno id eologico e co n la Sicilia perno economico La fortuna dapprima l o favorì, consen tendogli di assalire p ersi n o San Pietro, ma improvvisame nte gli si rivo lse co ntro . Una terribile ed inarrestabile epidemia scoppiata tra l e s ue truppe, nella ca l ura estiva, lo lasciò, nel giro di pochi g iorni , praticamente inerme all a mercè dei suoi tanti nemici. Il rientro in German ia si trasfo rmò , allora, in un a disperata fuga, sostenuta sol tanto dai propositi di una vendetta, c h e nel maggio del 1176, parve finalmente a portata di mano. Il 29, infatti, le forze della Lega Lombarda si op posero a que11e imperiali n e i pressi di Legnano. L e due formazioni: " si confrontarono in una battaglia co mb att uta fino allo stremo da entrambe le parti Dapprima se mbrò che avessero l a meglio i tedeschi; la loro cavalleria pesante spezzò le prime file dei lombardi , gettandoli nella confusione. Ma l'as salto d e i t e d esc hi dov e tte arrestarsi intorno al Carroccio , non riu sce ndo ad infrangere l a resistenza di s perata di un pu g no di e roi che difendevano il punto centrale del lo ro sc hieramento ... Federico cercò invano di incoraggiare l e sue trupp e gettandosi in mezzo alla battaglia con il suo abituale coragg i o. Ne ll a mi schia ... venne di sarcio nato e sparì alla vista, in mezzo alla co nfu s ione e al g ro v iglio dei combattenti. L a sconfitta de i ted eschi fu total e e le loro p erdite immense Federic o incontrò molta diffi col t à p er ragg iun ge re
Pavia con il resto del suo esercito. Aveva combattuto e perso , e sarebbe stato folle pensare che i tedeschi lo avrebbero seguito se avesse tentato una rivincita ... " 1 <> 7 )

Fu giocoforza per l'imperatore, a quel punto sottomettersi, all'autorità papale, accettando, il 23 luglio del 1177, la pace, nonchè una tregua di quindici anni con la Sicilia ed una di sei con i Lombardi. Nonostante la residua diffidenza ben rappresentata da quel modesto intervallo, i suoi rapporti con i Comuni lombardi conobbero un repentino vistoso miglioramento. Nei giorni successivi, dopo il ritiro della scomunica, Federico si intrattenne affabilmente con gli ambasciatori siciliani, evidenziando gli interessi comuni che li legavano e che potevano costituire le basi per una vera alleanza. Forse si trattò dei prodromi di una politica meridionalistica in vista di futuri coinvolgimenti: di certo nel 1186 suo figlio Enrico VI si unì in matrimonio con Costan za d 'A ltavilla, figlia postuma ed erede unica di Ruggero II re di Sicilia. Molti aspetti di quel singolare matrimonio apparvero anche all'epoca stupefacenti se non incredibili, in particolare: " ... le tarde nozze di lei, più che trentenne, col figlio del Barbarossa, di circa dieci anni più giovane, e, dopo nove anni di infecondità, in età già matura, l'inatteso concepimento di un figlio ... "(68 >
Il 26 dicembre del 1194, nasceva ad lesi , paesino della Marche , Federico , il figlio di Enrico VI di Svevia e di Costanza d'Altavilla. Il giorno precedente s uo padre era stato incoronato, nella cattedrale di Palermo, re di Sicilia169> . Ma iI clima dell ' isola ebbe effetti nefasti sul giovane sovrano, stroncandolo nell'arco di appena tre anni. Alla sua vedova ed al neonato pervenne, così, in pesantissimo lascito, un impero immediatamente sconvolto da una itTiducibile anarchia. A peggiorare la situazione sopravvenne, a pochi mesi di distanza, anche la scomparsa di Costanza. ln quanto erede deU'impero svevo, essendo il secondo della casata con tale nome, fu Federico II imperatore, in quanto erede del regno nor-
manno essendo invece il pnmo, fu Federico I re di Sicilia<10 l. In quanto uomo, però, era soltanto un piccolo orfano di appena quattro anni, virtualmente a capo di un immenso ma agonizzante Stato, se nza nessuno che conc retamente si prendesse cura di lui. La madre, intrisa di un profondo odio antigermanico, aveva tentato, in quei pochi anni, di tener lontano il figlio dallo scettro imperiale, reputando che il so lo regno di Sicilja l'avrebbe ampiamente appagato, facendoglielo dimenticare senza alcun rimpianto. Si spiega così la sua incoronazione a re dell'isola all'età di appena due anni, il giorno di Pentecoste del 1198.
Mai come in quel caso, i desideri di Costanza trovarono una perfetta rispondenza nella Curia romana, per la quale la Sicilia restava pur sempre un feudo del papa. Eliminare, infatti , un imperatore ge1manico, discendente da una dinastia not01iamente indocile, per trasfo1marlo in un modesto sovrano siciliano, sostanzia lmente vassallo, rappresentava un'allettante prospetti va. Pertan to, proprio nell'anno in cui morì Costanza, il pontefice, constatata la situazione di completa anarchia dell'isola , nominò un collegio di quattro vescovi per ristabilirvi un minimo di legalità. Nel frattempo in Germania nessuno più si 1icordava dell'esistenza del piccolo rampollo degli Staufen: illegittimamente la corona era stata presa da Filippo di Svevia, fratello di suo padre.
L 'i nfanzia di Federico, ormai abbandonato a Palermo, da quel momento, divenne tragica: " ... nel castello, nessuno sembrò più occuparsi del bambino; i beni reali anzi furono così male amministrati, che egli si ritrovò letteralmente alla fame. I palermitani, mo ss i a pietà, s i presero cura di lui e lo nutrirono, chi per una settimana, chi per un mese, a seconda delle possibilità loro Libero da ogni sorveglianza, vagava pei vicoli del mercato [affollati] di gente tutta presa dagli affari: normanni, italiani, saraceni, tedeschi, ebrei, greci.
Suoi maestri, il mercato e i vicoli di Palermo: la vita stessa i nsomma ... Secondo il diritto feudale siciliano il re diveniva maggiorenne al compimento del quattordicesimo anno d'età ... [per cui] il 26 dicembre del 1208 .. il papa depose la tutela e da quel giorno
lNGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIACAZIONI fN ITALIAFederico governò da solo ... " <11 > . Per una singolare coincidenza pochi mesi prima, nel giugno, suo zio Filippo era stato ucciso a Bamberga: oltre al trono di Sicil ia il ragazzo si ritrovava così, più che mai, erede del grande Impero, unico Staufen in vita. La nomina ad imperatore lo raggiunse in Sicilia, nel 1212: unanimamente tutti i più fidi vassalli, ed in particolare la moglie Costanza d'Aragona, cercarono di distoglierlo dal!' accettare la carica, senza però trovare ascolto. Del resto, non si ha notizia di alcun serio legame tra i due coniugi, unitisi in matrimonio, due anni prima, probabilmente soprattutto perchè la sposa, una matura vedova, portava in dote 500 cavalieri spagnoli, peraltro subito sterminati da una violenta epidemia. Crollata l'illusione di poter contare su quel prezioso strumento militare, al giovane sovrano non restava alcuna speranza di infrangere la miriade di privilegi baronali, spesso abusivi, che minavano il s uo potere. Allora, forse, confidando nella maggiore simpatia che l a sua origine dinastica gli assicurava in Germania, dovette sembrargli più praticabile iniziare proprio da lì il suo percorso imperiale. Dopo un viaggio particolarmente lungo ed irto d'insidie, alla fine dell'anno riuscì a ricevere a Francoforte, la corona imperiale, che gli venne riconfermata nel 1215 dal grande Concilio Laterano.
Nel corso di quel lungo soggiorno ebbe modo di stringere saldi legam i con due grandi istituzioni che in seguito gli si sarebbero rivelate prezioso supporto di governo: l'Ordine Cistercense e quello dei Cavalieri Teutonici (72> In particolare con il secondo si dimostrò straordinariamente liberale e munifico, ufficialmente in funzione di una imminente crociata, in realtà per: " guadagnarsi la parte migliore dei cavalieri tedeschi per impiegarli in altri comp i ti. Così Federico si creò un piccolo esercito libero da gravosi obblighi feudali, indipendente da influenze esterne (venissero da principi laici o ecclesiastici), e assolutamente fedele e sottomesso (sottoposto com'era al papa solo nelle cose della religione). Questo ben presto divenne la sua spada e la sua arma. " <73> Assicuratasi, con abili mosse politiche la Germania, ottenuta una dilazione per la crociata e la
conferma a vita del regno di Sicilia, fu incoronato solennemente imperatore a Roma il 22 novembre del 1220. A questo punto disponendo ormai di una discreta forza militare, Federico potè, finalmente, dedicarsi a riorganizzare l'Impero a partire proprio dalla sua diletta isola.
In sostanza, il modello di Stato che Federico per anni aveva attentamente studiato e che si accingeva a concretizzare in Sicilia , assunta a significativo banco di prova, consisteva in una rielaborazione in chiave assolutistica dell'Impero romano, con una strnttura gerarchizzata, leggi ben precise e con al vertice un sovrano assoluto. Il 15 dicembre Federico giun se a Capua, dove fece una fondamentale tappa, re sasi necessaria per promulgare un editto in venti capitoli , nucleo primario della sua concezione istituzionale. Il dettaglio che: " queste leggi fossero già pronte in ogni minimo particolare e che egli abbia colto l'occasione per renderle pubbliche nella prima città del Regno nella quale potè far sosta, dimostra con chiarezza con quanta impazienza egli avesse atteso quel momento, nonchè la sua determinazione di portare in patria ai suoi sudditi la poco gradita novella che l'epoca dei fuorilegge e dei predoni era finita e che in futuro essi avrebbero avuto a che fare con un re che intendeva regnare di nome e di fatto. " (74 >
Pertanto: " ... a capo di tutta l'amministrazione egli mantenne i sette grandi ufficiali del regno normanno .. . Questi costituivano il consiglio della corona e da essi dipendevano gli ufficiali minori, i giustizieri provinciali, i giudici, i notai, i maestri camerari, i procuratori del demanio, i collettori, i tesorieri.
L'amministrazione della giustizia criminale era tolta completamente ai baroni e questa disposizione, insieme con la protezione accordata ai vassalli ... costituiva un fiero colpo per la feudalità. L'esazione delle imposte era completamente riorganizzata , quantunque sotto Federico , per la necessità stessa della s ua
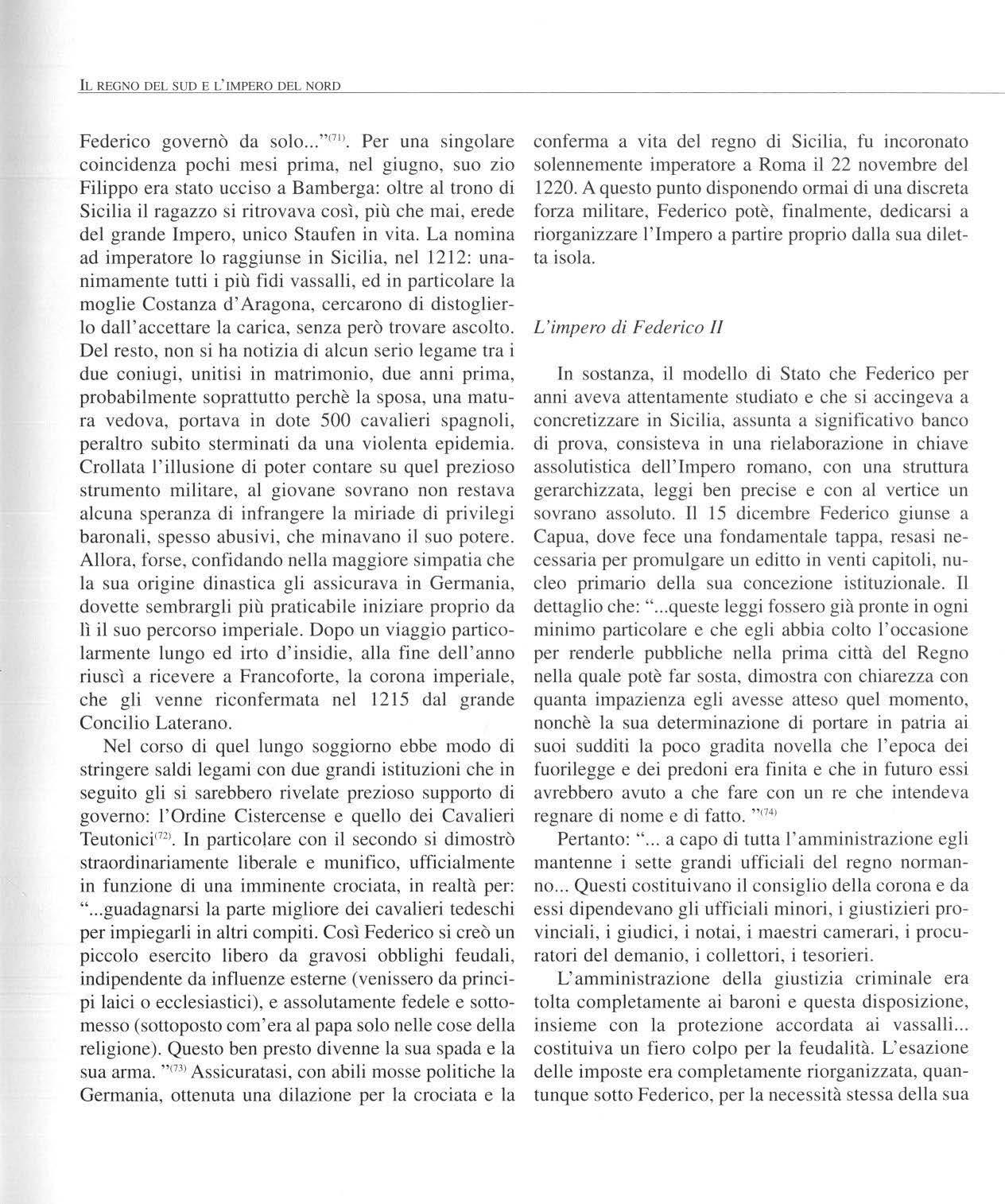
politica, la pressione tributaria si mantenesse molto elevata " <75 > _ E, per annientare le residue resistenze dei baroni più irriducibili, l'iniziativa che a Federico parve risolutrice consistette nel revocare gl'innumerevoli privilegi nobiliari non giustificati, espropriando, o demolendo, i castelli abusivi. Non a caso fra le norme promulgate a Capua ve ne era una: " ... diretta espressamente contro i baroni, nella quale si s tabiliva che ogni castello o fortilizio costruito dai vassalli negli ultimi trent'anni dovesse essere consegnato alla corona o distrutto: poich è anche il diritto di costruire postazioni difensive emanava dal signore, onde ai vassalli era stato sempre proibito di edificare castelli fortificati, fosse pure nei loro feudi. Anche qui il sovrano rivendicava un antico diritto. "t16>
Che tale diritto fosse antico risulta anche da quanto a suo tempo riferito su l feudalesimo lon gobardo, ma che, in pratica, fosse stato sempre disatteso, in specie dopo l'arri vo dei Normanni, risulta altrettanto incontrovertibile. La deliberazione di Federico li , quindi, ribadendo la mai abrogata remota disposizione, veniva , finalment e, a mettere ordine in un settore quanto mai arbitrario e fonte di arbitrarietà. Sebbene la concezione di fortificazione demaniale si ravvisi già nella precedente dominazione, l'averla trasformata da eccezione a prassi canonica rappresenta, per molti aspetti, l'atto di na scita dello Stato nella modernità dell'accezione. Più in generale, se fino ad allora l 'onere della difesa era stato assolto anche con un ampio ricorso alle iniziative private, talvolta tollerate talaltra addirittura incentivate, ma mai rinnegate perchè abusive, da quel momento esso rientrò nelle esclusive prerogative dello Stato, unico detentore legittimo della forza armata; ogn i deroga , peraltro asso l utam en te straordinaria, avrebbe dovuto essere esplicitamente autorizzata. Per cui: " ... parallelo alla statalizzazio ne di nobiltà e cavalleria fu un altro nuovo provvedimento: per la prima volta, d'ordine di Federico, numeros i castelli, rocche e manieri passarono alle dirette dipendenze della corona: le fortificazioni non servivano più a difendere il singolo feudatario bensì tutto
lo stato: furono più di duecento i castelli incamerati, tanto che Federico dovette creare un nuovo corpo di funzionari che soprintendessero a questo 'orga ni smo per la dife sa de] paese', vigilando sull'a mmini strazione e manut enzione dei castelli, sceglie nd o impiegati adatti allo scopo e occupandosi delle spese ge nerali
In tempo di pace, co ntrariam ente all'uso di quello e d'altri tempi, i castel1i non avevano presidio alcuno, ma al massimo, un castellano e un paio d'armati; in tempo di guerra invece, i feudatari e gli abitanti dei dintorni, come già avevano contribuito all'edificazione e alla manutenzione del castello, dovevano, secondo i loro obblighi e per ordine dello stato, fornirlo d'un presidio e sostenere le spese del suo mantenimento.
S'attuava così una s pecie di difesa nazionale ... piano unico nel suo genere per il quadro unitario con cui era stato matematicamente pensato " <77l
Circa l'istituzione, intorno al 1230, di funzionari addetti al con trollo dei castelli, definiti Provisores castrorum, va aggiunto che si rifaceva, molto probabilmente, ad analoghe cariche esistenti in Provenza e precedentemente, come ri s ulta da documenti pervenutici, già adottate dai Normanni. Nella più antica commissio, 1230-31, infatti, si legge:
"
.illa eciam castra, que reparacione videbitis indige re faciati s ab illis districtione , qua convenit, reparari , a quibus tempore bone memorie regis Gulielmi secundi consobrini nostri, fieri consuevit..." '1si .
Per quanto è possibile accertare i compiti di tali funzionari consistono in:
1° - Sorveglianza delle armi, armamenti e vettovagliamenti dei castelli.
2 °- Presidiare, con numero s ufficiente di armati i castelli.
3°- Pagamento del so ldo agli armati.
Nel 1239 viene riorganizzato l'Ufficio dei Provisores castrorum e contemporaneamente viene istituita la carica
 INGEGNO E PA U RA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITAUA
INGEGNO E PA U RA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITAUA
di Collettores per gli incassi della corona e vengono nominati nuovi Justiciari in tutte le provincie. Le zone di attività dei vari Collettores sono d'ora in poi le stesse dei rispettivi Provisores e questa suddivisione in zone dello Stato permarrà poi, all'incirca identica, sino alla fine del Regno di Carlo I... "( 79 >_
Un'ultima annotazione deve necessariamente riguardare i presidi abituali di quei tanti castelli. Innanzitutto va rilevato che la statalizzazione non eliminò completamente, almeno sotto il profilo amministrativo, l'esistenza di castelli feudali, per cui le due tipologie confluiscono in due distinte classi, ovvero i: " .' castra exempta' e 'non exempta'; al presidio dei primi provvede lo Stato mentre a quello dei secondi pensano i feudatmi. Poichè molti castelli passano continuamente da una categoria all'altra e poichè il ricordo delle antiche tradizioni per le quali tutti i castelli erano guardati da feudatari, non è ancora spento, regna nella organizzazione delle guarnigioni una grande confusione.

Troviamo, nello stesso castello feudatari e al loro servizio serventes pagati dallo Stato. Si ema nano disposizioni in base alle quali alcuni feudatari debbono abitare colle loro famiglie nei castelli, mentre altri contribui sco no con un servente per ogni 20 once di valore del proprio feudo. Quelli che non hanno un feudum integrum, (cioè il cui fondo ha un valore inferiore alle venti once) si debbono riunire e contribuire con quota parte proporzionale per fornire al castello un servente per ogni venti once di valore cumulativo.
Nell'ambito del castello ogni feudatario deve avere una casa nella quale depositare, all'epoca del raccolto, le provviste, e riporre le armi e i cavalli che è obbligato a fornire onde mantenere in efficienza le difese del castello ... " <~0> In ogni caso, gli uomini destinati alle gum·nigioni sono complessivamente pochi, mediamente tre o quattro al massi mo per castello: sappiamo da precisi riscontri documentari che il loro totale per provincie era così distribuito:
A capo dello scheletrico presidio stava un castellano che: " ... alla fine della dominazione normanna ed al principio di quella sveva era il padrone del castello, con poteri assoluti amministrativi e militari, agli ordini del Sovrano; seno nch è col progredire d e11 'organizzazione dello Stato egli non conserva ch e il nome e deve rinunciare a tutte le prerogative della sua carica per passarle ai funzionari nuovamenle istituiti: Provisores, Ju sticiari, ect ...
Il Castellano ai tempi normanni e nei primi anni del regno di Federico viene nominato dal Re; dopo l'istituzione dei Provisores castrorum la nomina viene effettuata da detti Provisores , salvo che per i 'castra exempta' che dipendono sempre dal Sovrano ...
li Castellano viene investito della carica con una commissio che ... ha due sottospecie:
a) '.forma de custodia'
b) 'forma quod recipiat' (cioè ordine di prendere in consegna dal predecessore tutto, nello stato in cui si trova).
Il Castel1ano viene rimosso dalla carica con la 'forma quod desistat et assignet' (cioè ordine di cessare dalla carica e consegnare il castello e appartenenze al successore).
Al Castellano sono date inoltre le patentes ed è nominato 'usque ad heneplacitum nostrum' ... generalmente restano in carica a lungo ... Le paghe amrnontano ... prima del 1278: per il Castellanus miles a 2 tarì al giorno ... c ioè annue oncie 24 e 10 tarì; per il
Castellanus scutifer ... a I tarì e 4 grani al giorno ... cioè annue oncie 14 e 18 tarì...
I compiti ed i doveri del Castellano sono.
- sorvegliare il castello;
- non abbandonare il castello per nessun motivo;
- non portare armi fuori del castello se non per ordine e servizio del Re;
- curare la munutenzione delle vettovaglie e delle armi;
- (prima del 1239) provvedere al pagamento dei soldi e stipendi;
- (dopo del 1239) assistere solamente a questi pagamenti;
- originariamente esercitare la sorveg lian za sulle vigne, frutteti, mulini, terre, ecc. di pertinenza del castello
- prendere patte delle commissioni istituite per periziare l'ammontare dei lavori di manutenzione. " < 8 1> .
Sebbene già nell'ultima fase del regno normanno fossero state edificate strutture difensive che, come precisato, possono senza alcun dubbio ritenersi dei veri castelli e non più delle semplici fortificazioni, fu con Federico II che siffatte costruzioni attinsero il loro apice funzionale e la loro razionale definizione architettonica. In esse ben poco venne lasciato alla discrezionalità ed alla originalità del progettista, vincolandolo a rigidissimi valori dimensionali plano-altimetrici e ad altrettanto precipui canoni estetici.
Il castel1o, nella logica federiciana, costituiva un' opera militare, con una sua precisa valenza tattica che, però, unitamente ai suoi analoghi disposti secondo un predeterminato scacchiere, perseguiva anche finalità strategiche, difendendo il territorio ed appoggiando l 'ese rcito imperiale nelle sue campagne. Infatti: " una rete ben collegata di castelli o più semplicemente di punti d'appoggio ben fo1tificati sarebbe stata un'ottima garanzia per il controllo e il dominio del meridione. E a tale scopo Federico si dedicò con tutte le energie,
come attestano la lettera di Tommaso da Gaeta e gli esempi eloquenti che ci rimangono. Po ssed iamo in proposito una serie di false interpretazioni s ulle proporzioni e i tempi rapidi di questa particolare attività edilizia, che hanno suscitato idee assolutamente non fondate.
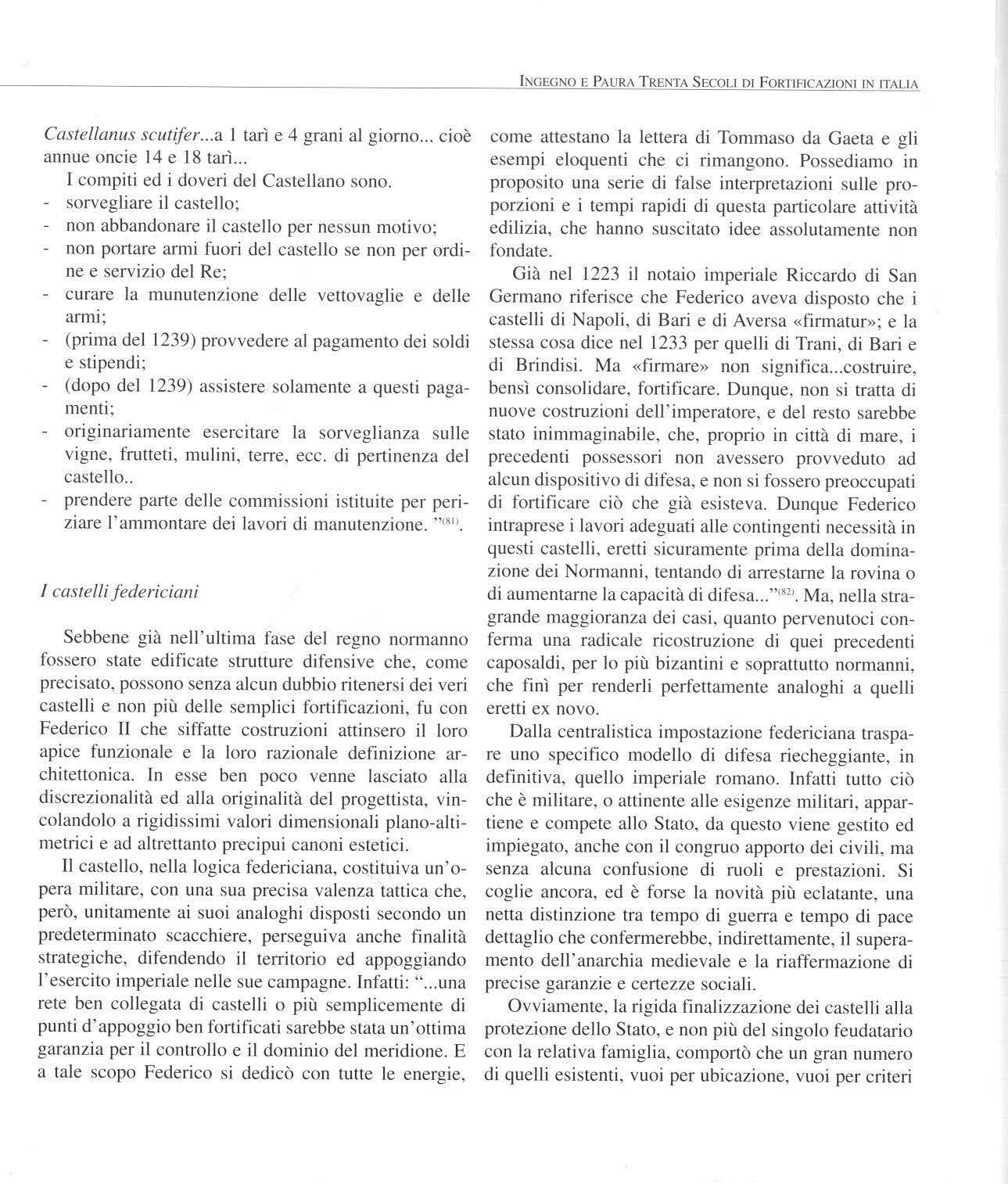
Già nel 1223 il notaio imperiale Riccardo di San Germano riferisce che Federico aveva disposto che i castelli di Napoli, di Bru·i e di Aversa «firmatur»; e la stessa cosa dice nel 1233 per quelli di Trani, di Bari e di Brindis i. Ma «fi rmare >> non s ignifica costruire, bensì consolidare, fortificare. Dunque, non s i tratta di nuove costruzioni dell'imperatore, e del resto sarebbe stato inimmaginabile, che, proprio in città di mare, i precedenti possessori non avessero provveduto ad alcun dispositivo di difesa, e non si fossero preoccupati di fortificare ciò che già esisteva. Dunque Federico intraprese i lavori adeguati alle contingenti necessità in questi castelli, eretti sicuramente prima della dominazione dei Normanni, tentando di arrestarne la rovina o di aumentarne la capacità di dife sa... " 1821 • Ma , nella stragrande maggioranza dei casi, quanto pervenutoci conferma una radicale ricostruzione di quei precedenti caposaldi, per lo più bizantini e so prattutto normanni , che finì per renderli perfettamente analoghi a quelli eretti ex novo.
Dalla centralistica impostazione federiciana traspare uno specifico modello di difesa riecheggiante , in definitiva , quello imperiale romano. Infatti tutto ciò che è militare, o attinente alle esigenze militari, appartiene e compete allo Stato, da questo viene gestito ed impiegato, anche con il congruo apporto dei civili , ma senza alcuna confusione di ruoli e prestazioni. Si coglie ancora, ed è forse la novità più eclatante, una netta distinzione tra tempo di guerra e tempo di pace dettaglio che confermerebbe, indirettamente , il superamento dell'anarchia medievale e la riaffermazione di precise garanzie e certezze sociali.
Ovviamente, la rigida finalizzazione dei castelli alla protezione dello Stato, e non più del singolo feudatario con la relativa famiglia, comportò che un gran numero di quelli esistenti, vuoi per ubicazione , vuoi per criteri
I NGEGNO E PAURA TRENTA SECOLl DI FORTIFI CAZIONI IN ITALIAarchitettonici, vuoi per impianto strutturale, risultasse assolutamente superfluo od inadeguato, causa di onerose manutenzioni e, per giunta, potenziale centro di ribellione. Per contro, molti siti strategicamente basilari, nella nuova prospettiva di difesa nazionale , apparivano pericolosamente sguarniti e vulnerabili. Per i primi, perciò, fu decretata la radicale demolizione mentre nei secondi, si pose mano, freneticamente, alla edificazione di castelli standardizzati. È estremamente probabile che la dirigenza federiciana, di risaputa razionalità e d'inusitata solerzia, non disgiunte da una pars imoniosa amministrazione delle finanze, avesse già da tempo elaborato per quel grandioso programma un modello base di castello, perfettamente calibrato alle precipue esigenze militari. Infatti: " ... è da notare un'altra importante conseguenza del passaggio dei castelli da feudali a statali: con l'edificazione di nuovi castelli ... s' inaugurò un nuovo s tile architettonico ...
potevano essere costruiti come i castra romani, secondo un s istema unico, con poche varianti, il quale anche esteriormente, offri va il massimo di semplicità e sobrietà matematiche: un quadrato di pietra con una torre in capo a ogni lato. Nessuna concessione all'adattamento ambientale: i castelli di Federico II seguono una loro logica e non più quella del terreno ... " (83>
Più precisamente, nel modello di castello introdotto da Federico II: " ... si nota, comunque, uno stile del tutto unitario .. .i castelli, in quell'epoca sorgevano adeguandosi alle condizioni naturali del terreno ed assumevano, spesso, una particolare caratteristica dovuta proprio a tale stato di cose; ciò non avvenne per le fabbriche imperiali che furono, invece, rese il più possibilmente indipendenti dalla particolare configurazione del terreno e, anche, quando i castelli furono impiantati su alture, si cercò sempre di preferire luoghi che permettessero di mantenersi fedeli al modello prestabi 1ito. Si ebbe un rinnovamento della morfologia dovuto, infatti, ad un progetto studiato in tutti i dettagli e dettato dalle esigenze per le quali contavano molto le esperienze fatte dall'imperatore durante le crociate in Oriente... Questi castelli presentano nel loro
impianto una regolarità matemati ca ed una c hiarezza di linee rette con volumi che si articolano su pianta quadrangolare o rettangolare, con quattro ali munite di torri cilindriche o poligonali in corrispondenza d egli angoli .. .''' 84 > .
Nella matrice architettonica di s iffatti caste lli per alcuni stu dio si è evidente l'influsso: " ... di quelli dell'Ordine dei Cavalieri Teutonici in Prussia, che hanno tutti lo stesso impianto, lo stesso stile, servendo agli stessi sc opi di quelli del mezzogiorno d ' Italia , e dipendenti dallo stato anch'essi ... " ' 85 >
Il concetto informale della fortificazione su pianta quadrata con quattro torri ammorsate ai vertici e fuoriuscenti dal filo delle cortine intermedie, lo abbiamo già incontrato esaminando le estreme produzioni imperiali romane, nonchè alcune ville ru s tiche del III -IV secolo. Lo abbiamo pure intravisto fra i più complessi castelli normanni, per i quali si sono ipotizzati apporti crociati . Nel caso di quelli federiciani, però , tale riproposizione planimetrica, certamente vagliata e ponderata per fini meramente difen sivi, cela qualcosa di più di una semplice affinità casuale, o di una pedissequa imitazione. Ed è coerente ravvisare alle spalle di quell'op zione il ruolo affatto secondario dell'Ordine Ciste rcense . Molto probabilmente, infatti, furono proprio i suoi ingegneri che, nell'accingersi a fondare i tanti conventi-aziende agricole dislocati in Germania, imbattutisi al pari dei Cavalieri Teutonici , nei ruderi ancora ben leggibili dell e menzionate ville rustiche, o di qualche quadriburgo del limes danubiano, non tardarono ad apprezzarne l'ottimale rapporto tra rispondenza difensiva e rapidità costruttiva, sinonimo di economicità, recuperandone perciò altrettanto prontamente i canoni dimensionali ed architettonici. Quei criteri potevano facilmente applicarsi ad un monastero in territorio ostile come ad un castello statale, essendo entrambe le costruzioni scev re da ostentazioni superflue.
Una attenta rielaborazione, se mai, dovette essere compiuta per adeguare siffatto castello-tipo alle più avanzate armi individuali da lancio che, nel frattempo , si andavano diffondendo e perfezionando , prime fra

tu tte l a micidiale bales tra. Qual e fosse ormai la s ua poten za si può arguire dal dettaglio che la Chiesa, nel Concilio L ate ranen se d el 1139 , ritenne necessario limitarne l ' impiego ai so li combattimenti contro gli infedeli , essendo un ' arma 'aborrita da Dio e non adatta per i cris tiani ' . Ovviamente, qu e ll e umanitarie prosc ri z ioni non ebbero alcun seguito registrandosi un diffonders i ad oltranza della balestra ed un s uo ulteriore perfez ionamento. Non a caso: " Riccardo Cuor di Leone nel 1199 all'assedio di Chaulus, e Filippo Augusto, l'adot-
tarono di nuo vo per le loro trupp e, malgrado il brev e di Innocen zo III che le sco municava ri c hi a mando si al di vieto co nciliare... In Italia la ritroviamo costantemente implicata in tutte le guerre deJla Chiesa o dell ' Impero , fra Gue lfi e Ghibellini, in tutte le lotte frat ricide fra i Comuni, in molti ssimi fatti d ' arme ... In Genova , finalmente, e fino dai primi tempi del suo impiego, si costituì un addestramento organizzato per i balestrieri i quali formarono co mpa g nie mercenarie che co mbatt e rono per t11tta Europa " (86 ) Di certo intorno alla fine dell 'X II secolo, una di sc re ta bales tra man esca forniva una g ittata utile di circa 100 m , con un a ca denza di tiro di due o tre verrettoni al minuto, capaci , per la loro eccezionale forza di penetrazione, di trapa ssare, in quel ra gg io , qualsiasi corazza. Pres taz ioni del genere detemunarono , quale criterio di fens ivo prioritario, la riscoperta e l'esaltazione de l tiro di fiancheggiamento, ed i tecnici di Federico ne acce ntu aro no al ma ssi mo lo sfr uttamento dimen s ionando su lle s ue potenzialità i loro castelli. In un pai o di castelli tra quelli ancora s icuram e nte leggibili s i ri scopre un impianto planimetrico talmente sofist icato da eliminare quals ia si set tore defilato: per la rilevanza ne esamineremo in dettagl i o le caratteristiche. Sempre in relaz ione all'accresciuta violenza dei tiri , nella fatti spec ie offensivi, tutti i castelli vennero dotati di coronamento merlato , con merli rettangolari distanziati fra loro da un intennerlo di uguale larghezza. Al loro riparo i tiratori potevano tranquillamente ricaricare le armi, limitando l'apparizione dal I' i ntennerlo al so lo istante di lancio. Come per il fiancheggiamento , anche per la me rlatura s i deve, in sostan za, parlare di un recupe ro culturale classico: infatti la merlatura federiciana è identi c a a quella romana, cioè perfettamente a filo con l 'es tradosso delle sottostanti cortine, senza quegli aggetti che compariranno alcuni decenni dopo per rimediare a comprovati inconvenien ti.
La merlatura a filo, infatti, se proteggeva ottimamente gli arcieri ed i bales trieri, impacciava gravemente la difesa piombante , sempre indi s pensabil e contro g li assalti. Per riuscire a gettare verso il bass o ma ss i, o liquidi ust ionanti , era indispensabile s porger-
 79 Ninfa: evid e nte la merlatura 'a filo·.
lNG EGNO E PA URA TRENTA SECOLI DJ FORTIFICAZIONI IN ITAL.IA
79 Ninfa: evid e nte la merlatura 'a filo·.
lNG EGNO E PA URA TRENTA SECOLI DJ FORTIFICAZIONI IN ITAL.IA
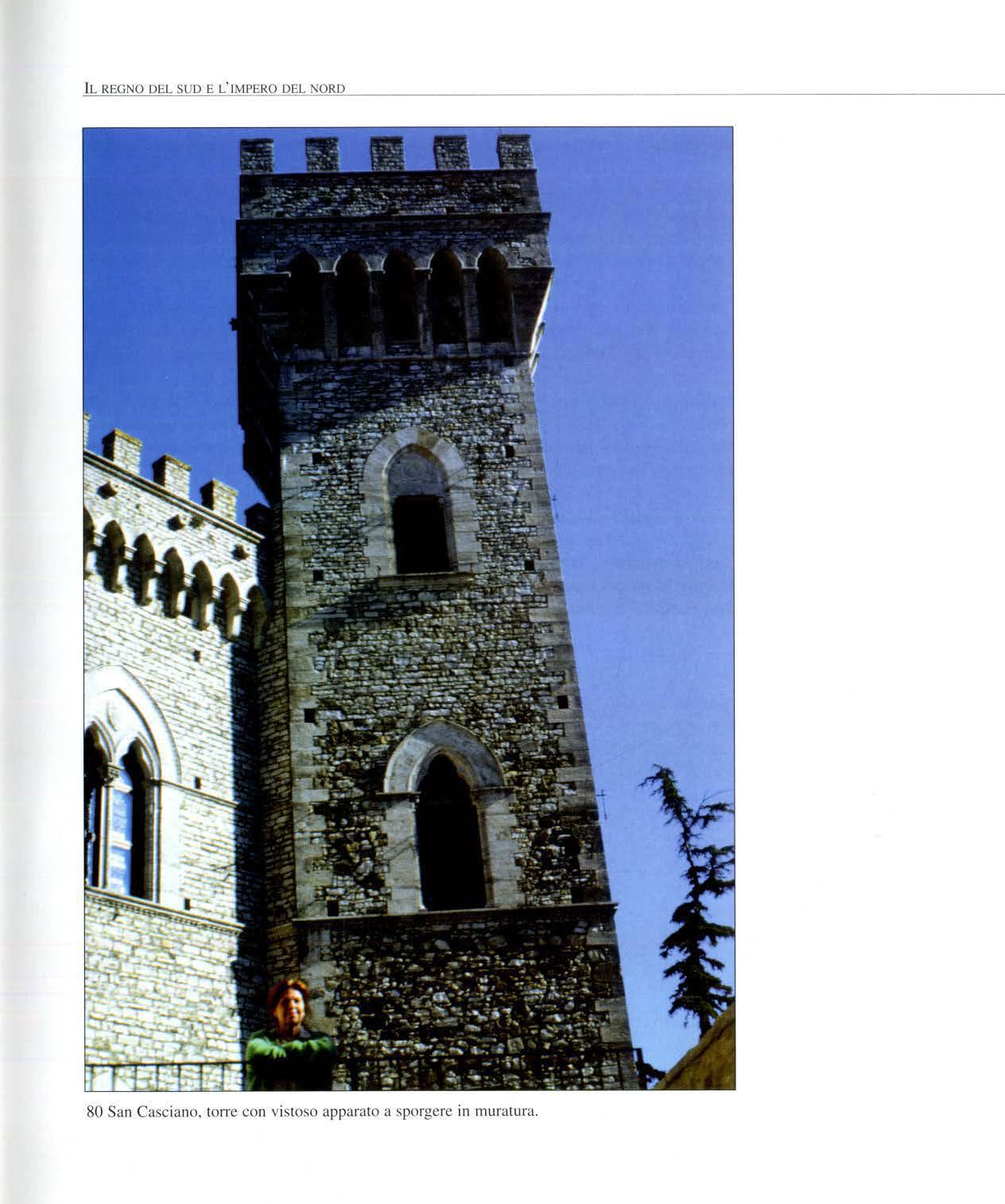
si notevolmente al di fuori degli intermedi , superandone lo spessore, il che finiva per rendere l'operazione lenta, imprecisa e rischiosissima, in specie se l'assediante di s poneva di balestre. Il rimedio che di lì a breve fu introdotto per risolvere il problema, peraltro già sporadicamente e parzialmente presente sulle fortificazioni normanne, consistette in un ponteggio ligneo a sbalzo applicato su 11 'estradosso del coronamento.
Si componeva di sporti infissi nelle mura alla base delle merlature, di circa un metro e mezzo d'aggetto. Su di e s si poggiavano orizzontalmente dei tavoloni e verticalmente dei murali sorreggenti una schermatura di graticci e leggere as s i. Quella sorta di balconata a sbal z o era completata abitualmente da una copertura s piovente, anch ' e ssa di legno, connotandosi come una veranda pensile insistente sull'intero perimetro del castello. Attraverso apposite buche, disposte ad intervalli regolari lungo l'impiantito , dette 'piombatoie' o 'caditoie ' , si potevano la sciar cadere vers o il bass o massi e 1iquidi , in perfetta s icurezza. Identica sicurezza god e vano pure i tiratori , che nascosti dalla schermatura , scagliavano dalle sue s ottili fes sure, in sostanza feritoie, i loro dardi. Le p1incipali caratteristiche negative del dispositivo descritto , del resto facilmente intuibili e risolvibili anche all'epoca , erano l ' estrema infiammabilità e rapida deperibilità della struttura. Il che spiega l'assoluta mancanza di una sua qualsiasi, anche minima, permanenza limitandosi le relative testimonianze alle sole riproposizioni iconografiche.
Un ultimo singolare, ma ancora una volta affatto inedito, espediente difen sivo s i rintraccia, sistematicamente, nei castelli federiciani , agevolato dalla loro rigida simmetria planimetrica: quello esoterico. Dall'orientamento geografico , alla sequenza numerica dei moduli dimensionali, infatti, possono agevolmente 1icavarsi i precisi criteri scaramantici e astrologici propri dell'ambiente culturale dell'imperatore.
Circa la tecnica costruttiva, essendo sempre l'altezza il principale fattore interdittivo , parve logico avvalersi delle soluzioni a notevole sviluppo verticale, implicanti l'adozione dell'arco a sesto acuto , o ad
ogiva, di recente acqui s izione. Anche in questo caso la s ua elaborazione viene a scritta all'Ordin e Cis tercen s e che: " contribuì a diffondere in tutto il mondo cristiano l ' arte di Francia, l'opu s francigenum, esportandone i modelli sin nel cuore del restìo Mezzogiorno ... "<81) . Adattata alle specifiche e s igenze militari, quella modernissima s oluzione strutturale definita 'gotico nascente ' <ss i, consentiva la realizzazione di complessi funzionali, sicuri ed economici: quattro ali intorno ad una corte quadrata , con quattro torri quadrate agli spigoli 189 i su soli due piani!
Affatto casuale, pertanto, che Federico Il, profondo conoscitore di risors e e capacità culturali , gratificass e ben presto i grigi monaci di innumerevoli concessioni e riconoscimenti , monopolizzandone , però , la qualificata cooperazione edile , per cui di mol t i: " ci s tercensi si servì come architetti per la costruzion e di castelli , e all'edificazione, in Puglia, dei più importanti e dei più belli di e s si parteciparono quas i sempre capomastri del l ' ordine.
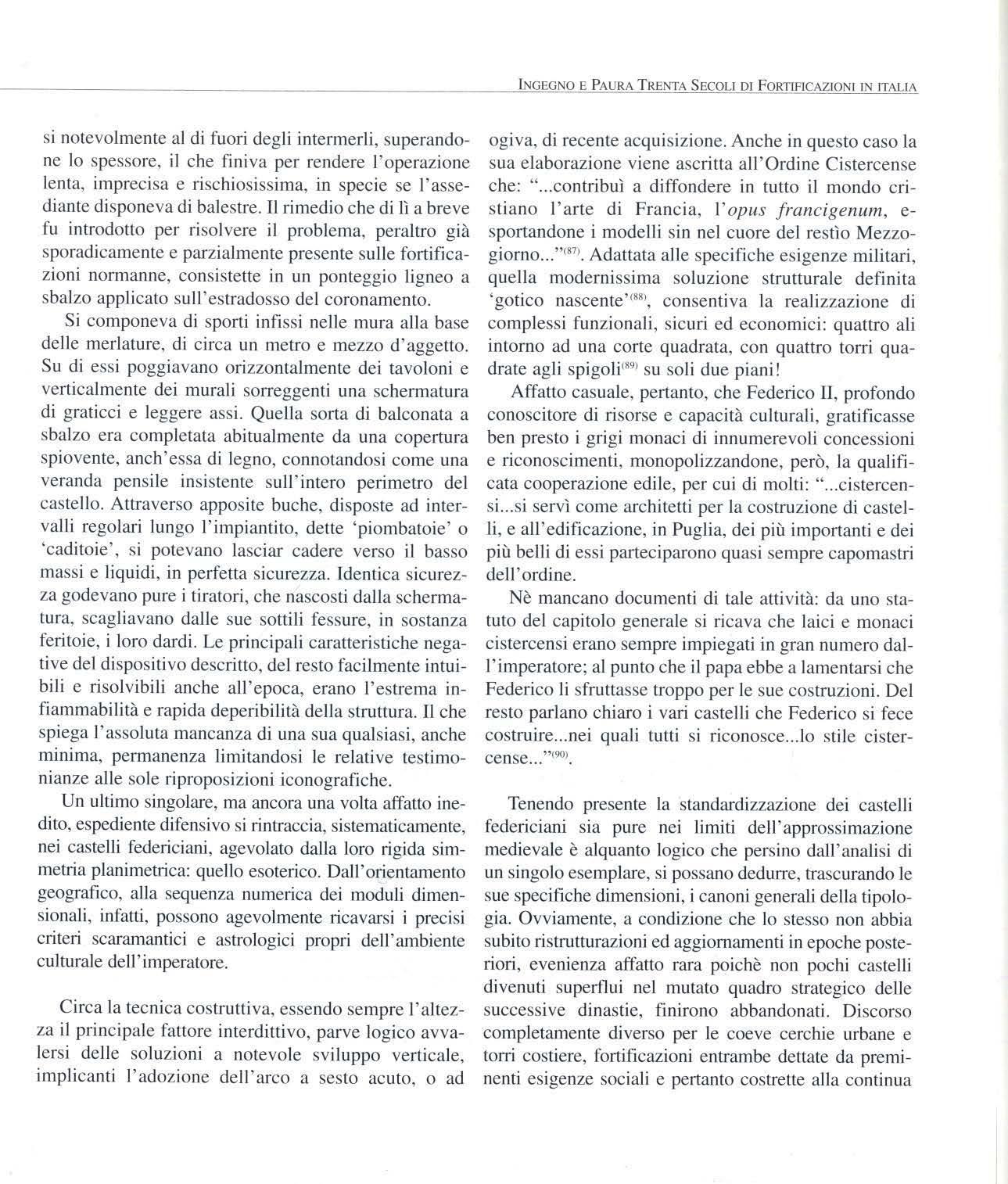
Nè mancano documenti di tale attività: da uno s tatu t o del capitolo generale si ricava che laici e monaci cistercensi erano sempre impiegati in gran numero dal!' imperatore; al punto che il papa ebbe a lamentarsi che Federico li sfruttass e troppo per le sue cos truzioni. Del resto parlano chiaro i vari castelli che Federico si fece cos truire ... nei quali tutti si riconosce ... Jo s tile cistercense ... " <90i
Tenendo presente la standardizzazione dei castelli federiciani sia pure nei limiti dell ' approssimazione medievale è alquanto logico che persino dall ' analisi cli un singolo esemplare, si possano dedurre, trascurando Je sue specifiche din1ensioni, i canoni generali della tipologia. Ovviamente, a condizione che lo stesso non abbia subito ristrutturazioni ed aggiornan1enti in epoche posteriori, evenienza affatto rara poichè non pochi castelli divenuti superflui nel mutato quadro s trategico delle successive dinastie, finirono abbandonati. Discorso completamente diverso per le coeve cerchie urbane e torri costiere, fortificazioni entrambe dettate da preminenti esigenze sociali e pertanto costrette alla continua
riqualificazione: ranssuru, perciò, scontri. significati vi n-
Tra i primi dispositivi legislativi promulgati nell'isola dall'imperatore, spicca la riadozione deJJe precedenti normative tributarie destinate alla formazione di una marina da guerra. Infatti: " .le antiche leggi normanne avevano previsto una serie di provvedimenti grazie ai quali era possibile creare e mantenere sempre in ottima efficienza una flotta. I proprietari di alcuni feudi e varie città e centri importanti del Regno erano obbligati a fornire legname per la costruzione e denaro per la manutenzione della flotta - questi tributi erano conosciuti sotto il nome di lignamia e marinaria -, nonchè un certo numero di marinai per equipaggiarla. Federico ripristinò quelle leggi cosicchè al la fine del 1221 poteva già contare su due squadre navali ... " c9 11 • È interessante ricordare che in seguito
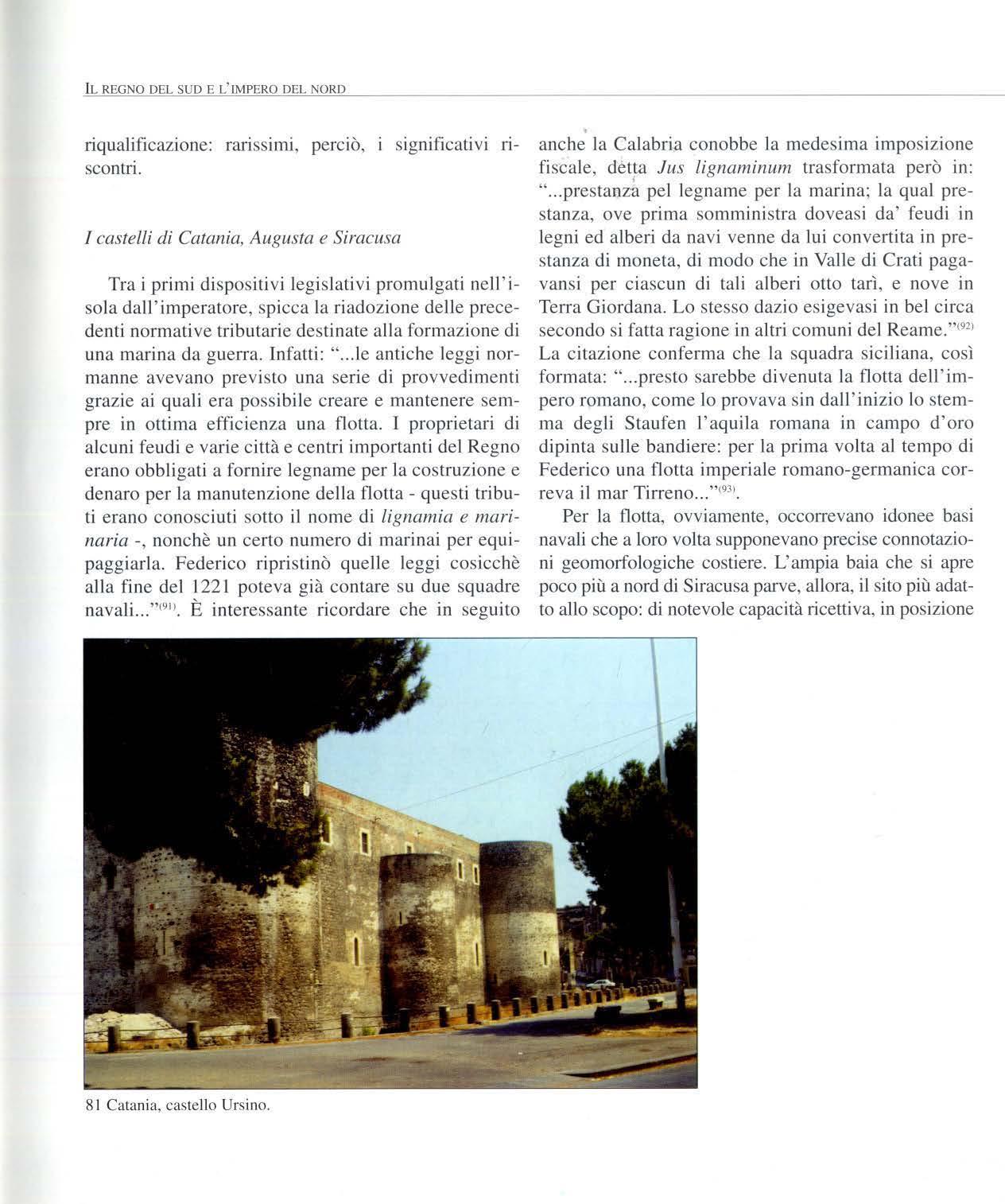
anche la Calabria conobbe la medesima imposizione fiscale, det~ Jus lignaminum trasformata però in: " ... prestanzà pel legname per la marina; la qual prestanza, ove prima somministra doveasi da' feudi in legni ed alberi da navi venne da lui convertita in prestanza di moneta, di modo che in Valle di Crati pagavansi per ciascun di tali alberi otto tarì, e nove in Terra Giordana. Lo stesso dazio esigevasi in bel circa secondo si fatta ragione in altri comuni del Reame." (921 La citazione conferma che la squadra siciliana, così formata: " presto sarebbe divenuta la flotta dell'impero romano, come lo provava sin dall'inizio lo stemma degli Staufen l'aquila romana in campo d'oro dipinta sulle bandiere: per la prima volta al tempo di Federico una flotta imperiale romano-germanica correva il mar Tirreno ... " '93 l
Per la flotta, ovviamente, occorTevano idonee basi navali che a loro volta supponevano precise connotazioni geomorfologiche costiere. L'ampia baia che si apre poco più a nord di Siracusa parve , alJora , il sito più adatto allo scopo: di notevole capacità ricettiva , in posizione
82 Catania. castel Ursino foto aerea.
bruicentrica nel Mediterraneo centrale e facilmente sorvegliabile, soddisfaceva ogni richiesta, al punto tale da meritarsi non solo l'immediato avvio dei lavori ma, finanche, la definizione dì Augusta. La progettazione della fortificazione che avrebbe dovuto difenderla fu affidata a Riccardo da Lenti1ù, già realizzatore di quel Castel Ursino a Catania, simile, se non altro, per l'adozione deJle torri cilindriche a Castel Maniace di Siracusa. La singolare anomalia dei due castelli ci costringe ad una breve divagazione.
Il primo, eretto a partire dal 1239, in riva al mare e ricoper1o dalJa lava dell'eruzione dell'Etna del 1669, conserva, oltre ad una notevole simmetria strutturale, una singolare matrice mediorientale. Infatti: " è tra le costruzioni fortificate volute dall'imperatore quello più simile, nella tipologia, ai castelli arabi delJ 'epoca ommiade. Ha grandiosa mole quadrata con ton-i cilindriche ai lati e altre min01i sulle mediane dei lati .. .''<9- 1>
Il secondo, della metà degli anni '30, invece: "fuco-
struito a Siracusa nella cinta esterna della pe1ùsola di Ortigia... [el se si guarda attentamente la s ua pianta, s i constata con stupore quanto essa si disco s ti da quella !canonica federiciana, tranne che per l'] assoluta regolarità della configurazione planimetrica, ma questo è solo un aspetto in comune, perchè qui la disposizione a 4 ali si è trasformata in uno spazio interno comprendente interamente la supertìcie primitiva di m. 50x50.
Quest'ultimo a sua volta fu trasfom1ato mediante 16 colonne in un ambiente porticato suddiviso in ventiquattro campate a crociera ogivale.
Solo tramite uno spazio centrale, come un cortiletto interno a modo di tromba aperta all'insù, luce ed aria penetrano all'intemo ... [ma] nel castello stesso tutto fu distrutto ... Esso deve essere stato di una ineguagliabile bellezza; soprattutto per il cru·attere orientale che gli de1ivava dalla mancanza di direzione di questa selva di colonne, tale da ricordare l'interno delle Moschee, come forse quella di Cordova Che Castel Maniace non dovesse servire in primo luogo, come quello di Catania e Augusta, da baluardo militare, lo fa capire il fatto che esso fu eretto con magnifiche pietre squadrate, del tutto liscie e senza giunti, ma soprattulto la ricchezza e Io sfarzo del suo allestimento artistico. Nes s un ' altra costruzione impeiiale possiede un portale così maestoso e costruito da materiale tanto prezioso ...
In Castel Maniace ci imbattiamo piuttosto per la prima volta in una costruzione imperiale che rivela chiaramente l'interiore sviluppo dello schema costruttivo, dapprima concepito solo rnilitru-mente, vale a dire del «castrum», a palazzo vero e proprio, la cui vera funzione è il prevalere della funzione di abitazione nei confronti dell'impo1tanza militare...Da questo punto di vista si deve allora ritenere per certo che , poichè al piano terra si trovava solo un atrio gigantesco, ed anche le scale a chiocciola che portavano in su, e le quattro torri angolari parlano in tal senso , era progettato almeno un piano superiore... Tracce che esso sia stato sia pure solo iniziato, non si sono rilevate .. .' '19s, _
Tornando alla baia di Augusta, intorno alla metà degli anni '30, fu eretto con la proverbiale solerzia
 INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI Fo1rnF1CA ZI0Nl IN ITAUA
INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI Fo1rnF1CA ZI0Nl IN ITAUA

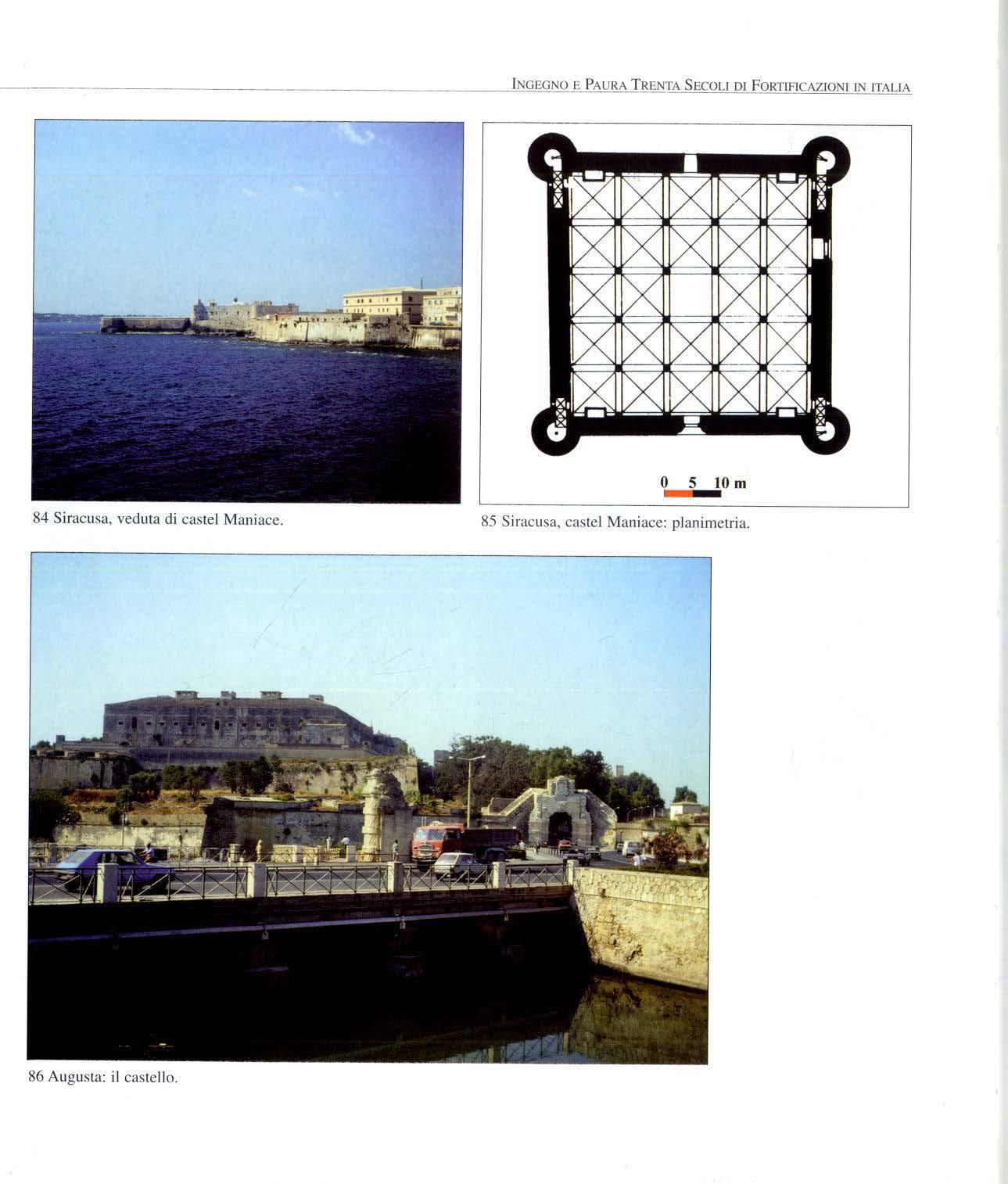 1NGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI Dl FORTlFICA ZION1 IN JTALIA
O 5 10 m
84 Sirac us a, veduta di castel Maniace.
85 Siracusa. castel Maniace: planimetria.
86 Augusta: il caste ll o
1NGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI Dl FORTlFICA ZION1 IN JTALIA
O 5 10 m
84 Sirac us a, veduta di castel Maniace.
85 Siracusa. castel Maniace: planimetria.
86 Augusta: il caste ll o
un ennesimo castello, questa volta privo di reminiscenze islamiche, consistente nel tipico blocco quadrato con torri quadrate ai vertici e corte centrale quadrata. Per meglio difenderlo si ritrovano al centro delle co r tine che non contengono i vani d'accesso, in posizione rompitratta, anche due semitorri rettangolari, e nella cortina principale una torre semiottagona, le cui dimensioni trasversali sono identiche a quelle delle due semitorri , lasciando perciò presumere che anche quest'ultime o rgina ri amente fossero semiottagone, ed in numero di quattro, una per ogni lato. Va osservato al riguardo che il castello di:
"Aug u sta ha pagato il più alto tributo alle profonde trasformazionj successive e a ll e orribili deturpazioni " 1961 Attualmente: " si presenta come un quadrilat ero d i 62 metri di lato con tre torri quadrate ad ogni angolo, due torri mediane e una toITe poligonale. Tuttavia numerosi elementi possono lasciar congetturare che il progetto i ni z iale non s i a stato comp letato o perlomeno sia stato successivamente modificato ... " <91 >
Al di là della perfetta individuazione della valenza strategica del sito, confermata dal protrarsi dell' impiego militare del castello fino al 1894, vi è una seconda ser ie di osservazioni, di natura balistica, che derivano dalle curiose sern it OtTi ce n trali. M a è necessario prima approfondire un a ltro caste lJ o federiciano strao rdinari ame nte sim ile a quello di Augusta: quello dell'Imperatore a Prato.

Storicamente la sua data di costruz ion e è compresa fra il 1237 ed il 1249 e fu fatto erige re da Federico lungo l ' itinerario c he collegava la parte peninsulare dell'Impero co n qu e lla cont in e ntal e. D al punto di vista architettonico: " ... l'edificio, pur così geografica mente lontano, è ri ferib ile alla tipologia d ei castelli federiciani di Pu g lia e di Sicilia. A pi a nta quadrilatera, con torri agl i a ngoli e a ltre al ce ntro delle cortine, esso ripropone, nella purezza e rego larità delJa volumetri a, nel
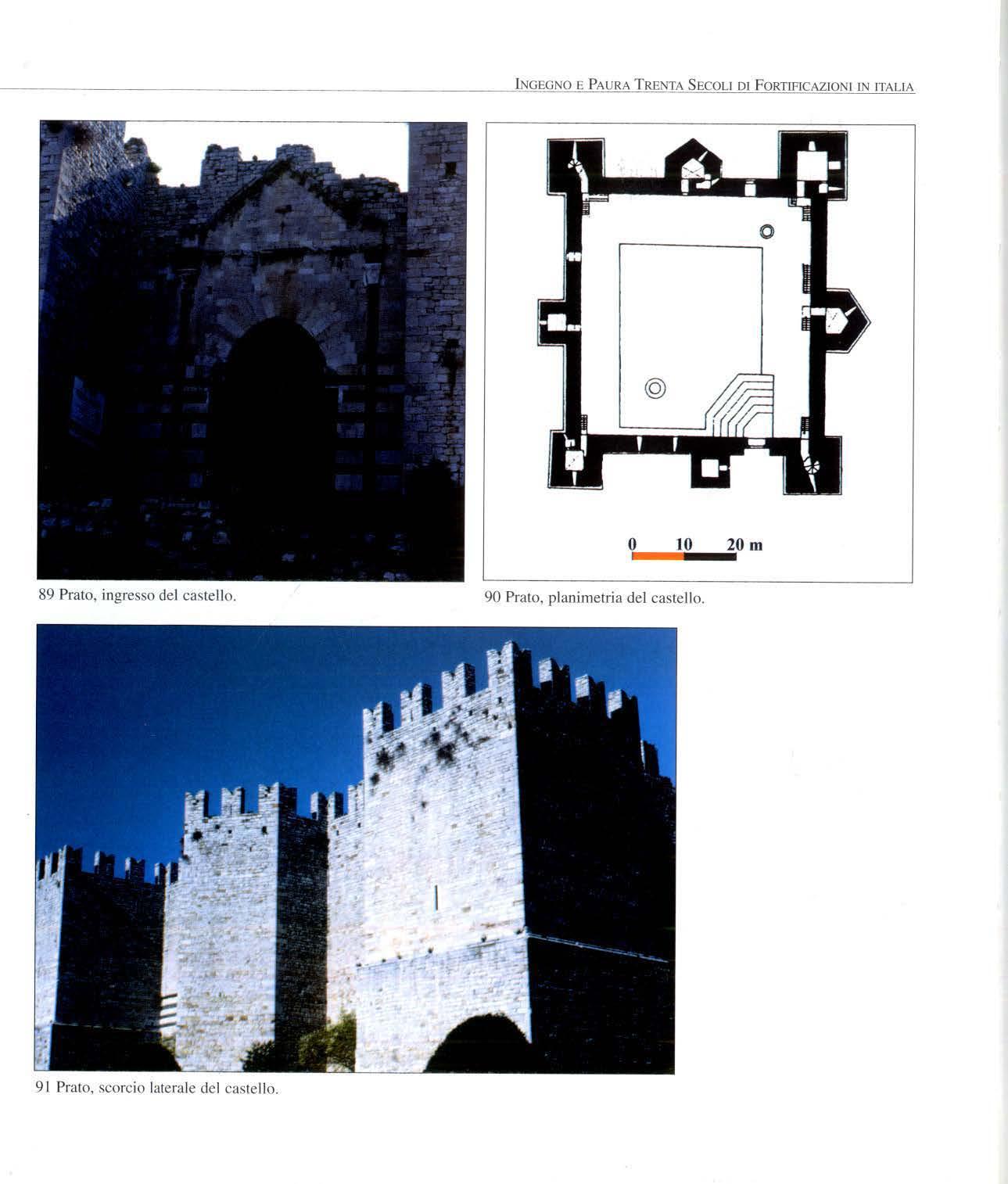

materiale costruttivo e nelJe grandi superfici senza aperture, la nobiltà delle costruzioni sveve " (9si Va rilevato che le due torri intermedie, delle quattro originarie , si differenziano da quelle omologhe di Augusta unicamente per la pianta.
Mentre le siciliane infatti sono semiottagone, con cinque lati esterni alla cortina, le toscane sono a pianta semiesagona con solo quattro lati verso l'esterno, che vengono perciò a formare una sorta di puntone.
L'accortenza che, in prima approssimazione, sembra una in s ignificante variante architettonica, ad un più attento esame, appare , invece, come la fase finale dei tentativi espletati , in rapidissima successione , per s opprimere i settori defilati antistanti al piede delle torri. Ad Augusta, le ton-i intermedie , sporgendo fuori dalla cortina più delle torri d ' angolo, rie scono perfettamente a tirare davanti a loro , battendo ogni minimo punto del terreno , mentre quest ' ultime non possono fare altret-
tanto , impedendoglielo gli spigoli della torre centrale: deficienza che determina il permanere dinanzi ad essa di un piccolo settore immune al fiancheggiamento. Le torri intermedie del castello di Prato, invece , a forma di puntone, pur es sendo sempre più aggettanti rispetto alle angolari, non hanno però il lato anteriore, sostituito da uno spigolo ottuso che, per la sua configurazione, consente a quest'ultime di spazzare entrambe le sue facce convergenti eliminando, perciò qualsiasi settore defilato.
La soluzione, certamente efficacissima e risolvente la ultramillenaria debolezza , aveva un unico, ma significativo difetto: un eccessivo costo , essendo non s olo neces sario raddoppiare il numero delle torri ma anche realiz zare i conci di quelle centrali secondo un preciso ed invariabile angolo. Il che, come accennato , lasciò spazio ad un altro sistema che si rintraccia nel castello del Macinale , eretto press o Caserta.
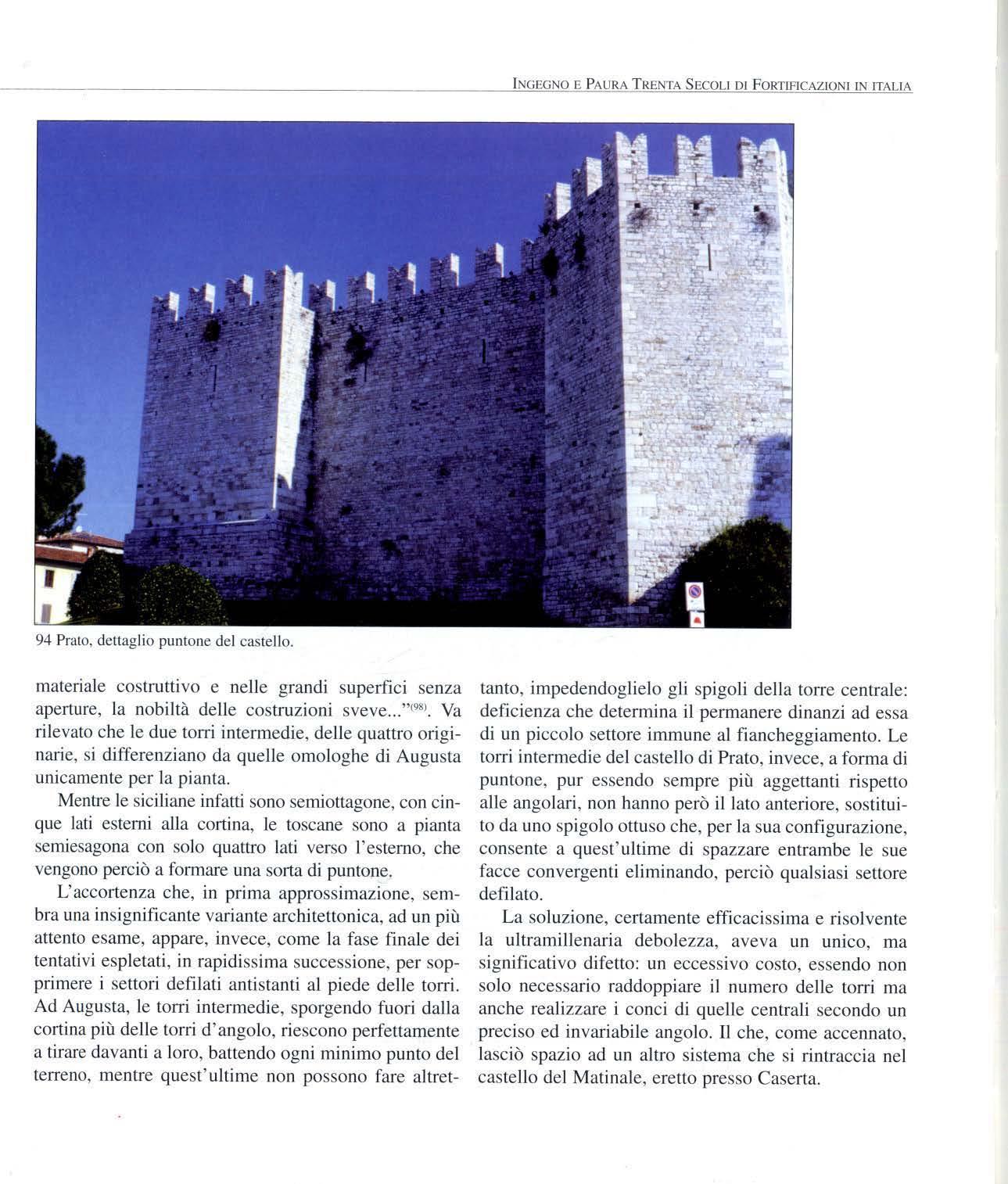

Grazie ad una serie fortuita di circostanze uno dei castelli scampati alle successive ri strutturazioni, anche se non deJ tutto aUa funzione di comoda cava di pietra, e finito semp li ceme nte dimenti ca to al termine dell 'epopea sve va , sve tta non lonta no da Napoli, s ull ' abitato di San Felice a Can ce llo. Per una se ri e ancora più s tra ordinaria e d imp ond e rabile di concause, pur ri s pe cc hiand o fedelme nt e i canoni appena esposti, su quel modesto castello furono realizzate dal progettista sofistica ti ss ime quanto misconosciute, ora come allora, variaz io ni planimetriche allo scopo di eliminare ogni se ttor e d efi lato al fiancheggiamento se nza però raddoppiare il numero dell e torri. Singolarità che, im pli ci La me nte , so ttinte nde il possesso da parte dello stesso personaggio di una ragguardevole pe1i zia militare, indispensabile per e laborare tali migliorie, e di una ancora più ragguardevole autorità politica, indispensabile per imporle: la s ua esatta identificazione, tuuavia, es ula dai limiti del presente st udio.
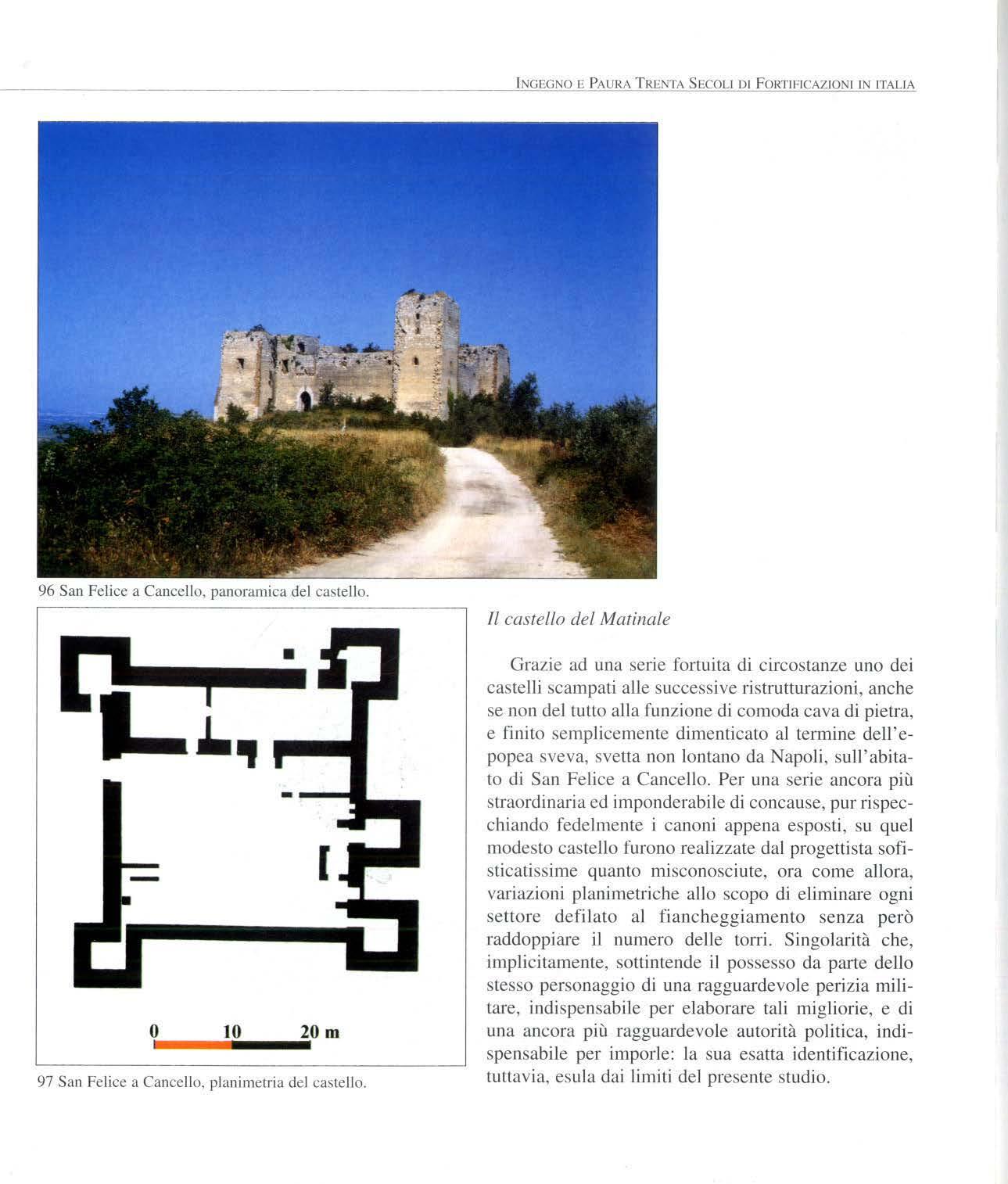

A quota 260, sul piccolo centro campano, incombe una severa massa geometrica, prima ed indubbia connotazione della matrice sveva del castello. Si tratta del solito tetro prisma quadrilatero con quattro tozze torri quadrate ai vertici , più una quinta anomala, forse posteriore, in posizione asimmetrica sul lato di ponente. Torri e cortine non dovevano originariamente differire in altezza: quella che oggi, invece, domina l'intera co s trnzione, ubicata sullo spigolo volto a levante, fu soprelevata qualche decennio dopo l'ultimazione del castello.
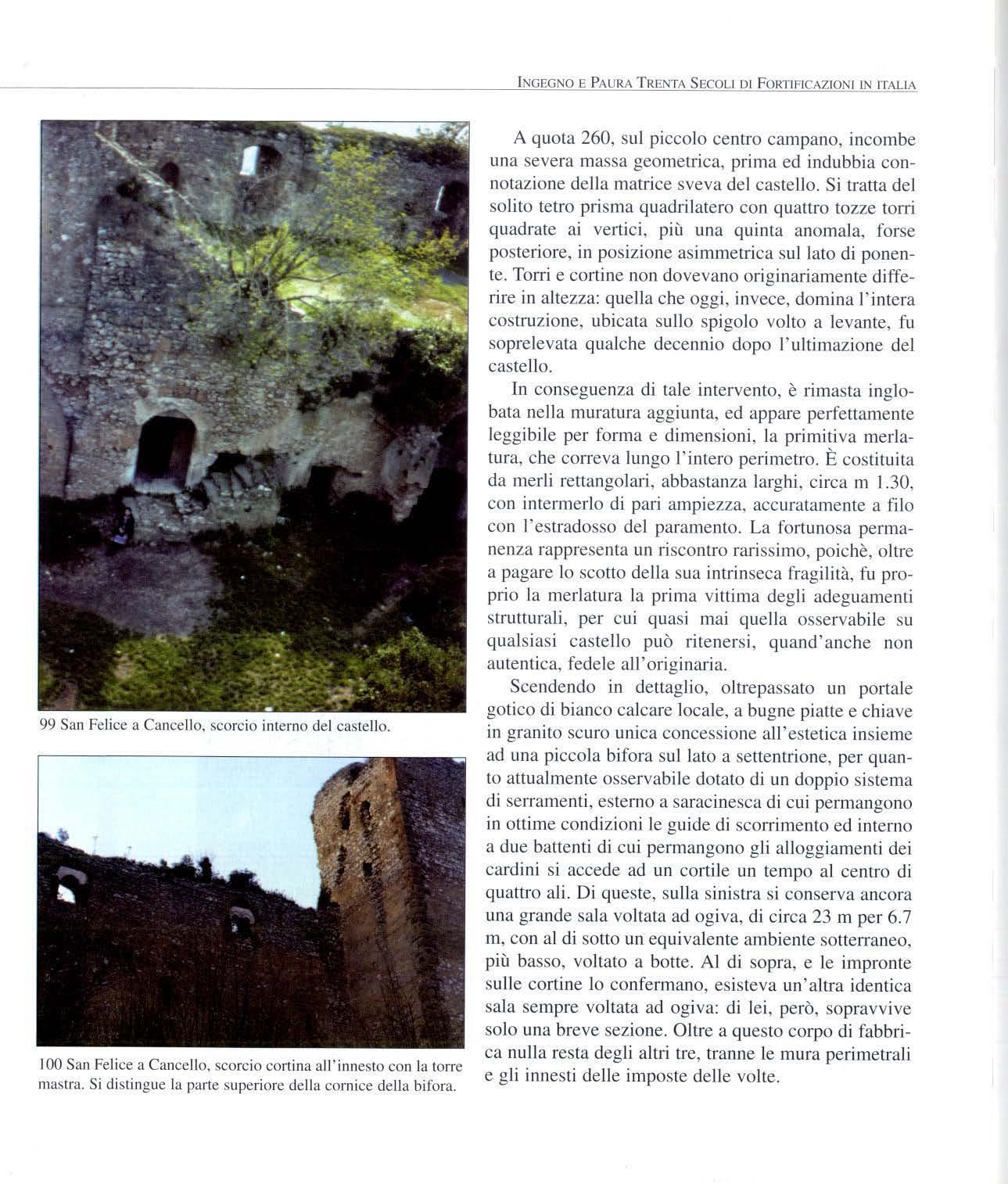
In conseguenza di tale intervento, è rimasta inglobata nella muratura aggiunta, ed appare perfettamente leggibile per forma e dimensioni, la primitiva merlatura , che con-eva lungo l'intero perimetro. È costituita da merli rettangolari, abbastanza larghi , circa m 1.30 , con intermerlo di pari ampiezza , accuratamente a filo con l'estradosso del paramento. La fortunosa permanenza rappresenta un riscontro rarissimo, poichè, oltre a pagare lo scotto della sua intrinseca fragilità, fu proprio la merlatura la prima vittima degli adeguamenti strutturali, per cui quasi mai quella osservabile su qualsiasi castel1o può ritenersi, quand'anche non autentica, fedele ali' originaria.
Scendendo in dettaglio , oltrepassato un portale gotico di bianco calcare locale, a bugne piatte e chiave in granito scuro unica concessione all'estetica insieme ad una piccola bifora sul lato a settentrione , per quanto attualmente osservabile dotato di un doppio sistema di serramenti, esterno a saracinesca di cui permangono in ottime condizioni le guide di scorrimento ed interno a due battenti di cui permangono gli alloggiamenti dei cardini si accede ad un cortile un tempo al centro di quattro ali . Di queste, sulla sinistra si conserva ancora una grande sala voltata ad ogiva, di circa 23 m per 6.7 m, con a l di sotto un equiva lente ambiente sotte1nneo , più basso, voltato a botte. Al di sopra, e le impronte su ll e cortine lo confermano, esisteva un'altra identica sala sempre voltata ad ogiva: di lei , però, sopravvive solo una breve sezione. Oltre a questo corpo di fabbrica nulla resta degli altri tre , tranne le mura perimetrali e gli innesti delle imposte delle volte
99 San Felice a Cancello, scorcio interno del castello. 100 San Felice a Cancello. scorcio cort in a a ll'innesto con la torre mastra. Si distingue la parte superiore della cornice della bifora. INGEGNO E PA URA TRENTA S ECOLI DI FOinI FIC AZIO NI IN ITALIAIn pianta, quindi, si tratta di un edificio quadrato di circa m 27 di lato con all'interno una corte quadrata , di circa m 12 di lato con ai vertici quattro torri quadrate di m 9.5 di lato. Verticalmente si componeva di due piani fuori terra, originariamente pari a circa m 15. al netto della merlatura, altezza conservata intatta solo dalle to1Ti. che mantengono immutata anche la compartimentazione interna. Jn tutte, il sotterraneo risulta adibito a cisterna, a cuj una tubatura sottotraccia in cotto adduceva le acque piovane raccolte in copertura. Sempre nelle torri, il piano teneno, bucato da strette feritoie fortemente strombate, era riservato alla difesa di fiancheggiamento radente. L'accesso ad esso avveniva dalle sale adiacenti e, se necessario, da lì mediante scale volanti fatte passare attraverso una botola della volta, era possibile raggiungere il sovrastante ambiente, di circa m 5x5, anch'esso comunicante direttamente soltanto con la sala adiacente. In questa. inoltre, faceva capo una strettissima, appena
60 cm, ripidissima ed angolata rampa di scale, ricavata nello spessore murario dei fianchi di ciascuna tone che immetteva alle loro coperture, comunicanti con quelle deU' intero castello riparate dalla merlatura continua. Dalla sommità delle toni riusciva praticabile il tiro di fiancheggiamento ficcante. Tanto al primo piano, come ali' inferiore, ogni torre, ed ogni sala, disponeva di una latrina, dal cui locale, attraverso un ca vedo, era possibile prelevare 1'acqua dalla sottostante cisterna: lo scarico con condotto verticale sfociava suIJa base esterna delle cortine. Sempre al primo piano, ogni torre, su entrambi i lati non innestati alle cortine, disponeva di due finestre, fortemente strombate e munite di battenti e cancellata, raggiungibili mediante pochi scalini e dotate di sedute laterali. Ultima pe11inenza di ognuno di tali ambienti un grande camino dall ·altissima cappa, ricercatezza che permette di cogliere il notevole comfort di quei castelli rispetto alla coeva edilizia abitativa. Comfort.

ovviamente, allora come oggi, finalizzato ad eliminare lo stress dei soldati unicamente per migliorarne il servizio.
Circa l'entità della difesa passiva. le rnmature perimetrali delle cortine non eccedono lo spessore di m 1.80, mentre quelle delle torri raggiungono quasi m 3, confermando il valore ostativo preminente ad esse assegnato. Non a caso è proprio nella accorta asimmetria del loro aggetto che si ravvisa l'accennata impostazione spe1imentale, pm nella sostanziale aderenza ai canoni dell' architettura militare federiciana <99>
In dettaglio , a Cancello, ogni torre quadrata fu innestata alla cortina, con le due facce esterne ortogonali le sole intere non ali ineate alle concordanti delle torri adiacenti. Infatti, ciascuna torre presenta la prima faccia esterna, quella parallela alla cortina e prospiciente la campagna, anetrata di quasi un paio di metri rispetto a quella con lo stesso orientamento della torre contigua. La seconda faccia, poi, ad essa perpendicolare in modo da formare lo spigolo diagonale dell'intero castello, a sua volta sporge di quasi un paio di metri rispetto alla concordante della torre

successiva , e così dj seguito. Ne derivava la possibilità di battere da ciascuna torre il terreno antistante alla successiva: ovviamente l'accorto dispositivo , pur dimezzando il critico settore defilato antistante alle torri risultato già notevole non lo eliminava, però, del tutto (10<ll, come ne] castello di Prato. Consapevole di quella estrema permanenza , 1' acuto progettista adottò un u]teriore accorgimento planimetrico, ancora più innovat i vo ed enigmatico.
Alle due torri che fiancheggiavano il vano d ' ingresso, quelle poste cioè sul versante meno ripido della col-
lina e quindi sul fronte più esposto, volle applicati, sin dalla fondazione, degli stranissimi zoccoli , a pianta vagamente cuneiforme, quasi dei rozzi speroni, i cui vertici appaiono, in vistosa divergenza dalle diagonali de] castello coincidenti, come precisato, con gli spigoli delle toni.
Il che dà origine ad una evidentissima alterazione della verticalità di quest'ultimi , che sembrerebbe ascrivibile quasi ad una sorta di riprovevole imperizia costruttiva, in nessun modo giustificabile e peraltro maldestramenle camuffata, da una certa altezza in poi ,
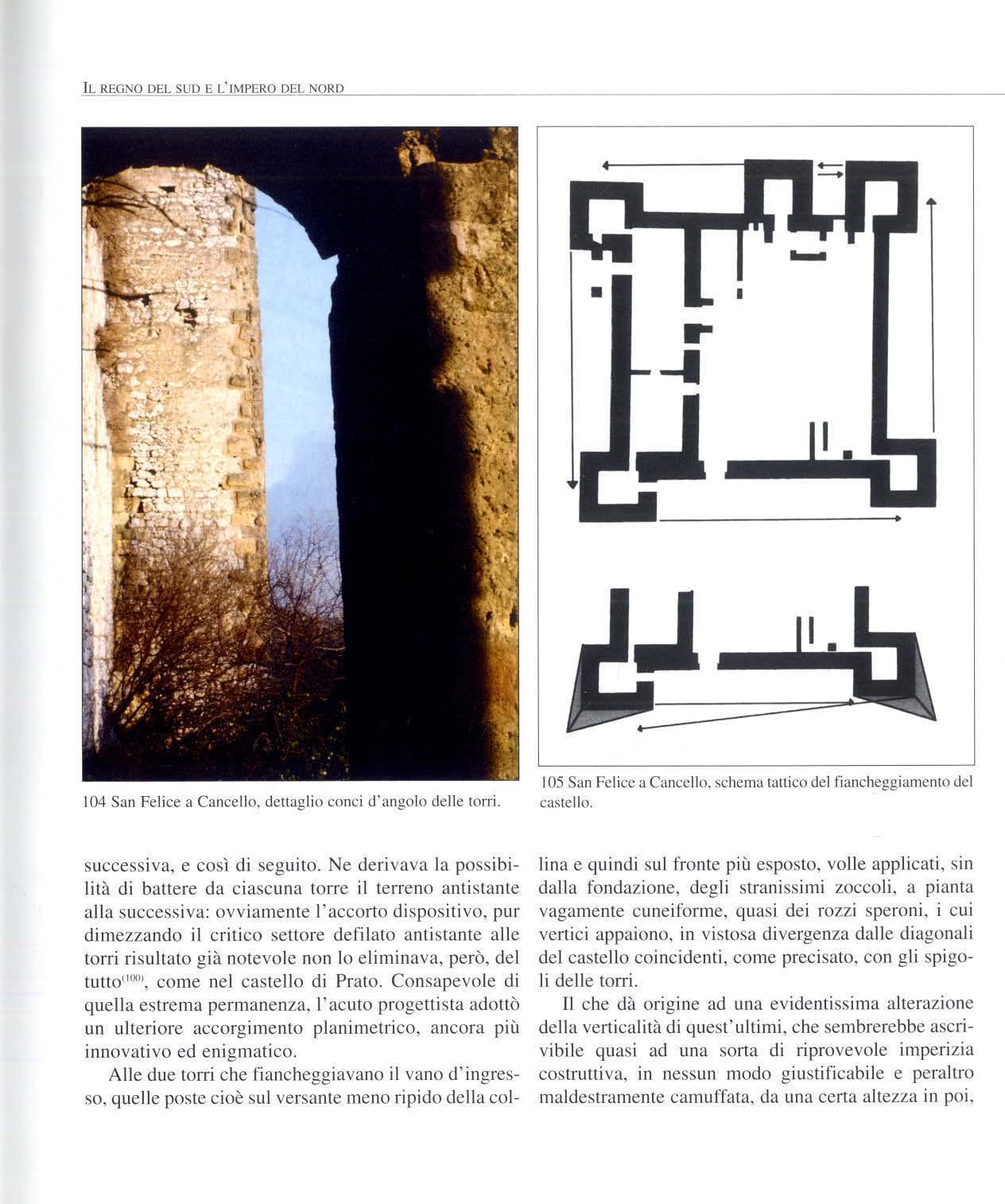
medìante una rastremazione delle facce delle due torri interessate.
Traguardando, però, da entrambi i vertici di lali 'speroni' è facile scorgere per intera la faccia della torre opposta. quella che per i I suo impianto rientrante dovrebbe, invece. risultare assolutamente invisibile. Pertanto la stessa. sebbene battibile anteriormente, è in grado a sua volta, grazie appunto al menzionato sperone. di fiancheggiare ìl piede della torre 'protettrice' el iminandone qualsiasi settore defilato. E, logicamente, identica potenzialità possiede la seconda. Per gli attaccanti ne derivava che lungo i tre lati meno scoscesi, ma un accenno di sperone si coglie anche per le torri posteriori, in nessun punto era possibile defilarsi rispetto al fiancheggiamento! È l'avvento, grezzo quanto si voglia. nella prima metà del XIII secolo, del criterio del forte a quattro bastioni. ovviamente congruo agli archi ed alle balestre.
Non diversamente da quanto a suo tempo rilevato per le mura di Telesia, l'accorta disposizione non trovò estimatori. Non ricevendo alcuna verifica bellica, al pari del castello, finì rapidamente clirnenticata" 11 1> !

Federico Il amava definirsi puer Apuliae. esplicita testimonianza del grande affetto che lo legava alla splendida regione già prediletta dai Nonnanni: logico quindi che prop1io in essa si rintraccino i suoi più significativi castelli, rendendo impossibile menzionarli tutti sia pur schematicamente. Limiteremo perciò l'esemplificazione ai più interessanti sotto l'aspetto castellologico.
f1 castello di Bari, nonostante le successive trasformazioni, cui va ascritto l'attuale aspetto di fortezza bastionata. conserva ancora all'interno della cerchia cinquecentesca l'oiiginale quadrilatero svevo, con le tipiche torri quadrate ai vertici. Va comunque osservato che la vistosa asimmetria che lo caratterizza, dipese dalla preesistente fortificazione norn1anna, eretta al tempo dell'occupazione della città da parte di Roberto
il Guiscardo, nel 1071. La stessa, come comprovano i ruderi sottostanti ad una torre, sorse. a sua volta, su di una più antica opera greco-romana, innalzata con blocchi di tufo di grande compattezza, le cui dimensioni erano all'incirca di m l.7x0.8x0.8, posti in opera a secco su filari isodomici. Storicamente, di tale remotissima struttura. si rintracciano menzioni in Orazio e Tacito.
Il castello normanno per le successi ve insuITezioni e guerre intestine finì praticamente distrutto, per cui Federico fl, fra il 1233 ed il l 240. diede incarico a Guido del Vasto di ricostruirlo ampliandolo. Assunse allora, per quanto consentito dalle permanenze, la configurazione canonica di: " ... impianto quadrangolare rafforzato agli spigoli da torrioni parallelepipedi. Di essi i due verso l'abitato risultano. per maggior difesa, molto aggettanti rispetto alla 1inea delle cortine perimetrali. Torri e cortine sono rivestite da bugne a bauletto in tufo carparo.
Nel1a cortina di ponente, a fianco della cosiddetta torre dei Minorenni, si apre il bel portale con archivol-
L'IGEGNO E PALIRA TRENTA SECOLI DI FORTIFlCAZIONJ lN LfALIA 106 Bari, planimetria del castello.to ogivale ... Poichè non vi è in questo portale alcuna traccia di un ponte 1evatoio, se ne deduce che esso fosse preceduto da un recinto oltre il quale c'era il fossato e nel quale si apriva un'altra entrata munita appunto di ponte levatoio. Attraverso questo portale si entra in un portico che si protrae neJJa corte. Esso è coperto da volte a crociera sostenute da capitelli alcuni in stile corinzio, altri costituiti da diversi ordini di foglie stilizzate e con agli angoli aquile sveve ... L'altezza delle torri doveva raggiungere i 30 m. Le dimensioni di due lati di base delle torri 1ivolte a Sud (la torre dei Minorenni e quella de1 Semaforo) sono m. I 5.20x 15.45 e m. 16. l0xl5.70. Le due torri verso il mare si chiamano del Monaco e del Vento.
La torre del Semaforo ... presenta due bellissime monofore a tutto sesto AJl ' interno essa è formata da tre ambienti disposti l'uno sull'altro e collegati tra loro da una sca1a a cruocciola, ricavata nella muratura [che l ricorda per i pmticolari tecnici , le analoghe opere

di Castel del Monte. Una sca la simile sale all'interno 107 Gioia del Colle, planimetria del castello. della Torre dei Minorenni ... ''1 10 2)
Il castello di Gioia del CoJJe, si erge a quota 360 m, sulla cresta che separa le Murge orientali da quelle occidentali. La s ua pianta è quadlilatera irregolare, ed i lati sono orientati verso i punti cardinali.All'interno il solito c01tile con andamento simile. Probabilmente la costruzione originaria disponeva di quattrn toni ai vertici: attualmente però ne sopravvivono soltanto due, per l 'esattezza Torre De' Rossi, alta m 26.40 e Torre Imperatrice, alta m. 24.1 O rispettivamente con lato di base m 10.50 e m 9.70. Entrambe appaiono alquanto trasformate e modificate. Tra loro corre 1a cortina, che racchiude il po,tale, ad arco policentrico, con conci bugnati a raggiera. Un secondo portale di dimensioni maggiori, a configurazione ogivale sempre policentrica, si apre nella cortina di ponente. Quanto alla tecnica muraria esterna: " ... è costituita di tre diversi tipi ...che denunciano tre epoche diverse di realizzazione: piccoli conci lapidei di pietra calcarea, sulla cortina Nord e Nord-Est; bugne rettangolari a bauletto con canaletti incavati, sulla to1Te Imperatrice; bugne rettangolrui poco aggettanti e schiac-
ciate molto consunte dal tempo , su n1tto il re sto della costruzione.
Tl materiale usato è il carparo rosso, un tempo reperibile a non molta distanza ad eccezione della parte bassa delle torri le cui bugne fino a m. 4.50 di altezza sono di pietra calcarea mollo chiara, come pure le bugne degli spigoli delle torri e quelle che incorniciano i portali, le finestre e alcune feritoie.
Le cortine alte circa 12 metri sono divise in due piani : quello inferiore presenta strette fe1itoie non tutte originali, in quello superiore si aprono numerose finestre di varia forma e grandezza ... La tradizione vuole che intorno al 1230 Federico Il, di ritorno dalla sesta Crociata si sia fennato a Gioia ed abbia ristrutturato il castello, trasformandolo da fortezza in dimora regale Più probabilmente... per la posizione strategica della località. inserì il castello di Gioia negli scacchieri fortificati di cui di sseminò il suo regno di Sicilia e di Puglia ... " no3 ,
A Trani il castello fu eretto in riva al mare, quasi dirimpetto alla grandiosa cattedrale, uno dei massimi
esempi di romanico pugliese. La fortificazione è forse tra quelle meno compromesse dalle successive trasformazioni , per cui conserva più netta la matrice federiciana. La pianta è ovviamente quadrata con quattro torri, anch'esse quadrate ai vertici. Intorno al perimetro correva un fossato, originariamente in comunicaz ione con il mare, so lu zione che implicava un ponte levatoio , in seguito sostituito da un o fisso.
In epoca cinquecentesca gli vennero aggiunti un bastione, inn es tandolo s ul corpo della torre volta a sud-ovest, ed un tempietto, al centro deJ cortile. Per quanto è possibile appurare, la costruzione del castello fu intrapresa intorno al 1233 ed ultimata 16 anni dopo, come conferma un ' i sc ri z ione posta su l suo lato settentrionale. Si sa ancora che: "Filippo Cinardo ... conte di Conversano e di Acquaviva , uomo di armi , ammiraglio e feudatario di Federico , più che dirigere i 1avori della costruzione , fu invece presente come intenditore di fortificazioni e in qualità di provvisore; il barese Stefano di Romualdo invece diede il suo contributo arti Sti CO " 11011 •

Senza dubbio l'epi s odio più tragico svoltosi tra le sue mura è la straziante cattura della vedova di Manfredi , la giovane regina Elena Commeno , che dopo la morte del consorte vi si era rifugiata, con i suoi quattro bambini, in attesa di potersi imbarcare per 1' Epiro, sua terra natale. Tradita dal vile castellano , fu consegnata a l d'Angiò. Imprigionata a Napoli e se parata dai figli, morì dì dolore nel giro di pochi anni.
E proprio allo sfo1tuna to Manfredi va ascritta la costruzione del castello di Manfredonia, forse l'ultimo castello s vevo. Eretto , sei anni dopo la morte dell ' imperatore nel 1256 quando il figlio fondò , nelle immediate adiacenze, la nuova città in sostituzione di Siponto , distrutta completamente dal terribile teITemoto del 1223, il castello conserva , nelle parti più antiche , le t ipich e impostazioni federiciane.
11 progettis ta fu, con molt a probabilità, Giordano da Monten santa ngelo: nel 1258 la fortificazione risulta prossima all'ultimazione, mentre la città lo sarà circa

otto anni più tardi. Gli Angioini, gli Aragonesi ed infine gli Spagnoli lo potenziarono, ognuno secondo i vigenti criteri dell'architettura militare, al punto che attualmente ben poco rimane, oltre all ' impianto planimetrico e ad una torre quadrata, dell'originaria struttura, composta comunque di un recinto quadrato con quattro torri quadrate aj vertici.
Federico II non fu il primo sovrano a cimentars i con il flagello delle incursioni da mare, ma senza dubbio fu quello che affrontò con maggiore decisione il problema della difesa costiera, er igendo diverse torri sulle insenature più minacciate. Di esse, tuttavia, pochissime sono scampate alla successiva demolizione, resasi necessaria per far posto alle più moderne costruzioni destinate, inevitabilmente ed esattamente negli stessi siti, alla
medesima funzione. Tra le superstiti c'è quella di Vendicari, presso Siracusa, fatta costruire, con molta probabilità, da Federico II per proteggere un porto adibito al commercio granario, sebbene le più antiche informazioni ad essa relative rattribuiscano all'iniziativa di Pietro d'Aragona, nei primi anni del '400. Ma si trattò , verosimilmente , di uno dei tanti rifacimenti subiti dalla torre nel corso della sua lunghissima esistenza. Si spiega così: " .la diversità di stile riscontrata da Agnello tra ciò che resta del piano superiore e tutta la struttura architettonica del piano inferiore, il cui impianto è tipico del l'architettura sveva. La solidità del pianterreno è tipicamente sveva , così come la tecnica muraria del rivestimento esterno, che. secondo Agnello, si richiama a quella di Castel Maniace ... Fra gli altri richiami a monumenti svevi lo studioso ne individua alcuni con il castello di Enna, con Castel del Monte ad Andria, e con Castello Ursino a Catania ... " " 05)
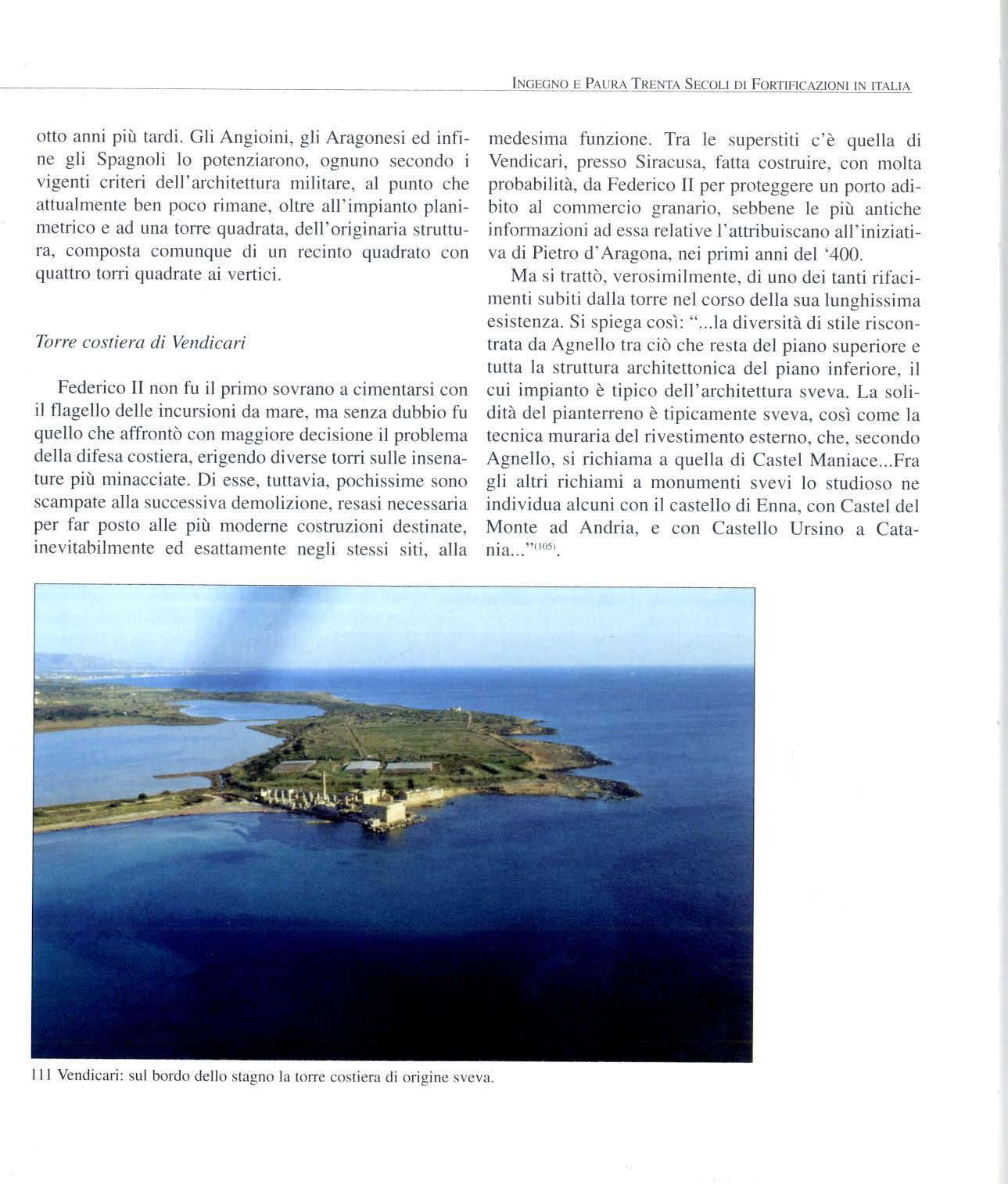
Si tratta dj una fortificazione che, sebbene non si possa definire castello ma piuttosto recinto con torrione, riecheggia alcune connotazioni esoteriche particolarmente care ali' aschitettura sveva, quali, per tutte, l'impianto ottagono del dongione. Per la sua semplicità deve necessariamente collocarsi nella fase più controversa del recupero della Sicilia, quella della eliminazione dei Musulmani. In tale logica: " .. .fu il più importante cardine dello scacchiere federiciano di Sicilia. Posto nell'interno dell'isola con funzione integratrice dell'incastellatura costiera, doveva probabilmente consentire l'arroccamento nel caso di invasioni musulmane provenienti dal sud. Circondato su tre lati da scarpate inaccessibili, collegato nel quarto alla città attraverso un piano facilmente controllabile. offriva eccezionali possibilità difensive sfruttate anche dagli Angioni duranti i Vespri siciliani. Il fortilizio le cui dimensioni consentivano l'acquartieramento di un esercito di 7 mila uomini, ha cinta pentagonale difesa
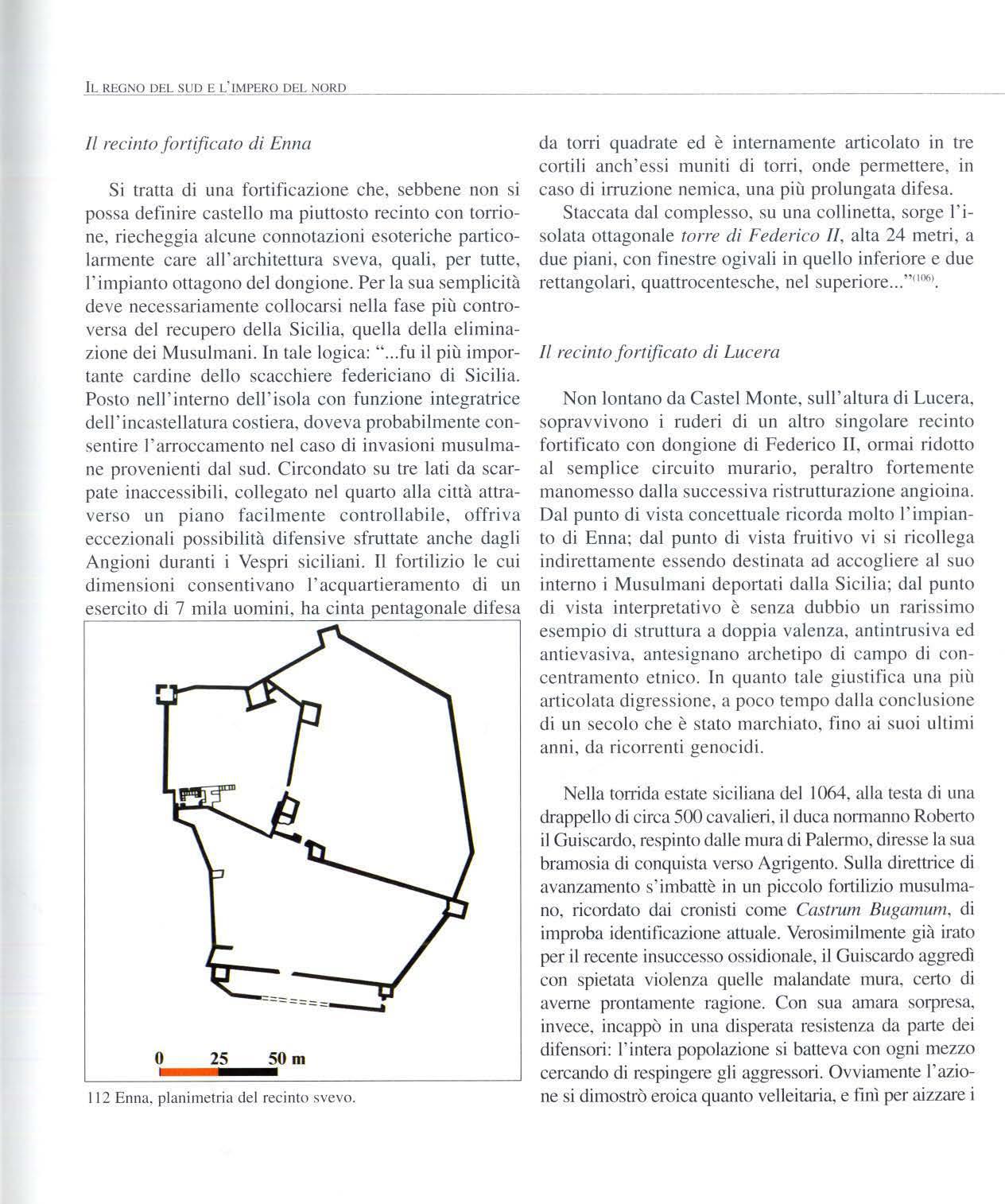
da torri quadrate ed è internamente articolato in tre cortili anch'essi muniti di torri, onde permettere. in caso di in-uzione nemica, una più prolungata difesa. Staccata dal complesso, su una collinetta, sorge l'isolata ottagonale torre di Federico li , alta 24 metri, a due piani, con finestre ogivali in quello inferiore e due rettangolari, quattrocentesche, nel superiore ... " 111)(,)
Non lontano da Castel Monte, sull'altura di Lucera, sopravvivono i ruderi di un altro singolare recinto fortificato con dongione di Federico II, ormai ridotto al semplice circuito murario, peraltro fortemente manomesso dalla successiva ristrutturazione angioina. Dal punto di vista concettuale ricorda molto l' impianto di Enna; dal punto di vista fruitivo vi si ricollega indirettamente essendo destinata ad accogliere al suo interno i Musulmani deportati dalla Sicilia; dal punto di vista interpretativo è senza dubbio un rarissimo esempio di struttura a doppia valenza, antintrusi va ed antievasiva. antesignano archetipo di campo di concentramento etnico. In quanto tale giustifica una più articolata digressione. a poco tempo dalla conclusione di un secolo che è stato marchiato, fino ai suoi ultimi anni, da ricorrenti genocidi.
Nella torrida estate siciliana del I064, alla testa di una drappello di circa 500 cavalieri. il duca no1manno Roberto il Guiscardo, respinto dalle mura di Palermo, diresse la sua bramosia di conquista verso Agrigento. Sulla direttrice cli avanzamento s'imbattè in un piccolo fortilizio musulmano, ricordato dai cronisti come Castrum Bugamum, di improba identificazione attuale. Verosimilmente già irato per il recente insuccesso ossidionale, il Guiscardo aggredì con spietata violenza quelle malandate mura, certo di averne pronta.mente ragione. Con sua amara sorpresa, invece, incappò in una disperata resistenza da parte dei difenso1i: l'intera popolazione si batteva con ogni mezzo cercando di respingere gli aggressori. Ovviamente l'azione si dimostrò eroica quanto velleitaria, e finì per aizzare i
11 3 Lucera, panoramica del recinto svevo.
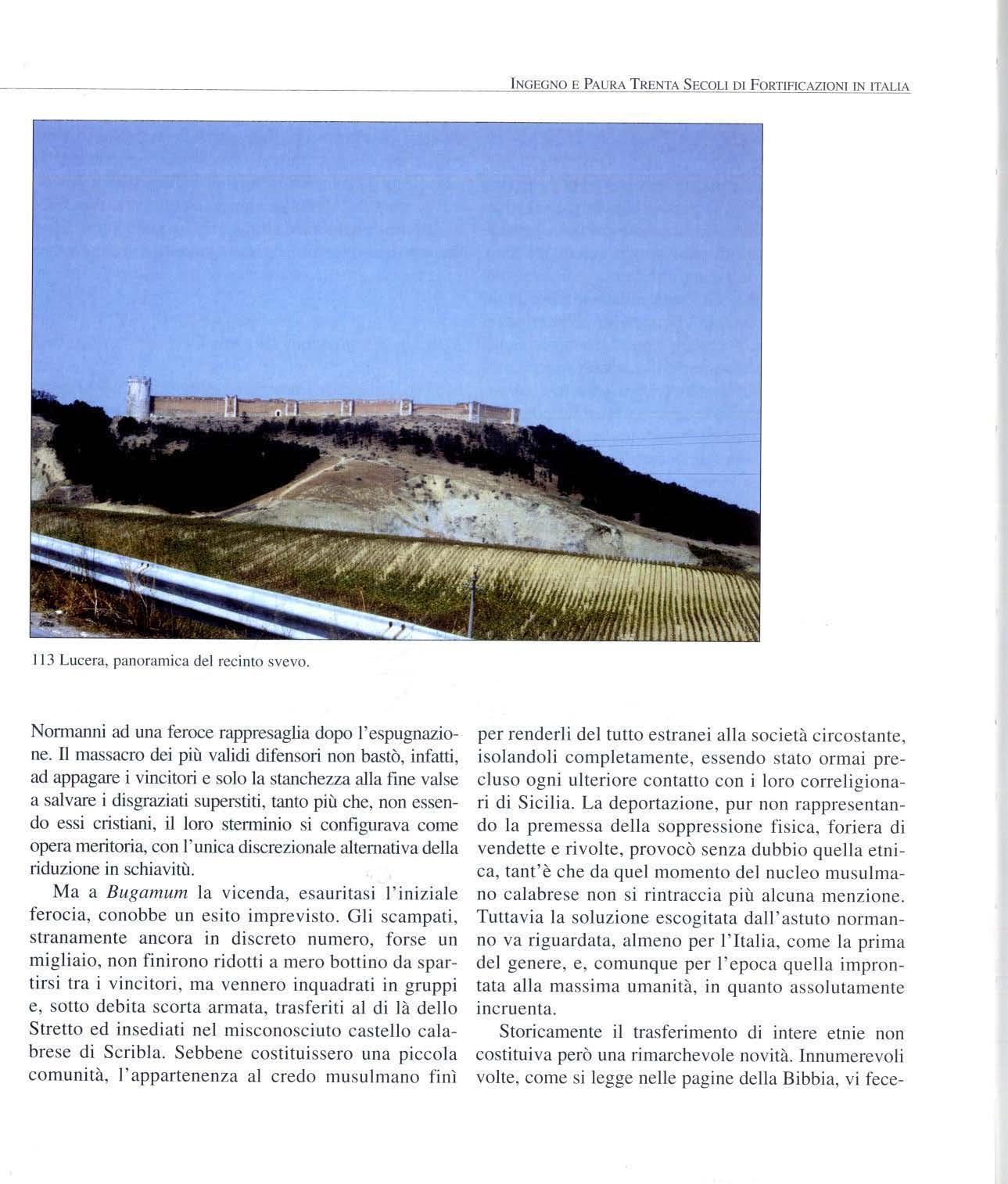
Normanni ad una feroce rappresaglia dopo I' espugnazione. Il massacro dei più validi difensori non bastò, infatti, ad appagare i vincitori e solo la stanchezza alla fine valse a salvare i disgraziati superstiti , tanto più che, non essendo essi cristiani, il loro sterminio si configurava come opera meritoria, con l ' unica discrezionale alternativa della riduzione in schiavitù.
Ma a Bugamum la vicenda, esauritasi l ' iniziale ferocia, conobbe un esito imprevisto. Gli scampati, stranamente ancora in discreto numero, forse un migliaio, non finirono ridotti a mero bottino da spartirsi tra i vincitori, ma vennero inquadrati in gruppi e, sotto debita scorta armata, trasferiti al di là dello Stretto ed insediati nel misconosciuto castello calabrese di Scribla. Sebbene costituissero una piccola comunità, l'appartenenza al credo musulmano finì
per renderli del tutto estranei alla società circo s tante , isolandoli completamente , e ss endo s tato ormai precluso ogni ulteriore contatto con i loro correligionari di Sicilia. La deportazione, pur non rappresentando la premessa della soppressione fisica, foriera di vendette e rivolte, provocò sen z a dubbio quella etnica , tant'è che da quel momento del nucleo musulmano calabrese non si rintraccia più alcuna men z ione. Tuttavia la s oluzione e s cogitata dall ' a s tuto normanno va riguardata, almeno per l ' Italia , come la prima del genere, e , comunque per l ' epoca quella improntata alla massima umanità, in quanto assolutamente incruenta.
Storicamente il trasferimento di int e re etnie non costituiva però una rimarchevole novità. Innumerevoli volte, come si legge nelle pagine della Bibbia, vi fece-
ro ric o rso i sovran i assiri o babilonesi, ed innumerevoli vo lt e anche l e legioni romane l o app li caro no a popolazioni ree di resistenze particolarmente ostinate, ma non tanto ingiustificate da 1icbiedeme l o ste rminio o la ridu z i o ne in ma ssa in sc hi avi tù. La singolarità dell 'opzione no rmanna , se mai , s i individua nel contesto in cui si manifestò, caratterizzato dall'assoluta intolleranza religiosa, tipica de i confli tti a for te connotazione co nfe ss ional e e finalizzati alla omogeneizzazione territoriale ed antropica, ossia, alla eliminazione fisica dei 'diversi', in quanto soc ietà alternati va non inte grabile e possi bile nucleo di coagulazione di futur .i te ntativi di riconquista. Posta così la questione, la deportazione di inte re co munità , che inevitabilme nte avrebbero 1ic ostituito altrove le originarie i stituzioni, sembre re bbe per lo meno incoerent e rispetto a ll 'acce nnat a lo g ica. In realtà, però, rappresentava sollanto la premessa di una fatale, per quanto dilazionata, dissoluzione etnica, esito inevitabile di una sopravvivenza più o meno prolungata ma comunque terminale, capace però, nel frattemp o, di fornire discreti vantaggi, in specie quando applicata a comu nità islamiche.
Da un punto di vista pratico, infatti, lo sradicame nto di inter i g ruppi me diante deportaz i one in località isola te, finiva col trasfo rmare g li sconfiL Li. da indocili ribelli, in sudditi fedelissimi, in quanto ben co nsapevoli c he la perdita della protezione del loro dominatore li avrebbe inesorabilmente avviati ad un ma ssacro, inevitabile perchè non più procrast inato da favorevoli co ntes ti geografici nè frenato, anzi incoraggiato, da co ns iderazioni di tipo morale. Considerando il perdurare dell'abitudine meridionale d ' impiegar e l 'agge tti vo «cris tiano » qual e s o s tanti vo s inonimo di individuo , s i può immaginare come, nel passato, al cessare di quella coITispondenza biunivoca cessasse pure ogni diritto , persino quello alla soprav vivenza.
La so lu zio ne normanna , in definiti va, introduce va, ammantandola con ipocrite umanitari s mo , una procedura bellica assolutamente inedita , imperniata sull'isolamento degli infedeli previa cattura, se lezione , deportaz ione, concentramento e, magari , sfruttamento.
Pertanto, vuoi per i positivi risultati, vuoi per la mancanza di a ltern at iv e altr etta nto efficaci c h e non fossero lo s termini o, l'iniziativa non restò isolata: dodici a nni dopo, infatti, il co nte Ru ggero, frate llo di Rob e rto, la riesumò applicandola ai sopravvissu ti a ll a conquista di Castrum ludi ca, altro caposaldo musulmano, non lontano da Catania.

Ma la va lenza dell'operazione sopra descritta va 1icercata in un ambito di verso da quello dell'eventuale vantaggio economico deri va nte dal lavoro coatto. Stante, infatti, la s ubordinazio ne del potere temporale a quello s pirituale, qual s ia si sov rano sa pe va perfettamente che, in caso di sco muni ca, eve nto affatto raro per le più svariate motivazioni, ai s udditi sarebbe sta to fatto esplicito di vieto di obbedire ai suoi ordini, sotto pena d'incorrere nella medes ima sanzio ne Tutti i s udditi, ovviamente, cristiani però: mantenere, quindi, un nucleo, e meglio a ncora un contingente militare, fedelissimo per quanto detto, ed immune da tale iattura, costitui va una so rt a di assicurazione su l potere e s p esso sulla vita. Il che s i tradu sse nella procedura appena accennata, c h e s i ri solse, per usare una tragica definizione atluale, in una antesignana 'pulizia etn ica', completata da prestazione militare forza ta(101 1 • D a quel momento, infatti, i sovrani norman ni disposero se mpre di un contingente di arcieri musulmani, spesso in funzione di guardia pretoriana.
Nel 122 1, quando Fede ri co II tornò in Sicilia, deciso ad est irpar vi l'anarchia imperante, si convinse c he essa fosse cagionata oltre c he dalla in s ubordin az io ne dei baroni, anche e soprattutto dall'intolleranza fra le diver se componenti razziali e re li giose ln una apposita dieta , tenutasi a Me ss in a, sta bilì quindi gli obblighi per i s udditi considerati 'sp uri ', tra i quali gli Ebrei, che obbligò a portare un apposito dis tintivo giallo. L'anno seg uente fu la volta de i Mus ulmani , c he , dopo le iniziali stragi normanne , s i erano saldam e nt e in se diati nelle propaggini più interne ed ino s pitali de ll'i so la. In quelle inatta cc abili contrade, dopo una rapida riorganizzazione , avevano conseguito un vistoso incremento demografico. È probabile che il fenomeno dipendes se princi-
palrnente dagli incessanti arrivi di altri correligionari, fuggiti dalle campagne e dalle città per le ricorrenti stragi perpetrate dai cristiani, di cui l'ultima, particolarmente efferata, si era verificata a Palermo nel 1190 , ma non è da escludersi un sostanzioso apporto dell ' immigrazione clandestina dal Nordafrica. Di certo i Musulmani, resi baldanzosi dal numero e dalla s upposta inviolabilità dei loro covi, iniziarnno a razziare le campagne ed i vilJaggi, annientando la pubblica sicurezza. L'intollerabile situazione portò nel 1222 all ' avvio di una massiccia operazione militare contro Jato, nei pressi di Palermo , ritenuta la roccaforte islamica per antonomasia.
Un effimero successo, Jato cadrà definitivan1ente nel 1246, indusse l'imperatore a sottovalutarne la potenzialità. Pochi mesi dopo , il mas sacro a tradimento del presidio insediatovi costituì il segnale per la 1ipresa ad olu·anza delle ostilità. Nell'occasione venne impiegata anche la marina da guerra imperiale, che attaccò le coste barbaresch e per recidere ogni eventuale legame tra i Musulmani delle oppos te sponde. Le durissime operazioni si protrassero per alcuni anni e, sebbene le cronache coeve siano in solitamente laconiche al riguardo , a partire dal 1224 i combattimenti ebbero un sistematico corollario .
Contestualmente al progredire delle conquis te dei singoli caposaldi saraceni , e dei sistematici rastre11amenti, il numero dei prigjonieri e dei profughi si accrebbe a dismisura, creando nell'immediato complessi problemi , circa il loro mantenimento, e nel prosieguo, circa la loro so1te. Al termine del primo biennio di combattimenti essi , superando le 20.000 unità, eguagliarono la popolazione di una met:ropo)j dell ' epoca. A quel punto, esauritasi la fase più vjolenta della pulizia etnica, occoffeva definire il destino di quella moltitudine miserabile di uomini , donne, bambini ed anziani: anche per la di sinibita morale dei tempi il loro sterminio in massa appariva ripugnante e, forse , neppure attuabile, senza contare che tale soluzione avrebbe indotto i tanti ancora liberi ad oppoITe una resistenza fanatica.
Probabilmente allora Federico II si ricordò della remota opzione dell ' avo materno: tra i suoi demani sul continente non difettavano ampi ed incolti tenitori, totalmente disabitati e lontani da qualsiasi cittadina o paese, ideali quindi per
deportarvi i Saraceni. Occorreva, in ogni ca5o , adeguare il sito prescelto, ovviamente secondo i c riteri e le circos tanze vigenti , alla inedita destinazione , evitando accorta mente ch e potesse trasformarsi in una nuova e più c oriacea roccaforte musulmana. In quella malaugurata ipotesi, per la straordinaria 1ilevanza demografica dei deportati, ridwfa al]' obbedienza sarebbe 1isultato drammatico. Paradoss almente , per l' identico motivo, si rendeva indi spensabile una completa autosufficienza dell'insediamento: in altre parole si sarebbe dovuto realizzare una sorta cli accampamento dove concenuare tutti i Saraceni siciliani, costringendoli a lavorare, un antesignano ' campo cli concentramento' etnico.
L' antica colonia militare romana di Lucera, all 'epoc a una remota di s tesa di mace1ie e cli ruderi, app e na di stinguibili tra i rovi 1igogliosi sulla sommità di un pianoro, con tre lati impervi ed uno meno ripido , sembrò pos sedere i requisiti ottimali. Ai s uoi pi e di una ten-a incolta e selvaggia , che attendeva soltanto di essere recupe rata all ' agdc oltura, e d all'intorno il dese1to. Il pare re dei tec nici imperiali confermò l'intuizione dell ' imperatore: nessuna difficoltà impediva di sostituire que lle rovine con un mode sto villaggio, il cui is olamento sarebbe stato garantito da una muraglia continua co1Tente lungo il cigho de l pianoro, con un unico accesso sul versante meno ripido. Pres a la decisione , i lavori ini zi arono con l ' abituale solerzia: probabilmente furono proprio i prinù deportati , appos ita.menti fatti affluire, ad erigere la grande cerchia.
Sebbene le s carne notizie ci tramandino una pot e nzialità ricettiva ma ss ima del recinto di circa 200 famiglie, tenendo conto del nucleo medio musulmano 2000-3000 unità , è molto verosimile , in realtà, che si atte s ta s se intorno ad una cifra doppia. L ' incessante sopraggiungere di colonne di derelitti, attraverso un ' estenuante marcia di quasi 500 chilometri, sotto la spietata sorveglianza delle sentinelle teutoniche, portò, al di là di og1ti previsione, la popolazione a superare , in pochi mesi, le 16.000 persone , senza, peraltro , che la 'pulizia ' si confermas se conclusa.
La Lucera Sara cenorwn, nuovo nome della vecchia colonia, prese, pertanto, a debordare dai ristretti limiti del recinto, acquisendo il tipico aspetto di una casba araba, con i mercati brulicanti di vita. Nell ' arco di pochi anni i

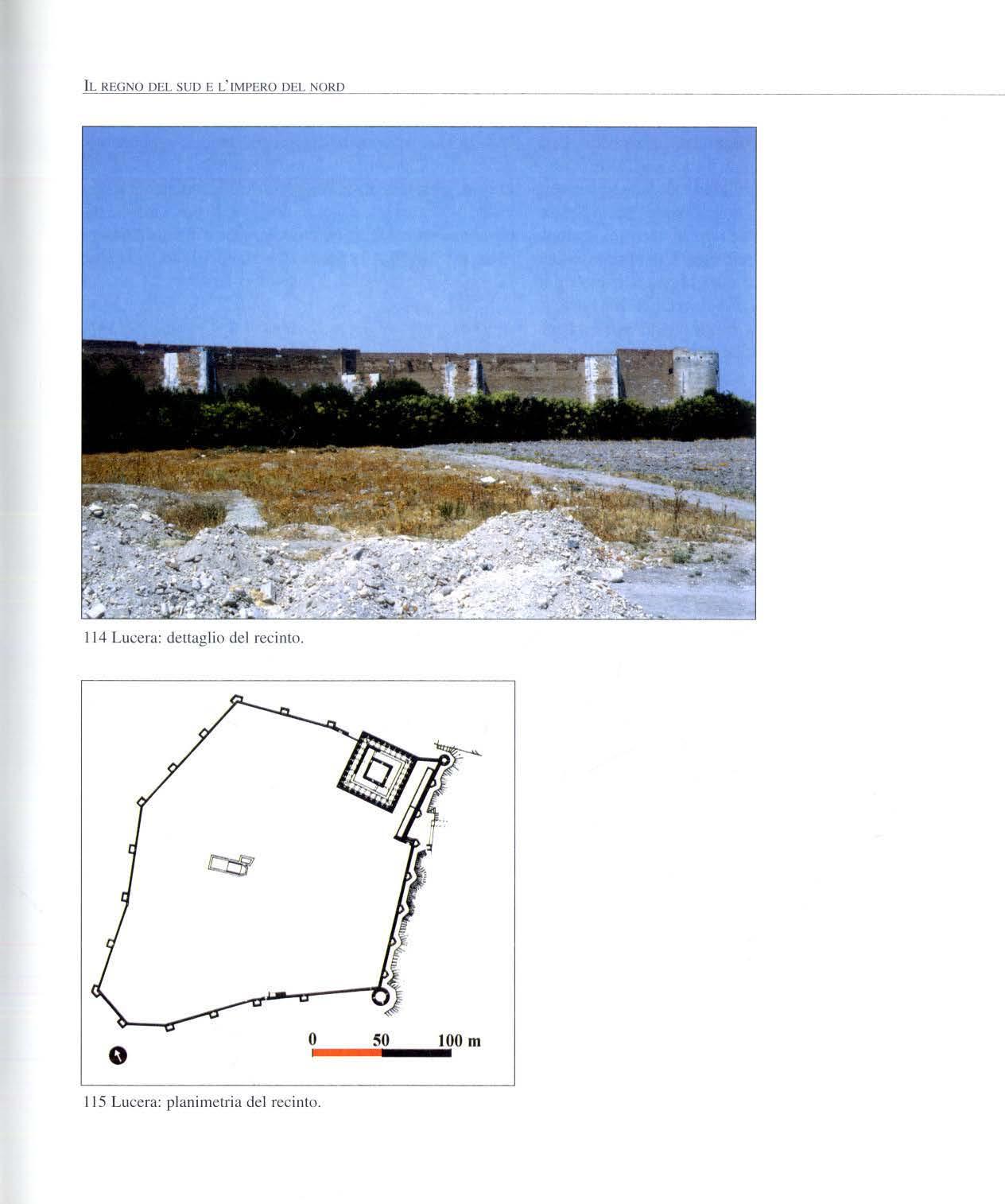
suoj abitanti, infatti , avevano dissodata la terra circostante, di cui pagavano regolarmente il canone di affitto (oltre alla tassa p er la tolleranza religiosa, di is lamica invenz ione) ripris tinando , con il ritrov a to benessere e l'esplicito in coraggiamento di Fe derico , la loro tradizionale soc ietà . Si erano dati un proprio capo e dei propri organi di poli zia, avevano costruito, oltre ai quru.ti e ri este rni al recinto, alquante mo schee con i relativi minare ti. lJ can1po di concentramento s i era, in pochi anni, tra sformat o in una laboriosa e pacifica cittadina araba.
Ne] frattempo il rispetto della dignità umana dimos trato dal giovane imperatore, la s ua innegabile capacità militare , la sua acce1tata fi erezza e la s ua indipendenza religiosa, p ersi no di fronte al pontefice, avevano suscitato il rispetto e l'ammirazione dei deportati. All'odio viscerale s ubentrò allora una venerazione fanati ca della quale, logicamente, Federico seppe subito avvan taggiarsi, differenziando le attività della co lonia. Tra i più pres ta nti ragazzi saraceni selezionò i migliori arcie ri ed i più es p erti g u errieri, fonnandone un di sti nto con tin ge nte militare . Ai contadini affiancò schiere di fabbri, 1inomati costruttori d'armi, c h e iniz iaron o a forgiare per l 'ese rcito imperiale lame e corazze . Anche le fanciulle furono s pinte a mettere a frutto l a l oro abihtà tessendo preziosi drappi e ricamando sfarzose vesti per il loro signore e padrone e per la corte. Giorno dopo giorno, la fiducia reciproca si rinsaldò: per i Mu s ulmani l'imp era to re di venne l ' indiscusso s ultano , e per Federi co gl i antichi nemici si trasfom1létrono nella s ua g uardi a imperiale, immune da qual sias i sco munic a.
E quanto tale rapporto si fosse radkato e co nso lidato lo dimos tra l ' edificazione, all'interno del recinto, ormai di venuto l'acq uaitieramento del contingente saraceno , di un sontuoso palazzo imperiale, una sorta di evolutissimo dongione, che Federico elesse a s ua dimora nei peiiocLi di residenza in zona. Per la fantasia popolare che, ormai s i s bizzaniva s ulle di sso lutezze d el 'sultano battezzato', protetto da sanguinari arcieri infedeli, era al s uo interno c he sc hiere di s pl endide odalische allietavano le notti di Federico in un crescendo di depravazion e e luss uria!
Significativainente i partecipanti al Concilio di Lion e avviatosi alla fine di giugno del 1245: " ... sapevai10 c he l a
vera ragione del conc ili o erano i peccati dell ' imperatore, e su di ess i Inn ocenzo scatenò l ' inv ettiva. I saraceni di Luc e ra, gli hare m di s til e mu s ulmano, le in1peratrici sorvegli ate da eunuchi, le alleanze di F ederico con i maomettani. .. tuue queste c olpe vennero sciorinate e dipinte ne i colori più scuri... "t 108> Alla fine il 17 lu g li o del 1245 Innocenzo rv, lo dichiarò destituito in questi tennini:
" Dopo aver sottoposto ad accurata disamina insieme con i nost:Ji fratelli e al sacro concilio. i delitti so pra elencati del prin cipe , e molti altri , in forza del potere di legare e sciog liere affidatoci da Cristo...dichiariamo e proclanùamo che il principe, il quale si è dichiarato iI1degno dell'impero e del regno nonchè cli tutti gl i o nori e dignità, a causa dei suoi peccati è ripudiato da Dio come im peratore e come re...Noi li togliamo a lui con questa sente nza e sciogliamo per se mpre dall'impegno quanti gli so no legati dal gi uramento cli fedeltà, e in forza dell 'a uto1ità apostolica vietiamo a chiunqu e di obbectirgli o di secondario d'ora in avanti co me imperatore o re. Disponiamo che chiunque in futw·o gli accordi il co nsiglio, l' aiuto e il favore incorra per ciò stesso nella scomu ni ca. Coloro cui spetta l'elezione neu unpero, devono eleggere senza indugi un successore. Sul regno di Sicilia disporremo Noi secondo il cons ig lio dei nostri fratelli ."'
Inu tile aggiungere c h e mai come in quella circosta n za la guardia saracena si mostrò solidale con l'imperatore , evitando qualsiasi ribellion e.
Dal punto di vista arc hitetto ni co, quel malfamato palazzo impe 1iale : " ... del quale oggi rimane so lo una piccola parte, dovette essere un altissimo donjon ... imp os ta to su di uno zocco lo quadrilatero sc ai-pato anch 'ess o a due piani , dei quali quello s uperiore al livell o del teITe n o e quello inferi ore so tteITaneo.
Qu esto torri o ne dov ette avere all ' interno un piccolo cortile ed essere quadro nella parte bassa ed ottagonal e nel piano più alto, come vediamo dai di segni del vedutista Depr ez, reali zz ati n el 1778 Ric c hi ss imi motivi ornamentali romanico-gotici lo adornavano. All ' interno si custodiva una raccolta di sc ulture classiche [ed] una parte del teso ro di Stato, dato che nel castello vi era s i s temata una delle zecc h e imperiali "e I 10)
Più difficil e, in vece, stab ilire l'aspetto originale del r ecinto dis tinguendolo dalle s u ccess iv e alterazioni angioine. In linea di m ass ima, esso s i componeva di
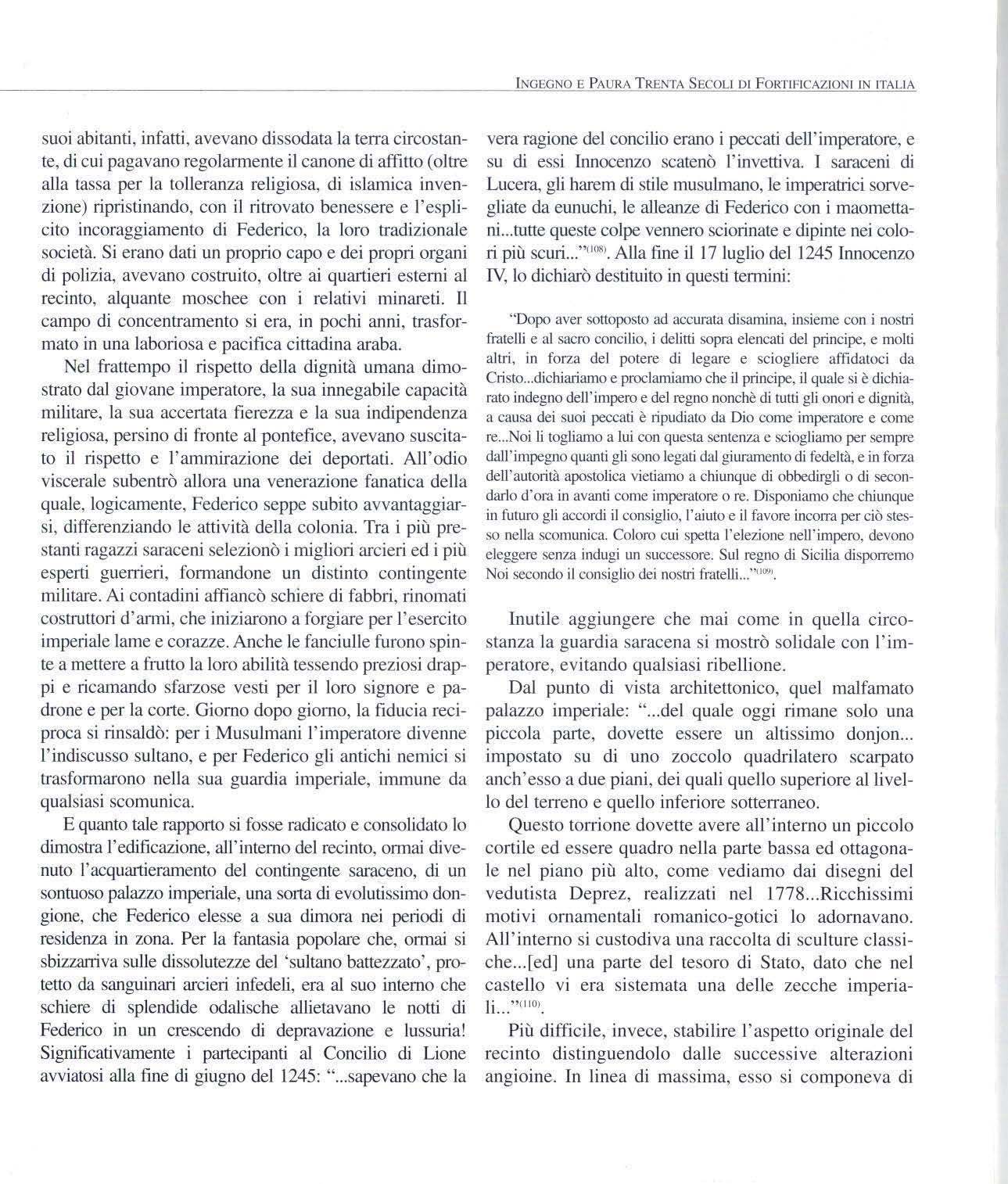 INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZION I IN ITALIA
INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZION I IN ITALIA

Junghi segmenti di cortine retti lin ee, alte ci rca l 3 metri, scandite da 24 torri, per lo più quadrate, che serravano al loro interno un ' area di oltre 8 ettari. Una più massiccia muraglia si eresse a sbarramento del lato meno ripido, ed in essa si collocò la porta d'ingresso, strutturandola con impianto sceo . Va rilevato che le 7 torri rompitratta che muniscono questo lato sono tutte del tipo dei punt01ù di Prato, ovvero a pianta pentagonale con lo spigolo verso l'esterno, mentre quelle d'angolo sono cilindriche . L 'adozione deve allora verosinùlmente inquadrarsi in un programma di potenziame nto della capacità difensiva del recinto, che infatti , ottenne così un asso luto dominio del terreno a nti stante, essendo privo del s ia pur minimo settore defilato e quindi perfeltamente idoneo agl i arcie ri saraceni che ne costituirono, da un certo momento in poi, la guarnigione. P ertanto è probabile che la primitiva cerc hi a acquisì le caratteristiche di una grande base fortificata , forse in previsione o in concomitanza della costruz i o ne del palazzo che Federico volle ubicato proprio alle spalle dello spigolo orientale di questa tratta. Disgraziatamente: " non essendo in possesso di alcun documento, no n possiamo indicare con certezza 1' anno in c ui Federico fece iniziare la costruzione del palazzo della colonia sarace n a, ma quasi sicuramente ciò avvenne intorno al 123 3 ... " 01 11 •
Tuttavia, la cinta c he attualmente recinge il pianoro, con uno sviluppo di circa 900 m, da molti studiosi, è attribui ta all'iniziativa di Carlo d'Angiò a partire dal J 269. A lor o parere in precedenza la co lonia saracena sare bb e stata: " se nza mura nè torri fe] si svilu ppò sull'a ltipiano , come città apert a " <11 21 • Tal e tesi, però, co'1trasta con la logica dei s ucc essivi avve nim e nti , poicbè se nel 1269 Carlo d'Angiò: "es pu g nò la fortezza e costruì l a gigan te sca cinta " <J1 3 \ quale sa rebbe stata la fmtezza esp ugnata? Non certo il palazzo di Federico c he, nùlitarmente parlando, non s i config urava nemmeno co me castello! D el resto altri autori ricordano che la g uarni g ion e saracena insorse contro l'odiato angioino nel 1268 , in conseguenza della discesa di Corradino di Svevia, fornendogli cos ì il pretesto per l'eliminazione di quel caposaldo , c orre ntemente defi-
nito la 'Chiave di Puglia', proprio per la sua notoria valenza stnitturale. Perchè avendolo distrutto Carlo d ' Angiò avrebbe dovuto ricostruirlo e, se i saraceni erano stati annientati, per chi?
Ovvio, pertanto, 1itenere che, ancora una volta, si ebbe dopo l ' avvicendamento dinastico soltanto un intervento di riqualificazione o di potenziamento, non nutrendo, peraltro, il nuovo sovrano un concreto interesse per tale fortezza, e meno c he mai per i suoi saraceni, dai quali del resto era fortemente detestato. In oltre la sostanziale identità architettonica e funzionale fra le to1Ti pentagonali di Prato e quelle di Lucera accredita la matrice sveva di quest'ultime, diversissima dal canone angioino che preferi sempre toni cilindriche, senza dubbio più arcaiche , ma precipue della cultura castellana francese. E forse proprio le due torri cilindriche all'estremità della tratta in questione , quella detta della Leonessa o della Regina, alta m 25 con m 14 di diametro e l'altra più piccola detta del Leone, rappresentano appunto l'esito dell'acclarato intervento angioino Più a ttendibile, in conclusione, che: " .le mura, dopo parziali immediati smante ll amenti, furono ricostruite dallo stesso demolitore fra il l 268 ed il 1283 che provvedeva ad integrare il largo fossato ... " <114 > , forse in previsione di un possibile impiego, manifestatosi poi infondato .

Con la scomparsa dell'imperatore per la co l on ia di Lucera ini ziò un rapido tramonto. La ricordata in surrezione del 126 8 fu la sua ultima certifi cazione di esiste nza. Estinta la dinastia sveva fin ì smembrata e distnitta. All'interno del recinto vennero concentrati branchi di maiali. Qu anto al magnifico dongione ne seguì l a so rte, su be ndo devastazioni a ncora maggiori, più radicali e protratte ne l tempo: persino alla fine del XIX secolo si impiegarono cari che di es plos ivo per demolirne gli estremi ruderi!
Immancabilmente ogni tratt ato s ull 'architettura sveva si sofferma su l le ggendario Castel del Monte.
INGEGNO E PA URA TREN TA SECOLI DI FORTIFICAZIONI I ITALIAO 5 10 m
l 18 Andria: planimetria di Caste l del MonLc.
Eppure l ' unica certe zza che si ha su questa stup efacente costruzion e, 1iten uta il cas tello fede ri ciano per antonomas ia è, paradossal m e nte , il suo non essere castello, ma, forse, una sp l e ndida e s ugges tiva re si d e n za fortificata. Per il re sto non si sa nemmeno se Federico vi abbia mai potuto soggiornare o addirittura se abbia potuto vederla u ltimata , se bbene alcuni studios i ritengono che sia stato lo stesso imperatore a progett arla perso nalmente
Molto più verosimilmente Fed erico avrà s tudiato, deJI' a ll ora d e tto castello di Santa Maria, i pro ge tti co n l 'abituale curiosità e ma gar i s ug gerito alcune modifiche o alcune lin ee guida, limitandos i, per il resto, a so llecitare l' ultimaz ion e. Esiste, infatti , un: " .. .uni co documento in prop osi to , che, però, h a s usc it ato sempre tante contraddizioni per la s ua in terp re tazio ne da non esserc i di alcun aiuto. Il 28 ge nnaio del 1240, l' imp erato re impartì da Gubbio , al gi us ti zie re della Capitanata, l'ordine di ini ziare il pavimento nel castello di
Santa Maria, che doveva essere di pietra caJcarea e di altri mate riali affini ... [per il resto] sarebbe incomprensibile che nessun accenno fosse s tato fatto ad un soggiorno dell 'i mperatore qui , se bbene s i sappia con ce rtezza che più vol te negli ultimi anni di regno Federico soggiornò per lun ghi periodi nelle vicinanze di Castel del Monte. " 1 115 > È comunque credibile che alla sua morte il castello fosse se non ultimato prossimo ad esserlo, non rintracciando s i alti.imenei chi avrebbe avuto in teresse a farlo.
Architettonicamente s i compone di un corpo ottagon a le , con un corti l e centrale anch'esso ottagonale, e di otto torri, sempre ottagonali, innestate agli spigo li estern i. Verticalmente è ripart ito s u due piani , ciascuno di otto camere, tutte ugual i fra l oro a trapezio isoscele . In quattro torri s i trovano altrettante scale a chiocciola. L 'o rientamento, determinato dall'asse del portale è perfettamente coi nc id ente con i quattro punti cardinali. Per l a s in go lare opzione p lanimetrica il fiancheg giamento è talmente penalizzato d a l far escludere a priori q ualsiasi ip otes i di impiego difen sivo di tipo militare. Del resto la sfarzosissima decorazione interna, l ' impiego dì marmi policromi e pre g iati per il rive s tim ento delle pareti , i sofisticatissimi impia nti igienici con acqua co rre nt e, ecc ., confenna no, inequivocabilmente, la de stinazione residen ziale dell 'edificio. Sponta neo allora chiedersi: " .. .per quale scopo Federico lo avesse fatto erigere. Certo , malgrado la s ua perfezione , potre bbe essere sta ta una costruzione puramente funz ional e, e non un castello di caccia; o rispondendo ad esigenze più particolari, essere s imbol o di potere o esprimere una sacral e rappre se ntazione nel profano; o forse ancora, fu rea li zza to propri o qui, prima del rinasc imento , un ese mpio di architettura ideal e completamente fine a se stessa? I tentativi di dare un a rispo sta a qu est i que si ti sono quasi infiniti " <11 <»
Quale effettivamente sia s tata la genesi di quella sp lendida residenza c i è del tutto ignoto, mentr e, inv ece, ci è perfettamente noto il s uo impiego s ucce ssivo, particolarmente atroce p er gli eredi di Federico. D opo la cattura, a Trani, d e lla moglie di Manfredi che finì impri g io nat a, con la figlia, in Castel de ll'O vo a Napoli,

da dove so lo quest ' ultima, nel 1284, u scì viva, i suoi piccoli ss imi figli ma sc hi EITico, Azzolino, e Federico, vennero rinchiusi a Caste l del Monte. Tra quelle mura trnscorsero una durissima prigionia: soltanto Errico sopravvisse abbastanza a lungo, per essere trasferito, dopo quasi 40 anni di detenzione, e sempre da prigioniero, a Napoli, dove morì poco dopo f111 l
Abbiamo, in precedenza, più volte ricordato, e Castel del Monte ne è la mass ima manifestazione, la componente esoterica che influì sulla progettazione della maggior pat1e dei castelli federiciani. Nessuna meraviglia, quindi, che l'imperatore, ad onta ciel suo proverbiale scetticismo, credesse se non nelJa magia almeno nell 'as trologia, peraltro all'epoca reputata scienza. Secondo la tradizione, apprese così che sarebbe morto presso una porta di fe1To, in un luogo dal nome di 'fiore'. Da quel giorno Federico si guardò bene dal recarsi a Firenze, o in quals iasi altro posto che avesse una qualche assonanza toponomastica con i fimi.
AJla fine di novembre del 1250, mentre in viaggio da Foggia verso Lucera, si sentì mal e durante una battuta di caccia. Fu trasportato nel più vicino castello, dove le s ue condizioni s i aggravai·ono al punto che, il 1° dicembre , pareva imminente la morte. Tuttavia, nei giorni seg uenti si riprese, almeno quel tanto che bas tava per redigere i l te stamento. Terminato l'atto chiese dove si trovasse e, saputo c he stava nel castello di Fiorentino, ebbe un s inistro presentimento . Avendo osservato: " ...che il suo letto era collocato contro una porta allora murata .. .fece abbattere il m uro e vide che nascondeva una porta di fe1To ...Guardando la po1ta esclamò: « Mio Dio, se è ora che io ti renda l 'anima, la T ua vo lonta sia fatta» " n 18 1 • Il 13 dicembre , dopo aver 1icevuto i sacramenti ed indossata la bianca veste dei monaci cistercensi, spirò. Con un solenne funerale tornò a Pale1mo, dove riposa nella cattedrale in un sarcofago di porfido rosso.
D i ca5tel Fiorentino restano al presente insignificanti ruderi.
 1 19 Andria. veduta di Castel del Monte.
120 Andria: dettaglio torri di Castel del Monte.
INGEGNO E PA URA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITAUA
1 19 Andria. veduta di Castel del Monte.
120 Andria: dettaglio torri di Castel del Monte.
INGEGNO E PA URA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITAUA
1 Da H.PIRENN E, Storia d'Europa dalle invasioni al XVI secolo, rist. Roma 199 J. p.38.
1 Da H.PIRE NN E. Storia , cit p.39.
1 Da H.A.L.F1SHER. Storia d'Europa. Milano 1964, p.194.
• Da H A.L.FISHER. Storia , cit p.195.
5 Precisa al riguardo J.F.C.FULLER, Le battaglie decisive del mondo occidentale. r ist. Roma 1988, voi.I, p.308: "Sappiamo ben poco della battaglia, e neanche resatto luogo ove essa fu combattuta; la data è l'ottobre del 732. Probabilmente il p1imo contatto avvenne vicino a Tours e si trattò di una scararnuccia...Carlo organizzò l'esercito in <.olide falangi, imperniate sulle truppe franche. Isidoro de Beja lo chiama 'un esercito di europei'. essendo composto di uomini di differente origine e linguaggio ".
" Da C.H.BECKER. L'espansione dei saraceni ili Africa e in Europa, in Storia del Mondo Medievale, Milano 1979, voi.II, p.79.
' Ricorda P.MARAY IGNA. Storia dell'arte milirare moderna. Torino 1926. voi.I. pp.43-44: "La civiltà medievale non comportava l'esistenza di una organizzazione militare speciale. permanente; !"esercito si identifica con l'aliquota della popolazione che godeva il diritto di portare le armi pcr conseguenza esso consisteva in una riunione temporanea di combattenti di pari grado sociale e quindi militare. Ogni calcolo esulava dall'arte di condurre eserciti siffatti. che si riunivano nel momento d'impiegarli e che si scioglievano per volontà dei singoli componenti, in base a dirilli prestabiliti ed emanati dalla costituzione sociale cosicchè ciascun signore rispondeva al bando del sovrano seguito da un numero variabile di cavalieri, scudieri. paggi e gentiluomini, propri i vassalli e rimaneva in campo per un periodo di tempo variabile da un minimo di pochissimi giorni ad un massimo di quaranta La prima ed importante conseguenza di siffalla organizzazione degli eserciti, era quella che la condotta delle operazioni si limitasse alla battaglia Di strategia in quest'epoca non è il caso di parlare; ma non è neanche il caso di accennare alla tattica. poichè l'urto della massa si scomponeva in una serie di duelli individuali ". Ovvio che in tale contesto la conduzione di un assedio esulasse completamente dalle procedure correnti.
Da W.H.MC NEILL, Caccia al porere, tecnologia, armi. realtà sociale dal{ 'anno Mille. Milano 1984, p. I 8.
' ln particolare, precisano R.A.PRESTON, S.F.W1SE, Storia sociale della guerra, Verona 1973, p.85: '·La staffo accrebbe grandemente l'efficienza della cavalleria. consentendo a un cavaliere seduto saldamente di vibrare un colpo possente con la lancia o di alzarsi dalla sella per usare la spada con maggiore potenza ...".
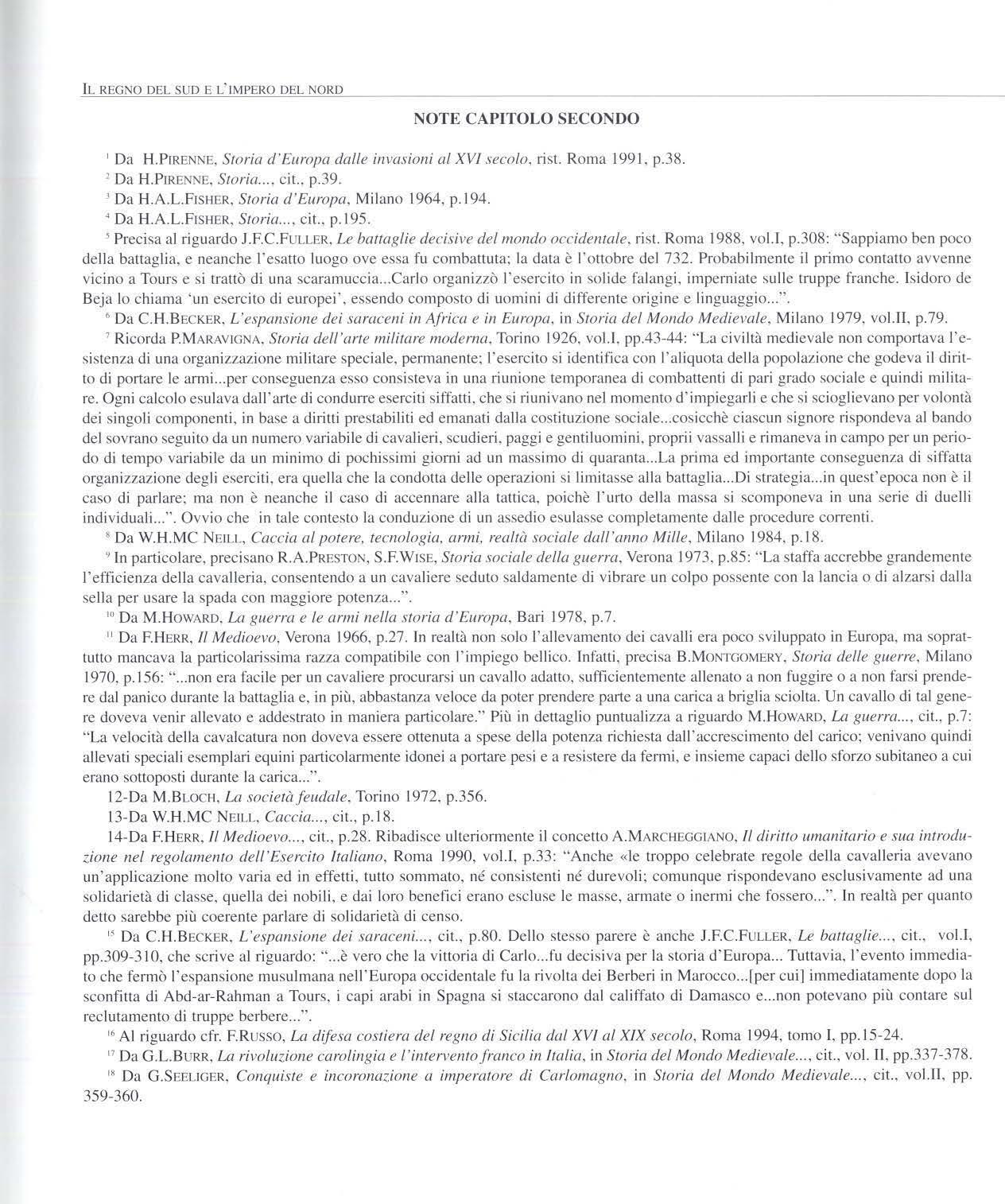
10 Da M.HOWARD. La guerra e le armi nella storia d'Europa, Ba1i 1978. p.7.
11 Da F.HERR, li Medioevo, Verona 1966, p.27. In realtà non solo l'allevamento dei cavalli era poco sviluppato in Europa , ma soprattullo mancava la particolarissima razza compatib ile con l' impiego bellico. lnfalli, precisa B.MONTGOMbRY. Storia delle guerre. Milano 1970. p. 156: " ... non era facile per un cavaliere procurarsi un cavallo adatto, sufficientemente allenato a non fuggire o a non farsi prendere dal panico durante la battaglia e, in più, abbastanza veloce da poter prendere parte a una carica a briglia scio lta. Un cavallo di tal genere doveva venir allevato e addestrato in maniera particolare:· Più in dettag lio puntualizza a 1iguardo M.J IOWARIJ, La guerra ... , cit., p.7: "La ve locità della cava lcatura non doveva essere ottenuta a spese della potenza richiesta dall'accrescimento del carico; venivano quindi allevati specia li esemplari equ i ni pa1iicolarmente idonei a portare pesi e a resistere da fermi, e insieme capac i dello sforzo subitaneo a cui erano sottoposti durante la carica .' '
12-Da M.BLOCII, La società feudale. Torino l 972. p.356.
13-Da W.H.MC NEII.L. Caccia , cit., p.18.
14-Da F.HERR, // Medioevo , cit., p.28. Ribadisce ulteriormente il concetto A.MARCHEGGIANO, lf diritto umanitario e sua introdu;,ione nel regolamento deff 'Esercito Italiano, Roma 1990, vol.l, p.33: "Anche «le troppo celebrate regole de ll a cavalleria avevano un'applìcazione mo l to vaiia ed in effetti, tutlo sommato. né consistenti né durevoli; comunque rispondevano esclusivamente ad una solidarie tà di classe, quella dei nobili, e dai loro benefici erano esc l use le masse, annate o inenni che fossero " . In realtà per quanto dello sarebbe più coerente parlare di solidarietà di censo.
' " Da C.H.BECKER. L'espansione dei saraceni , cit.. p.80. Dello stesso parere è anche J .F.C.FULLER. Le battaglie , cit., voi.I, pp.309-3 10. che sc1ive al riguardo: ·'...è vero che la vittoria di Carlo .. .fu decisiva per la storia d'Europa ... Tuttavia, l'evento immediato che fermò l'espansione musulmana nell'Europa occidentale fu la rivo l ta dei Berberi in Marocco fpcr cu i l immediatamente dopo la sconfitta di Abd-ar-Rahman a Tours, i capi arabi in Spagna si staccarono dal ca l iffato di Damasco e ... non potevano più contare sul reclutamento di truppe berbere ...".
16 Al riguardo cfr. F.Russo, u1 difesa costiera del regno di Sicilia dal XVI al XIX secolo, Roma 1994, tomo I, pp. l 5-24.
17 Da G L.BURR, La rivoluzione carolingia e l'intervento ji-anco in //alia, in Storia del Mondo Medievale , cit , voi. Il, pp.337-378.
1" Da G.SEELIGER, Conquiste e incoronazione a imperatore di Carlomagno. in Storia del Mondo Medievale... , cit., voi.IL pp. 359- 360.
•
10 Da F.L.CARSTEN, Le origini della Prussia, Bologna 1982, p. 16.
10 Da H.PIRENNE, Storia cit., p.75.
11 Da H.PIRENNE, Storia cit., pp.77-78.
22 Da G.SEELIGER, Legislazione e governo di Carlomagno, in Storia del Mondo Medievale... , cit., voi.TI, p.455 .
11 Da M.BLOCH, La socielù cit., pp.423-424.
2 • Da F.CONTI, Castelli del Piemonte, Milano 1975, p.17.
15 Da A.MAWER. I Vichinghi, in Storia del Mondo Medievale ... , cit., pp.749-750.
16 Da M.BLOCH, La società ... , c it., p.436.
11 Da M.HOWARD, La guerra , cit., p.21.
211 Da M.BLOCH, La società... , cit., p.425.
29 Da J.LE GOFF, La civiltà dell'Occidente Medievale, Torino 198 I , p.70.
"' Da M. BLOCH, La società , cit., p.461.
\i Da M.BLOCH, La società , cit., p 449.
12 Da H.A.L.FISHER, Sroria .. . , cit., p.236.
13 Da E.PONTIERI, Tra i normanni ne/l'Italia meridionale, Napo li 1964, p.71.
14 Cfr. P.BELLJ D'ELIA, Aceptus, in La Puglia fra Bisanzio e f'Occide111e, Milano 1980, p.143.
35 Cfr. S.RUNCIM AN, Storia delle Crociate, Torino 1976, voi.I, p.42.
36 Da S.R UNC IMAN, Storia , cit., pp.49 -50

37 Cfr. C.A. WILLEMSEN , D.0DENTHAL, Puglia terra dei Normanni e degli Svevi, Bari I978. p.13.
18 Cfr. J.N.D.KELLY, Vite dei Papi, Asti 1995. pp.255 -257.
39 Cfr. F.Russo, La difesa costiera del regno di Sicilia , cit., tomo 1, pp.23-29.
0 Da G.JONES I Vichinghi, Roma 1978, pp.428 -42 9, nota n° 6.
41 Da G.JO NES, I Vichinghi , cit., pp.428-429, nota n° 6.
41 Cfr. E.DE LEONE, La colonizzazione dell'Africa del nord, Padova 1957, pp.31-32.
1 Da F.BARBAGALLO, Storia della Campania, Napoli 1978, voi.I, p.150.
•• Da L.SANTORO, Tipologia ed evoluzione dell'architettura militare in Campania. in Arch.Stor.Prov.Nap., terza serie, voi. VII -VIII (1968-69), Napoli 1970, p.106.
45 Da M.BLOCH, La società feudale, Torino I975, p.341.
"6 Da LHOGG, Sroria delle fortificazioni, Novara 1982, pp.38-45.
47 Da L. SANTORO, Tipologia , cit., p. 106.
48 Cfr. E.C rusA, Pagine per una storia di Pietrame/ara, in Cinque secoli di storia nell 'a lra provincia di Terra di Lavoro, All i Co nv. Naz. Pietramelara 14- 15 giugno 1996, Roma 1996, pp.72 -73.
"'' Cfr. LA.MURATORI, Rerum ltalicarum Scriptores, Milano 1732 tomo II, parte V, p.293.
50 Da C.GHIRARDACCr, Historia di Bologna, tomo Tl, p.386, La citazione è tratta da E.ClUSA, Pagine , cit., pp.73 -7 4.
51 Da L.CHIUMENTI, La consistenza architettonico-urbanistica del nucleo urbano di Pietramelara. Ipotesi di ricerca sulle ma1rici fo11damen1a/i, in Cinque , cit., p.90
52 Per uno scorcio d'insieme sull'argomento cfr. M.DE M ARCO, Torri e castelli del Salento, Lecce 1994, pp.3-94. Per notizie più dettagliate e vaste cfr. R.De VITA , Castelli, torri ed opere fortificate di Puglia, Milano 1982, pp.44- 147.
51 Cfr. J .HOGG, Sroria .. . , cit., p.41.
5 • Da M.ROTILI, Archeologia postclassica a Torello dei Lombardi. Ricerche nel Castello Candriano (1993 - 97), Napoli 1997, pp. 16 - 17.
55 Da M.R cmu, Archeologia , cit., pp.16 - 17.
s• Cfr S.MOSCARlELLO, Mantella tra note e immagini, Avellino 199 1, pp.147- 154.
51 Da F.MAURICI, Castelli medievali in Sicilia. Dai bizantini ai normanni, Palermo 1992, p.176.
58 Da F.MA URICI, Castelli , cit., pp. 178-179.
59 Circa la comparsa della balestra, già prima del mille ne è documentato l'impiego bellico in Europa. Precisa C.DE VITA, al la voce Balestra, in Enciclopedia ragionata delle armi, Verona 1979, p. 89: " ... nel success ivo Xl seco lo è presente in l nghilterTa e nelle regioni dell'estremo nord, importata probabilmente dai Normanni ". Cfr. W.REm, La scienza delle anni dall'erà della pietra ai nostri giorni, Milano 1979, pp.45-48
INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIA<.o Da S.RUN CIMA N, Storia , cit., voi.I, p.74.
6 1 Da S.RUNCIMAN, Storia , cit.vol.I, p.80
61 Da G.LANGE, Architettura delle Crociate in Palestina, Como 1965 , pp.90-91.
6 1 Da L.SANTORO, Tipologia , cit., p. I 07.
64 Cfr.G.LENZJ, Il castello di Melfi e la sua cos truzione, Roma 1935, pp.53-59.
6 l Da C.A.WILLEMSEN, D.0DENTHAL, Puglia , cit., p.13.
66 Da G.TORRIERO, Il Castello normanno di Casaluce, in li restauro dei castelli nell'Italia meridionale, Atti Caserta 10-11 marzo 1989, pp.116 - 117.
67 Da U.BALZANI, Federico Barbarossa e la Lega lombarda , in Storia del Mondo Medievale , cit., voi.TV, pp.896-897.
68 Da E.KA NTOROWICZ, Federico Il, imperatore, Milano 1976, p.6.
69 Cfr.G.MASSON, Federico Il di Svevia, Milano 1978, pp.21 -2 7.
7° Cfr. D.MACK SMITH, Storia della Sicilia medievale e moderna , Bari 1971, pp.67 -8 4.
71 Da E.KANTOROWICZ, Federico ... , cit., p.23.
72 Cfr. F.L.CASTERN, Le origini , cii., p.19.
11 Da E.KANTOROWICZ, Federico ... , cii., p.83.
74 Da G.MASSON , Federico , c it., p 93
75 Da R .MORGMEN, Medioevo cristiano, Bari 1978, p.171.
76 Da E.KANTOROWICZ, Federico , cit., p. I 04.
77 Da E.KANTOROWICZ, Federico ... , cit., p.107.
78 La citazione è tratta da G.L ENZ I, Il cas tello , cit., p.75
7Y Da G.LENZI, Il castello , cit., p.76.
• 0 Da G.LENZI , Il castello , cit., p.86.
"' Da G.LENZI, Il castello , cit., p.85.
82 Da C.A.WILLEMSEN, D.0DENTH/\L, Puglia , cit., p.26.
83 Da E.KA NTOROWlCZ, Federico , cit., p.108.
84 Da LSANTORO, Tipologia cit., p.116. Sulla ques tione della matrice orientale cfr. A.CADEI , Archit ettura federiciano. La questione delle componenti islamiche, in Nel segno di Federico Il, atti del lV Conv.lnter. di Studi della Fondazione Napoli Novantanove, Napoli I 989, pp. I43 -1 58. Ed anche cfr. S.LANGÈ, Architettura della crociate in Palestina, Como 1965 , pp.129-133.
81 Da E.K.ANTOROWICZ, Federico ... , cii., p. 108.
86 Da G.D E FLORENTIIS, Storia delle armi bianche, Milano 1974, p.136.
87 Da G.DUBY, L'arte e la società medievale, Bari 1977, p . 148.
88 Cfr.F.Russo, Canoni dell'architetturafedericiana nel Castello di S.Felice a Cancello (Caserta), in l ' Universo, riv.I.G.M.I., anno LX, n° 5, Firenze 1980, pp.857-874.
89 Cfr. L. SANTORO, l 'a rchitettura militare sveva in Campania, in Scritli in onore di O.Morisani. Catania 1982, pp.117 - 126.
\IO Da E.KA NTOROWICZ, Federico ... , cit., p.8 1.
9 ' Da G.MASSON, Federico , cit., pp.96-97
92 Da L. B1ANClilNI, Della storia delle finan ze del Regno di Napoli, Palermo I 839, p.82.
91 Da F.R usso, la d!fesa costiera del regno di Sicilia , cit., tomo 1, p.31.
94 Da A.CASSI RAMELLI, Castelli e fortificazioni, Milano 1974, p.176.
91 Da R .DE VITA, Castelli , c i t., p.409.
96 Da C.A.W ll, LEMSEN, / Castelli di Federico Il nell'Italia meridionale, Napoli 1979, p.31.
9 1 Da L.D UFU R, Augusta da città imperiale a città militare, Pa lenno 1989, p.28.
98 Da A.CASSI RAMELU , Castelli , cit., p.125.
Il'> Cfr.C.A.WTLLEMSEN, Componenti della cultura federiciana nella genesi dei castelli svevi, in R.DE VITA, Castelli , cit., pp.422.
100 Cfr.D.PALLONI, La transi zione , in Rocche e bombarde, di M.MAURO, Ravenna 1995, pp.15-19.
101 Cfr. F. Russo, Ragguaglio sul seuore defilato, i n C.ROBOTTI , Capua, Lecce 1996, pp.137-148

102 Da R. DE VITA, Castelli , cit., p 89.
1 <>J Da R DE VITA, Castelli , cit., p. l LO.
104 Da R.DE V1TA, Castelli , cit., p.132.
0 ' Da S.BURGARETTA, I segni dell'uomo, in Vendicari, Palermo 1991, p .109 .
106 Da A.CASSI RAMELLI, Castelli , c it. , p 172.
'
07 Circa la sch i av itù militare nell'Islam cfr. B.LEw1s. Ra zza e colore nell'Islam, Milano 1975. pp.58-71.
'
0 ~ Da G.MASSON, Federico , ci t. , p.403.
,e"' La citaz i one è tratta da F.HERR, Il Medioevo , c it. , p. 324.
11 0 Da R.DE VITA, Castelli cit., p.54.
11 1 Da C.A.WILLEMSEN, / Castelli cit.. p.38.
112 Da R.DE VITA, Cas,elli , c it. , p.51.

11 ' Da R.DE VITA, Castelli , cit. p.54.
"' Da A.CASSI RAMELLI, Dalle caverne ai rifugi blindali. Milano 1964, p.95.
11 i D a C.A.WILLEMSEN, / Castelli... , cit., p.48.
116 Da C.A.WILLEMSEN, I Castelli , cii., p.51.
"' Cfr. G.A.LAURIA, Castel del Monte, Napol i l 86I. pp.43-58.
118 Da G.MASSON, Federico cit., p.93.
Come osservato nella premessa, le massime costruzioni dell ' umanità possono sempre agevolmente ricondursi alle istituzioni religiose e militari, in una sorta di simbiosi mutualistica. Nel Medioevo cristiano, però, l'esigenza di stabilire un primato fra i due poteri determinò la logorante dialettica fra Chiesa ed Impero. Progressivamente, fra i due contendenti andò ritagliandosi crescente rilievo un terzo attore, destinato ad assumere, col trascorrere dei secoli, un ruolo politico determinante , fino ad affennarsi quale unico vincitore: la borghesia. La dinamica classe sociale, almeno inizialmente, non era costituita dagli abitanti delle antiche città, tradizionalmente passivi e parassiti, ma dai residenti nei borghi dai quali dipendevano la formazione e la distribuzione delle risorse primarie.

Tra il potere della fede ed il potere delle armi s'incuneò così quello del denaro, di per sè privo di forza autonoma ma perfettamente in grado di condizionare inesorabilmente gli altri due. Non a caso i prodromi del suo avvento si colgono nel drastico ridimensionarsi dell' ignoranza e del feudalesimo, entrambi causa ed effetto della stagnazione materiale e culturale precipua dell 'ultimo terzo del primo millennio. La logica della produzione e del commercio, infatti, imponeva una più consistente alfabetizzazione ed un più vasto mercato. Ma, affinchè potesse attingere le massime potenzialità propulsive occorreva, esattamente come ad un incendio , un minimo periodo di innesco e di propagazione. Esso nella fattispecie corrispose a quella singolare e straordinaria ripresa che si registrò a cavallo fra il X e l'XI secolo, avviatasi nei borghi rurali e rapidamente trasferitasi negli asfittici centri urbani. Se, infatti, il collasso dell'Impero romano aveva trasformato la sua vitale e capillare impalcatura socio-amministrativa in uno spettrale e sterminato cimitero di città, da quel momento proprio fra quelle fatiscenti rovine divampò una
vigorosa rinascita, quasi una resurrezione.
La città, peraltro mai definitivamente estinta ma pesantemente ridimensionata ed emarginata, conobbe così un suo nuovo ciclo esistenziale, acquisendo in pochissimi decenni una predominanza economica e politica che non fu più possibile sottovalutare, ed, ovviamente, una incoercibile aspirazione all'autonomia. In s intesi in: " .. .Italia, [per ] l'assenza di un'autorità centrale più pronunciata che in Germania le città riuscirono a trar profitto dalle continue lotte tra il papa e l'imperatore. Questo sembrò dare al movimento un carattere più politico; ma come altrove, fu la ricchezza accumulata e l'importanza commerciale a mettere le città in grado di sfruttare la situazione politica " <1 1 •
E poichè nulla più dell 'ap parato militare richiede denaro , la ricchezza prodotta dall'iniziati va borghese fu, in breve tempo, in grado di sostenere truppe cittadine ottimamente armate ed addestrate. Gli orgogliosi eserciti imperiali impararono, a loro s pese , non solo a tenerne debito conto ma, soprattutto, a temerne il confronto campale avendo realizzato che contro siffatte milizie, razionalmente organizzate e fortemente motivate, poco poteva persino il valore disperato della cavalleria. Per molti aspetti fu quella la conclusione della fase più oscura del Medioevo, costituendo una netta cesura tra l'epilogo della società barbarica ed il prologo della società comunale.
Per quanto delineato, alle spalle della rinascita urbana deve collocarsi il fenomeno dei borghi prima e dei comuni poi: del resto tutte le città indipendenti di quel vivacissimo scorcio storico si definirono tali. In ogni caso, però, il: " comune non diventa, subito, e senz'altro, una cosa identica con la città e la sua costituzione; non soppianta subito ogni diritto signorile. Vi sono luoghi ove si andrà innanzi per un secolo e più in una condizione intermedia, di compromesso e confusione, in cui
non si sa veramente da chi, a rigore, la legge emani e quale sia il limite tra le due autorità ... " < 2 •
Dei borghi già è stata tratteggiata la genesi e le originarie caratteristiche architettoniche d'impianto, sostanzialmente similari dovunque. Più complessa e variegata risulta, invece, sia la trasformazione di molti di loro in città sia, più in generale, la rinascita di quest'ultime dopo il collasso provocato dalle invasioni barbariche: entrambi i fenomeni, tuttavia, sembrano ascrivibili ad un'unica motivazione. Infatti: " .il popolamento delle città nei dettagli ci sfugge. Ignoriamo in quale maniera i primi mercanti che vi si stabilirono sì installarono in seno alla popolazione preesistente o accanto ad essa. Le città, le cui mura racchiudevano spesso spazi vuoti occupati da campi e giardini, dovettero fornire all'inizio un posto che ben presto divenne troppo angusto. È certo che in molte di esse, a partire dal X secolo, i nuovi venuti furono costretti a stabilirsi fuori delle mura ... [AncheJ il popolamento del borgo fu detenninato dalle stesse cause che agirono nelle città, ma avvenne in condizioni abbastanza diverse. Qui, in effetti, mancava ai sopravvenuti lo spazio disponibile.
I borghi erano fortezze le cui mura racchiudevano un perimetro strettamente limitato, per cui fin dal principio i mercanti furono costretti a stabilirsi, per mancanza di spazio, al di fuori di questo perimetro. Essi costituirono, accanto al borgo, un borgo esterno, cioè un sobborgo (forisburgus, suburbium). Questo sobborgo è anche chiamato dai testi borgo nuovo (novus burgus) in opposizione al borgo feudale o borgo vecchio ( vetus burgus), al quale si è aggiunto. Per indicarlo si trova, specialmente nei Paesi Bassi e in Inghilterra, un termine che risponde mirabilmente alla sua natura: portus. Nel linguaggio amministrativo dell ' Impero romano si indica con portus non già un porto del mare ma un luogo chiuso che serve di deposito o da tappa per le merci .. .''(J>.
In italiano, di quella lontana vicenda, sopravvive il termine portico , anch'esso di per sè privo di qualsiasi attinenza con il mare . Ciò non esclude che tanti porti, o portici, medievali fossero concretamente tali, sebbene per lo più fluviali , lasciando arguire , ancora
una volta, che alla base dello sviluppo dei borghi e delle città prima, e dei comuni poi, abbiano giocato sempre i traffici e gli scambi a vasto raggio, inevitabilmente marittimi. Il fenomeno non deve stupire eccesivamente, considerando che, all'epoca, la continuità della superba rete stradale imperiale era scomparsa: al suo posto una miriade di rischiosi segmenti viari, resi tali dal crollo dei ponti e dal banditi s mo, ulteriormente frammentati da infinite barriere daziarie. Ovvio , pertanto, che le vie d'acqua, dolce o salata che fosse, costituivano senza confronto le migliori e le più veloci, prive per antomasia di limiti geografici, di sagoma o dì carico, senza pendenz e e senza usura , nonchè esenti da pedaggi e balzelli , s ituazione, peraltro, destinata a re sta re immutata fino al XX secolo.
Per tornare alla genesi dei borghi nuovi, alcuni s tudiosi ne s ubordinano la formazione al consenso, più o meno tacito, ad edificare le abitazioni all'immediato ridosso della cerchia del vecchio borgo. A loro avviso, infatti: " .. .la soluzione tipo fu quella di consentire che le abitazioni venissero erette lungo il perimetro esterno della cinta muraria, ma le conseguenze sono facilmente intuibili, perchè è evidente che la cinta muraria venisse a perdere la sua primitiva funzione difensiva. E non solo perchè le abitazioni ad essa appoggiate ne rendevano più facile la scalata, ma anche perchè si dovette rivelare assai precaria la condizione stessa dei loro abitanti, esposti com'erano alle ben prevedibili conseguenze di un qualsiasi assalto esterno. "< 4 >
L' ipotesi, però, proprio perchè le conseguenze erano fin troppo prevedibili, e per i vecchi abitanti e per i recenti, non sembra condivisibile. È di gran lunga più probabile , invece, ritenere che l'addossamento delle abitazioni alla vecchia cerchia fosse tollerato soltanto dopo la costruzione di una nuova murazione più ampia e solida, che avrebbe assicurato la protezione del!' intero nucleo residenziale, senza pericolose soluzioni di continuità difensiva. È altresì probabile che in tal modo si ponesse riparo all'inadeguatezza della vetusta murazione, incoraggiando i mercanti benestan-
 ING EGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIA
ING EGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIA
ti a realizzarne una più moderna e sicura in cambio della concessione di potersi stab ilire al suo interno. Al di là delle supposizioni , appare comunque certo che l'aumento del benessere abbia prodotto tanto l'ampliamento dei borghi, quanto la necessità di una mag g iore protezione. Esso, infatti, determinò un vistoso salto demografico, ma anche il miglioramento della consistenza e delle capacità offensive degli eserciti medievali, con il conseguente superamento del la tradizionale inettitudine ad espugnare persino le più rozze fortificazioni perimetrali.
Il processo, appena schematizzato, si attuò, in pratica, in un las so di tempo tutto sommato relativamente breve, in specie se paragonato ai lunghi seco li di inerzia precedenti. Gli agglomerati mercantili ed i sobborghi commerciali, a differenza di quelli meramente rurali e feudali, manifestarono immediatamente una vivacissima tendenza all ' espansione ed allo sv iluppo economico. La loro dinamicità li trasformò in polo attrattivo per numerosi altri aspiranti imprenditori e per s pregiudicati mercanti che ne gonfiarono incessantemente la rilevan za. Sotto il profilo residenziale, fatte salve le ovvie proporzioni, il fenomeno può equipara rsi all'odierno dilagare delle bidonville intorno alle metropoli: ma, mentre quest'ultime sono abitate da masse di diseredati e di emarginati, i sobborghi di allora ospitarono la componente sociale più agiata ed attiva. Sotto il profilo storico, invece, ricorda molto quanto verificatosi, quasi un migliaio di anni prima, intorno agli accampamenti romani, quando alla pletora di capanne erette a poca distanza dalla cinta, per motivi essenzialmente economici, finiva col subentrare una cittadina, che fagocitava la preesistente stru ttura militare dotandos i di una propria cerchia urbica. L'originario impianto castrense veniva testimoniato dalla permanenza dell'incrocio stradale ortogonale del centro.
Similmente , in moltissimi casi, all'inizio del XII seco lo, i nuovi borghi serrano completamente i vecchi , ai cui piedi si sono strutturati, costipandone le mura perimetrali e rendendole praticamente inutilizzabili. Ma, non essendo credibile neanche l'ipotesi di una presenza abitativa aperta, contestualmente al pro -
liferare di quel coacervo di abituri compare una seconda cerchia, resa indispensabile dalle ricchezze in es sa accumulatesi, irresistibile richiamo per predoni e saccheggiatori. La tumultuosità dell'espansione edilizia e la conseguente indetermin azione dimensionale urbanistica, tuttavia , co nsentono semplicemente l'adozione di una difesa perimetrale di tipo campale, ovvero non rigidamente fissata ma facilmente ampliabile, seb bene intrinsecamente fragile ed effimera: una palizzata, ad esempio, destinata all'esclusiva protezione notturna. Non appena, però, la situazione s i stabilizza , e le risorse disponibili lo permettono, quelle leggere difese sono sostituite da cerchie murarie tra le più avanzate possibili. In pratica so lo: " ... a partire dal XII secolo la prosperità crescente delle colonie mercantili permise loro di rafforzare la propria sicurezza cingendo i nuclei abitati di baluardi di pietra, fiancheggiati da torri, e in grado di re s istere ad un attacco regolare. Da questo momento furono anch ' esse fortezze. La vecchia cinta feudale o vescovile che continuava ad innalzarsi ancora al loro centro , perdette così ogni ragion d'e ss ere. A poco a poco si lasciarono a ndare in rovina le mura inutili ... " < 5 >
Modalità di ampliamento a parte, va comunque sottolineato che le due comunità residenti nei borghi non ebbero la medes ima definizione, quasi per ribadire e sottolineare la loro diversa origine. Infatti: " ... furono gli abitanti del borgo nuovo, cioè del borgo mercantile, a ricevere o, più probabilmente, a darsi l 'appellativo di borghesi [mentre] quelli del borgo vecchio ci sono noti sotto il nome di castellani o di castrenses. È una prova di più , e particolarmente significativa, che l'origine della popolazione urbana dev'essere cercata non tra la popolazione delle fortezze primitive, ma nella popolazione immigrata che il commercio fece affluire attorno ad essa e che , a partire dall'XI seco lo , cominciò ad assorbire gli antichi abitanti. "< 6)
Della bipartizione sociale del borgo ampliato, costituita , da una parte , dai contadini, spesso piccoli proprietari , e dal feudatario, e dall'altra dalla più recente classe di artigiani e mercanti, si troverà un pre -

ciso riscontro anche nella successiva 1st1tuzione del comune. Non a caso: " .il comune italiano possiede sin dalle origini due anime e due vocazioni, l ' una borghese e imprenditrice, l'altra fondiaria e redditiera. Per ora nel generale rigoglio di una società in via di espansione e di trasformazione, è la prima a prevalere ... Ma verrà il tempo in cui anche l'altra anima quella redditiera e possidente riemergerà e darà il suo stampo a una nuova e meno esaltante fase della lunga storia della città italiana ... " 11> Del resto anche una sostanziale ambiguità di potere permase nei comuni. Infatti se: " è ben vero, in linea generale, che feudalesimo e comuni si oppongono su tanti punti essenziali ... non è un paradosso dire anche che nel comune persistono a lungo notevolissimi residui feudali [che] acquistano un certo rafforzamento per l'introduzione di governi di tipo signorile ... " <8> E come il castello finì per emblematizzare , architettonicamente e militarmente, il potere della casta feudale dominante sui contadini circostanti, ali' interno della cerchia urbana la torre gentilizia varrà a rappresentare il potere della ricca borghesia sulla restante popolazione.
Anche nel contesto appena schematizzato la fortificazione dà una esatta testimonianza del mutare dei costumi, finendo col tornare , paradossalmente, alla sua più lontana impostazione. Quella, per intenderci, che, al di là delle implicanze meramente militari, socialmente sottintende il superamento dell'individualismo , essendo necessario uno sforzo organizzato e collettivo per provvedere alla comune salvaguardia mediante l'erezione delle mura e la loro difesa. Con l'avvento degli Stati di grande rilevanza, e soprattutto con Roma, quell'arcaica impostazione si dissolse rapidamente al dissolversi delle autonomie deJle città-stato. Tutti i loro abitanti confluirono in una organizzazione superiore in cui la sicurezza era monopolio di una precipua istituzione. Alla diretta prestazione sulle mura urbiche il cittadino sostituì la contribuzione fiscale, essendo competenza di professionisti garantire l ' inviolabilità delle frontiere. Le successive devastazioni dei barbari, infrangendo il sistema, annientarono il rapporto fiduciario che lo aveva generato e sostenu -

to, obbligando ogni centro abitato a provvedere di nuovo autonomamente alla propria difesa. Non desta perciò eccessiva meraviglia che: " mai come nel medioevo si sentì acutamente la necessità di agire in modo collettivo, [poichè] l ' individuo contava ben poco. Il grande nobile possessore di un feudo, poteva permetters i di stare per suo conto, di costruirsi un proprio potere indipendente, di conservare i propri privilegi ed il proprio dominio sui vassalli; ma , ai livelli più bassi, un uomo , da solo , poteva fare ben poco nella lotta per l'esistenza. " c9i Pertanto radicatasi la costatazione che: " .. .il singolo era troppo debole per lottare da solo o per cambiare la realtà esistente ... nacque .. .l'idea di unirsi e di associarsi. E a mano a mano che la popolazione aumentava, che la ricchezza cominciava a diffondersi e che la società avanzava. questo bisogno di progresso, questa tendenza ad associarsi, divenivano sempre più forti ... " <10•
L'in sufficienza del singolo, del resto, era emersa pienamente anche in tutte le attività produttive e di scambio implicanti il superamento dei ristrettissimi ambiti dell'autarchia feudale , in particolare nel commercio a media distanza o nell'artigianato di maggiore complessità, quale quello metallurgico e tessile. Se si volevano conseguire risultati remunerativi appariva indispensabile associarsi in forme cooperative, ed il concetto molto rapidamente si spostò dal campo lavorativo a quello politico. In altri termini se una libera associazione di più individui, unendo le risorse, consentiva intraprese altrimenti precluse, una identica impostazione sul piano sociale, unendo le forze, avrebbe frustrato gli arbitrii e le angherie dell'aristocrazia, trasformando le tante impotenze in potere collettivo.
È probante, al riguardo, il sincronismo genetico del comune, che rappresenta la traduzione politica delle delineate concezioni, in relazione all'ampia area geografica interessata. In pratica si rintraccia, contemporaneamente, in Francia, in Germania ed in Italia. Parimenti probante è la sua irrilevante presenza, all'interno delle stesse regioni, laddove nel frattempo si fosse organizzato un forte potere centralizzato e stabile , come nel Mezzogiorno, capace di garantire una di-
screta sicurezza. In ogni caso, al di là delle indubbie affinità, i comuni ostentarono notevolissime diversità sia formative sia normative, per cui ciascuno di essi può essere considerato un caso a se stante. Ne derivarono impianti difensivi altrettanto diversificati e peculiari, basati su criteri infonnatori di grande interesse, che vale la pena di approfondire.
un 'art iglieria moderna ed efficace, di cui subito s i dotarono le principali monarchie europee, e contro la quale nulla potevano le obsolete fortificazioni comunali, ristabilì la soggezione della libera istituzione.
Sotto il profilo storico, la massima proliferazione dei comuni si verificò fra il 1100 ed il 1400. Ed è certamente significativo che se i prodromi del fenomeno comunale coincisero con la grande ripresa economica, il suo esaurimento, o quantomeno la sua stasi, coincise, a sua volta, con la realizzazione di un 'efficace artiglieria. Concomitanza non casuale, bensì logica conseguenza della connotazione fortemente competitiva ed aggressiva dell ' istituzione comunale, che, dopo averne rapidamente stravolto la concezione, finì per favorirne la disgregazione. Infatti, pur scaturendo da un ' istanza sociale unitaria largamente condivisa il comune conservò nel proprio patrimonio genetico lo spirito di sopraffazione proprio del feudalesimo , accentuandolo.

E se: " ... nel secolo XII il comune italiano è fusione di classi, unità di popolo ... [proprìo] in questa fusione matura la nuova classe borghese e nell ' unità presente si preparano i contrasti prossimi ... " <111 • Saranno, in pratica, la smodata competizione egemonica fra ricche famiglie di mercanti e la eccessiva sperequazione economica fra queste ed il popolo, ad annientare l'originaria solidarietà instaurando la faziosità fratricida tipica del feudalesimo. Tant'è che, neJl'arco di un paio di secoli: " al culmine della sua fioritura il comune ci appare così, come un sistema politico-istituzionale che ha raggiunto lo stadio e la consistenza dell 'organizzazione statale, ma è caratterizzato dalla compresenza di molti poteri che formano altrettanti stati nello stato ... La tendenza di ciascuno dì questi poteri è quella di diventare totalitario .. .Una lotta cronica e violenta agita perciò la vita del comune ... "( 12i L'avvento di
Per spiegare l'originarsi dei comuni esistono ovviamente molte teorie , tanto più che il fenomeno appare, come già detto , nonostante il suo vasto e contemporaneo manifestarsi, talmente diversificato da proporsi come spontaneo ed indipendente. Assurdo, quindi, supporne un'unica matrice. Eppure per i vecchi studiosi i comuni rappresentavano gli estremi epigoni dei municipi romani: l 'ipotesi appare troppo semplicistica in quanto il notevole intervallo , e le contaminazioni barbare, mai avrebbero consentito tanta sopravvivenza, pur ammettendone l'affinità. Senza contare che la stragrande maggioranza di essi non vanta alcun collegamento con l'a ntichità classica, e nasce per rispondere ad esigenze anch'esse prive di remote analogie. Altri studiosi collocano ali' origine dei comuni l'estendersi della proprietà indivisa e dei diritti collettivi: i riscontri, però, appaiono marginali. Per altri ancora lo stimolo aggregativo va ricercato nella progressiva autonomia del distretto giudiziario, oppure in una precisa iniziativa reale, o ecclesiastica: ne ss una te si, tuttavia, è supportata da una sig1ùficativa esemplificazione. Indubbiamente al riguardo un ruolo , sebbene indiretto , potrebbe averlo svolto la Chiesa , allorquando per arginare la violenza imperante, impose, con l ' istituzione delle cosiddette 'paci di Dio ' e ' tregue di Dio ', la sospensione di qualsiasi scontro armato dal tramonto del mercoledì al mattino del lunedì. Da lì, forse, la sinistra fama del martedì! Traendone immediato beneficio gli artigiani ed i commercianti, è credibile che entrambe le categorie si coalizzassero in qualche modo per renderle stabili. Parimenti plausibile, per restare nell'ambito delle motivazioni a sfondo religioso, è il forte impulso mercantile innescato dalle crociate, ed implicante, necessaiiamente, forme associative abbastanza ampie. Simile, in sostanza, l ' ipote s i incentrata sulle 'gilde', suffragata dalla constatazione che i principali comuni, come accennato, sorsero quasi sempre o
lungo il corso di fiumi navigabili, o lungo le coste. In conclusione, il fattor comune del fenomeno comunale è comunque correlato allo sviluppo del commercio, prescindendo dalle sue particolari estrinsecazioni.
Dal punto di vista legale il comune medievale, nel concetto più ampio: " può essere considerato «persona» giuridica collettiva; un corpo che poteva detenere proprietà , esercitare diritti, possedere vassalli, ed amministare giustizia. All'interno del mondo feudale esso si schierava al fianco dei grandi proprietari terrieri; come costoro infatti poteva rendere e pretendere omaggio, avere tribunali propri per i suoi affittuari, e con costoro poteva trattare praticamente da pari a pari; era in sostanza una seigneurie collective. Talvolta un comune poteva addirittura dichiarare la guerra e negoziare la pace , stipulare trattati e stringere alleanze senza l 'a utorizzazione o il controllo di alcun grande signore feudale. Simbolo della sua autorità erano il possesso di un campanile, da cui chiamare a raccolta in occasione di assemblee generali, ed una sala pubblica, in cui poter trattare gli affari, tenere incontri, ed amministrare la giustizia; la prova della sua esistenza in quanto organismo corporato era il sigillo comune, da apporre a tutti i documenti ed atti pubblici. Tutti i comuni eleggevano o nominavano propri funzionari per condurre gli affari comunali ... Sia la città sia la campagna .. .potevano darsi , e infatti si diedero, questa o quella forma di organizzazione comunale, ma ali' avangua rdi a furono in genere i comuni urbani; essi furono i primi a costituirsi in organismi corporati, ed i più decisi ad affermare l 'autorità comunale. "< 13 )

Occorre, infine, per vagliare le tipologie fort ifi catorie adottate dai liberi comuni, e le loro peculiarità, fare un accenno ai rapporti fra questi ed il coevo feudalesimo. In particolare il comune nacque da una fiera avversione al potere feudale o non ne fu piuttosto una mutazione, progressivamente ricondottasi , con l'acquisizione di autonomie e prerogative e, quindi, con la rivendicazione di privilegi e monopoli, a tale connotazione archetipale? In quest'ultima ipotesi , per ovvia conseguenza, anche in ambito fortificatorio, avrebbe finito
per riprodurne i più deprecabili aspetti, tramandandocene la testimonianza architettonica. Di certo, quanto: " più s i prosegue nello studio del movimento comunale, tanto più appare evidente che esso non fu che una tappa naturale nello sv iluppo dell 'eco nomia. Il progresso economico è la sola causa di valore universale realmente sottesa a tutta la gamma di ragioni immediate , a tutte le complesse forme di sviluppo individuale. La società dei tempi feudali si trovava, per così dire , in uno stadio infantile. Protezione dall 'al to in cambio di servizi dal basso; ad una classe l 'o nere di combattere e all'altra quello di lavorare; protezione anzichè competizione, ecco il principio ideale del feudalesimo, che fondava sul po ssesso della terra tutti questi rapporti e servizi Ma anche nella sua forma migliore il sistema feudale non era fautore di progresso, e nella sua forma peggiore arrivava a commettere grossi abusi e la protezione si trasformava facilmente in oppressione, il se rvizio in servaggio. Il movimento comunale non rappresentò un tentativo di opporsi all'intero sistema feudale in quanto tale , bensì lo sforzo di impedirne gli abusi, e di contribuire al progresso materiale e politico, non però malgrado il feudalesimo ma, anzi, secondo le sue stesse linee; in sostanza una città puntava a divenire un proprietario terriero. Difesa e progresso erano nel medioevo i bisogni primari, e l'associazione fu uno dei mezzi più naturali per soddisfarli Non si trattò quindi di una rivoluzione bensì di uno sv ilu ppo naturale, un segno che la società stava lottando per arrivare alla libertà " <14> _
Il fenomeno comunale, in definitiva, al di là di ogni romantica interpretazione, deve essere ricondotto ad una generalizzata istanza economica, esattamente come il feudalesimo aveva risposto ad un' altrettanto generalizzata esigenza di sicurezza. Lo scopo, in entrambi i casi fu conseguito pienamente, ma a vantaggio di un'unica componente sociale, mercanti le per l'uno e nobiliare per l'altro. All'ampiezza del feudo corrispose quella del mercato, alla potenza delle armi quella del denaro, allo sfruttamento dei contadini quello degli operai. Ed all'incessante conflittualità fra i
baroni corrispose un'altrettanto irriducibile belligeranza urbana fra le diverse casate. Nessuna meraviglia che, in breve, anche la politica comunale finisse per aderire a quell'unico stereotipo, estendendo la giurisdizione sulle campagne circostanti ed avviando una cruenta contesa egemonica con i comuni limitrofi. Pertanto i rapporti fra quest'ultimi divennero tanto più violenti quanto più essi erano simili e vicini, riproponendo, per molti aspetti, il contesto di esasperata rivalità che già aveva afflitto le città-stato del l'antica Grecia. Alla base delle contese non c'era nessuna nobile motivazione mirante ad annientare vessazioni ed arbitrii ma semplicemente l'esigenza di garantirsi aree di mercato sempre più vaste ed esclusive a scapito dei vicini. Nell'arco di meno di un secolo i comuni finirono, perciò , col riprodurre, al loro interno, il peggiore feudalesimo ed all'esterno il più violento imperialismo.
Pertanto l'Italia: " ... benchè si venisse rapidamente assicurando il predominio mondiale nell 'a rtigiano e nel commercio internazionale, era tormentata da guerre pressochè continue tra città e città, in lotta per i confini della diocesi e i diritti feudali, o a proposito di pedaggi e di mercati , o bramose di estendere la loro potenza sul contado, cioè sulla campagna circostante, o di continuare entro le stesse mura le lunghe ed ereditarie contese nobiliari. La semplice vicinanza era causa sufficiente di feroci e lunghi rancori. Bastava che Firenze si schierasse con un litigante, perchè Pisa, Siena e Genova si unissero all'avversario; Milano si alleava con le altre città, ma non certo con Cremona o Pavia; e finchè la questione dello sfruttamento della Corsica e della Sardegna rimase aperta tra loro, Genova e Pisa furono implacabili rivali. La posizione delle città italiane nella grande contesa tra impero e papato non fu dunque determinata da nessun principio politico superiore lma dal] desiderio di espansione e sulla gelosia commerciale ... La grande lotta politica del medioevo diede soltanto nuovo colore e maggiore intensità a rivalità così aspre e bellicose da rendere necessaria in ogni città l'organizzazione degli abitanti in una milizia di fanti e di cavalieri. " <15J
Per diversi autori tanta inconcepibile aggressività in una soc ietà mercantile deve essere ricondotta al venir meno del clima di terrore dei secoli precedenti ed, in particolare , dell'incubo saraceno. Per altli alla trasformazione , grazie al denaro, delle raffazzonate milizie cittadine in un efficace strumento militare. La progressiva aggregazione delle campagne costituì il primo sintomo della trasformazione dell'istituzione comunale. In d ettaglio tale fagocitazione si attuò: " ... sia attraverso la penetrazione economica realizzata dagli abitanti delle città con l'acquisto dei terreni nelle campagne circostanti, sia con le armi e la sottomissione del contado alla città ... Una volta portata a termine la sottomissione del suo territorio, la città vi imponeva le sue leggi: le rocche e i castelli venivano abbattuti, i feudatari più selvatici e riotto s i costretti almeno per una parte dell'anno a tisiedere in città. Di più: nel contado conquistato il comune procedeva talvolta a una politica di ristrutturazione territoriale, promuovendo la formazione di «ville franche» e «castelfra nchi » e facendosi l ' impresario di grandi lavori di bonifica e di regolamentazione del regime delle acque .. .In qualche caso si procedette anche all'affrancamento dei servi dai gravami angarici feudali ... " c16>
Le operazioni militari, come accennato, che sempre più frequentemente videro coinvolti i comuni, sia per la conquista del territorio circostante sia nelle contese con gli altri comuni, implicano la disponibilità di truppe permanenti, ed, ovviamente, di più elaborate fortificazioni. Per cui la: " professionalizzazione della milizia diventa ... inevitabile. La esprimono a livello politico-sociale, le fortune delle superstiti feudalità come seminario di signori. E la esprimono, in maniera più appariscente, ma senza sostanziale differenza di significato storico, le fortune delle compagnie e dei capitani di ventura ... " '17)·
Ben emblematizza quanto delineato la vicenda di Firenze che: " ... dimostrò per la prima volta la sua giovane forza nel 1082, quando riuscì a respingere I' assedio cui l'aveva sottoposta Enrico IV. Essa divenne la fortezza del contado, di cui sistematicamente sottomet-

te e costrìnge alla residenza in città la nobiltà feudale. L'alleanza stipulata nel 1171 con Pisa procura al suo commercio l'accesso al mare. La cinta muraria del 1173-1175, che include ì nuovi quai1ieri sortì all'esterno delle mura romane, significa la conclusione dì questo primo periodo dì ascesa. Accanto aì nobili residenti in città ... dedìtì soprattutto al servizio militare, alle cariche municipali, al notai·ìato e alle podesterie , stanno ì ricchi mercanti, che come la nobiltà, vivono ìn case fortificate e turrite ... Al di sotto si forma la massa crescente degli artigiani. Nonostante le faide tra le vai·ie casate, scoppiate nel 12 l 6, e nonostante il contrasto di partito fra guelfi e ghibellini, il '200 regi stra un'enorme espansione ... La vitt01iosa lotta contro Siena le procura Poggibonsi, e con ciò la signoria sull'intero contado (1208). Negli anni '20 inizia ìl dissidio con Pisa, sviluppatosi in una sempre crescente rivalità commerciale e in un odio accanito sino a che alla fine, nel 1410 , con l'acquisto di Porto Pisano e Livorno , Firenze ottiene l'accesso al mare ... A Firenze il '200 vede anche la grandiosa espansione del settore finanziario. Accanto aì Genovesi e ai Lucchesi, anche i Fiorentini diventano banchieri della Curìa... così come dei re e prìncipi inglesi e angìoini .''11 8> Nella citazione, si coglie in Firenze, situazione peraltro analoga in tutti i comuni coevi, all'interno della immancabile fortificazione perimetrale, la prese nza dì una nuova tipologia fortificata, quella delle torri gentilizie. Come meglio emergèrà più innanzi esse rappresentano l' uJti mo tassello della ri propos izione del feudalesimo su scala urbana , l'equivalente cittadino del castello, confermando anche strutturalmente la supposta stretta affinità tra la società feudale e quella mercantile.
s ituazione dì Firenze, sappiamo che nella sua contea prima del 1050 si contano 52 castelli, ben 130 cìnquant' anni dopo ed oltre 200 nel XIII secolo. Chiunque, legittimamente o no, disponeva di una minima autorità, persino religiosa, eresse fortificazioni per salvaguardare la propria esistenza ed i propri averi. Tutte, pertanto, furono costruite per la s icurezza dei detentori, seb bene indubbiamente, tutte, nel loro complesso contribuivano alla s .icurezza dello Stato. Questo, per l'identica ragione , tendeva, a far coincidere il suo perimetro con le coste marittime, con il corso deì fiumi e con le catene dì montagne, trasformandoli , con opportune integrazioni difensive, in una grande cerchia. La risultante di tante iniziative concomitanti fu un territorio, sostanzialmente chiuso, all'interno del quale ogni singo lo nucleo abitato, dalla città al borgo, dal castello alla toITe, costituiva a sua volta una enclave chiusa dalle proprie mura. Al calar delle tenebre, chiunque per qualsiasi ragione non si fosse trovato in uno di quei recinti, assumeva i connotati o della vittima o del predone.
Oss ervazioni
Il Medioevo, anche nell'immaginario collettivo, è l'epoca dei castelli. In effetti mai come nella società feudale si edificarono fortificazioni tanto numerose e di tanto variegata impostazione. Per restare ancora alla
11 comune che, per quanto delineato, finì per assomigliare ad un minuscolo stato feudale, ne riprodusse al s uo interno persino l'esasperata compartimentazione difensiva. Al perimetro di frontiera corris po se, infatti, la cerchia urbica , deputata alla s icurezza collettiva, ed ai castelli le dimore fortificate, per la sicurezza privata. Paradossalmente, anche in quel ristrettissimo ambito aggirarsi al calar delle tenebre nel dedalo delle viuzze, rappresentava oltre che una violazione delle severe disposizioni una palese aspirazione al suicidio. E se la connotazione saliente del territorio medievale fu quella di un susseguirsi di alture sormontate da castelli, quella del comune fu un costiparsi di ton-i svettanti dalle mura della cinta: una sorta dì gigantesco istrice. In definitiva una variante verticale ad altissima densità dell 'i ncastellamento disperso in orizzontale.
Dal punto di vista architettonico, pur essendo indubbio che la cerchia comunale ostentasse alcune peculiarità che la differenziavano dalle murazioni feudali coeve, la vera novità fu rappresentata appunto dalle torTi gentilizie e dalle dimore fortificate. Ovviamente ,
 INGEGNO E PAURA TRENTA S ECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIA
INGEGNO E PAURA TRENTA S ECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIA
come l'edificazione dei castelli, almeno formalmente, da un certo momento in poi, richiese una esplicita autorizzazione sovrana, anche quella delle torri gentilizie, dopo una breve fase di anarchia, presuppose il rilascio di una concessione comunale. Il che non evitò, in entrambi i contesti, abusi continui, più gravi e sfacciati quanto più potente era la casata che li aveva perpetrati. La fin troppo evidente somiglianza tra la proliferazione delle torri e quella dei castelli, nonchè degli arbitrii relativi alla costruzione, potrebbe essere stata, per molti versi, la conseguenza di una tipicità tutta italiana, ovvero: " .. .l'ingresso forzato dei nobili nelle città . Mentre al di là delle Alpi la nobiltà costruisce i suoi castelli al di fuori delle città, in It alia spontanemanete o meno i nobili si trasferiscono nelle città stesse ... L'inurbamento forzato della nobiltà rurale è molto diffuso, anche se variano le condizioni imposte al nobile In Italia la nobiltà urbana entrò nel commercio, più precisamente in quel grande commercio d'oltremare che ebbe ben presto come effetto la creazione di imperi coloniali, sotto forma di reti di basi commerciali, da parte delle città marinare italiane di Venezia, Pisa e Genova e alla fine anche da parte di una città dell'interno come Firenze. I n seguito in Italia cadde quasi completamente il diaframma tra il ricco mercante e il nobile dedito al commercio . Il nobile fu invaso da una mercantile sete di profitto e la c ittà dai demoni dell'espansione coloniale e militare e del dominio. fl contado divenne un territorio sottoposto alla città. In ItaJia sorsero non signorie te1Titoriali, come nel regno di German ia, ma stati c ittadini . Qu esto però fa anche sì che quelle lotte per il potere che a nord delle Alpi vengono disputate nelle interminabili faide territoriali, in Italia si effettuano in città: le grandi famiglie rivali si combattono da palazzo a palazzo, da torre a torre. Perciò è dall'interno che viene minacciata la pace cittadina ... " 11 9 > _
Una significativa conferma di tale ipotesi la si può cogliere nel Mezzogiorno, che, come detto, risulta meno interessato, sia dal fenomeno del comune, sia dalle s ue inedite fortificazioni private, s ia, infine, più in generale dallo sviluppo commerciale, protraendovisi, per contro, abnormemente il sistema feudale. Infatti:
·'.. .la struttura feudale trasse motivi di vita dalle esigenze ed attività marziali della monarchia normanna, ossia rispondeva ad un ben organizzato sistema di controllo del territorio sovrapposto alle realtà esistenti e verso di essa diffidente. L'immagine che rende meglio questa meccanica del l'organizzazione militare è il fatto che i Normanni, mentre «posero il centro del loro potere nei castelli», di solito li «costruirono fuori delle vecchie cinte murarie», ossia a fianco delle città, in modo da poter conservare una maggiore indipendenza bellica e da rendere più efficiente il controllo e la difesa rispetto ai potenziali nemici anche interni. Il sistema feudale fu mantenuto in vita dalle monarchie sveva, angioina, aragonse e trovò anche più tardi condizioni di favore nel bisogno del governo centrale di lasciare in funzione organismi e forme di organizzazione del potere periferico accentrati sotto un'autorità locale e dotati di una qualche forza militare. Questa esigenza fu tanto più sentita nel Mezzogiorno rispetto al Settentrione in rapporto al pericolo che proveniva dal mare, e che era costante, non dipendeva dalle congiunture belliche internazionali, ossia dalle eventualità, sempre meno frequenti nella tarda età moderna, d' invasioni nùlitari. " <20 >

A Sud e a Nord troviamo, così, due condizioni nobiliari in netta antitesi: nel meridione i baroni continuano, più o meno spontaneamente, a fornire una qualche prestazione militare, fonte, se non di reddito, almeno di gratificazione e di occupazione, ragion per cui, nella: " ... politica della nazione dominante si scontravano ...e prevalevano alternativamente due esigenze opposte, di richiamare i baroni nella capitale ... o di utilizzarne il potere periferico per un più facile controllo del territorio specialmente verso l'esterno. Già l'organizzazione normanna prevedeva che la custodia marittima, ossia il servizio di vigilanza e difesa nei castelli costieri, fosse espletata nelle contee feudali da quei feudatari che possedevano terre confinanti con il mare. La funzione rimase costante nel tempo, così come l'ambiguità dei governi. " <21 1
Nel settentrione, invece, non esistendo alcuna necessità del genere, i baroni si ritrovano privi di ogni impie-
go pratico , il che fornisce una plausibile spiegazione del)' improvviso interesse della nobiltà inurbala per il commercio, che permette, tra l'altro, di impiegare le ingenti rendite agrarie, frutto non di rado del persistere del lavoro servile, confluite nelle sue mani. È significativo al riguardo che nel 1256 il comune di Bologna abbia operato un riscatto generalizzato dei servi della gleba addossandosene gli oneii. Così l'atto:
" Considerando ciò, la nobile città di Bologna, che ha s empre combattuto per la libertà, memore del passato e provvida del futuro, in onore del Redentore Ges ù Cri s to ha liberato pagando in danaro, tutti quelli che ha ritrovato nella città e nella dioces i di Bologna astretti a condizione servile; li ha dichirati liberi e ha s tabilito che d'ora in poi nessun schiavo osi abitare nel territorio di Bologna affinchè non si corrompa con qualche fermento di s chiavitù una ma ss a di uomini naturalmente liberì. " <22>
Il documento, estremamente importante per la comprensione della società comunale, va però interpretato nella sua effettiva valenza. Innanzitutto la motivazione del riscatto risulta meno esaltante di quanto enunciato: occorrevano nuove braccia per le industrie cittadine e quello era l'unico modo per reperirle a buon mercato. Secondariamente l'intento non dovette trovare pieno adempimento, tant'è che la disposizione fu reiterata 26 anni dopo. Infine, a ben leggere il dispositivo, Bologna interdice la residenza nel suo temtorio agli schiavi, peraltro privi di ogni libertà decisionale , ma non ai mercanti di schiavi, che infatti continuarono anche nei secoli successivi, la loro abietta quanto lucrosissima attività. Una identica injziativa venne adottata anche da Firenze che proibì, nel 1289, la vendita simultanea delle terre e dei relativi servi: la motivazione prioritaria del provvedimento restava pur sempre la ricerca di mano d'opera a basso costo.

A differenza dei vecchi borghi, quasi sempre abbarbicati a cocuzzoli, più o meno impervi, i loro amplia-
menti , come pure più in generale i comuni urbani, ebbero una ubicazione meno arroccata , spesso perfettamente orizzontale. Nel primo caso si trattò di una conseguenza obbligata, poichè , coincidendo la preesistente cerchia con il ciglio tattico, le case costruite al s uo esterno si aggregarono o lungo la pendice o nella sottostante campagna. Nel secondo, invece, l ' impianto pianeggiante deve considerarsi una scelta canonica, essendo l'unico compatibile con una facile espansione omogenea e priva di limiti insormontabili. Ora, essendo in entrambe le circostanze, pressochè assente ogni difesa naturale, ad eccezione forse dell ' eventuale corso dei fiumi, le caratteristiche architettonico-militari tanto dei castelli quanto delle cerchie non potevano pedissequamente riproporre quelle tradizionali d ' altura. Ne derivarono perciò, soprattutto per l'interdizione passiva, soluzioni strutturali e dimen sionali originali che divennero la nota distintiva della fortificazione comunale più avanzata. In ultima analisi, po ssono considerarsi la riproduzione a11ificiale degli ostacoli morfologici , implicanti , però , una maggiore reazione attiva.
L'istituzione dei comuni, come in precedenza accennato, rese disponibile, perchè direttamente coinvolta, una forza armata s e non regolare, per lo meno , numericamente determinata e discretamente consistente in rapporto al perimetro da difendere. Tenendo presente che nel XIII secolo le e s ercitazioni pratiche con le anni da lancio , archi e bales tre , si succedevano nei maggiori centri con discreta frequenza , le rispettive mura, in caso di necessità , potevano contare su di una quantità di valenti tiratori quale non era stata mai disponibile in nessun castello feudale. Logico , quindi , che le cerchie comunali , dovendo sopperire alle accennate carenze naturali, si avvalessero pienamente di tale opportunità, articolandosi in maniera da trarne i massimi vantaggi, innanzitutto attraverso l'accentuazione dei dispositivi per il tiro piombante e per quello fiancheggiante.
Ne scaturì , sempre in larga schematizzazione, un accorto andamento delle cortine con fitta scansione delle torri per sfruttare il fiancheggiamento, una ragguardevole altezza sia delle une che delle altre per incrementarne
l'insorn1ontabilità ed accrescere la violenza dei lanci, nonchè una straordinaria ampiezza dei fossati, per frustrare l'accostamento nemico. Quest'ultimo espediente assolve anche ad un'altra, e non irrilevante prestazione, ricorrente al profilarsi di un assedio: fungere da recinto per il bestiame, ed a volte persino da rifugio per gli sfollati del contado non ritenuti di sufficiente fedeltà. Riu sciva, così, possibile proteggerli più a lungo mediante le armi da lancio, garantendosi, al contempo, una maggiore autonomia alimentare, ed una disperata resistenza antemurale, pur senza gravare l 'intero abitato del loro mantenimento. Pertanto il fossato, raramente eccedente i 15 m, in molte cerchie comunali raggiunse i 25 m. E, quando venne scavato in terreni incoerenti, fu dotato di un ulteriore accorgimento, di eccezionale sviluppo futuro: il muro di controscarpa. Esso consisteva in una sorta di argine, parallelo al piede delle fortificazioni, che impedendo lo smottamento della sponda esterna, scongiurava il riempimento del fossato. Forse si era constatato del tutto casualmente, in seguito all'accumulo del materiale di risulta, il vantaggio ostativo derivante dal suo innalzarsi rispetto al piano di campagna. La configurazione da accidentale si trasformò in canonica, remota premessa dello spalto avanzato e del relativo tiro radente contro gli attaccanti in avvicinamento.
In conclusione, per le fortificazioni comunali: " .. .furono adottate mura perimetrali art icolate, non solo, ma elevate ad altezze fino ad allora inusitate, e munite di torri sporgenti ... mentre già ci si orientò verso accorgimenti tattici sempre più idonei ad impedire ogni sopresa ed ogni assalto in forze. Infatti un primo carattere veramente nuovo delle fortificazioni adottate dai borghi comunali è nel fatto eh' esse sono permanenti, o almeno costruite con questo impegno, in quanto si propongono di garantire l'incolumità non più solo di una persona o di una famiglia ma di una collettività intera, che partecipa direttamente, in molti casi manualmente, alle varie costruzioni, e con uno spirito che rispecchia, in concreto, la mentalità nuova e funzionale della civiltà comunale ... " m> .

Sempre nell'ambito delle fortificazioni comunali, e più in particolare del loro tracciato, un apporto senza
dubbio interessante, in quanto collegato alle migliori esperienze europee, lo fornirono alcuni ordini monastici. Tra essi spiccano, quello cistercense, ovviamente, e quello francescano. Di entrambi si ravvisano peculiari criteri urbanistici e difensivi non di rado conservatisi fino ai nostri giorni.
Riguardo alle realizzazioni dei primi il: " ... discorso sull'Italia è troppo complesso per poter essere affrontato ... secondo 1' ottica esclusiva del rapporto tra cistercensi e città nuove. Si possono fare alcune considerazioni generai i sulla estrema varietà degli schemi d'impianto adottati nel Duecento, dovuti soprattutto alla molteplicità delle autorità territoriali (in particolare i Comuni del Centro Nord) che hanno promosso la fondazione di terre nuove. L'apporto cistercense tuttavia si può riconoscere maggiormente nelle aree dove il predominio della città sulla campagna è meno accentuato (ad esempio in Piemonte e nell'Italia meridionale) e anche qui si può in prima approssimazione identificare con la piazza quadrata centrale, presente nella prima metà del secolo soprattutto in queste due aree. Ma si tratta di un tipo di piazza più complesso e «moderno», integrato con l'impianto cruciforme cli due strade assiali che permettono l'accesso alla piazza dal centro dei lati invece che dagli angoli ... Non mancano neppure esperienze di «ritorno» che fanno pensare ad una influenza dell 'urbanistica delle città nuove sulle ristrutturazioni delle zone direzionali delle città antiche: ne è un esempio la piazza comuna le di P arma (fine sec. XII-fine sec. XIII) che riflette nell'impianto quadrato e negli accessi angolari ed assiali la problematica delle piazze porticate mercantili di tanti centri di nuova fondazione; anche qui l'esperienza si trasmette in simili, più sistematiche operazioni successive ... " '241 • Quanto appena delineato è, pe r molti aspetti, la trasposizione sul piano urbanistico dei criteri di razionalità e di ortogonalità già ravvisati alle spalle dei castelli feder i ciani. È presumibile, pertanto, che, originariamente, tali comuni avessero fortificazioni perimetrali rettangolari, scandite da torri quadrate con interassi dell'ordine della quarantina di metri, con spigoli
di pietra accuratamente sagomati. Non è pertanto casual e c he fra l e realizzazioni cistercensi, o d 'is pirazione cistercense, rientri pure Manfredonia , dove è : •· ancora ri conosc ibil e l'impianto a scacc hiera ri gorosa ment e eseg uito ... " <25 )
Per gli o rdini mendicanti g li influ ss i so no notevo lmente ma ggiori , poi c hè l'impianto dei: '' ... co nv e nti ... nell e città ubbidisce ad es igen ze economiche, politich e e re li giose tanto precise quanto vaste e com plesse. In generale gli ordini contribuiscono a l rafforzamento del regime urbano dominante , gara ntendo il mantenimento della pace e collaborando, spesso in mani era diretta , alla gestione politico-amminis trativa del comune o de lla città; essi vanno visti, nel loro in s ieme, come l'indispensabile sostegno a d una nuova politica e a una nu ova prospettiva urbani stica dell e città d e l Duec e nto ... Ciò è particolarm ente ev idente per l'area umbro -to scana do ve il conso lidar si delle s trutture comunali s i verifica proprio in armonia con la precoce e vigoro sa diffus ione degli ordini ... È proprio l'iniziale loro origine di «se n za terra» che accomuna i mendicanti ai mercanti e ai banchieri più c he ai propri e tari agrari, al comune più che al vescovo, all 'econom ia e alle classi della città più che all'economia agricola e ai contadini ... se nza di ess i il c omune italiano non avrebbe potuto controllare l' e norm e movimento demografico del XIII seco lo , gestire le opere pubbliche in città e nel co ntado , stri ngere l'organismo cittadino in una nuo va, moderna maglia di se rvizi e poli monumentali " <2<> i
Ovviamente tanta di sponibilità non avvenne senza un congruo corrispettivo, ravvi sabil e eminentemente nel forte condizionamento esercitato dai reli g ios i s ulle is tituzioni comunali. Emblematica, al riguardo, appare la tendenza dei conventi a d addos sars i alle mura in cor1i s pondenza delle porte, per lo più all'interno della cerchia, meno fr e quentemente all'esterno, qua s i a voler meg lio so ttolineare l'intima correlazione tra il fattor e difen s ivo pubblico e l' ini z iati va monas tica, controllando , al contempo, di rettamente le entrate e le usci te. Ufficialmente però la: " ... relazion e tra conventi e porte
è co nnessa con motivi di prevista espansione e di relazione stretta con il territorio; in questa luce van no viste soprattu tto le localizzazioni esterne, m e ntre quelle in terne so no assai m e no significativ e, e tendono se mai a sfr uttare le rendite delle po11e o le organizzazioni territoriali urbane legate alle porte stesse... " <m
Quan to evidenziato circa le for tifi caz ionj perimetrali co munali potrebbe sembrare , in prim a approssimaz ion e, id e ntic o a quanto riscontrabile nella coeva produzione feudale. In realtà , però, la minore e laborazione e robustezza di quest'ultima, fatte sal ve le cerchie delle cap itali , tradi scono una insormontabile diffidenza da parte d el potere cen trale. La sp iegaz ion e è quella g ià fornita per le cittadine romane non di frontiera, sempr e blandamente cintate reputandosi una maggiore saldezza un temibil e ostacolo per la loro sottomissione nel caso, non improbabile, di rib ellio ne Senza contare c he s ui comuni in combevano le reciproche minacce, iattura ines istente per l'altra tipologia. Infatti , un a s i g nifi c ativa ragione d el potenziamento delle: " ... fortificazioni con cui il Comun e dovette c irco ndare i I suo agglomerato urbano ... [fu] quell o di difendersi dalle conco rre nze, d a11 e c ittà rivali. Un mot ivo, questo, c he sta a d indicare come, già ne l s uo affern1a.rsi, fosse conge nito, per il Comune, il germe della decade nza, intimamente connesso forse proprio con l 'esaltazion e dell ' individua)j smo, proteso al s ucc esso e d all ' affermazi o ne, in ogni campo e con ogni mezzo, ma in se nso s trettame nte egoistico ... " 128)
È questo il più singolare paradosso della fortificazione comunale che nata da una esigenza collettiva fini sce per diventa.re la garante di un esasperato egois mo , più esattamente di un aggressivo particolarismo egemonico, riproducendo i difetti del s istema feudale , ulteriorm e nte aggravati dalla dinamica mercantil e. Pe rtanto: " .. .invece di perfez ion are i mezzi di c omunic az ione terre stTi e marittimi .. .invece di p erfez ion are i sis temi di produzion e e quelli mercantili (è tuttavia con i Comuni ch e ebbero origine le banche e le industrie), i mercanti comunali preferirono di spe rdere le loro energie nel combattersi. Di qui una ulteriore esige nza
 INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI 1) 1 FORTIFICAZIONI JN ITALIA
INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI 1) 1 FORTIFICAZIONI JN ITALIA
di fortificarsi, individualmente oltre che colle tti vamente: le città pullularono di case torri, oltre che di cinte murarie sempre più a rticolate e robuste. " <29 >
Un significativo esempio, riassuntivo di quanto delineato, è rintracciabile nella vicenda sto1i ca di Todi e delle sue fo11ificazioni. Va, comunque, ribadito che quelle erette nel XIU seco lo , non diversamente da tutte le altre coeve, hanno subito pesanti su·avolgime nti successivi, in particolare tra il '400 ed il '500, resisi indispensabili per prolungarne la validità adeguandone, per quanto e fin quando possibile, la resistenza passiva alle artiglierie.
te recuperate dalla città. L'avvio dell'autonomia comunale può farsi risalire agli inizi del XII secolo, come testimoniano alcuni tentativi di affrancamento dalla Chiesa, alla quale Todi era stata donata nel 962 dall'imperatore Ottone I. ed il suo primo governo consolare. Contemporaneamente inizia pure la fagocitazione dei territori c ircostanti, secondo precise direttrici strategiche ed economiche. Ovviamente il limite dell'espansione non è determinato dalle asperità naturali, ma dal1e rivendicazioni dei Comuni limitrofi, in pa rti colare di Perugia, con cui Todi cerca di conservare buone relazioni, indispensabili per bilanciare l'ostilità di Orvieto.
In rapida sequenza entrano in suo possesso Amelia nel 1208, Terni nel 1217, e quindi, nel 1232, le terre
Il primo documento che menziona l 'esistenza di un territorio facente capo a Todi 1irnonta al 760, al tramonto del regno del longobardo Desiderio. Da esso se ne ricavano, con discreta precisione, i contorni, sostanzialmente, coincidenti con quel1i della Diocesi. Questa, a sua volta, ri calcava quelli del Municipio romano del I sec. a. C., ennesima co nferma del permanere sotto i regni barbari delle antiche suddivis ioni amministrative. E proprio alla remota promozione giu ridi ca viene ascritta la riqualificazione della primitiva cerchia urbica d ' 01igine etrusca, e rett a con blocchi di travertino intorno a due colli separati da una in se ll atura, c irca due secoli innanzi. Nonostante l'intervento la fortificazione risultò, in breve, inadeguata a contenere la popolazione vistosame nte incrementatasi. Si operò, allora, un ampliamento della superfic ie urbana tramite poderosi muri di terrazzamento, innal zati lun go i lati o riental e e settentrio nal e della c ittà, anche per fungere da m ass iccia cortina difensiva. L'assetto non subi alcun mutamento in epoca altomedievale, se si eccettua la trasformazione del teatro in caposaldo.

Intorno al Mill e, la giurisdizione di Todi risulta notevolmente ridimensionata, a vantaggio di alcuni feudi in sediatis i nei suoi paraggi. Nei decenni successiv i, però, si registra un loro progressivo s membra -
mento, con la perdita di alquante frazioni, prontamen-
dello Status Alviani. Da ogni sottomissione deriva un gettito di tributi che incrementa le 1isorse del Comune, consentendogli, tramite acquisti, ulteriori ampliamenti territoriali. Al termine: ·' del XIII sec. l'estensione del contado e quella della Diocesi coincidono perfettamente; segno che l'istituto comunale ha voluto ricalcare i confini di quello ecclesiastico Le finanze del Comune traggono notevoli sostanze dal nuovo patrimonio territoriale, sostanze che vengono impiegate in altre conquiste o in attività economiche, che richiamano in città un sempre maggior n u mero di abitanti. '' 00 >
Stando ai dati disponibili il contado raggiunge allora la cifra di circa 35.000 abitanti e la città di 12.000, entità immense per l'epoca, che rendono troppo angusta la vetusta cerchia. Pertanto. nella prima metà del XIII secolo, se ne erige una nuova , la terza, imposta soprattutto dall'esigenza di proteggere i borghi, per I' esattezza Borgo Nuovo, Borgo Ulpiano e Porta Fratta, nei quali si è concentrata l'accresciuta popolazione. Esauritasi ben presto la loro ricettività, cominciano a sorgere altri sobborghi verso Settentrione. Contemporaneamente il comune: " ... fa costruire ai confini del territorio 34 for-
 I 22 Todi: porta urbica della seconda cerchia
INGEGNO E PAUR1 \ TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZION l lN ITALI/\
123 Todi: torre comunale.
I 22 Todi: porta urbica della seconda cerchia
INGEGNO E PAUR1 \ TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZION l lN ITALI/\
123 Todi: torre comunale.
tilizi; nel 1321... 1inforza la Rocca di Pontecudi, s ituata ai piedi del colle di Todi; nel 1326 .. .innalza il borgo fortificato di Castel dell 'Aq uila , per sorvegliare gli Amerini e i loro frequenti tentativi di ribellione; dal 1331 al 1333 Fratta viene rafforzata con torri e baluardi. "rn; Tanta attività fortificatoria coincide, non a caso, con l'inasprirsi dei rapporti tra Todi e la Chiesa, in seg uito alla rivendicazione della piena indipendenza. Nel 1339 esplode la ribellione, che culmina nel 1362 nella condanna pontificia seguita, ne l 1368, dal I' interdetto di Urbano V, comminante l a revoca di ogni auto-
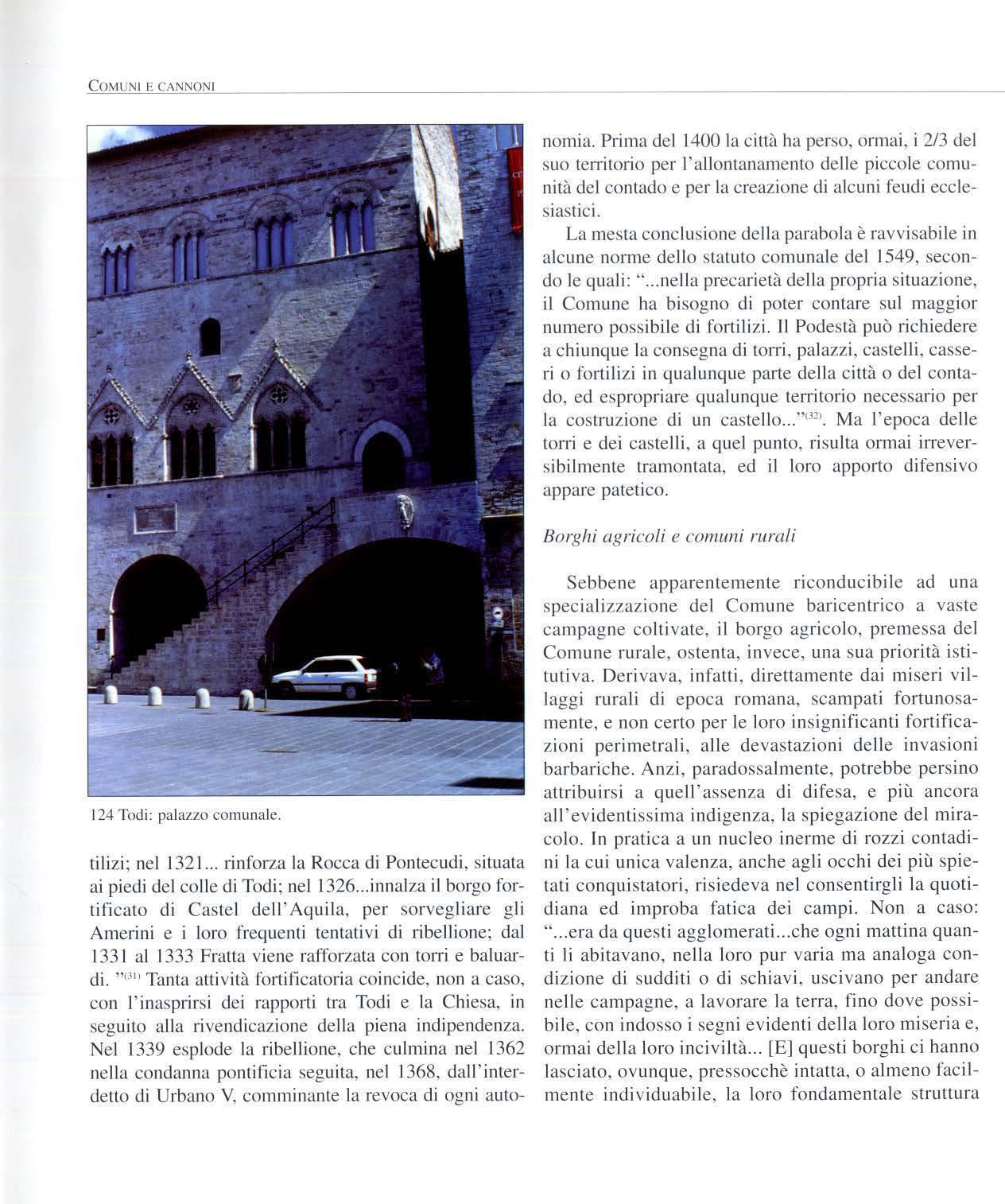
nomia. Prima del 1400 la città ha perso, ormai , i 2/3 del suo terTitorio per l'allontanamento delle piccole comunità del contado e per la creazione di alcuni feudi ecclesiastici.
La mesta conclusione della parabola è ravvi s abile in alcune norme dello statuto comunale del 1549, secondo le quali: " ... nella precarietà della propria s ituazione, il Comune ha bisogno di poter contare sul maggior numero possibile di fortilizi. Il Pode s tà può richied ere a chiunq ue la consegna di to1Ti, palazzi, castelli, casseri o fortilizi in qualunque parte della città o del contado, ed espropriare qualunque territorio necessario per la costruzione di un castello .. . " 02> Ma l'epoca delle toni e dei castelli, a quel punto , ri sulta ormai irreversibilmente tramontata, ed il loro apporto difen s ivo appare patetico.
Borghi agricoli e comuni rurali
Sebbene apparentemente riconducibile ad una s peciali zzaz ione del Comune baricentrico a vaste campagne co lt ivate, il borgo agricolo, premessa del Comune rurale , ostenta, invece, una s ua priorità istitutiva. D e rivava , infatti, direttamente dai miseri villaggi rurali di epoca romana, scampati fortuno s amente, e non certo per le loro in sig nificanti fortificaz ioni perimetrali, alle devastazioni de ll e invasioni barbariche. Anzi , paradossalmente, potrebbe persino attribuirsi a quell'assenza di dife sa, e più ancora all'evidentissima indigenza, l a sp ieg azione del miracolo. In pratica a un nucl eo inerme di rozzi contadini la cui unica va lenza, anche agli occhi d e i più spietati conquistatori , risiedeva nel consentirgli la quotidiana ed improb a fatica dei campi. Non a caso:
" ... era da questi agglomerati ... che ogni mattin a quanti li abitavano, nella l oro pur varia ma analoga condizione di sudditi o di sc hiavi, uscivano per andare nelle campagne, a l avorare la terra , fino dove possibile, con indos so i segni evidenti della loro miseria e, onnai d e lla loro inciviltà [E] questi borghi ci hanno la sciato, ovunque, pressocchè intatta, o almeno facilmente individuabile , la loro fondamentale s truttura


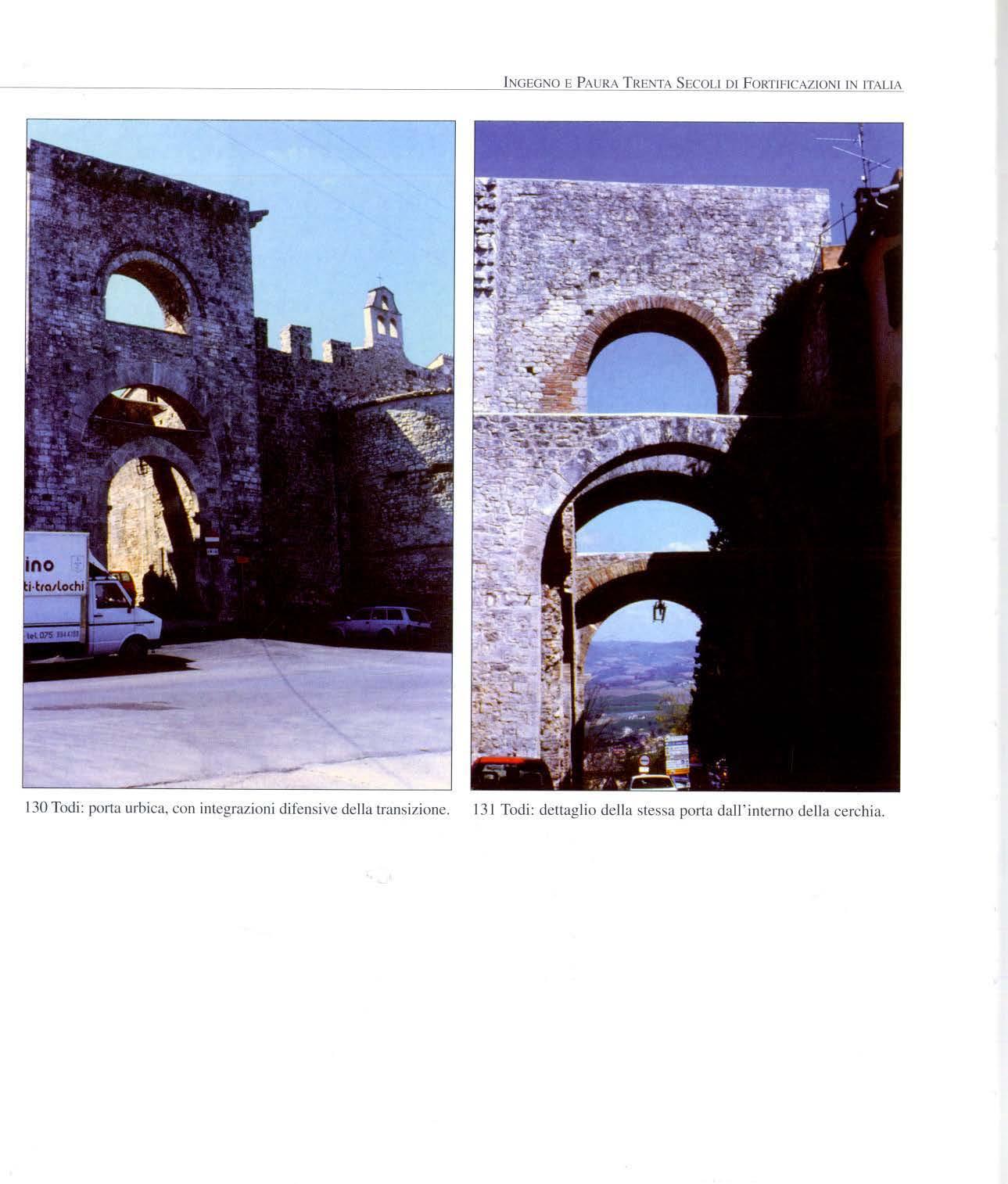
urbani st ic a . Una struttura nella maggior pa rte dei casi, ge nuinamente romana, cioè geometrica (quadrata o rettangolare) e simmetrica, esatta, precisa e pulita, col rispetto persino delle misure cons uetud in arie ... '' (331 Significativamente nei borghi agricoli, almeno fino a ll 'X I secolo, non esistevano le piazze non praticandosi alcun mercato o alcuna riunione!
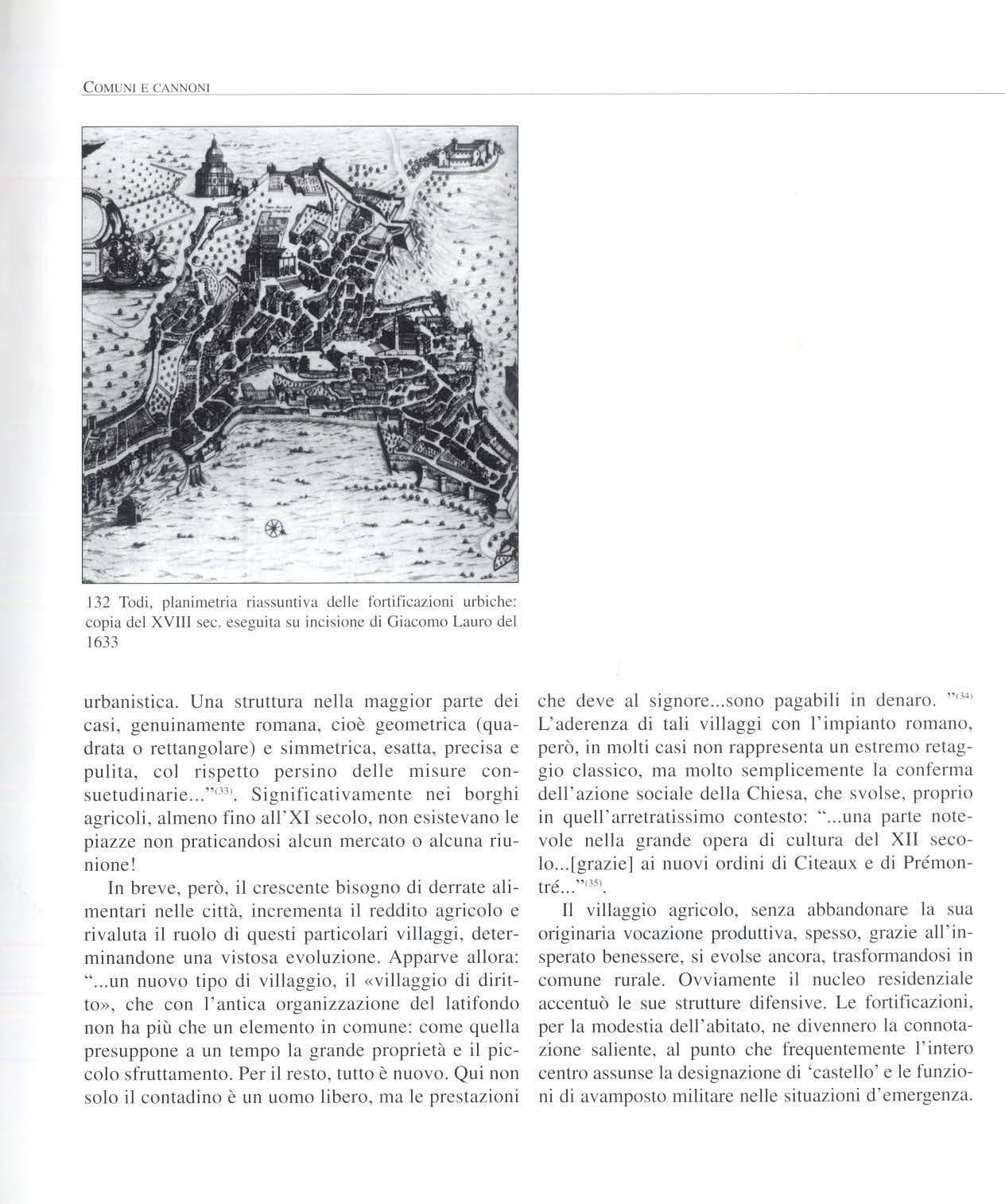
In breve, però, il crescente bisogno di derrate alimentari nell e città, incrementa il reddito ag ri co l o e rivaluta il ruolo di questi particolari villaggi, determinandone una vistosa evo lu z ion e. Appm·ve a llora : " ... un nuovo tipo di villaggio. il «vi lla ggio di diritto», che con l 'a nti ca organizzazione del latifondo non ha più che un e l emento in comune: come quella presuppone a un tempo la gra nd e proprietà e il piccolo s frutt amen to. Pe r il resto, tutto è nu ovo. Qui non so lo il contadino è un uomo libero, ma l e prestazioni
che deve al signore ... sono pagabili in denaro. "c~ 4 l L'aderenza di tali villaggi con l'impianto romano, però, in molti casi non rappresenta un estremo retaggio c lassico, ma molto semp li cemente la conferma dell'azione sociale della Chiesa, che svolse , proprio in quell'arretratissimo contesto: " ... una parte notevole ne ll a gra nd e opera di cultura del XII secolo ... [graziel ai nu ovi o rdini di Citeaux e di Pr émontré ... " 05 '
11 vi !! aggio agricolo , senza abbandonare la sua originaria vocaz ione p roduttiva , spesso, grazie all'insperato benessere, s i evo l se ancora, trasformandosi in comune rurale. Ovviamente il nucl eo residenziale accentuò le s ue strutt ure difensive. Le fortificazioni, per la modestia dell'abitato, ne divennero la connotazione saliente, al punto c h e frequentemente l'intero centro assunse la designazione di 'castello' e le funzioni di avamposto militare nelle situazioni d'emergenza.
Un esempio del genere è ben rappresentato dal piccolo borgo di Panicale, adagiato: " ... sul fianco orientale del monte Petravella ... splendida posizione, dalla quale domina , a nord , gran parte della valle del Trasimeno; a sud la piana del Nestore e, a nord -oves t, la Val di Chiana... Pur legato alle vicende di Perugia , non appare ad essa 'sogge tto'; Panicale, situata nel cuore del Chiusi , assicurava rifornimenti di pane e carni e , al tempo stesso, costituiva un valido avamposto del fiorente comune perugino , da cui riceveva sos tegno e garanzia di libertà, di fronte alle potenze più forti. " 061 Jn conseguenza della particolariss ima ubicazione il piccolo centro: " presenta un originale impianto « per avvolgimento», con la prese nza di un
consistente nucleo abitato fuori delle mura. Il paese, s trutturato fra i seco li XIII e XIV, si articola intorno a tr e piazze disposte in asse, che si allungano verso la som mità del colle .. . " 13 7)

Nel 1037 i Panicales i si affrancano dalla soggezione feudale, costituendosi in libero Comune. Conside rando che a tale risultato perverranno Pi sa nel 1080 e Pavia nel 1084, reputate le preco1Titrici dell'autonomia: " ... è quasi s icuramente, que sto di Panicale , iI primo esempio in ltalia di libero comune.. .IJ periodo di autonomia, però , dura poco e già nel 1075 il casteJJo è di nuovo sotto il dominio di varie famiglie nobili, che per molti anni ancora si fregeranno del titolo di Conti di Panical e. Durante il loro dominio il castello diviene s empre più munito , saldo e s icuro , non al punto però di res istere ad un violentissimo assedio che nel 1131 portò alla parziale distruzione delle rnura ... " 118>
Quali fossero, ali' e poca , le caratteristiche e l 'e ntità di quelle arcaiche fortificazioni è difficile ipotiz zarlo: molto probabilmente s i trattava più che di una vera cerc hia, troppo evoluta ed onerosa per il pi cco lo abitato, della s tretta connessione delle s ue case esterne, s is t ema elementare ma non certo inefficace. Lo schema urbanis tico concentrico, del re sto, che riproduce la disposizio ne d e i carri dei nomadi intorno al bivacco per difenders i nel corso della notte , accredita tale s upposi z ione. Di certo tanto la di str uz ione delle mura quanto la loro pronta ricostruzione testimoniano la perfetta consapevolezza della validità tattica del caposaldo. Infatti, quando nel J202 Perugia riesce ad impossessarsene, lo include nella propria giurisdizione con funzioni di avampo s to fortificato, raccordandolo ad una: " rete a maglie strette che utilizzava il fuoco e gli specchi come mezzi di trasnù ss ione Torri di avvi s tamento e dife sa , dispo s te a chiusura della valle e in continuo e diretto rapporto con quelle abbarbicate sulle terrazze del Tras imeno, [chel consentivano l'arrivo di messaggi a Perugia nell'arco di pochi minuti ... Gli impianti più importanti formatisi ne l me dioevo so no quelli di Panicale e Piegaro ... " C\9)
Nel 1244, Panicale ritorna sotto l'egida di Chiu s i, s ubendo nel 127 1 gravi danni alle s ue difes e nel corso
IN GEG NO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIA
degli scontri fra Guelfi e Ghibellini. Nel 1276 Perugia lo recupera nuovamente, concedendogli però statuti con ampie autonomie e, soprattutto, più moderne fortificazioni. Al riguardo si rileva dalle fonti: " ... che Panicate nel 1276 era in potere di Perugia, ma minato in gran parte per le gravi lotte sostenute, per cui le furono restaurate le mura per ordine di quei magistrati. Panicale ebbe a soffrire pure attacchi feroci dai soldati dell'imperatore Enrico Vll di Lussemburgo nel 1312 , conducendosi egli a Roma per esservi incoronato, perchè Roma era in potere di Giovanni d'Angiò e degli Orsini guelfi. E Perugia. anche lei guelfa, previdente fece restaurare le mura di Panicale e ben munire quel castello con molti altri che erano stati danneggiati dalle vicine città ghibelline. A quest'uopo un Dominus

Galganus da Panicale, ch'aveva saputo con bella cura e perizia mettere al sicuro il nativo castello con nuove e ben intese fortificazioni, fu nominato architetto dal
Consiglio di Perugia ... " (40 >
Anche a Panicate, le mura che ancor oggi serrano il
borgo non sono, almeno nella maggior parte ciel circuito, quelle del XTII secolo, bensì la loro riqualificazione trecentesca, e soprattutto quattrocentesca, condizionata dal peso crescente dell'artiglieria , sia in funzione offensiva che difensiva. In particolare, le: " ... mura dalla forma ellittica irregolare fasciano il nucleo abitato. A levante delle mura sulla cresta del colle si è sviluppato un insediamento lineare che conduce al rione S. Sebastiano. Gli isolati del nucleo più antico sono caratterizzati dalla doppia schiera, mentre quelli che si appoggiano sulle mura di cinta dalla schiera semplice ... " 1J 1) Di sicuro, il vero elemento superstite della vecchia murazione è senza dubbio il suo andamento, privo di un preciso tracciato geometrico ma ancora aderente al ciglio tattico della collina, per meglio sfTuttarne l'apporto interdittivo. li che rende la cinta: " ...quasi ovale: la parte più stretta volta a levante, ove trovasj Porta Perugina, era assicurata dalJa controporta in isbieco come si vedeva ancora prima dell ' anno 1898, difesa da una torre quadrata che le sta a fianco;
verso il Trasimeno, alla distanza di circa m. 20 dall'indicata porta, si eleva un torrione di forma cilindrica che guarda la stretta viuzza, che ripida discende verso la vi Ila di Lemura e il Pian di Tresa: poscia a tramontana su d'una linea leggermente curva si prolungano le mura castellane, oggi in gran parte distrutte; ma anticamente forti e fornite di qualche torrazzo. bertesca o guardiola, perchè essendo quella la parte più discoscesa e ripida del colle, riusciva meno accessibi le ai nemici e più difficile agli assalti. D alla parte di ponente nel punto verso la Toscana, le mura avanzandosi nascondevano una seconda porta, oggi detta Fiorentina, la quale doveva avere dinanzi un ponte levatoio. poichè oggi vi è un te1rnpieno sorretto da un muro; e a fianco della suddetta porta si alza al so l ito una torre quadrata a difesa, e alla distanza poi di circa 40 metri verso sud sorge altra torre di forma rotonda. E di faccia, a mezzogiorno, sulla curva delle mura, seguono più spesso torri quadrate e spalti, aventi ai piedi un fosso oggi colmato, su cui si è formata una strada di circonvallazione
che si disse appunto del Fosso. Questa parte del castello era la più munita di opere di difesa. perchè la più accessibile e la più facile agli attacchi del nemico. L'interno (nella piccola parte antica che rimane) aveva come si vede, vie molto anguste. case addossate su case, piccolissime e costruite in pietra con le porte e le finestre anguste a sesto per lo più rotondo e abbassato, o posteriormente rifatte a mattone a sesto riquadrato ... " 14~> In dettaglio: " ... il sistema compositivo degli edifici residenziali si basava sulla cellula elementare «gotica» di forma quadrangolare più o meno regolare e con superficie variabile. L a struttura abitati va era quella delle case-torri, caratterizzate da edifici di tipo monofamiliare ... "'H 11 •
Tanto la irregolare scansione delle torri quanto la loro diversa configurazione geometrica, al di là delle più o meno stravolgenti aJterazioni determinate dal1· armamento a fuoco, confermano la matrice arcaica della cerchia e la sua elementare concezione: segno inequivocabile del ridimensionarsi nei tempi successi-

vi della originaria valenza tatti ca ad onta della evidenziata ubic azione geografica. La modestia d e lla fortificazione potrebb e, pertanto, so ttintendere lo scarso valore remun erat ivo. in te nnini di preda , di un abitato che, però. paradossalme nte , si prese nta fortemente reattivo in dife sa . In pratica , nonostante la ro zzezza della cerchia. la s ua espugnazione s i sarebbe dimostrata eccessivamente onerosa in relazione ai po ss ibili guadagni. n gravitare di tante case private direttamente s ulle mura ne è. in qualche maniera , la spiegazione e la causa. E che tale disposizione notevolmente antica ,
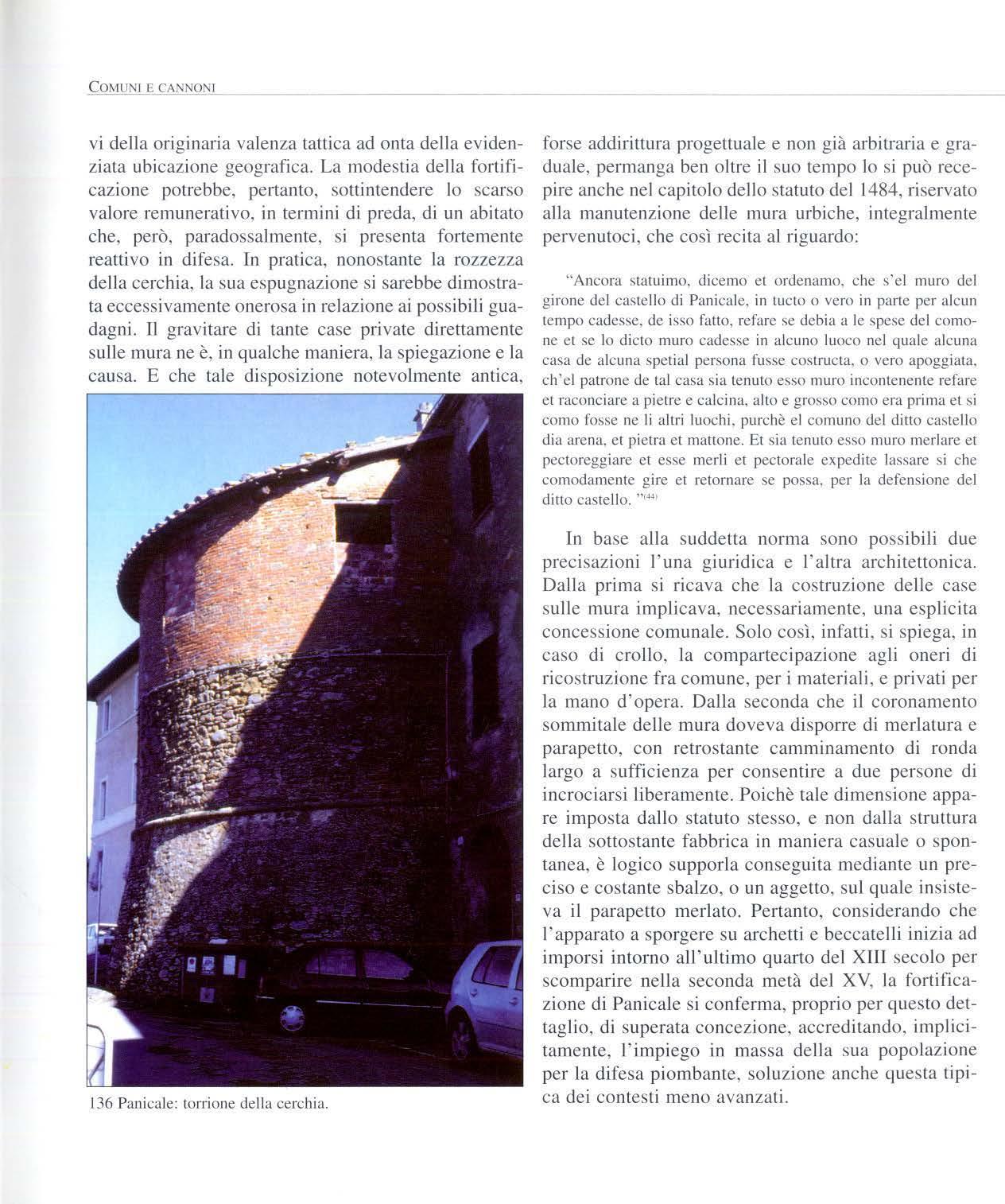
forse addirittura progettuale e non già ru-bitraria e graduale, permanga be n oltre il s uo tempo lo s i può recepire anche ne l capitolo dello s tatuto del 1484. ri se rvato alla manute nz ion e delle mura urbich e, integralmente perve nutoci , che così recit a al riguardo :
"Ancora s tat uimo. dicemo el o rd enamo. che s ' e l muro del giro ne del cas tello di Panica lc , in tucto o vero in parte per alcun tempo ca de sse, dc isso fatto, rcfarc se debia a le spese del comone e t se lo dicto muro cadesse in alcuno luoco nel quale alc un a casa de alcuna spc tial persona fusse cost ructa, o vero apoggiata, ch'c l patrone de tal casa sia te nuto esso muro in contene nte refa re et raconciare a pietre e ca lc ina, alto e g rosso co mo era prima et si corno fosse ne li altri lu oc bi purchè e l comuno del ditto castello dia aren a . et pietra et mattone. Et sia tenuto esso muro merlare et pecto reggia re et esse merli e t pectorale expedite lassare si che comodamente gire et retornare se possa, per la defensione del ditto castello. "' '" '
In base a lla s uddetta norma so n o po ss ibili du e precisaz ioni l'una giuridica e l'altra architettonica. Dalla prima si ricava che la costruzione de ll e case s ull e mura implicava, necessru·iamente, una es pli c ita concessione comunale. Solo così, infatti. si s piega , in caso di crollo, la compartecipazione agli oneri di ri costruzione fra comune, per i materia li , e privati p er la mano d'opera. Dalla secon d a che il coroname nto so mmitale delle mura doveva disporre di merlatura e parapetlo , co n retrostante camminamento di ronda largo a s ufficien za per consentire a due pe r so ne di incrociarsi liberamente. Poichè tale dimensione appare imposta dallo s tatuto stesso, e non dalla struttura della s ottos tante fabbrica in maniera casuale o s pontanea , è logico s upporla conseguita mediante un preciso e costante sbalzo, o un aggetto, s ul quale insisteva il parapetto merlato. Pertanto, considerando che 1' apparato a sporgere su archetti e beccatelli inizia ad imporsi intorno all'ultimo quarto del X l ll secolo per scomparire nella seconda metà d e l XV. la fortificazione di Panicale si conferma, proprio per qu es to dettaglio, di superata concezione , accreditando , impli c itamente , l'impiego in mas s a della s ua popolaz ione per la difesa piomb a nte , soluzione anche que s ta tipica dei contesti meno avanzati.
COMUNI E CANNQ_t-; l 136 Panical e: torrione della cerch ia.

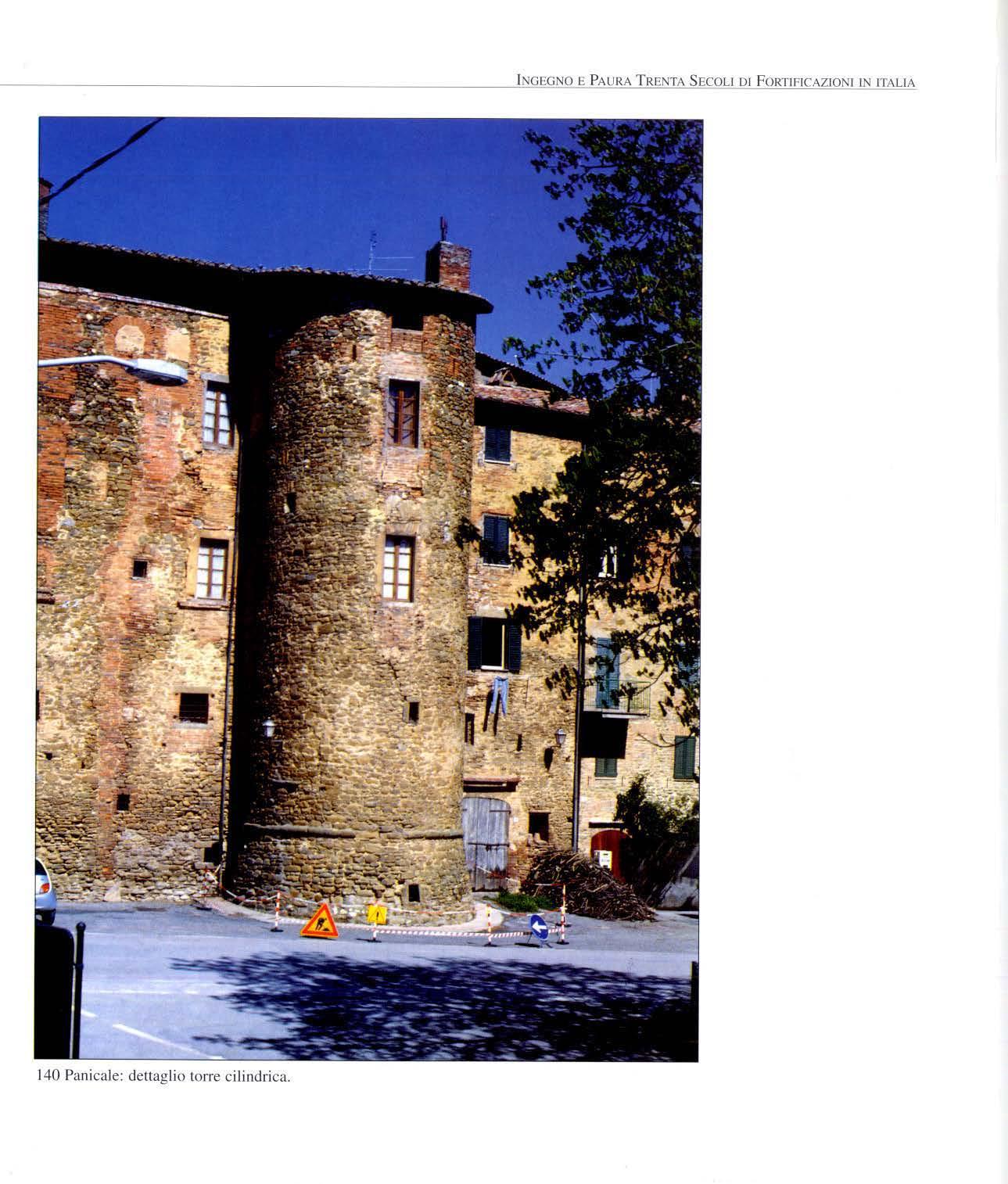

Altre interessanti prescrizioni riguardano il rispetto della integrità delle mura, per cui:

"Statuimo ancora, che niuno ardisca per verun modo rompere , né descarcare, né cavare, né per altro modo destruire el muro del circuito del ditto castello, né farce alcuna novità con finestre, né altrimenti, a la pena de . XX. so lde de denare per ciascuno et per ciascuna vo lta, et sa lde cinque de denare per ciascuna pietra; et niente meno, sia constrecto a refare esso muro a suo i spese.
Dicemo ancora, s tatuendo , che qualunche persona avente casa sopra el muro del ditto castello, nella quale casa fose alcuna fines tra, sia tenuto esse finestre remurare, o vero ferrare , acciochè per esse fenestre uscire né intrare possa " (45i
Anche da questa precisazione risulta ribadita, al di là della contestualità tra case e mura, la necessità di rimediare alle peggiori carenze della cerchia. Le finestre, che si vietano tassativamente, o qualora già esistenti se ne prescrive la chiusura, confermano, infatti, la permanenza di una pericolosa incuria osteggiata dalla nuova dirigenza.
La prosperità di Panicale ebbe modo di manifestarsi pure nel secolo successivo, tant'è che nel 1479, al profilarsi della guerra tra i Fiorentini ed il Papa, si provvide a potenziare ulteriormente le mura con nuovi caposaldi e si restaurò il fossato. Svanita la paura, lo sviluppo continuò come testimonia l'edificazione, nel 1480, di due sobborghi esterni. Solo la perdita del suo ricco mercato, nel 1548, provocò l'irreversibile inversione di tendenzal46l
Uno splendido esempio di borgo rurale fortificato, può essere considerato Monteriggioni, anch'esso abitualmente definito 'castello' . Posto nei pressi di Siena, si sviluppò all'interno di una cerchia di 560 mdi perimetro, scandita da 14 torri rettangolari. Venne edificato nel 1213 dai Senesi per difendersi dalle paventate aggressioni fiorentine. Così, infatti, recita una lapide posta vicino alla porta verso Siena:
Un antico manoscritto sintetizzava nei seguenti termini le caratteristiche salienti del borgo:
" Il castello, che a ragione facilmente si avrà retratto la denominazione, resta lontano dalla città di Siena miglia sei, situato sopra un monte alquanto elevato, a sinistra della strada, per la quale si va a Firenze, e poco distante dal dominio fiorentino. 11 castello è di forma ovale circondato di forti mura con torrioni e baluardi e due sono le Porte per le quali si porge l ' ingresso, che quella volta a Levante si nomina la Porta S. Giovanni e l'altra a Ponente la Porta franca
La ved uta del castello rimane scoverta da tutte le parti, non avendo se non in distanza altri monti, che gli sov rastino , e esso castello in un piano sopra poggio eminente circondato da fosso, e da bastione per ogni parte, e perciò, secondo l'antica fortificazione creduto inespugnabile. Ha una sola strada che conduce dall'una all'altra Porta , e alcuni vicoli, che tutti riescono in essa. Le case non sono né d'aparenza né comode, ma basse e anguste, e abitate da soli mazza ioli e pigionali, che in tutto la popolazione non passerà le 70 anime, e quelle tutte povera gente "' 48 1 •
Un raccolto borgo agricolo, quindi, ma con compiti salturiamente militari di avamposto, ottima esemplificazione di questa particolare tipologia. Infatti: " .il Castello murato di Monteriggioni avrà sul territorio circostante non solo la funzione difensiva per Siena ma una sua autonomia economica, religiosa, politica. Codeste istanze, materializzate dagli uomini che ne erano i legittimi rappresentanti, si affacciavano sulla piazza interna, a significare una «fusione ideologica» rec iprocamente concordata ed accettata. E quando gli eventi politici pongono la necessità di servirsi di Monteriggioni come strumento militare come nel 1259, allorchè i fiorentini mossero guerra a Siena le alte mura e il fossato, nonchè «un migliaio di soldati» (evidentemente reclutati per l'occasione anche fra i villani e i contadini) ne impediranno la resa "<49l
Le fonti ci tramandano il rendiconto delle spese sostenute, negli anni seguenti, per la sua manutenzione , in particolare delle porte e delle torri, segno che
l'efficienza del caposaldo veniva reputata di primaria importanza. Ulteriori informazioni concernono l' abolizione del Vicariato nel 1342, ed ancora i restauri apportati al ponte ed alla torre del cassero. Seguirono altri assedi tra i quali quello del 1478, condotto sempre dai Fiorentini, e quello del 1526 nel corso del quale la Repubblica fiorentina , nonostante l'utilizzo delle ormai progredite armi da fuoco, non riuscì ad aver ragione della coriacea fortificazione.

Sensata, per conseguenza, la decisione di potenziarla sottoponendola a cospicue ricostruzioni , compiute tra il 1545 ed 1554. Insensata, invece , l'opzione di non aggiornarne la concezione , ferma in pratica alla sua originaria edificazione, ed ormai ampiamente superata. E, come prevedibile nonchè sottolineato dal memorialista, quelle fortificazioni erette secondo l'antica maniera e giustamente reputate, all ' epoca inespugnabili, alla metà del Cinquecento risultavano ormai giubilate. Pertanto era trascorso appena un anno dall ' ultimazione di quei lavori, quando il 17 aprile del 1555, dopo un violento investimento , nel più ampio contesto della resa della Repubblica se-nese agli ispano-medicei, Monteriggioni capitolò definitivamente.
Al margine della gloriosa epopea del borgo murato si impongo no alcune considerazioni suJla sua impostazione difensiva. Innan zitutto va osservato che la pianta circolare, pur racchiudendo la massima superficie con il minimo perimetro, non era nel XIII secolo, già da tempo, reputata conveniente . Il fiancheggiamento, infatti , per la convessità delle cortine risultava deficitario e l'appoggio reciproco fra torri contigue scarso, rendendo perciò indispensabile ridurne l'interasse. Non a caso lun go questa cerc hi a si avvicendano ogni 40 m, ridondanza eccessiva per cortine ad andamento lineare. Ma ciò che stupisce maggiormente nelle torri in quest ione, al di là del loro rilevante numero, e della pianta rettangolare, sostanzialmente s imil e a quella delle fortificazioni federiciane, è una peculiarità che in Toscana ed in Umbria trova frequenti riproposizioni, e che lascia sottintendere una malcelata diffidenza verso i difensori piuttosto che una raffinata astuzia contro gli
attaccanti. essendo ricavata a prezzo di una sensibile perdita di solidità strutturale.
A differenza di tutte le ton-i quadrilatere finora incontrate, quelle di Monteriggioni hanno soltanto le tre facce laterali esterne, mancando della retrostante: la pian ta diviene perciò una sorta di U aperta verso la piazza. La disposizione, invisibile da fuori, consentiva però dall'interno di tenere, costantemente, sotto controllo, o sotto tiro, i difensori delle stesse, posizionati su i loro vari piani. Ufficialmente la strana configurazione traeva origine dalla necessità di evitare che l'eventuale conquista di una toITe potesse fornire al nemico un caposaldo autonomo di improba tacitazione. In realtà, però, sembrerebbe di gran lunga più convince nt e credere che si volesse impedire, nel ri ssos o contesto comunale, la potenziale defezione, o il tradimento , di una fazione cittadina, sopprimendo l'autonomia strutturale delle ton-i. in ogni altro contesto reputata basilare perchè finalizzata alla loro resistenza ad
oltranza. Dato l'ottimo stato di conservazione delle to1Ti di Monteriggioni è agevole riscontrare quanto detto , nonchè verificare la compartimentazione verticale, ottenuta con tre volte a botte sovrapposte, delle quali il calpestio della intennedia coincide con la quota del cammino di ronda, e quello della superiore con la copertura, che lo domina di circa 6 m.
Un'analoga planimetria ad U delle torri è possibile scorgere anche nel borgo viario di Montagnana, presso Padova, nella pianura veneta. La sua grandiosa cerchia, perfettamente conservata, si snoda per circa 2 km, lungo un perimetro rettangolare con 4 porte fortificate e 24 torri pentagone, aperte posterio1mente, di s tanziate mediamente da un interas se di circa 40 m. Tl camnùnamento di ronda è protetto da una merlatura continua, a filo con l'estradosso della cortina, senza alcun aggetto. Un ampio fossato interdice l'acco sta mento lun go l'intero circuito. Come le torri di Monteriggioni sug-
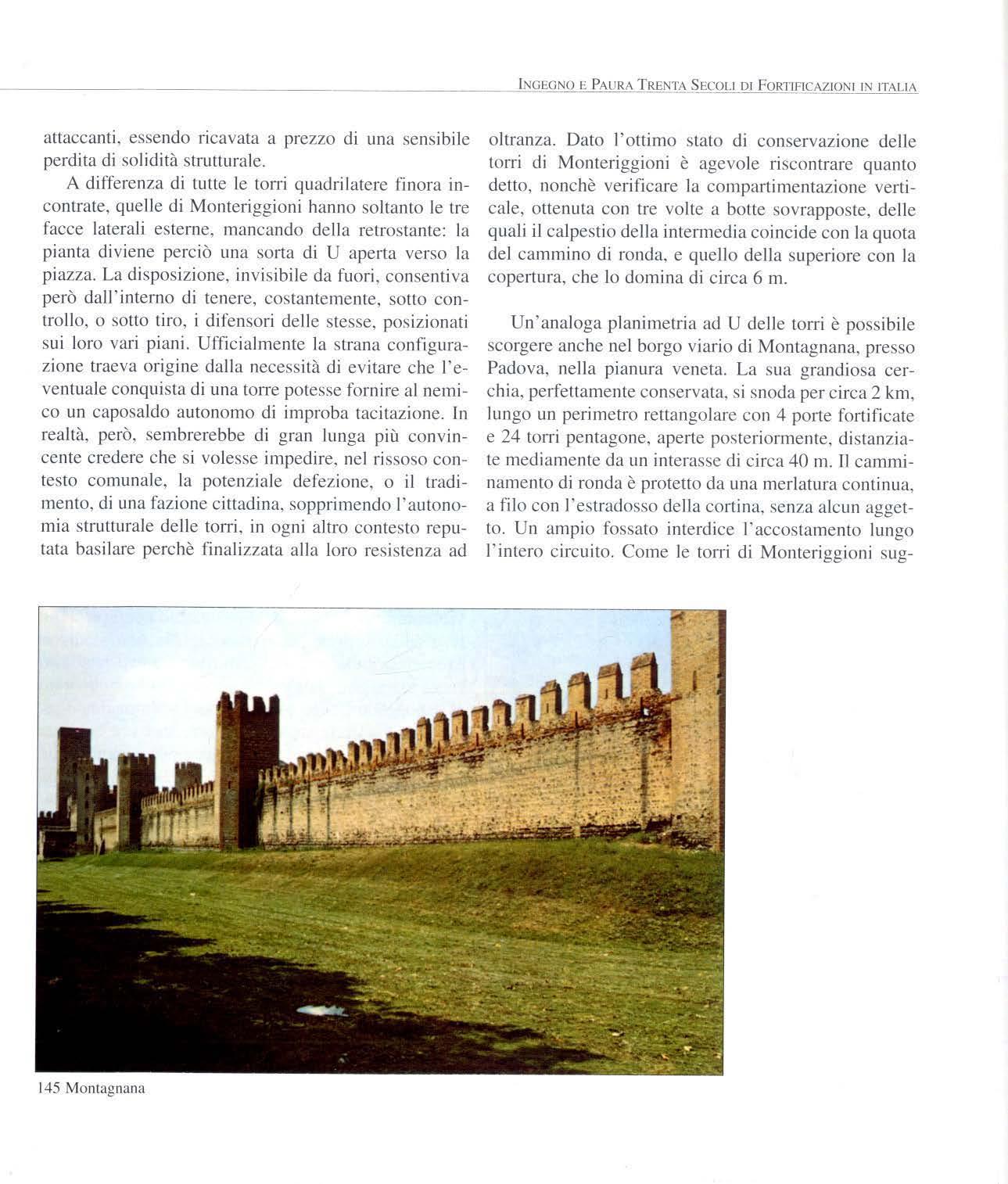
geriscono una certa aderenza ai canoni federiciani, anche queste di Montagnana, a forma di puntone, sono molto simili a quelle del castello di Augusta: forse non si tratta di una semplice coincidenza , poichè la cerchia venne restaurata nel corso del XIII secolo da Ezzelino da Romano, fedelissimo dell'imperatore.
Altre torri ad U si ritrovano pure a Cagliari, in corrispondenza con le tre porte dell'antica cittadella pisana, note come torri di S. Pancrazio, del Leone e deJJ ' Elefante. Di vertiginosa altezza, circa 35 m , vennero erette, stando alle rispettive lapidi, tra il 1305 ed il 1307 ad opera dell ' architetto Giovanni

Capula(~ 0 , Simili , pure, le venti torri disposte lungo la cerchia di Iglesias, fortificazione avviata dai Pisani agli inizi del 1300, neJ corso della loro breve dominazione ed ancora non terminata venti anni dopo•51 • , mancandone quasi una metà sostituita , provvisoriamente, da una palizzata con antistante fossato. La marginalità dell'opera è del resto ulteriormente te s ti-
moniata dal suo coronamento merlato di superata concezione , s empre a filo e senza il minimo accenno di aggetto.
L'origine pisana degli ultimi e s empi, accredita l'ipotesi che l'espediente delle torri aperte debba relazionarsi al clima di endemica conflittualità intestina dei comuni centro-settentrionali. Ma altre toni ne furono la mas s ima manifestazione: quelle gentilizie.
Le fortifica z ioni private: le torri gentili zie
Una nutritissima tipologia fortificat01ia, quasi peculiare dei Comuni , dal momento che vanta poche riproposizioni al di fuori di tale ambito, è quella delle case-to1Ti urbane e, sopranutto, deJJe toJTi gentilizie. in merito va osservato che e sse , pur ricordando sotto l'aspetto strutturale le più antiche toni autonome longobarde e normanne, rispondevano ad una diversissima logica
d'impianto e di funzione. Non svettavano, infatti, sopra un ' impervia altura, isolate e lontane da qualsiasi centro abitato, ma, al contrario, si ergevano, quasi a ridosso l'una dell'altra, nel cuore delle città. Ed appunto in relazione al loro impianto urbano non ebbero l'ingresso sopraelevato, immancabile nelle precedenti. Adottarono sempre la pianta quadrata, in quanto staticamente più salda ed architettonicamente più compatibile con una fruizione residenziale , ferma restando la piena subordinazione ai c1iteri difensivi ed offensivi, comunque p1ioritari.
In precedenza è stato tratteggiato il contesto di sfrenata astiosità che, da un certo momento in poi, afflisse tutti i comuni, in particolare quelli più prosperi e popo-
Iosi. I pretesti scatenanti furono disparatissimi, andando daJJe gelosie mercantili a quelle politiche, daJJe ambizioni egemoniche a quelle signorili: ogni motivo fu reputato valido per aizzare e suppo1tare faide e rancori irriducibili. La semplice residenza nei normali fabbricati divenne perciò eccessivamente rischiosa e in breve volgere si passò dall'adozione di ingenui accorgimenti cautelativi, quali serramenti rinforzati ed aperture al piano terra ridottissime, alla costruzione di vere case-fortezze15 1 • La ristrettezza degli spazi urbani , però, non consentiva rilevanti s uperfici e, del resto, nessuno disponeva del numero di familiari, o di dipendenti, sufficienti per difenderle. Nè, peraltro, la difesa di siffatte strutture avrebbe potuto beneficiare dei necessari settori di tiro sgo mbri, ritrovando s i costipate dalla pletora dei caseggiati dei centri medievali. Impos si bile , perciò, per queste e per innumerevoli altre ragioni, adottare le soluzioni specifiche della più avanzata fortificazione militare. Soltanto alcune delle sue caratteristiche tornavano utilizzabili, logicamente le meno costose e le meno complesse, in particolare quelle passive. Fra queste l'altezza, che consentiva di dominare dall'alto il dedalo di vicoli, di incrementare la forza viva del tiro piombante e di garantire l'inviolabilità dei proprietari, fornendo, inoltre, sebbene in verticale un certo numero di ambienti ricettivi di discreta superficie complessiva. La struttura ideale, pertanto , avrebbe dovuto svilupparsi su di una modes tissima superficie con una rilevante altezza: sarebbe stata perciò a forma di torre.
Constatatasene ben presto la validità, chiunque ne ebbe la possibilità si dotò di siffatte fortificazioni p1ivate , unico scampo dalle vendette e dalle insidie dei concittadini. Così quel cUma è ricordato in una memoria del 1297 relativa a Pistoia:
" Le re vo lu zionì , le insolenze. le rubberìe , li assassinamenti. che giornalmente accadevano. le co ntrarietà conti nue, c he tra i Cittadini passavano, cagionarono diffidenza tale tra le persone, che s i viveva da tutti con gran sospe tto , e timore: quindi ciascuno per sic urezza stava nella propria casa fottificata , e chi aveva la Torre. la provvede va di ciò. che poteva aver di bi sog no , arrivando in questi te mpi le Torri in Pìstoja al num ero dì sessa nta alcune

delle qua li si vedono a ncora tullora elevate sopra l e fabbriche, alcune sono coperte dai tetti, altre nelle case racchiuse, e a ltre da l tempo e dalle guerre rovinate, e dcstrulle: ed è qui da notarsi, c he non potevan si fa bb ricare le To rri che dai nobili, e queste aveva no l e loro misure. dirnodochè per fuggire l'in vid ia non potevano passa re un a limitata a l tezza . ,,,, ,,
Per quanto è possibile arguire, dalle fonti e d ai ruderi, a Savona ve ne dovettero essere almeno una qu arantina, a Bolog na forse 260. Di que st' ultim e sopravvivono la torre deg li Asinelli ( 1109 - 1119) , che attinge ancora i 97 mdi al tezza, con una base di 12 metri per

lato ed uno strapi ombo di 1.2 , e la pressocchè coeva della Garisenda, ci mata nel X IV seco lo, proprio per l 'eccessi va pendenza raggiunta pari a m. 2.37 s ui 47 d'altezza residua. A R oma, stando al Gregorovius, se ne con ta va no addirittura 900. molte con ril evanti dimensioni di base. Quanto a Pi sa s i trova menzione di almeno 600 torri. È indubbio che nella maggior parte di esse no n ci si rifu g ia sse so lt anto nei momenti di massima te n s ion e ma vi si abitasse stabilmente per periodi progressivamente più lunghi, come in veri castelli urbani.
Quale fosse l'aspetto di una grande città med ievale, pullulante di altissime torri gentili zie, è possibile immaginarlo da una cronaca redatt a nel 15 87 da Gi ovanni Villani relativa a Fir e nze, quando la città ne co nse rvava a ncora un gran numero :
" ma pure la Città dentro era unita di Cittadini e era mo lto forte di mura con grosse torri , e fos s i pieni d ' acqua , e dentro alla picciola Cittade hebbe in poco tempo appresso di l50 torri di Cittadini d i altezza di braccia 120 l'una (circa 70 m ), s anza quelle delle mura della Città: e per l'altezza deUe molte torri ch' erano allora in Firenze si dice , ch ' e ll a s i dimostrava da lungi , e da presso di fuori la più bella, e rigogl iosa Cittade del suo picciol si to. che si trovasse ... "•l•,.
La s traordinaria altezza delle to ni gentilizie eccede abbondantemente la mera es ige nza difensiva e, pertanto, la s i deve necessariamente attribuire a finalità offensive, concrete e ps icologich e. È assurdo, in fatti, s uppon-e al ri g uardo una se nsibile differen za fra la protezione offerta da una torre di 50 mdi alte zza ed una di 70 , come pure un più mortifero esito per un ma sso fatto cadere dalla più alta. Sensato, invec e, pres umere c he p sicologicamente la seconda facesse più impre ss ione della prima, riu sce ndo visibi le la s ua sommità da qualsiasi vicolo circostante, con la logica conseguenza concreta che i dardi da essa scag liati avrebbero facilmente potuto raggiungerlo.
In altre parole l'alte zza veni va ricercata non per incrementare la violenza dei tiri piombanti ma per amp iiare il raggio di quelli ficcanti fin dentro ai v icoli più insignificanti: la so mmità delle torri, quindi, po-
trebbe equipararsi ad una sorta di elicottero in volo staziona.rio!
Ed, in breve, proprio l'altezza delle torri gentilizie, delle quali è funzione esponenziale l'onere di costruzione, rappresentò la misura della ricchezza e del potere della casata detentrice. Probabilmente l'esasperarsi di tale ostentazione, il minaccioso incrementarsi del raggio offensivo dei tiri ed i gravissimi incidenti che sicuramente saranno avvenuti per difetti di costruzione o di fondazione (poche tra le torri sopravvissute sono prive di spiornbamenti imputabili a parziali cedimenti basamentaJi) indussero gli amministratori pubblici a limitarne l'altezza massima consentita, in una sorta di democratizzazione verticale.
La maggioranza dei comuni, pertanto , dopo i primi decenni di anarchia e d 'arbitrio, non tollerò più siffatte smodate manifestazioni di orgoglio e prepotenza, obbligando tutti a non oltrepassare in altezza la toITe di cui era stato munito il palazzo pubblico; per quelle
eccedenti già esistenti si decretò la cimazione. Per restare a Firenze:
" cominciarono a fare il palagio che è dietro alla badia in su lla piazza di Santo Apollinare. cioè quello che è di pietre conce colla torre: ché prima non avea palagio di comune in Firenze, ma stava la signor ia quando in una parte della città e quando in un'altra. E quando il popolo ebbe presa la signoria e s tato , s i ordinarono per più fortezza del popolo, che tutte le torri di Firenze (che ce ne avea grande quantità alte braccia centoventi) s i tagliassero e tornassero alla mi s ura di cinquanta braccia e non più. E così fu fatto: e delle pietre s i murò poi la c ittà di Oltrarn o. E le predette torri erano quasi tutte, o la maggio r parte, di nobili di Firenze: e poche ve n'avea che non fossero di nobili, e ben ve n'era di quelle che s'e ran fatte dalle vicinanze
La vicenda della regolamentazione dell'altezza delle torri gentilizie dimostra, se mai ve ne fosse bisogno, che la djfe sa privata ha sempre goduto da parte delle legittime autorità di un esplicito consenso o, almeno, di un tacito assen so, meritandosi pienamente la qualifica

di 'delegata'. La globalità delle fortificazioni private, infatti, in presenza di un comune nemico cooperava pur sempre alla salvezza collettiva, a patto che ne fosse controllata discretamente l'adozione. In ultima analisi, era un modo scaltro e a costo zero per dispoITe di ulteriori fortificazioni. Anche per le torri gentilizie tale prassi sembra esser stata rispettata, non soltanto per la definizione dell'altezza ma anche per la stessa edificazione che, ben presto, venne subordinata alla pedante concessione rilasciata dai cosiddetti Ufiziali di Torre.
Dal punto di vista strutturale quella singolare fortificazione privata urbana, per inciso una delle poche di mat1ice non militare, era, come accennato, estremamente semplice. Sia le toITi propriamente dette che le case-torTi, spesso pratican1ente simili, insistevano su di una superficie ridottissima, mediamente un quadrato di circa 7-10 m di lato. Ne consegui vano vani interni, al netto dei muri, mai superiori ai 25-30 mq, destinati alle tipiche funzioni residenziali di ogni abitazione coeva. Al piano terra stava la bottega, o il fondaco, ai livelli superiori, accessibili tramite scale di legno, non di rado volanti per ragioni di sicurezza, ambienti riservati alla vita quotidiana. Più in alto ancora le camere da letto: al riguardo non si coglie alcuna differenza fra le ton-i erette a Firenze, a Pistoia, a Prato, a Pavia, a Volten-a, a Bologna, a Roma o a San Gimignano.
ln dettaglio, la: " ... casa toITe ha forma assai semplice. Due pilastri (più raramente tre o quattro) in solida struttura lapidea erano uniti nella parre tenninale da archi ogivali o a tutto sesto; i piani intermedi erano scanditi da architravi in pietra o in legno, ovvero da archi scemi in mattoni: su questi riposavano i solai lignei o 'palchi' I tetti, risolti «a padiglione», avevano orditura lignea che terminava nell'aggetto di gronda: questa, che era la parte visibile dalla strada, risolveva non solo il problema di riparare la facciata e i passanti dalla pioggia ma aveva quasi sempre valore dimostrativo se non ostentativo della famiglia titolare ... Nelle case a pilastri, che costituiscono ... la tipologia più diffusa, si apri vano talvolta finestre assai eleganti, bifore, arcate a pieno centro con una colonnina nel mezzo sostenente due archetti rotondi che riempiono il vuoto dell'arco
grande senza trilobi. Peraltro, anche trifore e quadlifore non erano assenti ... AI piano terreno era la bottega... ai piani supe1iori .le sale mentre la cucina era preferibilmente collocata in alto per dare facile sfogo al fumo e evitare così il «fumicaiolo» che avrebbe pericolosamente interessato per l'intera altezza la costruzione. I <<comodi» igienici erano l' acquaio spesso ricavato in nicchia. in muratura con una canalizzazione che talvolta scaricava ove vi fossero nelle chiaviche cittadine, altre volte direttamente sulla pubblica via... "'561 •
Circa l'utilizzo: " ... la casa torre veniva abitata , generalmente , al piano nobile dal signore e nei piani superiori dalla famiglia; domestici e sudditi si distribuì vano negli abituri superiori o circostanti; questa la «destinazione d'uso» più consueta " 15 1 > Ed è emblematico che un 'unica struttura, tanto ristretta, finisse per costituire una sorta di ·carota' della stratificazione sociale dell'epoca, in cui l ' importanza del ruolo ricoperto era inversamente proporzionale all'altezza del!' alloggio occupato!

Pur non mancando un discreto campionario di singole case torri e ton-i-gentilizie, quasi nulla rimane, invece, della loro fitta compresenza in ambito comunale. Unica eccezione è quella di San Gimignano, non a caso definita la città delle torri. Non tutte, ovviamente, sono sopravvissute, ma le tante superstiti forni.scono un ' idea di quella lontana difesa intraurbana.
Come molti centri medievali anche S. Gimignano sorse a controllo di un nodo stradale, posto per l'esattezza ad un paio di chilometri dall'incrocio della via Francigena con la via Pisana. Il primo: " ... documento che ci attesta l'esistenza del castello di San Gimignano è del 929: con esso il re d' Italia Ugo di Provenza dona il monte, sul quale sorge il castello, al vescovo cli Volterra. Il castello è situato ad Est della via Francigena sul poggio della Torre o Canova, ad ovest è Montestaffoli (poi sede della rocca); tra questi due capisaldi si costituisce il borgo di San Gimignano. Nel
949 San Gimignano è nominato come borgo: Prope burgo Sancti Geminiani in Marcignano e nel 998 si ha notizia che il borgo è cinto di mura.

La rapida espansione di San Gimignano va messa in relazione alla posizione favorevole in cui è ubicato il castello. 11 borgo si è fonnato lungo la via Francigena e le mura racchiudono un tratto di questa strada, che entra dall'arco della Cancelleria per uscire da quello dei Becci; nel borgo la via Pisana confluisce nella via Francigena. La via Pisana è la principale congiungente di Pi sa a Siena L'incrocio di queste due importantissime vie commerciali, fa di San Gimignano un importante centro di smistamento e di vendita ... Tra il 1000 ed il 1100 il raggio d'influenza della giurisdizione territoriale di San Gimignano si ingrandisce notevolmente. Il contado è ancora sotto la signoria del vescovo di Volterra, che, per mezzo di acquisti e donazioni, è riuscito a superare la feudalità laica... " <58>
Le risorse che consentono la notevole espansione di San Gimignano dipendono per buona parte proprio dall'incrocio stradale e dai relativi dazi di transito. Per il resto: " ... due sono i prodotti commerciali che San Gimignano può offrire: lo zafferano, che nel '200 veniva esportato non solo nelle fiere della Champagne, a Napoli e a Me ssi na , ma anche nell'Africa settentrionale e addirittura in Egitto, sia pure forse su navi pisane, e inoltre il vino. Non era invece molto importante lo sv iluppo artigianale ... " <59 i. La ricchezza , quindi, non è frutto di attività mercantili o artigianali ma piuttosto di una rendita di posizione e, pertanto, finisce come presumibile nelle mani di poche famiglie. Queste ultime, costituiscono: " .. .il ceto superiore della città la vecchia nobiltà dei vicedomini e fide/es del vescovo, e più tardi dei consoli; gli ultimi due gruppi devono le loro sostanze non solo a rendite fond iarie, ma anche al commercio e al prestito. A far costruire le torri furono famig li e di mercanti e di prestatori, che avevano adottato questo stile di vita tipico della nobiltà cittadina. La città aveva una struttura sociale armonica: nel '200 i grandi patrimoni ammontavano al 28,9%, i medi al 48,3% e i piccoli al 22,8%. La nobiltà di origine feudale ... partecipava alla vita politica e amministrativa
150 San Gìmignano 151 San Gimignano ING EGNO E PA URA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZION I IN ITALIAdel comune, ma non in posizione dominante Con le guerre civili, il '300 porta in città il regresso, la perdita dell'autonomia e l'annessione a Firenze .. .''(601 • Lentamente da allora la città iniziò a perdere molte delle sue numerose torri gentilizie, ed al presente ne restano: " 15 esemplari delle settanta che la coronarono un giorno nel lento ondulare della campagna senese. E la 'Rognosa' che è la torre del Podestà, dall'alto dei suoi 52 metri, le sovrasta tutte come per precisa ordinanza, la famiglia dei Salvucci, lì di fronte, dovette riconoscere umilmente. Sicchè la leggenda narra che raddoppiando il puntiglio e il numero delle torri, la stessa famiglia costruiva le due attigue, che ancor oggi si vedono, eludendo furbescamente la imposizione e vi n cendo ancora una volta la gara con la somma delle altezze. La quale versione popolare e bonaria offre una spiegazione non troppo ortodossa delle tante torri gemellate o solidali nella difesa allora non frequenti, ma nemmeno sconosciute e meglio dominanti gli accessi interposti " c6 1>.
Quest'ultimo dettaglio relativo all'edificazione di torri binate, rappresenta l'estrema sofisticazione della particolare tipologia fortificatoria. Con il progressivo evolversi delle armi da fuoco le torri gentilizie presero a sparire rapidamente, essendosene pienamente recepita l'estrema fragilità, connessa proprio con il loro più ostentato motivo d'orgoglio: l'altezza.
Tra il X III ed il XIV secolo, dopo quasi trecent' anni di ininterrotto sviluppo demografico, le stime proposte dal Beloch, e parzialmente integrate con le risultanze di altri studiosi, fanno ascendere l'ammontare della popolazione dell'Italia ad un totale di quasi 12 milioni di persone, così distribuite:

"Isola di Sicilia (1227): almeno centom il a abitanti dei quali quarantamila a Palermo, ventisettemila a Messina, e diecimila a Catania.
R eg no di Napoli: due milioni di abitanti secondo B eloc h, tre milioni secondo Egidi; cinquantamila a
Napoli, secondo Fuiano.
Stati della Chiesa: due milioni di abitanti al massimo , dei quali trentacinquemila a Roma intorno al 1220, secondo Cancellieri, quarantamila a Bologna verso il 1370, undicimila ad Orvieto nel 1292.
Toscana: all'incirca due milioni di abitanti verso l'anno 1300 secondo il Fiumi, che concorda con le indicazioni date dal Villani; in questo periodo Firenze dovrebbe avere novantacinquemila abitanti, San Gimignano tredicimila (secondo Fiumi), Lucca, Siena e Pisa intorno ai ventottomila (secondo Beloch).
Pianura Padana: circa quattro milioni di abitanti , dei quali almeno centomila a Milano (1288 ), novantamila a Venezia (1338), trentamila a Padova (1320), trentamila a Verona (1320), trentamila a Pavia (1250)". (621
L'entità complessiva non differiva da quella coeva della Francia, valutata da analoghe stime intorno a 15 milioni: ma l'estrema frammentazione ne rendeva assolutamente insignificante il peso politico-militare. Unica eccezione, il regno delle Due Sicilie che pertanto, dopo la morte di Federico II, finì per costituire la più ambita preda di aspiranti sovrani, ed un irresistibile richiamo per la Francia e per la Germania in virtù delle sue potenzialità economiche e strategiche.
Il 29 agosto del 1261 fu eletto papa Jacques Pantaléon, di nascita francese, già patriarca di Gerusalemme, che prese il nome di Urbano IV Per la storia rappresentò il primo pontefice non ' italiano ' , anomalia che ebbe inunediate conseguenze, originandosi, da quel momento, una politica vaticana sfacciatamente filofrancese. La scelta di quattordici nuovi cardinali, molti dei quali non a caso suoi connazionali, gli garantì il consenso nell'ambito del Sacro Collegio, incrementando così la sua libertà d'azione tesa a restaurare la compromessa autorità temporale.
Urbano IV aveva perfettamente compreso che anche Manfredi di Svevia, non diversamente dal padre, mirava ad unificare l'Italia sotto il suo scettro , evenienza nettamente antitetica aJla sua visione geopolitica. Indispensabile perciò annientarne qualsiasi ulteriore iniziativa, sostituendolo, al più presto, con un altro monarca di acce11ata lealtà, ovvero con un francese.
Confermata la scomunica a Manfredi nel marzo del 1263, avviò trattative segrete per fargli subentrare Carlo d ' Angiò, fratello di Luigi IX, ponendo la massima attenzione ad evitare che il designato potesse trasformarsi in un futuro avversario. Dal canto suo Carlo non sembrava affatto disponibile a fungere, nella vicenda, da semplice burattino nè, meno che mai, in caso di successo, da re a sovranità limitata. Ad ogni buon conto nel 1264 accettò il titolo di senatore di Roma: ma proprio in quello stesso anno il papa morì. Gli successe, quasi a ribadire l'immutata linea politica, un altro francese, Guido FouJques , con il nome di Clemente IV Senza frapporre indugi il neoeletto pontefice concluse le trattative del predecessore riaffennandone i punti irrinunciabili per la Santa Sede. Innanzitutto il Regno delle Due Sicilie avrebbe dovuto staccarsi irreversibilmente dal!' Impero ed il suo sovrano non avrebbe mai dovuto possedere altre cariche negli Stati pontifici, in Lombardia o in Toscana; lo stesso, inoltre, con l'assunzione della corona, avrebbe corrisposto al pontefice 50.000 marchi, impegnandosi, sempre in suo favore, ad un tributo annuo di 8.000 once d'oro, nonchè alla fornitura di 300 cavalieri per un trimestre l'anno , esentando, infine, il clero regnicolo da ogni imposizione fiscale. Le clausole, vessatorie ed umilianti, vennero però sottoscritte: l'ambizione sfrenata di Carlo d'Angiò ebbe così modo di manifestarsi pienamente, dopo un passato trascorso a scalare i gradini del potere, dal governo della Provenza, peraltro ottenuto in virtù del matrimonio con Beatrice, figlia del conte Berengario IV, alla contea del Piemonte, carpita tra il 1258 ed il 1264.

Soltanto nell'anno seguente, Manfredi , finalmente, percepì il pe1icolo che lo sovrastava. Tentò allora disperatamente di difendere il Regno: ma ormai era troppo tardi. Nel febbraio del 1266 si accampò nei pressi di Benevento preparandosi allo scontro risolutivo con il Francese, che ebbe luogo il 26 febbraio. Le truppe dello Svevo, un aggregato di Germanici, Lombardi e Saraceni, non ressero l' u1to degli Angioinj ed il giovane sovrano, compresa la sua imminente sconfitta, si procurò la morte gettandosi nella mischia. Poche ore dopo Carlo ottenne l ' agognato trono.
Il s uo governo, che pure aveva trovato alquanti sostenitori nei baroni normanni, mai sottomessi dalla dinastia sveva, si dimostrò immediatamente ancora più oppressivo ed intollerante del precedente. Le mire smodate dell ' Angioino sembravano fatte apposta per esasperare il già odioso fiscalismo, moltiplicando le spese per avventure militari di improba riuscita. La situazione precipitò ulteriormente dopo la morte del pontefice , nel 1268 , allorquando Carlo d ' Angiò si ritenne libero di agire per estendere i suoi interes s i anche al resto d ' Italia, continuando paradossalmente la politica svev a. Pertanto: " dopo una guerra di un anno in Toscana, costrinse Pi sa alla pace nel 1270 e nello stesso anno Siena capitolò, divenne guelfa ed espulse i ghibellini. Ecce z ion fatta per Pisa , Carlo agì d'accordo con i nobili e i banchieri guelfi, cui era profondamente legato. Il suo governo era mite e, per così dire, «costituzionale»; diede al paese sconvolto pace e prosperità. Nell'Italia se ttentrionale , estese il s uo dominio so ttomettendo nel 1270 Torino ed Al essan dria; nello stesso anno divenne signore di Brescia, dopo aver cercato di ottenere la stessa posizione anche nelle altre città guelfe; la sua richiesta fu respinta nel 1269, anche se egli ottenne una specie di giuramento di fedeltà ... "<M .
La crociata lanciata da Luigi IX contro Tunisi , nell'e s tate del 1270, lo vide se non tra i convinti fautori almeno tra i protagonisti <64 > . La morte del fratello, avvenuta intorno alla metà di agosto dello stesso anno, lo pose a capo dell'impresa , che subito sfruttò abilmente a proprio vantaggio. In breve, costretto l'emiro a 1ispettare gli antichi accordi sottoscritti con gli Svevi pagando gli arretrati e le spese della guerra , si assicurò, oltre alla soggezione di Tunisi, una discreta risorsa economica, indispensabile per l 'a ttuazione dei suoi piani. Disgraziatamente per lui , però, al ritorno dal Nordafrica , il 23 novembre del 1270, mentre la flotta regnicola era alla fonda a Trapani , un violentissimo fortunale la distrusse completamente, ponendo fine ad ogni progetto<65 > Nonostante ciò, appena due anni dopo le truppe angioine occupavano Durazzo (M>, dopo aver
INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTlr!CAZIONI IN ITALIAinfranto la resistenza del figlio di Michele Angelo II, fratello di Elena d'Epiro, la disgraziata vedova di Manfredi.
Ma, a quel punto, la sorte dell'Angioino mutò radicalmente: anche il semplice controllo del territorio circostante alla città albanese si dimostrò subito esulante dalle sue concrete potenzialità: 1' insuccesso innescò la sua parabola discendente. Per procurarsi una nuova flotta, Carlo si alleò, nel 1273, con i fuoriusciti genovesi guelfi, scacciati dalla città dai ghibellini dopo la rivolta del 1270. Quindi: " ... costrinse la città alla guerra, ma venne sconfitto sia per terra che per mare. Genova poteva ora far entrare gli spagnoli in Lombardia ed approfittò dell'occasione: il 26 ottobre del 1274 si alleò con i ghibellini della Lombardia occidentale, Guglielmo VII di Monferrato ed Asti, che stavano cedendo agli attacchi di Carlo e introdusse in Lombardia 1000 soldati spagnoli. Tutte le città ghibelline, sempre più numerose , immediatamente riconobbero Alfonso X nel suo titolo. Infine, la vittoria riportata il 1O novembre 127 5 dal marchese Tommaso di Saluzzo sul siniscalco di Carlo a Roccavione fece sì che il re siciliano perdesse il Piemonte. Ben poco sostenuto dai Della Torre, suoi alleati, gli veniva meno la supremazia nell'Italia settentrionale ... " '671 •

La perdita del Piemonte e della Lombardia fu rapidamente seguita dal repentino ridimensionamento del suo potere in Toscana. Dopo anni di sterili trame per recuperare la perduta rilevanza, uno spiraglio di speranze gli derivò dall'elezione a papa, il 22 febbraio del 1281, di un altro francese, Simone de Brion, che prese il nome di Martino IV. Tanto bastò, infatti, per convincerlo ad intraprendere un ancora più sfrenato progetto aggressivo: la conquista della stessa Costantinopoli.
Tutte quelle rovinose guerre, però, avevano stremato le finanze del Regno, rendendo ancora più intollerabile lo
già spietato fiscalismo. I sudditi gli erano ormai tutti apertamente ostili, aizzati dai suoi brutali esattori e dalle sue insolenti soldataglie: non occoITeva una notevole perspicacia per prevedere, da un momento all'altro, una terribile rivolta. Ed il 30 marzo del 1282 la paventata esplosione avvenne, violentissima, in Sicilia. Il contesto geografico non fu affatto casuale: l'isola, dal giorno della conquista francese, annientata ogni sua autonomia, svilito ogni suo prestigio, era stata ridotta al rango di disgraziata colonia agricola da sfruttare selvaggiamente senza alcun riguardo per la sua cultura, e quel che è peggio, per le sue effettive potenzialità economiche.
Probabilmente: " ... Carlo e i suoi banchieri toscani, ingannati dalle loro conoscenze di storia antica e dalla fama delle fertili pianure intorno a Napoli e a Palem10, condivisero l'illusione che il Sud fosse fonte di ricchezze inesauribili; ma in realtà queste ricchezze leggendarie erano dipese dal buon governo, dall'armonia sociale e dalle cure costanti di una numerosa popolazione lavoratrice interessata alla produttività agricola. Tali condizioni non esistevano più. La Sicilia non poteva proprio portare il peso delle ambizioni esagerate di Carlo , e il risultato fu la più famosa rivolta della storia dell'isola. "<<,K>
A Palermo, il lunedì di Pasqua del 1282 , alcuni soldati francesi, con l'abituale tracotanza, vollero perquisire la gente che si era radunata fuori le mura della città, per festeggiare la ricorrenza. Secondo la tradizione uno di loro oltraggiò una donna , finendo immediatamente massacrato dai presenti. Che l'insulto fosse un semplice pretesto per lo scatenarsi della rivolta lo dimostra il fatto che, pur ammettendone la veridicità, in quanto tale non costituiva nè un aberrante eccesso, nè una significativa novità. In un appello dei Siciliani indirizzato al papa nei giorni seguenti si può leggere:
"Costoro [i france s i] dici ci dovean reggere , co s toro amministrar la giustizia! ... Non è ribellione, o padri cos critti , quella che voi mirate; non ingrata fuga dal grembo di una madre: ma re s is tenza legittima, secondo ragion canonica e civile; ma casto amore, zelo della pudicizia, santa difesa di libertà Ecco le donne sforzate al cospetto <le' mariti; viziate le donzelle; accumulate le ingiurie .'"' 69 >
Pertanto, la gravità della provocazione stava, se mai, nel contesto in cui si estrinsecò, saturo di violenza repressa. Nelle ore seguenti, infatti, l'intera isola insorse contro i suoi dominatori dando prova di una efferatezza senza precedenti. Qualsiasi uomo di accento vagamente francese, o supposto tale: " ... venne trucidato e si dice che molte migliaia di francesi fossero uccisi in poche ore. 1 monasteri furono invasi e i monaci uccisi, vecchi e bambini massacrati, e anche donne siciliane sospettate di essere state ingravidate da soldati francesi furono sbudellate. La sepoltura cristiana fu spesso rifiutata. Non era una rivolta feudale ma una rivoluzione popolare, e proprio per questa ragione il suo successo immediato fu grandissimo; ma per la stessa ragione, fu particolannente barbara. Solamente i successivi sviluppi politici resero possibile esaltare un orribile massacro come uno degli avvenimenti più gloriosi della storia ... " <70i
Esaurita la mattanza dei francesi, recuperato un minimo di raziocinio, i rivoltosi realizzarono I' imminente scatenarsi della rappresaglia reale , e cercarono freneticamente un valido protettore al quale consegnare l'isola. Lo individuarono in Pietro d'Aragona, marito di Costanza, figlia di Manfredi ed unica erede degli Hohestaufen, la cui liberazione era stata estorta a Carlo d'Angiò pochi anni prima. E lo spagnolo, dopo una iniziale apparente ritrosia, accettò la richiesta. Sbarcato a Trapani il 30 agosto, venne proclamato re il 4 settembre a Palermo. Inutilmente , nei quattro mesi precedenti, tanto il papa che il sovrano, con minacce e con lusinghe, avevano tentato di recuperare la Sicilia.
Dal canto suo il nuovo sovrano, che già da tempo ambiva al possesso dell'isola in funzione della progressiva conquista dell'intero regno, non rimase a lungo inoperoso. La sua flotta, al comando dell'ammiraglio Ruggiero di Lauria, intraprese ben presto una serie di scorrerie contro le marine napoletane. Per l'Angioino l'esigenza di presidiare le coste, divenne perciò prioritaria. Del resto anche la difesa interna del Regno, tramontata la concezione statuale federiciana, e la relativa logica militare, imponeva un radicale riassetto delle tante fortificazioni, in molti luoghi ormai
superflue ed in altri, invece , indispensabili. Il che, come accennato , si tradu s se nella anacronistica riaffermazione del più rozzo feudalesimo , supportato da un ulteriore infittirsi dell'incastellamento territoriale.
Senza voler entrare nei dettagli delle vicende dell ' epoca, peraltro estremamente complesse ed articolate, osserveremo soltanto che il Mezzogiorno , già relativamente ai margini della politica sveva, si ritrovò all'improvviso al centro della dinamica internazionale e, di conseguenza, della conflittualità. Il che per le caratteristiche geografiche del Regno , trasformò gli abitati 1ivieraschi della sua sterminata frontiera marittima in avamposti, a cominciare dalla stessa capitale. Logico , pertanto, che la visione difensiva angioina della fine del XIII secolo: " ... mirava a fortificare in primo luogo Napoli ed i centri di una certa importanza , lasciando in uno stato di completo abbandono tutte le popolazioni dei paes i sparsi nell ' entroterra , determinando l ' emigrazione sia verso la capitale che nei centri più importanti " <11 > Considerando, inoltre, che nello stesso periodo l'architettura militare intraprendeva un ennesimo salto evolutivo, imposto dal potenziamento e dalla razionalizzazione delle dinamiche ossidionali , si comprende agevolmente lo stimolo pressante ai radicali aggiornamenti ed alle ricostruzioni di cui furono fatti oggetto tanti caste li i.
Un significativo riscontro del mutato stato di cose si ravvisa persino nella notorietà che, a partire da quegli anni, iniziarono ad assumere gli architetti e gli ingegneri militari, fino ad allora figure professionali assolutamente misconosciute e trascurate. Nella produzione angioina si individuano, perciò, reputati protomagistri per lo più francesi e provenzali, intenti ad applicare lungo le coste mediterranee i precipui criteri architettonici d'oltralpe. Tra essi spicca la: " figura di Pierre d' Angicourt.m>, un nobile originario della regione di Beauvais, che vediamo a1 servizio del re per circa trent' anni ...La diretta esperienza militare , di cavaliere feudatario .. .lo qua1ificò in maniera parti-
 ING EGNO E PA URA TR EN TA S ECOLI DI fORTIFIC AZ IONl IN JTALIA
ING EGNO E PA URA TR EN TA S ECOLI DI fORTIFIC AZ IONl IN JTALIA
colare per le opere di fortificazione e castelli: infatti ... [alcuni] documenti attestano.. .la [sua] direzione di lavori nei castelli di Bari, Brindisi e Barletta, sul volgere del 1280 Più difficile è stabilire se si debba a lui la pianta del Castelnuovo di Napoli, come vuole il Bertaux, ricordando la sua presenza in città sin dall'inizio dei lavori Altri documenti ricordano Pi erre d' Angicourt, cas tellano di castel dell'Ovo ... " 173\
Quelle diverse concezioni fortificatorie iniziarono a diffondersi rapidamente nel Re gno. La manifestazione più percepibile fu il sostituirsi delle cilindriche e snelle torri angioine a quelle quadrangolari sveve. L'adozione di torri a pianta ci rcolare, sebbene di per sè affatto rivoluzionaria, lo divenne per l'accettazione pressocchè totale del nuovo modello da parte dei progettist i reali, esattamente come era avvenuto, sotto la precedente dinastia, per la pianta quadrata. Circa i criteri strutturali: " .. .la matrice è, probabilmente, attribuibile al XII secolo; di tale epoca, infatti , è il castello francese di Montbrun, di carattere tipicamente feudale, costruito in un'epoca in cui l'opera del singolo artefice era quasi annullata da quella delle corporazioni medievali ... Ma il raffronto fra le due aree, francese ed italiana, non può fornirci sicure analogie o matrici informative caratterizzanti la derivazione dell a produzione italiana da quella d'oltralpe... È evidente, comunque, che nell'Italia meridionale, l'architettura fortificata degli Angioini assunse un carattere proprio, differenzian do si nettamente dalla tipologia di epoca normanna e sveva, svolgendo temi nuovi, imperniati su volumi nei quali spiccano le torri cilindriche su base scarpa ta " 04 >
Al di l à di una preferenza meramente estetica, l'opzione deve motivarsi, innanzitutto, con il minor costo delle torri cilindriche, fattore determinante in un programma di riqualificazione tanto imponente. Ri s ultavano, infatti, più rapide da costruire, perchè prive dei grossi conci d'angolo perfettamente squadrati, altrimenti indispensabili per la saldezza deg li sp igoli, e di più facile realizzazione non contemplando l'impi ego di mano d'opera particolarmente qualificata. Ma prescindendo da tale vantaggio, di per sè re l ativamente condizionante in

ambito militare, la predilezione per l'impianto circolare deve ascriversi ancora ad una mutata esigenza difensiva, a sua volta conseguenza di un mutato scenario ossidionale, caratterizzato da un incremento della violenza degli impatti balistici.
È emblematico al riguardo constatare che tra i maestri:" ... francesi del tempo di Carlo I va aggiunto Jean de Toul, lorenese, ricordato nel 1270 come «carpenterius» e fam iliare del re, in cui nel primo termine è implicita una particolare perizia strutturale, peraltro confermata non soltanto dal 1itrovare altre volte Jean indicato come «ingegnerius» [da notare che per i francesi coevi l' ingegno è ancora la macchina d'assedio n.d.A.], ma anche dal fatto che con la stessa qualifica di «carpentiere» è indicato maestro Honorè, l'ingegnere capo di Luigi IX di Francia. Anch ' egli, dunque, come Pierre d' Angicourt, era architetto di particolare perizia militare, capace di eseguire le macchine belliche in legno, allora largamente usate per gli assedi, non meno che di erigere torri in muratura .. . " (75 > _
Per avere un'idea del potere distruttivo raggiunto dalle macchine da lancio dell'epoca, basti ricordare che, proprio sulla base di un disegno dell' Angicourt, Napoleone III ordinò la ricostruzione di un grosso mangano. Alle prove pratiche, il congegno si dimostrò capace di scag li are masse di circa 5 q. alla distanza di alcune centinaia di m!
La configurazione cilind1ica delle torri, lo si sapeva s in dai tempi di Vitruvio, reagiva meglio agli urti, comportandosi al riguardo come una sorta di arco, ovvero scaricando la sollecitazione attraverso i singoli conci s ull 'intera struttura, senza originare pericolosi scorrimenti e svellimenti. In oltre la rotondità favoriva la deviazione dei proietti, o la sensibile decurtazione della loro energia cinetica residua, limitandone notevolmente i danni. L'adozione, che pochi decenni dopo si applicherà a tutte le murature d'estradosso, sia di una singola torre che di un poderoso castello, di una scarpatura basamentale, sembra ulteriormente avvalorare l 'ipotesi, essendo ormai notorio l'attenuarsi della violenza degli impatti con l'allontanarsi della traiettoria dei proietti dalla norma le alla superficie battuta, e costi-
tuisce una peculiare caratteristica delle fortificazioni angioine. Ma una connotazione ancora più inconfondibile di tale architettura militare si coglie nel coronamento merlato, rimasto fino ad allora sostanzialmente immutato dall'età classica.
Tanto i Normanni quanto gli Svevi, come del resto anche i Longobardi, infatti, avevano munito le rispettive opere difensive con l'identico, tradizionale dispositivo. In tutte quelle applicazioni il coronamento appare la semplice conclusione delle cortine, proseguendone senza alcuna soluzione di continuità iJ filo. La disposizione già deficitaria, come a suo tempo osservato a proposito dell'architettura sveva, era ulte1iormente peggiorata con l'avvento dei grossi mangani. Infatti, il rozzo rimedio fino ad allora impiegato e consistente: " ... nel sovrappo1Te alla sonunità del muro o della torre una ' incastellarw-a' , cioè una struttura sporgente di legno. posata su mensole infilate in apposite 'buche pontaie' lasciate nella stmttura del muro "06 ', non forniva alcuna protezione contro le loro offese. Facile schiantmne i tavolati, più facile m1cora incendiarli. Forse a seguito del potenziamento delle artiglierie neurobalistiche, forse per l'intensificarsi delle operazioni ossidionali, forse per la diminuita disponibilità di legname a causa della incessante deforestazione, i progettisti trovarono alla fine una valida soluzione al secolare problema.
Nella sezione sonunitale delle mura ammorsarono delle mensole di pietra, a scansione serrata e regolare , dette beccatelli, sull'estremità superiore delle quali impostm-ono un'ininterrotta teoria di archetti sui quali insisteva il pm-apetro merlato. La disposizione consentiva di far sporgere l'intero apparato di circa un metro rispetto al filo delle cortine da cui la definizione di 'apparato a sporgere' 1icavando alle sue s palle, nei vuoti tra una mensola e l'altra, le piombatoie. n coronamento appena descritto, prontamente adottato in tutte le costruzionj milita.Ii angioine, divenne dovunque la nota distintiva per antonomasia dell'architettura castellana, tanto da sopravvivere ben oltre la sua effettiva validità, in funzione meramente decorati va. La razionalizzazione delle piornbatoie determinò , a sua volta, per meglio sfruttarne le potenzialità interdittive, un ulteriore
incremento dell'altezza delle strutture , in perfetta concordanza con i canoni gotici. Ovviamente l 'es ito ottimale del tiro piombante supponeva una verticalità dell e muraglie. connotazione, però, che di lì a breve dovette inevitabilmente abbar1donarsi per l'avvento delle artiglierie. estendendosi l 'adozione della scarpatura a tutte le fo1tificazioni. È pres umibile. tuttavia che in molte di esse, come del resto in quelle che già in qualche modo ne disponevano , non si volle ancora rinunciare all'apporto della dife sa piombante, per cui si stabilì con notevol e precisione l'angolo di abbattimento della scarpa in modo di consentire il rimbalzo dei massi secondo una direttrice pressochè orizzontale, con esiti micidiali per gli attaccanti, persino ad una decina di metJi di distanza da essa.
La definizione territoriale che il regno di Napoli acquisì in epoca angioina, protrattas i nel tempo fino alla s ua scomparsa, fece sì c he le ubicazioni difensive identificate nei primi anni della dinastia conservassero. intatta ed immutabile, la loro preminenza tattico- s trategica per oltre cinque secoli . Ne derivarono , perciò, continui interventi su ogni opera difen siva, indispensabili per adeguarla ai ricorrenti aggiornamenti del settore militare. Si spiega così perchè, ad onta della rilevantissima produ z ione di castelli e fortificazioni in quel cruciale scorcio s torico, quasi nulla ci s ia pervenuto in condizioni di discreta l egg ibilità. Dal mae s to so Cas telnuovo di Napoli, impropriamente ma significativamente detto Maschio Angioino, al modestissimo castello di Castellanrn1are di Stabia, dal torrione di Ve lia a quelJo di Le Castella, press o Capo Ri zzu to, tutti , pur conservando una inequivocabile matrice angioina, testimoniano la s travolgente riqualificazion e successiva, in particolar-e aragonese, imputabile al perfezionamento delle a,tiglierie a polvere.
A completare ulteriormente la falcidia contribuirono vistosamente anche la travagliata decaden za e la violenta dissoluzione della dinastia, caratte1izza te da una sequela di sc iagure naturali e be lliche non di rado concomitanti. In particolare il regno di Giovanna I fu funestato da un ' invasione ungherese e da una conflittualità incessante condotta da spietate compagnie di ventura,

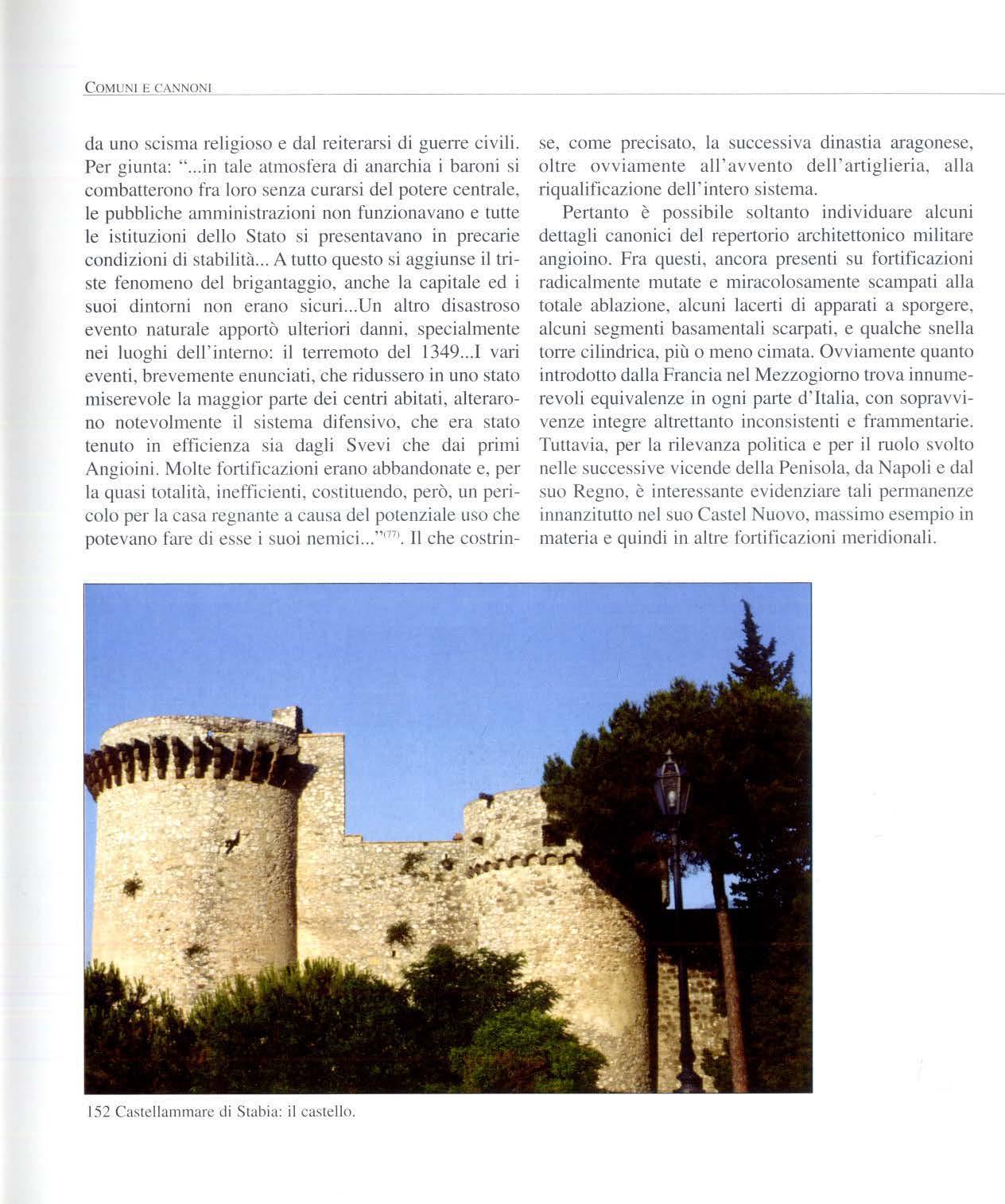
da uno scisma religioso e dal reiterarsi di gue1Te civili. Per giunta: " in tale atmosfera di anarchia i baroni si combatterono fra loro senza curarsi del potere centrale, le pubbliche amministrazioni non funzionavano e tutte le istituzioni dello Stato sj presentavano in precarie condizioni di stabilità ... A tutto questo si aggiunse il triste fenomeno del brigantaggio, anche la capitale ed i suoi dintorni non erano sicuri ... Un altro disastroso evento naturale apportò ulteriori danni, specialmente nei luoghi dell'imemo: il teJTemoto del 1349 .. .l vari eventi, brevemente enunciati, che ridussero in uno stato miserevole la maggior parte dei centJ.-i abitati, alterarono notevolmente il sistema difensivo, che era stato tenuto in efficienza sia dagli Svevi che dai primi Angioini. Molte fortificazioni erano abbandonate e, per la quasi totalità, inefficienti, costiluendo, però, un pericolo per la casa regnante a causa del potenziale uso che potevano fare di esse i suoi nemici " 177 '. Il che costrin-
se, come precisato, la successiva dinastia aragonese, oltre ovviamente all'avvenlo dell'artiglieria, alla riqualificazione dcli' intero sistema.
Pertanto è possibile soltanto individuare alcuni dettagli canonici del repertorio architettonico militare angioino. Fra questi, ancora presenti su fortificazioni radicalmente mutate e miracolosamente scampati alla totale ablazione, alcuni lacerti di apparati a sporgere, alcuni segmenti basamentali scarpati, e qualche snella torre cilindrica, più o meno cimata. Ovviamente quanto introdotto dalla Francia nel Mezzogiorno trova innumerevoli equivalenze in ogni parte d'Italia, con sopravvivenze integre altrettanto inconsistenti e frammentarie. Tuttavia. per la rilevanza politica e per il ruolo svolto nelle successive vicende della Penisola, da Napoli e dal suo Regno, è interessante evidenziare tali permanenze innanzitutto nel suo Castel Nuovo, massimo esempio in materia e quindi in altre fortificazioni meridionali.
152 Castellammare di Stabia: i I castello.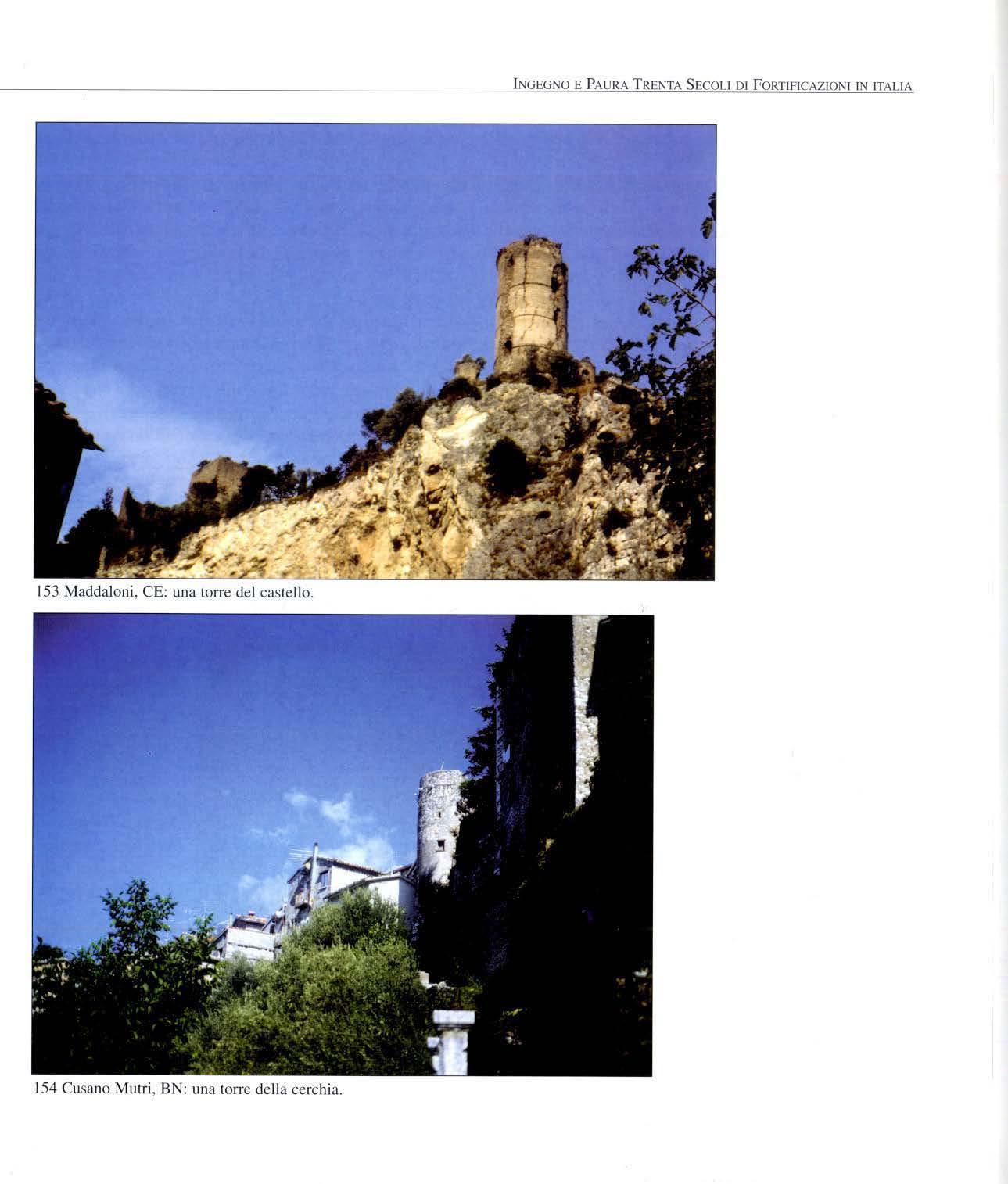
A distanza di tredici anni dalla conquista del regno , agli inizi del1a primavera del 1279, Carlo d'Angiò stabilì di edificare, poco discosto dal1e mura di Napoli, un grandioso castello, del tipo di quelli già numero sissimi Oltralpe. La decisione fu prontamente tradotta in pratica, complice l'inasprirsi dell'intolleranza dei s udditi e la constatazione dell'eccessiva vulnerabilità da mare della città. La sua ubicazione , praticamente sulla spiaggia, ne rappresenta, infatti , la più eloquente testimonianza.

In dettaglio , il: " ... luogo prescelto fu nel bel mezzo del campus oppidi, quell'ampio pianoro che si stendeva tra le mura occidentali della città e le rovine de]]' antico castrum o oppidum Lucullanum tra le pendici del colle Paturcium detto poi di Sant'Elmo, ed il
mare. Su quel punto della costa, che sovrastava Porto Pi sano, sorgeva una piccola altura, che scendeva ripida al mare , declinava con dolce pendio verso la città e si allargava pianeggiando verso il Lucullano Dal 16 maggio cominciarono a partire gli ordini per apprestare il materiale: il giustiziero di Terra di Lavoro (Gentile) inviava gli operai, quello di Principato la calce, quello di Calabria il legname dei bo schi silani .... " <18> Per l'accennata rilevanza guadagnata dagl' ingegneri, del castello sapp iamo che Ja direzione dei lavori: " ...fu assunta da Pierre de Chaule, che terminò l'opera nel 1284; primo castellano fu Philippe de Vi11ecublayn ... " 09 i _
Il brevissimo intervallo tra l 'avvio della costruzi on e e la pre s unta ultimazion e ci conferma, oltre al carattere volitivo del sovrano, il precipitare degli eventi, culminato nella guerra dei Vespri, che finiro-
155 Napoli: Caste l Nuovo.no col rendere il castello indispensabile. È probabile però che la sua configurazione, tanto frettolosamente conseguita non fosse pienamente soddisfacente, forse perchè troppo modesta, forse perchè non realmente ultimata: di certo l'effettiva conclusione dei lavori avvenne sotto Carlo II (1285-1309) e Roberto d'Angiò ( 1309-1343), in epoca cioè sensibilmente posteriore. Della originaria impostazione quasi nulla rimane attualmente: " la più cospicua testimonianza ... è la cappella Palatina ... unico elemento superstite della reggia angioina. La prima notizia della sua costruzione risale al tempo di Carlo II (I 307) ... Non abbiamo alcuna fonte figurativa della primitiva costruzione ... e non siamo in grado di formulare una qualsiasi ipotesi sul suo aspetto, possiamo solo supporre in base ai confronti con analoghe costruzioni della Provenza, che si trattasse di un castello-palazzo avente la duplice caratteristica di difesa e di magnifica dimora del signore. I documenti ci informano
soltanto che vi erano utilizzati tutti gli accorgimenti difensivi adottati in quell'epoca: alte torri e cortine, coronamento con merli e caditoie, base scarpata delle murature, fossato. Secondo il Finò i costruttori si ispirarono al castello di Angers, ascrivibile ai primi decenni del XIII secolo; è certo, comunque, che esisteva un'analogia planimetrica tra l'episodio napoletano ed i coevi castelli di Anjony e di Villandraut. Quest'ultimo castello di pianura, costituito da una cinta su impianto rettangolare rinforzata da torri cilindriche angolari ed il mastio sostituito dalla coppia di torri fiancheggianti la porta, con l'intero organismo costruttivo gravante sul cortile centrale costituisce !"anello di congiunzione tra il modello delle costruzioni difensive islamiche e le numerose costruzioni che sorsero in Provenza e in tutta 1'Europa ... " <~0'
Nonostante le successive profonde trasformazioni, però, con sufficiente probabilità è lecito presumere che l'impianto planimetrico del Castel Nuovo sia sostanzialmente rimasto inalterato, riducendosi, in estrema sintesi, ad un trapezio irregolare con quattro torri cilindriche ai vertici, ed alcune intermedie. Altrettanto probabile è che le stesse, originariamente altissime, abbiano subito soltanto una insignificante cimazione, provvedendo la rilevante spessorazione del loro corpo, e soprattutto le immense falsebrache apposte alle basi, a renderle a lungo invulnerabili alle offese balistiche. Di certo le suddette torri, come del resto l'intero circuito delle cortine, terminavano con un apparato a sporgere in muratura, su archetti e beccate] I i.
Più complesso, invece, stabilire, oltre alle quattro torri d'angolo d'impianto canonico, il numero e la posizionatura delle altre che sicuramente vennero costruite. Infatti è: " ... fuor di dubbio che quattro torri fossero negli angoli, ma non erano queste le sole. Almeno tre stavano dalla parte del mare. Una era la torre del Beverello, che stava press'a poco dove sta la omonima torre aragonese, nell'angolo nord-est del castello, ed era parimenti la torre maestra. Con questa s'identifica quella torre che stava sul

Porto Pisano, di cui sappiamo che re Carlo sospese la fabbrica il 14 settembre 1279 ... Anche sul mare stava un'altra tone situata presso la cappella palatina, dal lato meridionale, sulla quale Roberto fece sopraelevare una camera nel 1317. Ed è questa con quasi certezza quella famosa Torre Bruna, nella quale il re conservava il suo tesoro Ugualmente sul mare, presso la Bruna, era una Turris inferior, ove era una camera della Grotta marina, che conteneva un'altra parte del tesoro regio. Essa però poteva essere anche la parte inferiore della torre Bruna. Un'altra torre anche sul mare, doveva occupare l'angolo sud-est: ma di essa non è notizia nelle fontj. Doveva sorgere dove ora è la Torre dell ' Oro o in quei pressi. Sul lato settentrionale del castello, quello che guardava la città, stava la porta , ed era, secondo lo
schema tradizionale, affiancata da due torri , di cui è esplicita notizia nelle fonti. Un'altra torre doveva infine occupare l'angolo nord-ovest, presso il luogo dove oggi sta la Torre dì San Giorgio ... Le cortine, che racchiudevano gli appartamenti della real famiglia e dei cortigiani, dovevano essere abbastanza ricche di vani di luce con finestre ogivali, talora bifore , riccamente adorne, come attestano i numerosi frammenti ... Queste cortine erano ricoperte da terrazze, ed a volte anche da tetti. Sul loro margine esterno, come in cima alle torri , erano i tradizionali coronamenti merlati in aggetto sul muro esterno, con sottostanti caditoie.
Il fossato , che cingeva il castello dai tre lati di terra, è spesso nominato nelle fonti [che] ci assicurano che non vi fu mai portata l'acqua del mare. La sua
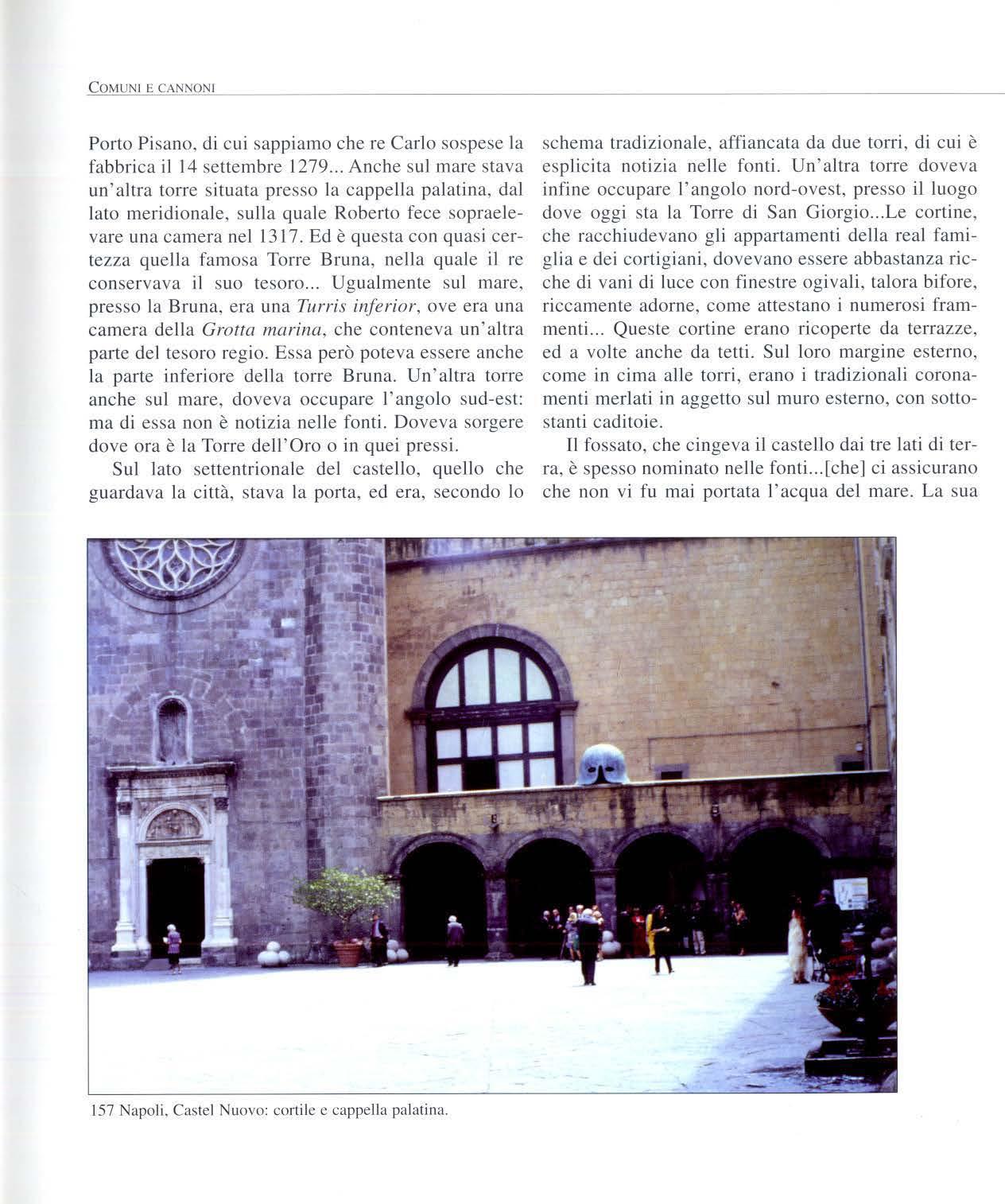
larghezza doveva essere cli circa sette canne [ 14 m circaJ, perchè tale era la lunghezza delle travi adoperate nel 1281 per la costruzione del ponte levatoio.
La porta del castello ... era chiusa da un cancello ricoperto di lamine dì ferro.
Davanti le stava il gran ponte levatoìo ... [che] si abbassava mediante un congegno di ruote e di catene sul ciglio esterno, dove era un'altra porta. Questa era aperta in un recinto murato e merlato, detto balium, il quale , mediante due muri s barranti il fossato, e paralleli all'interposto ponte, si congiungeva d'ambo i lati con le due torri fiancheggianti la porta del castello. Di questo piccolo antemuraJe è dettagliata notizia in un documento del 1283 ... " <~11 •
A partire dal 1443 il castello , appena descritto , subì radicali riqualificazioni ad opera di Alfonso d'Aragona, nuovo s ovrano di Napoli, con interventi tanto estesi e complessi da protrarsi per ben 15 anni. Attinse così la connotazione architettonica difensiva più avanzata del momento , s ostanzialmente quella che ancora oggi conserva.
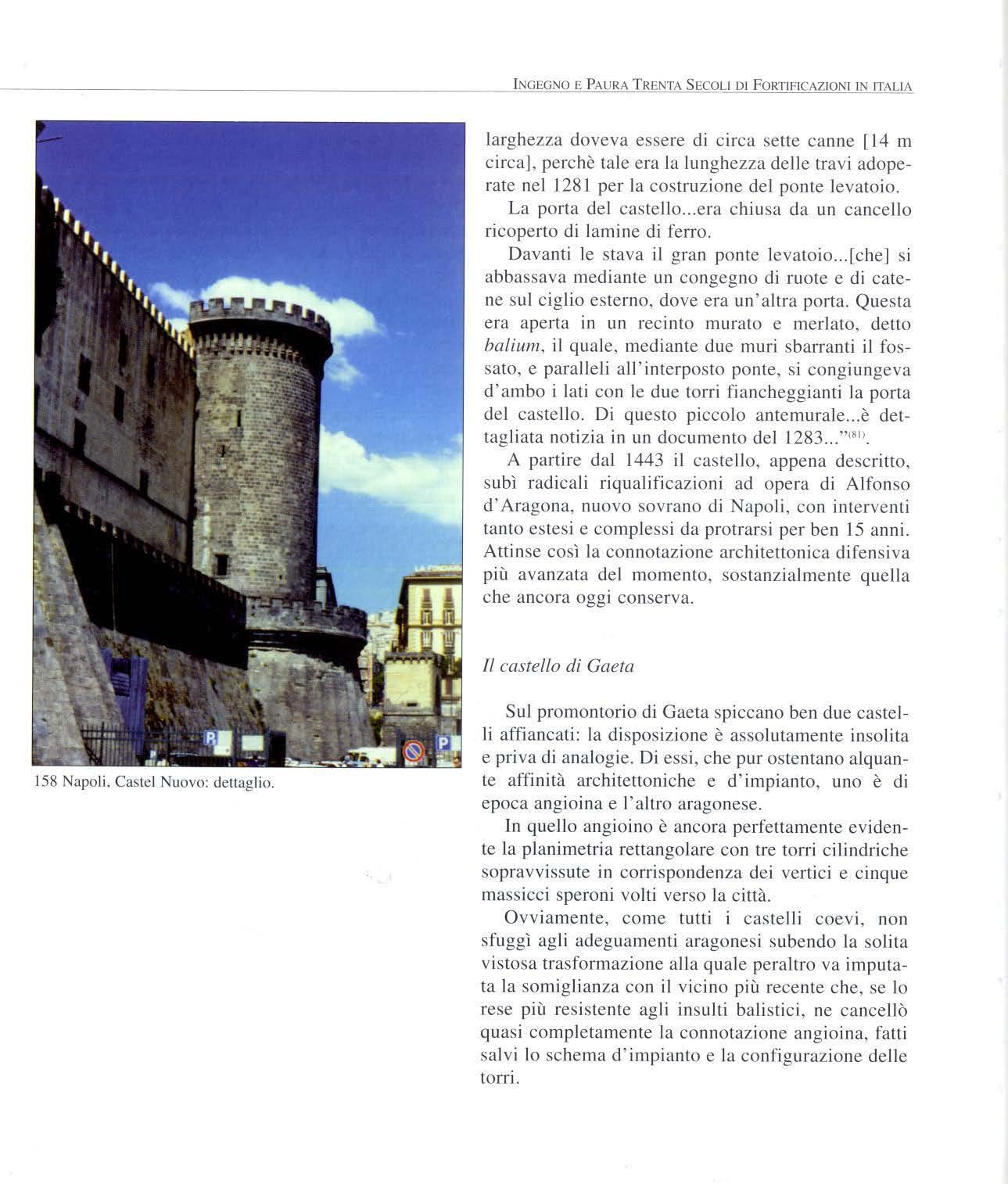
Sul promontorio di Gaeta spiccano ben due castelli affiancati: la disposizione è assolutamente insolita e priva di ana logie. Di essi, che pur ostentano alquante affinità architettoniche e d ' impianto , uno è di epoca angioina e 1' altro aragonese.
I n quello angio i no è ancora perfettamente evidente la planimetria rettangolare con tre torri cilindriche sopravvissute in corrispondenza dei vertici e cinque massicci speroni volti verso la città.
Ovviamente, come tutti i castelli coevi , non sfuggì ag l i adeguamenti aragonesi subendo 1a solita vistosa trasformazione alla quale peraltro va imputata la somiglianza con il vicino più recente che, se lo rese più resistente agli insult i balistici, ne cancellò quasi completamente la connotazione angioina, fatti salvi lo schema d ' imp ianto e la configurazione delle toni.
158 Napoli, Castel Nuovo: dellaglio. INGEGNO E PAURA TRE NTA SECOLI DJ FORTIFl CA Z JONI IN ITA LIA

Poco discosto da Gaeta , per l'esattezza sul porticciolo di Mola, nell'ambito del ricordato programma di difesa costiera, gli Angioini eressero uno dei loro più robusti caposaldi, costituito da un alto ton-ione cilindrico circondato da un recinto. 11 toponimo tramanda l'esistenza di un grande stabilimento molitorio, che già intorno al X-Xl secolo, per la sua rilevanza economica venne debitamente fortificato, assumendo l'aspetto di un piccolo castello. Agli inizi del '200 lo si potenziò ulteriormente, e verso la fine dello stesso secolo: " ... Carlo II cl' Angiò fece erigere al centro .... [del] recinto fortificato, un 'alta e possente torre circolare: in tal modo si venne a creare un vero e proprio fortilizio che per la sua posizione a rido sso del mare ed accanto alla via Appia, poteva assolvere alla funzione di vigilanza e, in caso di necessità, di difesa attiva del territorio " <82 '

Nel corso dei seco li il complesso difensivo sub ì numerosi attacchi e ripetute riqualificazioni, conservando dell'originaria impostazione so ltanto il vetusto torrione.
Que sto, infatti: " unica parte superstite dell'antica fortificazione, appare in numerose stampe ancora con le sue opere esterne. Il corpo cilindrico , coronato dal solito motivo archeggiato su mensole, è chiaramente un'opera angioina, voluta da Carlo II d'Angiò (1289) per la difesa del litorale; qui però il coronamento presenta gli archetb ogivali invece che a tutto sesto ... " <83 > . La modestissima singolarità costituisce forse l'estremo retaggio architettonico dell ' epoca di costruzione, dominata ancora dai canoni gotici.
Siffatti torrioni, intorno alla fine del XIII secolo, vennero edificat i in discreto numero e molti di essi ancora sopravv ivono , se bben e inglobati in fortificazioni più recenti, per lo più aragonesi. È questo il caso di quello di Fondi, a poca distanza dal precedente , fuoriuscente dalla massiccia mole quadrata del mastio del castello.
Similmente fagocitato da una fortificazione posteriore, in questo caso una torre costiera vicereale napoletana del 1563, è quello di Cas tallabate , nei pressi di Salerno. Fu de1 re sto proprio in quel drammatico scorcio storico che la maggior parte delle torri costiere angioine , grandi e piccole , vennero trasfo rmate in caposaldi per la difesa della frontiera marittima dagli attacchi corsari turco-barbareschi.
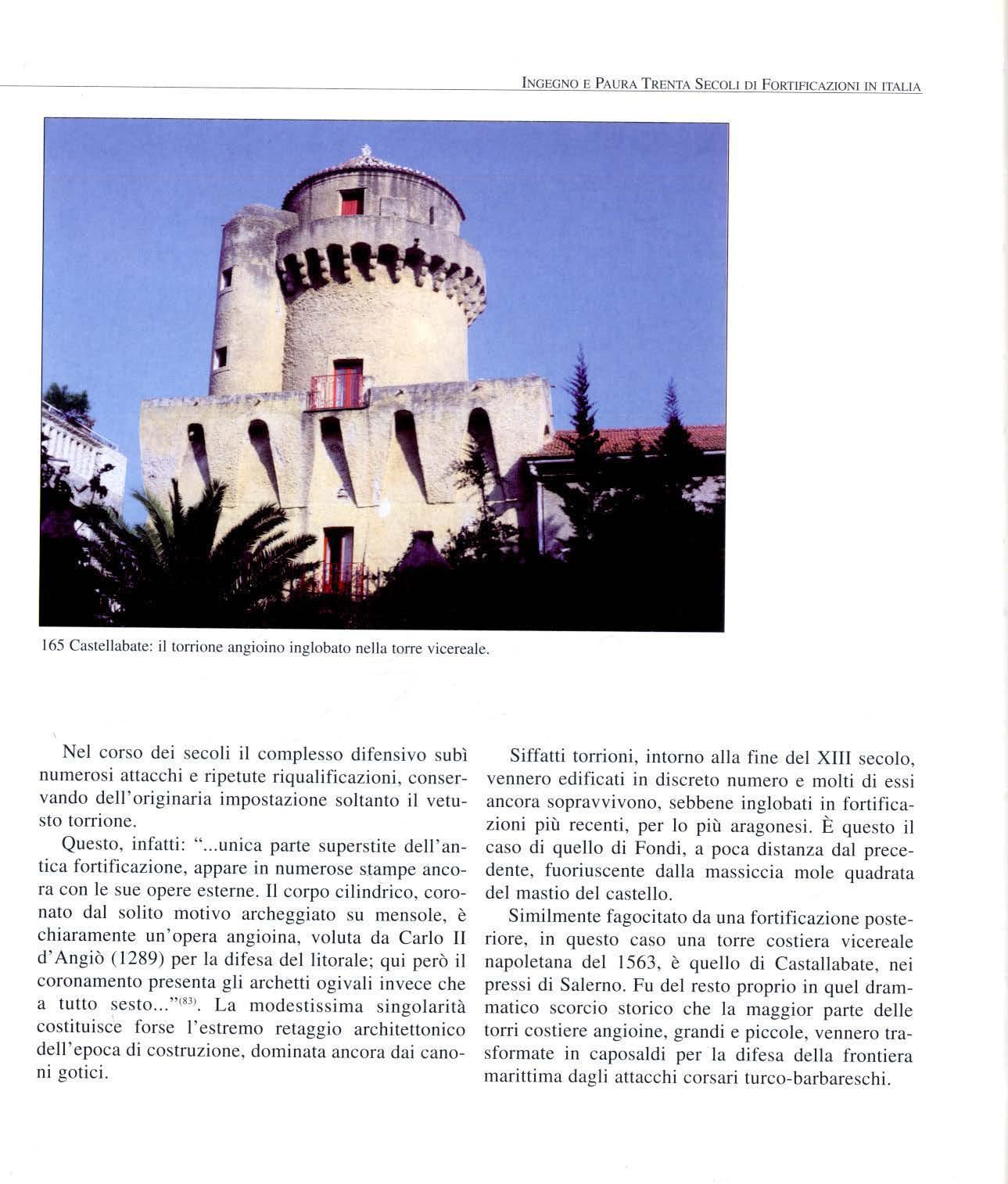
Le Caste/la di Capo Rizz uto
Un notevole esempio del genere è rintracciabile presso Iso la di Capo Rizzuto , do ve tra i rud e ri d e lla fortifica z ione aragonese-vicereale di Le Cas te lla s i erge, in tutta la s ua impon e nza , ed in di sc re te condizioni di conservazione, un altro torrione cilindrico di matrice angioina<s4 >
Trascurando la s toria antica che ricorda il toponimo di Caste l/a s in dal 304 a.C , in occasione della s tipula del trattato tra Roma e Taranto re sos i nece ssa rio per definire i limiti di na v iga z ion e delle ri s petti ve flotte <85 \ le fonti iniziano a menzionarlo a p a rti re dal 1290 , ne l cont es to della guerra dei Vespri. In quell'anno, infatti, ai primi di luglio, l 'a mmiraglio
Ru ggie ro di L a uria v i s barcò , in nome e per conto del re di Sicilia , Giacomo d ' Ara go n a , figlio dì Pietro. J1 piccolo ce ntro fu investito violentemente, e: " non se n za st ra ge de gl i abitanti e iattura di cose, dopo un ' oppugnazione continua dì quasi otto gio rni ... " <86!, costretto a capitolare.

Le cro nache tramandano che nella circos t a nz a l ' ammiraglio ebbe ra g ione di un'i soletta: " ... se u locus qui dicitur Li Caste lli ... " <81 > . Lo g ico , pe rta nto , credere che una t a nto prolun gata re siste nza potesse dipendere so lo da una robusta fortificazione, tale comunque da giustificare il toponimo.
E che il sito venisse ritenuto di rilevanza strategica lo conferma il verificarsi, appena due a nni più tardi , di un altro attacco , co ndotto dallo stesso ammi-
raglio nei suoi immediati paraggi e risolto s i ancora una volta in un disastro per gli Angioinic ~g>.
Dopo quest'ultimo episodio le notizie sulla fortificazione cessano completamente, per riprendere nel 1380 , allorquando Alessandro Malena acquista: " il Castello della Torre, e l'isola nelle pertinen ze di Cotrone ... ' ' 189 > .
Il nome del castello ribadisce, se nza alcuna ambiguità, il ruolo in esso preminente di una toITe. Logico, quindi , presumere che il complesso avesse nel frattempo assunto le caratteristiche di un recinto. serrante al s uo interno una torre di notevoli dimensio ni , di tipica fattura angioina, esattamente come verificatosi a Gaeta.
In epoca aragonese prima e vicereale poi, il caposaldo si poten ziò ed articolò, acquisendo le connotazioni di una fortezza bastionata, il cui perimetro coincideva con quello dell'i so lotto d'impianto.
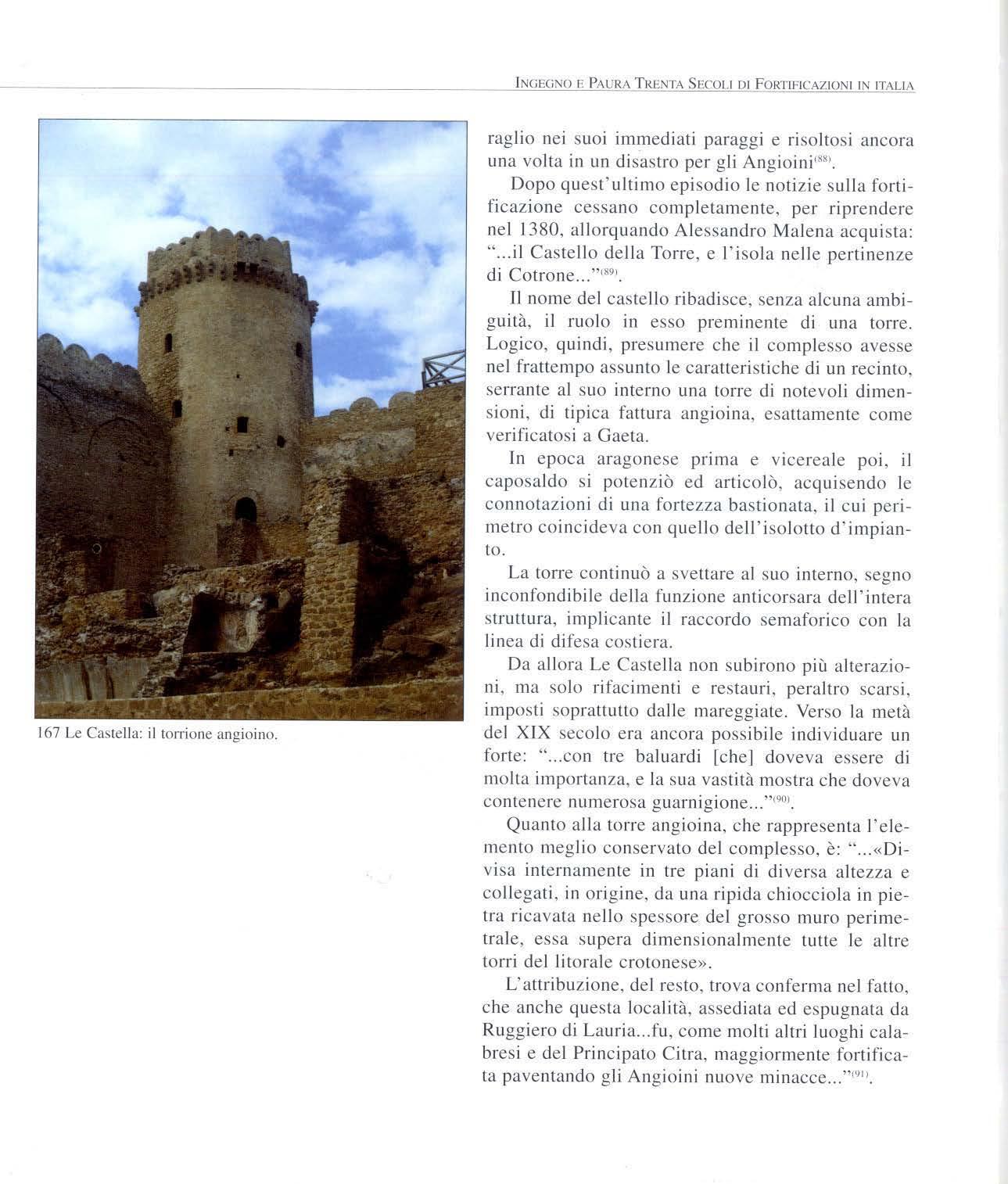
La torre continuò a sve ttare al suo interno, segno inconfondibile della funzione anticorsara dell'intera st ruttura, implicante il raccordo se maforico con la linea di dife sa costiera.
Da allora Le Castella non subirono più alterazioni, ma solo rifacimenti e re s tauri , peraltro scarsi, imposti soprattutto dalle mareggiate. Verso la metà del XIX seco lo era ancora possibile individuare un forte: " ... con tre baluardi [chel doveva essere di molta importan za, e la sua vastità mostra che doveva co nten ere numerosa guarnigione .''1<>01 •
Quanto alla torre angioina, che rappresenta l'elem ento meglio conservato del complesso, è: " ... «Divisa internamente in tre piani di diversa altezza e collegati, in origine, da una ripida chiocciola in pietra ricavata nello spessore del grosso muro perimetrale , essa supera dimensionalmente tutte le altre torri del litorale crotonese».
L'attribuzione, del resto , trova conferma nel fatto, che anche questa località , assediata ed espugnata da Ruggiero di Lauria... fu, come molti altri luoghi calabresi e del Principato Citra, maggiormente fortificata paventando gli Angioini nuove minacce ... "'9 1>
Il crescente flagello delle incursioni da mare, perpetrate dai Pisani, dai Genovesi, dagli Aragonesi, ed ovviamente dai Saraceni, come più volte accennato, costiinse la dinastia angioina a varare un programma di difesa costiera impostato su torri da erigersi sulle propaggini più sporgenti della costa. Loro tramite si sarebbero potute continuamente sorvegliare sia le retrostanti insenature sia le potenziali spiagge di atterraggio. In caso di avvistamento di imbarcazioni sospette, le vedette, con concordati segnali acustici avrebbero perciò immediatamente fatto evacuare le popolazioni limitrofe, per l'epoca unico rimedio praticabile contro le incursion1.
Tanto la torre di Mola di Gaeta quanto quella di Le Castella. appartennero a quella particolare tipologia di fortificazioni, formanti nel loro insieme estese catene difensive. Dal punto di vista strutturale possono rite-

nersi, come molte altre analoghe, i caposaldi principali, insistendo l'intera teoria su torri notevolmente più piccole, sebbene di gran lunga più numerose, tutte, comunque, otticamente collegate fra loro. Pur non avendosi alcuna documentazione certa circa la continuità per l'intero perimetro del Regno di tale sistema di vigilanza costiera - ed è estremamente probabile che in realtà si sia trattato piuttosto cli diversi segmenti autonomi limitali ai soli settori critici - è indubbio che torri del genere venissero erette lungo ogni marina meridionale, con minore o maggiore frequenza in rapporto alla vulnerabililà Jocale.
Il servizio di guardia, e forse la costruzione stessa delle torri, ebbe una vistosa intensificazione a partire dal 1282, in concomitanza con la guerra dei Vespri, quando anche i castelli litorali della Puglia e della Calabria furono posti in stato di allerta. Infatti: " ... è in tal senso l'ordine di Carlo, principe di Salerno, inviato (1284) ai 'Giustizieri' del regno di far custodire con
somma diligenza le torri del litorale «e che gli uomini di guardia siano attenti a so llecitamente avvertire l' avvicinarsi al lido delle navi nemiche e dei ribelli, con il segno di fumo di giorno e col fuoco nella notte, e nel modo consueto per indicare il numero delle navi» ... Ma già all'inizio del regno di Carlo J era stata data particolare attenzione alle difese costiere. Da Napoli, infatti, il sovrano, sin dal 1269 ordinava (18 novembre) <<di munire con sentinelle, riparare e fortificare le torri di tutto il Regno per difesa contro i pirati e contro i nemici» e, a distanza di dieci anni, venivano impartiti analoghi ordini; un documento del 19 aprile del 1279, indirizzato al 'Giustiziere' del Principato , per la custodia del suo territorio, cita le torri di Caricla (Roccacilento), Licosa (Castellabate), Tresino (Agropoli), lssica (Castellammare della Bruca) , Conca (al Capo di Conca sulla stessa costiera), Palus Nudus (torri di San Severino di Camerota), An~forisca (San Giovanni a Piro) , Capo d'Orso (costiera amalfitana), Montes Plagij e Torricella di Sopramonte (Vico) , Corvo e Montemaggiore (Son-ento ). Di queste la torre dell 'Assi ola esiste ancora, utilizzata nel programma vicereale, ridotta in altezza, secondo una tipologia riportata in disegni del secolo scorso "(92>
Considerando che proprio l'attivazione di un dispositivo continuo di difesa costiera fu tra le più interessa nti ed innovative realizzazioni fortificatorie angioine, ci è parso coerente riproporre qualche significativo
esempio di opere del genere ancora presenti sulla costa 169
dibile e congrua quindi, alla men peggio, a] programma anticorsaro vicereale del 1563. È a base circolare Torre Assiola con alzato tronco-conico: originariamente si deve presumere che su questi si innestasse un corpo cilindrico Si erge nei pressi di Praiano, e la s ua esistenza è di notevole altezza. Due ambienti sovras tanti , dei storicamente certificata sin dal 1269-70. La località in quali l'inferiore accessibile da un ingresso rialzato, cui fu innalzata viene ricordata, già in un documento coperti con volte a calotta eseguite a getto, la s uddividei J202 , come Scio/a, toponimo , peraltro, tuttora dono internamente , probabili permanenze della primivigente. La torre presenta a carico della s ua sezione tiva impo stazio ne. Lo s pessore murario alla base rags ommitale una evidentissima alterazione imposta dal- giunge quasi i 3 m , rastremandosi progressivamente l'esigenza di renderla meno vulnerabile e più difen- fino ai 2 della cima. Il materiale impiegato è la pietra

calcarea locale in piccoli conci irregolar i. All'interno del muro a monte si ricavò la scala c he co ll egava i diversi pian i fino alla copertura c'1 11 •
Domina dall'alto l'abitato di Amalfi: è raggiungibil e da Ra ve11o e di lì per Pontone, attraverso un percorso di avvicinamento percorribile esclusivamente a piedi. Faceva parte delle fortifica7ioni del fronte a terra di Amalfi, per l'esattezza della Ro cca di San Felice, di cu i restano all' intorno testimonianze di mura merlate. Circa la sua vice nd a s tori ca sembra accertato che possa attribuirsi al 1278, ovvero al contesto dell'Assiola e della cerchia di Positano.
Subì restauri ad opera della c it tà nel 1292 ed ancora nel 1305, nel 1355, nel 1440 , conservando tuttavia fino ad oggi la sua configurazione originaria, almeno per grandi linee. Analogamente alle coeve torri costiere non presenta vano di accesso a ll a quota di campagna l asciando supporre l'impiego di una scala volante. Id entica la scansione con basamento scarpate ed alzato cilindrico'9 4 '.
Le torri appena delineate, giova rip ete rlo , grandi o piccole che fossero, non era no finalizzate a difendere. in se nso lettera le, gli abitati limitrofi e, del resto, non lo avrebbero potuto fare con l e armi a di s po s izion e in alcun modo ma so lo a favorirne l 'evac uazione al profilarsi di un avvistamento sospe tto. Poich è una siffatta evenienza non riusciva sem pre attuabile, nè peraltro era compatibile co n un minimo di sic urezz a, la sopravv iven za dei paesi rivieraschi, dal XIII seco lo , dipese, più che mai, dalla presenza di fort ificazioni perimetrali di maggior respiro. Tuttavia, per l ' abnorme protrarsi della minaccia corsara, cessata definilivamente soltanto nel 18 30, quelle strutture ri cevettero, nelle epoche successive, reiterate riqualificazioni e potenziamenti
170 Positano: dettaglio di un a torre.

perdendo ogni connotazione ongrnaria. Pertanto , anche nel contesto della pur abbondante produzione angioina è possibile so ltant o individuare dei frammenti e dei brandelli: e, fra i tanti, il caso della cerchia di Pos itano.
L'antico borgo abbarbicalo aJ1a costa rocciosa di fronte alle isolette d e i Galli, costitu iva l'ultimo nucleo residenziale stab il e ad ovest del ducato amalfitano. La sua oiigine viene attribuita ad alcuni cittadini di Paestum miracolosamente scampati a ll e incursioni saracene dell'Vlll-IX secolo . Grazie a ll ' in accessibilità dei luoghi è probabile c he il piccolo v illaggio non avesse avuto immediatamente bisogno di massicce fortificazioni, tanto più che la crescente potenza navale di Amalfi costi-
tuiva già di per sé un discreto deten-ente. Con il trascorrere del tempo , ed il declinare della Repubblica, la costruzione di una solida cerchia divenne inevitabile, essendosi moltiplicato il numero dei potenziali aggressori e la violenza degli assalti. Stando ai rarissimi documenti pervenutici al riguardo sappiamo che intorno al 1268:
"Universitati Po sitani asserenti faci sse muros et fortilitios iuxta mare propriis s umptibus ut tuerentur ad insultibus hostium ... "'95
Logico supporre che si trattasse di un circuito murario turrito eretto intorno ali' abitato. Di tale fortificazione sopravvivono appena due snelle torri cilindriche. Ed anche queste sono alquanto alterate rispetto alla p1imiti va configurazione, condizione indispensabile, del resto, per la loro conservazione. In ogni caso: " ... presen tano ancora l'aspetto tipico delle torri de] XIII secolo e caratterizzano le spo rgenze rocciose sulle quali s'innestano: l'una (della trasita) che si sprofonda nel mare tra le spiagge della Marina e di Fomillo, e l'altra (de lla sponda) oltre la marina, verso Praiano " (96>
Nelle fortificazioni angioine abbiamo ri scontrato, da un certo momento in poi, l'adozione sis tematica della scarpatura alla base delle torri e dell e cortine. In quanto tale non costituiva una eclatante novità, rintracciando sene analogie strutturali, a partire dal II millennio a.C, in conseguenza della comparsa del!' ariete. Anche trascurando quelle premesse, e le più recenti romane , la scarpatura si ritrova ancora ai piedi dei dongioni normanni. ln questi però è insensato presumere che servisse a scongiurare gli impatti di improbabili macchine ossidionali, laddove è più plausibile, invece, imputarla all'esigenza di ridurre la rilevante pressione esercitata sul terreno da siffatte costruzioni alte e massicce. Essendo, però, muniti di scarpa pure i toITioni impiantati sulla roccia occorre ricercarne altre finalità, quali, ad esempio, impedire
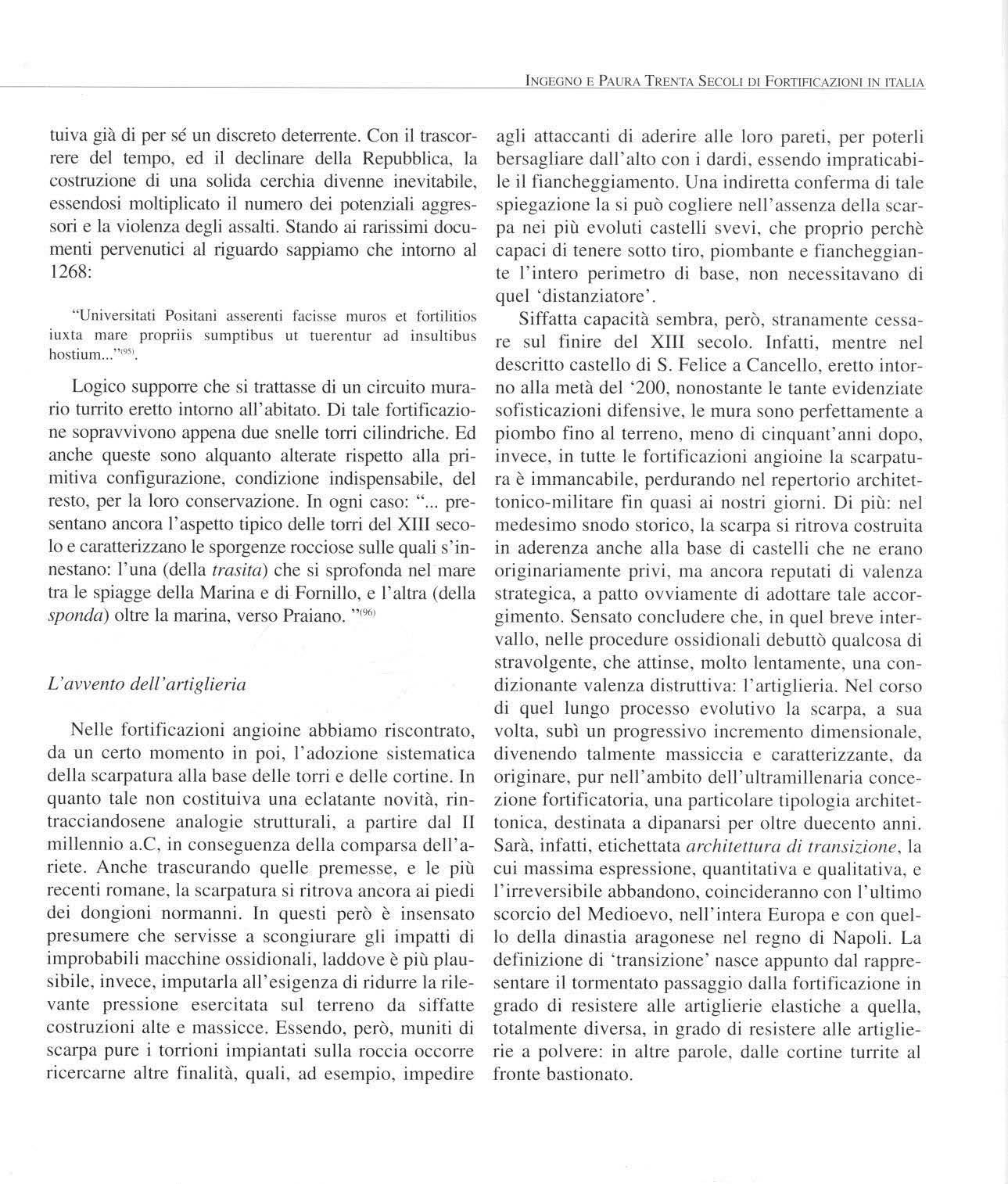
agli attaccanti di aderire alle Ioro pareti, per poterli bersagliare dall'alto con i dardi , essendo impraticabile il fiancheggiamento. Una indiretta conferma di tale s piegazione la s i può cogliere nell'assenza della scarpa nei più evoluti castelli svev i, che proprio perchè capaci di tenere sotto tiro, piombante e fiancheggiante l ' intero perimetro di base, non necessitavano di quel 'distanziatore ' .
Siffatta capacità sembra, però, stra namente cessare sul finire del XIII seco lo. Infatti , mentre nel descritto castello di S. Felice a Cancello, eretto intorno alla metà del '200, nonostante le tante evidenziate sofist icazioni difensive, le mura sono perfettamente a piombo fino al terreno, meno di cinquant'anni dopo, invece, in tutte le fortificazioni angioine la scarpatura è immancabile, perdurando nel repertorio architettonico-militare fin quasi ai no stri giorni. Di più: nel medesimo snodo sto rico , la scarpa s i ritrova costruita in aderenza anche alla base di castelli c he ne erano originariamente privi , ma ancora reputati di valenza s trategica , a patto ovviamente di adottare tale accorgimento. Sensato concludere che, in quel breve intervallo, nelle procedure ossidionali debuttò qualcosa di stravolgente, che attinse, molto lentamente , una condizionante valenza distruttiva: l ' artiglieria. Nel corso di quel lungo processo evolutivo la sca rpa , a sua volta , s ubì un progressivo incremento dimensionale , divenendo talmente massiccia e caratterizzante, da originare, pur nell 'a mbito d e ll'ultramillenari a concez ione fortificatoria, una particolare tipologia architettonica , destinata a dipanars i per oltre duecento anni. Sarà, infatti, etichettata architettura di transi z ione , la cui massima espressione, quantitativa e qualitativa , e l'irreversibile abbandono, coincideranno con l'ultimo scorcio del Medioevo, nell'intera Europa e con quello della dinastia aragonese ne l regno di Napoli. La definizione di ' transizion e' nasce appunto dal rappresentare il tormentato passaggio dalla fortificazione in grado di resistere alle artiglierie elastiche a quella, totalmente diversa, in grado di re sistere alle artiglierie a polvere: in altre parole, dalle cortine turrite al fronte bastionato.
ING EGNO E PA URA TRENTA SECO LI DI FORTIFICAZIONI IN ITAL!APer la Storia della Poliorcetica, come più in generale della tecnologia e della civiltà, l 'invenzione e, soprattutto, l'impiego propulsivo della polvere pirica rappresenta un pun to nodale, equiparabile forse alla scoperta del fuoco. Di certo per la prima volta l'uomo potè padroneggiare energie notevolmente superiori a quelle fino ad allora disponibili che, per un verso o per l 'altro , erano riconducibili alla forza muscolare più o meno ingegnosamente accumulata, più o meno rapidamente liberata, ma mai eccedente la somma delle potenzialità di pochi individui. Da quel momento, invece, le energie impiegate in ambito militare, ed ossidionale in particolare, non avranno alcun limite insormontabile e tenderanno continuamente a crescere, rendendo necessari a un' altrettanto si m metrica c r escita delle strutture passive delle fortificazioni, nel disperato tentativo di neutralizzarne gli effetti. Quando , però, s iffatta ingenua contromisura si confermerà insuffi ciente, costringendo al l 'adozio ne di una concezione architettonica radicalmente diversa, la transizione finirà e con essa il Medioevo. In pochi decenni i castelli e le cerchie turrite di verranno le s uggestive reminiscenze di un mondo e di una soc ietà definitivam e nte tramontati.
Come accennato, i prodromi della vicenda, per quanto è possibile arguire dalle incerte fonti, sembrano rimontare agli inizi del XIII seco lo. In un manoscritto arabo dell'epoca si rintraccia una dettagliata relazione circa un miscuglio composto di dieci parti di salnitro, due di carbone ed una e mezzo di zo lfo. L 'a utore precisa che, per ricavarne un impiego propulsivo , una volta messe insieme, le tre sostanze andavano pestate e triturate , in granuli sottilissimi, e quindi costipate all'interno di un tubo , per un terzo della sua lun ghezza. Riusciva possibile, a quel punto, provocandone la deflagrazione per mezzo di una fiammella, far espellere violentemente dal tubo stesso una pall a, o una freccia, in precedenza inseritavi. È innegabile che l'ignoto trattatista abbia così fornito la de scrizione di una rudimentale bocca da fuoco: disgraziatamente però è improbo appurare con assoluta certezza la data del documento e la sua effettiva originalità. Una indiretta
conferma cronologica, tuttavia, si coglie propno nell'approssimazione del congegno, simile ad altri coevi, che per la scriteriata composizione della polvere, per la discrezionalità della quantità impiegata e per l'imponderabile resistenza del metallo sarebbe risultato estremamente pericoloso per chi avesse osato anche soltanto maneggiarlo. Nessuna meraviglia, quindi, che per un lungo periodo, pur risapendosi perfettamente dell'effetto pirotecnico, lo si relegas se al ruolo di strana curiosità, evitandone qualsiasi utilizzazione pratica come arma.
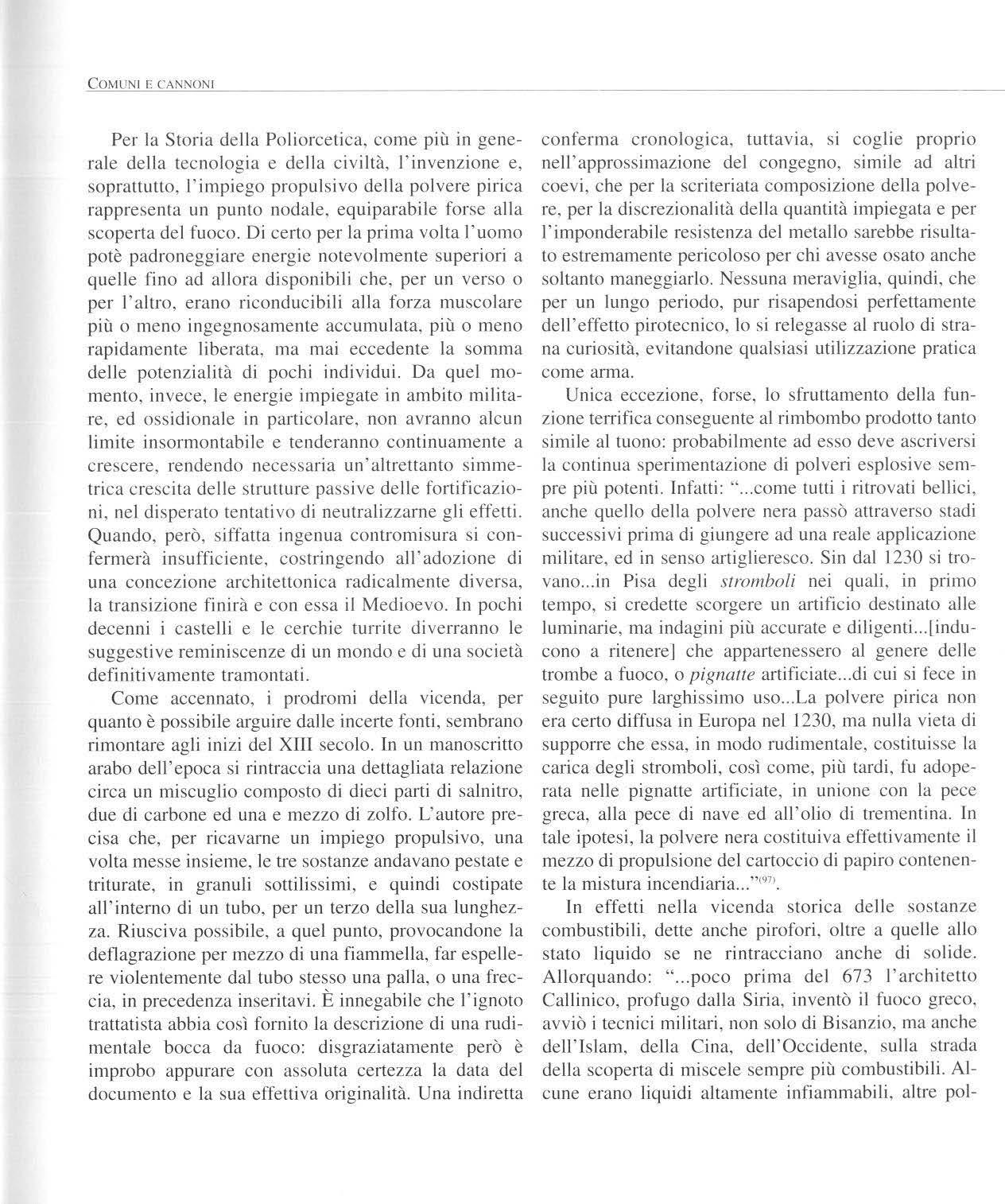
Unica eccezione, forse, lo sfruttamento della funzione terrifica conseguente al rimbombo prodotto tanto simile al tuono: probabilmente ad esso deve ascriversi la continua spe rimenta zione di polveri esplosive sempre più potenti. Infatti: " ... come tutti i ritrovati bellici , anche quello della polvere nera passò attraverso stadi successivi prima di giungere ad una reale applicazione militare, ed in senso artiglieresco. Sin dal 1230 si trovano in Pisa degli stromboli nei quali. in primo tempo, si credette scorgere un artificio destinato alle luminarie, ma indagini più accurate e diligenti linducono a ritenereJ che appartenessero al genere delle trombe a fuoco, o pigna/le artificiate di cui si fece in seguito pure larghissimo uso ... La polvere pirica non era certo diffusa in Europa nel 1230, ma nuJla vieta di supporre che essa, in modo rudimentale, costituisse la carica degli s tromboli , così come, più tardi, fu adoperata nelle pignatte artificiate, in unione con la pece greca, alla pece di nave ed all'olio di trementina. In tale ipotesi, la polvere nera costituiva effettivamente il mezzo di propulsione del cartoccio di papiro contenente la mistura incendiaria ... " <m .
In effetti nella vicenda storica delle sostanze combust ibi li , dette anche pirofori, oltre a quelle allo stato liquido se ne rintracciano anche di solide. Allorquando: " poco prima del 673 l'architetto Callinico, profugo dalla Siria, inventò il fuoco greco, avviò i tecnici militari , non solo di Bisanzio, ma anche dell'Islam, della Cina, dell'Occidente, sulla strada della scoperta di miscele sempre più combustibili. Alcune erano liquidi altamente infiammabili, altre pol-
veri. Fra queste ultime una combinazione di carbone, zolfo e salnitro, divenne d'uso sempre più frequente la polvere da sparo; ma essa aveva due difetti: in primo luo go le tecniche di purificazione del salnitro erano imperfette, in secondo luogo la polvere non conteneva spaz i di aria, che permettessero una combustione tanto rapida da divenire un 'esplosione. Gli esperimenti con queste miscele ed i miglioramenti nei metodi di purificazione del sa lnitro, giunsero tuttavia a tal punto in tutta l'Euras ia durante il XIII secolo, che la conversione della polvere in gas avveniva tanto rapidamente da rendere in evitabile l'invenzione dei fuochi d'artificio. Le «lance di fuoco volanti>> usate nel 1232 nell'assedio di Loyang e di K 'ai-feng-fu , non devono essere s tate niente più che delle candele romane perchè lanciavano fiamme so lo a qualche decina di passi. Nel 1258 vengono m enzionati a Colonia oggetti che probabilmente erano dei veri e propri razzi, ed intorno al 1260 Ru ggero Bacone li conosceva già ... Sicchè la confusa storia della nascita degli esplosivi e delle armi da fuoco è spiegabile solo come un complesso di esperimenti regionali paralleli, basati essenzialmente sulle varie forme di fuoco greco, con scambi occasionali di miglioramenti tecnici, man mano che i metodi chimici venivano perfezionati. " <<>s)
Al riguardo, però, bi sogna aggiungere che in molti memoriali e cronache del XIII e del XIV secolo si fa riferimento a 'tor menta' tonanti: la precisazione è estremamente significa tiva. Le prime artiglierie, infatti, non godettero di una precisa designazione, come del resto di un precipuo impiego, rispetto alle più sperimentate e funzionali macchine da l ancio: scag liavano comunque palle di pietra contro fortificazioni e, per conseguenza, si chiamarono anch'esse 'tormenta '. La sola differenza, sensibilissima, consisteva nell' assordante fragore prodotto dal loro impiego. Ragion per cui i cronisti più scrupolosi iniziarono a precisare se, nel particolare assed io, erano stati impiegati congegni silenz io si o tonanti. Per lungo tempo quella nota distintiva rimase l'unica traccia dell'impiego della nuova arma. Quanto tale diversificazione fosse reputata basilare lo dimostra il fatto che ancora intorno alla metà del
'300, in alcuni manoscritti se ne individuano gli estremi echi. Nel 1340, ad esempio, nel corso dell ' assedio di Tarifa in Spagna, condotto dai Mori , si utilizzarono da parte di quest'ultimi:
'' ... rnaquina s y in ge nios de truenos que lan za ban bala s de hicrro "199 1
Un paio di anni dopo sono i so ldati di Alfonso XI ad essediare i Mori in Algesiras , ed in tale circostanza ancora una volta:
" los Moros de la ciudad lançaban muchos trueno s contra la hueste en que lançaban pallas de hierro tan manas co rno mançanos may grandes ... " ncx,,
Fatta salva l'incertezza linguistica, secondo alcuni memorialisti italiani il primo impiego di armi da fuoco , più o meno di questo genere, avvenne in Europa intorno al 1212 ad opera dell'imperatore Ottone IV, dando per buono che si sia trattato di una vera arma e non piuttosto di un sem plice segnale acustico. Stabilire, infatti, quando il cannone sia comparso significa, innanzitutto, stabi lire esattamente cosa debba intendersi per cannone. In ogni caso, con l 'a vanzare del XIII secolo, i riferimenti ad armi da fuoco impie gate negli investimenti ossidionali divengono sempre più frequenti ed espliciti, lasciando motivatamente concludere che qualcosa di molto simile ad una sia pur rudimentale artiglieiia doveva ormai essere comparsa. Del resto, come innanzi accennato, le scarpature che iniziano a munire sistematicamente le basi delle fortific azioni, proprio in quel medesimo scorcio storico, sono già di per sè una indubbia testimonianza.
Per l ' Italia i primi incerti ssimi accenni a non meglio precisate, e precisabili, artiglierie rimontano al 1216, allorquando i Bolognesi andarono: " ad assediare Santo Arcangelo in serv izio di quei di Cesena , et ivi stette ro sei settimane et colle bombarde buttarono le mura a terra .. . " cloll _Similmente, nel 1239, nel corso dell'assedio del castello di Vignola si parla ancora di bombarde, e più esp licit amente, add irittura nella stessa

Bologna, nel 1274 dove si fa riferimento all'impiego di armi da fuoco in uno dei tradizionali scontri fra opposte fazioni. A loro volta i Fiorentini, stando all' Historia Fiorentina di Leonardo Aretino, nel 1253: " ... si fermarono colla gente a Tizano, il quale luogo perchè era forte di sito, sostenne più dì la forza del campo, e finalmente, vinto dalle bombarde, si diede nelle loro mani " (1021 • Sempre nella stessa storia si può ancora leggere che nel 1261, nell'assedio di Facchio furono impiegate nuovamente le bombarde, delle quali, pochi anni dopo, si avvalse pure Carlo d'Angiò a Poggi Obizzi. Tuttavia anche riguardo ai suddetti brani dell'Aretino, occorre ribadire, come più in generale innanzi precisato, che: " ... la versione dell 'Acciaiuoli fu fatta nel 1473, quando cioè l 'uso delle bombarde era già diffuso , e che essi non corrispondono al testo latino, dove è adoperata la parola tormentum, la quale ... era generica ed adoperavasi a significare qualunque sorta di macchine guerresche " 003 i Conclude, pertanto, scetticamente il Montù affermando che: " ... notizie sull'impiego delle armi da fuoco nel secolo Xlii , a voler tener conto delle testimonianze non controllabili, se ne trovano a josa anche per quanto riguarda l'Italia... " <104 i_ La sincronicità e la molteplicità dei riferimenti, lasciano però presumere che qualcosa di molto simile ad una rudimentale artiglieria, a partire dalla seconda metà del XIII sec., doveva saltuariamente impiegarsi. E soprattutto, ciò avveniva in maniera progressivamente meno sperimentale ed episodica, a differenza di quanto era accaduto nei decenni precedenti, in varie parti d'Europa, e specialmente in Italia.
Per restare al Regno di Napoli, nei registri angioini, nell'ambito delle disposizioni per la gue1ra dei Vespri, si rintraccia un significativo riferimento ad armi da fuoco. Il documento, redatto il 12 maggio del 1284, ordinava al castellano di Castel Capuano in Napoli 1105i di consegnare al vice-ammiraglio della flotta:
"Belistas, quarellos , cannunculos pro projicendo igne s ilvestro, lanceas , lancione s, rampiculos, scu tos, squarzave l a, pavensa et alia arma pro armatione galearum " <106
Il brano, sebbene s ia indubbiamente relativo ad un congegno funzionante a polvere pirica, ancora una volta, è alquanto indeterminato. Infatti: " ... molti storici , fra i quali il Guglielmotti , ritengono che i cannunculos pro projicendo igne silvestro fossero armi da fuoco rudimentali, ma potrebbe anche dars i che fossero null'altro che le canne da volare e far tuono del libro di Marco Greco. Si oppone da molti, ai suddetti documenti che autorevoli scrittori di quel tempo non hanno fatto parola dell' artiglierie; citando s pecialmente Dante, Egidio Colonna e Marin Sanuto, e facendo caso singolarmente di questi ultimi due, i quali scrissero diffusamente delle armi in uso ai loro tempi e del fuoco incendiario da gettare sui nemici ... " c1011 • Per lo stesso motivo, del resto, è difficile credere che un ' intelligenza disinibita e speculativa come quella di Federico 11 , circolando da tempo s imili allusioni a miscele esplosive, non se ne sia in qualche modo occupata, incentivandone magari la sperimentazione diretta. È, tuttavia, anche probabile, proprio per le intuibili implicanze militari e , in ultima analisi, per la supposta origine diabolica del fenomeno, che ogni ricerca in materia avvenisse nel più assoluto segreto. Basti considerare al riguardo che i Bizantini comminavano la morte a chiunque avesse, in qualsiasi modo , divulgato persino marginali accenni sulla composizione del 'fuoco greco': ed il segreto rimase talmente ben custodito, nonostante l'ultrasecolare impiego, che non ne conosciamo gli effettivi ingredienti.
Non a caso, proprio in quegli enigmatici sifoni lanciafiamme alcuni studiosi hanno intravisto lo spunto del cannone, affermando che: " mentre la polvere da sparo ed i razzi hanno avuto, a quanto sembra, uno sviluppo internazionale, i cannoni hanno un 'o rigine occidentale , e derivano dalla tecnica bizantina di lanciare il fuoco greco con tubi di rame. Che tubi di questo tipo venissero usati in occidente anche dopo l ' inven zio ne della polvere da sparo è indicato dalla distinzione fra baston àfeu e baston à pouldre, nei quali ultimi veniva impiegato il ben più esplosivo fewe volani invece del fewe gregois. Furono gli occidentali che cominciarono a lanciare con questi tubi palle di pietra e di ferro
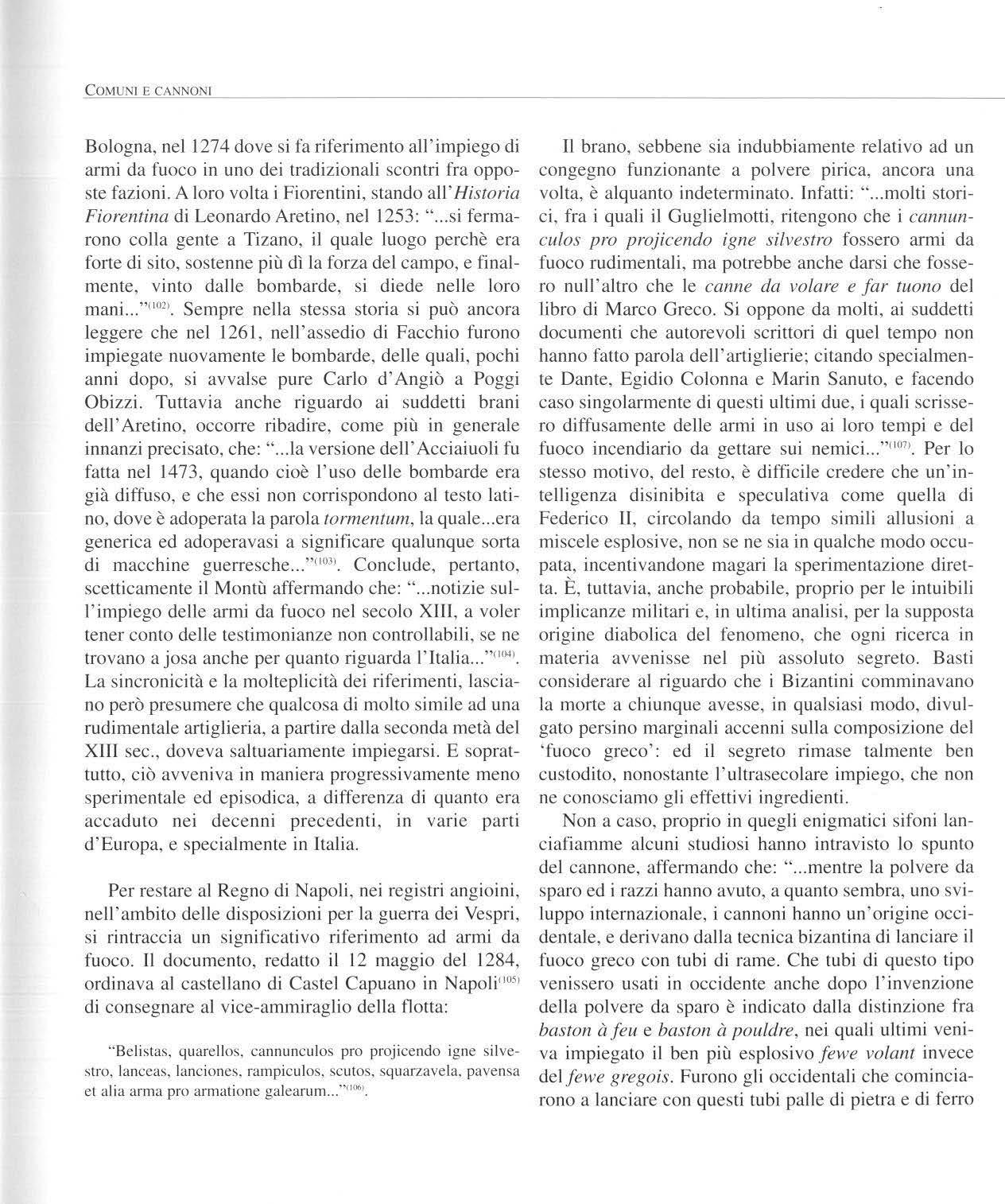
invece del fuoco, anche se la prima raffigurazione di un cannone (1327) mostra il lancio di un'enorme freccia e non di una palla ... " 008 )
Per avere, però, la certezza dell'avvento delle bocche da fuoco dobbiamo attendere i primi decenni del XIV seco lo , ed in particolare il 1322, anno in cui fu fuso a Mantova un vaso di bronzo, una sorta di mortaio completo di foro focone, nonchè di gioia di bocca e di culatta. Si trattava, stando ali' Angelucci, di un: " ... cannone ... del peso di libbre I 5, once 11 di Mantova (chilog. 49,41) ed in mezzo a fogliami rozzamente imitanti l'alloro e l'acanto, aveva la croce di quella città, comune a molte altre di Lombardia. Le iniziali P. P. P. F. (forse Petrus Paulus P. ? Fecit) che stanno ad indicare il maestro gittatore, e l'anno 1322, costituiscono il pregio incontestabile di questo monumento , perchè operate di rilievo nel getto e non incise posteriormente. Le dimensioni di quest'arma sono le seg uenti: lunghezza ... dell'anima m. 0.740, diametro interno alla bocca m. 0.055, al fondo m. 0.45 [0.045). La portata poi era: col proietto di ferro, di chilog. 0.343 Lcorris pondente ad una libbra , pari al calibro di m. 0.0541; col proietto di pietra, di chilog. 0.120; la proporzione tra il peso di questo colla bocca da fuoco nel primo caso: 1/14.4 , nel secondo: 1/41.17.
Disgraziatamente questa preziosità fu nel 1849 tolta insieme con altre armi, come questa inutili, dai cessati dominatori stra nieri ed ora ornerà forse qualche privata raccolta od avrà fatto la fine dalla quale l'intelligente possessore l 'aveva liberata... " <um_

Al di là delle caratteristiche fom1ali, il disperso reperto sembrerebbe, se non altro, accreditare un ruolo primario all'Italia nella produzione delle bocche da fuoco. Di sicuro a partire dalla s ua data di fusione, le notizie sulle artiglierie, e sul loro impiego, divengono innumerevoli ed estremamente circostanziate. E, paradossalmente, proprio dalla pedantesca precisione con cui i trattatisti si dilungano circa le loro connotazioni e prestazioni in ambito ossidionale traspare, implicitamente confermata, l 'origine di siffatte armi nel seco lo
precedente, non potendosi in alcun modo credere all'avvento improvviso, e al corretto impiego , di un'arma tanto rivoluzionaria. Ovvio , perciò, concludere che l'ampio lasso di tempo intercorso fra i primi incerti riferimenti e le prime concrete testimonianze corrisponda alla fase di perfezionamento tecnico-operativo, sia pure rudimentale, delle bocche da fuoco. In ogni caso va ribadito che l 'amb ito d ' impiego delle stesse fu per quasi due secoli esclusivamente quello degli assedi, ovvero finalizzato alla demoli zione a distanza delle fortificazioni, divenute om1ai invulnerabili alle coeve macchine da lancio, ad onta della loro ulteriore evoluzione. Non è, perciò, affalto casuale che le bombarde, fino alla conclusione del Medioevo, continuarono a scagli are palle di pietra, esattamente come le antiche artiglierie meccaniche, sebbene di dimensioni mag giori.
La novità era, invece, l'energia con la quale quelle andavano a percuotere le mura, essendosi ben presto reso attuabile il tiro teso al posto di quello arcuato. Dai reperti disponibili, infatti, s i ri cava che dopo una serie di pezzi sostanzialmente s imili a rozzi mortai, corti di anima e grossi di calibro, capaci perciò soltanto di lanci fortemente parabolici, a partire dalla seconda metà del XIV secolo la produzione.si orientò verso bocche notevolmente più lunghe e sottili in grado di tirare, ad alcune centinaia di metri di di stanza, palle di calibro più modesto ma con traiettoria quasi orizzontale. Il perfezionamento consentiva impatti con energie cinetiche re sidue di gran lunga s uperiori, con esiti devastanti inu si tati. Infatti , mentre nel tiro parabolico le pall e percuotevano con una modesta frazione della velocità iniziale , perchè ampiamente decurtata dalla resistenza dell 'aria nella lunga traiettoria ascendente e discendente, in quello brevi ss imo teso la perdita era insignificante. Senza contare che, avvenendo la percussione quasi perpendicolarmente alle bas e delle mura riusciva della massima violenza, assolutamente in sos tenibile per le fortificazioni dell'epoca, che finivano per crollare verso l'esterno , colmando per g iunta il fossato, con esiti immaginabili. Fu questa l a sp iegazione balistica della scarpa, impi egata come primo rimedio sia per incrementare la resis ten za p ass iva d e lle fortificazioni
INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIAsia per deviare le traiettorie dalla normale. Inutile , per allora, spessorare le strutture esposte per la loro intera altezza, tanto più che se anche i cannoni avessero potuto tirare più in alto, gli impatti sarebbero stati comunque obliqui.
La scarpatura che restituì alle fortificazioni la capacità di resistere aJle prime artiglierie, provocò, però, in quest'ultime un vistoso incremento dimensionale. Essendo, infatti, l'energia cinetica residua funzione della velocità e della massa delle palle, il suo potenziamento dipendeva esclusivamente dalla maggiorazione di quest'ultima, ovvero dalla grandezza delle palle, che, a sua volta, implicava un proporzionale accrescimento dei pezzi. L'impossibilità di conseguire velocità di lancio superiori dipendeva, come accennato, dalla cattiva qualità delle polveri, resa anche peggiore dal fatto che: " le scosse, durante il trasporto, portavano il salnitro, più pesante, sul fondo, ed il carbone, più leggero, in superficie ... [provocando] una combustione lenta e relativamente inefficiente [che] costringeva gli artificieri a pressare la polvere nel cannone con un blocco di legno, e chiudere quindi il colpo con stracci o creta allo scopo di contenere il gas finchè non raggiungesse la pressione necessaria per il tiro ... " 0 10J Ma la definitiva soluzione di quella grave limitazione fu conseguita soltanto
dopo il 1420, con l'invenzione della polvere in grani. Pertanto, fino ad allora, solo con palle più grandi era possibile arrecare danni maggiori. Il che finì per rendere i cannoni talmente pesanti ed ingombranti da doverli costruire in più sezioni da assemblare al momento dell 'impiego Nonostante tali enormi inadeguatezze le conseguenze delle artiglierie furono stravolgenti, sulle fortificazioni prima e sulla politica poi.
I feudatari, infatti: " sono in grado di armarsi individualmente, ma è assai difficile che riescano a disporre di pesante e non nascondibile materiale d'artiglieria; e tanto meno possono averne i popolani .. .! villaggi e le città, sì, ne posseggono; ma man mano, i primi si arrendono alle seconde, e queste fanno atto di soggezione al Signore o al Governo centrale, i quali così, poco a poco , dispongono di tutte le forze militari, e quindi anche delle bocche da fuoco già feudali e comunali ... Il processo storico e politico di cui si è fatto cenno si svolge in It alia con assai maggior lentezza che non in altri Paesi e soprattutto con ritmo diverso da zona a zona " <11 1 ) Nessuna meraviglia, quindi, che la comparsa di un'artiglieria veramente funzionale, quella che poi dominerà s ui campi di battaglia fino alla metà del XIX secolo, coincise con la conclusione del Medioevo e la formazione dei grandi stati nazionali.

1 Da E.C.LODGE, li movimen/o comunale specialmente in Francia. in Sloria del Mondo Medievale. Milano 1980. voi.V, p.764.
1 La citazione è tratla da G.YOLPE, li Medioevo, Firenze 1933 , p.214.
3 Da H.P IRENNE. Le città del Medioevo, Bari 1980, p.97.
• Da G.CACIAGLI, li castello in Italia, Firenze 1979, pp.103-104.
' Da H.PlRENNE, Le citrà. ... cit.. p. I02.
6 Da H.PIRENNE, Le città cit., p. I03.
' Da G PROCAC'CI. Sroria degli italiani. Palermo I 971. vo i. I. p.23.
" Da E.SESTAN, Le origini delle signorie cirradine: w1 problema storico esaurilo?. in !rafia medievale. Napoli I 967, pp. 209-21 O.
9 Da E.C.LODGE. li movimento .... cit.. p.740.
"' Da E.C.LODGE, Il movimento cit., p 758
" Da L.SALVATORELLI, C!raliu comunale dal secolo XI alla metà del secolo XIV, in Storia d'Italia illustrata. Milano 1940, pp.315 - 317.
12 Da G.GALASSO, Potere e istilu~ioni in Italia dalla caduta de/Umpero romano ad oggi , Milano 1976. p.29.
1 ' Da E C.LoDGE, li movimenlo , cii.. p.742.
"Da E.C.LODGE, li movimenlo , cii. , pp.757 -758.
i i Da H.A.L.FISHER, Storia d'Europa, Bergamo 1964, pp.316-3 I 7.
16 Da G.PROCACCI, Storia cit., pp.19 - 20.
" Da G.GAL\SSO, Potere cit., p.39.
18 Da E.ENNEN. Storia della cirtà 111ediel'(i/e, Ba1i 1975. pp.157 - 158.
19 Da E.ENNEN, Sroria cit.. p. 129.
10 Da R.AJELLO, // problema storico del Mezzogiorno. L'anomalia socio-istitu z ionale napoletana dal cinquecento al ser1ece1110. Napoli 1996. p.34.
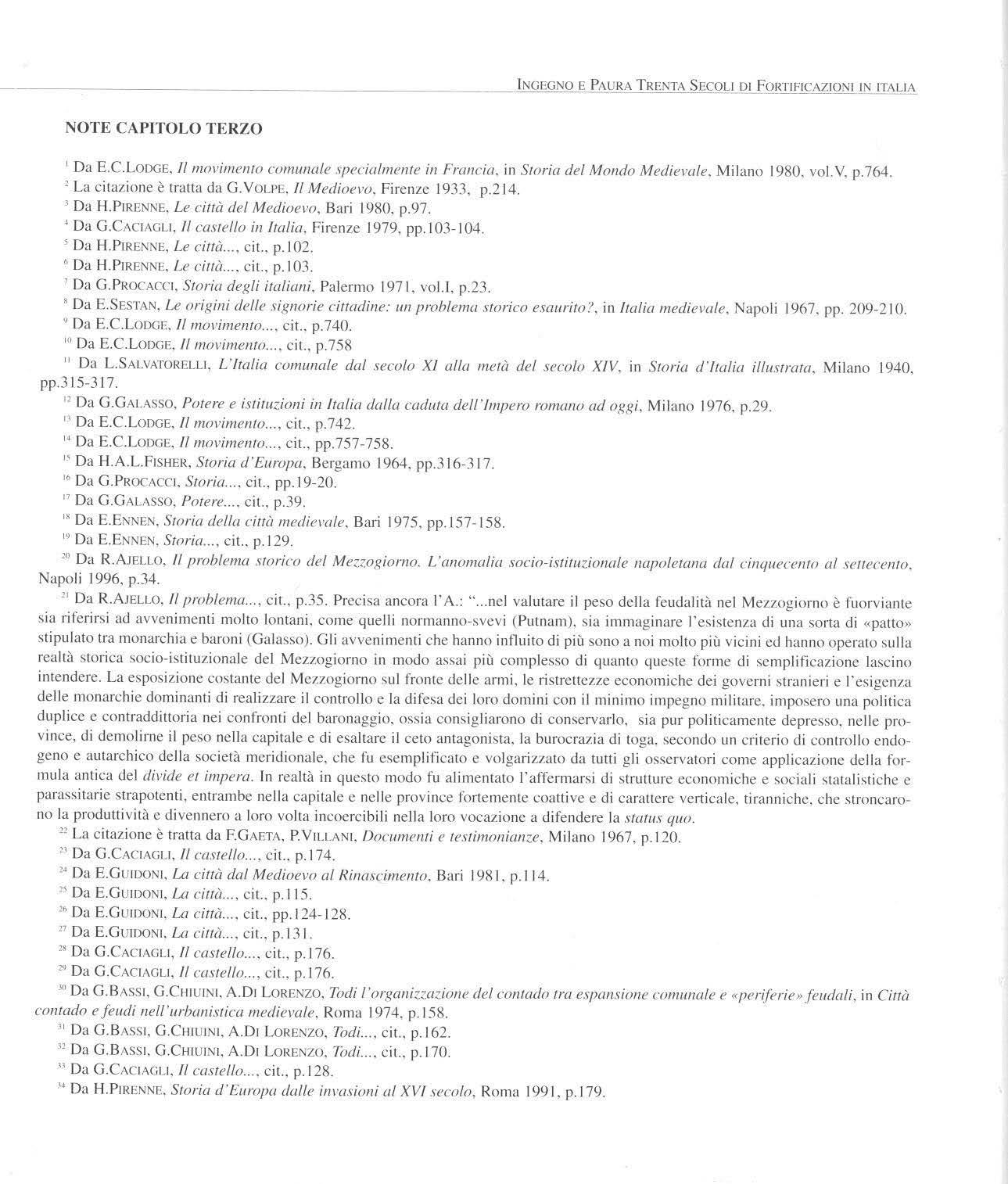
21 Da R.AJELLO , // problema , cit. , p.35. Precisa ancora I' A.: " ... nel valutare il peso della feuda lità nel Mezzogiorno è fuorviante s ia riferirsi ad avveniment i mo lto lontani. come quelli normanno-svevi (Putnarn). sia immaginare l'esistenza di una sorta di «patto» stipulato tra monarchia e baroni (Galasso). Gli avvenimenti che hanno influito di più sono a noi mo l to più vicini cd hanno operato sulla rea ltà storica socio -istituzionale del Mezzogiorno in modo assa i p iù complesso di quanto queste forme cli sempl ificazione lascino intendere. La esposizione costante del Mezzogiorno sul fronte delle a rmi, le ristrettezze economiche dei governi stranieri e l'esigenza delle monarc h ie dominant i di realizzare il controllo e la d ifesa dei loro domini con i l minimo impegno mi litare. imposero una pol itica duplice e contraddittoria nei confronti dt:!l baronagg io. ossia cons igliarono d i conservar lo, sia pur politicamente depresso. ne ll e province, d i demolirne il peso nella capitale e di esalta re il ceto antagonista, la burocraz ia di toga secondo un criterio di controllo endogeno e autarchico della società meridiona le, che fu esemplificato e volgarizzato da tutt i gli osservatori come app l icazione della formu la antica del divide ef impera. Tn realtà in questo modo fu alimentato l'affermarsi di strutture economiche e socia li sta talistiche e parass i tarie strapotenti. entrambe nella capitale e nelle province fortemen te coattive e di carattere vert icale, tirann iche. che stroncarono la p roduttività e divennero a loro volta i ncoercibili nella loro vocaz ione a d ifendere la status quo.
22 La citazione è tratta da F.GAETA. P.Y JLLANI. Documenli e testimonianze, Milano 1967, p .1 20.
11 Da G.CACIAGLI, li castello. .. , cit., p.174.
2 J Da E.GUIDONI, la città dal Medioevo al Rinascimento, Bar i 1981. p 114.
2 ' Da E.GUIDONI. La citrà ... , cit.. p. 115.
2 " Da E.GUIDONI. la cillà ci t. pp. 124-128.
27 Da E.GUIDONI . la ci11à ... , cit., p.131 .
28 D a G.CACIAGLI, Il cas1ello cit., p.176.
2 " Da G.CACIAGLI, li castello ... , cit.. p.176.
30 Da G.BASSI, G.C111urN1 A.D I LORENZO. Todi l'organizza zione del con/culo tra espansione comunale e «periferie » feudali, in Ci11à contado e feudi nel/'urbanisrica medievale, Roma I 974. p. l 58.
11 Da G.BASSJ, G.CHIUINI, A.D 1 LORENZO. Todi cit., p.162 .
12 Da G.BASSI, G.CHIUINI, A.DI LORENZO. Todi cit., p.170.
" Da G.CACIAGLI, li castello cit., p.128.
u Da H.P IRENNF. Storia d'Europa dalle im •asioni al XVI secolo, Ro ma I99 I, p.179.
; 5 Da H.PIRENNE, Storia d'Europa , cit., p.180.
; 6 Da G.P.CHIODINI, R.TOSTI , Panicate comune rurale. Lo statuto del /484 e gli atti del notaio Cristoforo di Pietro del 1312, Perugia 1989, p.XV.
·" Da N.D.VINCIARELLI, Storia e paesaggio: i castelli e le ville. in Trasimeno lago d'arte, Roma I 994, p.52.
'" Da L.LEPRI, Alla scoperta di Panica/e, Perugia 1994, p.24.
'" N.D.VtNCIARELLI, li territorio della val/e del Nestore, in Da edicola campestre a santuario mariano, att i del conv. l 995, Perugia 1998, p.58.
0 Da O.GRIFONI, Memorie istoriche su ?emica/e terra etrusco- umbra. Città di Castello 1918, pp. 18-19.
" N.D. VtNCIARF.LLI, Il territorio del Trasimeno. Ventiquattro insediamenti minori. in Storia della Cittcì. Electa Ed it.19 , 1982, p. I 08.
"
2 Da O.GRIFONI, Il territorio , cil., pp. I0-11.
,; Da N.D. VtNCIARELLI, Storia e paesaggio , cit., p.57.
-1-1 Da G.P.CHtODINl. R.TOSTI, Panirale comune , cit.. p.69.
45 Da G.P.CHJODINJ, R.TOSTI. Panica/e comune ... , cil., p.69.
46 Cfr.L.LEPRI, Pcmicale e i Cappuccini dei secoli XVI e XVII, in Silvestro Pepi da Panica/e e il suo atlante, Perugia 1993, p.36.
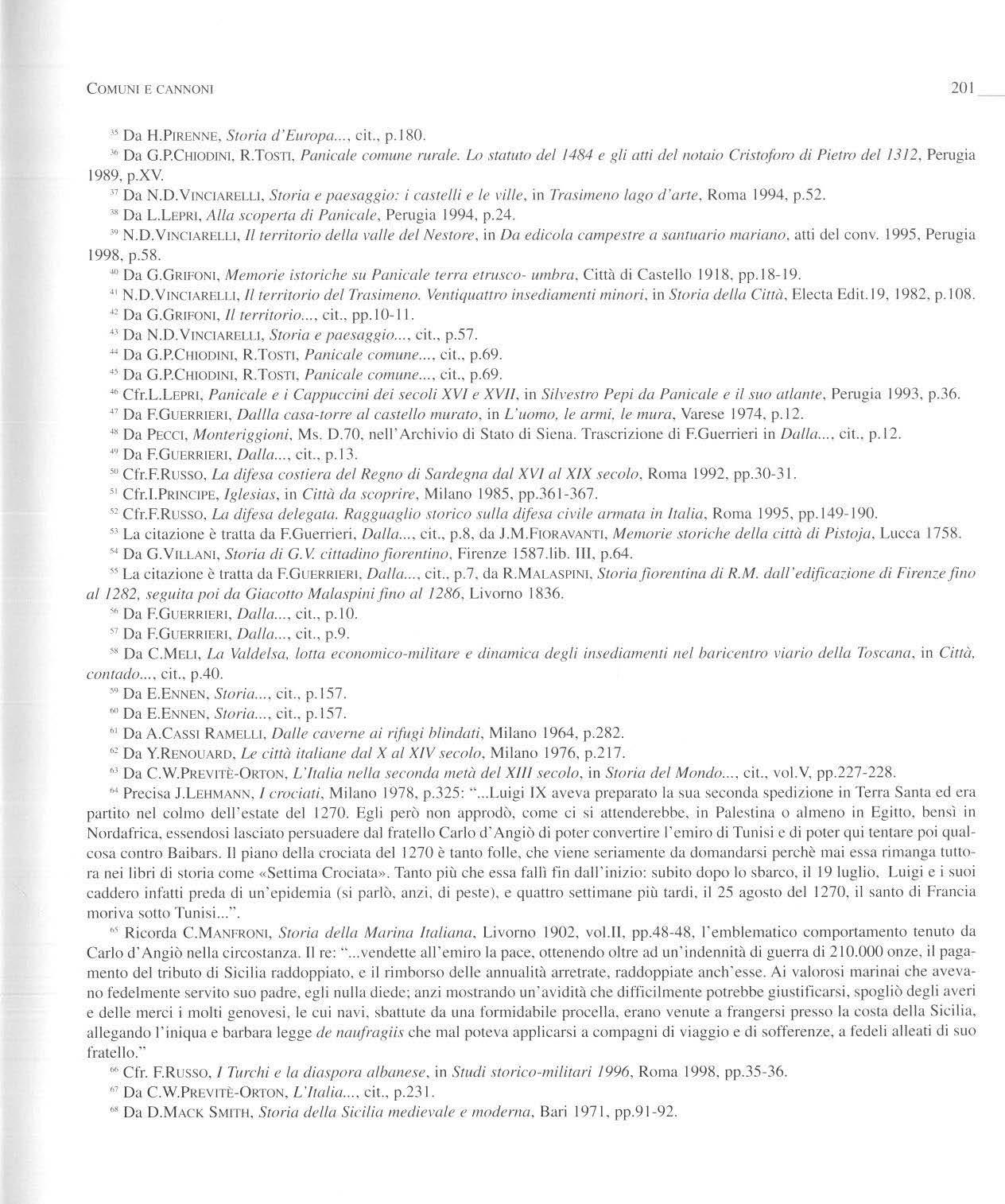
47 Da F.GUERRIERI, Dalila casa-torre al castello murato, in L'uomo, le armi, le mura, Varese 1974 . p.12.
48 Da PECCI, Monteriggio11i, Ms. D.70, nel!' Archivio di Stato di Siena. Trascriz ione di F.Guerrieri in Dalla cit.. p.12.
49 Da F.GUERRIERI. Dal/a ' cit.. p. I3
50 Cfr.F.Russo, fo difesa costiera del Regno di Sardegna dal XVI al XIX secolo, Roma 1992, pp.30-31.
51 Cfr.I.PRtNCIPE, Iglesias. in Ci1tà da scoprire, Milano I 985, pp.361-367.
'~ Cfr.F.Russo, fo difesa delegata. Ragguaglio storico sulla difesa civile armata in Italia, Roma 1995, pp. I49 - 190.
5 ' La citazione è tratta da F.Guerrieri, Dalla , cit., p.8, da J.M.FlORAVANTI , Memorie storiche della città di Pistoja, Lucca 1758.
54 Da G. VILLANI, Storia di C. V. ci tiadino fiorentino. Firenze 1587 .li b. TII, p.64.
" La citazione è lralla da F.GUERRtERI, Dal/a cit.. p.7. da R.MALASPINJ. Storia fiorentina di R.M. daWed(fica zione di Firenz.efìno al 1282, seguita poi da Giacotto Malaspinijìno al 1286, Livorno 1836.
'" Da F.GUERRIERI. Dalla , cit., p. IO.
7 Da P.GUF.RRJERI, Dalla , cit.. p.9. Da C.MELI, La Va/del.sa , lotta economico-militare e dinamica degli insediamenti nel baricentro viario della Toscana. in Città. contado , c it.. p.40.
''' Da E.ENNEN, Storia ... , cit.. p. I 57.
"'' Da E.ENNEN, Storia cit., p.157.
61 Da A.CASSI RAMELLI, Dalle caverne ai rifugi hlindati, Milano I964, p.282.
61 Da Y.RE NOUARD. Le città italiane dal X al XIV secolo, Milano 1976 , p.217.
6-' Da C.W.PREV!TÈ-OtffON, L'Italia nel/a seconda metà del Xlii secolo, in Storia del Mondo ... , cit., voi. V, pp.227-228.
""' Precisa J.L EHMANN, / crociati, Milano 197 8, p.325: " Luigi IX aveva preparato la s ua seconda sped izione in Terra Santa cd era partito nel colmo dell'estate ciel 1270. Egli però non approdè\ come ci si allcndcrcbbe, in Palestina o almeno in Egitto. bensì in Nordafrica, essendosi las cia to persuadere dal fratello Carlo d'Angiò di poter convertire l'emiro di Tunisi e di poter qui tentare poi qualcosa contro Baibars. Il piano della crociata del 1270 è tanto folle, che viene se riam ente da domandarsi perchè mai essa rimanga tuttora nei libri di s tori a come «Scuima Crociata». Tanto più che essa fallì fin dall'ini1 io: subito dopo lo sba rco , il 19 luglio. Luigi e i suoi caddero infatti preda di un'epidemia (si parlò, anzi, di peste). e quattro settimane più tardi. il 25 agosto del 1270, il santo di Franc ia moriva sotto Tunisi ... ".
~· Ricorda C.MANFRONI, Storia del/a Marina Italiana, Livorno 1902, voi.Il, pp.48 -48, l'emblematic.:o comportamento tenuto da Carlo d'Angiò nella circostanza. Il re: " vendette ali' emiro la pace. ottenendo oltre ad un'indennità di g uerra di 2 I 0.000 onze, iI pagamento del tributo di Sicilia raddoppiato. e il rimborso delle annualità arretrate, raddoppiate anch'esse. Ai valorosi marinai che avevano fedelmente servito suo padre. egl i nulla diede; anzi mostrando un 'avidità che difficilmente potrebbe giustifica rsi, spogliò degli averi e delle merci i molti genovesi. le cui navi, sbattute da una formidabile procella, erano venute a frangersi presso la costa della Sicilia, allegando l'iniqua e barbara legge de naufragiis che mal poteva applicarsi a compagni di viaggio e di sofferenze , a fedeli alleat i di suo fratello."
"'' Cfr. F.Russo, i Turchi e fa diaspora albanese, in Studi storico-militari /996. Roma 1998, pp.35 -36. ,,; Da C.W.PREV!TÈ-ORTON, L'Italia , cit., p.231.
(>l\ Da D.M ACK SMtTH, Swria del/a Sicilia medievale e moderna, Bari I 971. pp.91-92.
ING EGNO E PA URA TRENTA SECOLI DI FORTIFI CAZION I IN !TALIA
69 La citazione è tratta eia O.PROCACCI, Storia ... , cii., voi. I, p.59.
70 Da D.MA CK SMTTH. Storia , cit., p.93.
71 Da L.SANTORO. Tipologia ed evo luzione dell'architellura militare in Campania, in Arch.Stor.Prov.Nap., terza se1ie, vo l.VII-VTTT (1968-1969), Napoli 1970. p.118.
12 Cfr. B.GILLE, Leonardo e gli ing egneri del Rinascimento, Varese 1972, pp.25-30.

73 Da A.VENDITI!, Napoli angioina. Urbanistica e architellura, in Storia di Napoli, Napoli 1976. pp.820-822.
74 Da LSANTORO, Castelli angioini e aragonesi nel regno di Napoli. Segrate 1982, p.80.
7 Da A.YEND!TTI, Napoli , cit., p.824.
1 • Da J.HOGG, Storia delle fortiflcazimzi, Novara 1982, p.47.
77 Da L.SANTORO. Tipologia , cii., p.12 I.
78 Da R.FILANGERI, Castel Nuovo, Napoli 1964. p.4.
19 Da L.S ANTO Ro. Castelli cit., p.66.
''" Da L.SANTORO, Castelli cit., p.67.
8 Da R.FrLANGERI, Castel cit., p.16.
81 Da G.M.DE Rossi, Torri costiere del Lazio. Roma 197 I , p.113.
8 -' Da L.SANTORO, Castelli , cit., p.73.
"'Cfr. O.VALENT E. Una storia millenaria, Le Castel/a. Catanzaro I 993, pp.30-3 I.
~, Cfr. T, MOMMS EN, Storia di Roma antirn. 1ist. Bologna 1979, lib.11, pp.487-488.
~ 6 La citazione è tratta eia O.VAI.ENTE, Una storia cit. , p. 30, nota 32.
87 Da E.PONTIERI, Ricerche sulla crisi d ella Monarchia siciliana nel secolo Xlii, Napoli 1958, p.215.
811 Cfr. M.AMAR!, La guerra del Vespro Siciliano, Firenze 1866, pp.6-7.
89 Da F.CAMP/\NILE, Dell'armi overo insegne de' Nobili, Napoli 1680. p.92. La citazione è tratta da O.Valente, Una storia , cit., p.32, nota 34.
9 " Da G.F.PUGUESE. Viaggio dalle Castel/a a Crotone per capo Colonna, in Il Piwgora, a.I, 1845. p.178 La citazione è tratta eia O.Valente. Una storia ... , cit., p.16 nota 7.
9 ' Da L.SANTORO, Castelli , cii., p.1 14.
92 Da L.SANTORO, Castelli... , cit., p.93.
"
1 Cfr. L.SA NTORO, Le torri costiere in Campania, in Napoli Nobilissima, Napoli 1967, n° 4, pp.45 -46.
''J Cfr. L.SA NTORO, I castelli del ducato ama(fìtano , cit., pp.1-20.
"' Da M.CAMERA , Memorie storico-dip/0111atiche dell'antica c illà e ducato di Amalfi, Salerno 1876-1881, Il, p.592.
96 Da LSA NTORO, Castelli.... cit., p.93.
97 Da C.MoNTÙ, Storia de/l 'artiglieria italiana, Roma I934. vol.l, p.89.
911 Da L. WHJTE Jr., Tecnica e società nel Medioevo. Firenze 1976, p.159.
99 La citazione è tratta da E.BRAVETTA, L'artiglieria e le sue meraviglie, Milano 1919, p.67.
"
10 Da E.B RAVETrA, L 'artiglieria , c il. , p.67.
'" ' Da C.MONTÙ, Storia , cit.. voi.I. p.93.
'"
2 Da E.BRAYETrA, L'artiglieria , cit.. p.57.
10 ' Da E.BRAVEITA , L'artiglieria , cit., p.57.
,OJ Da C.MONTÙ, Storia cil., vo i.I p.93.
,os Cfr. F.FASCIA, Castel di Capuana, Napoli 1996. pp.25-61.
106 Da E.BRAVETTA, L'artiglieria , cit., p.58.
'°' Da E.BRAVETTA, L'artiRlieria ... , cit., p.58
IUIJ Da L.WHITE Jr. , Tecnica , cit., pp.160-161.
1011 Da E.BRAVETTA, L'artiglieria ... , ci t. , p.85.
11 0 Da L.WHJTE Jr., Te cn ica , c it., p.162.
111 Da C.MONTÙ, Storia ... , cit., p.97.
La fine di un'era
li XII ed il XIII secolo videro il proliferare abnorme della fortificazione , applicata in ogni settore ed in qualsiasi possibile variante. Dai castelli alle cerchie urbiche, dalle torri gentilizie alle torri costiere, dalle dimore patrizie ai monasteri, dai ponti alle masserie e, addirittura, ai pozzi, nessun edificio, o struttura pubblica di una qualche importanza, ne andò esente. La spiegazione del fenomeno deve attribu irsi, ovviamente, alla contestuale incapacità di espugnarle. La deficienza, oltre a renderle garanti indiscusse della sicurezza , ne prolungò vistosamente la longevità, ammortizzandone i costi e saturando il territorio. Per conseguenza finirono col divenire, relativamente parlando, un'architettura infestante e solo l'affermarsi dell'artiglieria valse ad invertire la tendenza.
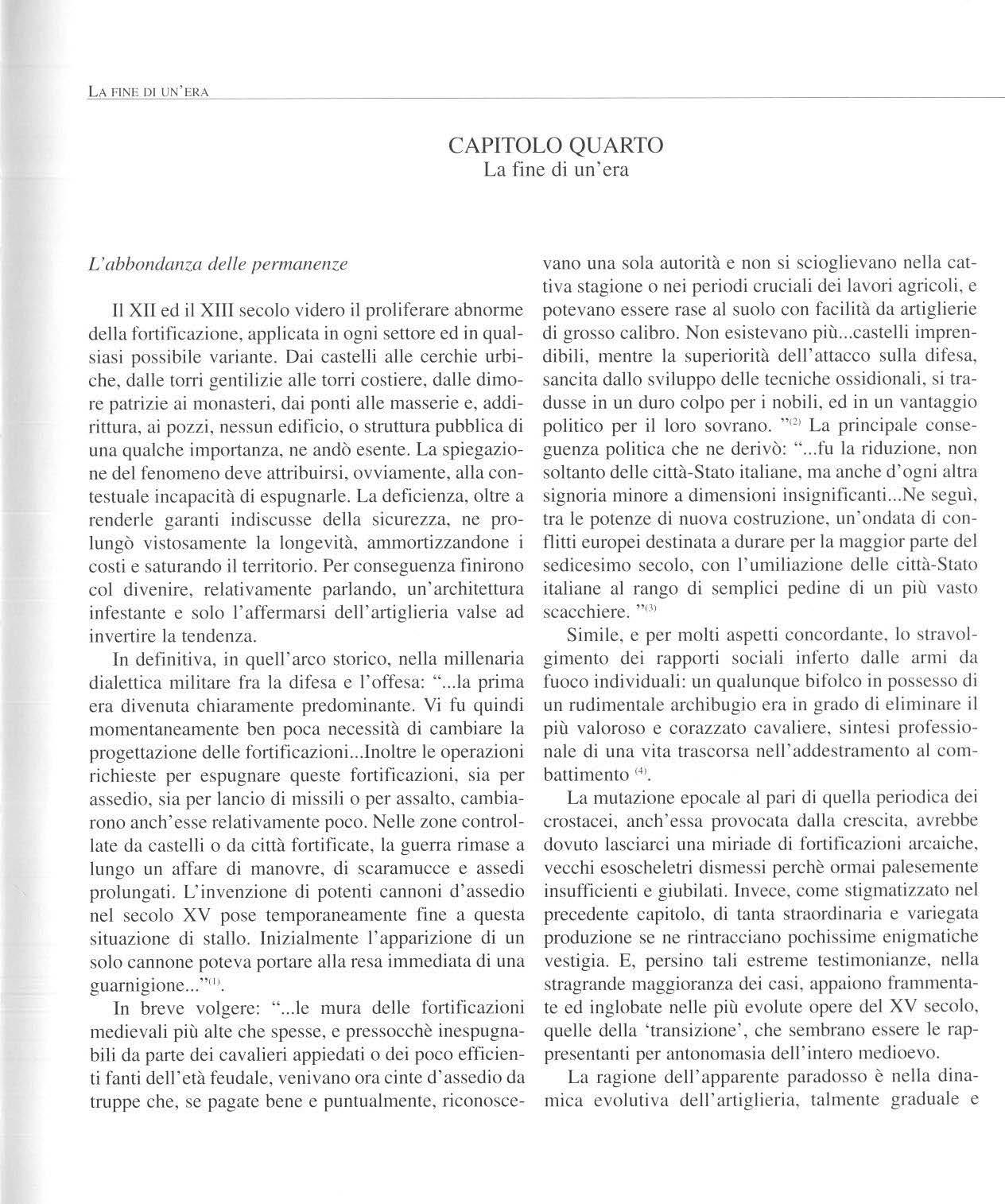
In definì ti va , in quell'arco storico, nella millenaria dialettica militare fra la difesa e l'offesa: " ... la prima era divenuta chiaramente predominante. Vi fu quindi momentaneamente ben poca necessità di cambiare l a progettazione delle fortificazioni .. .Inoltre le operazioni richieste per espugnare queste fortificazioni, sia per assedio , sia per lancio di missili o per assalto, cambiarono anch'esse relativamente poco. Nelle zone contro llate da castelli o da città fo rtifi cate, la guerra rimase a lun go un affare di manovre, di scaramucce e assedi prolungati. L'invenzione di potenti cannoni d'assedio nel secolo XV pose temporaneamente fine a questa situazione dì stallo. Ini zia lm ente l'apparizione di un so lo cannone poteva portare alla resa immediata di una guarnigione " (' )
In breve volgere: " ... le mura delle fortificazioni medievali più alte che spesse, e p ressocchè inespugnabili da parte dei cava li eri appiedat i o dei poco effic ienti fanti dell'età feuda le, venivano ora cìnte d'assedio da truppe che, se pagate bene e puntualmente, riconosce-
vano una sola autorità e non si scioglievano nella cattiva stagione o nei periodi cruciali dei lavori agricoli, e potevano essere rase al suolo con facilità da artiglierie di grosso calibro. Non esistevano più castelli imprendibili, mentre la superiorità dell'attacco sulla difesa, sancita dallo svi luppo delle tecniche ossidionali, si tradusse in un duro colpo per i nobili , ed in un vantaggio politico per il loro sovrano. "12 > La principale conseguenza politica che ne derivò: " ... fu la riduzione, non soltanto delle città-Stato italiane , ma anche d'ogni altra signoria minore a dimensioni insignificanti ... Ne seguì, tra le potenze di nuova costruzione, un ' ondata di conflitti europei destinata a durare per la maggior parte del sedicesimo secolo, con l ' umiliazione dell e città-Stato italiane al rango di semplici pedine di un più va s to scacchiere. "'3 >
Simile, e per molti aspetti concordante, lo s travolgimento dei rapporti sociali inferto dalle armi da fuoco individuali: un qualunque bifolco in possess o di un rudimentale archibugio era in grado di eliminare il più valoroso e corazzato cavaliere, sintesi professionale di una vita trascorsa nell'addestramento al combattimento <4 > _
La mutazione epocale a l pari di quella periodica dei crostacei, anch'essa provocata dalla crescita, avrebbe dovuto lasciarci una miriade di fortificazioni arcaiche , vecchi esoscheletri dismessi perchè onnai palesemente in suffic ienti e giubilati. Invece, come stigmatizzato nel precedente capito lo , di tanta straordinaria e variegata produzione se ne rintracciano pochissime enigmatiche vestigia. E, persino tali estreme testimonianze, nella stragrande maggioranza dei casi , appaiono frammentate ed inglobate nelle più evolute opere del XV secolo , quelle della 'transizione', che sembrano essere le rappresentanti per antonomasia dell'intero medioevo.
L a ragione dell'apparente paradosso è nella dinamica evo luti va dell'artiglieria, talmente graduale e
lenta, da suggerire, e consentire, l'adeguamento progressivo di quasi tutte le fortificazioni , di volta in volta, ritenute con modesti interventi ancora utilizzabili. Pertanto: " molto tempo ancora trascorse prima che la fortificazione prendesse nuove forme , atte a renderla più resistente alle nuove armi, ed appropriata all'uso delle medesime nel la difesa. Imperocchè la sola esperienza poteva dimostrare 1'insufficienza delle disposizioni allora usate, e vincere da una pa1te l 'avve rsione alle innovazioni, ben naturale in un genere di costruzioni che richiede ingenti spese, e dal1' altra da un certo rispetto per l'antichità che forma uno dei caratteri di quei secoli del rinascimento della arti e delle scienze. " '51
In pratica, la cosiddetta architettura militare di transizione, più che una riqualificazione concettuale dei precedenti criteri fortificatori consistette in una loro dilazionata maggiorazione dimensionale. Non si può, in generale, attribuire questa utopica procedura all ' incompetenza dei progettisti o, peggio ancora, alla sottostima delle potenzialità dell'artiglieria, ma soltanto all'errata valutazione dei tempi necessari per il loro pieno conseguimento.
Forse a causa della difficoltosissima sequenza di postazione e d ' impiego delle bombarde , dell'in significante violenza d'impatto dei loro rozzi proietti di pietra , nonchè della scarsa conseguenzial ità per l' imprecisione del tiro e per l'irrisoria cadenza, nessuno, nemmeno i più attenti osservatori e tecnici militari dell 'epoca , riuscì a prevederne, dopo quasi un secolo e mezzo di trascurabili progressi, l'imminente balzo evolutivo. Perchè stupirsene quando lo stesso Machiavelli, ancora al principio del XVI secolo, considerava le artiglierie campali un gravoso e costoso impedimento più che una te1Tibile arma? Scriveva infatti:

'" so no molte più le volte. e sanza comparazione, che l'artiglierie grosse non percuotono le fanterie, c he quelle ch'elle perc uotono; perchè la fanteria e tanto bassa e quelle sono così difficili da trattare, c he, ogni p oco che tu l'alzi, e lle passano so pra la te s ta dei fanti; e se l'abba ss i, dann o in terra, e il co lpo non perv iene a quegli " 16>
Quindi , pur non escludendosi in assoluto migliorie per le bocche da fuoco , le si s uppo sero sempre in un futuro remoto. Per l'immediato l'unica evoluzione credibile, e verificabile, concerneva soltanto l'incrementarsi delle loro dimensioni. Fidando su di un simile postulato gli ingegneri e gli architetti si limitarono ad un simmetrico accrescimento delle resistenze passive delle strutture difensive maggiormente esposte. Quando però , allo scadere del XV secolo, le artiglierie attinsero all ' improvviso un notevole grado di efficienza, trasformandosi nell'arma che s ostanzialmente permarrà immutata fin quasi alla metà del XIX sec., l ' ingenua contromisura non bas tò più.
Dopo un'arco d'impiego di quasi seimila anni, al dissolversi del Medioevo l ' impianto difensivo impostato sulla cooperazione torri-cortina, esaurì improvvisamente, ed irrimediabilmente , la sua validità e venne abbandonato. A differenza di quanto fino ad allora verificatosi non fu più attuabile alcun adeguamento, per cui proprio da quel cruciale momento ci perviene la miriade di cerchie e di castelli, tutti, quand'anche non coevi, ormai con connotazioni s imilari: massicci gusci di pietra pateticamente fragili agli insulti balistici!
In conclusione, il castello: " ... aveva dominato le guerre medievali, quando le uniche risorse a disposizione clell' attaccante erano quelle ereditate dall' antichità classica: catapulte, arieti, assalti con scale e, soprattutto, fame. Le grosse artiglierie posero fine a tutto ciò: la demolizione delle mura di Cos tantinopoli l 1453] effettuata dall ' a11igl ieria turca, fu , sotto questo e sotto molti altri aspetti, il simbolo della fine di un'era nella storia dell'uomo occidentale ... " m .
E che l'ultramillenaria vicenda delle cortine turrite, al crollare di quella mitica cerchia, fosse pervenuta ad una soluzione di continuità lo dimostrano i criteri base , assolutamente inediti , che si adotteranno a partire dai decenni successivi. Alla corazzatura lapidea delle mura subentrerà il paramento tenero , in tufo o in mattoni , alla loro compatta massa cementizia la soffice terrapienatura , alle loro ton-i il bastione. Ora essendo tale impostazione totalmente divergente dalle precedenti non fu più praticabile alcun utilizzo delle preesistenti strutture. La
]NGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTI FICAZIONI IN ITALIAmodernissima concezione, che in breve sarà definita la trace italienne, per fornire il suo pieno apporto difensivo obbligava a realizzazioni interamente nuove ed omogenee. Disgraziatamente, però, implicava: " ...costi ... sbalorditivi. Il progetto di cingere Roma con una cerchia di diciotto possenti bastioni fu abbandonato nel 1542 quando si accertò che la costruzione di un solo bastione era costata 40.000 ducati Siena aveva perso la sua indipendenza quarant'anni prima in gran parte perchè i suoi governanti si erano imbarcati in un programma di fortificazioni che non potevano permettersi finanziariarnente ... " <8> Assurdo, pertanto, incrementarne ulteriormente gli oneri demolendo, le mastodontiche fortificazioni tardo medievali! Per cui si adottarono, al riguardo, due opposte tendenze: laddove il loro valore di posizione fu reputato insostituibile le si conservò, racchiudendole in una cerchia bastionata, trasformandole così in cittadelle, ridotti o ricoveri protetti. A rendere tale procedura meno episodica contribuì l'orientamento prevalente ad aggiornare: " ... le piccole fortezze più che [la] lunga cinta muraria delle città come era naturale che accadesse in un periodo di innovazione. Quindi, a subire trasformazioni furono le rocche che costituivano il fulcro delle difese che proteggevano le città italiane... " <9> In tutti gli altri contesti, invece, vennero semplicemente abbandonate al loro destino.

In entrambe le situazioni, comunque, sopravvissero, più o meno fatiscenti, più o meno deturpate, ma mai stravolte radicalmente. Considerando, infine , che nella seconda metà dell'Ottocento si demolirono moltissime cerchie bastionate , specie quelle ormai interne alle città per la loro presunta insignificanza e per il loro concreto ingombro, isolandone perciò la rocca, è facilmente desumibile il prevalere delle opere di transizione su tutte le precedenti tipologie architettoniche.
Nessuna meraviglia, pertanto, che gli esempi relativi siano talmente numerosi ed abbondanti da costringere ad una inevitabile selezione, basata più che sulle caratteristiche strutturali, sostanzialmente sempre simili, sul ruolo storico che la particolare opera sostenne. A rendere possibile questo criterio subentra un fattore in precedenza insignificante e scarsamente attendibile: la
disponibilità delle fonti scritte. Con il XV s ecolo, infatti, la burocrazia iniziò a costituirsi dando origine a carteggi complessi ed articolati, soprattutto in ambito militare. Dal canto suo la progettazione adottò la rappresentazione grafica moderna, con piante, prospetti , sezioni ed assonometrie, corredando gli elaborati di dettagliati computi metrici. Senza contare, infine, che con l'avvento della stampa un gran numero di tecnici avvertì l'esigenza di divulgare e tramandare le proprie conoscenze, fornendo così la chiave di interpretazione oggettiva delle sue scelte. La ricerca storica, perciò, da questo momento cessa di essere deduttiva per divenire analizzati va.
Tuttavia, prima di procedere all ' approfondimento delle fortificazioni di transizione, in base a quanto appena delineato, è indispen s abil e per vagliare la ]oro ottimale connotaz ione una s intesi dei p e rfe z ionamenti conseguiti dall ' artiglieria nella seconda metà del XV secolo.
L'artiglieria dalla compars a alla metà d el XV s e colo
Riuscendo fin troppo ovvio che le gro s se artiglierie d'assedio ebbero facilmente ragione di criteri fortificatori estremamente remoti, ciò che stupisce, di primo acchitto, non è il loro abbandono ma, piuttosto, l'abnorme protrarsi della loro agonia! In realtà , però, la vicenda si dipanò in maniera alquanto più compless a e meno scontata.
Innanzitutto bisogna osservare che, al di là dei rudimentali ordigni brevemente tratteggiati nel capitolo precedente, e della cui concreta efficacia ben poco si sa, l'avvento delJe armi da fuoco fu , per un discreto numero di anni, caratterizzato dalla prevalenza quasi assoluta dei piccolissimi calibri, ovvero delle cosiddette armi ' manesche'. Infatti: " è assai probabile che all'inizio quas i tutte le armi siano state di piccole dimensioni, tanto piccole che un solo uomo poteva reggerle con una mano , mediante un manico, e applicare con l'altra un ferro incandescente al focone.All'occorrenza si poteva piantare il manico per terra, dandogli l ' inclinazione voluta, e
 INGEGNO E PA URA TRENTA SECOLJ D I FORTI FICAZIONI IN ITALIA
171 Bombardella manesca de l X rv sec.
INGEGNO E PA URA TRENTA SECOLJ D I FORTI FICAZIONI IN ITALIA
171 Bombardella manesca de l X rv sec.
dar fuoco alle polveri evitando di assorbire sul corpo il contraccolpo dello sparo. Comunque ci si rese conto assru presto che sj potevano realizzare pezzi d' aitiglieria di dimensioni notevoli, per i quali in Italia si usava di preferenza la definizione di 'bombarde'. Questo tipo di artiglieria, che oggi potremmo definire 'pesante', poteva essere molto utile durante glj assedi, anche se per molto tempo non riuscì a superare in efficacia le catapulte e le altre macchine nevrobalistiche ... " 0 0>
In particolare, le: " .. . armi da fuoco portatili si imposero molto più rapidamente. Meno costose e più maneggevoli delle balestre, benchè non potessero produITe un volume di fuoco equivalente. contro un caval iere corazzato avevano un'eguale efficacia distrutti va "( 1)).
Quindi tra la supposizione del ruolo risolutore della bombarda e la sua concretizzazione già intercorse un discreto intervallo, speso in continue migliorie all'arma ma non alle fortificaz1oni. Una eloquente testimonianza può ravvisarsi nell'originaria vastissima diversificazione dei pezzi, a partire dai metalli impiegati nella loro fabbricazione. Al riguardo occorre fare subito una netta distinzione fra quelle gettate in bronzo e quelle forgiate e, successivamente colate, in ferro. Dal punto di vista cronologico sembrano essere sostanzialmente coeve, sebbene destinale a predominare nel corso della storia alternativamente: le prime fino al XV ll seco lo, e le seconde d'allora in poi.
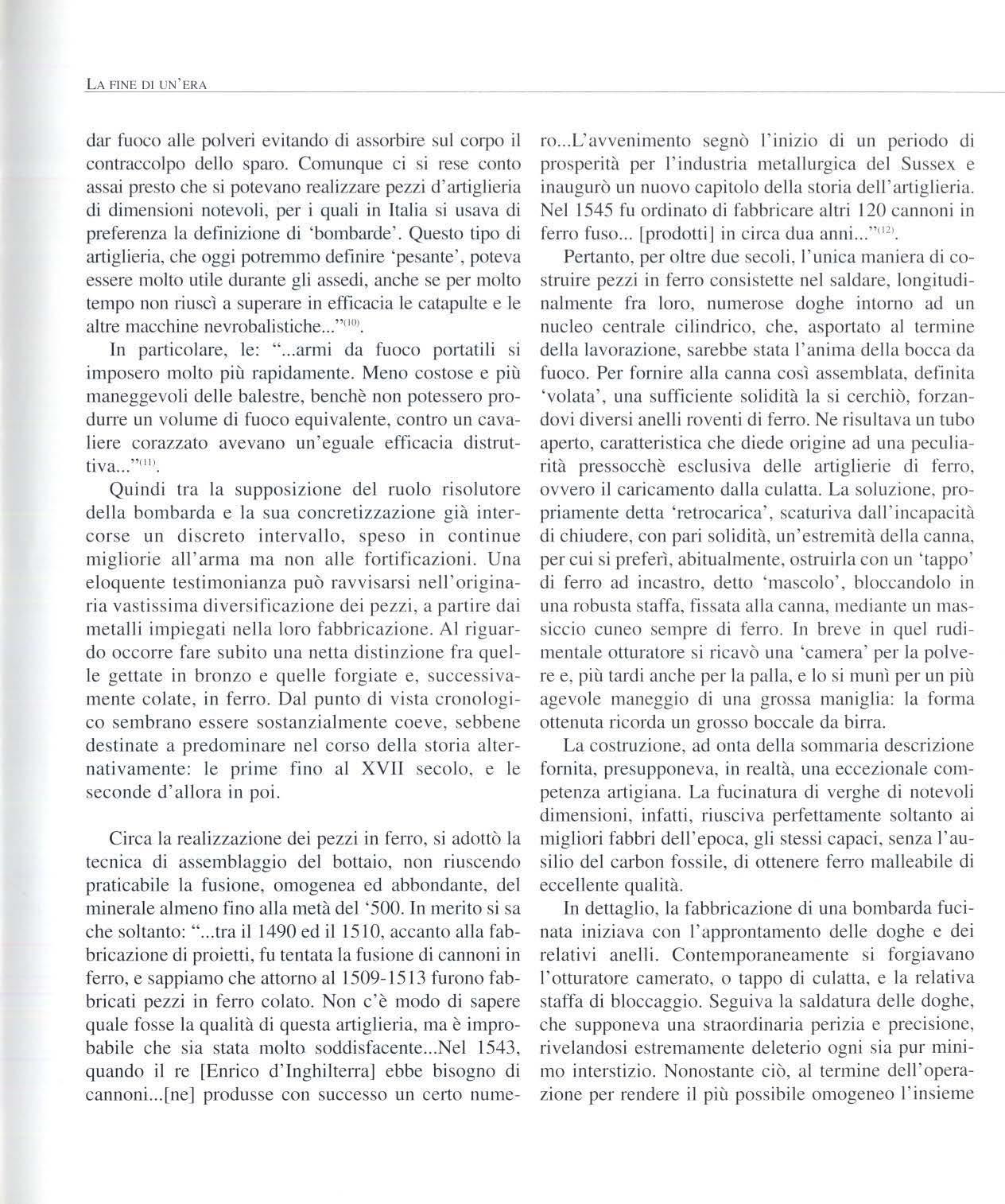
Circa la rea l izzazione dei pezzi in ferro, si adottò la tecnica di assemblaggio del bottaio, non riuscendo praticabile la fusione, omogenea ed abbondante. del minerale almeno fino alla metà del '500. In me1ito si sa che so ltanto : " ... tra il 1490 ed il 1510, accanto alla fabb ri caz ione d i proietti, fu tentata la fusione di ca nnoni in ferro, e sappiamo che attorno a l 1509-1513 furono fabbricati pezzi in ferro colato. Non c'è modo di sapere quale fosse la qualità di questa artiglieria, ma è improbabi le che sia s ta ta molt o soddisfacente .. .Nel 1543, quando il re lEn rico d' l ngh i lterra j ebbe bisogno di cannoni [nel produsse con successo un certo nume -
ro L'avvenimento segnò l'inizio di un periodo di prosperità per l'industria metallurgica del Sussex e inaugurò un nuovo capitolo della storia dell'artiglieria. Nel 1545 fu ordinato di fabbricare altri 120 cannoni in f f L d · j ' ' d · " <Pt erro uso... pro ott1 in circa ua anni....
Pertanto , per oltre due secoli, l'unica maniera dicostruire pezzi in ferro consistette nel saldare, longitudinalmente fra loro, numerose doghe intorno ad un nucleo centrale cilindrico, che, asportato al termine della lavorazione, sarebbe stata l 'a nima della bocca da fuoco. Per fornire alla canna così assemblata, definita 'volata', una sufficiente solidità la si cerchiò, forzandovi diversi anelli roventi di ferro. Ne risultava un tubo aperto, caratteristica che diede origine ad una peculiarità pressocchè esclusiva delle artiglierie di fen-o, ovvero il caricamento dalla culatta. La so luzione , propriamente detta 'retrocarica', scaturiva dall'incapacità di chiudere, con pari solidità, un'estremità della canna, per cui si preferì, abitualmente, ostruirla con un ' tappo ' di ferro ad incastro, detto 'mascolo', bloccandolo in una robusta staffa, fissata alla canna, mediante un mass iccio cuneo sempre di ferro. In breve in quel rudimentale otturatore si ricavò una 'camera' per la polvere e. più tardi anche per la palla, e lo si munì per un più agevole maneggio di una grossa maniglia: la forma ottenuta ricorda un grosso boccale da bi1Ta.
La costruzione, ad oma della sommaria descrizione fornita, presupponeva , in realtà, una eccezionale competen7,a artigiana. La fucinatura di verghe di notevoli dimensioni , infatti, 1iusci va perfettamente so ltanto ai migliori fabbri dell'epoca, gli stessi capaci, senza l' ausilio del carbon fossi le, di ottenere ferro malleabile di eccel lente qua lità.
In dettaglio, l a fabbricazione di una bombarda fucinata iniziava con l'approntamento delle doghe e dei relati vi aneli i. Co ntemporaneamente si forgiavano l'otturatore camerata, o tappo di culatta, e la relativa staffa di bloccaggio. Seguiva la saldatura delle doghe, che supponeva una straordinaria perizia e precisione, rive landosi estremamente deleterio ogni sia pur minimo interstizio. Nonostante ciò, al termine dell'operazione per rendere il pìù possibile omogeneo l'insieme
 l NGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI rn FORTlFICAZl ONJ IN ITALIA
172 B ombar da a rn as c o lo de l Xl V sec . 17 3 De tt ag li o masco lo.
I 74 B om ba rd a in fe rro de l X TV sec .
l NGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI rn FORTlFICAZl ONJ IN ITALIA
172 B ombar da a rn as c o lo de l Xl V sec . 17 3 De tt ag li o masco lo.
I 74 B om ba rd a in fe rro de l X TV sec .
canna, anelli e staffa dell'otturatore, si poneva l'intero pezzo in un apposito forno a riverbero. La temperatura co nseg uibile no n bastava a provoc arne la comp le ta fu sio ne ma solta nto un modesto avvio, formando perciò un a patina su tutta la superficie , ottima per s i g ill are qual sias i fessura.
Un interessante: " ... st udio recente di una bomba rda di c irc a du e me tri di lun g he zza ha fatto e merge re la possibilità di varianti circa il s iste ma di fabbricazione ... descritto. Sembrerebbe c he in quella bombarda le doghe fossero s tate stre tt e, dagli anelJì di rinforzo. attorno ad uno spesso tubo formato da una lamiera avvolta su se stessa.

S e così fosse, ci trnveremmo a ll a presenza di una sofist i cat issima tecnica di cos tru zione, non impossibile de l res to per la capac it à dei fa bbricanti di quel tempo, che sapevano costruire mostri feJTei del tipo di Mon s Meg, pesante 50 quintali, e della D ulle Griette pesante ben 150 quinta li , ancora visibili rispetti vame nt e a l castello di Edimburgo e nella c ittà di G a nd in Svizzera. Nella quasi totalità queste gra ndi bocche d a fuoco erano costituite da due parei: il mascolo e l a ca nna.
Il mascolo cons isteva in una porzione di circa un terzo della lungh ezza cotale de ll 'aima, sfi labil e dalla canna vera e propria ed amovibile per pot e rvi facilmente a llogare la carica di polvere. La palla, di ferro ma più spesso di pietra, veniva posta nella parte posteriore della canna: s i aveva cos ì una rudimental e retrocaiica. Il masco1o aveva se mpre una sez ione es terna ed int e rna i11feriore a queJla della canna, pur avendo pareti più spesse per meglio resistere allo scoppio deJla polv e re. La canna, o cannone, restava fissa sul ceppo di legno che fungeva da affusto, me ntre il mascolo ne veniva totalmente rimosso con l 'aus ilio di argani, se molto pesa nte " ll 31
Le artiglierie in fe rro cerchiato a retrocarica, nonos tante la loro rudimentale co nc ez ione, fornivano alcuni vantaggi fun?.ionali c he s i dimostrarono talmente convenienti da prolungarne l 'adozio ne fino al secolo XIX. Tra que s ti , in particolare. la possibilità di ricaricarle se nza estrarre la volata dalle cannoniere, dettag lio utili ss imo neg li ambienti molto ri st retti, conve-
ni enza che si accentuò allorquando anche il proietto fu posto nella ca m era. Onde evi tare c he durante l'inse rim e nto del mascolo nella c ul atta fuoriuscissero la polvere e l a palla, spesso sostituita da frammenti di fe1To o di pietra, da cui il nome di 'petriero' al pezzo, se ne c hiud eva la camera con un tenero diaframma di legno. Grazi e a quel se mpli ce accorgimento la bombarda a retrocarica poteva perciò tirare anche con forti a ngoli di depressione, prossimi alla normale, a differenza di qual s ias i altra bocca d a fuoco, riu scendo così a 'spazzare' efficaceme nte il piede della fortificazione con una micidiale mitraglia. Per sfruttare a pieno tale prestazione i petrieri vennero sospesi in una forcella, o 'braga', fissata a sua volta su di un caval let to, c he g li co nse ntiva un 'ampio basculamento. In o ltre, disponendo ciascu n pezzo, normalmente, di almeno tre masco li precaricabili. era agevol e sostit uirli rapidamente, dopo ogni colpo. incrementando l a cadenza di fuoco, fino a cinque volte quella d e ll e norm a li a rt iglierie. Scriveva nel 1621 il Sardi nel suo celebre trattato al riguardo:
·'Si trovano ak:uni Pezz i che si dicono a Braga, quali si caricano con i scrven tori, o vero Mascol i ; quest i si usavano anticamente di fcn-<> battuto et in questi nostri tempi si usano di ferro e di Bronzo p uro Ma molto diffe renti da que lli an ti c hi nella grandèzza. e portata d i palla. perchè anticamente si usavano che tirava no ce nto e più libre di palla di Pietra. tutte di Ferro battuto, come ne ho vedute due nella città di Gantes lsi tratta del la To ll e Grete di Gand] in Fiandra. in una piazzetta vicina alla gran Pia7,7a, di s tese in terra scavalcate con i suo i Ma~coli. tanto smi s urata una cli quelle. che ogni grosso homo sar ia potuto passar per dentro la sua canna, benchè r a lt ra non fosse tanto smisurata
Et la Serenissima e Potentissima R epubb li ca di Yent tia s opra le sue Galere, ed altri Va-;seli, oltre ag li a ltri smisurat i peLZi di cinquanta e sessanta libre di Pa ll a di ferro. dispensa per armargli buon num ero di questi tali Pezzi, ma molto più gagl itmli e rinforzat i, ricchi di Metallo. et di Canna più lunga , che i Provenziali.
Questi non s i cav a lcano sopra a Ru ote. ma sopra a lcuni gro s si ferri a forcella. ficcati sopra il Bordo del Yassel lo. di maniera che con una co d a lunga cli ferro di dietri alla Braga s i possono volgere et girare da qual parte r uomo vuole. con molta facilità e pres tezza.
Tirano Balle di Pietra; et spesso si caricano con Pezzetti di Ferro, et scaglie di Pietra, et catenette. e nello abbordare i vasselli le sca1icano con grande mortalità, et danno dei nemici.
Si caricano con i suoi Mascoli di Bronzo. e di l'e1TO. et p,ima di mettere per di dietro la Palla, si mette un buon Boccone (stoppaccio) e Coccone di legno dolce, e per di dietro si fa tener forte alla Braga con buoni cugni di Ferro. e deve il Bombardiere quando dona il fuoco. satre a parte. e non di dietro immediate per ogni buon rispetto. et i Mascoli doveriano essere per lo meno tre per ciascun pezzo per non dar tempo al nemico di riposo, pcrchè nella prestezza el numero grande di tiri consi~te il Fatto.
Tali Peni in difesa di castelli. Torri. Frnti e simili, contro battaglie cli mano et scalate, non ponno fare se non grandissimo effetto. dispen s andogli ai fianchi, quantunque piccoli. et altri luoghi, o posti convenienti. "o1, ,
A fronte di tanti vantaggi, che rendevano il petriero sostanzialmente simile ad una grossa lupara, il difetto principale era rappresentato dalla scarsa tenuta dei gas al momento dello sparo. Ne conseguivano da qui l'avvertimento del Sardi a non porsi immediatamente dietro al mascolo ampie sfiammate e, non di rado, violente rotture della staffa. Per contenere al massimo quei temutissimi incidenti, la carica di lancio di siffatti pezzi si mantenne sempre notevolmente inferiore a quella deJle bombarde di bronzo tradizionali di pari calibro, la cui costruzione fu, comunque, di gran lunga più semplice, sia per il minor punto di fusione della lega e sia per la ultramillenaria esperienza sul getto. ed il maneggio più sicuro.
Non a caso, ed è per molti versi paradossale, i primi costruttori di pezzi in bronzo furono gli stessi artigiani che producevano le campane. In pratica: " I' artiglieria di bronzo fuso comparve molto presto, e incontrò subito grande favore, non solo perchè il bronzo è meno soggetto alla corrosione, ma anche perchè il procedimento di fusione rendeva possibile la fabbricazione dì cannoni ad avancarica ed eliminava così tutti i pericoli e le difficoltà connesse con il problema del l'otturazione posteriore. Quanto al l'aspetto economico dell' alternati va. non c'è dubbio che come materia prima il ferro costava molto meno del bronzo. Tuttavia , sino a
quando non si sviluppò la tecnica per colare canne cli ferro resistenti, l'alternativa rimase tra bronzo fuso e feITo battuto. Ora, il procedimento di fucinatura assorbiva più lavoro e di conseguenza costava di più di quello di fusione. La differenza tra i prezzi finali si riduceva quindi notevolmente. Benchè si continuasse a costruirne, i cannoni in ferro battuto vennero sempre più considerati come un malagevole ripiego.
Il rame , la materia prima fondamentale per la fabbricazione dell'artiglieria in bronzo, proveniva principalmente dall'Ungheria , dal Tirolo, dalla Sassonia e dalla Boemia. Lo stagno, il metallo che va unito al rame, proveniva principalmente dall'Inghilterra, dalla Spagna e dalla Germania. Quantunque le materie p1ime provenissero da un limitato numero di regioni, la fusione dei cannoni in bronzo veniva praticata quasi dovunque da artigiani che non avevano alcuna difficoltà ad alternare la produzione di campane con quelle dei cannoni e viceversa. Ques ti artigiani lavoravano su commissione o venivano ingaggiati per determinati periodi di tempo. Più tardi furono anche creati arsenali governati vi più o meno pcrmanenti ' 15 ' dove i cannoni venivano fabbricati da personale qualificato stabile o da esperti assunti temporaneamente. Bisogna aggiungere che a quell'epoca la divisione del lavoro fra artiglieri e fonditori non era sempre ben definita e molto del lavoro di fusione era in realtà svolto da artiglieri che prestavano regolare servizio negli eserciti " 111 ''
L'enorme richiesta di artiglierie in bronzo provocò una fortissima domanda del metallo: basti considerare che per oltre tre secoli il termine metal lo definiva per antonomasia il bronzo. ln pochi decenni gli approvvigionamenti di rame, di stagno e dì z inco: " ... assunsero un'importanza critica per i signori d ' Europa. E quando le nuove artiglierie si diffusero anche in Asia ebbe inizio la seconda età del bronzo
A rigor di termini ... la seconda età del bronzo non ... lduròJ neppur un secolo (1453 - 1543) lma] modificò radicalmente l'andamento delle economie: per esempio accrebbe a dismisura l'importanza delle miniere di rame e argento dell'Europa centrale, come s ta a dimostrare l'esplosione di prosperità che sul finire del quin-
 INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICA Z IONI I N ITALIA
INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICA Z IONI I N ITALIA
dicesimo secolo investì la Germania meridionale, la Boemia e le regioni adiacenti. e come dimostra anche l'impero finanziario creato dai Fugger e da altri banchieri tedeschi-meridionali ... Arrivò però il momento in cui la sm.tituzione dei peui in feITo a quelli in bronzo e in ottone determinò la crisi della prosperità mineraria ... " , il•.
Dal punto di vista esecutivo la realizzazione dei cannoni in bronzo prendeva l'avvio dalla formazione di uno stampo. Questo " ... veniva ottenuto avvolgendo attorno ad un nucleo di legno trecce di paglia su cui veniva spalmato uno strato di argilla, polvere di mattoni e grn...,so per rendere plastico il miscu lgio. Mentre alcuni operai giravano su se stesso il nucleo, appoggiato su icfont'i supporti. altri ne formavano il profilo servendosi d1 :-.agome gil1 pronte. Su questo finto cannone veni\a formato lo :-.lampo, a segmenti separati che veni vano successivamente uni li e solidalmente trattenuti tra loro da un· i ncastcllatura di bande di ferro. Al centro di questo stampo sì infila\a un nucleo cilindrico che, una volta raffreddala la fusione e rimosso, lasciava il vuoto della canna. Lo stampo, o gli stampi per la fusione contemporanea di più pezzi, venivano infilati verticalmente in buche nel terreno e lo spazio tra l'uno e l'altro ben costipato di terra. Occorrevano alcuni giorni perchè la fusione si raffreddasse, dopodiché si provvedeva alla rimozione delle forme e si estraevano le bocche da fuoco che venivano pulite, lisciate. lu cidate, mentre l'anima poteva anche essere alesata con macchine idrauliche ... "•1 ~'.

Circa il muni1.ionamento di quei cannoni, sia in ferro che in bronzo. come incidentalmente accennato più volte, si utilizzavano palle di pietra calcarea, meno frequentemente- di granito. Va precisato che non esistendo una ngida unificazione dei calibri, in pratica ogni cannone richiedeva una sua palla, incongruenza chè ne rendeva estremamente complicato l'approviggionamcnto. Quanto fosse difficile destreggiarsi tra sfere appro~simativamente identiche lo dimostra che, fino all'avvento dei proietti cilindro-ogivali. il calibro
non designava il diametro dell'anima del pezzo ma il peso della palla, di più facile accertamento. Pertanto, uno stesso cannone quando tirava palle di pietra aveva un calibro pari ad un terzo di quando tirava palle di ferro! In fase cli costruzione gli sca lp ellini valutavano la dimensione delle palle mediante una coppia di crivelli, rispettivamente uno di poco più grande del necessario e l'altro invece di poco più piccolo: la pietra doveva perciò passare il primo ed arrestarsi al secondo. Intuibili le approssimazioni geometriche: ovvio che per compensarle si lasciasse fra la palla e l'anima una notevole tolleranza, definita 'vento', che si cercava, in fase di caricamento, di ridurre mediante l'interposizione di slracci fungenti da guarnizione. Intuibili, pure, le ragguardevoli perdite di compressione e la conseguente fiacchezza dei tiri.
Scriveva, ad esempio, a ridosso del 1480 Francesco di Giorgio Martini circa le bombarde:
"È da sapere che le macl'hinc delle bombarde con più varie e diver'ie misure e forme ~i fanno. Anco è da vc:dere di che materia sieno... La bombarda dia e~~erc Ji rame o dì ferro fatta, quantunque el più di brorvo ~ieno, e queste più facilmi.::nte si rompano: per la corruzione della materia frangibili sono. E quando di rame sieno. essendo tenacissimo, per qualche strano caso o incovcnicntc si speZLeranno ... E perchè ciascuna di yucste misura richiede. è da sapere che quando le bombarde. spingarde e cerbottane piLr Jonghe sono. tanto più con furia e lontan gilla. e massime la tromba sua col cannone a e~~a conveniente. Poniamo sia una bombarda che tragghi di pietra lire (libbrej cento. eJ cannone ~uo non dia essere manco di pietre due Idue diametri della palla di lunghea.aj. e la tromba d·cssa pietre cinque. Sia una che la pietra di dugento pesi, el cannone due pietre e mezzo è da fare e la tromba cinque e mez70 E quando la tromba di troppo pondo fosse. a vite di più pezzi far si puè,. Anco è da !>aperc che I i I cannoni la quinta parre più stretti in fondo che in bocca e a forma di piramide son da fare E la bocca d'esso cannone in suo diametro el quarto del diametro della tromba overo el ter1.o. E molti sono che la quinta parte fatto l 'hanno. " " '''
Per l'illustre tecnico, quindi, i cannoni sono ancora composti di due parti assemblate insieme, con diametri diversi e configurazione conica, molto simili a quelli dell'inizio del X IV secolo, destinati a scagliare esclusi-
vamente palle di pietra. Epp ure, ad onta di tanta arcaicità, quei pezzi avevano già raggiunto sign ifi cative velocità di lancio, come dalle parole dello stesso autore s i può inequivocabilmente riscontrare:
"E certamente tutte le altre macchine all/iche per cagione di questa potentissima chiamata bombarda vane e s uperflue si possono appe ll are; lo impeto della q uale solo a chi con li sensi lo comprende è credibile, perochè più veloce è el moto della pietra impul sa da quella che del orrendo s trepito da quello causaro alle urecchie dell i c ircus t anti " ;w,
Nella st o ria dell'uomo quei proi etti avevano s uperato per l a prim a volta la 'barri era d el suo no ', ovvero i 340 rn/sec. Ma s i trattava dell'unico ap prezzab il e progresso per arn1i che esistevano ormai da quasi due secoli!
Sensato perciò s timare che anche per neutralizzare tale potenziamento sare bbe ba s tato un ulteriore incremento degli spessori d elle fo rtifi cazioni ed una maggiore inclinazi o ne delle loro s upe rfici esposte . Il c h e fu, per l'ennesima vo lt a, prontamente attua to.
Ne ll ' ultim a metà d e l XV seco lo una se n e di pe rfez ion amenti , s in go larment e già da anni adottati, venne ro applicati tutti contemporaneamente a ll e ar1iglierie frances i, determinandone un improvviso salto tecnologico, assolutamente inimma ginabil e fino a quasi pochi mesi p1ima. L 'e quilib,io fra offesa e difesa, fa ticosamente 1incorso dall a trans iz io ne, fu annienta to ed il canno ne div e nn e d a qu e l mom ento una terribil e macchina esotermica per demoli zio ni a di stanza. Ecco in dettag lio i punti qualificanti della rivolu z ionaria mutazione. Innar1zitutto il si stema di costruzione di artiglierie in doghe cerc hiate ve nne quasi completamente abbandonato, riservandolo ad una mode s tiss ima tipologia s pecializzata, a favore d ei pezzi monoblocchj genati in bronzo. Del res to i vantaggi offerti dal bronzo non s i limitavano alla minor temperatura di fu s ione ed alla pass ivaz ion e alla corros ion e, ma in s is tevano , prioritariame nte, s ull a sua
maggiore elasticità alle sollecitazioni, dalla quale, in ultima analisi, scaturiva Ja caratteristica sonorità delle campa ne . Questa basilare peculiarità rese i cannoni di bronzo, anche nei secoli successivi, sempre superiori a quelli di fe1TO colato, più fragili e pe1ico]osi per c hi li adoperava . Conoscenze più precise sulla proprietà e sul corn prnta rn ento del metallo avevano po1tato a ll'indi vidu azio ne di leghe co n titoli più idonei al gravoso impiego, sebbe ne, ancora nella prima metà del XV seco lo, la tecnica del getto non si discostasse, sensib ilmente, d a quella adottata per le ca mpa ne.
Come accennato, il metallo liquido ,rndava a colmare un a matrice provvista di ·nocciolo·, originando una sorta di tubo c hiu so ad un a estre rnità. Tal e procedura provocava, inevitabilmente. una a ppro ssimata coassialit à fra le pareti interne ed esterne delle bocche da fuoco, oltre naturalmente ad una più o meno grave cavitazione dell'anima. Ne derivavano anomalie funzionali c he decurtavano vistosamente l'efficienza dell 'arma, minandone pericolosamente l a tenuta a l cimento dinamico e privandola di una precisa punteria. Qu est'ultimo difetto, c he nei casi più gravi rendeva inutilizzabile la bocca da fuoco , si orig inav a dal fatto c h e la mira veniva presa traguardando una copp i a di risalti posti sopra la vo l ata del cannone in corrispondenza della 'g ioia di bo cca' e di 'cu l atta', ri nfor zi applicati alle sezioni più tormentate. Ora esse ndo la superfici e esterna non coassial e a quella interna, la linea di mira divergeva da que ll a d ella traiettoria dei proietti. l trattatisti del XVI secolo c hi a ma va no qu ei tiri 'costieri · cioè di cos ta , di fianco, ovvero di var-ica ti rispetto alla direz ion e del pe zzo La disfunzione che in effetti affliggeva , sebbe ne in misura di ve rsa, tutti i cannoni d e ll' epoca, in fase di co llaudo, se di piccola entità, s i compensava alla meglio, ma l a punteria restava comunque compromessa.
A partire dalla seconda metà del XV secolo , s i iniziò a co lar·e il bron zo in forme prive di noccio lo. Preca u z ion e abituale consisteva nel posizionarle con la bocca verso l'alto , onde aumentare l a d ensità del m eta llo in 'culatta', scong iurando così il formarsi di cav ità in quella parte c ritica. I pezzi ottenuti erano quindi co mpl e tame nte pieni. per cui l 'an ima s i ricavava pe r trap ana-
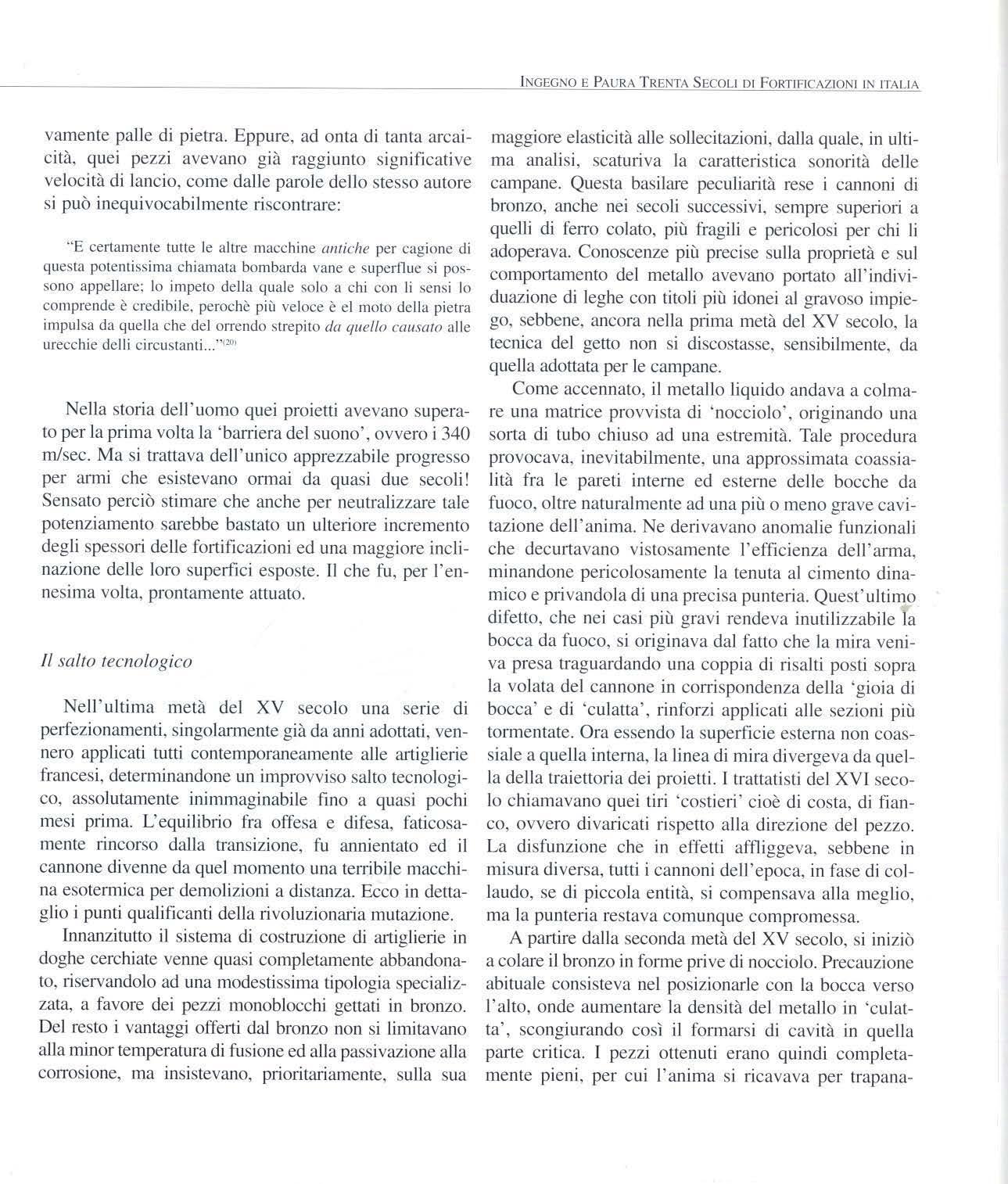 INGEGNO I: PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFIC/\ZlONI IN ITALIA
INGEGNO I: PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFIC/\ZlONI IN ITALIA
zione mediante apposite alesatrici idrauliche. Una conferma in merito si riscontra allorquando: " ... nel 1479, il 27 di ottobre, un tale Paolo Niccolini, del contado lucchese, espone ai Magnifici Signori Anziani e Gonfalonieri di Giustizia di Lucca: «corno lui intenda fare uno edificio da trapanare spingarde ad acqua in nel Comune di S. Quirico a Petronio». ''(2 1' I maggiorenti, apprezzata l'uti lità della macchina, perciò già ben nota, diedero parere favorevole e relativa licenza.
Di analoghe macchjne, peraltro, se ne rintracciano alquanti disegni nei codici di Leonardo, come pure nei taccuini di altri tecnici deU 'epoca. In breve iI proced imento ili venne canonico per tutti i tipi e calibri di aitiglierie.

Il cilindro generato dall'alesatrice, oltre ad una assoluta regolarità geometrica risultava anche perfettamente coassiale poichè, abitualmente, non era l ' utensile a ruotare ma l'intero pezzo , fungendo in tal modo da volano: estremamente semplice, quindi , controJJarne il centraggio con appositi traguardi fissi.
Grazie alla precisa lavorazione la tolleranza fra proietto ed anima poteva di conseguenza ridursi, favorendo e provocando, l'utilizzo di palle a loro volta geometricamente regolari, quali so lo una fusione in stam pi garantiva. Ed appunto, proprio in quegli anni comparvero i proietti s ferici di ferro, spesso temperato. L ' impiego generalizzato per tutti i calibri anticipa di poco la calata di Carlo VIII del 1494. Non a caso molti storici militari sono portati ad attribuirne J' invenzione agli artiglieri francesi, ma le palle di ferro non erano, anche in questo caso, una novità assoluta, pur apparendo tali per la rapidissima diffusione. Già da diversi decenni, infatti, i piccoli calibri le utilizzavano correntemente. In particolare: " le pal le di ferro e di piombo non erano ignote in Italia, e anzi alcuni dei primi cannoni usati nel Trecento avevano sparato proietti del genere, ma si era trattato sempre di palle piccole. I cannoni pesanti del Quattrocento s paravano tutti palle di pietra che venivano o trasportate insieme ai
pezzi o apprestate sul luogo da tagliapictrc ... Le palle potevano essere del peso di 150 chi Ii di qui si capisce che il problema di mettere a punto un· artiglie1ia mobile ed efficiente non era affatto legato [soltanto J alla fabbricazione dei cannoni .. .'' 1 '
L·introduLione della palla di ferro ehbe immediate ripercussioni sulla loro produzione che superò. finalmente, l'anarchia vigente determinando l'esigenza della standardinazione dei calibri. premessa per approvvigionamenti abbondanti a costi unitari inferiori. Dal punto di vista balistico, grazie sempre alla palla ùi fen-o, la violenza del tiro subì un formidabile incremento. Che la portata dell'innovazione sia stata recepita nella sua piena conseguenzialità si evince facilmente datranalisi strutturale dei cannoni dell'epoca: quasi lutti ostentano un vistoso aumento differenziato degli spessori della canna in funzione delle accresciute sollecitazioni assumendo la configurazione rastremata che da allora non avrebbero più dismesso.
Ma il vero salto di qualità si manifestò negli investimenti ossidionali. nei quali la palla di fetTo sostituiva quelle gigantesche di pietra, eliminandone drasticamente le inadeguatezze. Prima fra tutte rinLrinseca fragilità di siffatti proietti che costringeva a limitare le caiiche di lancio per evitarne la frantumazione nell'anima. Il che non evitava, però, una jdentica frantumazione in minutissime schegge al momento dell'impatto, di scarsissimo danno per le murature rivestite di grossi conci di duro basalto o cli granito. Per rimediru·e all'esasperante deficienza gli espedienti non erano mancati, tra i quali quello di cerchiare le palle con anelli di fen-o, soluzione che in pratica serviva solo ad usurare maggiormente la bombarda ed al pari delle consimili si dimostrò di dubbia efficacia.

Va ancora osservato che la bassa densità delle palle di pietra, la loro necessariamente modesta velocità iniziale e l'assenza di rotazione. causavano delle traiettorie poco stabili, per cui bastava una leggera inclinazione delle superfici battute per deviarle decurtandone fortemente la già scarsa energia cinetica residua. Si risapeva, infatti, empi1icamentc da oltre un secolo che
rimpatto era tanto più violento e devas;tante quanto più il suo angolo d'incidenza si avvicinava alla perpendicolare. Come pure, e sempre empiricamente. che ammetteva un valore limite al di -:otto del quale il proietto rimbalzava, e che la dure/La de1t·estradosso del bersaglio lo accentuavano. Tanto per esemplificare, per le moderne artiglierie contro il cakestn11.Lo è di circa 30° e di 40° contro le blindature metalliche, ovviamente con proietti ogivali ruotanti '''' . Con proietti sferici, relativamente lenti, i valori scendono ulteriormente: ciò ~piega il perchè. almeno ini7ialmentc. il rimbalzo o la deviazione delle palle di pietra rappresentasse la neutrali7Zazione per anlomasia degli impatti.
Con le palle di fen-o !' energie cinetiche residue registrarono un enorme incremento . Fu la conseguenza delradoLione di cariche di lancio polen;,.ìale. della maggiore accelerazione dei proietti per la supe1iore compressione consentita dalla riduzione del ·vento·. e della uipJjcata densità degli stessi. La concornitann1 delle tre concause fornì ri~ultati sbalorditivi. per cui in breve: '·...i fonditori di cannoni delle Fiandre e della Francia avevano ... scoperto che anni molto più piccole potevano anecare gli stessi danni di bombarde tre vo lte più grosse se so lo si fossero rese le canne ahbastanLa resi-:tenti da lanciare, invece di pietre, palle di ferro con fuoco di batteria... "' 2~> E cannoni molto più piccoli significavano più numerosi a pmità cli costo. più facili da Lrasportare e pit1 leggeri e rapidi da maneggiare. All'identico risultato contribuì un·altra innovazione divenuta. in quel medesimo scorcio storico, di uso universale nelle artiglie1ie: quella dei cosidetti ·orecchioni·.
Erano questi i supporti trasversali, gettati in s ieme al pezzo, che ne permettevano il bascol amen to, oltre ad un più razionale e solido incavalcarnento sull'affusto. La rotazione della canna nel piano \'erticale, definita comunemente ·aJzo', è quella c he, in pratica, com.ente di vaiiare la gittata del cannone, variando la c.; ua inclinazione: da quella minima con angolo di O°, a quella massima teorica con angolo di 45°. Fino ad allora, so ltanto inclinando l'intera imbracatura alla quale era
LNGEG\O 1:-. P.-,LRA TRE:--JTA Sr·çou oi F01{J llKAL10N1 IN 1rA1 ' "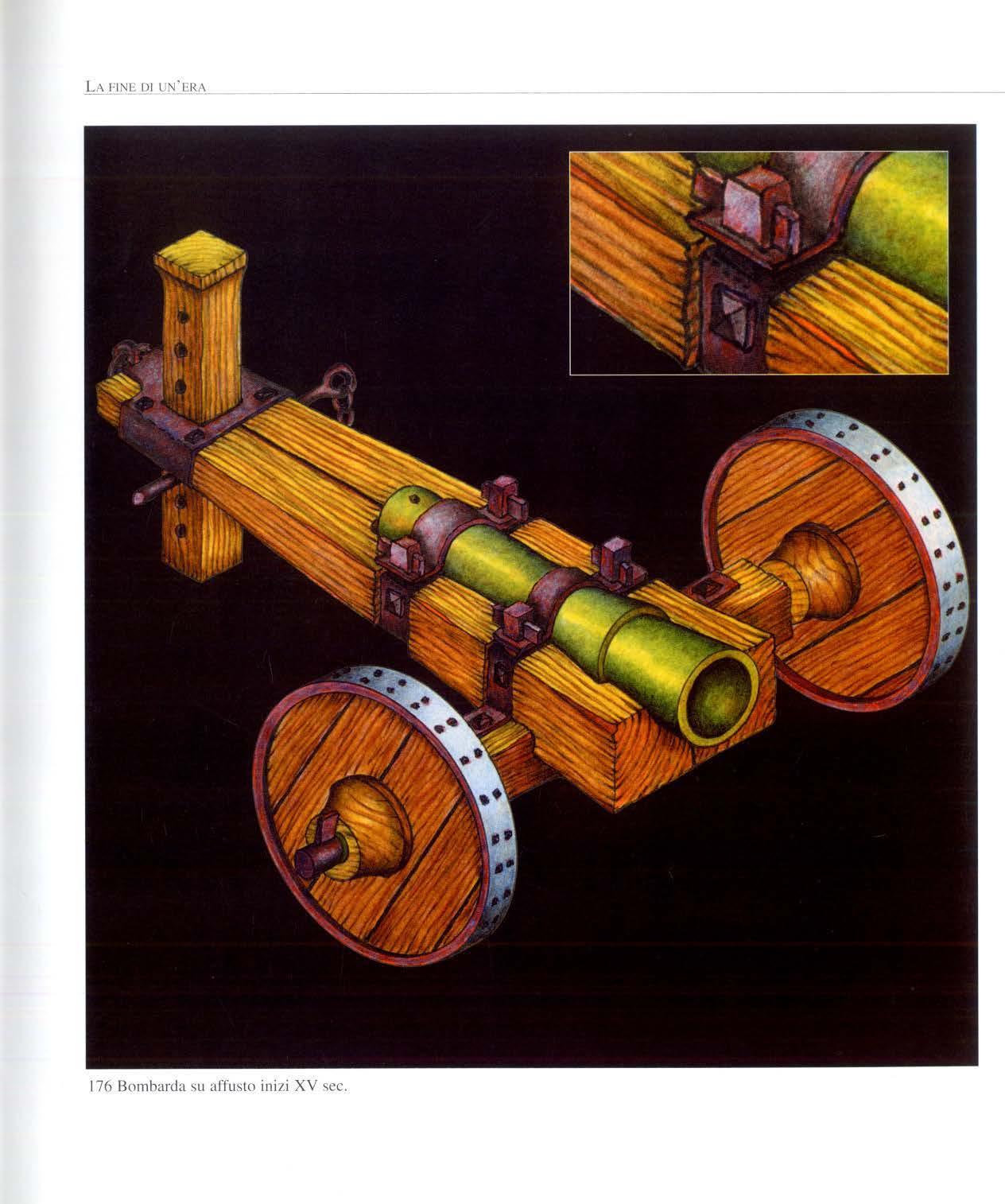
avvinta la bombarda, si perseguiva il medesimo scopo, con quante difficoltà, lentezze ed imprecisioni, è però facilmente immaginabile,
Dal punto di vista geometrico gli orecchioni si innestarono in conispondenza del baricentro del pezzo, avendo cura di lasciare una leggera preponderanza in culatta, quanto bastasse per mantenerlo, anche con lievi inclinazioni dell'affusto. stabile su di esso, Una pari stabilità, ma in fase dinamica, venne conseguita abbassando l'asse degli orecchioni Lispetto a quello dell ' anima, rendendone quasi complanari le rispettive supe1fici. Si ingenerava, pertanto, al momento dello sparo una coppia di reazione, dal basso verso l'alto, che inchiodava la culatta contro la robusta traversa sottostante, più spesso un cuneo , rendendo il complesso affusto-cannone rigidamente solidale. Ne risultava, così, del tutto soppressa ogni deleteria oscillazione che altrimenti avrebbe inficiato la punteria. Al contempo si smorzava la corsa retrograda dell'arma, propriamente detta ' rinculo', scaricandosi una consistente :frazione dell 'energia cinetica di reazione verticalmente, tramite l'affusto, sul terreno.
Una magistrale esemplificazione di quel basilare perfezionamento può ravvisarsi negli splendidi cannoni gettati da Sigismondo Alberghetti, per la Repubblica di Venezia. I loro orecchioni sono perfettamente idonei allo scopo sia per consistenza meccanica sia per posizionatura, garantendo infatti la preponderanza di culatta e la stabilità di tiro.
Sempre nel quadro di radicale pe1fezionamento e potenziamento dell'artiglieria non sfuggì, alla vasta rielaborazione, anche la sua componente più spiccatamente attiva, ovvero gli esplosivi, e la maniera di confezionarli per l'impiego balistico. A partire daJla metà del XV secolo si produssero e si diffusero le polveri granulari che consentivano una deflagrazione ottimale con pressioni specifiche di gran lunga superiori alle precedenti, a parità di peso. Il fenomeneo dipendeva dalla: " più rapida combustione; dal momento che le superfici esterne dei grani potevano prendere fuoco nel medesimo istante, rendendo più potente la detonazione grazie al minor lempo di passaggio (e quindi minor
dispersione) dei gas rapidamente combusti in accelerazione intorno alla palla e lungo la canna... " (25 >
Persino il dosaggio deJle componenti delle polveri divenne sufficientemente costante, e meno scriteriato, differenziandolo in funzione dello specifico impiego. in stretta correlazione con i calibri. Verso la fine del secolo si osserva una riduzione percentuale del carbone nelle miscele esplosive, ennesima conferma della aumentata energia potenziale impiegata, ed un accurato dimensionan1ento ponderale delle cariche di lancio in rapporto alla massa dei proietti. A dimostrare la rilevanza di quella che apparentemente sembrerebbe una ovvia disposizione, basti considerare che la maniera più spiccia fino ad allora utilizzata per aumentare la gittata consisteva nell'aumentare la quantità di polvere!
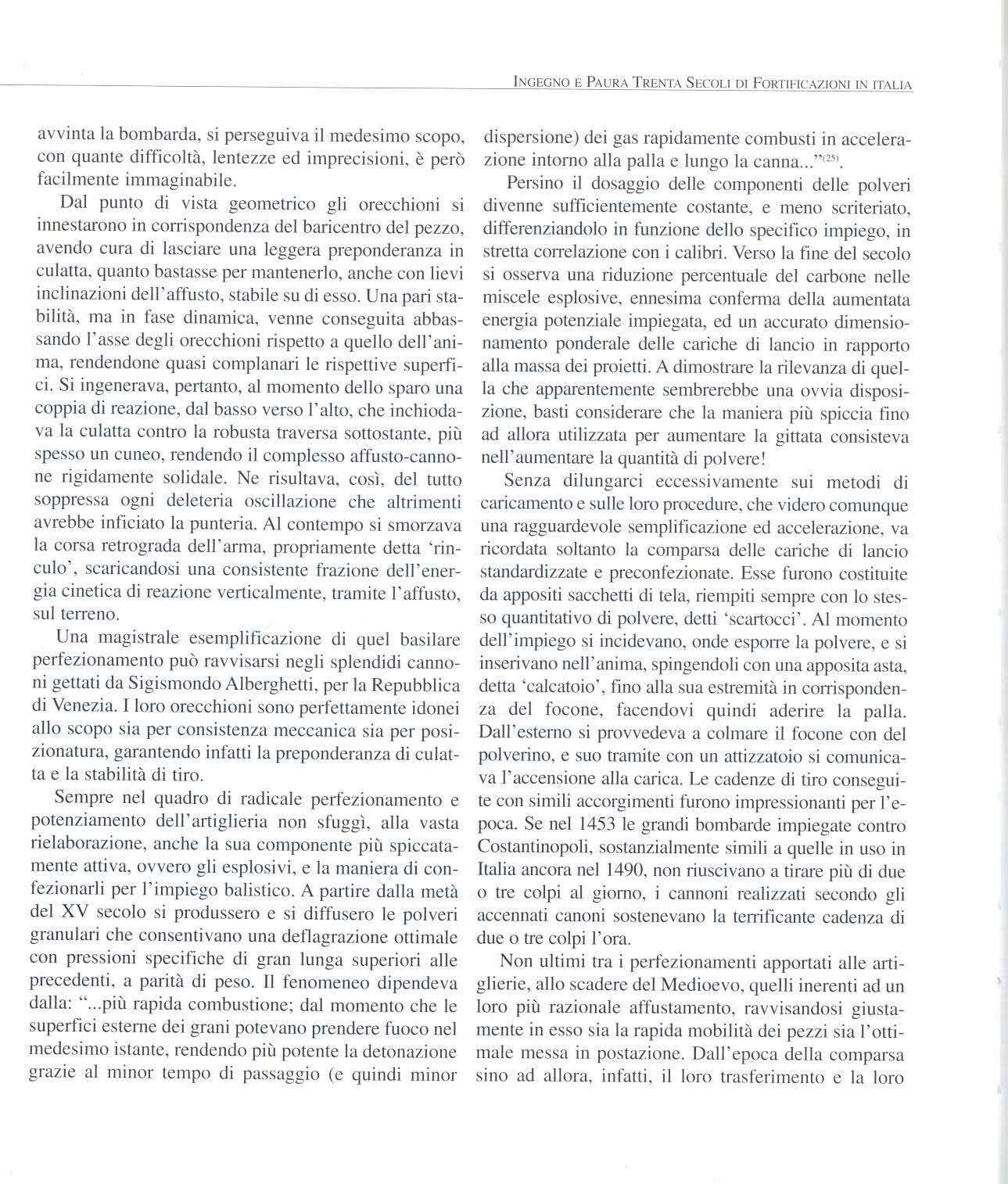
Senza dilungarci eccessivamente s ui metodi di caricamento e sulle loro procedure, c he videro comunque una ragguardevole semplificazione ed accelerazione, va ricordata soltanto la comparsa delle cariche di lancio standardizzate e preconfezionate. Esse furono costituite da appositi sacchetti di lela, riempiti sempre con lo stesso quantitativo di polvere, detti ' scrutocci'. Al momento dell'impiego si incidevano, onde esporre la polvere, e si inserivano nell ' anima, spingendoli con una apposita asta, detta ' calcatoio', fino alla sua estremità in corris pomlenza del focone, facendovi quindi aderire la palla. Dall'esterno si provvedeva a colmare il focone con del polverino, e suo tramite con un attizzatoio si comunicava l'accensione alla caiica. Le cadenze di tiro conseguite con simili accorgimenti furono impressionanti per l'epoca. Se nel 1453 le grandi bombarde impiegate contro Costantinopoli, sostanzialmente simili a quelle in uso in Italia ancora nel 1490, non 1iuscivano a tirare più di due o tre colpi al giorno, i cannoni reali zzati secondo gli accennati canoni sostenevano la terrificante cadenza di due o tre colpi l'ora.
Non ultimi tra i pertezionamenti apportati alle artiglierie, allo scadere del Medioevo, quelli inerenti ad un loro più razionale affustamento , ravvi s andosi giustamente in esso sia la rapida mobilità dei pezzi sia l' ottimale messa in postazione. Dal!' epoca della comparsa sino ad allora. infatti, il loro tra sferimento e la loro
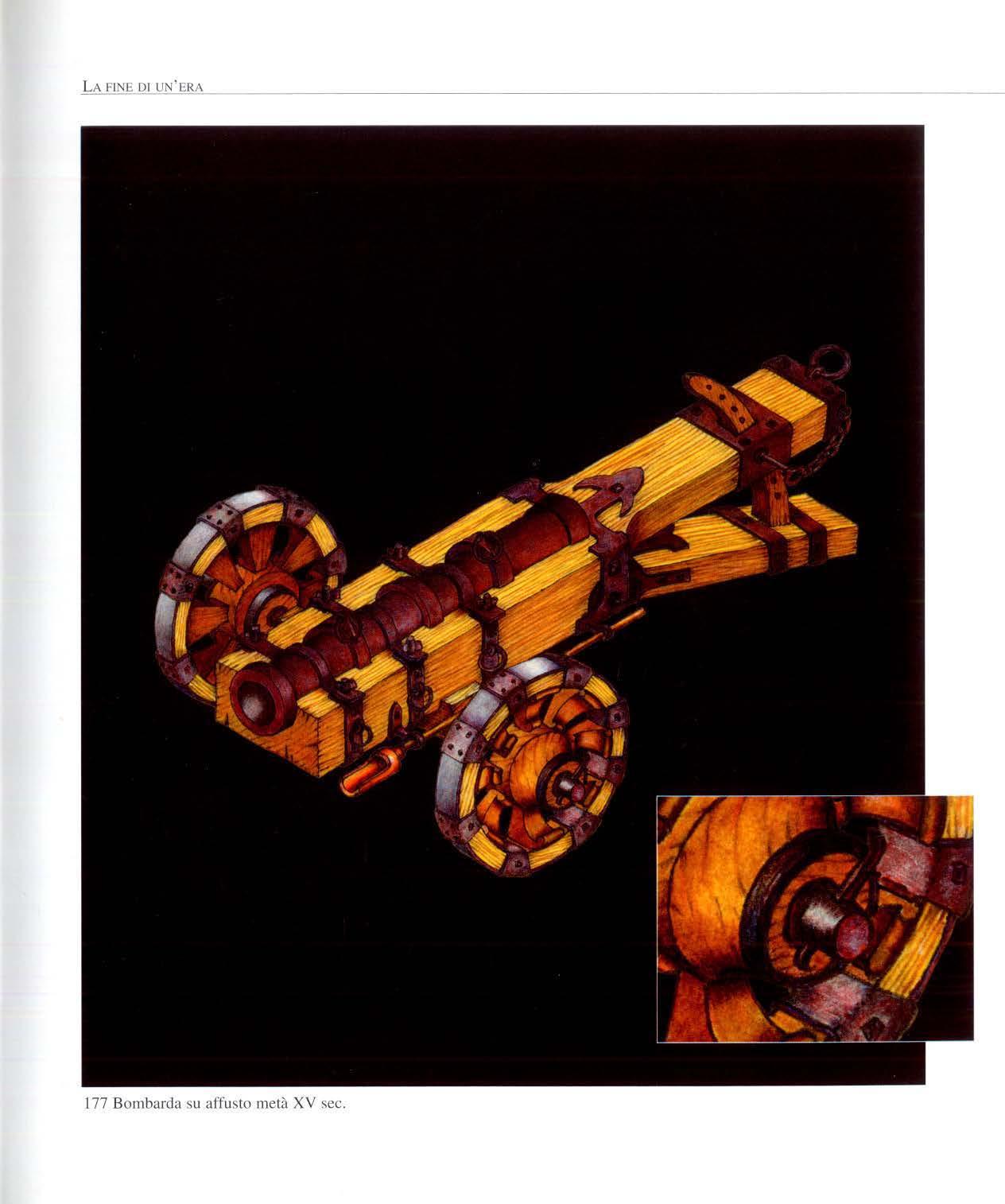
178 Aornbarda a doghe di ferro su affu~to statico del XV scc:.
movimentazione in batteria erano stati attuati <.:aricandoli .,cmplicernente su delle normali carrette. posizionandoli alla men peggio. una volta giunti a destina,ione, con ceppi, cunei e funi su rudimentali culle di legno. Con l'introduzione dell'affusto a ruote per bocche da fuoco dotate di orecchioni, schematicamente composto di due robuste travi, assoni, distanz.iate da traverse, ca/mtrelli. quanto bastava per accoglierli. oltre a risolversi il problema esasperante del trasporto, lento, logorante cd onerosissimo. si disponeva, in qualsiasi istante, del supporto ideale per l'immediato impiego delr artiglieria. 11 passaggio dalla configurazione cli traino e quella di batteria richiedeva poc.:hissimi minuti. il tempo di caricare i peni. attingendo le munizioni dai rispettivi cassoni!
Quanto condizionante fosse lo spostamento dei cannoni lo si può agevolmente dedurre considerando che persino dopo l'adozione degli affuc;ti a ruote, nel 1554, gli Spagnoli per metterne in movimento i 50 di cui di-
spongono nei Paesi Bassi, hanno bisogno di: " ... un «piccolo treno» di 473 cavalli per i soli ca\alieri. più un «gran treno» di I074 cavalli, più 575 carri con quattro cavalli ciascuno, ossia in tutto 4777 cavalli, il che fa 90 cavalli per ogni peno .. .'°"'. Se questa risulta la situazione per una singola bocca pesante circa IO quintali e perfettamente affustata. è facile immaginare quale fosse stata per pe, ,i di 50 quintali senza alcun tipo cli supporlo: comprensibile l'impossibilità d'impiegare i cavalli per i traini. Nel 1472, il parco dell'artiglieria milanese. forte di appena 16 pevi. richiedeva per spostarsi 227 carri e 522 pariglie di buoi! Il bue, infatti: " era l'animale da traino a cui si ricorreva comunemente in Italia anche se allora l'esercito pontificio faceva un uso notevole di bufali per muovere le proprie artiglierie. Sia il bue sia il bufalo erano lenti, soprattutto se dovevano procedere \U ~trade malagevo1i. Molti dei peni più grossi di artiglieria per essere trasportati dovevano essere prima smontali e il tra<,porto delle gro.,sc palle di pietra poneva quasi altrettanti problemi quanto lo spostamento dei cannoni che le dovevano sparare .. .! pesantissimi cannoni di grosso calibro richiedevano settimane di lavoro per essere messi in posizione di tiro e per essere pronti al tiro "' ''> E non era ancora finita, poichè. anche dopo la messa in posizione. modificare la punteria o, addirittura, cambiare bersaglio, costituiva per i serventi di quelle artiglierie una fatica improba e spossante. Quanto appena e<.,posto spiega a perfezione perchè nel 1499 i Veneziani, nel corso dei combattimenti in Romagna spesso: " ... dovevano rompere i cortaldi in peai o ...deciderc se «li ca1111011i hisoRnava mmpere... per farli cond11re con mino spe:w ». " •~K>
Tornando all'affustamento dei pezzi. l'incavalcamento avveniva poggiando i loro orecchioni sugli appositi alloggiamenti ferrati, detti ·orecchioniere', ricavati sulla sommità degli assoni. Per la preponderanLa del peso in culatta, con l'affusto su te1Teno discretamente piano, il cannone si adagiava subito con una linea di tiro appros<;imatamente orizzontale. tale, comunque, da richiedere, per entrare in a?ione, soltanto una minima correzione di alzo. Le ruote. dai mas-

sicci e tozzi raggi. pesantemente cerchiate di ferro e molto più larghe di yuelle dei normali carriaggi. espediente indispensabile per attenuarne la pressione specifica sul terreno, venivano ulteriormente rinforzate con handelle chiodate in corrispondenza di ogni incastro. Il loro profilo era conico. per l'esattezza a campana, con il vertice costituito dalla faccia interna del mozzo aderente all'assone. La strana configurazione dipendeva dall'esigenza di ampliare la distanza tra i cerchioni in modo di aumentare la stabilità laterale del cannone affustato. che per la posizionatura sommitalc del baricentro. risultava estremamente critica. Senza tale precauzione, un'inclinazione su di un fianco di una ventina di gradi sarebbe bastata a provocarne il rovesciamento. Normalmente l'affusto era dotato di due ruote per i calibri piccoli e medi, e di quattro per quelli maggiori: in questo caso però le due supplementari costituivano un avantreno che si aggiungeva soltanto durante gli spostamenti.
L'introduzione degli orecchioni. come più in generale la trapanazione dell'anima, la spessorazione differenziata della volata. nonchè la palla di ferro e gli affusti. oltre ad eliminare i relativi peggiori difetti delle arcaiche artiglierie. erano prodromici. in ultima analisi, alraumento della carica di lancio. La manifestazione più eclatante di tale evoluzione fu l'inusitata capacità demolitrice attinta dai cannoni d'assedio, contro la cui violenza non esisteva ormai alcuna contromisura difensiva. A quel punto le bombarde del Martini, cli appena pochi anni prima, come osservato, apparivano anacronistiche. Infatti: " ... bisogna notare che quando il Martini scriveva, era cambiato il sistema delle artiglierie non solo per le forme, ma eziandio per le grossezze delle parti dei diversi pezzi ... "' ""'. Per cui, ad onta della sua indiscussa genialità e competenza: ·•... i cannoni di Francesco di Giorgio sono ancora molto simili a quelli del Taccola (morto prima del 1458). Si riesce a mala pena ad avere sentore. in qualche abhozzo, della trasformazione che si sta producendo. Lo stesso Leonardo non segnerà alcun progresso degno cli nota. Pare che in questo campo gli italiani manifestino un certo grado cli ruTetratezza: quest'arretratezza spiega, in una certa maniera, il rapido
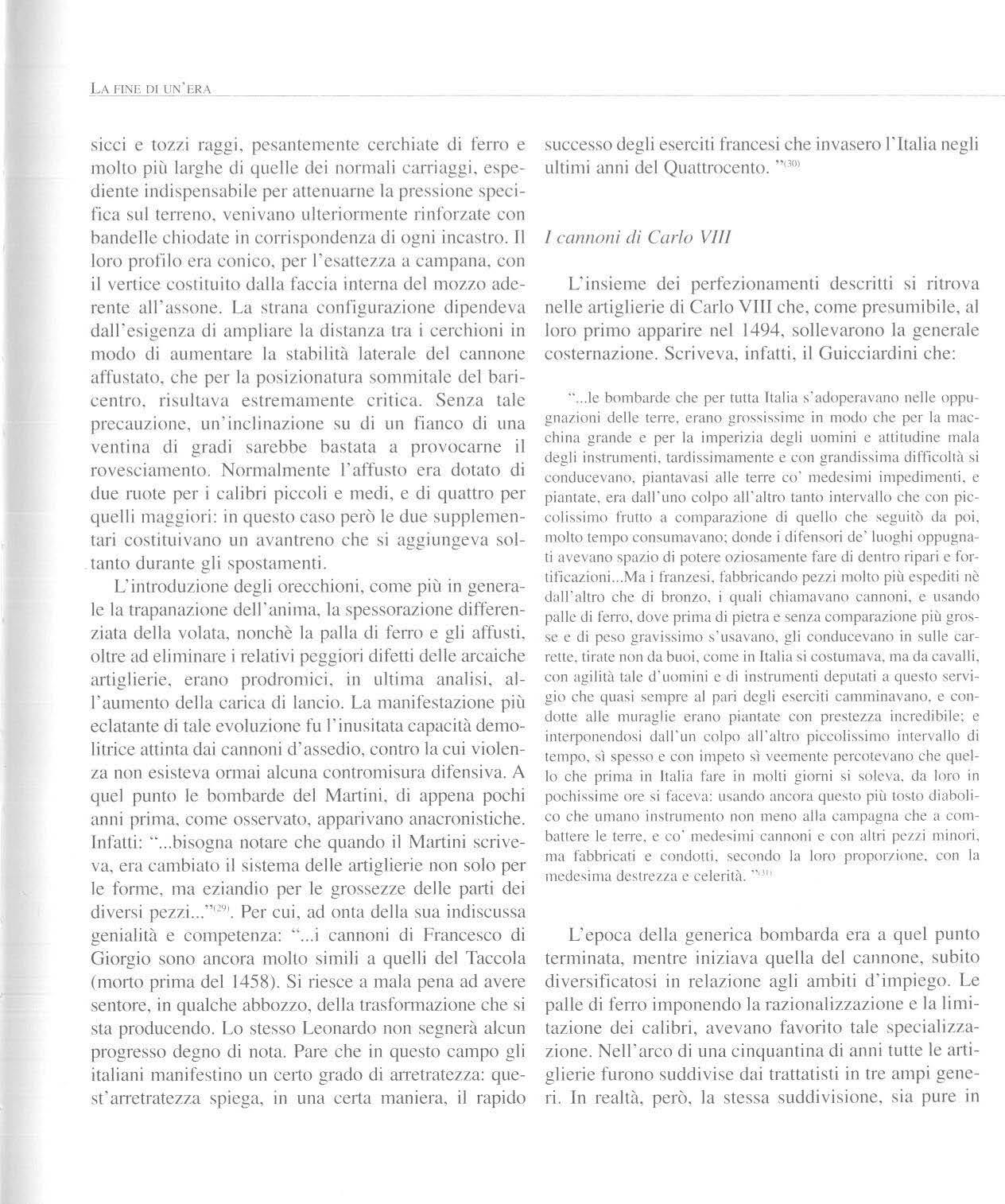
successo degli eserciti francesi che invasero l'Italia negli ultimi anni del Quattrocento. ''110 >
L'insieme dei perfezionamenti descritti si ritrova nelle artiglierie di Carlo VIII che, come presumibile, al loro primo apparire nel 1494, sollevarono la generale costernazione. Scriveva, infatti, il Guicciardini che:
·· le bombarde che per tutta ltalia s'adoperavano nelle oppugnazioni delle terre. erano grossissime in modo che per la macchina grande e per la imperizia degli uomini c allitudine mala degli instrumenti, tardissimamente e con grandissima difficollà si conducevano. piantavasi alle terre c:o· medesimi impedimenti, e piantate, era dall"uno colpo ali" altro tanto intervallo che con piccolis~imo frutto a comparazione di quello che seguitè> da poi, molto tempo consumavano; donde i difensori de' luoghi oppugnati avevano spazio di potere 01iosa111ente fare di dentro ripari e fortificat.ioni Ma i frarJLesi. fabbricando pezzi molto più espediti nè dalJ'altro che di bronLo, i quali chiamavano cannoni, e usando palle di feno, dove prima di pietra e senza comparazione più grosse e di peso gravissimo s'usavano. gli conducevano in sulle carrcllc. tirate non da buoi, come in Italia si costumava. rna da cavalli. con agilità tale d'uomini e di instrumenti deputati a questo s ervigio che quasi sempre al pari degli eserciti camminavano. e condotte alle muraglie erano piantate con prcstea.a incredibile: e interponendosi dall'un colpo all'altro piccolissimo intervallo di tempo, ~ì spe<;so e con impeto \Ì veemente percotevano che quello che prima in Italia fare in molti giorni si solcva, eia loro in pochi'>sirne ore si faceva: usando ancora questo piL1 tosto cliaholico che umano instrumento non meno alla campagna che a c ombattere le terre. eco· mecle'>imi cannoni e con altri peui minori. rna fabbricati e condotti. secondo la loro propor1ionc. con la medesima clestreaa e celerità .,,
L'epoca della generica bombarda era a quel punto terminata, mentre iniziava quella del cannone, subito diversificatosi in relazione agli ambiti d'impiego. Le palle cli ferro imponendo la razionalizzazione e la limitazione dei calibri, avevano favorito tale specializzazione. Nell'arco di una cinquantina di anni tutte le artiglieri e furono suddivise dai trattatisti in tre ampi generi. In realrà. però, la stessa suddivisione. sia pure in
maniera meno rigida e convenziona le, se mbra già in auge ver o la fine del XV secolo, quando ancora si usava de ignare i pezzi con no mi di a nim a li , pe r lo più uccellì rapaci o serpe nti vele no si, per meglio sotto linearne la rapidi ss ima letalità.
Nel primo ge nere ricordato dalla trattalistica coeva, co me delle 'c o lubrine ' rientravano Lutti i ca nn o ni a grande rapporto lra la lunghezza dell'a nim a ed il diametro d el la pall a, modulo dimensionale del pezzo, impropri ame nte d efi nito ca libro. Generalizzatosi l 'impiego d ei proietti sfe rici di ferro, infatti, il calibro, es presso in libbre, mediamente g. 336 cadauna, corrispon deva al diam etro della palla ave nt e quel peso.

Appartenevano a l primo genere anche i cannoni d i piccolo cal ibro , quale il 'sagro' da 8, il 'mczzosagro' da 4, il 'falcone' da 6, il 'fa lconeuo· da 3. lo 's me rig li o' da 2 cd ultimo il 'moschetto' da I , nome che de s ig na va la più minu sco la artiglieria affus tala 1 21 • Bisog na agg iun gere c he questi pezzi vantava no un rapporto lunghezza/diametro dell'anima uperiore a quello delle colubrine propriame nt e dett e, di calibro compreso fra le 24 e le 50 libbre. e s pessori di bronzo s urdimen ionati. li loro pc o può essere st im ato, sta ndo agli ese mplari perv en ulici , intorno a ll e 220-250 vo lte quello della palla. che saliva a 380-450 per qu e lli prolun gati e rinforzati, altri menti de tti 'con ricchezza di m e ta llo '.
Nel secondo genere erano so lit ame nt e inclusi i cannoni d'assedio e da fortezza, di ca libro cioè fra le 50 e le 120 li bbre, artig li eri e specia li zzate nell e demo li z ioni di mura, o ne ll a d ifesa delle piazzefort i, in og ni caso do tate di minore mobilità.
Infin e ne l terzo genere s' in cludevano i cos idd e tti ca nnoni petrie ri cd i m ortai. D ei primi , e de l loro ru o lo su ll e fort i ficazioni, abbiamo già fo rnito una esa urient e de scr iz ione. D ei secondi è s uffici e nt e rico rd a r e che ce nsi tevano in pezz i ad anima corti ss ima, di e nor me cali bro, capac i di scagl ia re, co n pa r abole fortemente arcuate palle, giga nte sc he e, dall a seco nd a me tà del XVI sec olo. a nc he esp los i ve'" : val idi ss imi, quindi , negli assed i per il bombardame nto al di là deJJe mura.
Ogni innovazione tecnologica, dopo la sua introduzione, subisce un continuo sviluppo: in ciò ricorda la crescita degli organismi viventi. Le artiglierie, però, per circa un secolo e mezzo più che divenire grandi erano soltanto divenute grosse, lasciando così presumere che, con un identico processo di surdimensionamento, anche le fortificazioni avrebbero potuto continuare a fronteggiarle. Pertanto come l'incremento delle potenzialità distruttive delle bombarde si perseguì aumentandone, soprattutto, il calibro della palla e la relati va carica di lancio così la resistenza delle mura si maggiorò aumentandone lo spessore e I' inclinazione. In definitiva, come accennato, nessuna novità concettuale riducendosi la vicenda ad una rincorsa tra due esagerazioni. Non mancarono in quell'ampio contesto ingegni più acuti che tentarono di escogitare, sia pur confusamente e contradditoriamente, soluzioni meno ovvie, intuendo che quell'infantile confronto non poteva protrarsi all'infinito, in specie nelle fortificazioni, non fosse altro che per gli oneri rapidamente crescenti, e per la durata, rapidamente decrescente.
Non a caso l'architettura militare di lransizione appare caricaturale, incapace di infrangere gli schematismi arcaici e di crearne di sostitutivi altrettanto validi, pur tradendo, in alcuni significativi dettagli, una percezione della immjnente risoluzione tecnica. Tra questi, in particolare ed abbastanza chiaramente, la tendenza alla s istematica abolizione delle merlature e della difesa piombante, o comunque ravvicinata; lo spostamento verso il basso, radente il terreno, dell'interdizione attiva; la terrapienatura dei volumi supportan ti le art iglierie; l'unificazione della quota degli spalti, indispensabile per la loro movimentazione spedita, e, soprattutto, l'adozione di perimetri ad andamento spezzato per favorire il reciproco appoggio delle singole sezioni. Si trattava, in ogni caso e senza dubbio, di adeguamenti imputabili alle artiglierie ma, paradossalmente, non del nemico ma proprie, ovvero non per ridurre la vulnerabi lità della fortificazione ma per incrementarne il rispetto, non per accrescerne la prestazione passiva ma quella attiva. Jl che contribuì a

prolungare la sopravvivenza di concezioru strutturali altrimenti inadeguate.
Curiosamente, infatti, il potenziamento delle bocche da fuoco, perseguito per demolire le mura finì per rivelarsi ancora più conveniente per difenderle. Per una serie di ottime ragioni, ben presto: " .. .l'artiglieria servì forse di più alla difesa che ali' assalto delle città e delle fortezze. I cannoni collocati in postazioni stabili sulle mura di una città potevano essere riforniti con maggiore speditezza ed essere usati più rapidamente e con maggiore etficacia dei cannoni collocati dagli assedianti in postazioni provvisorie, dopo essere stati trascinati sul posto da località lontane molti chilometri. Per questi motivi ... l'arte delle fortificazioni, pur dovendo rispondere alla nuova minaccia dell' artiglieria campale, conobbe un processo innovativo assai lento " <34 > _
Il parere è condiviso daJJa maggioranza degli studiosi. Per essi le conseguenze più rimarchevoli prodotte dall'avvento dell'artiglieria sulle fortificazioni vanno ricercate non tanto nelle loro reiterate modifiche per sostenerne l'offesa, senza dubbio vistose, quanto piuttosto in quelle necessarie per consentirne il razionale impianto in funzione difensiva, culminate proprio nell'andamento spezzato delle mura e nella loro te1Tapienatura. Quanto inadeguato risultasse per l' armamento balistico la pedissequa riproposizione di un circuito tradizionale lo si può desumere da un rapporto, inoltrato nel 1496, dal governatore veneziano della città di Otranto, la cui cerchia era stata ricostruita appena pochi anni prima. L'ufficiale, infalti, giustificava l'abnorme esigenza di artiglierie, precisando che:
" anchor non se di manda per tanto quanto è al bisogno, perchè questa ter ra vuolsi più de mezzo miglio [perimetro della cerchia]. et va per la mazor parte al tondo LcircolareJ et taliter che le co1tine non se puoi soccorrere l'una cum l'altra però bi s ogna grande offes a per ogni parte .. .'')~•.
Eppure fra i primi propugnatori del perimetro difensivo a salienti e rientranti spicca, Francesco di Giorgio Martini, non del tutto estraneo alla rifortificazione della disgraziata città, implicita conferma che l'ecces-
!->i\O onere dei nuu, i criteri fini\ a, spesso, per imporne la rinuncia . Del resto, nonostame le sue sensalissime intui.lioni. non riesce a liberarsi dei coslosissimi, ed om1ai inutili torrioni, che colloca ai \ertici dei salienti. Così dal suo trattato al riguardo:
··10 pe1 me. quanto c.:on,ideran: ho potuto in nelle difc,e delle homhardt:. a,,i diffo.:il mi pare da es,e poteN d1tendare. ~1a de' più salullkri modi che \ eder c1 posi-.u, ,ie da fan: g.1w,:,e cd amprie mura con alte e dt:pend.:nti scarpe, tonde. arntc. facciale. e ,rni ,urati torroni E nu,,,ime in :,ullt: fronti e Mremità degli angoli. aci:iò che le 11pp<Ne mura da e-..-.1 d1te,e e cuperte ,,eno. I:: in nella ,ommita <l .:,,i i ~opra pmti cahc.:1 colle loro d1tese lii coronamento a :,porgerel Po~,am,i .farc alcune ocn1ltc Jifc!,C in ne ll e loro ba~,c11e o,ern 111fra gh angoli. m:c.:iò che due facce d1klllkrc po,-.,no :·
sia dinamica. contro le sollecila11oni impresse dalle bombarde. Pertanto progressivamente le mura e le torri si spessorarono. munendole di grandi scarpe. e si riem pirono, in parte o completamente, di terra per consentire l'istallaLionc sulla loro sommità delle bocche da fuoco. ln falli: " essendo, da principio. limitato l'uso delle artiglierie nella d1 fesa. non erano esse piantate che sulla piattaforma delle torri Però in hancia dal 1400 almeno eravi usann1 di terrapienare un trailo della cortina per piantarvi le artiglierie: Mct7 erane munita nel 1444. mentre dello slc..,,o secolo furono. fra le altre, fornite di terrapieno le citti1 di Bologna (ove fu fatto largo metri .5 ). Ca..,almaggiore, Piacen1a e I' antica cittadella o· Anversa. Fccensi nel ... egu1to. miglior<1ndosi le ar11glie1ie, terrapieni più ampi,. capaci di sostenerle ", ~ 1 •
In pratica si incominciò ad intervenire sulle fortific,11ioni giù e..,i..,tenti abba..,sandonc innai11itu1to l'a1te11a delle torn e delle Cl>rtine. La sagoma tanto elevata tipica dell'an.:hitellura mililare del X tl -X lrI secolo si trasforma\'a in un. fin troppo. facile bcr..,aglio per le bombarde. O,, iamentc la 'cimatura· comportava anche delle rinuncie, non sempre affrontate a cuor leggero. Jnfatti: ··... se la difesa si abbassa divema meno vulnerabile ... contt:mporaneamcnte. diminuisce il ,uo dominio e il raggto d1 avvistamento e quello della Mione utile con la quale tener lonlano l'approccio e il lavoro di mina nemico. Se la dilesa invece si al.la. il 111:mico, da posi,ioni ben più lontane. gode l'offerta di un maggior bersaglio e piu comodamente. e meno penrnlosamentc, lo può colpire ... "•!'.
Pre, alse. logicamente. l'c-.igenLa di ridurre la \ ulnuabilnà. e rapidamente tulle le strutture si ahha'>:-iarono, mutando vis tosamente l'originaria connow1ione. Ma quel sofferlO rimedio era di tipo poten1iale. o, \'ero finalizzato a ,opprimere una e\ idcnte debolc,La, mentre se ne imponevano e.li più consistenti d1 tipo concreto, ovvero finalizzati ad incre111entare la resi'>tenza passi, a delle opere, sia statica, contro le ol'le'>e.
Tale e:-ipcdienle fu, in bre\e volgere di tempo. ""tematicamente ri enato alle ton i che per il costante incremento di diametro cd abbas:-iamento c.lell'altc1.la, nel frallcmpo. erano divenute dei torrioni. Per cui :-iehbene: .... nei ~ecolr >..IV e XV c:ont111uo..,,i a far uso frequente delle torri rotonde furono abbassate al livello delle mura, ed aumenlato sino a 20 metri il diametro loro. affinchè la piattaforma fosse capace dcli' artiglieria.
Però i volti sostenenl i la piallaforma non potevano a lungo re'-)i-;tere alle scosse prodotte dallo sparo de ll e bombarde .. ,<così nel 1440 una grossa bombarda piantata sulla torre maestra di Peschiera al decimo colpo intronolla per modo che a l colpo seguen te la sco!->sa fella cadere in fascio. Videsi allora che per 1iparare tale inconveniente era necessario un piantato di terra, e pcrchè tcrrapienavansi le cortine onde fossero più solide, così viepp iù abbisognava nelle torri per questa e per la ragione anzidetta. ed ancora perchè il tarle tutte dt muraglia sarèbbc stala spc..,a intollerabile.» Fra i primi torrioni terrapienaLi citansi quello di Rimini nel 1437, e di Castel Numo di Napoli nel 1450 ... "
L. abbas ... amc11to e la scarpalura rendevano del lutto impraticabile il tiro piombanle. sen1a conlarc che l'ap paralO a !->porgere ad L'S'>O de..,tinato. ,i conferma, a
 Le fmi della E1wm,io11e
INCiH,1\0 I P,\l RA'( Kl ·'II,\ Sl,<'OLI Ili hlRTlHC,\/10'\I IN lli\l i,\
Le fmi della E1wm,io11e
INCiH,1\0 I P,\l RA'( Kl ·'II,\ Sl,<'OLI Ili hlRTlHC,\/10'\I IN lli\l i,\
troppo fragile ai colpi di bombarda trasformandosi in una micidiale fonte di schegge. In pochi decenni fu drasticamente ridimensionato, riducendone gli sporti ed incrementando la solidità delle sovrastanti merlature. Nonostante ciò, le: " .. .innovazioni che precedettero il secolo XV sono di lieve importanza e poco note ... Cercossi di aumentare la resistenza del muro col dargli esternamente una scarpa assai pronunciata (da 1/4 al 1/5) ... Continuavasi dapprima a fare i parapelti merlati ad imitazione degli antichi: ma poichè per la violenza delrartiglieria, le schegge staccatene dai merli maggior danno cagionavano ai difensori che non i proietti stessi, convenne aumentare la grossezza dei merli, e nel seguito costruire i parapetti smerlati. con banchina per r uso delle armi della difesa .. :·,.m,.
L'abolizione della difesa piombante produceva, però. dinanzi al piede delle mura una fascia pericolo:::.amente defilata, non potendo le bombarde tirare in depressione , per cui la sua interdizione dipendeva dai pochi cannoncini petrieri disponibili. assolutamente insufficienti per J' intero perimetro. Indispensabile , perciò. portare in basso i grossi calibri in modo da poter tirare radente il terreno. La soluzione, tuttavia, non fu di facile attuazione, proprio per l'enorme spessore che a tale livello avevano raggiunto ormai le mura munite di scarpa, non di rado di una decina di metri. lmpossibik praticarvi una feritoia. simile ad una galleria e, necessariamente, priva di strombatura. Unico rimedio ricavare proprio nella massa muraria degli appositi locali destinali ad ospitare i pezzi, limitando così la sezione attraversata dalla troniera a poco più di un metro: le casamatte.
L'accorgimento. però, se risolveva un problema ne creava immediatamente un secondo: occorreva escogitare un sistema di ventilaLione delle casarnatte per evacuare rapidamente i gas di sparo che altrimenti le avrebbero saturate con pochi tiri. Dopo alcuni tentativi di scarso successo ci si avvalse, probabilmente, dell 'esperienza maturata nei domestici forni per il pane. Sul cielo della troniera si praticò una s olla di cappa portandola a sfiatare, con una lunga canna fumaria nello spessore delle mura. sulla copertura dell'opera. Un ottimo esem-
pio di siffaui 'sfiati' è ravvisabile nella rocca di Ostia , forse il primo sicuramente funzionante.
Utilizzando le bombarde sempre palle di pietra , per neutralizzarne gli impatti, oltre alla scarpatura, si ricorse alla corazLatura degli estradossi delle fortificazioni con grossi conci di roccia durissima La soluzione, peraltro costisissima. si confennò, per nn discreto arco di tempo , senza dubbio efficace. Le palle tirate al di sopra della scarpa si fracassavano su quella blindatura lapidea , disperdendosi in una rosata di schegge, innuocue per le mura ma micidiali per chiunque si fosse sporto dalle stesse. Il cordone a profilo torico, detto ·reclondone', che si interpose, da un certo periodo in poi. tra la base inclinata e l'alzato verticale di ogni fortificazione, se rviva appunto ad impedire c he le suddette schegge, od anche i frammenli della mitraglia del fiancheggiamento a tiro incrociato. falcidiassero i difensori raggiungendoli attraverso le buche delle piombatoie. Non di rado di siffatti cordoni ne vennero impiantati addirittura due:, con il secoudo appena al di sotto dell'apparato a sporgere.
Ad ogni buon conto, per ridurre al massimo le superfici \ erticali più vulnerabili e pericolose, la scarpa prese a salire, mentre i coronamenti assunsero il tipico profilo sfuggente destinato a permanere nei secoli successivi. Per la :::.tessa ragione i torrioni furono realizzati esclusivamente su pianta circolare. o ricondotti comunque ad essa. Ricorda va. infatti. Francesco cli Giorgio nei suoi trattati che:
··... la ro1undi1à dellt: torri ... io confirmo cs:-.ert: utile e necessaria, pcrchè pili re:,1ste e menu ricevt: le percosse dt:11<1 bombarda ..... ,
E quando anche tale rimedio si dimostrò insufficiente si escogitò un ulteriore potenziamento passivo. In pratica: " ... come già nell'ultimo Medioevo si era procurata alle torri e alle cortine la scar patura delle mura verticali. con camiciature inclinate aggiunte contro la base del muro per evitare il gioco delle mine e l'approccio delle torri d'as sa lto , si ritenne utile duran-

te la trans1Z1one generalizzare l'analogo concetto di ·camiciatura' bassa distanziata e parallela al muro con caratteristiche di rinforzo contro tiro, riempendo una strisc ia del fosso e contenendo il rinten-o con un secondo argine in muratura. Nel basso antemurale così ottenuto a spese dell'ampiezza del fossato, si riunivano in tal modo parecchi vantaggi, perchè a una più valida sede guadagnata alla difesa leggera vicina e radente del fosso e della controscarpa, si aggiungeva un cuscinetto di ammortamento e di difesa del muro. Tanto da meritare facile adozione in quasi tutte le fortificazioni europee, col nome di 'falsabraca' ... " 142>
In co nc lusione nell'architettura di transizione gli interventi principali, e le caratteristiche salienti da intendersi soprattutto come tendenze, possono schematicamente così rubricarsi:
l3 Abbassamento delle cortine e delle toITi, preferibilmente non assoluto, perchè la fo11ificazione doveva pur sempre conservare una sua emergenza per controllare la zona ad essa circostante e garantirsi dalle faci l i scalate. Pertanto lo si ottenne incrementando la profondità dei fossati. Il dislivello , in sostanza, restò di poco alterato, pur esponendosi l'intera opera per un a minore s upe rficie fuori terra.
2a Aumento consistente degli spessori delle cortine e delle ton-i, che divennero, progressivamente, i massicci torrioni e le mastodontiche muraglie delle stru tture pervenuteci. L a concezione passiva restò però vi ncolata al contrasto netto ag l i impatti dei proietti non metallici, per cui si rivestirono i loro estradossi con grossi e spess i co n ci di durissima pietra, fungenti da corazze fracassapalle .
3 a Sostituzione a parit à di moda lit à d'impiego de ll e antiche artigl ie ri e neurobalistiche con quelle a polvere, postandole perciò sempre su ll a sommità delle strutture, in particolare, sulla copertura dei torrioni, detta piazza d'armi. La sol u zione si rivelò dal punto di vis t a balistico est remamente infelice e richiese, inoltre, un rafforzamento de ll e murature
per sopportare le crescenti sollecitazioni. Verso la conclusione della transizione le artiglierie si piazzarono nelle basse casamatte , recuperando una maggiore efficienza.
4a Sostituzione della fragilissima merlatura , con robusti merloni dal profilo trasversale sfuggente , propriamente detto 'balistico ', per agevolare la deviazione dei proietti.
sa Accrescimento e perfezionamento delle opere antemurali, quali fossati e scarpature, che in maniera identica alla rotondità dei torrioni ed ai profili dei merloni, favori vano la deviazione dei proietti.
Tenendo conto che i parametri dimensionali dell'architettura di tran s izione clipesero dalla valutazione dei progettisti, certamente condizionata, ma soggettiva, è possibile individuare, nel suo arco esi s tenziale, più che dei valori limite ottimali delle significative tendenze i cui estremi corrispondono ai criteri più avanzati. I n particolare:
1° - Rapporto altezza-diametro dei torrioni

Costituisce forse la più ev id en te connotazione della trans izione, anche perchè è re l ativa alle componenti strutturali pervenuteci in maggior numero. Per il M artini il suo valore ottimale, per eleme n ti non isolati, si attestava intorno ad 1-0.8. Tende comunque a diminuire sensibilmente col trascorrere del XV seco lo.
Nelle fortificazioni del XV secolo il diametro dei torrioni appare relazionato a lla loro espos izione. In pratica un torrione posto al ve11ice di un angolo ottuso ostenta un diametro minore di uno posto a l vertice di un angolo acu to. La ragione deve attri bui rsi, oltre aJla superiore vu l nerabi lit à del secondo, a lla necessità cli postare su ll a sua piazza un maggio r numero di can n oni indispensabili per battere il settore di teITeno antistante più ampio.
INGEGNO E PAURA TR E NTA S ECOLI l)J FORTIFICAZIONI JN ITALIA 2 ° - Rapporto angolo esterno-diametro dei torrioniOvviamente tale esigenza divenne basilare soltanto dopo l'adozione massiccia dell'artiglieria in difesa, per cui il valore tende a diminuire lentamente.
3° -Rapp o rto vuoto-pi e no n ei torrion i
Come delineato, per sostenere le sollecitazioni delle artiglierie postate sulla piazza si costruirono dapprima torrioni con le volte rinforzate, poi, crescendo a dismisura il loro diametro, interamente pieni, fatti salvi i vani per le casamatte e per le scale a chiocciola. Il valore pertanto tende a ridursi fin quasi a zero.
4° -Rappo rto larg hezza-a ltezza d ell a cortina
Al pari di quanto rilevato per i torrioni, anche nelle cortine si registra una netta tendenza alla diminuzione.
5 ° -Rap po rto a ltezza sca rpa -cortina
Con il trascorrere dei decenni, incrementandosi lo spessore della scarpa per evitare che assumesse angoli troppo acuti, facilitando perciò la scalata, se ne aumentò l'altezza lasciandone praticamente immutata l'inclinazione. Gradatamente, pertanto, la scarpa s'innalza fino ad estendersi, in alcuni casi quali le torri cost iere vicereali napoletane, all'intera struttura Il rapporto quindi tende a decrescere lentamente.
6° -Rappo rto alt e zza st rutture-em e rgenz a dal terre no
Scriveva il Martini al riguardo, precisando un criterio ormai già d'impiego generalizzato : " ... le mura del c ir cuito siano alte per sè, ma in «basso loco situate» dal che ch i ara apparisce l'idea di sacrificare il comando sulla campagna con tanta cura cercato dagli antichi, per so tt rarre una maggior parte di muro ai tiri diretti dell' artig l ieri a; e mentre eglì assegna alle torr i ed al recinto 16 in 20 metri d'altezza, dà al fosso 13 a 16 metri di profondità ( e larghezza doppia), prescrivendo inoltre lo spalto per
viemeglio ricoprire le murature. " '43 > [I che farebbe assegnare, in fase già matura, al rapporto il valore 4-5: la tendenza sarà di aumentare ancora, sebbene di poco.
7 ° - Ra p por to fronte corti ne -fro nte co m p less ivo
Nella fo11ificazione antecedente alle arrni da fuoco tale rapporto oscillava mediamente, nelle migliori realizzazioni, intorno al valore di 0.5. Nella transizione , per la maggiore gittata delle artiglierie, se ne osserva un significativo incremento con la tendenza ad aumentare ulteriormente , sebbene di poco.
8 ° -Rap p o rto s up erficie d efila ta -b attu ta
Esaminando i castelli federiciani se ne è evidenziato il costante impegno teso ad eliminare, entro il raggio d'azione delle balestre, qualsiasi settore defilato. In rarissimi casi l'intento fu conseguito quasi completamente, mentre in tutti i rimanenti il valore si attesta intorno a 0.15-0.1. Nella transi z ione la tendenza è verso una ulteriore diminuzione: solo con l'avvento del bastione toccherà sistematicamente lo zero.

Oltre ai precedenti parametri, gli studiosi del settore ne hanno individuati altri ancora, senza dubbio emblematici ed indicati vi dell'evolversi della transizione. Tra questi, in particolare :
"Uso di artigli eri e in cas amatta ... nelle rocche della transizione si ricorre in larga , quasi preponderante, misura all'uso di artig l ierie in casamatta.. .ln aumento.
Uso d el tiro rad ente .. .in tutte le rocche più evolute si pongono le bocche da fuoco, per loro natura a tiro teso , in posizioni ta l i da spazzare tangenzialmente le posizioni di un eventuale attaccante, così da aumentare enormemente la probabilità di colpi a segno .ln aumento
Quota unica del cammino di ronda. Realizzata al fine di facilitare lo spostame n to delle forze difensive
uomini e pezzi d'artiglieria nel punto di volta in volta più minacciato " ' 111 •
Vagliando le aitiglierie e le fortificazioni della seconda metà del '400, sono stati citati numerosi brani dei trattati di Francesco di Giorgio Martini, non a caso definito il 'Leonardo senese' per il suo ampio coinvolgimento nella produzione artistica e scientifica dell'epoca. La celebrità. tuttavia, gli derivò dal ruolo sostenuto nell'architettura militare di transizione, di cui, universalmente, è ritenuto il massimo esponente. Di lui, infatti, il Vasari scriveva che: " nell'architettura ebbe grandissimo giudizio, e mostrò di molto ben intendere quella professione ... Fu Francesco grandissimo ingegnere, e massimamente di macchine da guerra ... merita che gli sia dovuto grande obbligo, per aver facilitato le cose dcli' architettura e recatole più giovamento che alcun altro avesse fatto da Filippo di ser Brunellesco insino al tempo suo " H 5>
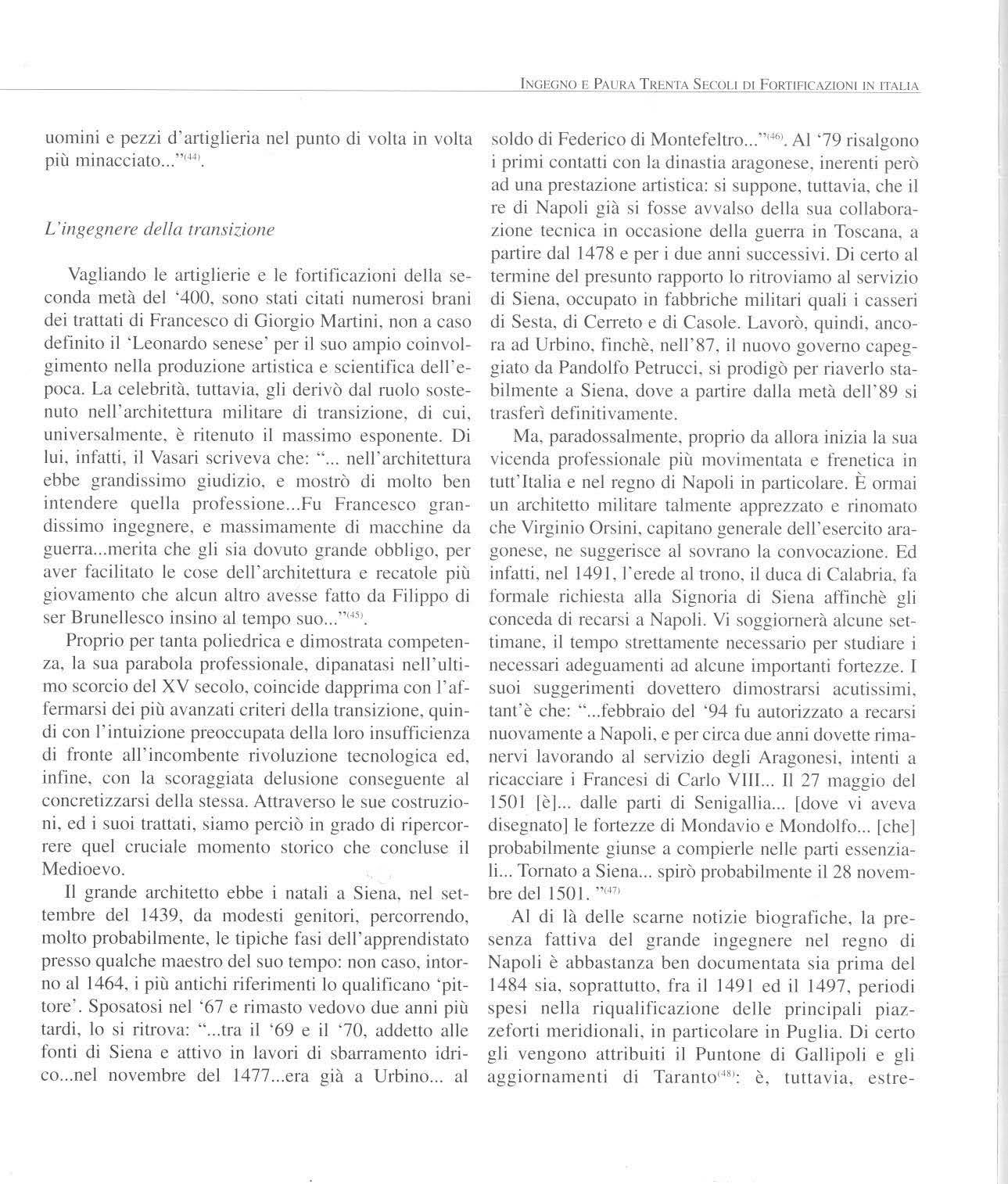
Proprio per tanta poliedrica e dimostrata competenza, la sua parabola professionale, dipanatasi nell 'ultimo scorcio del XV secolo, coincide dapprima con l'affermarsi dei più avanzati criteri della transizione, quindi con l'intuizione preoccupata della loro insufficienza di fronte all'incombente rivoluzione tecnologica ed, infine, con la scoraggiata delusione conseguente al concretizzarsi della stessa. Attraverso le sue costruzioni, ed i suoi trattati, siamo perciò in grado di ripercorrere quel cruciale momento storico che concluse il Medioevo.
Il grande architetto ebbe i natali a Siena. nel settembre del 1439, da modesti genitori, percorrendo, molto probabilmente, le tipiche fasi dell'apprendistato presso qualche maestro del suo tempo: non caso, intorno al 1464, i più antichi riferimenti lo qualificano 'pittore'. Sposatosi nel '67 e rimasto vedovo due anni più tardi, lo si ritrova: " tra il '69 e il '70, addetto alle fonti di Siena e attivo in lavori di sbarramento idrico ... nel novembre del 1477 ... era già a Urbino ... al
soldo di Federico di Montefeltro ... " i-*<,> Al ' 79 risalgono i primi contatti con la dinastia aragonese, inerenti però ad una prestazione artistica: si suppone, tuttavia, che il re di Napoli già si fosse avvalso della sua collaborazione tecnica in occasione della guerra in Toscana, a partire dal 1478 e per i due anni successivi. Di certo al termine del presunto rapporto lo rilroviamo al servizio di Siena, occupato in fabbriche militari quali i casseri di Sesta, di Cen-eto e di Casole. Lavorò, quindi , ancora ad Urbino , finchè, nell'87, il nuovo governo capeggiato da Pandolfo Petrucci, si prodigò per riaverlo stabilmente a Siena, dove a partire dalla metà de11'89 si trasferì definitivamente.
Ma, paradossalmente, proprio da allora inizia la sua vicenda professionale più movimentata e frenetica in tutt'Italia e nel regno di Napoli in particolare. È ormai un architetto militare talmente apprezzato e rinomato che Virginio Orsini, capitano generale dell'esercito ai·agonese, ne suggerisce al sovrano la convocazione. Ed infatti. nel 149 l, l'erede al trono, il duca di Calabria, fa formale richiesta alla Signoria di Siena affinchè gli conceda di recarsi a Napoli. Vi soggiornerà alcune settimane, il tempo strettamente necessario per studiare i necessari adeguamenti ad alcune importanti fortezze. I suoi suggerimenti dovettero dimostrarsi acutissimi, tant'è che: " .febbraio del ·94 fu autorizzato a recarsi nuovamente a Napoli, e per circa due anni dovette rimanervi lavorando al servizio degli Aragonesi , intenti a ricacciare i Francesi di Carlo VIII ... li 27 maggio del 150 I lè] ... dalle parti di Senigallia ... [dove vi aveva disegnato] le fortezze di Mondavio e Mondolfo ... !che] probabilmente giunse a compierle nelle parti essenziali Tornato a Siena spirò probabilmente il 28 novembre del 1501 . " < 4 71
Al di là delle scarne notizie biografiche, la presenza fattiva del grande ingegnere nel regno di Napoli è abbastanza ben documentata sia prima del 1484 sia. soprattutto, fra il 1491 ed il 1497, periodi spesi nella riqualificazione delle principali piazzeforti meridionali, in particolare in Puglia. Di certo gli vengono attribuiti il Puntone di Gallipoli e gli aggiornamenti di Taranto <~ 8 ) : è, tuttavia, estre-
mamente probabile che la sua consulenza si estendesse, in realtà, all'intera linea difensiva costiera, stante la incombente minaccia turca. In quell'immane compito, che comportava tra l'altro continui spostamenti di migliaia di chilometri, fu validamente coadiuvato da allievi ed assistenti fra i quali si distinsero Antonio Marchesi da Settignano e Baccio Pomelli per non parlare di Ciro Ciri !~ 9 > Una grande intesa personale, inoltre , lo dovette legare al duca di Calabria, che ne ammirava incondizionatamente la perizia, fino a divenirne quasi un discepolo. Curiosamente, però, l'apice della sua celebrità coincise con il totale superamento della sua dottrina!
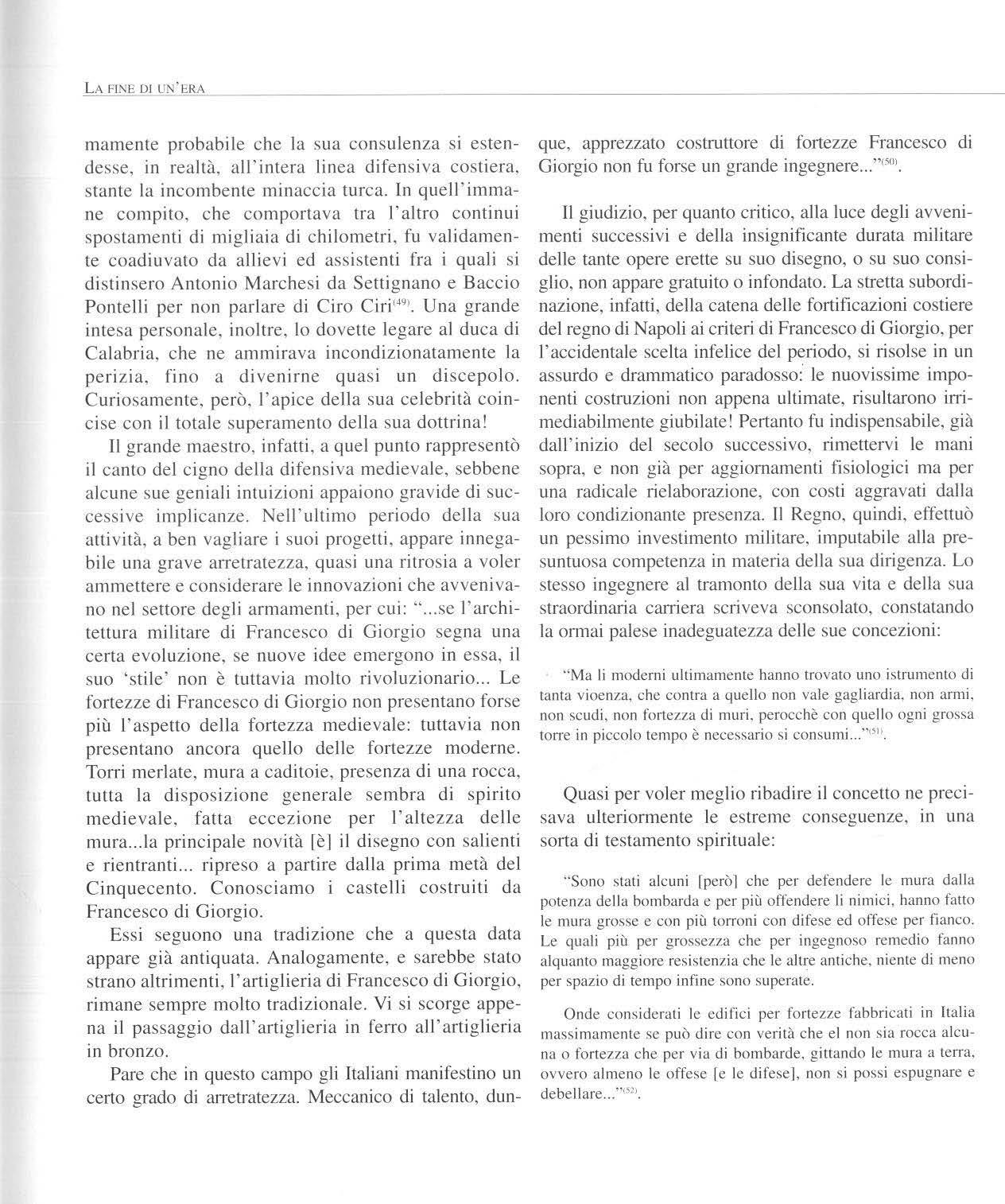
Il grande maestro, infatti, a quel punto rappresentò il canto del cigno della difensiva medievale, sebbene alcune sue geniali intuizioni appaiono gravide di successive implicanze. Nell'ultimo periodo della sua attività, a ben vagliare i suoi progetti, appare innegabile una grave arretratezza, quasi una ritrosia a voler ammettere e considerare le innovazioni che avvenivano nel settore degli armamenti, per cui: " ... se l'architettura militare di Francesco di Giorgio seg na una certa evoluzione, se nuove idee emergono in essa, il suo 'stile' non è tuttavia molto rivoluzionario ... Le fortezze di Francesco di Giorgio non presentano forse più l'aspetto della fortezza medievale: tuttavia non presentano ancora quello delle fortezze moderne. Torri merlate, mura a caditoie, presenza di una rocca, tutta la disposizione generale sembra di spirito medievale, fatta eccezione per l'altezza delle mura ... la principale novità [èJ il disegno con salienti e rientranti ripreso a partire dalla prima metà del Cinquecento. Conosciamo i castelli costruiti da Francesco di Giorgio.
Essi seguono una tradizione che a questa data appare già antiquata. Analogamente, e sarebbe stato strano altrimenti, l'artiglieria di Francesco di Giorgio, rimane sempre molto tradizionale. Vi si scorge appena il passaggio dall'artiglieria in ferro all'artiglieria in bronzo.
Pare che in questo campo gli Italiani manifestino un certo grado di arretratezza. Meccanico di talento, dun-
que, apprezzato costruttore di fortezze Francesco di Giorgio non fu forse un grande ingegnere... " < 5m.
Il giudizio, per quanto critico, alla luce degli avvenimenti successivi e della insignificante durata militare delle tante opere erette su suo disegno, o su suo consiglio, non appare gratuito o infondato. La stretta subordinazione, infatti, della catena delle fo1tificazioni costiere del regno di Napoli ai criteri di Francesco di Giorgio, per l'accidentale scelta infelice del periodo, si risolse in un assurdo e drammatico paradosso:· le nuovissime imponenti costruzioni non appena ultimate , risultarono irrimediabilmente giubilate! Pertanto fu indispensabile, già dall'inizio del secolo successivo, rimettervi le mani sopra, e non già per aggiornamenti fisiologici ma per una radicale rielaborazione, con costi aggravati dalla loro condizionante presenza. Il Regno, quindi, effettuò un pessimo investimento militare, imputabile alla presuntuosa competenza in materia della sua dirigenza. Lo stesso ingegnere al tramonto della sua vita e della sua straordinaria carriera scriveva sconsolato, constatando la ormai palese inadeguatez za delle sue concezioni:
·'Ma li moderni ultimamente hanno trovato uno istrumento cli tanta vioenza, che contra a quello non vale gagliardia, non armi. non scudi, non fortezza di muri, perocchè con quello ogni grossa torre in piccolo tempo è necessario si consumi " <m_
Quasi per voler meglio ribadire il concetto ne precisava ulterionnente le estreme conseguenze, in una sorta di testamento spirituale:
·'Sono s tati alcuni [però l che per defendere le mura dalla potenza della bombarda e per più offendere li nimici, hanno fatto le mura grosse e con più torroni con difese ed offese per fianco. Le quali più per grossezza che per ingegnoso remedio fanno alquanto maggiore resistenzia che le altre antiche, niente di meno per spazio di tempo infine sono superate.
Onde considerati le edifici per fortezze fabbricati in Italia massimamente se può dire con verità che el non sia rocca alcuna o fortezza che per via di bombarde, gittando le mura a tena, ovvero almeno le offese [e le difese], non si possi espugnare e debellare " "12
Il che soprattutto per il regno di Napoli era disgraziatamente vero , in uno snodo storico estremamente critico e gravido di tragedie imminenti, le cui fasi prodromiche possono individuarsi nella caduta di Costantinopoli nel 1453 e nella conquista di Otranto nel 1480.
nea infrangendo irrimediabilmente i resti della sua precaria stabilità: la potenza ottomana.
Negli anni '80 del XIV secolo l ' espansione turca nei Balcani dilagò inarrestabile, nonostante la disperata resistenza delle popolazioni locali. Ve rso la fine del decennio si rinnovò un estremo tentativo di ribellione al giogo ottomano, capeggiato dal principe serbo Lazzaro , alleatosi nella circostanza con la Bulgaria e la Bosnia. Il sultano affrontò allora, personalmente alla testa delle sue truppe , gli insorti ed , il 15 giugno del 1389, nella piana del Campo degli Uccelli Neri , Campomerlo, più nota da quel tragico giorno con il toponimo turco di Kosovo , li sbaragliò<54 l _ Venne però ferito a morte da un serbo: il che non gli impedì di far giustiziare in sua presenza, prima di spirare, il principe Lazzaro.
A partire dal 1350 gli equilibri che in qualche modo si erano affermati in Italia, tradiscono un progressivo esaurimento e degrado. Il processo non dipese: " ... da un arresto, e tanto meno, fda] un'involuzione della naturale formazione e sviluppo delle forme statali, anzi dello Stato che tende sempre più ad emanciparsi dalle classi e dai partiti, dalla monarchia universale e da quella teocratica, e neppure perchè venga meno il fiorire della cultura. Ma il raggio d'azione dell'attività degli Italiani , intesa nel suo più ampio significato, si accorcia. E ciò mentre la capacità creativa e la vigoria degli altri popoli aumenta. Di fronte alla nuova forza espansiva di questi, al loro dilatarsi e progredire, la forza espansiva italiana tende lentamente a cedere: condizioni esterne meno favorevoli o più ostili, e diminuita capacità ed energia nella società italiana ... " <rn , sembrano esserne le principali concause. Come se non bastasse un nuovo è più temibile protagonista debutta sulla scena mediterra-
Secondo la prassi tradizionale dei Turchi, alle vittorie sul campo seguivano le stragi e le deportazioni dei prigionieri destinati alla schiavitù. Per le popolazioni balcaniche assoggettate le condizioni esistenziali divennero, in breve, terribili: catture di familiari, imposte gravosissime, intolleranza religiosa, espropri delle terre, sequestri di bestiame e di raccolti , annientamento dei commerci e crollo di qualsiasi reddito rappresentarono lo scenario dei primi anni della dominazione ottomana. Senza contare la crescente conflittualità interna aizzata dalle frequenti abiure di comodo e dalle conseguenti discriminazioni. Molti albanesi, rimasti di fede cristiana, iniziarono perciò ad abbandonare le loro terre, dirigendosi parte verso nord, nel Kosovo, parte verso est e verso sud in Grecia ed in Argolide, parte, infine, verso Durazzo e da lì verso l ' Italia!55 l _ Nonostante ciò la pace non regnò affatto nei Balcani, anzi , a partire dal 1430 la lotta contro i dominatori , sempre serpeggiante e spesso sfociata in sanguinose azioni di guerriglia, prese a coordinarsi e ad organizzarsi in una vera resistenza ad oltranza. Pochi anni dopo una fortunata circostanza bellica le fornì un capo leggendario: Giorgio Castriota Scanderbeg.
Nel frattempo, il regno di Napoli, il più minacciato daJJa espansione ottomana, viveva il travaglio della
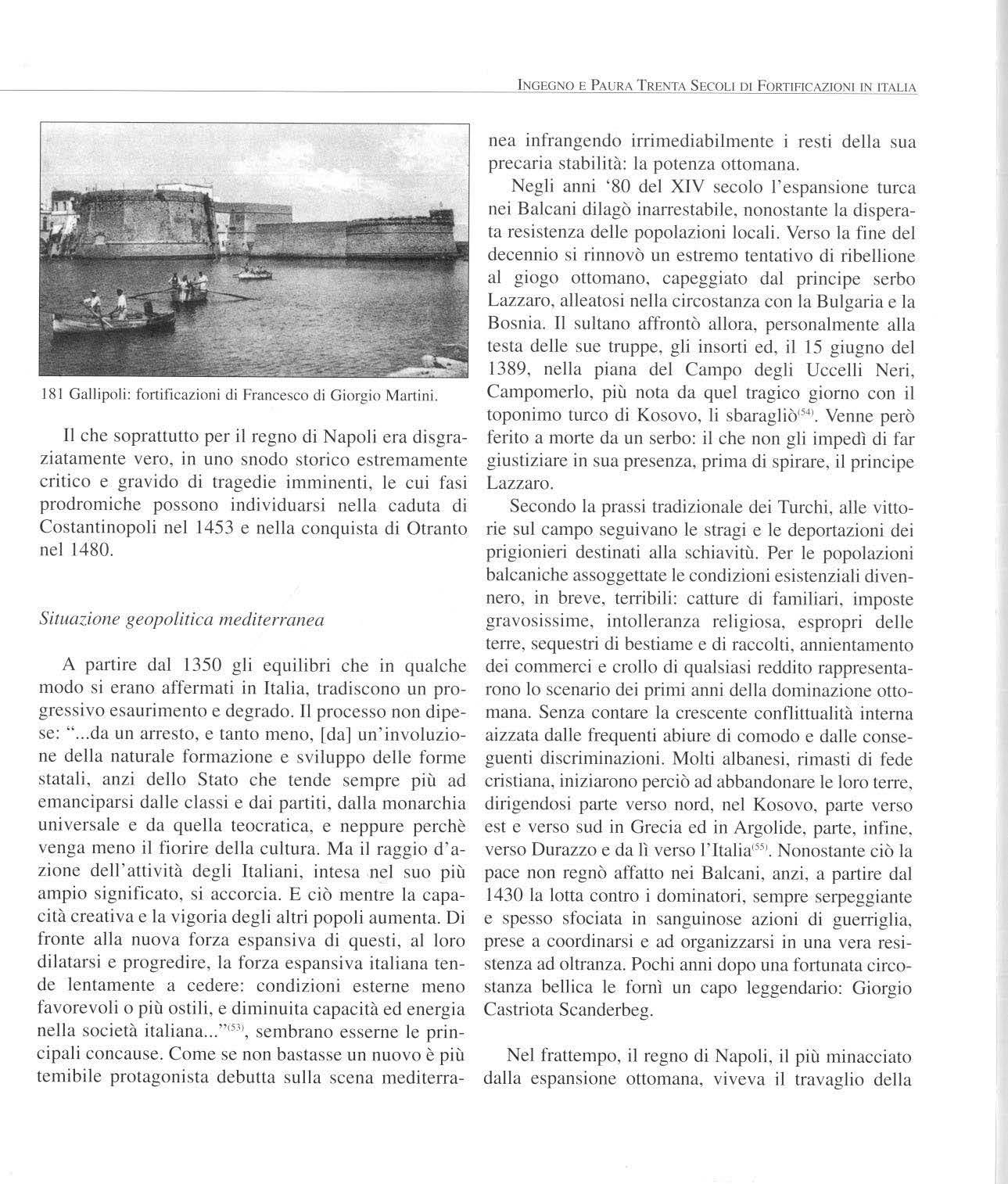
successione dinastica. A renderla ulteriormente più grave contribuì l'ascesa al trono di Spagna di Alfonso V d'Aragona nel 1416' 56', che aveva ereditato dal padre Ferdinando: " gli stati riuniti di Aragona, Catalogna, Maiorca, Valencia e Sicilia. All'epoca la Sicilia era governata dall'altro figlio di Ferdinando, Giovanni, che i siciliani, nel loro desiderio d'indipendenza, avevano tentato cli eleggere loro re. Per sventare questo pericolo, Alfonso richiamò Giovanni in Spagna. Ben presto, anch'egli si trovò trascinato nel vortice degli affari italiani, specialmente a causa della vecchia disputa fra l'Aragona, Genova e Pisa in merito alla Sardegna e alla Corsica. Alfonso si trovava appunto in Sardegna quando ricevette un'ambasciata dalla regina di Napoli, Giovanna II, la quale chiedeva il suo aiuto contro i numerosi nemici che tentavano di sottrarle il regno di Napoli. Essa promise ad Alfonso il titolo di duca di Calabria, e la successione al trono di Napoli, al momento della sua morte. Il nemico più potente della regina era il duca francese Luigi III d'Angiò che, come suo padre Luigi II prima di lui, accampava diritti sul trono di Napoli. Alfonso rispose all'appello di Giovanna, accettando i tennini della proposta. Inviò quindi una squadra navale contro Luigi, che minacciava Napoli con una flotta, riportando una vittoria schiacciante .. .Ma Giovanna era alquanto incostante e cambiò di nuovo idea; su istigazione del suo amante diseredò Alfonso, e trasferì il diritto di successione al trono a Luigi d' Angiò .. . " '571 •
Ovviamente, secondo la logica dell'epoca, la doppia adozione di Giovanna, che nonostante i suoi q uattro matrimoni non aveva avuto alcun figlio, scatenò una guerra tra i due pretendenti. L a morte della regina nel 1435, acuì la contesa tra Aragonesi ed Angioini che cessò soltanto nel 1442 dopo la vittor ia dello spag no lo(58l _
Nei Balcani, frattanto, l a resistenza contro i Turchi continuava a divampare e, proprio in quel 1442, un'armata ungherese al comando del re Ladi slao sconfisse un esercito ottomano presso Sofia. Tra le truppe catturate si trovava un certo Scanderbeg, il cui nome originar io era invece
Giorgio Castriota, di fede cristiana e di famiglia albanese, arruolato forzatamente dal sultano(59> Pur non appartenendo alla maggiore nobiltà locale i Castriota, all'epoca, vantavano già una lunga tradizione di intensi legami con Venezia, tant'è che Giovanni Castriota, padre dello Scanderbeg , ne ricevette il 19 maggio 1413 la cittadinanza onoraria. Quanto al figlio Giorgio ed al fratello Stanissa l'otte1Tanno a loro volta nel 1445. È però presumibile che intrattenessero rapporti anche più intensi con la dinastia aragonese di Napoli, alla quale infatti sei anni dopo offriranno, con un apposito trattato, la città di Croia appena strappata ai Turchi. La spiegazione deve ricercarsi nella diversa posizione assunta nel frattempo dalle due capitali in politica orientale. Venezia, infatti, si era persuasa che l'unica speranza di conservare le sue colonie ed i suoi commerci dipendeva da un accordo con i Turchi e che qualsiasi violazione, anche indiretta, ne avrebbe determinata l'inevitabile perdita.
A Napoli, invece, Alfonso d'Aragona tentava di riavviare la visione normanna e sveva circa i Balcani, ritenendoli, non a torto, di interesse strategico primario per il Regno. Il che si coniugava perfettamente con le mire della resistenza albanese. Non può escludersi, peraltro, che il sovrano cercasse di interporre una sorta di stato-cuscinetto filoaragonese, fra la costa adriatica prospiciente la Puglia e l'Impero ottomano, capace di frustrarne le ulteriori iniziative espansive e nessuno meglio degli insorti a lban esi poteva contribuire a concretizzare il progetto.
Di certo lo Scanderbeg, riacquistata la libertà, riconvertitosi al cristianesimo e recuperato il vero nome, intraprese una incessante guerriglia contro i Turchi che si sarebbe protratta, irriducibile, per i successivi 24 anni. Ma la consacrazione deJle sue doti militari si ebbe nel 1450 allorq uando lo stesso Murad II, con il figlio Maometto II, dovette rinunciare a protrarre l'assedio alla sua roccaforte stremato dalle implacabili controffensive guerrigliere: il sultano sopravvisse appena un anno alla umili ante sconfitta. 11 giovane erede, pertanto, preferì indirizzare la sua ambizione ad un più remunerativo obiettivo, la con-
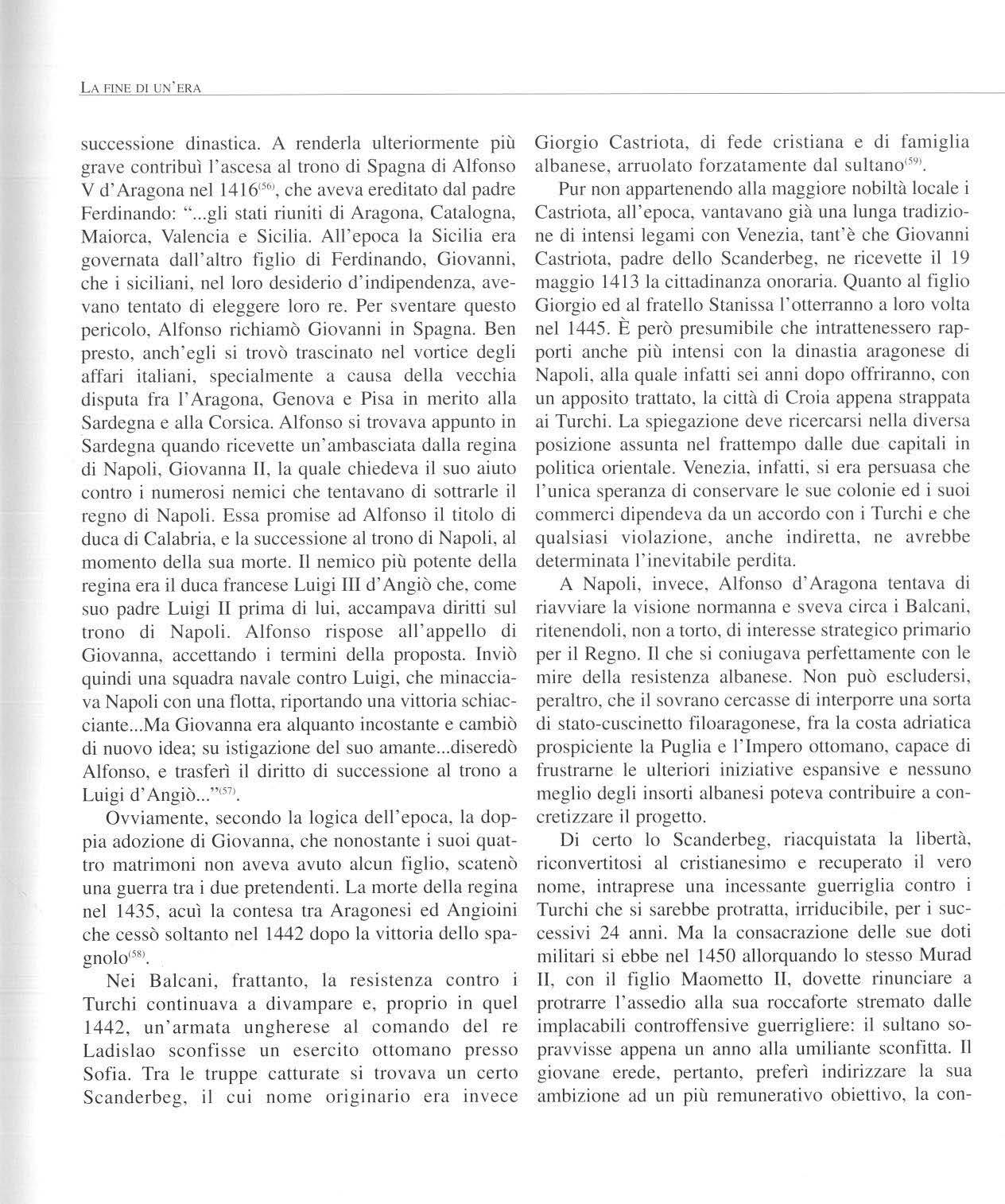
quista di Costantinopoli. Dal 1451 g li eventi presero a precipitare irrefrenabilmente verso quella drammatica conclusione.
Ad una pedante ricerca, però, non sfuggono alcuni acuti osservatori i quali, sin dal 1428 , avevano evidenziato, giustamente allarmati, che persino il semplice istaurarsi di una talassocrazia ottomana avrebbe costituito, già di per sè, una gravissima minaccia e non certamente per la sola Costantinopoli, ma per l'intera Cristianità.
La loro disperata invocazione, peraltro continuamente reiterata negli anni successivi, affinchè le potenze europee si coalizzassero superando ogni fratricida astiosità , non riscosse purtroppo alcun significativo consenso. Ancora nel 1452 scrivevano, atterriti dai rapidi progressi dell 'artiglieria turca, in cui acutamente individuavano la punta di diamante dell 'apparato militare destinato ad aver ragione della mitica Città, scongiurando le nazioni occidentali a non disinteressarsi della sua difesa , poichè nella sua inviolabilità stava collocata, senza alcun dubbio, la loro futura indipendenza e sicurezza. Ma l'accorato e lungimirante appello rimase , al pari dei consimili precedenti, assolutamente inascoltato!
Il principio della fine: Costantinopoli 1453
Le operazioni dirette per la conquista di Costantinopoli presero avvio proprio in quegli stessi mesi. In marzo il sultano Maometto II raggiungeva il Bosforo con al seguito un esercito di oltre 50.000 uomini ed una flotta di una trentina di navi di varia tipologia.
Tra i tanti rinnegati che erano affluiti presso le sue armate, attratti dal miraggio di copiose ricompense e favolose carriere, spiccava un certo Urban.
L' individuo, alquanto celebre nella sua professione, era d'origine ungherese, provetto costruttore di possenti bocche da fuoco. Dietro un lautissimo ingaggio elargitogli dal sultano, l'artigiano realizzò delle masto-
brecciare le leggendari e fortificazioni di Costantinopoli. Le maggiori avevano le seguenti caratteristiche <()()) :
la Bombarda:
Peso del pezzo: tra le 20 e le 48 tonnellate
Lunghezza dello s te sso: tra i 5 ed i 7 metri
Calibro: tra gli 800 ed i 1200 mm
Peso della palla: tra i 400 ed i 500 kg
23 Bombarda:
Calibro: circa 710 mm
Peso della palla: intorno ai 440 kg
3a Bombarda:
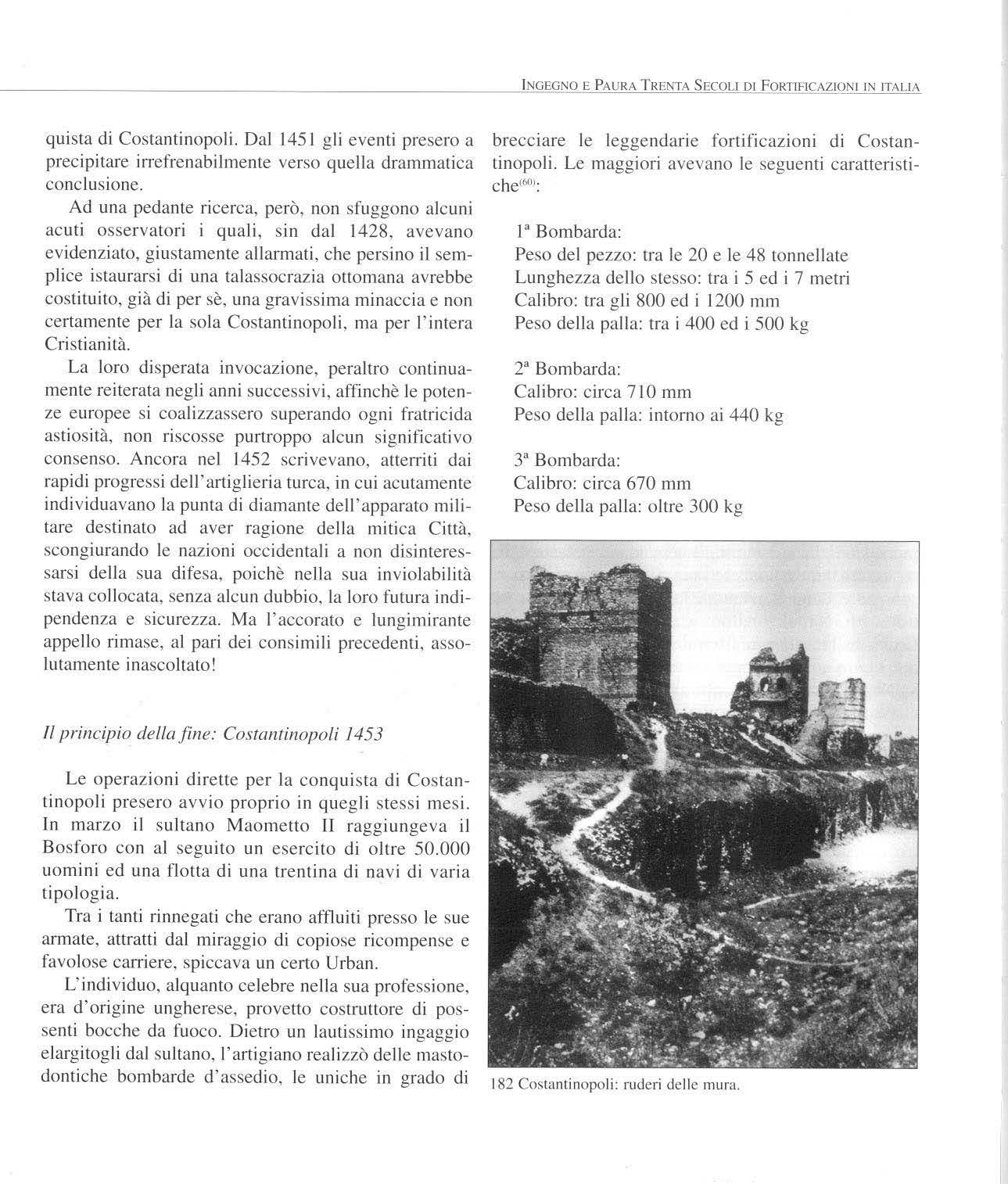
Calibro: circa 670 mm
Peso della palla: oltre 300 kg
dontiche bombarde d'as s edio, le uniche in grado di 182
Quanto ali' entità complessiva delle artiglierie schierate, gli osservatori coevi concordano in circa 50 pezzi, tra grossi e medi calibri, oltre a 500 di piccolo.
Al 55° giorno d'assedio, al terzo attacco generale, dalle brecce delle mura schiantate dalle mostruose palle di bombarda, irruppero i giannizzeri: per la capitale orientale dell'Impero romano fu la fine. Per comprendere il clima di terrore che di lì a breve si abbattè sull'Occidente occoITe, sia pur succintamente, citare una delle innumerevoli, e sostanzialmente identiche, relazioni su quanto accadde subito dopo nella disgraziata città. Così Isidoro di Kiev:
"Yiae quidem omnes strale ac angiporti sanguine
Tutte le vie, le strade ed i vicoli erano pieni di sangue e di umore sangu igno che colava dai cadaveri degli uccisi e fatti a pezzi. Dalle case venivano tratte fuori le donne, nobili e libere, legate tra loro con una fune al collo, la se rva assieme alla padrona e a piedi nudi. per lo più, e così pure i figli rapiti con le loro sorelle. separati dai loro padri e dalle loro madri, erano trascinati via da ogni parte " '"''
In poche ore della numerosa popolazione di Costantinopoli, secondo attendibili stime almeno 200.000 persone, non ne restò più nessuna al suo interno. Tutti i sopravvissuti finirono deportati e venduti come schiavi.
La funesta notizia s'abbattè sul mondo occidentale circa un mese dopo, raggiungendo ogni angolo abitato e suscitando dovunque un'ipocrita e sterile costernazione, mutando l'imbelle apatia or i ginaria in una isterica attesa delle ulteriori immancabil i conquiste turche. Circolavano di bocca in bocca notizie, più o meno attendibili, circa le imminenti iniziative del sultano. Tra queste, quella che più atterriva le popolazioni meridionali del regno di Napoli, recitava che Maometto Il:
"Primo enim triremes centum septuaginta... ha approntato centosettanta triremi tra grandi e piccole, e le ha inviate nel Mar Egeo in direzione delle isole Cicladi per sottometterle al suo impero: si s ta poi preparando con un esercito immen so verso tre città... poste sul Danubio allo scopo di espugnar-
le ... si propone di attraversare l'Ungheria, di devastarla ... ha deciso di passare in Italia il prossimo anno e così pensa di passare per mare da Durazzo a Brindisi ... " 0 10 •
La stessa allarmante diceria veniva proclamata anche da Enea Silvio Piccolomini, futuro papa Pio Il, che così scriveva il 25 settembre 1453:
" .ltaliam anno proximo invadere stat uit... Ha deciso di assalire l'anno prossimo l'Italia, sta preparando una flotta immensa. procura anche ciò che è necessario alla guerra. Ha scelto come punto di transito il tratto da Durazzo a Brindisi
GraL di Stiria, 25 settembre 1453. '% ·''
Ma, dopo un primo sommario aggiornamento delle tante fortificazioni sparse lungo la costa pugliese, il trasco1Tere tranquillo degli anni indusse gli Aragonesi a dimenticare la minaccia, sospendendo gradatamente tutti i lavori.
Stando alla maggioranza dei testimoni sopravvissuti, la squadra ottomana, circa 150 imbarcazioni, comparve dinanzi alla cittadina di Otranto il 28 del mese di luglio del 1480. 11 contingente messo a terra, e sul dettaglio le fonti non sono pienamente concordi, contava almeno I 0.000 uomini, con 5 grosse bombarde, oltre ad un numero non trascurabile di artiglierie minori<6-l> . Già la stessa sera i turchi occupavano le adiacenze di Otranto, iniziando i preparati vi per l ' investimento della cinta. Alcuni giorni dopo:
'· assestate le bombarde per far la battaglia incominciarono a battere la città da più bande, cioè <la levante da un alto dove erano certe calcare antiche distante dalle mura 540 passi, et un altro monte chiamato il monte di S. Francesco per ponente distante passi 80 dalla banda di scirocco, d ' un largo dove si diceva il monastero della Candelora distante dalle mura 60 passi et anco tenevano dalla parte cli ponente da un luogo detto la Rocca matura distante dalla città 200 passi. Però primo colpo fu tirato , fu eia questa banda di Roccamatura e diede la palla ad una finestra d'una casa che stà alla strada di mezzo che era della famiglia del li

Garbotti et andrà scorrendo per della strada fino ad un largo che si dice la piazzella quasi in mezzo alla città
Or questa balleria facevano con certe bombarde grosse di gran meraviglia c he parevano essere botti e vi erano alcune di ferro et altre dell'uno e dell'altro metallo e tiravano palle di pietra viva di smisurata grandezza meucndole dentro coli' ingegno perchè alcune erano di circuito cli dicci palmi, altre d'ouo e t a ltre di sei che ancora se ne vede per la città una quantità che tutte le strade ne sono piene [ve ne erano all'epoca anche moltissime di quelle aragonesi n.d.A.J così di dcnLro come cli fuora e le rive del mare: benchè li Signori Veneziani, quando ebbero questa città in pegno di Ferdinando II ne portorno in Venezia un a quantità grande le più bdle. più g rosse, e più meravigliose, quali posero nel loro arsenale per un t rofeo e m emor ia et erano di peso dette palle alcune di sci cantare, alcune più et alcune meno , secondo la gra nd ezza e vo lum e loro; che quando dette palle sparavano. era tanto il terrem o to c he pareva che il cie lo e l a terra si volessero a bbi ssa re. e che le case et ogni edificio per il gran terrore pareva c he allora cascassero ...
Tutti gli animali così agresti c he domestici se n'erano per la gran paura fuggiti dal tenitorio e per l' aria non si vedeva un uccello. Di piL1 usavano certi s trum enti chiama ti mortari, quali tiravano palle di pietra grossissime in alto verso l 'a ria , sp inte daHa vio lenza della polvere e cloppo cadevano dette palle in mezzo della c ittà sopra delle case, talché non s i poteva camminare per le s trad e. nè meno stare in casa laonde si pigliò espediente d'abbandonare le case e ridurre tulle le donne e figlioli nella Chiesa Maggiore sotto la co nfessione di quella con alcun i altri vecchi decrepiti. ""'''
Grazie alle gigantesche artiglierie i Turchi riuscirono a conquis tare la città il 12 agosto, dopo soli tre giorni di furiosi bombardamenti. Aperta la breccia per Otranto e la sua popolazione fu la fine: occorrerà un contrassedio di oltre un anno e mez zo per recuperarla, ormai ridotta ad un cumolo immenso di macerie. Dei s uoi abitanti, oltre 6.000, ne erano rimasti meno di 300!
Evacuati i Turchi sopravvissuti (('6l, sì provvide senza indugio alla rico s truzione delle s ue fo11ificazioni , premessa inevitabile per ripopolarla e, soprattutto, per evitare pericolose repliche della tragedia. Incaricato deJJa direzion e tecnica fu il nobile napoletano Mé:u-cello Arcamone: verosimilmente si limitò a tradurre in pratica le indicazioni architettoniche espresse dallo s tesso
duca di Calabria c he si dilettava in materia, e molto aveva appreso dalla frequentazione del Martini. La consistenza dell'int ervento è te stimoniata dall a sua strao rdinaria durata: ancora nel 1492 i l avo ri ri s ultano in corso, e questa volta so tto la supervi sio ne dello stesso Francesco di Giorg io. AJcuoi anni dopo, finalmente com pletati, rispecchiavano i più avanzati criteri della transizione.
Pe r quanto acce11abile, il: " ...recinto dell e mura di Otranto ha un tracciato poligonale c he s i può di stinguere in quattro fronti. La fronte a N o rd , in cui è la porta della città, va dalla toITe Ippolita fino al Bast ione della porta s tessa. La fronte ad Es t è costituita dall'alto muraglio ne di s ponda battuto dal mare: aveva tracciato poligonale con ripi egamenti ad angolo retto ; i quali, peraltro in seguito, furono tolti in gran parte, e sostituiti con tratto rettilineo, come oggi si vede.

La fronte a Sud è chiusa da tutto il castello ed ha una cort in a appoggiata ad un bastione, dalla parte del mare, e ad una faccia del s alient e esterno del castello, dalla parte di terra ; innanzi ad essa è un larghissimo fosso. La fronte ad Ovest è costituita, verso l'estremità meridionale da due cortine e due torri-del castello, ne ll a parte centrale , da una lunga cortina rettilin ea appoggiata ad una totTe del castello, da un lato, ed alla torre Du c hesca dal1' altro; verso l'altro es tremo da una altra breve cortina fra le due torri Duchesca ed Ippolita.
La torre Ippolita fa parte delle opere che furono costruite da Re Ferrante d ' Aragona, subito dopo aver scacc iato i Turchi da Otranto. Ebbe il nome di Ippolita in onore di Ippolita Sforza , figlia del duca di Milano e s posa di Alfonso duca di Calabria. IL suo diametro, alla sommità, è di m. 12 circa ; e l'altezza pareggia quella delle mura. Sulla sua s uperficie cilindrica, al di sopra del cordone si vede l ' arma dei re aragonesi .. .1 beccatelli che coronano la torre , e sorreggono il parapetto sovras tante, hanno sagoma composta di gusci ed ovoli dritti separati da li s telli
Dalla torre Ippolita il tracciato delle mura ripiega ad angoli molto ottu s i verso est, sino alla po11a della città. La dispos izione di que s ta porta è un caratteristico esempio de ll'architettura militare dell'epoca. E ss a è
I NGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IK ITALIA
collocata in una ton-e, o meglio tra due mezze torri del diametro di m. 1O circa. Porta e ton-e hanno la deno1ninazione di Alfonsina... Alla torre a sinistra della porta si appoggia col fianco un ampio baluardo che protegge la porta stessa con offesa di fianco, e la copre con un orecchione arrotondato, impedendo che potesse esser battuta da tiri d'infilata.
Innanzi la po,ta Alfonsina ... esiste tuttora ... un'altra porta praticata nel muro, che... costituiva una linea di difesa più avanzata a proteggere l'ingresso della città. Dinanzi a questo muro correva il largo fosso ... L'asse della porta esterna è molto spostato ed obliquo rispetto a quello della porta Alfonsina; in guisa da ottenersi più 'entrate reverse · come diceva Francesco di Giorgio Martini .11 castello giace nel l'angolo sud-ovest della città .'"°7)
Per una serie di osservazioni sulla struttura delle mura e sui nomi dei torrioni è lecito concludere che la cittadina apparve ai Turchi serrata da una cerchia non molto dissimile da quella descritta, con un circuito sostanzialmente identico, ma con torri e cortine senza dubbio più sottili e più alte, attribuibili alla fase intermedia della transizione. Quanto. poi. fosse gravoso l'adeguamento di siffatte fortificazioni alla fase finale
della transizione lo testimonia pienamente il lentissimo avanzamento dei lavori ad Otranto. nonchè un significativo dettaglio: dopo sedici anni, molti dei pezzi destinati all'armamento della cerchia e del castello stavano ancora custoditi nelle cripta della Cattedrale. Il luogo, uno dei pochi scampato alle distruzioni, e reputato più di ogni altro sacro per l'indiscriminato eccidio dei cittadini che vi si svolse '(,N ), avrebbe potuto solo in forza di una esigenza non altrimenti soddisfacibile trasformarsi in deposito di artiglieria. Ovvio, quindi, presumere che, a quella data, facevano difetto tanto le strutture del Castello come i locali destinati alla conservazione delle munizioni e delle armi, ai quali in ogni costruzione militare si destinò una comprensibile priorità. L'emblematica constatazione ci è consentita eia un inventario dell'armamento esistente. redatto nel 1496 in occasione della cessione temporanea di Otranto a Venezia. Lo stesso prezioso documento ci permette di vagliare quanto tradizionale fosse rimasta l'artiglieria aragonese rispetto a quella di Carlo Vlfl, e per estensione la coeva architettura militare.
Artiglierie dei forti e del castello di Otranto consegnate dal Comm;ssario del Re al Governatore Veneto il 25 marza del 1496.
''Serenissimo Principi et Exccll. mo

D. D. Augustino Barbadino. Dic XXV Mensis Ma1i lndictione Xliii, in civitate ldrunti.
Bona reperta in civilate ldrunti et per magnificum D. Aloy si urn dc Caxali Novo. Comrnis~ariurn et Deputatum specialem nuncium Serenis. mi Regi s Neapoli. clc. Magnificoquc Domino Petro Superantis pro 111. mo Ducali Domino Yeneratirum Guberna101i diete civitaLis consignata, et primo: Videlicet.
Una bombarda de bronzo nominata la Rognosa con lo mascolo a viola. la u·omba larga palmi 4 I /2. et lo muscolo longo palmi 4 1/2, larga de bocca palmi 2 J/3 posta a la cortina de Grissolio. Item una bomharda de fc1TO nominata Yìceopinione. longa palmi 4 1/2, larga in bocha cum uno mascolo Je bronzo. longa palmi 4 l/4. larga in bocca palmi doi.
In la dieta cortina:
ltcm una bombaJda de bronzo. nominata la Famata, senza anelli, longa palmi 5. lo rnascolo de bronzo a vita longo palmi 3 1/4, larga dc bocca palmi 2, sc hienzata lscheggiatal in bocha desoto, posta in la dieta cortina.
Item una bombarùella de ferro cum doi ane lli , cum uno mascolo inzocada vecchia. cum tuta palmi 7. nella dieta co11ina, larga quatro dea rdi La l in boe ha.
ltem una bombarda dc ferro nominata Miser in po, longa palmi JJ • la tromba cum anelli 6. lo mascolo lungo palmi 4. larga in bocha palmi I 1/2. lo mascolo e l'imbocatura è rota .
Jtem una bombarda de ferro de reparo, longa palmi 9 cum el mascolo con doi anelli, larga in bocha do dea, susu la torre.
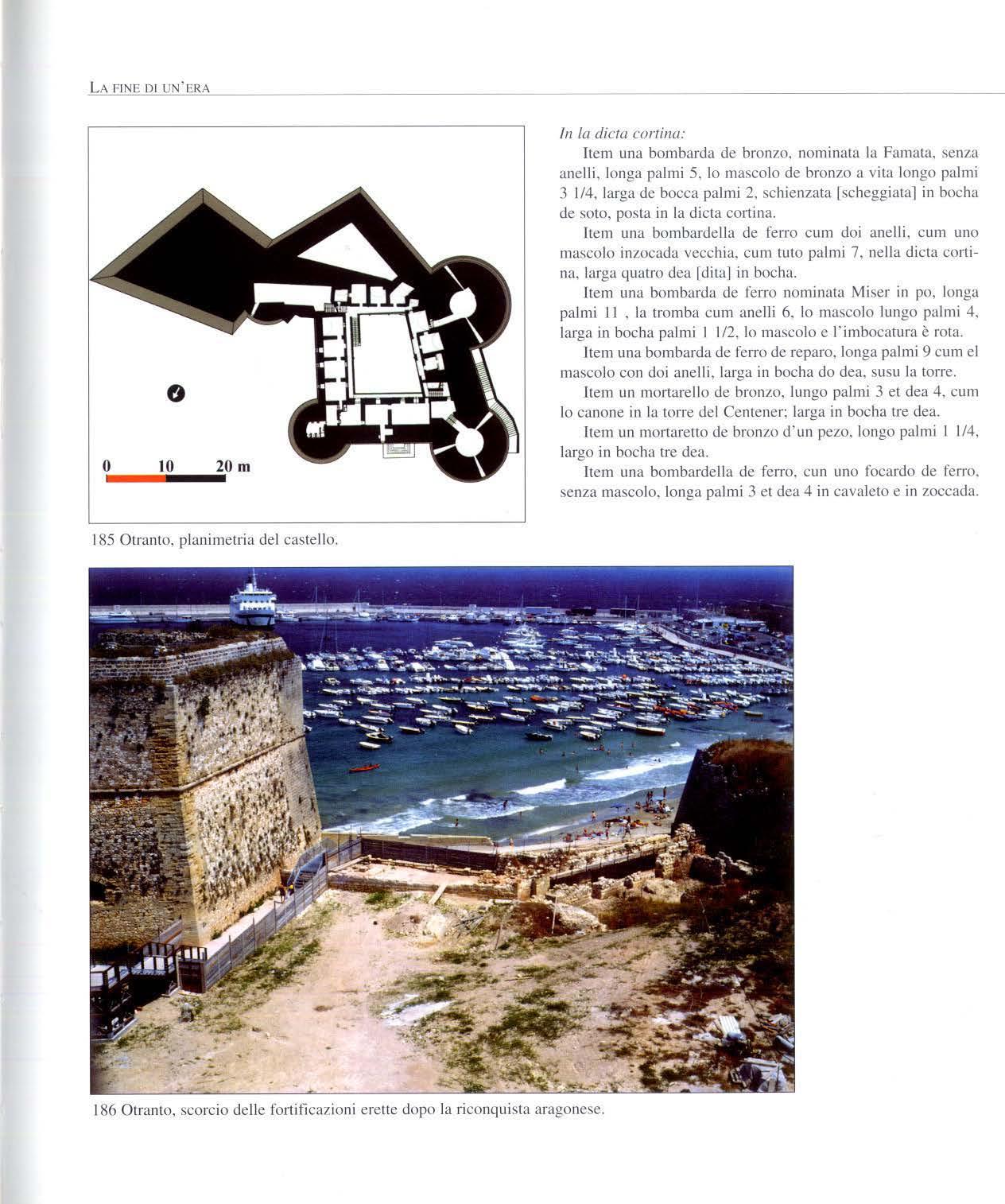
ltem un mortarello de bronLo, lun go palmi 3 et dea 4, cum lo canone in la torre del Centener: larga in bocha tre dea.
Item un mortaretto de bronzo d'un pezo, longo palmi I 1/4, largo in bocha tre dea .
ltem una bombardella de ferro. cun uno focardo de ferro. senza mascolo. longa palmi 3 et dea 4 in cavaleto e in zoccada.
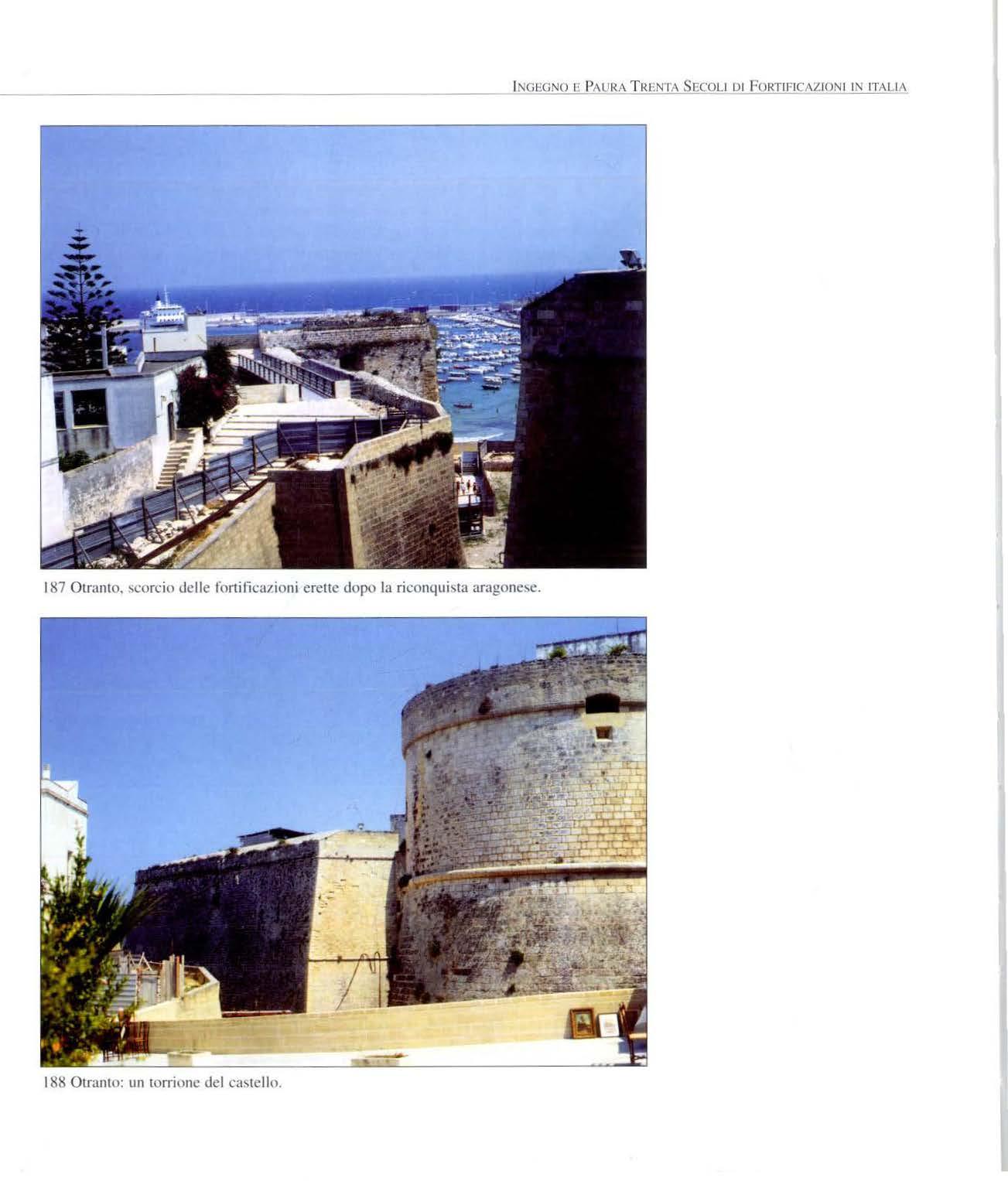
Item un mortaretto de bronzo senza mascolo cum una forcada. in cavaleto senza pironi, longa palmi I et deda rdita I 4.
In la forre Maistra della porta
Item una bombardclla de fcm> cum forcada in cavalleuo et pironi, longa palmi 3 senza mascolo. larga in bocca dcc.la 3, so pra la po1ta.
Item una bombarde ll a dc feJTo cum forcado in cavalletto et pironi, longa palmi 3 senza mascolo , larga in bocca deda 3, sopra la porta.
Item una bombardella de ferro cum uno forcado e pironi in cava ll etto et pironi, longa palmi 3, larga in bocca 3 deda, sopra la dicata toJTe.
Item una bombardella de ferro rota , non val niente.
Item tre mascoli de ferro. longi palmi do. r uno cun anello. uno per mascolo sopra la dieta totTe.
Item una bombarda de fetTo lunga palmi 4 l/2 cum anelli 4 in suso caro inazzo se nza mascolo, larga in bocca mezzo palmo curo so forcacla et pironi posta al Maistro Campaner.
Item un passavolante de bronzo , longo palmi 13 de l Signa! della covezza in un pezm, largo in bocha deda 4 suso uno carro roto cun suo forcado et pironi al dicto campaner.
Alla torre de la Canronada
Una bombarda de fetro cum anem 3. longa palmi 6, larga in bocca deda 6.
Item un bombardella de ferro in cavalleno com forcada et pironi, longa palmi 4 e decla 3, larga in bocha deda 3. rota in boca.
Alla forre Duchessa
Quattro bombarde de ferro in cava lletto. cum forcadc et pironi. longa palmi 4 e dea 3 l'una , larga in bocca 3 dea.
Item una bombardella de ferro senza forcade c pironi , longa palmi 3 1/2.
A la torre Hipolita
Quattro bombarde de ferro in cavalletto cum forcade e pironi. longa palmi 3 l/2, larga in bocha 3 dea.
Item un passavolante di feJTo cum anelli 4 in cavalletto cum forcade et pironi, lungo palmi 9, largo in bocha 3 dea.
A la torre sopra lo Portone
Tre bombarde ll c con cavallclli forcade et pironi, longe pa l mi 3 l'una, larga in bocha 3 dea, cum uno masco lo per una bombarda.
Su la rorre del Ma zzamne
Tre bombardelle de ferro in caval letti cum una forcada sola. longa pa lmi 6, l'una , larga in bocca 3 dea cum li canoni
ftem una bomba rdella de bronzo in cavalletto cum forcade et
pironi. cum el suo mascolo, lon ga cum lo mascolo palmi 4, larga in bocha 4 dea
Item un mortaretto de bronzo de uno pezzo, longo palmi doi e mezo, larga in bocca 4 dea
Item una bombarda nominar.a S. Maura de bronzo foderata de ferro. lunga palmi 5, cum uno mascolo de feJTo longo palmi 31/2. larga in bocha palmi I et dea 4 cum el suo lecto.
Item una bombarda de ferro cum anelli 4 susu un carro rotto cum forcada et pironi, longa palmi 7. larga in bocha dea 6
Item un carro cum due rote cerchiare de fcno per passavolante ...
Item doy cannoni da bombarda da reparn de ferro rotti , longi palmi 2
In la rorre del Ma zzamne
Item un canone da bombarda de ferro com suo anello bono longo palmi 2
Item 29 masco li de sp ingardelli de ferro boni cum soi maneggi. et alcuni senza maneggi, longi palmi 1 sotosopra

Item doi mascoli de spi ngarde de ferro curn li soi anelli longi palmi do l'uno.
Al Celso
Una bombarda de bronzo nominata la Rufiana longa palmi 5. cum li soi mascoli.
Alla cortina Duchesca et alla torre Hipolita
Do bombarde de fem) cum cavalletti in forcade et pironi, longa palmi 3 l' una. larga in bocha tre dea. larga in bocha palmi I. cum doi ,mclii de ferro.
In caxa de Maesfro G11lielmo Bombardiere
Sette mascoli de bombardelle de ferro, longi un palmo l'uno
Item 3 mascoli de ferro da passavolante cum anelli 2 l'uno , longi palmi 2 l'uno
Item doi mascoli de ferro da bombarda cum li so i anelli. longi palmi 2 l'uno
Item dt1e mortarelli dc bronzo cum due doi anelli de ferro, longi pa l mi 2 1/2 l'uno. largi i n bocca dea 4.
Sotto la Confessione della Chiesa
Cannoni I8 de bronzo cum soi manegi longi palmi 11 /4 so!osopra
Undexe bombarde de bronzo mm anelli 2 e 4 per una. longa palmi 3 sotosopra, larga de bocca dea 4 in 6
Sy IseìJ archi bus i de bronzo cun so i forcade. longi palm i S l'uno
Quattro forcade de bombarde cum 3 p ironi
Una bombardella de ferro et guasta picola.
U luno] pa<,,avolanre dc ferro longo palmi IO largo in bocha dea 4, sen1.a mascolo e t sen t a so ca rro Quat o rd ex an.:hibusi clc ferro cum w i manegi. l ongi pa lmi 4 l'uno
Una bombardclla de bronzo cum uno ma,;colo, longa palmi 2 el mascolo I palmo. larga in bo c ha 3 dea. U na forcacla dc ferro curn pirone " 1 '.
L ' inventario s i dilun ga quindi nelle munizioni , che risultano se mpre di tipo tradiLional e se nza a lc una palla di ferro. Eppure. se mai fosse s tata dis ponibile un'artiglieria più mod e rna proprio ad Otranto se ne s arebb e trovata tra cci a in quel fine seco lo. Del res to una identica architettura e, se n La dubbi o, un id e ntico armamento s i riscontrano pure nelle ma gg iori piazze aragon es i dell a Sicilia e d e lla Sardegna.
Mila =:.zo
Nel medesimo contes to di paura e di fren e ti ca riorganiz zaL ionc difensiva del dop o Otranto deve co llocarsi anche la riqualificazion e della c ittadella di Milano. Dal punto di v is t a morfologic o il s uo promontorio d 'im pianto ricorda quell o di Gaeta, ergendos i per un cen tinai o di metri s ul mare con pareti a picco , a ppena meno ripide verso l'istmo che lo co llega alla t e rraferma. Analoga pure , per molti aspetti, la sua vicenda s torica. Infatti , per il naturale arroccamento , e per la sottos tant e prese nza di un ottimo port o, il si to ris ulta con tinuam ente abitato s in d a ll a più re mota antichi tà. Al vi llaggio preistorico si sostituì, alcuni millenni dopo . una so rta di acropoli, se mpre prot etta da fortificazioni dipanante s i s ul medesimo tracc iato e con la medesima logica ostativa.

Con l'ellenizzazione di Mylai: " avvenuta tra J'VII1 ed il VII secolo, racropoli greca assunse nuova dimensione, che non mancò di accrescersi nei secoli successivi, con il «castrum» romano bizantino espugnato e raso al suolo. netr843 dal condottiero arabo Fadhl Ibn Giàfar. Su queste antiche fondamenta i nuovi conquistatori non tardarono ad innalzare un loro fortilizio dando così inizio al nucleo più antico dell'attuale Castello coll'integrare (soprattutto sul fronte est, sud-est) le difese già predisposte dalla natura.
Nel medioevo la funzione fo>trategica del Castello di Milazzo ... Lqualc] antemurale di Messina, acquistò un significato ed un valore più rìmarchevoli ... divenendo, poi, la chiave della difesa del settore orientale della Sicilia .. .'''701 • li che comportò un susseguirsi di consistenti potenziamenti ed aggiornamenti alle fortificazioni. l'ultimo dei quali rimonta al periodo vicereale, procedendosi, da allora in poi. alla semplice manutenzione delle strutture. rimaste in servizio anche dopo l'Unità d'Italia.
La vera peculiarità, quindi, della Cittadella di Milazzo è nella invarianza della sua destinazione, per nùllenni esclusivamente militare. e. sostanzialmente preclusa agli insediamenti civili. Non essendoci, pertanto, alcuna pressione residenziale interna , nè a ridosso della cerchia, al momento di riqualificarla la soluzione più semplice fu quella di duplicm"la erigendone una più evoluta a breve distanza. Per l'identico motivo, un volta ultimata non fu necessario demolire la più vecchia onde recuperarne l'ingombro. Al termine della lunghissima vicenda, si ebbe un sistema concentrico con opere tanto più antiche quanto più vicine alla sommità del promontorio.
Il borgo racchiuso in una sua autonoma cinta muraria, si articola alla sua base, sulla streua lingua dell'istmo, ottimamente servito da un capace porto, già famoso caricatore di grano nel Medioevo. Le acque ad esso antistanti furono testimoni di grandiosi eventi storici, a riprova della rilevanza strategica del luogo. Tra questi, spicca, la mitica battaglia navale tra Romani e Cartaginesi, svoltasi nel 260 a.C., nel corso della la Guerra Punica, che vide la vittoria del console Caio Diuilio' 711 •
La spianata apicale del promontorio fu ritenuta in epoca sveva ideale per rimpianto di un ennesimo castello: forse a suggerirlo contribuì il grande dongione quad1ilatero normanno che già vi sveltava da oltre un secolo e mezzo.
Di ce110 quando l'architetto Riccardo da Lentini, d'ordine di Federico TT, ne elaborò la planimetria in virtù della sua solidissima muratura e ragguardevole mole, pensò bene di inglobarlo nell'erigenda castello, assegnandogli il ruolo di mastio. Probabilmente a quella scelta progettuale va ascritta la singolare pianta trapezoidale assolutamente inedita nella produzione federiciana, ma che neUa fattispecie meglio aderisce al ciglio tattico del promontorio. Ne conseguì perciò un maniero i cui due prospetti principali appaiono di dimensioni diverse, il maggiore sul fronte a tcn-a cd il nùnore a mare. Immutate rimasero le connotazioni accessorie. quali le torri quadrate angolai·i e <li mezzeria, e la loro tetra severità accentuata dagli scuri conci lavici dei cantonali e dalle archeggiature ogivali. Ma laddove il protomastro accentuò la sua libertà creativa fu nel!' inserimento del dongione al centro del prospetto minore.
Formalmente quest'ultimo si presenta, pur tenendo conto dei molteplici interventi successivi, adattativi ed integrativi. come un tipico prodotto dell'architettura normanna, forse uno dei migliori, munito di possente scarpatura basamentale su tutti e quattro i lati. Va, inoltre. osservato che la scai-patura per il suo inserimento nelle cortine del castello svevo deve necessariamente supporsi antecedente allo stesso e, quindi alle anni da fuoco, emblematica conferma di quanto in precedenza supposto al riguardo. Nei rilievi del Negro<12 > redatti nel XVII secolo, il mastio domina ancora vistosamente la massa del castello, mentre al presente eccede di pochi metri le sue cortine ed ostenta, per giunta, un parapetto a profilo balistico con una cannoniera strombata per lato. Ovvio, pertanto, ritenere che la sua cimatura avvenne solo nel corso di quello stesso secolo, in notevole ritardo con la prassi, grazie alJ'avanzamento della linea difensiva sulla pendice del promontorio che lo poneva al riparo dai tiri d'artiglie1ia. Essendo la scarpa del don-

190 Mi lazzo , panoramic a
gione alta circa 10 m , sui 14 residui , è credibile che lo stesso originariamente attingesse la trentina di metri , caratteristica che, tenendo conto della quota d ' impianto. doveva renderlo estremamente importante per i collegamenti a distanza con gli altri caposaldi della Sicilia orientale , spiegandosi così la riluttanza ad abbassarlo. Al presente è correntemente definito come ' toITe saracena ' o 'araba ' , appellativo che gli derivò più che dalla finalità, dal contes to in cui sorse, ovvero della conquista nom1anna dell ' isola dagli ::u-abim• .

In età aragonese, iniziatosi a manifestare pienamente il devastante ruolo delle artiglierie negli assedi, anche a Milazzo fu giocoforza procedere alla riqualificazione del castello. La soluzione adottata fu di tipo canonico, ovvero si circondò la vecchia opera con una possente muraglia scandita da mastodontici torrioni fortemente aggettanti verso l'esterno e la si chiamò, ovviamente, 'la cinta aragonese·. In realtà, però, più che di una cinta vera e propria, si trattava di uno sbar-
ramento fortificato, correndo da un estremo all ' altro del promontorio, in maniera da isolarne la s ommità s u cui s orgeva il castello e su cui già svettava il dongione. Il restante perimetro non richiedeva nulla del genere in quanto naturalmente inaccessibile: per puro scrupolo lo si serrò. comunque, con una leggera murazione condotta in aderenza al suo ciglio, senza particolari accorgimenti interdittivi, ad eccezione di un paio di piazzole per artiglierie.
In dettaglio l'opera aragonese constava di una robustissima cortina, vistosamente scarpata per l'intera altezza, daUa quale fuoriuscivano , più del rispettivo raggio , cinque torrioni di notevole diametro, con basamento scarpato e corpo cilindrico. Su di essi nessuna traccia di coronam,ento , forse eliminato in seguito, forse mai costruito: la loro sommità è risolta da un parapetto a profilo balistico in cui si aprono diverse cannoniere fortemente strombate. La porta di accesso alla cittadel.la si ricavò in prossimità del versante settentrionale. fra gli

ultimi du e torrioni impiantati apposita m en te a breve intera sse.
Sebbene il potez iam e nto aragonese vada asc1itto, co n buona probabilità, al co ntesto della g uerra otrantina, e comu nque in epoca posteriore a l 1470, l ' interesse di re Alfonso p e r Milazzo risulta di gran lun ga antecedente, esse ndo quel castello uno dei ve rtici del sistema Mess ina-Taormina-Siracusa, da cui ne] XV seco lo dipendeva il contro ll o d e ll ' intera isola . Un diplo ma del 1444, infatti, così lo certifica:
AJfon so per grazia di Dio re d'Aragona e di Sicilia
Cons id erando dunque il sit o e la dispo sizione del luogo della Città di Milazzo, che è pross ima e di fronte ai nemici e cons iderando sopra ttutto come sovrasti il pericolo su Jl e altre parti indi fese dell'intero Regno: perciò, essendo nostra volontà p revedere e provvede re pèr il futuro, e poichè l a s uddetta argomentazio ne c i rende
favorevoli aJla cus todi a ed al rafforzamento delle fortificazioni della s te ssa Milazzo , c he i naturali vo Jlero difendere intrep idamente e con fe 1mezza, crediamo e siam fenni su tal proposito. qui da noi attestato dal presente privilegio"11•>
La cinta arago nese no n fu l'ultimo avanzamento della line a dife ns iva d ella cittadella di Milazzo. Il rapidissimo progredire dell'artiglieria ne van ifi cò ben prest o l ' apporto , ad onta della sua imponenza. Agli inizi del XVI secolo s i stimò, pe11anto, indispensabile procedere ad una ulter io re riqualificazione del caposaldo La so lu zio ne escogitata , significativame nte, fu id entica: erigere un nuo vo sbarrame nto, questa volta bastionato, più avanzato, ma sem pre corren te da un estremo all'altro del promontorio in modo di poITe fuori tiro, tanto il dongi o ne quanto il castello e la stessa c inta aragonese. L' opera s i avviò a partire dal 1523 ed ebbe, l ogicamente, l a d efinizione di 'ci nta s pagnola '<75 , _ I l av01i s i protrassero p er c irca un a ve ntin a d 'a nni , sotto la dii-ezione . dell ' in geg nere militare Antonio Ferramolino.
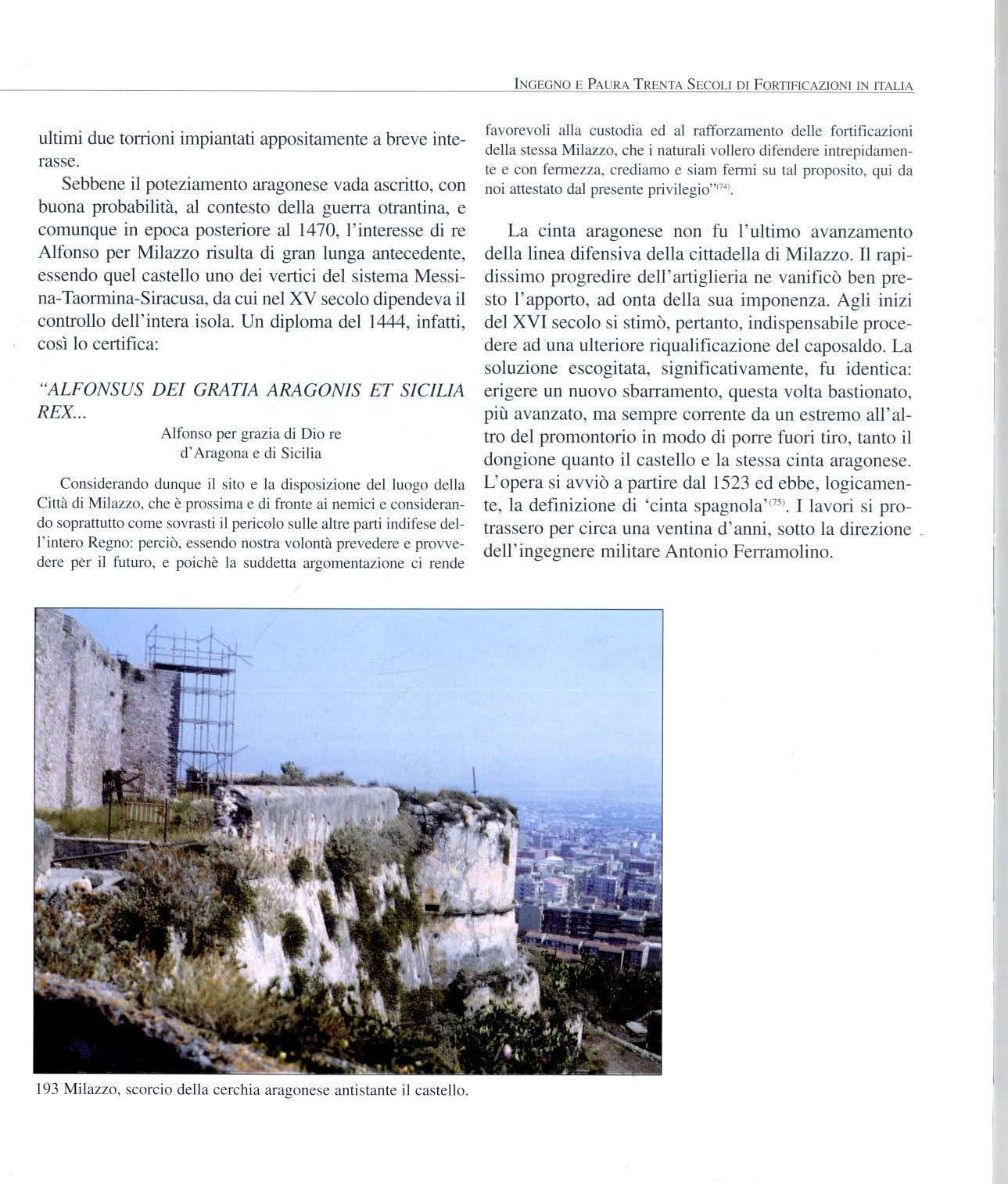 193 Mi l azzo, sco rcio della cerch i a aragonese anti s ta nte il castello.
INGEGNO E PA URA TRENTA SECOLI D I FORTIFICAZIONJ IN ITALIA
193 Mi l azzo, sco rcio della cerch i a aragonese anti s ta nte il castello.
INGEGNO E PA URA TRENTA SECOLI D I FORTIFICAZIONJ IN ITALIA

 I NGEGNO E PAURA T RENTA SECOLI DI FORTIFlCAZIOt',1 IN ITALIA
I 96 Mila zzo, particolare innesto torrione cortina.
197 Mila zzo: ingresso de lla cerchia arago nese.
I NGEGNO E PAURA T RENTA SECOLI DI FORTIFlCAZIOt',1 IN ITALIA
I 96 Mila zzo, particolare innesto torrione cortina.
197 Mila zzo: ingresso de lla cerchia arago nese.


Un'altro interessante caposaldo riqualificato nel corso della transizione dagli Aragonesi, e che ricorda sia pure in tono minore jl precedente, è quello di Castellaragonese, già Castel Genovese , ed attualmente Castelsardo. Costituì a lun go il polo difensivo settentrionale della Sardegna, ed in quanto tale 1icevette per diversi secoli costanti cure ed attenzioni tese a potenziarne ed a migliorarne le fortificazioni Come la sua movimentata vicenda toponomastica sottintende, la costr uzione originaria va attribuita ai Genovesi , agli inizi del XD secolo, quando: " il castello e più tardi la ci ttà con la sua cinta fortificata, venivano elevati di fronte al mare , in una singolare e meravigliosa posizione, disposti quasi ad arco sulla vetta e sul ripido fianco di un promontorio , alta l 14 metri, a picco verso il mare e digradante verso la terra dove tende a formare un piccolo istmo.
È certo che la cinta fo rtifi cata raggiungeva il s uo massimo sviluppo molto tardi, giacchè, dal principio non vi doveva essere altro che il 'cas tello', circondato dalle case e dalle capanne, sotto la cui protezione erano state edificate ... " 1761
• Per quanto è ormai assodato furono i Doria a creare: " due punti d'appoggio da una parte e dall'altra di Sassari: Alghero e Castelsardo, dal semplice scalo di Fruisano. Le due rocche sì pensa, risalga-
no all'incirca all'anno 1100: si tratta di realizzazioni rapide, che attestano una ferma volontà di colonizzazione e di intervento ... " <rn
Il sito d 'i mpianto di per sè già inattaccabile, uno scoglio di granito circondato quasi interamente dal mare, fu reso del tutto inaccessibile con opere concettualmente simili a quelle di Gaeta e cli Milazzo. Al pari delle due celebri piazze, anche Castellaragonese godeva di un sottostante approdo, la Cala di Frigiano o di Fruisano, che gli forniva il basilare accesso da mare, improbo da recidere in caso di assedio. Una pressocchè totale oscurità avvolge le prestazioni militari del1a minacciosa rocca durante i primi tempi de11a s ua esistenza. Di assedi, senza dubbio, ne avrà sostenuti diversi ma di espugnazioni, probabilmente, nessuna come l'immutata sovranità genovese lascia motivatamente presumere: dal che la consolidata fama di inviolabilità.
La conquista aragonese della Sardegna, attuatasi nel corso del 1323 , rappresentava la premessa indi spe nsabile per la restituzione della corona di Sicilia, secondo gli accordi di Anagni accettati da Giacomo II suo re '181 • L'impresa fu diretta dall'infante Alfonso, futuro Alfonso III-IV, il Benigno. I D01i a, i Malaspina, Sassari ed Ugone d'Arborea, consci della ineluttabile conclusione della vicenda, strinsero su bito accordi con gli Aragonesi, ottenendone un 1iconoscimento feudale.
200 Castelsardo. panorami ca INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI I N ITALIA 201 Caste lsardo: porticcio lo di Fruisano.Pisa, invece, affrontò il combattimento, ma soccombette rapidamente: Iglesias cadde il 7 febbraio del 1324, Cagliari si arrese il 19 giugno, e poco dopo la sfortunata Repubblica dovette cedere al re d ' Aragona ogni suo diritto sull'isola. Grazie alla lungimirante alleanza
Castel Genovese, restò nelle mani dei Doria, tant'è che gli stessi, in data 1336, ne accettarono gli statuti del borgo. Soltanto nel 1448 re Alfonso, dopo un asprissimo e lungo a s sedio , riuscì ad averne ragione strappandolo alla potente casata: per meglio sotto lin eare la rilevanza dell'evento lo ribattezzò Castellaragonese , nome che manterrà fino al 1767.

È probabile che la conquista: " sia avvenuta con notevoli danni e distruzioni ... [ma] la ripresa deve esse-
re stata abbastanza facile , sia per la compatte z za del1' abitato in relazione alla limitata estensione, sia soprattutto per la posizione e le caratteristiche morfologiche del sito, fattori che avevano contribuito alla s ua fortuna ma anche all'inevitabile incapsulamento entro una forma urbana che richiama più il castelliere preistorico se non proprio il villaggio nuragico che la fortezza medievale. L' impressione che si ricava già all ' inizio del XIV secolo è quella di un borgo ordinato , praticamente autosufficiente entro le sue mura e il s uo territorio " (79) , P ertanto , quasi certamente, dall ' indomani della conquista iniziarono i lavori di ammodernamento e potenziamento dell'arcaico, ma coriaceo , fortili z io.
Si trattò, comunque, dj interventi integrativi , tipici della fase intermedia della transizione , poichè ben presto il ruolo di principale piazza fu acquisito da Alghero, con conseguente decadimento strategico di Castellaragonese. Nel 1543, infatti, i pochi abitanti del borgo lamentavano che le mura ormai si sg retolavano per vecchiaia ed incuria. Tuttavia l 'agg ravars i dell'incursività turco-barbaresca determinò l 'es igen za di mantenerlo ancora in servizio, dotandolo di un minimo di artiglieria, senza però aJcun ulteriore significativo intervento sulle fortificazioni.
Roma in una moschea; nessuno ignorava l e tenibili conseguenze della impreparazione. Pertanto come accennato, a partire dal 1481, s i avviò una radicale riqualificazione delle fortificazioni di Gallipoli , di Taranto e di Brindisi , in particolare, dove s i edificò s ull'i s ola di S. Andrea un forte a forma di grossa torre quadrata , chiamato Castello Ro sso<80 > Sempre alla stessa epoca , e per il medesimo fine, rimonta la costruz ione del Caste llo di Baia presso Napoli 1811 , a difesa del golfo di Po zz uoli , di cui il Sumrnonte nella s ua Cronaca dice:
Riconquistata Otranto il tardivo programma di rifortificazione del regno di Napoli fu alacremente portato avanti. Nessuno ormai reputava millanterie le ambizioni ottomane di trasformare anche S. Pietro in

" ... (Alfon s o Il) fè una fortezza sopra il porto di Baia per defenzione di Pozzuoli , la quale fin' à nostri tempi s i vede e s i chiama il Castello di Baia " '82 '.
Tuttavia, le motivazioni che costrinsero la dinastia aragonese a quell 'i mmane programma difen s ivo non vanno individuate esc lu s ivamente nella minaccia turca,
204 Ba ia , panoramica del castello. INGEGNO E PAURA TREN TA SECOLI DI FORTIFIC AZION I IN ITALI/\che indubbiamente restava la principale, ma anche nella crescente ostilità della Francia di Carlo VIII, che non lasciava presagire un futuro tranquillo. Si spiega così che nel 1484 si avvertì impellente la necessità di provvedere a rifortificare la stessa Capitale'83 ' Pure in questo caso si seguirono identici criteri architettonici, sebbene logicamente su scala ben diversa e significativa: una sorta di ve1tice massimo della transizione.
Esauriti i complessi preliminari. con l'avvento dell'estate, la grandiosa fortificazione venne finalmente iniziata:
"Hoggi che sono 15 jugno 1484 si è posta la prima preta de le mura nove di Napoli con le tun-e, et s 'ei posta innaiui lo Carmine present.e la maestà dc lo signore re Fen-ailte, et lo capo dc delle mura e i messer Francisco Spiniello .' ""')
Così nella scarna cronaca del Passaro la descrizione della cerimonia della posa della prima pietra della erigenda murazione di Napoli. Al di là di alcune conte-
stazioni sulla data del!' effettivo inizio dei lavori, può ritenersi certo che, nell'estate del 1484, con grande solennità e sotto la diretta supervisione del Re, si pose mano all'ampliamento della sezione orientale della cerchia urbana, a partire dallo 'spigolo del Caimine'. La fastosità della cerimonia meglio sottolineava la tilevanza della costruzione e, soprattutto, il suo ingentissimo onere: quasi trentamila ducati reperiti mediante l'imposizione di ulteriori gabelle.

L 'o pera, senza dubbio fra le maggiori del secolo in Italia, aveva avuto una lunga incubazione. Già nel 1463 infatti si era proceduto ad un ridotto ampliamento della tratta prospiciente la marina' 85 ' Ma , nei termini di un programma organico ed esecutivo, quale fu poi concretamente realizzato, non si può retrodatarla oltre il 1483.
La murazione di Ferrante era destinata a snodarsi lungo la direttrice Forte del Carmine-Castel Capuano-Foria. Po sta la prima pietra. e l'immancabile iscrizione comme-
morativa dell ' avvenimento still a facciata del vecchio torrione dello Spero ne (s u ccess ivam e nte detto del Carmine per la vicinanza dell 'omonima chiesa), i lavo1i s i arrestarono per circa cinque mes i. La costruzione riprese nel novembre dello ste sso anno , quando iniziarono ad operare contemporaneamente diversi cantieri. Il Fo1te de llo Sperone, baluardo di rilevante importanza tattica, in quanto simm etrico del rinnovato ed aggiornato Castel Nuovo , fin} per e ssere incastonato fra i torrioni chiamati ' La B rava' e 'Trono'. Quest'ultimo costituiva il vertice di un angolo approssimativamente retto fra la direttri ce parallela alla marina e quella orientale. Poco o nulla risulta delJa tratta meridionale, ossia costiera: di s icuro all'inizio del l 500, prima quindi che fosse edificata quella vicereale ad occidente, essa esisteva con le relative p01te ed era oggetto di regolare manutenzione.
Alla fine del seco lo , tutta v i a. la murazione non era ancora totalm e nt e ultimata . La sezio ne orientale , utili zza ta int eg r a a nche nel s uccess ivo a mpliamento vicereale , ed alcune altre a nord e lun go la marina dovett ero essere fra quel l e portate a termine. Il co mple t ame nto del pe rim etro difensivo ebbe, per direttore dei lavori, Antonio Marchesi e s i ri so ls e proprio ne gl i ultimi mesi di reg no della din astia aragonese.
La direzione ini zia le , invece , seppur limi tatamente a ll a so la componente architettonica, era s tata sostenuta da Giuliano da Mai ano (1432-1490), se mpre sotto la sovrinte ndenza d e llo Spinelli. Gli succe sse il verone se Fra Giocondo<x 6) , rinomato tecnico , che ri sul t a operante a Napoli alla fine d e l 1489: a lui si de bbono, tra l 'altro , molti ss imi disegni reda tti per il trattato di arc hi tettura ed in gegneria militare di Francesco di G iorg i o Martini , che a partire dal 1491 compare ad intervalli regola1i a Na po li (lo s i era visto , co mu nque. fino a quel momento, con una ce rta frequ e nza , se bbene in maniera occasionale). Ciò l ascia fondatamen te supporre eh' eg li ab bi a av ut o un ruolo tutt 'altro che seco ndario nella progettazione e nella d irezione delle e rigende mura aragonesi. Confermere bbe l'a sse rto la s ua presunta presenza a Napoli in occasio n e della cer im on ia di po sa della prima pietra , come ri s ulta da

cronache contemporanee. Non è, infine, da escludere che lo stesso duca di Calabria, abbia partecipato all 'ideazione <~11
La poderosa fortificazione, snodantesi originari amen te per quasi due chilometri, era costituita, in sintesi, da una massiccia cortina ad andamento rettilineo-spezzato , difesa da ben venti tonioni lungo la direttrice orientale, più uno lungo la marina, tutti di mastodontiche dimensioni, fuoriuscenti in saliente dal filo esterno della cortina. Un ampio e profondo fossato debitamente controscar pato, impediva l'ac-
costamento alla muraglia; quattro ponti, in corrispondenza di altrettanti varchi, di cui tre a carattere monumentale , le famose porte del Carmine , Nolana e _ Capuana, ed uno di tono minore. detto di S. Sofia, assicuravano l'accesso alla città.

La struttura muraria deJla cortina s i componeva di una so lidi ssima massa passiva, con spessore oscillante fra i cinque ed i se tte metri , edificata impiegando blocchi di tufo giallo di estrazione locale, ben cementati. La sua faccia esterna era rivestita di una durissima corazza lapidea di basalto grigio, realizzata con conci parallelepipedi di circa cinquanta centimetri di spessore e di equivalente altezza, dispo s ti in corsi regolari magistralmente giuntati. Verticalmente, in stretta osservanza dei canoni martiniani , essa appariva divisa in due sezioni di cui l'inferiore scarpata, con discreto angolo di abbattimento, e la supe1iore, invece, perfettamente a piombo: in mezzo il redondone
Il diametro dei torrioni ostenta una vistosa escursio ne fra la decina di metri e gli oltre venti. La loro massa era interamente piena: cavi erano solta nto, e parzialmente, quelli che fiancheggiavano le porte. Le esigenze della funzione avevano imposto alcuni vani, dove erano aJJoggiati il corpo di guardia ed il
presidio per la manovra della chiusura. Sulla terrazza di copertura di tutti i torrioni erano postate le artiglierie, al riparo de11a semp lic e merlatura, s ia pure di tipo più robusto, a merloni. di quella medievale. Tale di spos izione poco felice delle batterie difen s ive sulla 'piazza d'armi', ad un so l o o rdin e di fuoco scoperto, "in barbetta ' , è tipica della tran s izione
ancora in capace di s fruttare a pieno i nuo v i armamenti. Questa valutazione è confermata dalla presenza in diversi torrioni di anacronistiche ca ditoie , utili esclusivamente per la difesa ravvicinata ed in netto contrasto. quindi, con quella a di s tanza imposta da ll e artiglierie: è in pratica un ultimo retaggio della guerra ossidionale dei seco li precedenti.
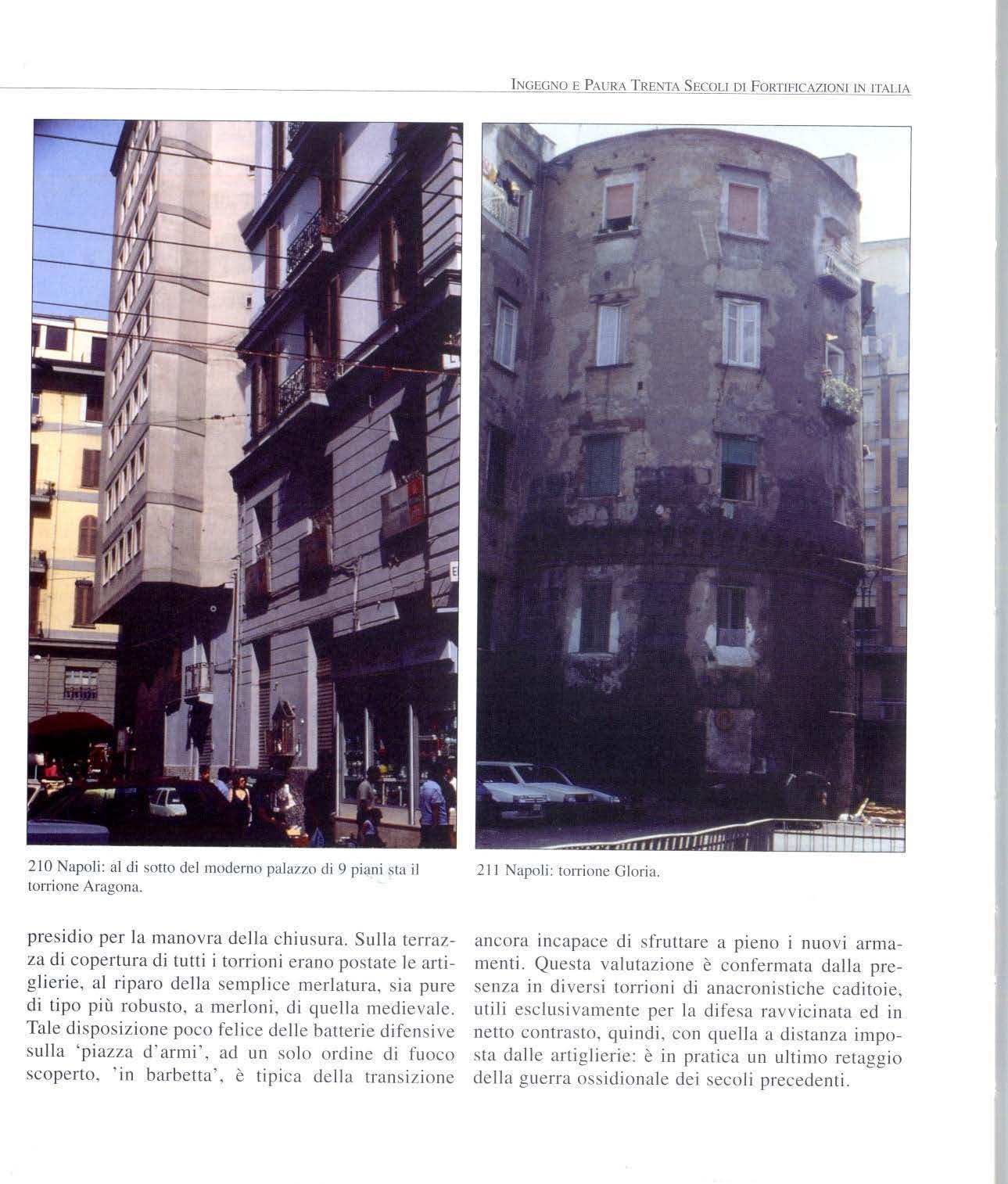 210 Napoli: al di sotto del moderno palano di 9 piani sta il tonion e Aragona.
210 Napoli: al di sotto del moderno palano di 9 piani sta il tonion e Aragona.
Il coronamento dei merloni non presenta criteri di uniformità: infatti in alcuni è sorTetto da una teoria di archetti poggianti su mensoloni che fuoriescono dal corpo cilindrico dei torrioni, dietro i quali si aprono le famose caditoie: in altri, invece, ampi lastroni aggettanti sostituiscono gli archetti, formando così una sorta di ballatoio, completato sempre dai merloni. In que-
sf ultima configurazione manca il secondo coronamento torico ritenuto, logicamente, inutile. Le significative differenze potrebbero essere imputale sia ad un adeguamento alle rapide evoluzioni tec1ùche, che si andavano elaborando mentre la murazione era in corso, sia più semplicemente al diverso avviso dei vari tecnici che nel tempo diressero i lavori.

Dei ventuno torrioni aragonesi ne restano oggi soltanto quattordici, più o meno deturpati e fagocitati da una squallida edilizia abitativa. Della poderosa cortina soltanto radi lacerti di poche decine di metri, e per giunta I imitatamente alla sola sezione scarpata, ci permangono, anch'essi molto manomessi ed alterati. Sono scomparsi del tutto i I fossato, che doveva misurare oltre venti metri di larghezza ed almeno sei di profondità, ed i ponti antistanti alle porte. Identica sorte per l'ampia strada di circonvallazione interna, che assicurava la perfetta agibilità della fortificazione, il munizionamento e la manovra delle artiglierie. Essa formava, inoltre, una
vistosa fascia di rispetto, che impediva, o meglio avrebbe dovuto impedire, il progressivo costipamento delle difese da prute dell'edilizia civile. Le strutture murarie delle porte Nolana e Capuana ci sono pervenute fortunatamente abbastru1za integre: quella del 0U"mine, invece, fu vandalicamente demolita nel secolo scorso.
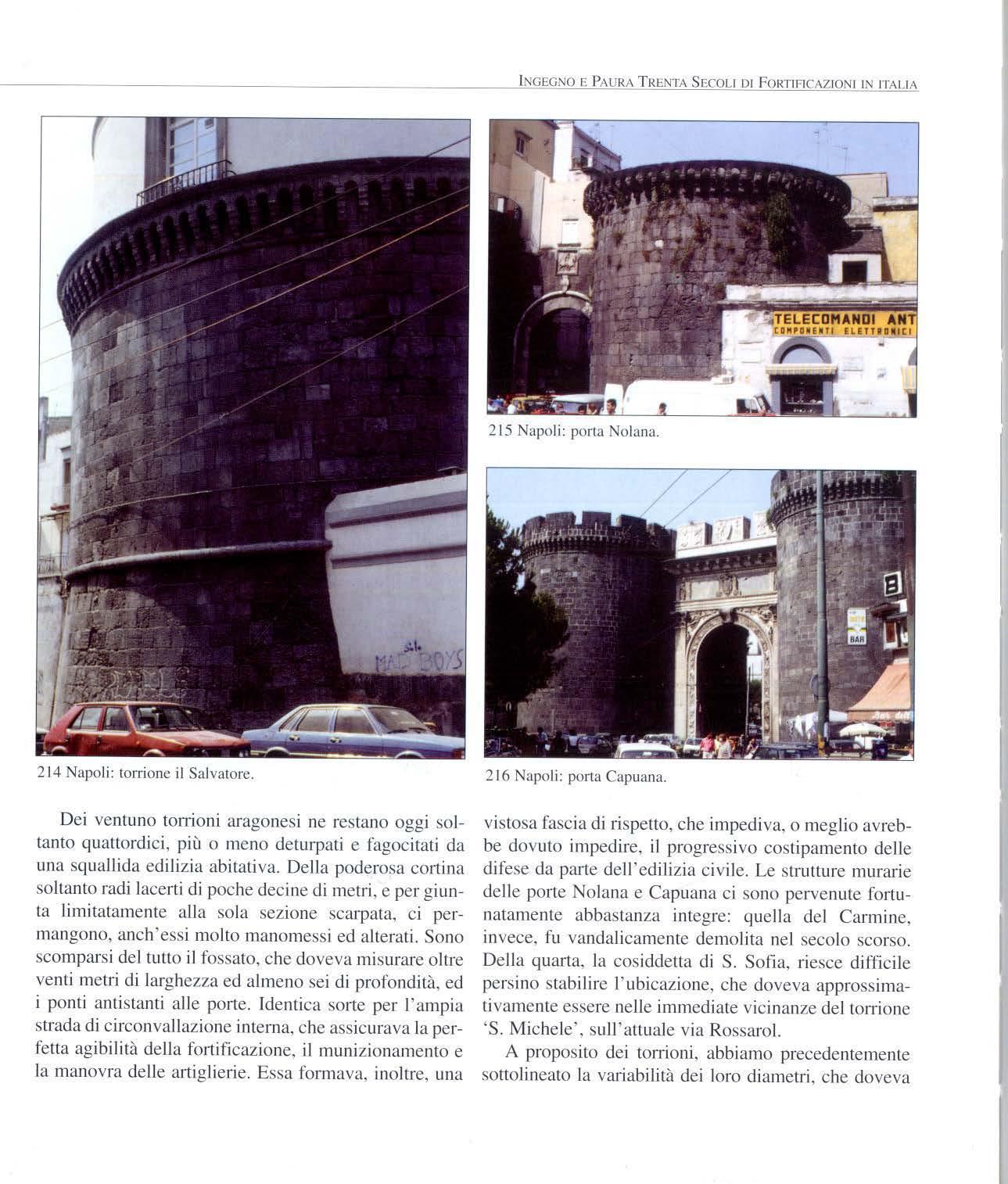
Della quarta, la cosiddetta di S. Sofia, riesce difficile persino stabilire l'ubicazione, che doveva approssimativamente essere nelle immediate vicinanze del ton-ione ' S. Michele ' , sull'attuale via Rossarol.
A proposito dei torrioni, abbiamo precedentemente sottolineato la variabilità dei loro diametri, che doveva
214 Napoli: torrione il Salvatore.però necessariamente 1ientrare anch'essa in una logica strutturale di stretta osservanza dei dettami dell'ingegneria militare. I criteri di dimensionamento per l'epoca in questione , come accennato, possono essere ricondotti fondamentalmente a due. Il p1imo di essi vede il diameu·o funzione dell'angolo esposto, il secondo funzione dell'aimamento. Nel nostro caso deve essere stato adottato senza dubbio il primo, poiché non si riscontra dalle dimensioni dei torrioni e dalla loro posizione planimetrica alcuna significativa logica di armamento. Analogo discorso va fatto per gli interassi dei tonioni, la cui escursione esula da qualsiasi plausibile scopo difensivo. Infatti essi non sono costanti, come sarebbe stato normale in una fortificazione perimetrale urbana di questo tipo: dai 55 m dei segmenti cli cortina compresi fra i torrioni Duchesca-S. Efremo-S. Giovanni, si passa agli oltre 150 fra 'Fortitudo ' -'Fedelissima'-'Cara Fè'. Jn generale si osserva un addensamento a nord di porta Nolai1a, fino al torrione ' S. Michele'. Nei primi 300 m, fra le p01te del Carmine e Nolana, ad esempio. ve n ' è uno solo, mentre nei successivi 450 se ne contano ben cinque.
Anche a carico del tracciato, lungo cui si snoda la fortificazione aragonese, è possibile riscontrare I' identica discontinuità rilevata per gli interassi dei torrioni. Infatti, rifacendoci alla planimetria, possiamo osservare che, mentre le tratte di cortina a sud di porta Capuana sono perfettamente rettilinee ed allineate (chiaro indice, se non altro , di una predeterminazione e libertà coerentemente perseguita in fase esecutiva) a nord di essa la situazione è completamente diversa. Più che di un allineamento , sarebbe esatto parlare di una spezzata casuale, priva di ogni appiglio teorico di natura militare, quale, ad esempio, l'aderenza al ciglio tattico od al tracciato a salienti e rientranti. Si deve pertanto dedurre che la murazione, almeno nella sua tratta settentrionale, fu pesantemente condizionata da favoritismi ed interessi privati , oltreché da complessi edilizi inamovibi1i<881 •
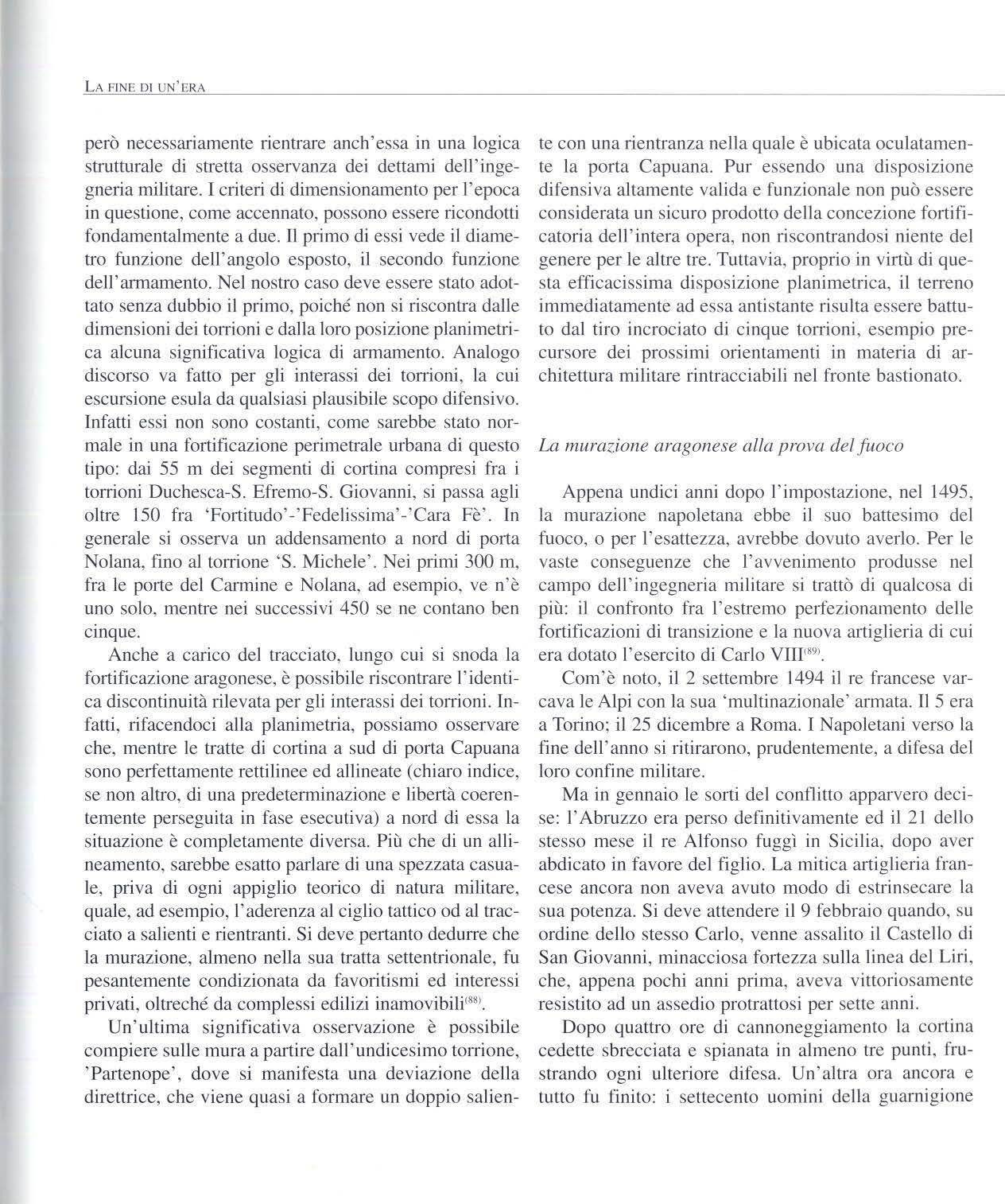
Un'ultima significativa osservazione è possibile compiere sulle mura a partire dall'undicesimo torrione, 'Partenope', dove si manifesta una deviazione della direttrice, che viene quasi a fonnare un doppio salien-
te con una rientranza nella quale è ubicata oculatamente la porta Capuana. Pur essendo una disposizione difensiva altai11ente valida e funzionale non può essere considerata un sicuro prodotto della concezione fortificatoria delJ ' intera opera, non 1iscontrandosi niente del genere per le altre tre. Tuttavia, proprio in virtù di questa efficacissima disposizione planimetrica, il terreno immediatamente ad essa antistante risulta essere battuto dal tiro incrociato di cinque torrioni, esempio precursore dei prossimi orientamenti in materia di architettura militare rintracciabili nel fronte bastionato.
La muraz ione aragonese alla prova d el fuoco
Appena undici anni dopo l'impostazione, nel 1495, la murazionc napoletana ebbe il suo battesi mo del fuoco, o per l'esattezza, avrebbe dovuto averlo. Per le vaste conseguenze che l'avvenimento produsse nel campo dell'ingegneria militare si trattò di qualcosa di più: il confronto fra l'estremo perfezionamento delle fortificazioni di transizione e la nuova artiglieria di cui era dotato l'esercito di Carlo VIII 189>
Com'è noto, il 2 settembre 1494 il re francese varcava le Alpi con la sua 'multinazionale ' armata. Il 5 era a Torino; il 25 dicembre a Roma. I Napoletani verso la fine dell'anno si ritirarono, prudentemente, a difesa del loro confine militare.
Ma in gennaio le sorti del conflitto apparvero decise: l'Abruzzo era perso definitivamente ed il 21 dello stesso mese il re Alfonso fuggì in Sicilia. dopo aver abdicato in favore del figlio. La mitica artiglieria francese ancora non aveva avuto modo di estrinsecare la sua potenza. Si deve attendere il 9 febbraio quando, su ordine dello stesso Carlo, venne assalito il Castello di San Giovanni, minacciosa fortezza sulla linea del Liri, che, appena pochi anni prima, aveva vittoriosamente resistito ad un assedio protrattosi per sette anni.
Dopo quattro ore di cannoneggiamento la cortina cedette sbrecciata e spianata in almeno tre punti. frustrando ogni ulteriore difesa. Un'altra ora ancora e tutto fu finito: i settecento uomini della guarnigione
giacevano massacrati. [I pan.ice dilagò: Capua si atTese il 18 febbraio, non osando opporsi. Lo stesso accadde a Napoli, dove il 20 l'avanguardia francese entrò senza aver sparato un colpo. Il 22 Carlo VITJ sfilò per la città dopo il solenne ingresso alla testa della sue truppe da Porta Capuana, abbastanza simile-ironia della sorte-ad un arco di trionfo.
Il tempo storico delle mura aragonesi era irreversibilmente scaduto. Con una cadenza di fuoco di due colpi l'ora i grossi cannoni d'assedio, in grado di sparare addirittura al di fuori della gittata del tiro di controbatteria, in meno di mezza giornata avrebbero potuto, agevolmente, sgretolare ampi tratti della fortificazione.
A Napoli la murazione ru·agonese non subì alcun smantellamento: sopravvisse restando in un certo senso i I monumento di se stessa.
Le apprensioni aragonesi su possibili ulteriori aggressioni ottomane, intorno alla fine del XV secolo, non erano affatto immotivate, non manifestandosi la benchè minima attenuazione della spinta espansiva islamica. Le sue terribili incursioni, infatti, si abbattevru10 ormai anche su località ritenute geograficamente sicure e militarmente protette, come ad esempio il Friuli, abbastanza lontano dalla sponda del!' Adriatico , da secoli considerato l'inviolabile golfo di Venezia. Al riguardo le: " prime vere minacce si ebbero nel giugno 1499, col guasto del territorio di Zara. Pure i provvedimenti difensivi furono lenti e scru·si. L'attenzione del Senato era troppo assorbita dal teatro di guerra milanese e da quello sud-orientale, ove nell'agosto cominciavano presso Modone le ostilità! Ai 3.000 uomin.i del presidio di Gradisca si aggiunsero 1.300 cavalli, e solo all'ultimo, con l'acqua alla gola, dall ' occupata Cremona si fecero partire altri 600 cavalli e 1.000 fanti che non poterono giungere in tempo... Il 28 settembre la tempesta ottomana, da 7 a I 0.000 uomini, si rovescia sul Friuli. Il provveditore veneto Andrea Zancati non
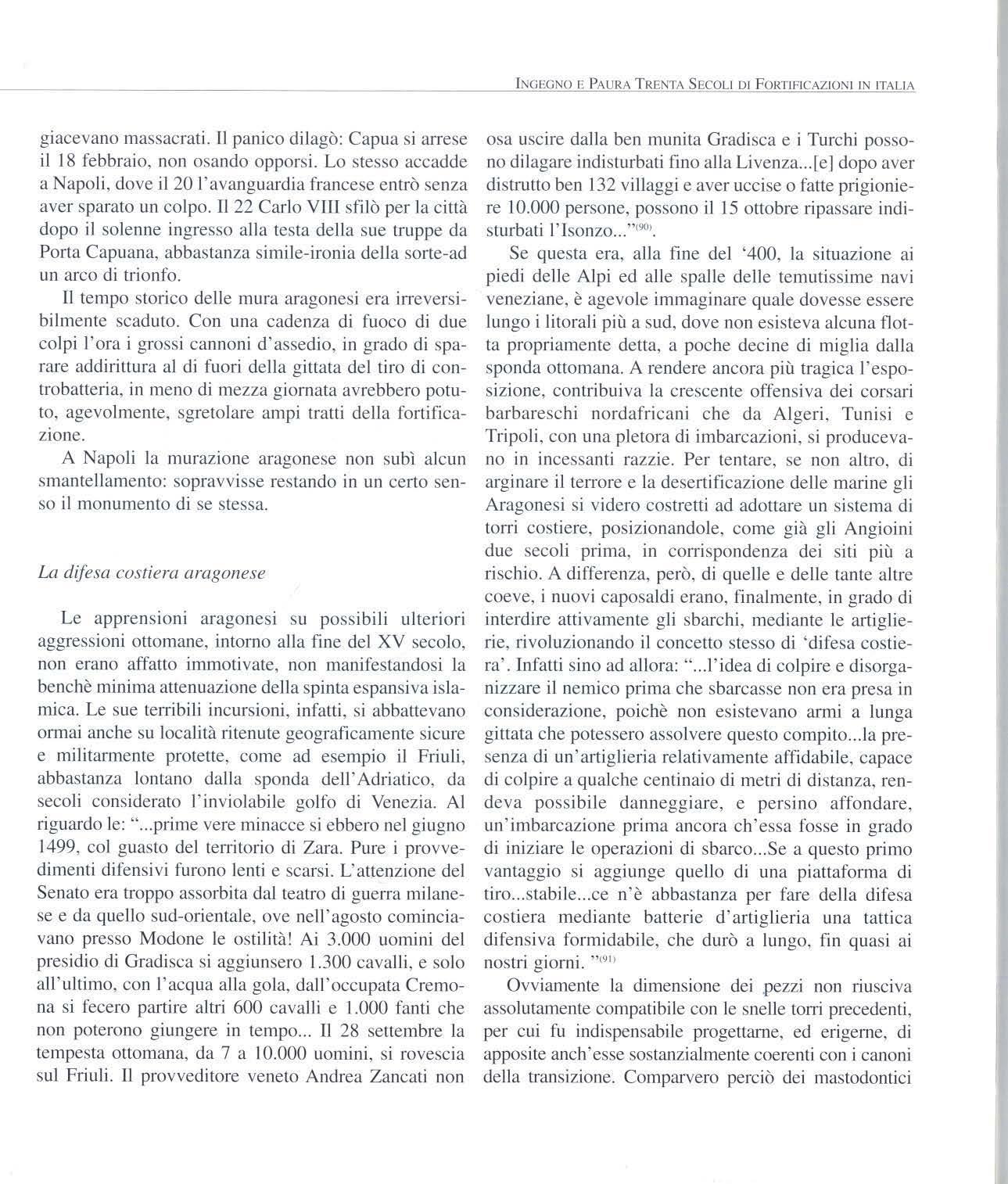
osa uscire dalla ben munita Gradisca e i Turchi possono dilagare indisturbati fino alla Livenza ... [el dopo aver distrutto ben 132 villaggi e aver uccise o fatte prigioniere I 0.000 persone, possono il 15 ottobre ripassare indisturbati l ' Isonzo ... " 1<xn _
Se questa era, alla fine del '400, la situazione ai piedi delle Alpi ed alle spalle delle temutissime navi veneziane, è agevole immaginare quale dovesse essere lungo i litorali più a sud, dove non esisteva alcuna flotta propriamente detta, a poche decine di miglia dalla sponda ottomana. A rendere ancora pi C1 tragica l 'esposizione, contribuiva la crescente offensiva dei corsari barbareschi nordafricani che da Algeri, Tunisi e Tripoli, con una pletora di imbarcazioni , si producevano in inces s anti razzie. Per tentare, se non altro, di arginare il teITore e la desertificaz ione delle marine gli Aragonesi si videro costretti ad adottare un sistema di torri costiere, posizionandole, come già gli Angioini due secoli prima , in corrispondenza dei siti più a rischio. A differenza, però, di quelle e delle tante altre coeve, i nuovi caposaldi erano, finalmente, in grado di interdire attivamente gli sbru·chi, mediante le artiglierie , rivoluzionando il concetto stesso di ' difesa costiera'. Infatti sino ad allora: " .l'idea di colpire e disorganizzare il nemico prima che sbru·casse non era presa in considerazione, poichè non esistevano armi a lunga gittata che potessero assolvere questo compito .. .la presenza di un'artiglieria relativamente affidabile, capace di colpire a qualche centinaio di metri di distanza, rendeva possibile danneggiare, e persino affondare, un'imbarcazione prima ancora ch'essa fosse in grado di iniziare le operazioni di sbarco ... Se a questo primo vantaggio si aggiunge quello di una piattaforma di tiro ... stabile ... ce n'è abbastanza per fare della difesa costiera mediante batterie d'artiglieria una tattica difensiva formidabile , che durò a lungo, fin quasi ai nostri giorni. " 191 >
Ovviamente la dimensione dei pezzi non riusciva assolutamente compatibile con le snelle torri precedenti , per cui fu indispensabile progettarne, ed erigerne, di apposite anch'esse sostanzialmente coerenti con i cru1oni della transizione. Comparvero perciò dei mastodontici
INGEGNO E PAURA TRENTA S ECOLI DJ Fo1n IFICAZIONI IN ITALI Atorrioni, quasi dei fo1tini a pianta circolare, cospicuamente armati, ma per il loro ingentissimo costo, di numero necessariamente limitato. fn ogni caso costituiscono una basilare tappa della difesa costiera. ed anticorsara, presente lungo le marine italiane.
Un interessante esempio del genere si rintraccia poco più a sud di Castelsardo, per l'esattezza a Bosa, presso la foce del Temo, dove domina con la sua enorme massa cilindrica l'estremità rocciosa di una lingua di sabbia, protesa nel mare per circa 400 m. Al l'epoca della costruzione il piccolissimo promontorio appariva nettamente staccato dalla terraferma, essendo ancora l'Isola Rossa. Circa la precisa collocazione cronologica della fortificazione, sebbene venga correntemente attribuita al cinquecento, è più sensato ravvisarla nell'ultimo scorcio del XV

secolo, o, al più tardi, nei primi anni del successivo. Conforta tale supposizione la vicenda dell'ostruzione del Temo attuata, nel 1528, quale estrema difesa contro la paventata risalita del suo corso da parte delle imbarcazioni francesi. 11 rimedio, si dimostrò ben presto peggiore del male: il fiume, infatti, si impaludò irrimediabilmente m> privando la cittadina del suo porto-canale, approdo abituale delle coralline, e fonte di cospicui introiti. Impensabile, pertanto, che in un contesto cosl degradato si sarebbe innalzata un'opera di tanta imponenza, in gran parte a spese degli abitanti limitrofi. Del resto le connotazioni architettoniche sono al riguardo inconfondibili. La scansione volumetrica rispecchia perfettamente i canoni martiniani , con basamento scarpate e terrapienato, cornice torica, corpo cilindrico ed una caditoia sull ' ingresso.
L'acces so al piano agibile, posto al di sopra del redondone, avveniva mediante una scala volante e s terna, attraversando un doppio ordine di serramenti con intercapedine di sicurezza. In dettaglio un portone
all'esterno. sormontato da una vistosa bertesca, e, dopo un risicatissimo veslibolo a sua volta dominato da una piombatoia ricavata nell'enorme spessore del muro. una saracinesca all'interno.
Nel vasto locale la pianta da circolare diviene ottagona con, al centro di ogni lato, una profonda e strombatissima troniera, per selle pezzi di piccolo calibro, essendo l'ottavo vano occupato dall'ingresso. Si tratta in definitiva di una enorme casamatta ad otto appostamenti, ridondanza consentita soltanto dal rilevante diametro del torrione. Per lo stesso motivo. però. non era adottabile una coperlura formata da una volta a calotta. troppo debole per sostenere le sollecitazioni statiche e dinamiche impresse dai grossi calibri che avrebbero dovuto istallarvisi sopra. La loro presenza è certificata dalle sette cannoniere in barbetta, a doppia stromba mm, ricavate nel massiccio parapetto: r ottava è sostituita deJl'imbocco della piombatoia e della bertesca. La soluzione elaborata consistette nel suddividere rintcro ambiente in otto spicchi uguali, ciascuno dei quali concluso da una volta a vela triangolare, convergente su di un grande pilastro centrale, anch'esso ottagono, sul quale scaricava. L'insieme determinava una struttura estremamente solida e compatta, eseguita con eccezionale maestria.
Al livello dell'imposta delle vele si scorge ancora una teoria di gattoni destinati a sorreggere un impalcato ligneo che suddivideva ve1ticalmente il locale in due ambienti, riservando la parte superiore ad alloggio della guarnigione e quella inferiore alla batteria. Un grosso camino. le cui tracce sì scorgono sul pilastro, fungeva da cucina e da riscaldamento nonchè da indispensabi l e complemento per il servizio ai pezzi. L'accesso alla piaaa d'armi somnùtale avveniva attrave rso una scala ricavata ne llo spessore del muro.
Dal punto di vista offensivo i l torrione di Bosa si conferma quasi isotropo. La leggera, ed ineliminabile, asimmetria relati va al vano d'ingresso ed alla bertesca, fu orientata verso terra, da dove l'offesa si presumeva trascurabile.
Assurdo, pertanto. tentare di attaccarlo da mare esponendos i al tiro senza dubbio più preciso e pesan-
 218 Bosa: dettaglio ingresso de l torrione.
219 Bosa: dettaglìo piazza del torrione.
218 Bosa: dettaglio ingresso de l torrione.
219 Bosa: dettaglìo piazza del torrione.
te dei suoi pezzi. E forse proprio per la comprovata validità si ricavò da quella tipolo gia una variante di dimensioni appena più modeste. e quindi meno costosa, da sc hierare sia nel regno di Napoli, sia di Sicilia, s ia in Corsica. Proprio una di siffatte torri fu protagonista. alla fine del '700, di un singolare episodio che ne attesta ulteriormente la perfetta rispondenza alla funzione.

La Corsica rientrò per un lungo periodo nei possedimenti aragone s i, ricevendo perciò anche lei alcune
torri anticorsare nei sit i più a rischjo. Tra questi il piccolo centro di S. Fiorenzo, affacciato sull'omonimo golfo alla base della penisola di Capo Corso, dove fu eretta a Punta delle Mortelle.
Nel corso delle ostilità tra Francia ed lnghilte1Ta, successi ve alla Rivoluzione, il 7 febbraio del 1794, comparvero dinanzi alla ormai vetusta torre due unità da guerra britanniche , per resattezza I' HMS Fortitude e I' HMS Junio armate rispettivamente di 74 e 32 pezzi, agli ordini di lord Hood. Senza frapporre indugi, accertatesi che la ton-e era presidiata da alcuni so ldati francesi, le due navi aprirono un micidiale fuoco di bordata. Ciascuna di esse constava di 16 palle da 24. 29 da 18 ed 8 da 12 , che con micidiale frequenza si abbatte-
222 Crotone: torre Meli ssa.
vano sulla to1Te. Già la semplice tenuta strutturale confermava a tre secoli di distanza l'ottimale dimensionamento passivo del manufatto. Ma, da un certo momento in poi, non fu quella la caratteris tica che più sorpre se gli attaccanti.
La guarnigione di Punta Mortella, infatti , dando prova di temerario sprezzo del pericolo, brandeggiando l'armamento principale, un pezzo da 18 libbre, e quello seco ndario, un'altro da 6 , ed impiegando palle roventi si produsse in un terribile controtiro. I tragici riscontri non si fecero attendere: dopo poche salve di aggiustamento, s ulle due fregate gli allibiti comandanti dovettero lamentare l'uccis ione di 6 uomini e d il ferimento di 54. [ danni alle unità, poi s i incrementavano colpo dopo colpo, la sciando presumere che l'insistere nel duello avrebbe messo a repenta glio la sicurezza delle stesse. Con immaginabile umiliazione venne dato l'ordine di sospe ndere il fuoco e di al Iargarsi 193 >
Nei mesi successivi i tecnici dell ' ammiragliato studiarono l'accaduto, ed in particolare la torre, che con britannica noncuranza era nel frattempo divenuta Torre Maitello, ricavandone un prototipo da impiegare, a loro volta, nella difesa costi era. Pochi anni dopo, nel 1798, d'ordine del luogotenente Stuart, ne fu munito il litorale della Britannia: l'alto ufficiale era uno dei due comandanti di Punta delle Mortelle!
Dal 1805, le ormai noti s sime torri Marte llo : " ...divennero l 'ele mento fondamentale del piano di difesa costiera britannica: ben 73 ... erano state costruite entro il 1808 , a protezione delle coste meridionali dell'isola. Quasi su bito dopo venne avviato un analogo programma relativo alle coste orientali, che portò alla costruzione di altre 29 torri ... Quando nel l 812, cessarono i lavori, la costa della Gran Bretagna era protetta da una catena di 103 torri costiere, che si esten deva da Aldemburgh, nel Suffolk, fmo alla foce del Conde, nell'Essex, e da Folk:estone, nel Kent, fino a Seaford, nel Sussex ... " <94 >
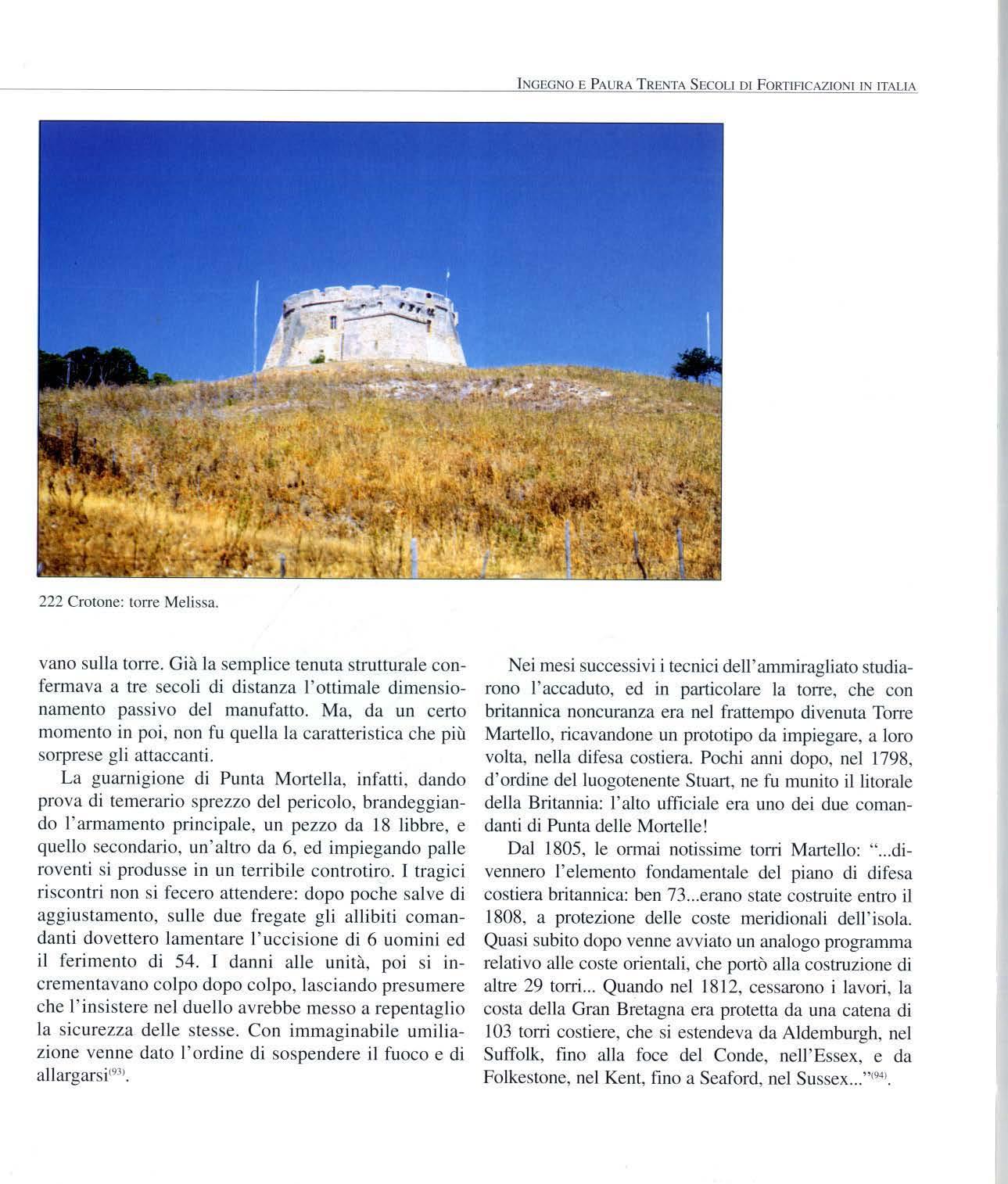 l NGEGNO E PA URA TRENTA SECOLI DI F ORTlFJCAZION I IN ITALIA
l NGEGNO E PA URA TRENTA SECOLI DI F ORTlFJCAZION I IN ITALIA
Negli anni successivi le ton-i Martello si eressero lungo tutte le coste dei domjni britannici, dal Sudafrica, all'India, al Canada. Del dimenticato spunto aragonese conservavano oltre alla forma, a tronco di cono, il pilastro centrale sulla cui sommità, fuoriuscente nella piazza di copertura, era imperniato il sottaffusto del loro unico pezzo da 50 libbre. Anche in Sicilia intorno al 1810, nel corso dell'esilio di Ferdinando di Borbone a Pale1mo sotto la protezione della flotta britannica, ne vennero edificate alcune. Fra queste, la torre di Magnisi, presso Augusta , senza dubbio la meglio conservata, pur avendo in qualche modo partecipato alla
Seconda Guen-a MondiaJe(95 > .
di Leuca , nel comune di Castrignano del Capo, ed è ricordato con il curioso nome di Torre Uomini Morti , probabile deformazione di Domini Morti. La fortificazione è m enzio n ata in tutta la cartografia cinquecentesca, in diversi documenti, nonchè sulle mappe ottomane di Piri Rai s(96 > , riscontro ulteriore della sua supposta origine ed epoca.
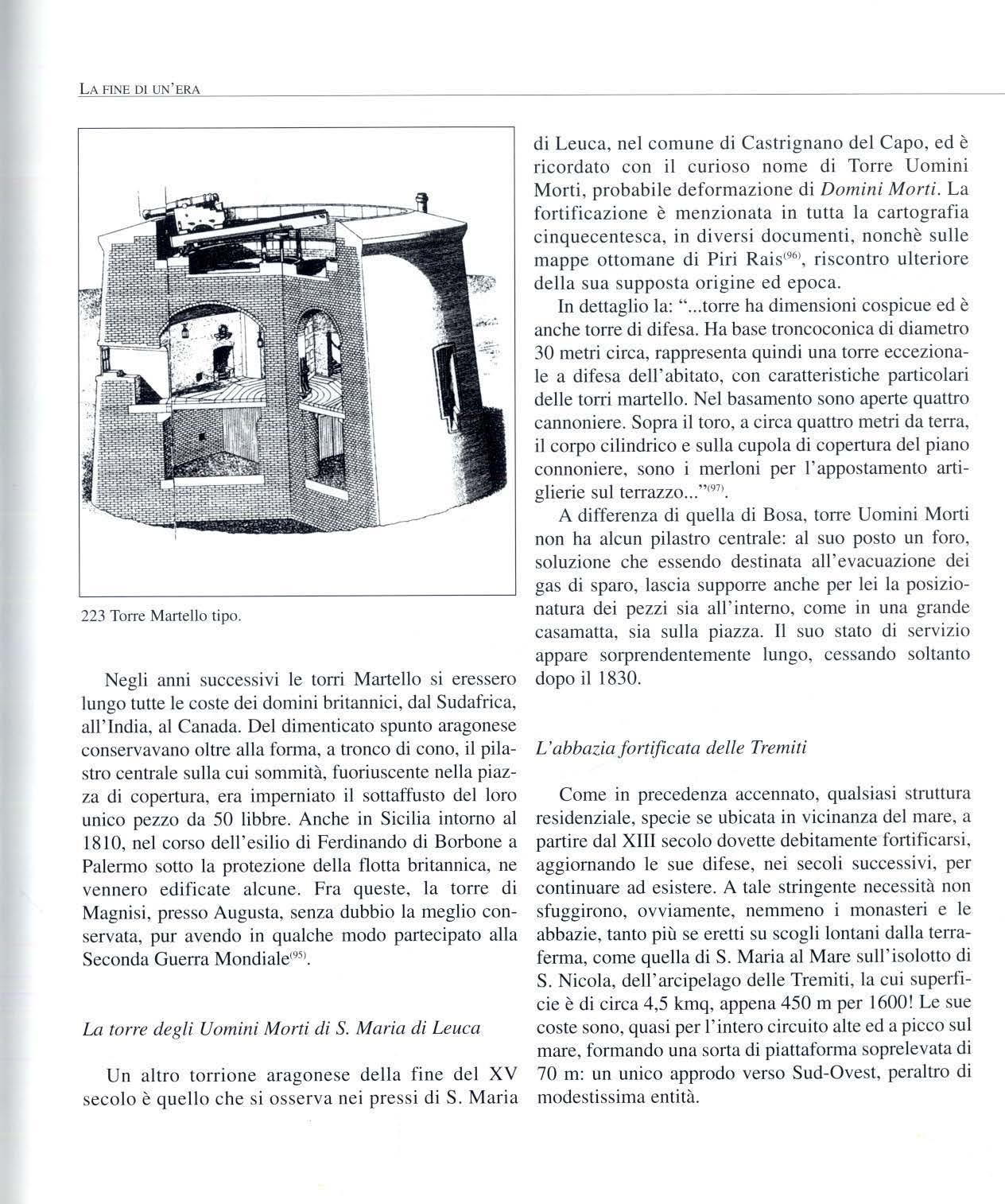
In dettaglio la: " ... torre ha dimensioni cospicue ed è anche torre di difesa. Ha base troncoconica di diametro 30 metri circa, rappresenta quindi una torre eccezionale a difesa dell'abitato, con caratteristiche particolari delle ton-i martello. Nel basamento so no aperte quattro cannoniere. Sopra il toro, a circa quattro metri da terra, il corpo cilindrico e su lla cupola di copertura del piano connoniere, sono i merloni per l'appostamento artiglierie sul terrazzo ... "< 97 )
A differenza di quella di Bosa, toITe Uomini Motti non ha alcun pilastro centrale: al suo posto un foro , soluzione che essendo destinata ali' evacuazione dei gas di sparo, lascia suppoITe anche per lei la posizionatura dei pezzi sia all ' interno, come in una grande casamatta, sia sulla piazza. Il suo stato di serv1z10 appare sorp rendentemente lungo, cessando soltanto dopo il 1830.
Un altro torrione aragonese della fine del XV secolo è quello che si osserva nei pressi di S. Maria
Come in precedenza accennato, qualsiasi struttura residenziale, specie se ubicata in vicinanza del mare, a partire dal XIII seco lo dovette debitamente fortificarsi. aggiornando le sue difese, nei secoli successivi, per continuare ad esistere. A tale stringente nece ss ità non sfuggirono, ovviamente, nemmeno i monasteri e le abbazie, tanto più se eretti s u scogli lontani dalla teITaferma, come quella di S. Maria al Mare sull'isolotto di S. Nicola, dell'arcipelago delle Tremiti , la cui superficie è di circa 4,5 kmq, appena 450 m per 1600! Le s ue coste sono, quasi per l'intero circuito alte ed a picco s ul mare , formando una sorta di piattaforma soprelevata di 70 m: un unico approdo verso Sud-Ovest, peraltro di mode st issima entità.
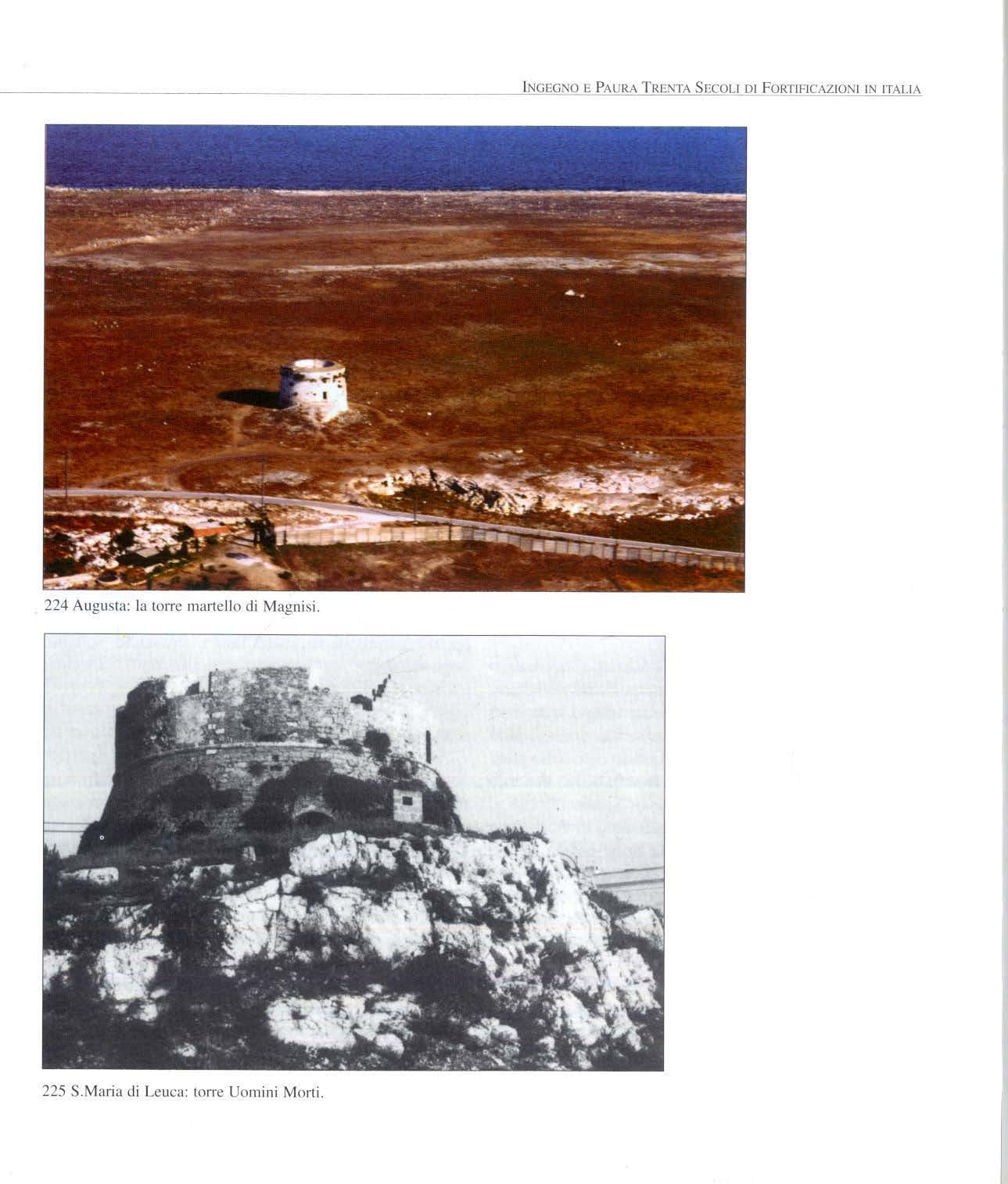
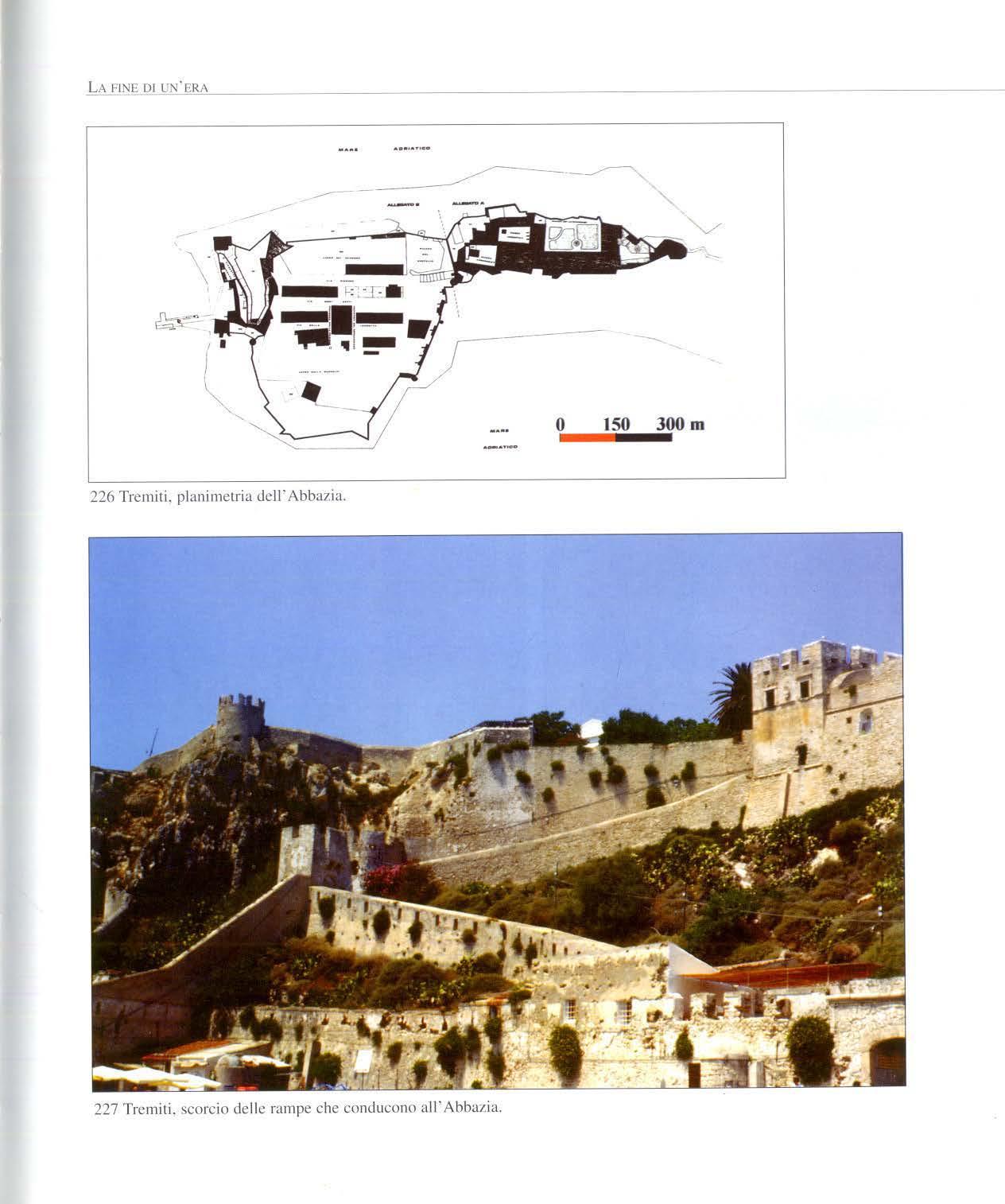
La presenza di un monastero benedettino a San Nicola è accertata sin dai primi anni del X secolo , ma per lo scadimento della disciplina, nel 1237 , il complesso fu trasferito ai Cistercensi, che ne avviarono subito l'ampliamento. Nella circostanza, per esplicita volontà di Carlo d'Angiò, provvidero pure ad incrementarne le difese. In particolare: " si progettò allora di tagliare , isolandola, la parte fortificata dal resto dell'isola.
L'abbazia divenne così una fortezza inespugnabile. Tutlavia dopo vani tentativi, i pirati dalmati, all' i -

nizio del XIV secolo, riuscirono a penetrare nell'abbazia con I' inganno <QS) ed a saccheggiarla. Dopo il saccheggio l ' abbazia rimase abbandonata fino a quando, nel 1412, Gregorio XU la diede in consegna ai Lateranensi. Con essi l'abbazia tornò ad essere ricca e potente , venne restaurata ed abbellita. Le fortificazioni angioine vennero riparate ed ampliate ed aumentò notevolmente il numero dei torrioni di difesa ... " 1991
In dettaglio, la fortificazione quattrocentesca , tipicamente di transjzione , si sviluppa lungo un peri-
metro di circa 800 m , senza mutare l'impostazione angioina e se nz a demolirne le opere che vengono so ltanto integrate con nuovi caposaldi.
Il primo di questi è un torrione posto ad interdizione del porticciolo , nelle cui adiacenze è il portal e d ' ingresso , detto Prima Porta.
Da lì , attraverso rampe sc hermate da un cortina forata da una teoria di fu c iliere, s i raggiunge la Torre del Cavaliere del Crocifi ss o, munita di piombatoie s ui sottostanti pas s aggi.
La salita prosegue ancora fino alla parte s uperio -
re dell ' isola dove è impiantato un altro torrione detto ' del Penne ll o', anch'esso munito di tre piombato ie per l ' interdizione d e ll'acces so. Per raggiungere: ··... la part e più alta delle fortificazioni chiamate «il Cannone », perchè i vi erano po s tate le artiglierie , la strada si trasforma in galleria e sbocca in un v icoletto e poi s ulla piaz ze tta detta «il Montone » . Proseg uendo lungo l ' attuale corso Roma s i arriva al «Forte del Cas tello » o «C a s tello della Badia», ai cui lat i si congiungono le mura che circondano l ' isola ... ,,, ,001

234 Tremiti: l'estremità dell'isola.

I sovrani aragonesi concessero continui privilegi ali' Abbazia, al punto che la sua giurisdizione si estese anche alle prospicienti coste sulla terraferma.
La validità delle fortificazioni fu dimostrata dal fallito attacco turco del 1567: il che non impedì il successivo rapido declino del complesso che. dopo il 1737 sotto i Borboni , divenne proprietà demaniale, mentre la sua comunità religiosa venne del tutto soppressa nel 1782. Nel decennio successivo le vetuste mura si trasformarono in colonia penale.
Verso la fìne della transizione: la rocca di Ostia.
La noti zia della tragedia di Otranto raggiunse in pochi giorni anche Roma, che se da un parte si sentì sollevata per non essere stata lei, almeno in quella circostanza, l'obbiettivo dell'attacco, dalr altra realizzò pienamente la sua vulnerabilità attraverso la risalita del
corso del Tevere. L'esigenza di frustrare definiti vamente la ten-ibile minaccia provocò la costruzione di un'opera che è ritenuta, per molti aspetti, l'ultima esponente della fortificazione di transizione e la prima, larvata, rappresentante di quel la bastionata: la rocca di Ostia. Pochi anni dopo il vicino fo11e di Nettuno ne sarebbe stato, a pieno titolo, l'indiscusso capostipite. Paradossalmente lo Stato militarmente più insignificante, disorganizzato ed arretrato si dotò allora, forse incon sciame nte, delle opere difensive più evolute. La straordinaria rilevanza dell'episodio nella storia della fortificazione obbliga ad indiv iduarne meglio l'autore. anche a costo di una breve digressione.
Prob abilmente già nell'autunno del 1480, a llorquando fervevano i contrattacchi miranti a scacciare i Turchi da Otranto, il vescovo di Ostia, iI cardinale Giuliano della Ro vere, futuro papa Giulio II. nipote dell'allora pontefice Sisto IV, al seco lo Francesco della Rovere, dando indubbia prova delle sue spiccate attitu-
INGEGNO E PAURA TRE:'\T/\ SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN rlALIAdente contraddizione con la supposta reazione emotiva. Già dal 1479, infatti, era perfettamente nota, e costantemente spiata, la grandiosa formazione navale che si stava allestendo a Valona in vista di un massiccio attacco alla crìstìanità11 03 i Meno nota, invece, la sua precisa destinazione, repuntandosi la Puglia soltanto il più facile ed ovvio bersaglio ma non certamente l ' unico o il principale, imperando sempre lo spettro di un'invasione diretta contro Roma. In tale contesto la notizia della conquista di Otranto avrebbe trovato i lavori della fortezza iniziati e febbrilmente portati avanti. La scampata incursione dal Tevere, probabilmente, consentì un insperato rallentamento della fabbrica, resosi peraltro necessario per una più accurata ponderazione dell 'o pera. Potrebbe spiegarsi così la strana incertezza circa la paternità inventiva della stessa, attribuita correntemente a Giuliano da Sangallo ed al cardinale Giuliano della Rovere. Più precisamente sembrerebbe potersi scartare la tesi che vorrebbe conciliare tale duplicità sostenendo che: " ... fu costruita da Baccio Pontelli su disegni di G. da Sangallo, con pianta triangolare, due torri circolari e un gran torrione trapezio posti ai vertici. Una delle nostre prime realizzazioni bastionate. " 1104 )
dini e competenze militari, si assunse il duplice onere, propositivo e finanziario, dell'edificazione di una modernissima e possente fortezza in grado di chiudere l'accesso a l corso del Tevere. Sarebbe so rta perciò in adiacenza del borgo di Ostia, nello stesso sito di una vetus ta torre<IO ll_
La fortezza o forse meglio la rocca per la estrema importanza che le si attribuiva ai fini ostativi la si volle di costruzione totalmente nuova, e rispondente ai più ava nzati canoni dell'architettura militare. Per alcuni studiosi, però, l'iniziativa deve collocarsi nel 1479, ovvero un anno prima dell'attacco ad Otranto, su istanza del cardinale Estouteville e su progetto di Baccio Pontelli u021
• La tesi non appare nè incredibile nè in stri-
In realtà le torri circolari sono tre, tutte di identico diametro, ma non di identica altezza: una di esse, infatti, sovrasta notevolmente le altre due e solo alla sua base si distingue il famoso baluardo trapezoidale. Ora un simile impianto appare nel 'Taccuino' di studi di Giuliano da Sangallo, con l'unica differenza che il triangolo è equilatero, ed il torrione si trova in posizione baricentrica. La evidente anomalia porta ad escludere l'ipotesi di un progetto teorico e di una realizzazione pratica di due distinti architetti, in quanto in tal caso la rocca sarebbe stata una deformazione arbitraria e pasticciata della traccia del famoso maestro, in nessun modo giustificabile. È invece molto più sensato ritenere che, complice la fretta, intorno al torrione esistente, forse l ' attuale mastio della rocca, fosse avviata la costruz ion e dì una fortezza triangolare, adattandola, per quanto possibile, al terreno ed alle preesitenze tra le quali il ricordato borgo. Soltanto in un secondo momento, quel-

lo del dopo Otranto, per lo scadere della tensione, e per i risultati non certo brillantissimi, si sollecitò I'intervento dell'illustre ingegnere
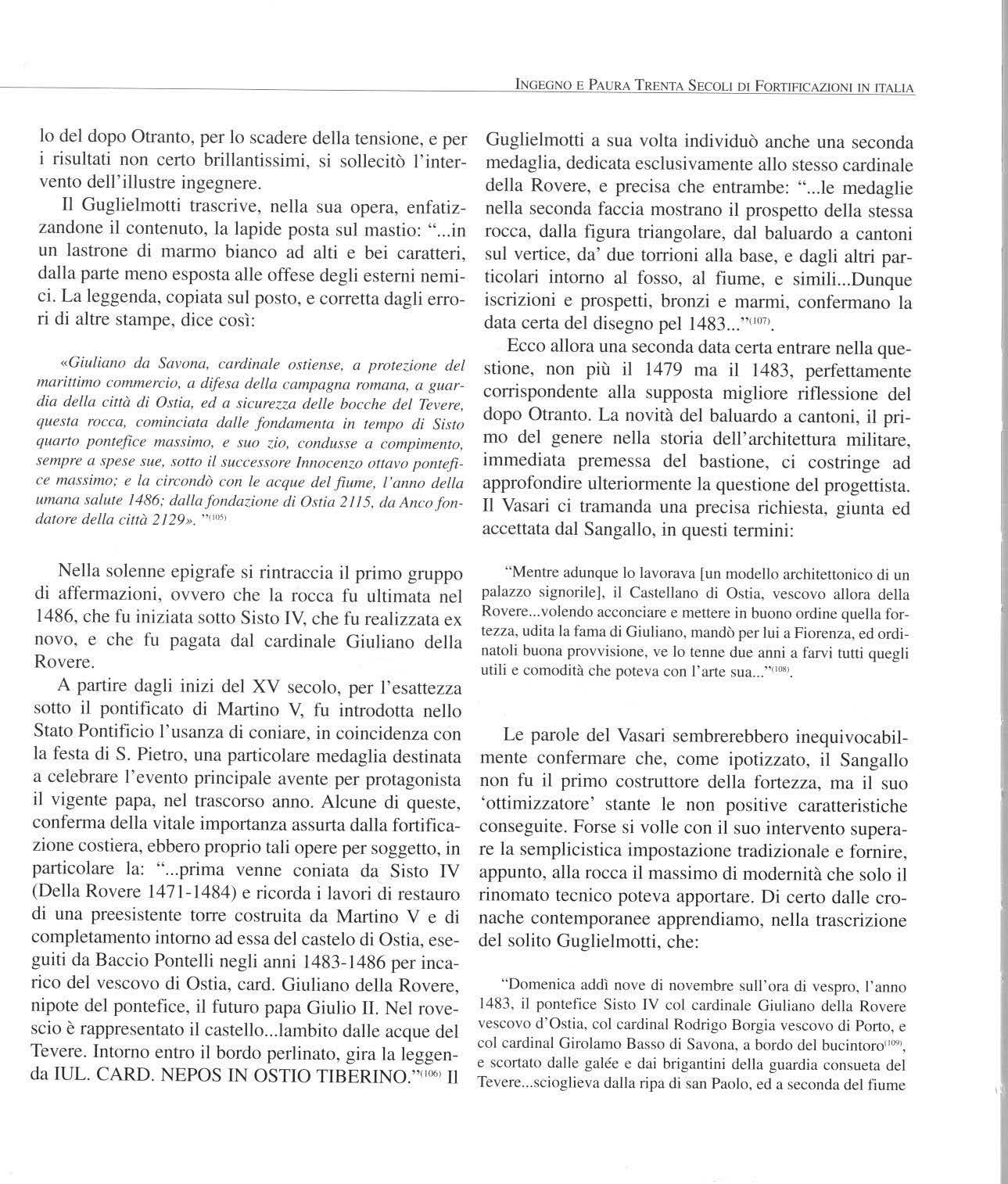
Il Guglielmotti trascrive, nella sua opera, enfatizzandone il contenuto, la lapide posta sul mastio: " ... in un lastrone di marmo bianco ad alti e bei caratteri, dalla parte meno esposta alle offese degli esterni nemici. La leg genda, copiata su l posto, e corre tta dagli errori di altre stampe, dice così:
«Giuliano da Savona , cardinale ostiense, a protezione del mari/timo commercio, a difesa della ca mpag na romana, a g uardia della c ittà di Ostia , ed a s icurezza delle bocche del Teve re, questa ro cca, cominciata dalle fondamenta in t empo di Sisto quarto pontefice massimo, e suo zio, condusse a co mpimento, semp re a spese sue, sotto il s uccessore Innocen zo ottavo pontefice massimo; e la c ircondò con le acque del fiume, l'anno della umana salute 1486; dalla fondazione di Ostia 2115, da Anca fondatore d ella città 2129». " o os;
Nella solenne epigrafe s i rintraccia il primo gruppo di affermazioni, ovvero che la rocca fu ultimata nel 1486 , che fu iniziata s otto Sisto IV, che fu realizzata ex novo, e che fu pagata dal cardinale Giuliano della Rovere.
A partire dagli inizi del XV secolo, per l 'esattezza sotto il pontificato di Martino V, fu introdotta nello Stato Pontificio l'usanza di coniare, in coincide nza con la festa di S. Pietro, una particolare medaglia destinata a celebrare l 'evento principale avente per protagonista il vigente papa, nel trascorso anno. Alcune di queste, conferma della vitale importanza assurta dalla fortificazione costiera , ebbero proprio tali opere per soggetto, in particolare la: " ... prima venne coniata da Sisto IV ( Della Ro vere 1471-1484) e ricorda i lavori di restauro di una preesistente torre costruita da Martino V e di completamento intorno ad essa del castelo di Ostia, eseguiti da Baccio Pontelli negli anni 1483-1486 per incarico del vescovo di O stia, card. Giuliano della Rovere, nipote del pontefice, il futuro papa Giulio II. Nel rovescio è rappresentato il castello lambito dalle acque del Tevere. Intorno entro il bordo perlinato, gira la leggenda IUL. CARD. NEPOS IN OSTIO TrBERIN0. "< 106 > Il
Guglielmotti a sua volta indiv iduò anche una seconda medaglia , dedicata esclusiva m ente allo stesso cardinale della Ro ve re , e precisa che entra mbe: " .le medaglie nella seconda faccia mostrano il prospetto della stessa rocca, dalla figura triangolare, dal baluardo a cantoni sul vertice, da' due torrioni alla base, e dagli altri particolari intorno al fosso, al fiume, e simi li Dunque iscrizioni e prospetti, bronzi e marmi , confermano la data certa del di seg no pel 1483 ... " <101i Ecco allora una seconda data certa entrare nella questione, non più il 1479 ma il 1483, perfettamente corrispondente alla supposta migliore riflessione del dopo Otranto. La novità del baluardo a can toni , il primo del genere nella sto ria dell'architettura militare , immediata premessa del bast ione , ci costringe ad approfondire ulteriormente la questione del progettista. Il Vasari ci tramanda una precisa richiesta, giunta ed accettata dal Sangallo, in questi termini:
" Mentre adunque lo l avorava lun mod ello architettonico di un pala zzo s ignorile], il Cas tellano di O s tia, vescovo allora della Rovere ... volendo acconciare e mettere in buono ordine quella fortezza , udita la fama di Giuliano , mandò per lui a Fiorenza, ed ordinatoli buona provvi s i one, ve lo tenne due anni a farv i tutti quegli utili e comodità che poteva con l 'arte s ua "0 08 >
Le parole del Vasari sembrerebbero inequivocabilmente confermare che, come ipotizzato, il Sangallo non fu il primo costruttore della fortezza, ma il suo ' ottimizzatore' sta nte le non po s itive caratteristiche conseguite. Forse si volle con il s uo intervento superare la se mplicis tica impostazione tradizionale e fornire, appunto, alla rocca il massimo di modernità che so lo il rinomato tecnico poteva apportare. Di certo dalle cronache contemporanee apprendiamo, nella trascrizione del so lito Guglielmotti, che:
" Domenica addì nove di novembre s ull 'ora di vespro, l'anno 1483, il pont e fice Sis to IV co l cardinale Giuliano della Rove re vescovo d'Ostia, col cardi na l Rodrigo Borgia vescovo di Porto, e co l cardinal Girolamo B asso di Sa vo na, a bordo del bucintoro(IO'» , e scortato dalle galée e dai brigantini della guard i a co ns uet a del Tevere scioglieva dalla ripa di san Paolo, ed a seco nda del fiume
IN GEGNO E PAURA TR ENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIAnavigando, approdava in men di tre ore ad Ostia. Per quella riviera trattenevasi quattro giorni, insino alla sera del dodici, diligentemente rivedendo ogni cosa...
Bravi quivi ad opera il celebre Giuliano da Sangallo per acconciare sul terreno nel proprio sito i disegni già fatti ed approvati in Roma " <11 0'
È que s ta una ennesima conferma alla nostra tesi: il Sangallo verso la fine del 1483 assume la direzione dei lavori della fortezza di O stia, che in qualche maniera già esiste, ma che ostenta alquante deficienze. Il suo progetto, redatto nei mesi precedenti e presentato in Roma, è stato accettato: quindi se ne conoscono, perfettamente, le caratteristiche, la portata e la validità, per cui anche ad opera incompiuta, od appena iniziata, quale poteva essere la rocca nel 1484, anno in cui mor1 Sisto IV e successivo alla coniazione della medaglia succ itata, nessuna difficoltà presentava raffigurarla, sulla base dei grafici, nella sua interezza. In particolare l'incisore avrebbe perciò evidenziato proprio i suoi ormai ben noti elementi caratterizzanti, quelli cioè integrativi e poteziantori, quali appunto il famoso 'baluardo a cantoni' che compare, infatti, nel conio perfettamente definito. Che la questione sia da porre in s iffatti termini si desume anche dal prosieguo della cronaca, in cui si descrive il Sangallo intento a tracciare sul terreno le generatrici di progetto: per l'esattezza ad 'acconc iare ', ovvero ad adattare la s ituazione del terreno e per estensione delle opere gravantivi sopra alla s ua diversa concezione fo11ificatoria.

Comprensibile, pertanto, pure il sopralluogo del papa in tale delicatissima fase, specie se correlata ad una recentissima inadeguatezza della medesima struttura. Sempre in relaz ione alla eccezionale valenza storica-architettonica della rocca ne tracceremo una descrizio ne più accurata.
vamente prutendo da quello parallelo alla costa m. 20, e quindi m. 23 per quello parallelo al corso del fiume, ed ancora m. 18 per quello che contiene la porta d'ingresso protetta dall'antistante autonomo rivellino. Dal fondo del fossato le citate cortine si innalzano di circa m. 12, in parte scarpate ed in parte appiombate, separate dal caratteristico cordone torico, ripattizione concorde anche nel corpo dei torrioni, innestati in corrispondenza di ciascun vertice, ed a pianta circolare di m. 15 di diametro. La muratura, in corsi regolari di mattoni cotti appare di ottima fattura, con uno spessore, pieno, di m. 5. Al di sopra della sezione verticale si impianta l'apparato a sporgere supportato da beccatelli ed archetti, sormontati, a loro volta, da una regolare merlatura di tipo guelfo. Alla base degli ' intermerli' sp ic cano accurati conci di pietra calcarea bianca, più propriamente 'scudi', nei quali si ricavarono delle feritoie archibugiere dalla standardizzata forma circolare con sovrastante fessura perpendicolare per la mira111 n
In dettaglio la rocca di Ostia si struttura s u una inconsueta configurazione di triangolo scaleno. I lati, costituiti da altrettanti segme nti di cortina, misurano rispetti-
Fin qui, in sostanza, una perfetta adesione ai canoni dell'architettura di transizione vigente, tranne che alla base del torrione fungente da mastio, ben evidente per la sua ragguardevole altezza, circa m. 24, ed adibito a 'mastio' perchè dominante l'intera rocca. Lì infatti, come pure nell'innesto alle cortine degli altri due opposti torrioni si individuano i primi elementi em brionali della nuova impostazione difensiva. L' ammorsamento tra le cortine ed i torrioni non si praticò in corrispondenza del loro diametro, ma alquanto più innanzi, consentendo perciò una scarsissima fuoriuscita del loro corpo tronco conico dal perimetro triangolare, giusto quanto indispensabile per alloggiare le casamatte dei pezzi per il fiancheggiamento. Per quella basilare prestazione balistica si distinguono, infatti, le rispettive troniere, appena al di sotto del coronamento torico, corrispondenti ad altrettante casematte per artiglieria di grosso calibro, perfettamente in grado di battere quasi ogni punto esterno della rocca. La disposizione descri tta riduceva al minimo, senza però eliminare del tutto, i settori defilati, ultimo retaggio dell'architettura di transizione. Al di sotto delle tro-
niere si scorge un altro ordine di feritoie, contraddistinte da altrettanti scudi di bianco calcare, per archibugiere o per artiglierie di piccolo calibro, disposte a scansione regolare lungo l'intero sviluppo del perimetro murario. La loro quota d'impianto appare di poco eccedente il livello di massimo invaso del fossato, con il risultato di consentire un micidiale fuoco a pelo d'acqua. Al riguardo la sua profondità fu fissata in maniera da poterlo allagare, tramite una derivazione dall'adiacente corso del Tevere regolata da apposite saracinesche' 112 1 •
Dove però tutti gli studiosi concordano nel riscontrare l' apporto del Sangallo, ovvero, la principale innovazione della fortificazione è alla base del 'mastio'. Attorno al corpo cilindrico, venne fabbricato il celebre basso rinforzo poligonale, correntemente definito ' baluardo a cantoni', antesignano dell'imminente bastione. Grazie al suo sviluppo triangolare le traiettorie balistiche provenienti dalle casematte degli
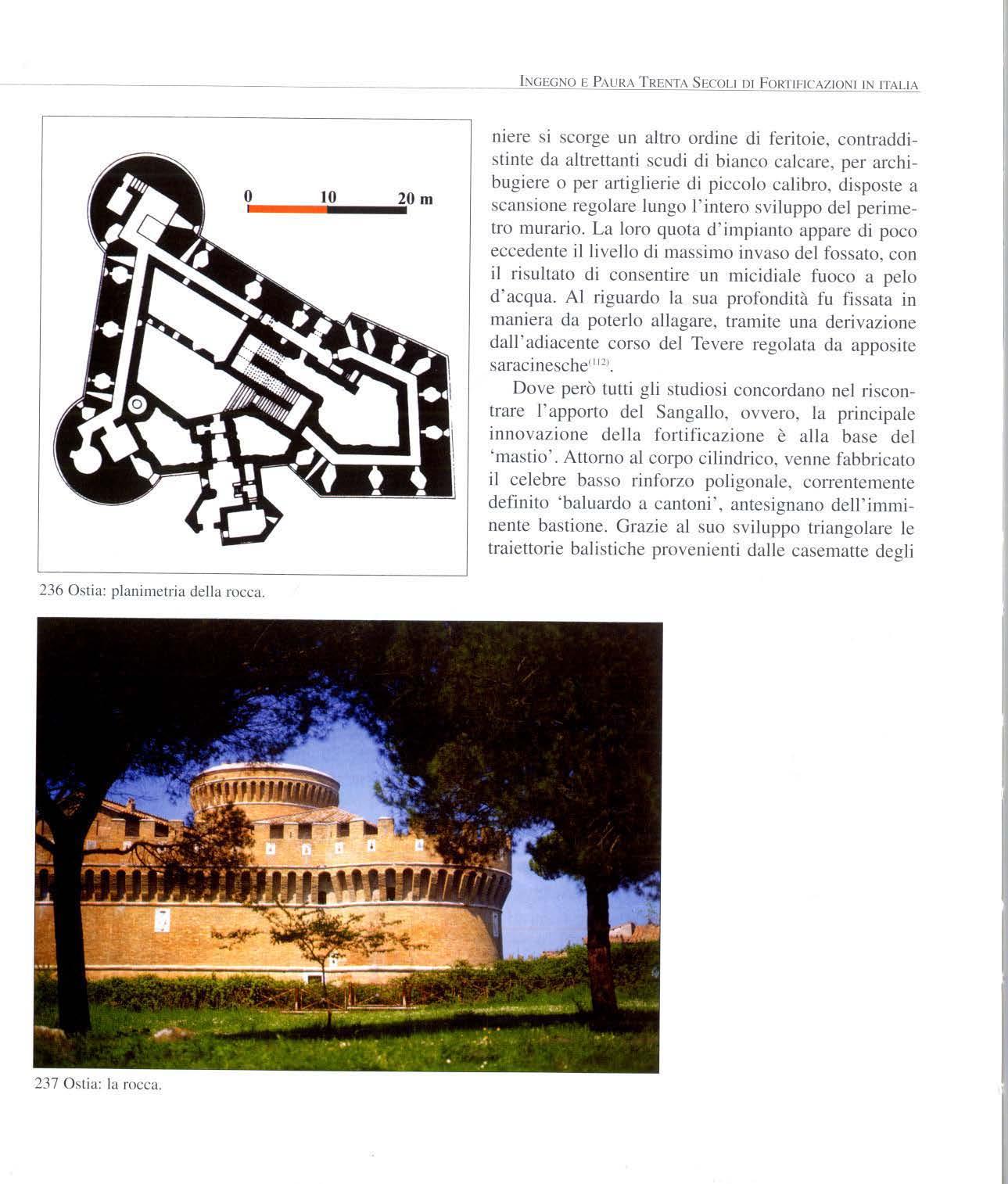 236 Ostia: planimetria della rocca.
237 Ostia: la rocca.
236 Ostia: planimetria della rocca.
237 Ostia: la rocca.
opposti torrioni riuscivano a prenderne d'infilata le facce, eliminando qualsiasi punto defilato, fino ad allora limite critico della difesa attiva. Purtroppo per la sua eccessiva acutezza, il vertice esterno, qualora costruito, si sarebbe trovato a ben sessanta metri di distanza, lunghezza assolutamente abnorme per un bastione e causa di una gravissima fragilità strutturale. Ne conseguì lo smussamento dello stesso, tramite una cesura quasi perpendicolare alla sua faccia di levante: la figura ottenuta divenne così un ·puntone'. Intuibile che con siffalla soluzione una parte del fiancheggiamento andava persa, creandosi proprio innanzi allo smusso un settore imbattibile: al che si rimediò, in maniera certamente meno valida ed affidabile, con il
tiro proveniente dall'alto del mastio, capace, questo sì, di tenere sotto tiro ficcante però l'intera area in ques tione . La soluzione, se nza dubbio intelligente, dimostra da un lato la perfetta valutazione dell' inadeguatezza non più rimediabile, e dall'altra la capacità del Sangallo ad elaborare una soluzione estrema. Un'ultima innovazione precorritrice si individua nella disposizione del rivellino, antistante la po11a d'ingresso. La sua massa muraria eliminava la sua diretta battibilità, altrimenti troppo fragile e pericolosa. Rappresenta anch'esso un elemento destinato ad assurgere a dispositivo canonico di lì a breve.
Venendo alla distribuzione interna, premesso che le muraglie non sono terrapienate altro dettaglio che le conferma ancora tipicamente di 'transizione' superato il fossato esterno, largo oltre m. l5 e profondo più di 3, tramite un ponte levatoio, si perviene al rivellino, e quindi attraverso un secondo ponte, a direzione 0110gonale rispetto al primo, si guadagna il portone p1incipale della rocca.
Il vano d'ingresso risulta interdetto da tre ordini successivi di chiusure e saracinesche, sulle quali campeggia una lapide, che enuncia la finalità della fortificazione e l'epoca di costruzione. Così ne descrive la visita il Guglielmotti: " ...Tra la seconda e la terza porta, a destra ed a sinistra dell'androne, si vedono murate due portelle, che certamente nei secoli passati mettevano ai corridoj delle basse casematte. Batterie di somma importanza per la storia dell'arte: stanze buje e invisibili al di fuori, se non quando vengono indicate dalla strombatura delle cannoniere, coperta da lastroni di marmo. col pertugiuo mistilineo, di figura circolare pel pezzo, e cuneiforme per la mira. Niuna meraviglia prenderà per la chiusura delle portelle chi consideri la successiva assegnazione della rocca a ricovero dei condannati, che in numero di più centinaja, ed in certe stagioni, vi erano condotti ali' opera delle saline: ciò posto, si è voluto toglier loro l 'accesso a quel laberinto di nascondigli. e impedirne la fuga. Perciò le casematte di Ostia non sono conosciute se non a pochi ... al pari di noi ...


Scalando adunque per di fuori cinque metJi di muraglia, infine al primo abbaino della base. presso al fianco del torrione occidentale; e calandoci giù giù dentro per le tacche d'un piano inclinato, con le candele in mano, possiamo penetrare nell'interno delle batterie. Camminando sur un palmo di guano (deposito secolare di lUlti i pipistJ·elli di maremma), troveremo un corridojo a volta reale, largo quasi due metri, alto cinque, che gira tutto per di dentro parallelo alla muraglia del recinto primario, e ne segue l'andare; rettileneo dietro alle cortina, circolare intorno alle torri, e ad angoli salienti e rientranti, secondo la forma del baluardo. Corridojo in somma, che da una pa11e e dall'altra fa capo alle due portelle murate, come ho detto in p1incipio ... " 1lll)
In effetti nelle piante della quota bassa del forte appare ben definito il descritto corridoio, e proprio la sua singolare ed assoluta concordanza con la muraglia sovrastante ci porta ad intravederne un suo doppio impiego. Al di là della chiara funzione di disimpegno per le batterie basse. suggerisce anche quella di efficace contromina, caratte1istica che nelle opere bastionate appena successive diverrà di prammatica con identiche connotazioni, sebbene a quota d'impianto inferiore1114 ' Prosegue nella visita l'illustre storico: ·' La regolarità dell'andito cresce a doppio per il legame delle bau.erie, raccolte in un solo sistema intorno aJ medesimo. Sono venti al pian terreno: tre alla cortina della base, tre a quella di ponente, due sui fianchi del baluardo, otto sulle facce, e quattro negli angoli de' due tonioni. Vedete venti camere, Lutte eguali, di figura esagona, con un solo angolo appuntato all'ultimo lembo della muraglia esterna per non indebolirla; e ciascuna ricavata nel pieno istesso del muro, che è grosso di cinque metri ... Voltoni solidi, accesso spedito, batterie capaci, troniere ingegnose, sfiatatoj vivaci, ventilazione aperta: in somma sicurtà dì stanza a difesa e ad offesa, con tutto quel che meglio ha saputo infine ai nostri giorni mettere insieme il genio militare " (1 1' 1 • Ad ulceriore conferma della rispondenza degli sfiati delle casematte osliensi ricorda il nostro autore: '' .Io di prop1ia esperienza posso dire che, dopo esservi penetrato per la

tromba a punto di uno sfiatatojo. quantunque a] di fuori alitasse a pena una brezza leggiera, sentivo viva addosso la ventilazione; onde vedevo or qua or la spegnersi le candele nelle altrui mani e nelle mie ... "< 116i Colpito dalla singolare disposizione della teoria di casamatte, collegate orizzontalmente dal corridoio continuo e verticalmente, tramite i descritti camini, con la sommità della rocca, anche il Guglielmotti ne imuisce la duplice funzione, per cui: " .... ripensando alla ingegnosa forma degli sfiatatoj ostiensi, mi sembra leggere nei pensamenti di Giuliano il duplice proposito: tirare l' aiia, e sventar le mine. Imperciocchè quelle camere aperte nei muri maestri, e comunicanti cogli alti corridoj e colle lunghe trombe esteriori, scusano i pezzi, gli androni. le gallerie, glì spiragli, ed ogni altrn artificio delle contromine permanenti " 11 111
In altre parole, attraverso gli sfiati, oltre aJ ricambio dell'aria. sarebbe stato possibile, in caso di penetrazione nemica mediante un cunicolo da mina o più verosimilmente, data l'acqua nel fossato, da una breccia saturare il dedalo di gallerie e casamatte con densi gas Lessici, prodotti dalla combustione dello zolfo o della resina. La procedura, divenne in breve precipua della gueJTa sotterranea, essendo l'u1ùca in grado di arrestare ogni ulteriore avanzamento nemico, senza compromettere le strutture difensive ' 1181 • Proseguendo il sopralluogo, racconta l'autore: " Continuandoci nel giro del piano teJTeno, troviamo ciò che di meglio potrebbesi volere oggidì: la piazzetta austera attorniata dagli a11oggiamenti, il pozzo, la cisterna, i magazzini, i sotterranei, la chiocciola di passaggio secreto, la cappella, e lo scalone del l'appai lamento nobile. Prima di salire, venite alla postierla di sortita e di soccorso, opposta all'ingresso principale dal lato di ponente, verso il fiume, alla estremità della cortina, sotto la protezione del fianchetto. Al di fuori latroverete inzaffata e clùusa con muratura moderna, aJ modo istesso che sono chiuse le due porte dei corridoj dabasso Meglio vi apparirà dalla parte interna, dove restano ancora i canali della saracinesca, e il vano di altre quattro p01te min01i per tenere sempre diviso il corpo della rocca alle spalle degli amici ed alla fronte
dei nemici. Non s i apriva una di quelle porte , se nza chiuderne un'altra...
Al primo ripiano della scal a trovate il passo per le mediane batterie, altresì casamattate, c he non girano attorno, ma s i stanno a due a due rincattucciate nei fianchi de] baluardo, e negli angoli mistilinei dei torrioni. Quindi potete vedere le camere e gli alloggiamenti; e da ogni parte, specialmente nelle sale e nelle volte, stemmi, ornati, rabeschi, e pitture, disgraziatamente consu nte da] tempo e dalJ'incuria... "< 119>
Infine, circa la compartimentazione sommital e della fortezza, eccone la relati va de scr i zione: " ... monteremo in alto sul piano scoperto, e distingueremo tutta l'area in due parti: l'una dei rondelli, e l'altra delle piazze d'armi. I primi, per guardie e archibus ieri seguono l 'a ndare delle tre co rtin e sullo sporto dei piombatoj, tra due muri: di fronte il grosso parapetto, a tergo la parete degli interni a1loggiamenti. Le piazze sui tre baluardi portano le troni e re per la grossa artiglieria con quest'ordine: ogni torrione ne ha quattro; metà sui fianchi per difesa della cinta, metà sulla fronte per offesa alla campag n a: il baluardo a cantoni n'ha otto, che stanno a due a due sui fianchi, su lle facce e su ll a fronte.
Il mastio torreggiante domina l'entrata, l 'uscita, e tutte le piazze sottopos te: ha scale secre te per le casematte, pei corridoj, e specialme nte la portella di soccorso . .. " <120>
È senza dubbio questo l'elemento più arca ico dell'intero comp l esso . La s ua altezza appare ormai decisamente anacronistica per la tarda architettura di transizione. Da quasi un seco lo, infatti, erano state drasticamente mozzate tutte le strutture verticali di maggiore elevaz ion e, o com unque valutate eccessivamente e poste ai tiri delle artiglierie d'assedio e quindi pericolosissime per i difensori al momento del loro inevitabile cro llo Nè peraltro trovava più sco ntata adozione il criterio di estr e mo cap osaldo difensivo, proprio dei 'maschi' medievali. L'aver munito la sua base del famoso baluardo c i testimonia l'esatta percezione della sua arcaica co ncezione, ma anche la ins opprimibi le necessità della s ua pe rman enza per eliminare l'eccessi-
vo settore defilato antistante, e per fornire un appoggio balistico in og ni punto de11a rocca. Tenendo conto, infine, che la potenziale offesa si supponeva condotta da corsari male armati, e per nulla disponibili ad intraprendere veri investimenti ossidionali, assolutamente esulanti dalle loro finalità belliche e dalle loro modalità operative, la conservazione del giubilato torrione si sarà s timata , oltre che valida, ancora praticabile. Eccone la de sc ri z ione del Guglielmotti: " Dalla porta del mastio , di marmo bianco e di bello st il e sangallesco, passando innanzi potete raccogliere, oltre alle consuete iscrizioni, anche la misura della colossale muraglia, grossa infino ai parapetti di quattro metri, e il diametro di quindici, e l 'altezza di ve ntiquattro; indi potete visitare le camere e le sale, e in ultimo dalla massiccia volta sali re al supremo ballatojo, donde il castellano spaziava con lo sguardo
Sommata ogni partita, e messa la rocca a] compiuto, non ]e daremo meno di cinquanta pezzi: venti grossi per la offesa lontana, e trenta minuti per difesa vicina " <•2 •>
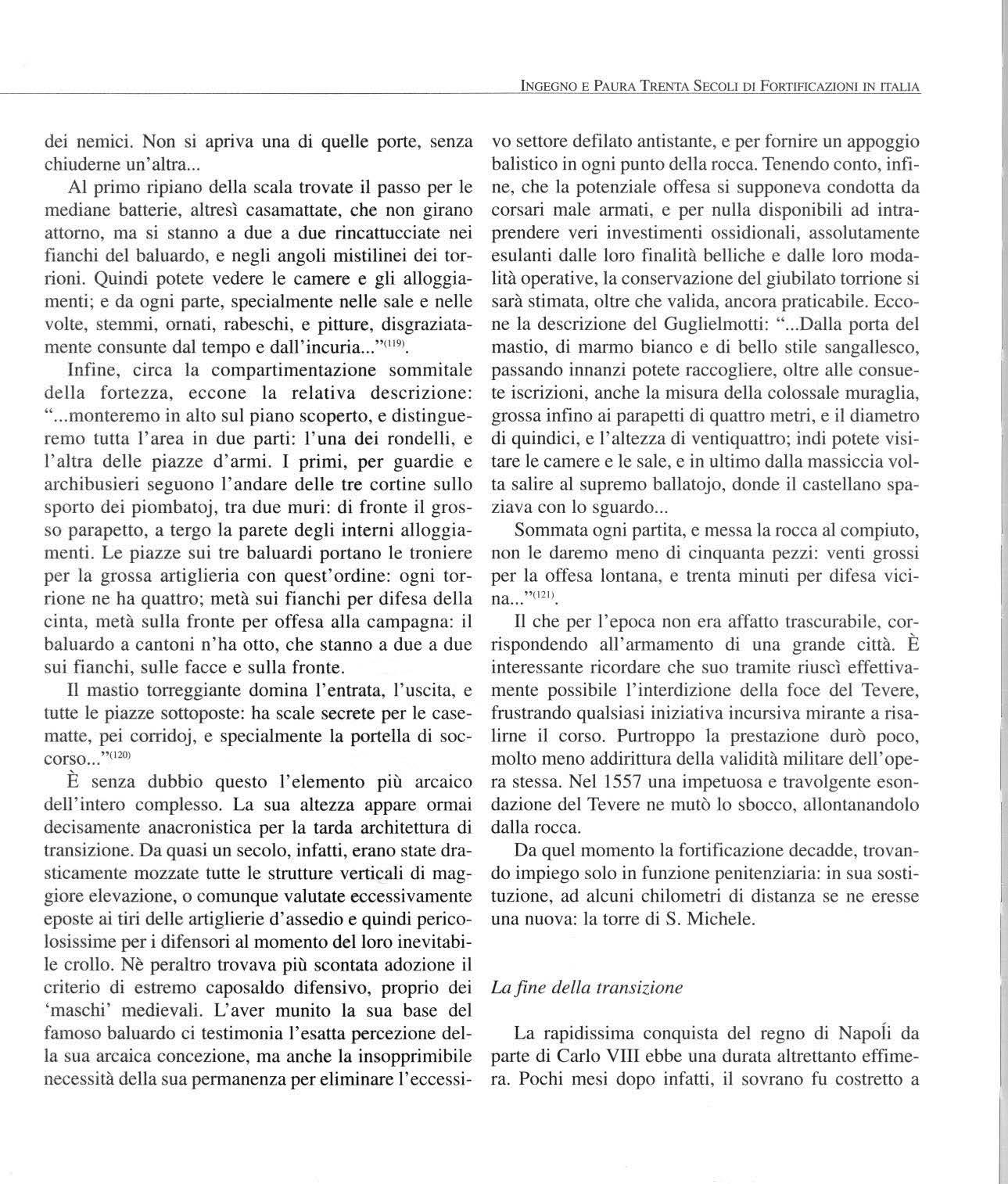
I1 che per l'epoca non era affatto trascurabile , corrispondendo all'armamento di una grande città. È interessante ricordare che suo tramite riuscì effettivamente possibile l'interdizione della foce de l Tevere, fru strando qualsiasi iniziativa incursiva mirante a risalirne il corso. Purtroppo la prestazione durò poco, molto meno addirittura della validità militare dell'opera stessa. Nel 1557 una imp etuosa e travolgente esondazione de l Tevere ne mutò Jo sbocco, a llont anandolo dalla rocca.
Da quel momento la fortificazione decadde , trovando impiego so lo in funzione penitenziaria: in sua sostituzione , ad alcuni chilometri di distanza se ne eresse una nuova: la torre di S. Michele.
La rapidissima conquista del regno di Napoli da parte di Carlo VIII ebbe una durata altrettanto effimera. Pochi me s i dopo infatti , il sovrano fu costretto a
INGEGNO E PAURA TRENTA SEC OLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIAnttrarsi precipitosamente lasciando soltanto alcune guarnigioni nelle principali fortezze, in attesa di un suo ritorno. A Napoli anche il Castel Nuovo ne ebbe una c he s i oppose stre nu amente ai tentativi aragonesi miranti a sopprimer la. Dimostratisi vani tutti gli espedienti escogitati, si tentò quale estrema ri sorsa una procedura mai tentata prima.
Il 27 novembre del 1495 alle ore 23, l'irreale silenzio subentrato al fragore dei rabbiosi assalti sa nguinosamente infrantisi contro le poderose cortine del Castel Nuovo di Napo li nel co rso della giornata, fu squarciato da una terrificante esplosione . Al cupo boato fece immediatamente seguito l'inco nfondibile schianto di mura cro llate rovinosamente. Diradatasi la densa coltre di polvere, nell'incerta luce lunare, riaffiorò la ben nota sagoma della maestosa costruzione, priva però di una vasta sezione frontale: al suo posto un enorme c umulo di fumanti macerie. Sebbene allibiti, i soldati di re Ferrandino d'Aragona, da ore in trepida ed immobile attesa, scavalcarono fulmineamente quell'inconsistente ostacolo, decisi a soffocare nell'impeto ogni ulteriore resistenza dei difensori. Ma la guarnigione francese non era più in grado di combattere. I pochi incolu mi avanzavano, storditi e barcollanti, verso gli attaccanti solo per arrendersi, mentre tutt'intorno riecheggiavano le grida dei tanti feriti ed i gemiti degli agonizzanti maciullati dalle pietre divelte.
esped iente che un suo concittadino, Mariano di Jacopo detto il Taccola, anch'egli ingegnere, alcuni decenni prima aveva elucubrato nel suo trattato De machinis. Nessuno, però, fino ad allora aveva mai osato accertarne la concreta fattibilità. Consisteva nel costipare una rilevante quantità di polvere pirica nella testa di una galleria, condotta fin sotto le mura della fortezza nemica, facendola brillare mediante una miccia.
La deflagrazione avrebbe provocato il crollo della sovrastante costruz ione. Improbo, però, stabilire il numero dei barili di polvere necessari, l'affidabilità della miccia e la sua effettiva durata: una qualsiasi inadeguatezza avrebbe comportato il fallimento dell'impresa e, quasi certamente, la morte dei minatori. Solo la disperazione di quei giorni e la sagacia del Martini valsero a superare le fin troppo leggittime titubanze. E, proprio per meglio garantire l'esatto orientamento del cunicolo, il Senese ne affidò lo scavo ad un esperto ingegnere militare, Antonio Marchesi da Settignano, che in pochissime notti esaurì il lavoro, consentendo il rivoluzionaro epilogo.
Quell'esplosione può a giusta ragione consider arsi la definitiva conclusione dell'architettura di transizione. A Nettuno, infatti, proprio negli stessi giorni, si avviava la costruzio ne del forte del Sangallo, con i suoi funzionali bastioni. Puntuale, pertano, la constatazione secondo la quale: " .. .l'ingegnosità italiana, stella polaLa tragica sequenza, che vedrà nel corso dei sue - re di ogni altro popolo che con gli Italiani venisse a cess ivi ci nqu e secoli innumerevoli riproposizioni, contatto, non avrebbe sub ito a lungo il maggior poteostentava però, i n quella allucinante notte, una signi- re dei parchi d'assedio Entro g li anni venti del 1500 ficativa novit à. La devastazione del Castel Nuovo, le fortificazioni del nuovo modello italiano erano .in infatti , era stata prodotta dalla prima mina esp losiva grado di resistere agli assalitori meglio equipaggiati. de lla storia, progettata, posizionata e fatta brillare da Comportavano però un costo enorme. Solta n to gli Francesco di Giorgio Martini, a l cui genio si era Stati più opulenti e le città più ricche potevano perancora una volta rivolto il re di Napoli! mettersi il lusso della decina di bocche da fuoco e Ponderate e scartate le tre classiche modalità di degli immani lavori d'ingegneria necessari per quella espugnazio ne di un caposaldo, alla mente del Senese che ormai veniva chiamata al di là delle Alpi la 'trace balenò l 'ard it o proposito di mettere in pratica un italienne ... " <122 > .
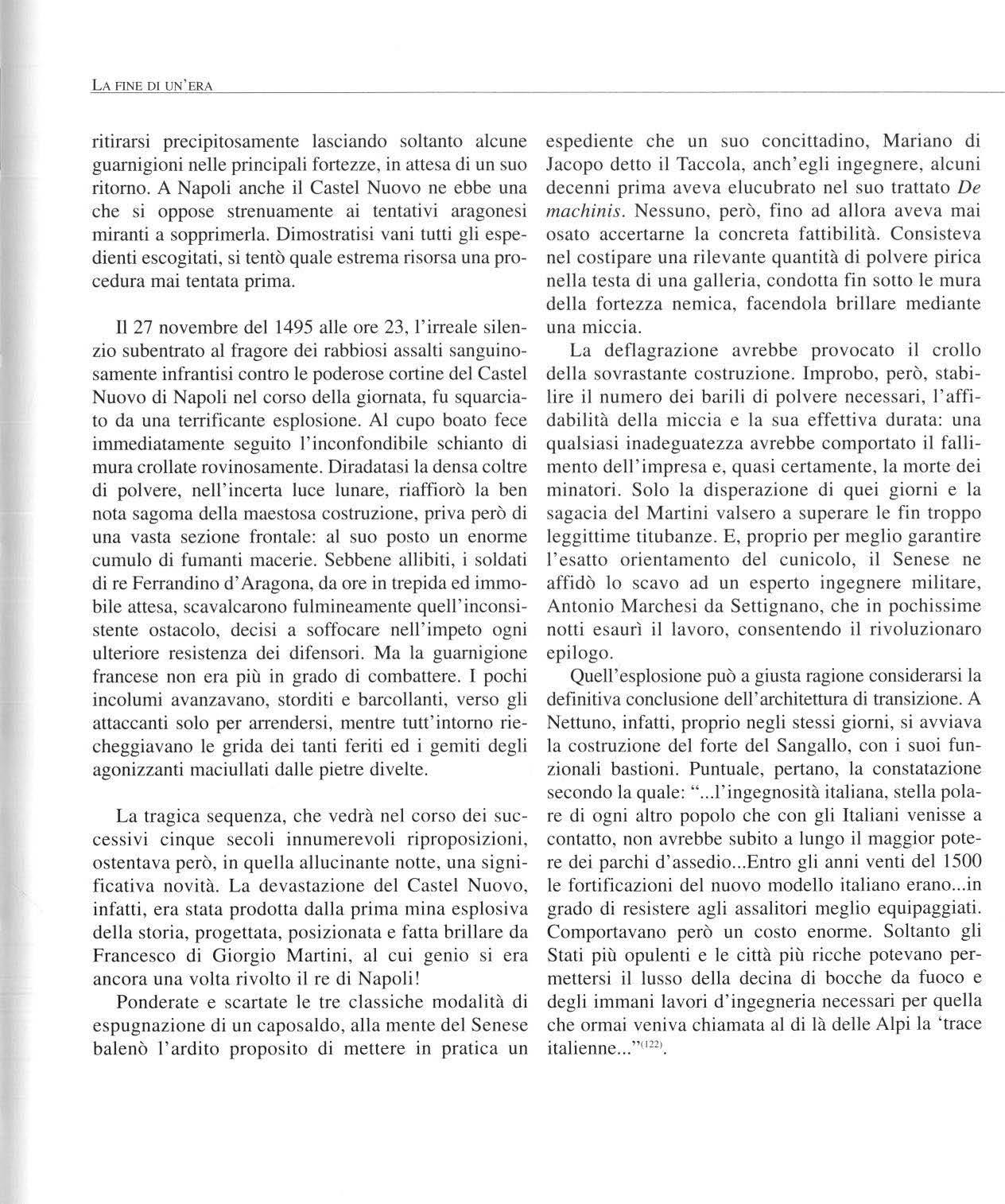
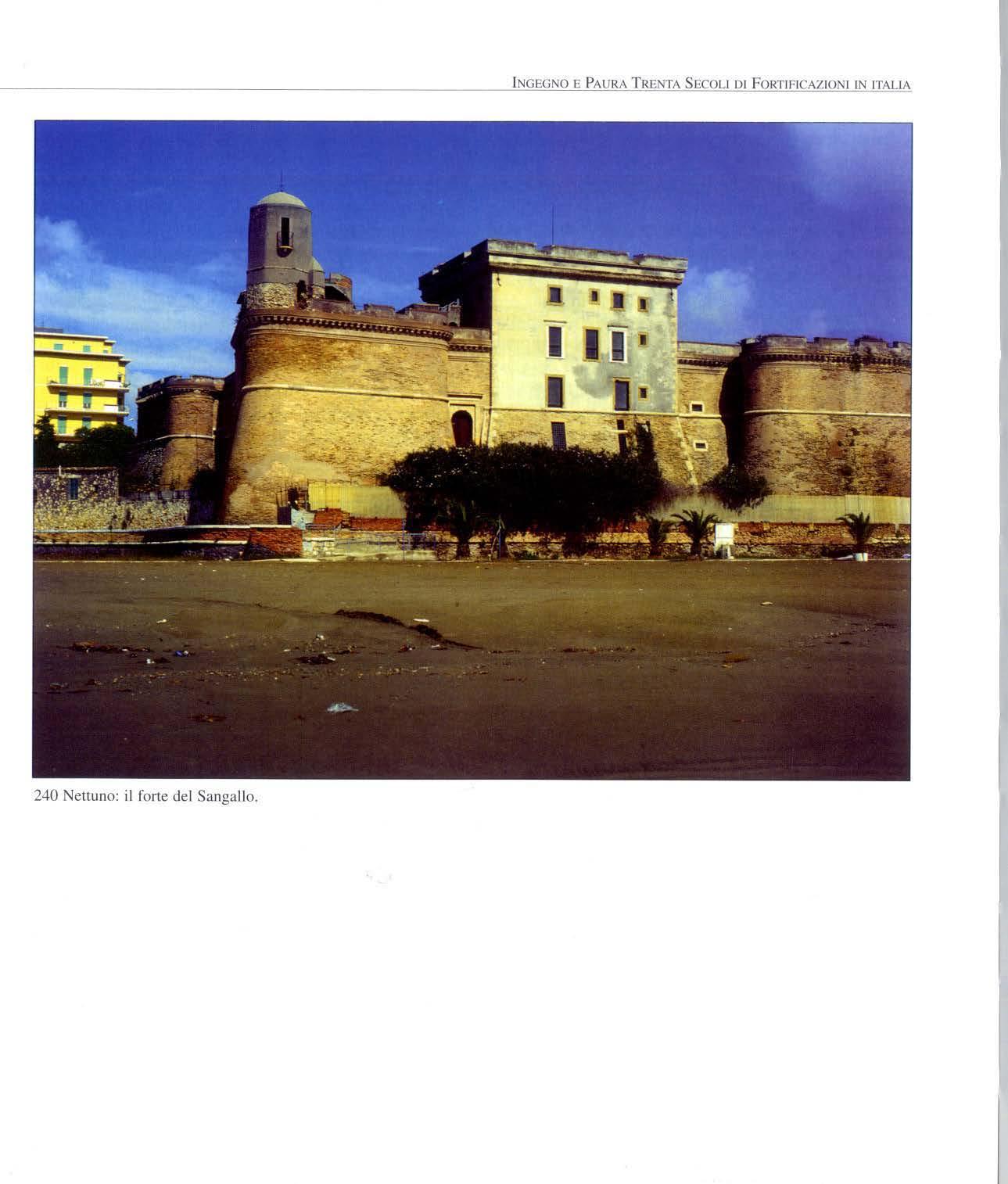
1 Da G.PARKER. La rivoluzione mili/are. Le innovazioni militari e il sorgere dell'Occidente, Bologna 1989, pp.20 -21.
1 Da R.Puoou, Eserciti e monarchie nazionali nei secoli XV-XVI. Firenze 1975, pp.11-12.
' Da W.H.Mc NEILL, Caccia al potere. Tecnologia. armi, realtà sociale dall'anno Mille. Varese 1984, p.77.
' Precisa R.PuDDU, Eserciti cit.. pp. l2 - l3 , che una: " influenza importante ebbero le armi da fuoco in genere sul piano dei rapporti tra le class i sociali.Veramente rivoluzionaria , se si pensa che, come ha sotto lineato lo sto rico L.Stone a proposito delJ'lnghilLerra dei Tudor, la possibilità da parte di un plebeo in possesso di un'arma da fuoco e capace di servirsene, di colpire un nobile da lontano. annullava d'un colpo la tradizionale superiorità dell'aristocrazia nell'uso delle armi ... Non deve perciò st upire lo sterminato numero di editti che, nei vari paesi d'Europa, vietavano ai plebei di fare uso di armi da fuoco, né che la stessa esistenza delle nuove anni suscitasse le pro teste e lo sdegno degli ordini privilegiati .. .Sia la Chiesa che i nobili. falciati in gran numero sui campi di battaglia dal fuoco di cannoni e archibugi manovrati e impugnati dalla plebaglia, si opponevano al diffondersi dei nuovi strumenti di morte, così distanti da una concezione cavalleresca e 'crist iana' della guerra ".
' Da C.SACHERO, Corso di fortificazione permanente d'attacco e d(fesa delle piazze forti, 2• ed .. Torino 1861. p.26.
b D a N.MACHIAVELU, Dell'Arte della Guerra, lib.TTI , cap.7
7 Da M.HOWARD. La guerra e le armi nella storia d'Europa, Bari 1978. p.65 .
8 Da G.PARKER, La rivoluzione , cit., p.26.
9 Da M.MALLETI, Signori e mercenari. La guerra nell'Italia del Rinascimento , Urbino 1983, p.170.
10 Da S.MASINI, G.ROTASSO, Dall'archibugio al Kalashnikov sette secoli di armi da.fuoco, Milano 1992, p.14.
11 Da M.HOWARD, La guerra , cit.. p.61.
12 Da C.M.CIPOLLA. Vele e cannoni. Im ola 1983. p.32
u Da S.SQUADRONI, Fabbricazione ed uso delle antiche artiglierie. in Antiche Artiglierie nelle Marche secc.X/V-XVI a cura di M.Mauro , Ancona 1989, voi.I, p.13.
1 • Da E.BRAVETIA. L'artiglieria e le sue meraviglie, Milano 1919, p.176.
15 Ricorda al riguardo M.A.BRAGADLN, Le Repubbliche Marinare, Verona 1974, p.8 l: "In Italia , i Veneziani furono i primi a diventare abilissimi costruttori di cannoni, e la repubblica destinò al «getto» delle artiglierie un largo terreno (da qui nacque il vocabolo <<ghetto » quando, in seguito g li israeliti si installarono in quel luogo)."
16 Da C.M.CIPOLLA. Vele .... cit.. pp.18 -1 9.
17 Da W.H.Mc NEILL. Caccia , cit.. p.74.
i s Da S.SQ UADRONl, Fabbricazione... , cit., p.12.
19 Da F.DI GIORGIO MARTINT, Trattari di architelfura ingegneria e arte militare. a cura di e.Maltese, Verona 1967, vol.l, p.220.
20 Da F.DI GIORGIO MARTIN!, Tral/ati... , cit., vol.n. p.418.

21 La ci tazio ne è tratta da E BRAVETIA. L'artig lieria , cit., p.122.
22 Da M.MALLETT, Signori... , cit.. p.166.
2' TI rimbalzo dei proietti fu sfnittato a lungo sul campo di battaglia per incrementare la gitta ta del tiro senza che però la palla si sollevasse molto dal terreno. conservando così per buona parte della sua traiettoria potenzialità mortifere. Ancora nel 185 I il gcn. G.ULLOA, Del/ arte della guerra, Torino 195 I. voi.I. p.136, scriveva al riguardo: "'Considerando finalmente i ti1i relativamente al bersaglio. r a1t iglieria non può colpire che di jìcco o di rimbalzo. Il tiro dicesi di ficco quando il proietto hatte direttamente il bersaglio, cioè senza salti o rimbalzi.
E' detto il tiro di rimbalzo a llo rchè il proietto vien lanciato in guisa che urta nel suolo senza ficcarvisi, e ne risalta percorrendo in aria una seconda curva, ricade poi a l termine di questa, e riurtando il suolo nell'istessa guisa descrive altre e altre curve. finchè non si estingue il moto.
I proietti lanciati da' pezzi da campo non rimbalzano se percuotono il terreno sotto un angolo maggiore di 7 in 8 gradi ".
2
• Da W.H.Mc NE IL L. Caccia .... cit.. p.75.
25 Da W.H.Mc NE IL L, Caccia cit., p 76
2
• Da F.BRA UDEL. Le strutture del quotidiano , Torino 1982, p. 365.
11 Da M.MALLETI, Signori .... cil. . p.166.
Da M.MORIN, Art iglieria, in Enciclopedia ragionata delle anni a c ura di C.BLA IR , Verona 1979, p.64. alla voce.
1<i Da E.BRAVETIA, L'artiglieria , cit.. p.87.
10 Da B.GJLLE, Leonardo e gli ingegneri del Rinascimento, Varese 1972, p. l3 I
31 La citazione è tratta da F.Gurcc1ARDINI, Storia d'Italia , voi.I, cap.ll. Sostanzialmente simile anche il parere di P.Iovrus, Historiae, voi.I, pp.24-25, che così scriveva: "Ma soprattutto diedero gran meraviglia a ognuno più che trentasei artiglierie su carrette, le quali con incredibile prestezza, erano tirate da cavalli per luoghi piani e diseguali: le maggiori di esse, lunghe otto piedi e pesanti seimila libbre di bronzo , si chiamavano cannoni, le quali tiravano palle di ferro grandi quanto una testa d'uomo. Poi erano le colubrine, più lunghe della metà ma più strette di canna e di minor palla. Seguivano i falconi di proporzioni varie, di cui i più piccoli scagliavano palle grosse come una arancia. Tutti questi pezzi erano inseriti in due grosse assi co n le fibbie tiratevi sopra, e sospese con le loro anse in modo che, per dirigere i colpi, ruotavano intorno all'asse. I piccoli avevano sotto due ruote e i grossi quattro, delle quali quelle di dietro si potevano levare e mettere per affrettare o rallentare la corsa; e i maestri carrettieri li facevano correre con tanta rapidità che i cava ll i postivi sotto, incitati da ll e sferze e dalle grida, nei luoghi piani tenevano lo stesso passo dei cavalli liberi ".
n Cfr. F.Russo, A.ffustamento di due pez,z,i da sedici rinvenuti nella fortezza di Carlo V di Capua destinati alle Artiglierie della frontiera marittima del Regno di Napoli, Lecce 1995, pp.40-46.
J.i Cfr. G.MARTENE, Flagello militare, Napoli 1676, pp.2-108.
34 Da M.MALLETI , Signori , cit., pp.166-167.
35 La citazione è tratta da L. MAGGIULLI, Otranto, Lecce , 1893.
36 Da F.DI GIORGIO MARTJNJ , Trattati , cit., voi., p.13.
37 Da A.CASSI RAMELLI, Dalle caverne ai rifugi blindati, Milano 1964, p.328.
38 Da C.SA CHERO, Corso , cit., p.28.
39 Da C.SACHERO, Corso ... , cit., p.28.
4-0 Da C.SACHERO, Corso , cit., pp.26-27.
• 1 Da F.DI GIORGIO MARTIN I, Trattati , cit., voi.II, p.430.
• 2 Da A.CASSI RAMELLI, Dalle caverne , cit., p.336 .
..., Da C.SACHERO, Corso ... , cit., p.27.
"' O.PALLONI, La transizione, in Ro cche e bombarde fra Marche e Romagna nel XV secolo, di M.MAURO, Ravenna 1995, p.20.
• 5 Da O.VASAR I, Vita di Francesco di Giorgio scultore ed architetto e di Lorenzo Vecchietta scultore e pittore senesi, in Le vite de' più eccellenti pittori, scultori et architettori, Milano 1928- l 930, Il , p.75.
46 Da C.MALTESE, Introdu zione, in F.Dr GIORGIO MARTINI , Trattati , cit., pp.XI-XII.
47 Da C.MALTESE, Introdu zione , cit., pp.XIJ-XIV.
48 Precisa al riguardo G.C.SPEZIALE, Storia militare di Taranto negli ultimi cinque secoli , Bari 1930, pp.30-31: " Eran al seguito del duca [Alfonso d' Aragonaj Francesco di Giorgio Martini e Ciro Ciri di Casteldurante, architetti militari va lenti ss imi ...Tutti in s ieme convennero che era necessario rifare dalle fondamenta il caste llo, e ne sta bilirono all'ingrosso il progetto; ma intanto per rendere più sicura la città, fu stimato prndente isolarla nel mare tagliando la penisola sotto le mura della rocca Finalmente conclusa la guerra d'Otranto nel 1481, gli Aragonesi ebbero un pò di re sp iro ... La corte prese a suo carico la costruzione del nuovo castello che doveva sorgere, secondo il progetto elaborato da Ciro Ciii e Francesco di Giorgio Martini, al posto della rocca bizantina ".
• 9 Per ulteriori approfondimenti sull'opera dei tre architetti cfr. L.SANTORO, Castelli angioini... , cit., pp.193-198. so Da B.GILL E, Leonardo... , cit., pp.130-136.
s, Da F.DI GIORGIO MARTIN!, Trattati , cit., vol.U, p.418. si Da F.Dr GIORGIO MARTIN!, Trattati. .. , cit. , voi.li, p.428.
53 Da P.P tERI, li Rinascimento e la crisi militare italiana, rist. Torino 1970, p.21.
54 Cfr. A.BIAGINI, Cossovo tra mito e storia, in L'Universo, riv.I.G.M., Firenze, anno LXXIX, luglio-agosto 1999, pp.458 e sgg.
55 Cfr. F. Russo , I Turchi e la diaspora albanese, in Studi Storico-Militari 1996 , Roma 1998, pp.40-67.
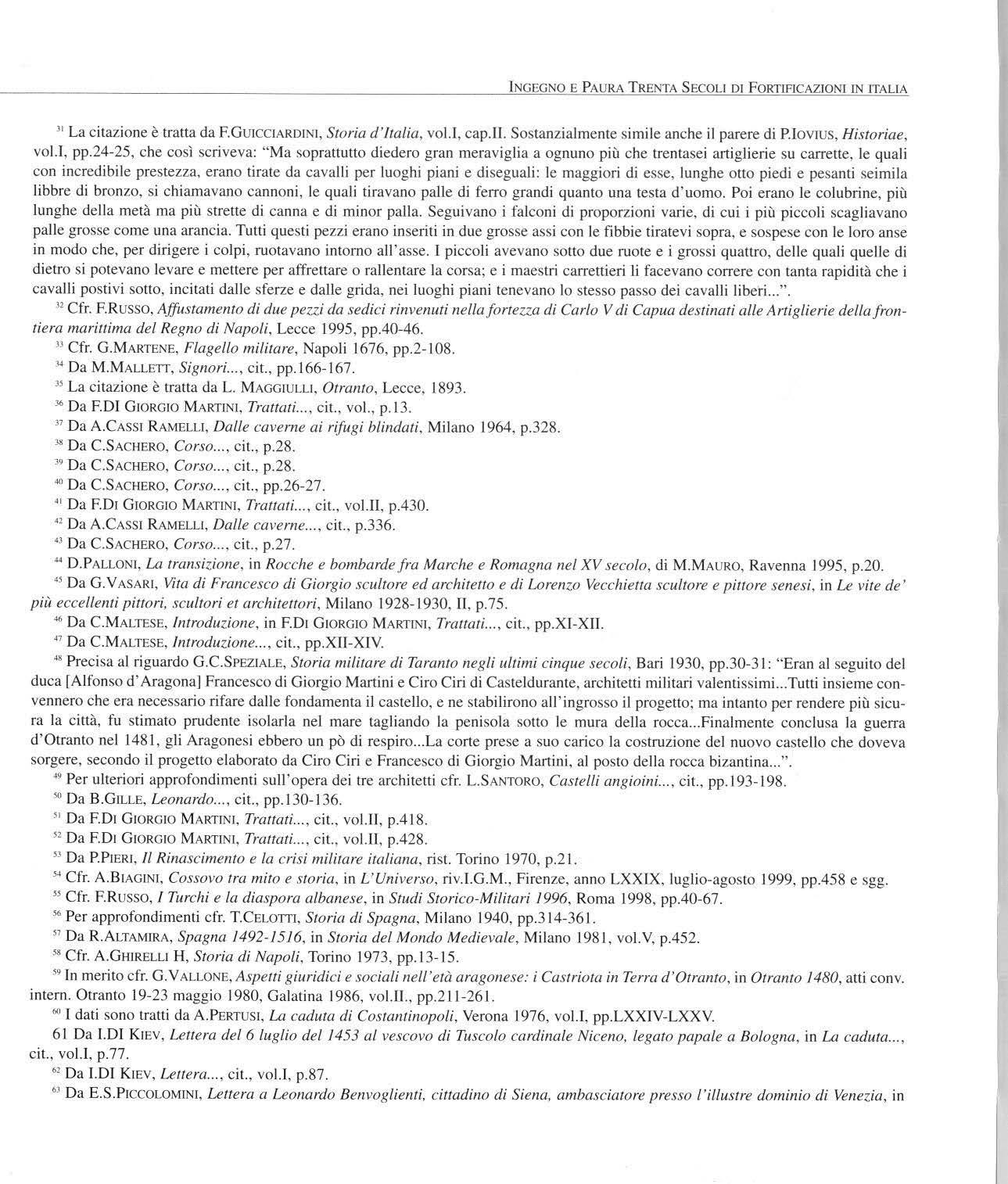
16 Per approfondimenti cfr T.C ELOTII, Storia di Spagna, Milano 1940, pp.3 14-361.
57 Da R.ALTAMIRA, Spagna 1492 -1516, in Storia del Mondo Medievale, Milano 1981, voi.V, p.452.
58 Cfr. A .GHIREL LI H, Storia di Napoli, Torino 1973 , pp.13-15.
59 In merito cfr. G.VALLONE, Aspetti giuridici e sociali nell'età aragonese: i Castriow in Terra d'Otranto, in Otranto 1480, atti conv. intern. Otranto 19-23 maggio 1980, Galatina 1986 , voi.Il., pp .211-261.
00 1 dati sono tratti da A.PERTUSI, La caduta di Costantinopoli, Verona 1976, voi.I, pp.LXXIV-LXXY.
61 Da I. DI KIEV , Lettera del 6 luglio del 1453 al vescovo di Tuscolo ca rdinale Niceno, legato papale a Bologna, in La caduta , cit., voi.I, p.77.
62 Da I.D I K tEV, Lettera , cit., voi.I, p.87.
63 Da E.S.P rCCOLOMINI, Lettera a Leonardo Benvoglienti, cittadino di Siena, ambasciatore presso l'illustre dominio di Venezia, in
La caduta , cit., voi.Il , p.65.
64 Cfr. F.R usso, Guerra di Corsa, Roma 1997, tomo I, pp.83 -88.
65 Da M.LAGGETIO, Hi storia della guerra di Otranto del 1480, ri s t. Lecce 1940, p.30.
66 È in teressa nte ricordare che la maggior parte dei turchi arresisi si arruolò sotto le insegne aragones i, dove ancora negli anni s ucce: risulta impiegata in vari teatri bellici, s ino al s uo progressivo totale annientamento. Per quanto è possibile rico st rnire si trattò di circa 700 c !ieri, al comando dell'agà dei g i annizzeri di nome Sebech, rinnegato di Metelino. La loro azione fu particolarm e nte apprezzata dal re di N~ il 21 agosto del 1482 a Campomerto, quando intervennero per e vitargli la cattura ad opera delle truppe di Sisto IV.
67 D a B DI CASTIGLIONE, Castelli pugliesi, Roma 1927, pp.211-227.
63 In merito cfr. O.MONACO,/ Beati Martiri di Otranto , Napoli 1980, pp.37-40; G.GIANFREDA, Storicità del Martirio dei Martiri di Om Napoli 1980, pp. 37 e sgg; F.R usso, Guerra , cit., pp. 89-96.
th Archivio di Stato di Venezia, Commemoriali, reg.18 , cc.63r. -7 I v. e cc. 221 v. -222v.
10 Da A.MICALE, Il castello di Mila u,o, Me ss ina 1985, p.16
71 Cfr.J.MORDAL, Venticinque secoli di guerra s ul mare, To rino 197 3, pp.18-19.
72 Il cod ice dei ri lievi di F.N EGRO 1630, relativo a tutte le fortificazioni costiere della Sicilia è custodito nell a Biblioteca Nazionale di Ma Ms l.
73 Prec isa al riguardo F.CHALADON, Storia della domina z ione normanna in Italia e in Sicilia , Napoli 1999 , p .2 28: " La prima spedizione a dimostrato c he era diffic i le impossessarsi di Me ss ina , c i si risolse dunque ad abbandonare la città e a dirigere l'a ssalto con tro Milazzo. Le 1 pesi imbarcaron o di notte, probabilmente dal lato di Pezzo o di Canitello al fine di avere una traversata meno lunga e vennero a sbarcare a di Messina, verso Faro (18-25 febbraio 1061 ) Una parte della guarnigione di Messina tentò invano di fermare i Normanni che devastaro1 regione di Milazzo e ritorn arono verso la loro flotta con un ricco bottino ... " . La conquista quindi avvenne nel corso dell'estate successiva
74 La citazione è tratta da A.MICALE, Il castello , cit., p. 138.
75 Per approfondimenti cfr. F.Russo, La d(fesa costiera del regno di Sicilia dal XVI al XIX secolo, Roma 1994, tomo 1, pp. I 08-118.
76 Da S.RArru, Bastioni e torri di Castelsardo. La ro ccafo rte dai tre nomi: Castel Genovese, Castell'Aragonese, Castelsardo. Contn alla storia dell'architettura militare, Torino 1953, p.16.
77 Da J.HEERS , Pisani e Genovesi nella Sardegna medievale, in Storia dei Sardi e della Sardegna, Milano 1988, voi.Il, p 238.
78 Da D.M ACK SMITH, Storia della Sicilia medievale e moderna , Bari 1971, pp.100-108.
79 l.PRINCrPE, Sassari Alghero Castelsardo Porto Torres, B ari 1983 , p.57.
80 Al riguardo cfr. R D E VITA, Caste lli, torri ed opere fortificate di Puglia , Milano 1982, pp.140-144.
81 Pe r approfondimenti cfr. A.MAURO, Il cas tello aragonese di Baia, Napoli 1979, pp.29-121.
82 Da O.ANTONIO SUMMONTE, Dell ' Historia della città e Regno di Napoli, Napoli 1675 , tomo m, p.495
83 Cfr. F. R usso, La difesa costiera del regno di Napoli dal XVI al XJX secolo, Roma 1989.
84 La citazione è tratta da C.CELANO, Notizie s ulla città di Napoli, rist.Nàpo li 1974, voi.I, p.49.
85 Cfr. L.SANTORO, Le mura di Napoli, Napoli 1984, p.182.
86 Sull'argomento cfr. A.DELLA ROCCA, Le mura di Napoli aragonese. Porta Capuana e la loro vicenda storica, Napoli 1978 , pp.9-14
87 Cfr. L.S ANTORO, le mura di Napoli, 1984, pp.68- 72.
88 Cfr. G.S EPE, La murazione aragonese di Napoli, Napoli 1942, p. l l.
89 Cfr. P.PIERI, il Rinascimento , cit., pp.337 -3 40.
90 La citazione è tratta da P.Pr ERI, Il Rinascimento , cit., p.389-390, nota n° 2.
91 Da J.H OGG, Storia delle fortificazioni , Novara 1982 , p.107.
92 Sull'impaludamento della foce del Temo, cfr. F.R usso, La difesa costiera del regno di Sardegna dal XVI al XIX secolo, Roma pp.89-91.
93 Cfr. M.GR UNDY, The Martello Towers of Minorca, in Fortress , vol.19, 1991, pp.28 e sgg. Ed anche E.J.GRIMSLEY, Martello To1 Liphook 199 l, Great Britain.

Da J.HOGG, Storia... , cit., p.1 34.
95 ln merito cfr. R.D , ROSA, La torre Martello di Magnisi, in Studi Storico-Militari /994 , R oma 1996, pp.283-367.
96 Per approfondimenti cfr. A. V ENTURA, La Puglia di Piri R eis, Manduria I 990 , introduzione.
97 Da V.FAGLIA, Censimento delle torri costiere nella provincia di terra d'Otranto, Roma 1978, p.83.
98 Cfr. B COC ARELLA, Cronaca istoriale di Tremiti, ora vo lgariu,ata a comun beneficio da d.Pedro PDi Rib era, Venetia 1606.
99 Da R.D E VITA, Castelli. , cit., p .73.
100 Da R.DE VITA, Ca.-stelli , cit., p.70.
101 Cfr. G . M.DE Rossi. Torri medievali della Campagna Romana, Roma 1981, pp.129-133. Al riguardo B.GILLE, Leonardo e gli ingegneri cit., p.143, così precisa: "La grande opera militare di Giuliano da SangaJlo è la fortezza di Ostia, che dominava la foce del Tevere e la cui costruzione era stata ordinata dal cardinale dcJla Rovere La pianta di questa forte27,a è oggi conservata alla Biblioteca municipale di Siena fra le carte dell'architetto. Essa appartiene a un'epoca di transizione tra le forme antiche e le nuove tecniche, che vedranno l a luce alcuni decenn i dopo. Essa rappresenta, in ogni caso, pe,fe t tamente il tipo di fortezze che Francesco di Giorgio ha descritto nel suo trattato di arch itettura. Ha l a forma di un triango lo pro l ungato, con bastioni circolari alla estremità.Vi è conservata l'antica torre medievale, protetta da un bastione ad ango lo leggermente sagomato a salienti e rientranti: essa serve <li rocca al la fortezza ,.
101 Sono di questo avviso A.C.CENnARINI. M.GIACCAGUA, Rocche e castelli del Lazio, Roma 1982. pp.181.
'"' Puntualizza sulla delicatissima questione P.EGIDJ, La politica del Regno di Napoli negli ultimi mesi dell'anno 1480 in Arch i vio Storico Napoletano N ° XXXV. Napol i 19 IO: "Già dall' 11 agosto 1479 Venez i a ufficialmente e ra s tata richiesta dai turchi di aiuto per una spedizione contro la Pug l ia e contro il papa, e i tu r ch i a torto o a ragione, avevan credulo <li poter contare su ta le aiuto tanto che nel marzo 1480. come per intesa precedente, essi chiesero passo pei port i veneti e vettovaglie e la fornitura e l' armamento per settanta ga lere ... Forse non ebbero nulla: certo è però che le trattative corsero ... ".
1114 Da A.CASSI RAMELLI, Dalle caverne ai rifugi blindati. 1ren1a secoli di architettura militare. Mi l ano 1964, p . 345.
wi La c i tazione è tratta da A G UGLJELMOTII, Storia delle fortificazioni nella spiaggia romana risarcite ed accresciute dal 1560 al 1570, Roma 1880, p.56.
06 G.SACCHr LoorSPOTO, Castelli ed opere difortiflca::.ione del La zio nelle medaglie pontificie. in Lunario 1977 Casal i e Castell i Roma 1977, p.465-466.
w, Da A.GUGLIELMOTII. Storia delle , cit., p.58.
10 ~ Da G. V i\SAR I, Le 11ite de· più eccellenti piuori scultori ed archi tettori seri Ile da Giorgio Vasari pillo re aretino, c011 num·e a111101az,ioni e commenti di Gaetano Milanesi, Firenze I 906, tomo TV, .272.
J()Q C irca tale termine cosl scrisse A.GuGUEI.MOTfI , Vocabolario marino e militare, Roma 1889, a lla voce: "Nome derivato dal precedente , come a dire, Bucio d'oro: perchè eg l i era lo scafo senz'a lberi. e tanto ricchissimo di dorature, che i Francesi a Venezia ne l l 797 lo bruciarano per cavarne moneta. Potrebbe definirs i q uel grandioso bastimento da remo che serviva ai principi d'Italia per piccole navigaz ioni di piacere o di comparsa Bucintoro di Roma, quello che i Papi usavano, navigando sul Tevere, e per la marina propinque. di che trattano sovente gli scrillori .. .''.
1111 Da A.GUGLIELMor n, Storia delle cit., p.59.
' " Sulla forma delle feritoie cfr. M.MAURO Antiche ar1iglierie , ci t. , pp.48-56.
" ' L'espediente di aJlagare i fossati, non sempre adottato da cu i la suddiv isione di questi in u midi ed asc i utti non offriva in fatti so ltanto de i vantaggi per i dife nsori. Il primo e leme nt o negativo deriva n te dalla sua adozione era la scarsa salubrità del)' aria . ammorbata dal ristagno dell'acqua e la eccessiva umidi t à ne i locali terrane i , i nadatti alla conservazione delle mu n i7.ioni e dei viveri. Altro fattore di l imitazione era costituito da ll a forte variab il it à del liveJlo <l' i nvaso, non di rado troppo scarso per una efficace pro t ezione. come pure, ne i climi 1igid i dal gelo che eliminava <li fatto tale ostacolo. A ciò s i doveva aggi u ngere la diffico l tà di contrattacchi risolutori ed infine il maggior costo delle ope re necessarie, dettagli tulli che in pratica ne ridussero fortemente l 'ad07ione, specie dopo l'avvento delle artig lierie rinascimenta l i.
111 Da A.GUG LI F.I.MOTII. Storia delle , cit., p.71.
11 • Una dettag liata descrizione su un dispositivo co n ti n uo di galleria di con t romina lo si può leggere nelle prescri7.ion i tecnico esecutive re lative al la cerchia bastionata d i Palermo redatte dal I · ing. Ferramolino intorno al 1530: in merito cfr. F. Russo, La difesa costiera del Regno di S i cilia .... cit.tomo I , pp .94- 108.
111 Da A.GUGLIELMOlTI. Storia delle cit., p.7 1
116 D a A.GUGLIELMOTrl, Storia delle ... , cit.. p.73.
111 DaA.GUGLIELMOn r, Storia delle , ci t. , p.73.
m Si tratta delle p r ime manifestazioni, sicuramente ricercate, de l la 'gue rra chimica'. favorite dall'angustia degli ambienti e dalla particola r issima venti lazione.
11 • Da A.GUGUELMOlTI, Storia delle ... , cit., p .75.
,:o Da A.Gt:GLIELMOTTJ. Storia delle , cit.. p.76.
121 Da A.GUGLIELMOTII, Storia delle , c it. , p.77.
12 2 D a W. H .Mc NE!LL. Caccia cit., pp.77-78.


Il caste ll o de ll e P ietre di Capua
Il caste ll o di Casaluce presso Aversa
La rinasci ta de ll ' Im pero
F ederico II i mpe r atore
L'imp e ro di Fe derico II.
I caste lli fe de ricia ni
I cas telli di C atani a, A ugu sta e S irac usa......
Il cas tello d ell ' I m pe ra to re a P rato
Il castell o d e l Matin ale
Caste lli d i B a ri
G io ia del Co lle, Tr a ni
Torre cos tiera di Vend icari
Il recin to fort ificato d i E nn a
Il recinto for tificato d i Lu cera

L'eni gm a di Cas te l d e l M onte
Il cas tello co l nome d i fi o re
NOT E
S ECO N-DO
D ai b orghi ai co muni
I lib e ri co mun i ....
O sservazioni su lle fortificaz io ni co m
Le for tificaz ion i perimetra li comu nali
di
Borg hi ag ricoli e com uni rural i ...
P anica le
M onte ri gg io ni .. .. .... .... ...
Le fo r ti fi caz io ni p ri vate : le torri gen tili zie
S a n Gim ig nano ......... .... .... ...
Il Reg no Angioin o
I Ves pri Sic ilian i
Le fortifi caz io ni an g io in e
C as te l N uovo di Napoli
Il cas tell o di G aeta ....
Il to rri one di Mo la
Le C as te ll a di. Cap o Ri zz uto
L'avvento dell'artiglieria........ .. ... . ... . .. .. .................. .. ............................................................................. .
NOTE CA PITOLO TERZO .................................................................................................................. .
CAPITOLO QUARTO
La fine di un'era
L'abbondan za delle permanenze
L'artiglieria dalla comparsa a lla metà del XV secolo .. .. .. .............................. .. .. ...... .............................. ..
Il sa lto te c nologi co
I cannoni di Carlo VIII. .............. .. .. .......... ........................ ... .... .... .... .... . ... .... ... .............. .. .. .. .. .. .. .. ...........
I limiti de lla tran s iz ion e ... ..................
Le fasi della transizione
L' in geg nere della transizio ne .. .... .... ... ..............
Situazione geopo litic a mediterranea ..
Il princ i pio d ella fine : Costantinopoli I 453 ...... .........................
Mura e bomb arde ad Otr a nto ................................................................................................................
Arti g lieri e dei forti e d el caste llo di Otranto ne l 1496 ...........
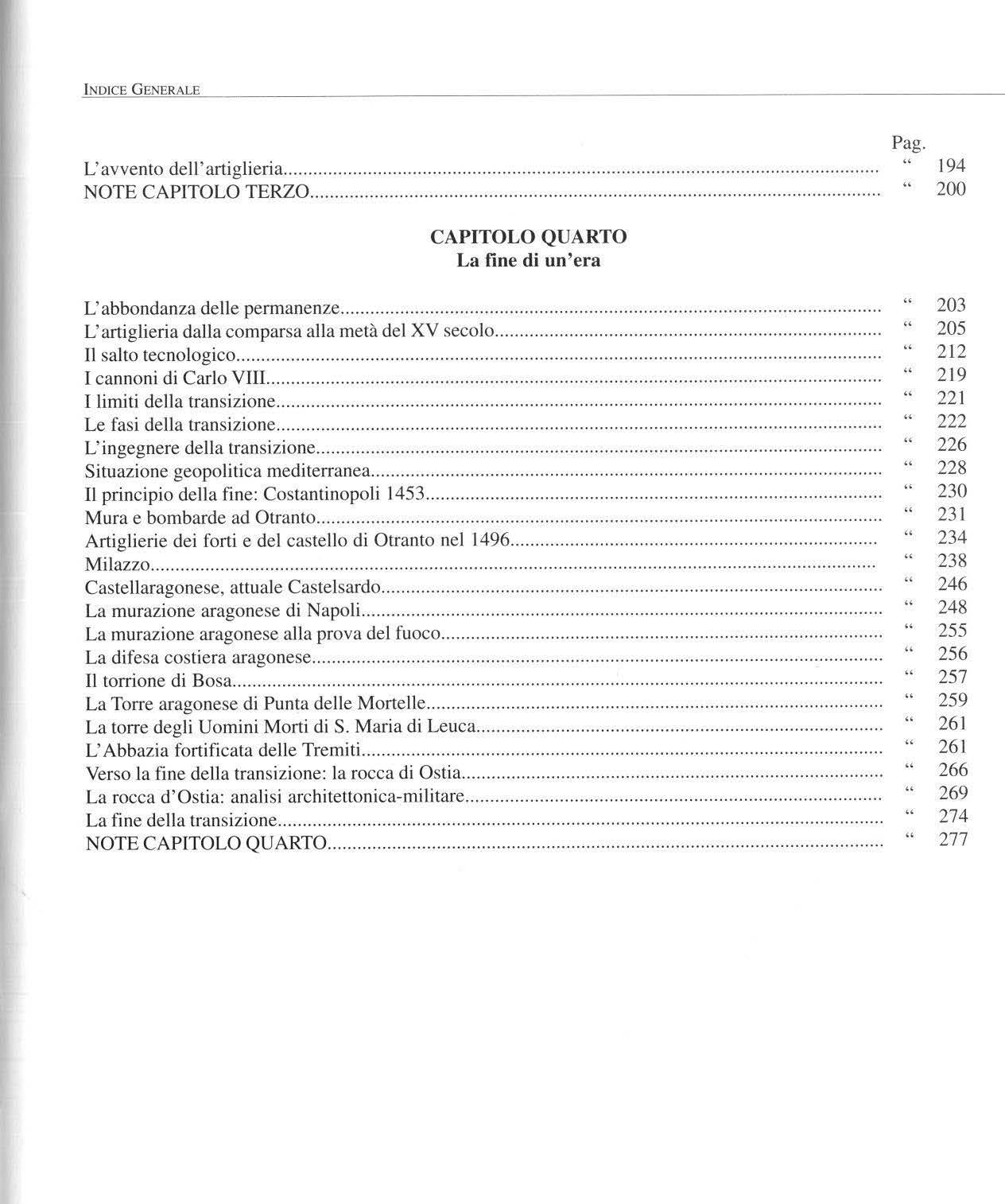
Milazzo
C aste llarago nese, attuale Castelsardo
La murazion e aragonese di Na poli
La mur az ion e aragonese alla prova del fuoco
L a difesa co sti era aragonese
Il torrione di Bosa
La Torre aragonese di Punta delle Morte lle ..
La torre de g li Uomi ni Morti di S. Maria di Leuca
L'A bbazia fortificata delle Tremi ti ........................................................................................................
Verso la fine della tran s izione: la rocca di O stia
La ro cca d ' O stia: analisi architettonica-militare ... ...
La fin e della transizione
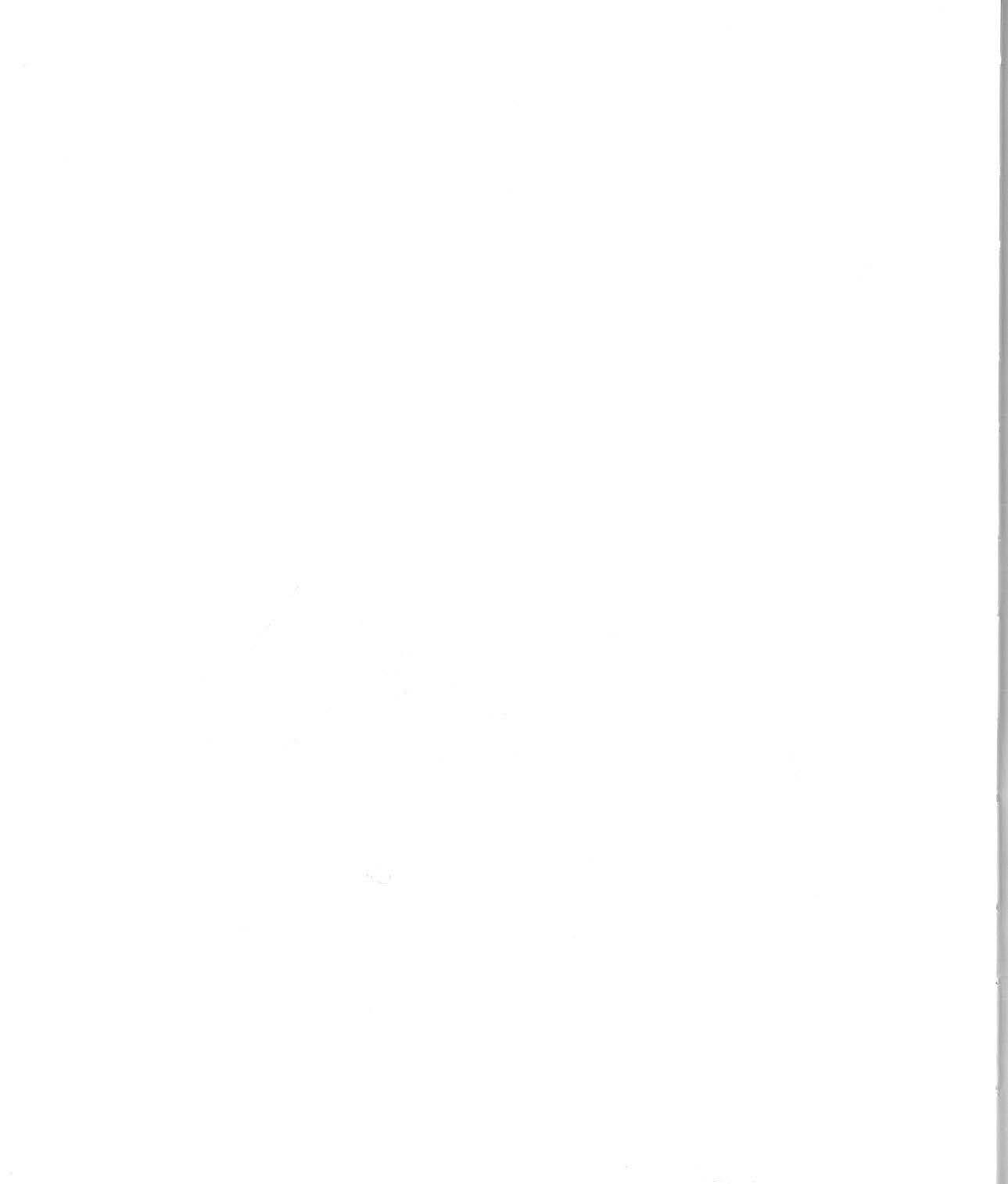
1-Napoli , veduta di Castel dell'Ove .. . ................................... . ................... .. .. .. ...................................... .
2-La pianura fra il Vesuvio ed i monti Lattari, solcata dal Samo: in primo piano il castello di Lettere.............. .
3-S.Agata dei Goti , veduta aerea........................................................................................................... .
4-S.Agata dei Goti: lato nord-ovest. ...................................................................................................... .
5-S.Agata dei Goti: lat o sud-est.
6-S.Agata dei Goti: porta urbi ca.................................................. .......................................................... .
7-S.Agata dei Go ti: interno della porta
8-S.Agata dei Go ti: scorcio urbanistico
9-S.Agata dei Goti: scorcio urbanistico ................................................................................................. .
10-S.Agata dei Goti: scorc io urbanistico
11 -Val Veno sta, castel Appiano: plani metri a .. ......
12-Val Venosta, castel Tschengelberg: planimetria................................................................................ .
13-Val Venosta, caste l Frolich: planimetria ........................................................................................... .
14-Salerno, panoramica caste ll o di Arechi ........... ....................................................................... .......... .
15 -Salerno, cas tello di Arechi: planimetria ...... .... .. ................................................... . ....................... ..... .
16-Salerno, foto aerea della città antica............................................................................................... ...
17-Salerno, particolare della mappa disegnata da Nicola San toro nel 1790 .......................................... .
18 -Salerno, dettaglio d ella torre mastra ................................................................................................. .
19-Salerno, scorcio del castello ....................................... ..................... .... . ............................................ .
20-Salerno, panoramica della città
2 1-Vairano Pate nora: veduta aerea
22- Vairano, panoramica
23- Vairano, planime tria
24-Vairano, dettaglio di una porta del borgo ... ..................................................................................... .. .
25-Montesarchio, panoramica ................................................................................................... ............ .
26-Montesarchio, planimetria............. ..... ... .. ............. ... .. .. ...... ............ .. .............. ..... ... ........... .... .... .. ...... .
27-Montesarchio: il torrione .................................................................................................................. .
28-Montesarchio: il caste llo .......................................................................... . ....................................... .

29-Montesarchio: dettaglio del castello .... .. .. .... .. .. .. ... ... ..... ..... .. .................. ..... .. .. .. .... .. .......................... .
30-Montesarchio, dettaglio del borgo .......................................................... . ... ...... .. ... .... . .. .. ... . .............. .
31-Montesarchio, dettaglio del borgo ............................ ..... . .............. .. ..... . ................. .... . ...... ... ..... .. .. .. .. .
32-Caserta Vecchia, il torrione ... .. .. ....... ................................................................................................. .
33-Benevento, planimetria cerchia longobard a
34-Benevento, scorcio dell e mura ... ...... .. .. ... ... ... .. ..... .. ...... .. . ... ...... ...... .........
35-Benevento, basa mento di una torre quadrata
36-Benevento, torre rotonda d'angolo: b e n evidente il materiale di spoglio
37-Benevento, basamento di una torre simi circolare ............................................................................. .
38-Benevento, altro scorcio d elle mura
39-Benevento, dettaglio di una torre .. ..................... .. ..............
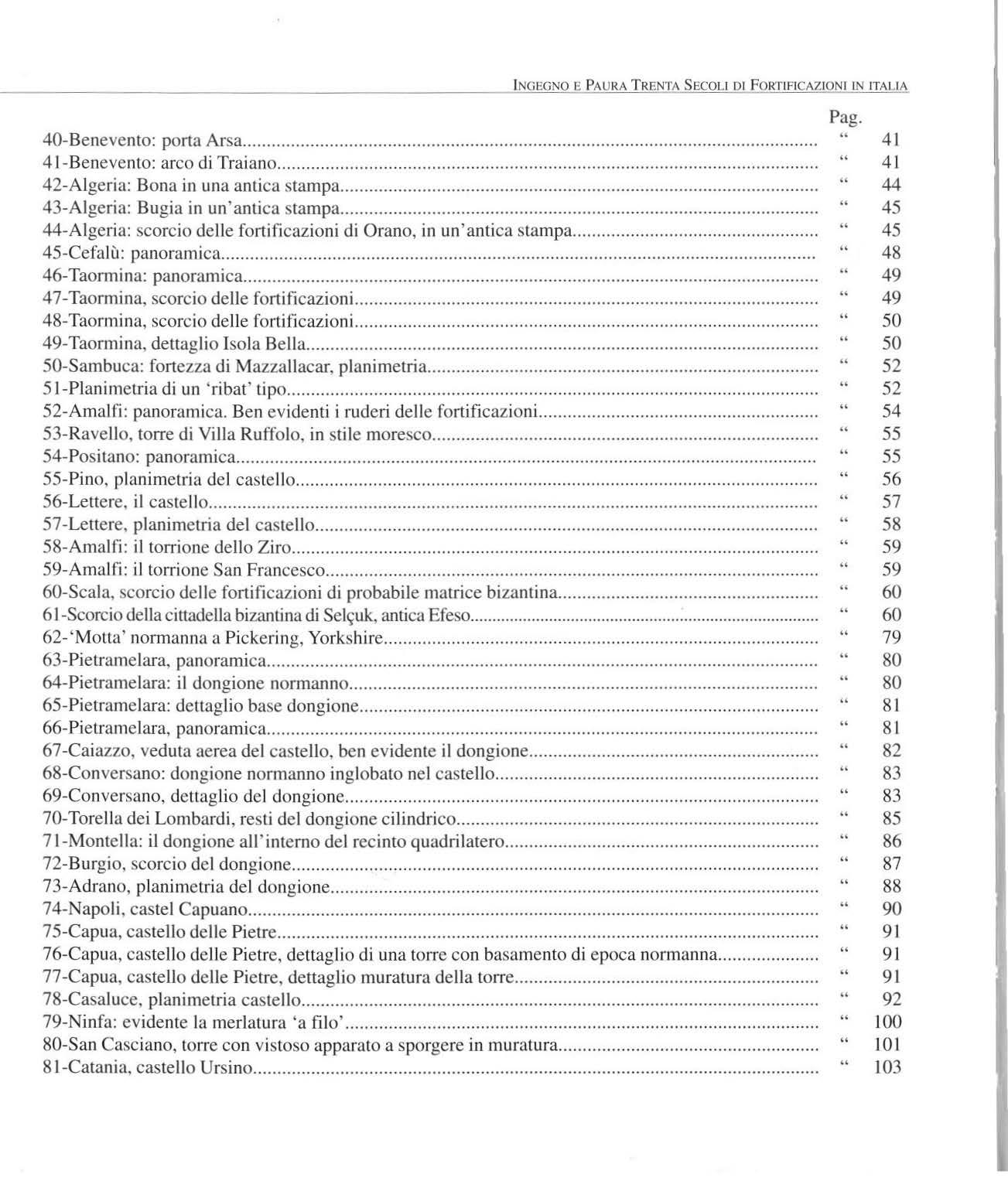

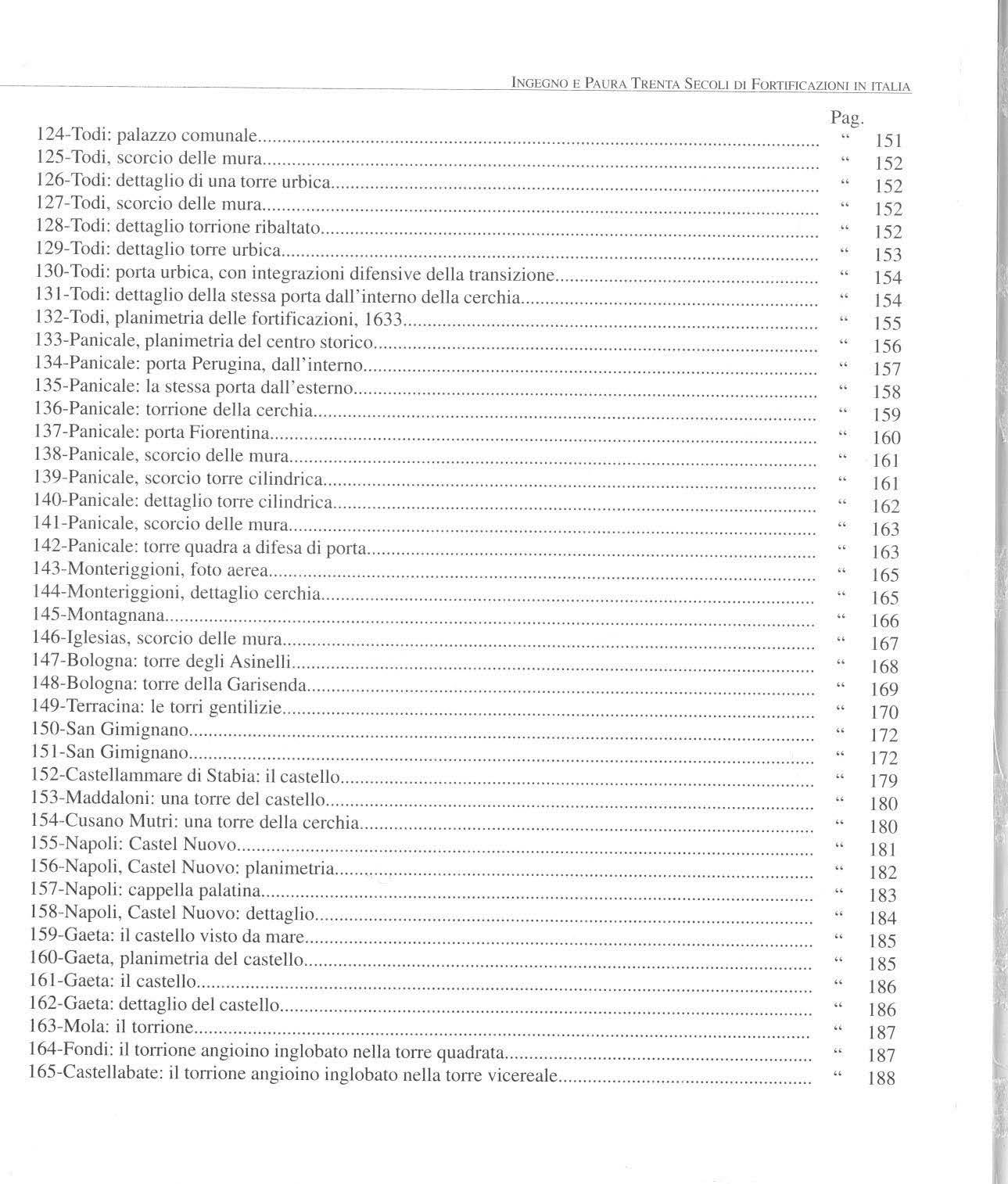
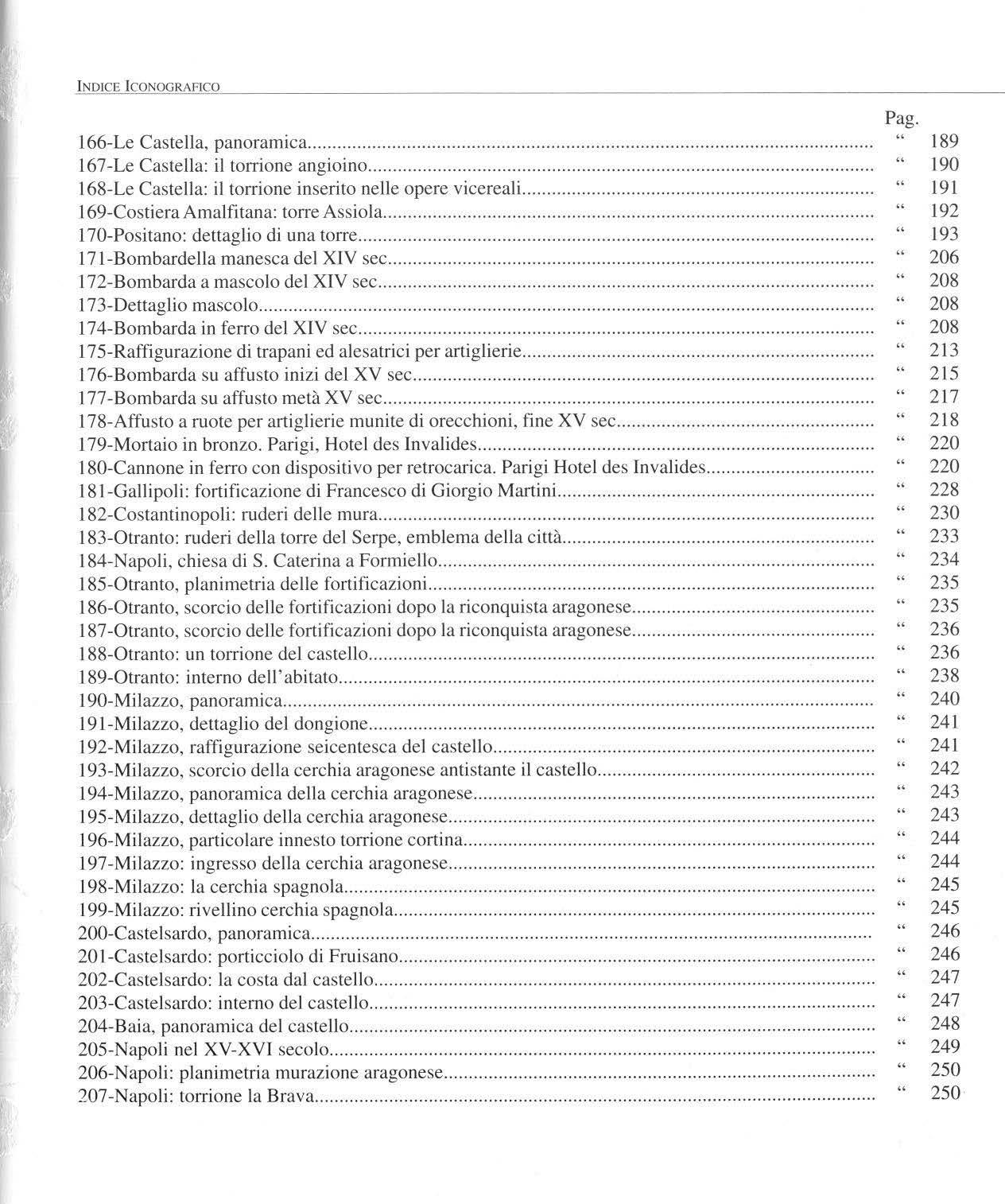
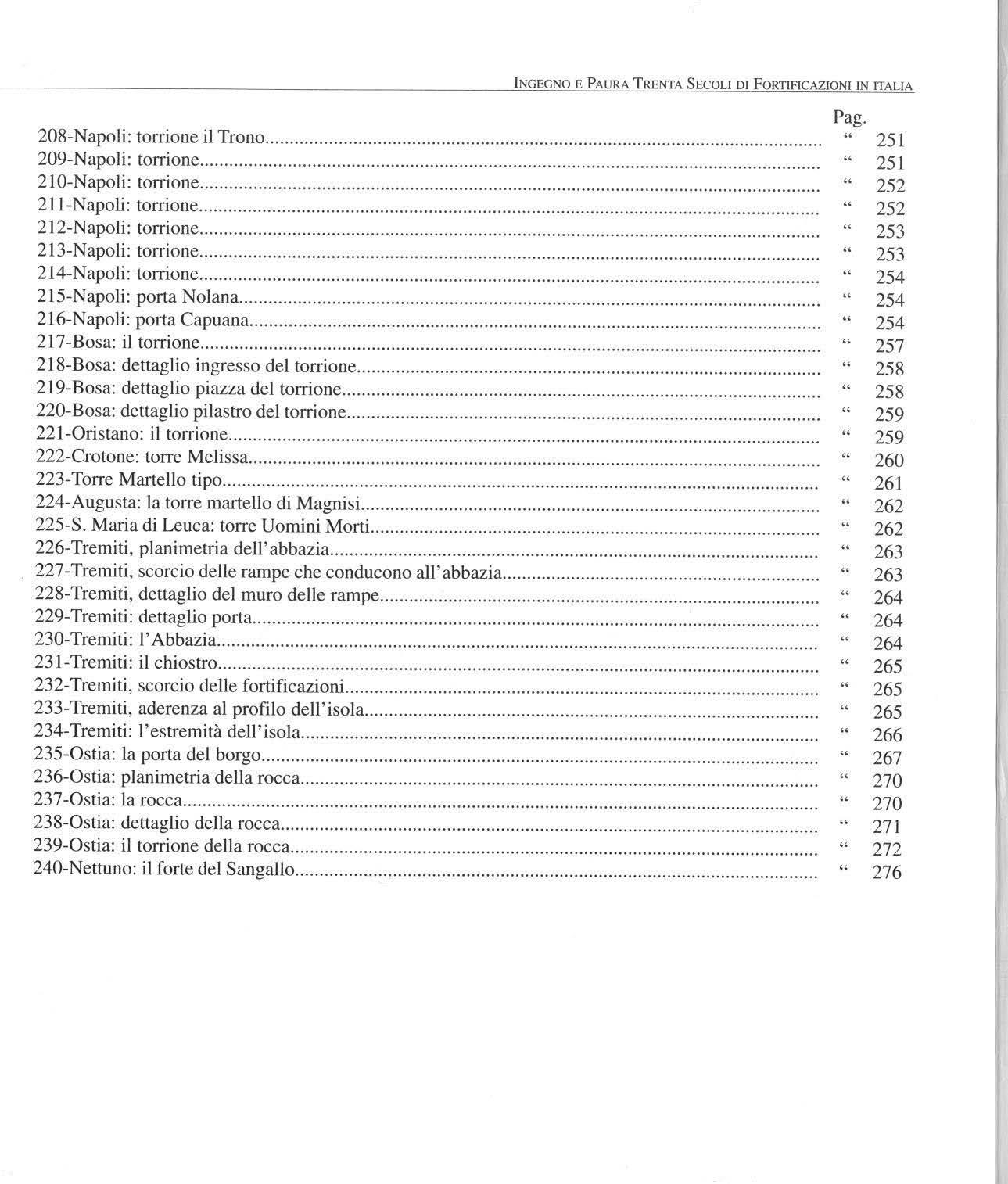
Finit o di stampare nel mese di giugno 2005 nello stab il im ento della Soc iet à Ed itrice Imago M edia
Azienda con Sistema Qialità Certificato ISO 9001:2000 da SGS ITALIA con certificato N° ITOl/0106
