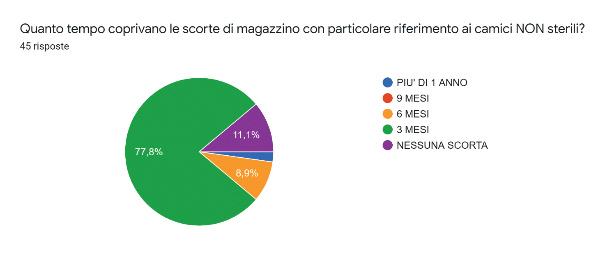ISSN 1723-9338 BIMESTRALE DI TECNICA ED ECONOMIA SANITARIA 11/12.22 FORMAZIONE FARE VIII CORSO DI ALTA FORMAZIONE VITTORIO D’AMBROSIO L’APPROVVIGIONAMENTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NELLA PANDEMIA: ESPERIENZA DELLA ASL DI TERAMO RAFFAELE PETROSINO PNRR: PARITÀ DI GENERE E CONTRATTI PUBBLICI – LA PRASSI UNI/PDR 125:2022 ANNALISA DAMELE SULLA REVISIONE DEI PREZZI NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE. BREVI OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA ANAC N. 37/2022





















fare® Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità fare® Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità fare® fare® Segreteria Organizzativa EDICOM Srl - Via A. Corti 28 - 20133 Milano Tel: 02/70633694 - info@gsanews.it Hotel Barceló Aran Mantegna XXII CONGRESSO NAZIONALE FARE Roma 26-27 ottobre 2023 SAVE THE DATE
Tecnica e metodologia economale
Bimestrale di tecnica ed economia sanitaria fondato nel 1962 per l’aggiornamento professionale degli economi e provveditori della Sanità. ISSN 1723-9338
Organo ufficiale della FARE
Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità
www.fareonline.it
fareDirettore responsabile Giovanna Serranò
Direttore editoriale Enza Colagrosso Tel. 393.5564782 e.mail: redazione.teme@gmail.com
In copertina: foto di Valentina Quarta
editoriale

3 A.R.E.A. punta sulla formazione articoli i DPI nella pandemia 4 L’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale nella pandemia: esperienza della ASL di Teramo tessuto non tessuto e tessuto tecnico 8 La vestizione degli operatori sanitari al tempo del COVID-19 dalle associazioni


13 Revisione prezzi: normativa, problematiche e ipotesi risolutive PNRR
16 PNRR: parità di genere e contratti pubblici La Prassi UNI/PdR 125:2022 prezzi di riferimento 19 Sulla revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture. Brevi osservazioni alla delibera ANAC n. 37/2022 gestione 22 Il tema dell’assenteismo nei contratti di somministrazione lavoro della pubblica amministrazione fascicolo sanitario elettronico 25 Fascicolo sanitario elettronico e PNRR: le ultime novità e i risvolti in materia di privacy documentazione assistenziale 28 L’appropriatezza della documentazione assistenziale: il d-catch instrument come elemento di accuratezza clinica ed organizzativa VIII Corso di formazione FARE 33 VIII Corso di Alta Formazione 2021/22 per Funzionari e Dirigenti in Sanità gli esperti rispondono 45 L’avvalimento del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio aziende informano 46 L’importanza della scelta d’acquisto per ottimizzare la rilevazione della traccia elettrocardiografica contenendone i costi 48 focus
Le foto all’interno sono di Andrea Leonardi
Andrea Leonardi vive e lavora a Roma, svolge da trent’anni attività di grafico, elaborazione fotografica e consulenza nelle arti grafiche. In questo numero oggetti ripresi da un laboratorio d’informatica
Direzione, Amministrazione e Pubblicità EDICOM s.r.l.
Sede legale: via Zavanasco, 2 20084 Lachiarella (MI)
Sede operativa: Via Alfonso Corti, 28 - 20133 Milano tel. 02 70 63 36 94 fax 02 70 63 34 29 e-mail:info@fareonline.it


Abbonamento ordinario annuale Euro 100,00 c.c.p. 38498200 intestato a Edicom srl Copia Euro 1,29
Impaginazione e Stampa STI - Stampa Tipolitografica Italiana Via Sesto Celere, 3 - 00152 Roma - Tel. 06 5814649 e-mail: info@grupposti.it
Autorizzazione del tribunale di Milano n° 15 del 25/01/16 La pubblicità non supera il 45% del numero delle pagine di ciascun fascicolo della rivista. © Copyright EDICOM s.r.l. - Milano
Le opinioni espresse negli articoli firmati vincolano soltanto gli autori. La posizione ufficiale della FARE sui vari temi ed argomenti trattati nella rivista è unicamente quella contenuta nei documenti degli organi deliberanti. In caso di riproduzione è necessaria la preventiva autorizzazione scritta del Direttore di Teme. L’editore garantisce la riservatezza dei dati forniti dai destinatari della rivista TEME nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003. Gli interessati (destinatari o autori) hanno la possibilità di far valere i propri diritti, senza alcuna spesa, secondo quanto previsto dall’art.7 del sopra citato D.Lgs. rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati Barbara Amoruso presso Edicom, Via Alfonso Corti 28, Milano.

sommario
novembre-dicembre 2022
8
16 13
25







VISITA IL SITO FARE ● essere informato sulle ultime notizie della sanità ● ricevere aggiornamento professionale ● conoscere le iniziative della Federazione Seguici anche su Linkedin www.fareonline.it Casa Editrice fare® Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità fare® Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità fare®
Amoroso - Presidente A.R.E.A.
A.R.E.A. punta sulla formazione
Finalmente, dopo il Covid, l’Associazione abruzzese e molisana ha riaperto il cantiere formazione e lo ha fatto alla grande programmando nel secondo semestre dell’anno corrente, ben tre eventi. Il primo si è svolto a Pescara nell’Auditorium del Museo delle Genti d’Abruzzo, per fare un’analisi di come l’evoluzione della normativa, della giurisprudenza e della prassi hanno influenzato gli appalti nella fornitura di beni e servizi sanitari, pertanto abbiamo coinvolto la nostra Centrale Acquisti (ARIC) per conoscerne gli orientamenti e i collegamenti con le Centrali di altre Regioni e portare l’esperienza di due Centrali di Acquisto (Umbria Salute ed ESTAR) che rappresentano delle best practises nelle procedure di acquisto di farmaci e dispositivi medici. Nel secondo evento, svoltosi il giorno 11 novembre a Campobasso nella sede dell’ASREM, è stato scelto un argomento oggi molto ricorrente che è l’innovazione, pertanto abbiamo coinvolto le due Centrali di acquisto e i buyer delle Aziende regionali, nonché un Sanitario ed un’Azienda commerciale. Per la Centrale Abruzzese è intervenuto l’Avv. Donato Cavallo che ha riferito che nell’anno in corso sono state indette per conto degli Enti Sanitari, Locali e Regionali 92 gare, delle quali ne sono state aggiudicate 31, riferite alla fornitura di beni, servizi e lavori ed ha presentato una flow chart utilizzata nelle gare, con evidenza nell’applicazione dell’inversione procedimentale, dell’esecuzione anticipata del contratto e dell’inserimento delle clausole obbligatorie e premiali per i bandi finanziati con i fondi del PNRR e PNC.

La Direttrice della Centrale Molisana Dottoressa Alberta De Lisio, oltre a parlare delle gare esperite ed in adesione con altre Regioni, si è soffermata sulla formazione del proprio personale e quindi si è dimostrata interessata anche ad una collaborazione con l’Associazione. A seguire sono intervenuti il Dottor Vittorio D’Ambrosio della ASL di Teramo che ha presentato un lavoro, risultato molto interessante, sull’analisi dei costi sostenuti per le mascherine FP2 nel periodo ante Covid, durante e post, il cui dettaglio potrà essere visionato su TE.ME. Sempre della ASL di Teramo il Dottor Domenico Lori ha parlato della gara relativa al servizio per l’erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche di risonanza magnetica nucleare la cui particolarità era legata alla fissazione del prezzo a base d’asta riferito alla media della remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, preventivamente decurtate del 20%. Il Dottor Antonio Di Sciascio della ASL di Chieti ha presentato in anteprima il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico con i diversi aspetti applicativi. La Dottoressa Rosa Vilma della ASL di Pescara ha parlato dell’affidamento a Cooperative del Servizio di Gestione e Assistenza Sanitaria dei codici bianchi e verdi del pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Pescara. Il Cardiologo Dott. Leonardo Paloscia ha evidenziato le criticità nella stesura di un capitolato tecnico e la difficoltà nella introduzione di nuovi prodotti innovativi. Infine il Dottor Giuseppe Monita della Società MTE International ha parlato di ostacoli ed opportunità nelle gare innovative. Il terzo evento sarà di nuovo a Pescara il giorno 19 dicembre con una chiusura di fine anno col botto sul nuovo Codice dei contratti con relazioni del Presidente della VII Sezione del Consiglio di Stato Dottor Claudio Contessa e dell’Avv. Alessandro Di Sciascio del Foro di Chieti.

3
editoriale
Claudio
D’Ambrosio
L’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale nella pandemia: esperienza della ASL di Teramo
Idispositivi di protezione individuale (DPI), intesi quali dotazioni indossate dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, rappresentavano, prima della pandemia, una voce di acquisto del tutto marginale e residuale rispetto alla totalità delle categorie merceologiche in ambito sanitario. Il ricorso all’utilizzo di tali dispositivi era infatti circoscritto a quei reparti in cui gli operatori, per la specifica tipologia delle attività, risultavano maggiormente esposti ad agenti o sostanze pericolose: oncologia e anatomia patologica rispettivamente per l’esposizione a farmaci antiblastici e formaldeide, laboratori analisi per ciò che attiene alla manipolazione dei reagenti. Per meglio comprendere la portata delle azioni messe in campo dall’ufficio acquisti per garantire l’approvvigionamento di DPI durante la pandemia, è utile far riferimento al dato di partenza ossia alla situazione contrattuale esistente al marzo 2020 per la fornitura di facciali filtranti di protezione di tipo 1 e di tipo 2 più comunemente denominati mascherine ffp2 e ffp3, che hanno avuto, poi, più largo utilizzo nel corso della fase emergenziale: nella ASL di Teramo era in corso di esecuzione un accordo quadro con unico operatore economico di durata quadriennale, aggiudicato mediante RdO sul mercato elettronico di Consip, per un valore di € 11.300,00 ed una previsione di fornitura per un totale di n. 15.000 pezzi. Tale contesto iniziale va confrontato con quello che, di lì a breve, si sarebbe poi rivelato l’andamento delle forniture, in vigenza delle iniziative
di acquisto successivamente avviate e che saranno più dettagliatamente descritte nel prosieguo della presente trattazione: basti pensare che, dall’inizio della pandemia e fino a novembre 2022, quindi in soli 25 mesi, risultano effettuati ordinativi di ffp2 ed ffp3, per un totale di n. 1.456.043 pezzi e per un valore di € 538.736,00 con una media di utilizzo pari a n. 58.241 mascherine/mese.
L’elevato livello di dettaglio delle caratteristiche tecniche minime dei dpi declinate nella documentazione di gara, ha garantito la fornitura di prodotti qualitativamente validi senza determinare restrizioni della concorrenza
La prima fase
Nella primissima fase dell’emergenza, che può essere collocata nel periodo marzo – maggio 2020, la necessità di garantire la fornitura dei DPI agli operatori sanitari, ha rappresentato la priorità assoluta nelle attività dell’ufficio acquisti. Al fine di convogliare tutte le risorse materiali disponibili verso il reparto Covid creato presso il Presidio Ospedaliero di Teramo, fu effettuata, tra le altre, una ricognizione delle giacenze di DPI ed in particolare di mascherine ffp2 e ffp3 disponibili presso le farmacie dei quattro presidii ospedalieri dell’Azienda: le evidenze delle scorte registrate, alla luce dei dati sull’andamento dei contagi di quei giorni, lasciarono da subito presagire di quale entità sarebbe stato lo sforzo che la macchina amministrativa e tecnica avrebbe dovuto mettere in piedi in pochissimo tempo per garantire agli operatori sanitari impegnati sul campo, le “armi” per difendersi e contrastare il virus. In tale frangente, dunque, si procedeva in modo estemporaneo, spesso sacrificando il principio di rotazione a beneficio del superiore interesse della salute pubblica, con affidamenti diretti ad operatori economici già fornitori della asl e magari locali, in un’ottica di favorire la tempe-
4
i DPI nella
pandemia
Vittorio
- Direttore U.O.C. Acquisizione beni e servizi - Azienda U.S.L. Teramo
2. La prima gara
stività delle consegne. A tal fine, l’innalzamento della soglia per affidamenti diretti € 139.000,00, introdotto dall’art. 1 comma 1 del DL n. 76/2000 in vigore già da luglio 2020, ha rappresentato un validissimo strumento in termini di semplificazione ed accelerazione delle procedure nell’ottica di dare impulso all’attività amministrativa. Tale modus operandi , tuttavia, come era facilmente prevedibile, non si rivelò risolutivo per soddisfare quelle che erano le effettive necessità in termini di volumi di acquisto. Alla già cronica carenza di materiali ed alle connesse difficoltà di garantire gli approvvigionamenti, si aggiunsero rilevanti criticità nello specifico mercato di riferimento che ha subito, in quella fase particolare, profondi cambiamenti non solo per effetto dell’ingresso di nuovi operatori economici improvvisamente riconvertiti alla commercializzazione di DPI e non propriamente affidabili in termini di garanzie di fornitura, ma anche per l’introduzione da parte di questi ultimi, di una prassi quantomeno singolare per la pubblica amministrazione quale la richiesta di anticipazione dell’intero prezzo della fornitura al momento della effettuazione dell’ordine, probabilmente dettata dalla necessità per gli operatori economici nazionali, di sottostare a regole di mercato di fornitori extra UE.
Dopo i primi tre mesi dall’inizio dell’emergenza, caratterizzati, come si è visto, da criticità nella gestione degli approvvigionamenti e nella programmazione delle iniziative di acquisto, i tempi si sono rivelati maturi per la pianificazione di procedure da espletarsi secondo i canali ordinari. Nell’agosto del 2020 è stata indetta una gara a procedura aperta per una base d’asta di € 4.524.390,00 determinata sulla scorta dei prezzi medi di acquisto registrati nella prima fase della pandemia, per una durata di due anni, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo ed articolata in n. 21 lotti. La formula contrattuale prevista era ovviamente quella dell’accordo quadro con unico operatore economico per singolo lotto di gara, proprio in ragione della impossibilità di prevedere con quello che sarebbe stato l’andamento della pandemia e, quindi, dei reali volumi di acquisto nel corso della durata dei contratti La risposta del mercato è stata soddisfacente avendo partecipato alla gara n. 47 operatori economici (alcuni anche con sede in Stati esteri in ambito UE) con una media di n. 6 offerte pervenute per lotto e, dei n. 21 lotti previsti, per n. 14 di questi si è pervenuto ad aggiudicazione. Le forniture, grazie alla previsione di clausola di esecuzione anticipata dei contratti, hanno avuto decorrenza dal novembre 2020, nelle more della stipula dei rispettivi accordi quadro.
Scheda di sintesi gara n. 1
i DPI nella pandemia
te per lotto e, dei n. 21 lotti previsti, per n. 14 di questi si è pervenuto ad aggiudicazione. Le forniture, grazie alla previsione di clausola di esecuzione anticipata dei contratti, hanno avuto decorrenza dal novembre 2020, nelle more della stipula dei rispettivi accordi quadro. Punti di forza e criticità
PRIMA GARA – ANNO 2020
BASE D’ASTA: € 4.524.390,00
DURATA CONTRATTUALE: 2 anni OPZIONI: proroga semestrale e quinto d’obbligo NUMERO LOTTI: 21 INVERSIONE PROCEDIMENTALE: si
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: accordo quadro con unico operatore economico
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo
DATA DI INDIZIONE: 10.8.2020
DATA AGGIUDICAZIONE: 25.11.2020
DURATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: 3 mesi e 15 giorni OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI: 47
PARTECIPAZIONE MEDIA PER LOTTO: n. 6 operatori con maggiore partecipazione per i lotti 4 e 5 riferiti a mascherine ffp2 e ffp3 (rispettivamente 26 e 20 operatori)
LOTTI AGGIUDICATI: 14/21
LOTTI NON AGGIUDICATI (offerte non conformi): 5/21
LOTTI DESERTI: 2/21
DATA DI STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO: 12.1.2021
Scheda di sintesi gara n. 1
2.1 Punti di forza e criticità
L’inversione procedimentale prevista nella lex specialis, oltre alla sua tipica finalità di accelerazione della gara, ha consentito alla stazione appaltante di utilizzare con immediatezza i prezzi emersi dall’apertura delle buste economiche, quale riferimento di congruità per la effettuazione di affidamenti diretti, nelle more dell’espletamento della procedura e dell’attivazione degli accordi quadro Inoltre, pur in presenza del criterio di aggiudicazione al minor prezzo, l’elevato livello di dettaglio delle caratteristiche tecniche minime dei dpi declinate nella documentazione di gara, ha garantito la fornitura di prodotti qualitativamente validi senza determinare restrizioni della concorrenza Per ciò che attiene all’aspetto più prettamente economico, la stipula dei contratti ha consentito di realizzare forti risparmi rispetto a quelle che erano le condizioni praticate ante aggiudicazione: il ribasso medio riscontrato è risultato infatti
La prima gara Dopo i primi tre mesi dall’inizio dell’emergenza, caratterizzati, come si è visto, da criticità nella gestione degli approvvigionamenti e nella programmazione delle iniziative di acquisto, i tempi si sono rivelati maturi per la pianificazione di procedure da espletarsi secondo i canali ordinari. Nell’agosto del 2020 è stata indetta una gara a procedura aperta per una base d’asta di € 4.524.390,00 determinata sulla scorta dei prezzi medi di acquisto registrati nella prima fase della pandemia, per una durata di due anni, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo ed articolata in n. 21 lotti. La formula contrattuale prevista era ovviamente quella dell’accordo quadro con unico operatore economico per singolo lotto di gara, proprio in ragione della impossibilità di prevedere quello che sarebbe stato l’andamento della pandemia e, quindi, dei reali volumi di acquisto nel corso della durata dei contratti. La risposta del mercato è stata soddisfacente avendo partecipato alla gara n. 47 operatori economici (alcuni anche con sede in Stati esteri in ambito UE) con una media di n. 6 offerte pervenu-
L’inversione procedimentale prevista nella lex specialis, oltre alla sua tipica finalità di accelerazione della gara, ha consentito alla stazione appaltante di utilizzare con immediatezza i prezzi emersi dall’apertura delle buste economiche, quale riferimento di congruità per la effettuazione di affidamenti diretti, nelle more dell’espletamento della procedura e dell’attivazione degli accordi quadro. Inoltre, pur in presenza del criterio di aggiudicazione al minor prezzo, l’elevato livello di dettaglio delle caratteristiche tecniche minime dei DPI declinate nella documentazione di gara, ha garantito la fornitura di prodotti qualitativamente validi senza determinare restrizioni della concorrenza. Per ciò che attiene all’aspetto più prettamente economico, la stipula dei contratti ha consentito di realizzare forti risparmi rispetto a quelle che erano le condizioni praticate ante aggiudicazione: il ribasso medio riscontrato è risultato infatti pari al 70%. Altresì, in sede di negoziazione delle condizioni contrattuali, al fine di valutare l’opportunità di avvalersi della opzione di proroga semestrale ex art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, sono state riconosciute, per la quasi totalità dei lotti, significative migliorie sui prezzi di aggiudicazione proprio in considerazione della estrema variabilità delle condizioni di mercato dovuta al progressivo e rapido aumento dell’offerta. Il giusto dimensionamento dei fabbisogni di gara ha rappresentato, in sede di progettazione della procedura, uno dei profili più critici: dopo soli pochi mesi dall’inizio della pandemia, riscontrato anche l’andamento oscil-
5
2
nella pandemia
La seconda gara
Scheda di sintesi gara n. 2
lante della curva dei contagi già dall’estate del 2020, non era semplice prevedere, anche se in termini i più pessimistici possibili, quelli che sarebbero stati nel biennio a seguire, i reali fabbisogni pur in presenza di uno strumento contrattuale molto flessibile come l’accordo quadro. Infatti, già nelle fasi iniziali dall’attivazione delle forniture, sulla scorta dei volumi e della frequenza degli ordinativi da parte delle farmacie ospedaliere, si è avuta subito evidenza della iniziale sottostima dei fabbisogni. I fattori che hanno maggiormente determinato il rapido esaurimento dei quantitativi dei lotti principali (mascherine, tute per rischio biologico, occhiali di protezione ecc.) con conseguenti criticità in termini di stock out sono risultati: 1) la seconda ondata di contagi registrata dal novembre 2020 in corso di svolgimento della gara e quindi non prevedibile, nella sua portata, al momento della progettazione; 2) le decisioni dell’unità di crisi aziendale che ha previsto la dotazione di dispositivi di protezione ffp2 per tutti i lavoratori e disposto la tenuta di scorte trimestrali per scongiurare potenziali situazioni di carenza, a fronte dell’esplosione dei numeri della pandemia. Ulteriori criticità nella gestione delle forniture sono state registrate anche per effetto della difficoltà ricorrente da parte degli operatori economici contrattualizzati negli accordi quadro, ad evadere l’ordine per intero e nei tempi richiesti, proprio in ragione dei rilevanti volumi oggetto dei contratti attuativi. La strada per l’immediata attivazione di una nuova procedura di gara di più ampio respiro era dunque obbligata.
BASE D’ASTA: € 9.622.272,00
mercato di riferimento caratterizzato, come si visto, da estrema variabilità. La gara, sempre con aggiudicazione al minor prezzo, prevedeva una base d’asta di € 9.622.272,00 (quindi raddoppiata rispetto alla prima, a fronte del dimezzamento della durata) determinata sulla scorta dei prezzi di aggiudicazione della prima procedura, ed era articolata in n. 20 lotti, inclusi quelli in precedenza non aggiudicati. Per ciò che attiene alla formula contrattuale prescelta, si è passati dall’accordo quadro con unico operatore economico all’accordo quadro con più operatori economici per singolo lotto di gara, stante, come si è visto, l’alea insita in questa particolare tipologia di fornitura; i criteri ed i meccanismi di stipula dei contratti attuativi saranno illustrati nel paragrafo seguente. Nell’ambito di questa procedura si è avuto modo di registrare una ulteriore apertura del mercato a testimonianza del progressivo ampliamento dell’offerta: hanno partecipato n. 70 operatori economici, con una media di n. 13 offerte pervenute per lotto e, dei n. 20 lotti previsti, per n. 17 di questi si è pervenuto ad aggiudicazione. Le forniture, grazie alla previsione di clausola di esecuzione anticipata dei contratti, hanno avuto decorrenza dal giugno 2021, nelle more della stipula dei rispettivi accordi quadro.
SECONDA GARA - ANNO 2021
DURATA CONTRATTUALE: 1 anno
OPZIONI: rinnovo annuale e quinto d’obbligo NUMERO LOTTI: 20
INVERSIONE PROCEDIMENTALE: si
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: accordo quadro con più operatori economici secondo un meccanismo a cascata sui primi 5 in graduatoria
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo DATA DI INDIZIONE: 7.1.2021
DATA AGGIUDICAZIONE: 16.6.2021
DURATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: 5 mesi OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI: 70
La nuova gara a procedura aperta, indetta a gennaio 2021 (quindi dopo poco più di un mese rispetto all’aggiudicazione della precedente), è stata ricalibrata, rispetto alla prima, con previsione di una durata contrattuale pari ad un solo anno ed opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Tale scelta, orientata dall’esperienza maturata in occasione della prima gara che, come si è visto, prevedeva una durata biennale, offre la possibilità alla stazione appaltante, di procedere, dopo un solo anno, alla rinegoziazione delle condizioni economiche in vista dell’attivazione dell’opzione di rinnovo. La previsione in argomento è particolarmente significativa proprio in considerazione delle particolari caratteristiche del
PARTECIPAZIONE MEDIA PER LOTTO: n. 6 operatori con maggiore partecipazione per i lotti 3, 7 e 15 riferiti a camici in TNT, tute tipo 5/6 e mascherine chirurgiche (rispettivamente 27, 32 e 34 operatori)
LOTTI AGGIUDICATI: 17/20
LOTTI NON AGGIUDICATI (offerte non conformi): 3/20
LOTTI DESERTI: 0/20
DATA DI STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO: 17.7.2021
Scheda di sintesi gara n. 2
3.1 La fase esecutiva degli accordi quadro
L’apertura degli accordi quadro a più operatori economici (massimo cinque) è stata dettata dalla necessità di far fronte al notevole aumento dei volumi di acquisto Come si è avuto modo di evidenziare, infatti, non tutti gli operatori erano in grado di evadere l’intero ordine nei tempi richiesti: con l’ampliamento della platea dei possibili fornitori, dunque, si garantiva la possibilità di ripartire tra questi ultimi gli ordinativi di valore più elevato con tempistiche certe, ferma restando la previsione, quali clausole dell’accordo quadro, di massimali per ordinativo (per lotto) e dell’obbligo di evasione di almeno il 50% dell’ordinativo stesso nel termine di 20 giorni dalla sua ricezione I contratti attuativi vengono stipulati sulla base della graduatoria di gara fino al quinto classificato, in ragione di un meccanismo “a cascata”, acquistando i dispositivi in base al seguente ordine di priorità:
La fase esecutiva degli accordi quadro L’apertura degli accordi quadro a più operatori economici è stata dettata dalla necessità di far fronte al notevole aumento dei volumi di acquisto. Come si è avuto modo di evidenziare, infatti, non tutti gli operatori erano in grado di evadere l’intero ordine nei tempi richiesti: con l’ampliamento della platea dei possibili fornitori, dunque, si garantiva la possibilità di ripartire tra questi ultimi gli ordinativi di valore più elevato con
• dall’operatore economico risultato primo in graduatoria (primo fornitore) e, in caso di indisponibilità da parte dello stesso a fornire la quantità totale dell’ordine, rivolgendosi al secondo classificato in graduatoria per la parte rimasta inevasa e così via, fino al quinto classificato e fino a concorrenza dell’interno ordinativo;
• entro due giorni dall’interpello, il fornitore deve comunicare la propria disponibilità ad evadere l’ordine ed in quale misura specificando il cronoprogramma della fornitura
6 i DPI
tempistiche certe, ferma restando la previsione, quali clausole dell’accordo quadro, di massimali per ordinativo (per lotto) e dell’obbligo di evasione di almeno il 50% dell’ordinativo stesso nel termine di 20 giorni dalla sua ricezione. I contratti attuativi vengono stipulati sulla base della graduatoria di gara fino al quinto classificato, in ragione di un meccanismo “a cascata”, acquistando i dispositivi in base al seguente ordine di priorità:
Esempio di meccanismo a cascata sui primi 5 in graduatoria
quantitativo richiesto
almeno il 50% per il 1° fornitore cronoprogramma a 20 gg.
graduatoria pezzi risposta su disponibilità quantità disponibile quantità dispon a 10 gg.
quantità dispon a 20 gg.
rimanenza
1° fornitore 50 entro 2 gg. 25 15 10 25
2° fornitore 25 entro 2 gg. 15 15 10 3° fornitore 10 entro 2 gg. 5 5 5 4° fornitore 5 entro 2 gg. 5 5 0 5° fornitore
Totale Entro 8 gg. 50
Esempio di meccanismo a cascata sui primi 5 in graduatoria
4. Conclusioni
• dall’operatore economico risultato primo in graduatoria (primo fornitore) e, in caso di indisponibilità da parte dello stesso a fornire la quantità totale dell’ordine, rivolgendosi al secondo classificato in graduatoria per la parte rimasta inevasa e così via, fino al quinto classificato e fino a concorrenza dell’interno ordinativo;
Conclusioni
In disparte tutte le questioni procedurali, le implicazioni dei meccanismi di operatività degli ordini e delle forniture e tutto ciò che attiene alla fase esecutiva degli accordi quadro, un dato, più di ogni altro, risalta agli occhi di chi è chiamato, nell’ambito della macchina amministrativa di una azienda sanitaria, a garantire forniture di standard qualitativi elevati a condizioni economiche che risultino rispettose dei vincoli di bilancio sempre più stringenti.
• entro due giorni dall’interpello, il fornitore deve comunicare la propria disponibilità ad evadere l’ordine ed in quale misura specificando il cronoprogramma della fornitura.
Il risultato più tangibile, conseguito con la riedizione delle due procedure di gara in un ristretto arco temporale , è stato rappresentato dalla realizzazione di significative contrazioni della spesa sia per effetto dell’attivazione degli strumenti di negoziazione previsti all’interno dei contratti, ma, soprattutto, quale naturale conseguenza, in termini microeconomici, di stimolo di un mercato tanto dinamico quanto vulnerabile.
Tale impostazione, se da un lato richiede sicuramente una attività di programmazione da parte dei punti ordinanti delle farmacie ospedaliere, dall’altro consente, entro un termine massimo di 10 giorni in caso di interpello di tutti e cinque i fornitori della graduatoria, di avere una pianificazione chiara e completa delle consegne.
In disparte tutte le questioni procedurali, le implicazioni dei meccanismi di operatività degli ordini e delle forniture e tutto ciò che attiene alla fase esecutiva degli accordi quadro, un dato, più di ogni altro, risalta agli occhi di chi è chiamato, nell’ambito della macchina amministrativa di una azienda sanitaria, a garantire forniture di standard qualitativi elevati a condizioni economiche che risultino rispettose dei vincoli di bilancio sempre più stringenti.
Il risultato più tangibile, conseguito con la riedizione delle due procedure di gara in un ristretto arco temporale, è stato rappresentato dalla realizzazione di significative contrazioni della spesa sia per effetto dell’attivazione degli strumenti di negoziazione previsti all’interno dei contratti, ma, soprattutto, quale naturale conseguenza, in termini microeconomici, di stimolo di un mercato tanto dinamico quanto vulnerabile. Scheda
5
Occhiali
Tute per rischio biologico tipo 3/4
Camice in TNT non sterile
Mantellina a scafandro dpi
Mascherina di protezione delle vie respiratorie FFP2
€ 13,50 € 12.49
€ 5,40 € 2,35
€ 6.30 € 5,00
€ 2,70 € 0,37 € 0,19
Mascherina di protezione delle vie respiratorie FFP3 € 3,60 € 0.77 € 0.48
Scheda di sintesi andamento prezzi da gara 1 a gara 2
€ 3,84 € 2,75
€ 1,47 1,20
€ 0.80 0,69
7 i DPI nella pandemia
di
sintesi andamento prezzi da gara 1 a gara 2 DPI Prezzo unitario base d’asta Prezzo aggiudicazione 1° gara Prezzo dopo negoziazione 1° gara Prezzo aggiudicazione 2° gara Prezzo dopo negoziazione 2° gara
€
€
€
€
di protezione a mascherina
7,20 € 2.85
1.49 € 1,10 Mascherina Chirurgica
0.36 € 0.08
0.03 € 0.02
tessuto non tessuto e tessuto tecnico
La vestizione degli operatori sanitari al tempo del COVID-19
Il mercato dei dispositivi medici, negli ultimi anni, si è configurato particolarmente dinamico, a causa della sostituzione del cotone, imposta dalle normative comunitarie, della diffusione dei dispositivi tessili per sala operatoria (DTSO) monouso e del ricorso all’outsourcing da parte delle strutture ospedaliere. I DTSO hanno la funzione di “proteggere e prevenire il trasferimento microbico durante gli interventi chirurgici e altre procedure invasive, riducendo la diffusione di agenti infettivi, pertanto i prodotti è necessario che siano rispondenti a stringenti standard qualitativi ed elevati grado di criticità”. Due sono i segmenti che ad oggi compongono il mercato: DTSO monouso Tessuto Non Tessuto (TNT) e DTSO riutilizzabili Tessuti Tecnici Riutilizzabili (TTR). Nel mese di gennaio 2022 è stata svolta una ricerca per analizzare la domanda e l’offerta in relazione al mercato e alle categorie merceologiche “Tessuto Non Tessuto” e “Tessuto Tecnico Riutilizzabile”, con focus specifico sulla vestizione degli operatori sanitari. Il periodo di riferimento è quello intercorso tra il mese di Marzo 2020 e il mese di Maggio 2020, cosiddetto “periodo Covid”. Dal lato della domanda si è indagata l’acquisizione di informazioni circa la gestione delle vestizioni in Tessuto non Tessuto e in Tessuto Tecnico Riutilizzabile del personale sanitario durante il “periodo Covid”, nonché l’eventuale adozione di sistemi di stockpiling e utilizzo dei Criteri ambientali minimi (CAM) da parte delle Aziende Sanitarie. Dal lato dell’offerta, invece, si
Solo poche Stazioni Appaltanti sono passate dall’utilizzo del materiale Tessuto non tessuto, al Tessuto tecnico riutilizzabile, infatti, nella maggior parte delle Aziende sanitarie, gli operatori sanitari indossano camici in TNT e solo in poche strutture sono indossati camici in materiale TTR
è indagata l’attestazione delle informazioni di cui sopra, le eventuali potenzialità intercettate dal mercato e la potenziale adozione di sistemi di stockpiling da parte delle Aziende Sanitarie. Dette informazioni hanno consentito al gruppo di lavoro di valutare se le potenzialità del mercato fossero già conosciute ed applicate, in che percentuale e in quali ambiti siano individuabili margini di crescita. Tutto ciò ai fini dell’ottimizzazione delle forniture in oggetto, non solo in relazione ai periodi critici, ma per una modalità di gestione basata su buone pratiche che possa diventare la normalità. L’obiettivo di svolgere l’indagine su larga scala, con il tentativo di ottenere risultati rappresentativi di un’intera popolazione, ha portato all’utilizzo del criterio di campionamento non probabilistico a supporto della ricerca. Il campione selezionato per l’indagine è risultato essere composto dalle due categorie presenti sul mercato ed in particolare è stato preso in considerazione: il “campionamento per quote lato domanda” attraverso l’individuazione delle Aziende Sanitarie del settore pubblico indirizzando la survey ai Provveditori, gli Economi e ai Farmacisti, agli Operatori Sanitari (caposala - infermieri) dentro e fuori il reparto/sala operatoria di tutte le Regioni d’Italia. La survey, composta da un questionario multiple choice, è stata somministrata ad un totale di 400 indirizzi mail, nonché a tutti gli iscritti all’associazione FARE attraverso modulo Google. Il “campionamento per convenienza lato offerta” interrogando gli Operatori economici del settore: Servizi
8
Katiuscia Carota - ASST Ospedale Niguarda di Milano - Francesco De Feudis - Servizi Ospedalieri S.p.A. - Ivana Reverdito - SCR Piemonte S.p.A. Francesca Belletti - USL di Parma - Marta Rossini - ASST Santi Paolo e Carlo - Gian Luca Viganò - ASST Spedali Civili di Brescia
Ospedalieri, Medical Device, U.Jet e l’Associazione di categoria ASSOSISTEMA. Il questionario, composto da domande aperte, è stato svolto con il metodo di indagine postale ed è stato integrato con interviste dirette per approfondire alcuni aspetti salienti.
Il questionario ha ottenuto 55 risposte, la cui distribuzione è così suddivisa: 64,45% NORD, 24,44% CENTRO e 11,11% SUD. Le risposte ottenute sono state pressoché concordi. Nelle domande iniziali della survey si è indagata la carenza dei camici sia sterili che non sterili e di entrambe le tipologie. È emerso che la scarsità dei camici sterili è stata avvertita in misura maggiore dagli enti rispetto a quella dei camici non sterili. Raramente, però, le stazioni appaltanti si sono trovati senza entrambe le tipologie di camici. Il questionario ha evidenziato che, in riferimento ai camici sterili, le Stazioni Appaltanti hanno dovuto cambiare le modalità di approvvigionamento del vestiario, trovandosi a gestire in maniera differente sia i contratti che le annesse problematiche riscontrate. Cambiamenti, questi, sentiti in modo meno sensibile per i camici non sterili.


Le Pubbliche Amministrazioni, per fronteggiare l’emergenza, hanno dovuto ricorrere a contratti stipulati da Centrali di Committenza regionali, Consip o Invitalia e altrettante volte si sono trovati a prorogare i contratti già in essere.
tessuto
non tessuto e tessuto
tecnico
Si è riscontrata una variazione importante anche per la gestione delle scorte di magazzino in riferimento sia ai camici sterili che ai camici non sterili per la maggior parte delle Stazioni Appaltanti coinvolte. Infatti solitamente la giacenza copriva un fabbisogno medio pari a tre mesi di attività, mentre nel periodo emergenziale dettato dal COVID-19, è stato ravvisato un mutamento nella gestione degli stock per entrambe le tipologie di camici con andamenti pressoché contrastanti.
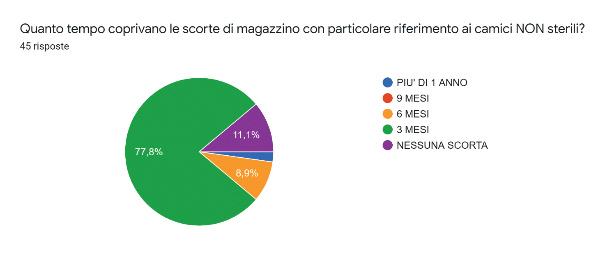
Da ciò si evince che gli enti hanno reagito in maniera differente all’emergenza sanitaria: alcuni hanno adottato la teoria di riempire i magazzini di scorte, altri hanno continuato ad approvvigionarsi con le modalità da sempre utilizzate, invece altri hanno optato per non dotarsi di scorte.
Dalle risposte si è evidenziato, infatti, che il concetto dello “stockpiling dinamico”, ovvero la gestione delle scorte di magazzino in base al reale consumo, è conosciuto da molte Pubbliche Amministrazioni ma, tra queste, non tutte lo adottano.
Rilevanti anche le informazioni pervenute circa la scarsa qualità del materiale e le alte percentuali di ritardi nelle consegne dei prodotti contrariamente ai punteggi positivi ottenuti in merito alla conformità dei prodotti e alle norme sulla sicurezza.
La survey ha evidenziato che, ad oggi, solo poche Stazioni Appaltanti sono passate dall’utilizzo del materiale Tessuto non tessuto, al Tessuto tecnico riutilizzabile, infatti, nella maggior parte delle Aziende sanitarie, gli operatori sanitari indossano camici in TNT e solo in poche strutture sono indossati camici in materiale TTR.
Si è osservato, infatti, che un’alta percentuale di Aziende Ospedaliere coinvolte non sono rimaste soddisfatte dall’utilizzo del materiale TTR, non ritengono economicamente conveniente il nuovo materiale proposto e non lo reputano sufficientemente efficace. Hanno, però, percepito positivamente la sostenibilità ambientale connessa all’utilizzo del materiale TTR rispetto all’uso del materiale TNT, pertanto, questa tipologia tessuto continuerà ad essere utilizzata in un’alta percentuale di enti. Dall’indagine è stato rilevato, inoltre, che un’elevata percentuale di stazioni appaltanti conosce e ritiene importante il Decreto del 30 Giugno 2021 relativo all’adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggi di prodotti tessili, ivi incluse le mascherine (CAM).

9
tessuto non tessuto e tessuto tecnico

Poche strutture, però, lo stanno applicando all’interno delle loro realtà.
Nell’ultima parte della ricerca è stata analizzata l’importanza della provenienza geografica del fornitore, ma le risposte ottenute hanno avuto una distribuzione non uniforme.
Dal lato dell’offerta, invece, è stato somministrato un questionario a tre Operatori Economici che si occupano della commercializzazione dei prodotti in questione: Servizi ospedalieri per la filiera del TTR; Medical device ed U.Jet per il mondo TNT.
Le risposte ottenute sono affini, seppur provenienti da ambiti differenti.
È emerso, infatti, che le due Aziende operanti nel business afferente al TNT si erano dotate di scorte di magazzino per fronteggiare l’emergenza sanitaria dettata dal COVID-19, durante la quale si sono registrate variazioni incrementali dei livelli di consumo rispetto ai fabbisogni programmati dei clienti storici e si sono presentate richieste di fornitura di nuovi potenziali clienti. La produzione, infatti, è stata riorganizzata per allineare quan-
to più possibile la domanda e l’offerta in un mercato caratterizzato da continuità di fabbisogni straordinari di clienti nuovi e di vecchia data.
Servizi Ospedalieri, in qualità di fornitore di camici in TTR, invece, ha dichiarato di possedere scorte di magazzino limitate atte a reintegrare solo il fuori uso.
Tutte le imprese coinvolte hanno dichiarato di aver adottato il modello dello “stockpiling dinamico”, al fine di evitare eventuali sprechi economici e accumulo disordinato di materiale, specificando se siano state pianificate consegne mensili ai clienti nei limiti di lotti minimi di acquisto, lead time e programmi di produzione imposti dai fornitori.
Le problematiche che hanno dovuto fronteggiare sono state inerenti alla logistica e all’approvvigionamento per far fronte ad ordini massivi ed improvvisi sia nel recupero della materia prima sia per il blocco dell’export e dell’import che per la produzione stessa dei dispositivi.
Per esigenze Covid hanno dichiarato di aver venduto una percentuale variabile tra l’80% e il 99% di camici non sterili, mentre percentuali molto inferiori di camici sterili. A seconda invece della linea produttiva si sono commercializzati solo camici con materiale TNT o sia TNT che TTR nella percentuale rispettiva 70% e 30%. Le richieste pervenute durante il periodo Covid si sono rivelate attinenti alla linea produttiva: infatti alle aziende che producono e commercializzano solo prodotti monouso sono stati richiesti solo prodotti in TNT, invece alle imprese specializzate sia nel TNT che nel TTR le richieste sono state bipartite e soprattutto legate alla disponibilità attuale.


Le difficoltà di reperibilità legate ai camici sterili sono state causate dalla non disponibilità in magazzino che ha comportato l’inizio della produzione in Italia, invece per il TTR sono state proposte varie soluzioni di prodotti con tessuti diversi in relazione alla criticità della destinazione d’uso.
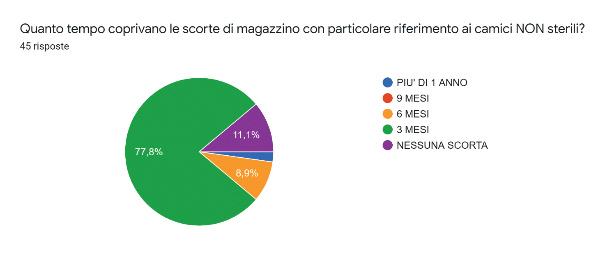

10
Tutti, però, hanno convenuto che non siano state riscontrate difficoltà nella proposta di alternative ai clienti, come l’ostilità al passaggio da un prodotto all’altro. Si è evidenziato che i pregiudizi maggiormente diffusi legati all’utilizzo del TNT sono legati all’impatto ambientale, al comfort ed alle prestazioni meccaniche, mentre per il TTR sono la garanzia di stabilità delle prestazioni conseguenti alla complessità del processo di ricondizionamento e le elevate quotazioni economiche. Il TNT, infatti, garantisce un efficace effetto barriera, risponde ad una facilità di utilizzo, soddisfa i criteri di efficacia, sicurezza, leggerezza e comodità per chi li indossa, ma ha come principale difetto quello di generare un discreto quantitativo di rifiuti speciali non riciclabili, invece il TTR, grazie alla presenza di una membrana protettiva che funge da barriera al passaggio dei liquidi, garantisce le medesime performance di sicurezza anche dopo svariati cicli di ricondizionamento, una buona protezione dai liquidi, una barriera antivirale e antibatterica estremamente efficace e un impatto ambientale ridotto. Le enormi differenze nelle strutture dei costi delle due tipologie di prodotti sono il risultato della diversa natura di essi, ma anche della differente configurazione delle loro filiere produttive. Infatti, mentre per ciò che riguarda il TNT, la maggior parte dei costi si ha nella fase di manifattura, il TTR trova nella fase dei servizi forniti agli acquirenti la componente di costo più importante. È stato riscontrato, inoltre, che, mentre le imprese legate al mercato del materiale TNT hanno acquisito nuovi clienti durante il periodo Covid, quelle legate al TTR hanno mantenuto gli stessi, seppur proponendo un diverso mix di prodotti. È stato comunicato che si sono ottenuti feedback positivi nel passaggio da TNT al TTR, dimostrabili dal fatto che il trend del TTR si sia attestato come duraturo in quanto, passato il picco, le Aziende Sanitarie che si erano convertite al TTR, non siano tornate ad utilizzare il TNT. L’utilizzo del TTR in alcune strutture negli ultimi dieci anni, con il fine dell’efficientamento continuo, ha prodotto i seguenti vantaggi nel profilo ambientale a confronto con qualsiasi prodotto alternativo: riduzione del consumo di gas, del consumo di energia elettrica, del consumo di acqua, del riscaldamento globale (gas effetto serra), dello strato di impoverimento di ozono, dell’ossidazione fotochimica (smog), dell’acidificazione del terreno e dell’eutrofizzazione delle acque. I vantaggi caratteristici di una migrazione dal TNT al TTR sono la visibilità da parte del cliente del processo di ricondizionamento e di sterilizzazione, la minor produzione di rifiuto speciale, il minor impatto ambientale, il comfort e il luogo di produzione e l’impegno etico inteso come valore in un processo produttivo che prospetta nuove
tessuto non tessuto e tessuto tecnico

leve competitive coerenti con uno sviluppo sostenibile per la collettività. Solo per i camici realizzati con materiali TTR è stato sottolineato che è impossibile la delocalizzazione della produzione, del ricondizionamento e della sterilizzazione. Nella terza fase della ricerca si è proseguito intervistando il Segretario Generale di Assosistema nella persona del dott. Matteo Nevi al quale sono state poste due domande.
Nella prima domanda somministrata è stata richiesta una breve panoramica su come, nel periodo compreso tra i mesi di marzo-maggio 2020, l’associazione di categoria ha percepito il cambiamento del mercato pubblico e privato, in riferimento alle dinamiche di approvvigionamento dei camici e, più in generale, alla vestizione degli operatori sanitari ipotizzando come possa evolversi il mercato dei camici nel futuro. Il segretario ha risposto comunicando che il Covid, dal suo punto di vista, ha stravolto totalmente l’intero sistema sanitario inteso anche come l’insieme dei servizi coinvolti. Il servizio maggiormente interessato è stato quello delle lavanderie industriali, infatti, tutti gli asset che compongono questo settore sono diventati centrali nella lotta al Covid e, in particolare, la vestizione dell’operatore e la gestione dei posti letto sia ordinari che in terapia intensiva. Il Covid, però, può essere visto anche come un’opportunità per stravolgere la gestione degli acquisti e dei servizi connessi, implicando la richiesta di un servizio costruito all’interno di un modello di “gestione continua delle scorte”. Il camice, infatti, rappresenta un elemento chiave sul quale può essere misurato e applicato sin da subito il nuovo modello di acquisto che permetterebbe una gestione più attenta dei magazzini e un miglioramento della qualità del servizio e della fornitura, poiché basato su prodotti riutilizzabili confezionati in Italia. L’utilizzo di materiale riutilizzabile, infatti, offre notevoli vantaggi in quanto, resistendo a più cicli di lavaggio, permane per un tempo più duraturo all’interno del ciclo produttivo garantendo, pertanto, un bene sempre “fresco” e
11
tessuto non tessuto e tessuto tecnico
disponibile.
Si deduce, quindi, che, se nell’anno 2020 avessimo utilizzato questa logica di approvvigionamento, avremmo goduto di due vantaggi: il non raggiungimento di 30.000 tonnellate di monouso da smaltire e una risposta concreta alle nuove necessità del mercato attraverso la filiera italiana e le lavanderie industriali. Durante la pandemia, di fatto, non si è riuscito ad efficientare il processo di acquisizione sia da un punto di vista di pianificazione strategica di approvvigionamenti e scorte, sia da un punto di vista di sostenibilità ambientale, aspetto disatteso in più occasioni, nonostante gli interventi normativi e gli indirizzi richiesti anche dalla Comunità Europea sulla riduzione dei rifiuti.
Si rileva, pertanto, che in un sistema di approvvigionamento dinamico basato sulla nuova suddetta logica di acquisto, le lavanderie industriali rivestano un ruolo strategico, in quanto permettono alla Struttura Ospedaliera una gestione dinamica del magazzino attraverso l’impiego di camici in materiale TTR, piuttosto che in materiale monouso. Si può ipotizzare che in futuro il mercato di acquisto di camici si evolverà verso politiche di acquisto di forniture e servizi annessi basati sui concetti di riutilizzabilità e durabilità e verso un approccio manageriale della gestione dei “magazzini”, ovvero una dinamica di stockpiling, che in Italia è possibile implementare, in particolar modo per i camici, grazie alla presenza di un’intera filiera locale di grande prestigio. Nella seconda domanda posta è stato chiesto se l’introduzione di un nuovo modello di acquisto nelle Pubbliche Amministrazioni potrebbe avere anche dei riflessi ambientali. Il Segretario ha fornito una risposta affermativa spiegando che ci si auspica che sia proprio la Pubblica Amministrazione in collaborazione con le imprese a spingere la transizione verso il green. Proprio in virtù di questo auspicio, nel corso dell’anno 2021 è intervenuto il legislatore prevedendo una norma che si dia precedenza agli acquisti di prodotti in tessuto tecnico riutilizzabile sia essi DM o DPI nella logica di mettere in primo piano sia la salute di chi utilizza il prodotto sia la tutela del sistema ambientale. In linea con il legislatore, anche il Ministero della Transizione Ecologica congiuntamente con il Ministero della Salute è intervenuto aggiornando il Decreto CAM su prodotti tessili, DPI, DM, camici per uso ospedaliero in data 30 giugno 2021. I Ministeri hanno provveduto, difatti, ad inserire un riferimento ai camici, che consta nell’imposizione alle Stazioni Appaltanti dell’utilizzo in via prioritaria di camici in Tessuto Tecnico Riutilizzabile, fatti salvi ai casi in cui i camici siano destinati a specifiche tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all’uso di Tessuto Tecnico Riutilizzabile sanificato.
I Ministeri hanno, quindi, esplicitato in maniera chiara la normativa del legislatore, evidenziando come la discrezionalità della scelta del camice monouso sia residuale e soprattutto necessiti di un giustificativo esplicito legato alle “controindicazioni nell’utilizzo di Tessuto Tecnico Riutilizzabile per alcuni interventi”. La norma dichiara che “le strutture sanitarie e socio sanitarie, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, devono prevedere l’uso e di conseguenza la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale marcati CE in tessuto tecnico riutilizzabile da sottoporre a successiva sanificazione e sterilizzazione, fatta salva la possibilità di adottare una fornitura dedicata alle particolari tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all’uso di tessuti tecnici riutilizzabili sanificati”. Il tema della sostenibilità ambientale e del riutilizzabile è avvalorato dall’esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto. Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è incentrato sulla transizione green, quindi si può dedurre che questo rappresenti il primo tassello dal quale una Pubblica Amministrazione possa da subito centrare un obiettivo strategico per il Paese. Guardando al futuro, ci sono chiari vantaggi nel passare da un modello di “fornitore di beni” a un modello di “gestione continua delle scorte” come servizio chiave. Bisogna imparare ad orientarsi, ad innovare e adeguare costantemente i modelli di approvvigionamento, introducendo concetti nuovi come i modelli cosiddetti “ibridi”, in cui poter trarre il meglio da ogni prodotto/ manufatto sulla base della convenienza e della disponibilità sul mercato, sulla velocità di fornitura, mantenendo sempre la bussola sulla migliore soluzione in un dato momento. Il desiderio sarebbe di operare in un’ottica di Value Based Procurement, valutando un determinato acquisto in modo globale, considerando l’intero ciclo di vita del bene. Questo permetterebbe alle Pubbliche Amministrazioni di paragonare e valutare le forniture sì in base a costi e qualità, ma anche prendendo in esame le conseguenze cliniche, sociali ed economiche. È auspicabile che le strutture applichino nelle loro realtà i CAM ipotizzando che il mercato di acquisto dei camici si evolva verso politiche di acquisto di forniture e servizi annessi basati sui concetti di riutilizzabilità e durabilità e verso un approccio manageriale della gestione dei “magazzini”. La preparazione alle emergenze dovrebbe essere un imperativo per la programmazione sanitaria di ciascun Paese ed il sistema di pianificazione delle scorte, parimenti, dovrebbe rappresentare un punto fondamentale ed imprescindibile per rafforzare le strategie di preparazione e pianificazione del Sistema Sanitario Nazionale, pertanto, dovrebbe essere dinamica e periodica.
12
Revisione prezzi: normativa, problematiche e ipotesi risolutive
Il 19 ottobre 2022 si è svolto a Roma, presso il Campus Talent Garden, il Convegno dal titolo “Revisione Prezzi: Normativa, Problematiche e Ipotesi Risolutive” della neo-ricostituita Associazione Economi e Provveditori del Lazio (A.E.L). Ma facciamo un passo indietro, nella primavera del 2021 è stata ricostituita l’Associazione Economi e Provveditori del Lazio (A.E.L.) la quale, dopo anni di assenza nel panorama delle Associazioni di settore, ha ripreso la sua attività sotto la guida del nuovo Presidente, la Dott.ssa Monica Caira. Tra gli obiettivi del nuovo Presidente e non solo, vi è stata sin da subito l’esigenza di costituire una rete di idee e confronto capace di trovare soluzioni condivise a problematiche comuni tra le quali l’attuale e complessa questione della revisione dei prezzi nel panorama degli acquisti di servizi e forniture in sanità, posta al centro della discussione del Convegno del 19 ottobre scorso. L’evento, svoltosi con il contributo incondizionato di CsaMed, ha visto la partecipazione di relatori di eccellenza quali l’Ing. Mauro Cappello –Docente universitario ed esperto di fondi europei, l’Avv. Lucio Lacerenza- PNRR Avvocati Network Advisory, il Dott. Angelo Furfaro – Responsabile Unità Operativa Complessa Beni e Servizi Policlinico Umberto I di Roma, il Dott. Guido Gastaldon – Responsabile Area Sanità, Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi Consip, il Dott. Massimo Riem – Presidente F.I.F.O., il Dott. Lorenzo Terranova – Direttore Affari Istituzionali di Confindustria
dispositivi medici e il Dott. Gianmaria Casella – AD CsaMed, i quali si sono confrontati con una numerosa platea di Assistenti, Funzionari, Dirigenti e Direttori dei Provveditorati della Regione. È stato il Dott. Angelo Furfaro, in rappresentanza dei Provveditori della Regione Lazio, a farsi portavoce delle problematiche che investono il ruolo del Provveditore nell’esercizio della sua funzione nell’attuale panorama socioeconomico, un panorama investito dalle riflesse e pesanti conseguenze economiche della pandemia da Covid-19 e del conflitto Russo-Ucraino. L’aumento del costo del gas, dell’energia, le gravi carenze di materie prime hanno colpito, invero, anche il mondo della Sanità dove gli Operatori Economici appaiono sempre meno in grado di mantenere i prezzi offerti in procedure di gara aggiudicate in loro favore prima dell’attuale crisi e stabiliti nei vari contratti. Dunque, l’interrogativo risulta chiaro: attesa la presente e ingente crisi che sta colpendo tutti i settori dell’economia nazionale e non solo, quali sono gli strumenti normativi di cui dispongono le Stazioni Appaltanti per far fronte alle sempre più frequenti richieste di revisione dei prezzi per gli appalti in corso di esecuzione? Non è stato semplice e non è semplice rispondere a questo interrogativo in quanto, seppur il problema risulta essere diffuso in tutti e settori, in campo normativo si è provveduto a disciplinare esclusivamente la questione con specifico riguardo agli appalti di lavori. Il D.L. 73/2021, convertito con L. 106/20211 all’art.
1 DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 -Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084) - Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021 - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176).
13 dalle associazioni
Eugenia Marrelli - UOC Provveditorato ed Economato - ASL Frosinone
La sospensione rientra tra le facoltà che il Codice riconosce alle Stazioni appaltanti ma è bene tener presente che la sanità con tutte le sue necessità difficilmente potrebbe ammettere sospensioni per le gravi conseguenze che si abbatterebbero sui pazienti e sulla generale economia di gestione ospedaliera
1-septies2 ha sancito un meccanismo di compensazione in favore delle imprese da porre in essere sulla base di decreti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) atti ad individuare le variazioni percentuali superiori all’8%, in aumento o in diminuzione, da applicare alle lavorazioni eseguite. A tal riguardo si è espressa anche l’ANAC (parere consultivo n. 37 del 6.9.20223): la stessa Autorità, richiamato il principio generale per cui «il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, ciascuno con una propria autonomia e peculiare funzione nell’economia della procedura (il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando il procedimento di gara ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando, di norma in relazione agli aspetti tecnici, anche in funzione dell’assumendo vincolo contrattuale),
(…) costituiscono nel complesso la lex specialis di gara ed hanno natura vincolante per concorrenti e stazione appaltante (…)»4, riporta l’attenzione sull’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 rubricato “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, invero, è facoltà delle Stazioni Appaltanti procedere con una modifica dei contratti di appalto nei settori ordinari e speciali, senza una nuova procedura di affidamento, nelle ipotesi tassative e con le modalità di cui al medesimo articolo. Con specifico riguardo al tema della revisione dei prezzi, è lo stesso comma 1, lett. a) dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 a subordinare la sua applicazione alla previsione nei documenti di gara in clausole «chiare, precise e inequivocabili» della stessa procedura di revisione.5 Proseguendo, però, con quanto disposto dall’art. 1-septies del D.L. 73/2021, con-
2 Art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse. Ai fini dell’accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
3 Caro materiali: applicabilità dei commi 1 e 2 dell’Art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 e in merito ai recenti decreti sulle compensazioni dei prezzi dei lavori e delle forniture - Richiesta parere. FUNZ CONS 37/2022.
4 Delibera Anac n. 159/2021 - prec 23/2021/S.
5 Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)
1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.
14
dalle associazioni
vertito con L. 106/2021, è la stessa ANAC a richiamare il parere MIMS n. 1196/2022 con il quale lo stesso Ministero ha chiarito che «l’art. 1-septies del d.l. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021, non ha reintrodotto l’istituto della “revisione dei prezzi”, la cui funzione era quella di mantenere l’equilibrio sinallagmatico attraverso l’adeguamento dei prezzi posti a base del contratto: la compensazione prevista dal comma 2 del suddetto articolo non costituisce riallineamento del prezzo contrattuale, bensì una sorta di indennizzo che il legislatore ha inteso riconoscere all’appaltatore nel caso intervengano le condizioni indicate dalla norma…»6. Se, dunque, per il settore dei lavori pubblici il legislatore è intervenuto per far fronte alla problematica di che trattasi, per i settori dei servizi e forniture le Stazioni appaltanti si trovano immerse in una lacuna normativa che non permette l’elaborazione di una risposta comune al problema. In questo vuoto normativo, considerato l’art. 30 comma 8 del D.lgs. 50/2016,7, si è pensato, pertanto, di richiamare in causa l’art. 1664 del Codice civile.- Onerosità o difficoltà dell’esecuzione- il quale accorda una revisione del prezzo in favore del committente o dell’appaltatore «qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto». Ma, a tal riguardo, si è espressa l’ANAC chiarendo, nel parere consultivo n. 20 del 6/9/2022, che la possibilità di «applicare l’art. 1664 c.c. ai fini della revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture, sembra non trovare riscontro nelle previsioni dell’art. 106 del Codice, il quale oltre a non contemplare tale ipotesi, sembra costituire altresì una norma speciale in tale materia, dettando una specifica disciplina in tema di variazioni dei contratti in corso di esecuzione». È, infatti, lo stesso art. 106 del Codice a fissare i casi che sono «da ritenere tassativi in quanto derogatori all’evidenza pubblica». Dunque, attesa la naturale “alea del contratto” e richiamati i principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1375 e 1175 del Codice civile, quali strade rimangono percorribili da parte dei Provveditori per far fronte alle ingenti richieste di revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture? Inoltre, è possibile procedere con l’eventuale sospensione dei contratti, così come previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016? Certamente la sospensione rientra tra le facoltà che il Codice riconosce alle Stazioni
appaltanti ma è bene tener presente il settore di riferimento e, nello specifico, appare condivisibile l’idea che la sanità con tutte le sue necessità difficilmente potrebbe ammettere sospensioni, non perché la sospensione non sia disciplinata a livello normativo, ma per le gravi conseguenze che si abbatterebbero sui pazienti e sulla generale economia di gestione ospedaliera cui si potrebbe giungere se si disponesse la sospensione di una fornitura di dispositivi medici o di un servizio ospedaliero. E allora, non si potrebbe, d’altro canto, procedere con una rinegoziazione dei termini contrattuali? Anche questa appare una via percorribile da parte delle Stazioni appaltanti ma è una soluzione che, indubbiamente, esporrebbe i Responsabili Unici del Procedimento (R.U.P.), chiamati ogni giorno a rispondere alle emergenze ed esigenze sanitarie con soluzioni concrete e immediate, ad un rischio connesso alla loro personale responsabilità per danno erariale. Questi, e non solo qusti, sono stati, dunque, gli interrogativi e le tappe di ragionamento che hanno acceso il dibattito tra i relatori e tutti i partecipanti al Convegno A.E.L. del 19 ottobre scorso, quando, per la prima volta dopo lungo tempo, si è cercato nuovamente di trovare una rotta comune interpretativa e operativa capace di condurre i Provveditorati della Regione fuori da quello che è stato definito “il porto delle nebbie” dove, ad oggi, risulta difficile, in mancanza di un preciso intervento del Legislatore, procedere ad un equo bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco. l’Associazione Economi e Provveditori del Lazio (A.E.L.) Di qui il fermo intento dell’Associazione Economi e Provveditori del Lazio (A.E.L.) di farsi portatrice, anche nelle sedi legislative, delle istanze che provengono dal mondo operativo concreto, non da ultimo attraverso anche idoneo contributo propositivo in occasione del redigendo nuovo Codice degli Appalti.
Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; (fino al 31 dicembre 2023, per i contratti relativi ai lavori si veda l’articolo 29 della legge 28 marzo 2022, n. 25) (…).

6 parere Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 1196/2022.
7 Art. 30, comma 8, D.Lgs. 50/2016: «Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.» (comma così modificato dall’art. 8, comma 5, lettera 0a), della legge n. 120 del 2020)
15 dalle associazioni
PNRR: parità di genere e contratti pubblici – La Prassi UNI/PdR 125:2022
Uno degli obiettivi strategici cui mira il PNRR è l’inclusione sociale che contempla, tra le priorità di maggior peso e con una valenza socio-economica particolare, la parità di genere. Nel 2020 le donne che hanno perso il lavoro sono state circa il doppio rispetto agli uomini e nel 2021 il rapporto tra il tasso di occupazione femminile e maschile ha registrato una differenza pari al 17% (uomini 67,1%; donne 49,4%), con una percentuale di donne occupate inferiore alla media europea (63,4%) registrata nel 2021. Altri aspetti di criticità si registrano rispetto a fenomeni ancora ben radicati, come il “gender pay gap”, vale a dire la differenza di genere nella retribuzione, nonché la c.d. “segregazione occupazionale” (orizzontale e verticale) per effetto della quale le donne accedono ad una tipologia di occupazioni più ristretta rispetto agli uomini e ai livelli di responsabilità più bassi. (S. Negri, F. Valente, Mercato del lavoro e squilibri di genere: un primo approfondimento , in Bollettino ADAPT n. 25/2022).
La circostanza che il mercato del lavoro e la partecipazione ai processi decisionali siano ancora caratterizzati da significative differenze di genere, trova ulteriore conferma in un’altra ricerca, pubblicata nel marzo 2022 da EY e SWG SPA (Parità di genere & Leadership al femminile. Un’analisi della situazione italiana), da cui è emerso, attraverso il campione degli intervistati (514 donne e 103 uomini), che solo per un dirigente su tre ( 2 su 5, tra gli uomini) la propria azienda ha un piano per la parità di genere: tale circostanza lascia piuttosto perplessi atteso che (sulla scorta dell’ambito di intervento Investimento 1.3: Sistema di certificazione della parità di genere, previsto dalla componente M5C1: Politiche per il lavoro – Missione 5: Inclusione e Coesione) la L.162 del 5/11/2021, introducendo l’Art. 46-bis al
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo (Dlgs.198/2006), ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la certificazione della parità di genere (al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità) e ha legato al possesso di tale certificazione l’esonero, per le aziende private, dal versamento dei contributi previdenziali in misura pari ad un massimo di €.50.000 annui. Ma non è tutto: alle aziende private, che alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento siano in possesso della certificazione della parità di genere, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti; inoltre, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere.
Da tale ultimo assunto, emerge chiaramente come il legislatore, in ossequio alla destinazione delle risorse del PNNR, abbia inteso prestare una particolare attenzione al perseguimento della parità di genere utilizzando anche un settore particolarmente strategico per il Paese, quale quello del procurement delle pubbliche amministrazio -
16
- Presidente ACEP
Raffaele Petrosino
PNRR
Nel 2020 le donne che hanno perso il lavoro sono state circa il doppio rispetto agli uomini e nel 2021 il rapporto tra il tasso di occupazione femminile e maschile ha registrato una differenza pari al 17%
ni: l’esempio immediato è costituito dal D.L. 77/2021, coordinato con la legge di conversione 29 luglio2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. L’art.47, co.4, del citato D.L. dispone, infatti, che “Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne….”. Il comma 4, poi, prosegue disponendo che costituisce requisito necessario dell’offerta l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.
Il comma 5 dispone, altresì, che ulteriori misure premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che si impegni, tra l’altro, ad assumere donne, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
Non è superfluo sottolineare che la norma prevede anche meccanismi sanzionatori: infatti, il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla stessa comporta l’applicazione di penali (commisurate alla gravità della violazione e propor-

zionali all’importo del contratto) mentre, soltanto in casi specifici e tassativi, l’aliquota del 30% può essere esclusa o può essere stabilita una quota inferiore.
Il comma 8 dell’art.47 ha previsto, infine, l’elaborazione di linee guida per la definizione delle modalità e dei criteri applicativi delle misure previste dall’art.47, con indicazione delle misure premiali e la predisposizione di modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto: dette linee guida sono state predisposte con D.M. 7 dicembre 2021, emanato a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità
In esecuzione di quanto previsto dall’art.4 della L.162/2021, nel mese di marzo 2022 è stata pubblicata, quindi, la Prassi di Riferimento (PdR) UNI 125:2022 sulla Parità di Genere, che identifica i requisiti per la certificazione di parità di genere richiamata dal PNRR e dal medesimo art.4.
Quanto alle prassi di riferimento, è bene precisare, preliminarmente, che trattasi di documenti UNI (Ente Nazionale di Unificazione, organismo italiano di normazione) che “introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, quando non ci sono norme né progetti di norma nazionali, europei o internazionali. Sono elaborate sulla base di un rapido processo di condivisione tra i soli autori, non più di 9 mesi, in appositi Tavoli e sotto la conduzione operativa di UNI: dopo due anni dalla pubblicazione, si valuta se far evolvere la prassi di riferimento in un documento normativo; dopo cinque anni o sono trasformate in norma UNI o sono ritirate” (www.uni.com).
17 PNRR
La Prassi UNI/PdR 125:2022 (Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performances Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazion i), sviluppata in collaborazione con alcune importanti associazioni nazionali in rappresentanza delle donne imprenditrici (CONFAPID, Gruppo Nazionale delle Donne Imprenditrici di Confapi; AIDDA, Associazione imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda; AICEO, Associazione Italiana CEO), è stato il risultato del tavolo di lavoro coordinato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, a cui hanno preso parte il MEF, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Consigliera Nazionale di Parità, il Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale prassi definisce, per l’appunto, le linee guida sul sistema di gestione per la parità tra uomo e donna e prevede la definizione di un insieme di indicatori prestazionali (KPI) nelle organizzazioni; essa individua sei aree di indicatori che possono connotare una organizzazione: Cultura e strategia; Governance; Processi HR; Opportunità di crescita in azienda neutrali per genere; Equità remunerativa per genere; Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. L’importanza della Prassi UNI/PdR 125:2022 è stata sancita dal Decreto 29 aprile 2022, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.152 del 1-7-2022, che, all’art.2 (Il rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese ) ha disposto che al
rilascio della certificazione della parita’ di genere provvedono gli Organismi di Valutazione della Conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento CE n. 765/2008. Il legislatore, quindi, ha inteso predisporre un meccanismo di verifica molto rigoroso circa l’osservanza, da parte delle aziende, dei parametri occorrenti per ottenere la certificazione della parità di genere: tale rigore, infatti, è testimoniato dalla circostanza che l’attività stessa è demandata agli Organismi di Valutazione della Conformità (Conformity Assessment Bodies, CABs), vale a dire a quegli organismi accreditati (che eseguono attività di valutazione della conformità, ovvero che svolgono tarature, prove, ispezioni e / o attività di certificazione) definiti “di terza parte”, che svolgono un’attività di valutazione indipendente, imparziale e competente rispetto al soggetto (impresa) destinatario di tale valutazione.
In conclusione, quindi, le certificazioni conformi alla Prassi UNI/PdR 125:2022, non solo hanno la funzione di consentire alle imprese di accedere a punteggi premiali nel settore delle gare d’appalto e ai fini dell’accesso agevolato a finanziamenti pubblici, ma hanno un impatto altamente strategico per le stesse imprese giacchè il perseguimento e l’effettiva realizzazione della parità di genere apporta un concreto e benefico effetto reputazionale nei confronti sia dei clienti (siano essi privati o pubbliche amministrazioni) che dei dipendenti, generando anche importanti risultati in termini di performance economico-finanziaria rispetto alle imprese prive della detta certificazione.

18
PNRR
Sulla revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture. Brevi osservazioni alla delibera ANAC n. 37/2022
L’art. 29 del d.l. 27.01.2022, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022) ha stabilito che “ al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19” per gli atti di gara “ a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 501, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1”.
1 Fermo quanto sopra, la disposizione introduce norme diverse per forniture e servizi, da un lato, e lavori dall’altro lato.
Q uanto ai primi viene prevista soltanto la necessità di inserimento della clausola di revisione prezzi nella lex specialis, senza alcuna indicazione sul quantum limite dell’incremento, né sulle modalità mediante le quali l’appaltatore deve procedere per il riconoscimento della revisione. Per i lavori, invece, viene delineata e procedimentalizzata una procedura specifica di riconoscimento dell’adeguamento dei corrispettivi contrattuali.
Quanto al primo profilo viene in rilievo il sopra citato art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, il quale, per gli appalti sottosoglia, prevede che i contratti di servizi e forniture possano essere modificati “se il valore della modifica è al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto” (comma 2, lett. b).
La norma, evidentemente, ha una portata limitata e, proprio per evitarne un’applicazione distorsiva, il medesimo comma precisa che “in caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche”.
Le richieste di adeguamento dei corrispettivi contrattuali presentate dai fornitori possono essere trattate e inquadrate nell’ambito di una duplice cornice giuridica, sia pubblicistica, che privatistica
2. Stante il quadro, le richieste di adeguamento dei corrispettivi contrattuali presentate dai fornitori possono essere trattate e inquadrate nell’ambito di una duplice cornice giuridica, sia pubblicistica, che privatistica.
Per gli appalti sopra soglia, invece, si potrebbe fare riferimento al comma 1, lett. c) del medesimo art. 106, ai sensi del quale – fatto salvo il limite dell’aumento di prezzo fino al 50 per cento del valore del contratto iniziale (art. 106, comma 7) – i contratti possono essere variati ove “ la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice” con la precisazione che “in tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera” e, inoltre, che “tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”. Tale ultima disposizione, peraltro, verrebbe applicata nei casi in questione in via estensiva in quanto, a rigore, essa fa riferimento alle modifiche dell’oggetto
1 L’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 prevede che è possibile la modifica dei contratti di appalto “se le modifiche a prescindere dal loro valore monetario sono state previste dai documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi”.
19 prezzi di riferimento
Annalisa Damele - Dirigente S.C. Approvvigionamenti e Gestione della Concessione ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
prezzi di riferimento
dell’appalto (e non già agli adeguamenti economici) ed è obiettivamente finalizzata ad allineare gli affidamenti a innovazioni tecniche sopravvenute. É opportuno, quindi, che l’eventuale adeguamento dei corrispettivi contrattuali basato su tale previsione si fondi su una motivata operazione ermeneutica a sostegno dell’applicabilità della medesima nei casi specifici.
3. Quanto al profilo privatistico, assume rilievo l’art. 1467 del Codice civile, in forza del quale “nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458 [...]”, con la precisazione che “la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.
In effetti, l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 pare rientrare a pieno titolo negli avvenimenti “straordinari e imprevedibili” e nell’ultimo capoverso dell’articolo si rinviene la possibilità di addivenire legittimamente ad una rideterminazione del corrispettivo contrattuale, previa – ovviamente – la motivata valutazione di equità della stessa, tanto più necessaria in caso di commesse pubbliche.
Si aggiunga, poi, che più specificatamente l’art. 1664 del Codice civile (norma speciale rispetto all’art. 1467, in quanto relativa ai contratti di appalto) dispone che “ qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano
verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”.

In particolare, si potrebbe ragionare sull’applicazione dell’ultimo periodo, in quanto l’emergenza sanitaria da Covid – 19 potrebbe essere ricondotta ad una fattispecie di difficoltà di esecuzione del contratto derivante da cause “ simili ” a sorprese geologiche, in quanto altrettanto imprevedibili e indipendenti dal volere dell’appaltatore 2
Si tratta, ovviamente, di proposte di inquadramento che valgono come proposta di discussione per gestire in maniera efficace ed efficiente le numerose richieste di adeguamento prezzi che pervengono dai fornitori a causa dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell’emergenza Covid-19.
4. Con parere 13.09.2022, n. 37 Anac si è recentemente soffermata sulla problematica della revisione dei prezzi rilevando che l’unica previsione applicabile sarebbe l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, escludendo, invece, l’utilizzabilità dell’art. 1664 Cod. Civ..
Il rilievo muove dal presupposto che la possibilità di
2 La giurisprudenza civilistica sull’art. 1664 ha, infatti, chiarito che vanno escluse dal novero delle difficoltà oggettive di realizzazione del contratto soltanto quelle legate al fattore umano (ex multis Corte Cass., Sez. I, 28.03.2001, n. 4463).
20
prezzi di riferimento
applicare l’art. 1664 “oltre a non trovare riscontro nelle previsioni dell’art. 106 del Codice che costituisce norma speciale e fonte legittimante le variazioni dei contratti in corso di esecuzione, sembra altresì esclusa dalla giurisprudenza amministrativa che ritiene inapplicabile tale norma agli appalti pubblici, secondo il principio di specialità della disciplina dettata dal Codice”.
Sennonché, l’orientamento giurisprudenziale cui fa riferimento Anac si è formato nella vigenza del d.lgs. n. 163/2006 e in un contesto giuridico nel quale la disciplina privatistica aveva, nell’ambito dei contratti pubblici, un ruolo marginale.
Tant’è vero che l’art. 2, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 disponeva che “per quanto non espressamente previsto nel presente codice l’attività contrattuale dei soggetti di cui all’articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile”.
Veniva, quindi, esperito un rimando generale e generico alla disciplina codicistica, che, peraltro, essendo riferito alla complessiva “attività contrattuale”, pareva effettivamente orientato ad avere una ricaduta minima.
L’assetto normativo attuale, tuttavia, è difforme dal precedente.

Ed invero l’art. 30 del vigente d.lgs. n. 50/2016 dispone che “ per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici … si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile” . Ecco, quindi, che vi è uno specifico richiamo alla disciplina codicistica che non può essere sottovalutato, né
– si ritiene – bypassato richiamando il principio di specialità.
Da un lato, infatti, deve tenersi conto della disciplina di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, ma, dall’altro lato, è lo stesso d.lgs. a specificare che alla fase di esecuzione di applicano le disposizioni del codice civile.
Non si vede, quindi, come possa attualmente escludersi l’applicabilità dell’art. 1664 del codice civile, né quale utilità ciò potrebbe avere.
Sotto un profilo pratico, infatti, per i contratti privi di clausola di revisione le stazioni appaltanti si trovano a dover dare seguito alle richieste di rinegoziazione dei fornitori e necessitano di tutti i possibili riferimenti giuridici per il relativo inquadramento.
Ad avviso di chi scrive, quindi, il quadro nel quale muoversi a fronte della presentazione di un’istanza di rinegoziazione, non può non ricomprendere:
• il citato art. 30, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici … si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile” ;
• l’art. 1, comma 2 bis della legge n. 241/1990, secondo cui “i rapporti tra il cittadino e la P.A. sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”;
• gli artt. 1467 e 1664 del codice civile, i quali, unitamente agli artt. 1366, 1374 e 1375 consentono di effettuare una rinegoziazione derivante dai principi di buona fede e equità integrativa.
21
Il tema dell’assenteismo nei contratti di somministrazione lavoro della pubblica amministrazione
La questione delle ore di assenza dal servizio del personale destinato ad un appalto – generalmente nota come “assenteismo” - è uno degli argomenti più delicati dell’intero panorama degli appalti pubblici. Per “assenteismo”, sia ricordato a beneficio di tutti, s’intendono tutte le ore in cui un lavoratore destinato ad un appalto non presta il proprio servizio per ragioni contrattualmente giustificate; perché, ad esempio, in godimento di ferie, o perché assente per malattia o in ragione di particolari permessi sindacali o di studio. In queste circostanze, ad un’ora di assenza di un lavoratore si associa un doppio costo per l’appaltatore/datore di lavoro: da un lato, dovrà comunque retribuire il lavoratore assente (ad esempio perché in ferie), dall’altro, dovrà anche retribuire un altro lavoratore che sostituisca il primo per l’intero periodo di assenza. Il tema assume portata decisiva in particolare (ma naturalmente non solo) negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, ove cioè l’incidenza dei costi della manodopera sull’appalto “è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto” (secondo la definizione datane dall’art. 50 del d.lgs. 50/2016) e nel cui ambito, pertanto, il costo del lavoro costituisce la principale componente del quadro di spesa dell’appaltatore. Com’è facilmente immaginabile, quindi, si tratta della voce che più è in grado di incidere, per le imprese, sulle spese complessive di commessa in questo tipo di appalti: minori saranno le ore di assenza del personale sull’appalto, minori saranno i costi del lavoro cui l’appaltatore dovrà far fronte. La sopradetta – qui semplicisticamen-
te sintetizzata – equazione, è sottesa a tutti gli investimenti in politiche di incentivazione al lavoro attuati dalle principali imprese di servizi, al fine di ridurre il più possibile le ore di assenza non indisponibili (come le ferie, ad esempio, che, anche se non godute dal lavoratore, gli vanno comunque retribuite). Chiaro che, dato lo scenario, quando un appaltatore formula un’offerta nell’ambito di un contratto di servizi a una pubblica amministrazione (soprattutto se quest’ultimo rientra tra quelli labour intensive), deve ben calibrare questo profilo, al fine di garantirsi che, attraverso il prezzo offerto, sia in grado di compensare anche questa voce accessoria del proprio costo del personale nell’ambito della gestione economica complessiva dell’appalto. E tuttavia, se la questione dell’assenteismo impatta così grandemente sulle politiche gestorie e commerciali delle imprese di servizi, lascia per contro totalmente indifferenti le stazioni appaltanti committenti (salvo costringerle, talvolta, a risolvere improbi “rompicapi” quando, in gara, si trovano a dover valutare l’anomalia di certe offerte): queste ultime esternalizzano “in blocco” il servizio al prezzo offerto dall’appaltatore, e quali che ne siano i reali (maggiori o minori) costi di gestioni è profilo rientrante nell’alea dell’imprenditore. Sotto lo specifico profilo del costo del lavoro, l’impresa che sia in grado, all’interno dei limiti giuslavoristicamente imposti, di massimizzare le ore di lavoro del proprio personale sopporterà una minor spesa, quindi, otterrà un maggior guadagno; viceversa, dovrà sopportare maggiori spese, vedendosi ridotti i guadagni: rientra in ogni
22 Paolo Cavallo - Studio Brugnoletti&Associati
gestione
Ancora oggi moltissimi bandi delle amministrazioni, finalizzati alla conclusione di un contratto di somministrazione di lavoro, contengono clausole che escludono che la p.a. rimborsi anche le assenze dei lavoratori somministrati
caso nell’ontologica natura dell’appalto, il cui rischio imprenditoriale ricade sull’appaltatore, che tale dinamica sia totalmente estranea al controllo (ed in fondo dall’interesse) del committente/pubblica amministrazione. Quanto brevemente riepilogato sul tema dell’assenteismo, assume contorni inediti nell’ambito di una particolare tipologia di contratti labour intensive: i contratti di somministrazione lavoro stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Quest’ultimo è l’unico caso, infatti, in cui si assiste – o meglio si dovrebbe assistere poiché in concreto non sempre accade, per quanto si dirà oltre –ad un totale ribaltamento di prospettiva. Occorre premettere che, rispetto alla natura di questo tipo di contratti, la giurisprudenza amministrativa ha ormai definitivamente chiarito che la somministrazione lavoro non è assimilabile a un contratto di appalto (sulla differenza tra appalto e somministrazione vd. su tutte Consiglio di Stato, Sez. III, 12 marzo 2018, n. 1571: “il contratto di appalto ha ad oggetto un’obbligazione di risultato (con cui l’appaltatore assume con la propria organizzazione il compito di far conseguire al committente il risultato promesso), mentre la somministrazione di lavoro sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l’Agenzia per il Lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate dal committente)”).

Nel contratto di somministrazione l’Agenzia invia in missione dei lavoratori presso un utilizzatore/pubblica amministrazione, nel cui interesse e sotto la cui direzione e il controllo essi svolgeranno la propria attività, secondo lo schema dell’obbligazione di mezzi: questo particolare rapporto ribalta la prospettiva sull’assenteismo. La somministrazione di lavoro, del resto, è caratterizzata proprio dal fatto che seppure il formale datore di lavoro del somministrato rimane l’Agenzia, il suo sostanziale datore di lavoro/coordinatore diviene l’utilizzatore, cioè la p.a. committente: dunque solo quest’ul-
tima ha la capacità in concreto di incidere – anche –sulle assenze dei lavoratori. Un’altra caratteristica della somministrazione di lavoro incide sul tema dell’assenteismo: per legge, tutti i costi retributivi e contributivi che il formale datore di lavoro (Agenzia) deve sopportare durante l’invio in missione del lavoratore devono essere rimborsati dall’utilizzatore. Dispone, infatti, il d.lgs. 81/2015 (il noto “jobs act”), all’art. 33, comma 2, che “Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. Detto articolo prevede dunque un “obbligo” espresso dell’utilizzatore di rimborsare all’Agenzia per il Lavoro gli oneri retributivi e previdenziali da questa “effettivamente sostenuti” per i lavoratori inviati in somministrazione: in altri termini, tutti i costi del lavoro diretto - non essendovene di altra natura che retributivi o contributivi – che l’Agenzia è costretta a sopportare per un lavoratore inviato in missione presso l’utilizzatore. E ciò naturalmente significa che anche i costi di tutte le assenze previste da CCNL e giustificate dei lavoratori somministrati (su tutte, ad esempio, le ferie concordate) dovranno essere posti a carico dell’utilizzatore; né le parti (Agenzia e Pubblica Amministrazione) potranno disporre diversamente in sede contrattuale poiché, come si evince dall’utilizzo del termine “obbligo”, il rimborso, da parte dell’utilizzatore, si configura come un precetto di legge imperativo, come tale indisponibile negozialmente dalle parti ed il cui mancato rispetto da parte dell’utilizzatore configura una chiara violazione di legge. Dunque, a differenza di un “normale” appalto di servizi, in cui l’assenteismo è tema tutto interno all’appaltatore che potrà, attraverso politiche di supporto e incentivazione al lavoro, marginalizzarne l’incidenza al fine di incrementare i propri margini di guadagno scaturenti
23 gestione
dal prezzo (fisso) che l’amministrazione gli corrisponde per la gestione dello specifico servizio, nel contratto di somministrazione è ex lege previsto che tale voce sia posta a carico dell’utilizzatore, che deve rimborsarla all’Agenzia unitamente alle restanti componenti del costo del lavoro. Nonostante il disposto normativo, ed ormai una giurisprudenza anche amministrativa che ha definitivamente superato la (errata) sovrapposizione tra appalto di servizi e somministrazione, è tuttavia significativo che ancora oggi moltissimi bandi delle amministrazioni finalizzati alla conclusione di un contratto di somministrazione di lavoro, continuino a contenere clausole che escludono che la p.a. rimborsi anche le assenze dei lavoratori somministrati. E se non escludono tout court di rimborsare il costo delle ore non lavorate, talvolta i bandi impongono alle Agenzie di farsi carico anche di questa voce di costo nell’ambito dell’offerta economica da presentare in gara, erroneamente assumendo che rientrino nell’alea dell’appaltatore tutti i costi delle ore di assenza dei lavoratori inviati in missione presso la p.a. committente. L’errato approccio delle amministrazioni al tema del rimborso dei costi per l’assenteismo è stato oggetto di esame anche a livello giurisdizionale; in una fattispecie in cui un’Agenzia per il Lavoro aveva ingiunto alla p.a. di rimborsare tutto il costo del lavoro dei somministrati, comprese le ore di assenza, il giudice ordinario ha concluso – nei termini sopra detti – ribadendo la sussistenza dell’obbligo per l’utilizzatore di farsi carico dei costi dell’assenteismo. In questo giudizio (si trattava di un giudizio civile ordinario, avendo la p.a. opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dall’Agenzia per il Lavoro) si controverteva sui costi delle festività infrasettimanali, il cui rimborso integrale secondo l’Agenzia le era dovuto in quanto facente parte degli oneri retributivi e contributivi sostenuti per il personale somministrato, che la legge (il citato art. 33 del jobs act) pone a carico dell’utilizzatore; la conclusione
cui è pervenuto il Giudice Ordinario è stata: “detti corrispettivi, pacificamente pagati ai lavoratori somministrati, devono essere rimborsati all’opposta in forza del citato art. 21 del Decreto Biagi” (Tribunale Piacenza, Sez. Unica Civile, 11 gennaio 2018, n. 19). Quest’ultimo articolo, nel frattempo sostituito dall’art. 33, comma 2, summenzionato, è di contenuto identico a quello odierno e anch’esso prevede “l’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro”; di guisa che la predetta sentenza si attaglia tanto alla previgente normativa quanto alla presente. Naturalmente, sia detto per inciso, il rimborso dovuto dal committente riguarda unicamente il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia anche per le ore di assenza giustificate, mentre non è ovviamente dovuta la maggiorazione applicata a titolo di margine di Agenzia; ipotesi, quest’ultima, seccamente da escludersi poiché il margine corrisponde al ricavo dell’Agenzia, che non avrebbe alcun titolo per esserle corrisposto in assenza effettiva di lavoro prestato dal somministrato assente. L’argomento è complesso e di recente sviluppo, e non ha ancora attecchito nella cultura dei contratti pubblici e, soprattutto, delle amministrazioni committenti, i cui bandi molto spesso violano l’impostazione sopra descritta; tuttavia è opportuno, nell’ottica di una migliore gestione di questa specifica categoria di contratti che, da un lato, le amministrazioni vengano sensibilizzate a prendere atto che in sede di assegnazione di un contratto di somministrazione di personale, resta comunque a loro carico il rimborso per intero del costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’Agenzia, di cui dovranno quindi tenere conto nell’individuazione del quadro economico di commessa e nella composizione della base d’asta e, dall’altro, che detto obbligo resta comunque circoscritto alla corresponsione del solo costo del lavoro, e che non è dovuto null’altro che non sia detto rimborso.

24
gestione
Fascicolo sanitario elettronico e PNRR: le ultime novità e i risvolti in materia di privacy
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 luglio 2022, con Decreto 20 maggio 2022 sono state adottate le Linee guida per il potenziamento del fascicolo sanitario elettronico (FSE) allo scopo di garantirne la piena diffusione, l’omogeneità e l’accessibilità su tutto il territorio nazionale nelle tempistiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Pilastro della nuova sanità digitale, il FSE ricostruisce la storia clinica del paziente rendendo disponibili e facilmente accessibili i documenti e le informazioni che possono agevolare il percorso di cura, differentemente alla cartella clinica che documenta quanto accaduto in un ricovero sanitario
Introdotto dal D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 e regolamentato dal D.P.C.M. n. 178 del 29 settembre 2015, il fascicolo sanitario elettronico è lo spazio virtuale nel quale sono raccolti i dati e le informazioni sanitarie dell’utente. Nello specifico, l’art. 12, co. 1 del D.L 2012 lo definisce come “l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale”. Pilastro della nuova sanità digitale, il FSE si limita pertanto a ricostruire la storia clinica del paziente rendendo disponibili e facilmente accessibili i documenti e le informazioni che possono agevolare il percorso di cura, differentemente dal compito oramai riconosciuto alla cartella clinica che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, documenta fino a querela di falso quanto accaduto in un ricovero sanitario (Sent. n. 22694/2015).
La disciplina regolatrice del FSE è stata recentemente ridefinita dal D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25 che, anche nell’ottica
di potenziare il ruolo dell’Agenzia per la Sanità nelle Regioni (AGENAS), ha di fatto reso obbligatorio l’inserimento dei dati da parte degli operatori del SSN entro 5 giorni dall’erogazione delle prestazioni. Nel quadro normativo anzidetto si sono inseriti gli stanziamenti previsti all’interno della Missione 6 del PNRR pensati per dare decisivo impulso e rendere concreta la fruibilità e la circolazione dei dati sanitari digitali nel periodo 2022-2026. I fondi del PNRR contribuiranno infatti a fornire soluzione ad una diseguale adozione del FSE in tutte le Regioni italiane mirando alla realizzazione di una rappresentazione quanto più puntuale delle condizioni di salute del paziente, del proprio contesto sociosanitario e dei propri piani socioassistenziali. In particolare, l’investimento 1.3.1. della Missione 6 Componente 2 del PNNR stanzia 1,38 miliardi di euro per il potenziamento del FSE da realizzarsi attraverso il raggiungimento di due target:
• Entro il 2025, l’85% dei medici di base dovranno alimentare il fascicolo sanitario elettronico;
• Entro il 2026 tutte le Regioni e le Province Autonome dovranno adottare ed utilizzare il FSE e dunque entro 3 mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida dovranno presentare i propri piani di adeguamento per aggiornare i propri sistemi e ricevere le risorse finanziarie necessarie per attuarli. Tali obiettivi, come si evince dalle Linee Guida del maggio 2022, presuppongono il preliminare raggiungimento
25 fascicolo sanitario elettronico
Beatrice Iommi - Studio legale Piselli & Partners Roma
fascicolo sanitario elettronico
di target a medio e lungo termine implicanti modifiche qualitative in tema di:
1. Accesso: attuare un FSE omogeneo sul territorio nazionale che rappresenti l’unico punto di accesso ai servizi del Sistema sanitario nazionale;
2. Integrazione: rendere il FSE strumento di agile condivisione di dati clinici tra professionisti e strutture sanitarie pubbliche e private, anche in relazione all’operato delle farmacie nella definizione del giusto piano terapeutico;
3. Personalizzazione : implementare la numerosità di dati clinici contenuti dal FSE per aumentare la capacità di diagnosi e cura personalizzata, sulla scia di quanto già previsto all’interno del Decreto del Ministero della Salute del 18 maggio 2022;
4. Policy: impiegare lo strumento del FSE per orientare le istituzioni sanitarie e per supportarle nella definizione e attuazione di politiche di prevenzione, programmazione sanitaria, oltreché agli enti di ricerca per motivi di ricerca medica e biomedica.
In sostanza gli intenti del PNRR volti a rafforzare il FSE ed a superare le sfide strutturali del SSN (tra le quali, solo a titolo esemplificativo, si accenna al preoccupante divario territoriale nell’accesso alle cure) presuppongono il raggiungimento di obiettivi intermedi, e si esplicano attraverso quattro direttrici d’azione che incidono sul nuovo contenuto, sui nuovi servizi, sull’architettura e sulla governance che caratterizzeranno in futuro il fascicolo sanitario.
Entro il 2026 si prevede infatti la piena operatività del FSE quale unico ed esclusivo punto di accesso ai servizi di sanità digitale per i cittadini, con modifiche rilevanti che riguardano altresì l’accesso ai servizi di prenotazione e pagamento delle prestazioni mediche, oltre che ai servizi di erogazione di farmaci e di emergenza, sino ai servizi di telemedicina (quali l’erogazione di tele-visite da parte di medici specialisti, di tele-consulto e tele-assistenza). Il percorso di digitalizzazione ed implementazione cui mira il PNRR pone tuttavia una serie di problematiche che ancora non hanno trovato soluzione in relazione alla tutela della privacy degli utenti del SSN che vedono i loro dati immessi in maniera massiccia all’interno del nuovo fascicolo elettronico. Il primo interrogativo da porsi è capire come conciliare la nuova visione del fascicolo sanitario elettronico con l’esigenza di tutelare la privacy del paziente?
S appiamo che il nuovo FSE mira alla creazione di un “ecosistema” (EDS) di dati e documenti sanitari attraverso la duplicazione delle informazioni generate per finalità di cura. Queste confluiranno infatti all’interno di quella che si profila essere la più grande banca dati in materia sanitaria presente nel nostro paese in grado di raccogliere
a livello centralizzato informazioni mediche. Il rispetto della normativa europea e della disciplina di settore in materia di privacy tuttavia impongono maggiori garanzie che sembrano esser state in prima battuta trascurate dal nostro legislatore. Le maggiori criticità, già sviscerate dal Garante della privacy con proprio parere negativo datato 22 agosto 2022, delineano un quadro preoccupante che rischia in sostanza di vanificare i diritti costituzionali degli interessati nel bilanciamento con le nuove esigenze di modernizzazione ed implementazione del Sistema Sanitario Nazionale. Nello specifico, si accenna ad alcune delle criticità che emergono nella nuova visione del FSE, che impongono forse una maggiore cautela nel pensare ed attuare la gestione dei dati sensibili se non si vuole pregiudicare l’esercizio dei diritti dell’utenza. Dagli schemi di decreto che sono stati presentati dal Ministero della Salute, le prime problematiche emerse si registrano in relazione alla corretta individuazione degli Enti pubblici coinvolti e delle strutture sanitarie interessate che potranno fruire delle informazioni sanitarie quali titolari del trattamento dei dati.
S econdo la normativa di settore, il titolare del trattamento dei dati personali è infatti il soggetto deputato all’individuazione delle finalità e dei metodi di trattamento dei dati personali raccolti, le cui responsabilità sono puntualmente disciplinate all’interno del Codice sulla privacy (D.Lgs. 196/2003). In altre parole, si tratta del soggetto che decide come e perché devono essere trattati i dati e ne definisce pertanto le relative modalità. Nelle nuove proposte legislative i primi interrogativi sorgono proprio perché il legislatore non ha individuato in maniera puntuale e preventiva il perimetro di titolarità di trattamento spettante in materia al Ministero della Salute rispetto a quello da ascrivere agli altri soggetti che a vario titolo alimentano la banca dati, fruiscono dei servizi offerti dallo stesso e hanno la possibilità di consultarlo. T ale carenza ha purtroppo delle indubbie ricadute in termini di responsabilità. La normativa di settore, nello specifico l’art. 82 del Regolamento sulla privacy prevede infatti che l’interessato al trattamento dei dati personali abbia il diritto di ottenere il risarcimento del danno, sia patrimoniale che non, a seguito di una condotta omissiva o attiva che integri una violazione delle regole poste a tutela della disciplina di settore (v. art. 82 GDPR, co. 1. “Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”).
È infatti chiaro che una preliminare individuazione delle figure e degli Enti in questione, dei relativi compiti e del relativo perimetro di responsabilità (in relazione alle varie tipologie di trattamento per le finalità di alimenta-
26
zione, di diagnosi cura e riabilitazione, di prevenzione, di profilassi internazionale) è in grado di assicurare tutela all’utenza ed in generale ai soggetti fruitori del FSE che in questo modo rischiano di veder compromessi i propri diritti in caso di violazione dei principi dettati dal codice in materia di trattamento dei dati.
Ulteriori criticità si pongono poi in relazione proprio al rispetto degli anzidetti principi. L’art. 5 del Regolamento EU sulla privacy impone nella gestione dei dati personali il rispetto di una serie di principi eterogenei che assicurano un trattamento lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. Solo a titolo esemplificativo, il GDPR elenca tra i tanti il principio di proporzionalità del trattamento rispetto all’interesse pubblico perseguito, il principio di trasparenza, di aggiornamento, di minimizzazione ed integrità dei dati.
Ai fini del rispetto di tali principi, come anche chiarito dal Garante della privacy nei propri pareri forniti nel corso degli ultimi mesi, si impone certamente una analisi di ciascuna delle operazioni effettuate dai diversi soggetti a vario titolo coinvolti nel trattamento dei dati sensibili.

Le nuove proposte legislative presentate appaiono tuttavia sul punto lacunose. Ed infatti, in assenza di una puntuale indicazione dei soggetti responsabili del trattamento e del rispetto dei principi in questione si rischia un errato trattamento dei dati, con ricadute in termini di cattiva utilizzazione del nuovo strumento FSE.
Basti sul punto ragionare in relazione ai due principi di aggiornamento e completezza dei dati. Se concepiamo il FSE come mezzo per ricostruire in maniera completa ed esaustiva la storia clinica del paziente appare necessaria la previsione di un obbligo, con le connesse responsabilità per i soggetti coinvolti di provvedere alla consultazione, all’alimentazione ed all’integrazione del FSE in maniera continuativa allo stato attuale carente. L’art. 12, co. 3 del D.L. 179/2012 si limita a chiarire che il FSE deve essere alimentato in maniera “tempestiva e continua”,
ma alcun obbligo è previsto per gli operatori di consultare ed implementare il relativo fascicolo con dati mancanti. Un ragionamento di questo tipo tuttavia si impone poiché diversamente verrebbe frustrata la reale portata innovativa del FSE quale strumento idoneo a fornire una diagnosi ed un trattamento terapeutico/farmaceutico personalizzato ed adeguato ad ogni paziente. Le brevi considerazioni sopra svolte dimostrano come il legislatore debba maneggiare con cura la nuova disciplina del FSE. Si rischia infatti di garantire una implementazione tecnologica del fascicolo sanitario a discapito dei diritti fondamentali degli utenti e dei principi generali previsti dalla disciplina comunitaria in materia di riservatezza. Le nuove proposte normative appaiono dal punto di vista della privacy ancora lacunose e presentano profili di contrasto con la normativa di settore. Come auspicato dagli addetti ai lavori è necessaria una maggiore attenzione in relazione ad aspetti non marginali della disciplina, occorre meglio specificare i contenuti e le modalità di alimentazione della banca dati, le modalità per manifestare il proprio consenso nel rispetto delle diverse finalità per i quali vengono trattati i dati, le relative responsabilità etc. Gli schemi di decreto già proposti dal Ministero dalla salute, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro dell’economia e delle Finanze, che si inseriscono nel percorso a più fasi ideato per dare attuazione alla Missione 6 del PNRR, sono infatti stati criticati dal Garante della privacy a causa delle criticità riscontrate. Sarebbe pertanto opportuno che i Ministeri coinvolti nei lavori si adoperino per consentire l’attuazione di un nuovo FSE, e di un contestuale nuovo ecosistema di dati sanitari, che in linea con le esigenze di modernità del sistema sanitario, sia in grado di rispondere in maniera fattiva alle richieste delle utenze senza tuttavia importare il sacrificio di diritti di rango costituzionale, come il diritto alla riservatezza.
27
fascicolo sanitario elettronico
Stefano Marcelli(1) - Renato Rocchi(2) - Tania Miconi(3) - Chiara Gatti(4) - Fabio Toia(5) - Federico Lattanzi(6) - Alessia Galli(7) Arianna Mancini(8) - Isabella Baglioni(9) - Francesca Ciarpella(10) - Claudia Parziale(11)
della
assistenziale: il
come elemento di accuratezza clinica ed organizzativa
La documentazione assistenziale come indicatore di qualità e appropriatezza all’interno dei sistemi di cura: analisi delle criticità Negli ultimi decenni lo sviluppo tecnico-scientifico ed i cambiamenti politici, sociali ed economici, hanno determinato, in diversi settori sanitari, l’implementazione degli sforzi per garantire la qualità dei prodotti. Istituzioni in una vasta gamma di aree hanno tentato, giorno dopo giorno, di raggiungere l’eccellenza investendo nella qualità dei loro servizi al fine di soddisfare le esigenze dei propri utenti. Il ventennio, dal 1950 al 1970, è stato segnato da una gestione incentrata sul “prodotto” e solo dagli anni ‘90, è stata evidenziata l’esigenza di qualità e produttività che ha comportato modifiche nei processi interni della governance sanitaria. Le organizzazioni si sono sempre più orientate verso la gestione della qualità, al fine di sostenere le turbolenze del mercato competitivo, attraverso una profonda revisione nel settore dei rapporti con il cittadino, specialmente all’interno dei sistemi sanitari. La letteratura scientifica ha largamente dimostrato l’importanza
contenenti
relativi ai processi
della documentazione assistenziale che costituisce un tassello fondamentale per la qualità della presa in carico dei pazienti complessi. Una documentazione chiara e concisa è essenziale per garantire cartelle cliniche accurate e affidabili al fine di sviluppare aspetti cruciali caratteristici dei processi interni delle organizzazioni che producono performance, poiché abbracciano valori medico legali e assistenziali che facilitano la continuità assistenziale e l’individualità di cura. Nei sistemi sanitari di tutti i Paesi, la qualità della documentazione sanitaria, rappresenta il presupposto imprescindibile per il perseguimento di target di eccellenza. In tale contesto, l’appropriatezza delle cure verso ciascun utente, il libero accesso ai servizi sanitari e l’eticità nell’assistenza, fungono da elementi di garanzia delle prestazioni. Una documentazione accurata e accessibile è un elemento essenziale della pratica infermieristica sicura, basata sui processi dell’Evidence Based Nursing (EBN), dove i professionisti della salute assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica e le preferenze del paziente, all’interno di un determinato
28
documentazione assistenziale
L’appropriatezza
documentazione
d-catch
I
1 Direttore Attività Didattiche Professionalizzanti - CdL Infermieristica – ASUR Marche Area Vasta N.5 2 Direttore - UOC Servizio Professioni Sanitarie - ASUR Marche Area Vasta N.4 3 Bed Manager - ASUR Marche Area Vasta N.4 4 Coordinatrice Infermieristica - SOD Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita UTIP – AOU Ospedali Riuniti di Ancona 5 UOC Pronto Soccorso – ASUR Marche Area Vasta N.3 6 UOC Potes 118 – ASUR Marche Area Vasta n.4 7 Infermiera - SOD Pronto Soccorso – AOU Ospedali Riuniti di Ancona 8 Infermiera - UOC Medicina e Chirurgia d’Accettazione e D’Urgenza-Pronto Soccorso
Marche Area
4 9 Tutor clinico di tirocinio – CdL Infermieristica -
Area
10 Infermiera - Area Punti Vaccinali Covid -
Area
11 Infermiera – UOC Neurologia
instrument
dossier
informazioni
di caring, evidenziano una relazione contingente tra la validità e l’incisività dei dati raccolti sul paziente con la relativa pianificazione e una netta connessione con la mortalità degli stessi
- ASUR
Vasta n.
ASUR Marche
Vasta N.4
ASUR Marche
Vasta N.4
- ASUR Marche Area Vasta N.5
contesto di risorse disponibili. La documentazione basata sul processo infermieristico rende fattibile l’attività di caring poiché sviluppa la capacità di tracciare i bisogni del paziente attraverso l’uso di un vocabolario comune, una scrittura leggibile e l’uso di simboli e abbreviazioni autorizzate. Rappresenta in pratica l’insieme delle attestazioni che registrano quel complesso eterogeneo di informazioni sanitarie, anagrafiche, sociali, aventi come scopo la rilevazione del percorso diagnostico-terapeutico del paziente secondo un criterio di ordine temporale, al fine di predisporre gli opportuni interventi sanitari e di poter effettuare anche eventuali indagini scientifiche, statistiche e medico legali. Di fatto, ottempera la funzione di una certificazione di ciò che si rileva e che si fa, dove i criteri di qualità comprendono completezza nelle descrizioni, leggibilità, identificazione delle priorità, resoconto cronologico degli eventi, informazioni obbiettive, tempestività, valutazione continua, attraverso indicatori di processo e di risultato, dove il singolo operatore si assume la responsabilità del suo operato. Testimonia, in altre parole, il chi, il che cosa, il come, il quando e il perché del trattamento del paziente nel corso di un ricovero. Ciò coincide con la definizione formulata dall’American Hospital Medical Record Association secondo cui “the medical record is the who, what, why, when and how of patient care during hospitalization”. Il dossier che accompagna ogni singolo paziente si è gradualmente migliorato in riferimento alle innovazioni dell’organizzazione ospedaliera e all’incremento della complessità in termini di risultati raggiunti, divenendo un mezzo di comunicazione interprofessionale, capace di mostrare appropriati, efficaci e affidabili i dati necessari per erogare le performance sanitarie necessarie. L’implementazione di strumenti informativi ha reso evidenti la capacità e il valore intrinseco dei singoli professionisti, di identificare e valutare i bisogni di assistenza dell’utente con l’obiettivo di formulare diagnosi infermieristiche sulla base di modelli esclusivi, definendo interventi mirati per raggiungerli. Le schede validate scientificamente, che contestualizzano le performance assistenziali, rappresentano parte integrante delle informazioni cliniche per soddisfare i requisiti etici, legali e professionali dell’intero processo di vigilanza e di cura, sia eseguite manualmente che elettronicamente. Esperti di settore attraverso indagini conoscitive, hanno dimostrato che i dossier contenenti informazioni relativi ai processi di caring, evidenziano una relazione contingente tra la validità e l’incisività dei dati raccolti sul paziente con la relativa pianificazione e una netta connessione con la mortalità degli stessi. Le notizie del paziente contestualizzate in un’ottica globale di intenti e di motivazioni, tese alla prevenzione degli eventi avversi,
descrive il problema (classificazione) del paziente, fattori correlati (eziologia), e caratteristiche definenti (segni e sintomi) contestualizzati in un linguaggio inequivocabile e chiaro. Governare e stimare i risultati attesi di un processo attraverso l’utilizzo di una documentazione meticolosa sono elementi fondamentali per mantenere elevati livelli di accuratezza ed efficienza; molti studi, invece, evidenziano notevoli carenze di conoscenza di questi strumenti. Tali criticità, dimostrate dalla letteratura scientifica, sembrano motivate da carenza di personale, da conoscenza inadeguata dei possibili risvolti medico legali, nel carico di lavoro, da mancanza di formazione dedicata e da carenza di supporto da parte delle Direzioni Aziendali. Nonostante l’evidente importanza della certificazione delle attività assistenziali in termini di risultati raggiunti, questa oggi viene vissuta come un elemento oneroso per i professionisti dove il tempo effettivo impiegato per tale attività rappresenta un elemento di forte criticità. La durata dell’impegno dei professionisti della salute per la documentazione varia a livello internazionale. Ad esempio, in Canada gli infermieri dedicano circa il 26% del loro tempo alla certificazione delle proprie performance, in Gran Bretagna il 17%, e negli USA le percentuali variano dal 25% fino al 41%. Nei Paesi Bassi, il personale assistenziale ha riferito di dedicare in media 10,5 ore a settimana alla attestazione delle proprie attività che si contestualizzano a circa il 40% del loro tempo a tale funzione. Studi dal Sud Africa e dall’Uganda hanno riportato carenze negli atteggiamenti, nella conoscenza e nei comportamenti pratici. Gli studi condotti in Kenya e Ghana hanno anche evidenziato la mancanza di un metodo standardizzato e l’insufficiente informazione sui processi.
D-Catch instrument: accuratezza e appropriatezza dello strumento L’accuratezza della documentazione infermieristica in ambito ospedaliero è stata valutata in molte realtà attraverso la rilevazione di tre elementi chiave del processo decisionale infermieristico: diagnosi, interventi e outcome. La struttura e i contenuti del processo di nursing sono riconosciuti a livello internazionale quali elementi chiave e costituenti lo sfondo teorico di una documentazione accurata. È scientificamente provato che una Diagnosi Infermieristica (DI) puntualmente scelta e correttamente formulata attraverso specifici criteri quali il metodo PES (Problem label, Related factors, Signs and symptoms) e supportata da una dettagliata valutazione dei pazienti, fornisce indicazioni chiare e lineari su fenomeni e concetti di natura assistenziale. Fino al 2007 nessuno strumento era in grado di quantificare l’accuratezza delle diagnosi infermieristiche,
29 documentazione assistenziale
gli interventi ed una valutazione dello svolgimento e dei risultati generali, nulla era destinato a questo scopo. Nel 2007/2008 finalmente nei Paesi Bassi, da due Pannelli di Delphi, viene elaborato il primo strumento in grado di valutare i parametri. Sulla base delle discussioni di consenso di entrambi i panelli di Delphi, i membri hanno concluso che lo strumento di documentazione infermieristica ideale era caratterizzato da una scala di misurazione dell’accuratezza quantificabile suddivisa in criteri di quantità e qualità, così come lo strumento Cat-ch-Ing. Hanno anche concluso che incorporare la scala a 7 punti di Lunney nello strumento consentiva di misurare ogni diagnosi infermieristica separatamente in termini di problema, fattori correlati e segni e sintomi, ovvero la struttura del PES. Sulla base dei commenti dei panel Delphi, i criteri dello strumento di Lunney sono stati integrati in una versione modificata dello strumento Cat-ch-Ing per quanto riguarda sia i criteri quantitativi che quelli qualitativi, portando infine alla formazione di un nuovo strumento: il D-Catch. Lo sviluppo di una metodologia condivisa di controllo sulla qualità della documentazione infermieristica finalizzata a misurare costantemente le informazioni presenti in riferimento a indicatori di processo fondamentali come accuratezza e rintracciabilità permette di approfondire l’analisi dello scostamento tra l’operatività quotidiana e i requisiti previsti dalla normativa vigente. Il D-Catch instrument è un modello psicometrico utilizzato per la misurazione e l’accuratezza della documentazione infermieristica negli ospedali. La validità e l’efficacia dello strumento sono state testate per mezzo di coppie di revisori indipendenti. L’efficacia è stata valutata e costruita mediante l’analisi fattoriale esplorativa con componenti principali e la rotazione varimax. La consistenza interna è stata misurata con Alpha di Cronbach. L’affidabilità interna dello strumento D-Catch è stata testata calcolando Kappa ponderata di Cohen (K(w)) per ogni coppia di utenti. I risultati ottenuti durante la validazione dello strumento lo hanno ritenuto valido e affidabile per valutare l’efficacia della documentazione infermieristica in ambito ospedaliero. Nello specifico sono stati identificati, tre componenti principali di analisi fattoriale; l’accuratezza della diagnosi infermieristica era l’unica variabile con carico sostanziale sulle due componenti (0.907) e un carico modesto su un componente (0.230). La coerenza interna (alfa di Cronbach) è stato 0,722. L’affidabilità interrater (K (w)) varia tra 0,742 e 0,896. Successivamente alla validazione dello strumento sono stati proiettati e divulgati i dati ottenuti in altri 10 reparti dei Paesi
Bassi. Nello specifico lo strumento è stato utilizzato per quantificare la precisione di struttura record, dati di ammissione, diagnosi infermieristica, interventi infermieristici, valutazioni svolgimento dei risultati, leggibilità del rapporto di cura. I punti 2 e 5 sono stati misurati con un punteggio somma di criteri quantitativi, 1 e 4 criteri qualitativi mentre 1 e 6 sono stati misurati con una scala Likert a 4 punti che ha affrontato i criteri di sola qualità. Lo stesso studio è stato poi condotto in Norvegia dove lo strumento è stato tradotto in base all’andamento culturale, lo sviluppo e le raccomandazioni scientifiche. Nel contesto italiano lo stesso è stato validato secondo valutazione psicometriche confermando la validità, la specificità e l’accuratezza. Contestualizzazione organizzativa dell’assistenza e valutazione prospettica del processo di caring Lo studio in oggetto è stato condotto presso l’Asur Marche Area Vasta n. 5 Stabilimento Ospedaliero di San Benedetto del Tronto (AP), nel periodo pre-covid, interessando le UU.OO di Medicina Interna, Geriatria, Ortopedia, Neurologia, Cardiologia, Chirurgia, Psichiatria, Ostetricia, Pediatria e Nido. La metodologia utilizzata si è basata sull’utilizzo di coppie di revisori indipendenti, casualità random, verifica retrospettiva cronologica in base all’archiviazione delle cartelle, con criterio di inclusione di ricoveri maggiori di tre giorni. I dati raccolti sono stati sottoposti a procedure statistiche di tipo descrittive e confrontati con la letteratura. Tutti i dati dei pazienti sono stati trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003 al fine di garantire la massima riservatezza e tutela della privacy. I dati inoltre sono stati esplicitati con specifici grafici che hanno permesso di avere un quadro diretto della qualità assistenziale delle varie Unità Operativa. Sono stati esplorati sei aspetti tra cui il livello della struttura della cartella, l’accuratezza dell’accertamento, l’appropriatezza della diagnosi infermieristica, degli interventi infermieristici, la valutazione degli out come e la leggibilità. Ad ogni item come da letteratura è stato conferito un punteggio, per i dati quantitativi (4): Completo (3): Parzialmente completo (2): Incompleto (1): Mancante, mentre per i dati qualitativi (4): Molto buono (3): Buono (2): Moderato (1): Scarso. Come evidenziato dal grafico (Grafico 1), considerando il punteggio 3, come valore soglia per certificare comunque un livello di sufficienza nell’area considerata, appare comunque evidente una prima differenziazione tra i vari dipartimenti, dove l’area materno infantile per un 90% si trova a non poter soddisfare i requisiti minimi di una buona documentazione assistenziale.
30
documentazione assistenziale
Andando nel dettaglio e partendo dai contesti organizzativi più sfavorevoli rispetto alla ricerca esplorativa, la UOC Ostetricia raggiunge un livello ottimale solo e soltanto nel dato qualitativo riferito alla leggibilità, mentre negli 5 aspetti si attesta ad un livello incompleto. La Pediatria pur manifestando un livello superiore di media rispetto alla UOC Ostetricia non raggiunge in nessun aspetto la sufficienza a differenza del Nido che almeno in due aree come la leggibilità e l’appropriatezza degli interventi conquista un valore idoneo. Nell’osservazione dell’andamento del grafico del Dipartimento della Salute mentale e nello specifico la UOC Psichiatria, soltanto la leggibilità e la struttura della cartella sono risultati conformi. Osservando l’area Chirurgica, il giudizio oggettivo legato ai vari Item aumenta di livello, in termini di adeguatezza in linea con le best practice, anche se non in maniera completa ma sicuramente migliori del Dipartimento Materno Infantile e della Salute Mentale. Confrontando i dati tra la UOC Chirurgia e UOC Ortopedia, appare evidente che in quest’ultima si raffigurano valori come competenza e abilità nella governance di tutti gli aspetti relativi alla leggibilità e alla struttura della documentazione, con picchi di completezza pari al livello ottimale riferiti alla stima della valutazione dell’out-come, dell’appropriatezza degli interventi, della diagnosi e dell’accertamento. Analizzando l’area Dipartimentale Medica, tranne la UOC di Cardiologia
che descrive una stratificazione dei vari aspetti al di sotto della soglia di validità, le UU.OO Medicina Interna, Geriatria e Neurologia si attestano a livelli medio alti relativamente a tutte le condizioni che riconducono ad una quantificazione ottimale della buona pratica certificativa delle azioni assistenziali. Implicazioni per la pratica Molto spesso si tende ad arrivare al raggiungimento dell’obbiettivo senza pensare quale sia stato il vero processo che ci ha portato ad esso. La prevenzione del deterioramento dello stato di salute del paziente è primariamente di responsabilità infermieristica dove il singolo cultore delle attività di caring elabora giudizi e agisce sulle minacce emergenti per la sicurezza del paziente attraverso un processo denominato “nursing surveillance”. Florence Nightingale scrive in “Notes on Nursing” che l’insegnamento più importante per un professionista della salute è istruirlo su cosa osservare, come osservare, quali sintomi indicano un miglioramento, quali un peggioramento, quali sono importanti, quali non lo sono e quali sono indice di trascuratezza. L’omissione di informazioni chiave per il buon esito delle cure può comportare danni in termini di outcome compromettendo gli esiti assistenziali portando ad un aumento dei costi sanitari. Una scarsa documentazione può influire negativamente sulla efficacia, qualità e visibilità delle performance con conseguenze legali e professionali.
31 documentazione assistenziale
Razionale scientifico
1. Asmirajanti M. Et al. Nursing care activities based on documentation. BMC Nurs. 2019 Aug 16;18(Suppl 1):32.
2. Bøgeskov BO. Et al. Essential task or meaningless burden? Nurses’ perceptions of the value of documentation. Nordic J Nurs Res. 2019;39(1):9–19.
3. Bompan. A. Et al. Accuracy of hospital nursing documentation: a multi-center observational study. Prof Inferm. Apr-Jun 2020;73(2):81-88.
4. Borsato FG. Et al. Assessment of quality of nursing documentation in a University Hospital. Acta Paul Enferm 2011;24(4):527-33.
5. Collins SA, Et al. Relationship between nursing documentation and patients’ mortality. Am J Crit Care. 2013;22(4):306–13.
6. Considine J. Et al. Nurses’ documentation of physiological observations in three acute care settings. J Clin Nurs. 2016;25(1–2):134–43.
7. Cooper AL.Et al. Is nursing and midwifery clinical documentation a burden? An empirical study of perception versus reality. J Clin Nurs. 2021;30(11–12):1645–1652.
8. Daskein R. Et al. Aged-care nurses’ knowledge of nursing documentation: an Australian perspective. J Clin Nurs. 2009;18:
9. Duarte MSM. Et al. Acreditação hospitalar x qualidade dos serviços de saúde. R Pesq: Cuid Fundam Online. 2010;2(Supl):182-5.
10. De Groot K. Et al. Nursing documentation and its relationship with perceived nursing workload: a mixed-methods study among community nurses. BMC Nurs. 2022; 21: 34.
11. De Groot K. Et al. Use of electronic health records in relation to standardized terminologies: a nationwide survey of nursing staff experiences Int J Nurs Stud. 2020;104:103523.
12. Garcia. A. Et al. Implications of Clinical Documentation (In)Accuracy: A Pilot Study Among General Surgery Residents Hosp Top. Apr-Jun 2017;95(2):27-3.
13. Gomes DC. Et al. Terms used by nurses in the documentation of patient progress. Revista Gaúcha de Enfermagem. 2016;37(1):e53927.
14. Kebede M. Et al. Nursing care documentation practice: the unfinished task of nursing care in the University of Gondar Hospital. Inform Health Soc Care. 2016;42:1–13
15. McCarthy B. Et al. Electronic nursing documentation interventions to promote or improve patient safety and quality care: a systematic review. J Nurs Manag. 2019;27(3):491–501
16. Moldskred PS. Et al .Improving the quality of nursing documentation at a residential care home: a clinical audit. BMC Nurs. 2021 Jun 21;20(1):103.
17. Nakate G, Et al. Knowledge and Attitudes of Select Ugandan Nurses towards Documentation of Patient Care Afr J Nurs Midw. 2015;2(1):056.
18. Nøst TH. Et al. D-Catch blir norsk. Sykepleien [Internet]. 2015; 2015(05).
19. Paans W. Et al. Patients’ care needs: documentation analysis in general hospitals. Int J of Nurs Knowl. 2015;(26)4:178-186.
20. Paans W. Et al. What factors influence the prevalence and accuracy of nursing diagnoses documentation in clinical practice? A systematic literature review. J Clin Nurs. 2011;20(17–18):2386–2403.
21. Paans W. Et al. D-Catch instrument: development and psychometric testing of a measurement instrument for nursing documentation in hospitals. J Adv Nurs. 2010;66(6):1388–400.

22. Ofi B. Et al. Nursing documentation: experience of the use of the nursing process model in selected hospitals in Ibadan, Oyo State, Nigeria. Int J Nurs Pract. 2012 Aug;18(4):354-62
23. Rabelo-Silva ER. Et al. Advanced Nursing Process quality: Comparing the International Classification for Nursing Practice (ICNP) with the NANDA-International (NANDA-I) and Nursing Interventions Classification (NIC). J Clin Nurs. 2017 Feb;26(3-4):379-387.
24. Royal College of Nursing. Nurses spend 2.5 million hours a week on paper work - RCN survey. London: Royal College of Nursing; 2013.
25. Roumeliotis N. Et al. Reorganizing care with the implementation of electronic medical records: a time-motion study in the PICU. Pediatr Crit Care Med. 2018;19(4):e172–e9.
26. Schenk E. Et al. Time motion analysis of nursing work in ICU, telemetry and medical-surgical units. J Nurs Manag. 2017;25(8):640–6.
27. Taiye BH. Knowledge and practice of documentation among nurses in Ahmadu Bello University Teaching Hospital. IOSR J Nurs Health Sci (IOSR-JNHS). 2015;4(6):1–6.
28. Wang N. Et al. Quality of nursing documentation and approaches to its evaluation: a mixed-method systematic review. J Adv Nurs. 2011 Sep;67(9):1858-75.
29. Yen P. Et al. Nurses’ time allocation and multitasking of nursing activities: a time motion study. AMIA Ann Symp Proc. 2018;2018:1137–6.
32 documentazione
assistenziale
VIII Corso di Alta Formazione 2021/22 per Funzionari e Dirigenti in Sanità
Scuola Permanente di Formazione dei Buyer Pubblici della Sanità Area Provveditorato - Economato - Patrimonio

33
Il Federalismo vent’anni dopo la sua nascita
Gruppo di lavoro:
Barni Sabrina ESTAR, Toscana
Ferrante Angelo ASL BAT, Puglia
Ozzo Francesco ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, Lombardia
Rizzi Valentina AZIENDA ZERO – CRAV, Veneto
Rutigliano Antonia ASL BAT, Puglia
Stacchini Erica ESTAR, Toscana
Zanellati Nicola AZIENDA ZERO – CRAV, Veneto
Nel corso della presente trattazione si cercherà – sinteticamente e senza alcuna pretesa di esaustività – di delineare gli elementi fondamentali del Federalismo, soprattutto in ambito sanitario, esaminandolo a vent’anni dalla sua nascita nel contesto di alcune Regioni (Lombardia, Veneto, Toscana e Puglia) quali paradigmi in grado di evidenziarne problematiche e punti di forza sul territorio italiano nel suo complesso. Com’è noto, il termine «Federalismo» viene utilizzato principalmente in tre contesti interconnessi tra loro: socio-politico, inteso quale modalità organizzativa delle istituzioni di uno Stato che si articola in due livelli: centrale e federale; fiscale, il cui obiettivo prevalente consiste nel decentramento del potere fiscale, con l’attribuzione a livello locale di una maggiore autonomia finanziaria e la possibilità per gli enti del territorio di stabilire entrare e uscite proprie; e, infine, sanitario, che consiste nel reperimento e utilizzo autonomi delle risorse da destinare specificamente ai servizi sanitari.
Quest’ultima impostazione, pur non scevra da critiche, consentirebbe di individuare con maggior accuratezza i bisogni specifici della comunità amministrata dalle singole realtà sanitarie territoriali, fornendo così le più adeguate risposte di politica sociale e sanitaria, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Chiaramente, si tratta di un tema complesso, visto che il settore sanitario occupa una porzione assai significativa della spesa pubblica. Basti pensare che nel 2021 la spesa sanitaria è risultata pari a 127.834 Mio €, come risulta dai dati della Sezione II “Analisi e tendenze della finanza pubblica” di cui al Documento di Economia e Finanza 2022 approvato lo scorso aprile.
Ciò premesso, è pacifico come il settore sanitario rappresenti un costo che, come si avrà modo di esaminare, deve essere determinato sulla base dei fabbisogni standard delle singole Regioni, quali criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, al fine di assicurare i c.d. livelli essenziali di assistenza (LEA), così come stabiliti dal D.P.C.M. del 12 gennaio 2017.
Pertanto, al fine di tratteggiare un quadro il più possibile completo sull’applicabilità di alcuni principi propri di un sistema di tipo federale all’ambito sanitario italiano e valutarne rischi e benefici, non si può prescindere da una breve analisi storica e normativa che ha portato all’attuale configurazione del nostro contesto socio-sanitario, partendo quindi dalle origini e dalla evoluzione del SSN.
Possiamo suddividere la storia del nostro sistema sanitario in tre grandi fasi: la prima trae origine dalla nascita del Regno d’Italia nel 1861 e si conclude con la Seconda guerra mondiale; l’inizio della seconda risale al 1946, anno in cui viene costituita la Repubblica italiana, e culmina con l’istituzione del SSN (1978); il terzo periodo, infine, ancora in atto, è caratterizzato dai tentativi di rendere il sistema sanitario sostenibile, pur mantenendo intatte le sue peculiarità virtuose: equità nell’accesso alle cure indipendentemente dal reddito, dal ruolo sociale e dall’inquadramento lavorativo del singolo cittadino e alta qualità dei servizi offerti. Un primo momento di svolta significativo nell’organizzazione del sistema sanitario in Italia si registra nel 1888, anno in cui viene emanata la “Legge Crispi-Pagliani”. Con questo decreto si delinea una struttura piramidale, articolata in tre livelli gerarchici: centrale, provinciale e comunale. Il progetto riformatore del governo Crispi si completa nel 1890, quando viene promulgata la “Legge sulle opere pie”, che sancisce la trasformazione degli ospedali da “opere pie”, sostenute da elargizioni e donazioni benefiche, a “servizi di pubblica assistenza” (IPAB). Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani sono chiamati alle urne. Tema del referendum è la scelta della forma di governo che l’Italia, appena uscita dalla Seconda guerra mondiale, dovrà assumere. Più di un anno di lavoro è necessario all’Assemblea costituente per dare vita alla Carta costituzionale dell’Italia repubblicana, che entra in vigore il 1° gennaio 1948,
34 VIII corso di formazione FARE
Tutor: Fabrizio Muzio
VIII corso di formazione FARE
con i suoi 139 articoli di cui gli artt. 2, 32 e 117 caposaldi nella “Tutela della Salute”. Subito dopo la Seconda guerra mondiale, l’ambiente ospedaliero vive un periodo di crisi, vittima del mancato aggiornamento tecnologico. La maggior parte dei presidî è, infatti, carente di attrezzature al passo con la modernizzazione della medicina. A metà degli anni Cinquanta ha avvio il fenomeno che, in Italia, viene definito “boom economico”, caratterizzato da una massiccia crescita economica e tecnologica che fa seguito alla fase di ricostruzione postbellica. Solo con la riforma ospedaliera attuata nel 1968 dal ministro della Sanità Luigi Mariotti con la Legge 12 febbraio 1968, n. 132, ci si avvicina a una piena attuazione dell’articolo 32 della Costituzione: ogni cittadino ha diritto ad avere un’assistenza ospedaliera appropriata e cure gratuite sono garantite a tutti i bisognosi. Vengono mossi i primi passi verso la regionalizzazione degli enti ospedalieri, che verrà definitivamente formalizzata nel 1974: lo Stato delega alle Regioni compiti di pianificazione e d’istituzione di nuovi enti e la responsabilità di emanare leggi riguardanti vigilanza e tutela dell’assistenza sanitaria e ospedaliera, all’interno dei limiti imposti a livello centrale. Si tratta dei piani ospedalieri regionali quinquennali. Viene inoltre disciplinata l’assistenza privata, ammettendo che una serie di enti possano svolgere assistenza ospedaliera. Nell’ambito pubblico, quindi, vengono riconosciuti enti ospedalieri, ospedali psichiatrici e istituti di ricovero e cura, nell’ambito privato, invece, case di cura e fondazioni. Al fine di superare i limiti d’inefficienza e inefficacia verificatisi nel sistema sanitario, la Legge 833 del 1978 prevede un radicale rinnovamento della sua impostazione, imperniato sul principio dell’“universalità dei destinatari”. Tale principio si basa sull’eliminazione della disparità socio-sanitaria presente nell’organizzazione fino ad allora vigente e sulla fondazione di un sistema sanitario nazionale UNICO. Con l’istituzione della nuova legge, il sistema sanitario nazionale viene strutturato secondo un modello definito “verticale”, al cui vertice troviamo lo Stato (livello centrale), seguito dalle Regioni (livello intermedio) e infine dagli enti locali (livello periferico), a ogni livello competono specifici compiti. Il modello di sanità introdotto dalla L. 833/78 fallì, sia a causa della gestione demandata ai Comuni e alle USL e sia a causa del sistema di finanziamento del servizio sanitario che, a fronte di una netta estensione delle prestazioni fornite e del principio di gratuità delle medesime, non prevedeva un rigoroso controllo della spesa ed una responsabilità in caso di eccessi di spesa. I limiti di questo assetto, apparsi già alla fine degli anni ’80, portarono alla necessità di rafforzare la responsabilità del livello regionale e ad abbandonare il modello USL, troppo frammentato (ben 652 USL) e politicizzato, da qui, quindi, prese l’avvio il processo di decentramento attraverso il D.lgs 502/92, la cd. “riforma della riforma”. Il D.lgs 502/92, sostanzialmente ha, da una parte, confermato gli obiettivi di fondo e i valori della L. 833/78 e dall’altra ha innovato gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi del SSN, perseguendo la regionalizzazione e l’aziendalizzazione della sanità italiana. I principali obiettivi della cd. “riforma della riforma”, sono stati: il rilancio della programmazione sanitaria, il raggiungimento di livelli uniformi di assistenza, la riorganizzazione della AUSL, la responsabilizzazione finanziaria delle Regioni, i meccanismi di partecipazione dei cittadini.
A seguire, nell’evoluzione normativa, l’ultimo intervento organico in materia sanitaria è costituito dalla cd. “riforma ter”, adottata con il D.lgs. n. 229/1999. Con la cd. “riforma ter” viene completato il processo di regionalizzazione: il SSN diviene il «complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali. Successivamente alla introduzione della riforma ter, è stata approvata la legge cost. n. 3 del 2001, nota come “riforma del Titolo V”, che ha modificato il riparto delle competenze Stato/Regioni, nello specifico:
- 117 2c. competenza esclusiva dello Stato: lo Stato può legiferare, in via esclusiva su determinate materie (es. difesa, immigrazione, etc)
- 117 3 c. competenza regionale concorrente: alle Regioni è attribuita la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato (es.tutela della Salute)
- 117 4 c. competenza residuale esclusiva delle Regioni: spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
Si ribalta quindi il principio di distribuzione delle competenze legislative fra Stato e Regioni: la competenza legislativa regionale pare aumentare nei contenuti ed essere potenzialmente aperta, idonea a legiferare su ogni materia altrimenti non riservata dalla costituzione ad altri soggetti. Ma questo non significa che allo Stato siano riconosciute competenze marginali e poteri ridotti o di scarso rilievo: le attribuzioni riservategli dalla costituzione sono infatti molte e molto rilevanti, in quanto attengono a settori fondanti dell’ordinamento generale (es. tutela dell’Ambiente).
La modifica dell’assetto di governance della Sanità, da accentrato a federalista su base regionale, ha comportato anche il cambiamento del relativo sistema di finanziamento, che è passato dal modello di finanza derivata, in cui la sanità regionale era finanziata dai trasferimenti statali, al federalismo fiscale, con cui la sanità è finanziata con
35
VIII corso di formazione FARE
tributi regionali, compartecipazione regionale ai tributi erariali e un sistema di perequazione volto a correggere gli squilibri territoriali. Questo cambiamento di passo è stato dettato dalla necessità di responsabilizzare le Regioni sia sul fronte della spesa sanitaria sia sul fronte del prelievo fiscale, in quanto gli amministratori regionali dovendo rispondere delle loro decisioni nei confronti dei cittadini-elettore sono stimolati ad assumere comportamenti più responsabili: in caso di bilancio regionale che chiude in disavanzo, non potendo più contare sul ripiano a piè di lista da parte dello Stato, le Regioni devono provvedere alla copertura con proprie risorse, per cui devono provvedere o all’aumento della pressione fiscale regionale oppure ridurre alcune voci di spesa del bilancio regionale. Il cambiamento del sistema di finanziamento della sanità è segnato da due provvedimento legislativi: 1) il D. Lgs 56/2000, che ha introdotto il federalismo fiscale in sanità; 2) il D. Lgs. 68/2011, che ha introdotto il criterio dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario. L’attuale sistema di finanziamento è quello derivante dal D. Lgs 56/2000. Con la legge di bilancio, previa intesa raggiunta in sede di conferenza Stato-regioni, viene determinato il fabbisogno sanitario nazionale standard. Con intesa della Conferenza Stato-Regioni le risorse del fabbisogno sanitario nazionale sono ripartite nelle due componenti “fabbisogno sanitario vincolato” e “fabbisogno sanitario indistinto”, viene inoltre determinata la quota spettante a ciascuna regione:
• fabbisogno sanitario vincolato: sono le risorse destinate al perseguimento di specifici obiettivi ed è finanziato con il Fondo Sanitario Nazionale, dunque, con risorse a carico del bilancio statale (per es: medicina penitenziaria, finanziamento per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, borse di studio per MMG, riabilitazione termale, assistenza ad extracomunitari irregolari, finanziamento Istituti Zooprofilattici Sperimentali)
• fabbisogno sanitario indistinto: sono le risorse ripartite tra le varie regioni per l’erogazione dei LEA Il fabbisogno sanitario nella sua componente “indistinta” è finanziato dalle seguenti fonti: - entrate proprie degli enti del SSN: ticket e ricavi derivanti dall’attività intramoenia dei dipendenti - fiscalità generale delle Regioni: imposta regionale sulle attività produttive - IRAP nella componente di gettito destinata al finanziamento della Sanità, e addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche –IRPEF
- bilancio dello Stato: finanzia il fabbisogno sanitario non coperto dalle altre fonti di finanziamento ed avviene attraverso la compartecipazione delle Regioni all’Imposta sull’IVA e la compartecipazione alle accise sulla benzina e gasolio per autotrazione in relazione ai consumi avvenuti sul proprio territorio Questo sistema di finanziamento comporta che le Regioni con più alta capacità reddituale hanno maggiore capacità fiscale e, dunque, maggiori risorse per il finanziamento dei rispettivi SSR, per cui riescono ad erogare i LEA e livelli aggiuntivi di prestazioni; le Regioni con minori capacità reddituali dispongono di minori risorse per il finanziamento sanitario e questo comporta che a stento riescono ad erogare i LEA e a volte sono inadempienti ai LEA. Questa sperequazione è solo in parte compensata dalla misura perequativa delle diverse capacità fiscali. Conseguentemente, il sistema di finanziamento alimenta differenziazioni territoriali nel soddisfacimento dei bisogni e del diritto alla Salute. Il D. Lgs 68/2011 ha sostanzialmente confermato le succitate fonti di finanziamento della Sanità, ma ha introdotto quale elemento di novità che il livello di finanziamento garantito alle Regioni è quello che deriva dal computo dei LEA in base ai costi standard, che costituiscono il quantum di costo ideale, ossia il costo in condizioni di efficacia ed efficienza. Le Regioni che dovessero sostenere una spesa sanitaria superiore a quella che deriva dai costi standard, per la maggiore spesa dovranno provvedere con proprie risorse a carico del bilancio regionale. E’ notorio che i SSR presentano forti differenziazioni sotto il profilo della performance, intesa come rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti, per cui Regioni con sistemi sanitari meno performanti, a seguito dell’introduzione dei costi standard a partire dal 2023 avranno ulteriori difficoltà ad erogare quel nucleo essenziale di prestazioni costituito dai LEA.
Parlando di Federalismo, diamo uno sguardo alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (Conferenza) che rappresenta oggi la principale sede di confronto e coordinamento tra le prerogative dello Stato e quelle degli enti regionali. Compito di questo ente è contribuire alla formazione di una volontà unitaria tra Stato e Regioni, nelle materie di interesse regionale. Tra le sue prerogative principali, da segnalare l’influenza nella decisione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni. Con il progressivo decentramento delle funzioni statali, culminato con l’attribuzione alle regioni di nuove competenze a seguito della riforma del titolo V° della costituzione, la Conferenza Stato-Regioni ha acquisito un’importanza crescente, abbandonando la veste di organo meramente consultivo e accrescendo il suo ruolo negoziale e di influenza sul processo decisionale. Infatti lo Stato, se vuole intervenire in materie di infrastrutture, sanità, governo del territorio, protezione civile, non può prescindere dell’intesa con le Regioni (Sentenza n.74 Corte Costituzionale).
36
VIII corso di formazione FARE
PANDEMIA COVID-19
Il 31 dicembre 2019 arrivava da Wuhan la notizia di una nuova forma di polmonite virale; dopo un mese, il 31 gennaio 2020, il governo Conte dichiara lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario”, in risposta alla dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica internazionale” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del giorno prima. Il 23 Febbraio 2020 viene emanato il Decreto Legge n.6 in seguito al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emesso ulteriori decreti recanti le norme sul contenimento del contagio. A fronte di tali provvedimenti nazionali (DPCM) le Regioni hanno emesso molteplici ordinanze mirate ad adeguare la disciplina dei DPCM alle esigenze espresse dal territorio locale. Nel marzo 2020 il Governo ha istituito le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) per aiutare i Medici di Medicina Generale nella gestione sul territorio dei pazienti COVID o sospetti COVID. Ogni USCA ha il compito di assistere a domicilio i malati di COVID-19, ospedalizzando, precocemente ed esclusivamente, i casi gravi.
ll caso Toscana: Il SSR della Toscana è regolato dalla L.R. 40/2005 rivista alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. 84/2015 e ss.mm.ii. Nell’ambito della gestione delle attività, al fine della costituzione degli elementi innovativi, lo scenario del SSRT vede al centro l’individuazione delle Aree Vaste - la fusione delle Aziende Sanitarie - l’integrazione fra il sociale e il sanitario - la costituzione di ESTAR a supporto delle funzioni tecnico-amministrative delle Aziende Sanitarie stesse. L’Area Vasta è definita come “l’ambito di attuazione della programmazione strategica regionale nel quale sono integrate le programmazioni dell’azienda unità sanitaria locale e dell’azienda ospedaliera universitaria” . Sono state individuate tre Aree Vaste: AV Nord Ovest, AV Centro, AV Sud Est. A ciascuna AV afferisce una sola Azienda USL e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di riferimento. La riduzione delle Aziende Sanitarie, ha permesso un’organizzazione più omogenea nell’erogazione dei servizi ai cittadini, il rafforzamento della programmazione di Area Vasta e la revisione dei processi di governance. Alle AUSL afferiscono le Società della Salute (SdS) che sono soggetti pubblici, costituiti per adesione volontaria dei Comuni di una stessa zona-distretto e dell’AUSL territorialmente competente, per l’esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate. Parimenti le sinergie tra AOU e AUSL compiute attraverso la programmazione di Area Vasta con rete ospedaliera integrata sui contesti più ampi, hanno permesso la valorizzazione del territorio, economia di scala sui diversi processi e governo regionale delle tecnologie. In tale assetto organizzativo, il SSRT non poteva che non focalizzare la questione sulla centralizzazione degli acquisti e non solo. Con L.R. 26/2014 è stato istituito ESTAR (Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale) per l’esercizio, mediante dipartimenti di livello regionale, delle funzioni tecniche, amministrative delle Aziende Sanitarie, degli Enti del SSR e delle SdS. E’ competente in materia di approvvigionamento di beni e servizi - magazzini e logistica distributiva - tecnologie dell’informazione e della comunicazione - tecnologie sanitarie- procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale- processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al SSR. La sua mission è l’ottimizzazione della spesa pubblica regionale mediante la gestione centralizzata e standardizzata delle funzioni delegate, applicando la programmazione regionale e partecipando alle strategie aziendali relative alle tecnologie con l’obiettivo di erogare prestazioni di qualità. ESTAR opera quale Centrale di Committenza per conto delle Aziende Sanitarie della Regione, ed è il soggetto avvalso per gli appalti sanitari del Soggetto Aggregatore della Regione Toscana. Ma il suo punto di forza è che ESTAR non è solo una Centrale Acquisti ma è anch’esso un Ente che fa parte del SSRT, del quale condivide l’obiettivo finale ovvero offrire ai cittadini prestazioni e servizi di qualità. App Toscana Salute: Nell’ offerta sanitaria la RT introdotto l’App Toscana Salute che consente al cittadino di accedere a vari servizi di sanità digitale (ca 30). L’App si scarica da Apple store o da Play store e si utilizza con lo SPID. Ad oggi è stata scaricata da ca un milione di cittadini e ca 5.360.000 sono stati gli accessi al FSE, 240.170 le prenotazioni Cup, 185.450 le televisite, 745.170 le prenotazioni di prelievi con zero code, 63.630.000 le ricette elettroniche inviate. Campagna vaccinale: A fine dicembre 2020 è stata avviata la campagna vaccinale contro il COVID-19, dando priorità agli operatori sanitari al fine di mantenere in piedi il sistema e ai fragili e agli anziani, per cercare di abbassare fin da subito il rischio di ricovero e decesso nella popolazione generale. Per tutto il 2021 l’epidemia non si è mai arrestata e, con l’avvento della variante Omicron, si sono registrati un numero di contagi mai raggiunto prima. Nel periodo preso in considerazione (gen.2021–gen.2022) rispetto agli eventi attesi, si sono osservate riduzioni di circa il 53% dei contagi, il 69% delle ospedalizzazioni, il 71% dei ricoveri in terapia intensiva, il 79% dei decessi. Senza i vaccini, l’impatto di questi contagi sui servizi ospedalieri e sulla salute delle persone sarebbe stato decisamente superiore e non sarebbe stato possibile affrontare quelle fasi, e quella in cui ancora oggi ci troviamo, senza introdurre limitazioni più stringenti alle attività.
Il Caso Veneto: Il SSR si basa su quattro principi fondamentali: universalità delle prestazioni, equità, umanizzazione dell’assistenza socio-sanitaria, integrazione socio-sanitaria.
Il PSSR 2019-2023 definisce un modello “Hub and Spoke” sviluppato in coerenza con quanto previsto dal DM 70/2015. Le tipologie di strutture previste sono: 5 Ospedali Hub con bacino di popolazione di circa 1 milione di abi-
37
VIII corso di formazione FARE
tanti - 2 Ospedali di rilievo provinciale - 2 Hub di rilievo regionale - L’Istituto Oncologico Veneto Hub di rifermento per la patologia oncologica - Ospedali presidi di rete SpokeOspedali nodi di rete e strutture integrative di rete - Strutture private accreditate. Il 25 ottobre 2016 è stata emanata la legge regionale n.19 che ha riformato il SSR istituendo la Centrale di Committenza regionale nota come Azienda Zero. Obiettivo di tale intervento è la razionalizzazione delle risorse e la contestuale efficace ed efficiente erogazione delle prestazioni sanitarie. La Regione Veneto ha inoltre operato il trasferimento ad Azienda Zero della Centrale Regionale Acquisti per tutta la Regione (CRAV) divenuto soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 comma 1, del decreto legge n.66 del 2014, convertito con legge del 23 giugno 2014 n. 89, inserito nell’elenco ANAC dei soggetti aggregatori con delibera Anac 784/2016. La legge regionale n. 19/2016 oltre alla riorganizzazione territoriale delle aziende sanitarie ha affidato ad Azienda Zero la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale. Azienda Zero provvede dunque ad erogare mensilmente le risorse finanziarie alle aziende sanitarie. I canali di finanziamento sono i seguenti: quota capitaria pesata - finanziamenti a funzioni - dotazioni e costi standard. Il modello di riparto delle risorse deve ricomprendere anche i criteri per l’assegnazione delle risorse pe l’erogazione dei LEA. Inoltre una peculiarità del Sistema regionale Veneto è il supporto dato dalla CRITE (Commissione Regionale per l’Investimento, Tecnologia e Edilizia). Questo organo di fondamentale importanza supporta la Giunta regionale nella funzione di definizione e realizzazione degli obiettivi di governo e di amministrazione (art. 54 comma 1 dello Statuto Regionale). Grande importanza assume il parere rilasciato da questo organo all’indizione delle gare. Infine uno sguardo alla gestione dell’emergenza sanitaria ha fatto emergere una debole collaborazione fra Governo e Regioni. La disciplina statale avrebbe potuto lasciare alle Regioni maggiori possibilità di intervento, sia in ragione delle loro competenze in materia sanitaria sia per la differente diffusione del virus sul territorio regionale in un quadro unitario. Soprattutto nelle situazioni di emergenza il modello di separazione delle competenze non è funzionale essendo necessaria un’azione coordinata tra gli enti, al fine di adottare soluzioni più efficaci, in grado di conciliare l’esigenza di decisioni accentrate che però tengano conto delle esigenze territoriali.
Il Caso Puglia: a causa della diffusione del virus COVID-19, in Puglia è stato necessario un ripensamento dell’assistenza sanitaria ed ospedaliera, partendo dalla riconversione di alcuni ospedali per la gestione dei pazienti affetti da Covid-19, dovuta alla cronica carenza di posti letto nella regione Puglia, dopo circa 10 anni “soggetta” al Piano di Rientro della spesa sanitaria. Determinante nella gestione pandemica è stato il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione e della Telemedicina, una dimensione polivalente dell’assistenza sanitaria – ospedaliera, territoriale e integrata – con un aumento delle funzioni classiche dell’emergenza - urgenza e 118 sino alla funzione dell’Ospedale dedicato alle Maxi Emergenze ubicato presso la Fiera del Levante di Bari. Il Caso Lombardia: Le cure primarie sono la porta di accesso, il primo contatto delle persone, della famiglia e della comunità con il Servizio Sanitario. Le cure primarie rappresentano una vera e propria area-sistema dotata di caratteristiche peculiari e molto diverse da quelle, altrettanto tipiche, dell’assistenza ospedaliera. Nel 2020, la rete territoriale delle cure primarie facenti capo all’ATS di Milano, era composta da 400 Pediatri di Libera Scelta (PLS) e 2.089 Medici di Medicina Generale (MMG). Di questi ultimi solo 1.954 sono titolari, 122 sono medici in formazione e quindi con massimale ridotto e 107 gli incaricati provvisori. L’insieme è così ripartito nei territori:
Distretto
MMG PLS Milano città 828 133
Nord Milano 157 31 Rhodense 291 61
Ovest Milanese 280 56
Melegnano e Martesana 389 86
Lodi 144 33
Totale 2.089 400
La DGR 3478/2020 della Medicina Generale ha introdotto nell’organizzazione territoriale delle cure primarie, come misura di contrasto alla pandemia da covid19, l’individuazione di modalità di condivisione delle informazioni e degli strumenti fra MMG appartenenti a territori omogenei. Sono stati a tal fine costituiti 62 Centri di Riferimento Territoriale (CRT), che raggruppano tutti i MMG secondo una logica territoriale, con l’intento di favorirne il coinvolgimento attraverso un approccio omogeneo delle attività comuni che sono proprie della medicina.
38
VIII corso di formazione FARE
Azioni strutturali
Nel 2021 come per il 2020, l’attività delle ATS e delle ASST è stata indirizzata in maniera prioritaria alla gestione della pandemia Covid-19. Sin dall’inizio dell’emergenza le ATS hanno progressivamente potenziato le funzioni e i servizi maggiormente coinvolti nella gestione della pandemia. Tutti i servizi aziendali e le diverse funzioni - nel rispetto delle indicazioni emanate da Regione Lombardia, Istituto Superiore di Sanità, Protezione Civile, Ministero della Salute e Governo – sono stati rimodulati in base all’evoluzione delle esigenze generate dalla diffusione del COVID-19.
Azioni organizzative
Relativamente alla gestione della pandemia l’attività delle ATS si è caratterizzata in tutte le linee di intervento per quanto di competenza e nel rispetto delle indicazioni regionali e nazionali fra cui: controllo andamento epidemiologico; gestione delle segnalazioni, dei casi sospetti e accertati; attività di tracciamento e sorveglianza, rapporto con le strutture per l’erogazione delle prestazioni diagnostiche, di ricovero e cura, assistenziali, di sorveglianza; rapporto con le Cure Primarie; organizzazione campagna vaccinale e implementazione delle iniziative territoriali di cui al Piano Territoriale approvato negli ultimi mesi del 2020. In particolare la campagna di vaccinazione per le diverse categorie della popolazione secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Struttura Commissariale Nazionale e da Regione Lombardia ha costituito un ambito di estrema rilevanza e di grande impatto sulle attività dell’Agenzia. Altro elemento di particolare significatività che ha caratterizzato l’affronto della pandemia è stato il lavoro svolto in collaborazione con altre Istituzioni per consentire una ripresa dell’attività scolastica ad inizio d’anno e per approntare un monitoraggio costante della situazione specifica del mondo scuola fino al periodo delle vacanze estive. L’assetto federale in sanità presenta dei punti di forza, ma anche delle criticità che costituiscono aree di miglioramento. I punti di forza del federalismo convergono verso la identificazione di questo come strumento di efficientamento delle istituzioni:
1. La flessibilità: i governi regionali possono adottare soluzioni più rispondenti alle specificità locali. Possono garantire risposte più adeguate e coerenti alle differenti esigenze territoriali, perché diverse sono le caratteristiche demografiche, epidemiologiche e le connesse condizioni di salute della popolazione nelle diverse realtà regionali
2. La responsabilizzazione locale e la razionalizzazione della spesa: il sistema sanitario federale è funzionale alla gestione orientata all’efficacia ed efficienza nell’impiego delle risorse pubbliche disponibili, in quanto consente di responsabilizzare gli amministratori e decision maker regionali e locali, che rispondono delle loro decisioni nei confronti dei cittadini elettori, per cui sono stimolati ad assumere comportamenti più responsabili sia sul versante delle entrate fiscali sia quello della spesa sanitaria
3. Livelli di prestazioni ulteriori rispetto ai LEA: le Regioni, nell’esercizio della loro autonomia funzionale, gestionale, organizzativa, amministrativa e finanziaria, possono decidere di erogare livelli di prestazioni ulteriori rispetto ai LEA con risorse a carico del bilancio regionale, che costituisce un’opportunità in più per i cittadini
4. Funzionale agli acquisti centralizzati di beni e servizi: questo consente di realizzare delle economie di scala che derivano dall’aggregazione della domanda e il risparmio di energie procedimentali
5. Limita la concentrazione del potere, riduce il rischio di errore, sviluppa soluzioni virtuose: il sistema sanitario federale ha una pluralità di centri decisionali, questo assetto tende a limitare la concentrazione del potere e riduce il rischio di errore, nel senso che in territori più piccoli diviene più semplice rimediare agli errori decisionali eventualmente commessi. In questa prospettiva possiamo considerare il federalismo del SSN come un assetto di governance, atto a sperimentare soluzioni organizzative diverse nei vari territori regionali, utile per esportare in altre Regioni soluzioni rivelatesi virtuose (c.d. best practice).
Le criticità del sistema sanitario federale sono riscontrabili nelle grandi differenziazioni nel soddisfacimento dei bisogni e del diritto alla Salute: i cittadini residenti in Regioni diverse non possono contare, a fronte di analoghe esigenze (es: problemi oncologici, di diabete o di assistenza protesica) su una capacità di risposta e di presa in carico simile. Indicatori significativi di queste differenziazioni territoriali sono: 1. spesa pro-capite regionale: La spesa media nazionale è di € 1.866 (anno riferimento 2017). In Regioni come Lombardia, Veneto, Emila-Romagna è superiore a € 1.900 pro-capite, mentre in alcune Regioni meridionali è di poco superiore a € 1700 (precisamente € 1.723 in Campania ed € 1.748 in Calabria). Queste differenze non sono dovute al fatto che al Sud ci sia un minor bisogno di salute ma derivano dal sistema di finanziamento, che assicura un livello di finanziamento superiore alle Regioni economicamente più sviluppate. Notoriamente i sistemi regionali al Nord hanno una gestione razionale delle risorse pubbliche, dunque, la loro maggiore spesa pro-capite si traduce inevitabilmente nella erogazione di un maggior livello qualitativo e quantitativo di prestazioni sanitarie.
39
corso di formazione FARE
2. erogazione dei LEA: Il monitoraggio dei Lea fotografa un Pese che marcia (almeno) a tre velocità.
Regioni di prima fascia: garantiscono un più elevato livello di adempimento nell’erogazione LEA: Veneto, Emilia Romagna Toscana, Piemonte, Lombardia e Liguria
Regioni di seconda fascia: hanno raggiunto un punteggio intermedio; si tratta prevalentemente di Regioni del Centro Italia: Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Basilicata
Regioni di terza fascia: hanno il più basso livello di adempimento LEA, a stento raggiungono la sufficienza (punteggio sufficiente 160), quali Campania, Calabria e Molise. In particolare Calabria e Campania nell’anno 2018 hanno per la prima volta raggiunto la sufficienza, dopo anni di inadempimento nella erogazione del nucleo essenziale di prestazioni.
3. mobilità sanitaria: la disomogeneità tra le aree del Paese in termini di qualità dell’assistenza sanitaria produce il fenomeno della mobilità sanitaria interregionale. I pazienti spesso si rivolgono alle strutture sanitarie del Nord, ove i sistemi di sanità pubblica sono qualitativamente superiori, per cui le Regioni meridionali presentano una mobilità passiva superiore a quella attiva.
4. screening oncologici: i dati rilevati con riferimento ai tre principali programmi di screening, mammella, cervice uterina e colorettale, rilevano notevoli differenze tra le Regioni. In generale, al Sud si registra una più bassa percentuale di copertura della popolazione.
5. tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie: Il “tallone di Achille” di molti SSR sono i tempi di attesa per i ricoveri ospedalieri e per le prestazioni diagnostiche e specialistiche, che delineano sempre più una situazione in cui il cittadino deve scegliere tra accedere alle prestazioni sanitarie pubbliche (gratuite e con pagamento del ticket) aspettando tempi molto lunghi, oppure pagare per ridurre o azzerare l’attesa rivolgendosi alla Sanità privata o alle prestazioni intramoenia.
Conclusioni
Il Gruppo di Lavoro ha preso in considerazione la genesi del nostro SSN, il Federalismo sanitario ed il suo sviluppo a più di vent’anni dalla nascita, i suoi valori declinati ed applicati con successo e non, così come - attraverso una rapida carrellata – tratteggiato le sue peculiarità con testimonianze di quattro ambiti regionali anche alla luce dell’esperienza Covid-19.
Quello che è emerso è la sostanziale impreparazione riscontrata in diverse Regioni nell’affrontare il tema cruciale della ‘gestione federalistica’, per recepirne in modo efficace e strutturale le sue sfide, sinteticamente riconducibili alla gestione della ‘res publica’ finanziaria e sanitaria. Un’efficace applicazione del Federalismo in ambito sanitario, in questo senso, avrebbe dovuto rappresentare un punto di arrivo di un cammino compiuto dopo un percorso virtuoso nelle differenti componenti gestionali (sociale, sanitaria, economico-finanziaria, infrastrutturale e politica) di ogni Regione. Nella realtà, al momento della sua nascita, il Federalismo non ha visto tutte le Regioni allineate e pronte a questo importante cambiamento; la sua validazione - per effetto della riforma del Titolo V della Costituzione – è giunta in un quadro di competenze, disponibilità di dati, livelli di programmazione e pianificazione in materia sanitaria diversi tra le Regioni. La crescente domanda di salute e l’offerta di produzione sanitaria a livello regionale pongono i cittadini/pazienti nelle condizioni di poter scegliere (nella maggioranza dei casi) a quale struttura fare riferimento, in quale Regione andare, creando una migrazione sanitaria ed una conseguente asimmetria nell’erogazione delle prestazioni cliniche tra le Regioni. La Sanità pubblica, attraverso la rete dei suoi ospedali e delle strutture assimilabili, compie quotidianamente una grande opera di prevenzione, cura, riabilitazione, assistenza verso tutta la popolazione che ne fa richiesta. In questo senso è utile ricordare la necessità che le strutture pubbliche hanno di assicurare i LEA, attraverso un equo, efficiente ed appropriato impiego delle risorse disponibili. Ed è proprio sul tema delle risorse (e del loro impiego) che si concentra un punto vitale del Federalismo; i vari modelli adottati di ripartizione del FSN fino ad oggi non si sono rilevati perfetti, creando continue divergenze tra le Regioni che attingono principalmente a questi importi per la gestione sanitaria ordinaria e corrente. Abbiamo visto come anche nella gestione della pandemia, ci siano state modalità e tempi di attuazione differenti tra le Regioni, cosa che ha costretto il Governo ed il Ministero della Salute ad intervenire ripetutamente per assicurare - a livello nazionale - un’uniformità di interventi e decisioni fondamentali per il contrasto alla diffusione del virus. Da quanto emerso, non è possibile rispondere alla domanda se il Federalismo sia stato un bene o un male per la Sanità. Esistono certamente margini di miglioramento, ovunque. Poiché risulta impensabile modificare la Costituzione un’altra volta su questo tema, è ragionevole proseguire, con maggiore determinazione e disciplina, a lavorare su tutte le c.d. ‘aree grigie’’ che queste gestioni - sia regionali sia territoriali - hanno portato all’evidenza dell’attenzione pubblica. Il bisogno sanitario di ogni persona resta l’obiettivo principale da raggiungere e soddisfare, perché si possa affermare di vivere nella conoscenza scientifica ed in un Paese quale l’Italia si merita.
40 VIII
Il settore acquisti in Sanitá: stato dell’arte e scenari futuri
Gruppo di lavoro:
Francesca Bosini
I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo”, Pavia
Rossana Indiveri Azienda Sanitaria Locale, Lecce
Giuseppe Licata Azienda Ospedaliera-Universitaria “Maggiore della Carità”, Novara
Alessandra Micciché
Azienda Sanitaria Provinciale, Ragusa
Domenico Paolo Nitrato Izzo Azienda di Servizi alla Persona, Pavia
Vincenza Piccione Azienda Sanitaria Provinciale, Ragusa Manuela Ronconi Fondazione CNAO, Pavia
Marco Sirica Azienda Ospedaliera-Universitaria “Maggiore della Carità”, Novara
CAPITOLO PRIMO L’acquisto di beni e servizi tra passato e presente
La figura del Provveditore nasce nel 1968 con la legge istitutiva degli Enti Ospedalieri, che codifica le categorie professionali di Provveditori ed Economi. La funzione annovera “la predisposizione degli atti riguardanti ogni acquisto e fornitura, la proposta di capitolati di appalto, la cura della regolare esecuzione dei contratti, le provviste in economia, il riscontro delle fatture e il successivo inoltro per la liquidazione”; in altre parole, le attività oggi identificate con il Provveditore. Dieci anni dopo, in seguito anche all’indebolimento della figura del Provveditore a causa della legge di riforma sanitaria, che lo vede come soggetto poco professionalizzato, il panorama legislativo risulta frammentario e stratificato, generando difficoltà interpretative ed applicative. La legge Merloni opera in questo senso, riordinando il quadro normativo e ponendosi come fonte di carattere generale, disponendo che eventuali “deroghe, modifiche o abrogazioni” delle norme in essa contenute possano essere disposte soltanto “per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni” della legge stessa. In seguito al recepimento della direttiva dell’Unione Europea 2004/18/CE, che riunisce le procedure per gli appalti, il Codice De Lise (D.Lgs. 163/2006) abroga definitivamente la Legge Merloni, raccogliendo per la prima volta tutte le leggi sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, portando a termine una vera e propria revisione del quadro normativo, raccogliendo in un unico testo tutte le leggi emanate in materia, dall’Unità d’Italia al 2006. Il nuovo codice degli appalti è stato emanato in attuazione di tre direttive europee, in risposta all’esigenza di semplificare le procedure, incrementare l’efficienza del sistema e garantirne la trasparenza. Rispetto alla precedente disciplina, è incentrato sullo snellimento delle procedure e sull’adozione di alcuni correttivi. Uno dei principali problemi che si è cercato di risolvere è l’incremento dei costi in cui si sono spesso imbattute le stazioni appaltanti, ma anche ulteriori obiettivi d’innovazione, sostenibilità ambientale, accessibilità degli appalti alle piccole e medie imprese e agli operatori dell’intero mercato europeo. Esso mette a punto un “sistema di qualificazione”, gestito da ANAC, delle stazioni appaltanti, che comporta processi di aggregazione tra le stesse, con l’obiettivo di ridurne il numero, ottenendo efficientamento e professionalizzazione del public procurement. La necessità della qualificazione appare intesa come problema non inerente esclusivamente a questi organismi, ma da ricondurre a criticità di fondo della situazione odierna della p.a., dove carenze organizzative e carenze di professionalità non solo producono gravi inefficienze e sprechi, ma anche un indebolimento della capacità di fronteggiare fenomeni corruttivi e criminali. Il nuovo Codice attribuisce all’ANAC il compito di definire una disciplina di maggiore dettaglio sugli ulteriori requisiti di professionalità: si richiede una specifica esperienza professionale e un’adeguata formazione finalizzata all’acquisizione di competenze in materia di project management per chi esercita il ruolo di RUP. L’ANAC caratterizza in dettaglio compiti specifici e requisiti di professionalità del RUP-Project Manager, chiamato ad operare secondo consolidati standard di conoscenza nazionali ed internazionali. Pur non intervenendo nella materiale esecuzione delle attività, al RUP compete un ruolo di coordinamento e verifica sul corretto operato e sul rispetto delle funzioni affidate ai propri collaboratori.
CAPITOLO SECONDO L’evoluzione della funzione di public procurement Riflettere sul futuro del Provveditorato equivale a prospettare un’innovazione del SSN. Il public procurement e i suoi modelli di funzionamento rappresentano il sistema di acquisti pubblici, il punto cardine intorno al quale ruota l’intero SSN e la salute dei cittadini. Gli strumenti del cambiamento degli ultimi anni sono rappresentati da: centralizzazione dei processi di acquisto: centrali di committenza nazionali e regionali e promozione di consorzi per gli acquisti di area vasta sovra-aziendale, ampliando i bacini di riferimento; standardizzazione: introduzione prezzi e contratti standard; digitalizzazione: adozione e implementazione di strumenti di e-procurement.
41 VIII corso di formazione FARE
Tutor: Maria Grazia Colombo
VIII corso di formazione FARE
Le modalità di centralizzazione degli acquisti si inseriscono nel sistema di aggregazione della domanda pubblica, risultato di una stratificazione normativa avviata col sistema Consip. La centralizzazione, consente alle amministrazioni di beneficiare di economie di scala, ridurre gli intermediari, ottenere a prezzi più bassi e, riducendo le procedure, diminuiscono anche le spese. L’aggregazione degli acquisti contribuisce all’aumento della concorrenza che dovrebbe aiutare a professionalizzare la commessa pubblica. I soggetti aggregatori rientrano tra le centrali di committenza: questo modello operativo mira a gestire l’intero processo di procurement mediante la raccolta del fabbisogno dell’amministrazione di riferimento, la programmazione delle iniziative di acquisto e l’esecuzione delle procedure di approvvigionamento. Alle AS si impone di spendere meglio e ciò vuol dire fornire beni e servizi che permettano di garantire i più alti standard qualitativi (uguali su tutto il territorio, anche se esistono realtà ben diverse) e di mantenere inalterati i livelli di servizio della sanità pubblica. La centralizzazione degli acquisti da sola non produce risparmi: se manca un processo adeguato di analisi dei fabbisogni e di traduzione degli stessi in documenti di gara, il rischio è di generare maggiori costi e iniquità. Standardizzare non deve essere l’obiettivo, ma la conseguenza di una analisi dei fabbisogni. L’eccessiva standardizzazione in un contesto istituzionale in cui il controllo della spesa è inteso come riduzione dei prezzi di acquisto può deprimere il mercato e la sua capacità di innovazione.
La centralizzazione ha portato alla costituzione di soggetti specializzati a livello regionale. Analizziamo qui di seguito i diversi modelli:
- Modello lombardo. A.R.I.A. S.p.A. è l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Lombardia e opera in tema di “public procurement” ed “e-procurement” rinforzando gli obiettivi regionali per l’ottimizzazione e l’innovazione della spesa pubblica regionale. A.R.I.A. fornisce alla Regione Lombardia, agli Enti del Sistema Regionale, agli Enti del Servizio Sanitario Regionale e ad altre Pubbliche Amministrazioni il supporto e gli strumenti per migliorare l’efficienza delle attività di gara e per ridurre costi e tempi connessi alle procedure di selezione dei fornitori. Ultimamente, A.R.I.A. si sta muovendo verso l’utilizzo di sistemi dinamici di acquisizione (SDA).
- Esperienza piemontese. Con la L.R. n. 19/2007, la Regione Piemonte ha istituito la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR), società di capitali interamente partecipata dall’amministrazione regionale. SCR è stata costituita quale centrale di committenza, il cui scopo è la razionalizzazione della spesa pubblica e l’ottimizzazione delle procedure di gara, con riguardo ai settori di infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità.
- Aggregazioni e centralizzazioni in Puglia La Regione Puglia ha recentemente disciplinato con fonte legislativa il proprio sistema centralizzato di acquisti. Con L.R. n. 37/2014 ha designato la propria Società in house, Innovapuglia S.p.A. quale Soggetto Aggregatore regionale. Il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (SArPULIA), nella sua qualità di centrale di committenza e di centrale acquisto territoriale, promuove e sviluppa il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale e in particolare: presidia la spesa sostenuta dagli Enti del SSR, espleta gare aggregate per il SSR e per beni e servizi informatici nonché su delega per gli Enti locali, sviluppa e gestisce gli strumenti informatici di e-procurement e la piattaforma EmPULIA per lo svolgimento delle procedure di gara telematiche.
- Il sistema degli approvvigionamenti in Sicilia. Il modello di centralizzazione degli acquisti adottato si inserisce in un profondo disegno di rinnovamento del sistema sanitario regionale, che ha portato alla riduzione del numero di aziende sanitarie (da 29 a 17), suddivise in due Bacini (Occidentale ed Orientale), attraverso un processo di accorpamento e fusione. La Centrale Unica di Committenza, che ha assunto il ruolo di Soggetto Aggregatore, provvede agli acquisti oltre che per i diversi rami dell’Amministrazione regionale anche per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale. Storicamente, la Governance e la Mission prevalente del S.S.N. sono state caratterizzate da profondi processi di trasformazione, che hanno generato fasi di circa 7-10 anni, durante le quali le configurazioni e gli obiettivi di fondo venivano concettualizzati e rappresentati come stabili. Il COVID invece ha determinato, in controtendenza, il susseguirsi di almeno quattro “epoche” di policy, di mission e di cultura istituzionale in soli due anni (2020- 2021). Alcune di queste fasi si sono in parte sovrapposte e contaminate reciprocamente, richiedendo al Management di co-gestire logiche istituzionali e priorità di policy contrapposte tra di loro, trasformando il S.S.N. in un sistema “mission e data driven” seppur con un unico obiettivo: la cura, il monitoraggio e la prevenzione del contagio. La spesa sanitaria nel 2020, trascinata dai massicci stanziamenti emergenziali, è cresciuta di oltre 6 miliardi rispetto al 2019 (+5%). Nel corso dei primi mesi dell’emergenza, il limite all’acquisizione delle risorse umane e materiali era rappresentato dalla carenza delle medesime o dalle procedure di acquisizione, benché meno stringenti rispetto al passato. Si prende atto di come i sistemi regionali o aziendali culturalmente più abituati a navigare velocemente attraverso le procedure amministrative, hanno avuto maggiore accesso a fattori produttivi aggiuntivi finanziati dagli straordinari stanziamenti. La progressiva trasformazione poi del COVID, da emergenza in situazione endemica sufficientemente controllata, ha condotto poi alla terza epoca. In pieno svolgimento invece è la quarta epoca, caratterizzata dall’attività di costruzione del portafoglio di progetti finanziabili con il Piano Nazionale di Ripresa e
42
VIII corso di formazione FARE
Resilienza e riguardanti un ampio insieme di ambiti, dall’ospedale, al territorio, alla ricerca e allo stesso tempo di fattori produttivi aziendali, quali edifici, apparecchiature, sistemi informativi e tecnologie.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. Il nuovo D.L. Semplificazioni, rispetto ai precedenti interventi, ha un “motore” aggiuntivo, poiché si inserisce nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal nostro Paese alla Commissione Europea. In particolare, il PNRR italiano, a sua volta, si inquadra nel programma comunitario Next Generation EU (NGEU), ossia il pacchetto da complessivi 750 miliardi di Euro varato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica, nell’ambito del quale l’Italia, ha potuto beneficiare della quota più alta, pari a 191,5 Mld di Euro rappresentati dal c.d. Recovery Fund, cui si aggiungono i 30,6 Mld del Fondo complementare, quest’ultimo coperto con scostamento di bilancio. L’intervento, prefigurato dall’U.E. e concretizzato dal nostro PNRR nazionale, intende porre rimedio ai danni economici e sociali causati della crisi pandemica e, allo stesso tempo contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana, indirizzando il Paese verso un percorso di transizione ecologica e ambientale all’insegna della competitività, della formazione e dell’inclusione sociale, territoriale e di genere. Per quanto concerne in maniera specifica alle disposizioni in materia di appalti pubblici recate dal nuovo D.L. Semplificazioni, si evidenzia che, lo stesso interviene, sotto taluni aspetti in maniera significativa, sia su quelli specificamente legati alla realizzazione del PNRR, che sui contratti pubblici in generale. Questo “doppio binario” parrebbe rappresentare un primo elemento di difficoltà che incontra l’interprete nell’inquadramento della nuova normativa
CAPITOLO TERZO Ridefinizione di ruoli e spazi di manovra
Qual è dunque la prospettiva della nostra professione? Quali sono le linee di sviluppo future, quali le strade che ancora non sono state del tutto aperte nell’operare quotidiano del nostro lavoro? Dove e come riscoprire le motivazioni e le convinzioni che ci spingono a svolgere il delicato mestiere del Provveditore pubblico?
L’acquisizione di uno sguardo d’insieme è senz’altro un passo importante; assumere una prospettiva non meramente “legalitaria” e “difensiva” (ancora largamente prevalente) ma manageriale, che scende al livello concreto della conoscenza profonda della gestione dei processi, con tutto ciò che questo comporta.
La risposta vincente sembra consistere in un approccio multidisciplinare, basato sul confronto dialettico tra professionalità complesse e strutturate che si riconoscono e si rispettano, un approccio che si ponga come obiettivo la conoscenza anche diretta dei processi di produzione dei servizi sanitari perché non si può pensare in modo manageriale e gestionale se non si considerano i fattori produttivi e i processi di produzione di cui si è attori coinvolti, se non si mettono a fuoco gli outcome (cioè i risultati) delle strutture sanitarie. Attenzione all’outcome vuol dire accendere i riflettori sull’appropriatezza, l’economicità, l’efficacia, la trasparenza e rispetto della legge. Conoscenza degli outcome vuol dire attenzione ai risultati e alla soddisfazione dei pazienti rispetto ai servizi erogati anche in termini di salute e di efficacia delle cure. In questo processo di aumento della conoscenza e di evoluzione dell’approccio del Provveditore si colloca l’orientamento al managing by walking around, una tecnica manageriale basata sulla conoscenza diretta e informale dei processi produttivi che ruota attorno ad un’idea non rigidamente gerarchizzata e settoriale ma basata sulla condivisione delle conoscenze e delle informazioni e su un accesso ad esse il più possibile diretto e informale quale può essere il dialogo diretto e destrutturato con gli attori coinvolti, allo scopo di comprenderne i punti di vista e le problematiche legate all’utilizzo dei beni acquisiti. Si tratta di un approccio nato negli Stati Uniti negli anni 70 e che oggi è utile riscoprire nella prospettiva che qui interessa: dare profondità e arricchire di contenuti il nostro lavoro ma soprattutto lanciare un messaggio alle nuove generazioni di Provveditori.
Le esigenze di professionalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni indurranno necessariamente un’evoluzione del ruolo del buyer pubblico che vedrà da una parte l’erosione del proprio ruolo nelle procedure di acquisto e dall’altra un’estensione delle competenze sulla corretta gestione dei contratti pubblici spesso colpevolmente abbandonata a sé stessa. Una maggior professionalizzazione riguarderà sia i profili giuridici, chiamati a conoscere ed applicare l’elefantiaca normativa di settore che i profili economici chiamati all’analisi dell’economia applicata al ciclo dell’appalto passando per una sempre più importante conoscenza tecnologica soprattutto nel corretto uso delle piattaforme telematiche. Nello specifico settore sanitario il buyer pubblico sarà chiamato ad un sempre maggior dialogo con le figure professionali della Sanità che spesso, per incapacità comunicativa, non riescono nel fondamentale dialogo necessario ad un corretto approvvigionamento di beni e servizi. La professionalizzazione e la qualificazione delle Stazioni Appaltanti rappresenta il più importante gap da colmare nella Pubblica Amministrazione italiana che dovrà inevitabilmente essere il motore della ripresa attraverso una gestione oculata delle risorse
43
VIII corso di formazione FARE
derivanti dal PNRR. La funzione del provveditorato dovrà evolversi verso il motore trainante dell’Azienda che non solo si occuperà della mera fase amministrativa ma che si ponga quale interlocutore dell’area medico sanitaria per il corretto soddisfacimento dei bisogni aziendali nonché della corretta gestione delle risorse economiche pubbliche. Una contaminazione, quella del provveditorato, necessaria al fine di ridurre per quanto possibile le asimmetrie informative contro le quali inevitabilmente si scontrano le Amministrazioni e che rendono gli operatori economici sempre maggiormente dominanti nel proprio mercato di riferimento.
La Pubblica Amministrazione italiana è chiamata ad una rivoluzione che permetta la determinazione di un curriculum formativo comune con standard minimi per accedere a livelli più alti della carriera, in cui le competenze da acquisire siano sempre più tecnico-gestionali al crescere delle responsabilità che si ottengono nella funzione acquisti dell’organizzazione. L’attività del Provveditore è caratterizzata da una fisiologica, inevitabile tensione verso l’esterno che, sovente, si è concretizzata in una qualificata interlocuzione con il mercato ed il mondo delle imprese private. L’interazione pubblico-privato, nelle sue varie declinazioni, ha consentito la realizzazione di progetti significativi: il Servizio Sanitario Nazionale, negli ultimi quindici anni, ha fatto ricorso alle partnership pubblico-privato al fine di rinnovare il proprio capitale infrastrutturale e tecnologico, realizzare o ammodernare strutture sanitarie più o meno complesse e gestirne alcuni servizi. Tuttavia l’utilizzo delle forme tradizionali di appalto pubblico ha, finora, rappresentato l’opzione prevalente per l’affidamento di opere e/o servizi. È dato registrare, infatti, una risalente e persistente diffidenza della Pubblica Amministrazione nei confronti del Partenariato Pubblico Privato. Tale parsimonioso ricorso al PPP è verosimilmente ascrivibile, in sanità, ad una eccessiva prudenza ed alla consapevolezza della delicatezza della mission istituzionale di ogni Ente del SSN - la gestione del bene salute - che amplifica la percezione dell’eventuale ricaduta negativa di scelte sbagliate o azzardate. Senonchè, forte di referenze storiche inconfutabili, dell’ancoraggio giuridico al principio costituzionale di sussidiarietà (art. 118 Cost., ultimo comma) e, soprattutto, forte di alcune sue peculiarità (tra tutte, il trasferimento del rischio in capo al soggetto privato), nell’attuale contesto storico ed economico l’istituto del PPP si avvia a rivestire un ruolo strategico per varie ragioni, tutte strettamente correlate tra loro e riconducibili ad un acronimo, attuale e frequentemente evocato: P.N.R.R. Il proficuo utilizzo dei finanziamenti messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza impone a settori che, come la sanità, vengono da una importante storia di contrazione della spesa, un repentino recupero di risorse, strumenti e coraggio per riempire di contenuti la sesta missione del P.N.R.R. e perseguire gli ambiziosi obiettivi ivi individuati: 1) il potenziamento dell’assistenza territoriale attraverso reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina, per un accesso equo e capillare alle cure; 2) la promozione dell’utilizzo di tecnologie nella medicina, mediante l’innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. È l’occasione per portare a compimento il processo di deospedalizzazione e di valorizzazione della medicina del territorio ed è il momento in cui, attraverso il PNRR, l’Italia si impegna a fare un significativo passo avanti nell’ambito della digitalizzazione dei servizi sanitari: l’attivazione delle Centrali operative territoriali (COT), il completamento e la diffusione del fascicolo sanitario elettronico, la telemedicina che, con la tele-assistenza, il tele-consulto, il tele-monitoraggio e la tele-refertazione, garantirà la fruizione dei servizi sanitari al paziente presso il proprio domicilio attraverso uno scambio di dati, immagini, documenti e videochiamate, tra pazienti e professionisti sanitari, sono opportunità preziose e sfide importanti per affrontare le quali le aziende sanitarie devono strutturarsi in fretta. Ai buyer della sanità si richiede, con perentoria cogenza, un set di competenze elevate e critiche, dopo una progressiva erosione del proprio ruolo ascrivibile alla centralizzazione degli acquisti, che ha modificato gli scenari e, per molte categorie merceologiche di beni e servizi, ha ridisegnato ruoli ed alvei di competenza dei diversi attori, attribuendo alle singole aziende del SSN la titolarità della sola fase di esecuzione del contratto di fornitura, all’esito dell’aggiudicazione di appalti condotti, nella loro interezza, dalle Centrali Uniche di Committenza o dai Soggetti aggregatori regionali. Ebbene, soccorre il privato: il coinvolgimento del mercato, attraverso il partenariato pubblico-privato e le sue diverse metodologie attuative, la cui disciplina è dettata dagli art. 180 e ss. del D. Lgs. 50/2016, può senza dubbio rappresentare l’inizio di una positiva traiettoria evolutiva del sistema, favorendo una maggiore efficienza nella realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi pubblici nonché generando importanti benefici derivanti, ad esempio, dalla fruizione del know how e dell’elevato livello di specializzazione del soggetto privato per ovviare alla perdita di capacità progettuale che paga ora la dimensione pubblica. Ma se il P.P.P. appare lo strumento più efficace per investire i fondi del PNRR, tuttavia l’expertise del privato non è sufficiente a garantire, da sola, il buon esito dei procedimenti. Occorre comunque un recupero di professionalizzazione delle stazioni appaltanti, imprescindibile per una scelta ponderata e la corretta gestione di strumenti contrattuali impegnativi come quelli del partenariato pubblico privato. In tempi che non concedono esitazioni ed impongono scelte veloci e coraggiose, il buyer pubblico deve recuperare un ruolo decisivo, facendo un efficace uso del quadro normativo vigente e sfruttando le opportunità offerte dal partenariato pubblico privato anche per progettualità che esulano dal perimetro di copertura finanziaria del P.N.R.R.
44
Monica Piovi e Piero Fidanza
L’avvalimento del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio
Un nostro lettore chiede di sapere se il requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio possa essere prestato tramite l’avvalimento di cui all’art. 89 del codice dei contratti
Ènoto che la Stazione Appaltante possa richiedere al concorrente, tra i requisiti necessari per la partecipazione in gara, la previa iscrizione alla Camera di Commercio.
Trattasi di un requisito già previsto nel regime previgente, all’art. 39, c. 1, del D. Lgs. 163/2006 e collocato tra i requisiti idonei a dimostrare la capacità tecnica e professionale dell’impresa, il quale è assurto, nell’impianto del nuovo Codice dei contratti pubblici con la previsione di cui all’art. 83, c.1, lett. a del D. Lgs. n. 50/2016, a requisito di idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara.
La sua funzione risiede infatti nella garanzia, per la Stazione Appaltante, di selezionare un’impresa che abbia realmente un’esperienza specifica nel settore interessato dall’appalto, dimostrando il concreto ed effettivo svolgimento “di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 18/01/2021, n. 508).
Detto altrimenti, e come più volte chiarito dalla giurisprudenza, l’utilità sostanziale dell’iscrizione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico, poiché l’individuazione ontologica della tipologia d’azienda, al di là dell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo o nello statuto societario, può avvenire solo attraverso l’attività, principale o prevalente, che sia in concreto espletata (laddove si tratti di impresa operativa da tempo) e/o comunque documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio.
Compresa, quindi, la funzione sottesa al requisito in parola, ne consegue l’esclusione della possibilità per i concorrenti di ricorrere all’istituto dell’avvalimento disciplinato all’art. 89 del D.lgs. 50/2016.
Quest’ultimo, infatti, si applica ai soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. b) e c), D. Lgs. 50/2016 (cfr Consiglio di Stato, sez. V,16/11/2020, n. 7037) e non anche ai requisiti di idoneità professionale, i quali costituiscono requisiti strettamente personali, come tali intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l’Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, 5/11/2012, n. 5595).
Orbene, al pari degli altri requisiti di idoneità professionale, quali ad esempio le iscrizioni ad albi professionali, anche l’iscrizione alla Camera di Commercio deve necessariamente essere posseduta direttamente dal concorrente, essendo relativo alla sua soggettiva idoneità (professionale) a contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’impresa partecipante non può senz’altro avvalersi del requisito posseduto da un soggetto terzo venendo meno, altrimenti, quella imprescindibile e necessaria garanzia di idoneità professionale dell’aspirante concorrente di essere dotata di una specifica organizzazione aziendale, e di una conoscenza necessaria per consentire il corretto espletamento di attività oggetto di affidamento. Quanto sinora dedotto è stato, peraltro, recentemente richiamato anche dal Consiglio di Stato, sez. VI, 26/8/2022 n. 7482, il quale, dopo aver ricordato la funzione intrinseca del requisito, ha categoricamente escluso che per assolvere alla richiesta di iscrizione al registro delle imprese possa essere fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento.
45 gli esperti rispondono
L’importanza della scelta d’acquisto per ottimizzare la rilevazione della traccia elettrocardiografica contenendone i costi
Numerosi fattori incidono sui dati acquisiti tramite ECG, riflettendosi poi su come questi dati vengono utilizzati nelle decisioni diagnostiche e terapeutiche. Frequentemente l’acquisizione dei dati non corretta, coincidente con la rappresentazione di artefatti in un ECG, viene ricondotta solamente allo scarso segnale derivante dall’elettrodo. Nella realtà la qualità dell’elettrodo è di fondamentale importanza per l’acquisizione del dato e deve essere tenuta in considerazione ma anche altri fattori possono inficiare il risultato dell’esame ed erroneamente vengono attribuiti ad esso.


Svolgimento esame ECG: l’importanza della preparazione del paziente
L’acquisizione dell’attività elettrica del cuore tramite gli elettrodi è influenzata dal fatto che la pelle può non essere un conduttore elettrico ideale; pertanto, una buona preparazione è indispensabile e deve prevedere rimozione di eventuali peli, lozioni oli, polveri e asciugatura della cute. L’abrasione della pelle non è consigliabile in quanto potrebbe esacerbare allergie. Se si dedica qualche istante in più alla preparazione del paziente è possibile ottenere una maggiore qualità dei risultati già dal primo esame. Una buona preparazione del paziente garantisce una standardizzazione e coerenza dell’ECG indipendentemente dalla struttura e dal reparto in cui viene effettuato.
Dispositivo di acquisizione del segnale: l’importanza dell’elettrodo ECG
Focalizzandoci sull’elettrodo stesso al fine della riuscita acquisizione della traccia ECG è necessario che questo sia di qualità per ottenere in primis una traccia stabile senza artefatti ottimizzando i tempi di esecuzione dell’esame e la refertazione della traccia elettrocardiografica.
Le peculiarità positive del dispositivo sono direttamente proporzionali al risparmio di tempo nell’esecuzione dell’esame come, ad esempio, avviene in caso di facilità applicazione, adesività dell’elettrodo e capacità di conduzione ottimale in situazioni disomogenee. Ulteriore risparmio sulla variabile tempo si ottiene dal confezionamento (es. blister da dieci pezzi) dalla forma, dalla tipologia e sede del connettore.
Nella nostra realtà (Ospedale di Bolzano) con 70.000 esami ECG anno si stima che la perdita di un solo minuto a prestazione corrisponda a circa 1200 ore/professionista anno, equiparabile all’assunzione di una persona a tempo pieno.
Una tempistica corretta riduce il senso di frustrazione dell’equipe medico/infermieristica nell’esecuzione dell’esame e si traduce inevitabilmente nell’abbattimento delle liste d’attesa. Migliora, inoltre, la percezione positiva in termini di efficienza ed efficacia dell’intera procedura da parte dell’utente finale.
Spesso i professionisti adibiti all’esecuzione della proce-
46 AZIENDE INFORMANO
Massimo Giacometti - Coordinatore Infermieristico Cardiologia e Prove Funzionali - Azienda Sanitaria dell’Alto Adige/Sudtirol
AZIENDE INFORMANO
dura utilizzano elettrodi che si rivelano di scarsa qualità. Gli operatori non sempre segnalano questi malfunzionamenti e si adattano all’utilizzo di dispositivi non adeguatamente performanti. Questo avviene in primis per la convinzione che segnalare il problema non risolva lo stesso, in altri casi, l’esclusione dalle procedure di scelta del dispositivo (stesura del capitolato di gara, prove tecniche) genera negli utilizzatori un sentimento di frustrazione passiva e sfiducia verso le decisioni dell’azienda sanitaria.
Un elemento oggettivo che l’azienda ha per monitorare la qualità dell’elettrodo è determinarne i consumi ripartiti sulla quantità d’esami erogati e di conseguenza evidenziandone eventuali sprechi. Su 10.000 elettrocardiogrammi eseguiti, il consumo stimato è di 100.000 elettrodi con una variabilità fisiologica del 2%. Lo spreco nella realtà può arrivare al 20%/30 %. Questo indicatore, nonostante l’elettrodo venga conservato correttamente, è tutt’altro che empirico ed evidenzia lo spreco dovuto alla scarsa qualità generale costruttiva del dispositivo che ne determina frequenti sostituzioni. L’indicatore è altresì utile se escludiamo malfunzionamenti da cattiva conservazione del prodotto come esposizioni a fonte calore (raggi solari finestre ecc.).
Questo scarto “non fisiologico” è responsabile di un aumento di costi dispositivo equivalente a circa 15.000 pezzi considerando gare quinquennali.
Ridurre i malfunzionamenti con dispositivi idonei e di qualità Alcuni accorgimenti che possono essere adottati per ridurre malfunzionamenti fisiologici dell’elettrodo sono: Preferire lotti diversificati per ogni tipo d’esame in modo tale che le aziende possano offrire i prodotti migliori e idonei per le prove richieste. Un elettrodo di lungo monitoraggio ha caratteristiche diverse da quello di breve monitoraggio. Anche all’interno del lungo monitoraggio possiamo diversificare forme, grandezza, supporti adesivi ecc.
Privilegiare nell’acquisto confezioni in grado di mantenere umidità idonea della parte conduttrice evitando evaporazione della parte liquida o solida conduttiva. (Preporre confezionamenti con pochi pezzi se vengono eseguiti pochi esami al giorno).

L’importanza della stesura di un capitolato corretto Per quanto riguarda l’attenzione che le aziende devono provvedere nella stesura dei capitolati, condizioni sine qua non sono:
La commissione aggiudicatrice in un’ottica sinergica di risultato deve essere composta sia da esperti nell’utilizzo che da referenti di economati o farmacie che possono dare il loro contributo alla stesura del capitolato formale. La qualità deve essere premiata con minimo 70 punti su 100. Risparmiare pochi centesimi ad elettrodo si traduce in un contenimento dei costi immediato che deve essere confrontato con le considerazioni espresse in precedenza. Le prove per i prodotti in gara dovrebbero avere dei criteri oggettivi di valutazione e prevedere delle medesime condizioni di test. Se si sta testando un elettrodo per holter delle 24 ore è necessario riprodurre le condizioni di prova su pazienti con le stesse criticità. I risultati ottenuti dal posizionamento di un elettrodo di una ditta su un professionista che lavora seduto in uno studio sono nettamente diversi da un tracciato registrato su un paziente che lavora in movimento e sollecitato da continue vibrazioni.

Anche le condizioni ambientali dovrebbero essere sovrapponibili. Prove effettuate in condizioni estreme +30° o –10° danno ovviamente risultati diversi. Testare gli elettrodi in situazioni difficili (per esempio in estate in cui i pazienti sudano molto) fa emergere differenze sostanziali da dispositivo a dispositivo risaltandone le performance.
Anche se si corre il rischio di eccessiva dilatazione dei tempi di gara bisognerebbe testare i prodotti di ogni fornitore per un elevato numero di esami (circa 50) in modo tale che le differenze tra i dispositivi si propongano in maniera equa su tutta la campionatura. In ogni caso all’aggiudicazione dei prodotti pretendere corsi di formazione sull’utilizzo dei dispositivi da parte dell’azienda vincitrice che riduce la possibilità di problematiche post-vendita e si impegna in una solida ed efficace collaborazione.
47
Network4PA: l’ambiente ideale per fare scouting fornitori
Il Network4PA è un ambiente digitale e innovativo creato da Net4market per offrire alle PA lo strumento ideale per fare scouting fornitori e trovare il supplier più adatto alle proprie esigenze e realtà aziendali. Ricercare e fidarsi dei dati risulta un’attività complicata e dispendiosa in termini di tempo e denaro. Il portale permette di recuperare informazioni ufficiali, certificate e sempre aggiornate dalle aziende presenti nel Network.

All’interno del portale puoi trovare e verificare più di 100 mila Operatori Economici che lavorano con le PA. Inoltre, attraverso le funzionalità del modulo Benchmark puoi consultare e analizzare oltre 65 milioni di contratti delle Pubbliche Amministrazioni dal 2015 fino ad oggi.
Sei una PA e vuoi ottimizzare i tuoi processi d’acquisto? Visita il sito e scopri tutti i vantaggi del network.
www.networkimprese.eu

La redazione augura Buone Feste e Felice Anno Nuovo


























































































www.coopservice.it L’EFFICIENZA DIFFICILMENTE PASSA INOSSERVATA. Un partner unico per soluzioni integrate di facility