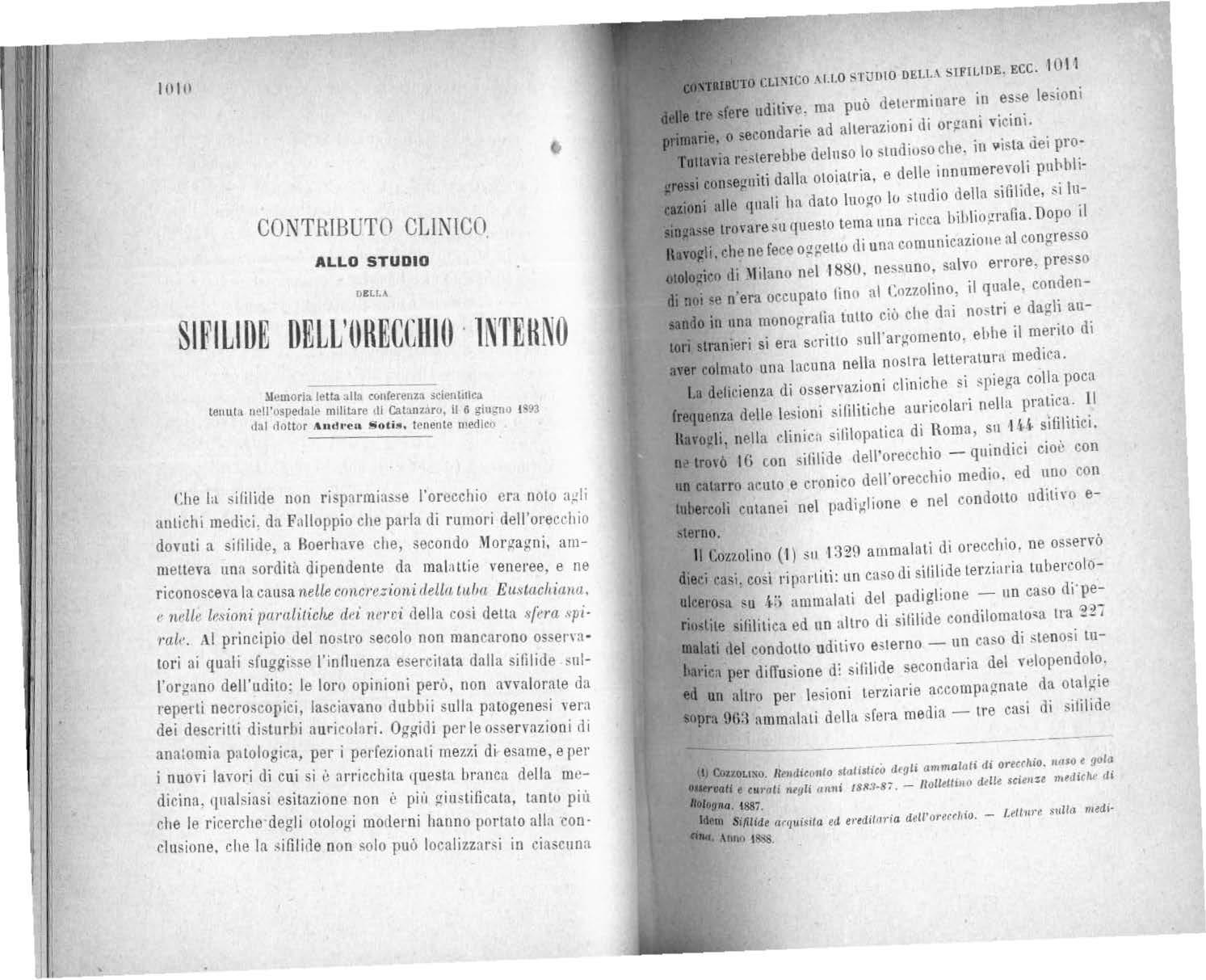
77 minute read
CONTRIBUTO CLINICO.
SIFILIDE DELL'ORECCIIIO ·lNT EHNO
--- -
Advertisement
:llo·morla letta :1lla c<.ouferenz,l scientsllca teuut< l militari' 111 Cat·•nz.uo, il 6 tl<tl •lottur AncJI'en Soti A. tl'nente n>edlcf)
Che la sifilide non risparmias:-.e l'orecchio cl'a nolo a·•li antichi medici. dn F;tlloppio rhe pal'la di rumori dovuti a sililide, a Hoerha"'e che, secondo ammetteva una sordi ttl dipendente da malilllie veneree e ne riconosceva la causa nelle cmu·, ·c.:ioni r/ellu tnlm Eusta ci1itma. t' nt•llt· dn' lll'l'l'i della co"i della sf'rra ,pi· ralt•. Al pnnc1p10 ùel nostro secolo non mancarono ossen·a· tori ai quali sfuggisse l'inlln ent.a esereilata dalla sifilide :-Ilil'organo dell'udito: le loro opinioni perù, non avvalorale ùa lasciavano dubhii sulla patogenesi ,era det descl'lllt dtslurhi auricohri. Oggitlì per le d t per i perfezionai i mezzi ùi esame, e per 1 nuon lavon dt cut si i· :ttTicchita questa branca della nwdirina. non è pilt tanto piit rlte le rteerche deglt otolo\{i moderni hanno portato :111:1 con. elusione. rhe la :-ifilide non !o\Oio può io ciascuna tre sft>re nditiv t>. ma può tlett•rminare in le-.i oni pnmarie, o set·omlarir ad alterazioni tli vi.ci ni. _ . Tanavia re:;terebhe deluso lo studioso che. 111 ae1 progressi dalla otoia.tria, e delle innnmere,·oli pnl,hlicuioni allE:' quali ha dato luogo lc1 :'Indio della silìlide, ,;j lusingasse trovare sn questo tema una ricca hihlio!!rafia. Dopo il l\av()jlli. che t\1' fere o!.q.:elto tli una comunicaziour al olOlogicn •li \l ilano nel 1880. nes!o\UOO, ,;alvo enore. presso di noi n'era orcupato tinn al t:nzzolino. il qnale, condensando in una monogratia tollo ciii che dni no,.,tri e autori stranieri si era s\jrillo sull'argome nto. ehhe il met·ito di aver colmato un a lacuna nella noslrn lelteratum medit·a. l a detu·ienza ùi ossen·azioni clinichr colla poca frequ enza dell e lesioni sifilitiche auricolari nell:t pratica. li nella clini ca silìlopatica di Roma , su 1 H sifilitici. Dl' tro\ Ò l() c.on dell'orecchio -quindici con un catarro awto e cronico dell'orecchio medio. ed nuo con tuberculi rntanei nel pttdiglione e nel condotto nditi'o eliterno .
Il t:ozwlino (1) 1:3!Hl ammalati di oreecl1io. ne dieci c·a.;i. ripartiti: un caso tli sililide ter7.iaria mbercoloolcerosa :;u :\,:i ammalali del padiglione - nn caso di·pes11ilitica ed un altro di sililide condilomalo<.a tra '221 malati tle\ t•ondollo uditi\'0 -un caso di :;tenosi tubarica per difTusiooe ù: sdilide secon tlaria del ed un altro per te,;ioni t\:t otal){ie sopra mn ammnln li dC'IIu sfera media- tre casi eli --- l l'.ollOWill. lleiHliC(IIIlO dt ah di ortcrhiO. 111110 t !)OI<) Ollft'ooli t cumli rw11i un n i JS/1.1·8; - noii•UuJt) lirlle ,,,,didw 1 11 loloona 188i. · ldfom Sifilide 11rqui<ilo ed ertdifm·io dell'orurl•io. - /,.ttu,·p medi· tllla. \tu"' trhs. del laherinto, uno per sifilide ereditaria, eù uno con 'ot·ditit sifilide endocranica aC<JUisita . quindi di portare un contributo a questo rapitolo di otoiatria, ed anche per ottemperare all'invito ciel mio caporiparto maggiore medico cav. Pinto, quale oggetto della presente comunicazione, ho stimato opporLuno riferii e hrcvementesu due> casi clinici, nei quali alla rarità della forma dioica co rrispose il successo terapeutico.
J.'inact'essihilitit di .l{r•IO parte dell'orecchio ai comunftn<'zzi <l'inda)fine, la poca familiarità dei medici colla semiotlt'a nurtcol.lre, l'e:;nme ·upel'liciale del sanitario non specialista, il quale. COil:'latata l'mfezione sifilitica. oon analizzandone i pii1 smtomi. s1 appaga della diagnosi generale se nza ,tahilire rJuella del l'afllnire dei malati nei dispensari celtki, do\a l'in,·e=-tigazione clinica si limita all'e,;ame delle parti \·isil1ili dell'orecchio sono tanti fattori che danno t·agtoue dell' es il-:na pereentuale delle afTezion i silil itiche auricolari nelle :;taiJstiche generali.
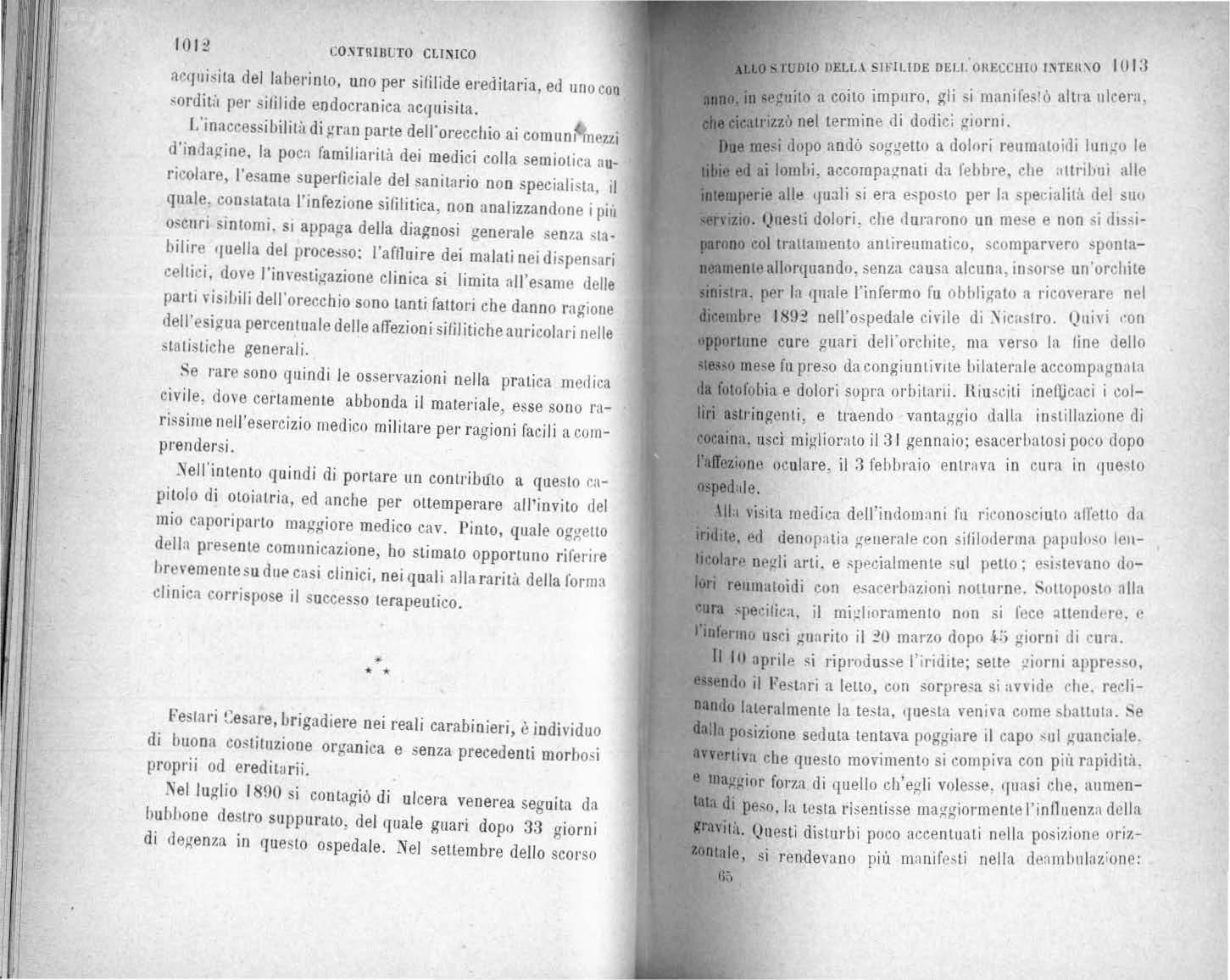
Se rarr sono tjuindi le os:'ervazioni nella pratica mcd1ca civile, do\e certamente abbo nda il materiale, esse sono rari ssime uell'esercizio medico militare per ragio ni facili a comprender·si.
ALLO:-. 1UDIO IIELL.\ SIFII.TDE OELI. OIIECCIITO uno. in a coito impuro, gli ...i mantff'" !ò altra nkera. che cic.tlriw'• nel termin e di dodici mi.
Oue 1116,.; clopo andò a dolo1·i reum;\lo itli lult.!o le llbie e•l ai loml•i. a•xoropa,:natl ùa fehbre, dte ·•llriltui allr mtempt•rie •Jnali si era e.-po.-to per la "Jle•·ialitit cl_el su_o ..en iz1u. dolori. che durarono un me.;e e db,..lpar•lno ,·oltrallaweulo antireumatico, scomparvero ,;pontaneanwntc' allorquando, senza causa alcun 1. in:;or.. e nn 'orchi te smi .. rr.t. pt>r l.t crnale l'infermo fu obbligato a rit'O\ nel nell'ospedale civile dt \n:a sl ro. l.)uid ··on upp•>rtune cure guari deli'orchite. ma vet·so la line dello t nlf-',e fu da congi nn tiVILe lti latemi c a1:corn pagn<lla ùa fotofobi a e dol ori sopra orhitani. HIU 't:iti inelijcari i co lliri astriugenti , e traendo vantaggio 1lalla insti llazione 1li coraina. uscì migli ornto il :J l gennaio; poeo rlopo l'aiTezionn oculare. il 8 feiiiH·aio entrava in rura in questo
\Il c 'i sita medica dell'iullom ;1n i fu all'rtto da 1r11ltll:'. t'cl denopalia gc•uerale con :; ili loclerma pa lenllcol.trP nc>glt a1·ti. e petto; e.;i• tC'Hlll O doluri renmatoidi notturne>. Sottoposto alla cura 'Jie•·itic·a. il mi!!ltnramento nun si l'c'Ce .. re. c• l'1111t·nno nsri il :W marzo dopo giurnt di t'Unl.
Festari Cesare , nei reali carabinieri , è individuo di huona co,tituzione Or!-(ani ca e senza precedenti morhosi proprii od eredita r·ii.
Nel luglio l H!>O si contagiò di ul cera vener·ea seguita da huhhone destro suppurato. del truale guarì dopr> 33 giorni di degenza in questo ospedale. sellembre dello scorso
Il lo ap1·J1, ,;i riprodus-e l' tt·iùite; sette :!ior ni il Fe:;tnri a lello, con si an irlt> dte. redinanclu late>ralm ente la te:;ta, cJne,.;ta \'entva come :-.ltattuta. Se dalla po sit.ione setluta tentava ti ea po '"' guanl'iule. rhe questo moviment'J si t'Ompiva con piit rapiditit.
A ma;.:g1o1· forza di 'tuello ch'egli vule;;se. rptnsi rhe, aumenlal.t tli pe,..o, la testa ri sentisse maggiormente l'inllnenza della gr:l\ ili1. ()u esti dislu rb i poco <H' cen tua ti nella pos i1.i on P tli'Ì7.zontalr, :; i rendev uno più mnntfrsti uella do nm l111lnz io nc: camminando in direzione rettilinea non perdera l'eq uilihric•. ma se do\eva da una \itl principale immeuerst in,. altra secondaria, se voleva \Oitarsi di lato o indietro, cadeva. on• non avesse avuta la precauzione di compiere ron lentezza movimento. l' reccupato di queste soll'erenw slahili il 20 aprile p. p. di dalla :-;ua stazione !Jerò nel viaggio un suo compagno rimarrò cll'e!!li aveva la bocca storta. e questa asimmetria silenziosamente. t·ichiamò la attenzione. Del fenornP no ehhe ma". . ,.. g10re cosctenza la nel pranzare. perche'· non solo il "thtO . ,.. era attutito ma. ar•·umulandosi gli alimenti MI soko aheololabiale. la mastiraz io ne l'i com piva co n dillicoltil. !X ello :.tPsso giorno notò diminu1.ione nell ' udito all'orecchio destro. ros t che sfuggiYa il ..;ignificato della parola clei ,e non tendeva l'orecchio s in is tro visita del aprile si rilevò: iridite dopp iaparaltst del facctale destro estesa a tuUi i mu sco li mtm ici rou contrattilità elcuri•·a muscolare leggermente t!inlfnuita. e riflessi consen·ati - deviazione nel velopl' nd olo. Esame obbiettivo deJI'o,ecchio e,;terno neuativo - tromiJa di Eustachio permeabilc all'e:;plorazio ne process i del \' al-
To.' n bee e del Politzer. La misu1·azione dell'acn 1ta uùtltva fatta per la 'ia t·ranic·t a(! "et·ea d" · · 1
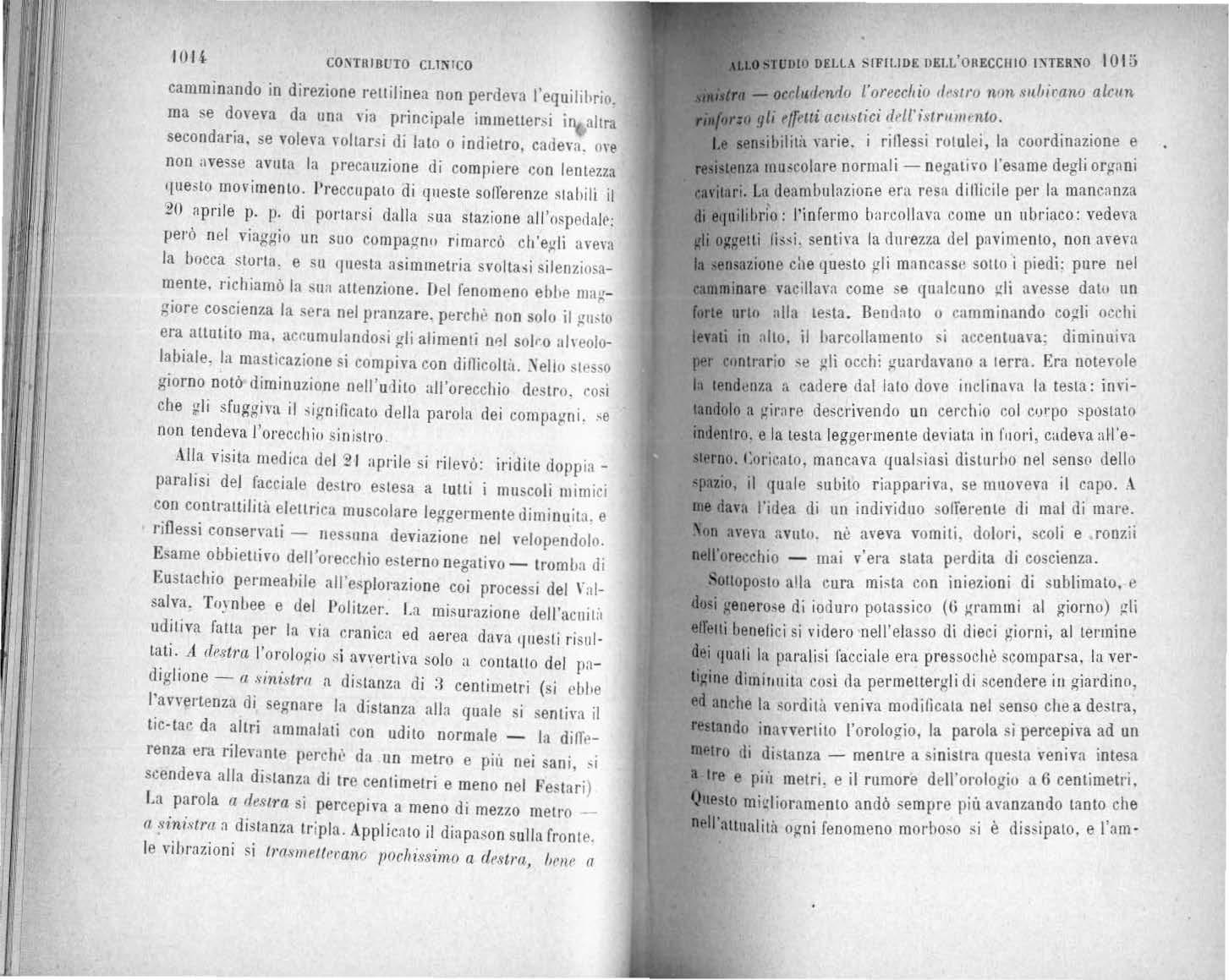
• ' " < uVa ljtleSlti'I Sll -
A dl•stm si av\'e rtira so lo a con tatt o del padtghone- a smtstrn a distanza di :1 centimelt'i (si (•bf,e
!:avvertenza di segnare In distanza alla quale si sentÌ\':! il LJC·tar da altri ammalali l'on udito normale - la difl't'renza tlm rile' ante perctH·· da un metro e più nei sani ,j scendeva alla distanza di tre centimetri e meno nel Fe:-ta,ri )
La parola a si per·ccpi,·a a meno d' me
• ' ' zzo metroa sinistra n distanza tripla. Applicnto il diapason sulla front e. lr \'Ìhra1.ioni si trasmpffl'l'anr. pncl11ssimo a dl'strlt, !11•111 , a
STUIIlO DELLA ll&l.I.'ORECCIIIO l 0
- oc rlwlmdo l'orecchi11 dt>sii'IJ n11n suhìrmw alcull n-forzo !Jli 1'ff.•tti acustici d,..ll'istrlluunto.
Le sen,.ihtl ttil rarie. i rillessi rotulei, la coordinazione e resistenza lllU $COiare normali - negattvo l'esame degli eav itari. La deamhnlnzior.e em resa difli cile per la mancanza di 81Jilil ih rio: l'in fermo barcollava come un ubriaco: vedem oggetti fis,.,i. senti,·a la durezza del pavimento, nort avHa la c:1e questo gli manca:>st' sotto i piedi: pure nel camminar·e vacillava come se l(nalruno ).(li avesse dato nn rorte urtu alla te:;ta. Bentla to o ··amminando CO;!li ocdti leY&ti in nlto, il barcollamento :oi accentuam: diminuh·n per contrario gli occh: guardavano a terra. Era notevole la tend enza a ca• lere dal lato dovo incli na va la testa: in' itandolo a ;.:iraro descrivendo un cerchio r.ol c•J•·po ::;postalo ind('nlro. e la testa leggermente deviata in l'1t 0ri , cadeva all'estt> rn u. t:urieato, mancava qual:;iasi disturbo nel senso dello spazio, ìl qual e suuito riappariva, se mnovova il capo. A me dava l'tùea di nn individuo di mal di mare. are\ a r. vu lo. uè aveva vomiti. dolori, scoli e ronzii nell' uret:dtio - mai v'era stata perdita di coscienza. Soltoposlo alla cura mista con iniezioni di :;uhlimato, e dosi dì ioduro potassico (tì l{rammi al giomo) gli efTeui henefi ci si videro nell'elasso di dieci al termine dei •f nnli la para lisi facciale era pressoché la vertig in e ùim itntita cosi rla permetter·gli di in giardino. ed anehe la sordità veniva moclilicala nel senso che a destra, restand o inavvertito l'orologio, la parola si percepiva ad un metro ·lt di,tanza - mentre a :.inistra qne:;ta veniva intesa a Ire e piu metri. e il rumore dell'orologio a 6 centimetri, Questo mi\(lioramen to andò se mpre piu avanzando tanto che Df'll'nttualrl it ogni fenomeno morhol'o :-;i è dissipato, e l'a m- malato non viene trattenuto all'ospedale che pe1· pro't'i!lllle la cura nelti111ore di qualche ricaduta. faccia a pe1· paralisi del fa cc iale de:>tropei sapori (amaro ..dolce. l' izzol;ulle Fran cesco, t:arahi n iere a vieùi. i! indi,·icluo di ntlida cnst1tuzio ne ol·gani,·a. e pri\O di precedenti rnor· hus1 propri od eredllari. "\t> l ùello ar111o r'co,·erava in «IUesto :;pedale per ulcera allu .;;eroto "e.:!uita da adenite doppia suppurata . .X el novembre successhu ,; I'Jtor·nù per dolori r·t•umatoidi, ma, con;;tatatnsi l' infel. tu nt • sitilitica. fu rurato con iniezioni di sublimato, in numero tli l :l. liquore di vau Swieten, e d1messo dopo una degenza ùi Ull mesi'. Il l O gennaio entrò una terza volta rou fpnomeni cii iridit e doppia sifil1t ica, e dopo i):) inier.ioni ùi sub lim ato usci guarito il 2.:; marzo p. p.
Le sue so ll'eren1.e datano tl al 28 aprile, gio rno in t'I li eominciò ad avvertire rumori all'orecchio $iuist1·o a-,ociali a durezza di udito e ltarcollamcnto della persona. \
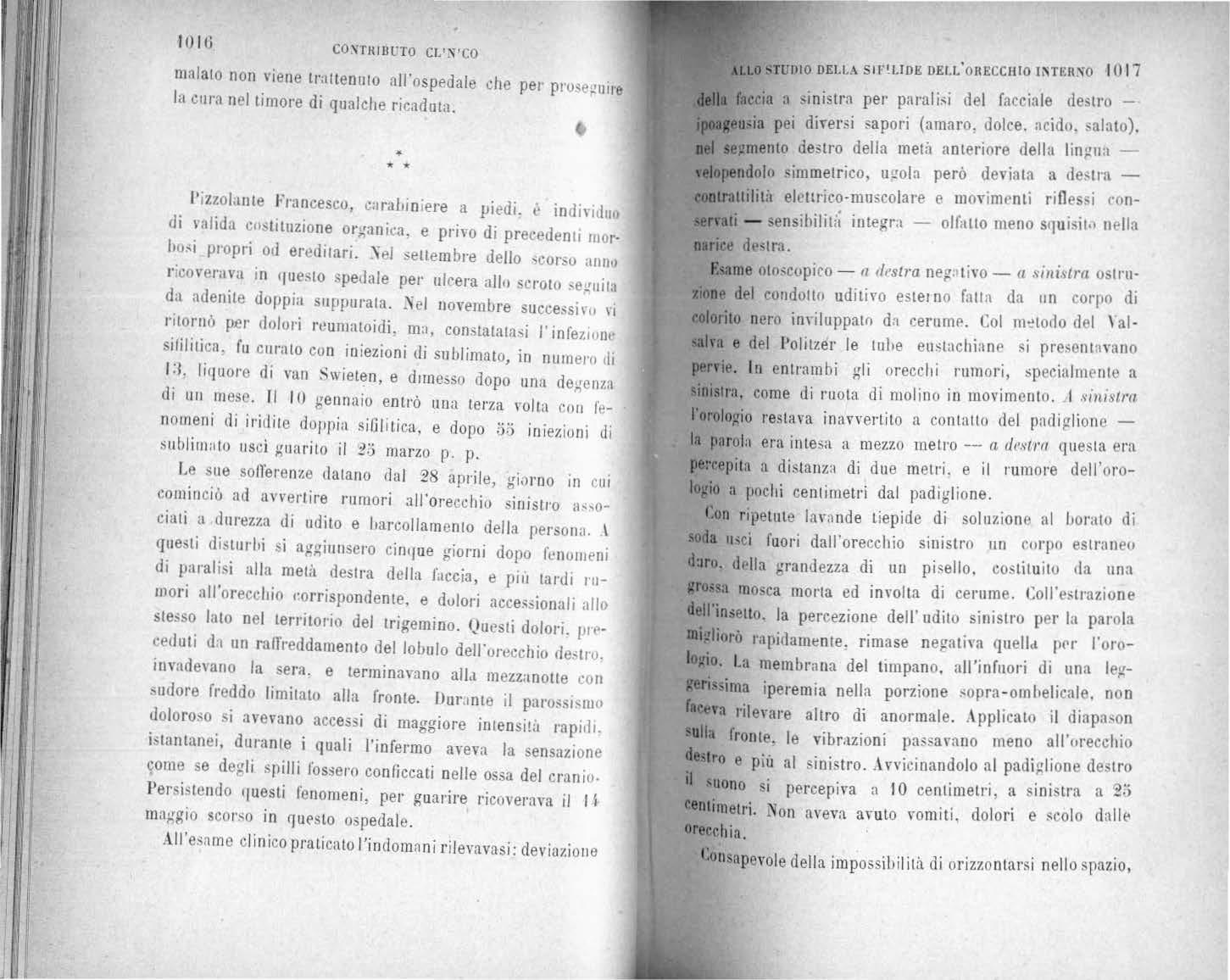
(}Uesti clisturl1i si axgiuUSCI'O CiDif Ue giomi dopo fenomeni di alla metà tlestra della faccia, e pil1 tardi tumori all'orE'ccliio t·orrispondente. e dolori allo stesso lato nel territorio del trigemino. IJ ursti dolori. ruet·eduti d·1 un rafl'reddamento del louulo dell'orecchio tnvade,ano la se ra. e terminavano all.t mezzanoue ,·on sudore freddo limitato alla fronte. Uur m te il paro$St:-;mo doloroso si ave,·ano accessi di maggiore inteositù rapirll. durante i quali l'infermo aveva la sensazione come se de,!di spi lli fossero conficcati nelle ossa del cmniu.
Persistendo IJU8sLi fenome n i, per guarire ricove1·ava il l i mn;!gi o scorso in questo ospedale .
All 'esame l' iod omn ni r ile,·avasi: deviazion e t:onsapPvole della impossibilita di or izzo nt arsi nello spazio,
MI se:zmen to destro della metit anter1ore della•elopendolo simmetrico, però aelettrico-mu scolare e movimi'OLI connati - ,ens ihiliti; integra - olfallo meno squisit•• nella narici! tl•·-tra.
Esame otn.-copico - n ,f,•stra neg. Li\'O- a sil!islm del condo Ilo uditi vo est et no fati a da un corpo dr colorito nt! ro im iluppato da Col lll"totlo nel \alsalva e del Politzer le tuhe si presentwnno penie . I n enLram hi gli orecchi rum ori, sperialmt>nte a sinistra, come di I'U Ola di molino in movimento. l sinistra res tav a inaVYertito a con tallu de l pndii-(lioncla parola era intesa a mezzo metro --· a dtwt?'lt que:o;ta era percepita n di s tanza di due metri. e il rumore dell'orologio a po chi centimetri dal padiglione.
Con ri petute lnnnde tiepide di soluzione al borato di soda lhci fuori dall'orecchio sinistm un ro i'IHI estraneu daru. tlc·lla grandezza di uu co:;tituito da una grossa mosca mo1·ta ed inrolta di cer·nme. Coll'e:'trazione dell'insPtto. la pe rcezione dell'udito sinistro per la parola rapidame nte, rimase qnelld prr l'orolol(io. l a membrana del timpa no. all'infuori di una legiperemia nella porzione :;opra - omhelicale. non faee,a r·ilevare altro di anormale . .\ pplicato il lliapa:;on sulla fronte. le "ibrazioni meno all'orecchio destro e più al sinistro ..\ rvi cìnandolo al padigli one demo U suono 'i percepiva a IO cen tim etri, a si ni•Hrn a ;?:; eentirnetr'i. Non aveva a,·uto vomiti, do lori e scolo orecr.hia.
•
CO:ì TRIBUTO CUNICO l'infl'rmo ·e t ne sava a letto. l nvilalo a nl mrniu ar·e l
C Il , •aro a ' '•l come un uhriaco 1·
• • • - J.( J oggelli non gli lDtorno. ne Il pavimento ced eva i suoi pledi- p \''li'Jih , l urt ' .'·l come se ft testtl rosse sbauuta do\'" . l . 1 l' - r l anche a letto. da quella parte tendeva a •·adt·re. li dlsturh'.' ala,;,ico si rende,-a più e,·idente ed intenso bendando gli o•·chi o portandol i in alt o . • - mentre atnella orizzontale, purché la te,.ta r·esta-se tmmohlle. psichiche, sensibilità varie, r ill e,:--i r·•tuler ed 'lltr·l leno · d 11 · ' menr e a vrta rli relazione e veg etativa nol'lnali . . Il pr·ecedente moriJo,;o .· impone,•a: t' il successo remprco nel Festal'i illCOI'ilJ.(giava ad aooii·Jre . b'l l . . ' [' • :.11 1 o a ' ur,, spe cr 1ca - in .aruzia di .1 d . l') tjue:s a opo tre g10rni scompa rvero .le nevr·Higie, e (Jueslo fu l'inizio di un lento ll1 ' l fJro · gressrvo miuJioran 1 d · ' " • 1'), leno. e oggi, cinquantesimo giorno ùi ospedale, la prosoplegia è sc ompa,·sa. l' udito sr ,. r.'prrsttnatt), la vertigine di mollo auenuata. cosi che tuuo la sperare una prossima guarigione.
'f , ,.
La f · ·l' · . c mrca nelle due i· f.Jr·es:;u che a facciale. ipocofos i. verLtJ.!•nt. l ruca forse Lt cau'a cioè la sifilide d'JT . . l l'. .. , 1 er ent e so o perdri• mentre nel primo caso la malnltla esonli Clln u·rdrte d . · oppra segurta t.lue )!iomi dopo da lesioni nel ;n ed o ne , d' d . no t e'tra, nel secondo ca:;o si manift>slò co n rnmorr e sorJ't: Il' nel Pizzolante non presentavano i falli varalilit:i facrial e pole\an.;i altri hnire i suoi di;;turhi (sord,t;'r, ru · mori. verti gnte) alla pres enza del rorpo estraneo nel condotto nditi\ o e:.terno. il quale. prodnc<>ndo aumentu di pre,.;ione nell'apparecch io di tleterminava uua ' nlla finestra ovai<', co n effett o dr ahnorme t> rci tamento sulle e'pren.;iom Jaherintiche
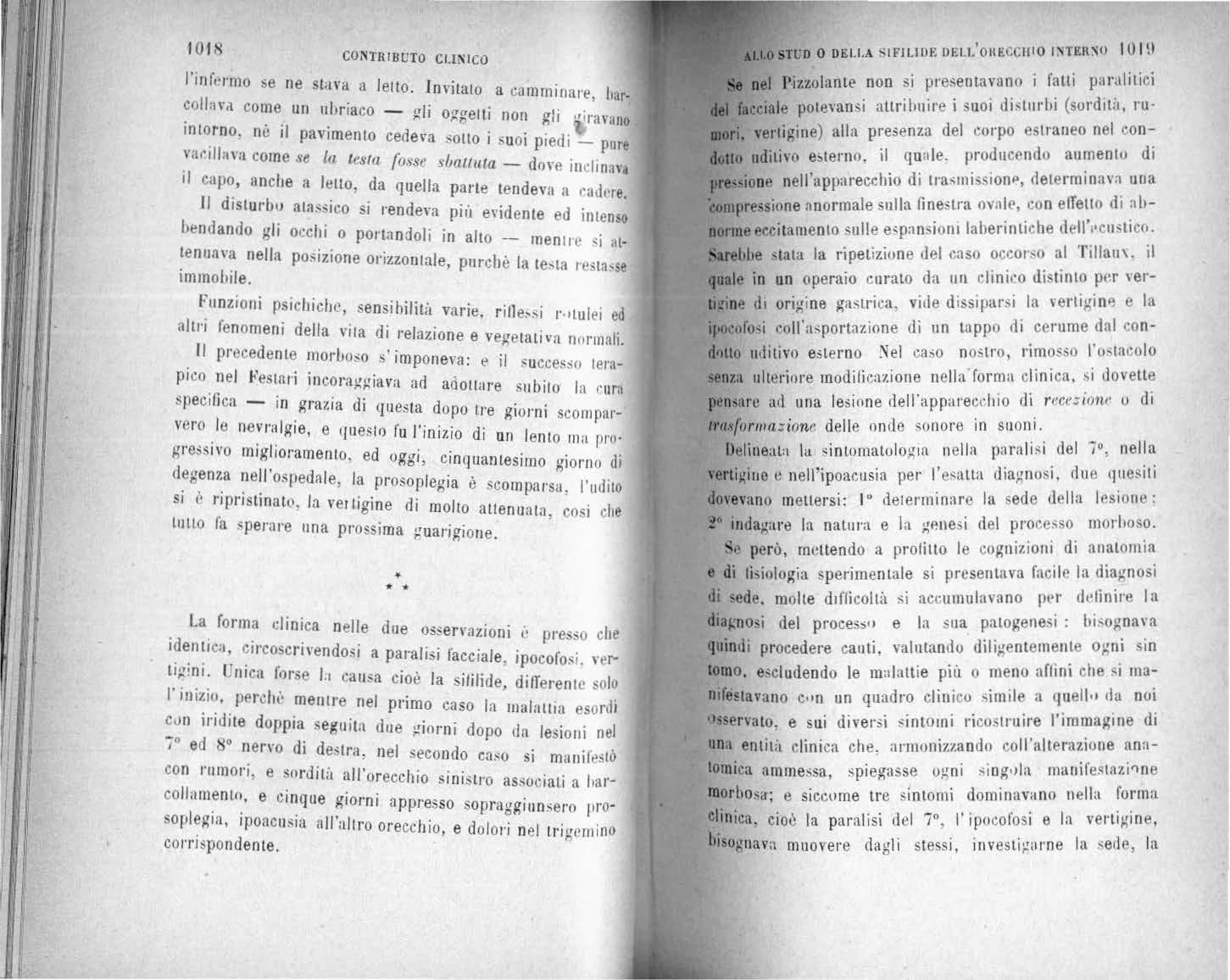
Sarel•he la ripetizione del cnso occoN1 al Tillau\. il quale in un operaio curalo da un dinico di'>tinto p<'r 'erlu:ioe dr gastrica. viti e la vertìgi e la n ll elineala la .;i nLOmatolog Hl nella parnli :< ì del i 0 , nella vertì:.:iu o c nell'ipoacusia per J' e:-a tla diagnosi, rlnf' IJllC:>iti do\'evan o rn ellersi: 1u determinare la ùella lf'sion e: iudag:u·d la natura e la gP.nesi del morl1oso. Se per ò, mettendo a prolitlo le cognizioni di anatomia e di fi si ologia sperimentale sì presentava facili' la diagnosi di molte drflicolli1 ,;i accumulavano JWI' tlt'linirP la del processo e la sua : quinù i procedere cauti. valnlamlo diligentemente si n tom o. escludendo le malatt ie più o meno afltni t:he manrfest a Yano c••n un quadro clini co ;;imile a quell•• da noi ·•sservato. e sui diversi ,;intorni ri costruire l'immagine di una entiti1 clinica che. armcJnizzando anatomica ammes a, spiega sse o:{ni ,i og•1la morho sa; e siccome tre sintomi dominavano nella forma clin ica. cioè la paralisi del 7° , l' ip(Jcol'osi e la venìgine, llìsognava muovere dagli stessi, investi;wrne la ::etl P, la origine c ro,;i alla diagnosi indireua del
•·oll'a:'portnzione dì nn tappo tli cerume dal •·ond••tto ud itivo esterno :'{el ca:;o nostro, t·imO S$0 J'o.;tacolo senza ul te ri ore modili cazi one nella forma clini ca, ;,i tlovelle pensare una le:;ione tlell'appnrecrlrro eli n •rv:imw u dr delle onde ,;onore in suoni.
• · 1 " a orecc 110 a ltarco llamenro, e ci nque u'o .
1. . .
• • • rnr appresso sopraggiuno;ero prolpoacusm ali altro orecchio, e dolo r i nel u·iaemino corrispondente.
La p·rralisi facciale. interessando lutti i muscoli fa l'cm escluder<> la origrne I'IH!twmùfrric{f, nella qu ali' i· rrsaputo l'Ili' :)0110 rispar·miati J'orbic<•lare delle pafpehre e rl corrugatore della fr·onte. La lesione quindi do1 e,·a tro1arsi ,uf cammino del netTo dal nucleo alle terii ii iHlzit•ll i peri ferie he.
L'c,-,cre conserrati i ruorimenti e la conrratt ilit.'r llllht'Oiare -l'associazione ùell'ipoa;.!euslia e dell'rpoa cu-ia alla par·afisi ioducera arl allontanar·:-i dalla periferia e f' 11 1'tar:;i piu profoudamente nell'acqncdotto di Falloppio o, piu in sopm del nel condotto 111lrti1o inferno.
La diminuzione del gusto nel segmento destro (porzinn e anteriore) dellu lingua dirnostra,·a t'IJe la dore1a trovar·, i al ùi sopra dP! punto di emer·genza della eortl:t del timpano. tm IJ Uesta e il ganglio geuicolato . l>,tlla gioranza dei lisiologi ,; opina cl1e le tihre gustative della •·orda del ti111pano decorrano insieme al 7• nel can ale di Falloppio fino :Il genicolato. dal quale llip :u·tirehhero per ra).(giun:!ere il trigemino a mezzo dE>i nerv r petr·o,..l snperlic1ali, e la clinica non smentisce. anzr t•onforta il corollario della tisiolo).(ia sperimentale . .\ella ca,rstica rat•colta dallo Stich si dimostra che le par;lli:'i dell a farcia pt•r lesione drl 7° alla h:1se del cranio ·prin111 t[,•lf• l Sllll pt>nt•lm::ione nel crmale wlilir? intt•rno non fnron 11 a penlita dPI gusto - nel ca<:o di prosopfP1i a associata ad aflernzir)J]e del gusto, la lesione occupava il tr mco tlel i" dal gan;.dio genicolato lino al punto di separa;done tlPifa conia del timpano. ( Bianchi) .
La mancata del velopendulo non era di o.;ln · alla foc alizzazione anatomica in que,-to punto. perrhi· t)euo fenomeno ha perduto molro del suo 1alore. Pel pa,;salo li ammeucm chi' fihre del facciale a mezzo del gran•le pe· troso superfi ciale penetrassero nel ganglio ... reno-palatino. e cpindi ucll'eleratore del palato m•)lle. Ol>Sen azioni elmiche e Jj,j ologiche :'cOs:>ero questa opm10ne, lllelllre Ror le.' ne delle la pnl\a sperimentali.'. perchè a1enòo a:1por1:ato il ganglio sfeno-palalino non risruntrù :tioimnwtrra del H•lnp enllolo. Per t:rl modo og-gidi si i• eonrhiu'o rhe quand • la deriaziont> del pabt 'l r,;iste, la lesione del 'iu lrovasi :al di lit del gangi io genicolato - q un ndo manca non !-ti è autorizzali ad escludere questa sede.
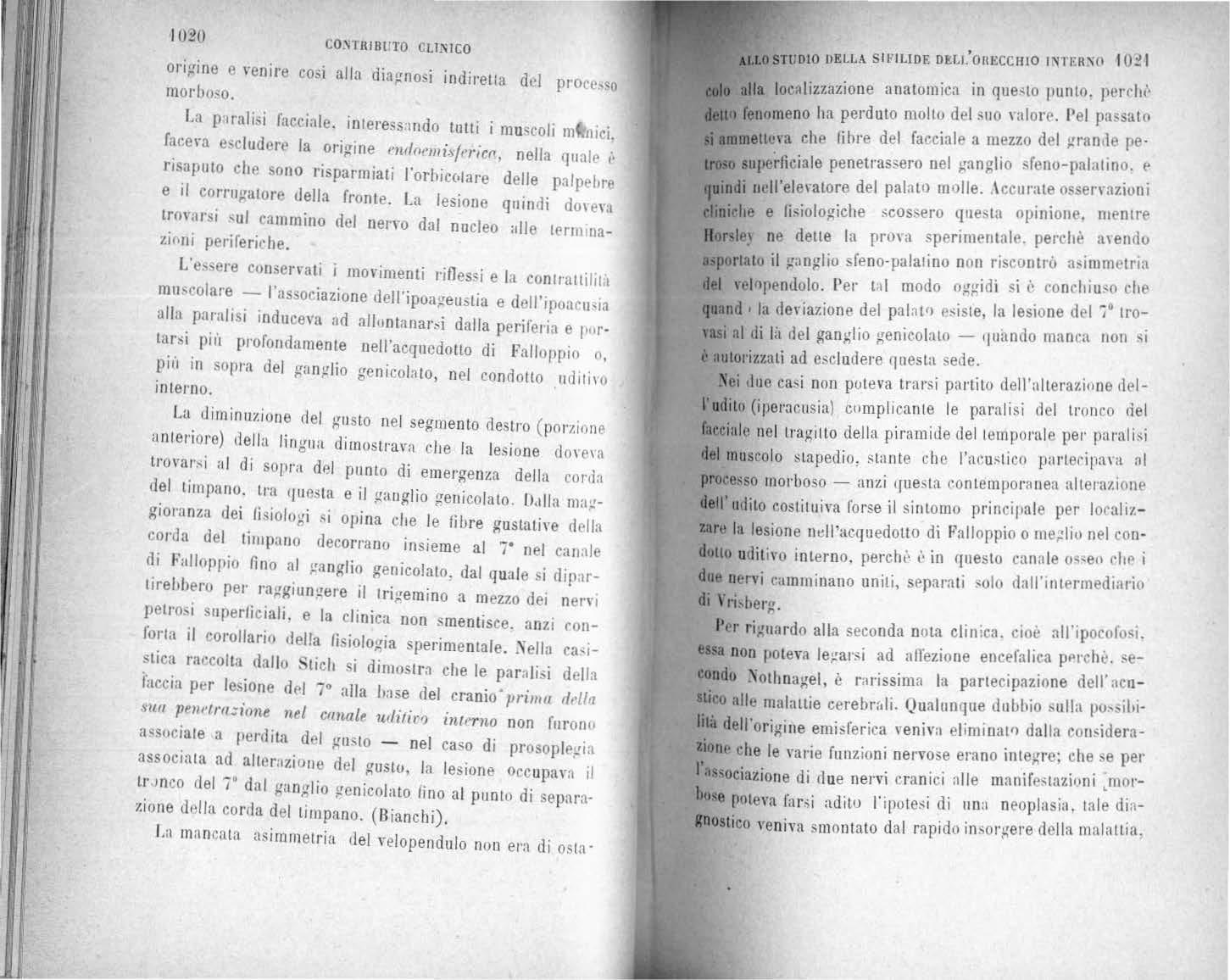
Nei t!ue ca,i non poteva trat·si partito dell'alterazione tlell'nditn (iper:mtsia) comp lican te le paralisi de l tronco del facciale nel tragttlo della piramide de l temporale per pnmlisi del musco lo stapedio, stante che l'aeu:;tico p:tr·Lerip:Ha al moruoso - anzi I(Ue!>ta rontempo1·anea alterat.ionf.' dell'udito costituiva forse il sintomo pr·incipale per· loralrzzare la lesion e nell'acquedotto di Falloppio o rue,:litl nel coudouo udit 11•o interno, percht• i• in questo eanale o--eo !'lrr i due Ot•rvi ramrnioano uniti, separ·ati 'Oiu rlall'rntermedial'iu di t• t•r ri ;.:nardo alla seconda nota clin ica. cioè a11'1pocufu.;i. essa non poteva le!.!arsi ad all'ezione encefalit·a prrrhl'. :;econdo .\othnagel, è rarissima la partecipazione dell' acnalico alle mal auie cereurali. Qualunque dublrio :;ulla lità dell'origine emisferica reniva eliminatr') dalla con,iderazionr· l'he le ,.a1·ie funzioni ne!'Vose erano integr·c; che pet· di due nervi t'mnici :-rlle .morbose pole\'a l'arsi adito di una neoplasia, tnle dla«nostico 1eniv a smontato dal rapido insorgere della malattia. la ttuale in pochi giomi, e senza preceduta da fenomeni irritativi, era giunta al suo acme.
Che la diminuzione dell'udito non fo sse prodotta M all'eliO ni organi 1li trasmi ssio ne delle onde sonore. lo di all'evidenza l' esam e oLoscop ico la permeahilitit della tromba di EustachiO, e so pratntto il ri :.ulta to sulla trasmissione cranica ed aerea delle vibrazi on i avuto co l diap.hon. Bandita l'idea di un a origin e su perfi cia le della durezza uditira, es..;a do,·e,·a riportarsi o a malattia del laherinL J o a lesio ne propria del nervo.
La della parte anteriore o posteriore ùel loho medio tlt>l cervelletto pruduce tendenza a cadere in avanti o indietro ( Fl euren s}. La del loho laterale o del peduncolo medio obbliga l'animale ad un rn o\ i mento d1 rotazione intorn o all'asse longitndinale. ( Lussana, )l ,tgendi e).
Oltre la parali:;i della faccia e la durezza dell'udito sovra · sta vano nel quadro clinico. e preoccupavano dipiù }(Il ammalati i disturhi dell'equilibri o - ehhen e la vertigine oiJblig.IVa a non ..;po·tare la sede morbosa dall'orecchio interno .
Senza le manifestuzi oni morhose del 'ì 0 etl 8° si sarebl!e
ÙO\' IIto di..;cutere con am pi Pz7.a tutla la ricca patogenesi della verllgi ne . prr dei vari momenti e5cfusa la vert igi ne riOessa o lOssicn - e per la integrità delltl Jive1·se se n-;1hi litit e dei riOes:;i patelln r i, e la mnn•:anza di fe nom e ni oculari, eliminaudosi le a!l'ezioni organi che del cervello e Ilei midoll o ;;pinale. due ip•1te:-i dowwa no discuters i. cioi' la vertigin e era di ori gine lahe ri ntica o hellare . .\e lln deficie nza di sintomi co ncomitanti difficile rrhhe stato il la diiJ'ere nza , perr hè. mentre le ricerche a natom iche oggidì dimostrano ch e libre 1lell'ncusrico si perdono nel •·ervelleLLo, gli esperimenti di fisi ologia mel· tono in evidenla l'id entilà funz ionale dei due organi per riguardo alla lor.omozione.
Elili ene alterazioni anatomiche e funzionali nei canali se· micirco lari danno a riguardo dell'equilibrio gli stes-i ell'etti deiiP a"portat.ioni dei vari segmenti del cen·elleuo.'. sione del canale semici rcolar e sttperiore sposta l'eqtul1bno lO ;l\·antl intorno ad un ' asse orizzo ntale- qttella del t:anale semirircolare posteriore Jit ::.postame nto indietro. mentre spnstamenti laterali so no determinati da lesio ni del semieircolare orizzontale. l) uin:ii intimo rapporto anatomléO. identit i1 fuuzioual e per riguardo al senso dell 'e!Juililll'io r endono al clini co dillici le s:ahilire l'origi ne dell'andatura atas!\ica. uve nou te nga ca lco lo di altri si ntomi che, oppor tunamentP \' aiutati. ,,, guidino =-nlla reua via. Nei due il rum ore all'orecchio, la diminuzione dell'udito. la p<t rali si del fa ccial e e , nel Pizzo la nte, i dolon del trigemino ta le una si ndrome morho,a, che, dis;;ipa ndo ogn1 causa rli errore. additavan o nell 'orecchio interno la se le dell 'alterali one anatomica .
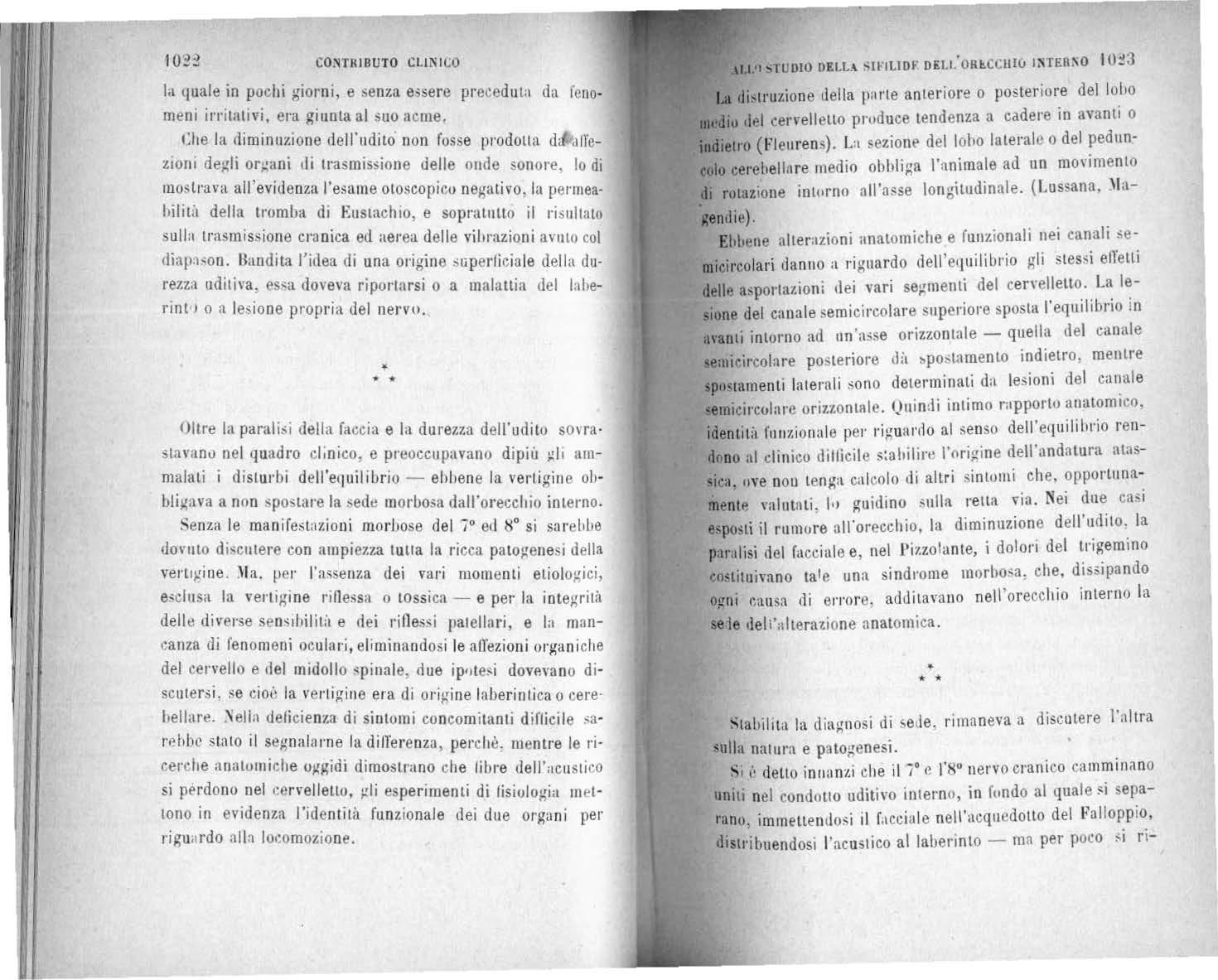
Stahil1ta la diagnosi di :;eJe. rimoneva a disc utere l'a ltra natu m e
S1 i· dello inunnz i che il i 0 e 1'8° nerv o crani co cam minan o uniti nel co ndotto uditivo inlernu, in fondo al quale separan o. immettend osi il facciule ne ll'acquedotto del Fallopp io, ùistl'ilmend osi l'ac ustico al laberinto - mn per poco ri-
102'1
CO'\IIIlllt:TO CLI:'\ICO corùi la anatomica delle di,-erse parti costitut·nti i·. c.he in esso se il lt.l 1 due net VI non t' nnmedmto, 1011rno. sarit mediato. !alto da non e:;dudere che di uno di influ1rt> funzionalità dell'alu·o. Es-.i potPYUDO le:;i primarramenle. o per diffusione di prnce:'SO nelle , 1r1o_ rompre..;sione d 1 le . .-ioni o,see di natura neo plastiCa o 1nlrnmmatoria.
Una malattia primili,·a non act·ettare pel fallo che nell'orec·chio Ì' t·arissima l'alterazione os:-:ea primari,\. mentre piit frequenti r1eotTono nella pratica la carie e la consrcnli\ e r. d all'ezio n i purulente della ca:;.;a del timpano: di più ùii'lkilmcrite :;i ··ont·epha una lt>sione ossa clte non si annun.·ias=-t> col sin10ma dolore. La brusca, repentinn mantfe.;tnione della paralisi e clei di.;turl• t auricolari, la rapida non fU\orivanu poi la di una possibi le compressione tlei nen i per esiti di prcH:es:-. 1 anatomi..:i localizzati nella rocca petrosa.
L'inizio della forma clinit•a con fenomeni seguiti o a disturbi auricolari, c lo sviluppo ulteriore del la paral isi facciale rlimostraYaoo che i cln<' nt>ni cranici parLeCIJI:l\'ano io modo srcoodat·io ad una le,ionc dell ' orecrhiu intemo: l'all'ezione però non poteva 1l 1 nat 1na flocristica, mancavano i fenomeni clelia nevrite. ma to::.to dt natura iperemica. perche se da nna partì:' l'anawmia patologica dirnostra quanto frequenti ,,an() nei lll'rl'l i disordini circolatori, dall'altr.t solamente l'1peremia gaYa la forma clinica. svoltasi repentinamente. ed anrhe celermente avviatasi verso la guarigione. I nfalli nel PiJ.zolan te i dolori neHalgici nl giorno d1 cura, e In pa r.1lisi facciale si era gia nttlmenle modificata al 10o. mentre oel i al 7° gioi'Oo di degemn si I11ltava un notevnle nei fenomeni paralitici, e 11e1 equilibrio. Nel diari o d io ico J'o<;s('rvazione che. lllf'Oll't' per la e·4en:;i<.ne della. paralisi. sembrava il pii1 cocnproa\·eva pel pmno !'l;;entito il del trattamenlu curativo; !Ilent re l' at'U:'liW. 1 di.;turbi tlel q unii' per ri spetlu all'audizion e non si pre.;euLal ano rilevanti, mo.;trò p1i1 rerr.lltar;o alla cura a.\oltata. \ Ila prodtuione di questo fe· aomeno c· retlo con··ot'l'\'s'ero due una di pro,·e--,o - l'altra anatom1ca.

In entram lu i casi h malallin .-'iniziò eon i Ùl..;lurhi tli eqoilit.ri o e solo in si presentarono la paralbi e l'ipocc.fo,.i. l) uesto nrio :,uc•·edrr,;i dei fenomeni lei c(IU\dro cl inico dimnslnt\a che la malauia -;i iniz1ò netl'oretehio interno . e 1lopo ..;i cli!Tu:-e al ..;rttimo, quindi lesionr, direi , pi ù antic'a nelle espan,ioni terminali dt!ll'acu--tico, più recente nelle lihre dt>l f,tc •·tale ; da qursla profondità di h>:;ione un tliver:w mo tlo di !'OTT ISpontlere ld trattamento te rapico.
La anatomica la vedo riposta nella islodei due nervi. antidti eh iama\ ano l'acu:;tit:o, por:iun1• nwtlc• rltl Jaccwll' qua..;i ad atle:;tare ello non era loro sfn,l.(gita la delicata ..;trnnura del ner\'o acu.;Lic·o ri,;petto al fiiCI'Ìal e, ÙCil0tnii1CitO JlOI';iOIV' diii'U. l)a que::ota lahi\itit all:tlOOlÌt'a der iva qnindi una minore rc•si:>tenza detracu,tiw ai proc,•sst mor hosi, uBa maggiore ricelliV1la per ;,:li ed una fa··llitit magl!iorc a piu lungamente i funesti elfeui.
CJo indi la diagno,;,i del processo era congestione nevrolaberio ttca . e non del solo lallerinlo. paolo ùi partenza, perchì· crui alla sintomatolo)!in del urtiva In paralisi t le\ 'i ". L'ipet·('mia. "' oltasi nel lauerinto. aveva p rio- cipalm ente colpito in e:>so i canoli :->emicircolari, donde romori e vertigini, e poi si era ùill'usa ai due nervi nel 'ondollo uditiro interno determ1n.n1do pet· tal modo la pnr.dn;i del facciale. e la dimiouziooP dell'utlito. La diagnos i di iperemia del lnheri nto 'eni,·a ad !ìia pel qna,Jro smtomat ico, rome per l'a ..;seu7.a di forme morho:;e propne dell'orecrhio medio, e di malattit> cereh1·ali.
L'opinione abbastanza fondata otoiatri moderui intorno alla rarit1t ùelle lesioni primitiYe dell'orecchio non dn>e,·a renderei titubanti sulla localizzazione Ilei promorhoso, poicltt\ se la po5izione profonda degli organi che costituiscono il laherinto li mette al 1·iparo dalle inUnenzc nociYe dei mezzi esterni, non è me n 'e1·o che essi po5sano risentire l'effetto di agenti tleleterii circo lanti nel sangue. Che il laherinto poi po:-sa non !ìOio co nt(e:>L ionar:.i. ma primitivamente infiammar:>i l'ha dimostrato il Yollolini colln mnlntti ·l t·iconosciuta dal suo nome, e ritenuta fin I[Ui erroneamente per e lo stesso nelle due !!iovanette, dalla cui os::.ervazione fu inùuuo ad ammettere un a nuova entita morhosa appellata dal suo nome. e alla autopsia delle 'fuali alt ra nota nnatomir.a non trorò rlt11 molta linf;l plastica interes:>ante il laberinto.
Che la lesione anatomo-patologica di natura iperemica si deduce,•a anche dal risultato curativo. il 'luale. 1'1'golarizzamlo la circolazione. potè farci sperare nella guari -
J.!ione; al quale si :;arel•be dovuto rinunciare o' t' mai ltl lesione fosse stata di natura nogistica, o l'esitn in atrolia per compressione di una forma neop lastica.
Nel Pizzolaote, oltre all'iperemia del laberinto origine prima delle sue soffe renze, si era riprodotta a destra l'identica alterat.io ne anatomica t·ome nel Festari. con la particolaritil di una rl ifl'usiune, perclu., com·
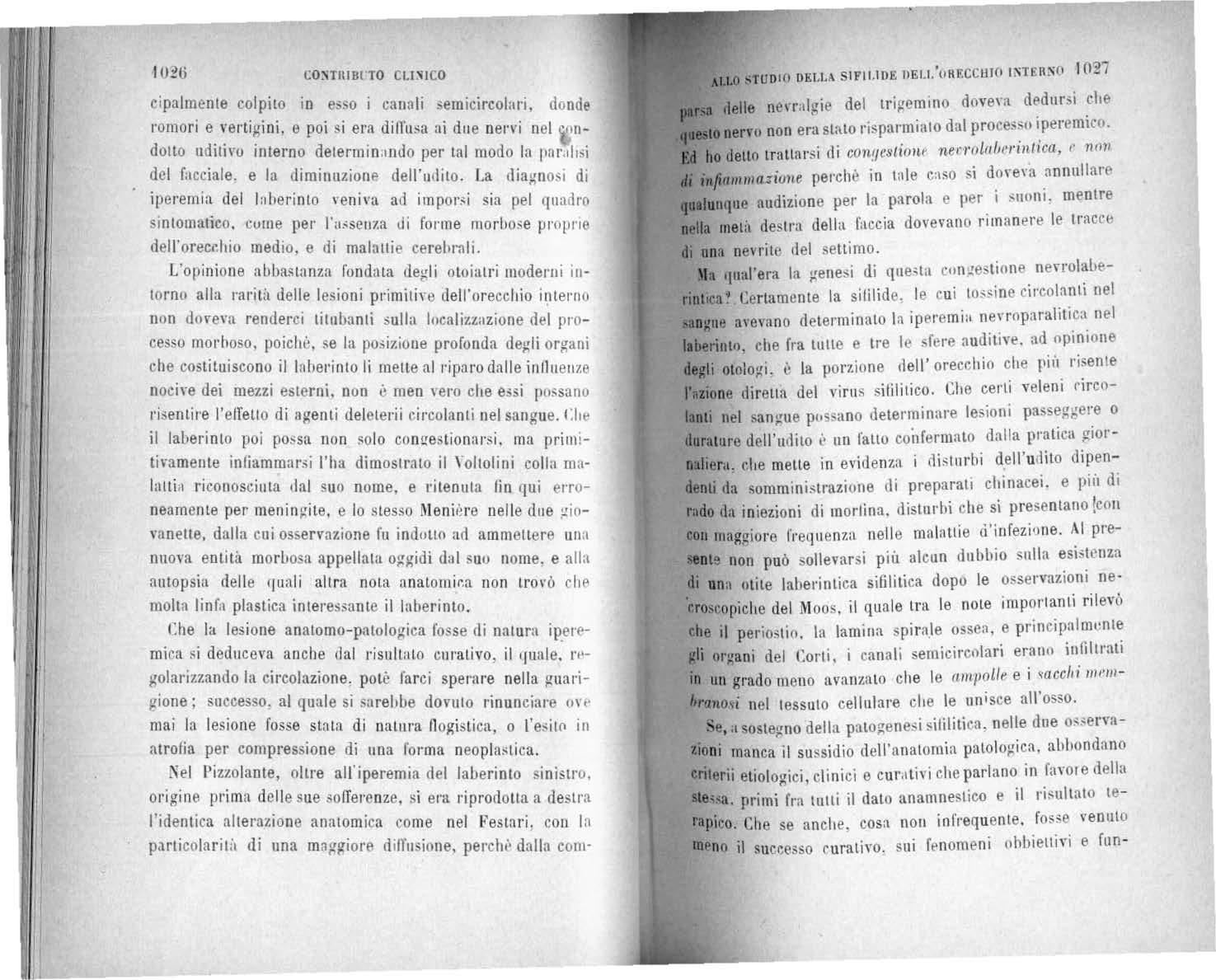
STUOl O OELI.A SIFII.IOI:: llEI.I.'ORECCI:lJO IX'Cii. RNO l 03i rlelle neHalgie del trigem1110 dove' il deùnr;.l ellenervo non era sttltO risparmiato dal proce:;:-o iperemiw. -'1 ho dello trattarsi di cOnfJCStimu ner l'olaln•l·illlica, l' non 4i infinmm a.:ione percht' in tale c:1so dore,·a _n nnullan1 qualunque audizione per la parola e per. i .;uunt. mentre Della met i1 destra della l'accia dovevano nmanere le traCC(' dt una nevrile del settimo. la •tmtl'era la gene:->i di que>ta nen-olaberint•ca 1 Certam ente la sililide. le cui cirr.olanti nel sangue aveHtn o determinato la nel laberint•>, rhe fra tulle e tre le :>ft•re nuùit1Ye. ad np1nwne degli otolo).(i. (• la porzione dell' orecrhio che piit risenle l'11zione tlireua del virus sililiti co. Che certi veleni rircolanti nel snn).(ue determinare lesioni passeg,;ere o dorature ÙE'II'utlilo i' nn fatto confermaLO rlnlla pratica giornaliera. che meue in evidenza i di:'turhi dell' udito dipendenti tla somministrazione eli preparati chinacei. e pii1 d• rado Ila iniezioni di morii nn, disturbi che si prese nt ano !con con maggioro frequenza nelle malattie à'infezi<llle. Al presente no n può sollevarsi piu alcun dnbhio :.nlla esi"tenza di un a ntite laherintica si61itica dopo le ne· 'cros,·opiclt e del Moos, il quale tra le note importanti rilevò che il la lamina :>pirale ossea, e gli del Corti , i ca nali selllicirC•)Iari erano inlìll1·ati in un grad o meno ava nzato che le ampnl/1' e i ml'lllbrano\i nel tessuto cellulare che le unisce all'osso .
Se, a della patogene.-i l'ililitica. nelle d ne ziooi man ca il sussidio dell'anatomia patologica. abbondano criterii etiolovi ci clinici e cur.1tivi che pa1·lano in fn , ore della n ' ste•,;a. pl'imi fra tutti il dato anamnestico e il risultato terapico. Ch e se anche. cos:t non infrequente. fos:-e ve nuto mPnn il rurativo. sui fenomeni ohhienivi e fun - tO:?"i l.O "\\IIlllU l O ILI\ lCO zionali poteva la tisillnomia di una malatlm ciel la !.eri n Lo prodotla da .;i li lid e.
Otolo.!i t• parlano d i una 'ertigine :;ili liLit·a: altri hanno o:-serva10 In malattia di Heoii•re di origine celtica (Bilnnt:font- 1\napp'. Il avendo studiato quattro t'asi tli ..,jfihdP del l:lherinto, ne llil'sume cosi i carattere : l 0 l ntlel•olnnento noterole dell' n iito che l•ru,;e;lmente con di rliagnost ic;nhili ùell'orel'duo es temo e meri io, P. che non è moti itit-atu col t ratlamento mPccauico.
Sorditil totale o qua-;i di percepire retti , lHm i.
.lo lliminnzintlf' delle pen;ezioni ,}el tli:tpasou per le ·ranidte. pen'eziont• prr la via aert•a che per la vra ossea.
'l • \ligliora!uenlo ed anche con un a c:ur;t mi,L·t mollo ener,..ica delle les10ni sililitiche del lahrrin to fin dall'inizio.
:;" t:orrelazione tra i fatti rlinki, ed il risultato clt-lle ricer-rlle an·tlomo-p:ttulogiclte per poco rltP siano ,.,Late.
In sci intli\idui s ililitici con utrezioni primarie dell'orc•t't'hio. P di cui tiue guarirono colla cura mentre n t•gll altri non fil adottala. lo S,'h\\3l'IZ r-ilevò questi siniOIIli : sOrtlitit impr·ovvisa arcompagnala tla rnuwri :\Ogge ttivi nello orecchio o por·zione posteriore del •:apo, vomito, vertigini . .uH11tura vacillante nel lmio o t'amminanclo ad occhi d1i1rsi. l.'es,une diretto dell'or·eccliio negati\o. oppure mcll.t'Vn in evid enza siu tomi rosi insign ifi ca nti da noli ll'tStevoli a la gravezza di'Ila lesione funzi o naie. Ln doccia aerea non miglioraYa le con•lilloni òell'uù1to. la sonlitit em hilaterale: nel ca::.o do'e inrontravasi sollanto da nn orecchio, il diapason veniva senti to piir fortemente dall'o recchio sano; nei casi di malaLLia bilaterale l'istrumento si senti\ a òirficilmente o nientr affauo dalle o::.'a crani che. llefìnita co:-ì la per una i711'1'emia nl'rflllaberintica mi studierò ll i spiega rt' con i dellugli della fisi ologia certi fenomeni in apparenza contr·adiLtori. e certe difli co ltà cli n iche che si presentavano a tutta prima alla mPnte dell 'osservatore.
Politzer. studiando la sifilide dell'orecchio, fa OS:'e rvare che la percezion e cranica diminuisce rapidamente quando l'ort>cchio è preso: e<lli Cozzolino. dopo ave r ri!!ordato che i sintomi dell' olito laherintica tt uelli che compongono la sindrome del )l enière, dà rome carallere patognomico di tloesta sordiLit la rapidità colla quale si basLapdo all'uopo pochi giomi, alcune settimane.
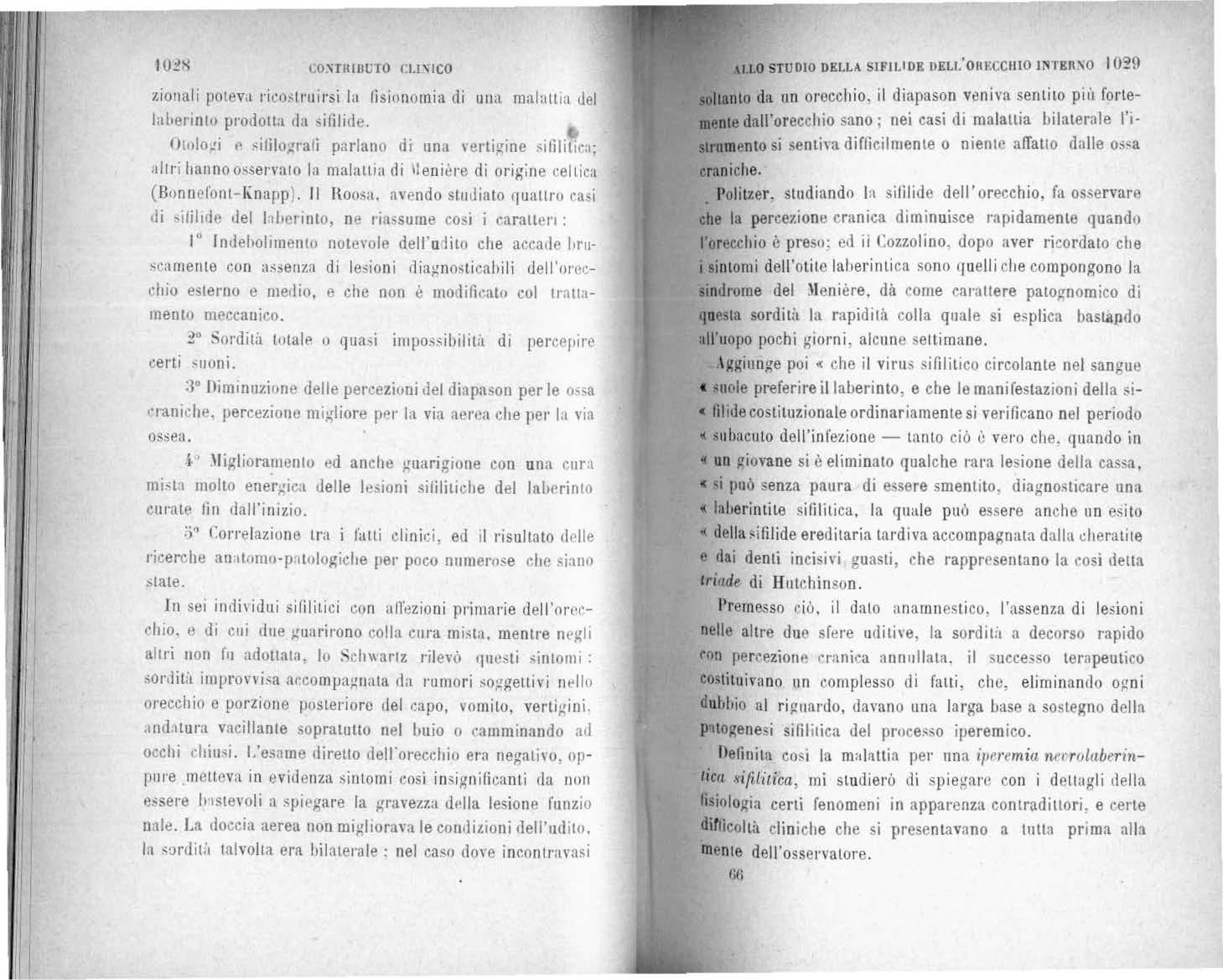
.\ jolgiunge poi « che il virus sifiliLico circolante nel sangue c preferire il laberinto. e elle le manifestazioni della sic lilitle costiLUzionale ordinariamente si verificano nel periodo « suhacuto dell'infezione - tanto ciò ù vero che, quando in oc un :ziovane si è elimi nalo qualche rara le;ione della c si pu ò senza paura di smenltto. diagnosLtcare una « laherintite sifi liLica, la quale può esse r·e anche nn esito « della ereditaria Lardi va accompagnata dalla cheratite 1lai denti inci'i>i guasti, che rappresentano la t'osi detta tri r1de di H utchinson.
Premesso dò, il dato anamnestico. t'assenza di lesioni nell e altr·e due sfere utliLi\'e, fa sorùrlit a decorso rapido ron Jlf.'rt•ezion P ··ranica annullata. il successo terapeutico costitnivan o un comp lesso di falli, che, el iminando ogni dulrltio al ri guardo, davano una larga base a sostegno della p·ttogenesi sifìlitica del iperemi co.
Prima di lullo. trattasi in cruesti cnsi di malattia del Per quale ragione gl'infermi percepivano a distanza la parola. meno il diapason. poco o nulla 1oro-
In otoiatria s i fa differenza Lra mala ttia di e la vertigine auricolare dn ca us t; centrale o periferica, me;.!lio detta di \l enière: e la differenza e analomica e nosografica.
La prima consiste in una congestione apoplelliforme del laberinto. e l'irritazio ne prodotta dai coa guli e le coazioni regressive degli si considerano come momenti causali alti a sviluppare una parte dei sin tomi dte costituiscono il quadro della malattia: l'altra qnasi sempre è dovuta alla gra,·e pressione della stafra sulla fine•tra ovali' o rotonda.
Nella prima si ha nno di vertigini, capogiri, \Omiti , rumori, perdita di coscienza, -caduta e so rdità completa, d'ordinario incurabile: nella seconda si hanno gran parte di qu esti fenomeni, però manca la perdita di coscienza, l'a ud iz ione talvolta è buQna . In questa sono intere ssati i goli canali se mi ci rco lari; iu quella l'alterazione invnde anche la coclea e per essa la lamina basilare. vero organo dei suoni e delle parolo. Molti a nni indi etro ebbi opportu nita di os·· sen-are un caso di malattia del enière, diaJ!nosticata alter· nntam enle per forma epilettoidi', e per t'ert1gine n stoma clw laeso e debbo dire cbe la l'orma clinica era sostanzialmente diversa da quella riscontrata nei due militari.
Nel borghese la vertigi ne veniva ad accessi; continuo era solo ilromore all'orecchio, progressiva la sorditit; qui invece il bat·col!amento. la vertig in e erano permanenti. l'el primo la malallia, prodolla probabilmente da inll uenza. reu · mati ca si iniziò con forli rumori all'orecchio si nistro egra- diminuzion e di udito associata a vertigine che invade' a ad preceduti da vomito ; qualunque fosse la. posizione dell'i nd ividuo, si condan nasse pure la verti )!iOe si manifesta\'a co n varia dutata di pochi se_co ndt Jl qn!lkhe minuto, producendo, talvolta hat..collamen lt. con bru 'l'l e r epentina caduta, tal altra ohnub1lamento hno a perdita completa di coscienza. Negli di sen;.o compl eto di bene3sere, deambulaz1one uormaltsstma; vita di relazione non alterata da alcun disordine funzionale, eccezion e fatta del rumore, t! della so rdità all'orecchio sinistro. La cnra eupept ic .1. quella deprimente. la idropinic.t e term o-n11nerale non ebbero presa sulla. malattia, la qnnle pei 11oli compen si si esaurì completamente dopo due anni. la,ci amlo, tra ccia indelebile della sua e:'i:-.te nza. una snrdi tìt unilaterale completa, incurabile.
P.lra:,!Onando C(UeStO C}Uadro COlla fo:·ma clinica dei due mil itat"i. facilmente si rileva quanta differenza inter · ceda tra le ste5se sta pei fenomeni che per la durata e l{li esili , falli questi che gi ustificano l'asserzione non si trauasse nelle flue osse rvazioni della vera malattia del
Si (' detto' innanzi che anche quando gli ammalati migliouell a percezio ne uditiva, il miglioramento doveva rialla percezio ne della parola e del!e \·ibrazi oni del diap e non n quella dell'orologio, il quale restava non ane rtitn ua nche a co ntatto del Del fenomeno credo debb a trovars i In spiegaz ione sia nella disposizio ne anatomica. che negli attributi funzionali che si conferisco no alle espan sioni periferiche dell 'ac ustico. (juesto nervo, giu nto al fondo del condotto uditiv o interno, si divide in dne l'am1, uno, il vestiholare, che si distribuisce alle due ampolle ciel comunican ti coi can.di semicircolari; l'altJ'O, tf ··ocleare, si termina nella i ciascuno di questi rami ter·· minali .;ono allrihuite funzioni dive rse a rigoarJo della faroltit uditiva. Secondo lklmholtz le fibre nervose che '' nt'lle ampolle destinate a percepire 1 vihrazioni nou uguali. cioè i rumori, mentre le film' tlt>l ramo t'ocleare, che si perdono nell'organo del Corti, pern .. iJisconn le ribr·azi,Jni ugnali. periodiche, cioi' i suoni ..\ nune,sa que:;ta 1lottrina, che pare accettata da tutti gli otolog1 moderni, essa nei due casi desrritti, nei quali. se è avvertita la parola, nou lo •" il rumore dell'or·ologio, ci dit la spie;.:azi,.,ne del fenomeno st ran o, e può anzi lino ad un certo puuto ilimostrarci elle delle tre parti formanti l'ore cchio interno (vestiholo, ca nal i semi ci rcolari e coclea), le prime due sono strtte mollo più dalla lesione iperemica, venen•lu in par·te risparmiata la coc lea. lln'altrn ra;.:ione del f11Uo può trovarsi nella rilles1Ìione che l'orologio dit rumor·i, e quindi la sua audizione è meno fa,•ile per·cht\ le onde sonore sono poche, e non uguali -mentre la voce è il di più suoni (acuti, bassi, ecc.) ed eccita perciò più facilme nte le fibre della lamina llasilar·e no sernipareti.·he. ifO&rigione d_i gravissimi. casi leggieri si in (l . . . t:he i nervosi siano l'effetto di un a compressione neopla stica o infiammatoria delle ossa, oppur·e la co nseguenza di uo'iperemia nevroparalitica propria del nervo, e l'interrento i' precoce, si può spernre nel successoquesto è tardivo, e =-e il processo anatomico nt'l nen•o t' dt natura infi ammatoria, o semplicemente ma che, trascurato. ha già dato l"esito di atrofia, pretendere che la cura 111i:>ta rimu o\'a o modifichi alternzioni anatomiche insuscettihili di qualsiasi miglioramento è il perchi• nè il mercuno, nè l'ioduro potranno ritornare alla loro iu nziona lità fiore nervose de}.:enerate o atrofiche.
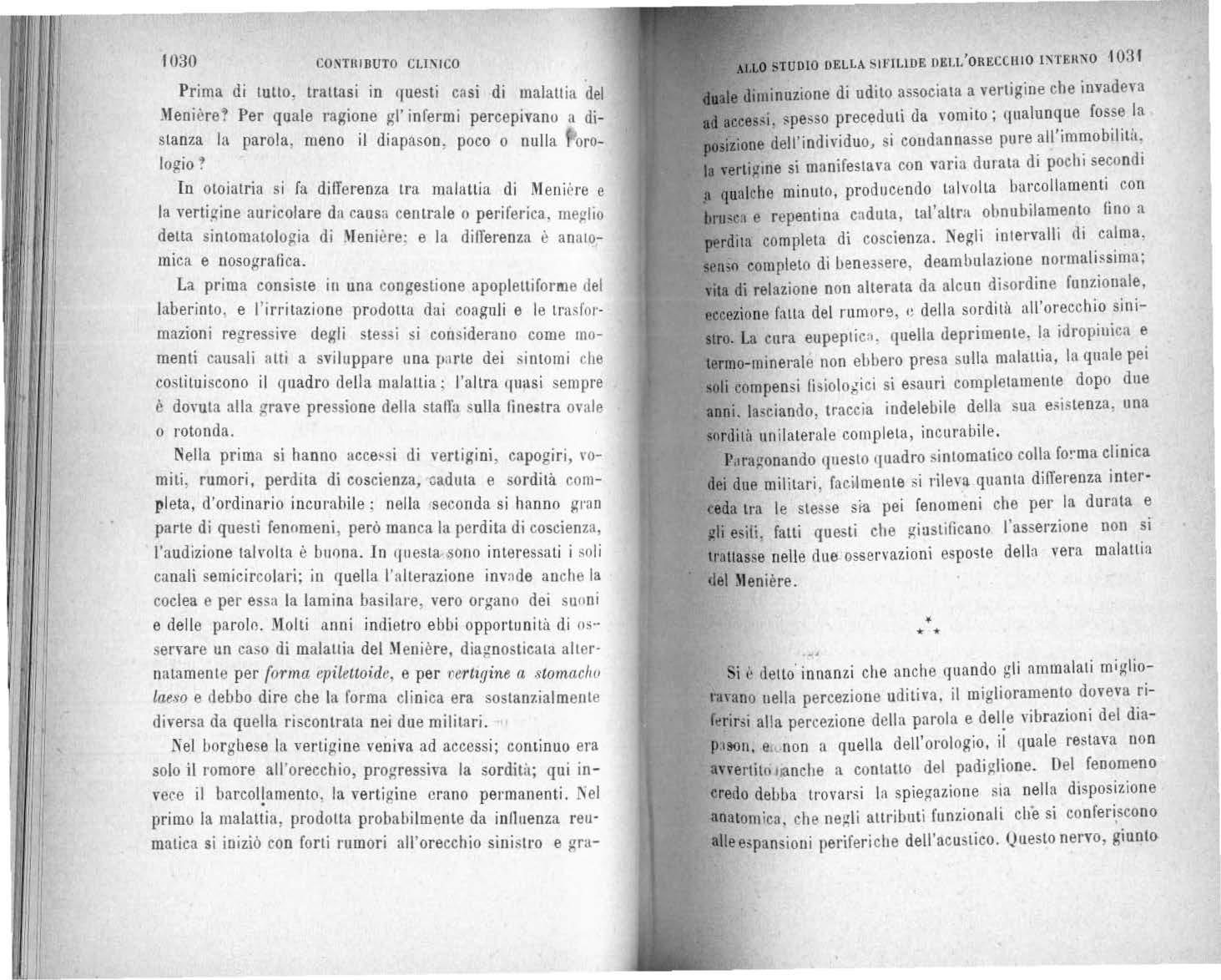
Da que;;La sostanziale differenza d1 es1t1 c denvata un,t o minore fiducia nella terapia, ed è che con •lierna ,.1cenda :;i io ora levato a cielo la .: ura spec1fica e tale altra si è gridato alla sua inertìcac ia.
:\ on ho certo l'autorità. nè la e:;perienza dr nssegnare la ra;iune intorno alla restilntio ad intcgrum o dell'aettslico preso da sifilide: pure. se è permesso esprrmer.'e una idea :;u questo proposito, credo sia il successo tentp1co '-llhord inato all'entilù della lesione cd al per·iodo n'intervento.
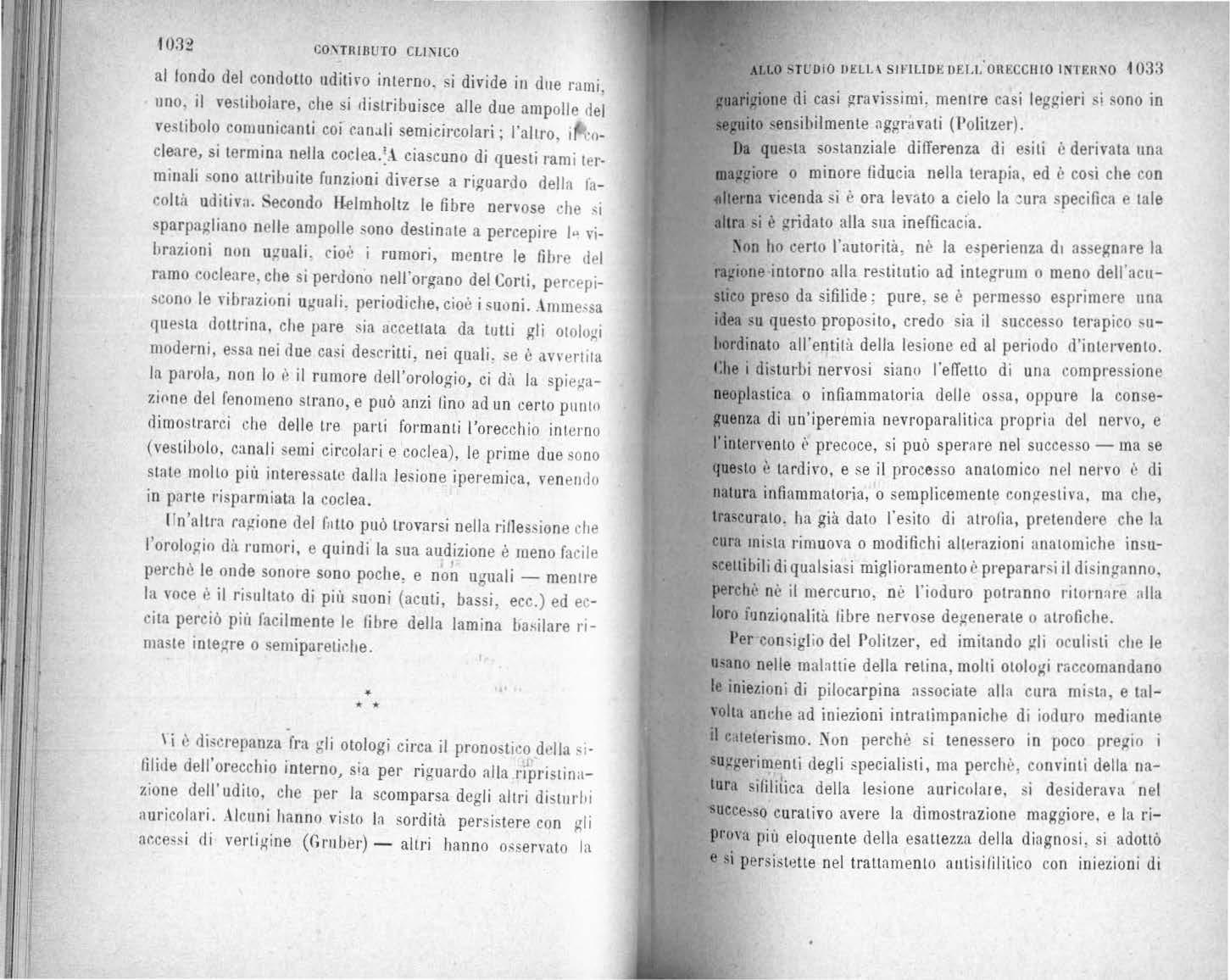
\i l• tii:;crepauza fra gli otologi circa il pronostico dt•lla" · dell'orecchio interno, sia per riguar·do alla rì'p r·istinazione dell'udito, che per· la sco mparsa degli altri distlll'lti auricolari . .\l euni hanno In so rdità persistere con gli eli vertigine (Gnruer·) - altri hanno o.-;servato la l'er del Politzer, ed imitando oculisti elle le osano nelle malattie della retina, molti otologi r:;ccomaodano le inietioni di pilocarpina associale alla cur·a mi,.ta, e tal\'ol ta am·lte ad iniezioni intratimpaniche di ioduro il •:1tetel'ismo. txon perchè si tenessero in poco preg1o ' degli specialisti, ma perch1\ convinti della natur.t sifilitica della lesione auricolare. si desiderava nel succe,so curativo avere la dimostrazione maggiore, e la ripru m più eloque nte della esauezza della _si e l\i persist•me nel trattamento autisililitico con lfllezlonr dr suulimato. e dosi alte di iodur·o (lj grammi al ) .
Il miglioramenLo nvvennto nei primi gio rn i di cur·;•. ··i animò a pro!ìeguirc, nella lusinga che, essendosi inter·venulo all' 1nizio del male, ci si poteva rip1·omeuere la sco mpnr•a della vertigine, della parali:.i , e la reintegrazione completa della fncollit uditiva; ed non senza compincimeuto vediamo realizzata tanta speranza.
Ed ora un'ultima co nsiJerazione. pu1· dando 1.• massima importanza al lt•mpo ed ai polt'l'l fhinlogui, primi fra Lutti i rimedi, ne5.:;uno, dico.
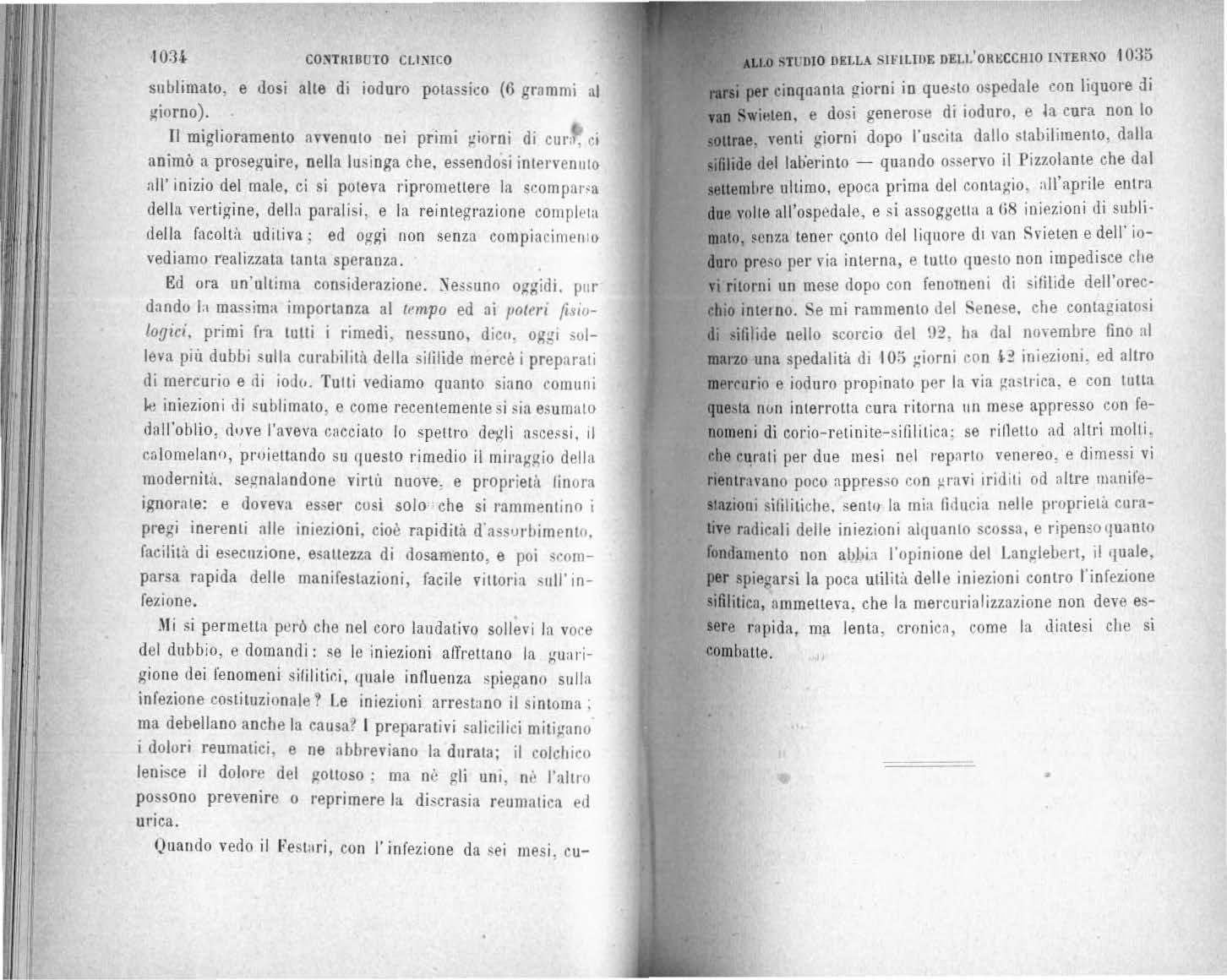
Iava p1ù dubui sulla curahilità della sifilide mercè i prepara1i di mercurio e t!i iotl<•. TuiLi vediamo quanto siano t•o muui k iniezioni lli sublimato, e come recentemente si :'in esumato dall'oblio. cltJVe t'aveva 1:ncciato lo spettro de-r!li nsce!'si, il t'nlomelann, pn>iettando su questo rimedio il miraggio dell a modernità. segnalandone virtit nuove, e proprietit fin orn ignorate: e doveva cosi solo che si ramrnentmo t pregi inerenti alle iniezioni, cioè rapidità d"a,s•Jrhirnentu, facilitit di esecuzione. esallezza di ùosamento , e poi .,,•omparsa rapida delle manifestazioni, facile villori .t .;ull' infezione.
.\l i si perm etta però che nel coro landativo sollevi la voce del dubbio, e domandi: se le iniezioni afl"rettano In ••uari,., giona dei fe nomeni quale inOuenza spiegano sulla infezione costi tuzi onal e? Le iniezioni ar restano il si ntoma , ma debellano anche la causa? l preparativi ::alicilici mitigan o i dolori reumatici. e ne abbrevia no la durata; il colduru lenisce il dolnrr del golloso : ma gli un1. rw l'nltro po ssono prevenire o reprimere la discrasia r·eumalica ed uri ca.
Quando vedo il Fe ">turi, con l'infezione da mes i. eu-
J'II'IÌ per ci nq11anta j!iorni in ospedale ron liquore di 'fiD Sw iaten, e dosi generose di iodnro, e cura non lo sottrae. venti giorni dopo l'usci ta dallo stabilimento. dalla sifilide tlel lab"erinto - quando o,;sE>rvo il Ptzzolante che dal senemhre ullimo, epoca prima del contagio. all'aprile enlra due volle att'ospùdale, e si assoggclla a ti8 inif't:ioni tli suldimato, tener del liqnore d1 van Svieten e dell'ioduro preso per via interna, e tullo que$LO non impedisce che 'i ritor·ni un mese dopo co n fenomeru di "ililide dPII'orecchio interno. e mi rammento del Senese, che di "ililllle nello scorcio dt>l tl2. h;t dal noYemùre fino al marzo una spedalità di l 00 ;:iorn1 t'Cl n \.2 iniezionL ed altro mf'rrnrio e ioduro propinato prr la via ga,u·ica. e co n Lulta questa nvu interroll a cura ritorna un me se appresso con fenomeni ùi co•·io-retinite-sifititicn: se rillello ad allri molti. che r ural i per due mesi ne l venereo. e vi rientravano poco appres-o l'l) n irilliti od nltre manil"estazionl sililitiche, "enlrJ la mia lit!ucia nelle p•·oprielil curative rnd1 rali delle in iezio ni alquanlo scossa, e ripen:w r1 uantu fonda mento non abl.•i ·1 l'op1nione del LanJ!Ieberl, d 'luale. per spiegarsi la poca util itit delle iniezioni co ntro l'infezione sifil itica, :unmeneva. che la mercu rinlizzazione non deve essere r;1pida, ma cronirn, come la ùinlesi che si comhaue.
RIVISTA J\1 E DI OA
Origine centrale e o u ra delle nevralgi e . - Dr.LMIS.(Gazette rtes HtJpitau:c, n. :W, 18fl3).
È una •1uestione mollo inler·essunle, anche dal punto di vista della praticu e della terapeutica, quella dellu sede reale delle nevralgie. Tale questione si ridure a IJUesto: il dolore, u"IIP di qual10iasi specie," prodotto nei punti stessi in cui i malati l'accusano, oppure è risentito in questi punti come se esso vi si producesse, alla gui8a per in cui gli amputali accusano un dolore nei loro monconi rlopo l'ablazione del membro eh e e•·a la sede e l'unica causa del loro male ?
A priori, la prima 1polesi <>embra la più verosimile: essa ba dato origine alla teoria deLla perUerica delle nevralgie(; ma numerosi neuropatologi sostengono la teoria della cent r ale. Se essa non é applicabi le a tutti i cas i, ciò che non é dubbio, ossa ne sp iega il più gran numero e si appogzia sopra a r gomenti atti a convincere.
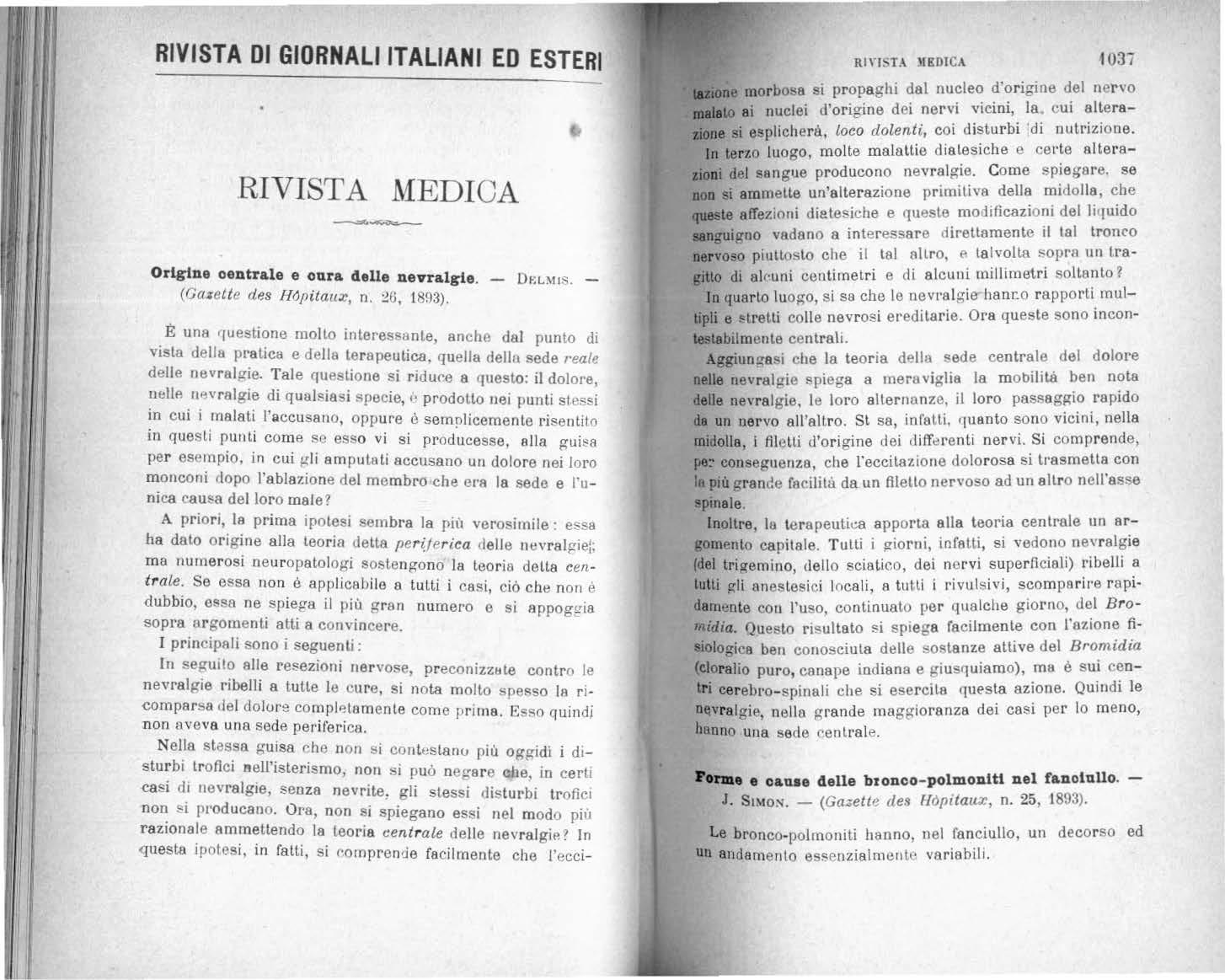
I principali sono i seguen ti:
In seftullo alle resezioni nervose, contrn le nevralgie ribelli a tutte le cu re, si nota mollo spesso la ri-comparl>a del dolol'e compiP.tamenle come p r ima. quindi non ave va una sede periferi ca.
Nella stessa guisa rhe non si contt-s tan u più oggidi i disturbi troftci l'lell'isterismo , non si può che, in certi casi dr nevralg•e, senza nevrite. gli stessi di«turbi trofìc1 non l'>i r•·oducano. Ora , non si spiegano essi nel modo piu razionale ammettendo la teoria cent rate delle nev r algie? In questa ipotesi, in fatti, si romprend e facilmente che l'ecci-
IUiOne si propaghi dal nucleo d'origine del n«.>rvo malato a i n uclei d'origine dei nervi vicini, la cui allerazione si e s pli c hera, loco dolenti, coi disturbi 'di nutrizione.
In terzo luogo, molte malattie dialesiche e certe alterazioni del san gue pr oducono nevralgie. Come spiega re, se non si a mm ette un'alterazi one primitiva della midolla, che queste affezroni dietesiche e queste mo Jificazioni del lir[uido 18nguigno vadano a interessare direttamente il tal trom·o ner voso piullosto che il tal allro, P talvolla !"Oprn nn tragitto dr al r·uni centimetri e di alcuni millimetri soltanto?
In quarto luogo, si sa che la nevralgie hanr.o rapporti multi pli e !' tr elli colle nevrosi e•·editarie. Ora queste sono incontesta bilmc nte centra\1.
Aggiun !.!a !'ll che la teoria dPIIu <>ede centrale del dolot'e nelle spiega a meraviglia la m obilità ben nota de lle nevralgie, le loro allern unze, il loro passaggio rapido da un n er vo all'altro. St sa, infalli, 1ruanto sono vicini, nella midolla , i fll elli d'origine dei rliffe r'enti nervi. Si comp r ende, pe: conseguenza, che l'eccitaz ione dolorosa si tJ'asmella con la piu q r an<!e facilità da un filetto nervoso ad un altro nell'asse spmale.
Inoltr e , la app orta alla teoria cenll·ale un a rgome nto capitale. Tutti i infatti, si vedono nevralgie Idei trige mi no, clello scialico, dei ner·vi superficiali) ribelli a lutti g-li anPslesic i locali, a tutti i rivulsivi, scomparir·e rapida mente cou l'uso, continualo per qualche giorno, ùel B r omùlia. Questo ric;ultalo si sprega facilmente con l'azione fisiologir a ben conosciuta delle !'OSlanze attive del Bromidia (elor alio puro, canape indiana e giusfJuiamo), ma é su i centri cer ebro - spinali che si esercita questa azione. Quindi le nev ral gil', nella grande maggioranza dei casi per lo meno, han no un a sede central e.
Ponne e cause d elle bz onco - p olmonitl n el fa n olullo J. - (Ga.oetle cles f-lòpitauz, n. 25 , 1893).
Le bronco-polmoniti hanno, nel fanciullo, un decorso ed un an da mento esc;pnzialmeute variabili.
È indispensabile di ·tinguPr ne tre forme clini che principali: la forma fulminante. la forma acuta, la forma ordinuria.
La forma fulminante della bronco polmomte ucciùP. • 1due o tre giorni, l'llvolta anche in poche ore: un cuta1'1·o !'Ofgeneralizzalo a lutto l'albero bronchiale>, prQilucente pr.tmo acc!1ito l'asfìssia. presenta, c.:ome l'in tomi pPi n· c1palt, un a ed un'Angoscia intensa, Ullfl "on<,rllit esager ata di Lutto il toraee Allo per•cussione, apnea, r'AJrtoll llni disReminati dappertutL0. una fOJ·ma moltn rnr11.
La forma acuiR è pur·e gruve: la diirata oltrtlpAS'"a r urflmt>ntc gli otto giorni. Oltre le le!'.>i•mi di capillare, alcuni noduli bronco- pueumonil'i hunno ti tempo di sviluppnr·si. La IOI'O pre:::enza prC'ducc. in meuo alla sonorità geoe1·alizzata. alcuni punti di :\la anche in questa forma i di.. turbi f.;nzionali preval!!ono di molto sui segni stelo-;copici.
La bronco-polmonite, nella s1.1a fo r ma più frequento. !Hl un andamento del lutto differente o moltn rn11n0 11c.:ulo. 11 <>uo ioizio i> msidioso. Nel cot·so di una ipertoRsP, eli un'influeozH, di una di una semplice corizza an che, compaiono, in un fanciullo che si sia esposto ol freddo. to-.se, stanchezza, febbre, arnba<>cia respiratoria. La t'ebbre sale lentamente. tmpiega due o tre ftiorni Rd oltrepa;:;.tJre :m l segni stetoscopici sono nulli. compaiouo zone dt tpersonot·ila, apnea, rantoli fini. Il carattere es,.,er.· ziale è il suo andamento per o..cillazion 1, pel' l.e alternative di mi:.rhnrarnl"nti e di ricadute si J•rolungan•• r.e'' un mese. Soven lt i fanciulli :;occombono. f<'ss 1 muoiono, sw bruscatnente per :-:in r·apidamente pet· asfissia,
D t tanto in tanto, sopraggiungono periodi di ed ancl rc di guari!!'ione apparente. Po!:'c ia f'J nuovi noduli b1 fP.bbre r isole. Da queRLe o,;cil· laz10111 u.na ver a SCJ'ezialur a di siot01ui .. te toc;copici. Da un g-tornll at dalla mattina alla $1'ra tutti i !"egni car.nbiano •h po"to e posMno an che cln u11 la to ali altro del pl'l lo. Quec::ti spostamenti se non si " della lot·o po"'•ibiliLu, danno talvolta luogo, 11 co nsulh, a sorprf><;e ed a malintesi.
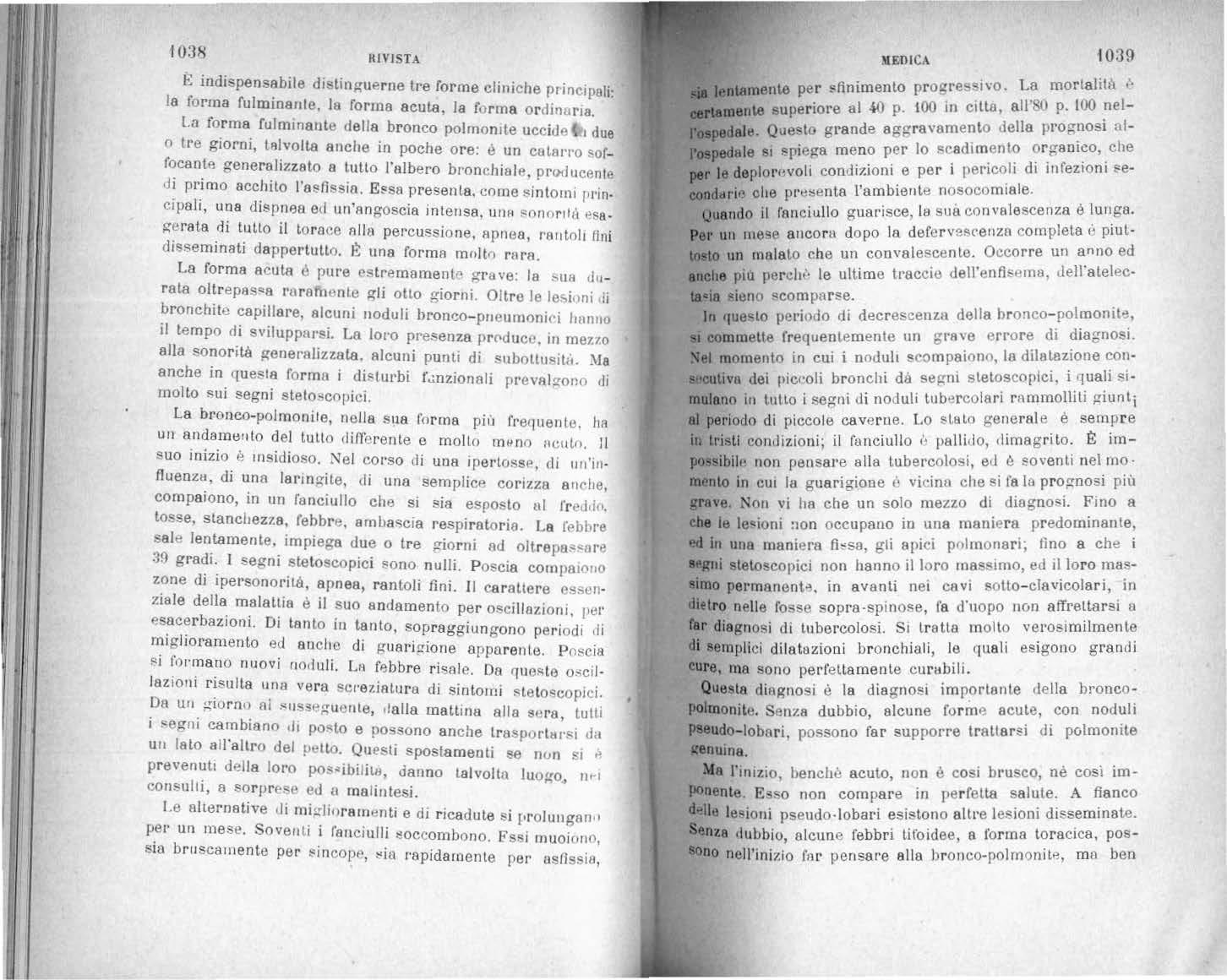
1entatmfmte ptl r !!'finimento progre'-"1 vo. La mortahlt\ ,-. super ior e al 40 p. 100 in citta, all'"O p. 100 nelgrande aggr avamen to Jella prognosi r-1 -
.. s1 '"piega meno per lo c;cadimenlo organico, che per le depl or <' volt condi?.ioni e per i pericoli di infezioni !i'eeood11ri•' che pt·esenta l'ambie1tte nosocomiale
Quando i l fan ciull o guarisce, 11:1 suà convalescenza é luuga. Per un tner;e ancoru dopo la deferveR<·enzn piutlolto un malato che un convalescente. Occorre un anno ed anche piu por cht'· le ultime traccia dell'enf!so>ma, dell'atelecla•18 c;ion o !'compor!>e.
In ' lllll"to pe1'1ndo di decrescenza della sa commett e frequentemente un g1'a'e t'rro re di diagnosi. Nel mom ento in cui i nodul1 scompaiono, la dilatazione consecutiva ùei JHCf'Oiì bronchi da segnt stetoscopici, i quali o:::imalano in tutto i segni ùi noduli tub er co lari rnmmollili l!iunti al periodo di piccole cave r ne. Lo slalo generale è semp r e in tristi con di zioni; i l fanciullo ,·. pallido, dimagrito. È impossibil•• non pensat•e alla tubercolosi, ed è so venti nel mo· mento i n cu1 la guarigione è vicino che !'i fa lo più grave. Xo n vi ha che un solo mezzo di diagno!'i. F1110 a ebe le le..ioni :wn occupano in una manir ra predominante, ed in una maniera fi sa, gli apici polrnonari, fino a che i legr1i stetoscopici non hanno il loro rnasc;imo, ed il lor o massimo pe rm anent-3, in avanli net cavi sollo - clavicolari, in dietro nelle fosRe sopra-spinoc;e, fa d'uopo non afft·ettarsi a far dia gnosi di tubercolosi. Si lratla molto vct·osimilmente di semplici dil atazioni br onchiali, le quali esigono grandi eure, ma son o perfettamente cu r 11bili .
Questa diAgnosi è la diagnosi importante della broncopolmon itt> Senza dubbio, alcuoe acute, con noduli Pttudo-lobnr i, possono far suppo!'re trattarsi ùi polmonite Renuina.
Ma l'm 1zto, bencbè acuto, non è cosi bPusco, nè cos1 imponente Esf"o non compare in pe r fetta salute. A fianco delle le.,ioni pseudo-lobari esistono allt•e lel'>ioni disseminale. Senza dubbi o, alcune febbr i tifoidee, a for ma toracica, posSOno nell'ini zio fa r pensa 1·e alla br onco-polmonite, ma ben lo stato L1flco SI palesa. Questt due dla!!;nosltci non hanno l'importanza del precedente il concorso di due faltort per agente infetti,•o, un terreno pr eparato per lo !=<viluppo ù1 questo agente. L'agente infettivo sarà costi· Luilo dallo dal pneumococco, dallo stafilococco. Il pt•imo predomirtera nelle b r onco- polmoniti lobultu·i, il se· condo nelle polmoniti pseudo- lobulari. Questi microb1 non !ii trovtmo mai nel polmone normale, ma esistono, allo stato nella bocca, nelln gola e nel naso. La loro peuetr·azwne nelle vie aeree, quando essa s ia favorila dal ter· reno, é quind1 facile. Questa ol'igine esLerna è dimostiala clalle localizzazioni pt•odominanti di questi micr obi. E«-<i sono_ più nei b r onchi che negli alveoli. alveoli stess1, ec:e:t sono più nume r osi a l <'entro cile alltl periferia.
Le cogniziom eziologiche sull'ortgine della bt•onco.-. .o\montte banno fatto, in que"t• ultimi anni, reali ed hanno un graot!is"imo intere!'\se per la cura e soprattutto per la profìlas"i.
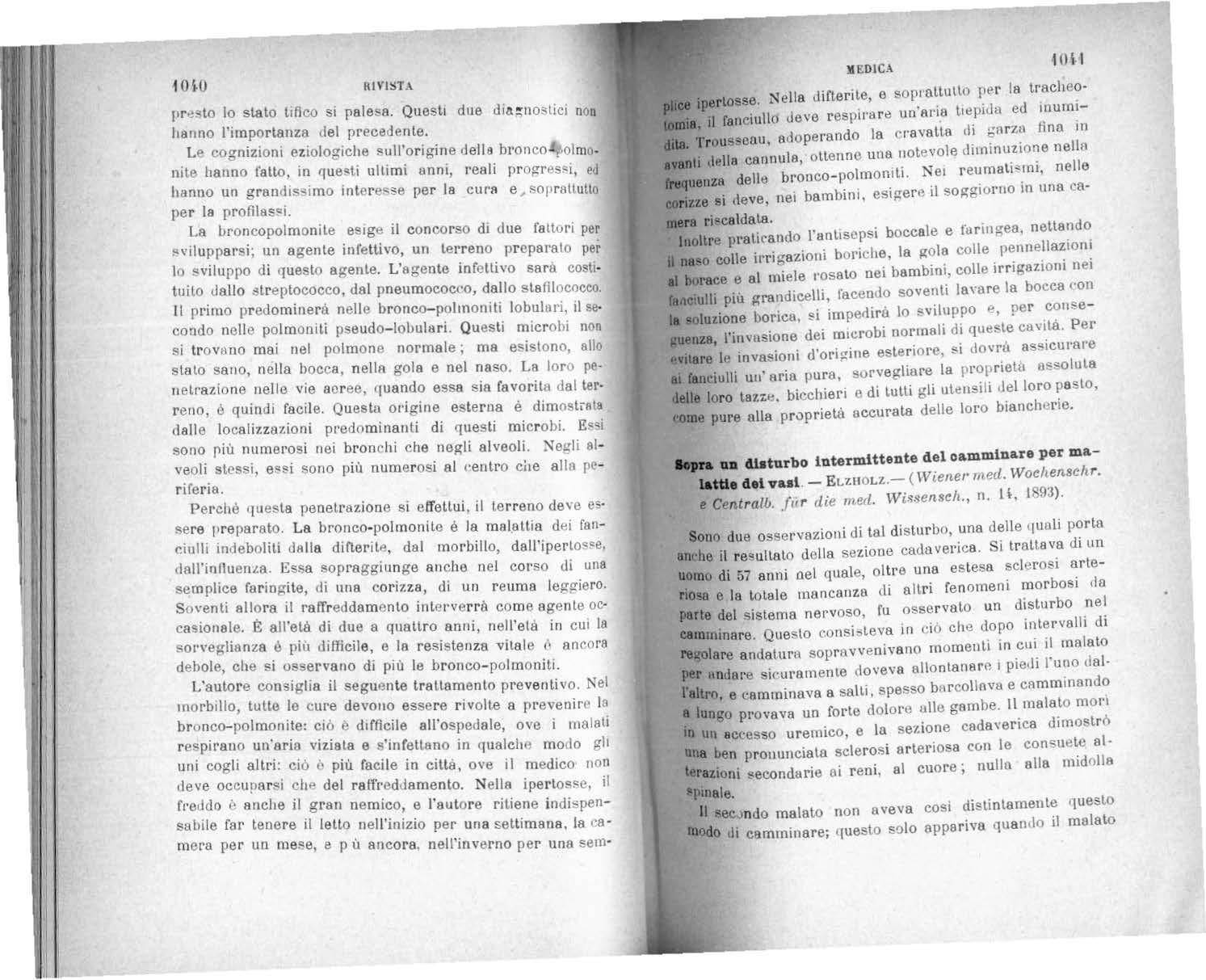
Perché questa peoett'azione si e ffettui, il ter r eno deve es· sere pr eparato. La bronco-polmonite é la m al.altia dt>i fanmoleboliti J11lla dinerile, dal morbillo, dall' iperlo!"c::e, dali mfluenla. Essa sopraggiun ge anche nel corso di una fariog.ite, eli una co r i1.za, di un r euma leggiero. all?ra ti raffr eddam ento inlet•ver rà come agente oc· cas10nale. E all'età di due a quattro anni nell'età in cu1 la sot·veglianza è piit difficil e , e la vita le i• ancora dehole, che si osservano di più le bronco-polmoniti.
L'autor e consiglia il seguente t rallamento preve ntivo. Nel tnorb1llo, tolle le cure devono esser e rivolte a prevenire la bron_co-polmonite: ciò ì> d1fficile a ll'ospedale, ove i malati viziata e s'infettano in f(UalchP modo gh um cogli al lrt: ctu t' più facile in città, ove il medico non del raff1·edùamen to. Nella iper tos!':e, il f1 P anche Jl. gran nemico, e l'autore ritiene indispensablle far tenere ti letto nell 'inizio per un a settimana, la ,·a· mera per un mese, e p ù ancora. nell'inverno per una sem· ce iper tosso. Nella d ifte r ite, e sop ra.ttutl<) per la tracheo· f,emia , il fan ciUllO Jeve resplt'ard un'aria t1ep1ÙH ed lllUrnidita- a doperando la I"J·avatta di :;nrzu finn in avanti ,Iella cannul a, ottenne una notevole diu1inuzione nelln ttequenza dell e bronco - polmonJli. Net nelle corizze si ,Je ve, net bambim, il soggiot'IIO in una ca· mera ri"caldata. llepr& ua dlaturbo lutermittente d el oammlnare per malattie del vaal. - Et..7.IIOLZ.- ( \Viener 11tecl. Woehen.sclt r e Cer>.tr alb . .[l'r die med. Wi!1senseh., n. l\., 1893).
JnoltN pt•atiC"ando l'anllsepsi boccale e nettando U naso colle ir·r iga zioni boriche, la p:ola colle pennellazioni al borace e al m iele t•osato nei bambini, colle irrigazJOni nei rane ulli piil g ra ndicelli, racendo sovenli laYare la bocca 1·on la t10l utione borica, si imperlirà lo sviluppo P, per conl"eguenze, J'in '"nsione dei mtcrobi normali d1 queste cavità. Per ev1tare ! P Jn va!':ioui esteriOI'e, si t!ovrù assicut·a•·e at Canriulli u u· aria pura, sorvegliaJ'e la Jl'Oprietu delle loro tazzf'. birchie•·i e di gli utt!nsili <lei loro pasto, come pure alla propriet.8 accurata delle loro bianch .. rio.
Sono due osservazioni di tal d isturbo, una delle quali porta anehe il re'lu lla lo della sezione cadaverica. Si tr allava di un uomo di 57 an n i ael quale, ol tre una es tesa sclc'rosi artenosa e la to tale mancauzo. ùi alt r i fenomeni morbosi da parte del s is tema ne1•voso, fu osse r vato un disturbo nel camminare. Questo eonsi,leva in ciò che dopo intervalli di regolare a.n da lurn sopravvenivano momenti tn cu• 11 malato per tt ndat·e sicuramente tlo"eva allontanarfl 1 pie<li runo dal· l'altro, e t a mminava a salti, spesso bnrcollnva e camminando a lungo provava un forte doloro allo gambe. Il malato mor1 in un sceesso uremico, e la sez ione cadaverica dimostrò una klen pr onunciata sclerosi arteriosa c<Jn le cono::uelc al· terazioni e:econdarie ai reni, al cuore; nullo. alla midolla 'Pmale.
Il malato non aveva cosi distintamente c1uesto !nodo <li ca m minare; questo solo appariva quan.Jo il malato era stanco e mostravasi con l'andatura wal sicura e bar1•he t>t !'omponeva di piccoli passi •! ren le,·a im magme di chi va avanti a tastoni ron prec zie-ne. Anche qut estsleva una estesa scleros i a r teriosa; ud ePcezione dell'atrofia e stesa regolarmente a Lutti i musco li, sun'alll'a ar>prezzabile positiva alterazion e si riscontra \'9.. L'E. discute la diagnosi differenziale fra questa a ll'e7.tone e l'ata ssia cerebral e, e i distu r bi del cammina r.· nella mielite. nella tabe, e la poliomielite cronica l'.. trofla nei focolat della midolla spinali' per scler ost a rterwsa nella poli n eul'ite e nella pAralisi P<'l'iodicn delle estre mità. Come nella intermillente delll1 Cbarcot é da imputarsene solo la sclerosi arteriot>a, la quale non permette che i muscoli si nutriscano mente per le grandi fatiche. bacilli tuber,:olosi, seguenc.lo, s econdo Weigerl. la ste!;c:a via della polvere dt carbone, penetrano nelle g lanc.lole bt•on· chiaiJ, che, specialmente nei fanciulli, divengono poi i focolai dt>lla malattia
Dott. CARLO SPENGLER. - Bulla. tuberooloal delle glandole bronoh!a.ll.- (Zeitsehrift .fiir Hugiene und In..feetionskrankheiten, volume 1a•, fascicolo 3• del 1893).
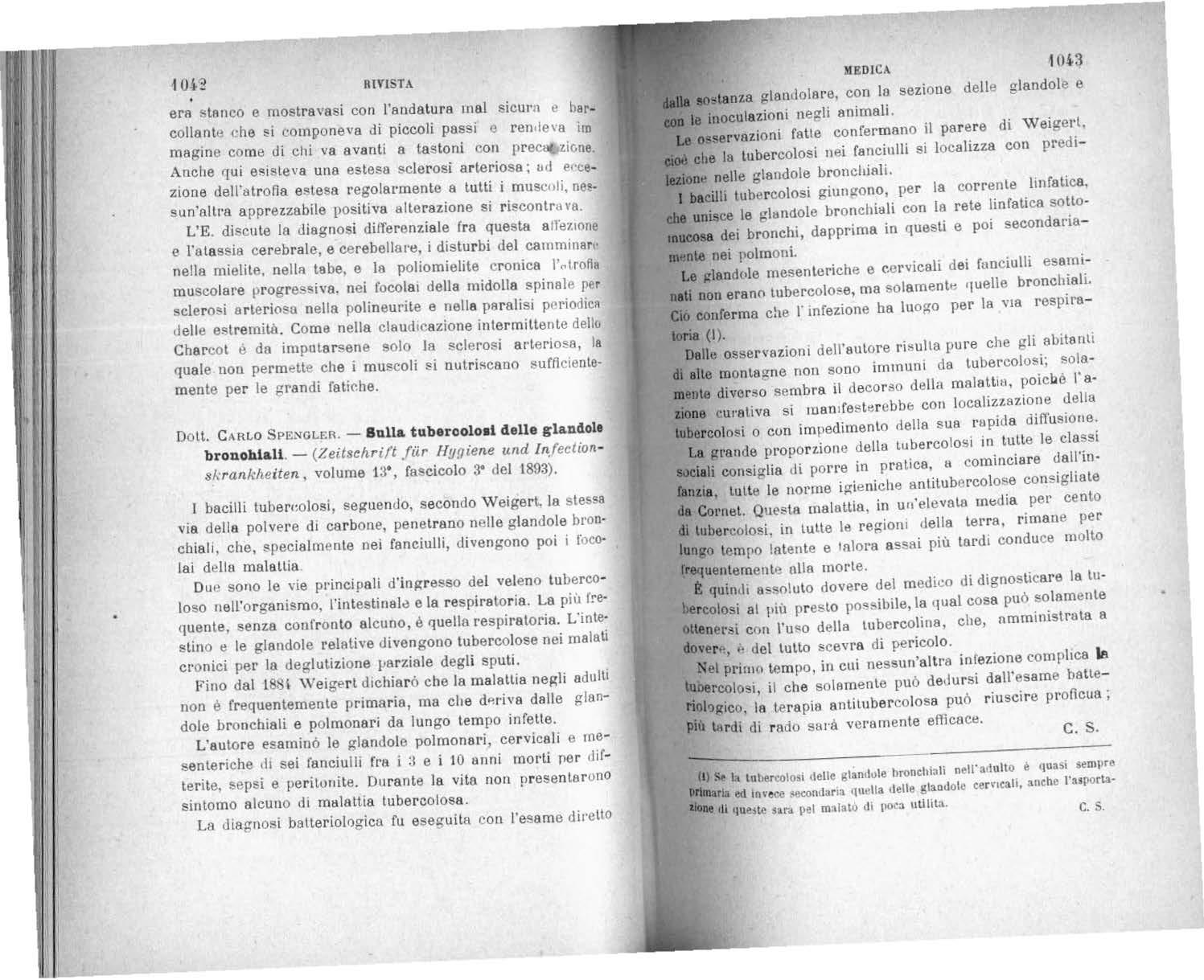
Du l' sono le ,·ie pt·incipali d' ingresso del veleno tubercoloso nell'organismo, e la respirator ia La più llueole, senza confronto alcuno, è quella respiratoria. L'inte· stino e le glandole relative dive ngono lubercolose nei malati cronici per la deglutizio ne parziale degli sputi.
Fino dal Weigert dichia r ò che la malattia negli adulti non é frequentemente primaria, ma che dqriva dalle glandole bronchiali e p olmonari da lungo tempo infette.
L'autore esaminò le gl andole polmonari, cervicali e mesenteriche d1 sei fanciulli fra i ;l e i IO anni morti per tlifterite, sepsi e perilonite. Duran t e la vita non pr esentarono sintomo alcuno dt malattia tubercolosa.
La Jtagnosi batterioll)gicn fu eses:tuita con l'esame di•·cllO eostanza con la sezione delle g landol e e ae inoculazioni animali o osservazioni fatte confet·mano il parere di Weigert. che la tubercolosi nei fanciulli si localizza con predillziont! nell e glandole broncldali. l bacilli tubercolosi per la corrente ltnfatica, elle unisce le ghmdole bronchiali con la rete linfatica sotlo· mDC088 dei bronchi, dapprima io questi e poi secondal'iaJMID\8 nei polmoni.
Le tnesenteriche e cervicali dei funciulli esamiaa\i non erann tubercolose, ma 'luelle bronchiali. Ciò conferma che l'infezione ha luogo per la vta respiraloria
Dalle(l).osservazioni
dell'auto r e risulta pure che gli abttanlt eli alle non sono immun i da tubercolosi; solamente diver:>o sembra il tlecor$o della malaltta, poicbè l'alione ruraliva si con localizl.azione della \ubercol o"t o con impedimento della sua r apic.la diffusione.
La grande proporzione della tube r colosi in tutte le classi IOclali consiglia di port•e in p ra tica, u cominciare dall'in· lanzia , Lulle le norme igieniche s nlilubr rcolose consigliate da Cornet. Questa malattia, in u11'elevata pet' cento eli tu bercolosi, in tu tte le regioni della terra, riman e per lungo tempo latenle e talora assai più tard i conduce mollo rrequentement·· olia mot•le.
t quin.ta assolu to dovere del medico di dignosticare la tubercolosi al pitl p r esto possibile, la 11ual cosa può solamente otlenersi c on l'uso della tube r colina, che, nmministrata. a dover•·, del Lutto scevra di pericolo.
Nel prun o tempo, in cui nessun'altra infezione comphca 1& \ubereolos•, il che solamente può dedursi dall'esame batleriol?gico, la terapia anlitub erco los a può riuscire proficua , più \Krdi di r ado sal'à v<wamente c. s.
(l) SI> h lul.ercolo>ì tlelle bronchiali nell' a•tullo è •tua>• sempre Primaria ed ,po:omlarta •tm•lla olelle glaollole cerncalì, anche I':U(lorta· tloae •Il •tUP.;te pel m'Ila 111 1•0 ·a utili la. • c.:),
Plopneumotoraoe •ubfrenloo e suo trattamento . - E. LEYDEN e REUVEI\S. - (Be r l . lilin.. Wochen.s 1: t'entra/b. .(11r die med. Wissenxch, u. 6, t .!,l:J).
La forma morbosa descritta prima Leyden, u rwlla clinica di questi dal Pfubl solto il nome di Piopneumncoraet sub.fren i co dapprima coi sintomi del pioprwumolorace ordinario. Pera lcunì particolari <::egni fisici (notevole abbassamento del fegato nell'ar.ldome, piccolo spostamento del cuore: il I'espi!•o vescicolare pure udibile immed iatamente sopra l'ampolla d'aria e quindi sopra il diafram ma) :o;.i pur riconoscere al letto del malato che qu,.sto focolajo puruleoto misto a1l aria risiede al di solto de l diaframrna. V1 malattia è stata Onora <::olo osservata irr seguito a perl'ora· zione intestinale, e particolarmente dopo la perfora1.i one di un'ulcera dello <::tornaco o del duodeno o del processo ve rmiforme.
Il piopnoumotorace subft'enico destro ù per lo più causato da ulcera duode nale, l'ulcera dello stomaco cagiona per lo piu l'allezione del lato sinistro. Il piopneumoto1·ace che deri,·a dal processo vprmiforme é in modo particolare infau,.to in quanto che oltre il focolaio subfrenico Lrovansi ordinariamente altri focolai ma1·ciosi fra gli intestini. Ben chl· ::ia pos!.'ibile la guarigione spontanea per perfora zrorw nella pleura o direttamente nei polmoni. pero, com e il L••y,Jen avve rte, difficilii!'isimo. In tulli i cusi in cui s:a pO!òsibile ti indicato l'intervento chirurg1co.
Il Leyden mo<::trò 1 preparati di un in cur 111 una ragazza fu operato felicemenlt> il piopneumiltorace destro che aveva avuto il suo punto di pa rtenza dal processo ''ermitorme; ma l'ultimo esito letale fu conseguenza tlr un fo · colaio subfre nico sinist r o non diagnosticato che <::i e r a ratto strad a nel polmone.
Il Ren vers r icorda cb e finora sono stati comunicai i ascessi sub freni ci contenenti ar•ia, dei IJUOii 3 guar·il·ono <::pon· lan e amente e 10 (con 3 guarigioni) furono sottoposti A operazio ne. La maggior parte di qu esti casi furono dJa;rnosti- eeti dopo m orte o durante la operazione, solo tre volte la dl8gnos i ru fatta in vita .
Il Renvers ba pure r iferito un altro di piopneumotoreee s inistro guarito co n la operazione, il quale deriva va evidente men te da un'ulcera dello stomaco. La operazione fu in questo caso per mezzo della puntura e metodo che l'A. r accomanda per la p ratica generale !'pecialmente nelle picccle città e nalla co mpagna .
Hivist A Chih Uhgi Ca
NIWM.\NN, WALLI NG eù altri autot•i americani.- L ' elettroUil nella oara degll •trlngtmentl uretrall . - (Centra lb . .fu r Chir ., N. 27, 1893).
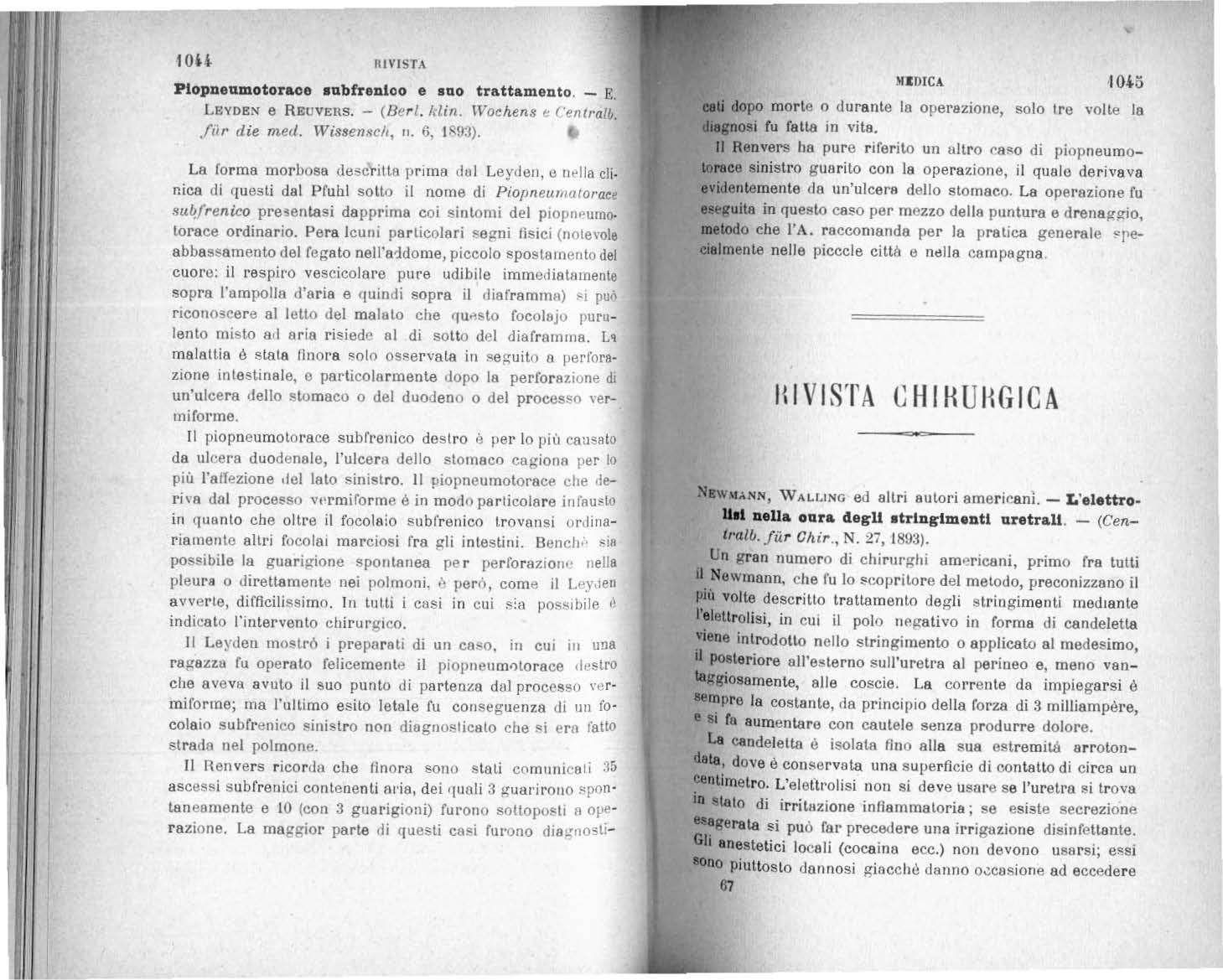
Un g ran numero di chirurghi amf!ricani, primo fra tutti ilN . . ewmann, ch e fu lo scopri lo r e del metodo, preconizzano il PIU volte descrilto trattamento degli striogimenti medtante l'e lettroli si, in cui il polo negativo in forma di candeletta introdotto nello stringimento o applicato al medesimo, il po.steriore all'esterno sull'uretra a! perineo e, meno vanfagg.osame nte, alle coscia. La corrente da impieg arsi è sempre la costante, da principio della forza di 3 milliampère e . , 81 a aumentare con cautele senza produrre dolore.
La candeletta è isolata tino alla sua estremitil. arrotondata, dove é con!'lervata una superfici e di conta tto di circa un L'el ettrolisi non si deve usare se l'uretra <::i trova ID stato d' · · · · · l •rrill:tZIOne mfiammatoria; se esiste secrezione si può far precedere una irrigazione disinfettante. h anesteti ci locali (cocaina ecc.) non devono usarsi· essi sono piuttosto dannosi giocchè danno o.!cas ione ad in fo1·za nello s pingere la Mnda e cosi le r ottu re e le emorral!ie, l" 'fUali devono as>iolufamentp eviLa r sJ. Qualunque so rta di e ac·ces'-1b alla elettroli-.i sia e":so traumatico, sia come puro: quelli cagionali eia tumori (p. es. ipe rlrofì!l della Cin che si clliawa s l rinp-imenlo Spll!' modico non é vero '-'ll·ing1m Pnlo e quindi si esclude da fJUesta cura, due o pit• g1menlt vi della stessa uretra SI rurano fAci lmente come uno soi,J.
E cco come st pr ocede c011 fjueslo metodo. Prllnierasi cerca IJUUle è il nurnero delle candeletll! che puo supe1·1.1re (l) str ing1mento o gli stringunenti. Fatto r1il <:i p1·ende la candeletta, o rella o curva, dal numero imrn•·ilialam onle supei·Ior o a quello Pl'ovato, la si intt·oduco c la !'i spinge fino allo stru1p-imento e !'i fa agi1•e la cot•reule di 3 milhampt;re. Ol)pO uno o dw· minuti la sonda S('inta Avanti con leg..tiPr<l prPssione supere r a lo eri RJI,.ra la s i fa avanzare flno in voscica; subito tiopo s'inlerl'Ornpe la corrente, si e-;II·ae la sond a e cosi te1'1nina la :;ecluta. l':el caso che la sonda non riesca a passa re pet· lo stringimento si aumenl1.1 la co rrente sino a cinque milliampére e secondo alcuni fino a d iet"i o quindici milliampére e 1-1i tenta di supe1•a re l'oc:.;tacolo; se neanche in 'Juesto m oùo la randelt>lta uou va anmti l>i sosptmde l'operat.ionc c si attende da otto a •1ualtnl·dici gio1·ni prima di ripetere 1t tentaLtvo.
N essunR ope1·uzione deve durare piu di dieci minuti. Il paziente, s ia che stia scùuto o in piedi o a letto non deve 1·ic:Pntit•c per questa opet'SlzionP alcuna se ,1ue::.la iukr· viene bisogna abbreviare le sedute X ella seduta sucCPf'-.h·a s 1 l'a passa r P un numet·o più gl'Osso e cosi in dieci o quindici sPdutc 1 nel pe ri odo di alcu11i mesi lo sl ringim ento ò .tilnlHlO t-d in modo stabile. L e r ecidive sono re.rissime; il met"do 1·iesce hene anche nPi casi piu l'ihelli e r·ende inutili ulteriori dilatazioni graduali. lJ paziente durante lu ru ra può atteuci... N alle proprie occupa z ioni senza uYe re mai dolo ri e feh bn• 1w andare incontro a pPr·icolo alcuno. Newmann u;:;a que lo melodo gia da 23 anni cd h11 con esso cu rato oltre 31J() ca-. .-:on risultati assa i favorevoli . Altri autori st>uuaci dPI metndu th
CltliWRG!LI.
••wn1ann hann () cu r alo con successo oltre UOO casi e t1•a queati anche st ringimeoti impermeabili con esito di fistola u r P· trale. Anche paztenli di 73 anni con i pertt·olia mtfliorarono
ZvKE RKANDL. - Bulla extrauretrotomla negll •trlnglmenti impermeabili e .ul catetnlsmo po•terlore .(Centra /b. f11 r Chir 27, 1893).
Nei casi in cni no n s i a trova1·e l'ing resso nello dopo praticato il La g li o esterno clell'urelra é necessari o esegutre il cateter ismo postertore che e sempre di successo.
Questo cateterismo retrogrado può esser e praticato in due modi E'd in caso è necessar ia una operazione preliminare. cio•' o pra tica la epicistotom1a e si guida il catetere dalla ferila soprapubica e per la via della vescica, oppure mettendola allo scope r to, si tlir;seca la rnembranosa dell'ui·etra posta dietro lo stringi mento, la si rend e P dall a fessura c::'ìntroduce il ra teterP che si t'a avanza r e 111 direzione
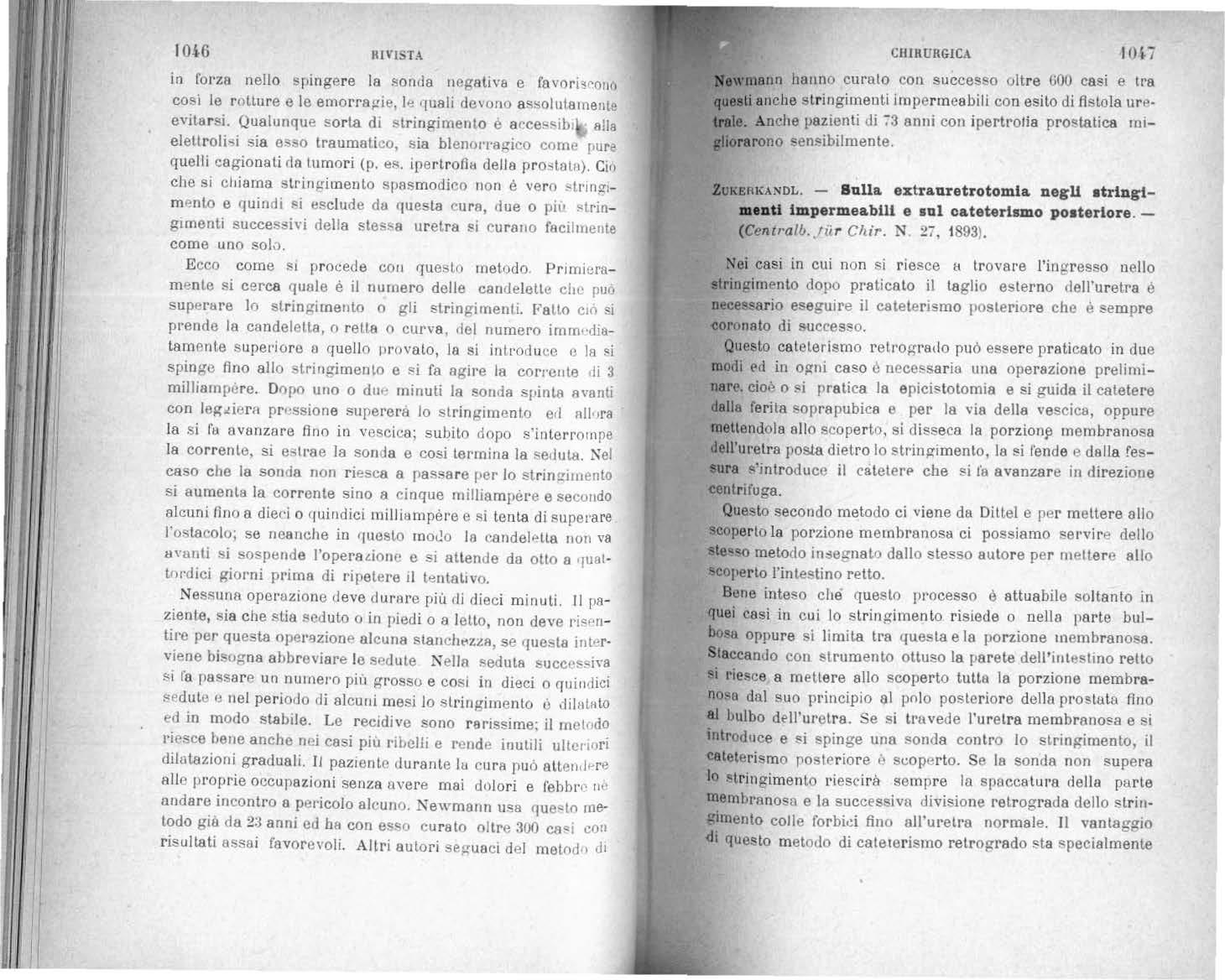
Questo secondo metodo ci vien e da OitLel e pe r mettere allo scoperto la porzione membt•anosa ci possiamo servi r t> dello ste««o melorlo insegnato dallo stesso auto r e per mettere allo «coperto l'in testi n o retto.
Bene inteso che q u esto processo é attuabile soltanto in quei casi in cui lo str ingimen to r is 1ede o nella parte buloppure si limita tra questa e la por zione 1nE>mbranosa. Staccando con strumento ottuso la parete dell'mtt>slmo retto si riesce a mettere allo scoperto tutta la porzione membrano..a dal suo principio al polo poslerlore della p1·ostata fino al lmlbo dell'ure tra. Se si tra vede l'uretra membranosa e si introdu ce e c:i spin ge una sonda contro lo stringimento, il cateterismo postrriore ,., scop<'rto. S e la sonda non supe1•a lo riescirà- sempr e la spacca tu1•a della purle memht•anosa e la successivu divisione ret r ograda dello stri ugimento colle forbid fino nll'urelra no rma le. Il vanta,.,.io di f[uesto m etodo di catete r ismo sta nell'assenza delle complicazioni che possona seguire ad una ferita de lla V6SCICa .
Per contro questo metodo presenta diJfìcolta tecnicb1 rhe non s'incontrano nella cistotomia soprapubica giacch1\ eS$O r1chiede esattissime cognizioni anatomiche della regione ed abili assistenti; l"autore consiglia una piccola modificazion e al metodo di Oeltel, ed f> che in luogo del taglio trasversale seruilunare col prolungare l'incision e esterna med iana s i venga fino in vicinanza dell'ano passando s ul rare de l per1· neo. È indicato il distacco dell' intestino retto, co me il primo metodo, quando in caso di la ce r azioni od altre lesioni traumatiche dell'uretra davanti alla porzione membran osa l'ure· trotomia esterua é rimasta senza risu!talo, nei 11uali casi non si riesce a trovare l'es tremità cenu·ale, e finalm ente è indicato in caso di falsa strada.
Koc HER. - Oontrlbuto chirurgico alla Aalolcgi• del cervello e del midollo •plnale e alle lesioni del c ervello prodotte da corpi ottu.li. - J 1ir Chir., N . 1893).
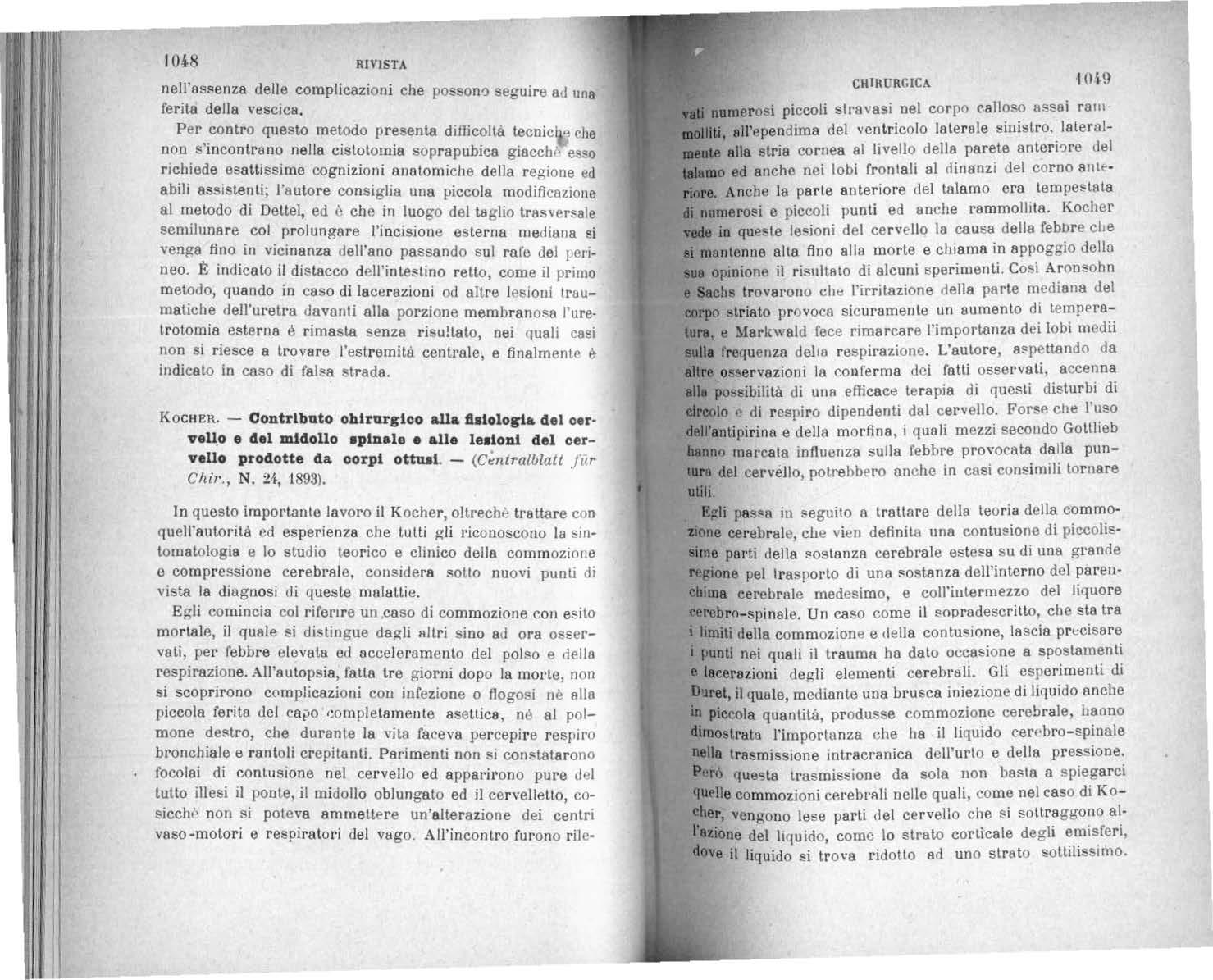
In questo importante lavoro il K ocher, ollrech è trattare c on quell'aulor-ila cd esperienza che lutti gli r·iconoscono la sln · tomalologia e lo studio teorico e chnico della commozione e compr essione cer ebrale, c onsidera solto nuovi punti di vista la diugnosi di queste malattie. comincia col rifert r e un caso di commozione con esito mo r tale, il quale si distingue dagli Hltri sino ad ora osservati, per febbre elevata ed accelet•amento del polso e della respirazio ne. All'autopsia, fatta tre giorni dopo la morte, non si scopr irono c0mplicazioni con infezione o flogogi nè alla piccola ferita del capo '!omplelameute asettica, n è al polmone de!'lro, che durante la vita fa ceva percepire respiro bronchiale e r antoli crepitanti. Par·imenli non s 1 constataroM focolai di contusione nel cer vello ed appat·irono pure del lulto illesi il ponte, il midollo oblungaLo ed il cervelletto, cnsiccht\ non si poteva ammette r e un'alterazione dei centri vaso -motori e r espir a to r i del vago . All'incontro fut•on o ril e·
CHlllURGICA
numeros i piccoli slt•avasi nel c o rpo c alloso assai ralll· all'epe n dima del ven tricolo laterale sinistro. laternlmea&e alla str ia cornea al livello della parete anteri')re llel talamo ed a nche nei lobi frontali al dinanzi del corno anlt · raore. An che la par te a nteriore del talamo era tempestata di numero!!i e piccoli punti ed anche rammollita. Kocher ftde io lesioni del cervello la cau"a della febbre che li mante nne alta fino alla morte e chiama in appoggio della tue opinione il risultato di alcuni sperimenti. Così Aronsohn e Sachs trova rono che l'irritazione rlella parte mediana del corpo lltr ialo p r l)vocl\ sicuramente un aumento di temperature, e fece rimarcare l'importat•za dei lobi mcdii aulla frequ enza del•a respirazi one. L'autore, a!!pett.ando da altre O!l!'ler va zioni la courerma dei fatti osservati, a ccen na alle possibilita di una efficace terapia di questi disturbi di elrcolo " di r espir{l dipendenti dal c erv ello. Forse che l'uso dell'anti pirin a e dellA morfina, i quali m ezzi "econdo Golllieb banno ma rca ta influenza sulla febbre provocata dalla punlara del cer vèllo, polrehbero anche in Ctlsi consimili tornare utili.
pas"a in seguito a trattare della teoria della commollone cerebr ale, che vien definita una contusione di piccolissime pat·ti della sostanza cerebrale estesa su di una grande regione pel tr asporto di una sostanza dell'interno del parenebima cerebr ale medesimo, e coll'inter mezzo del liquore eereb r n- sp in aJe. U n caso co me il sopradescritto, che sta tra i limiti de lla comm ozion e e della contusione, lascia prt::ci sa re l punti nei qua li il traumu ha dato occasione a spostamenli e lacerazion i degoli elementi cer ebraLi. Gli esperimenti di Duret, il qua le, mediante una brusca miezion e di liquido anche io piccola quantità, produsse commozione cerebrale, banno dimostra ta l'importunza che ha il liquido ceN•bro-spioale nella tras miSSIOne intracranica de ll'url o e della press ione. P erò •tue .. ta trasmissione da sola non hasla a spiegarci quPIJe commozioni cet·ebrAii nelle quali, come nel caso di Koeber, ve ngon o lese par Li del cervello che s i sottraggono all'azione d el hfJuido , come lo strato corticale degli emisfer i, dove il liquido si tro,·a ridotto ad un o strato sottilissimo.
Qui bisogna pensare nlJa trasmissione della pressione per mezzo della stes!"a sostanza cerebrale .
. C ue la massa del cerveùo agisca come conduttore è dimostralo dalla esplosione del cranio nelle ferite d'ar ma fuoco dai p r oiettili . .Altre pro\e adduce l autore valendosi degli di L'errar·l P . . · ,. . e1· quest{ :-<1 ser·vi di un Cl'anio ripieno in pat•le di getn parte tli sostanza cerebrale, in cui furono intro· dolh ID tubetti capillari ripieni di liquido coloe vetr mt copnoggelli. Quesli oggetti venivano scor;"i .. rotti caduta sul c r anio di una palla di t'erro di li liltbr•e da varte altezze. QuPi piccoli oggetti !"i disperdevano non solo verso la volta cet•eb r ale ma anch e alla base. Si conP_OI che effetto si mantfestava soltanto quando t rae da ciò la conclusione "'e!i(uenle: • se un trauma colpl_sce direttamente la parete del cranio, si sviluppa imnel contenuto del c r anio una forza che U"'dall'm teJ•no all'ec;terno. Questa fo r za pl·oveniente sviluppo della pressione idroslatica age rldo ta nto ·l d" · d · , 11 1reztone el come sopra altri punli del contenuto Jtella casta in diretto r apporto colla forza del trauma m rappo r to_ inverso collo spesso r e delle pareti del crnnro. Sulla qualità del la le!'ione o contusione che si suppongono avven u te nel ce r vello le ricerche di Sc'-m l u ans sopra a commoziOne spmale Cl forniscono 'lualche indica;,:ione. • Le fibre vengono annienta le senza che dapprincipio si possa d1mostr are tslologica mente 1 "1 dt"«ord"ne · - 1 m esse avvee sollento la s uccessiva frazione e degenerazione del c•hndr asse e la modificazione delle fibre nervee con o senza ùi r a m mollimPnlo o di cif"sll'izzazione nella so..;tonzn ci fanno avvertili dell'avvenuto lesione della so· o· a ccor do con A•hunkiewitz nuUt l'autori' lu possibilitA che la to m pression e falla da uno meningeo si ltmtli allo manifestazione di fenomeni paralitici od irrtlalort locah controlaterali, quindi i sintomi di emiplegia o convulsioni o contr atture laterali. Perci o dobbiamo ritene r e che da ' lu esti sintomi, ammesso che in precedenza si sia constatato il nolo libero intervallo fra il trauma ùel capo e l'insorger e dei primi sinlotni dt emnp1·essionP., si debbo ror diagnosi d i compression>: ce r·ebr ule anche mancando il rallen tamento del polso e del respiro.
Il c.:r_amo era pieno completamente, e l'efi"ello mancava se era lasciato uno strato d'aria tr a le ossa e la sostanza inlro_l tubetti capillari si frange,•ano più ra r amente dei e questt ultimi si rompevano soltanto quando non di :) m. m. dalla paret e interna del c r anio In ogm SI e otlenuto un risultato positivo e si é constatato che ' ' 'elrini st rompevano non solo nella dJrezton edel ma opposta, restando piiJ ou 1ne- ' frammenti o r Jgmallsl nel primo m odo.
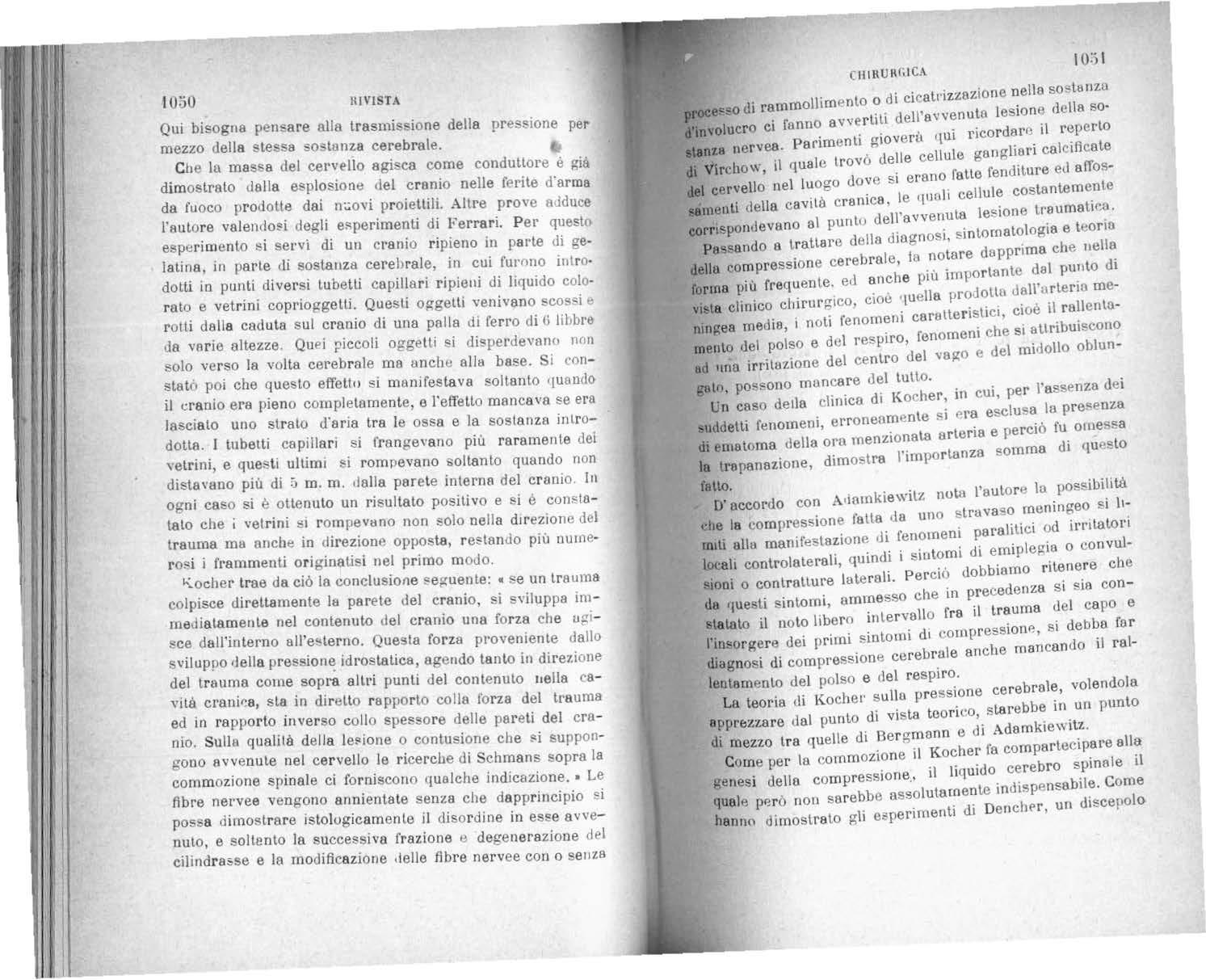
11 er vea. P arimenti gioverò rJUi ricordarn il reperto eli V\rc how, il 'luale trovò ùelle cellule calcificate .tel cervello nel luogo dove si erano falle fenditure ed alfoseémenti della cavità cranica, le qunlt cellule costantemente corr•sponde vano al punto del\"avveuuta lesione traumatica.
Passando a trattare della diagnosi, si ntomalologia e tPorin della com pr essione cerebrale, lo notare dopprtma che uella rorma più frequente. ed anche più importante dal punto di v1sta c linico cioo •1uella proJotlu Jal\"urteria meninf(ea m edie, 1 n oti fenomeni caratter istici, cioè il rall enlo.menlo del polso e del respiro, fenomeni che st atlribui!"cono ad 11na irritazione del centro del vago E> del midollo oblungeln, possono mancare del tutto.
Un caso della. clinica di Kocher, in cui, per l'assenza òe i sudde tti fenomeni, erroneamente !"i era. esclusa la pre!"enza di ematom a della ora menzionata arteria e perciò fu otnessa la tra panazione, dimostra l'importanza somma di I(UPsto fatto.
La t eor ia di Kochet· sulla p r e ssione cer ebrale, vo\endola a ppr·ezzar e ùal punto di vista too r it'O, sta rebbe in un punto di mezzo tr a quelle di Bergmonn e di Adamkte" ilz.
Come per la commozione il Kocher fa cornpartecipai'e alla genes i della compressione.. il liquido cerebro spinale il quale per ò non sarebbe a ssolutamente indispensabile. Come hann n dunostralo gli c.;;peritnenti ùi Dencht>r, un discepolo d1 Kocher, la c ere brale può eslrinsecar:si dopo ch"! il liquor cerebro spinale SI è e vacuato c ompl etamente.
L"aut.ore, d'accordo col Berg mann , spiega la disturbata funzione cerebrale c·oll' os taco lo all a ci r colazion e e rfeJ'Clò ritiene che una limitazione di spazio en tro il c ra nio a bbia por effetto un sv uotamento dei vasi s anguigni inlracerebrali, specialmente delle vene e ro n ciò vengano spremuti an che i condotti linfalici. H del distur·bo rir colatorio, che c r esce col g rad o della limitazione dello spazio. ben si ricoposce chnicamente nei diversi st.adi del quadro sintomatico della co mpressione cioè s tadio della compensazione completa, incompleta ed abolila.
KLC:MM. - Anatomia e terapia delle fratture della rotola. - (Centralblatt fiir Chirur!J., N. 25, 1893).
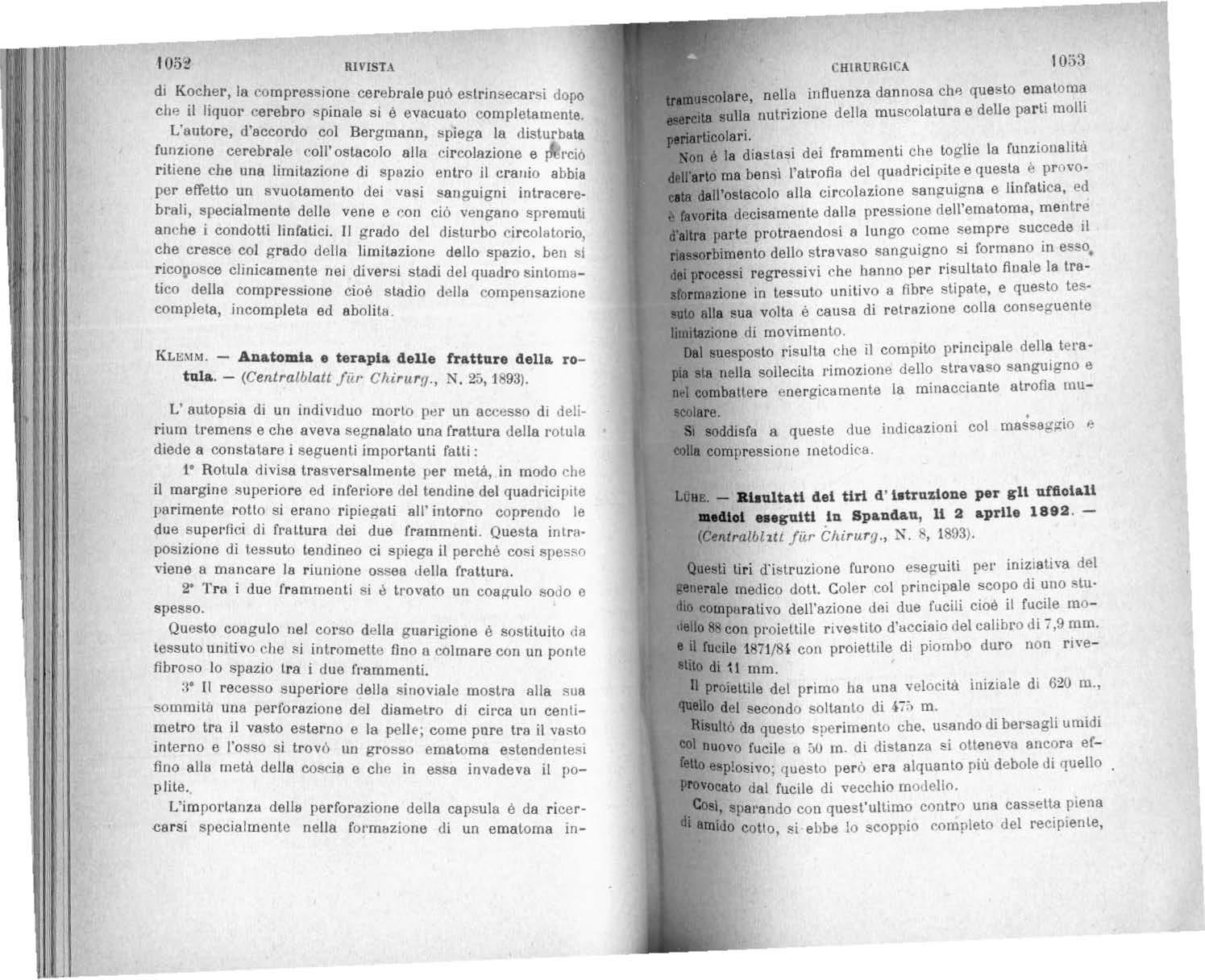
L 'autopsia d1 un indiv1duo morto un accesso di delirium lremens e che ave va segnala to u na frattura della r·olula diede a constatare i seguenti importanti faUi:
1• Ro tula divisa trasversalmente per met.a, in modo rhe il margin e s upe ri o re ed infel'iore del tendine del quadricipi te parimente r otto si eran o r ipiegati all'intorno cop r endo le due s upel'fìc i di frat tura dei due framm en ti. Questa inlrHposiz ione di tess uto tendineo ci spiega il perché cosi spesso viene a manca re la r iunione ossea della frattura.
2• T ra i due fram menti si ò ll'ova lo u n sodo e spesso.
Questo coagulo nel cor so d ella guarigione è sostitui to da tessuto umtivo che si intromette tino a colmare con un ponte fibroso lo spazio tr a i d u e framm enti.
:l' Il recesso s uperiore della sinovialo m ostra alla sua sommita una perforazione del diametro di cir·ca un centim e tro t ra il vasto e s terno e la pelle; come pare tra il vasto interno e l'osso si trovò un grosso ematoma estendentesi tino alla meta della coscia e ch e in essa invadeva il poP lite.
L'im portauza della perforazione della capsula è da ricercarst specialmente nella for·m!lzione di un e matoma in- nella influe nza dann osa chP- q uegto ematoma sulla nutrizione della mu scolalura e delle par li molli n pr oiettile del pr imo ba una vc locitA iniziale di 6:20 m., qllello del secondo soltanto di 4i:'l m.
Non è la diastAsi dei frammenti che toglie la funzi ona lità ciiU'arto ma bensì l' atrofi a del e i> ella dall 'ostacol o aJla ci r co lazione sangu1gn a e ltnfaltca, ed favorila decisamente dalla pr essione dell'ematoma, mentr.e d'altra parte protraendosi a lun go come sempr e suc:ede Il rla810rbirnen to dello strava8o sanguigno si formano m esso, dei processi r egressivi che banno per risultato finale la traatormazione in tessuto unitivo a fib r e stipate, e questo tesIUto alla sua volta è causa di r etrazi one colla limitazione di movimento.
Dal suespos to ris ul ta c·he il compito princi pale della tet·apia sta nella sollecita rimozione dello stravaso sangUigno e Del combattere e nergicamente la minacciante atrofia utuecolare.
Si soddisfa a queste due indicaz ioni col massagp;io .. cona com pression e JOetodi <·a.
LOaE - Jllaultati dei tlrl d ' iatrozlone per gll offlolall ae4lol negottl ln Spandao, 11 2 aprile 1892 .(Central &llU jii.r Chirurv ., ;:\. R, 1803).
Questi ti r i furono e!';eguiti pel' inizia tiva del pnerale medico dot t. Co ler co l principa le scopo di un o !>tudio compuralivo dell'azione dBi due fucili cioè il fucile mo•lello 88 con pl'o iellile r1vec:tito d'acciaio del calibro di i ,9 rom. e il rucile 1871/84 con pr oiettile di piombo du r o non r lveetito di 11 mm .
Risultò da questo sperimento che. usando di bersagli umidi CO) nuovo fucil e o :)0 m. di distanza si ollene''t.i ancora efret\o esplosivo; fJueslo però era alquanto piti debole di quello PI'Ovocato dal fucile di vecchin mo,lello.
Cosi, spar•ando con quest'ultimo contr o una cassetta piena di lllliùo collo , si ebbe lo scoppio <'omplelo del recipiente, mentre col fucila nuovo ::;alt ò v1a soltanto il coperchio. ln moùo !;i comportarono scutole di !alta piene cl' acqua o contenenti <'asselte piene eli c r e ta umula, e si troVò Lhe co1 proiettili a piccolo calibeo il foro d'entralu e erano picco li, all'incontro il canale l'atto nella Cl'ela si allar· gnva nel m e zzo ma verso l'uscita di nuovo s i restrin geva. In un cubo di creta senza ca«sella il pt•oiettile modello si et•a fatto un canale di 6 cent. c. di diametro, mentre la {1allottola di 1 1 m. spat·pagliava tulla la mate r ia
L\I olto dimostrativo ru il paragone con due vesciche tli maiale p1ene d' acfJU8 ; dal proietl1le il/Si- la vesc1ca J'r•stò totalmente lacerata. mentre per l'altra la lacerazione si lirrutò al luogo di del p r oiettile m odell o 88. l pol moni pet· tutti e due i proiettili a 50 m. eli cli,.tanza subirono etfetLi esplosi vi con apertu r a d'uscita di :12: per J'anttco prOJelt1le e solo di 10:15 pe r il nuovo.
Un osso tubulare colpilo dal nuovo nell'epifisi riportò un l'oro con scheggi a, dal vecchio proiettile sub1 l'azione esplosiva.
Un cranio di bue, privo del cervello, colpilo Ja proiettile modello 88 non scoppiò, all'incontro lo sco ppio si ... verin · calo in un cranio di cavallo il cervello.
Il capitano Heyking- che te n ne una confet·enza in que::\1 spet•imt>nti c;o<stieoe che i risultati ottenuti colla carica ridotta secondo il p r ocesso di Ryer non sieno propriamente confor mi a natu r a.
Cbrtamente non lo sono, ma se non si vuole r inunciare agli esper imenti che corrispondano a grandi distanze, non può dall'adottare le cariche ridotte ..\.oche dall'autnro, il quale in questi ultimi 30 anni esegui menti di Liro per il corso d'istruzione dei medici assi s tenti, furono adottale le cariche ridotte per le distanze di oltre 200 m.
Certamente i pezzi di cadaver i appesi che si usaron o per ·le esperienze non riproducevano le condizioni del corpo umano vivente
In questo esper imen to si ottennero sulle epifisi a :WO m. di clls tanza ferile a foro nello, ma fJUesLo non si osser\·ò
ClllllURtìiCA
neUe dia !ìsl , che sempre mostrat'ono uno scht>ggiamento o e steso anche a 1800 m.
Però c• da no tarsi che le più grandi scheggie erano te· nu\e 10 sito dal periostio, m e ntre le piccole scheggte verl'-O 11 foro ;l'uscita orano completamente libere. Ma oslante questo !!cheggia meoto al foro d'uscita ùe\1' oo::so •l. nelle pa r li m olli era :>tt·eUo e a parett lJsc1e, le scheggie gtacevano immediatamente sull'osso e non e1·ano affelto smosse.
WAGNER.- Contributo &llo atudlo dell' azione del proletUll 41 piooolo o&Ubro . - (Cenlralb. fii r Chit', N. 8
L'au tore d escrive 37 casi di fer 1te d'arma da fuoco prodotto cla fuc ile Mannlicher di R 111m. e da lui osser vati in Pra:em )SI. S em bra che in quello sia stata adoperala la vecelna polvere ne rA ma il referente non lo dice. I n 32 la carica fu di car tucce a pallottola ed in tre di cartucce da eser cizio e pet' due casi si è in dubbio sulla qualità della earica. Ris ul ta che tull<:! le 10 ferile della testa, ùue delle lre ferite del petto ed una delle 19 lesioni Addominali finirono colla m o r te, mentre le fe r ile della faccia e tutte le di· ciannove fer ile degli at•li te r minarono felicemente. tre ferile rro Jo tte da cartucce a salvtt, iJ cui prOiettile rappresentato da carla compressa, mancò il foro d'u8Cita. Nel canal e delle ferile sta vano i frammenti del tu· raeciolo di ca rla sminuzzato ed aderivano con una rona alle na rti molli. Uno di quei tre fe r ili mori per tetano. Nelle del cranto, tutte immediatamente mol•lali per •uicidi, la bocca della canna e t·a f;empre stata applicala contro iJ pia no del pavimento d ella bocca compt·eso tra il lll&.scellare in fe r iora e l'osso joide A par 1lil di ci!'costauze esse mostra r ono distruzi o ni sempre in min or g r ado di quelle prodotte in tempi anter iori del proietto W et•ndl di 11 mro. In fatti, quando e r a adoperato a scopo di suicidio il fucile Wer ndl, u na notevole porzione della volta cranica andava perduta e spesso anche una parte di cervello veniv.J lan - cista a dis ta n za; non rimaneva mai uno degli iu· tatti.
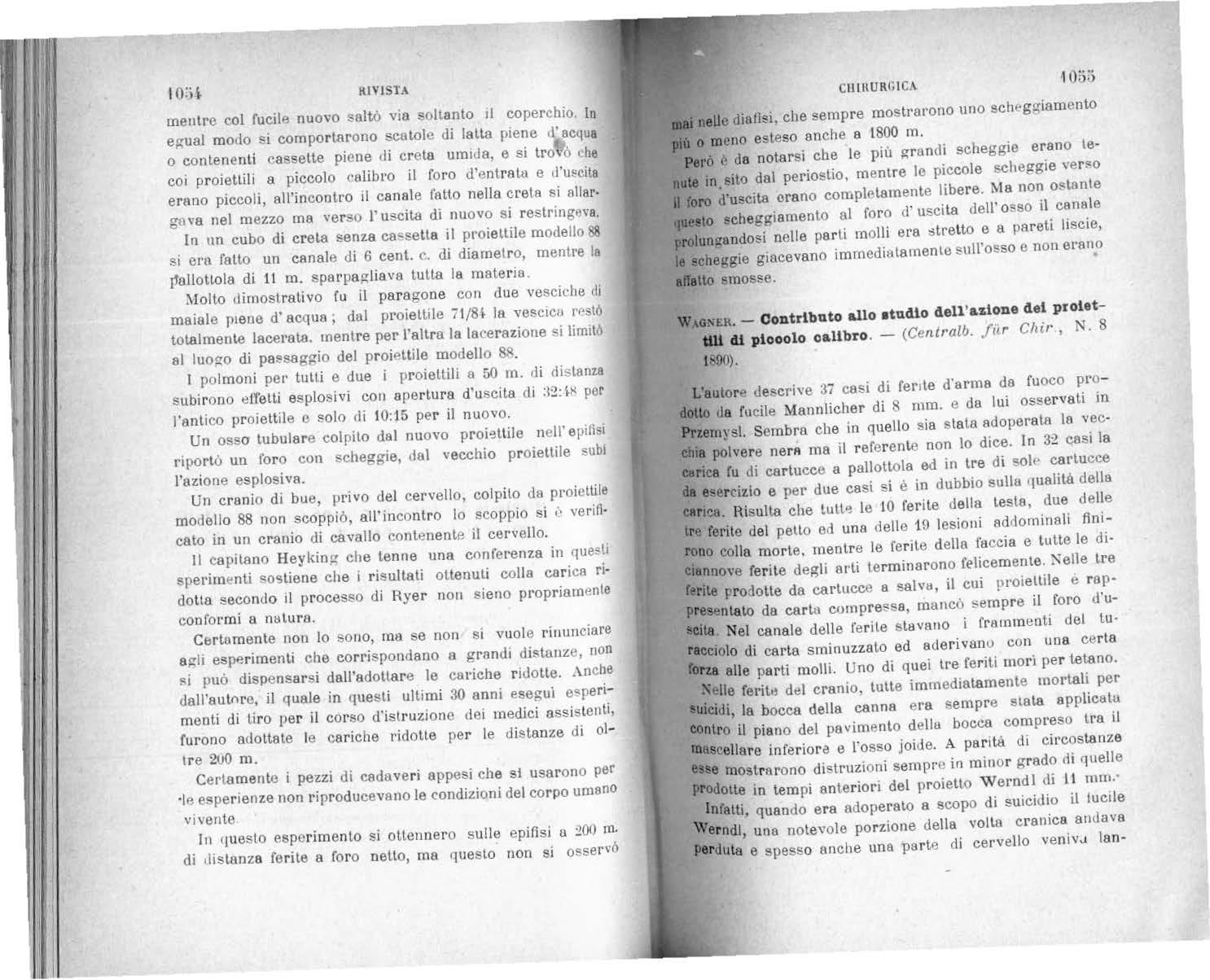
Colle ferite del cranio per mezzo dd fucile moderno lllvece rimanevano notevoli po r zioni di cer'vello intatto e lo scheg · giamonto del cranio el'a molto meno esteso, anzi si poteva vedere benissimo un rotondo foro d'u:;cila che in un caso presentava alla tavola vitrea soltanto il diametro di !l mm. Appunto in que!'llo caso si potevo scor gere in tuttll la sua larghezza un vero canale nella l"Ostanza del cervello. Anche il l'oro d'uscita nelle ossa era in meùia dellu grandezza di un fiorino, e nPlle parti molli raggiungeva appena un centimetro. La pre..sione cavitaria che si 1> sempre verilìcata si accusava colla for mazione eli numerose ed estese fendi · tura e diastasi di suture che erano lP prevalenti. ed iu fine con frattura dell'ossa clelia l'accia distanti dal canale delle ferite, non escluso il rnascellal'e superiore. Delle due fet·ite della faccia causate da mancato suicidio l'una mostrava un foro d'uscita assai largo alla cui o rigine devono aver avuto parte anche i g a s della pellve re. Un a delle ferile toraciche, in cui per una perdita di soslunza a solco sulle pareti del cuore er·ano stati a perti il ,·entricolo e l'orecchietta destra, ru suLito seguita da morte, la seconda poi guarì in i g1orni, anzi l'1ndivicluo dopo 20 giorui rientro al 1·orpl} abile al mili· la re servizio. Eppure egl i a veva ripol'tato a :!0 passi di elistanza una ferita penetrante all'Apice del polmone degtro; con fo r o d'entrata al dorso tre dita a destra e al· l'infuori cieli' a pofisi spinosa della terza vertebra dorsalt>, e con foro d'uscita largo uo dito sopra la metà della clavicola destra. Ne segui pneumolorace, abbon danti sputi di coat:uli sanguigni per tre giorni. Al i • gior'no tanto il foro d'entr·ata c.he d'!lscila e rauo cicatrizzati per prima intenzione. La fe r ita del basso ventre che ebbe esito letale (suicidio) fece constatare effeUi di pressione tdraulica alla milza. In· tet'ess:anti sono i due altri caRi che non tet•mioarono coli!! morte. l n uno il proiettile eoll'ato Ropra il legamento eh Falloppio ed uscito nel mezzo delle due natiche non a ve\'a le<:o, secondo tutte le appat•en7.e, nè l'intE-stino nè le os-.a d ella pelvi, pr·esenluva però un foro d'uscita g rande ed irn- con lesione dell'a r teria iliaca estet'na; 'lueUa f'erita senza quasi lasdare cicatr·ice visibile ma la lesione llll'•ll't8rìa ebbe per conseguenza una trombosi e gangrena gamba corrispondente, che rese necessaria l'amputadelle coscia nella sua parte mediana e poi una riamfldezione con estlo di guarigione . .
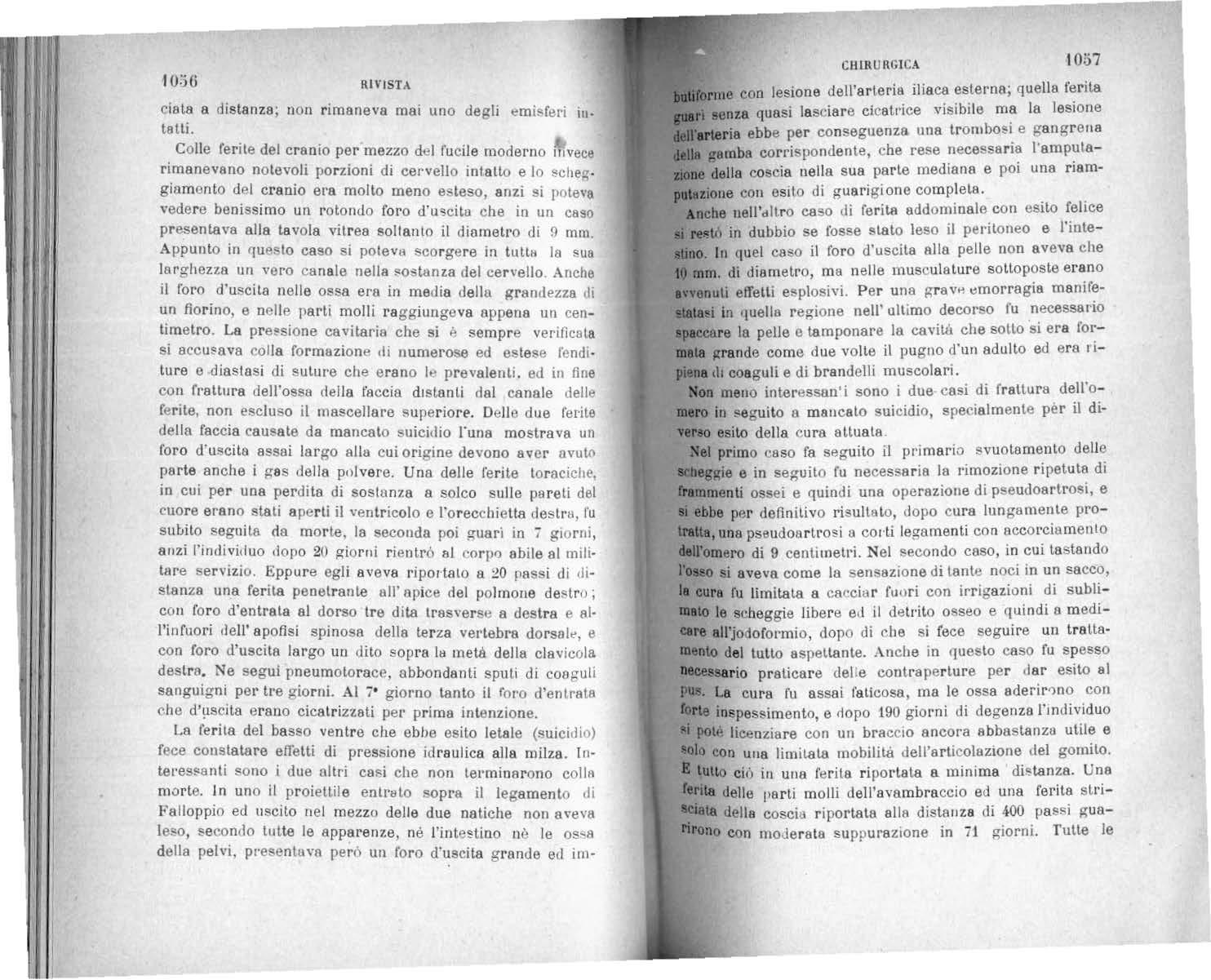
Anche nell'd ll r o caso di ferita addomroale con es1to felrce 11 mtù in dub bio se fosse stato leso il per-itoneo e l'intestino In quel caso il foro d'uscita alla pelle non aveva che tO mm. di diametro, ma nelle musculature sottoposte erano anenuli effeUi e splosivi. P e r una "morragia manifellalaei in •JUellu regione nell'ultimo decorso fu necessario 1paceare la pelle e tamponal'e la cavitil che solto si era fol·•ta come due volte il pu gno d'un adulto ed era t ipiena'" coaguli e di brandelli muscolari.
Non meno interessao'i sono i due casi di frattu ra dell'omero in seguito a man cato suicidio, specialmente per il di'fti'IO esito della c ura attuata
Nel primo caso fa seguito il pt'imario svuotamenlo delle tcbeggie e in seguito fu necessaria la rimozione r ipetuta di hmmenli ossei e quindi una operazione di e 11 ebbe pPr definitivo risull11lo, dopo cura lungamente protraUa, una pseudoartrosi a codi legamenti co n accorciamenlo delromero di 9 centi rnett•i. Nel secondo caso, in cui tastando l'oao si aveva come la sensazione di tante noci in un sacco, la cur a fu limitata a carcia r fuori con irrigazioni di sublilllto le scheggia libere ed il de tt·ito osseo e quindi a m edieare all'jodoformi o, dopo di che si fece segui re un tra ttamento del tut to aspettante. Anche in questo caso fu spesso Decessar io praticare delle contraper lure per cl ar esito al JlW!, La cura fu assai fa ticosa, ma le ossa aderir'>no con forte iospessimento, e ciopo 190 gio t·ni di degenza l'tndividuo ai licenziare con un bracc1o ancora abbastanza utile e eolo con una limilala mobilità ùell'a rticolazìone del gomilo. t lutto ci ù in una ferila r iportata a minima di"tanza. Una fenta delle parti molli dell'avambraccio ed una ferita SLI'i8eiata della cosch\ r iportata alla distau za di 400 passi guarirono con moJe r a ta suppurazione in 71 giorni. Tutte le mutilazioni prodollesi alle d:ta delle mani a piccole dis tan ze guarirono, e quas1 tutte co n cura escluSI\'amenle conservali\ a.
In ognJ caso \"autore o:;servò l'effetto esplosiVO ett-I colp1 vicini meno pronunciato di quello che si osservava una volla, lo che gli dà motivo òi consigliare che il trottnmento conservati\·o c.lellc modern e ferile d'a r ma da fuoco sia .:;pintll fino agli estremi limiti del possibile.
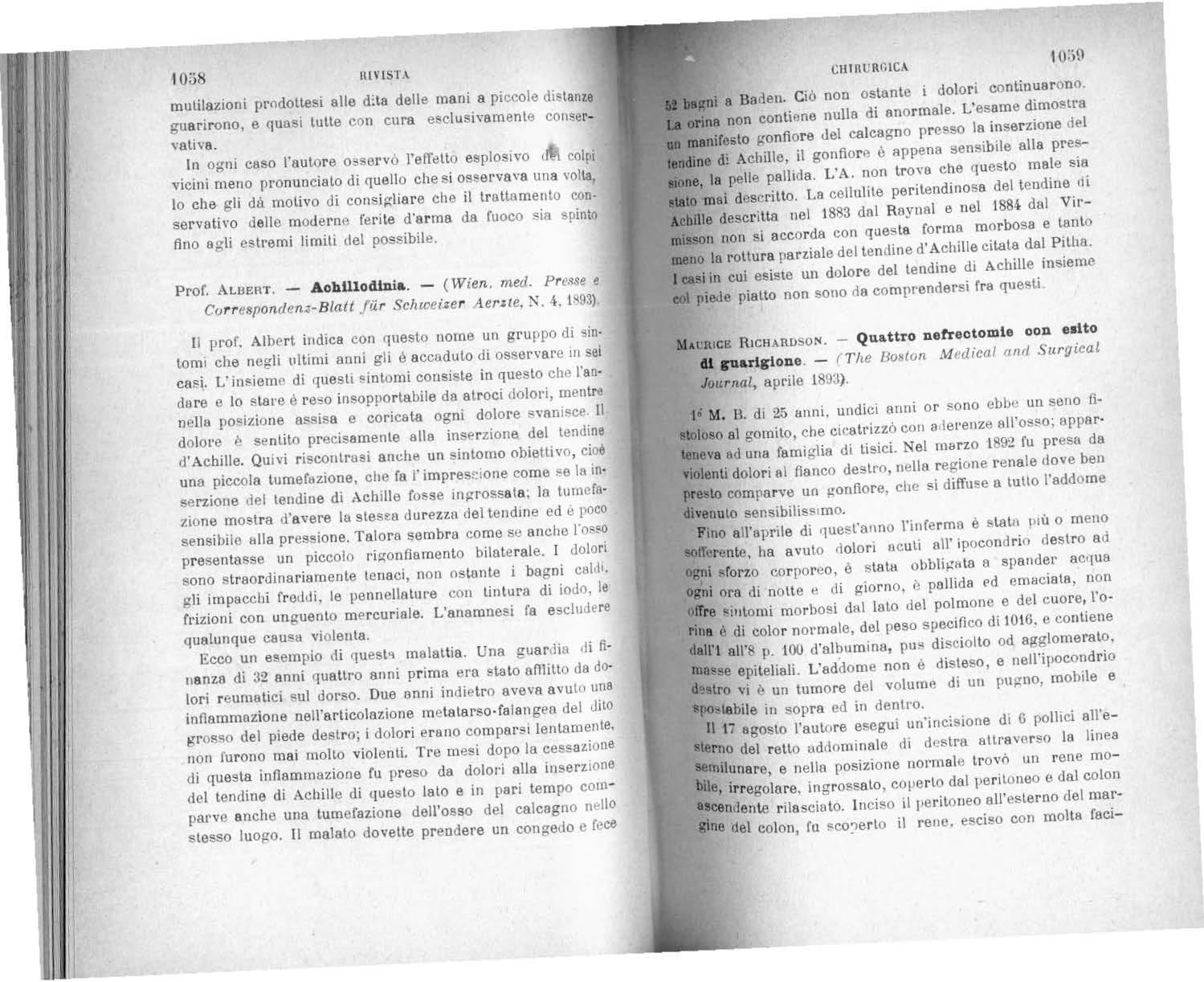
Prof. ALaERT. - Aoblllodlnia - ( Wien. med. Pre.sse e Co r r e sponden;-Blatl fiir Schw eize r Aer.:te, N. 'i.
Il prof. Albe rt indica co n 11uesto nome un gruppo di tom1 che negli l•lttmi anni gli é accudulo di osservat·e u1 sei casi. L' insiemP di 11uesli "in tomi in que sto l'an· dare e lo stal'e r re::;o insopportabile da atroci dolori, menlr<' nPlla poc;izione assisa e coricata ogni dolore c:vanic::ce Il dolol'e i> sentito precisamente alla inserzione del tendine ù' Achille. Qui vi risconlrasi am:he un sintomo obiettivo, cioè una piccola tumefazione, che fa r impres!'tone come la 1n · serzione del tendine di Achille fosse 1ngrossata ; la turnefa· zione most r a d'avere la clurezzn cleltendine ed o poco sensibile alla pressione. Talora sembro come ancho l os$0 p r esentasse un piccol o rigonfiamento bilaterale. l c.Jolor1 sono straordinariamente tenaci, non ostonte i bagni cul•h. gli impacchi fr oùcli. le ponneHalure co11 tintura di iodo, le fl'izioni con unguento mercuriale. L'anamnesi fa esclude re qualunque causa vi olenta.
Ecco un esempio di C(uesl'\ malattia. Una guartlia di fina nza di 32 anni quattro anni pr ima era stato amitto da do· lori reumatici c;uJ dorso. Due anni indi e tro aveva avu to una infiammazione nell'art icolazione m ctatarso- falangea del ùito grosso del piede destro; i dolori erano comparsi lentamente. non fur ono ma i mollo violenti. Tre mesi dopo la cessazione di questa infiammazione fu preso da dolol'i alla inserztonB del tendine di Achille ùi questo Ialo e in pari tempo cOJnpat've a nche una tumefazione dell'osso del calcagno nt>IIO stesso luogo. Il malato dovette prendere un congedo c fece
Ba ien . Ciò non ostanle i dolori continuarono. orina no n contiene nulla di ano r male. L'esame dimostra aa maniresto ùel calcagno presso inser zione del tendine d! Achille, il gonfiore è appe na sensibtle alla eaone, la pelle palltda. L'A. non tro,·a che questo stato mai dos (' rilto. La cellulite perilendinosa deltendtoe t1l Achille nel 1883 dal R aynal e nel 188<\ dal Virmisson non s i acco r da con questa forma morbosa e meno la r ottura parziale del tendine d'Achille citala dal P1tha. 1casi in c ui esiste un dolore del tendine di Achille insieme eol pieJe pia tto non sono òa comprendersi fra que!<li i .; M. 13. di 25 anni, undici anni or !<OnO eblJco un seno fistoloso al "Omito che cicatl'izzò co11 ade1·enze all'osso: appar· teneva od di tisici. Nel marzo 189:! fu presa da violenti dolor i al fianco destro, nella r ep;ione r enale dove ben presto com par ve un !!onfiore, che si d iffuc:: e a tullo l'addome divenuto sensibiliss·mo.
R1ce.>.nosoN. - Qua ttro nefreotomie oon esito 4l suarigtone . - ( Th e Hoston M t·dical nnrl Surgical Jotcrrt al, aprile 18\J:l).
F ino a ll'apr tle di 11 uesl"anno \'infermo è s tatn p1ù o m euo solfert:'ntP, ha avuto rlolori acuti all' ipocondrio destro ad ogni !\forzo co r poreo, é s tata obblijo!llla a acrtua ogni ora di notte P tli giorno, i> pallida ed emaciala, non oft're mo rbos i dal Ialo ciel polmone e del c uore, l'orina o di colo r no1·male, del peso specifico di 1016. e contiene dall'i al1 '8 p. 100 d'albumina, disciolto od m&!'>\'e e pi teliali. L'addo me non è d isteso, e v i /> un tumore del volume di un pugno, moh1le e &po!;labile in sopra ed in dentt·o.
Il ti agosto l'autore esegui un'incisione di G polhci slerno del r etto addominale tli drostr·a attraverso la hnea &emilunare, e nella posizione nol'mak tr ovn un rane mobile, irr egola r e, ingrossato, cope r to dal ]lOr itoneo e dal colon ascendente r ilasciato. I nciso il peritoneo all'esterno del margine del colon, fu !<Co:>erlo il reue. e!'ciso con molta faci -
Iitil tagliando l'u r elere fra. du e legature ad un polltce òall'organo, e legandone separatamente i vasi, che tagliati non sanguina r ono.
Fu quindi irrigato ed a sciugato con garza sterilizzata l'ad· dome nelle vicinanze del r ene asportato, l'uretere lascia to fu suturato n ell'angolo della rerit.a, !asciandovi per dr enaggio una listerella di gar za ster ilizzata che giungeva flno al luogo antecede ntemente occupato dal ren P. Le pareti addominali furon o unite con punti alterni di arge n to e di seta.
Dut•ante l'ope razione l'auto re passò la mauo sul r-ene sinistt·o. che trovò normale in fo rma e volume; tutta l'opera· zione durò 20 minuti, il r ene esciso e r a pe r mela occupato da un ascesso comunicante con 1' urelere.
Nel di seguente l'ammalata emise 620 g rammj d'o ri na, la temperatura sal i a 38°/l ma p resto divenne normale. e .$ giorni dopo l'oper azione. s i rimos!'le il drenaggio, !"inferma e r a apireltica, le intestina funzionavano regolarmen te, quindi al 7o gio r no si tolser o i punti, e l'emissione d elle o ri ne nelle 2't o re ascese a grammi 1500.
30 giorni dopo l'o perazion e l'inferma usci dall'ospedale completamente guarita; ma le avevano ancora traccia di pus e d'alb umina, cellule epiteliali in degene razione grassa. Il t•;me e s tir·palo era tubercoloso.
2• Sarah D. d'anni 3 1, da 5 anni c onse cutivi al secondo parto ba dolori spa smodici nella regione renale sinistra irradia. nti s i all'inguine ed alla coscia , c he du rano un g io rno o due, e s i rinnovano ogni 6 settimane. T re anni sono, per uno di questi ascessi dolorosi ricoverò all"ospedale. fu rin· venuto un a scesso dal reoe, che fu aperto, e ne rimase una fistola lombare, ùalla quale venne fuori orina mista a pu". Dopo I]Uell'operazione stelle relativamente b ene, ed attese ai suoi lavori, ma Ja tre mesi è debole, dimagt·ata, ed ha frequenti brividi.
L'esame fisico mostra una donna deperita, anemica con tempe ratura di 38•,5, polso 82, con un tumore n ella regione lombare sinistro della grandezza di una testa di feto , ben definilo all'in basso, inùe rJnito in alto, con pe r cussione ottusa che >'i rivela anchP all'in guine smistro. Le orine aci de, di normale hanno un peso di 10!8, danno traccia e epiteli squamosi, eccessi di urati e muco. Ne' polmoni ,, nel cuore nulla di anormale. .
Fu eseguita una lungo inci siouo nella linea linistra estesa fino al mat•gine cos tole, ed apel'lo ti peri· loneo r invenne una massa odHrente che riempiva tutto l'ipooo nd r io, fatta dalle intestina cho aderivano basso, e che separ a te, furo n o I'espinle e tenute la diana. 11 tumor e conteneva mone saccoccie dirette m tullt. 1 sensi, le più estreme delle quali penetravano nel mesenter10 del colon discendente, o raggiung-evano il r.orpo delle vertebre. Al centro di questa mussa infiammatoria e ra il r ene, nel quale penetrav9 il seno fistoloso che per tanto tempo era rimasto aperto. . .
F u con molla difficoltà enucleato il rene, fu rtemptLa cavitit che n e risult ava con garza , furono legati con seta 1 vasi r enali l'ureLe re fu legato, cauterizzalo e lasciato nell'addome fu falla un· incisione òi un pollice e mezzo altraYerso il seno fistoloso nel fianco per quale s i rece uscire un grosso tubo da drenaggto che s r apri\"u pr esso il m csente rio del <·olon òisce11ùenle, dal rruale per tutto il ...iorno c la nollfl con tinuò un gemtzto eiero>'o; l'inrerma tolle r ò bene l'operazione che non dur ò ptù di m ezz'ora. . , .
Nel gio r no seguente rurono e me!>si :340 d or1na, al :l• j:iior no vi fu nauseft e dcll'atldomt>, mtt. la ferila ;.i manteneva asciutta, e c.omin ciava a granulal'e, onde tu ricoperta con garza io.!ofor·mica, le deiezioni alvine comparv•'r o per la prima volla. .
Dioci giorni dopo l'operazioni• le orine et·ano Pf:so specifico di 1012, con tr•a ccie d'albumina, muco, eptteltt pavimen losi ma non ci lindri.

Per un a settimana ancora lo ferila fu medicata tutti i giorni, poi ogni due giorni; la cavilli ri e m pi di g ranula·
J.JOni, onde fu tolto il drenaggio
Al 14 settembre. 18 giorni dopo l'allo operativo,_ ai sen tiva bene la te mperatura era normale, comtnc1ava ad aum rn tur e in 'peso, l'emissiOne delle orine ammontava a t' grammi 160 ed il 6 ottobre usci dall'ospedale perfettamente guarita .
:l• Lucinda W . di 2V an ni aveva avu to ctnrrue ligft 1 un aborto, la sorella era mor·ta di luberr·olosi etl IH'r 10 anni a ,·eva avuto fiCC"f'S!'i di dispepsia dolorosa, sputi F>anguigoi senza tosse, H ad accel"so avevu notato l'aumento di una inlume!';cenza alla regione lombAre clt•!<lt·a. avvertila giù da i nnni. N egli ultimi 10 giopui i dolnt•i urano stati violenti e ft•equenti, aveva avuto brivtdt ed ll''"'·a YOmitalo una mt'zza laua rlt bile.
Il tumore dalla lo mbare si PslenùeHI 111 nHmt i fino alrombehco, di"Ct!OtiPva con la respirazione, et·a dt fo rma globosa, doloroso alla pr e!'stone ed Il rene ,..jni...tro non era soo:;pettaiJiiC'. L'enorme massa non pot e"a ..... !<l!rf'! allontanala dal fegnto ehe nella posizione genu-<·uhtlale, gonfiando il rello con ll<'r'fUR gasosa il tumore ern J'M•pinto in su ed in dietro, l'orina conteneva pus, cellul e epitt'liuli e voco sang u e, ma eil indt•i r e nali .
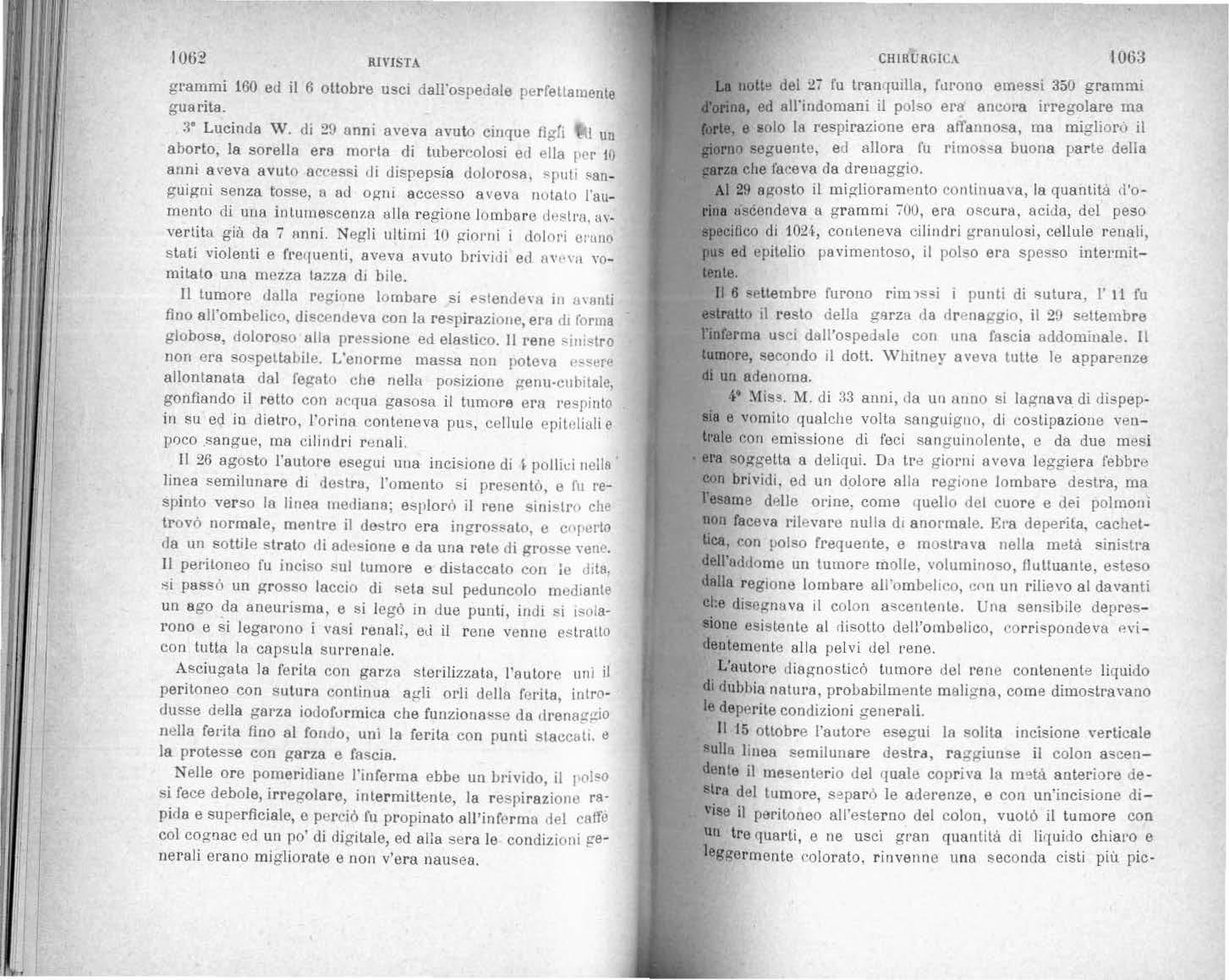
Il 26 agosto l'auto1·e esegui uua incisione di pol111:i nella· linea di rlestra, l'omeuto si presentò, e fu respi nto verso la lineA tucdiana; esploro ti rene sinbll•., cbe trovò normale, mentre il era ingt·os<:ato, c cnpel'IO da un sottile strato di od sione e da una rele tli groc;c;e ,·an•'. I l periloneo fu "UI tumore e distaccalo tou ic dtla. :-;t passò un grosso laccio di seta sul peduncolo mcdtanle un a go da aneu1·isma, e si legò ìn due punlt, indi l<'i '"'Piarono e si legaPono i vasi l'enali, eti il rene venne e;;lratlo con tutta la capsula SU I't'enale.
AsciugaLa la ferila con garza sle •·ilizzala, l'aulot·e un1 il peritoneo con su tura continua orli della ft>t·ila, inlroùusse della gat·za iotlofùrmica che funziona'- se da drena!!!!IO nella ferila fino al fonclo, uni la ferila con punti staccati. a la p rote::;se con garza e fac;cia.
. Nelle ore po_meridiaoc l'inferma ebbe un b1·ivido, il f'0l"o SI fece debole, 1rregolare, inlermillenle, la respirazione rapida e superficiale, o perciò ru propinato all 'infe rma del calfe col cognac cd un po' di dig1tale, ed alia sera le condizioni f!enera li erano mi glio rate e non v'o r a nausea.
Lran ruilla, fllrono emessi 350 grammi d'onna, ed all'tndomani il pùl'-o era ancot·a il'regolare tnn forte, e tml o la res pirazione era afftwnoc;a, ma migliorù il giorno segue nte, ed allora fu J'imos"'a buona pa rte che faceva da drenaggio.
Al 29 agos to il miglioramPulo rontinuava, la quantita cl'orina ""'condeva grammi 700, era acida, del peso epecillco di JO:H, conteneva cilindri gt•nnulosi, cellule renali , pus ed epitelio pavimentoso, il polso era spesso intet'miltentc.
Il 6 "t>llembre furono rim i punti di <;utura, l' 11 fu estratto il resto della gqrza da il 2H settembre l'inferma us rt cou una fascia addominale. Il tumore, "econdo il dott. \Vhilney a ve vA tutte le apparenze di uu adenoma.
M. di :33 anni, da urt nnno si lagnava di dispepsia e vomi to qualche volla sanguig rt o, di costi pazione vtlnlt·ale ron emissione di f'eci sanguinolen te, e da due mesi era "oggetta a deliqui. tra giot•ni aveva leggiera l'ebbt'•' cou brivtùt , ed un dolore alla rep-ti)IH' lombare ùeslra ma l'esam e ù,..lJe orine, come •1uello del cuore e ùei poi:Uoni non faceva rilPva1·e nulla dt anormal e . Et·a deperita, cachell•ca. ron polso frequente, e m ostr11\'a nella metà sinistra dell'nt),Jomo un tumore molle, voluminoso, flulluaule, esteso dalla regtone lombare all'ombeltro, c:C' n nn rilieYo al davanti cl:e dt«egnuva il colon ascentento. Una sensibile depressione al rl isollo dell'ombelico, <'O rrispondevn f'vitleutemonte a lla pelvi del t•ene.
L'auto1'e diag-nostico tumore del t•eue con tenente liquido di duLhia natu1·a, probabilmente maligna, come dimostra\·ano le dept' rite condizioni generali.
Il 15 ottobre l'autore esegui In incisione verticale !<ulJa lmea semilunare destra , il colon a scendenle il mesente r io ùel ' luale copri\·a la anteriore dedel tumore, sapa r o le aderenze, e con un'incisione divise il poritoneo all'esterno del colon, vuotò il tumore con un tre quarti, e ne uscì gl'an quantilti di li•[uiclo chia1·o e leggermente coloralo. rinvenn e una cis ti piu pie- che par imenti YUOtò, onde la massa del tumore si 1:1 che potù facilmente isolata e circondata da un .!aceto. Legò J'ureLer e, e riunì la ferila con sut1ra metallica. maggiore c ura egli pone nella sezione del peduncolo ve r llcalmente all'asse, previ a legatura con seta non troppo gro!'!sa, ste1·ilizzata con sublima to, che pero è imbar azzante l'attrito non pe rmette facilmente di str inaere i nooli debita posizione.
Il rene estratto misurava 25 MnlimeLr1 in lunah ezza ed .lJ .in era in parte sacc&to, in parte s 0 olido, la pat solida rappre:;;eutava ' , del tumore; era di cousistenza e. aspetto microscopico norma le, e si ap r i\'a in un urete re e sepa.rulo dall'altro uretere più ampio, nel quale i l.o porziOne saccata, la qualP era divisa in tre sacchi con loculazioni secondarie, tutte !'baccanti in una pelvi. La sostanza corticale del rene che copriva r 1ueste saccoccie era dura, lìb1·osa, come lo erano le pa1·eti dei succhi. La pelvi era ottur·ata da un calcolo oeJ•o e du ro che impedi"a il passaggio dellirJuiùo nell'urelc•re. Si trattava dunque di un'idronefrosi da calcolo un t•ene A doppio u r etere.
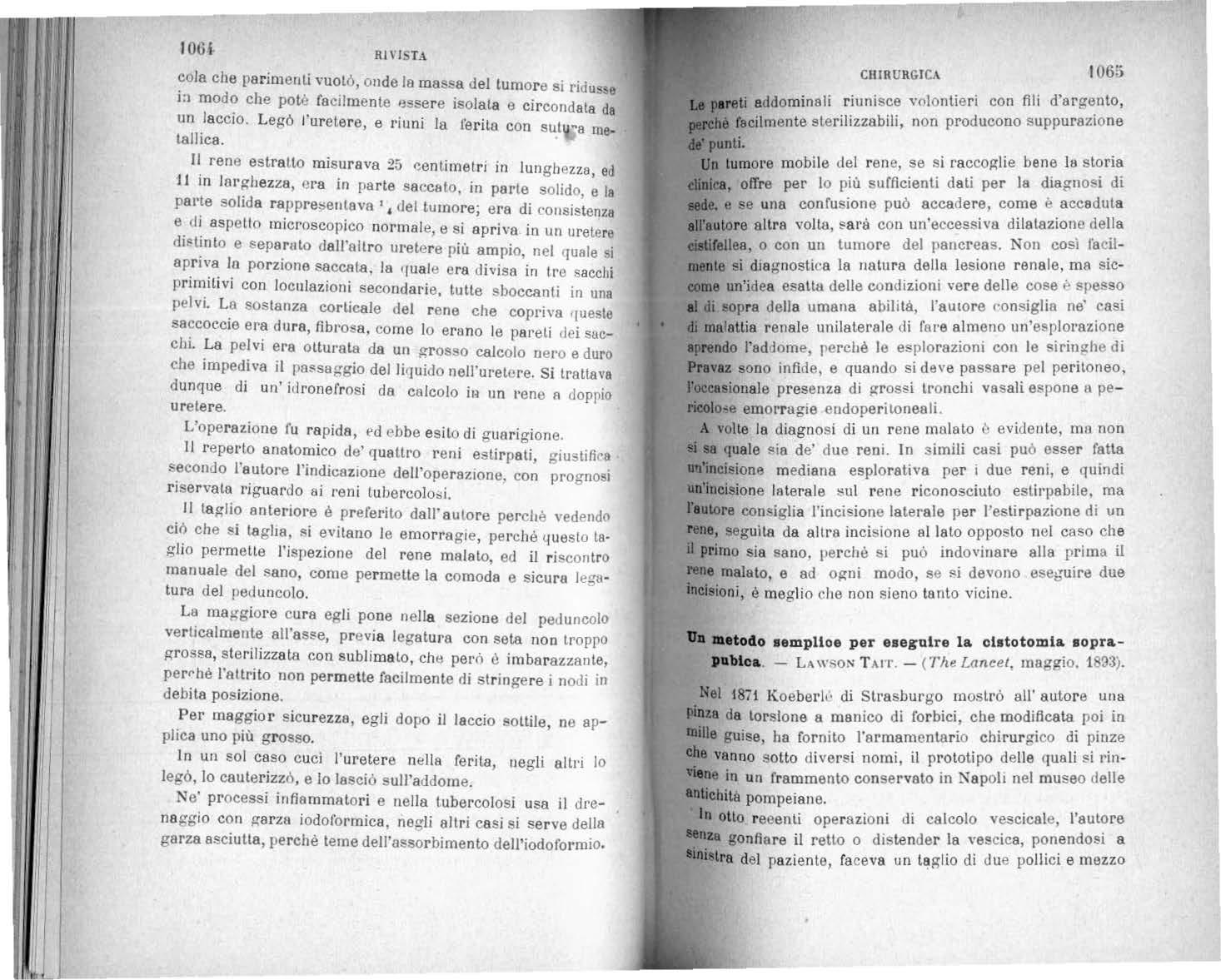
L'operazione fu r a pida, t'd Pbbe esito di guarigione.
Il repet·Lo anatomico do' rruattro reni estirpali giu<;tilka ;;econdo l'autore l'indicaziOn e dell'operazione, prognO:>I riservata riguar•do ai r·eni tubercolo,;i.
. Il ante r iot·e è preferito dall'au to re perchè vedendo che lagùa, !li evitano le emorrag•e, perchè questo la· glto permette l'ispezione del rene malato, ed il r i!'contro manuale del !;ano, come per mette la comoda e sicura legatura del peduncolo.
C) l n un sol caso cucì l'uretere nella ferila, negli alt1·i lo legò, lo cauterizzò, e lo lasciò sull'addome.
Per maggio r sicu r ezza, egli dopo il laccio sottile, ne applica uno più grosso.
N e' process i infiammatori e nella tubercolosi usa il ùr·econ garza iodolormica, neg li altri casi si serve della garza asciulla, pe r chè teme dell'assorbimento dell'iodofot•mio.
Chirurgica 1065
pareti addomi nali riunisce vnl o ntieri con fili d'arA'ento, ,.rché facilm ente slerilizzabili, non producono suppurazione 111 punti.
Un tum m·e mobi le ùel ren e, se s i raccoglie bene la storia diniea, offre per lo più sufficienti dati per la di Ilde. e s e u na confusione può accadere, come i• accaduta all'autore altra volla, s a rà con un'eccessiva dilatazion e clelia eiltirellea , o con un tumore del pancrea s. Non cosi facilmente si d1a gnostica la natu r a della lesione renale, ma siccome un'idea esalta delle condizioni vere delle cose f. spesso Il di !!Opra dell a umana abil1tà, l'autore ('Onsiglia ne' casi di malattia r enale unilaterale di ft\t'e almeno un'esp lorazione aprendo l'a d iome, perché le esplorazioni con le sirituthe di Pravaz s ono infide, e quando si deve passare pel peritoneo, l'occasionale presenza di grossi tronchi va s ali espone n pericolo·e emorr ag1e eudoperiloneali.
A volte la diagnos i di un rene molato <\ evidente, m11 no n ai sa 11uale ctia de' due reni . In s imili cusi può esser fatta ma'incisione mediana esplorativa per 1 due reni, e quindi un'incisione la terale sul r ene riconosciuto eslit•pabile, ma l'aulore conctiglia l' incisione laterale per l'estirpazio ne di un rene, s egulta da altra incis ione al lato opposto ne l caso che il primo s ia sano, per ché si può indovinare alla prima il rene malato, e ad ORDÌ modo, se !'Ì devono esegu ire due incisioni, è meglio c he non sieno tanto vicine.
lrll llletodo sempltoe per eseguire la olstotomla soprapabloa - LA\\'MN T AlT.- ( The Lancel. maggio. l 93).
Nel 18ì1 K oeberlt· di Strasburgo mostrò aU' autore una pinza da torsione a manico di forbici, cbe modificata poi in mille guise, ha fornito l'armam en tario chirur gico di pinze ehe vanno solto diversi nomi, il prototipo delle quali si l'in1iene in un fr ammento conser valo in Napo li nel museo delle lntiehita pom peiana.
In otto r eeenti ope r azioni di calcolo vescicale, l'autore lenza gonfla r e il retto o distende r la vescica, ponendosi a tini8Lra del pa ziente, faceva un di òue pollici e mezzo
1()tìli RlVI::;TA dal. pube m fino a scoprtre il tenaioc dei relli Stld<ltni· nalt. che ta_ljavtl poi per la l l . . • " 1111;.:; 1eua d1 un polltce nnmetliatamente al dtSOI·ra .!el\' lt. le. . l . . . . t l r ': li l uno dall'altro con un taa:lio lonl!ilndiuale dt polltce e mezzo, passaval'inotil.!e .::.tni"lro fra In l Arco_ del pube. l' In Jell'intlice. , re r • l con pinzette fino A la t>urele dt>llo 'e,ctca che rtconosceva al tallo. ed alla che offre alle lHnze mentre il tessuto cellulare si lllccra. aver. presa_ la vescica con una ,li quest" pinze. n:can o _alla prtma ptnza nt> »pplicava un'Altro, due pntZP l'itc le divnrira,·a. come " " una lal'arotomta; fra le due pinze faceva un occhiello con la l unta ili un bic:turi, e l'u!'<cila del ltqmJo avvcrltHI che, era Jn Tu tto ti re::;lo e!-!lt a forza di traztone -.ulle pmze (• Jivaricamenti con le dita fìnchr' "ull& s:tUJd J Il'' .t• • • a aol tnll·oJrurt•e una tana;.: lia, aliA quale pr·,•vtamentc mtrndollo pre!>t•nta"a l calcolo.
1 ullt gh operai i dall'n 1 •. . . • u ore sono guarllt irwnn ,·eun ,·ptJ•o assccuralo t'Oil punir. a Hl avvom r e s t propone d t rmunciare all'mulile drena •.! .O, suturando la ff'rtla. '"'
E!!li trova lanta facilità nel l'rcmlet· la ''esc·ica e lugliar•a, cb" non il bic:;otTno "' . • • n w 1 accomandare altra precanz,ou quell_a dr non ti r ar luot·i tropra pat•lc della "' scica. e_ ncn apnrla troppo in basso. pel' non incontrare l·· ra· tltct del plec:;so prostatico.
FttFOF.RlCt T RE\ - L'uso delllodoformlo nella ohlrurg a addominale. - ( The Lanrec. 1?-!ì.IJ.
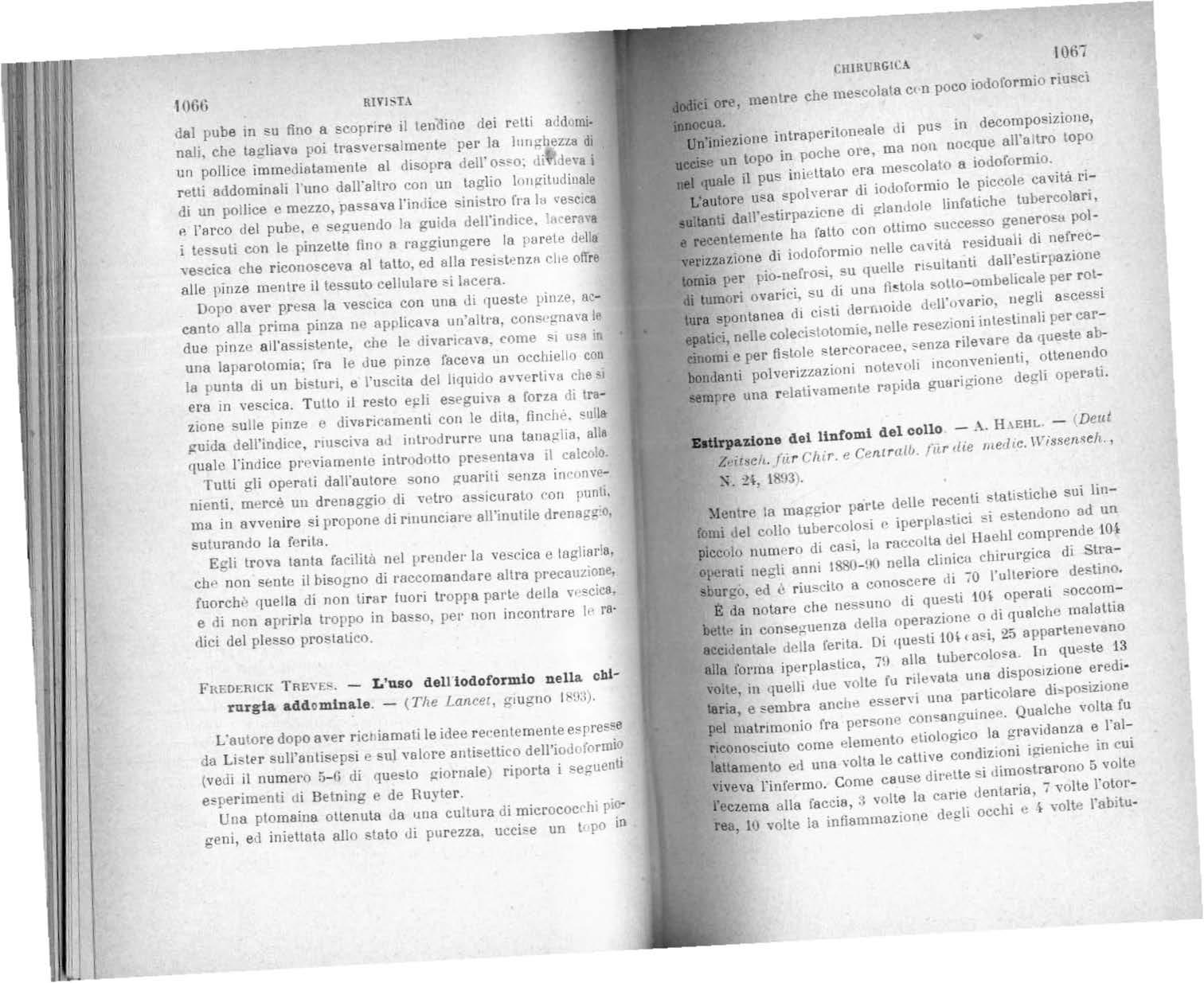
L'au1ore dopo aver · 1 • · 1 · . , . r_tc ramall e tdee r e•·eutemente da L t::-ler sull aullsepst e sul valore antisettico dell'ioJ ofMUli (vetlt ::i-li di questo giornale) riporta i c:e!!11enti t.lt Betning e de Ruvler.
" Una ottenuta da cultul'<:t di micrococrhi pie· .,ent, e,J mrellata allo Ji purezza. ucci!"e un L( po in mentre che me'-'colula c• n poco iodofo rmio un. Un'ulit>ZlOn e inlraperitoneale ol i pus in decomposizione, ueci!'•' un lCIPO in poche ot·e, ma non nocque alra1tro topo nel •1uale il pus ini... ttalo era me"colato a iol!oformio. L'autore usa ::.poher·ar di tOIIoformio le pic,•ole cavità t·isu tan ti dnll'e-.tir·pazicne fii glono!olt> linfattche tubercolari, e recen temente hn ratto con ottimo !tenerosu polvPrtzzaz tnne di wdoformio nelle covitu residuaJi di nefrcctomia pio-ne l't su quelle rtsullanli dall'esltrpaLiotte di tum·wi ovariri. su di una lìo:lolu per rottura spoulan ea dt ci,-ti ,let·n\Oitle .l•·U-.,var io, uegli epatid, nelle nellE> re!'<ezioni rnteslinali per carcinomi e per fistole :-enza rile"are da que;ole abbonclanti polverizzozioni noteYnh tnconvenienli, ottenendo una r dati,tlmenle t•npitla de!!li operati. li'f13 '• la maggior pat•le delle recenti sui !inComi del collo tubercolo'-'i ,. iperplasttci ,.;i e<>tenJono od un piccqlo nuowro dt cai'i, lo rnc;t'olla del naehl comprende lOi operati ue,..,ll anni 1 nella chuica chH'Ul'fdca d1 Slrasbur !!o, ed i.• ri u,-dlo A conoscere .lt 70 l'ulleriore de"tino.
Batlrp&zlone del Unfoml del collo - .\.. H .\EtiL - DetLl L· /H r (fu r. i! Cf>n.tra/11 Jur t/re lltetlrc.
E da nota r e cha .li questi \0} operati "occombetl•• in .Iella opet•ozione n di qualch" malattia acc hientalt- dl'lln l'erttn. Oi questi IO\.• a"'i, 25 appartenevano alla forma iperplaslico, /!l alla In 13 \Olle, n\ quelh •luc ,·olle fu rtlevala una disposJzione eredi· \aria , e sembra ancht> essen 1 una particolare di'posiZione pel malrtmonio l'ra per !"Ol\P coll"an!!utne<>. Qualche "olla fu r tcono,.ciuto come ··lemenlo la e rallallamenlo e•l una volla le cattive condiz,oni igtt>.ntche in cui viveva l'infermo Come cause Jir·t>lle dimost rarono 5 volte l'cclema alla faccia, .: volle la carte ,lentaria, -; ,·olte l'olol'rea, l O ,·olte la :nfiammazione degli occhi ,. \ \'Oll·· l'abrtu- dine d'annac:are tabacco. Fra le oppol!te opinioni de!:di autori sulle indicazioni e la esecuzione della operazionu dei linromi del collo r H . tiene una via di mezzo. L' 0 ,. parziale é !!'ufficiente quando le glandole incapsulaLe non sono ancora cresciute a grossi pacchi. l parchi invece debbono essere completamente enucleati con hs loro capsula , le suppurate e le suppurazioni peria il·niliche devono eliminate con la etl il vuotameoto.
La maggior parte dei malati (42) avevano, cominciarono a comparire i tumori glandolari, da 16 a 211 anni: segue quindi l'età di 11 a 15 anni con 22 casi, 'luella di 21 a 25 anni con Hl casi, e da l a 10 unni con 12 casi. 1 t•imaocnli erano per"one da 30 a 50 anni. La durala della mal attia fluo alla operazione. su casi potuti bent' av,·erar<', non ru piu di due anni, !i'olo in 11 ru di 3 e in :1 di \ ar 01.
La guarig'ione complet.a successe in 17 cast di glarulol" iperplasticbe io M di 10 totale 65 °/o dei ca-.r. Drslurbi generali non ne seguirono mai dopo le operazi 101 delle glandole iperplastiche, 4 volte dopo IJuelle dei Jinfomi Morirono di t •Jbe rcolosi dopo le prime 3 malati. dopo le allt•e tn. in Lutlo 22 • •. I n generale la proporzione delle guarigronr complete come dei cast di morte è in quo>..:lA statistica che nelle altre. Pero le recidive e la comparsa di malattie generalt dopo la operaziont• furono molto più r are nPlla clinica di Strasburgo che in altre. Se·
1•arali::i del racrale solo 4 ,·olte, rra cui 2 pt>r più di 2 e 3 annr










