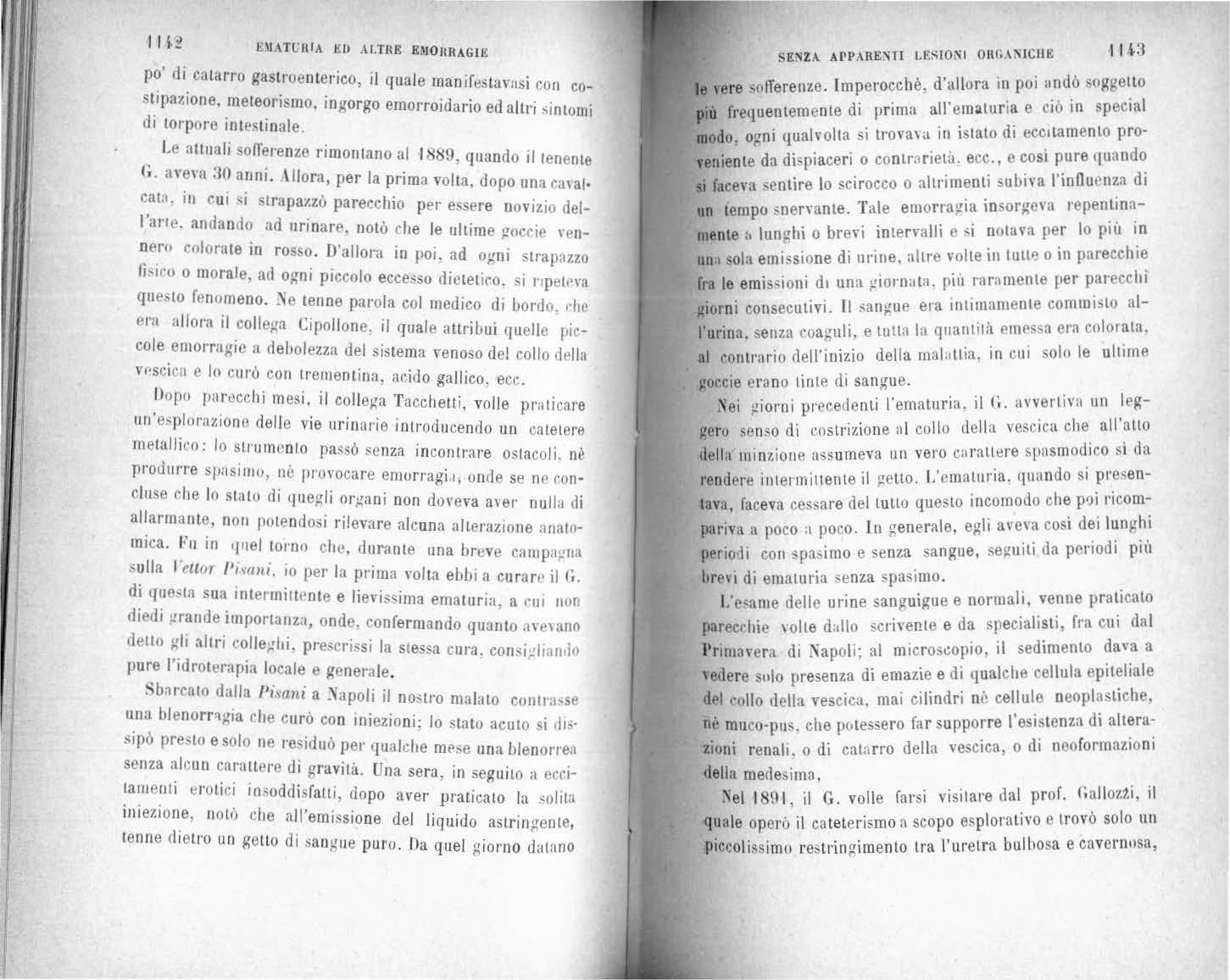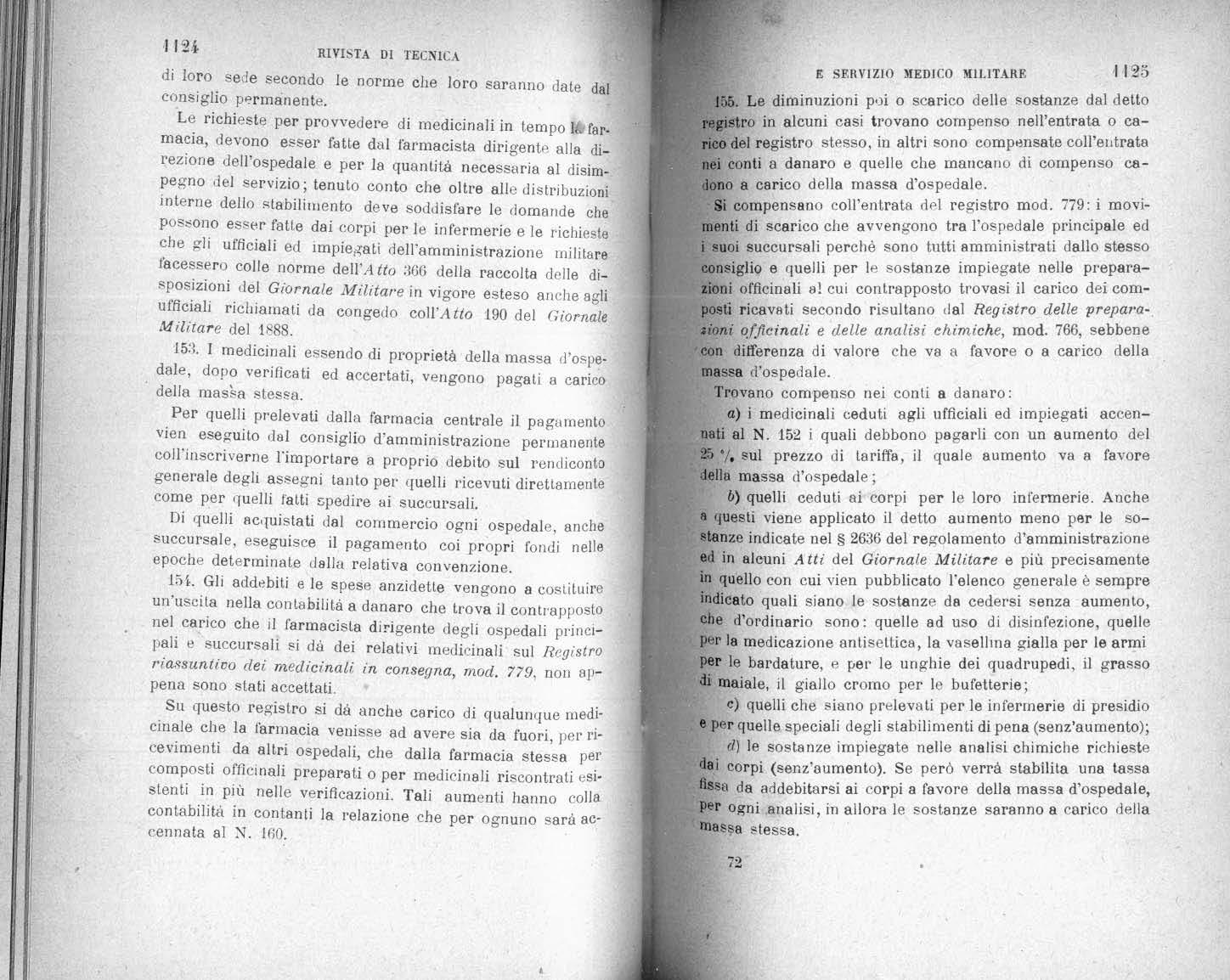
27 minute read
RIVISTA Dl TECNICA
di loro. sede secondo le norme che loro saranno date dal cons1glio p'O'rroanente.
richieste per provvedere di medicinali in tempo 1.,. fardevono esser fatte dul farmacista dirigentP alla direZIOlle ùeirospedale e per la quantità necessaria al disimpeg no del servizio; tenuto conto che oltre alle ùistJ·ibuzioni mterne dello "Labilimento deve soùùisfare le domande che esser fatte dai eorpi peP le in fermet•ie e le 1;ichieste che o-J ftì · 1· · · ,., 1 u cxa l ed deiramministrazione militare colle norme dell'Il tto :wa della raccolta delle dide l Giornale 111ilitare in vigore esteso anehe agli ufficiali r1chiamati ùa congedo coll'Atto 190 (lei r; · l M ·z· <•tOrna e 1 rtare del
Advertisement
15t I di proprietà della massa cl'o:-pe· dale, dopo ver1ficat1 ed a ccertati, vengono pao-ati a carico della massa stessa. o
. Per quelli p1·eievati Jalla farmacia centrale il pagamento vten eseauito 1lal cons'gl' d' · · · •. 10 amm1mstraz10ue permanente coJIJnscriverne l'importare a pr'opr·io debito s ul rendiconto generale degli asi>egni lauto per· quelli ricevuti direttamente come per quelli fatti spedire ai succursali.
Di quelli ac.ruistati dal cotnmer·cio ogni ospedale, anche succursale, eseguisce il pagamento coi propri fondi nelle epoche determinaLe dalla relativa conven?.ione.
Gli addtlbiLi e le spese anzidette vengono a costituire un usc tla nell L b'l'' · d . a con a l ha a anaro che Lcova il conll'apposto nel. carJco che Il farmacista di!'igenle degli ospedali pr·irtcte dil dei relali vi medicinali sul Registro det medicinali in consegna, mod. 779, nou appena sono stati accettali
. Su questo registro si da anche carico di qualunque medi· ch.e la fa r macia venisse ad avere sia da fuori, per ri· da altri ospedali, che dalla farmacia stessa per composti oflìc.:mali preparati o per medicinali riscontl'ati esi· stenti in più nelle veritìcazioni. Tali aumenti hanno< coiJa contabilità in contanti la t·elazione che per ognuno sara ac· cennata al :"'1. IliO.
E SRRVIZJO MED ICO MlLJTAllR 1125
Le di minuzioni p•)i o scarico delle Mstanze dal dello registro in a lcuni casi t rovano compenso nell'entrata o carico del reg istr o stesso, io altri sono compomsate coll'etJtrata nei conti a da naro e quelle che mancan o di compenso cadono a carico della massa d'ospedale.
Si compensano coll'entrata dPI registro mod. 779: i movimenti di scarico che avvengono tra l'ospedale principale ed i suoi succursali perchè sono tutti amministrati dallo stesso consiglio e quelli per le sostanze impiegate neiJe preparazioni of.ficinali al cui contrapposto tr'ovasi il carico dei composti ri cavati secondo risultano dal Registro delle prepa1 ·a1ioni o.fjici n ali e delle analisi chimiche, mod. 766, sebbene con diffe r enza di valore che va a favor e o a carico della massa d'ospedale.
Trovano compenso nei conti a danaro: a) i medicinali t:eduti agli ufficiali ed impiegati accennati al N . 152 i quali debbono pagarli con un aumento del 25 '/. s ul prezzo di tariffa, il quale aumento va a favo r e della massa d'ospedale; b) quell i ceduti ai corpi per le loro infermerie. Anche a rtuesti viene applicaLo il detto aumento meno per le sostanze ind icate nel § 2636 del regolamento d'amministrazione ed in alcun i Atti del Giornale Milita r e e più precisamente in quello con cu i vieu pubblicato l'elenco generale è sempre indicato quali siano le sosta nze da cedersi senza aumento, che d'ordi n a rio sono: quelle ad uso di disinfezione, quelle per la med icazione anlisellica, la vasellma gialla per le armi per le ba rda ture, e per le unghie dei quadrupedi, il g r asso di maial e , il giallo cromo per le bufelterìe; c) que ll i che siano prdevali per le infermerie di presidio e per quelle speciali degli stabilimenti di pena (senz'aumento); d ) le sostanze impiegate nelle analisi chimiche richieste dai corpi (senz'aumenlo}. Se però verrà stabilita una tassa fiss a da addebitar si ai corpi a favore della massa d'ospedale, per ogn i analisi, in allora le sostanze saranno a carico della stessa.
UIVISTA DI TEC 'ICA
Per tulle le distribuzioni sono a carico dei richiedenti anche lo di tt·asporto e, per gli ufficiali ed impiegati fuori del anche queJie
Sono scat•tcati a totale as;tgt•avio della massa d·ospedale: a) i medicin11li distribuili agli ammalati o consumati per uso gener·ale degli stabilimenti; b) le in•riegate per le analisi chimtche fatte per •lello stabilimento o chieste dalle autorità superiori per servizio : c) i medicinali di :ninutli per calo naturale e per eventuali avarif' che non siano da ascriversi a troppo prolungata giacenza in farmacia pel' state provviste quantità esuberanti ai come prevede l'Atto 9i del Giornale M i l ita r e 1890.
H>6. Dei medicinali come di tutto il materiale in genere i• il consiglio d'amrnmislrazione permanente che rispoude di· roLtarnente al Ministero ed il diretto r e in special modo risponde della conservazione dei m edicinali ed attr ezzi cd anche del servizio di farmacia Pssendone a lui a mdala la sorveglianze tecnica sull'andamento interno dal § 25H del lamento di amministrazione.
11 direttore, in conseguenza, di un ospedale succursale, ha pet· la conservazione dei medicinali e del mater iale f'llrmaceulico ver·so il consiglio permanentEl ed ha dit·ettamenle quella per la sorveglianza !:'uii'At.· dame nto interno della farmacia dell'ospedale da lui clirelle 15i. 11 farmacigta dit·igentt- essenclo consegnatario d1 tutta la dotazione farmaceuti ca dell'o"pedale ed anche tenu to a dirigerne il izio farmaceutico, oltre alia responsabilità che gh spetta come agente del con!<iglio specificata al N: hu an<'he vet·so il direttore quella de r ivante dagli obbhglu a lui falli claii'Arlicolo 2fi .!el regolam ento sul ser"izio !'ani· tario e dall'A tt? 11 8 del 1890 riguardante la conservazione delle sostanze vrlenose e di azione eroica.
I farmaetsti in sott'ordine sono anch'essi responsabili verso il farmactsta di rigente per quelle incumbenze che loro sono aflldate.
E S ERVIZIO MEDICO llii.ITARt: 11 37
Quanto alla parte tecnica del ser vizio dei medicinali e cioè alle manipolazioni e spedizioni, che per le forza naturale dPII ... coge non potessero esset· falle od efficact}rnente invigilate dal farrnacis\.1 dirigente, ogni farmacistA P dit•ettamente re"ponsebile errori professionali in cui fos"e incorso. (Continua).
RIVISTA D'IGIENE
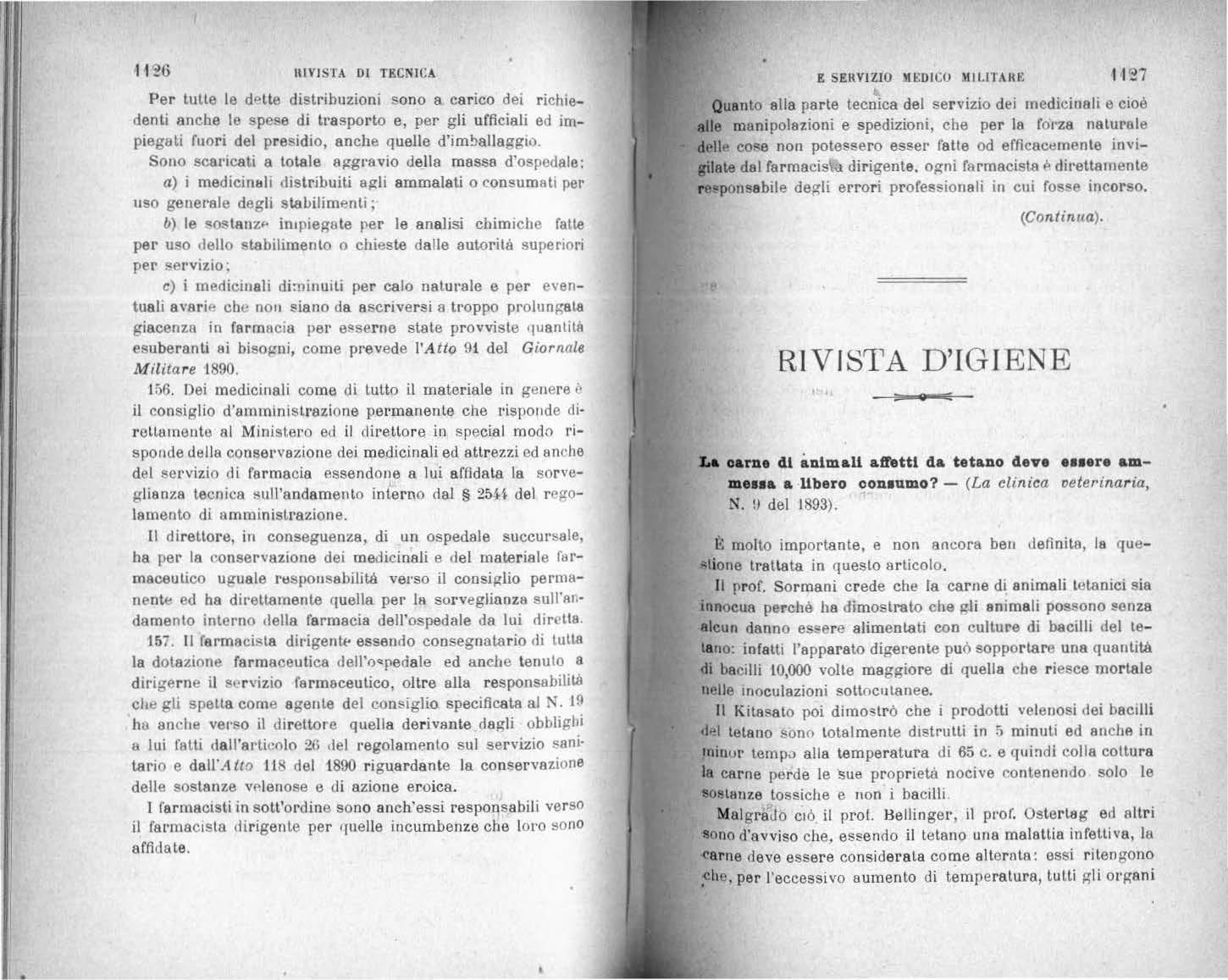
La oarn e dl animali afl'ettl da tetano deve •••ere amme t l a a libero oon1umo?- (La clinica oete,•ina r ia, N. !l del 1893).
m olto importante, e non ancora ben defini ta , le quetrattata in questo articolo.
Il pr of. Sormani c r ede che la carne di a nimali tetanici sia innocua perché ha dimostrato che gJi animali possono senza alcun dan no essere alimentati con culture di bacilli del telan o: infeltt l'apparato digerente può sopportare una quantttà di bacilli 10,000 volle maggiore di quella che r iesce mo rtale nelle rnoc ulazioni sotloculauee.
Il Ktte salo poi dimo::trò cbe i prodotti velenosi dei bactlli .J,I tetano sono totelmenle dtstrutti in !) minuti ed anche in rnin u r temp.> alla temperatura di 65 c. e quindi colla cottura la carne per de le sue prop r ietà nocive ro ntenendo solo le sostanze tossiche e non i bacilli
Mal g ra Jo ctò il pro!. Hellinger , il pr·of. Ostertag ed altri sono d'avviso che. essendo il tetano una malattia infettiva, la <'arne deve essere cons idera la come altornta: essi ritengono _che, per l'eccessivo a umento di temperatura, tutti gli ot'gani sono più o meno alte rati, di cattivo colore, in stato di lumf'· l'azione torbida e d'infi a mmazione parenchimatosa.
Ora il Sosua, medico veterina ri o utnciale arldetlo al macello di Brema, ha risollevata la questione del libero uso 0 meno delle carni tetanìche a di un cavallo affetto da tetano macellato il i3 sette mbre L892.
Egli fu d'avviso che qualunque animale affello da tetano deve esser•e sequestrato cd appoggiò il suo giudizi o s ul con· cetto mod e rno che ba della malattia ed in parte sulla notizia letta nei giornali che in una Joca l1tà dell'America del Nord ammalarono e morirono 10 persone per avere lllangiato carne tetanica .
Sovra PI'Oposta dello stesso Sosna, l'autorità s uperiore voll e sentir!' a nche il pRrer e de1 di1·ettori di due fra i più impor•tanti macelli tedeschi, ej in seguito decise che le carni degli animali affetti da tet mo tanto nello stadio qua,tto in quello più eleo a to deouno ess ere sempre sequestrate e distr utte.
È questo il pt•imo caso in cui l'autorité. sanitaria competente ha stabilito siffa tto principio 1'ispetto alle carni te tanic!Je, e per ciò é bene che venga portato a pubblica conoscenza.
LoRKENDOFER . - Sul batteri ohe al rt.oontra no nelle uova. d i pollo e conserva zione delle uova. - (Dall'istituto igienico di Be rli no. Arch . .fur Hyg . e Centralb . .fù r die med. Wissensclt . N. 26, 1893).
Sulla putrefazione ùelle uova esiste finora solo un lavoro dello S chrank ùell'a ono 1888, il quale nelle uova guaste trovò p r indpalmente il bacillus Huorescens putrid us e il proteus vulgaris. Eppure la put1•efazione delle uova è una calamità igienica di pr imo ordine, poiché nelle g r andi cillà in media circa il 20 p. 100 delle uova si c,omprano dai già g uaste da non potersi mangiare. Ne lla pratica si ri· conoscono le uova cattive da ciò che esse non sono più trasparenti e, nella avanzata putrefazione, in conseguenza
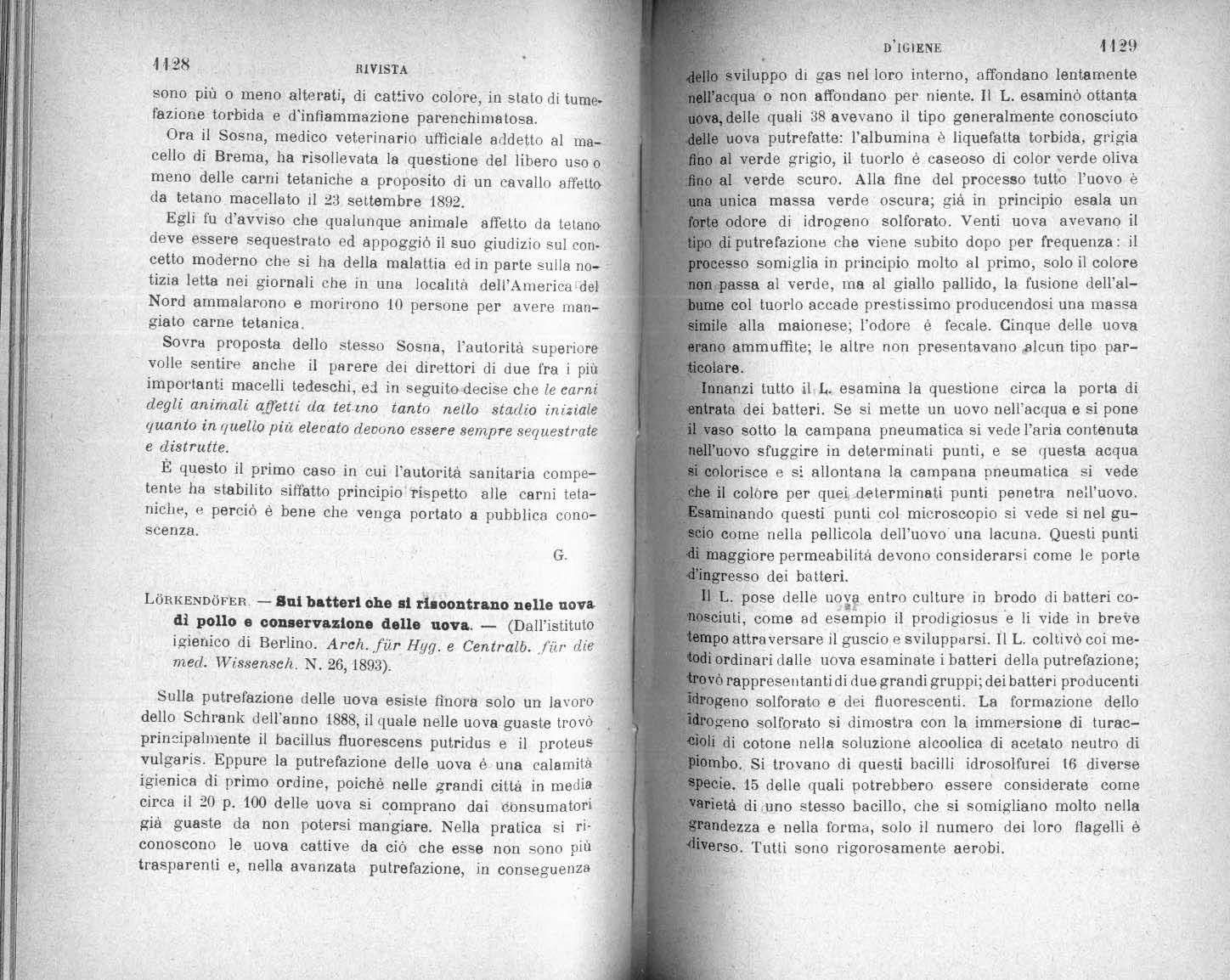
D'Jt.:I svilupp o di gas nel lor o inte rno, affondano lentamente - Alll'n'"'Ua o non affondano pet• niente. Il L. esamin ò ottanta delle quali 38 a vevano il tipo generalmente conosciuto uova putr efatte: l'albumina è liquefatta torbida, grigia Jlno al verde gl'igio, il tuorlo é caseoso di colo t' verde oliva :fino al verde scuro . Alla fine del pr ocesso tutto l'uovo è illl& unica massa verde oscura ; gié. in principio esala un forte odore di solforato. Venti uova avevano il tipo di putrefazione che vi e ne subito dopo per frequenza : il processo somiglia in pl'incipio molto al p rimo, solo il color e no n passa al verde, ma al giallo pallido, la fusione dell'albume col tuorlo accade pre stissimo producendosi una massa 11imile alla maionese; l'odore è fecale. Cinque delle uova erano ammu ffite; le altre non presentavano alcun tipo particolare
Innanzi tutto il L. esamina la questione circa la porta di -entrata dei batter i. Se si mette un uovo nell'acqua e si pone il vaso solto la campana pneumatica si ve<le l'aria conte nuta nell'uovo sfuggire in determinati punti, e se <(Uesla acqua ai colori sce e s i allontana la campana pneumatica si vede ehe il col or e per nt\termina Li punti penetl'8 nell'uovo. Esaminando questi punli col micr oscopio si vede si nel guteio come nella pellicola dell'uovo una lacuna. Questi punli odi ma ggior e pe rmeabilita devono considerarsi come le porte -d'i ngresso dei ba tleri.
Il L. pose delle uova entr o cul ture in brodo di batteri co· ' . 1losciuli, come ad es empio il prodigiosus e li vide in breve tem po attraversar e il guscio e svilupparsi. Il L. coHivò coi metod i or dinal'i dalle uova esaminale i batte ri della putrefazione; trovò ra ppresentanti di due g r andi gruppi; dei batteri producenti idrogen o solforato e dei fluorescenti. La formazione dello idrogeno solfo ruto si dimostra con la immer s ione di luracrli cotone nella soluzione alcoolica di !lcet.alo neutro di piombo. Si trovano di questi bacilli idrosolfurei 16 diverse tpecie. 15 delle ([Uali potrebbero essere considerate come varietà di , uno stesso bacillo, che s i somigliano molto nella g randezza e nella forma, solo il numero dei lo ro flageUi é .d ive rso. T utti sono eigoi'Osamente aerobi.
Condizion e fa v ore v o le per la p utrefa zione delle uo"a ,. principalmente l'aria u m ida. Per conservar e le uova il L. r accom and a di vemi ciarle . Anche le uova innestate coi p1ù attivi batteri della putrefa zione si const:r vano mangiabili e non mostra no a lcun au m dnlo eli batter i sono verniciate do po l'innesto
SANOER. - Sviluppo del baollll tubercolari .al terrenl nutritivi vegetali. - (Are/t. /ii.1· HIJ[]. e Centra li. tlir rlie metlzc. Wisse1.sch ., N. 18!l3)
Che 1 bacilli de l tube r colo crescono sulle patate é noto Ja lung-o tempo. Il Sander trovo che prosperavano mente anrhe l-;Ul cavolo, sulle carote ed allri terreni nutritivi e sugli infusi ùi queste piante. Quindi emer!!e cht> la t't-azione per lo sviluppo su questi terreni nutr1tivi non f> cosi importante per quelle sostanze albuminoidi uuimali. sembra anzi elle un ptccolo gl'ado d1 ac1d1ta nei primi s1a favorevole lo sviluppo dei bacilli. As!lolutamentc neces· sario é per lo "-Viluppo dei te r reni vegetali il libero ac·rt>!'SO dell'aria; la tempe r atura più fa vo r evol e :JHo- 39".
La quantitA di materia nut r itiva liquida veflelale non t> molto grande, nel brodo di patate vege tano rigogliosumeole e i11 lo sviluppo nei lerrPni vegetali è più ahbondante eire sugli animuli. Il S. osservò all'esame mil'l'osropico de1 d ei ba cilli che egli è inclinato a riguarda r e comP spore. Anche tr a.,portati dirPlta menlt> clal corpo animale l'ulle pata te posso no svi l u ppa r >"i i barilli Luber colar·i; sembra che queste sieoo ancora più adatta l•· lell'aga r glicerrnttto. Sviluppandosi nelle pata te ed su a!LI'i te r reni n u t1·ili vi vegetali per dono i bacilli tubercolari della loro virulen za. l luoghi di llli'Pzione cicatl'izzano ro m· pl ela m ente l'enza alcuna curn a nche nei porcelli n i d'India e solo lungo il corso delle vie linfatiche si avanla con lentezza il Pl'ocesso tubercolare.
L 'anatomia e la.1lelologla nel •eoolo XIV. -T. - ( Reoue tle ehirllr!Jie, N. l-, 18!l3).
L'auto re propone di riunir·e alcune delle principali zioni d'a nato1nia e J1 lì"iolog1a che lro' ano sparse nel libri clegli antichi, e eire sono 111dispensabil• all'l dei medesimi e delle teorie mediche allo r a amme.,se. Tah conoscenze che l"Ono tanto riflll'etle, servi r ono qua>'i solt.>, di base medicina fino ad llar\'ey, tre secoli t'a.
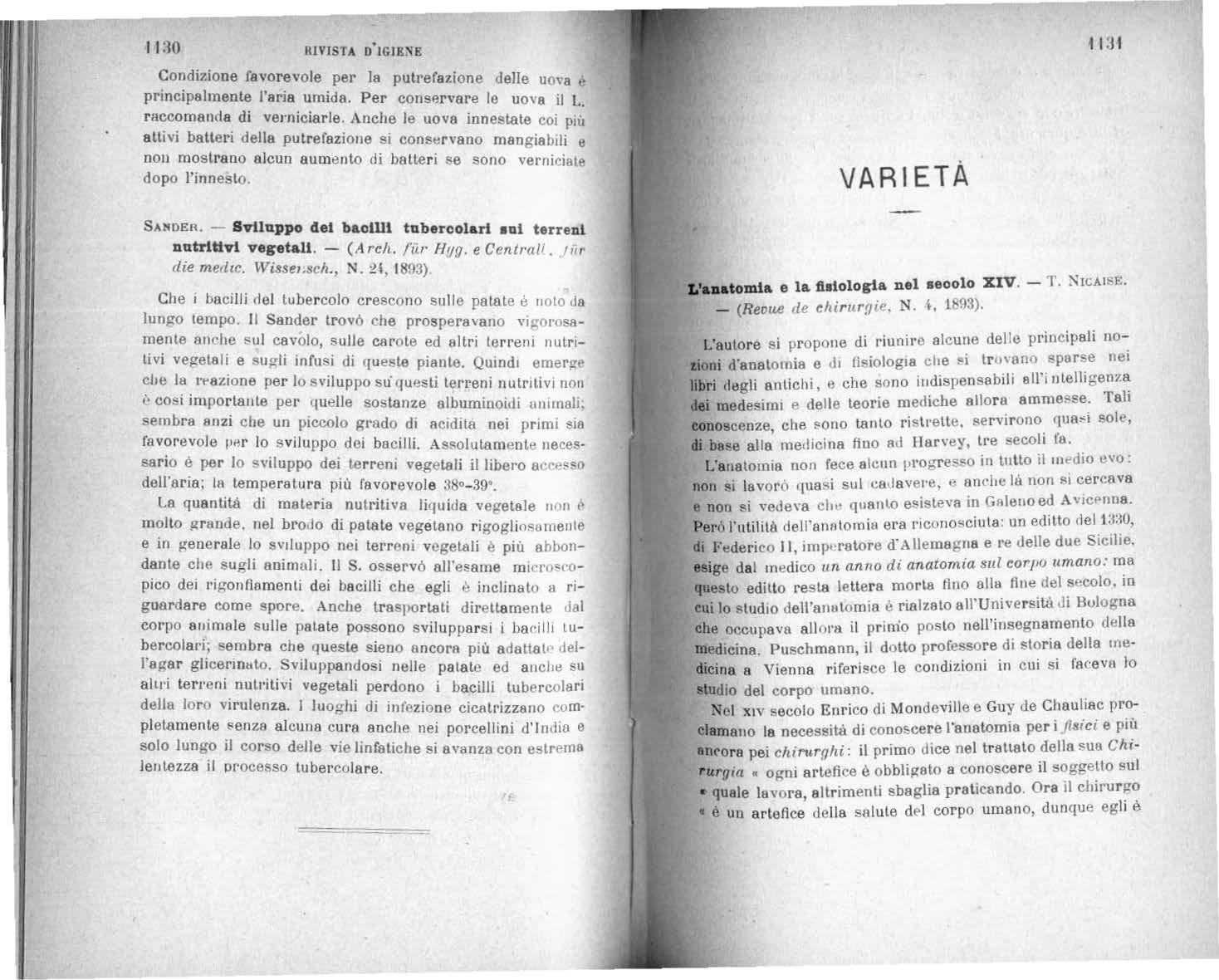
L'ana tom 1a non fece alcun pt•ogre<:<l'O in tu t to il lll t'dio t!"O: no n Ri tavo 1·ò '{UaHi sul cadave1·e, P anche lu non fii cercava e non si Yede,·a cl w quanto eRisteva in Galeno ed A ''ICPnna. Però l'utilità dell'anAtomia e r a I'IConoHciu ta: un ed itto deli:l:W, di Ft:"de r ico I l, imp• ·ratore d'A llemagna e re delle due Sic1he. esig e dal medico un anno di anatomia sul eorf'O umano: questo editto resta letter a morta lìno alla fine del secolo. m cui lo s tu dio dell'auoto!UI8 è rialzato all'Uni versita J i Bologna. che occ upava allol'a il pr in1o posto nell'insegnamento della med1cina. Puschmann, il dotto professore di storia della me· dicina a Vienna r iferi sce le condtzioni in cui si facevn lo l!tudio del corpo umano.
N el xtv s e colo Rnrico di M ondeville e Guy de Chauliac proclamau o la necessità di conoscere l'anat.omia per i }/ sici e p1ù anrora pei chirurnhi: il primo dice nel t r attato della sua Chi · ru rairt " ogni artefice è a conosce r e il sul quale l a vora, alt r imenti sbaglia p r a t icando. Ora 11
« è un artefice della snlute MI cor po umano, dunqu e egli è u obbligato a conoscerne la natura e la composizione, e per « conse guenza l'anatomia ». l libri che servono a questo studio quelli di Galeno e degli autori arabi.
Galeno che aveva studiato ad Alessandria fu pPr m olli !'e· coli l'oracolo dell'a natomia e della Daramberg lo ritiene un g ra nde anatomico, f[Uantunque egli non abbia di!'· :::.ecato aiLro che animali, scimmie specialmente. Gli arabi non fecero che copiarlo incompletamente. alterandolo e furono le loro tJ'ttùuzioni l'i volte nuovamente in latin o che servi r ono ai medici nel medio evo, finché alla fine del s iicolo x1v Nicola da Reggio tradusse le opere di Galeno direttamente dal grèco in latino, traduzione p1i.l esalt.a. c he fu quella ch "' l'eJ'VI a c>uy de Cbauliac
Tra gli autor·i arabi i più consultali fu1·ono Haly-Abba s e Av1cenna. 11 primo, medico persiano del x secolo fece , un tJ·atLato completo di molto in voga, intitoluto Malcl.:y, finché apparve il Canone di Avicenna, eire fu tradotto ver8o il xn secolo in Ialino da Costantino, e piu Lardi da Ste fano d'Antiochia col titolo di Regalts dLSpot.itio, spesso citata da Gu y, e eli cui il secondo e terzo sermo ne trattano dell'anatomia.
Avicenna fu il più grande medico a r abo dell' x1 secolo, il suo Canone è più sviluppato del Malcky, d1 cui s e gue il piano gene rale ; fu tradotto in latino alla fine del XII !:!Ocolo da Ge· rar·do da Crernona e da Alpagus: l'anatomia vi è d e ,.,cr ilta nel primo libro. L · iufluenza di Avicenna sulla medicina in occidente durò cinque secoli
Nel 130i En rico di Mondeville insegna anatomia a Montpellier, leggendo e commentando il testo d'A vicenoa c·oll'aiulo di 13 disegni, ri prodotti in piccolo in una traduzione francese della sua chirurgia, er:istenle in quella universila.
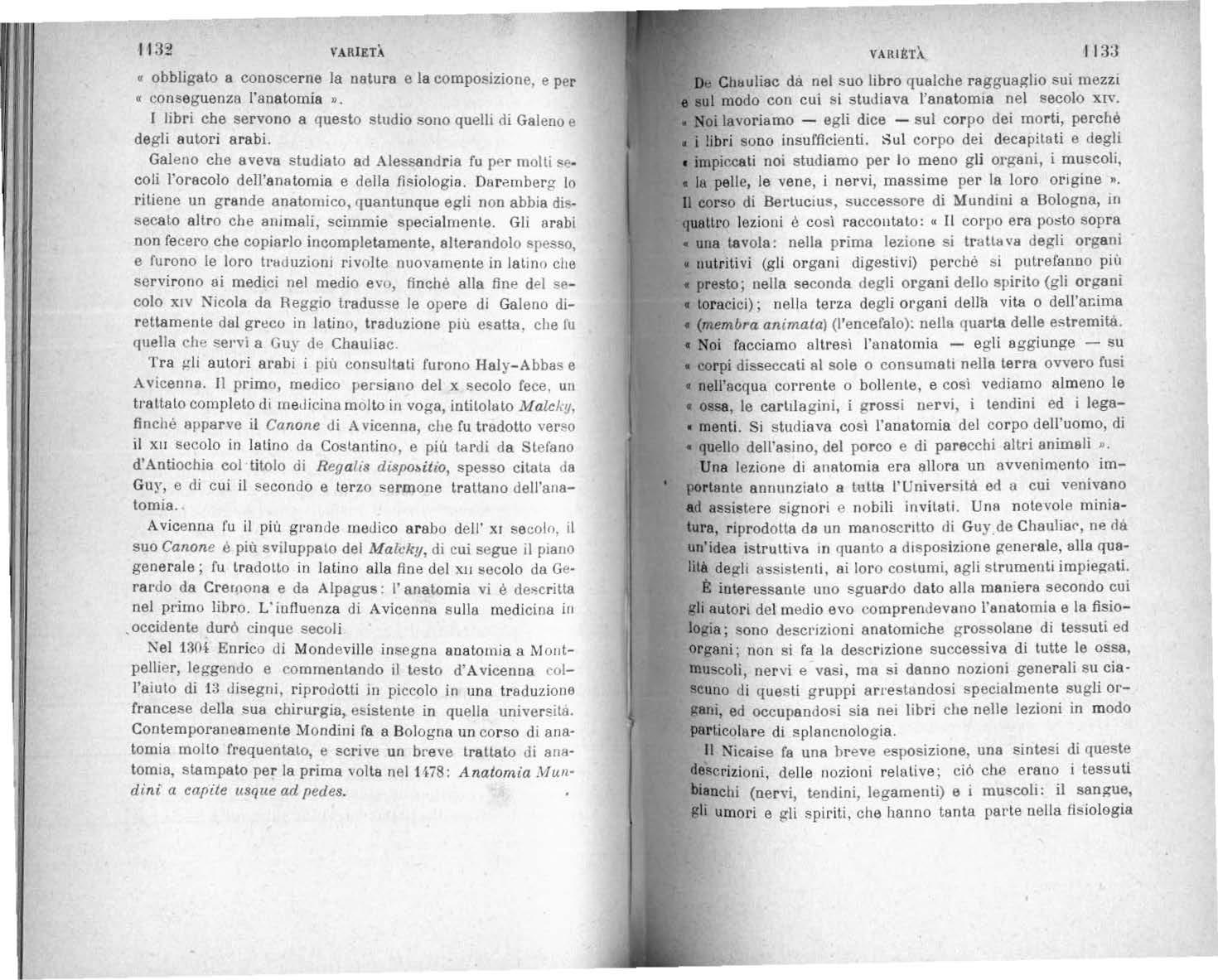
Contemporaneamente Mondini fa a Bologua un cor so di ana· tomia mollo fJ•equentaLo, e seri ve un breve trattato di a na· tom 1a, stampato per la prima volla nel H78: A nato mia JIun· dini a capite usque ad pedes.
Ch buliac dà nel suo libr o qualche ragguaglio sui mezzt e sul modo con cui s i s tudiava l'anatomia nel secolo xiV.
• Noi lavoriamo - egli dice - sul cor po dei morti, perché
• i libri sono insufficienti. Sul corpo dei decapitati e degli , impiccali noi studiamo per lo meno g li organi, i muscoli, c Ili pelle, le vene, i nervi, massime per la loro origine ».
Il corso di Bet·tucms, successore di Mundini a Bologna, sn quatlt•o lezioni é cosi raccontato: " Il corpo e ra po:sto sopra
• una tavola : nella pr ima lezione si tr attava degli organ i
1 nutritiv i (gli organi digestivi) perchè :,i put1·efanoo più
1 presto ; nella seconda degli organi dello spirito (gli organi c toracici) ; nel la terza degli organi dellà vita o dell'ar:ima c Noi fa cciamo a ltresì l'anatomia - egli aggiunge - su
• (mem bra animata) (l'encefalo): nella quarta delle estremità.
• corpi disseccati al sole o consumali nella te rra ovvero fusi
• nell'acqua cort•eote o bollente, e così vediamo almeno le
• ossa , le carlllagini, i grossi nervi, i tendini ed i lega-
• menti . Si studiava cosi l'anatomia del co rpo dell'uomo, di
• quello dell'asino, del porco e di parecchi altr·i animali »
U na lezione di anatomia era allora un Avvenimento impor tante a nnunzialo a tutta l'Università erl a cui venivano ed assis tere signor i e nobili inv itati. UnA notevole miniatu ra, ri prodotta da un manoscritto di Guy de Chauliar, ne clà un'idea istruttiva m quanto a disposizione alla qua· lilà degli assistenti, ai loro costumi, agli strumenti impiegati.
È interessante uno sguar do da to alla maniera secondo cui gli autori del medio evo ('Omprendevano l'anatomia e la fisiologia ; <sono descrizioni anatomiche grossolane d i tessuti ed or gani ; non si fa la descrizione successiva di tutte le ossa, muscoli , ner,' i e vasi, ma si danno nozioni generali su eia· scuno di rrue sli gruppi arrestandosi specialm ente sugli orgeni, ed occupa ndosi sia nei libri che nelle lezioni in m odo particolare di splancnologia.
Il Ni caise fa una hreve esposizione, una sintesi di queste de11crizioni, delle nozioni relative; ciò che erano i tessuti bianchi (nervi, tendini, legamenti) e i muscoll: il sangue, gli umori e spi1•iti, che hanno tanta pat'le nella fisiologia e nella patologia degli antichi : a che r estringevano la parte dell'aria r espirata. l ner1•i hnuno Ot'Ìf!ine nel ceJ'\'ello o nel midollo e trasmettono a tutte ! t} pu1·li del cor po 11 l'lentimenlo e il moviu1 ento. Quelli del cervello son dell1 sen.;;i tivi , q uelli del midollo motor·i, ma gl1 uni e gli altri e la virtu s .... nsith·a e la motr1ce, quale piu, quale meno. Gli auto r 1 l;Ono in certi se la <>ens1bililà •· il movimento son o portati da uno stesso nervo o du net·1•i dif"tinti: Go lleno pa r e a mmetta ner·vi m1sli. nervi specializzati. Guy non ,.i pron uncia; egh soggiungP: ancor più difficile.> cercare se le facoltà dei ner1·i porsostanzial men te o per irradiazione. È già degno di nota la pres entazione di tale questione. l nervi uditi vi sono cavi perch!'• possa circolarvi In r ito e le cose sonot·e arrivino al cer,•ello: il nervo ottico pure canicula lo perchè lo spirito .,.i i\·o "'i r echi dal cerl'f•llo all"ol'chio. al ct•istalilno che è il l'er0 organu vrstvo, e pt-·r lasciar fino al sensot•io comune le for111e Oj;!g-etti .
Le loro idee sullo stomaco, le intestina ed il feg11lo contenevano molte ve r i tà: er a esali a la nozione della vena porta, ma sconosciu ta la circolazione del cuore ed i suni rapporti coi polmoni. L'assenza di ultime nozi oni fu J'ori)!ine d elle loro err onee teor ie sul s angu e e 1 vs!:>i, sugli <:piriti, e la lor•l azionP. L'esame di teorie vigenti pl'imu .tclla d1 Har•vey (16 19) dilllostra quale immensa rivoluzione dovette produrre 111 >-Cope1·1a della p piccola circolazione: e l'icco me essa portava la demolizione completa di quanto si s apeva e si cri'dova, perciò nou é do me1·aviglia r si se incontrò una ostinnla resistenza e un secolo dopo Mery anrora la combatte mnanzi all'Accademia delle scieuze.
Grande sens1bllità allribuiva"i ai biaoclu, nel'\'1, tendiui, ligamenti e considerati della natura, cou qualche fra loro.
1 ligamenti r iuniscono le os;M fr a loro, e ser vono di r·ifugio ai nervi c uc sint neroorum sedes, et 'JUÌe.\ td e 1tlritra ·n juneturis: • essi concorrou o coi nervi alla composizione delle corde e dei muscoli.
La corda o è fo1·mata dal miscuglio dei ligomcnti delle giuntu1•e e dei uerv1.
La carnr 111Uscol1:1re fa po r te d'un Rruppo ge1wrico distinto col n o m e di came, coutenente tre specie, il la carne delle glandole e ganglii, e quella del glande; e forma il muscolo da mus, e le lacerle da lacertus, co><tituiti Ja un Uli'-'CUglio th llhre, \'illi, di semplice, con fibre di c·orJa o tendine e 'fllindi contenenti nervi.
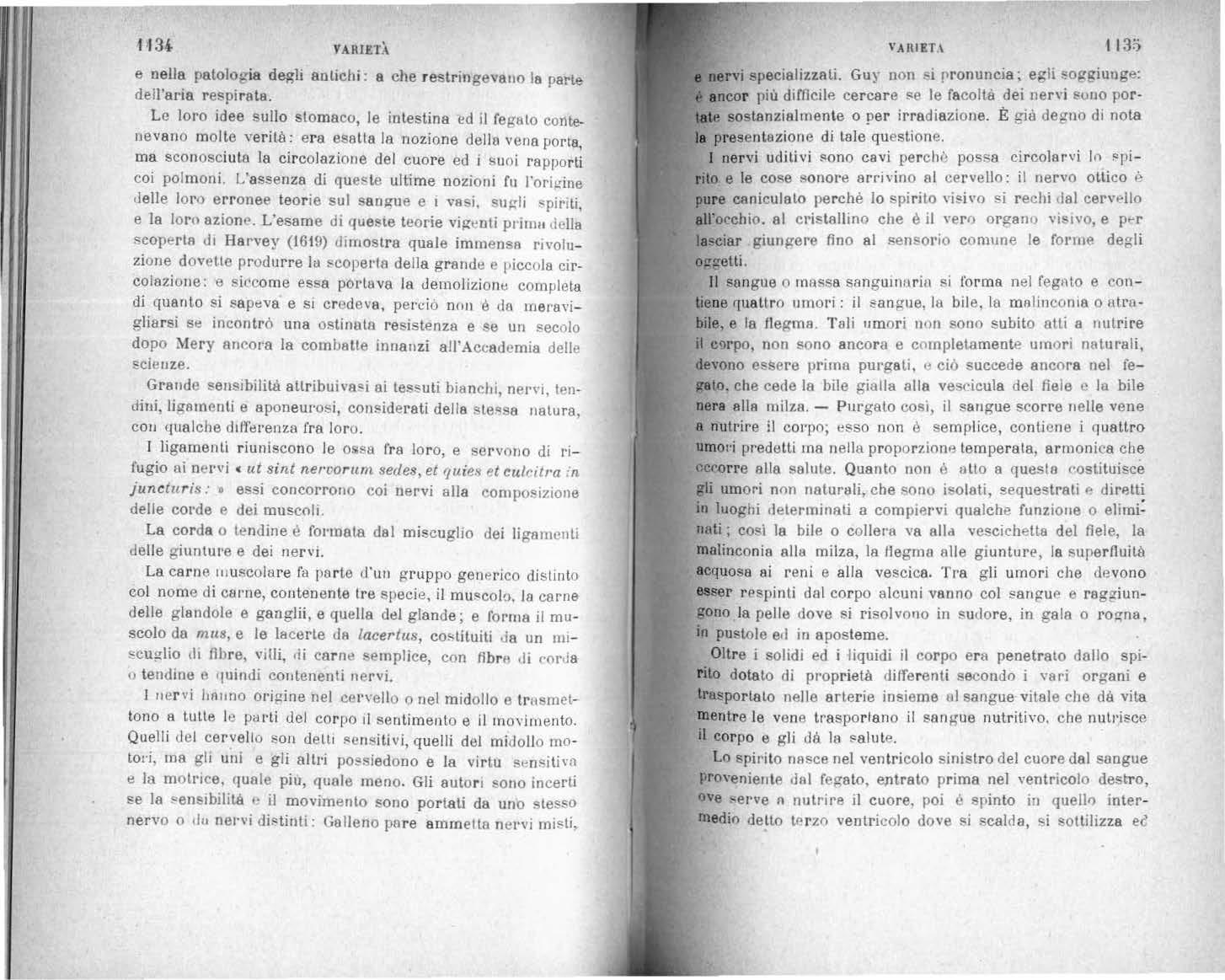
Il :;ongue n mnssa sAngUJnnrin Ri forma nel f'(>gt1lO e contiene rtuattro umo!'i: il :>angue, la bile, lo rnlll1ncuma o nt!'abile, e la flegm a T ali umori non !'!Ono subito alli a nutri re il c<>rpo, non sono anco r a e Ctllnplela mentP umori naturali, devo no essere prima purgati, "ciò succede ancora nel fegato, che cede la bile gialla alla vesf'icula del fiele t• la bile nera alla milza. - Purgato cosi, il sangue scorre nelle vene a nutrir·e il COI'po; esso non è semp lice, contiouo i quatt r o umo1·i predatli ma nella proporzione temperata, armonic-a che ccrorre alla Q uanto non è olio a questa c•ostit uisce gli umori non naturali, che icoolati, sequestrati ,. in luoghi determinati a qualche funzione o elimi: nati ; coc;i la bile o collel'a ''a alla del fiele, la malincon ia alla milza, la liegma alle giunture, la F\uperfluil.à acquosa ai r en i e alla vescica. Tra g li umori che ùevono esser r espinti dal cor po alcuni vanno col sangu(> e raggiungono la pelle dove si risol vono in Rutlore, in gala o roa-na, in pustole e•l in apos teme.
Oltre i solid1 ed i iiquidi il corpo era penetrato dallo spiri to dotato di prop rie tà diffe r enti secondo i ,·ar·i org:ani e trasportato nelle arterie insieme ul sangue vitale che dà vita mentre le von e t raspo r tano il s an g ue nutritivo, che nulr'isce il corpo e gli ùà la !'alutf'.
Lo spil'ito nAsce nel ventricolo sinistro del cuore dal sangue pro,·enien tf' diii e11trato prima nel ventricolo destro, ove -.er·ve n nutrire il cuore, poi c spin to 111 quello intermedio detto tPrzo ventricolo dove si scalda, si eè è e puritirato, e mflne passa nel ventricolo "'inistro ove forma lo sp1rito.
Lo spirito cosi formatl)si nel cuore, spi1·ito car.liaco, giUnto ne1 ventricoli del ceevello, subisce una nuova digestione e diventa lo spirito cJell'anirna: nel fegato e !.'so diventa lo spirito nutritivo, nei testicoli lo spirito generator e. Lo spirito, dice b:n. d1 M onde' iIle, • è più chiaro, sottile, puro, brillante «d i tutti 1 cor•pi fo r mati dai quattro elementi, 1-1 più presso • alla natura delle cose sopracelesti: esso è l'istrumento imer mediato dell'anima e forma tra quella ed d corpo un le« game amichevole e concorde. • Quindi gli spi riti d veicolo delle fa.:olla che essi tntsportano, sono d principio dell'azione di tutti gli
L'aria che penetra nei polmoni è preparata dall'ugola e non è nociva. mentre •1uella che penetra altrimenti come per es. dalle piaghe, e quindi non modificata, non pu r l{ata dall'ugol u era nociva; si att ribuiva g rand e importanza a tale funzione dell'ugola.
L'aria t\ por tata al polmone dai rami cJellu trachea arteriu, poi l'arteria venale, ramo clelia grande arteria (aor'La) la trasporta al cuore, dove enlt·a nelle due oreccllietle, che le servon<' da serbatoio come al sangue nutritivo, e di la sorte per rinf1·escare e temperare il cuore. Questo é il solo coucetto degli antichi SIJI compilo del polmone, la cui fuozwne era totalmente sconosciuta ; egli serviva solo ad espellere i vapori fumosi por tati dall'arteria venale, come le superfluità e le materie fJ'edde, umide e catarrali r icevute dal cerveUo ath·aver;oo al colatorio (retr ocavita delle fo sse nasali e del larin ge. Sconosciuti pure i r appo r ti dtjl polmone col
Il cuore ha i due ,·eotricoli, piu un terzo ventricolo o ca· vita intermedia in cui il sangue nutritivo, grossolano !li pu ritl ca, si fa più sottile, diventa sangue vitale. N el ventr1coto sinistro si forma lo spirito , che unito al sangue vitalo forma il l'angue spirituale il quale attraverso le arterie porta la v1ta e la funzione delle varie r egioni. -Il cuore ha due o r iftz1; per quello del ,·entricolo dest1·o entra un ramo della vena kili:; o la quale pot•ta il sa n gue del
Variet 1137
fega to nelle parti superio1·i, ramo che, fornito 11 san(!ue al ventricolo, si continua sotto nome ,Ji \'ena arterwsa, fino al polmone e vi porla il sangue nutritivo necel"'=ario alla sua nutrizione. Dall' orifìcio d el ventricolo sinistro sorte ltl g rande ar teria (aor ta) che manda rHmi a lulto il corpo: uno di questi, t'arteria venosa, porta al polmone i vapori fumosi e ne ripor ta l'a r ia per rinfrescare il cuore.
Sconosciuta era 111 circolazione sanguigna, 1\ granrle ed 11 piccolo circolo: ma si distinguevano le arterie •' le vene, ed il san gue diveJ•so che esse contPnevano: e ::;apeva che dopo 1110rte te vene rimangono piene, le arterie vuote: da ciò la esservi nelle arterie un <>angue sottile, vitale, mescolato nd uno spirito che si forma nel cuore, che da la vita eorl è l'agente della funzione di lutti gli or·gani, le ve ne contengono iuvece un sangue g 1·ossolano. denso, il san g ue nutritivo, che s! forma nel regalo ed è clic;tribuito dalla ven a chilis e s uoi t'ami ascendenti e discendenti: ma non è noto alcun rapporto tr a la vena arteriosa, ad una sola tunica, e l'arteria venosa a due tuniche, da un lato, coll'arte r ia e le vene polmonali.
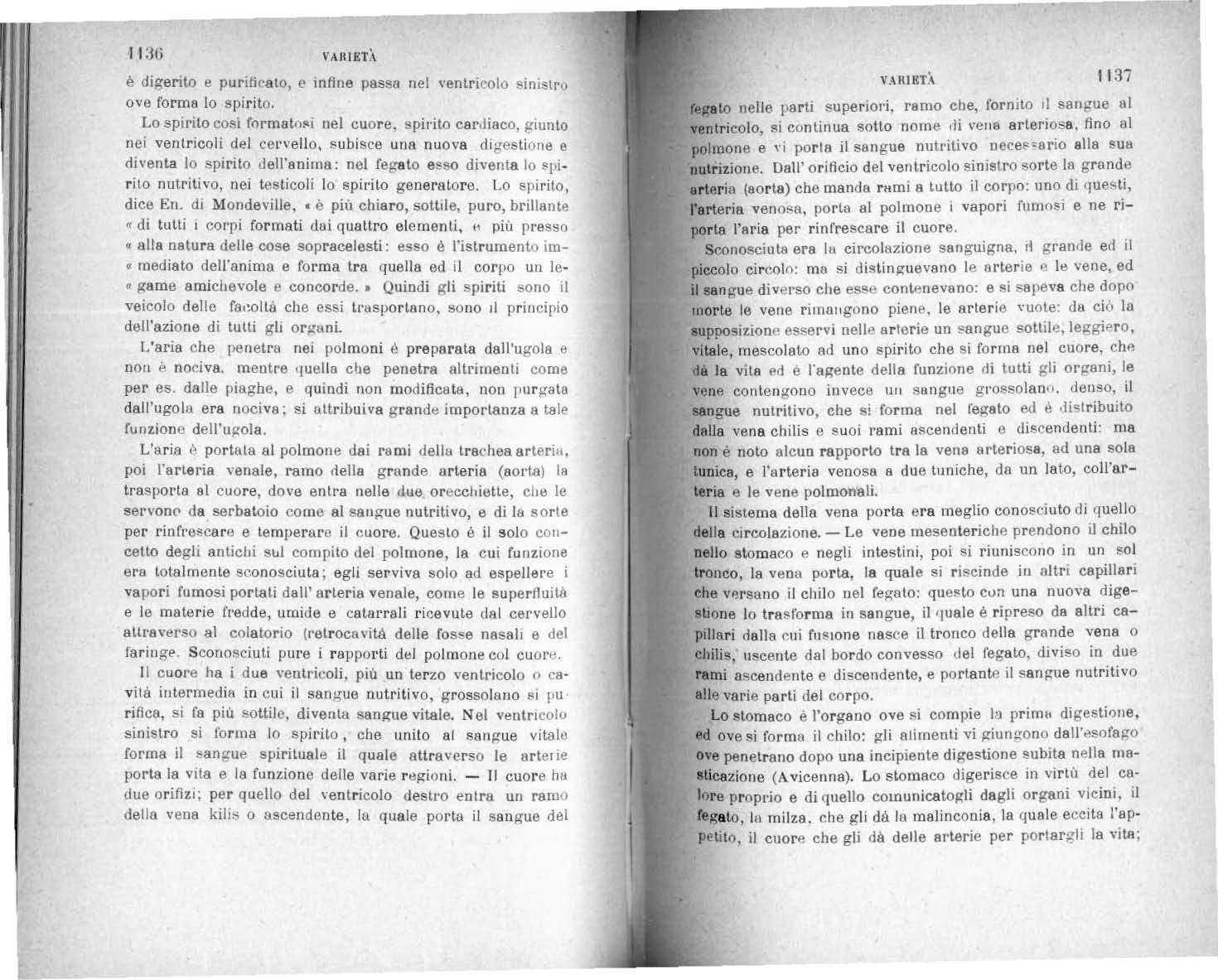
Il sistema della vena porta e r a meglio conosciuto d1 quello dell a ci r colazione. - Le vene meseoter iche prendono il chilo nello s toma co e negli inlestint, poi si riuniscono jn un sol tronco, la vena porta, la quale si riscinde in alt r i capillari che il chilo nel fegato: co:1 una nuova digeStiOn e lo t r asfor ma in sangue, il •tuale è ripreso da altri capill a r i nalla c ui fusiOne nasce il tronco della grande vena o chili s, uscente dal bordo convesso del fegato, diviso io due rami ascend en te e discendente, e portante il s angue nutritivo all ':! varie parti del co rpo.
Lo stomaco è l'organo ove si compie hl prim11 digestione, f!d ove si forma il chilo: alimenti vi giungono dall't!sofago ove penetr ano dopo una incipiente digestione subita nella malllicazione (Avicenna). Lo stomaco digerisce in vi rtù del calor e p r opeio e di quello comunicatogli dagli organi v1cini, ìl fega to, In milza. che gli dà la malinconia, la quale eccita l'appetito, il cuore che gli dà delle arterie per portargli la vita; il cer vello, dei ne rv t pel la vescicula del Ji,le manda pu r e la bile <;ul fondo dello s toma co.
Il cb tlo penetra dallo stomaco nell'intestino cl1e lo 1:11 fega to mediante le vene il ùigiurH• .,. pu re vuotato del chi lo dall e ve ne e dalla bile che gli u rr1va dalla vescichetla. Il cieco è considerato come un altro stomaco: secoudo alcuni il colon rice veva pure della brlfl nel punto o ve è a contatto del terzo lobo dd fegato, ciO c!JP rec<'i la a le feci, il cu i r icettacolo é il retto.
Il fegato é della seconda digestione; egh produ 1·.il sangue destinato a nutri re il corpo, mentre dal cuort:l parlo! il sangue che porta la vita e lo dal fegal1> dipende la nutri ziOne, dal cuor e le funzioni, le propr ietà degli 11 chilo portatovi dalla po rta e dalle mesenteriche vi subisce una nuova digestione in cui si fo r mano i qu attro umot•i: il sangue pro p r iamente detto, la bil e, l'atrabile, ed una acauosità, co · mune a Lutti.
L a bile, collera o l'luperlluilà collet·ica, va alla vescichetta del fiele e di là al fondo dello stomaco ed alle intestina per pulirli.
La superfluità malinconica, p r odotta nel fegato , passa per un canale nella mJ!za, e di lé con al tro canale allo per eccitarvi l'appet ito.
La super fluità acquosa del sanf!ue ne è estratta dai r.•ni, condottavi da un t·anale che si stacca dalla vena cuva. e quindi d al fegato: un altro canale porta l'acquosità delta ur in a nella vescica.
Infine dalla del fegato parte una g t•ossa vena d e tta la vena cbilis, c he si diviùe in due rami ascendente e discenden te (le du e vene cave) che portano il s an gue nutrilivo in tutte le parti del CtH·po.
Se gli antichi avevano qualclw nozio ne sui nervi, ben poco !'lapevanc• dei centri nervol'li. P ero si trova gia un accenno delle localizzazioni cer ebr al i: si an&mette da ta luo i ogni fa coltà il suo organo «ul cerve llo.
Alla prima parte del ventr icolo an teriore appartiene il:-enc;o comune, a lla seconda l'i mmaginazione: al ventricol o medro il pensie r o, il r agiona me nto, il giu dizio, al poste rio1•e la me· mol'ia. T r a i venlr i':Ol i vi so n o dei co ndotti per cui p spiriti: le res appr eftensas vanno da un ve ntricolo all'allro e r tcevono in ciascuno l'impt•essiooe delle facolta del cervello .
In certe r egioni si amm ettono degli emuntor i, o r g ani c:o · a& it uili di car ne g landulare e des tina li a t·accoglier e gli umorr non nttturali , morbosi; quelli del cervello son o soLto l'orec· chio r dietro la mascell a ; quelli del cuore nel cavo ascellare, quell i del fegato o del testicolo, all'inguine, dove per derivazione possono formarsi ùei bubboni. - Sono i ganglii linfa· tici e la loro funzione in parte esallamente iotet•pr etati.
Necrologi A
Glo vanD l llarttno Charcot na cq u e a Parigi rl 29 no'em bre 1R25 da mode"UI ma onor·ata farnigha di :a"or·atori. P ereor<oe regolarmente gli second ari e quelh di me· d irina in sua pa tria c nel 1862 fu nomina to ca po di servizio alla Salpè t r iP r e, ove col suo ami co Vul p1an intraprese la pubb licazion e degli Archioes médicales. Dalle osserva zioni ivi racco lte lrasl'ie i mat e r iali pe 1· parecchie sue memorie or igi nali.
Nel 1866 in cominciò le. !?-Ue lezioni di clinica m edica, cbl' sono diven ute celebr 1 in tullo il mo ndo scientifico, speci!tlmen te per le n umerosissime eJ importantissi m e scoperte sulle ma lattre del sistema n erv0$0
Dal 187:t al 1881 fu p r ofessore d'an a lomia patologica aUa Facoltà di medicina di Parigi ed in •1uesto periorlo cont inuò pure una serie di pubblicazioni ma laltte del s i.,tema ner voso.
Fu lui t·h e nel 1878 tolse all' l' ipn otismo e lo el evò a me todo sc ienti fico posilivo.
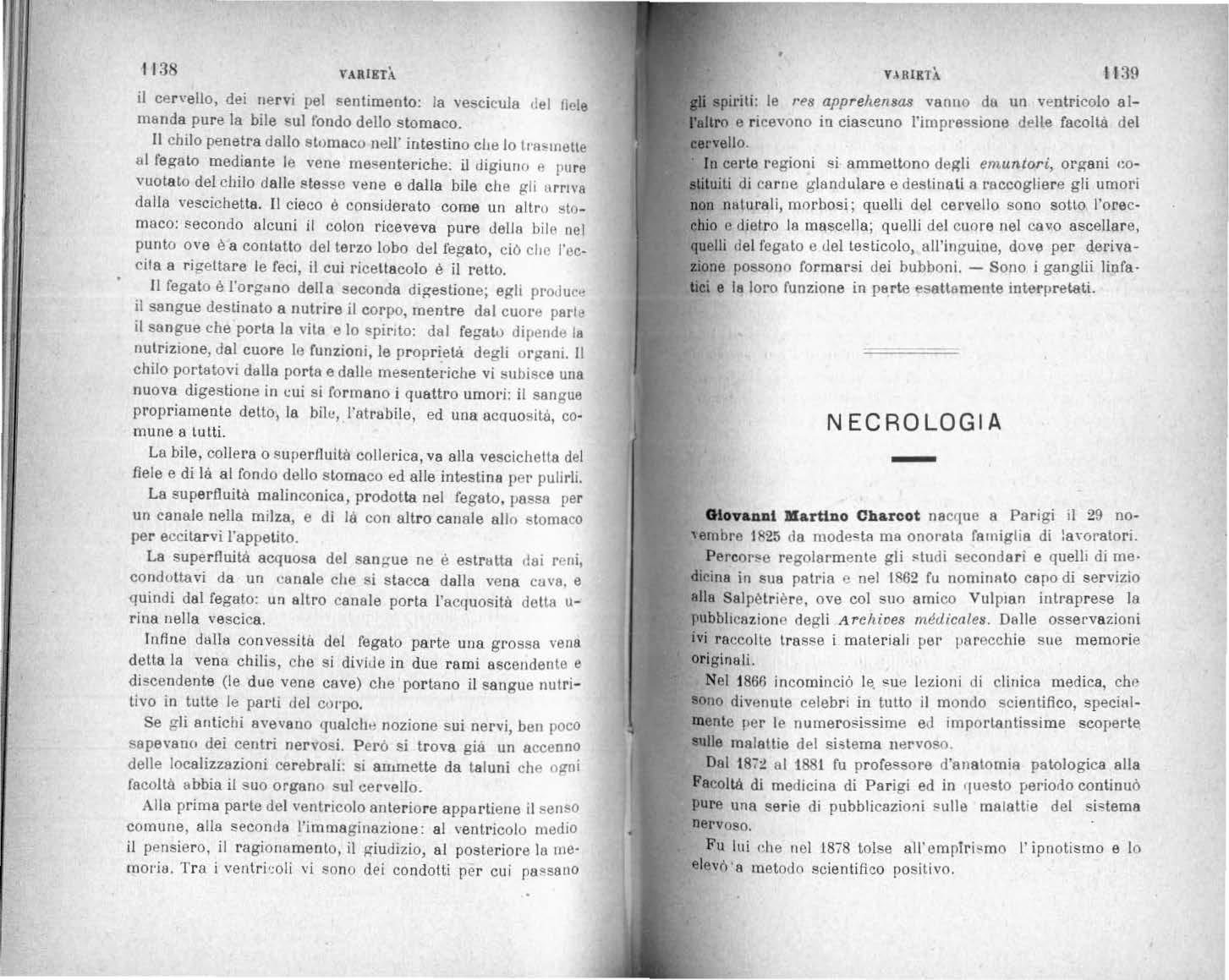
!'iECROLOGIA
Nel 1882 ebbe alla Salpètt•iore l'insegnamento rliniro malaltte ner vose.
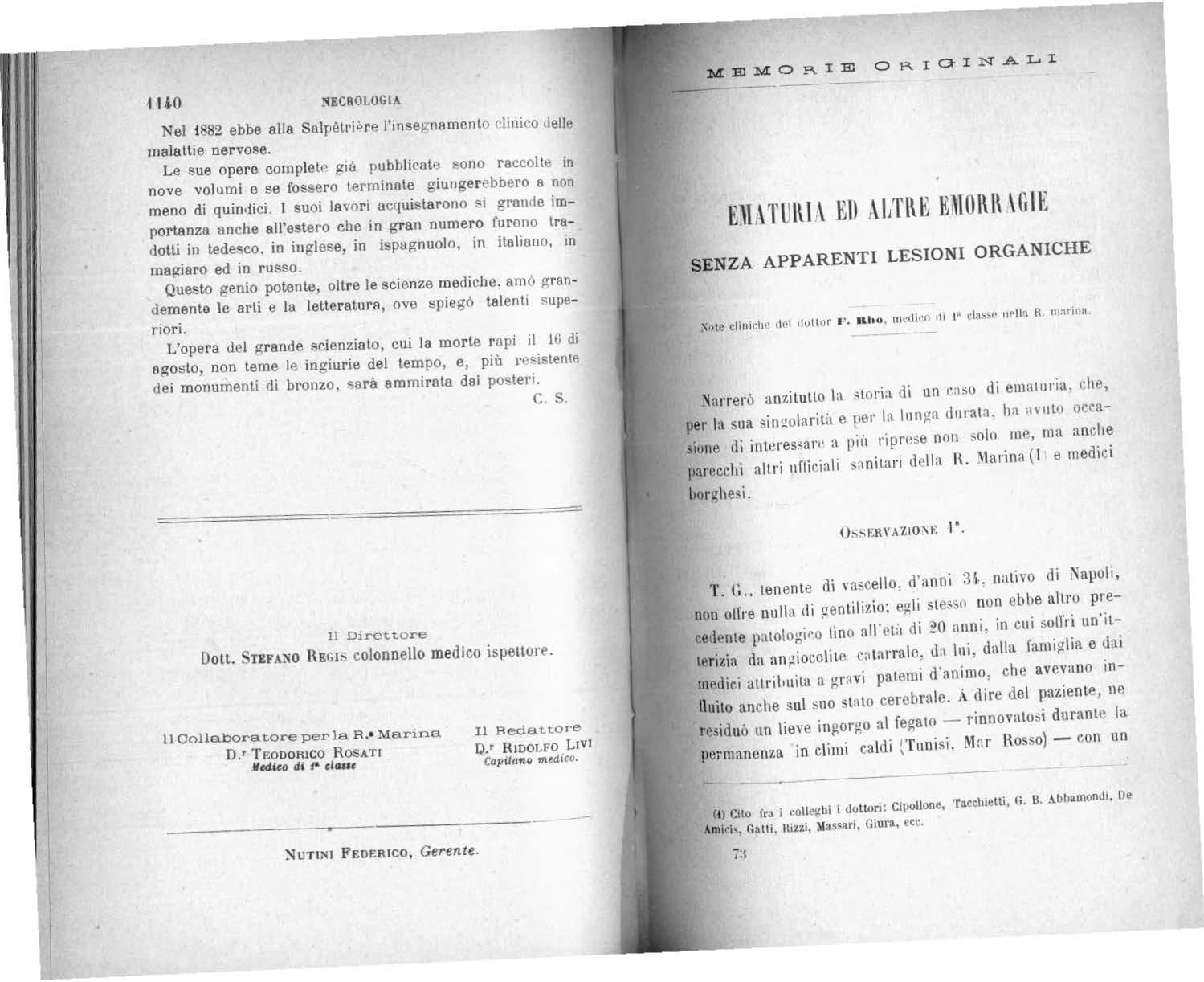
Le sue opere completf' già sono raccolte in nove volumi e se fos sero terminale giunger ebbero 8 non meno di quindici. l suoi lavori acfjuislarono gj gran•le imanche all'ester·o che in g r an numero fu r ono tradotti. tn tedesco, in inglese, in ispugnuolo, tn italiano, m magtaro ed in russo.
Questo genio. potente, oltre le sctenze medi che. amò g randemente le arlt e la letteratura, ove spiegò talenti superiori.
L'opera del fi(rande scienziato, cui la morte rapi il W di agosto, non teme le in giurie del tempo, e, più rl'sistente dei monumenti di bronzo, c:arà ammirala dai po!>leri.
\ •otr tiri ololtor t '. nh n mt•rlit•o oli l'' clnss•• nrlh [\ mariun . anzitutto ltì stori:t òi un caso ùi ematuria. rhe, per la sua e per la lun:!a dnrala. Ila avnto orcasiune di interessan' a pitt riprese non :-.olo me, ma anche pnrecclti altri snnitari dr\la 1\. i\larina (l e meclid 1•.
Il Diret.tore
Dott. TIFANO R&GI col onnello medico is-pettore.
11 Collaboratore per la R .• Mar1na
D.r TEODORlCO ROSATI .lltdleo d f l" eloue
FEDERICO, Gerente.
Il Redattore f).' RtDOLfO LIVI Ca pttano medico.
T. .. lenente di "ascello, ù'anni :1\.. nativo di non otl'l·e nulla ùi e:,:li ste.5so non ebbe altro prel'erlenle lino aii'Ni1 di ·:w noni, in cui soll'ri un'ittl'rizin dn angiocolite c:, tnrrale , da lui, d>llla e dai Ul Pllici attril•uila a !-(!':'lVi patemi d'animo, che avevano inlluit o anche sul <.no stato cerebrale. À dire ùel paziente, ne residui1 un lieve ingorgo al fegato - rinnovalosi duranti' la perm anenza in climi . .M nr Rosso) - con un
(l ) Cito ft•a l colleghi i dottori: Ci(IOLlooe, ·r acchietti, G. B '.bbamomli, l>l' i':\ po' di cata rro gastro enterico, d quale mao ifeslavasi t'o n cometeorismo, inKorgo emorroidario ed altri :-intomi dr torpore
-'m11'h, Gatti , Rizzi, Massarl, Giu1·a, ecc.
Le attuali soiTerenze rimontano al l X8tl, quando il tenente ave' a 30 anni. \ llora, per la prima volta, dopo una ra,al · cala. iu cur si st rapazzò parecchio per essere novizio dell'arrl•. andando ad nrinarr. notò che le ullime gocrie ,enner·o colora te in rosso. D'allora in poi . ad o;.mi :\lrapnzo fì-,it·u o morale. ad ogni piccolo eccesso dictetir.o. si r pet•''·a qne:.to fenomeno. " e tenne parola col medico di bord o. du• era allora il collega Cipollone. il quale attribui quelle pit·cole emonagic a debolezza del :;istema venoso del collo della ""scit·a e J(l curò con trementina, ac:irlo gallico. ect: .
Dopo mesi, il collega Tacchelti, volle praticare delle vie nrinario ino·oducendo un catetere metallico: lo slr 11m 1' n lo pa:;sò senza incont rar·e ostacoli. nè ptod.ru·r·e spnsiuw, nè (ll'O\'ocare emurragi t, onde se nl'toncinse r he lo stato di quegli organi non doveva a'er nulla tli allarmante, non potendosi rilevare alc un a alterazione anatomica. Fu in quel torno che, durante una ùreve l l'll11r 11 twmi. io per la prima YOila ebbi a curare il di que,tn sua rntermittcnte e lie\·issima ematuria. a t'ni tH>JJ diedi l.!rande importanz.1, onde. conferm ando quanto a\'e\ ano detto ){li altr·r colle,:hi. pre;;ni,-si la stessa cura. cono; i.!liando pure l'idr·otl't·apia locale e gener·aJe.
Rb:-11·cnto dalla Pi-Hmi a il nostro ma lato conlra,se una blenorr 'lgra che cu rò con iniezioni: lo stato acuto si drs· sipò presto e solo ne residuo per •rualclre mE'se una blenorrea senza alcu n cat·atterc di gravità . Un a sera, in seguito a rccitanteuti rnsoddi,farti, dopo aver prati ca to la solita ini ezione. nol(J che all'em issione del liquido ast r ingente, tenn e dietro un gello di sangue puro. Da quel gio rno datano le rere soiTerenze. l mperocchè. d'allora in poi :rndò so ggetto più frequentemente di pr ima all'em :tturia e ciò in special modo. qualvoh a si trova\ a in istalo di eccrtame nto proveniente da dispiaceri o co n tra ri età. ecc., e cosi pure si faceY a sentire lo scirocco o altrimenti subiva l'influrnza d1 nn tempo ;;nervante. Tale insorgeva 111ente ;, lun ghi o brevi inter>alli e .;;j notava pe r lo ptu tn 1111 , sola emi ssione di urine, altre volte in tullP o in parecchie rra le emissioni dr una )!iornata. piu raramente per parecchi "iorni consecutivi. LI era 111timaruente commisto al"l'ul'tna, senza coaguli, e tutta la quantità emessa era coloTata. al òell'inizio della malattia. in cui solo le ultime J.:Orcie t' r ano tiute di sangue.
;.!iorni preceden ti l'ematuria. i l un orero sen so di cos trizione al co ll o ùella vesrtca che ali allo della 1111 nzio 11 e ass um eva uu vero carattere spasmodico sì da rendere intermittente il L'ematuria. qua ndo si tava, faceva cessare del tullo questo incomodo che p?i ricompariva a poco a poco. I n generale, egli aveva cosi perio •ii con spa,;imo e senza sangue, da pcrrodt ptu lire\ i di ematuria ,-enza spasimo .
L'e,ame delle urine sanguigue e normali, venne praticato parecdrie , 0 1te dallo scrivente e da specialisti, fra cui dal l' rinta\·era di Napoli; al il sedimento dava a 'erl ere sulo presenza di emazie e di qualche cellula ù<>l ··nllo vescica, mai cilindri cellule neoplast1che, ni· muco-pus. che pCitessero far supporre l'esistenza di alleraziuni reoali. 0 di cata rro della vescica, o di nf'oformazioni ùell a i\ el 18\l 1. il G. volle farsi visitare dal pro f. lialloz1.i, il quale operò il cateterismo a scopo esplorativo e trovò solo nn pic co liss imo restrin gim enlo Ira l'uretra bulho sa e cavem,lsa,