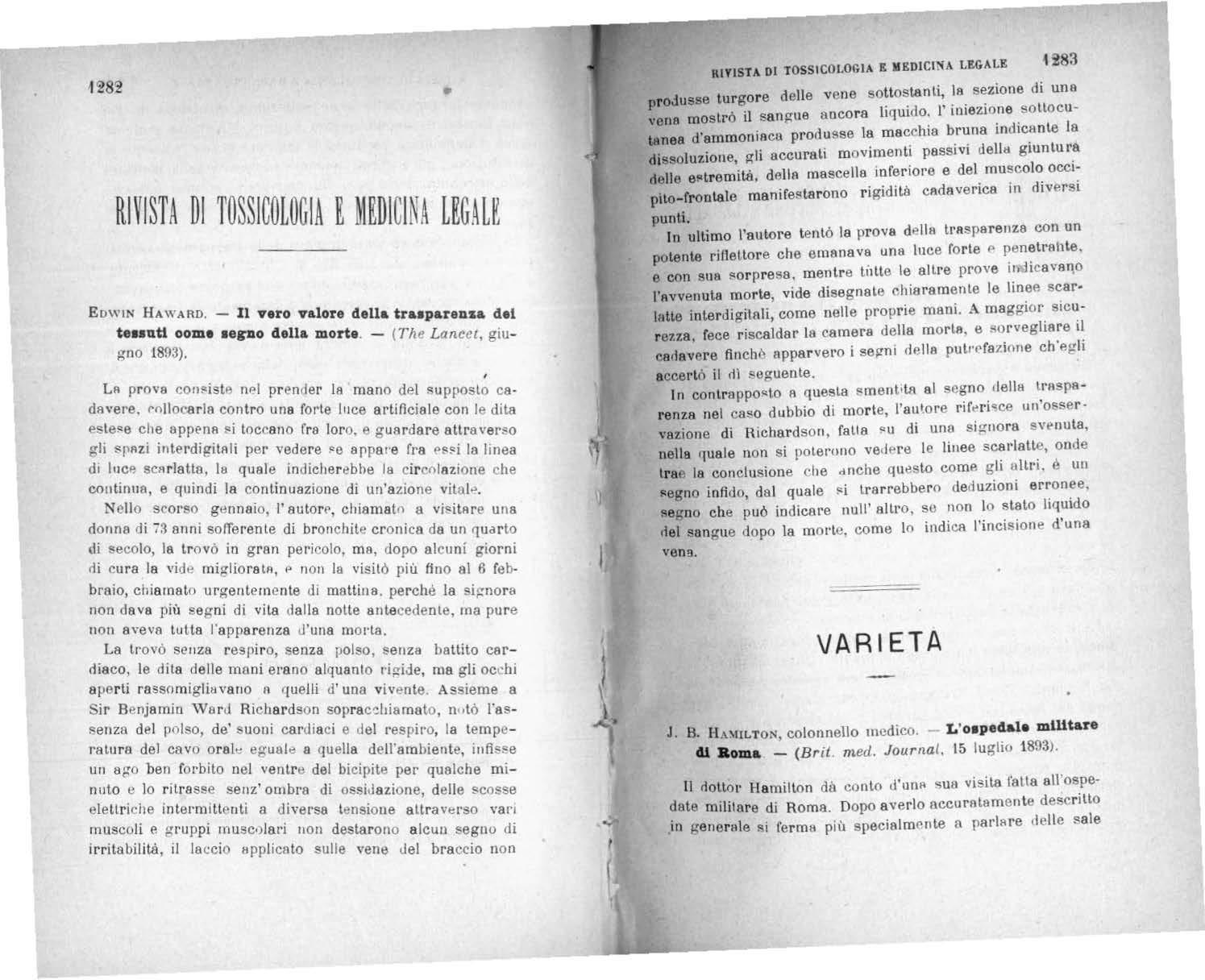
37 minute read
RIVISTA DI TOSSILOLOGIA E LEG AU
E ow1N HA WARD. - Il vero valore della traaparensa del te ..utl oome 1epo della morte . - Lancct, giugno 1893).
LA prova nt?l prender la mano del supposto cadAvere, rollocarla contro una forte luce artificiale con le dita E'ste;.e che appt>na tocca no fra loro, e gua rdare attraverso gli l"pAzi irilel'digitAii per vede r e "e appare fra t>!'!<i la linea d1 lucP scA rl atta, la quale indicherebbe la circol azi one che continua, e quindi la con tinuazione di un'azione vilal->.
Advertisement
Nell o scorso g e nnaio, l' autorr, chiamalo a vi"'ÌtAre una donna di 7a anni sofTe re nte di br onchitt• cronica da un quarto di secolo, la trovò io g r an pel'icolo, ma, dopo alcuni giorni di cura la vitle miglioratA, P non la visitò più tfn o al 6 febbraio, chiamato u rge n temente ùi mattina . perché la signor a non dava più s egni di vita dalla notte antecedente, ma pu r e non a,·eva tutta !"a ppare nza d'una mo1·ta.
La t1·ovò senza r espi r o, senza polso, senza battito carrliaco, le dita delle mani e1·ano alquanto l'igide, ma gli occhi ape rti rassomigliavano n quelli d'una vive nte. Assieme a Sir B e nJamjo Ward Richardson n11tò l'asd el polso, de' uoni cardi a ci e del respi1·o, la tempel'alura del cavo o raJ ,.. egua l.: a quella dell'ambiente, infi un ago ben forbito nel del bicipite per qualche minuto c lo ritrasse senz' ombra di ossiJ azione, d elle gcosse elellr iche mte1·mittr nli a di versa tensione va1'1 muscoli e g 1·uppi musc•Jlar·i non destarono a lcun se gn o ùi irritabilità, il laccio ttpplicato sulle vene Jel braccio n o n
RIYISTA DI TOSSICOI.OGIA K MEDICINA LltGALE i283
proJusse turgore d elle vrne .l a . di una mostrò il s an ,.,ue anco ra hqwùo. l uueuone sottocuvenB ,.. . i' l la ta 8 d'ammon 1a cu prorlu sse la macrhio bruna mc 1cttn e di::oluzion e, gli accurati mov imenti passivi ùelltt dell e e 11 tremità, d ella mascella mferio1·e e del muscolo occrpito-frontalo rigidità cadaverica in rlivPrsi punti.
In ultimo l'autore te ntò la pr ova dPlla t1•asparenza con un polente riflettore che emA nava una luce forte P e con sua mentre ti1tte le allre prove lt.hcavano l'avvenuta mo rte, vide chiaramente le sc a r · latte interdigitali , come n elle propri e mani. A maggwr. r ezza fece riscaldar la camera della mo rta. e sorvegliare Il fin cbt\ appar vero i dPlla pulrPfazione ch'egli accertò il rll ;.eguente.
In con LrappO"'lO a questa !'meut'tn al segno della li'Aspar enza nel caso dubbio di mo rt e, l'autore rir..r i"'CE' un'osse rvaz ione di R1 char dso n , Calla "U di una si!!:nOra SVI' nuta, nella IJUale n o n si poterono vedf' l'e le li nee onde trar' la conclusione che dliChe questo come gh nlll'l , é un "egno infido, da l quale tra rre bbero deduzioni che può indicare null' ailt'O, so non lo steLo llflUldo •iel sangue dopo la mo 1·te, come In indica l'incisione d'una vene.
Vari Eta
J. B. H .u!ILTON, colonnello medico · L 'o1pecl.al• mUltare 4l • om a - (Br ii m ed. Journa l , 15 luglio 1893).
li ilollor Hamilton dù conto 'iU8 visita l'alla all'ospedale mililare di Roma Dopo a verlo accuratame n te desr r ilto in g enerale si l'erma p1ù s peciAlmente n parlare delle l>a le
(l'ope r azione, dell'nrmamenlario chirurgico e delle :.;aie mortuarie.
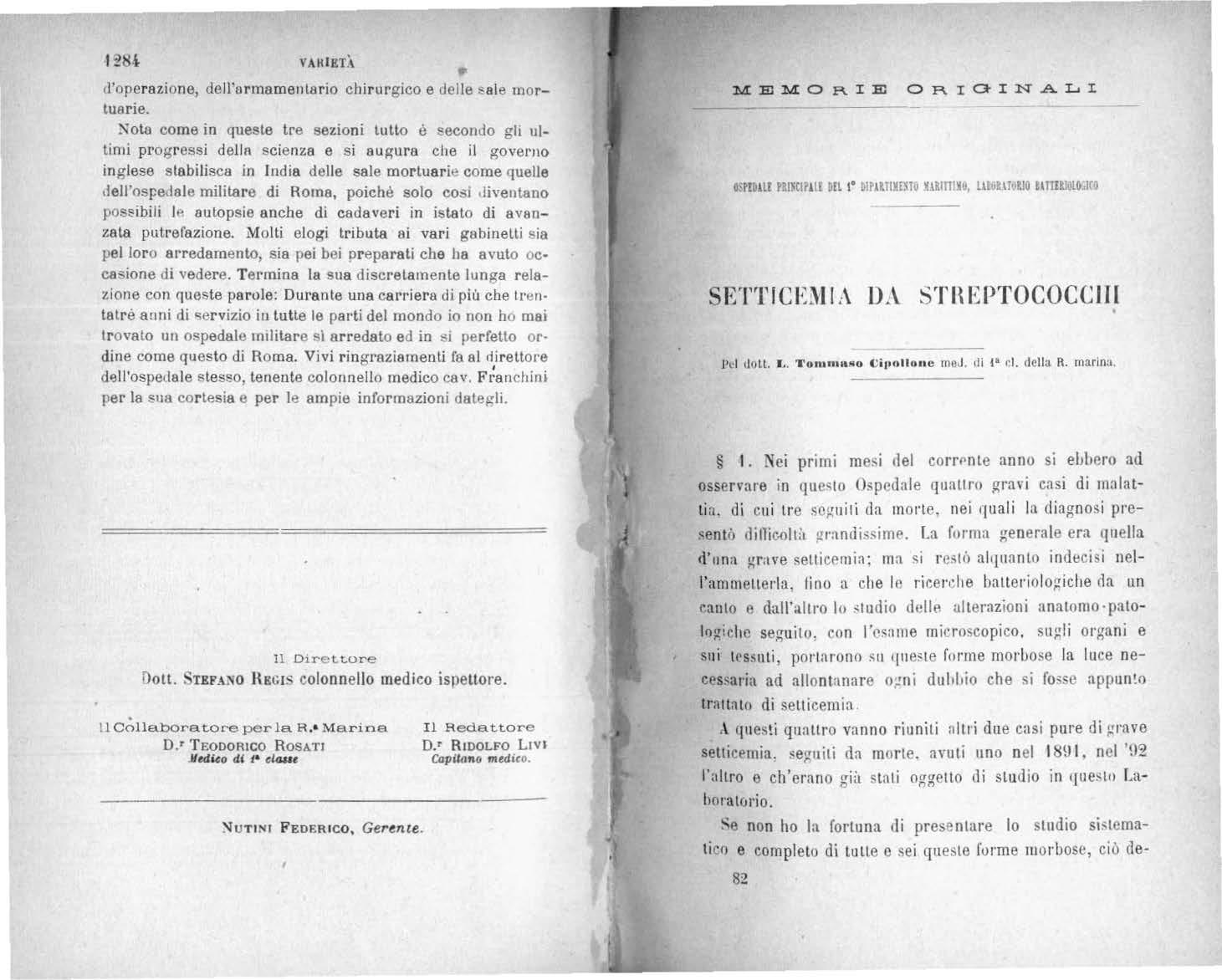
Xota come io queste tre sezioni lutlo è secondo gh ultimi progr•essi della scienza e si augura che il govemo inglese stabilisca in India delle sale morLuarie come quelle dell'ospe.lale militar e di Roma, poiché solo co5r dive ntano pos!!ibili lP autopsie anche di cadave ri in istato di avanzata putrefazione. Molti elogi tributa ai vari gabinetti c:;ia pel loro arredame nto, sia pei bei or eparati che ba avuto occa;;ione d i vedere. T e r·mina la sua discretamente lunga r elazione con f(Ueste pa role : Durante una carriera di piu che tr•en· talré auni di o;ervizio in tutte le parti del mondo io non h o mai trovato un ospedale militare c:;l arredato ed in pe rfetto or· dine come questo di Ro ma. Vivi ring raziamenti fa al òirettore dell'ospedale stesso, tenente co lonnello medico cav . per la sua cor tesia e per le am pie info rrn uzìon i datej.\li.
SETTJCEM IA D.\ STBEPTOCOCCHl
1l D1reLt.ore l)ott. R&GIS colonnello medi co ispettore.
l l Collaborato re per la R .• Marina
D .• TEoooRrco RosATI .llt4ko d( t • elaue
Il Redatto re
O.• Rr DOLFO Lrv1
§ l . Nei primi mesi tlel co rr t>nte anno si eLbero ad osservare in ques to Osprdnle quallro grav i cas i di malatti a. di cui tre scg niti da morte . nei quali la diagno si presentò dillic.oltit La furm a ge ne ral e era quella !l'un a grave selticemia; ma si re, tt'> a ltpw nlo nell'amm ellcrla, lino a che le rice r·,·he ila un rauto t> dall'a ltro lo ,;tudio delle altera zioni nnatomo·paloln girl tc seguito. co n microscopi co . sugli organi e Stri portarono S II queste forme la luce necessa ri a ad allontanare o,mi dultl,io che si trattato di seuicemia .
.\ ques!i qnnttro vanno riuniti oltr i due casi pure di gra ve seuict>mia. da morte . avuti uno nel l , nel 'H2 l'altro o ch'erano gii1 oggetto di stud io in <IUesw LahoratcJr·io.
Se non ho la fortuna di prese ntare lo studio ti co e completo di tutt e o sei qneste forme morbos e, ciò de-
1286 !->ElTICE'IT \ IL\ !->TltiWLOl.OCCIII ve:>i princrpalmcnte a che il medico militarb e ,opra Lnlli il dr marina, con le sue molteplici incombenze, che n(}n sempre pr·evet1nte, e troppo a interrompere il proprto la,·oro, uè ::.enrpre si trova uella possibilità d'isttluire a tempo utili al lello dell'ammalnto; e, d'altra parte, i rasi tli cui pal'lo son rima::;ti tulli poco tempo sollo l'osservazione dei medrci o spesso hanno prosentnto sintomi tumultuarii. Tut · tari1 la somma delli studi falli sino aù oggi mi pare che fornisca mater·inle suflk iente ad illustrare queste for·m c r1101'· hose eù a permetterne la puuhlieazionP.
l Caso .
§ t. Il soldato del ':?:>0 artiglieria J. F. rico\erato il l'i gennaio in questo ospedale e propriamentt' nel l Heparto di •:h ir·urJ!ia (medico capo doll. Holondaro), perd1t- afTello dn furo alla nuca. !)uesto ru :;uuito inci;)O, 'u otato de l puti e medicato antiseuicamente. L'iufe rrn o procedent hene; la T. asce llare il mauino del 18 gennaio era di 38°.1; la sern dello ste.;so giorno scesa a 3i".:) C.
Il mallino seguen te, se nza che al posto del faro si notasse alcun che di nuoro. l'infermo accu,ava nuovo malessere. Le T. del giorno furono serupre crescenti (:JSo,io• C.). Si notò fretjuenza di rcs!Jiro e dolore nlsenza fi.-ici tli aiTe?.ioue pl europulmooare. Prima che la T. i W", vi fu se usazione dì hri,·iùo piullosto forte.
Il gioruo 20 l'infP,rmo era giù grave. Le T. della )!i tlrnala furono pure in aumento ( W0 .1 - i0".8 - i-lo L), nouostanto la ::ommini:>tr·at.ione d'un grammo di antipirina.
SEl'TICEl! IA lU STBEPTOCOCCUI
ti dol ore al Ialo destro tlel petto era fo:·te e s1 esagerava alla pre:;sione, ma i sintomi fisici non rilevarono cosa. l o t[ueste condizioni l'infermo fu trasportato nel l Repal'lo Med ic1na (medico capo doll. Cal cng no). Quivi il giorno continuò l'alta termo-genesi ( W" , 6-.i.0•.3-40" C.); vi · era t endenza al vomito e si accentuarono i falli di prostrazione ge nerale. La lrngua era secca, largamente 1rnpatinata; la :;ete ard en te: il sensorio abballuto. Ad ogni colpo di tos,;e. che non era mollo freqnente, s'inacerbiva il dolore nlla hase del tora ce a destra. Si contarono l polsi e 3] alli respiratoni a minuto. Poco per volta s1 resero i d'una pleuro-polmonite hilnter;,le circoscritta. alle hasi pulmonari. in corrispondenza delle quali si a\e\'a limitata • ollusità dì percussione e si ascoltavano rantoli e respirazione bronchiale. Ma tanto agli apici che alle regioni polari In r isuonnnza di percu,;"ione era normale e t[UU.St normalo il murmure \'escicolare. Si notò pure aumento eonsidere,•ole dell'aia di splenica.
Tali condizioni rimasero invariate il giorno 22. crescendo l'O io la pr·ostrazione, malgrado l'uso di alcun i eccitanti {caffeina, alcool. anche per via ipoderrnica) e l'uso della digital e. L'i nftlrrn o, incoscio del suo grave stato, cominciò ad p1·eso da delirio e. in crr·Li momenti, da riso snl·donico.
Il mattino de l 23 gennaio lo !\lato dell'infermo em an-cura piil granL T. 40•: pol si piccoli. celeri, pro"t razi <>ne. apaLin, sgua t·do incerto , sclerotiche un poco ingiallite, tinta subitte1·ica della pelle. acce nno frequente al ,·omito, rtso sardonico. La sera si manifestò il coma eJ. alle Il ,:J O p. m. l'infelice spirava, dopo 5 giorni di mnla1lia, a non cont'll'e 1111elli ch'era rimnsto in cu ra per 11 {aco.
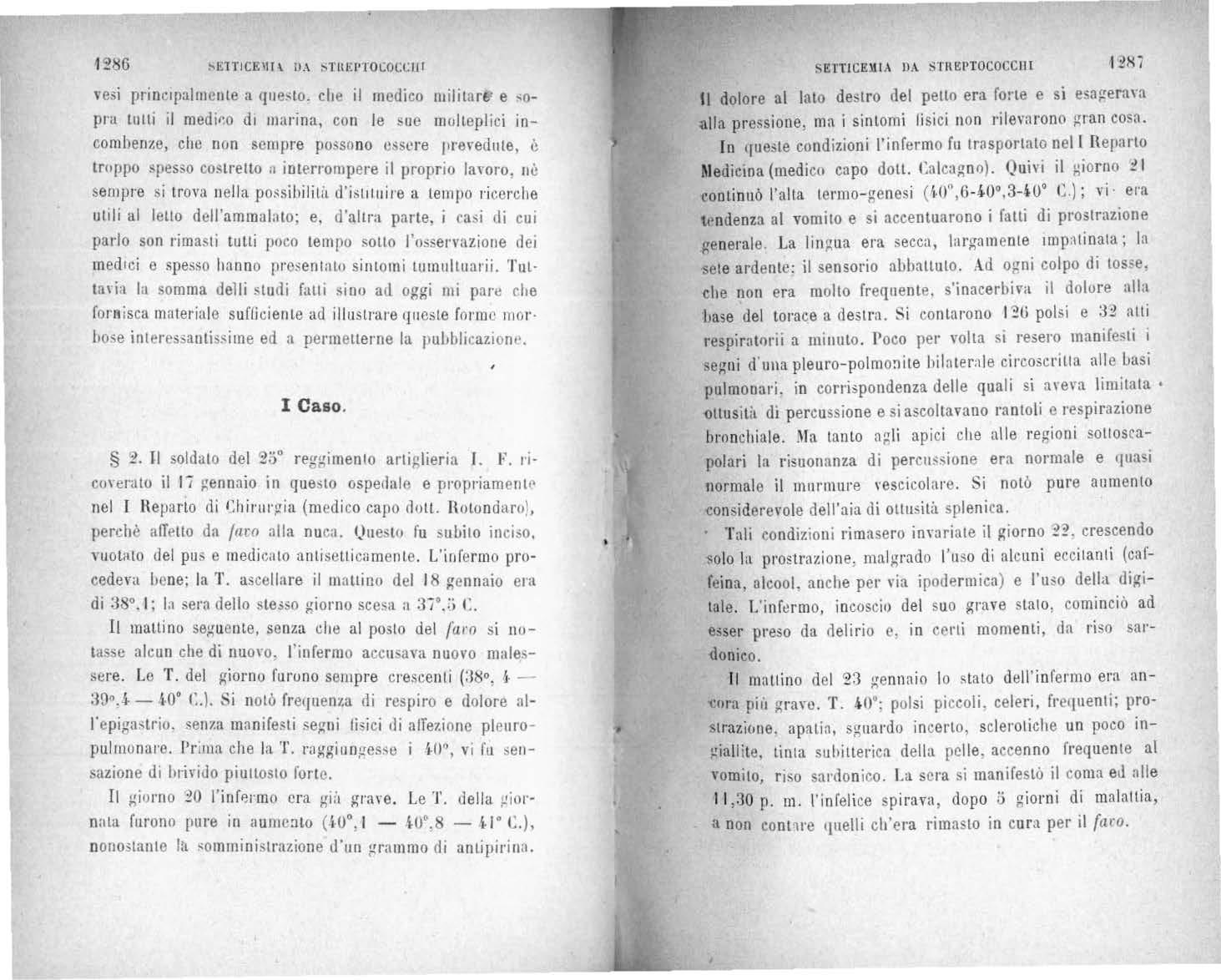
§ 3. Esame - Questa era srarsa, di giallo·aranciata, non limpida, C·>n pochissimo sediment(). lJion c hi ccio; P. S. l O?ì. -All'indagine chimica g j rinvenn ealbumin:t nella proporzione approssimativa di H: l 000: ao:senza di emati na; muco-pns non dimostrabile mente; tracce di fosfati terrosi: piccola quantità di alcalini: urati scarsi; pigmenti ordinari :\Car,;i, tranne· l'uro\ntina ch'e:-a in forte aumento: presenza del I II pigmeuto o p:gmento biliare imperfetto (quello che dava la tinta aranciata airurino) . - L'esame fecerilevare ammassi di leucociti: raro cellule d'epitelio Ye:;cicale degli st rati !' up erficiali; cili ndroiùi, cilindri ialini. cihndri granulosi; frequenti Ct>llule d'epitelio renule per· la mag}(ior parte con incipiente degenerazione grassa; gruppi. tli piccoliss imi cristalli romuoidali di acido uri t.:o .
Esami' dt'r;li sJmti. -Questi non furono mandati al Lahoriltorio per l'esame microscopico e per la ri cerca hatteriologica. Essi non furono mai abbondanti; men:e non vi si notò sa ngue, nè la tinta rugginosa dell'espettorato pneumonitico; ma una speciale tinta gialletta.
EsamP del scmyw·. - All' esame microsc opi co del sangue fatto la mattina cl el 2t gennaio, si trovò leggiero ma e\ ideme aumento dlleucociti; 'lllC:Hi erano in massima parte grossi, polinucleati o a nu cleo polilouato, con mo lte granulazioni uel pr·otoplasma. L'indagine lJatteriologica del fu fatta il medesimo giorno, con metodo pr esso a poco uguale a quello dal medico di l " cla :;s e prof. l'asqualo e pubulicato in unu de' suoi larori fatto a 1\J a:;:;ana(G l; e appunt•> per seg uir·e tale metodo sono uso a raccogliere l O- l :) gocciole di sangue pPr :;imili indagini: rna ciò nor• semprr r iesre possibile, ma5sime quando si tratta di mafati " r .tYi e irrequieti (•).
Jr; questo caso, per es . . dovetti acrontentarmi di gocc iole e no fcei due piastre con agar glicerinato.' che nel termostato a 3i" C.; ma fJIIPste rome ti tuho d t controllo rimasero sterili. Pertanto ness11na luce potè venir·e .a 'l'resto caso dalla ri cerca
§ 4- . Il giudizio prima che apparissero i sintomi fisici pulmonari, stette in favore tlella possihilitil di una l'lenrii t' dta{rrrmmatira , forma morbosa studiata bene da:'\. p.q e ca ratterizzata dalla manc·tnza completa di segni li:;iri e dalla mten-.tta ·de' rrenerali e funzionali, da febbre altissim a, da dispnea e da dolore laterale tal e. che l'infe r mo immobilizza una mela del torace e del dinfmmmn · speciali di questa forma m01hosa, come dolore tun "o il frenico con irradiazione nlla spalla. dolore ecce=-" o siYamente vi\' O alla pressione nella regione eptga:'ti'ICa e propriamente in un punto !i sso all'in.;erzione del pro1ungamenlo de ll a 1o• costola col margine dello sterno (/,ottua•' diaframmatico di G u e n e a u d e Mu s s y). altro pnnlo
(' 1 A piu questa rlrerca a\'6\0 ideato altro metodo che SJIC· n1 11 di pot•r presto u1eLt1·r11 in pralira; m:\ non ho potut.1 anrora !ar l';apJiarecchto Esso ti o' !'011->l s terc in nrtJJI· c1at•· cii 11 eu r te t n n l' di piccolo moLidto, ron dreolnrc su.perforle dello stnntufTo, il l[n nle, per non I'Cuir ((nuneg:;1ato dalln e;,,•re •li :m1iaulu Tult•l l'apftnrecchiu do1 rehhll es•cr cos trmto 111 modo r l1e ue ros:,a age,·ole la pprretta ste rilizzazione c!lÌIII!rnllolo tu un tutm d1 racitmcnte cuml' J.Otrehbe nppJu·ar>l a un JHIIJto 'IUaluuqnc d1•tta superllcie cutanea ttrer<'dentcmente stentizzato e com••, tu 4·3 c. cnh. eli sangue ;i 11i ricerche ba ltenotoglrhtl l'ili rnn 1Jll3llllta d1 sangue Il tullO do· esser•' caliiJmlo e !(mùUIILO all'esterno per voter tcuer conto npproodell:t di ,3n;;nc c'tr.ttlo.
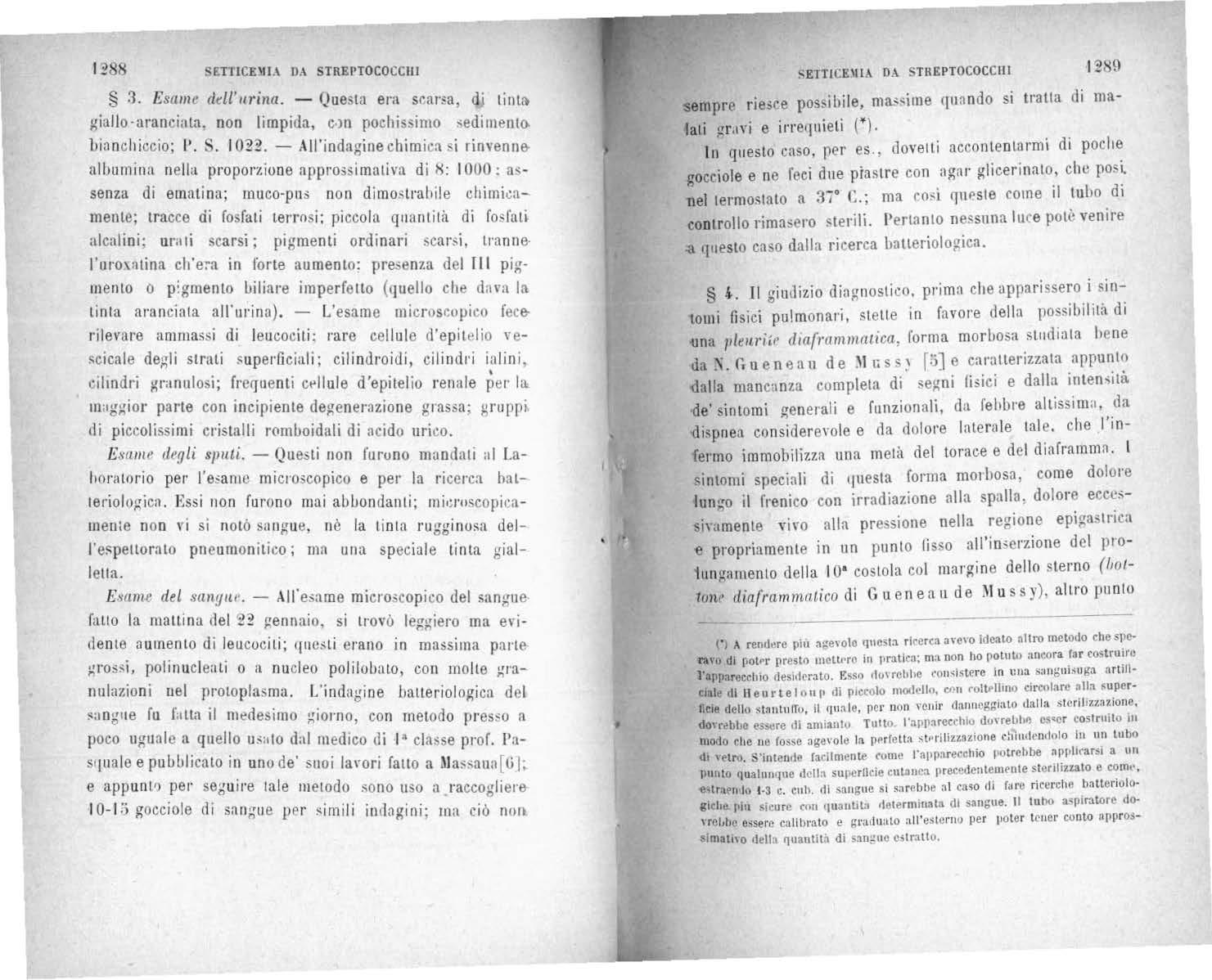
\ DA STREI'l'OCOCC lll doloroso a lh·ello della rachiJe e dell'ultimo spazio intercostnle, non si dele r minnrono assai neuameote. Mancava il singhiozzo ma vi era il vomito che il (, . de Mu s :' pure annovera u·a i sintomi speciali in:;iemo con l'ittero che, secondo 1' .\ ., si manifesta raramente. Questa diagnosi f11 fatta nei primi giomi dal signor Direttore dell' o-'pedale cav. P. Bocca, il quale fu anche il primo a farci rile\'are la sindrome fenomenica clelia selticemia, nllorcht• il quadri) clinico si delineò completamente, s pecie nei rasi che sal'anno in seguito riferiti. l . Nella posteriore del collo una sol uzione di con · ti nuo per favo inciso e non ancora cicatrizzato. Non lieve rossore dei tessuti circostanti.
I ntanto l'esame dell'urina aveva dimostrata la partecipazione dei reni e de l fegato al processo morboso, l'in gorgo della milza em considerevole e per il vomito persistente sr sCospettò :mche d'una partecipazione delle rneningi. Ollre a ciò l'analisi dell'urina, con la considerevole diminuzione di fosfati. e con l'aumento dell'uro\antina parlava in favore d'una infezio ne ac uta. Breve: si ammi. e infìne da tutti una grave in fezione generale e con questa diagnosi e con quella di plem·o-pneumonite hilaterale circoscri!La alle hasi, il cadaver b venne sul tavolo anatomico.
§o. A Questa fu eseguita 33 ore dopo la morte dal medico di l" ci asse doLLor Oa L t i l o e da me: no riferis,:o, per IH·evitil. le cose più importanti, che trascrivo dal libro delle autopsie.
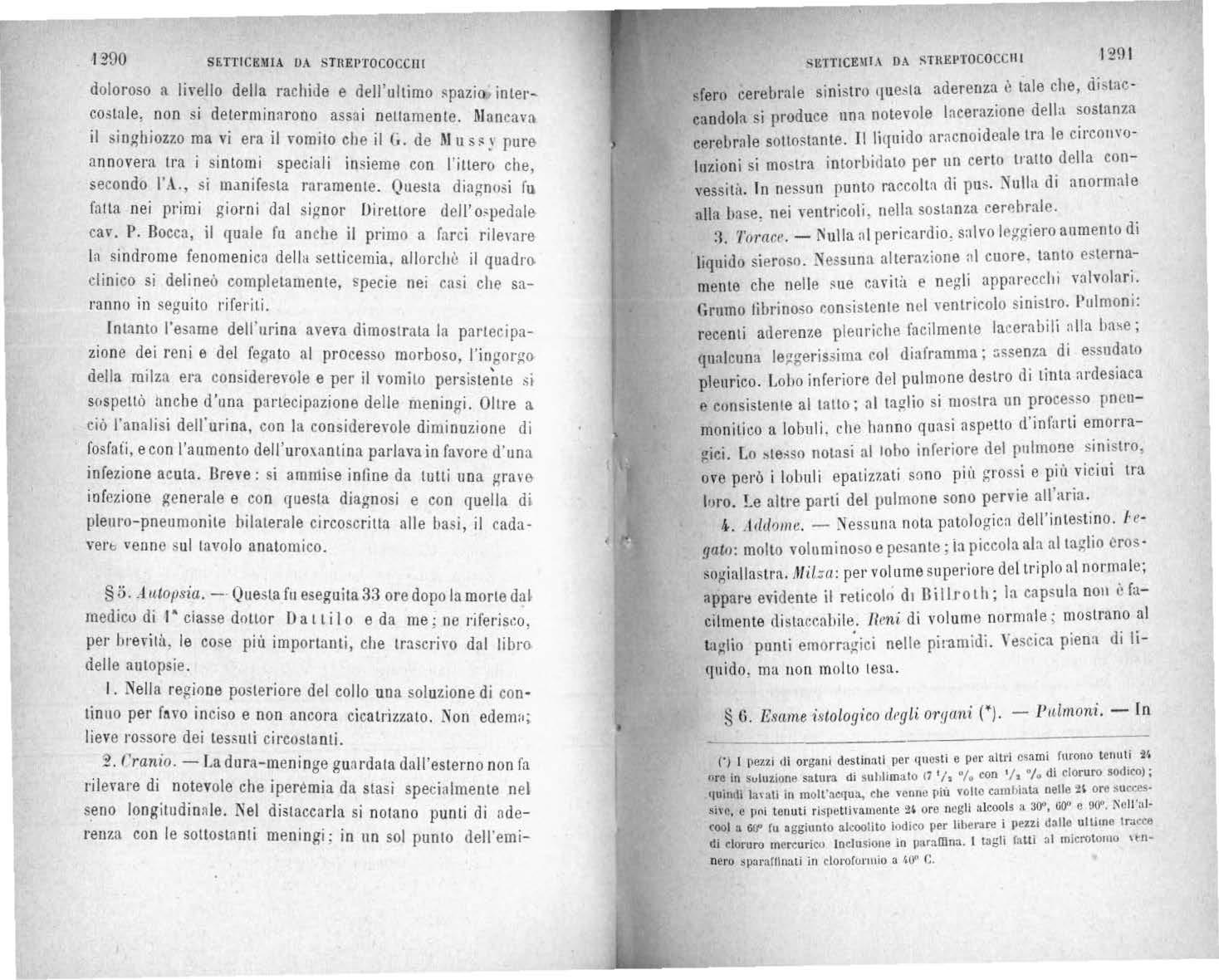
:2. f'ranio. - La dora-meninge gunrdata dall'esterno non fa r·ilerare di notevole che iperémia da stasi specialmente nel seno longitudinn le. Nel distacca rla si notano pu nti di nderenza co n le soltostonti meningi: io un sol punto clell'emi- ce reb rale si nistro tl ue,;ta aùereuza è tale che, di,taccandola si produce nna notevole lacerazione della cerebrnle sottostante . I llirruido at·ncnoidealetra le crrcouvolnzi oni si mostra intorhidato per uu ce rto tratto della convessitit. In nessun punto raccolta di pus. di anormale alla base . nei Yentricoli. nella sosta nza cer,.hralr. !l. Tnract'. - Nulla al pericardio. salvo an mento di liq uido siProso. alter:rt.ione al cuore. tanto mente che nel le ::ue cavitil e negli appnrccclll vnlvol:m. c; rumo fibrinoso ronsistcnte nt•l ventricolo sinistro. Pulmoni: rece nti aderenze pl euri che fo ci lmento lm·erabili alla ha., e; qu nlcuna rol diaframma; di pl eurico . Loho inferiore del pulmone destro cl 1 trnln ardes1aca p r.n nsislPnte al Lallo; al si ruostra un proce:>'O pneumonitico a lob11li. che lwnno quasi d'infarti emorragici. Lo :.te:;so notasi al loho inferiore del pulmone l>inistro. ov e però i lohuli epatizznti sono piir e pii1 vicini tra
I•J ro. Le altre parLi del pulmone sono pervie all'aria .
4- . •t ddnme. - nota pa tologicn dell'intestino. /'1'· ya t•J: molto voluminoso e pesante; la piccola ala al taglio eros· sogiall aiì tra. Mil::a: per vol urne superiore de l triplo al norma le; ev idente il reti colo dr Billroth; la non i• facilmente distaccnbile. Reni di vol ume mostrano al t.1glio punti nelle piram idi . \' escica piena di liquid o. ma uon molto tesa .
§ 6 . E.mme istologico drgli O?'ffani ( ' ). - Pttlmoni. -In r<Jr rispondenza dei Jobu li epal izzal i i tagli mo strano replezione degli alveoli per sangue. Trattati col metodo di W e i g e r t per la dimost r azione della Jihrma, •Juesta appari sce in ral'i punti, non in Lutti i tagli ed a lilamenti mùlto . .\el ce ntro delle regioni J'ah·eoli pieni d1 sangue s'mcontrailo arce di tessuto O\ e non si l'i conosce piu la struttura del parenchima pulmvnare. il quale sembra fuso in un tnllo lJUasi omogeneo o come tessuto Lrilllato prima con liscnio di poLas:;a. In questi campi, ove Il tessuto e in preda a necrobiosi, si trovano masse di microorganismi mollo addensati c di una sola :;pecie; do' 'essi sono più rari si osservano cocclt1 rotond1 spe:.so di,;posti a hrevi catenule di 3-5 In ullri punti i rnicrorganismi sono accumulali in mez:w a grupp1 di leucociti limitati in piccole cavità asccssoidali: di •Juc::.li leucociti alcuni sono pieni di cocchi. Attorno a questi piccol1 ascessi, proliferazione parvicellulare viunosto rigogliosa. os:;erva pu ro qua lche vaso cap illare della rete alveolare npieno, per breve lrallo, di cocchi i quali, colorali col metodo di We i gel' t, dànno all'aus·1 l'aspello di artificialrneute inrellato. -Q uesti coccl 1ì restano ben colorali coi metodi di W e i r g e r·L e di Gr a m; meno IJene col metodo d1 L ii ff! e r: colo rati col metodo di F r i c d l ii 11 d e r ore a caldo1e con quell o di 1\ i h h c r L, non capsula ti, aur.i con tali metodi si hanno callive colorazioni dei cocchi.
('J 1 pezzi tli organi destina\! per quosli e per altri csnmc furono tenuti i'o in soluzione di sulollmato t7 1/, •;. con ' l• "lo di rloruro socltco); CfUiwli la1 ali 111 morracc(ua che piu volle caml>i:tta ore sm·•:es· t•, e poi tenuti 24 ore n egli rtlcool3 (l 30", 00" e 9(10. l'iol!'nl· cooln w> ru ng"iunto nkoolilo iodico per hherare i 11ezzi dalle ultime tr..•·ct• di tloruro fnclu siune in l tagli fatti microLorttu ltnner·o in clorofiJrutio 3 C.
Rmi. - Epitelii dei tuiJolini co ntor ti in rigonliamenLo torbido, o de 0enerati o sfaldati . Emorragia inLcrstiziale fra i tubolini reLLi nell e piramidi. Qual che glome rul o scoppiato•e la cap:.ula ripi en.t di sangue. Frequenti ci lìntlrì nei Luh olini. Nei s i trov,1 non infrequentemente qualche ansa infarciLa di cocco i e dilatata ; altri se no vedono pure nei glomeruli a gruppi dì 8- 10 e più. .\n elle tra i Lnbolini retti si trova rJ oalche capillare pieno per on certo trallo di cocchi.
41i l.:a. - Frequen ti leucociti car iclu di mi crococchi e micrococ chi lib eri, spes,;o a catenule, nell e la cune e nei corpusc oli linfoidi.
Ft'!Jnto. - In alcuni punti i tagli oll enuli dalla piccola ala mostran o il tessuto epatico d:radato in modo che . a piccolo ingrand imento, le Yic c·apillari Lra le cellule sembrano del 1loppio più larghe del normale. \ J'o:·te ingrandimento ,;i os,.,ervano le colonn e di cellule epatiche assottigliate per evident e atrofia. delle cellole; alcune di que,:te scomparse. l ca• pillari in questi punti Jnscinno ossenare ncl lameote le loro {larcti; c cosi si può notai e che nel protopla,ma di c1ualche cellula endoteliale sporgente nell11me del capillare. 'i :;ono mi cro r.occhi a gruppi di pochi eleme nl1. Non si osscnano tratti di capillali infarciti di cocchi. ma questi ).!ruppi sono abhaslltnza frequenti. notando scne clue Irti io un sol campo mi r roscopìco ( L a i tz, oc. l' . .2). In qualche punto ::i nola incipiente c·cllulare del eonnelli,·o.
Ln pt·epnrazione delle mminyi è andnta a male e non po,so <lir nu lla in I microorgani.:;mi osservati nei reni. nella milza e nel fegato hanno i medegimi caratteri lllOrfolndi quelli osservati nel pulmone. dove solo so no in quantità mollo piii granite; e ,j comportano allo modo con i d1ITerenLi met odi dì colorazione.
§l . .\ bhiamo qui avuto un infermo C'he mentre si cura,·a !l' un favo all a nur.n. ca usa nè remo ta uì· prossima fu preso da grave forma morbo,_a, la •Juale per c-irca tre giorni oiTri sol tanto gravi sintomi I !\ioLomi locali della pl eut·o-polmonite dopo non deO<Jtarono tale estensione di processo da compromettere la \'ila. nì· la nefrìle giun se a pr odu rre urem i<'; difatti il dollùr C a l c ago o, ch'ebhe in cura l'inferm o, ha riferito, DPlla relazione mensile de l suo Rep art o. che di sin Lom: m·emici non st ebhe ne rn meno a parlare. La partecipazione delle meningi al mor·boso fu sospettata a pena in vita e le lesioni anatomo-patoJogi che, pur dimostrandoqn estapa rteripni one, non sono licienti a dar ragione della morte. D'altra parlo l'esame mirruscopico ha dimostralo che tulli gli organi esaminati contenevano in copia un microor;,(anismo che, per i caratteri potuti studiare, devesi ritenere sia il medesimo c clte st• · condo tutle le prubabilitù è Llll microorganismo e propr!amente lo piU!Jl'llU. il C)nale ha trO\'a Lo la sua porta d'entrata nel favo alla nuca. donde, per 1111 di granulazioni non mollo Httivo, durante il periodo guuriw>ne del favo, ha pot uto penetrare nella conentt> l limiti che m; so no io lavoro non mi perIIlf'llono di eutra re in una minuta. Ho mes.:a in vece ogni dtligenza nel segna r .:J le poche note clini che, le quali mi fu dato raccogliPre, ed og ni possibile ('nra nella ri · cerca delle alterazioni an,ttomo-patologiche sempre uste nsiltili nei preparati che "i consenano . Mi ri5erho solo. dopo l'esposizione di tutti i casi ra cco lti, di co111p letare il lavoro con qualc:he nola II Caso.
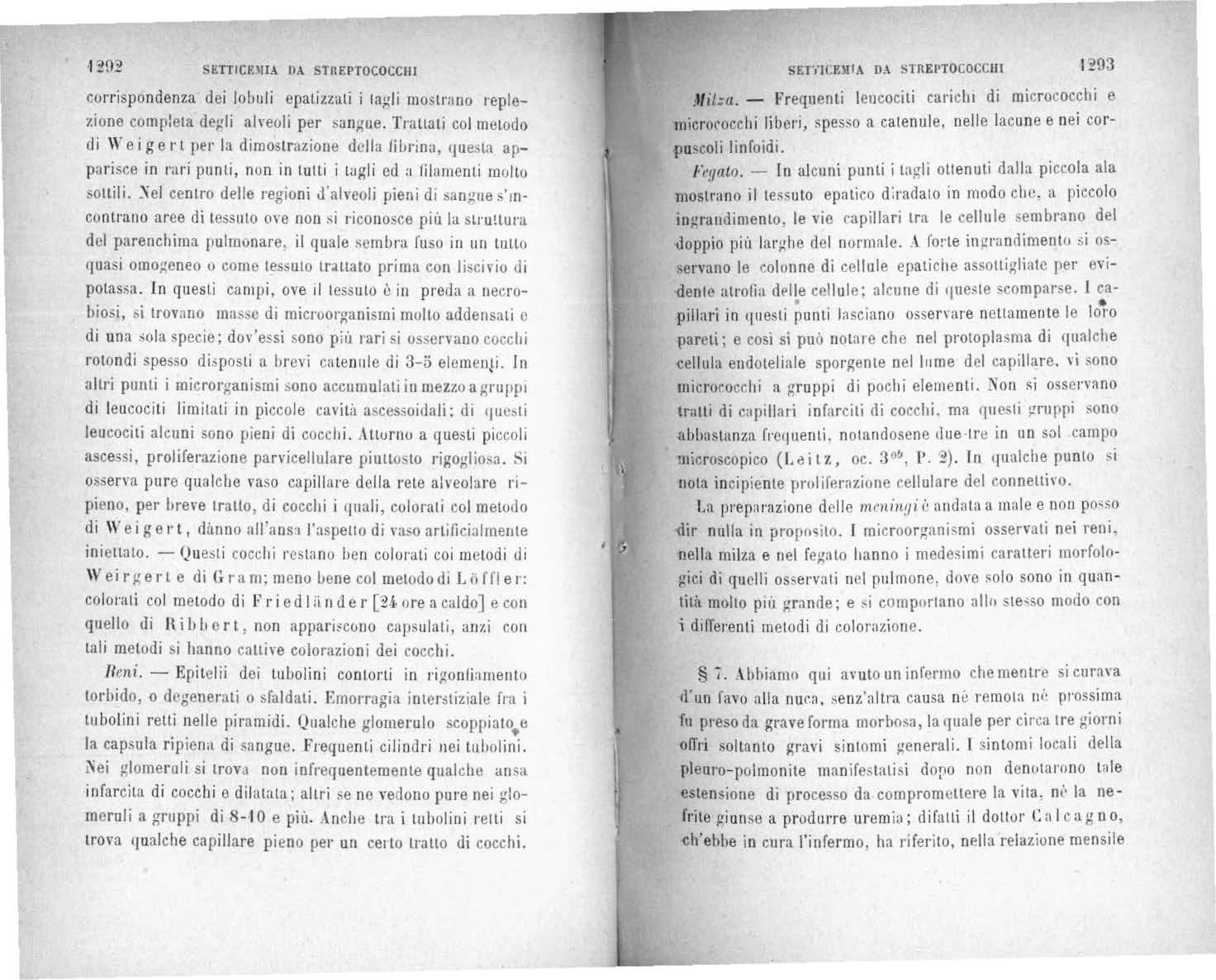
11 tJuadro cli nico disegnaLo dalla bre,·e clinica nfer ita i· qnello della setticemia !l decorso acuto.
§ S. 11 fuochista òel C. Il. E. S. Cio,·anni. imbarcato sulla n. nave Jffontlatore nell;t r·a1la di Spe7.iH. si prpsentò alla visit.t medira il mnll in o del 20 genrr.1io '18(1:3. accusando. geuerali e spos,atewl. T . :ri 0 .!l C. Stelle in ripo$u in se n7.;• mostra re si ntomi morhosi rileranti, vi fu
:o;ETliCElll.\ IlA STREPTOCOCCill 129i> aument o della T. il giorn o, .)8°,5; t'emissione quasi completa la sera, 3i 0 .3.
La notte l'infermo fu continuamente :-cgitato e il maltin<> se,;!uente, ri covernl'J a ll'ospedale di bordo. accusava sensazion e assai penosa di dolori al pello, alle ginocchia e ::pecialmente alla schie na. n forte cdalalgia, non affa nno, non disturbi nervosi. La T . ascellare e r·n di i.O• e. henchè nel cor·s'> del giomo si fosse daLa dell'anLipirina l ','t in più volte), aumentò sempre; cioè alle :3 p. m., Hl0,8 alle 7 p. m. \'i furono ripetute sensazioni di hriviùo, ma questo non fu intenso .
Il mattino del 3 1 gennaio lo stato dell'infermo si pre· sentara piuuosLo gr·a\e. Decubito dorsale, dolon assai penr,si alla schiena. che s'inacer·bivano forte ad ogni moviment o, dolo ri all a regio ne precordiale eù alle senza alcuna affezione localizzata alle articolazioni. Lingua ri ··o,erta d'una spes•a patina b:anco-gialliccia. bocca se mpre arida, sete ardente . T . ,i.Oo,U alle i a. m. Yi furo nCI parecchie oscillazi oni nel giomo, ma la T. non discese mai 'ott o i .s.o • e la sem era ùi nuovo 40".9. Si are,ano 4-0 atti re,;pi ra torii, l :30 polsi a minuto. l pulmoni all'nscoltazi one falla nnLeriormenLe non rile,·ar nu ll a; cos i pure il cuore. AIl' ascoltazione del dorso si notò c:re al semplice contallo dell'orecchio l'infermo gridara per acuti dolor·i: l'esame fu quindi breve e fece ril evare soflio bro nrhial e in corri sponden;.a Jelln punta sc:rpo lare destra. La pell e del dorso era alquanto nnossila e le;,rger mente ede· matosa; ma tale anossiment'J e leggi ero edema non eran lim itati da co ntorni preci si o semplicemente appariscenti , nù vi era traccia di llillcnc o di sudamine. non erpete !abbiate. non cia nosi del volto, non contratture di sor ta, non forte cefalgia. intelligenza netta. L'aia di spie-

1?96 lo.TTICH'II \ D.\ STilEI'lOCOCCOI ni ca era di poco aumentata: ni· altro si notava negli organi addominali. Si elthero all a sera profusi e l:l. notte vi fu scioltv. non co piusa . Quel gio rn o l'infermo stette a dieta di latte co n qualche urodo leg;:iero: gli si deuero cartine di salicilato sodi co e bevande alcalinizzate. li mnltino del 1° fehbra io le condizioni non rran guarì mutate. La T. ascellare alle 5 ell allo 'i a. m. ru di .i-0°.8. Ad un altro esame non si ascoltò più sollio bron chiale. Nulla al cuo re, tranue la frequenza dei hattiti: addome 1111 poco tumido, non dul ente. Al ginocchio destro una chiazza rossa come eritema scat'lattiooso: movi menti dell' :ll'ticol,tzione liberi. Si dettero altri 2:) centigrammi di chi niila con :25 centigrammi di antipirina.
.\Ile IO a. m. la T. era i-0°. L'infer·mo fu allor·a sbarcato e portato all'Ospedale dipartimenta le con tutte le cure poss ibi li e collocato nel TI Reparto medicina (medico cnpo dou. lluggiero A.).
Qnivi si notar(lOO anche i forti dolori alla schiena che rende vano peno:<o il decubito dor:;nle. La pello dE' l dorso ave,·a tinta :;i poteva so llevar·la in plichc c mostrara leggiero edema. Il dolore si propaga, a anche a! collo e perù i mo' i menti del c:tpo eran o altpranto penosi. ma poss:bili sempn•; non vi era accenno a contrallure. La pressione digitalc ese rcitala sulle apo li si ·spinose non fe ce riconosce re punti limitati di dolorahilità. Si ascoltò fugacement e un sotlio bronchiale nella sottoscapolare destra. \Il a percu ss ion e l'infermo non 5i prestò per i forti dolor·i. Pol:;o radiale aritmico. disc reto niJanno, tendenza al vomito.
La nolle l'infermo la insonn e . Al mattino(.:? fehfra io) il sno era aggravatissimo. T. i0°.3. Il pobo delle radiali non si percepiva, si perce pira inrece qu ello
SE1Tit:Elll \ DA lt9i delld femor.di. Si fecero iuiezioni sottncutanee Ili etere e di alcool ca nfornl o. L'in lelligeuza si poteva dire libera, ma l'infermo non ave1·a coscienza del suo gr·a,·e stato. 11 suo era incerto e la roce ave>a nn timbro specin le ,ecco. \'erso le O a. m. cu min r·iò a covrirsi tli freddo =- n· dore, a ll e 10.30 n. m. dopo l1re1•issima ugonia mori, cio!} fu fall o l'e3ame dell'urina. perché «Juella che ricoverato in ospedale fn gittaLa dall ' infermieri e poi lrnfermo non ue emise a ltra. Non vi ru nemmeno espettorazrone. L'indagine batteriologica del fu pure ist itu ita, al modo :.olito, il mauino del ? fehbr-aio, ma r iu ·ci negati\'a.
48 ore dopo la prima sen.;azione tli brivido.
OaJranamne'i prossima rile1a che qualche giorno prima di darsi malato lo S. a poco bene. 11111 non ne fece caso. Da un suo compagno si venne poi a s·rpere che In al'anti. s tando lo S. entro una •·arlloniera mentre si carica va carhone. rimase in mezzo al carbone lin f> a metà tronco per ci rca mezz'ora e durò fatica a venirne fuori. Si lav ò poi con acqua fresca, come i ma puro che da qu el gior·no egli comrnr•nsse a sentrrsr male.
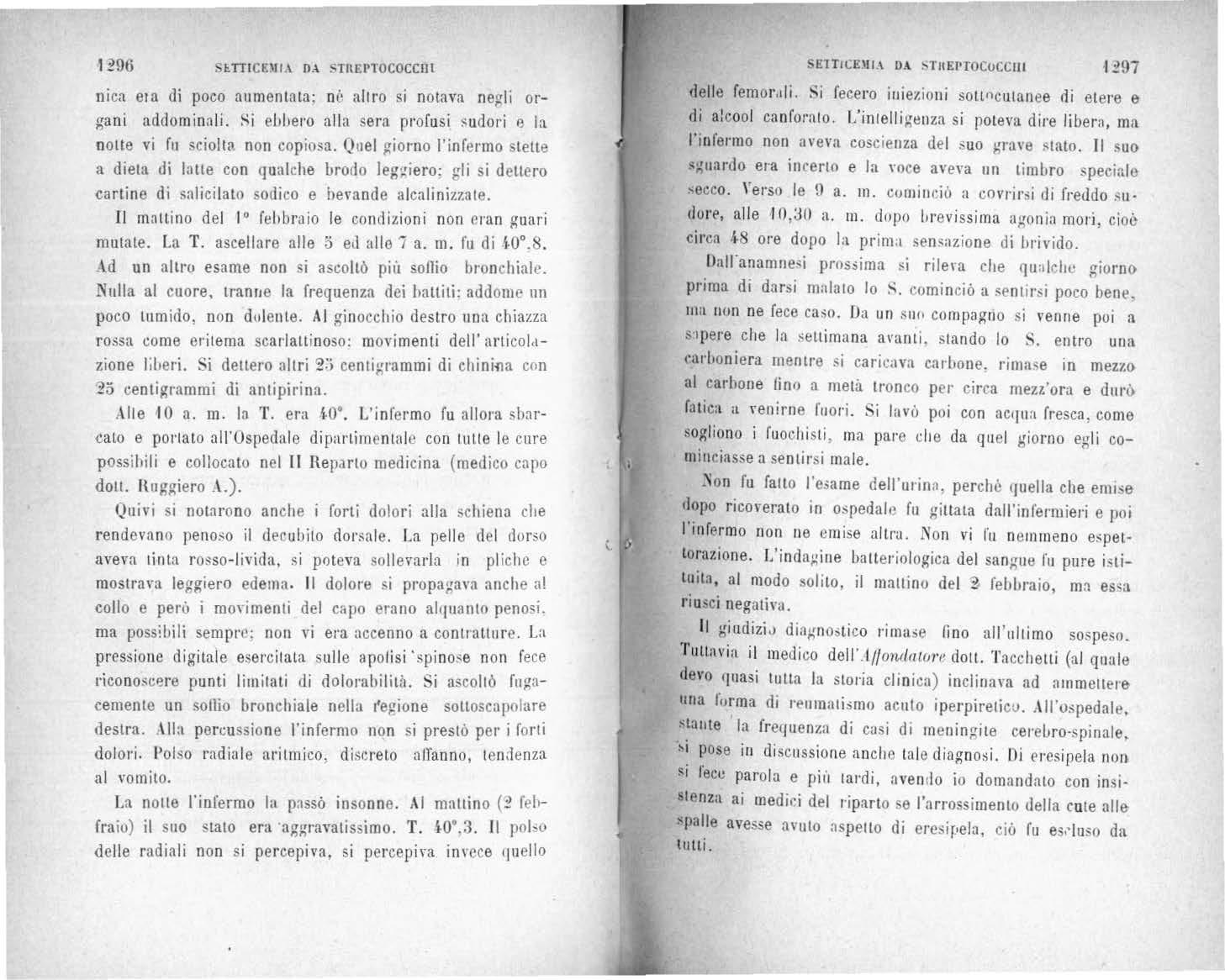
Il giudiziJ diagno:; Li co rimase fino all'ullimo sospeso. Tu llavia il medico dell '. lffondrlllJ1't' dott. Tacclreui (al quale devo quasi tutta la stor-ia clinica) ioclina1a ad arnmcllere una forma di r·eumatismo acuto iperpirelicu. All'ospedale, la frequenza di cas i di rn e nin gi te cereuro·spinale, pose in discussione anche tal e diagnosi. Di C>r·csipela non fece parola e pir'r tardi, aventlo io domandato con insistenza ai medid del riparto l'arrossimento della en te alle avesse al'uto as petto di orcsipela, ciò fu esdu so da llllli.
§ !l. .l tttopsia. - Quc:;La fu da me '27 ore dnpo la morte ed ora tra-;crivo clal libro delle a utopsie le nott> pr incipali. EstesP. macchie di decubito cadave rico nelle parti ùecli' i; a!le r egio ni scapo lari chiazze larghe ed a di co lor rosso vinoso e sono quelle che e:;i,tevano durante la malattia; nessun a scontinuitil òell'epitlermide, ne"'n na traccia di Oillene o di bolle. - trm,iu. altt•razione all'l'ncefalo ed ai suoi inYolucri. tranue che no n si vo;.:lia tener· conto d'un lie,·e intorbidamento dPIIiquido ara.cnoiòale fra a lcune· poche circonYoluzion i <l ella co nvessitit. La rachidt• fu di:'secala per inlero: nè il midollo nè le :;ue meningi pre:>t•ntavano alterazione di so rta. l' encrmlio e liqnitlo pcr icardico normali. Carità canlioe/11' etl apparecchi va lv olari norm ali. [\i el cuore destro un grumo fibrino so assai resistente. n 1mlmone destro non ha. a der enze pleuriclre; il suo parenchima i: pervio all'aria: alla base notansi rari no cl ulelli g rossi quanto un pi:'ello. come piccoli in l'a rti, al taglio di co lori to ardesiaco, di nspetto unil'orme . pa Al p. sinistro le aderenze pleuriche sono inv ece rileva nti, spec ialmente alla e col diaframm a O\'e son hriglic soLLi li facilmente lacerabili . Antero- lateralmeote, in co rri.;pondenza della sommi tà del lobo in[eriore v·,• un' aòere nz 1 di antica data. di consistenza fibrosa. che non ._i lucera c con' iene recidere con le forbici . Alla base del lobo inferiore "i so no anche noduli di tessuto infarcilo che hanno nl taglio tinta ardesiaca. Questi ooduli recì$i, vanno a fondn nE>II'acqna. Al cun i di essi . insieme con rruelli del pulmone destro vengono con.,e rvali per l'esa me microscopico . Il lobo !'\Uperiore del p. sinistro presenta ispessirne nto del p:1renchima posteriormente all'a pice: ma 11 0 11 vera epatizzazio ne. - lrld oml' . :'\ulla al peritoneo, nulla alla lle l tenue intest ir.o per intero.- La mil:cr
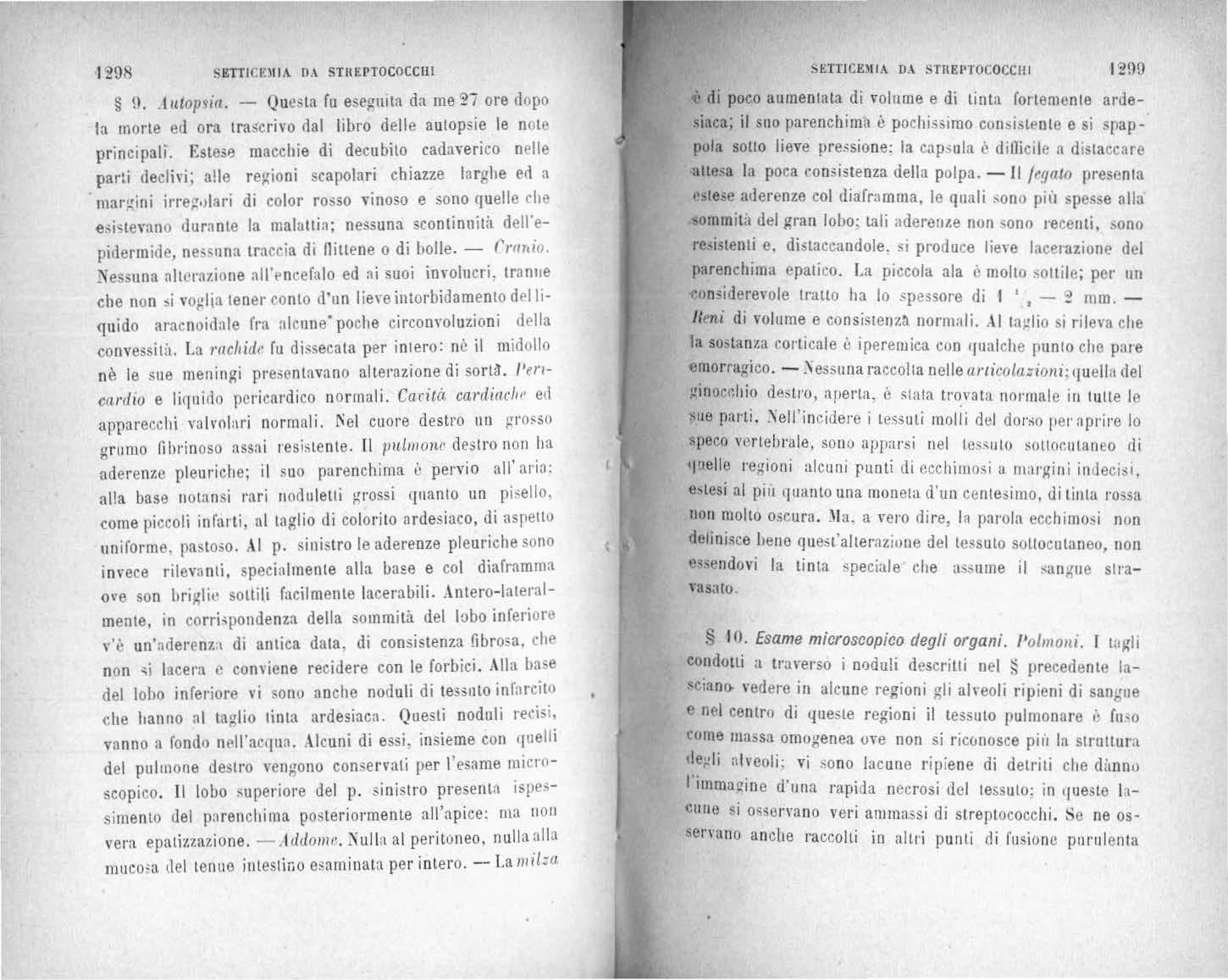
., di poco aumentala di vol nme e di tinta forLemenle ardesiaca; il suo parencbima è porhiss imo consiste nt e e si spappola sollo li eve pre::sio oe: la è drllicilt• .1 di'taccare altesa la poca co nsistenza della polpa. - llfr!Jntn presenta aclerenze col diaframma, le qu ali :;ono pi11 spesse alla ,ommiLù del gran lobo: Lati aderent.e non "ono recenti, :.ono c. dista ccandole. s1 produce lieYe lacerazione del parenchima epatico. La piccola ala «' mollo sotti le; per nn .·un;;iderevole lmtLo ha lo spessore di 1 ' * - :! mm.li mi di volume e co nsistenza normnli. Alta :.:lio s1 rileva eire la corticale è iperemica co n qual che punto che pnre t'mouag-i co . - S essuna mccolla nelle arlicoln:wm: 'luella del !!inoc(:hio ÒP::;tr·o, aperta. (• :;lata trovata normal e in tull e le :;ue parti . \ell ' in ciJe re i tessuti molli del do rso per upr ire lo lipeco vPrtel.Jral e, so no apparsi nel solloc:utaneo 1li quel lo regio ni alcuni punti di ecch imosi a margini indecisr. thles i al pin tjuanlo una mon e1a d'un ce ntesimo, ùi tin ta no u molto osrura. :\l a, a vero dir·e, In parola ecchimo i non deiinrsce hene quest'alternzione del tessuto sottocnlaneu, non la tinta ;;peciale che as:'ullle il sanl{ue stravasaio
§ IO. Esame microscopico degli organi. /1olmo 11 i. r tagli condotti a trarerso i ooduli descrilli nel precedente las.·,ano vedere in alcune regioni gli alreoli rip ieni di sangue r n<>l centr u di c.jueste regioni il tessuto pulmonare i· fn- o t'ume massa omogenea uve non si ri conosce pilr In sLrullura degli ah eoli: vi .--o no lacun e r ipiene di detr·iti che dirnn o l'imma !.!i nc d'unn rapida nrc rosì ùol 1ess uto : in queste hcuue si os>ùn·ano ver·i ammassi di streptococchi . Se ne osser\'ano anclte racco lti io altri punt i d i fusion e pnrul e nta
CIII insieme con ;.:randi qnantitit di leucoriti, alcuni de' quali ne sono infarciti. li contenuto alveoli epalizznti non é mai r·icco di leucociti come se ne trovano nella pnlmonite crnppale; nella mavgior parte ùi essi uon appari,.ce la fibrina (met?ùi del Weigerl o del linld•i); in pochi SI mo stra a filamenti rari e sottili. r sopra notati :.i comportano coi diversi metodi di colorazione :il io stesso modo che tJnelli rin' enuti nel l ra:;o (r. e. come qurtli, sono spro\Visli eli enp•ula e 0011 liancHI rormn·lanceo!ala. In hrevr: i prepar:ll.l ullE>u uti dal pulmone nel l e nel 1l c·a:;o rassomitanto fra loro, che p<ls.;ono auche confusi gli noi con gl• altri. La fig. l rappresenta un preparato I l ma e:':ia può servire anche per l'altro. L'unica tl•fJ'erenza è r ela tiva all'esten.;ione del processo, che fn nel l caso.
Jl eni. Le ma;.:giori alterazioni de!.!li organi si notano nei tuholini contorti della sostanza ccrlicale, l'epitelio dc' quali in pitl punti in allri punti le cellule sono in pn•1la a riaonfìnm ento torbido. Qua e là ootansi cilindri e dei cnpilln6 n tur:.:idi per molto Si nota anche, ma raramente. emorragia nell e c·apsule e da que.;tc il sa ngue s'è f:tllo strada nei tubolini urinileri. anse dei glumeruli e nei capillari tra i tubolini si trovano cocdt i a piccole catene di :J-1. elcm. ed n picroli gruppi, ma sono rari e mollo difficili a ricercare. Qne:-.ti cocrlii sia per la forma che per la grandc7.7.il. sia per i metodi r.oi quali restano co lomli rnssomigliano in tullo a quelli rinvenuti nel pulmone.
Mil::a. alter·a1.ione nella capsula c nelle Lrnherole. In alcuni punti si nola disfacimento dei globuli ros,i. Identica forma di microorganismi a piccoli gr·nppi; sono fre•1uenti i leucocili che ne hanno nel protoplasma. La quantitit dci
:,ETTICE'JIA 0.\ STREPTOCOCC..lll 1301 mir.roo•·:.!ani,rni della milza è di mollo ::.tiperiore a quPIIa dei reni.
Fegato. ,\ medio ingrandime nto si osserva che la rete cadrf!li acini è quasi tutta ripien, di in IJUalche gli elementi ffi()rfologici del c le cellule epatiche sono distribuile seoz'ordin e, per emorragia interstiziale, e qui vi le rellule sono r:1re ed rclrofìcho. In altri punti, ove non appari,; J'e emorraJ!in. i rapi Ilari dilntati e le cellule atrofiche (atrofia da l n poi si notn iutorhiùamento granuloso dPIIe cellule c>pntiche. La capsula del G l iso n del gran luho . d0\'6 s'ù trovata forte aderenza c·ol diaframma, ì.• ispessita e formata di tessnlu fibroso; tale alterazion e non è di data recente. Si nota pure proliferazione del connettivo peri portale nclli spazi :riangolari; ma il connettivo prol ife•·ato non rim piazza mai le cellule atrofiche. J micror· ganismi non s1 rwvengono in mnss1\ molto mu so11o frequ enti p;ccoli di uei capillari e nei leur,ociti.
80Uocutmwo. È la qunntitfl di streptococchi che si riuviene nel sollocutaneo e parimenti gra nù e è la immigmzione di leucociti nelle magli e !lei tessuto adiposo, alcune delle ctuali sono anche •·ipien e di sa ngne. l corr.h i o sono lib eri a catene di !}-ij element i u ra 1'chiusi nell e cellule rnigmtrici, entro cui spe;;so stn.nno in cosi grande numero, che non !ii scorge pil1 il loro nudeo. C:olorando i tagli col ca rminio e col metodo di We iJ(C r l. la zono di tes>uto invaso da microorganismi si os.;erva .:h'è limitata quasi nellamente io corrispondenza del limite fra co nneuivo sollocu tnn eo e strato muscolare sollostante, 111 mezr.o al quale non se ne trovano più; ma tra i fa scc ui fliU $Colari vi c\ proliferazione parvicellulare dl·l con nelli\'O o strnvaso di sa ngue; i va si del le$sulo musco lare dilatati pt>r molto s lllg ue. mostrano il ret icolo librinnso . ma in es::.i non si osserva no mìc roo rganismi. L'aspelto generale l'Ile dànno i preparati del tessuto sottocotaneo r quello di tessuto che carle in Ui fatti. malgra rlo la grande aflluenza di leurociti e la loro fase fagociti ca, do\'C è il numero di microorgnnismi la i lcucociti si mostrano mal colorati nei loro nuclei. rli guisa che il tessuto assume nspello uniforme come detrito ricco di rnicOLIChe. (n qualche puntu si del i mila la formazione di pi ccoli i 11Uali probabilmente :.i .are hl,ero manifestati anche cl inicamente. qualora il pro ceo\:.o fosse durnlo piti. a lungo. \ erso il derma non ho potuto dirnostrare egualmente bene la distribuzione dei microorganismi per difello delle preparazioni, le quali rimasero prive dell'epidermide e del corpo papillare; tullavia nei preparati sr osserva no le estremità profonde de ll e glandole a gomitolo intor·no alle I(Uali si trovano anche masse di mi crorgani::.mi e se ne trov ano anche nelrinterno di nlcune glandole: fatto d te mi rluole ùi non "' er polulo illu.;trarc rou preparazioni di t11lt0 il tessuto ('' ) . come puro nuu sono al caso di prcci:>a r·e quauta fosse l'e::tensione di tale alterazione nel tessuto sollocutancu del ùorso: i punti di con apparenza di furono però trovati in corrispondenza delle mac chie colorrosso- vinosoalla schiena: oou ve n'eran o a ll a cute del ginocchio. O\' e pure iu vita erasi manifestato dolore con arrossimento. n All':tUlOJISlll furono alcune JlOl'l.ll)lll cl! lOSS ll lO no'Ì puuu ov'c•sso appariva allo scopo eli vrc1erc se il trattava di rc·chlmo-i lrmlntrllit.:a, atll'iOI'lll' COUII' sc nella s torta Chll tC!I ('·· 8), Il fuochbtll S. por hl l!iornì avanti oli cader malato era rimasto prc,., tarlooue fino a mt'tz•l tronc•l. Fino a 1Jut•l momento, b hri''e dell'mfermo in o-pedali' lmrno d t ore) ,, f>Cr mancanz:.. •li untczir eire.• la ,u:.. latcia (oolili& ch'io ebbi in sùguito dal doll. Tacrhrtlil, non ,·er,t peusalu a una tto,.;ihile inret.iOIIr del tessuto sottocutanco.
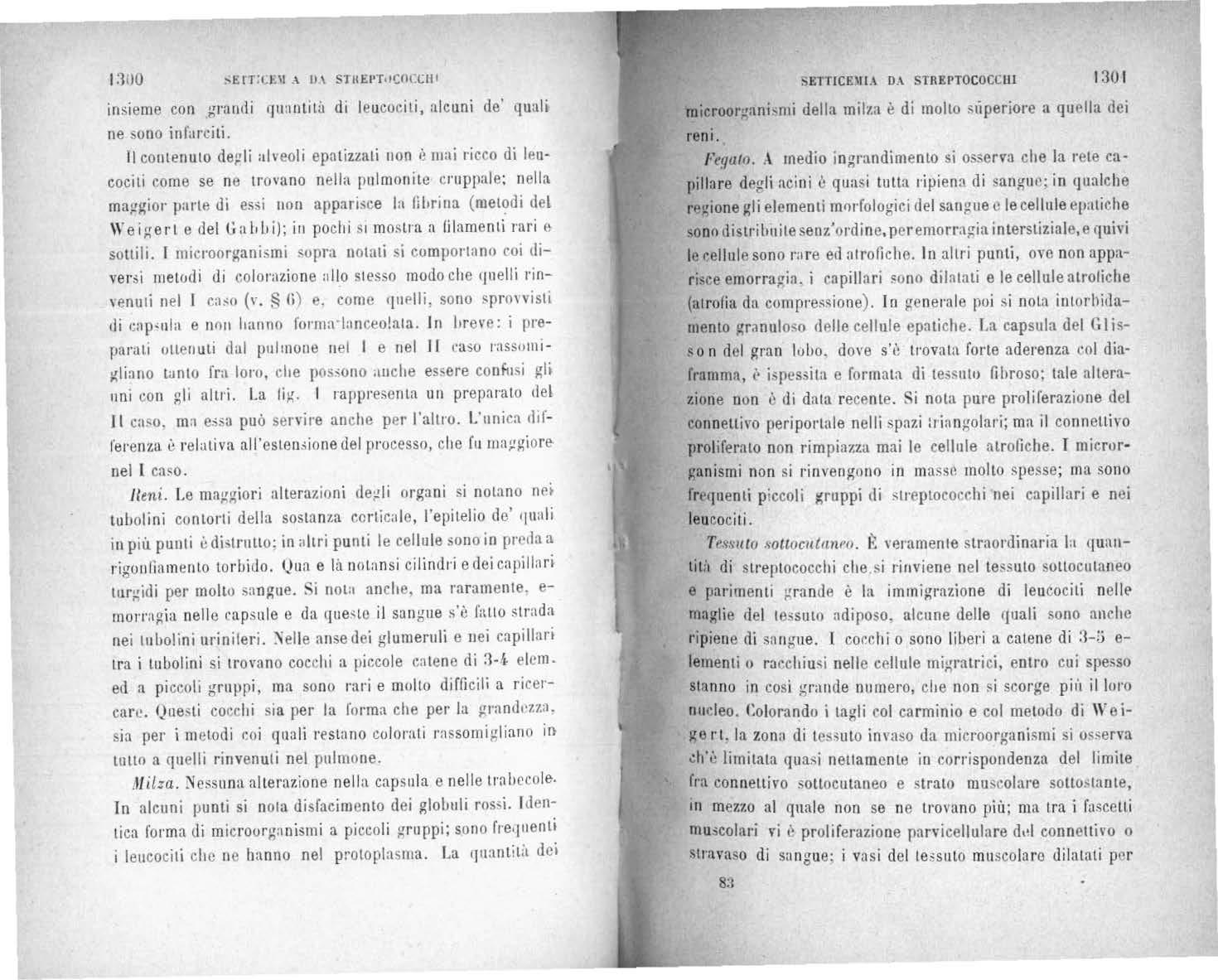
§ Il . Il o gii1 de t to che dei medici ch'ebbero tn -cura tJues to infermo fece diagnosi di eresipela e che. pilt ta rdi . doma ndati da me, esclusero truesta forma morhosa. Difatt i cli nicamente mancavano molli ca ratteri per ammetterla, come il color rosso 'ivo, la tensione, la lucidezza dell a pell e. l'edema, il propagarsi del processo con l'apparizione Ji :;OJu> marginate nei punti di nuovn invasione. le boll e o lliltene che sogliono co.;i frequentemen te manife;;tarsi nei casi di esle5a eresipela. Il no.;tro malato invece non presentava tensione della cute del dorso, la quale poteva non dilli cilmente sollevarsi in pliche: il colot·ito fin da principio fa livido, l'edema fu appena appariscente e fugace c il tl ulore era lullo speciale. massime per il carattere che ave\·a d' inace rbini ad ogni lieve tocco , 'luale il poggiare dell'orecc hi o pe r l'ascoltazione. Quanto a car,Hteri microscopici, alterazioni i·tologiche parlano in favore d'una necrosi rapida del tessuto so ttocuta neu. come suole inco ntrarsi sul fl em mo ne; e per '{nesto app1tnlo e per tulla la grave sindrome fe nomeni ca, bisogna ammeaere che la viru lenza <li (rues to era ben mag:;tiore di quella di cui è •lotato lo streptococco delle com u ni :>uppurazioni. che oggi quasi LutLi ritengono identico a quello di F e l h e is e n. È p11 re noto che la .::pecificili.t dello st reptococcodl Fel heisen oggi è messa in discns:-;ione, essendosi trovati da G ot·dan [71 e da altri ca;;i tipi ci di eres ipela nei tfuali l'agente eccitatore era lo stafìlococco piogcno aureo. ha quindi importanza etiologic.:a in questo caso la dilTerenziale Sl>pt·.Hlella. Mi hasla sofo far ri le,·are il fatto d'una sellice rn ia primitiva da streptococclti, la quale esce fuori ùei c,1si ben defi n tti in cui tale malattia può essere prodoun, 1:10è da infet:ione puerperalo, da infezione purulenta e da o sleom ie liLe.
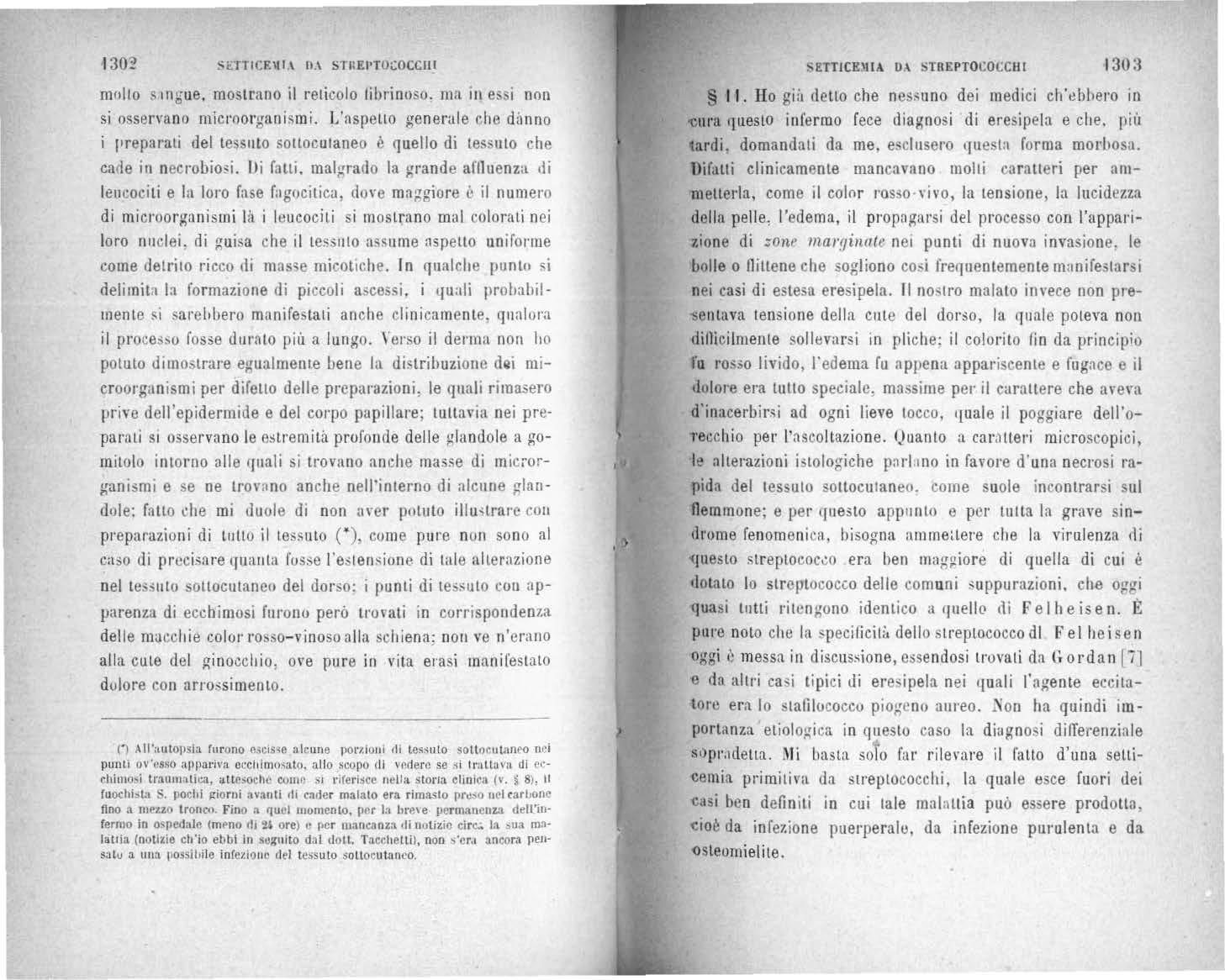
IH STREPTOCOCCill
Le nlter·azioni istologiche degli organi esaminati sono Lutto a tjuelle del I caso , tranne per il fegato, nel tpaale bisogna nmmellere anche nn proces.so di data anteriore. che ha prodotto l'ìspessimento della cap:-ula, le nderenze del gran lobo e la proliferazione del conneuivo petiportale; e per la pleura sinistra, che pur& aveva ade r enze di antica da ta. rn tutti gli organi si è trovato un microorgauismo, il 11uale non isolato e studiato in coltura , pure per i cara tteri e per· il modo di compor·tarsi coi tlirersi metodi di colorazione somiglia a quello studiato nel l caso e, come quello, r·iteng-o, con tutta probahilitir, che sia una varietà dello slreptot OCC(} piogeno. Que sto mi croo rganismo dal punto d'invasione, eire probabi lm eute è slata la cute del dorso, ma che nulla escludeabbiano co ntemporaneamente potuto essere anche le vi& respiratorie, ha ci r·colato col ed invnso tnllo l'organismo. Ma le alteruziooi istologiche degli orgnni sia per In poca che per il brevissimo tempo da che duraYano, non hastano a darci ragione della morte; e per(} dobbiamo anche qui ammeuere un andcnamenlo del sangue da plom aioe o da altri prodotti di decomposizioni battel'l che e quindi una intos·icazione selli ca . La si ndroll'e fenomenica della rnalallia è stata quella della ·etticemia a deacuto.
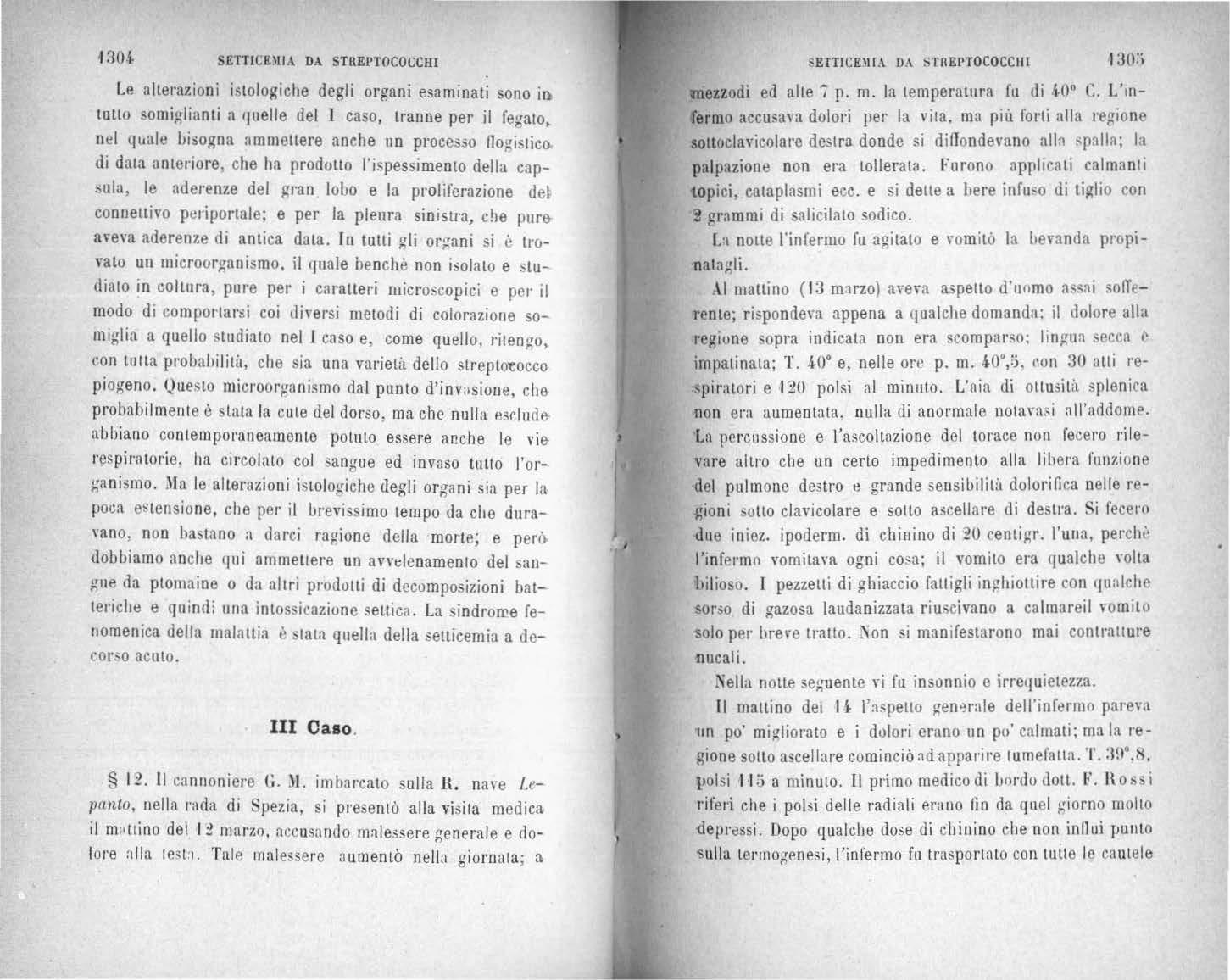
III Ca so .
§ l t. Il can noniere G. )1 . imbarcato sulla R. nave [ epanto, nella rada di Spezia, si presentò alla vi sita medica. il m •tt ino del l:? mu ru>, accusando m:t le.ssere rrenerale e don lore alla Tale ma lesse re aumentò nella cr iorn ata· a o ' mezzodì ed alte l p. m. la temperatura fu di i-0° C. L 'mfermo accusava dolori per la vita, ma più foJ'li alla regio ne destra donde si di fl ond evano spalln; la pa lpazione non em tolle raw. Furono applicati cal man ti topi ri, cataplasmi ecc . e si dette a here infu-.o di tiglio con grammi di snlicilato sodico. l:1 nolle l'infermo fn agitato e r omitò la hevn nda propinat agli. notte seg uente -ri fu insonnio e irretluietezza. li mattino de1 l f. l':'l:;pello dell'infermo pareYil un po' e i dòlori erano un po' calmati; ma la regione sotto ascellare cominciò :1d apparire tumefatta. T . :wo .X. polsi 11:) a minuto. I l primo medico di bnrdo dott. F. Hossi rifel'i che i po lsi delle radinli erano fin da quel giorno molto <leprdssi. Dopo qualche do5e di c hinino che non inOui J.IUIIto <3 ulla term ot::enesi, l'infermo fu co n tolte lo ca utele all'O,;pednle Dipartimentale, ove occnpò un letto del pr·imo 1\i , parto medicina (med. di t• cl. dott. P e tE-Ila}. Qui arrivò in uno stato di gravezza molto rilevante: aveva lo sguardo smarrito, gli occhi vitrei, l'intelligenza obnul1ilatn: T. pol"i 150 e più a minuto, alti respiratorii molto superficiali, tanto che bisognò eccirarlo con alcool ca nforalo, etere ecc.; l'infermo manteneva quasi immobile la metil de:.trn del torace. Alla , era la T. fu i-0°.8. l ntanto àal cavo ascellare fino al hordo costale di deslra fra In linea mammilln1·e e l'ascellare posteriore. la pelle era ùi tinta ro,so livida, tumefaua. non mollo calda, dolenti:;sima . centro di questa larga tumefazione si notava una macchia di tinta piu tendente al giallo, a margini molto indecisi. li mattino del l i) il suo stato non era migliorato, anzi andò aggravandosi nel corso del giorno, co n aumento continu o della T. (39",9 - 4-0°,5-4.1°,6 ), con pols1 molto depressi ( 140 a minuto). Si manife stò delirio che durò tuua la notte. la mauina del l G marzo vi fu collasso e l'infelice spirò alle 7,20 a m. cioè IJLtallro giorni dopo che s'era pre sentato la prima volla al medi co. notizia !:ìui precedenti di infermo: egli era
\1 mattino ( 1:3 m1rzo) a,·era d' uomo a,;sai soiTtrente; ri sponde,·a appena a qualche domanda: il clolore alla regi une sopra iorlicata non era scompariìo; l ingua secca t' impatinata; T. 40° e, nelle ore p. m. 4-0•,:j, ron 30 ntti respiratori e 120 polsi al minuto. L'aia di oLLusitit sple ni ca non era aumentata. n ulla di anormale notaval; i :di'addome. La percussio ne e l'ascoltazione del torace non fecero rile\'are altro che un certo impedimento alla libem funzione del polmone de3tro grande sensibilit it doloriOra nelle re.gioni solto clavicolare e so tto ascellnre di destra. Si fecero Juc iniez. ipoderm. di chi nin o di :w centigr. l'urta, perchi· l'infermo vomiLara ogni il vomito era qualche \Olta ltil ioso. I pezzeui di ghiaccio falligli con qualche !\Orso di gazosa laudanizzata riu sciva no a ca lmareil vomiln solo per llre\'e lrallo . .'\ on si manifestarono mai contralt ure nucali.
Tuua In tumefazione aveva un po · l' as pello di esteso. flemmon e. ma la pelle non era mollo tesa. non lucida, no n molto arrossita. :'\on si scorgevano llillene o sudamine o sco ntinuit it dell'epidermide in nessun punto, non edema, non zone marginali appariscenti. :-iemmeno si scorgevauo. disegnate le vene sup erficiali, oi• vi era linfangile. l ganglii nscellari non si pen;e pivano.
L'infermo passò la notte agi tata come la precedente e dormì pochissimo.
0 \ STil.KI'TOCOCCnT l :107 di robu sta costituzione e non era mai stulo r icoYerato in .
.\1 i di nou poter dare il reperLo uroscop11:o. L'urina di questo ioJermo non fu conservata a tale e quando io la l'infermo, aggravatissimo. uon ne emeueva più.
Jn.tayill e baw·riolo!Jica. - fu praticata il P' i.mo eli in O:'peclale togliendo, :d modo sohto . ci rca 10 gocciole di sangue dal polpastrello di un diLO . Feci pure delle srarificazioni al 1·entro della regione tumefalla e raccolsi anche di la il con tulle le cautele . Il ri:;nllato di questa doppia ricerca fu rompletamente uegati,•o, essendo rimasto sterile cosi il w!Jo di controllo. come le piastre di agar
§ 1:l. 11 dei sintomi e la tumefazione del lato destro del tron co davano qualcl1e iclea dell'infezione carbonchi osa: ma mollo mancavn perchè si potesse specilica1·e tale diagnosi. )la ad ogni modo, eòoui dagli altri casi su r·riferili , si diagnosticò una grave forma di infezione, in dipenclenza della 1umefnzione laterale del tronco, dovi in qnalcho collega il sos pello che trattan d una grave forma di tifo.
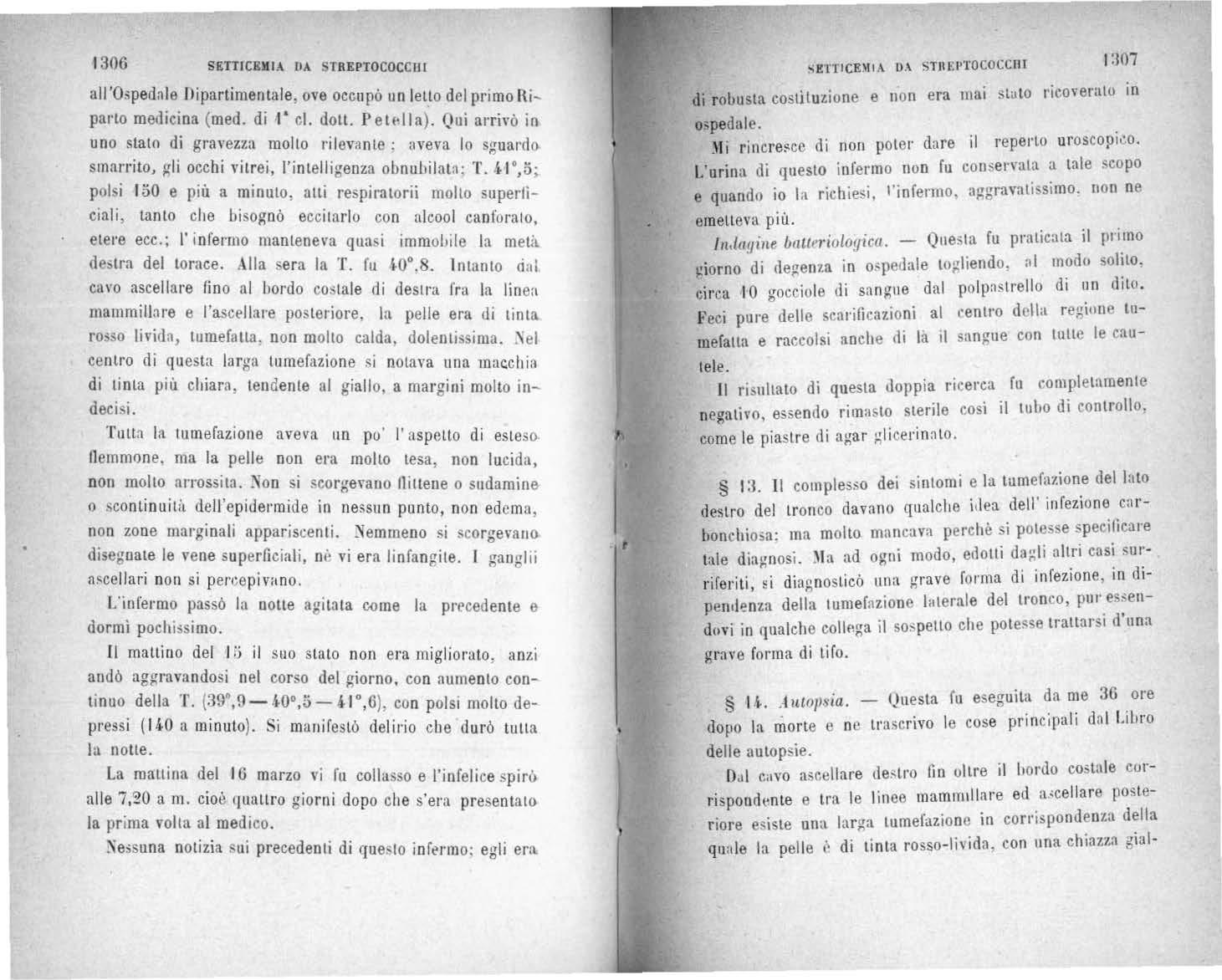
§ 1\.. AutoJ!sia. - l)uesta fu eseguita da me 36 .ore dopo I:L morte e ne trascrivo le cose principali dnl L1 bro delle autopsie.
OJI cavo ùe:;tro fio oltre il hortlo costale corrispooclt•nte e tra le lin oe mamrn1llare ed a.•cellare po,;teriore esiste una larga tumefazione in con-ispoode oza della quale la pelle t\ di ti nta rosso-li\ ida, con una chiazza gial - laslr a nel centro : dilit{entemen.te esamwata, l'epidermide non è scontinuata in nessun punto.
Crttnio. - L.1 dura meninge non presenlit altcraz1oni. 1 se ni venosi sono lurgidi. Alcuni spazi suh:\racnoidl'ali degli emisferi so no ripieni di licruido torl•iclo che in qualche punLo assume aspetto di pus Himosso l'encefalo, nulla di anormale alla as:.enza di liquido nei ventricoli; tela coroidea iperemicn.
Tom cr. - Cuore in normale; li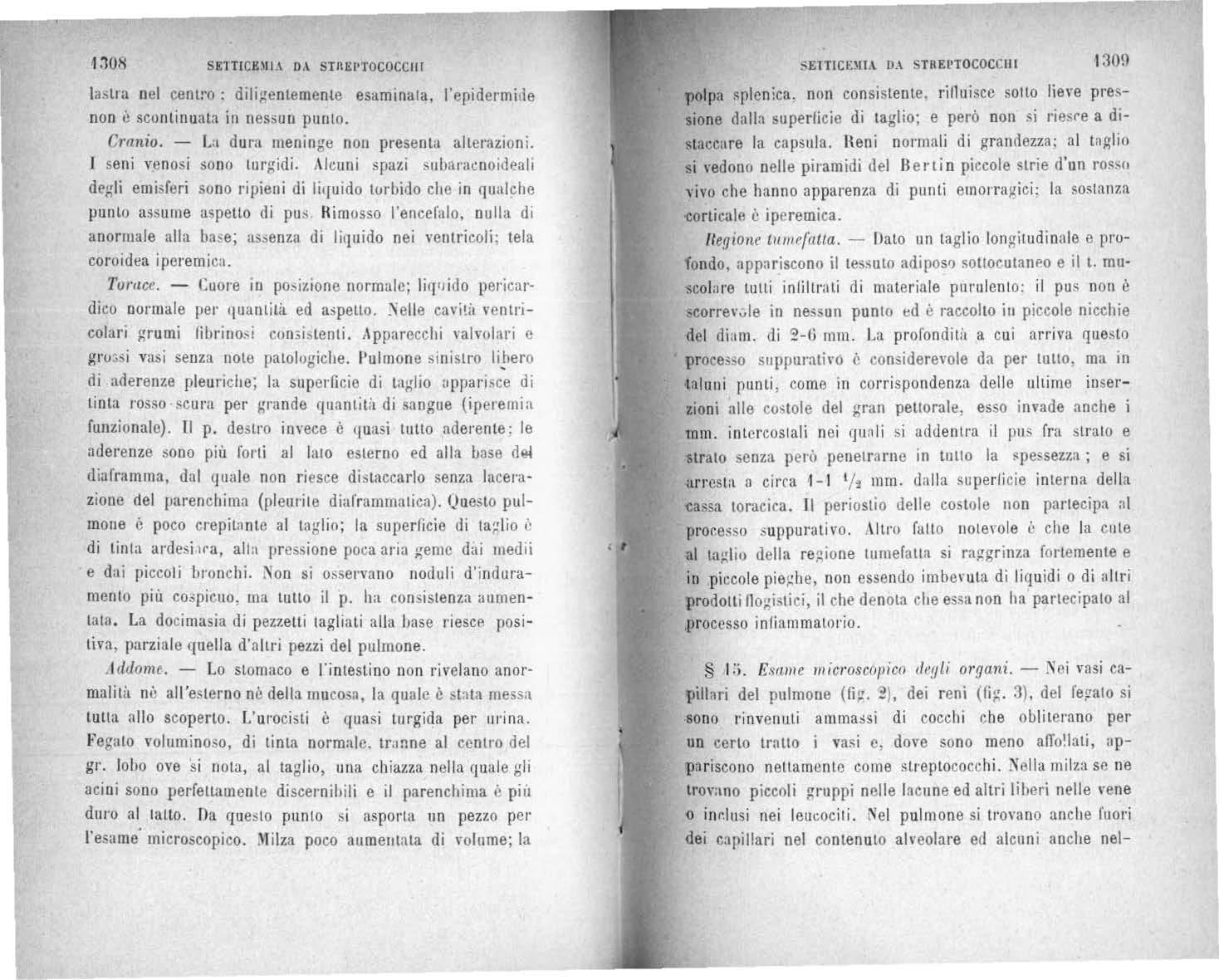
DA STREPTOCO CCHl l'interno dei leu coc iti ; mu non ho trovato , in questo raso. punti di fusione purulenta nè aree di tessuto in necrobiosi, come nei ca si preceden ti ; e di fatti anche all'esa me macroscopi co mancava no i noùuli di pnenmonite setti ca che si r inve nuti negli alt ri . r reni presentano ugualmente ne1 tult oli ni contorti epitelii in parte degenerati o disfalli e si osserva pure tfu alche tobolino urinifero pien o di glubul i rossi . fegato, iperemia d'al cu ne zone di capillari ne1 qual i gl. •·ossi stanno a nco ra acc umulat i in gran numero e le cellul e epatiche compre>.se co min ciano ad at rou1. · zar.si. Yi è pure inlorbidamento granuloso delle cellu le. ' tesauto !' Ollocu taneo :. i osservano veri ammassi di streptu· cocc hi, ove il tess uto 0 in co mpleto sface lo; in altri punti essi so no più distribuiLi, spesseggiando\ le forme a ca tenul e o qu ell e in clu se nei leu coci ti. I vasi sanguigni del tess uto so no trornbosati, in ess i si sco r:.;e bene il retico lo fibrinoso , ma non mi è stato · :;i bil e scovrini sui microorganismi. Sono anche dilatati i ca pillari delle pupille e i vasi dello strato reticolare. La proli ferazione parv icell ula re che si osserva appena in qualch e punto dello strato reticolare. è poi ge ner·ale nel tessuto adiposo sott ocutaneo, in cui v'è proprio fusione purulenta e il reti colo fibrinoso si diwos tra nell'ess ud alo. La proliferazione micotica r est a limitata al tessuto sottocutaoeo, in modo che nei prepa •·ati co lonlli col metodo ùi We i:; e r t si può seg ui1·e la linea a cui anivano gli slrrp · tococehi; so lo in 4u.dche punto es,;i arri vano piu in alto ed \.• in corri spo ndenza dei ra mi adtposi cntanei, che tlal tess uto adiposo so llocutaneo sa lgono sul tessuto perifoll ico !are più lasco o mandano rami latera li a lle glandole a gomito lo ((ig ..i., b). L'e pid ermide e lu cute propriam ente della
SETTlCE\llA DA STllEPTOCOCCUI stann o ancora co me barriera, attra ver·:-.o la quale microrganisrn o si è fatta slrada; nemmeno ne ho score rto nell e glandole; nemmeno nello spazio tra i peli e la Jof() ed avrerto elle ho preparati e colo rat i moltissimi tagli ùi pezzi presi in diver:;i punti del vasto flemmone. Ho pure condotto dei tagli attraverso gli l>trati muscolari del gr. pettorute e dei mm. iotercostali e da per tullo ho trovato forte proliferazione cellulare nel conoettt vo e grande quantità di streptococchi . Nella. pleura parietale e nella v1scerale tra loro. vi eran le note oel infiamm ativo; non fusione purulenta e nemmeno mi croorganismi.
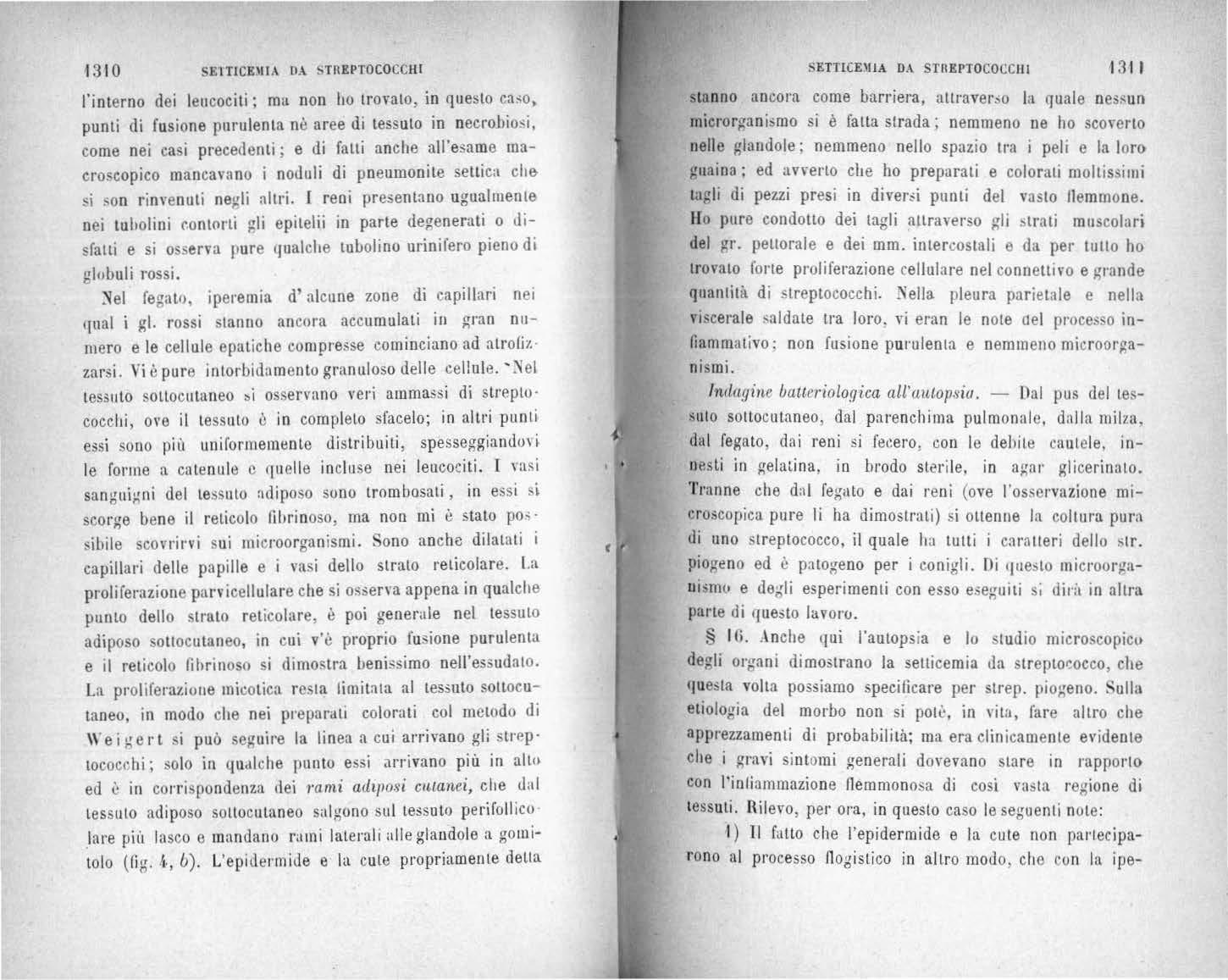
Indagin e batteriologica all'autopsia. - Dal pus del tessut o soltocu tan eo, dal parenchima pulmonalc, dalla ntil7a, dal fegato, dai reni si fe(:ero. co n le dehite caut ele, innesti in gelatina, in brodo sterile, in agar glicerinato. Tranne che dal fegato e dai reni (ove l'osl>ervazi one microscopica pure li ha dimostrati) si ouenne la coltu ra pura di uno st r eptococco, il quale ha tutti i dello piogen o ed è patogeno per i conigli. Ui questo UJ:>m l• e de61i esperimenti co n esso e;;eguiti s; dirit in altra pane di questo lavoro.
§ l U..\n che lfU Ì l'autopsia e lo st ud io microscopicv degli orga ni dimost r ano la seuice mia ùa che volta possiamo specificare per strep. piogeno. Sulla e tiolog ia del morbo non si potè, in 'iLa, fare altro che apprezzamen ti di probabilità ; ma era clinicamente evidente che i gmvi si ntomi general i dovevano sta re in rapporto con l'inli ammazio ne llernmono:;a di cosi va sta re,ione di n tess uti. Ril evo, per· ora, in questo caso le segue nti note: l ) l i fallo che l'epidermid e e la cu te non parteciparono a l pro ce sso fl og istico in altro moùo, che co n la ipe-










