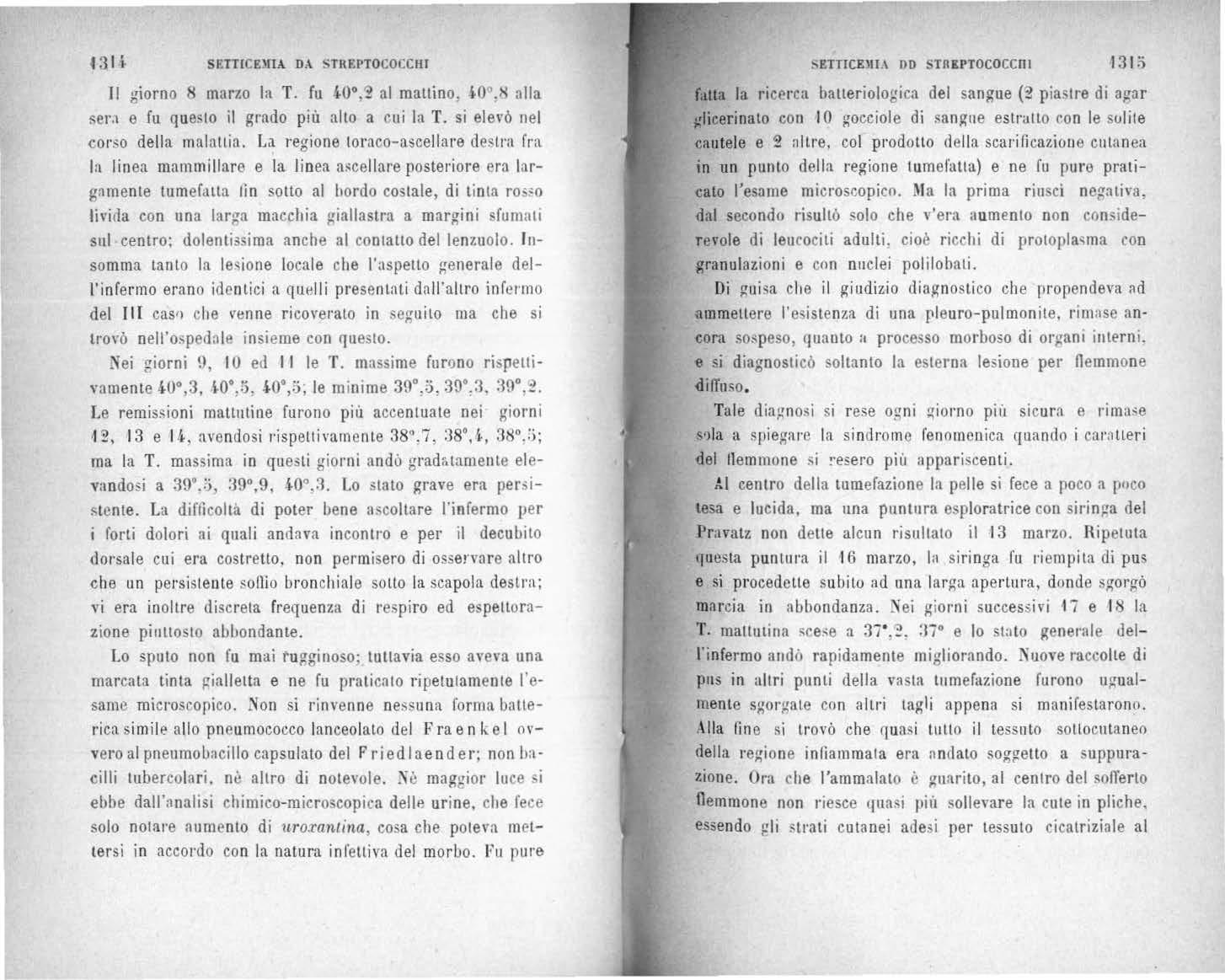
57 minute read
StTTICElliA DA STREPTOCOCCHf
I l giorno 8 marzo la T. fu al mallino . alla e fu questo il grado più alto a rui la T. si elevò nel della mal attia. La regione tomco-ascellare destra fra In linea mammillare e la li nea posteriore era lartumefalla lin sotto al hordo costale, di tinta li\' itla con una ma cchia giallastra a margini sfumati sul centro; dolerllissi ma anche al contallo del lenzuolo. Insomma lauto la locale che l'aspetto dell'infermo erano identici a quelli presentati dall'altro infermo del lll casi) che venne ricoverato in seg uito ma che si tr·ovò nell'o:.pednle insieme con giorni H, IO ed Il le T. ma ssi me furono rispellivamente 40°,3, i-0" ,:> . 4-0",;>; le mintme 39°,3 , 39".3, Le remissioni mattutine furono piu accentuate nei giorni 12, 13 e 14. avendosi l"ìspellivamente 38°.7 , :38°, 1· , ma la T. massima in quo3ti giorni andò gradntamenle elea 39".:j, :39°,9, i-0".:1. Lo stato grave era persiLa dìflìcollà dì poter bene ascollare l'infermo per i forti dolori ai quali andava incontro e per il decubito dorsale cui era costre tto, non permisero di ossenaro a ltro che un persistente sollìo bronchiale sotto la scapola destm; vi era inoltre discreta frequ enza di respiro ed espellorazione piuttosto aùùondante.
Lo sputo non fu mai rugginoso: lultavìa esso aveva una marcata tinta e ne fu praticato ripetutameote l'esame microscopico. :;on si rinvenne nes!\una forma batterica allo pneumococco lanceolato del Fra e n k e l ovveroalpneumobacillocapsulato del f'rìedlaender; non bacilli tuber colari. nè altro di noteYole. Xè maggio r lu ce sì ebbe dall'analisi chimico-microscopica delle urine, che fece solo notare nume nto di uro:rnntina, co.>a che poteva meltersi in accordo co n la natura infettiva del morbo. Fu pure falla la ricPrca hntterìologica del sangue (3 piastre di agar J:l icer ina to co n l O gocciole di gangne estratto ron le solite cau tele e 2 :tltre, col prodollo della scarificazion e cutanea in un punto della regione tumefatta) e ne fu puro praticato l'esame microscopico. Ma In prima riu sci dal secondo risultò l'olo che ''era aum en to non conl'ider ef ole di leurocìti adulti. cioP ric chi di ron granul azioni e con nuclei polilohati.
Advertisement
Di guisa che il giudizio diagnostico che propendeva ad ammellere l'esistenza di una pleuro-pulmonite, t'imasc ancora sospeso, quanto a processo morboso dì iuternì. e si diagn osticò sol tanto la esterna lesione per nemmone dì fTnso.
Tale si rese ogni qiorno pilt sicura e rima.;e a spiegn re la si ndrome fenomenica quando i carnlleri del ll emmone :;i !'esero più apparil'ceutì.
!l centro della tumefazion e la pelle si fece a po co n poco tesa e lucida, ma una puntura esploratrice con siringa del Pr;lvatz non dette alcun risultato il 13 marzo. Rip etuta questa puntura il 16 marzo, la siri nga fu r·iempita di pus e si procedelle subito ad una larga apertum, donde sgot·gò marcia io nbbondanza. giorni successivi 17 e 18 la T. mallulinn n 37•. :.?. :n• e lo sta to generale dell' infermo audiJ rapidamente migliorando. Nuove raccolte di pu s in altri punti della vasta tumefazione furono ugualmente sgorJ.(ate con altri tagli appena si manifestarono. Alla fin e si trovò che quasi tutto il tessnto sollocntaneo della regi one infiammata era nndato sog!!etlo a suppurazìone. Ora rhe l'ammalato è guarito, al centro del sofTer to fl emmone non riesce truasi più sollevare la cute in pliche. essendo cutanei ade5i per tessuto cicatriziale al strato mnsrolarP e in qualche . pnnto anche periostio delle costole. l'er non dire di alt ri, ricordiamo che J e a un e 1 [8, chiamava « setticemin cronica » anche la fchhre lenta, spesso poco elevata, che si osserva in seguito a ritenzione di « li'l.uidi putridi » sia nelle cavitit naturali che nelle pntolo · g1che d'a:;cessi). N i s se n Fra n z r9J poi ha, con opportulll esperi menti provato che il saugue 1l'inùi' idui afda proces,i acuti. anche se JH'ÌYO di germi. nesce patogeno per i topi. dei <Jnali produce la morte in poche ore.
§ 18. Ahhiarno dunque a\uto due casi. per ro:-.i dire, gemelli, nei 'filali l'andamento cliniro uei primi giorni t\ statn qua si identi co. È rimasto perfellamente oscuro in che mod o si fosse determinala l'affezione esterna uguale i11 entrambi, non avendo riscomrate lesion1 cutanee. Come si dimostrerà iu seguito, anrhe l' eccitatore della mal::lltia fu id enlico nei casi li[ e l \. anche in qu est'ultimo isolato. dal pus eslrattu wn la siringa dr Prava.tz. nno streptocorco ehe pe1· tulli i caratt.eri L' simile a quello ollenuto tlall'indagine batteriologica falla all'antop.;ia dei 11 l ra<;o.. grave form a morbosa, fortunatamente ifa guarrgr one, non l'i può altrimenti intendere cbe come fel1hre settica. E ciò sta in accordo co>i .:on le antiche vedute, secondo le fJunli la febbre era falla dall'nssorhimento. nel sa ngue di sostanze « .(Jutride » dei Lessnti io decomposizione (Oemmone): come con le moderne teorie chr I:L fanno dipendere eia prodotti eli decomposizioni hntll'rirhe .
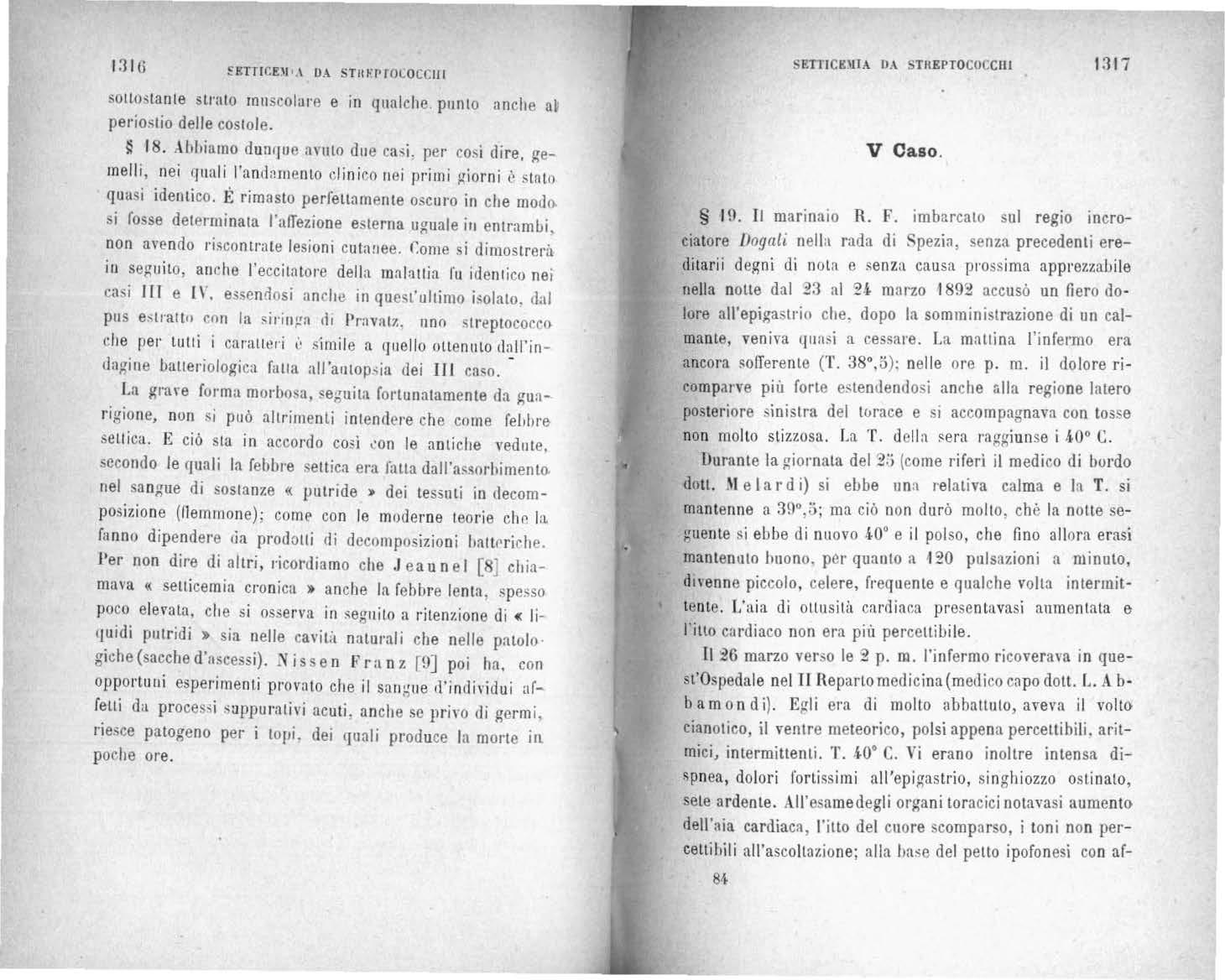
V Caso .
§ 19. Il marinaio R. F. imbarcato sul regio incrociatore lJ o,gali nella rada di Spezia, senza precedenti ereditarii degni di nola e senza causa prossima app1·ezzauile nella nolle dal 33 al 24 mnr'zo 1892 accusò un fiero dolore all'epigast rio che. dopo la somministraziooe di un calmante, veniva qua :\i a cessare. La mauina l'infer·mo era nncol'a so!Tel'ente (T. 38°,5 ): nelle ore p. m. il dolore ricomp;u ve più forte estendendosi anche alla regione latero poster iore sinistra del torace e si accompagnava con tosse non molto stizzosa. La T. della raggiun se i 4.0° t:.
Durante la giorna ta del 2:; (co me riferì il medico di bordo dott. e l ardi) si ebbe una relativa cal ma e la T. si mantenne a 39o,:;; ma ciò non durò molto , chè In notte seguente si ebbe di nu ovo 4.0° e il polso, che fino allora erasi mantenuto hnono, per quanto a 120 pulsazioni a minuto, d"enn e piccolo, celere, frequente e qualche volta intermittente. L'aia di oll nsità ca. 1·òinca presentavasi aumentata e l'illo cardiaco non em più percettibile.
Il .26 marzo verso le 3 p. m. l'infermo ricoverant io quest'O!>pcdale ne! H Reparto medicina (medico capo dott. L. Ab· h a m o n d i). Egli em di molto abballulo, aveva il volto cianotico, il venire meteorico, polsi appena percettihili. aritmici, intermittenti. T. 4.0° C. Vi erano inoltre intensa di!ìpnea, dolori forti ssimi all'epigastrio, singh iozzo ostinato, sete ardente. All'esame degli or·gani toracici nolavasi aumento cardiacA , l'illo del cuore i toni non percettibili all'ascoltazione; alla lm:-;e del petto ipofonesi co n af- lie>olimento del murmure 'escicolare, specialmente a nistra.
In prP;e07.<t di questi l>Ìntomi l>i ,:!indicò rhe alla plenropericardite. dJ natura probahilmente infettiva erasi una miocar·ilitc della medesima natura e rhe lo stato dell'infermo cm quindi gravissimo. Si usarono eccitanti sia per' ia ipoùermi.·a che Internamente e drlle coppelle scaricate alla regione cardJ;'ICa. Di tali cure l'infermo ,;i gio\'ò alquanto: ma il mattino del '27 marzo :::i eùhe i d'alto grado. temperatura in diminuzione fino a :Ji". polsi impcrcettihill, anuria completa. \Ile 5 ' • p. m. morte.
§ :20. Ecco le principali note J'ilevate dall'autopsia esedni medici di '.2a classe Landriano e Sestini iO ore dopo la morte.
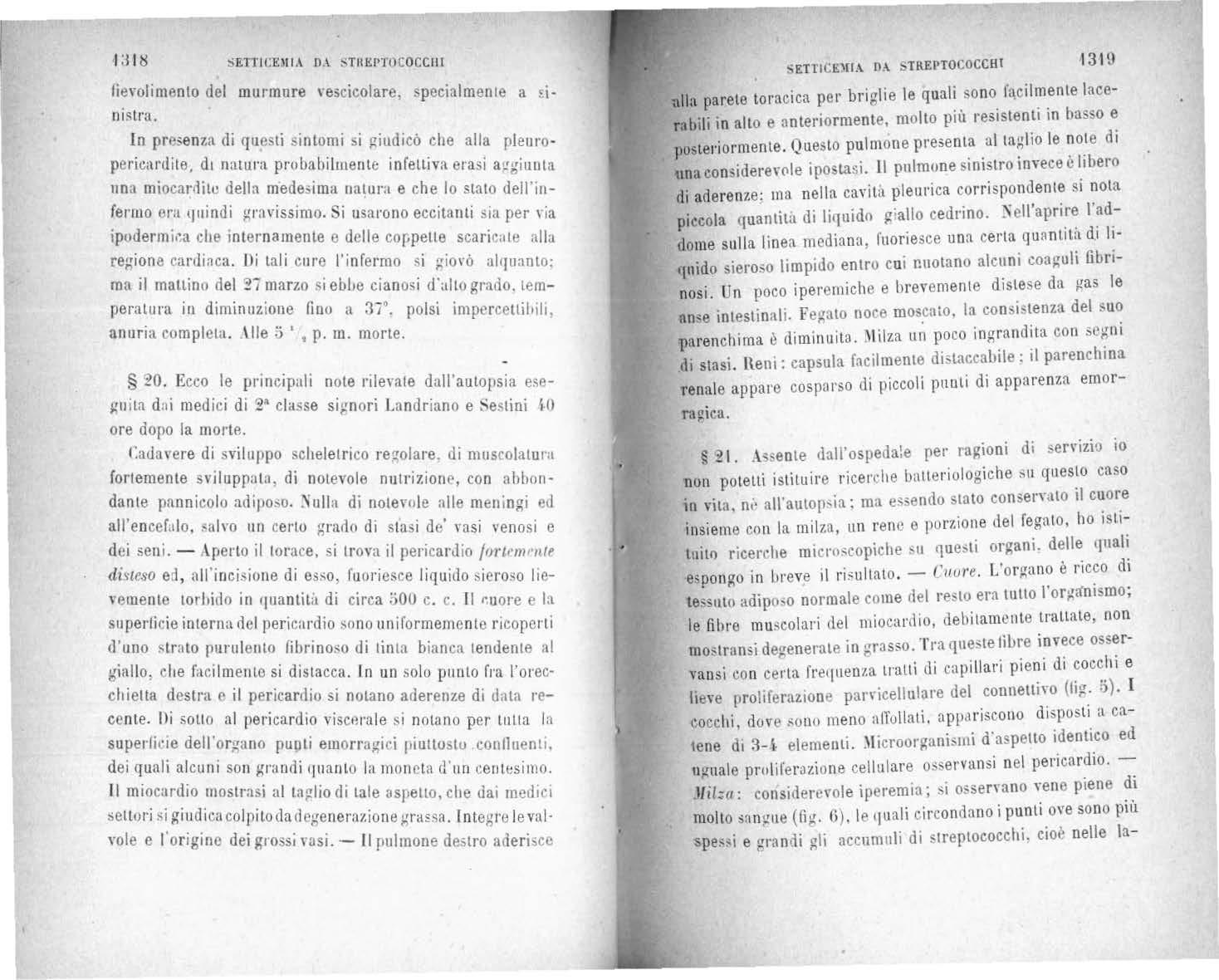
Cadavere di sviluppo gcheletrico reqolare. t.li muscolatura fortemente sviluppata, di notevole nutrizione, con nbbondante pannicolo adiposo. :Xulln di notevole alle meningi et! all'encefalo, :-ah·o un certo grado di stasi de' \'asi venosi e dci seni. - Apet"lo il torace, si trova il pericarJio fortNll i 'llif ed, nll'incisione di fuoriesce liquido lie' emente torhitlo in IJUantiLit di circa :jOO c. c. Il ruore e b superlil'ie interna del pericardio sono uniformemente ncoperti d'uno :-trato purulento fibrinoso di tinta bianca tendente al giallo, d1e facilmente si distacca. In un solo punto fra l'orecchietta destra e il pericarllio si notano aderenze di data recente. Di soLto al pericardio viscornle si notnno per tutta la superfi•·•e dell'organo puuti emorra}!il'i piullostu continent i, dei quali a lcuni so n grt1odi quanto la moneta d"nn eeutesimo. li miocardio mostra:oi al la!!lio di tale as1Jello, che ùa1 medit'l settori si giudica colp ito da gral:sa. Integre le val· vole e l'origine dei grossi rosi.- li pulmone destro aderisce ulla parete toracica per briglie le quali so no _ lacerabili in alto e anteriormente, molto più resJslenll m basso e poste1·i ormente. Questo pulmone le una considerer<'le ipost.asi. LI pulmune SlllJstro 10vece c libet o di aderenze: ma nella caviltt pleurica corrispondente si nota picco la I{Uantila di lit[nido cedrino. dome sulla linea mediann, fuoriesce una certa qu11nLJlil d• 11' tnido sieroso limpido entro cui r.notano alcuni waguli fibrinosi. Un poco ipercmiche e bre\'emente distese da j!as le intestinali. noce moscato, In consistenza del suo parenchima ò diminuita. ' l ilza Lll1 poco con di stasi. Re m: capsula facilmente di:;taccah•le: Jl parench10a renal e appare cosparso di piccoli JHlnti di apparenza emor-
§ 1. ..\s,ente dall'ospeda!e per ragioni di sen·izio io non potetti istilu ire riceJThe batteriologiche :-.u caso 1n vita, ni• all'autop.;ia; ma stato conserY<tto •l insieme con la milza, un rene o porzione del regato, ho tuitn ricerd1e micruscopiche :-11 questi organi. delle quali in breve il - f'uure. L'organo è ricco di l'> l' o tessuto adipo,o normale come del resto era tutto or;(('(THsmo; le fibr e mu-;colari del miocanlJO, debitamente trattate, non mo;.transi degenerate in grasso. Tra queste li hre in vece vansi con certa frequenza tralli di capillari pieni di cocch• e lillve proliferaziont> parvicellulare del (ti:z_- :j). l cocchi dove sono meno nfTullati, d1spost 1 a catene d 1 3-\ elementi . .\l icroorgani:.uli d'aspetto identico ed pro\iferazione cellulare oo;5ervansi nel .Jfil::o: considen•,·ole iperemia; ,i 05sen ano Yene ptene di molto sangue G). le quali circondano i punti ove sono pii1 spe:;:<i e grandi gli accumuli di streptococchi. cio!> nelle la- t'nne ove si npro no le ultime diramazioni vasali : se ne trovano anche nei c'ordoni della polpa splenica; mancano net corpuscoli del - Fl'gato: frequentissimi emboli micotici nella rete capillare, la quale, dopo colorazione metodo di We i f! e r t, resta, per essi. nettamente n in alcuni punti (v. fig. 7). - RPni: uguale. se non fretJuenza d1 streptococchi nei capillari tanto della sostanza corticale (fiSf. ) che della sostanza midollare (fig. 9). Alcuni glomeruli presentano anse talmente rip iene di microorganismì. che sembrano preparati con materiale d'iniezione. r.li epiteli i renali sono dege nerati e in parte sfaldati nei tuuolini contorti della sostanza corticale; DE'i tul.wlini retti si bellissimi cil indri che son rimasti ben colorati col carmino nlluminoso. l microrganismi dimostrati in deui organi son(} tulli dd metl1'simo tipo, cioè cocchi a brevi ca tene di 3-5 elementi: essi restano ben colorati co i metodi di G ram, di W e i g e l'L , di L Of f l e r . Dalla frequenza dei che si rinvengono in ogni Laglio giudica che miriadi di colorizz azioni r:netastatiche erano avvenute in tutti gli orga ni.
§ 32. In questo caso il fallo piu importante a prima è la pericardite lihrino-purulenta: tale importanza cresce dopo che microscopico ha dimostrata la miocardite micotica. Qu este alterazioni dovevano rendere nssai dinic•le la funzione del cuore e, per i disordini in essa veri(icati=-i. fu fJOssihile anche la diagnosi di miocardite fatta in vira dal medico che dirigem il riparto, dou. L. AuLa m 0 n d i. 1 polsi aritmici, filifor·mi. appena percettibili e la cia no!'i di alto grado verificatasi l'ultimo giorno di malaLLia, insieme co n la tensio ne del pericardio per molto essudato e la stasi degli organi, chtJ ha poi oppos to nuovo oslarolo alla funzione cardiaca. sono falli r lte sp iega no abbastanza clriara- mente co me la morte avven ne per indebolimento progres· sivo e quindi paralisi del cuore; e cosi giudicaront> i medici sellori .
Dalla storia clinica abbiamtl appreso che il primo sintomo fu on fiero dolore che, datJuanto poi s'èvisto.deve senza dubbio riferirsi al pericardio. La pericardite che es11rdi cosi inop inatamente fu prodolla da penetrazione e sviluppo nel cavo pericardico di un microorganismo (pr·ouallilmente lo streptococco piogeno) e pare che sia stata primaria. 4t se le « pr ime infiammazioni purulente avvengono nelle parti pro« fonde del corpo fa duopo ammettere che i hallerii, che le pro« muovon o, penetri no dall'intestino o dnl pulmone o dalla cute c o da qualunque piccola ferita nei tessuti e con In corre nte « sanguigna e linfatica so no trasport:1ti in un posto qualsiasi. c se nza lasciare alterazioni dimostrabili nel punto di entrntn >>
[6 p. 378, P. C.·.l·- a prescindere dai gravi sintomi ca rdiaci che richiamarono di più l'attenzione. vi furono altri fatti clinici come il sub ito della malattia, l'alta termo)!enesi. In partecipazione di altr·i organi al processo (pulmooi, pleure, reni), i quali tutti sono in dipendenza grave infezione del sangue da strep tococchi o dai loro prodotti Ho potuto infatti osser vare in questo caso la maggiore quantit à e posso anche dire la piu grande uniformittì degli emboli micotici in tutti gli orga ni e:;aminati: e le nlterazioni aoatom o-patol ogichè in essi prodottesi sono simili a tJUelle altri casi rrferili.
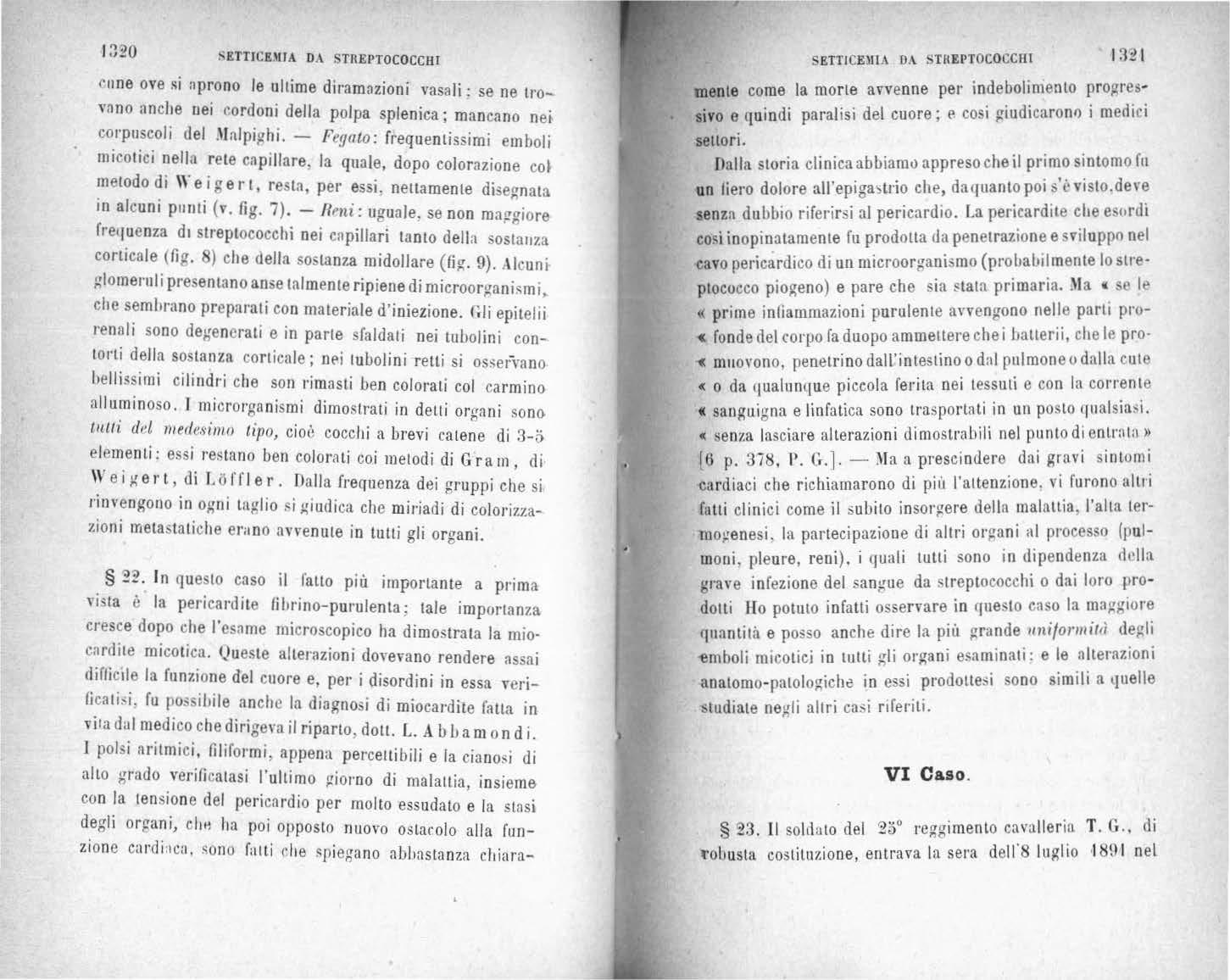
VI Caso .
§ 23. Il solct uto del 215° reggimento cavalle r ia T . G., di tobusta costituzione, entra va In sera del 1'8 luglio '180 l nel
SETTICElriA UA STREPTOCOCCHl
I Heparto medi cina (medico di 1• classe dottore Cognetti) coD febh re alta (40°,5) e li eve tumefazione in cor ri spondenza dell'articolazione omero-scapola re si nistra. 1'11'ern dolente alla pressione ed ai moYimenti. L'am malato accusava dolori a nche alle altre articolazioni ed era molto sofferente; aveva però intelligenza nella e non presenta,-a si ntomi che facessero sospettare aiTezioni localizzate agl'intestini o agli organi r espiratori; si pensò quindi che si di r·eumatismo. nrticolare acuto, ciò ch e. per i primi due giorni. indu sse n somministrare :j mi di salicilato sodico in l O nelle ore e ad ungE-re con pomata d'ittiolo la regione deltoidea si nistra . Ma la T. si mantenne sempre su periore a H)"' C.. il pol so era molto frequ ente e debole; v'e ra intensa ce l'alea. Si dettero eccitanti e si applicò ghiaccio sul ..:apo. ;\ella notte dallO all' t l vi fur·ono violenti esplosioni delira mi. tanto che si fu costretti ad assicurare l'infermo nel !ello e si applicar ono sa nguisughe ai processi mastoidei . t:n 'allc nta osservazione allo nta nò i sospetti di pulmonite e l'assenza di dolor·nbilitit alla pressione lun go le vertebre, specie le ce rvi cali, non permise di ammettere una meningite. della quale pure s'era avuto sospetto . Il giudizio diagnostico del med!co curante stelle piu in favore d'una grave infezione di reumatismo o prop riam ente di reumatismo cerebra le o iperpiretico che dir si voglia. Si appl icarono quindi Lutti i soccorsi del caso: si fu larghi nell ' uso del ghiaccio, delle bev:JDde alcalinizzale & 1e;germente ecci tanti. parchi nell ' uso di farmachi ant itermic1.
Il giorno Il luglio la T. rnggiunse un massimo di 4.1 °,5. L'articolazione omero-scapolare si ni stra era dolentissima: normale la cute della region e del toidea corri spo ndente. ma si percepiva che le mn:>5e muscolari sottostan ti era n sede d' infiamm azion e che si esten deva quasi a tullo il hra cc io. Uguali si ntomi comin ciavan o alla spalla dei\tra ov'era pur&
SETIICF.\IIA D-' ">TREPTOCOCCIII
. dol ore henchè non si fo:>se ancora manifestata m , . . -l n "l di mefazio ne. Le altre artico lazioni eran Il H:re. • l acce':is deliri o si r innovarono quel la notte e il giorno seg nent e · · :"\ n avev'L pnt l l ··nrermo si presentò a:roravatiSSiffiO .• o ' ' qua e 1 l> • , , i- 1" •· · coscienza: i polsi eran debo li. frequenti; la l an co ra , ,o, . f qualche colpo di cou VI u .. . l ma Quindi coma P morte nell e ore pom. dcJpo ·) wornl <l . -
Jan ia. . · · 1 . rr'str· del laboratorio non trovo u·accla rlt l'I Ce rc 1e l, e1 re/"1 1 . - • 1 riguardo a 'lue,;to CélSO; di modo che o le prin cipali note dell'autopsia, che fu da me esel'>mla
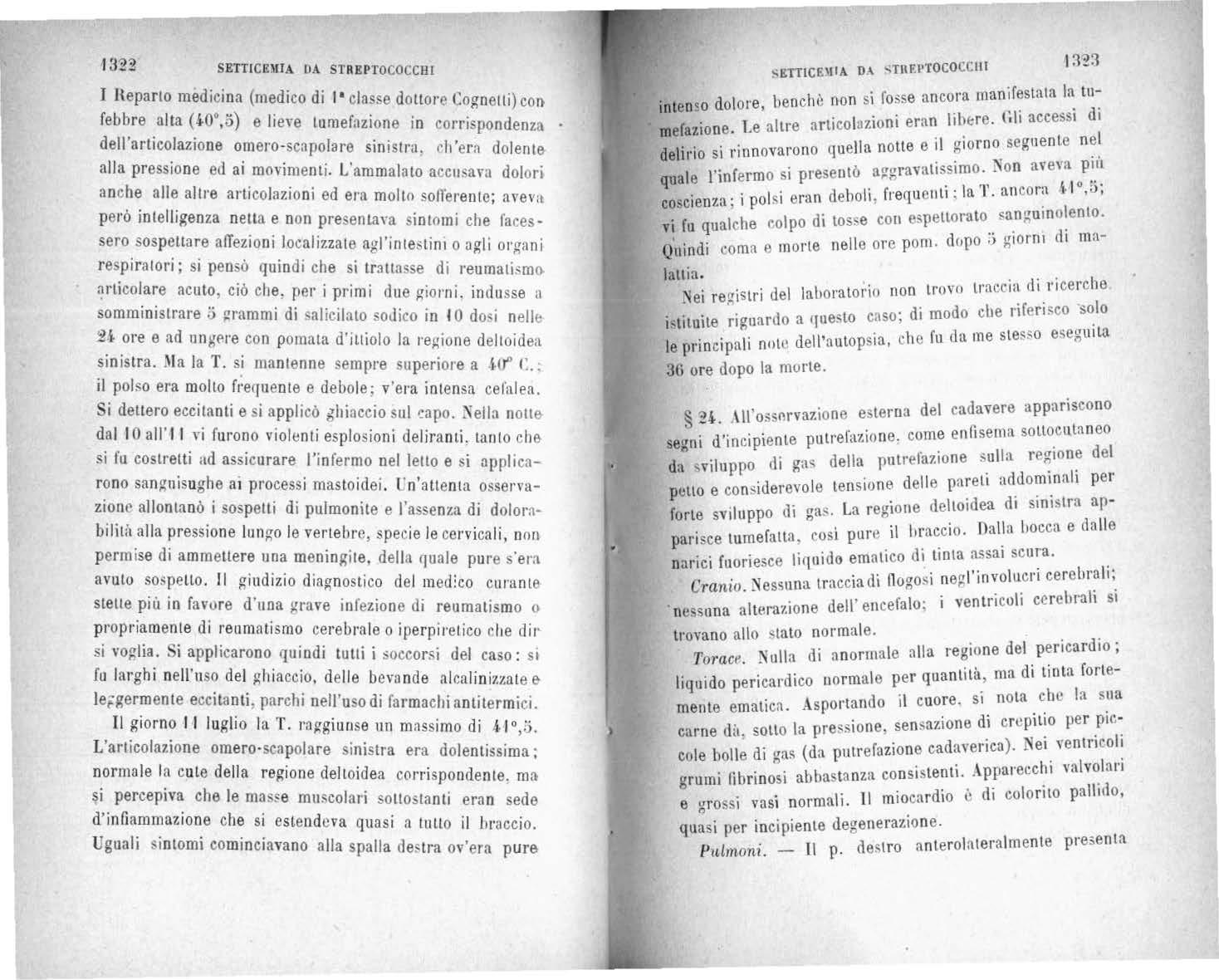
:.Hi ore dopo la morte.
\ ll'o-sorvazione esterna del cadavere a pparisco no . :> .. a··. nte putl·ehzione come enfisema sottocnta noo S6"nl tnCiple ' ' . · l d tt ·tuppo di era, della putrefazione sulla reg1one de ,\ ">VI l'> . J' pollO e ten sio ne dell e l fort e sviluppo di La regione ùeltoldea di l>IOI,tra ap . fatta cosi pure il braccio. l)al\ a bocca e da ll e pan sce tume ', . . narici fuorie sce liquido em atico di tmta a::sal . Cra nio. traccia di flogo si . 1 . . dell'encefalo· i ventricoli ccrehr·ah sr nessuna a ' trovano allo stato normale. . .
Tora cr. Nulla di a nor male alla regione del pen cardl o; t'l' 11a di tinta fort e- liq uido pericardi co normal e per quan 1 a.' 1 • • mente ematica. Asportando il cuore. St nota. la c;Lrne dit. solto la pressione, sen;;azione di per f · l .·ca) Ne1 ventncoll cole bolle di gas (da putre aziOne cac avei 1 · • ··t 1· \ pparecchi valvolat•t grumi fibrinm.i abbasta nza consts en L · _ . 1- 11 m1·oc" rdio è d1 colo rno palltd o, e vas1 norma t. " quasi per incipiente degenerazione.
Pn tmoni. - 11 p. destro anterolnt eralmente pleuriche mollo resistenti. Nel lobo superior·e e spew1lmente al suo margine interuo si notano infarti egra ndi, più o meno, come avellane, di forma piramJdale; nel lobo inferiore ve n'è uno solo del doppio piu grande degli altri ..\J taglio, in nessunc di questi inf.mi si od occl1io nudo , raccol!a anche incipiente di pus. Nel p. si ni stro, le cui aderenze plcuriche sono pilt lem•ierl' . • trovano pur·e grossi in farLi emorragici: in un groì'SO b1·onco sr Lrova un grumo sa nf:uigno.
Addc,me Anse intestinali fortemente distese da gas (fallo postmortale): nulla si nota nel mesentere e nel gr. oment o· normale di volume; la sua capsula per tratto è scollata per sviluppo di f.!HS della putrefazione; il è piutto;,to ischemico. La milza è di poco wg rand1ta; la sua polpa è mCJJie e si spappo la nssai l'aclimente. l reni, normali di volume, presentnno al tagl io qualche punto emorragico nella sosta nza corticale.
Aperta l'articolazione scapolo·omernle sinistr:., tanto la capsula che i ligamenti o le cart ilagini d'incrostazionc 11011 .alterazioni arwtomo-palologiche; il liquido sinoVIale non c 111 anmeuto. \l a dal collo anatomico dell'omen• a venire rn più verso il mezzo della sua dialisi si nota clw il tessuto muscolare dello strato profondo ha colori to rosso fosco c consis tenza minore che nel resto della ma ssa muscolare. Dissecando questi muscoli noi loro punti di altacr;o sull'osso. si scovre del pus di aspello sanioso, n un in grnndt' quantitù, ni! raccolto in cavo ascessoide, ma infiltralo ne nJi • • t'o mterstJZll muscolari. ln un punto sotto al collo chiru rgico dell'omero il periostio si distacca assai la cilmente dall'osso e questo appar·isce un po' iperemico. Asportata la testa dell'omero o parte della sua dialisi E> diviso lon"itudinalmente . o tn due questo frammento, si nota che il midollo è in part e avendo in segaito preparato il periostio della doccia bicipitale dell'omero sinistro, ho potuto osservare ch'esso era fortemente ispessito e che nella doccia Yi era pus in quantitit co nside revole . Di più, dopo indut·imento nell'alcool ho oltenuto dal periostio suddetto dei tagli che, colo rati col metodo di W e i gerLe con carmi no, mi hanno fatLo Vl3dere , oltre ad una forte proliferazione ce llulare, una lJUantitit immensa di cocchi a catene (lig . I O).
-di col orito rosso pallido tendente al giallo per degenerazione e per piccolissimo ni cchie pumlente ove il poco pu..; è di aspello identico a quello trovato inter nam ente nei mu· scoli. Il processo sn ppurativo far.evasi anche strada nella doccia hicipitale, ove il periostio e la guaina tendinea sono ispessili e facilmente distaccahili. Fatte le medesime indagini sull'articolazione scapolo-omerale destra c trovata pure in tegra l'articulazione. si è notato, al collo anatomico dell'omero , poco di S(Jllo alla linea d 'i nserzione dl:'lla capsu la arti1·olare, marezzamcnto dei tessuti tendineo e muscolnre con diminuita loro consistenza. ma senza visibile suppuraziano. Avendo spaccata anche la testa e il terzo superiore dell'omero destro, si trova che tanto la spongiosa dell 'osso, quanto la midolla sono fortem ente iperemiche. In nessu n altro punto ru rin venuta suppurazione dei muscoli e delle oss:1.
§ 2:5. Dal complesso di queste alterazioni locali io allora emisi il parere che n on si trattasse d'un caso di ostcomielite genuina u primaria, ma di :.rn processo soppurativo e icoroso cbe prima Ol'if:ine nei mus coli profondi del bra ccio . Ed aven,lo d1 più notato che, disse ccando il per iostio dell'omero si nistro, la so;;ta nza compatta dell'osso mostravasi iperemizzala in un punto al collo anatomico, pensai che li. con tulla pr·ohabiliti1. si fosse stai.Jil ito il transito del processo dall'esterno all'interno. A rite· nere primaria l'affezione mi spingeva anche il fallo che nell f'l midolla non si era quasi protlulla suppurazione, laddove io leggevo nel libro di Corn il et Ba be s « sur les Bacteri es et leur » cb e nell'osteomielite « le pu s s'y forme avec une rapiditt'· extreme» ( r ot. I pag. 4!l5), che in tjuesto caso non si sarehbe ver ificato.
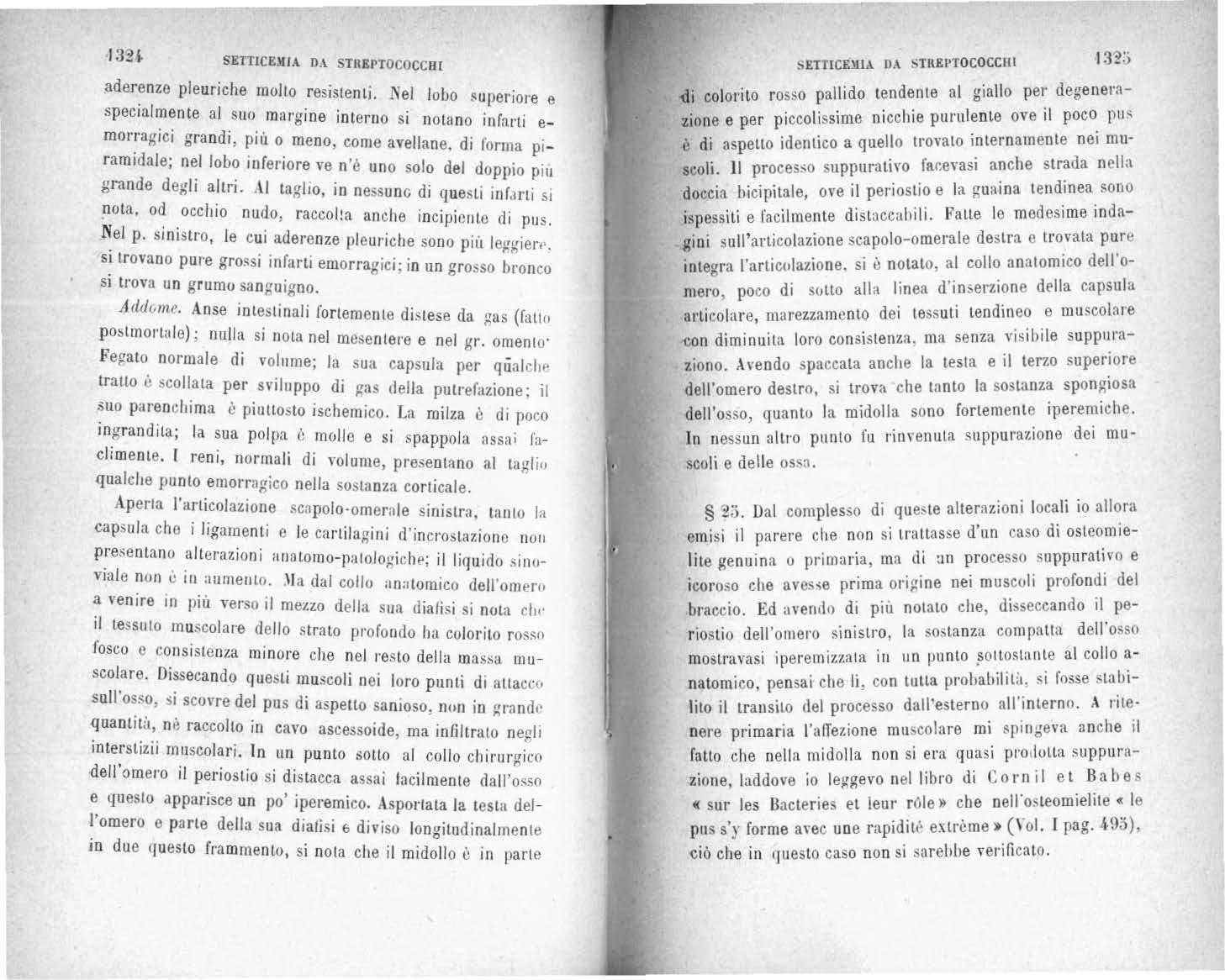
Restò cosi dimostrala l' esistenza d'una periostite acuta infettiva da streptococchi. alla quale han ten uto dietm il processo suppurati vo dei mu scol i (nemmone profondo), la osteomielite e quindi la forma settico pioemica. - e nella periostite infettiva acuta , come si legge a pag. l };j del trattato di anatomia patologi ca spe· ciale di E. Zieg l ar r10], «i l processo può cominciare cosi nella midolla delle ossa, come nel pet·iostio ed è ca ratterizzato da un 'infiammazione che ha un esito in suppurazione e talvolta anche in putrida e icoro:;n :.. nostro caso infatti il pus che s'è r invenuto nei muscoli profondi del braccio era co me sa nie: di più esso non r imaneva circoscritto in un ruvo ascessoide; e però nessuna reazione inliammatoria loca le attorno ai tessuti col piti ha opposto argine sa lutare al diffondersi per Lutto l'orga nismo dell'agente infetta nte.. Gl'inf:: rti pulmonnri, i punti emor· ragici della sostanza corticnle elci rene sono la pruova evidente che anche in CU$0 il rnicroorga nis mo piogeno ha circo lato co l sa ngue e, benché ma nchi la pruova palpabile della ricerca halleriologica e. in parte , qu ella dei p repa rati mic roscopici co ll a qua le non pos so ill ust rare questo percht'! gli orga ni interni, tro,•ati in uno di putrefazione pii1 che iniziale, non furono conservati pt' r l' esame , pure io credo d'essere autorizzato a conchiudere che anclre questo caso di grave setticemia fu dov uto acl uno streptococeo. dimostrato nel periostio della doccia hicipitalc dell 'omero, il quale co n tutta probabilità e1·a lo streptococco piogen o.
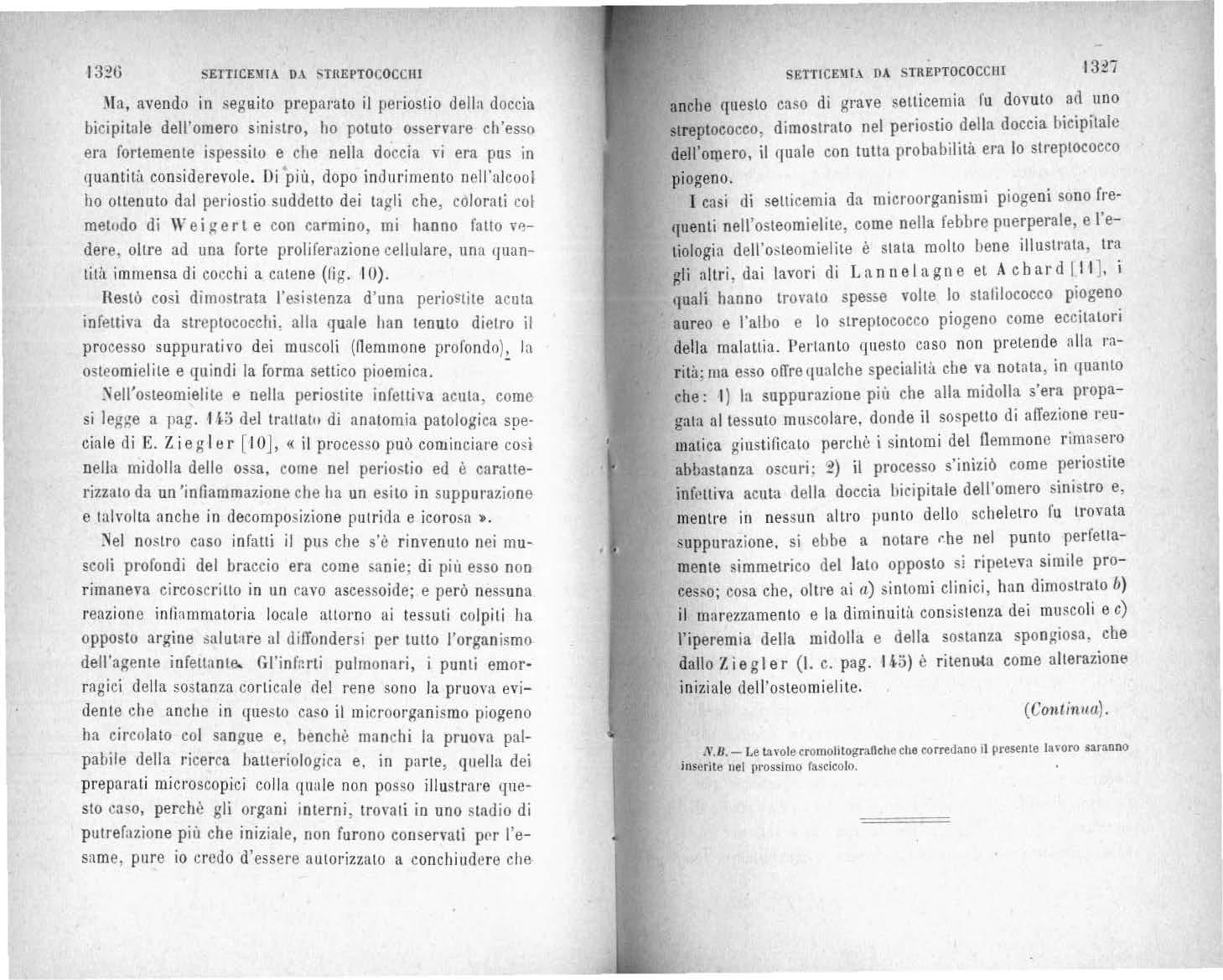
I casi di sellicemia da microorganismi piogeni sono fre· tfuenli nell' osleomielite, come nella febhre pnerperale, e l'etiologia dell'osteomi elite è Slata mollo ùene illustrala, tra gli nllr i. dai lavori di L a n uelago e el A c bard I li ] , i 'lual i hanno tro,·ato spesse volle lo stalilococco pioge no aureo e l'albo e lo st repto cocco piogeno come eccitatori dell a malaLtia. Pertanto questo caso non pretende nlla rar ità: ma esso oiTretfUalche specialità cbe va notata , in q nanto che: l) la suppuraziooe pi(J che alla midolla s'era propagata al tessuto musco lare, donde il di affezione reumati ca giustificalo perchè i sintomi del flemmone rimasero ab bastanza oscuri: l) il processo s'iniziò co me periosti le infetti va acuta della doccia hi ci pitale dell'omero sini stro e, men tre in nessun altro pu nto de ll o scheletro ru trovata supp urazione. si ebbe a notare rhe nel punto perfettamente simmet r ico del Ialo opposto si simile procesgo; cosa che, oltre ai a) sintomi clinici, han dimostralo b) il mnr czzame nlo e la dimi nuitit consistenza dei muscoli e c) \'iperemia della midolla e della sostanza spo ngiosa. che dall o Z iegler (1. c. pag. J.i-5) è ritenu-ta come inizi ale dell 'osteo mie lite.
( Contin11a).
· ' '. IJ .- Le t.'l\'Oie cromohtograOehe che corredano 11presente la,·oro saranno inserite nel [II"OSSÌffiO
Prodotte Dalla
Lettltra rntta a lla conr••ren za scientifica 518 ago:.to !893 presso l'ospedale militnro principale di Palermo dal dottor RodTae ll o Pi111po li . medico del38"
L'im po rtanza di questo gene r e di lesioni è pei medici mil itari più che per gli altri di gran lu nga aume ntala, dal mom ento che l;t dinamite è entrata a far parte dell e sostanze esplosive adoperate in guer ra, anzi è la pr·ima usata q uale mezzo di de molizio ne. Epperciò spero no n riuscira del tutto priva d'interesse l' esposizione del seg uente caso . o:ia avuto riguardo ai fatti obbiettivi, che al decorso mo rboso.
Durante il mio servizio di gua rdi a dal al 23 marzo scorso. fu co ndotto all'ospedale, per essere med icato di alGuae lesioni, Riso Giuseppe, marin aio di anni 38. abitante in via Borgo G.
I l paziente era in preda a leggiera. commozione cerebrale. intriso di sangue. colle vesti in parte lacerat e e completamente bagnate. Prese ntava le seguenti lesioni:
CONTRIB U[0 AttE LKS IOSI Pt\OD OT'CE DALLA DINAMITE 1;]29
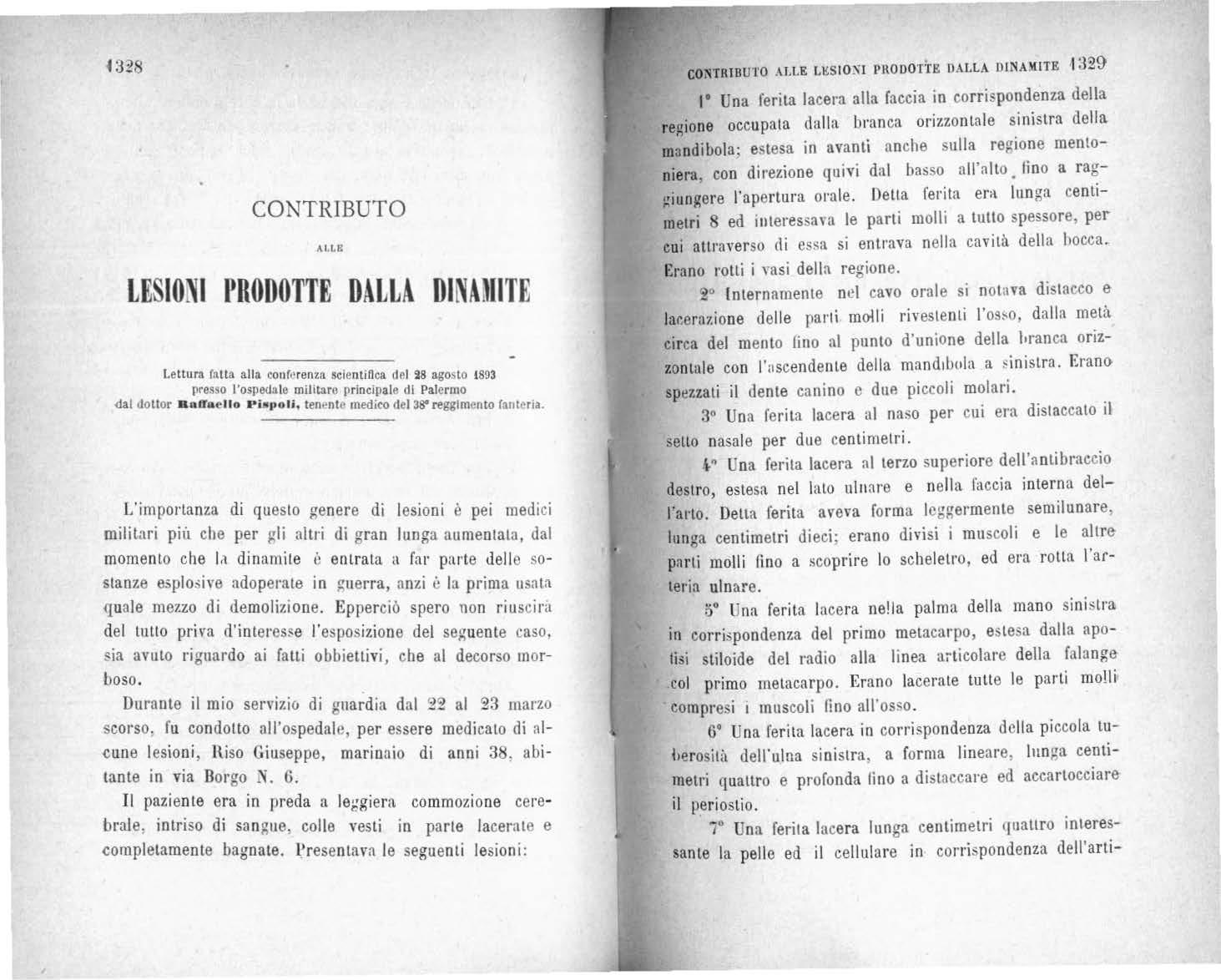
1• Un a ferita lacer·a alla faccia in co rri spond enza della regione occupata dulia. bran ca orizzontal e si nistra della mand ibola: estesa in avanti anche su lla reSlione mentoniera . con direzione quivi dal basso all'alto. lino a ragl'apertura orale. Della ferita era lun ga ce ntimetri 8 ed ruteressava le parti molli a tutto spessore, per cui att raverso di essa si entrava nella cavità della hocca. Era no rotti i Yasi della regione.
2o [ntern amente nel cavo orale si notava distacco e larernzio ne delle parli mo-lli rivestenti l'os!'o, dalla metà circa del mento lino al pun to d'unione della loranca orizzontale con l'ascendente della mandtbula a Eran() spezzati il t.lente canino c due piccoli molari.
3° Un a ferita lacera al naso per cui era distaccato il setto nasal e per due centim etri.
Cna fer ita lacera al terzo superiore dell'antibraccio des lro, estesa. nel lato ulnare e nella faccia interna dell'at'lo . Detta ferita aveva forma leggermente semilu nare. lun ga centimetri dieci; erano divisi i mu scoli e le altre pnrt i molli fino a scop rire lo scheletro, ed era r otta l'arter ia ulnare.
5° Una ferita lace ra nella palm a della mano si ni stra in corrispondenza del primo metacarpo, estesa dalla apofisi stiloide del radio alla linea a;ticolare della falange col primo metacarpo. Eran o lacer ate tulle le parli molli comp1·esi i musco li fino all'osso .
6° Una ferita lace ra in corri spondenza della pi cco la tuherositil dell'ulna si ni st ra, a form a lin eare. htnSla centimetri quattro e profonda lino a distaccare ed acca rtocciare il per iostio.
/ 0 Una ferita lacera lunga centimetri ttuattro inleressante la pell e ed il cellula r e in cor rispo nd enza dell'arti - colazione del quinto metacarpo colla falange del tJuinto di to, a destra.
8° \l olte abrasioni al pello, al collo. alla faccia ed alle braccia.
Tutte le de:>crille lesioni il Riso riferì che gli furono prodotte dallo scoppio di una cartuccia di dinamite, posta so tto ' aCCJlla in mare , dovo egli accidentalmente si trovava alla distanza di circa quallro metri. da notare che il L\iso era in una pi ccola zattera: per la violenza dell'esplosione fu non solo rovescinto in mare, ma insieme alla zattera sollevato dall'acqua e !andato lontano qual che metro.
Riso Giuseppe, è individuo ùi rostituzione l'orte e-robusto, te mperato nel !Jere, non t'• sifìl itico. non ha mai avuto malattie infeuive, nè ha altri precedenti morbosi che possano ostacolare il deco rso dell e les1oni riportate.
Disiofcltnte accuratamente le ferite con soluzione ùi hlimato all' l per mille. legai le arterie lese, a sportai un pi ccolo pezzetto di peri os lio maltrattato e le radi ci ùei denti spezzati. suturai usando il catgut per i punti profondi nei muscoli, c la seta nella sutura della pelle. ferita deli'antihraccio de5tro eù in quella dell a mano sinistra, essendo molto profonde, prima di riunire la pelle, posi un di garza idrofila ùismfettata. Appli cai q1tindi su tulle le rerite una medicatura all'iodoformio.
Le didtiarai guarihili in un limite di tempo massimo ùi giorni (mi riferisco co n questo alle pil1 gravi), tulle :-aho complicazioni, e pericolose quella all a fac cia di cicatrice ùetur·pnnte, e quella all'avambraccio de stro ed alln mano sinistra di storpiatura.
Ri sto1·ato l'individuo nelle condizioni generai:, giudican- inlrasportahile. lo ricoverai nel riparto chimrgico dell'ospedale.
Esporrò in due parole il decor:;o morboso: La sera dei 'U il Riso era apireuco. mentre la sera del giomo dopo la tem peratura er'" sa lita a 38° C., essendosi però ahbaiilan7.'l rim esso nelle condizioni generali.
11 giorno '24 si ebbe una marcata elevazione termica. :J!l0 ,8 C. Si nnoo\"ano le mcdicature· e si trova cile tLtlte le ferite. meno dell' antihraccio destro e d('l!a mano sinistra, non accen.nano a suppurare, mentre si i• raccolta in queste nna certa quanlilit di pus. Si sostituisce il drenaggio con tuho di gomma al di gar1.a, e si rimedi ca li giorno dopo (:.n marzo) la temperatura era notevolmente abhnssn ta, nè mai più sopn1 ai 38• t: .. 1n:t oscillò per altl'i cin11oe giorni fra 3ì" C. e :ri ".8 C., lino che, dal giorno ao marzo in av:JOti, fu sempre nei limiti lisiologici. Dopo cinque giumi si tolgon(• i punti da tutte le ferite, meno da quella dell'antibr.u;eio clestro e rlolln mano s inist ra, che si tolgono in\'ece in se ttima giornata. perchè que..;te co ntinuano un pu ' a su ppurare: le altre cicatrizzano di prima intenzione. Hin no1ate le medicaturc con vario inter· vallo di tempo, il Hiso il giorno 5 aprile. ossia dopo quattordici giorni di degenza, lasci a l'ospedale quasi completam ente goarito. co lla soia ane rtenza di venire a farsi medrcare ancora (jnalche rolta J'antihraccio e la mano. fino a completa cica triuazi one. che :>i efi'ettuò in veutoLto giorni.

In causa delle predelle lesioni non t•ima se alcun impedimento, ma si formaron o cicatric i solid e c abbastanza :.postahil i.
\'edi amo ora i ca ratteri pitt :>a lienti nell e de:;criue lesioni.
CO'\TRlOUTO ALLF. I.ESIONI
Gli effelti della dinamite sem hrerebhe che dovessero e.-sere identici a quell i prodotti dall'esplosione dei ga s, () clelle sostanze in genere, che inliammaodosi di fisico con vertendosi in un volume di gas molte volte mnggitJre. e i gas e :;os tanze produco no del te lesion i, che oltre ati' essere in rapporto colla violenza dell'esplosione, sono sempre in rapporto con la tempE>ratum vit't o meno elevata che si produ3se nell' esplosione stessa, per cui ciò che motto ri salta nPI rorpo dell'individuo rolpito ù l' u,tione dei tessuti. Invece il fallo che attira l'attenzion e quando si esamina una ferila prodolla da din :unite i· la mancanza di scollature. letteratura medica stono dei casi in cui In scoppiò nella mano del fe1·ito, ed io nessu no di questi casi si verificò l'elfouo della fiamma.
La spiegàzion e che può darsi a questo fenomeno i> la rapidi tit detta combustione; per cui arti interi sono lacerati e divelti, prima che la fiamma abbia avuto tempo di at.hruciar·oe i tessuti. (Rochard:.
l colpiti da gravi combustioni si lamentano subito dt dolori molto intensi. e cado no in preda a veri accessi di furore . Le lesioni prodotte dalla dinamite non sono dolorose al pari di quelle della polvere, che provoca dolore pel niu·o che con ti ene, però tardano a guarire e si prestano iliflit.: ilmente alla disinfezione in causa degli scollamenti e, piìt che mai, della compressio ne dei tessuti. Ma dopo guaritr, le cicatrici pòstume a lesioni da dinamite. non so no deformi e rallralle come quelle lasciate da ferite per sco ppio di polvere: fallo appunto che altl>iamo osser\'ato anche nel ferite prodotte dalla deOagrazione della polvere , le Sc!zioni so no meno nelle , le emonagie meno frequenti.
1'1\000TTE OALL.\ \liTE 1333
Le protlotle dalla dinamite. come \etlemmo nel caso no:,;tro , sono abbondantemente !'a nguin anti, con limiti decisi, poco contu-.e, e sembrano Le· oere nn posto di mozzo fra lo feritr co n1use propriamente dette e qu elle protlotte da strumenti quasi taglienti.
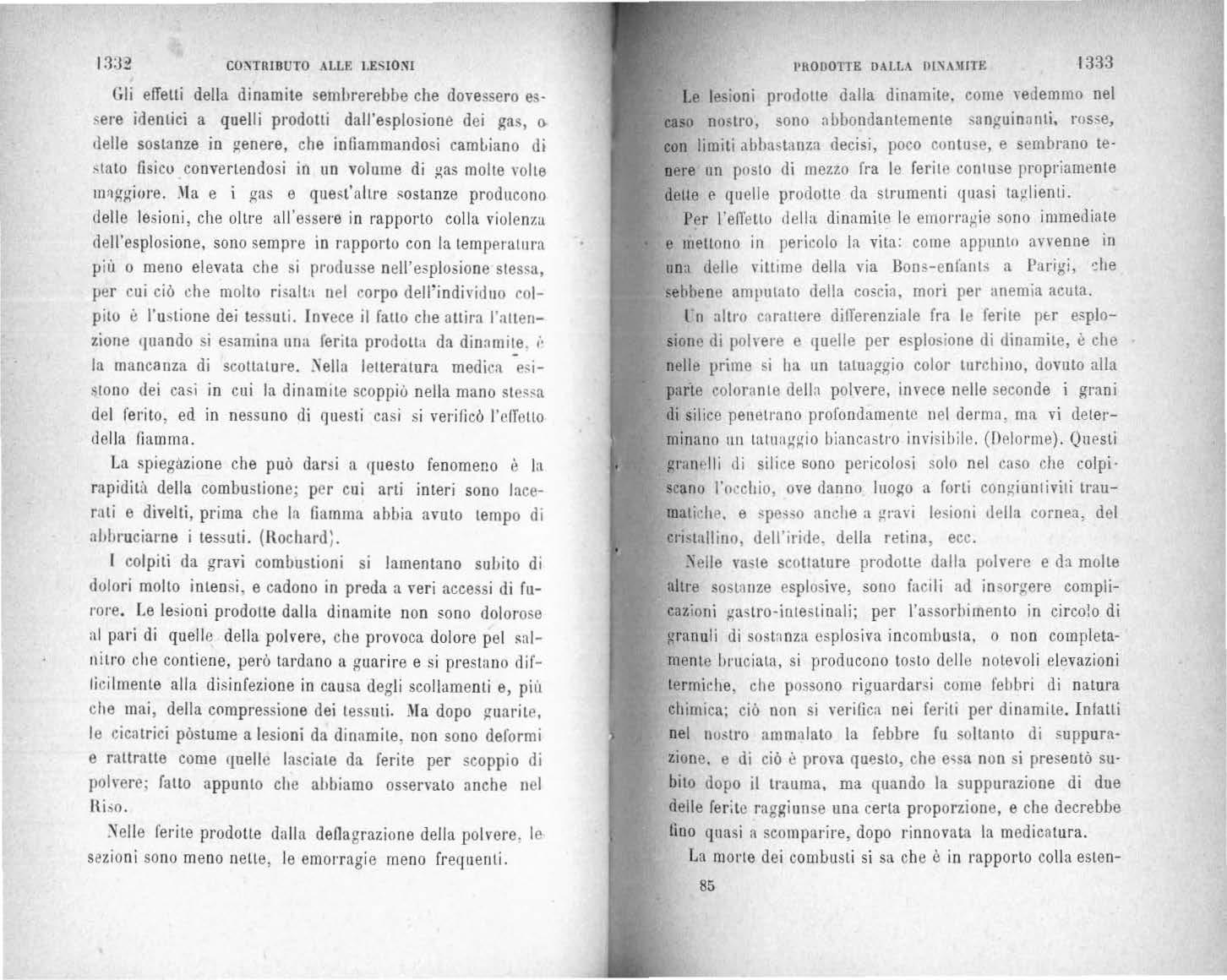
I'rr J'efl'euo drlla dinamite le emorTagio sono immeJiate e mettouo in perit:olo la vita: come appunto avvenne in un a delle \ ilttm e delta Yia Bon s-c nrauts a Parigi, e sehhene amputato della coscia, mori per anemia acuta. r n al li'CI carallere differenziale fra le ferrte pE:r esplosion e di poh ere e quelle per e'plos ioue di dinamite, è che nell e prime ha un tatuaggio color turchino, dovuto alla parte colornnle ùeli:l polvere, invece nelle seco nde i grani di sitic e pen etrano pro[onùamentc nel dermn. ma vi dolerminano 1111 tat tlilg:,:io iIl\' isi bil e. (D nlonn e). Qu rsti ui siliee sono pericolosi so lo nel t'a'>o dte colpi· scano l'occhio. ove danno a forti congi untiviti lraumatidlt>, e anche a gravi lesioni della cornea, del cl'i.. tallino, ùell'triùe. della retina, ecc.
.:\ elle vaste scollature prodolle ùnlla po!Yere e da molle altre sostanze espl osive , sono fa ci li ad complicazioni gastro-intestinali; per J'assorhimrnto in circolo di granuli ùi so:;t,nza csp lo5iva incombusta, o non completamente bruciata, si producono tosto dcllu notevoli elevazioni termi che. che possono con1e febbri di natura chimi ca: ciò non si verirìca nei feriti per dinamite . Inlalli nel ammalato la febbre fu soltanto di suppura· zione. e ùi ciò è prova quP.sLo, che non s i presentò su· bit o dopo il trauma, ma quando la suppurazione di due delle ferite raggiunse una certa proporzione, e che decrebbe lino qnasi a scomparire, dopo rinnovata la medicntura.
La morte dei combusti si sa che ò in rapporto colla esten- l:ONTIIIOUTO ALJ,g LE. sione della parre ahbruciata, assai pii.t che colla profondità dt'lla lesione, e la causa ri siede nella qnantitit di sa ngue 'i enP a co nt nllo della riscaldante, perchè il s•tngne ro.;i si altera qualilativamente in modo da non poter piil adempiere alla sua funzione di intermediario alla razione. la con).(estione tli organi interni (Zollin), ne'l la soppressione della allivitit della CIILC'. nè l'accumulamento di determinate sostanze nel sangue (Edenltuizen), nè mento tlel sangue (Baraùac). ni• ht diminuzione rillessa del tono (Son neobur·g). la rapidità della morte in ,·er te ustioni, ma solo le alte ra;:ioni del sangue stesso. che c1nsistono nel disfacimento dei corpuscoli rossi. e -sopra tullo nel faLLo che essi perdono la pr·oprietù di assorLi re l'os:;igeno (1\oenig). l uv ece nei feriti por dinnmite, la morto è in rnpporto diretto non co n l'estensione in superficie della lesione, ma con l'intensttà tlt>lla stessa, potendosi aver le più gravi mutilazioni. Si pnò d1re che nessun corpo espio· si vo ha mai prodollo traumati;mi cosi inten:-i come la dinamire. La di es:;a i• eapacc eli far si che un framm ento di penetri nel cervello aura,·ersando le due tavole del P·'•·ietale. che membra intt're si.1no di,•elte, la lesta lnnciara a distanza. Sono propri della dinamite i casi in cui le membra del ferjto producon o sull o stesso nuovi traumali smi, in cui per esempio le ossa, agenclo come pro iettili, penetrano nelle cavi tit (1\ochard).
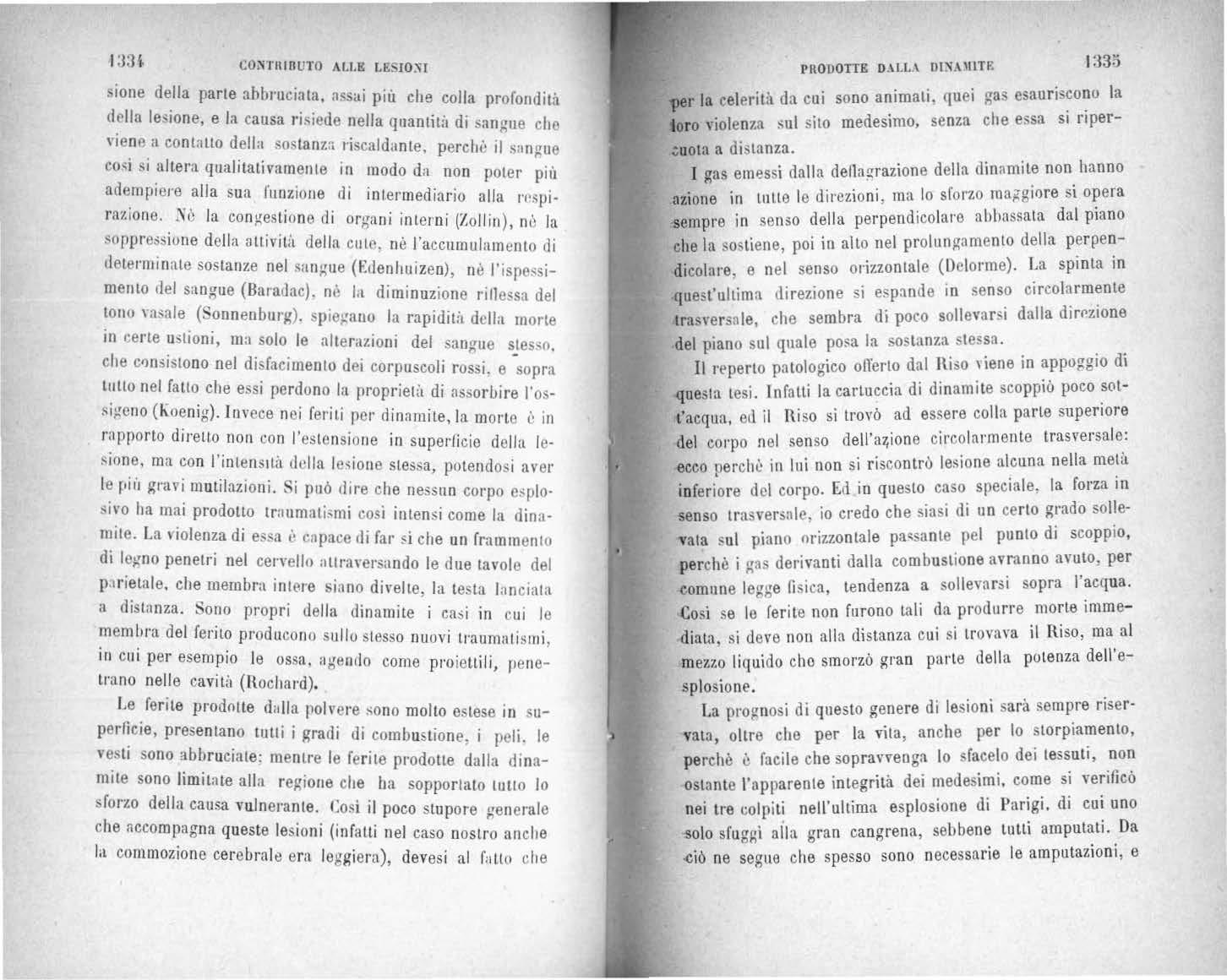
Le ferite prodotte dalla polvPre so no molto estese in superficie , presentano tulli i gradi di comb usti one. i peli. le vesti sono abbr uciate: mentre le ferite prodotle dalla di namite sono limita te alla regio ue che ha soppo r tato lutto lo sforzo della causa vuln era nte. Così il poco stupore generalo che accompagna queste lesioni (infatti nel caso nostro anc!Je la commozione cerebrale e ra devesi al fatto che lM'r la celerità da cui sono animati. quei ga:; la toro ,·iolenza sito medesimo, senza che essa st npera distanza.
1 gas emessi dalla deflagrazione della dinamite non hanno azi one in tutte le direzioni, ma lo sforzo ma;;gil)re si opera .semp re in se nso della perpendicolare abbassata dal piano che la poi in alto nel prolungamento della perpendi colare , e nel senso orizz ontal e (Oelorme). La spinta in q uest'ul tima direzione si e::;pantle in senso circo lar mente trasrersnle, che sembra di poco dalla dirl'zione del pian o sul quale posa la sostanza ste!'sn.
Il reperto pntologico oll'erto dal Ri so 'iene in appoggio di q uesta tesi. Infatti la cartu ccia di dinamite sco ppi ò poco t' acqua, eù il Ri so si trovò ad essere colla parte superrore del corpo nel senso dell'a7;ione ci rc olarm e nte trasversale: ecco nerchè in lui non si risco ntrò lesio ne alcuna nella melll in fertore do l corpo. Ed in questo caso specia le. la forza in senso trasversale, io cred o che siasi di un ce rto grado sollevata sul piano orizzontale pa-.sante pel punto di scoppio, perchè i gas derivanti dalla combustione avran no aYulo. per comune legge fi:;ica, tend enza a solleva rsi sop ra l'acqua. Cosi se le ferite non furono tali da proclurr·e morte immedi ata, si deve non alla distanza cui si trovava il Riso, ma a l mezzo liquido cho smorzò gran parte della potenza dell 'esplosione.
La prognosi di questo genere di lesioni sarà lle mpre riservata, oltre che per la vita , anche per lo storpiamento, pe rchè è facile che sopraHen ga lo sfacelo dei tessuti, non -Ostan te l'apparente integrità dei medesimi, come si verificò nei tre colpiti nell'ultima esplosi one di Parigi. di coi uno solo sfuggì alla gran cangrena, sebbene lulli amputati. Da -ciò ne segue che spesso sono necessarie le amputazioni, e bisogna amputare a distanza per li'O\'are te·· t' . . • :-:o,u r veram entesani. non colpili da 'lnpore •ollo l'inf1us·o J' tan to formitla l,il 1 . . . "' 1 1 una );Cossa e, Cl BVIIar e cost In canrrrcn" d . J l . Apr·o .·d' .. " "er emn . t po3slhllt demolizioni di trt't .\ l . spe , ' c t a notar·e clte sso, mancando la commozione cerehmle o e'· d ler,.,· ., · . . ' o quPsla r,,ret ,), SI polra HlllrUIJliSli'IJ'C il clorofo . . l'atto . . rmlo per operati\O. ar.t nece- ..u: l ' l' l' occhio dell' . l. ''• to nn <l rgente esame di'lhanno l; n ecc l IO: ma d_eJ resto 'Jilesti ll'tlUUJUtisnti 000 amento spectale. e la eura lor·o i..• m te . gent<rale ugnalt• a quella di tu Ile le altre ferito cr'o ·• f. nare l' e111 . · · ' t, re- or ra"l<l, ncer···are . c . . .
•· n l ot [Il e;,lranet. suturare con i 'aJJ mczzt e metodi secondo . . . · l cas,, rrcomporre oJi -S[J Odstam_e,llll, le parti che mi naccmuo sfacelo" ahhonantt avaurr 1 e ace 1· · . • ' nn ura I"SIIDU JUedtcatura antisettica.
Rivista Di Giornali Italiani Ed Esteri
Rivi Sta Me Di Ca
La clllataztone à e llo s t omac o ed 1 di stu rbi pstobtoi obe eu a provooa. - DEVAv. - (Jou rnal rle .\1édecin.e et de Chirurgie, luglio 1893). •
Il dottor Devay ha osservato di Bt·on un gran n umero di molati nei quali t'gli ha potuto sturliat·e l'inllucnza d ella dilatazione dello :;tornaco :3ullo '-lato nt>rvoso o sullo sviluppo delle malatLie mentali in pm·ticolare. Egli dimostra dt e nei la dilatazione dello stomaco può un a cau8a occasionnle per la pazzia e che negli alienali qu e!<la affezione imJll'ime al delirio un particolare. Si puo dire infatti che, nella !<lessa gui,:a che l'utero malato d opo il porto puo o \'\'elenartl e determinare pu 1.zie puerpcrali. cos'1 lo slumaco ùilateto gener,•rà una specie di follia to>'sica con tendenza alla lipemo11ia. Delre,to, <la lungo l<>mpo liPpt•esc:ione in tell t>llua le era l'lata n o ta ta, ma molto male intet·prelato. Bayle, !'ludiando le -pazzie simpntid1e, rece nol•we che l'onlerite e la ga'<lt·o-endanno luogo a feoomen1 cerebrali caratterizzati dalla mela ncooia, tla idee di uvvclenamentn, da rifiuto ùegli ali menti. Maury ha citato l'o«,.crvazione di uu ingegnere, il quale, affello da malAUia dello stomaco, pt·ec;entò sintomi ùi all'ezione malinconicn, che scornparvot·o dopo la cessazione d elln malattia dello sl'unuco. Ma pet' !3ayle, come per àiaut'Y si è lt·attsto di un renomeno simpatico, mentre che pe1· Devay $8 rel.Jbe un' inbssicazione. Da qu esta idea ne consegue un modo di tratta me nto che d à sover1Li bu oni risultati. Ce r tissimamente, la dil a tazion e dello stomttco determina disturbi psichici col seg u ente pr ocesso: sotto l'influenza della diminuzrone d i attività del succo gastrico si p r oducono nel vontricolo dilatato fermentazioni secondar·ie che sono veleni del s istem a nP r voso e possono delet•minat•e fenomeni depre ssivi o convulsi vi.

Bouver et e Devic hanno (IJmoslralo lo relazioni che esistono tr·a i disturbr dispeptici cd il cambiamento ù• cara\le r e . È com r una prima tappa che può condurre l'indivicluo pt•edisposlo all'alienazione mentAle. Gli ind ividur affetti rla fltlatazione del ventr·icolo presentano depressiontl cerebrale che si esplica con l'indebolimento e con la stanchezza d i tu tte le facoltà intellettuali, la memol'iu, l'applicazione, la volontà, il giudi?.io e la resistenza alle impt•essioni mor·ali.

Si comprende quindi facilmente come nei predispo!ltr, 1 disturbi mMta li si accentuino e come i malati cadono in uno stato vesanico completo in cui pr·eèomiua lo stato melanconico. Quesl& influenza della dilatazione sulla forma del deli r io. é anche dimostrala dal fatto che quando essa sopraggiungo in un individuo [.!ia vest\nico, si vede soventt modificar si il suo delirio e prendere il caratte re lipeman inco.
Nei falli di questo genere sar·A quind1 indi cata una cur·a attiva dello stomaco e dell'intestino: é necesMrio as::icur·are l'antisepsi del tubo intestina le ed ottenere la r egolar·ita uclla defeca zione. Quando sia possibile, é bP,ne fu r e la laYaturft d ello stomaco con una soluzione di naftolo ol 0,50 per 100. L 'u!"O inte r no delle preparalioni di nal1olo as!"ociate allo ma gnesia inglese possono dare i migliori ri!"ullati.
Ostru zione intest ina l e g u a. rltt c on u n p rooe11o molto semplice . - DE D uPLAA DE GAll.\T. - (G<Ueite d es n. 76, 18D;J).
Si tra tta di un uomo, del l'eh} di trent'anni circa, forte, vigoroso, di buona salute abituale.
Senza causa n ola, egli fu collo, du r ante la notte, da colich e secch e, violenti.
• r chiama r e un me< ICO, 1 1 l . ·1 1uale or-
Al malttn o, eg lt ece l fu '>'omitat o immediatal . ·1 medicn.men o di nò u n p u rga n e, • mente. ·orni diverse medirazioni furono Per• la durato di sei gt , usate nmlllmente. . l l'A il quale per sei giot·ni ="ell'otlavo g•orno fu o Le.• tutte le riserve lera. per s ma 111 utr tnen , ha mes"o 111 o • . . . rigeltoli: le tisane set. l e Tutti i medtcamenll erano peu te 1 guivan o la medesJma d Il malattia il venll'e e r a Ù · no "'Joruo e a ' .\1 quallor 1cesu n ala occbi i ncar- fìo la face tA rHggrmz , gon 1 • 1 terie fecali e1·ano d l - ate dolente c ma vali, la a omtn ' la •l lllnlalo era alla ri Ftelt.ale {'Or la bocci\. In una paro ' sua fin e . · . 1 ti l':\. credette uf:arc Vista l'inutlliLé. di tutti i meùJcamer ' -. i m ezzi meccani<·i . · 0 lot·o o r dinò d uomini IIIOilo . alcuu r isul ta to.
F ece chiama1'e ue . .
1 Lesta in e fece di s o ll evar e il pazil:'nle per ' a . l'' sncrava di pro. Ilo forll sco,se. ...... • irnpr•m ere di basso IO u onvul"'ivi che avrebbe r o l . · t t' · movunenlt c - d urre, n eg 1 10 es uu, 1 Ma non ottenne p olu lo r imellerh nel loro stato norma e.
1 ez-w il paziente . . e ad un a lro m . • Allora egh ncoi'S . l fianco· lluindi f!li fece sul del letto, co.rrcalo s.u ' Ida· che veniva · · l 1 eli · tere d acrtun t tep • d' o.mm u us 1·ar e u1 ::o • 1, t 8 il pollice e 1'111 ree l g li "lrm"eva ano r r•tir·Ala lu Cl\IIIIU a, e · '"' _ . tlalo Immeùiatamenle . 'l l' lo veDJS!'\e rrge . p er u n p•·•hre che l Jquu . 0 terzo cliste r e, . . t e un sec ondo, pol u ùop,), t't>Ce umm•nrs rar d' tenere colle . . 'l o non cesso maL l fin o n tre l1 ll'i ù t hquu o, thta r o.no otturato. , , ù.i l'f'stare in f!Uella Dopo un qua t'l<) d Ol s, stanco r·acr.omandandogh l'A. s i l'l'ce 80<;tituit•e llu un'all1'8 pe r sona , dr tener ben . d' . I>itali di materie 1 lato em1se tre rct
Dopo un'ora cn•c.a l ma . . fe cali. ed ollenne la completa guarlgtonc.
D. L J. BOKE:" HA\t e SoLnu F E;-o;wrcK. - EffetU patologici di alonne sostanze estratte dalla milza ditndtvidut soarlattinos l. - (Brtt. meri. Journal 19 zione volla col mettere le miscel(' per nlcune ore in un ayita lorc automatico Quando nulla pii.! m•trarsi, i renti hrp1idi fut•ono mescolAti e concentrati in una p1ccola massa no i modo sLr:>c:o dell'estratto alco•dico. Con questo pro1·esso l'apparecchi'> a vento unito ui hanno O"aminAlo 15 milze, lt> qunlr, Appena tolLe dal cudaverr-, furono irnmct·<>e r·ellifìcalo. -

Le belle rice_rche cii SidnPy Mar·lln, Hankin, nr10g,.r, Ronx l ersen Pd altr·r sulla cbimicn patolog:i.·u clelle malallie irraperto un vasto or·izzoule all'atti,·ità d., 1 patolog-r, e t dottor·i Bokonhom e Fen \\'itk dei lal>or1.1tori del R"AI dei mcdicr e chirurcd di Londru, <>eg:uendo il Sidnev Martm, lltlnno rivollo il loro studio sulla scaJ•Itlltina com.f' ci1P finora non !'ra RIAla presa in se t ia conc:;iùerRI.iorH'.
Le sostanze E''-lralle dalle tnib:e, poss()no di,·ir!ersr in t 1·,. clll!'\"Ì: tos:-;iche- di irl<'crta alli,·ita- dcbolrnPnt e tossicht>.
Questa distinzione permi"l! Agli os8f;rvalol'i di delt•rlllinar·e in qual gror·no dolla mulallia era avvenuta la mor te: le sostanz(' fortemonle to.::sicho si L1·ovarurro ne'-lJ indr· vJnui IDO l'li al 3° o 1• gio r no di mulutlia; 'lllello eh attivita in 'JII• lli morti ul t;>• giomo e debolmente to.::siclr•• negli indh·iùui morli in seguito ad una mniAtlia intcrcorrPnte.
Il metodo d'•_'sll'azione fu qul•llo giù adopPralo da Sidney ar·lllt sulla dirtorite. Le mil;.o furono tolle il più presto JlOSSibllO uopo ]a mnrle, e dopo 8CCUI'ata }aYatura, indso> e poste in bottiglie pi••ne di alc.:ool
In SCL:"uito, una macchina trilu•·att•ice, rurono rrdolle 111 finA poll1glia. la •ruale rimase irr contalto coll'alcool pe t· a lcune setlimHne e cosi tutte lo globuline c Je 1111 _ eleo-albumine f u·ono coagulale o rese wsolubili. L'alcool fu vuotato, il S)ll'emuto e lo porzioni liquiJe, dopo la Hltraz10ne, concentrale in pic·•·o!a massa (tJUa<.i dr l"Crropposa) in uu gnlncre Appa r ecctdo a vuoto i-lUI pt•incipio del condeu!'tato l'e di Licbi,!l' c m da poter concentrare indipendentemente sei csems tmultaneame nle. Il r esiduo solido fu trattato eoo ac• 1ua drstrllata ste•·rlizzata in successive po rzioni, aiutando rnotleva ai Ji, 1uiJi di bollire ad una temperatura mfcrwl e a 40• c., c dò fu ritenuto nece"sarro non !'apendosi st• il cnlor·e pole,·a t>!;!'ier· noctvo nllP !oi"f-line. . controllo duo nulle di rndiviòui moJ•li accinentalmcnte furono solloposle al medPsimo Anche qui l>i ottenne 1111 prodotto immergcnclo l'e.,tratto concentralo Jwll'a lcool assoluto, ma esHO e r <t piì1 fìoc<'oso e meno d r •(uello ollenulo dalle mib:e scarlallinose. Analizzalo, es;.o dd te la r eazione d'un'albumosi e ciò c.o ncorda. collo osser\'Ozioni di v .JaPk'<ch, Halltburten e Gourla y, i qua:i trovar o no che 1., rnilza contiene, poche ore dopo la morte, s•·tnpre mag-gio r•e 0 minor quantità d i pr·oteosi Quef-lli ultimi osset·-v ato r i ritengono <'ha qu"slo sia e che la p t•oteosi derh•i dalle cellu le splen1che e da1 l eucoc1l r. L'alcole ul"uto nellE' suddescrlllc operazioni conteneva ancn r·a m ollo mate ri ale insolubile. Fu trattato con CArbonato d i pola ssa secco allo scopo di privarlo d'og-ni tr·accia di acqua, d opo di fu separato dol sale ed cvoporato a secchezza nel vuoto a temperatura. Il residuo fu trattato con alcole assoluto e si ottenne un deposito dì tiro"ina e sali mmerali. L'estratto alcoolico, lasciato a ripOl'O per al cuni giorni, fece depositare uua sostanza (!cucina) che ader·ivn alla parete delle bottiglie. Il rimanente fu evaporuto a secchezza, un'altra voltn trattato con alcol e asgoJuto ed immer,-o in etere anidro. Il lrquido divenne immediatamente lorbi to e si depos ito con precipitato: questo fu sepa r a to, lavato con molto eter·e e con cloi'Ofot•mio puro in cui una parte dì esso si "ciolse. Nel trattamento coll'etere si una gran quantitù d'una materia oleosa, la cu i natur·u non i· per·nnco ddf'rminata.
Tu tti i lirluidi concenteati furono c·ol decuplo dt a lcool !n ogni cac:o una o minnl' quantità di un prPcipitato pasLOSO !JianchiSSÌIIIO O f(lflllO si !'Cparò a wndo 11111 ggior·e o minor tendenza ad aderire alle pareti eli' llfl be ,urglia. Dopo a ve1·lo la scit1lo prr Hlcuno se lll· in cl)ulalto coll'alcool, il precipitato fu <>epat·ato, lava to crJn altro alcool, disciolto in piccolo quantrtà d1 ncqutl e nuovamente immerso nell'alcool assoluto. Ripetendo pal'··cchie ,.0 tre questa operaziont>, Il prel'ipitato tlh·eune mollo pu ro: ru ({Uindl disseccato nel vuoto e conservato in botti glie t appate. . . .
Cos i prrplll'alo esso coslituisco una polvei'O o bianca, di reazione neutra e alcali11 a, pro ••Lamente m acqua ma insolubile nell'!llcool etPre e cloroformio.
L1• sostanze ottenute coi surrifer •li pr·ocessi appartengono alla clnsse delle proteosi e chiruicumente non si souo distinguere da quelle fol'male durante la digesli.:Jne.
Gli animali su cui si sperimeutò furono cavie, topi, coLa ()uanlità di sostanza iniettata fu in dr 0 . 10 gr. per chrlog r·a1111110 d'animalè, sciolta in pochi centimetri cubici d'acqua. Non si ebbe reazione locale: "Oio uua o duP volle si formò nel sito inoculato un poco Ji pus e null'allro.
1. Casi tossici. - La soluzione dell'estratto di milza d'individui m o rti dal fo al 5• gior11o, init"tlala alla dose di 0,1 gl' , per chilogr·ammo di peso d elle luogo dopo 25-30 minuti a paresi del treno posteriore e a dispnea e dopo altra mezza ora a prol'onùo collasso, dopo raffreddamento cutaneo. Lo a nimale "i rrslabilì più o meno pl'ontamente e il rrtorno allo nurmnle era accelel'ato da una ambiento di t :lO• F . Con tNnporaneam e nlo la tempe ratura dr·l corpo si abbassò gr·adal.8mente lino a ;>o F. {ll disotto della temperatura nol'lnale (che pei conigli è di 102o,4-103' F) e ciò avvonne 2- 3 or·e dopo l'iniezione. Due ore dCipo la temperatura salì al punto anzi, alcune volle, quautunquP fugacement••. lo sorpa!<S6. S e l'iniezione viPn pralrNtlu in una vena periferica la temperatura r•eLLalo si eleva, invece di abbassvr·si . Ji a•- i o F. per r·iloi'Dare in ore n Ilo stato norma le. Il giorno seguente l'iniezione nulla si o"ser,·a di an or male nel coniglio, ma il 7' o So giorno la lompe r alut·a si eleva e l'Appetito svanisce fìnchè, ordinal'iamente al 10• o tt• uiot·no, l'animale muore (m inimo 5", massimo 15• f:tiorno).
L' uri na presentava albumina; nessuna o normalità nel sangue nt> nei nervi motori come fu indicato ùa Sidney Mtwtin nelle i nrezioni di estl'allo di milza di individui morti per dirLerile. cas i settici. - L'estratto non dette in questi casi risultati uniformi. Negli an imali nolossi solo un lieve malessere 1• per avere 'tuakho l'>i01tomo t.li quelli osservati precedentemente fu mestieri porlar·e lo dose a 0,30 l! r. per ch•logrammo: La morte non a. vvcnne che d e volle: i conigli inoculalt furono l i.

3. Casi poslsearlallinosi. - L't strallo "Pienico d a individui morti in seguito a. malattie inlercor·rentr produs•e , iniettato, falli di !>peciale menzione. Mai no se:.rm la morte.
L'esamo anatorno-palol0gico clei .,ic;ceri fclce notare accu· m ul i di bile nell'intestino e macchie emor·ragiche nella nruccosa dello stomaco Oltre a ciò i reni ero no affetti da intensn n el'rite. Gli allrt orgttni non pl'esentavano nulla dr nnormnte. Allo scopo di detel'minare se i fatti surr·ifert li dipendeva."o r ealmentH dalle milze di Rokenham e 1nieltarono l'estratto di milze provenienti da indi,idui rnot•ti e le albumoc;i pepliche. Nell'un o e nell'altro c aso i ris u ltati fur·ono negativi.
Dal nn fJui esposto risulta chiar11mente che nPi casi di scarlallioo rap1damente letale si fol'ma pr otlotto di natura proteica, il quale può esse!'e. estr.atto _rn piccola quantità dall11 milza e che iniettato n<>ulr é 1'8pidamenle eliminalo dai r eni su rui, af!ent.lo du de terminA una nefrite par,mchimalorìa acuta. Questo l'l::iUIlalo si ottiene anch e quando la sPluzione dell'esLr·atto splenico viene pre,·iamente bollila.
Potrebbe anche che le alll.'razioni s:astro -inlE>slln al i descr•itLe eia Samuele Ft"nwick in casi di scu rlall111a possano dalla medesima causa, ma i citali Of:!;e J'v at.ori fanno notare che nei loro ecose non fu-
\rE DICA
rooo m'li inconl r·al" o chu neg-li uomini esse Insorgono nelle :H or·c della febbre, mollo tempo prima qnmdr dello sv1l u ppo l'anale.
G. G.
Ricerche 1nlla quantit à. dei corpuscoli del aang ae nel v&iaolo e nelle sue oomplicazloni . - R. PlCK. _ (Arc/1. fii r D"t'm. unrl S!Jph. e Ccmcralb fiir dieutcdic. .. N. 12, 1893).
. Le ricel'clte furono !"•leso a 42 ca c: i di vajolo; la numerazroue der corpu-<coli bianchi del sangue c:i fac<"va ogni giorno ed anche duP V111lc il giorno, quella dei r·o<:si nello intervallo alcuni giorni. Il r'o"ultalo fu il seguente: la infelioue \·a· .JOI?"'a nello st r etto sen<:;o non proùuce punto leucoc 1to!"i; POlche, e nel rer•todo d..,Jia cr117.ione durante il pil1 allo grllclo della fehhro, e nei ca<>i più gravi fino al loro lel'nlÌuc l etvlu non s i Lro,·a. alcun numenlo l t> ucocili . La infezione con purulenli cag iona mediocre l eucoc1Lm<J, per· lo più pr·oporziona le alla gravezza de l caso. l t>l'mino manca la leucocitos i. L'ultimo. fenomeuo non può metter,i solo in conto d"'lln pneu· ruonrl l'l lobulare !lernpr e ec:iRtita, poichè questa non domina sempre la ror·ma m cwhMa. Clli asce!"si che hanno il carat.delle inflamma?.i..>ni causatt> ordinari rnicrorganlsm r purulenti producono aumento di leucocili. Il nuntero dt>i cor·pu--coli ro c:si del SRil!!ue r imane durante tutta la durata della m tlnltia, ina lte rato.
Ottalità. agli apici po lmonart senza alterazione anatomica. . - M. II r tLLEA. - ( \Vien. klin . Woc/tens clt. c Centra/b. (ur rlie 1w•dicin. 11, 1893).
R ecen l P111P1Jle il Kernig ha dimo!'lrato che taloru nelle persone si ha o LLusila agli a pic i polm :::na ri senza fenomt>n r acus tici: questa ottu!'i!a con J(l s laLo normale dei polmoni, la qualo potrebbe facj l mente indur·re alla error1ca diagnosi Ji una in fll tr·azione deg li apici deve a llribu irsi alla dilatazione di que<>li ll!•ici in con<Je f:uen 7a del mArasma e del lr1ngo riposo 11 lr1l•. 11 Il • rller ha confermalo que.,lo fallo, ma lo Ila inoltr·e os.... ervalo non l!olo nell" persone colpite d11 mar·asrnn ma hen anche e ben nutrite In questi Cll!<i la Lro,·uta api ci polmonari non era piu climoslrabJle ncll'e:-ntlle d1 rafr1·onlo che faceva clopo L'ascollazione. Cau"a eli questo '-lato alellellA!>ico sono le escur·s•oui che fanno gli apici polmo nari a respirazione tranquilla. t.:n'allrn cau s a di sopra un·opicr> polml)nOI'e, c:pe· eia mente nella fos>'a sopt'aspinosa sto nelle usunmelrie del tOI'ace che talora sono piccole, poc:sono esc:et'P cir•cosc ritle a una o più coste o a una piccole parte di e!'s('; 111 c cr cos,tnnze non po$sono tcoprirsi rho co l tntto tiPI tlilo espl orolo r•e. La ollusilà derivèinle delle a sim m e lriu cupare tutta lu fossa sopr aspinosa o parla d i Sr cv1t1 di clar·e g l'tt!l peso, solto il r iguardo d iagnof'ticn, tlll.a lf'zza c) mancanza in quel luop:o del l'Umore r u"p n·alorlO, poi r h é I'JUeslo all'apice è in molle persone se no m ol lo debole o non affatto percetlibìle. t'H e nr v n el marzo 1891 descrisse un ca so !'imile, como distrofia ·mixeùematoide, e nell'ottobre t b!l1 ne ru descr1llo dal Blocldey nn ter·zo caso eguale a1 preceden ti . Il ?· dare a fJUesti casi il nome di adipo!'i do lorosa. Due dt que&ll furono alla sezione, senza potere più ta rd: fare l'eflame mi c roscopico degli organi nervosi cenlroli. Lo spes · simcnlo ùe l tessuto s i presenta dapprim a a focolai e a forma ùi nodi ora alle estre mità ora al tro nco, o pe r l o pi(t co n
Adipo al d olorosa. . - F. X. DERCUM. - (Centra/b. fii.r tlie m Pcl . N. 2P, 180.1).
È r('le'-la una malallia elle a primo aspetto ha l'appar·e.nzA della obesilò, ma associal.ll a sintomi n" r vost. Il DPr cum no riferi<:ce tre casi, dei quali il pr imo fu desc1·illo ùnl D. stesso nel 1 88 come distrofia del connellivo sotloculanco delle braccia e del dorso con fenomeni simili ol m ixeòema.
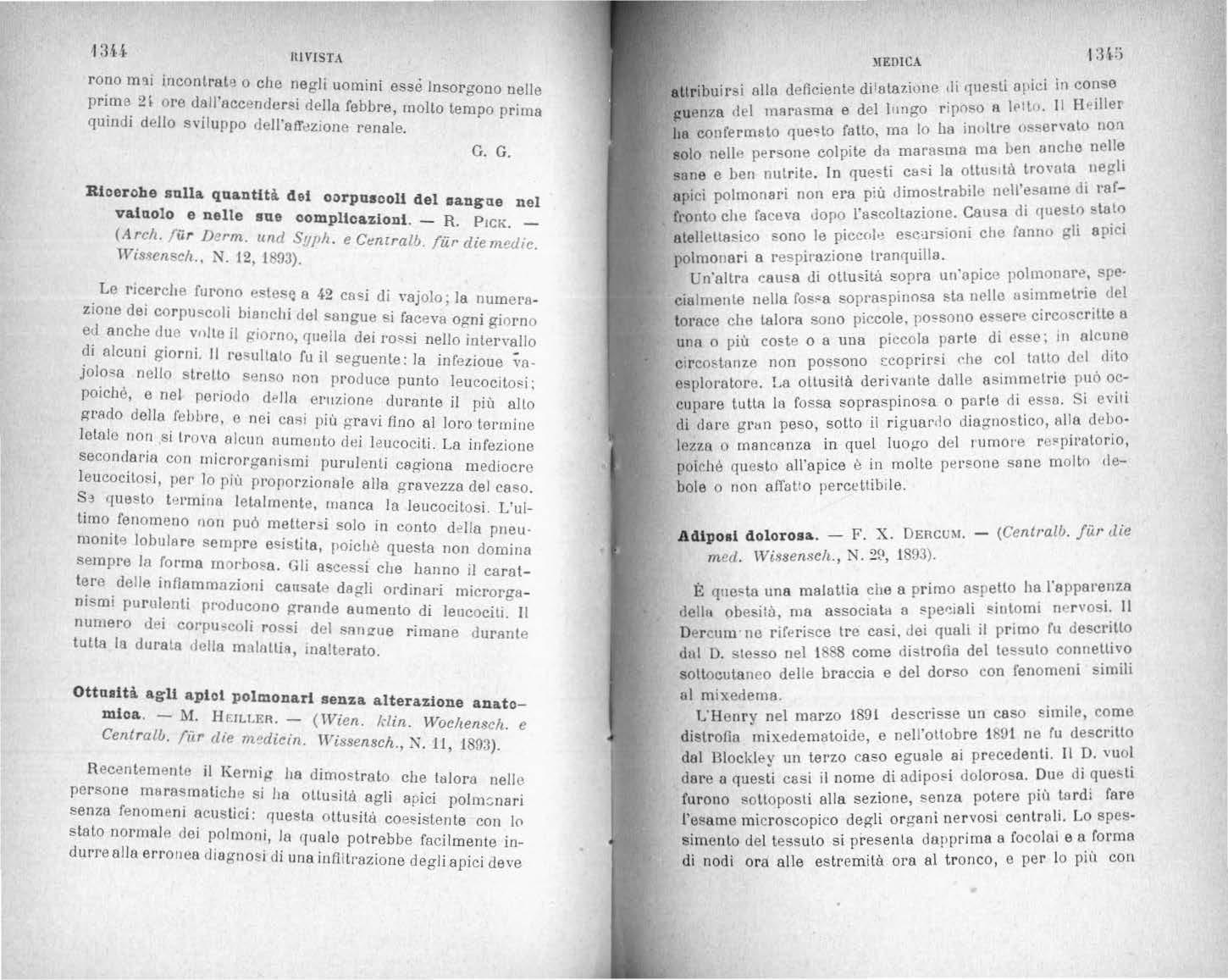
RIVISTA sen"azioni dolorose pas,.eggdre; nel primo caso erano anche dolenti alla pressione i nervi del braccio, ed erano atrofi ci alcuui muscoli della emin en za tenare e ipotenare. Altri dtsturbi net·vosi osset•vati furono: an estesia e iperestesia nei luoghi ingrossati, debolezza motorta, mancanza o diminuzione del la secrez ione del sudore, dolore di t esta . In due CA"i vi fu ernRlernesi, in uno metrort•agia. L'eta dei maiaLi era fra. 5 1 e G5 a n n i. l pezzelli ui tessuto che in due casi furono asportati Ja i luoghi ingro<>sati ed esaminali mostrarono tessuto connct· ti vo embr1onale e cellule adipose. Alla sezione fut·ono m due casi cellule indurite e calcificale. è t{ltCslA né un a semplice adìposita uè rnixedema; pet·e che si tcalti di uua. di!'ilrolìa del tessuto connettivo con metamorfosi grassosa a focolai sparsi e con alte razioni neuritiche infiammalorte.
Dott. At.DERTO ALau.- Relazione ollnloa e sperimental e •ull& oura della tubercoloal polmonare ool creosoto . - (Be rline r klinische Wochcnsclmft).
L'autore ha usato il creosoto ne• malati tubercolosi t·icovorati all'ospedale ;\loabit ( Berlino) e spettanti al ri parto del signor dit·ettore dott. P. Gullrnann. Furono per lo più usate le pillole di creosoto preparate dal fa r macista ognuna delle quali contiene 5 centigr ammi di creosoto.
L'u so quanLitativo del rimedio è indicato nello spercllio seguente: t. 6. 1887 - 31. 12. 1887. :lO,OOO capsule a 0,05 gr. 1 Cg. :>00 gr. di creosoto;
1. 8. 1888 - :3 1. 12. 188 . capsule a 0,05 g r. i Cg. 225 gr. di creosoto.
1. 1. 1889 - l. i. 1889. 24,000 capsule a 0,0;> gr. = 1 Cf{. 200 gr. di creosoto; l. t 1889 - L i. 1890 H 7,000 capsule a 0,05 gr. = 7 Cg. :150 g r. di creoso to; l. 1890 - 1. 4. 1801. 9'J.,500 capsule a 0,05 gr.= 1 Cg. 725 gr. di creosalo.
M&OIC,\
1. t.. t 891 - L i. tR92. 2:l't,OOO capsule a 0,0:> gr.= 1l iOO g r di creosoto; _
1 . 1- 1Rtl:2 - 1. 10. 1892. 165,000 capsule a 0,0<> gr. = 8 Cg. 22:i gr. di creosoto.
Alcuni malnli per lungo tempo fecet'<> u r;o di tre grammi .di creosoto al giorno; alL r i in pochi mesi ingoiarono 5000 plllole ed alcuni 9000 pillole, cioè l'lO grarnll)i di creosoto puro.
11 rimedio in "'ènerale, anche a fo r ti fu ben toiiP.rato e fu usato gli stadi della lisi, m a con predilezione nell f' fo r me iniziali.
11 prof. Sommerbrotlt considera il creosoto come un rimedio specifico della tubercolosi; pet·ò il cioll. ?uttmann dimostrò con su collure dt tubercolosi che occorre una soluzione t/400• di c r eosoto per impedire il loro sviluppo.
Mo. per ollener·e che tale dose circoli nPII"organismo cioè più di un grammo di creosoto ucl sangue, bisogner ebbe introdurre nello stomaco co:.i :.':l'Ande 'JUAnlila di rimeòio che supel'ert>bbe ogni limite terapeulico
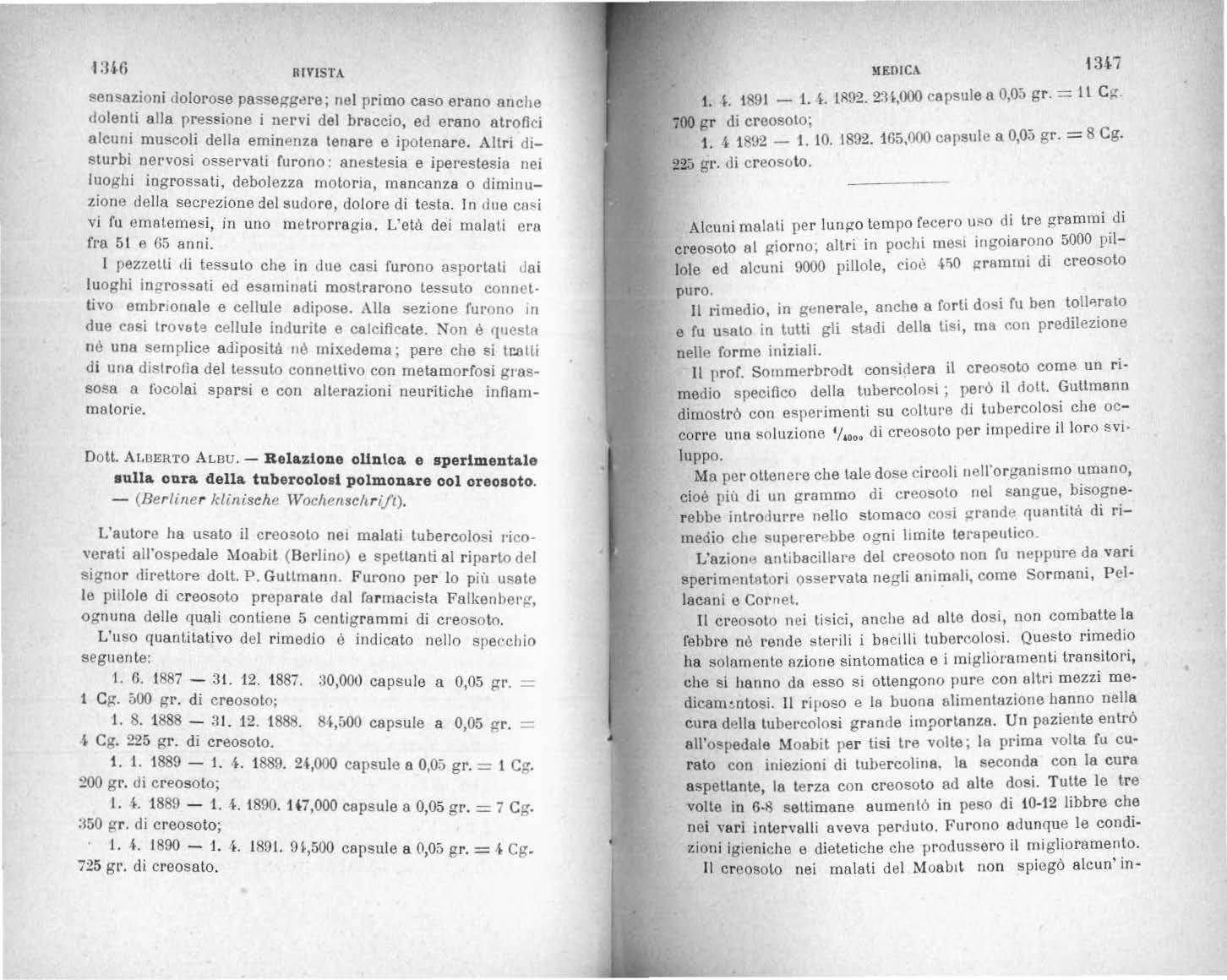
L'azion1• anlibacillat•e del creosoto non fu nepp111·e da vari sperimPntstori osservata negli animali, come Sormani, P ellacaoi e Cornet.
Il creosoto nei ti"ici, anche ad alte dosi, non combatte la febbt·e né rende ste1·ili i bacilli tuberrolosi. Que8to rimedio ha solnmenle azione sintomatica e i miglioramenti t ra nsitori, che si hanno da esso si ottengono pure con altl'i mezzi medicam tosi. Il riposo e la buona alimentazione hanno nella cura dPlla lub e1·colosi grande importanza. Un paziente entrò Moabil per lisi tre volte; la prima volla fu curalo con iniezioni di tubercolina, la seconda con la cura a spettante, la te rza con creosoto ad alte dosi. T utte le tre volte in 6·8 settimane aumentò io peso di i0-12 libbre che nei vari inte rvalli aveva perduto. Furono a dunque le condizioni ig1cniche e dietetiche che produssero il mi glio ramento.
Il creosoto nei malati del Moabt l non spiegò alcun' in-
nrvrsTA MEDICA
fluenza sul pror·o::-"0 tubercoloso polmonare, ma pt>l momento può tuttav1a come il mi!!lior rimed 1o
Pt>l magl!iOr numero degli ammalali sembra un buon ec;pettorunte, per allr·i uno stomut1co, e a!!isc,. como alli\'O Ionico.
Con es<lo non si ottengono però guarigioni della com. plete e durature.
Rclalivs111ante alln parte esperimentale che l'autore ha condotlo a termine in collaborazione del dott. \Vevl 1\ notare ìl mescoluto anche m grandi c;uantitit con tuùercolo!Si contenenti numeroc;i baciLi non ha a _que.:;tl d1 !mluppat·si e moiLiplicars1 moculaztonJ nella camera 11nteriore degli occhi di conigli, quanto nella cavitu peritoncalo di cavie.
- l l creosoto anche in alte dosi non al cun'azione sui bacilli Luberco lo"' i e non modifica il p1·oces:o Luberco loso Rpccillco ne1 polmoni. La credenza ùt Somm c rbt•odt od IIII'HLIOlle del creosoto sulla tu bercolosi non ha pcrciù alcun fondamento.
Hl VlST A CHIH UHG I CA
Fr attura della. volta del cranio , con i nfossa.mento diUD. framm ento osseo: sucohia.me nto pneumatico: guarigione . - l\1. FRoUMY, mèd. ùe r ég. - (Arcllioes mdclirales Br.l[JP.S, juil!et, 189::1).
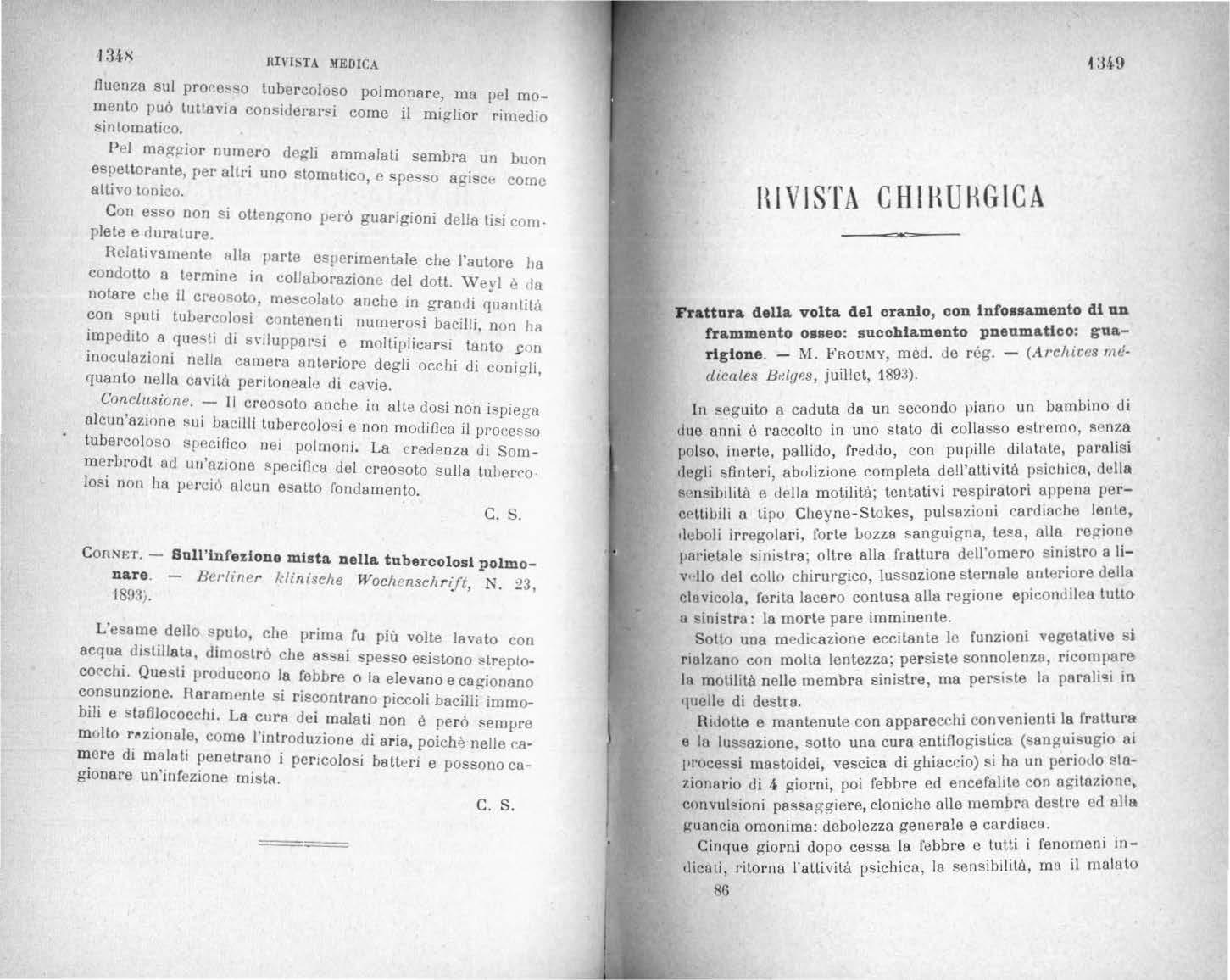
CORNt-:-r. - Soll'infezlono mista nella tubercolosi nolmonare . - Berliner kfinische Woc henseh r ift - 23, 1893,. '
L 'esame dello !"puto, che prima fu più volte lavato con acqua d1gtillat.a, dimostrò che a ssai spesso esistono :::treptococchi. Questi producono la febbre o la elevano e caaiouano . consunziOne. Raramente si riscontt·ano piccoli bacilli immobili e La cu ra dei malati non é pe r ò sempre m olto ri!ZtOnal e, come l'introduzione di a r ia, poicM nelle radi penetr ano i per1colosi batter1 e possono caglOoare un'infezione mistA.
In seguito a caduLa da un secondo piano un bambino di due anni è raccolto in uno stato di co ll asso eslt•emo, Sl'nza pol so. merte, pallido, freddo, con pupille dilnlnle, paralisi degli sfintet·i, abolizione completa de!l'attivité. psicltira, della RP usib1lilà e della motilité.; tentativi respiratori appena pera tipo Cheyne-Slokes, pulsazioni cardiache lente, irregolari, forte !Jozze sanguigna, lesa, alla l'eg-iono pat'ietale s10istra; oltre alla ft•attura dell'omero sinistr o a li""110 del collo cbiru1·gico, lussazione ste rnal e anteriore della clflvicola, ferita lacer o contusa alla regiOne lutto u "mi str a: la morte pare imminente.
Sotto una m edicazione ecc itante le runzioni vegelative s i rialzan o con molla lentezza; per siste sonnolenza, rtcompare lo m olilità n elle membr a sinistre, ma pers1ste lu parali'3i in qncllu di destra.
R idotte e mantenute con appa r eCl'hi convenienti la frattura e la lussazione, solto una cur a entiflogistica (sanguisugio 111 JH'Ocessi mastoidei, vescica di ghiaccio) si ha un periodo staziona l'io ui 4 giorni, poi febb re ed encerallle con convul::z1oni passagg1ere, cloniche alle membrn destt·e cd olia 1-(uoncia omonima: debolezza genera le e cnrdiaco.
Cinque g iorni dopo cessa la e LuiLi i fenom e ni in,Jicoli, 1·itorna l'aLLivilà psicbica, la sensibi lità, mo il molato 8() r<>:o:tA <>mlplef!ico ed nfasico. La boua sanguigna 111 risolvi' lentamente, e Rolo dopo 18 gior ni 11i puo esplorare la supPr· fice cr11nica e r ileva•·e l'infos8amcnlo di un lar go fl'ammenlo quadrlla te •'o spi11to in massa verso d ce t·vcllo, che comprim e special•ucnte col nntel'iore e piu ''erso il angolo i••ferioi'P. La bozza contenendo ancora una certa quanlltil. ti liquid0 molto mobile, si tento subito l'aspirazioni' pneumatica con una ventosa a base larga tanto da comp•·onùPrC il frammento e pt•endere appoggio al dt lù sui mar!!ini fis<.i dl311a volta c ramca fratturala: i bordi ne furono fissali con mastice aderente, il vuoto praticato colln pompa di Polain. Il •·•sullato fu suddi.,facente, il frammento riv l'rme IJUa<-i a liv ello coi lati superJOI'i e posteriori; l'abbassamento po3r:-istcva sebbene meno ma1'cato all'angolo anteriore ed inferiore. Pocha ore dopo la raccolta e1'a completamente sparita, si conc;lalaql qualche movimento nella gamhA ull'indomaoi era spnr1ta la paral1s1 fac1ale, i movim enLi alla g am ba più estesi. Si pt'ocede ad una seconda aspirazione più e pìu forte in alla :-ron•pAI'!'a dell'ematom a, e se n•l olLiene un rialzamento rompleto.
A parti1·e da i mo vimenti si nella gamba destra, ricompariscono e si accentuano nel braccio omonimo: otto giorni dopo l'infermo si serve delle sue membra co n forza eù agilità, solo il pollice destro resta parl'tico per fJuindici l'mlelligenza ritorna mtegra e nOJ'IDale.
Due mesi dopo l'accidente nulla piu rimane delle lesioni esterne, fratlu1·a e lu::sSiiZIOne: il ragazzo giuoca, camminu, curt•e, impiega ambo le mani, pt"rò é diventalo mancino· pet•s•::;le solo l'ttfasia, che scompare cinque o sci dopo in seguito ad una nuova educazione impartita con pCI'«everanza dal· J•Arenti.
L'insieme la s ucccssio ue dei fenomeni permellP. di pl'P· cisa1·e la naLura c la :::eùe delle les10nt ce•·ebrali causate dalla frallura. - L'e•nipl eg1a coerispoudeva all'arresto fuuziouole J'uua pu•·te Jcl cen•ello per compress1on e.
La della fnrcia a destra alla lesione del centro della porzione respirat\)ri a del (parte inferiore delle riue circonvoluzioni lt la paralisi del braccio destro a <Iella parte media della ci rco n voluztone la paralisi del membro a della pù r le superio•·e delle due circonvo\uzJOm ascendenti, c della parte media della parietale ascendente; l'afasia e r u alla contusione del p1ede della tòrzn circon,·oluzione frontale sinistr a. . .
Ques to punto, centro ubituale dell'afasta molr1ce, esser r tdotto ad un impotenza pt:lsseggera, come 1 cPntr• -dPJia moltlilil della fliccia, del braccio, e della gamba a desll'a e riar.qui"'tare poi le sue funzioni per ripaeazione della sione, ovvero la tei'Ztl circorwoluzione destra entro essa 111 azione pe r supplire all'inazione clelia congenel'e?
Nei destri l'emisfero s10istro pt·esiede solo alla facoltà del lingua ggio; nei sinistri al contrario il centro della è nell'emisfero destro: il soggetto era p!'ima destro, div_en.ne man cino dopo l'accidente. mollo probabile che in lm _1 emisfer o destt·o a bbia assunt.o la tenuta dal sinistro, e che la teeza circonYo)uziont> abb1a acquistalo 0 svil u ppato la fnco\LA del che essa possedeva allo gtato latente.
A. C.
Bull a li nfo - saroomato•l . - Ku;-.;onAT. - ( W ien. klin. H'oehe ns. e Centralùlattf•''' die med. t,l'issenseh., 18U:!)
11 Kun1Jrol os"ervo cluranle ultimi dieci an_ni di e il doppio numero di malatlle e Co•1 la scorta di 11uesto materiale, ollre mollt Intere:<;:aoli particoluri, du. la forma di cio che intend... per . .
F.;.;li dice che 11on sempre le glandole hnfatiche.' ma frequentemente alcuni follicoli \infalici e ben anche tl tant.o variahilmeote sviluppato tessuto adenoide sono il punto d1 partenza della Jinfosurcomatosi. Nello u!Leriore sviluppo essa
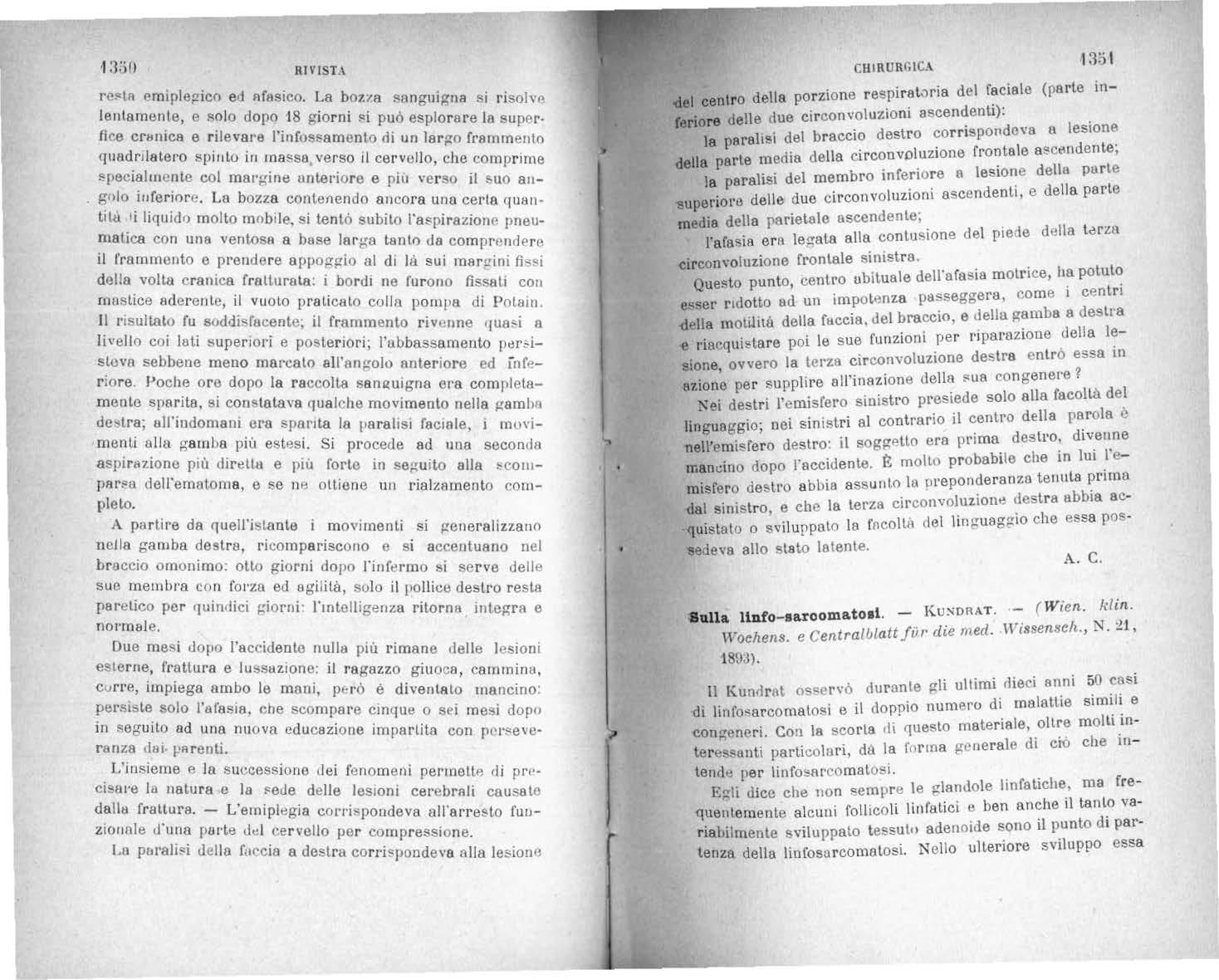
Cllii\U RGICA non solo ri m ane limitata a questo let·reno, ma invade le vi:inanze e distrugge tulli i tessuti che incontra. Si osserva p r opagazione regi onale sui èivcrsi gruppr di glandole ltnfaltcbe. :\Ia non sono mai come nella leucoemia attaccale tutte le glandole lio fa tiche, ma sempre il linfo-sarcoma r i limitato aù alcune regroni. Talora a v vengono apparenti melastasi, ma in quasi lutti i casi si può con altento esame stabilire che la metaslasi si fa per le vie Jinfatich e malate. I vac;i sanguigni non ammalano, possono solo esset·e compressi e cosi trombi secondaJ•i.
Sono piu frequenteme n te colpiti gli uomini delle donne e p.;r• lo pru le persone robuste. Secondo il K. può il linfosa r coma deri\·are dagli ingorghi pst:ùoleucoemici t' dal g1·anuloma maligno. In quanto alla sede primaria di K. riferisce che nei su o i casi, il punto di partenza fu-; volle dai follicoli delle fauci, volle da quelli dell'ileo, 3 volle dal cio:>f'O e l volla dai follicoli del retto. Nelle glandole Jiufatrcht> il pun to di partenza del tumore fu 9 volte da quelle del co llo, 9 ùa quelle del rnedias tino, 7 dalle glandole Jinfaliche mesenteriche e r etr opei·itoneali, 2 volle dalle inguinali e 1 volla d!llle ascellali. Due volle fu tratla in partecipazione la g landola liroide simulando cosi un gozzo. In un caso si produsse un enorme roggrinzamenlo e ulceraziono di tut to il lato siuisLro del collo, rli nv1do che, tranne i \'&si, i ne 1·vi e la glandola tiroide, era lutto digtrulto. Il lato sinistl'o della t'ariuge e •l ell'arco palatino era mcorpo ra to nel tumore. In tre i punti di pa 1·tenza furono 19 tonsille; in altri casi sono mala ti gli a ltri apparecchi follicolari avanti le ton._jiJI! 1na in questi casi Ol'dinariamenle non è possibile di stab.lii·c esat tamente ((URli gru ppi ammalarono primierame1rle I u tre casi si trovò una enorme con ulce razione 11egli or gani collo da cui due YOile si ebbeJ'O metaslasi (nell'ulna, tibia , costa e pure nel mesenterio e nello stomaco).
Un coso simi le si distinse percl1è si formarono pure vegelationi e ulce razioni nello s e 1·oto e nell'ileo.
Il del merliaslino orcupa più frefJuentemenl e Jl roglietto pleurale e il pe r ital'dio, node talora la sie r osa t} cumbiala iu untt !:lpessa co tenn a eo11 infìammazioue tìbrinosa orrarrica più rara mente il tessuto polmonare, i bronf'hi stcnos i bronchiale) e la trachea. l't\ramente le ' 'e ne del mediastino sono ingrossate e In un caso anche l'cc;ofago era ingrossato dalle del tumore e ristretto; in un altro caso questo era penetrato att r aver<:o i fo r ami inte rvei·tebrali nel canale vertebrale. un linfosarcomn tlelle glandole mec;onleriche si accompa un idrope chilo<>a. ln tre casi illinfosurroma d ol mesenlerto 1<i estese al ùuodeno e cagionò una icorizzuzione del duodeno. Nello stomaco prer:de radici di preferenza la forrnn infiltrante; quando è attaccala la mucosa si formano zioni 0 cicatrici. In ùue casi segui alla ulccrazJ one nite mo r tale. Anche nello intestino prevale la forma mflltrante. Anche in questo succedono non J'aramente tioni e an che perforazioni. In un caso la infiltrazione il dotto coledoco e fu causa di grave itterizia. Per lo p1u 1 _ tratti primieramenle o secondariamente dilatati, non 1·istrelli come nel cuncro. Un_ caso d1 '-'8t' · coma del retto ebbo per conseguenza la stenos1. ll K. conclude col dire che i linfo:>arcomi, per la loJ'O struttura per la loro sede primaria e per la loro estensiOne, sono da distinguersi dal sarcoma; ciò non ostanle crede si mantenga la denominazio ne di linfosat·coma,_ pot<•hè tla iiUe"ta è bene rappresentato il carattere deletPrlO della mad · d' t · a e CO'"i '"'r ande lallia . La tendenza a.J esten e rst a ts auz · .. che an clre la pronta estirpazione delle malate non pnò da r e la guarigione. Perc1o t l K con-dc. a il linfosa1·coma tanto fJUanto il sn1·coma e<l il carcinoma.
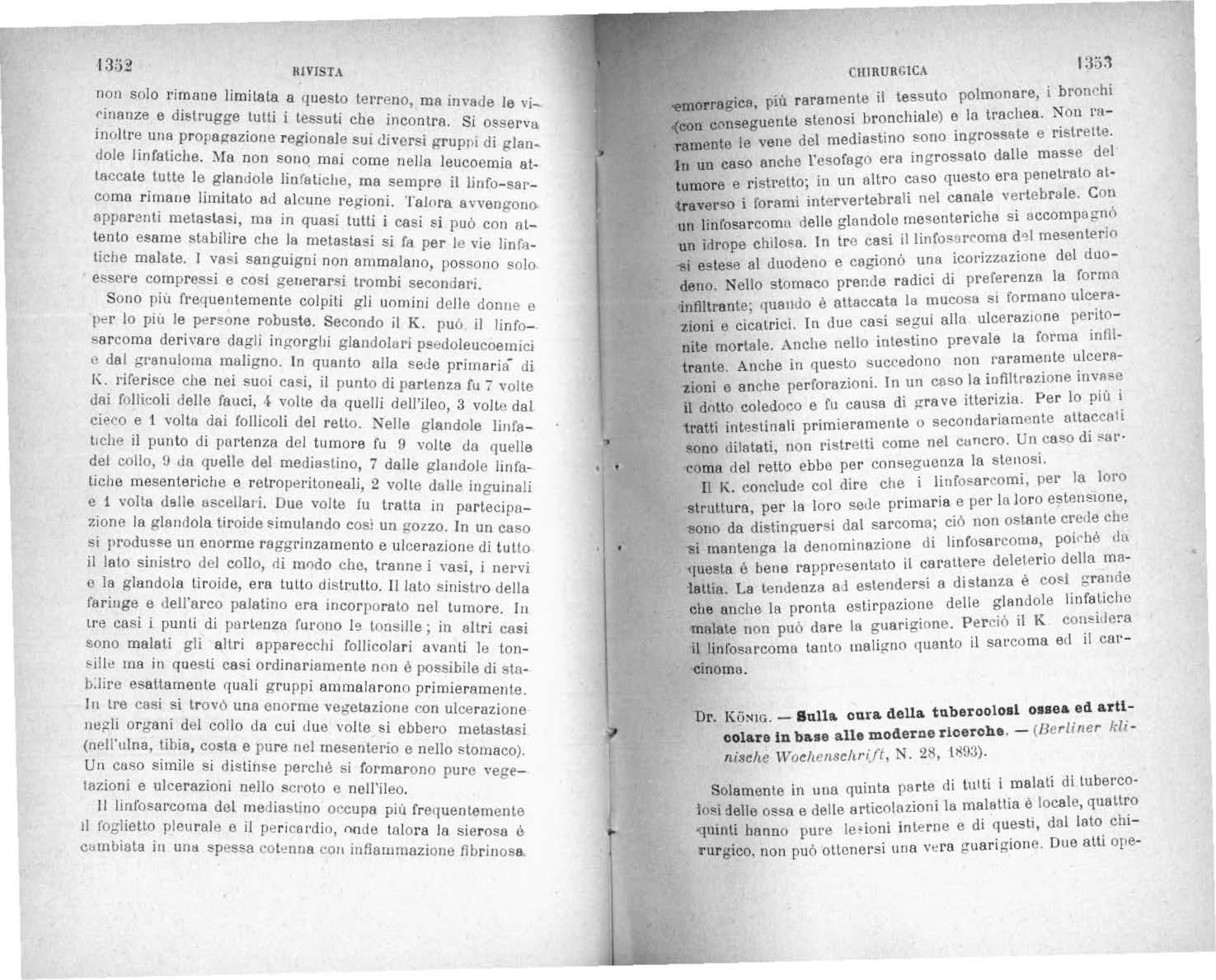
Dr. _ Bullt. ourt. della tuberool osl ossea ed a rtloolt.re in base alle moderne ricerche . - (!Jerli ner klrnisch e Woclt ens chri.fl, N. 2R, L8!l:3).
Solam ente in una quinta pa r te di tulti i malati di Lubercolo"i dell e ossa e delle articolazioni la malattia é locale, 1uinli banno pu1·e le-ioni interne e di quest1, dal Ialo_ ch irurg ico , non può ollenersi una vt' rn Du e altl ope-
CIIII\URGlC A rativi possono ri usci r e efficaci per la gua r igione r adicale locale: io primo luogo l'amputazio.me, che, poi non dà alcuna sicur ezza conLr o una recidiva, in secondo lu ogo la resezione; tutta la a ltre oper azion i sono solamente tentati vi inutili & dolorosi. A questi appartiene in pr imo luogo l'estr azione> parziale di ossa articolari. che il più delle volte é seguita da re· cidiva, inoltre il ras chiam en to del tessuto morboso col cucchiaio. Sono pu r e da prendere in conside r azio n e 1 metodi fisi c i funzionali. coi quali può o ttener;;i uu arr·esto dPl p r ocesso morboso , tanto usati da soli, com e con incorpora ;:ione del jodoformio. Secondo l'uuto re quest'ultimo p r ocesso è piu efficace del primo. Se la della tuùe1·colosi non è ce rta non !>i deve ricorrere resezione, mollo più che Ja ossea non darà all'articolazione il suo fisiologico p o tere funzional e . P e rci ò a cquista s em pre giore importanza 1! traUamento fi sico Nella terapia l'auto r e pr ende di mira la tube r colosi dell'articolazione dell'anca. Se l'ar ticolazio ne ò conteatla, sat•ti estesa e quindi ing es sata per procura1·e all:'arto il n ecessa1·io riposo. Con ques to trattamento un gran numero di ma lati di vengo no sa ni dopo ::-.ei mesi a due anni. Nella clinica di Gottinga negli ultimi l!) eon i su iOO coxili la m età c irca fu posta io usci ta dopo il trattamento ortopedico. L'altr a m età fu sottoposta a t r attamento opeeativo, una piccola parte fu curala con apertura di a scessi, iniezioni di jodofor mio, la più g ran parte con resezioni.
In totale furono reseca te 250 articolazioni d i anca, di cui :lO pe r acuti pro cessi senza tube r colos i; dei r estanti :!20 processi t ubercolosi curati lungamente c ol jodoformio morirono 11 18 per cento.
Nonos tante la piccola mortalità, l'esperi e nza insegna che que s to metod o da solo non P e l jodofor m io sono del t utto adalli tutti i cusi diffusi, gli e le idt·opi tuberall'incontro gli antich i processi con retr azioni n o n conven gon o per questo r imedio, anche perché il joduformio no n si pu ò diffonde r e nell'intet•no dell'ar tico · Jaz.ione . L e in iezioni devono farsi s ola mente 4 - 5 volte; se più
.. lo essere curala it.l . · 1 deve ogg1 t o La tube r colos i artico are .. n e pr ession e e r l. fi s ici come tral.lo ' primo luogo con mezzt ' . poso; me sopralulto dtf.)() In tal une circostanze, co é da tentare col JOdOfu s e- n sces"'i e d idr opi, la cura n ell'antico s ignificato è da c vi3• La resez io ne prt marle tare;
Pre di danno. Con que . . . nella umerose , s o no sem_ ottennero guar tgiOnl n . r llirru due 8001) l d. oo per (tOO neg l u O Il·' rimanf' nle mE>dln '30 e r cento. e "' f •m iJZJOn G medio del p . ·r . ce all'articolazione con Ol . enlo un a. per le !' l t'l e r ls oll't in capsulale le rmtc • le fo rme m • · dì fistol e; queste , come sse sono focola r i adallt nano per lo con la i gravi os!:el la tuber co losi . er ues la diagnosi ò Jmport.anle difficilmen te p lq tubercolosi articolare la dottri n a di cJoc che .arteria nut r itiva. Le arterte viene per embolia ùall.a portenza per lo svilupp':> · . ndisstmH tm d lo nutrili\'e sono di g r u . l . 1e' esse si osse rvano opo l s ' dell' artiCO 8ZIOI ' cl ella tu ùerco o l fi !\Viluppo dell'osso dell'epl tubercolosi ossea non " i. ma: I n u n fanciullo dJ un ann . tono· al conLrarto sJ n anco ra esJS ' l perché ossa no . . !l't dal 3•-uo anno a nt . , . ea ne 1 fanctu , 'luppa la tubercolosi oss . E 'ò c he vale pt>r l ur- svt U'epif1.:::1 c1 collo e a i nuclei ossei ne . r tutte le altre articolal, vale pure pe licolazione del anca , 1 . . delle rrlandole ·iOOJ. · 'nfillraZJOne "' · avt ClH1 1 • e Ln ter·a pin n e r cas l g r ne dopo quesla vJen . 1\'a.nputazJO , , c< n "-iAher ù di ricorrere a . la ca J)Sula. Ta nto lau, - Il' L' <•laztOne co n . l \tre l ·e..Ur paz ione d e ar tc 'd o d"avvtso c le o re Schmt toi•e, q uan to Bar ùenheue ,., ure resecare una parte l'aJ'ticolaz ione d ell' anca, convanoa pl d e ll'a rticola zione deld Ila tuberco ostdel baci no. ll petlcolo e Il a capsule, ne lla Sino Il , ossa ma n e \" a nca no n r isiede ne o d'. t o il piccolo trocanle r e b "'a muco'"a te r vitile e nella orco 11 cl!ts ioni.
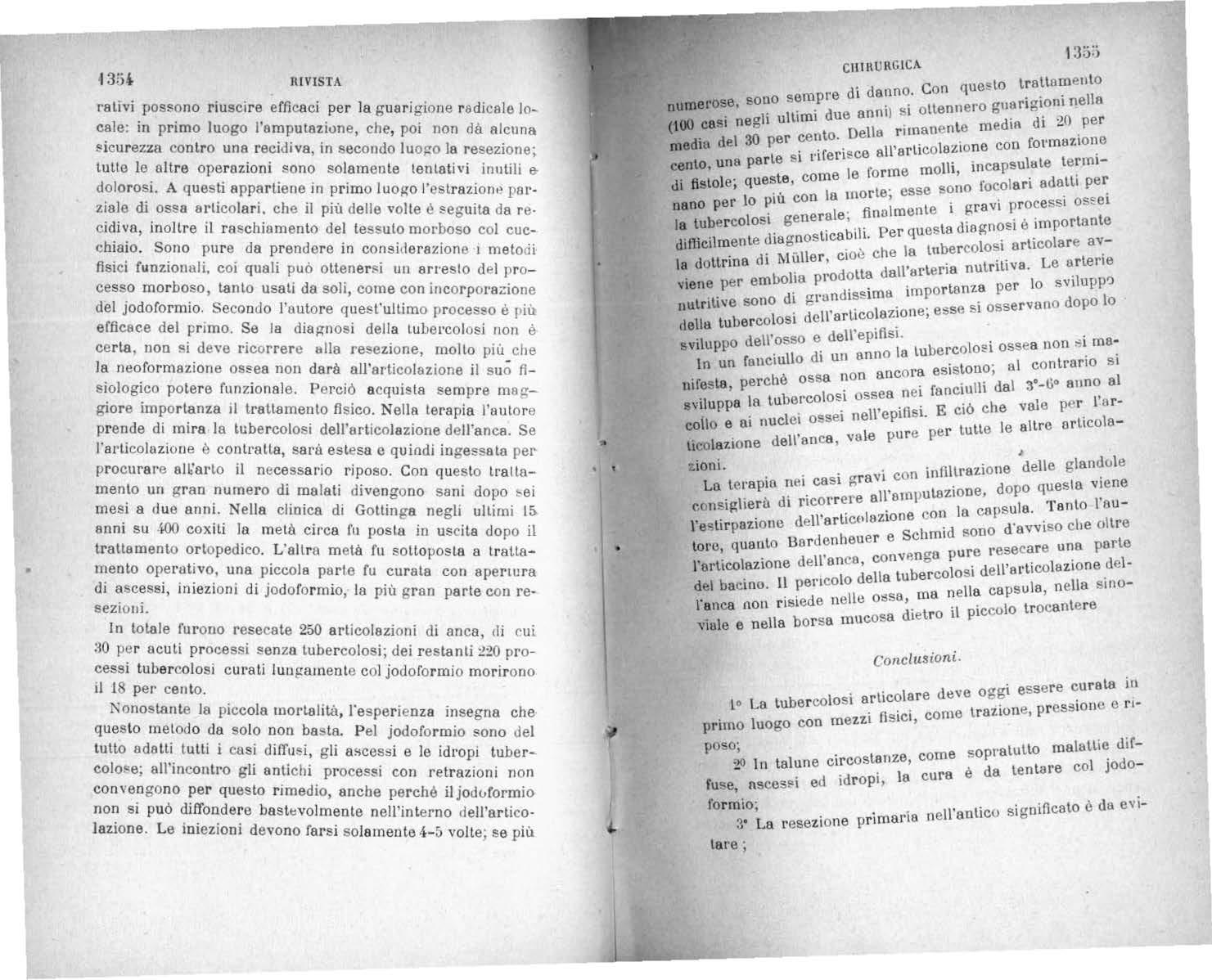
1-• Se non. bastauo, come per esempio, n.elle fìsto .e , n et procesl't gravi ca Reosi, allora nnn r1man e che l'operazion e, ampulazione ed esti r pazione della capsula.

C S.
Kon-rE J uN. - Guarigione dl una frattura del oranlo oon innesto osseo . - (Berliner l.linische W ochenschrift, N. at, t 8!J3).
Un r-iportò una grave frallUI·a del cranio per un colpo th leta_me e fu kaspor1ato all'ospedale non del lutto prtvo dt senst. Aveva una grande ferila nella parte destru del cra n io e precisamente nella ci1·convoluzionc centrale nel distretto dci cent1·i m otori. La ferita P.ra m ollo l'osso spezzato in moltissime parti e p r ofondam ente lllfossato.
L a lesione ossea aveva un a luughezza di 7 centimetr i, e una larghezza di cm. :1 •;, L'autore disinfe t tò Ja ferila ed el>lr a sse tutte le scherrge ossee. o
. Queste e t·aoo a ssa i numeraRe ed in oltre la tavola estPrna dt e r a rlel tutto sepa ra la dall'interna. l piccoli f 1·ammenlt furono disinfellati cui a causa dell' i'<tru - i_nl:e7.ioso, con cui e r a stata prodotta fa f.·rita, fJUindi llnme r ,J 10 una so luziu nt· d i clo ruro ùt sodio e ùopo avere nettato completam ente la ferita, che :;!iunge"a sino alla dunt
1/Ual e Jl"rò intatta, i fra mm e nti fut·ono •nne!"lA.ll nella ferita a guisa di prima della ta vola mlt! rna , quindi gli alt r i ddla tavola este r na, di rnodoché fu colmala. L e parti m o lli furono J•iunite con alcu01 punt1 di sutura.
.ha gra ndi vantaggi, e l'ouLor e ne ha già fJUatll 0 esempt, ro •cbè si evita con esso di lasciare unn grande .apertura OI>Seo n e l cranio, la quale per il paziente e ca usa dt mol te m o lestie ed anche di moHi pericoli .
. guarigione con adesione di tutte le scheggia ossee 6 dt mte r esse g ra nde per l'uomo. Un seco ndo ratto interessante si a l deco r so dAlla guarigione. Questo av - venne senza febbre, senza alle•·azione del polso, ma al quinto giorno si ma nifestarono crampi al lato oppos to dl·l l'ut·po
Comi nciaron o negli estenso ri dell'avambraccio, si 8 tutti i muscoli dell'avambraccio, raggmnsero i muscoli del volto 0 del collo e da ultimo s1 propagarono all e estremila inferior t.
Sici'OIIl e tutto procedeva normalmente, così l'autore non <Ielle ai del'crit ti crampi grande importanza, ma quando al srtttmo g io rno dopo la lesione oc;servò il malato in un a ccesso di for li c•·ampi pri\·o di coscienza, pensò chr nello ferila, nonostante la mancanza di febbre, fosse avvenutn <Jualclt u muta mento. specialmen t e per emorcagia consecutiva.
Percii> l'auto t·e riapri la ferila ed estrasse una ,Jella grandezza di un'unghia di pollicP. Il Kiirle vide allora che i fra mmenti ossei al 7' giomo avevano aderito con le o"sa e preci,samenle per granulazione, come il signo r Barlh ave•a r iferi to al congreS!'O chirurgico in ;\la l'burg.
Estratto il pezzetto osseo, s i pP.rsuase l'autore che nella ferit.a non era avv enu to nulla di anormale, apri pure la dut'll madre che e r a an cora intatta, pe r ' 'edere se sotto di es!'A fossP l!Vvenuto stra\'aso e, poichu non vi O"Servò alcun'al· teraziouc, incise il cervello in co r rts pondenza della piu elevata c it•couvoluzionc c penetro in un focolaio, c he conteneva sostanza cE-rebrale l'pappolata, est ralla la qual P, chi u!';c il fnro e tamp onir con garza al iodorormi o.
Anche dopo tale ope 1·azione i c r ampi non fur ono m odifì r al i. s1 ripeterono per due o tre vollc, quindi avvenne la guarigione.
Il pazi e nte del tutto guarito non ebbe quale !'Ucce;<::;ione morboM nè paresi, diminuzione d'intelligenza e presenta solam e nte in co r rispondenza d e lla lesione un pi ccolo O!'Se;'', coperto da t comu ni integumenti, che tende a chiuder si . c. s.










