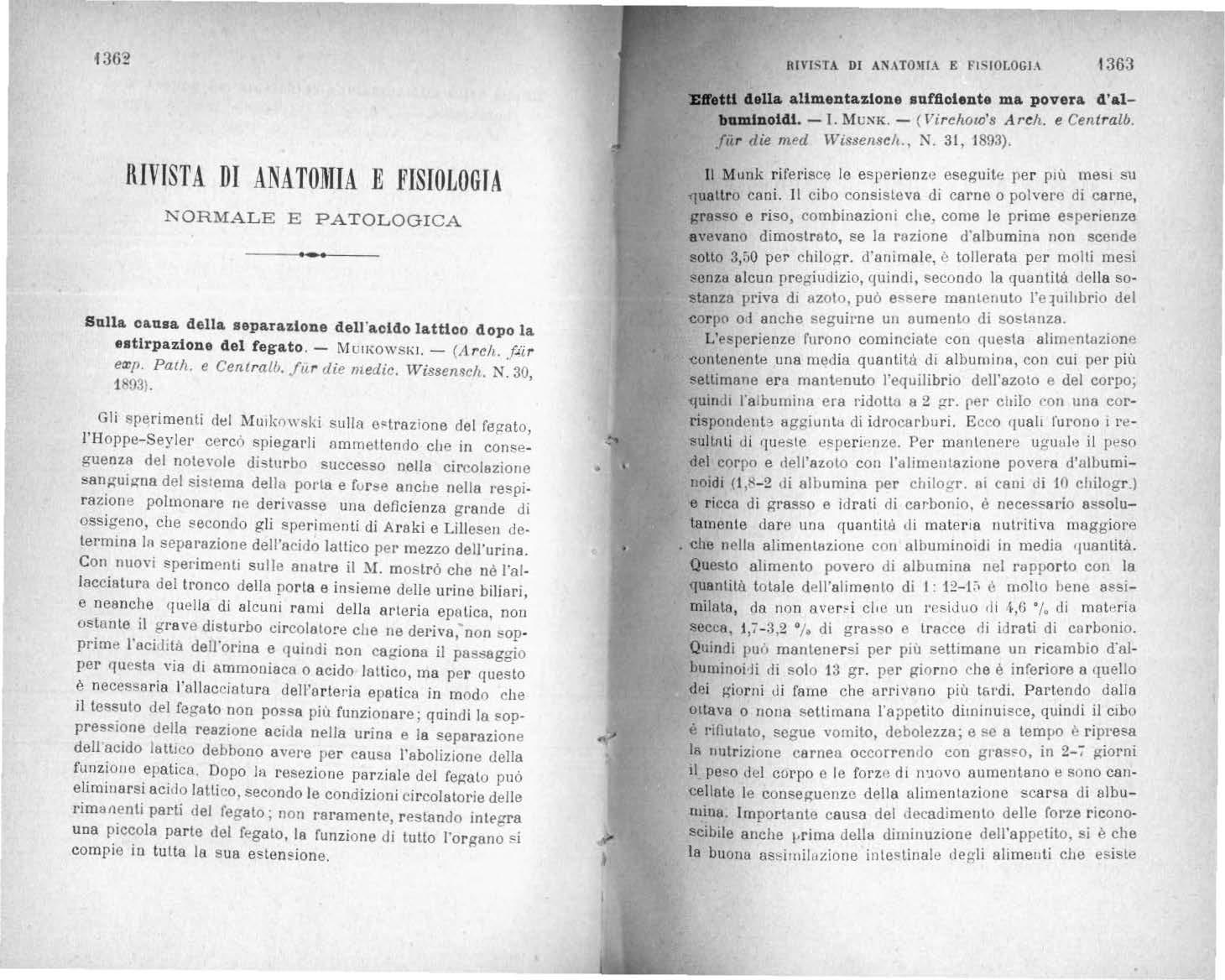
20 minute read
RIVISTA DI ANA E FISIOLOG fA
Kormale E Patologica
Sull a causa d e lla separazione dell 'a c ido lattico dopo l a estirpazione del fegato .- MutKOwst.;t.- (AT'ch. (.J.'iT' ea;p. Path. e Cen.t ra lb. fil T' rlie medie. N: 30 1 '<!)3). '
Advertisement
Gli spe rimenti dtll Mmko\\i>ki sulla ocotrazione del ferrato I'Hoppe-SeyleJ' cerco spiegarli nmmellendo cl1t> in guenza del notevole disturbo nella circolazione san.gOigoa del sistema dellu porta e anche nella respipolmonar·e n e deri ''asse una deficienza grande Ji oss1geno, che E>econdo gli sperimenti di Araki e Lillcsen determina In separazione dell'arido lallico per mezzo dell"urina. Con nuovi spet·imPnti sulle anatre il l\I. m ostrò che né rallacciatura del tl•onco della porta e insieme delle Ul'ine biliari, e quella di alcuni rami della at•leria epatica, non .gra ,·e disturbo ci r col atore clte ne de1•iva, non sop· p n me l act. ilt.à dell'orina e quutdi non CS;!iona il pus:>aggio per dt o acido lattico, ma per questo neces,Arta l allacr1atura dell'a r teria epatica io m odo che ti del fegato non po:;sa più funziooat·e; qoindi la sopdella reazione acttla nella urina e la separazione dell actdo latLwo debbono aver·e per causa l'abolizion e 1 Il" f. . . 'e " .epa.ttcu. la resezione parziale dol può ehmmarst acui o lallt co, secondo le condizioni <:ircolatorie delle riman enti parli del fegato; non raramente, restando integra una pa r te del fegato, la funzione tli tutto l'organo compte to tutta la sua metti della atlmentazlone sufflolente ma povera 4 ' &1bamJnolcU. - l. Mu:-.K. - ( Virclww's A r ch. e Cent ralb. fuT' die mPd WLssenselt., X. 31, 1893).
Il M un k ri ferisce le esperienze eseguile per ptù m est su •Juattro can i. Il cibo consisteva di carne o polvere di carne, gra..,Qo e r iso, combinazioni che, come le prime eQpertenze avevano dimostrato, !"e la ruzi one d'albuminA non scende solto 3,r,o per chilogr. d'animale, è toll e rata per molti mesi a lcun quindi, secondo la quantità della sos ta nza pt•iva di azoto, può e"«ere manlNIUlo re del co r po o i anche segu i!'ne un aumento di sostlmza.
L'E>sper Jeozo furono cominciale con questa alim t'n tozi onP <:oulcn ente una media quantita di albumina, con cui per più settim ane e r a mantenuto l'equilibrio dell'azoto e del corpo; <Juin dt l'albumina era ridoltu a 2 pPt' chilo r·on una corrisp ottdt>lll9 aggiuntu di idt•oca rburi. Ect'O r1ualt l'urano t rt:J i f]Ueste Per manteno t·e il peso dt>l corpo e dell'azoto cou l'alimeutazione povera d'albumiuoidi di alhumina per ot cani di IO chilogr.) e r icca di gt·asso e idrati cii carbonio , è necessario assolutame nte dare una quantità di mater1a nutritiva maggiot·e che n ella alimentazione co11 albuminoidi in media 'fUaolità. Questo altmento po\·ero di albumina nel rapporto con la qua nt itù totale dell'alimento di l : 12- f;, c mollo hene assimila to, da nnn cl>c utt t·esiduo tl i ·;. di mat.,ria secca 1,7 - :3,2 di gra;;«o E> tracce di iJrali di Ctll'bonio. Qumdi puo mantene r si per piu ,.eltimane un ricambio d'albumi nol'Ji di solo 13 gr. per gio r no c·h e é inferiore a r1uello d ei di fame che art•ivano piìt tr.rdi. Partendo dalla o tta va o nona Mllimana l'aj)pelito ditninuisce, quintli il ctbo è t•iftututo, segue vomito, debolezza; e «c a tempo f. ripresa lA uutriz1oue carnea occorrendo con gt'8S"O, in 2-7 giorni tl Pe"O del corpo c le forzr• d 1 n·Jovo aumentano e sono cancell a to le della ulimenlazione scarsa di albulUioa. I mportante causa del decadimento delle forze riconoscibile anche J·rima ùella ditntnuzione dell'appetito, si che la buonu assimil11zione inlcl"tin al e degli altmeuti cito esiste io pr incip io, ;> r es to dopo las· va p r ogr essivamente decadendo, e Sf•Pciolmeule qu e lla del g ra sso, ancora mollo rne11o quello de!.!l'id r ali di carbonio. La ehmu1aztone dell'azoto per rnPzzo delle fecce fiUmenta ti no al doppio di quella delle pmne 6-8 sellimane, quella del da 3- 5 °/o che era alla 8• settimana arriva nella i " tt 16 e "?Ila 10" i 1• a 28 • • ; gli idrocarburi digeribili anche nelle ullrmf' in ragione di •; . "!.e l>olo in ti '> o l un raso 1 - tnu terali nrlle fe cce. E!>senrlo S!"sorbita albumì11o e roc;i poco comincia la perdita dell da pal'ltl corpo e una lenta pr·ogressiva diminuztone del del ct.,.po, henché lu qu a :1tità assoluta della !"O!'tumw nutrili\'8 assimilata !"io anco r a capace di prodwre 80 per· clrilogr. e anche più. P e r questa perdita di e dt SÌ SpiPl?A. Jl decadimento de lle forze, il fJll816 lartlmcnte dtviene minaccioRo quando pe r la m a ncanza del· l'appetito la introd u zio n e e l'asso r bi m ento degli a lime n ti vengo no m agg iormente n soffl'ire. 11 Lu t•bamcn to della d iaeslione e dell o asso t·bimento derivA dalla ùtmlnuzione del la secrezione dei sughi digestivi, come si dimostra nurnet•ic·amenle per la bil<.>, òappo ichè la quantità della materia hilia r e nPIJe rigellole con le fecce é ridotta o •; '/ quanti la originaria; o nde le fecce perdono di colo:e ; fmalmenle a ppariscono quasi acoliche. Quindi la nutrizion e JlO\'e r a quando sutlìciente, offr e troppo poca albumllla alla continuo ricosliluzione del de le glAnrlolnri cbe sempt•e in parte !"i distrugge secreztone. l n uno sperimento il c1me morì imorovvipr·ima clte si fosse r o fenomeni· gravi; In sez10ne, oltre un ecce s"rvo dimagramento, dimostrò r aul· lllollimento e in parte degenerazione gra ssosa del muscolo cDrdiaco
Concludendo con u n a b r eve considera zione sul biso(Tno tli Hlbumina all'uomo, il M. rifiuta comP. int'ondate ed l lt lle le affe r maz ioni sulla poca quantità di al bumi noid i d i cui fa r ebbero uso nume r ose popolazioni special m ente asiatiche che vivono d i vegeta li poveri d i alb um ma. Q uand o a n ciJe il villù gro t·naliot·o dei g iovani come in un solo
Dl ANATOMlA E F ISIOLOGIA
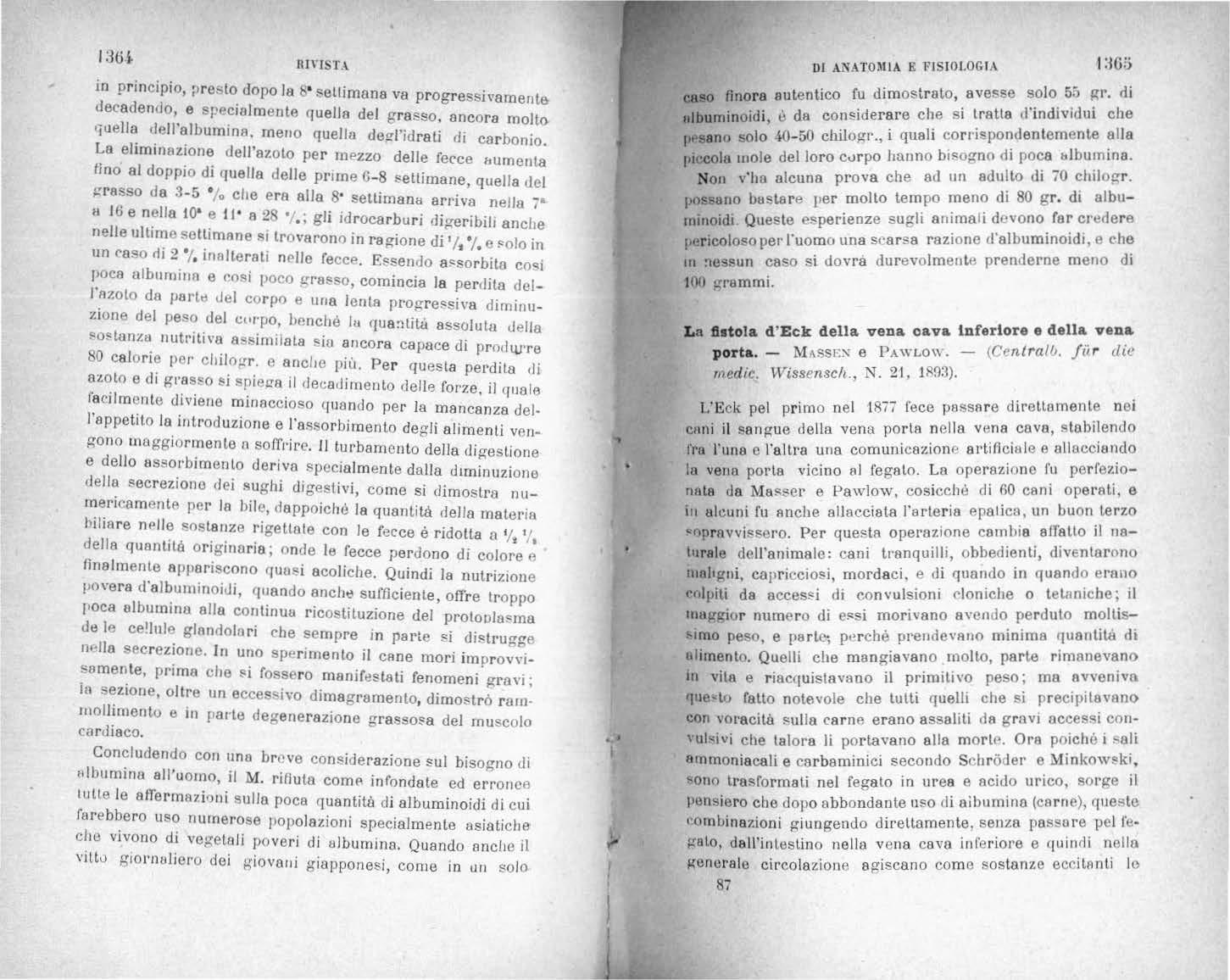
caeo fino ra aute ntico fu d imostr ato, a vesse solo 55 gr d i fllbuminoidi, è da conside rare che si l ralta d'i nd ividu i che pPsano solo 40-50 chilogr·., i quali cor rispond e n temente alla piceoht ruo le del lo r o cvr po hanno bi<>ogno di poca
Non v'h a a lcuna prova che ad un adulto di iO chiloqr . posl'ano bast.a r e per molto tempo meno di 80 g r. di alburninoidt Qu es te esperienze sugli animali devono far crt!der e pt•r ìcol oso per l'uomo una scarsa razio ne d'albuminoidi, e che rn cac:;o s i dovrà durevolmente prenderne meno di Hlo
L a a1tola d 'Eck della. vena cava inferiore e della vena porta. - MASSI': :\ e PAwLO\\. - (Ce ntrali•. fzi r dù: m edi r. l V issensch., N. 2 1, 1R!l3).
I.'Ec k pel primo ne l 18/i fece passa r e di r e ttamente n ei cnni il de lla vena por ta n ella vena cava, Rlabilendo fra l'una c l'allra una comunicaz ionP at·titlci» le e allacciando lu vena porta vic ino 11 1 fega to. La ope r azione fu per fezionata cla M aR><CI' e Pawlow, cosicchè di 60 cani ope r ati, e in alèuni fu anche allacciala l'arte r ia epalica, un buon te r zo "Opravvi sc:;e t'O. P er ques ta operazione cambie affa tto il nalltrale dell'an imalo: cani tranquilli, obbedienti, diventarono nrnlt(.tni, capr icciosi, morda ci. e di quando in quando et·ano rolpiti da acces!"i di convulsioni rloniche o letllniche; il nu me r o di ec:;si morivano aveodo perduto molt ise pa r te; pt> r ché prende\'11.110 m inima quanliUt d i ulirnento. Quelli che ma n giavano molto, parte rimanevano 111 vila e r iacq u istavaoo il primi livo peso; ma avveniva 'JilC'- l tJ fallo notevole che lulli quelli che si pr ecipitavano con vot·acilà ca r ne e r ano assaliti da g ravr conche talor·a li port.avano a lla m o r lf'. Or·a poiche 1 ammoniacali e ca rbaminici secondo Schroder c Minkow!!ki .
"Ono trasfor mati nel fega to in urea e acido urico, so t•gc il pens iero cb e dopo abbondante uso di aìbumina (ca r ne), quec:;le t·omlJinazioni g iu ngendo dit'ellamen le, senza passore pcl redall'inles li no n e lla v e na cava i11 fe riot'e e qu i11rli nella generale circo la zio n e ag iscano come sostanze eccitAnti lo convul:>ioni, sul sistema nervoso centrale. Si polè quindi ùimostrare che mentre i sali carbaminici portati nello stomaco dei can1 in slalo normale riescono inòifferenti, in quelli oper ati destano prima dei fenomeni di irritazione qumcli di paralisi: un rapido correre di qua e di hl, quindi atass ia, d1rticolla a camminare, ecc., sintomi che, secon do la quantità della dose (fino a 0,2 f! r . per chilo!! r. di animale) poRsono essere passeggeri. Di qui nu sce che i carbamati di pe1' sà velenosi sono p e r· via del fegato trasformati in sostanze non velenose e specialmente in urea. Finalm ente, dopo avere stabilito la fistola d'E ck , l'allacciatura uella vr>na porta nel fegato e l'allacciatura dell'arteria epatica, fu estu·pala quanto era possi bila (Sf&- 7/ 8- 11/ 1,) di sostanza «'paLica. Questi animali che vivevano solo da 2 a 6 ore cadevai10 in uno stato di sonnolenza quindi nel coma e morivflno in mozzo alle convulsi<mi. ll ahn e Nencki, i quali eseguirono la parte chimica dell'esame trovaro no nell'urina dei cani C'On la fistola d'Eck, confrontala con quella emessa pl'ima della operazrone, drminuila la secre zione della urea; in quelli con la llslola di E ck e cnn l'allacciatura dell'arteria epati ca o con la estirpazione di g ran parte del fegato, la ((uanlità dell'u r ea era notevolmente abbass ata, al contrario la quanlita dell'a ci do urrco era aumentala ne ll'urina fino al quadruplo anche senza l'allacciaLura dell'arteria epatica e senza la distruzione del fegato; più lardi se l'animale resiste alla operazione, lu elim1na ziono dell'acido urrco di nuovo scende alla quanti tà normale. Cani con la fistola di Eck e l'allacciatura dell'arteria epatica utoslra ron o inoltre un aumento d f'lla separ azione dei snli ammoniacali per l'urina, alcune volte solo relativamente in r apporto a lutto l'azoto o all'azoto della urea, allre \Olle assolutamente e questo quando gli animali sop ravvivevano aliA operazione per più di 20 o r·e. La ellmmazione dei ammoniacali aumenta l'apidamente, l•lstoc·ll è compa ri "t'(JnO 1 primi fenomem nervosi irrrlativi
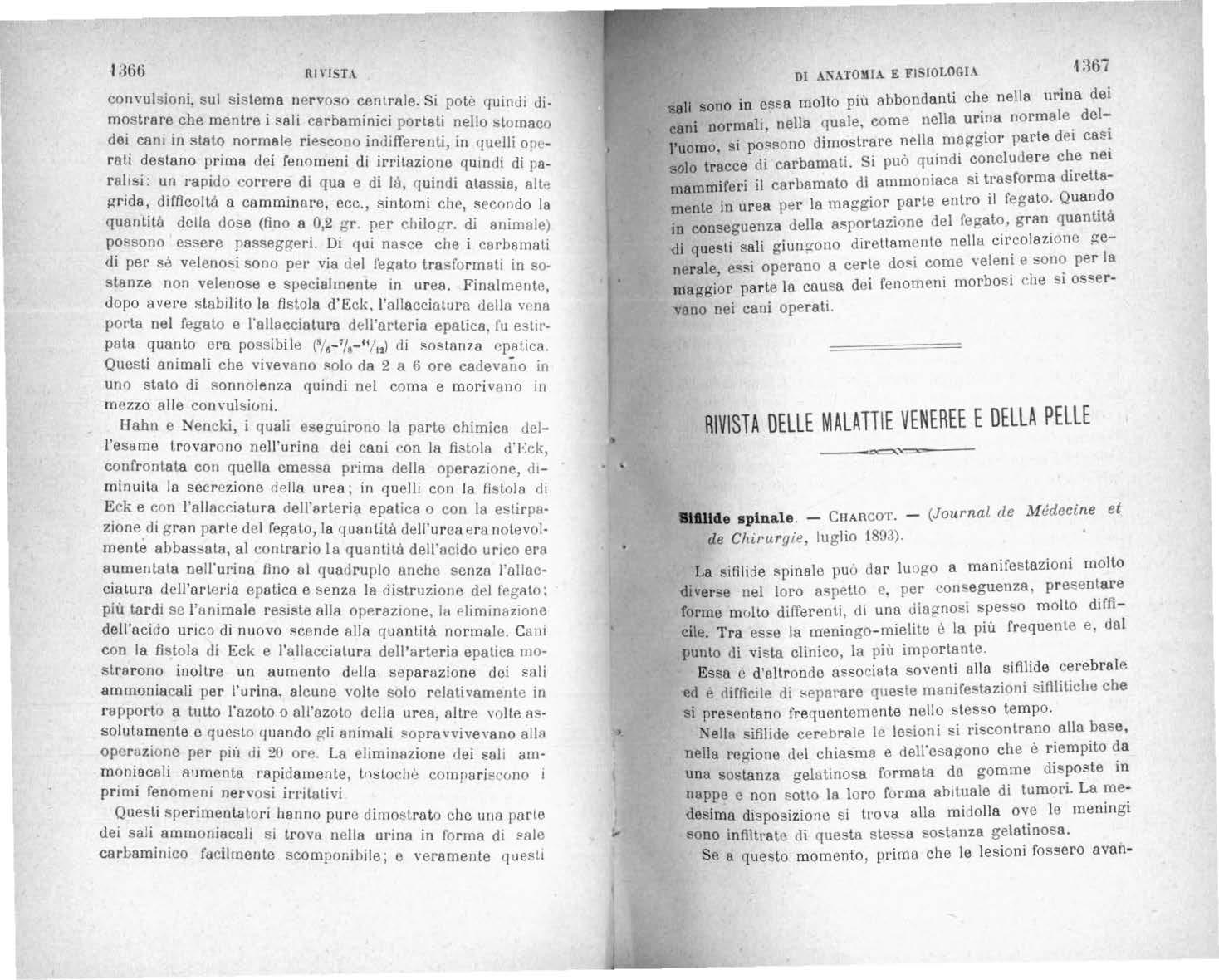
Questi Spe rim en ta tori hanno pure dimof'lrato che UIIB [>arte dei sali ammoniacali si lrova nella urrna in forma dr !'aie carbamiuico fdcilroenle scomponibile; o veramente questi
DI .\.SATOMIA E FISIOLOGI.\ 4:167 sali sono in essa mollo più abbond anti ch_e nella urina dei · rmalr nella quale come nella urrna normale del- csm no , • . . l'uomo, si possono dimoslrar•e nella maggior parte de1 solo tracce di carbamati. Si può quindi concludere ne t mammife r i il carbamalo di ammoniaca si trasforma drrellamente in urea per la maggior parte entro il fegato. 10 conseguenza della asporlazitme del gran_ quanlltà tli questi sali giungono dil'elLameute nella crr_colazrone f!enerale, essi operano a cer te do!'i come velenr e per la maggi or pa rte la cau!;la dei fe nomeni morbosr C"he s r osse r-vano nei cani operati.
Rivista Dellemalattie Veneree Edella Pelle
llllllde •plna l e - CHARCOT. - (Jo urna l de Médeeine et de Chiruryie, luglio 18!:):3).
La sifilide spinale pu ò dar lu ogo a manifestazioni molto di ver e nel IO l'O aspeLto e, per c:onc:eguenza, prec:e ntare fOl'm e mr,llo differenti, di una spes!;O mollo dirficHe. Tra esse la meningo-mielila e la più frequente e, dal punto di visla clinico, la più impo rtante.
Essa e d 'altr onde ac:soriala soven li alla sifilide cer•e brale ed è difficile di queste manifestazioni sifililiche che si presentan o fr equentem e nte nello stesso temp o. sifilide cerebrale le lesioni si riscontrano alla base, nella rnaione del chiasma e dell'esagono che è riempito da un a gelatinosa formala da gomme disposte in n appe e non solto la. l oro forma abrtuale di tumori. La medesima disposizi one si Ll'ova alla midolla ov_e le meningi infillt•ale ùi questa stessa sostanza gelalmosa.
Se a questo momento , pr'ima che le lesioni fossero avan- zale, i sintomi fossero abbastanza nelti per poter diag nosticare rrueste l'intervento terapeutico riu scirebbe utile ma questa diagnosi non è quasi mai fatta a tempo. '
Il quadro sintomatico è press'a poco IJUeUo della mielite tl 'a« vers a, ma c iò c he può far s up po rre la sifllide , si é che la localizzazione si fa l'lpesso sopr a una metà laterale dello midolla e quest& localizzazione speciale $i manife<:ta allo ra per ciò che si chiama la sind r ome di Brown-S érruard vale a di re che vi ha parali s i del membro del Ialo senza disturbo della sensibilita o con un po' d' ip ereste!'ia, allo r ché vi ha anestesia, mn senza paralisi. del lato opposto. falto è assai frerruen te nella clinica <.Iella mielite gommosa, e mollo raro, al con trario, nelle al tre forme. l\Ia a iLI'e loca liz zazioni possono t•iscontt·arsi e rendPre la silunzione molto più oscura: cio accade quando la lesio ne inter essa i fascetti posterior i della midolla, cagionando allora un'imita zion e a ssai grossolana delratassia locomotrice, o le maqse cent rali, ciò che puc'l pt•od u r re l'a trofia muscolare .
I n general e, l'evoluzion e della sifilide spinale si fa in due periodi che uon sono pern sempre distinti; il periodo meningeo ed il per iodo mielitico.
Il prim o ò il più so venli latente, mo :n al c uni malati si osserva un fenomeno c h e ÙO\'I'ebbe richiamare l'attenzione e cioé un dolore rachiahtico pa ra gonabile alla ce falea sifili: th1 pe r la s ua persistenza e per il suo ca rattere notturno. Ec;so r) d'altronde prece d u lo :-;o venti da rruesl'ulti mo. In u n rna ln to de l riparto compa r vE' r o dapprima dolori violenti di te«la pe r un mesi!, e quando si riusci a cal marli, senza ricorrere al joduro potassico, sopraggiunRe r o dolo r i t ra lo spalle, notlur·ni, con irradiazione nelle b r accia ed invas ione pr·ogress Jva della inferiore. È a llo ra che stato neces.sm·io intervenire, ma qua ndo il rnnlato entrò all'ospedale egh presentava gia disturbi o rinari, parali.:;i del membro infer iore clestr·o ed an este s ia ù"l membro inferiore s-inis tro a cc id en ti tutti indi ca nti lcsioui già ava nza le . ' sono identici al d••scrilto; ma gli accidenti compuiono m un'epoca 111o1to variabile della nel caso ùes crr llo essr erano mol l') tur·divi, perch é la da tava
DELLE \I\1•.-\TTIE \'E'\EREE E DELLA PELLE 1369
1ia 16 anni ; ma ess i possono es!;ere molto e presentarsi fiu dal sedicesimo mese. La caus a occasrouale h.a put•e una c erta influen za nella compa1·sa di complicazioni; soventi la localizzazione si fa su lla mrdolla dopo un traumutismo où unti fatica eccessiva; ChArcot ha vPd uto un velociped 1sta tla meuingo·mielite sifllitica una corsa pr olungata nella quale egli si e r a stancato ' ' lOlentemente. Anche le cause morali agiscono nello stes!.'O senso. Un rnalato del r eparto dell'autore, pt•etlisposto alle a/Tezionr nervosa, è stato collo da cefalea dopo disastri finanziari• che l'avevano completamente ro' inalo; malgrad o la persrslenzo della cefalea il suo caratte r e nottu rn o e la sua trasfor mazione in una' rachial gia d i ana loghi ca raller·i, l'attenzione del suo m edico non fu per nulla ri volta sulla probabilità della sitllide; attualmen te egli ò gotlopo:<lo al jodur o potassico ed alle fr izioni m t> r curiali che possono impedire l'evC\Iuzione ulle 11iore de gli accidenti, ma non rim edia r e alle dist ruzioni fa tte.
d. 9)
Charcot rifet•isce pure il caso di una donna r _:. annr, tnfP.ttata dal suo martlo, la quale, un anno dopo, fu colta da cefalea n otturna , poi da ptosi s inistra con diplopia, e qualche tempo dopo da dolor·i rac hia lgici sop rallutlo n otturni . susben presto da pa r alisi spasmodica limitata 8<1 uno dei mem b r i con sind r ome di Br•own -St•quard. MalgraJo la ri union !l di tutti fJuesti sintomi, che c ostituiscono il tipo della meuin go·mieliLe :; ifllitica, questa malata è stata cu r a ta p er mol to tem po per isterismo .
NPlla d ia gno'!i fa d'uopo t ener gran cont<l della SU«'cessione dei fenom eni c e r eb r ali e dei fenomeni rachialgici. Quando a quel momento la paresi con t•igidilà dei membr i, è necessar io affrcltar si ad agi r e, per chc la cura potreb be ancot·a i !!r avi danni. F a d'uopo soggiungere può esse r e poco p r o nunciata e c lte è probubile c he in molti c a si essa passi inavver tita.
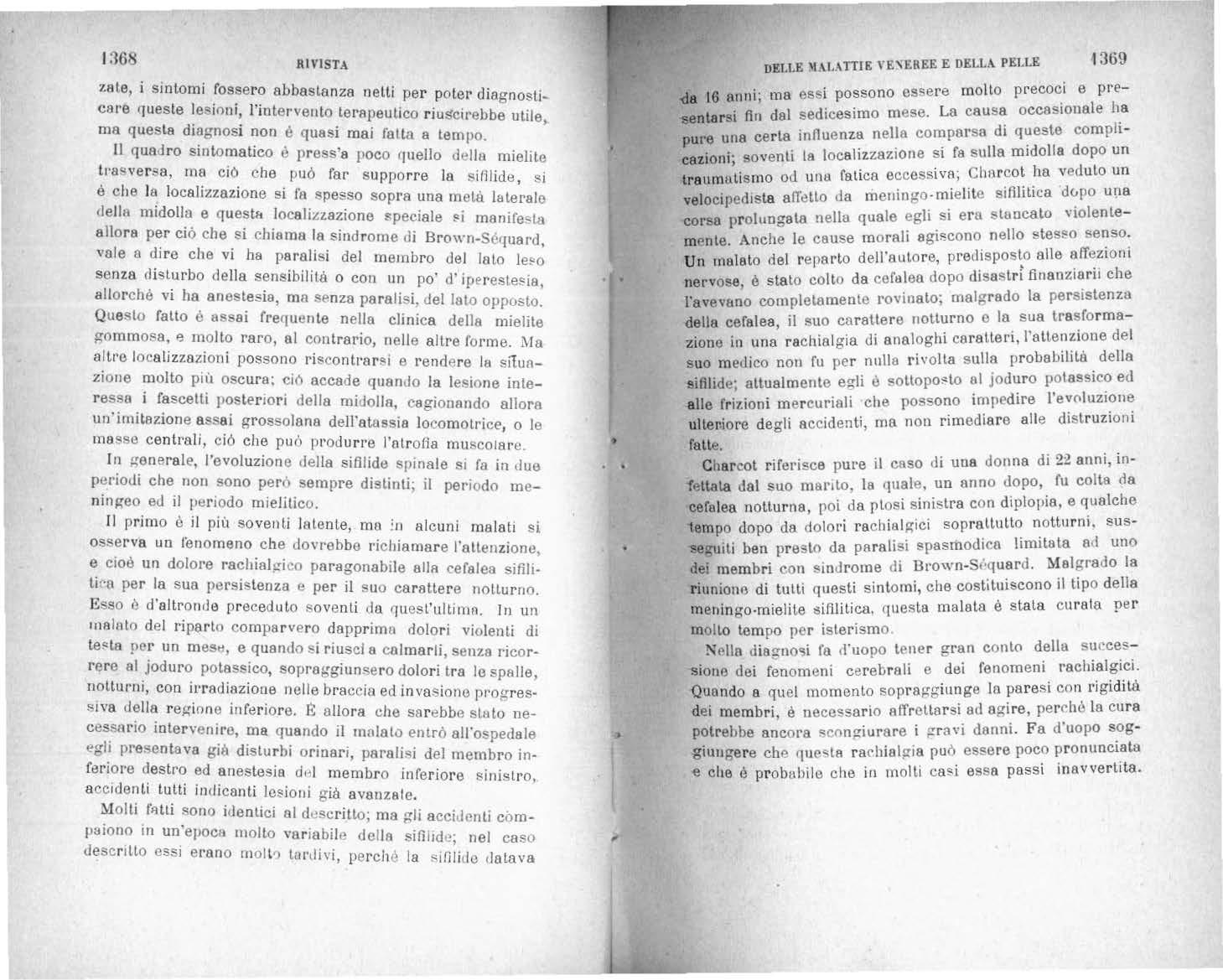
Sulla mlellte gonorroloa, - E. LEYDEN. - (Zeiiscllr. fìtT" kltn .\fed. e Cent,.alb. fii.r die medie. Wi ssenselt 2" J 8fl3). ., ' • "• pensa che la maggior parte delle paraple.,ie urmarr e debbano r!feri1•si alla gono rrea; spesso una locale del processo infiammatorio (mielite della rnJdolla lombare, neurite gonorroica delle estremità inferiori). Riferisce un esempio di mielite gonorroica. Era un uom_o sofferente di gonor·rea, rl quale alla fine di febbraro fu colprto a un tratto da dolori e paralisi delle gambe e della vescrca; estremita inferiori erano completamente zale, flaccrde e poco sensibi!J; il rifl esso patellare mancava ed _esiste va in. parte analgesia e anestesia termica; gli sflnterr della vescrca e del retto erano paralizzati (mielite acuta d?rsale e Quindi comparvero fenomeni di nrte, a crntura, cianosi, dispnea, e al principio di marzo l'esrto letale. La sezione dimostrò una cistite emorragica (gono rroica); flemmone retroperitoneale ; w·ri e parnc1strte pe r ilonite fib r osa secca; broncoP_neumonite; alla midolla do r sale nulla macroscopicamente SI potè rinvenire di anormale; al mic1·oscopio si osservaron o delle fresche cellule granulose e dopo indurimento una leucomielite lomba re (infiltrazione deila pia formazroue dr cellule granulose, rigonfiamento del cJirndro asse ecc); la sostanza grigia era del tullo integra. li \V crede prova r e che la teoria della origine nervosu dello non resiste a una rigorosa c r itica e fonda f{Uesta sua un materiale di 274 casi raccolto per consrolto del Pfle1ger dalla Societa medica di T uringia. Con qu esto alla mano, egli mostra che lo zoslel' non segue r eil di un. ne r vo o di lutto un plesso net•voso; 10 det 2!4 casJ, Jl lerrJtorio cu taneo colpi lo dalla eruzione eJ·a provved u to da diversi plessi nervosi. Ma anche m que1 ca si ir1 c · 1 · Ul a e ruzr oue segue appal'enteme nte
Sall'herpea zoater . - '1'11. v. \YASIBLOWSKr. - Cenzralb .fùr die mecl. WisMn.sch. N. 16, 189'2). .
DELLE MALATTIE YENEREE E DELLA l'ELLE ' la distribuzione eli un determinalo nervo, queslu localizzazione risponde egualmente bene, r;econdo Pflerger, 111 corso delle arterie come dei ner,•i; e possiamo r appresentare! che sile parti della pelle malate siano state trasportati per le vie dei principi irritanti che dete rminano lo formazione delle vesciche. Per ciò che riguarda le a"!lociate nevralgie, esse esistevano solo in r>G ca«i e il \V. le con«idera semplicemente come complicazioni dello E neppure crede che valgano a prova co ntra ria i pochr in cui la sezione cadaverica risconlr•ò malattie dei nervr e dt>r ma é inclinato a credere non essere que!'te gli eflelli di una unica causa morbosa o che alti'CI _mfll athe uYessero pr eceJentemente cagionato queste allerazroru nervoc:;e,
Il W. col P fleiger lo zoster come una malatliu infettiva acuta , e fonda questa opinione sulla comparsa molle voHP. osser vata della malattia a fol'ma epidemica, poi l'r·equente (l5l volte) periodo p rodromico, sul decorso spesso (in 0:3 casi) accompagnato da febbre, e sulla quasi •:ostan te immunilA di chi ne fu una volla colpilo. È conforta ta questa opinione dalla dimostrazione falla da Pfl eiger di pt•otozoi nelle cellule epiteli ali, che però non sono stale trovate da tutti gli osservatori o sono riguardate come degenerazioni epitelialt. Sul rondamento di alcune pr oprie osservazioni il W . dtce ùi potere confermare J'afl'ermazione del
RIVISTA DI TERAPEUTlCA
L egge genera.le dell'lpodermla . - Ipotena lone arterloaa. e tr&Ullfaa lontlpodermlohe . - CtJtRON. - {Ga.uelle d es HOpiiau ::c, N. 7 1893).
l n questi ultimi tempi furono iniettati sotto la pelle, a scopo terap eutico. liquidi d i composizione mollo dissimile. meno erano le idee teoriche che hanno condotto cioscuno degli sperimentatori a r icorrer e ad una soluzione speciale Ciascuno ù i essi ne attendeva effetti specifici, risultati dipendenti dalla natur·a del liquido adopPralo. Ora, basta legger e le comunicazioni di Gimbe r L. P r égaldino, Browu-St'•guard, Mairet, Onimus, Richet, Bertio, P icq ecc. p er Psser e colpili d al rauo che in luogo di agi r e ciascu no i o 111111 man iera differ·ente, questi liquidi cosi vurii (olio al creosoto, cloruro d1 sot110, succo testicola r e, sostanza midollare o re r l}bra le, sangue o sier'o di sa ngue animali) producono invnr labilmeute gli stessi effetti sub1eltivi.

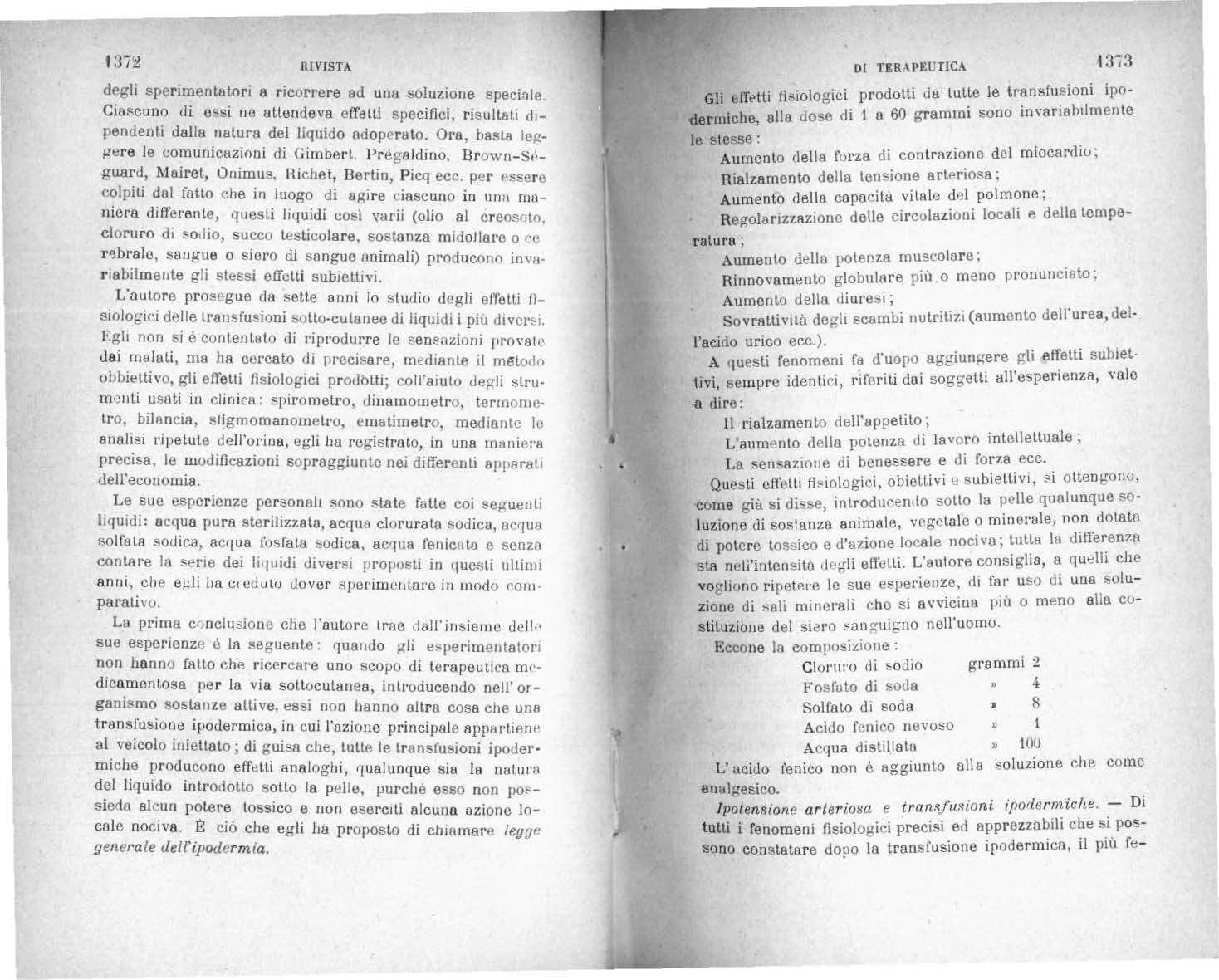
L 'autore prosegue da selle anni lo slwlio degli e/Tetti nsiologici delle lransfusioni solto-cutanee di liquidi i piu drverH Egh non si è contentalo di riprodurre le sensazioni provati' da i mlllali, ma ha ccl'cato cii preci!'tare, mediante il mstotlo ohbiellivo, gli effe tti flsiologrci proclòlti; coll'aiuto de:;cli strumenti usati in clin ica: spit'ometro, dinamometro, termometro, bilancia, sllgmomanomelro, ematimelro, mediante lo analisi t'ipelute dell'ol'ina , egli ha registrato, in una rnaniera p r ecisa, le modificazioni s opraggiunte nei differenti apparati dell'economia.
Le sue esperienze personah sono state falle coi seguenti liquidi: acqua pu r a sterilizzata, acqua clorur ata sadica, acquA l>Olfala sodica, ac11ua fosfala sodica, 8C'JII8 fenicota e senzA contare la ser ie dei li'Juidi diversi propo!>li in quesll ultinu che egli ha cteduLo clover spel'imenlare in modo con1· parati\'O.
La prima conclusione che l'autore tr ae dall'insieme dell" sue esperienze ò la seguente: quando non h a nno ratto che rice r c al'e uno scopo di terapeutira mc•dica menLosa pe r la via sottocutanea, introducendo nell'organismo sostanze allive. essi no n hanno altra cosa che una i poder·mica, in cui l'azione p ri ncipale apptu'tienP al veicolo inieltalo; di guisa che, tutte le transfusioni ipodermiche producono efft:Ui analoghi, 'f ualunque sia la natur'l'l del liquido introdotto soLto la pelle, purchè esso non s ieria alcun potere tossico e no n eserc1ti a lcu oa azione loc ale nociva . E ciò che egli ha proposto di chiamare generale dell'ipodermia.
Gli effet ti lìswlogici prodotti da tutte le tr•ansfusioni ipo1iermi che, alla dose di 1 a 60 g r ammi sono invariabrlmenle le s le!>se:
Aumento della forza di con t razione del miocardio; Rialza mento della tensione arte riosa;
Aumen to della capacita vitale dd polmone;
Regolarizzazione delle ci rcolazioni locali e della temperatura ; Aumento de lla potenza muscolare;
Ri nnovamento globulare piu o meno pronunciato; Aumento della diuresi;
Sov r allivilà degh scambi nulritizi (aum ento dell'urea, dell'acido urico ecc.).
A questi fenomeni fa d'uopo aggiungere effetti subrel· tivi, identici, riferiti d a i soggetti all'esper ienza, vale a dire:
Il rialzamento clell'appetito;
L'aumento della potenza di lavoro intellettuale;
L a l>ensazioue di benessere e di forza ecc.
Questi e/Tetti fh·iologic.i, obietLivi c subietlivi, ottengono, come già si disse, introducendo sotto la pl'IIC qualunque soluzio ne ùi animale, ve>getale o minerale, non dotala di pote r e tossico e d'ai' ione loca le nociva; tutta lo s ta nclì'inlensilà dPgli effetti. L'autore consiglia, a fJu elh che vog lio no ripetere le sue esperienze, di fa1· uso di una soluzi o ne di :--ali miner'ali che si avvicina p1ù o meno a lla costituzi one del si aro !:'an !rUig no nell'uomo.
Eccon e In composizione:
Cloruro eli !iodio
Fosfulo di soda
Solrato d1 soda
Acido fenico nevoso
Arr1ua distillala g r•ammi 2 4 8 » i , tuo
L' uciùo fenico non è aggiunto alla soluzione che come enlllgesico. .
Ip ot ensione ar te r iosa e trans.fusioni iporle r m.iche. - D1 tulli i fenomeni fisiologi c i precisi ed apprezzabili elle si poss ono constata r e dopo la t r ansfusione ipodermica, il più fe -
Di Triiapeutica
dele, il più significativo, il più quello che l'autore propone di adottare come criterio sperimentale, vale n dire la modificazione subita dalla pressione arteriosa, misurata alla radiale, ruediante lo sfìgmom anometro.
La tra sfusione ipodermica produce sempre un'elevazione della pressione arte1•iosa. Il grado di questa elevaz ione, il tempo piu o meno lungo durante il quale la tensione resta sopraelevata, la l'orma generaiP della curva nei casi in cui si pratica una serie di esper ienze regQJari sul rnl?ùesimo so::gPllo, variano: 1° secondo la dose adoperala; 2- secondo la composiz•ono della soluzionll usata; 3' secondo lo della pressione arleri of'a nel momento in cui la trasfusione è pr·aticata.
Nella mag6ior parte dei casi, dosi di 5 a 10 grammi df'tlo soluzione sovradella (siero arliflciale) producono di primo acchito un aumento di pr•essione variante da l a :J o { centig•·ammi di mercurio.
A dose eguale, il siero artificiale protluce etletti più pronunciflli e più durevoli che le soluzioni saline parziali precedentemente esperimentale dall'autore.
Le soluzioni di sali minerali producono effetti più a ccentuati e piu durevoli delle soluzioni d• sostanze vegetali od animali.
Più la tensione è debole nel momento dell'esperienza, pil'L l'a>'censioue é brusca.
Fin dalla prima tran!'lfusione, la tensione arteriosa si mantiene per tre o quallro giorni, talvolta più, ad un grado più elevato che prima della lra nsfusione, n Pi ::Joggetti che non sono tr oppo indeboliti. Essa si allbassR dopo un gio rno od anch e dopo quolche ora nei so!!gell• in cui l'adinamia è proConda.
So s i confronta l'azione c.Ji 5 g t•ammi di siero artifìciala con l'azione di una d ose di 40 centigrammi di c affeina pPr un F(rammo d'acqua iniettati successivamente, a ventiquattro o re di sott.o la pello dello s tesso individuo. f'i ronslata: 1• elle il rialzamento della ten!;'ione arteriosa è più conside revole di un o 2 col sio r o; 2" che esso è più du r evole, perché, invece di per f'istere ùue or e, ciò che è la media de lla caffeina. esso persiste da ventiquattro ore a due o tre giorni.
L'autore soggiunge che, nel corso delle sue ricerche, egli è stato colpito dall'estrema frequenza dello stato di abbAs· t!amento permanente della pressione arteriosa od ipotensione.
L'ipolensione non esiste soltanto nelle malattie del cuore non com pensate, nelle emorragie nell'adinamja delle grandi piressie infettive, nella lisi polmonare. Essa eserc ita un'Azione capitale nello shock, nella perilonite, nelle pelviperitonili acute o rl'oniche, nella nevrastenia, negli spos,ati di qualunque specie per sovraffaticamento. per debolezza congenita, per malattie croniche, per vecchia•a ed infine nPI· l'a nemia .
L'auto r e ha pottJLO formulare la correlaz ione fino aù ora sconosciuta fra il riassorbimento degli e ssudati peritoneali o pleurali ed il rialzam enlo della tensione urloriosa.
Stabilire questa lista di malatt ie a ipott'lnsione, sa t•ebbe basare su dali scientifici precisi l'indicazione tc ..apeutica delle ipodermiche.
L'auto re vorrebbe inOne richiam are più particolarmente l' attenzione sopra due delle principali applicazioni terapeu· tiche di queste lr11nsfusioni.
Quan do s i sottopone un anemico, un ipoglobulico ad una serie di transfu sioni ipodet·miche, senza modificare il suo regime, ser:za dargli altro medicamonto, «i constala, dopo un tem po relativamente br·eve, un vero rinnovam ento !!lobulare nettamente caratterizzalo: l o da un aumento del numero dei globuli rossi ; 2• dall'aumento dell'emoglobino; 3• dal r itorno dei globuli alle loro dimensioni fisiolos;:iche.
U n'a ltra a pplicazione lerapeutica ò quella che l'autor·e ha rilevato per il primo nel 1885: si t1·atta di essudati pai·aruelrici e per•me lrilici. Essi si riassorbono •:on una n otevole rapidità !>Otto l' innuenm dell' impulsione impressa a tutte le funzioni dell'economia con le lra nsfus ioni ipoJct·micl•e, impulsione che s i misura facilmente " matematicamente con l'el eYazione della pressione a r teriosa.
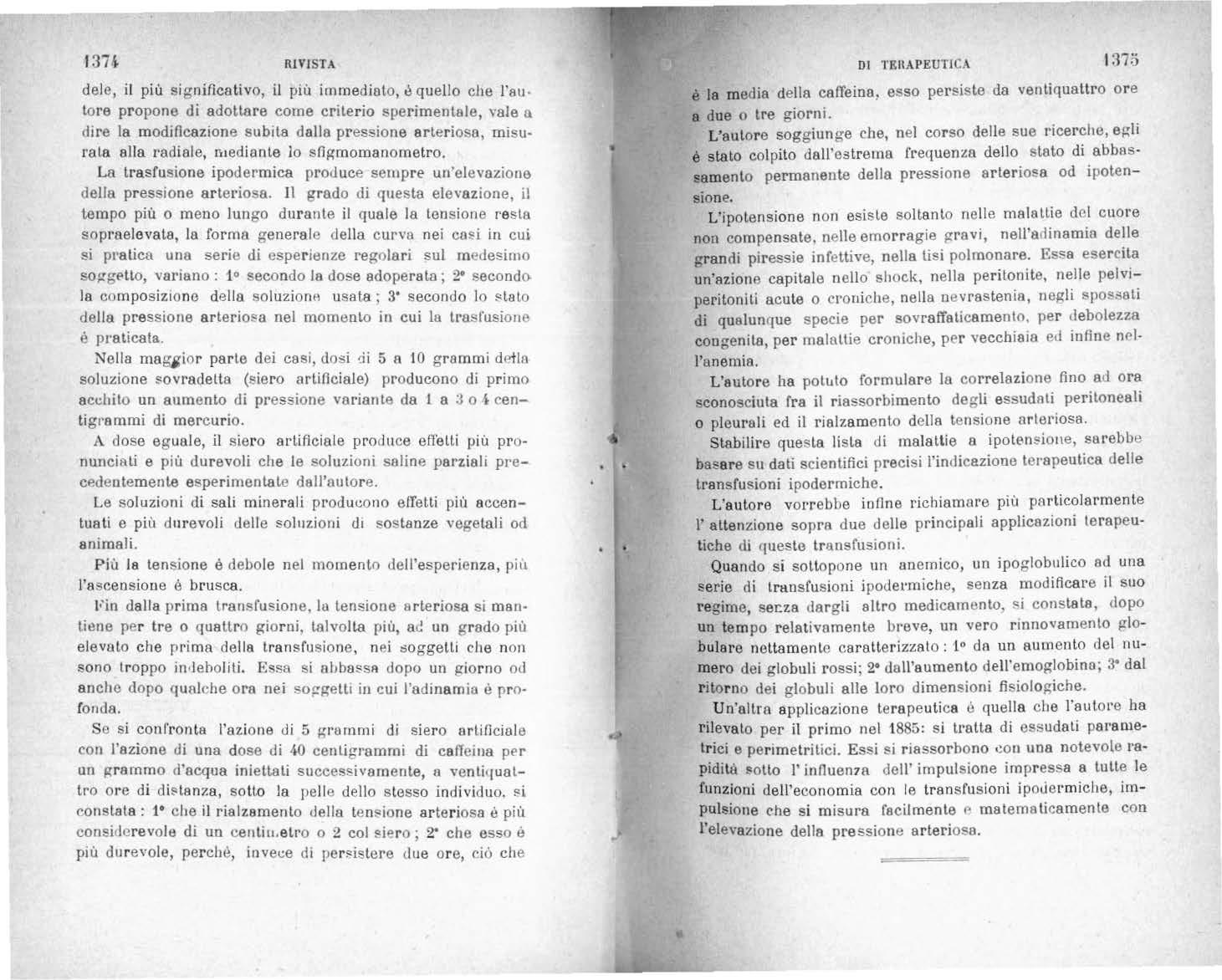
R1VlS1'A n ' IGIENE 1377
n1 • . W oLFF. - Rapp orto fra malatl e morti p e r tuberooloel - (Berlin e r /(/tnische N. 23).










