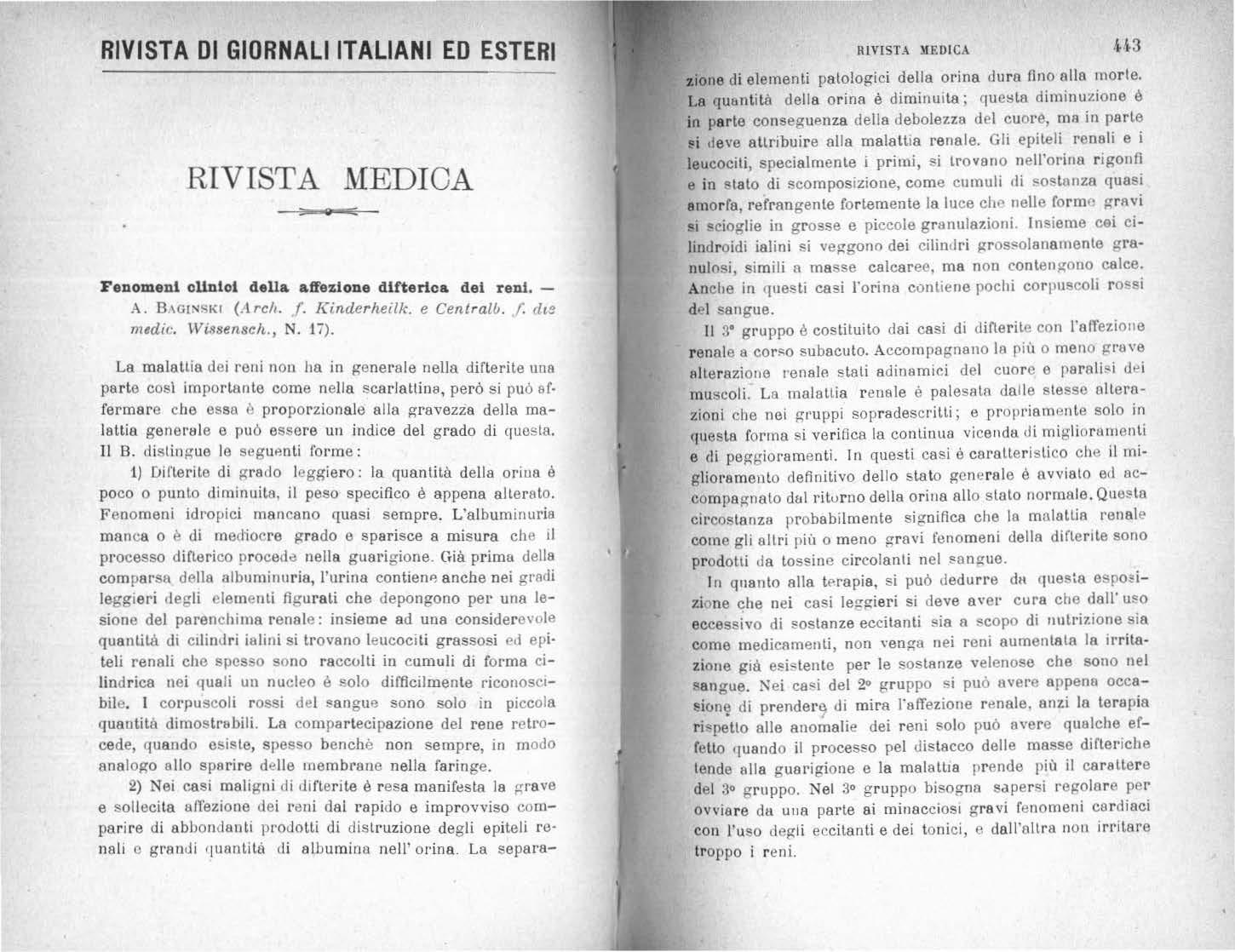
12 minute read
RIVISTA MEDI CA
Fenomeni oUntol della affezione difterica del rent. -
A. B \G!N'>KI (.l rch. f. J(inderheilk. e Centrali;. (. (ite medie. N. 17).
Advertisement
La malallia dei l'an i non ha in generale nella dirterite una parte cosl im portante come nella sca rlaltina, però si può af· fermare elle essa è pro po i•zionale alla gravezza della malattia e può essere un indice del grado di questa. Il B. distingue le fo1·me:
1) Difterite di gratlo leggiero: la quantità della oriua é poco o punto diminuita , il peso specifico é appena alterato. Fenomeni id1•opici mancano quasi sempre. L'al buminuria man ca o è di mediocre g ra do e sparisce a misura che d processo difter ico pr oceda nella guarigione. Già prima della comparstl della albumiuu ria, l'urina anche n ei gr·adi leggieri degli cle menti figu ra Li che depongono pe1• una lesione del parenchima renate: insiem e a d una consider e,ule quanlilà di c•lindri ialini si trovano leucoci ti g r assosi Pd epi· teli renali che spesso sono raccolti in cumuli di for·ma cili nd ri ca nei quali un nucleo è !'Olo difficilmen te riconoscibile. l corpuscoli r ossi de l l>angue sono solo io piccola qu a ntità dimostrabili. La compa rtecipazione del rene J'ctl·ocede, quando esiste, spesqo b e nchè non sempre, in modo analogo allo spari re dt!lle membrane nella faringe .
2) Nei casi maligni di drflerit.e é r esa manifesta la {!rave e solleci ta affezione dei rdni dai rapido e improvviso comparire di abbondanti peotloLLi di dist ruzione degli epiteli re· nali c grandi quantita di albumina nell' orina. La separa- zio ne di elementi patologici della orina du ra lì no alla morte. La della o rina é diminuila; questa é in par te conseguPnza della debolezza del cuore, m11 in pa r te l'i lieve attribuire alla m a lallia renate. Gli epiteli renali e i leucocili, specialmente i primi, si trovano nell'o•·ina r igonfi e in stato di scomposizione, come cumuli di quasi amorfa, refrangenle fo r temente la luce chP nelle :;:ravi si !>cioglie in grosse e piccole Insieme cei ciJiodroidi ialini si dei cilindri gros!'olanamenle granul osi, simili n masse calcaree, ma non contenttono calce. An che in I{Uesli casi l'orina contiene pochi corpuscoli r o"si d r·] sangue.
11 a• gruppo é costituilo dai ca si di difte r ite con l'affezione r enate a corl>O subacuto. Accompagnano la più o meno alterazione renate stati adinamici del cuor e e paralil>i dt'i m us coli. La malallia r enale é palesatA dalle stesse al terazioni che nei g r·uppi sopra descritli; e prop r•iamPnte solo in qu esta forma si verifica la continua vicendtt. di miglio r on1enti e eli peggiorame nti. 1n questi casi é caralleri s lico c hP il miglior·amento defini tivo dello sta to gene ral e é avvialo ed accompa gnalo dul rituruo della o rina a llo slalo norma le . Quos la cu·coslanza probabilmente significa che la mnlatlia ronale> come gli altri più o m eno g r avi feno m eni dit'lerJLe sono prodo tti da tossinc circolanti nel sangue.
1n quanto alla terapi a, si può dedu rr e d questa G!SPO"izion e che nei casi leggier i si Jeve a,·et• cura che dall'uso eccessivo di sostanze eccilanli sia a !'<COpo di uult•izione sia come medicamenti, n on ,·enga nei reni aumentala la irrita· zioue gu:i esi,.Lente per le sostanze velenose che sono nel sangue. Nei caqi del 20 gruppo -.i può ave1·e appena occadi prender e di m ira l'affezione renate, anzi la terapia r iqpello alle anomalie dei r eni solo può avere qualche effetto quando il pr ocesso pel dis tacco delle masse difter1che tende alla guat•igione e la malall1a pr ende più il caratter e del 3o g r uppo. Nel 3o g ru ppo bisogna saperl'li regolare pl'r ovviare da uua pa r te ai minacciosr g ravi feno meni cardiaci con l'uso deg li eccilan li e dei tonici, e dall'altra nou ir1•iLare tr oppo ì r eni.
MED
Deve in proibirsi la alimentazione carnea, eJ a nche Il b rodo troppo concen tralo il B. lo ritiene dir·eltamenle nocivo . Oltr-e a bbondante introd uzione di la tte, il B. ra ccomanda l'uso di uova, il peptone di Denayer, prl'par ato spacciato in commercio come sugo di carne, ed moltre mod e rate quantità di alco olici ma sch erate n el !alle o in decolli N e lla a z ione ca rd iaca con diminuila diuresi si è dimoslrnta utile 1!1 tliurt>tino allo di 0. 20, 0.50, e l g r·. 2-1 volle a l gio r no aller·nala con dosi di benzoato sodico e caffeina di 0.10 - 0.20. Terminata l'albuminuria <-i deve por r e mano alla dieta forlementeco r roboranle .
Nuovo metodo per la. determina zion e del n u m er o assoluto delle s i ngole spec ie dl leu oooltl . - ELZHOLz( Wie ner klin. W oc hens. e Cent r albl. fii r dic m ed. Wis-
N. i-H.
Nell'apparecchio di miscltiarnento d el n umeralo r e ùei globuli del sangue, di T homa- Zeis, b introdotto con la pipetta il da fino alla linea i" o alla 1/ ,, quinni è a gg iu nta fino alla part e media de ll'app a r ecchio una so luzione d i glicerina ed Posina , ed ambedue i liquidi souo fr·a lor o mescuotendoli per 3 o 4 minuti La composizione della mescolan za di gl icerina ed eosina è la seguen te: di ::;oluzi one acquosa al 2 p. l OOdi Posina 7,00, glice r ina45,0; acqua stillata 55,0. F atta la miscela si con la pipetta uua soluzione di violetto di genziana fino al segno H. QuP"la sol uzione si co m pone cosi: a 15 cm. di acqua si aggiun gono 5 a 6 gocce d• una soluzione acquosa concentrala di viol ello d i genziana e una goccia di al co le assoluto. Dopo nuovo timento, la miscel a ò la scia ta Hlcuni minuti nell'apparecchio di misch iamento ed è quindi esaminata nella camera di Zeis. L e cellule poli nucleari neutrollla mostrano in questi preparati un tono di colo r e violetto, le cellule sono di c-olore r osso violetto con p r evalenza di ro sso, i linfociti e le cellule di transizi on e ha nno granulAzioni turchine. Un piccolo numero di cellule rimangono sema colore e sono quelle che anche coi metodi dr Ehrlich si colo ri scono difficilmente. I corpuscol i rolls i del sangue sono dis tr•ulli. Scopo de l m etodo è ap punto quello di i cor puscoli r ossi e conservare le cellule scolorate, il quale scnpo, secondo E lz ho lz , s1 raggiunge com pl e tam ente solo col suo metodo. L'Eizho lz rav vis a in ques to un altro vantaggio ed che nella m escolanza del sa ng ue second o la sua indica1.ione, la ripartizione dei leu cociti i• più r egolare che nel m e todo Thoma-Z eiss.
JDaueua. del m a..a.ggio sul rloa.mblo ma.terla.le .
B. BENDI X. - (Zeilsch. jilr• klin. M ecl . e Cent ra lul. ftl. r die med. W issensch., N. 43).
Le r·icerche falle fin o ra n tJn avendo condotto a risultati sicur i i n par te p er chè non furono abbastanza osservate le cautele necessarie neg li sperim enti sul t•icambio m a tet•iale, il Bendix é tor nato s u questo studio. Sottopose due adulti e un fanciullo a costante (carne, pane, riso, 'bur ro, zucchet•o e rispettivam ente latte, pane, ciocco lato), il cui contenuto in azo to era ogni volla dete r·minato con l'anali-.i e, dopo che e rasi ra ggiunta la uniformit à nella separazione de ll' azo to,. trattati col m a ssaggio per 5/, d' o r<J , tr·e o quattro g1or m dt seguito, un peri odo successivo chiudeva la serie degh sperim e nti. N el periodo del massaggio aumentava la quantità della o rina in confronto col peri odo an tecedentE< di ci rca 10-t.iO p. 100 la dell'azoto per l' orina di 10- 15 p 100. X el p er iodo poste ri o r e la quanti là d ell'or ina o dell' a zo to non dimi nuiv a no subito, occorr evano da 2 a 5 gio rni per ché di nuovo r·a g giu n gessero il valore del periodo auteriore a quello del ma ssaggio; perciò il massa ggio ha ancora una r ilevante azione consecutiva ch e dura tanto più brev e te mpo q u a nto pi ù i periodi del massaggio sono inle rpolati, e lanlo più a lu n go quanto più sono giovani le persone soggette all o sperim tm to; n el fanc iull o di 2 '/ 1 a nni n on cessò completame nte s e no n do po o lto giorni. Deves i rtuind i amm ettere col Bum, ch.e con le manipolazion i de l massaf{g io sono dai muscoli tra spor tate nella ci r co lazion e generale delle materie che agiscono come diur etiche e aumentan o la scomposizion e de g li a lbuminoidi.
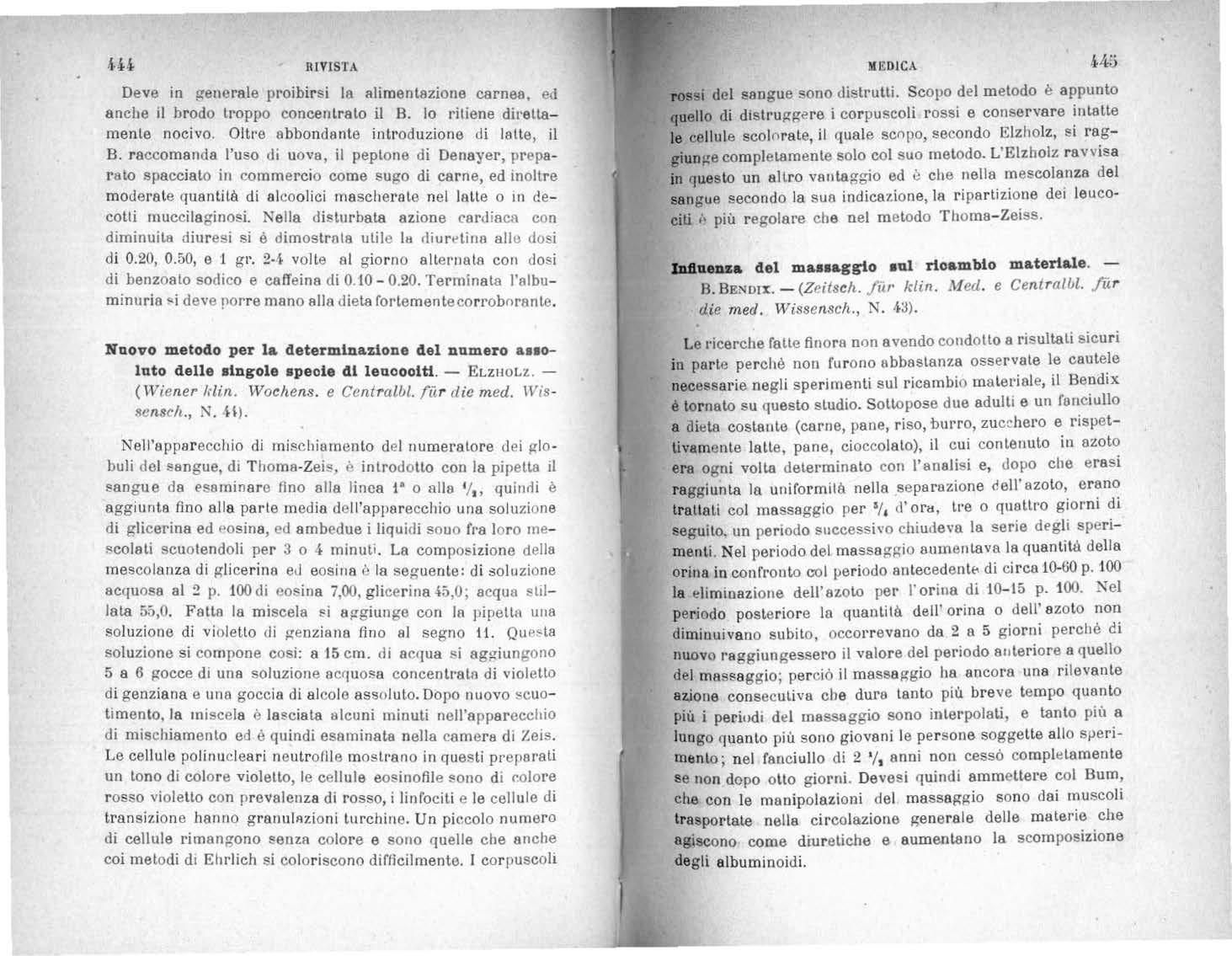
Nel fanciullo, durante il per 1odo del massaggio, il gras!';o con le fecce e ra solo 1/ 5 in confronto col periodo anteriore; il che attesta un piil facile assorbimento del grasso per l'azione del massaggio (azione meccanicaldiretla sul ventre nel massaggio a dd ominale) fors e anche aum entata secrezione del sugo gastrico; c cos1 pure la eliminazione dell'azoto per le fecce era un poco minore che nel periodo onter·iore, probabilmente in co nsegu enza della più abbondante secrezione del sugo g a stri co durante il massap-f:tiO.
Sulla polmonite da lnfiuenza - A. Ar.au.m"d. Woeh. e Cent r alb. (ur die med. Wiss ensclt, N. 51, 1895) .
L' Albu crede che alla influenza appartenga una forma di polmonile. Questa é una polmonite calar'l"ale o bl'onco-po!monile e s i pl"oduce pel' la propagazione agli alveoli della bronchite capillare designa la come catarro da influenza. Clinicamente la polmonite da influen za si distin gue genuina polmonite cruposa pei seg-uenti segni: l " La sulla parte infìllrata MI polmone spesso manca com· pletamente (polmon ite centr11le) od P oltremodo fugace , ovvero dopo bre"e tempo trasmigra in alt ro luogo, ed in questo caso non raramen te la polmonite da influenza prende la forma della polmonite migrante. La oltusilà è nei casi tipici della polmonite da influenza piccola e circoscritta. 2o Il rum ore res pirator·io è br·onchiale nei luoghi della inflll1'a· zione e talora è questo l'unico segno; ordinaria mente esistono rantoli. 3• Lo spu to non ti mai schietlametrte ru;.tgi· n oso, solo sul primo cominciAre spesso gialliccio, per lo più mucoso schiumoso. 1• La febbre entra per Io più, non sempre. senza brivido, sale a poco a poco, non r·aggiunge mai una grAnde altezza e te1·mina per lisi. 5° Il COI'SO S molto meno acuto di quello de lla genuina polmonite c r uposa; le inftllrazioni solo Ieolame nle r etro cedouo, la convalescenza é lenta e stentata. ù: da notare la frequente comparsa della pleurite) il c ui assorbimento è lentissimo, ma rar·amsn te passa io essudalo purulento.
MEDICA 4.47
Anatomicamente la polmonite da influenza si distinque per le sel!uenti particolarità. La iotlltr azione si eslende solo s u alcuni lobuli, la superficie di sezione è meno granulosa , più liscia, il suo colore non è grigio. ma chiaro, color roseo; l'iniiltrato è più molle, più povero in fibri na, rna ricco di cellule, di modo che talora ha l'aspetto di llll lirJuido pul'Ulento; in conseguenza di questo carattere la infiltrazione non rararoenle genera asccs !"o e cangrena nelle parli inftllrate, talora ne deriva il poeumotorace. Nella ver a polmonite cruposa un tale pneumolo race fu osser· vato in tutto tre volte. In quanto alla questione in qual rapporto sta la genuina pol monite cruposa con la influenza, l'A. crede che fra queste due roalaU ie nessuna r•elazione vi sia, si tr·alla o di una complicazione accidentale o di una infezi one secondaria.
Do tt. C. SPENGLER . - Sulla tuberoolosl polmona.re e sulle lnfezlont miste che la. oomplloano . - (Zeitschrij·, (iir ll!J{]iene und Injectionskranl.h ettell, volume XVIll, fase. Il).
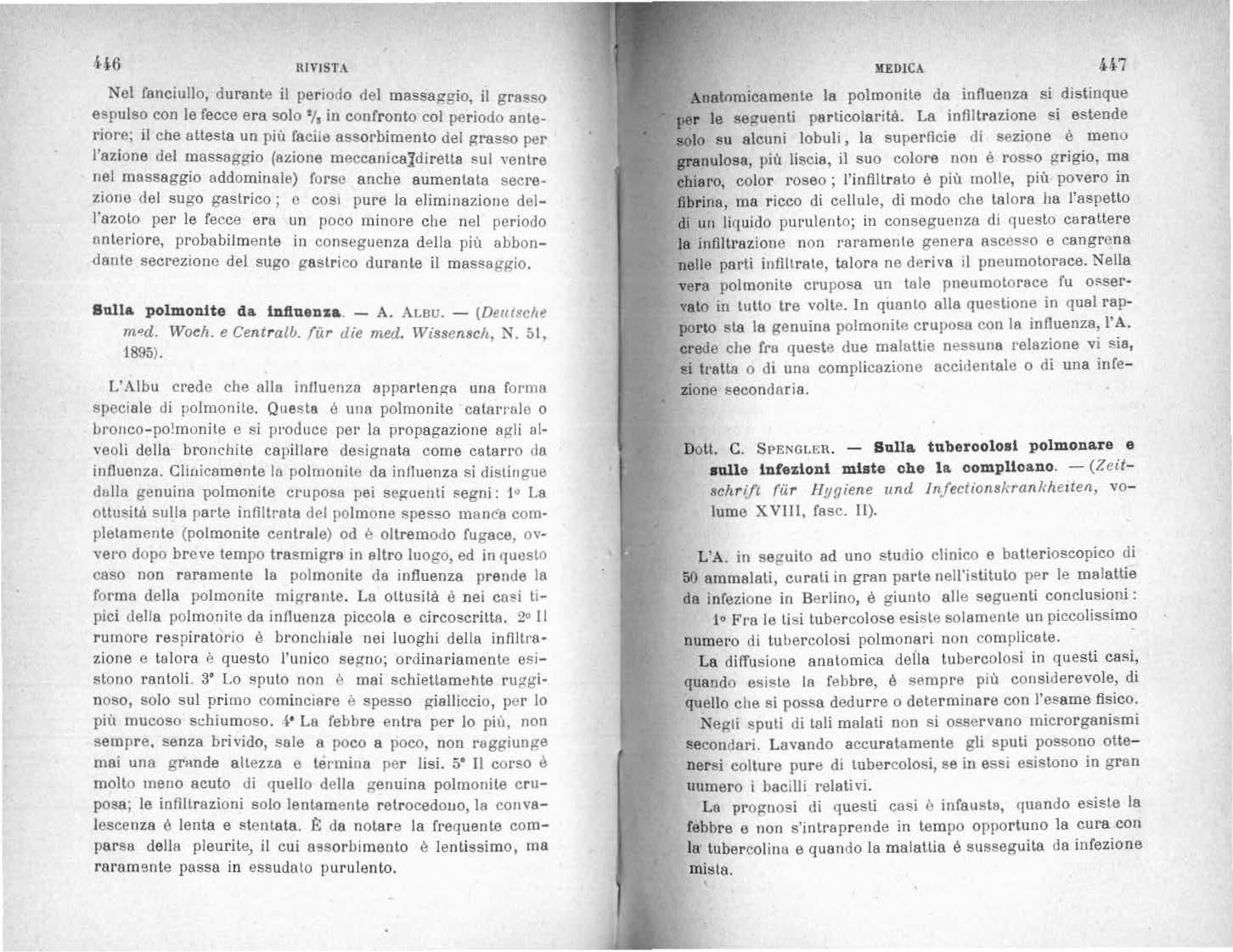
L 'A . in seg:uilo ad uno studio clinico e batterioscopico di 50 ammalali , curali in gran parte nell'i..,tituto pe r le malattie da i nfezione in Berlino, è giunto all e conclusioni: l o Fr·a le lisi Lubercolose esiste solamente un piccolissimo numero di tubercolosi polmonar·i non complicale.
La diffusione anatomica della tube rc olosi in questi ca!ìi, qua ndo esislo la febbre, è sE>mpre più considerevole, di qu ello che si possa dedurr·e o determinare con l'e!:'ame fisico.
Negli !';pulì di tali malati non si o"'ser·vano microrganismi secondart. L avando accuratamente gli sputi possono attenersi colture pure di tubercolosi, se in essi esrstono in g r an uumero i bacilli relativi.
L a di questi casi t> infausta, quando esiste la febbre e non s'intrapr ende in tempo opportuno la cura con la tub e r colin a e quando la m alattia é susseguita da infezione mista.
2" Nella ma ggio r parte delle lisi pol monari si ri« conL r ano infez1oni mi«le pe r slreplococchi. Le delle infezioni si di vido no in attive e pa ssive; at tive, se uuile a febb1 i, passive, se g li s lreptococchi che s i veggono negli "'PULI non cagionano febbri.
La dia g-nosi dell'infezione mista alliva è deterrninula da l'icerch e ba lle rioscop iche degli spu ti. collu re prevalgouo g li streptococch i, i qu ali o vi si sviluppano da soli od in n u merosissime coloniE', miste aò alt r e poche di batter i J 1ve r s i.
Quasi semp r e gli Rlreptococcb i infillran o il po r enchima polmonare e cagionano in esso un'infiammazione.
La lCi r o presenza nel tessuto polmonare, anchl' in lerritort non mo lto estesi, si manifesta con tutti i noti sintomi caralterisl1ci d e lla lisi, cioè febbre, sudori notturni, mancanza di appetito, dimag rame nto ecc.
S econdo che il tessuto polmonare normale o il morboso (tess uto c icatrizial e oò indurito) è colpilo dall'infezionE' il decorso è piu o meno grave. La Rra vità dipende inoltre dalla estensione dell·infezione p r imaria o secondari a .
Ra ram ente g li s lrep tococchi forman o nel tessu to polmonare ascessi chiusi, dai qua li le tossiche m seguito a pr essione s i riasso r booo e p ro ducono fe bbre settica di g rado elevato.
La prognosi dell'infezione mi s ta da str eptococchi è fav or evole, se l'infezione complica una t ubercolosi locale, se rlm nne localizzata e se l'infermo in tempo opportuno è sottopos to a cu ra climatica .
In egual modo che g li st reptococchi co mplicano la Lubt>rcolosi pol mona re i diplococchi di Frii.nke l, il tetrage no e io rari cal!i, anche g-li slafilococchi, qttindi i bacilli dell'influenza e della fa lsH influenza ecc.
Come la infezione mista attiva, così pure la passiva s i riconosce co11 le colture.
Se in m olte coltu r e di sputi si sviluppano· poche colonie di microrganismi secondari, allora la febbre non dipende dalla infezione mista, ma dalla tubercolosi o da focolai infetti vi esis ten ti allrove.
se streptococclli s i sviluppan o in mediocre quantità ne lle lture a llo ra gli sputi pr ima delle colture e sser e :vali ;e1 • ispogliarli dei ge rm i pro\'enienti da ll e v1e _respiratorie supt> ri o.ri. Ma se an che dopo tale con tmuan o a sviluppars i i deW è indizio che sede in cavern e 0 d1latazio m bronchiali. In ques t 1 cas1 per ò diflicile decider e, se la febbre abbia origin e da tubercolosi O tla Se?SÌ. . .
3o L im po rta nza dell' infezione mista nella de_llo tisi è dul fatto che solto rinfluen2'.8 chmahca l'infezione mista scompar e, la tubE}rcolo>;i r1man e immutata e la guari gione della tisi è soltan to appa r e n te.. .
4o La pr ofilassi della lisi 1·ichiede che ogn1 sputo tisi•:.o ed ogni secreto di qualunque sieno allon tanali dalle ùimot·e di u omini, pe r ev 1lar.1 11 poi· verizzamen to del mater iale infettivo; l'aseps i chir urgica deve e!!sere int rodotta pure nella profilassi della lisi. racC()mandazion e dell'atmosfera pri va di germi dell'alto mare, dei deserti e delle alte montagne si trovano d'acco r do la sctenza e l'empiri s mo.
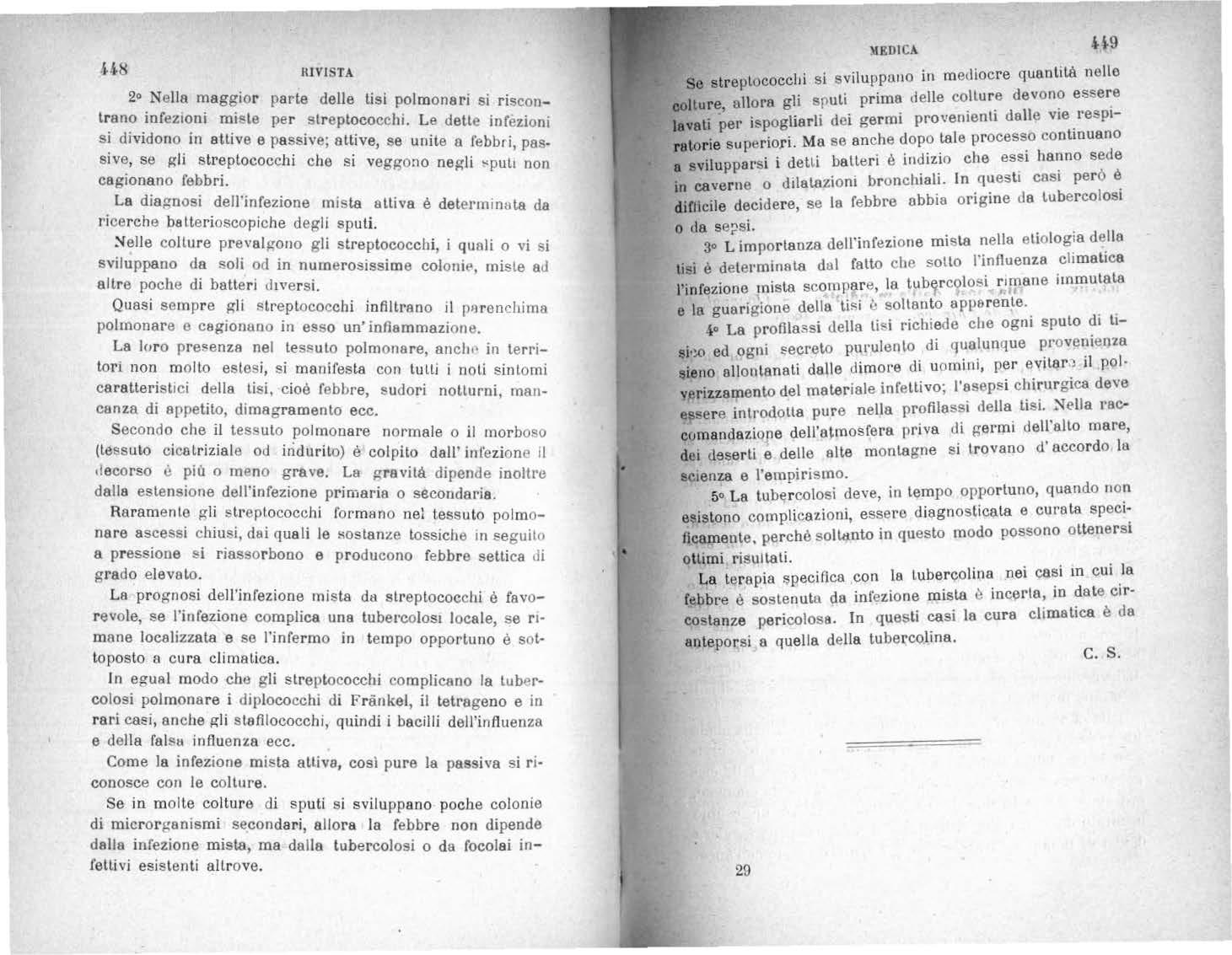
5o La tubercolosi deve, in tempo oppor tuno, quando esistono complicazioni, esse re d iagn osticata e curata flcame nle. pe r c hé soltanto in questo m odo possono o ltenerst o\ltmi risulta ti.
La ter apia specifica con la tubercolina nei ID cui la febbl'e é sostenulù. da infezione mista è ID date ct rcos lanze peri colosa. I n questi casi la cura climatica è da anlepors i a qu e lla della tube r colina.
ll!VI ST A CIIIIIURGIA 45 1










