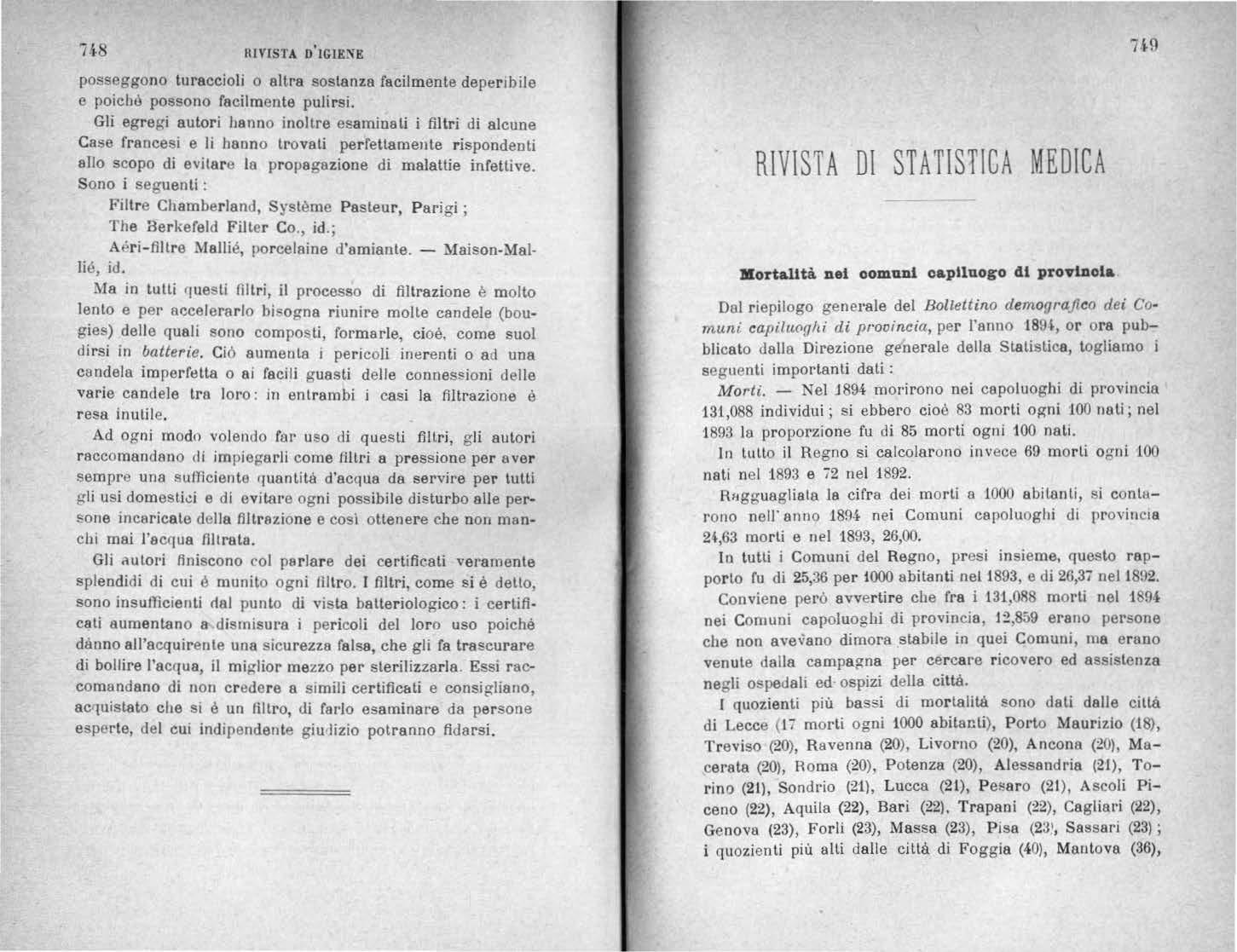
22 minute read
RIVISTA DI STATISTICA MEDICA
lllortalltà nel oomUDl captluogo di provlnola
Dal r iepilogo generale del Bollettino d emografico dei Comuni capiluoghi di proDincia, per l'anno 189i, or ora pubblicato dalla Direzione generale della Statistica, togliamo i seguenti importanti dati :
Advertisement
Morti. - Nel J894 mor·irono nei capoluoghi di pt•ovincia 13L,088 individui; si ebbero cioè 83 morti ogni 100 nali; nel 1893 la proporzione fu di 85 morti ogni 100 nal1.
I n lutto il R egno si calcolaro no invece 69 morli og ni 100 nati n e l 1893 e i2 nel 1892.
RSJ.g g uagliata la cifra dei m o rti a 1000 abitanti, s i r ono nell'anno 189-i nei Comuni capoluoghi di provinc1a 2l,63 mo r ti e nel 1893 , 26,00.
I n tu tti i Comuni del Re gno, presi insieme, questo rappo r to fu di 25,36 per 1000 abitan ti nel 1893, e di 26,3i nei 18H2.
Conviene però avve rtir e che fra i 131.0R8 mo rti nel 1894 nei Comuni capoluoghi di pr ovincia, 12,859 erano persone che non avevano dimora stabile in quei Comuni, n1a e r ano venute dalla campa gna per cer c a r·e r icover o ed assistenza negli ospedali ed· ospizi della citta.
I quozienti piu bassi di mo r talita !>ono dali dalle cittA di Lecce ( 17 morti ogni 1000 ab itar:Li), P o rto Maurizio (18), Treviso (20), Ravenna (20), Livol'no (:W), Ancon a (:W), Mac el'a la (20), Roma (20), P otenza (20), Alessandria (2 1), T or ino (21 ), Sondrio (21), Lucca (2 1), P e!<a r o (2 1), Ascoli Piceno (22), Aquila (22), Bari (22). Trapani (22), Caglial'i (22), Ge nova (23), Forli (23), Massa (23), P isa (231, Sassari (23) ; i quozienti piu a lli dall e cilla di F oggia (40), Mantova (36),
Cremon a (35), NO\'ara (34), Sale r no (:Ji ), Catanzaro (:H), Pa r ma (32), Piacenza (32), Siena (31), R eggio Emilia (30), Vicenza (30), Regg1o Calabria (30).
P a r ticolarmoole pct· Cremona, Man tova , Siena e Salerno il quoziente di mortalità è aggravtlto dal fort e numero di individUI avventizi morti negli ospedali e nei brefotrofi che hanno sede in quei Comuni.
Fra i m o rti uel 18!H nei Comuni capoluoghi se ne con ta· r o no 46 ,988 cioè 35,8 su 100, che non il quinto anno di età; nel 18!)3 i morti entro i primi cinq ue anni er·ano !>lati J7 ,6 su 100.
Nel complesso dei Comuni del Re gno i morti nei pri mi cinque anni di elà furono nel rapp o rto di 47,92 su 100 per r anno 1889, di 46,78 n e l 1800, di i6,98 nel 18!)1 e nel 18tl2 di 4i,80.
Nell e grandi città sono piu numerosi, in confl'onto allo popolazione totale, gl'individui adulti che non nei Comuni rurali; percbè uelle prime la natività è più bal;Sa; e ùi più e<>se l>Ogliono avere grosse guarnigioni militari e v t affluisce òai Comuni circostanti un gran numer·o di operat e di perùi !!ervizio i11 cer·ca ùi occupazione di morte. - Il prospCLlO contiene ancora una classificazione dei morti nel t 8!H, nei 6!) Comuni capoluoghi di provinr.ia, secondo alcuno malattie che sono piit spesso causa di mot•le. Siccome la statistica delle cause òi morte fu iniziata per i Comuni capoluoghi fluo dal 1881, con metodo uniforme d' indogine, possiamo, conft•ontando ft·a Io1 o i dati t·elalivi a ciascun anno del pe1·iodo 18, l-9i-, riconoscere se le condizioni sanitarie dei maggiori centr i di popolazione siano in questo frattempo mig liorate oppure peggio r ate. l 6!) Comuni capoluoghi di prtWincia al 31 dicembre 1881, dola d ell'ultimo censimen to, contavano 4,509,159 abitanti e al 31 dicembre 1894- ne contavano cioè in tredici anni a umentarono di 914,343 abitanti.
Inoltre un certo nume r o eh bamb1n1 nalt nelle città sono collocali a baliu in compagna, e se muoiono du r ante il periodo òi allaltamentu, Sùno compresi nella statistica del Comune nel qual e avvenne lu morte.
Le cift•oJ dei mot•lt nel 1894. confront-ate con quelle anni preceJent1, indicano in gene r ale una diminuzione dt mortalità per le mal11tlie infettive pt•cse in esame. Il uaJuolo che dal 1881 al 18M aveva una mortalità re lalivanwnl'3 bassa, assunse nel 1885 proporzioni g r a,·i e l'epidemia fu anche piu inten"a negli anni fìno al lti88; dopo quell'anno la mortalità per vajuolo é dt nuovo scem ata notevolmente. C onv iene avvertire che la legge per la tutela dell'igiene e l'lanitll pubblica, approvata'il 22 òicenl· bre 1888, ha re!"O obhligalor•ia la pt·alìca della Yncrmazionei e che la Direzion e di l'lanilù, pres"o il tlell' intet·n,..., ho aperto m Roma un Istttuto vaccmogeno cha procura la linfa animale per gl' innesli a tutti i Comuni che ne fanno richie:;ta.

L u mortalità per morbillo presenta oscillazioni Irregolari nei quattordici anni del periodo di osse 1•vazione ; lo stesso dicasi della scarlattina, per la quale per<\ la é maggiol'lllenle pronunCtala nel se nso ùi una diminuzione.
Per IR difterite si poterouo da r e le nol1zie sollanto a comin c iare dal lR83; perché nel 18Rl e nel 18 2 i morti per difterite furono sommali insieme ai mo r ti per et·up. Negli ann1 co rsi fra il 188:3 e il si uotò una diminuzione p t'O· gressiva nella morlf\lttà pet· causa, ma il 189:1 e il 18!)4 segnano di nuovo un aumento. É diminuilo notevolmente il numet•o dei morti pet· tifo e febb r e e l ancile quello dei morti per { ebb r i tLa malaria, ad eceezioue di una recr·udescenza avvenuta nel 1R85 e uel 1886. I cast òi morte per febb re puerperale e pet· altre malattie del parto e tl<'l puerperio avvenuti nel 18Ui- ::'Ono, in confronto della popolazione, meno numet·osi di quelli a vvf.'nuli negli anoi precedenti . Dal 1883 in poi è pure scemata sensi· bilmentP la mortalità per l11uercolosi disseminata in piu oropp ure localizzata nei polmoni, o rH·Ile meningi, o nel mesenterio, o nella pelle, o nel le articolazioni.
La sljilide, <'he nel 189 1 a,·e,•a causalo nei 69 Comuni capoluoglti di provincia 1090 morti o nel 1802 10ì\ nel t 89:J ne causò 1161 e nel 1894 J10t-; per contro lapellau ra causò nel 1891 99i morti, nel 1892 1018, nel 1893 solamente 68G e
T>z Rn'rsrA 01 surtsrJcA " "otcA
533 nel 1894. La mortalità per alcoolismo acuto e c ronico causò nel 1801 16-i mor•li, nel 1892 21 nel 1803 216 e nei 189, 157.
1 morti di br onchite acuta e cronica furono 12fl33 nel 189:!, 11 73 1 nel 1893 e 1166't nel 189i. I mCJrli di polmonite acuta furono 15368 n el 1892, 15315 ne l 1893 e 14780 nel quelli per malattie di cuore 86ii nel 1892, 8a55 nel J893 e 8J09 nel 189-i; quelli per enterite e d{a r r ea 129n nel J8V2, 13i23 nel 1893 e 12706 nel 189t Finalme nte i morti per suicidio ful'ono 654 nel 1892, 641 nel 1893 e 656 nel 1894.
Vari Et E Notizi E
Note •al oiJma 4J Bracciano e •al •no poUgono del dott. GrovANNJ CORNOLDJ, lenente medico nel -1.7• reggimento artiglieria, giù dirigente il ser·vizio sanitario del poligono.
Dalla cerchia di monti più o meno elevati che Jimrtano l'orizzonte della campagna romana spicca a N. O. la linea dei Sabatini, che si aggruppano into r no al gigantesco cr·atere, l!'asformato in lago per lo sprofondamento del cono centrale, e che rlalla vicina città che si specchia nelle sue limpidissime é con osciuto sotto il nome di lago ù i Bracciano.
La costituzionA geologica comune a quasi lutto il territorio che va dai monti Sabalini ai colli Albani è un deposito di origine vulcanica; e gli antichi vulcani che ne determinarono la formazione, spargendo anche a grandi distanze lave, ceneri e lapilli, avevano il lor·o centro da un Ialo sui colli Al· bani erlall'altro nei monti Sabatini. L'eruzione ebbe luogo dop•> la deposiz ione dei ter r eni pliocenici e posL-pliocenici che ne sono direttamente ricoperti. Il colore del lufo, ch e rappresenta il deposito d'or·igine vulcanico piu cospicuo, é qui ge-

li<OTIZIE E VARlEÙ 753
neralmenle gi allo-bruno o rossigno per la pre!'lenza di metallici. Va r ia ne é la consistenza, e quando è sulficiPnte per costituire una pietra da taglio, dicesi tu.(o lituule, che è un materiale a!"!'lai economico, impiegalo nelle coslt•uzioni di Roma, sebbene presenti il difetto di ritenere l'umidità. Si rinvengono anche dello (•olate di lave orJinarie, nere, compatte e mollo dur•e all'allrilo, le CJUali si estraggono per formare CJUei sassi cubico-piramr<lale delli selci, tanto per il lastrico delle vie dr Roma. Tali lave, abbondanti pressoché in tulla la campagna, si trovano specialmente intorno ai laghr Sabatioi dove for·mano dicchi e colate di non poca estensione, massime sul lerritor1o Ji Bracciano.
BrAcciano, antico municipio romano (Forum Clodh), ft>udo degli Orsini nel il grandroso ò imponente castello dei ryuali ò oggetto anche oggr di cur·iosità e di ammirazione, - c;orge in amenissima situazione, c;ull' orlo del lago omonimo. Dalla piazzetta della della Rocca, due s trade, fiancheggiate da case ben costruite, segnalamenle quella che condure all'ex-convento dei Cappuccini, dietro rl quale Lrovasi il poligono.
Il poligono di Bracciano é situato a ci rca due chilomPtri a S. O. della stazione ferrovia r iA, la quule è dt>l paese. Yi si accede pE>r una delle due !'lrade or ora accennate, quella cio1\ che, dopo ave1·e percorso tullo il paese, face ndo un legg'ero gomito al Castello, ot•a degli Odescalchi, diritta, con drscreta salita, lìno alla villa dei Cappuccini, donde si giunge sul Compo di tiro. seguendo- cosi 8 destra come a sinistr•a -la via vicinale che la costeggia. Il poligono occupa una zona di forma triangolare alluugata, col lato miuo!'e volto a N E. Sorge su terreno molto ondulato e con seguentemente ba alliLudmi vat'iabilissrme, che, in meùia, misuruno crrca 23u m. sul livello del mare. La sua superflcie è di circa 11-,000 m. q.; è spoglio o quasi di Al'bor ea, privo di case. povero di strade. A pr·oposito di strade, quelle che attraversano il pohgono sono alquanto trascurate e perciò m o lto polverose o fangose, a seconda delle stagioni e delle condizioni metereologiche: é possibile tuttavia percorrerle con veicoli quasr tutte.
La loro pt>ndenza è moderata, infer1ore cioé - a eccezione di qualche punto rh;tretto - al 10 per 100. La v1a provincia!" (l'antica « via Clodia •) e le poche strade conso rziali che fanno capo t1 partono da Braccian o sono invece disct•elamente man tenu te.
LP condizioni del te rren o (se si eccetlua che sono qui più le dtfrerenze di livello) non variano molto da quelle che in generale si o«servano nella campagna di R oma. Lo strato superficiale é argilloso, e il suo spessore é variabile da pochi centimetri a. uu metro, di rado piu. Solto di questo, e •{uasi dovunque, esiste, come già si è accennato. uno strato tufaceo, talora molto profouùo, per cui le acque del sottosuolo si lt·ovano anch'esse a una certa profondità. Da questa condi;,:ione, da quanto è detto l"UIIa topof!t'afìa d•'lla zoua ùi cui sa parla, dalla deficiente deri,•azione delle acque meteot•iche n canali artificiali, sia al lago di Bracciano, sia a terreni irrigabili, ne conseguono condizioni non favo · r evoli alla igiene della regione. Si comprende infall1 che se il lPneno p1ù si pt•esenlu arso e polvf'rOM nei mesi in cui ti !>Olc estivo - !'GOZa l'interruzione di qualche p10ggta benefica - batte su questa carnpa:xna, cO!'<I non debba e!'lcoere anchP dei suoi strati soLloslanti poicilé questi, data la na tu1•a eminentemente argillosa, e qntnd.i poco permeabile del terreno, sono e riman gono (malg ra do la siccità diurna dell'atmosfera) innltrali di umidilD.. E quest'umiùilé. do! terreno é cospicua nella r:.lagione nelle talora ostinato, durante la quale i luoghi più declivi divengono ttddir1llu ra larghe e imp ra ticabih pozzanghere.
Ecco le condizion i della zona dove f. situato il poligono, condizioni che necessariamente fanno l'tsenlire J1 loro intlu!>So sulla salubrilà del paese e c he allontaneranno, chi sa per quAnto tempo ancora, gli uomini animali dalla migliore volontà, dal t•iabililare terreni, che potrebbero divl!ntaro sorgente di ricchezza.
Da un erudtlo del paese mi fu assicura to che le condizioni igieniche dell'agro di Bracctano erano in un passato non lontano (cio é verso il principio del secolo) a lquanto migliori; egli crede di poter attribuire que s ta salubriiA al le folle boscaglie

<>nde era ricoperta la crel'lta dei colli distesi in catena, a S. <lei territorio, fra l'o r igine ciel fiume Arrone neL Lago, e Monte S. Vito. lo rit<>ngo che non per causA delle folle ed ampie selve, il mio interlocutore ragione, m a perché queste, sia per la loro posizione elevala, per l'altezza delle piante che le formavano, oppone,·ano un o"'tacolo non piccolo al vento costante che spira dal S verso Bracciano, lutti i gio rni nel pomerigqio. l venti di S. in falli sono qui i più pern1c1osi in quanto spirano radendo il suolo dopo esser sul Mediter·raneo e aver percorso le paludi Ponti ne, e giungono evidentemente caldi, nebbiosi e pregni di umidità. Auste r , graece notlws nominatu r, qttoniam est nebulosus et humeclus (Crellio).
Per la stes!'a ragione ritengo che la grande villa dei cappuccint col suo follo parco, in,.irme ad alcuni lralli viciniori dt terreno, pure ricoperti di piante d'alto fusto e situati, rispetto a Bracciano, in modo da opporre r iparo ai venti ap· pm·tatori di umiùila e talora di get•m i della malaria , a pt·eservare l' abilalo del capoluogo da quelle cause di malattia aftliggono invece cbi è coslrPtlo a lavo1·are e vivere nell' agro. Eà ceco la ragione per la quale è da ritd nersi Bracciano, contro il comune pregiudizio, un sito sa:ubre. n terreno sul quale fu stabilito il campo permanente della truppa, fino a che il numero di uomini e l'insufficienza dei locali adatti in paese, ha re 'iO necessario di ri correre all e tende e alle ba1·acche, non solo si trovava ri parato da1 venti <li S. O. ùalle Ot'ora accennate macchie, ma era ancora posto in posizione abbastanza elevala da spieg11re facilmente perché gli uomini accampali siano stati preservati quasi completamente da g ravi affezioni reumatiche e m alarichc. Tale risultato però io riten go debba!>i attribuire in parte anche alla secchezza rPlativu o insolita avuta nell'estate sco rsa, per la quale furono rare, anche nel resto della pr o vincia, le forme estioo-autunnali, o g ravi della malaria.
U clima, ,l'ordinario, non hl\ cambiamenti bru!';chi e pericolosi di temperatura; tuttavia la nebbia, più o meno densa, che talora si solleva dalla campagna e dal lago durante la n otte, e attraverso la quale il sole appena dopo qualche ora riesce a peoetr ar·e co' suoi raggi, non può non esercitare un'in11uen:ta sul corpo di chi (come spesso debbono fare i nosLri solJali), è costr•etlo a le,·arsi prima del giorno e a presLarsi a opere faticose nella campagna.
1 veot1 predominanti di SO. cui fu accennato sono costanLi o lLre che per la d1 r ezione, anche per• le ore iu cui spirano (da lle 11 fino verso Il tramonto): essi talora sono forLi , raramente impeLuosi. Verso la metà d ella notle si leva d' ordinario un vento in direzione opposta, ma che non ha nè la forza, nè la COtlanza, né la ùurala dei urimi.
Da mollo tempo esrsle a Bracciano un acquedollo in mu· ratura, che prendo le acque sorgive dal Monte della Fiora in quel di Oriolo, e, con un lungo giro giunge in paese dalla parte dei Cappuccini. Il più delle volle è sotterraneo, ma taloea, come lé. dove attraversa valli o strade incassale o declivi, resta all'sparlo ed è sostenuto da pilastri collegali da archi, a foggia delle antiche costruzioni romane. A un chilome lro cir·ca da l paese la sua acqua è parzialmente immessa in un tubo tl i ghisa in esso contenuto, n f(Uale poi si stacca dal condotto principale e ar•riva direttamente a Bracciano, dove fa capo a 4 fontane sparse nel paese, e ques t'acqua è adibila a uso potabile. La maggior parte però di della acqua procede nel condotto in mm·alura, e prima di a rriva r e io pael'e viene utilizzata come forza motrice di alcuoi mulini, poi continua a scorrere, ma scoper ta, a hvello del suolo (pe r cui è espesta a tutte le eause d' inf(uinamenlo); infine mette capo al cosi detto « F ontanone •. Queslo dovrebbe essere precluso a qualsiasi altro scopo che non quello di lavanda; però non solo vi si conducono animali ad abbeverarsi, ma talora vi si attinge anche acqua per bere, cagione unica q uesta delle dissenterie sporadiche osservate nell'autunno del 1893, fortunatamente t r oncate per la prontezza con cui i dotto r i Rivalta e Palazzi ne r ilevar ono la causa e reclamarono immediali provvedim enti.
Allr·a acqua sor giva è quella cl•e per la sua pr ossimità al rOspeda le, p r•ende il nome da e sso . È incan al a ta in un condotto di mu r a tu r a per una lunghezza non com pletam e nte ri-
l'iOTIZIE E VARIETÀ
conosciuta, poiché fu potuta seguire solo fino in de oza alla localita de t to • P r alaterra » dov e appunto l'Alt r o anno era piantato raccampamento, r estando flUivi c irca t :> m. al di sotto della superficie del te r reno (l ). La buona quali tà però che quest'acqua ha conservalo rru fa ritenere che o l'incanalamento di essa sorpassi la zo na del • P r ataterra • ovvero che, a cagione dell'elevatezza di questo campo e in virtù dell a riCOnosciuta azione nitrificante, depu r ali\'a propr•a del te rreno. siano Mrnpre l'lati neulrallzzall i materiali in•tuinanti a mano a mano che «i producevano (2). L'acqua dell'Ospedale fa capo a una fontana cui é annesso un grande lavatoio e abbeveratoio; zampilla a un livello un p(lCO pitì basso del paese, ed é ritenuta migliore delle summenzionate acque potabili: ha la portata di circa 4000 litri all'or·a.
Sulla smistrà della strada che conduce a Vicarello e Treun'altr a sorgente di acqua, chiamala (t la Cislerna •; ottima per f!U&Iita o della po r tata di circa :>000 lit1 i ull'ora . Unico inconveniente ùi quest' ncf(ua è f(Urllo di trovor·si a cit•ca un km . d al paese e a un live ll o molto piìt basso.
Nel territorio comunale, fuori del paese, vi sono vari foutanili con abbeveratoi. ln paese inollr' e esbtono 3 pozzi profondi appl'Ossimativamente m. 15. Non si ritien e che questi essere riempiuti in poche ore; il tempo a ciò nece«sario llel resto dipende dalla quantità di pioggia, caduta di recente. L'acqua ùi questi pozzi non è usata per bere, ma solo per altri usi domesttci. li Comune ha due med.Jc1 condotti, che retribuir<ce a 3500 lire annue ollre i pr·ovenli inerenti ai servizi estranei aùa comlotla. HH un ospedale con 12 letti per gli uomini e ti per le donne, destinati esclusrvamente alle malattie mediche. Il territorio comunale è ricco di lleno, vino, o!Jo, legna da arde1·e; ha pascoli e be:>ltarne eccellenti (le carn1 da macello ù1 Bracciano sono ::uerilamente rmomate). Dal lago che ha una Circonferenza d1 33 km., ul'l d1ametro dt 1:3 e una profondità di 300 m., secondo il LilLa, e mollo più, secondo a ltri, si estrae gran copia di pesce, che fot•ma una <Ielle ric- t chezze del paese. A Roma ìnflitli sono rmomate le trote e le anguille di Bracciano; e già fino da Strabone e Columella era nota tale specialità del lago braccianese, i cui lupos att r atastfue formavano la delizia degli an t ichi romani.

(l ) Da ai lavon ferroviari esprimere la oplnlnnr che l':te')na in parola provenire, per nttrnzione attraverso eta tJUella stessa ctell'ac•tuedotto dì Bracciano, e che trovcrehbe l'useiln attraver•o una breccia t Iella co>trllZione, dove questo é sot terranea.
(!) Certo l'ace.•nnal"l prc.rondit.il di questo d'acqua, prolonbilmcnte non lnc.tMiata, o la natura del terreno poco porosa costiluìsrono ronrllzlonl ravort•voli urta buona conservvJone, non venuta meno neanche qua orlo, pr r pi ù mool, un ru slnhilito in un• area d1rctlnmento '10pra5tanto. lo non cretlo tuttavia ehP la conclnsiono cui porterehhe In esperienu rle l decorso anno abbia ad accettnrsi senza discussione, poiché non é da dime nticare cha l'asHoluta mrutcanza di ploggic, iamenlnta In tul tn l'estate 1894, potrobbo essere stata la principale çagione oJel non avven uto inqulnnme nto.
L'alveo dei torrenti, che sono scarsi m questo Comune, non offre correnti sotto ghiaia.
Due lavatoi pubblici er<istono nel paese, ampi abbastanza e comodt, rorniti di acqua perenne; uno, come SI ,., dello, a nnesso alla sorgente dell'Ospedale; l'altro più grande (circa 110 m. di lato) al limìlare del paese, ma sulla stra.tla ui Vicarello.
Il paec;e, che conta poco più di 3000 abitanti, ha case private nelle quali si potrebbe al bisogno trovare ultoggto 150 ufficiali, non più. Dlf'eltauo i locali demaniali e comunali, sicché non ritengo fac1le di accantonare convenientemente più di 3:>0 uomini di tr·uppa.
Nel paese vi sono 5 mulini mossi da forza idraulica, e capaci ùi mttcinare 9 ttuinlali nelle 12 ore del g10rno; naturalmente li doppio se lavorano anche la notte. Vi sono moltre 10 rorni, capaci di cuocer·e in med•a 10 CJUinlali di f11rina per ogni inforoata. C'è anche una fabl>rice di acque gazzose e sellz.
F r a non molto Bracciano (semprP in vit•tù della forza m oLrice idraulica onde é provvtslo) sarà illuminato a lucP eleltr ica.
Le case di Bracciano sono fornite ùi latriue, i cu1 con- dolli fanno capo a collettor i disposti con una certa peodeuza, però e latrine e fogoatu1•e non sono prive di difetti rile vanti. Le prime mancano di acqua, di qualsiasi chiusu r a e rme tica, e hanno spesso il condotto di scarico nelle pareti; la fognatura pure manca di acqua t• per di provvedervi artificialmente durante i periodi di 11iccttà non r isponde che incomplelamente allo scopo di convogliare e trasportare lontano anche quel materiale di rifiuto, che dalla pubblica via dovrebbe passare in essa dil'ella.menle. Questa é la principale cau::oa di esalaziOni mefìticht> che talora si anerlono nelle non senza qualche pericolo la pubblica salutP.
La mm·bosita e la mortalilli. di Bracciano non sono rilevanti, e questi dali contradicono al pregiudiziO inval!:'o intorno alla salubrità del luogo. Yolendo dire qualche co<::a m particolare l:'ulle causo più comuni eli malattie e di morti, ricorderò che un gran contingente di malattie è dato dall'influenza, la quale in quest1 ultimr anni r<i é manii'èslata ripetutamente in forma epidemica, sebbene non grave, e cl i solito sul finire dell'autunno o 11111 p r incipo òella primavera. Nell'inYerno si ha llll nume l'O, non eccedente la med 1a normale, di malattie acuto degli organi respìratorii (bronchiti, polmoniti, pleuriti). Appresi cho si sono verificate ripelutamente alcune piccole epidemie dì tonsìll ile follicolal'e, specialmente in bambini, caratterizzate da sintomi locali non solo, ma anche da reaziOne generale piullosto intensa; la malattia però si risolveva sempre 10 pochi >!iorni.
Riguardo alle forme lifoidec ho constatato essere rari i casi di Lifo classH'O; ciò che può 1·ecar e qual eh sorpreRa, considerando i dift•tli già ricordati delle latrine f' della foSono invece relativamente più frequenti le .forme di febhri infettive, spesso persistenti; d' sono pure frequent i i cat11rri intestinali, prodolli da cause comuni.
Inollre nell'eslale del1893 ebbe luogo una pir.cola epidemia dissenterica, la quale come accennai, fu cagionala dall' uso potabile delle ac(]ue del « Fontanone . : infatti limitata alle sole famialie ehe aoecano fatto uso di 'l'"'st'acqua. Una affezione o predisposizione piullosto comune é la dia- t es1 urica accompagnata dulie o r dina1'io sue complicazioni (gotta , ecc.). Essa trova, a mio a vviso, la l'lua cagione principale nella ''ila poco attiva che una pa1·te di questa popolazion e agiata conduce. ll r a le con$eguenze di questa diatesi non sono rare le endoa1·Leriti tl]e cardiopatie, in genere, men tre poco lo sono le cirrosi epatiche; ciò che se fa rilenet·e essere l'eccessiva inclinazione di alcun i verso il vino una concausa di tale predisposizioue, esclude però l'alcoolismo. l casr d'infezt<'ne pt•irniliva che si ric:conlrano in paese, si riferiscono a individui che In <'O n trassero, allorchò si trovavano per lavori campestl'i o eli bonrlìca a Ce!'vetcri, Palidor·o, Maccarese. Casi di malarra si verificano pero nel ter r itorro del connme, come del resto quasi tlovuni'Juenellacarnpagna dr Roma.

Riguardo alla malaria non SI verificano c1uasi mai casi di infezione primitive entro l'abitato; e cosi i pochi militari colpiti da qnesta malatL1a la contrassero o all' accampamento o al poligono per servizio.
La frazione del comune dtJlta Piasciarelli, In vere, nell'estate come ci'autunno, è afiiitla dalle forme anche pil't gravi. In queslu frazione, (al pari di altre sparse per· la compag:na), J.. malattie in generale a«:-;umono Uflll gr·avita e proporziOJ!e magg-iot·e che non a Bt'Sl'Ciano; ciò elle dipende non sulo dal l'alto che spesso si ricorre al medico a malattia inoll1·ata, ma a nche 1wr·chè I]Ue«li deve sostenere Uflll vera lotta contro i p r egiudizr dell'infermo e delle cionnicciuola che lo circondano.
Conchiuden1lo mi !<Ono convinto che rrguar·do .alla malaria vi é per lo meno, la qua le credo di poter· attribuire alla filcilita con cui molti, troppo preoccupoLi dall'endemia, non persuadono facilmente <'he tante malattie febbr·ili ripetono la loro origin" da altra causa che l'infezione pa lust r e.
Anche la cifra della rno r talita è t•elali,amente !;Carsa. Le cause più comuni di morte sono: nell'età infantile le enteriti croniche e le loro complicazioni; negli adulti talorn iofl uisce la cachessia malaricn in quanto é capace di agg r avar e malattie già minacciose per se stesse; nei vecchi influisce indirettamente l'accennata cl iale!;i urica, in alcune sue com · plicazroni, sopra tutto nefrillche e cardio-vascolat'i; non rare sono le emor ragie cerebrali.
E Variet 76 1
Durante la scuola di tir o del 1894, alle q uali io pr est part e (que lla de l 27" a r tig lie r ia, e quella cen tr ale p er l e a r tiglierie d'assedio) il numero degli urlìciali s a li talo ra o ltre il centinaio; quello della truppa ascese a circa uo migliaio. Delle 11 compag'nie di cui e ra composto il 21• artiglieria , 5 soltanto furono accantonate, e cioè una al p alazzo del com u ne, del quale occupava le stanze più ampie e miglior i; una in un granaio del paese, le cui e r ano sforni te d'invetriate e d'Imposte e munite solo dr inferriate, sicchè i soldati dovettero provvedere con i Lei i da tenda; altre 3 nell'antico convento rlegli ùove hanno sede le scuole. Qur se non faceva difetto la cubatura non vi si ritt•ovavano però le altre conùrzioni pur capitali per la salubrilà di un luogo abitato, ft·a cui ac<'ennerò solo alle latrine poco igieniche, alla ventilaz.ione ùefìcienle ecc . La maggior parte delle finestre mPllevano in un cortile piccolo, umido, chiuso da mur1 alli, nel ctuale corrisponde"ano pure le latrine, che erano così piccole, incomo1le e qumdi onligieniche, che la loro conveniente pulitura - malgr·ado la migliore volont.A - è sempre un problema insolubrle. Tuttavia le condiziom buone, e lo spazro sufficiente lasciato a c1ascun individuo, hanno r eso anche questo accantonamento, ne l complesso, discrrlo .

L'accampamento sorgeva nella località della « Pratater ra • tra la ferrovia, che r1ui fa un gomito pronuncrato. e la stroùo. dei Cappuccini. La compagnia S. M . e il deposito erano alloggiale enLt'o barncche di legno, costruite pct• la ci r costanza, e che quindi avevano i difelti merenti alla l'retta e alla precarietà dt'lla costruzione. Questi però furono diminuili dalla vigilanza e dalle g1uste del d1retlo r e della scuola, coadiuvato da ch i scrive, verso il Comune.
l nliné, altre :l compagnie erano ricove r ate entr o tenùe mo· dello R0ma, in Lutto 9; delle quali 2 erano esposte cor loro lati lunghi da S. E. a X. 0., una in continuazione dell'nll r a; e le r·imanenli 7, coi loro lati lunghi esposti da N. E. a S. O., er ano collocate parallelamente tr a loro. Non mi dilungo su queste, poiché credo che s1ano nole a lutti. Pur non disconoscendo gli inconvenienti comuni attendamenti in genere, le rilengo 1n complesso il mezzo d'alloggiamento per le truppe, ogni qual volla uu comune non offra (ciò che accade di ft•equeute ) locali per acca ntonomMlo ampi e ed un tempo salubri. La compagnia treno non ha potuto alloggiata cbe tn un vecchio cascinale, sìluat.o sul poggto Colognola; la scuderia e 1·a ati un livello più basso del terreno cit·coslante, e la camerata in un locale soprastante appena 3 m. dal piano della scuder ia, da cui era separata per m ezzo di a ssi logor·i e !!'connessi e ta lora perfino interr otti nelle com mettiture.
Tutti tndistintamente i militari di truppa ebbero un pAglie· riccio ed una cope l'la di lana. La prigione e la sala e rano stabilite in tende coniche presso l'accampamento, cio chesotto il rappor·to igienico - non è senza inconventenli nelle ore ptù calde dell e g iornate e"live e nei gio rni molto piovosi. Le cucine erano stab11ile sotto tettoie improVYisale, rir arale dal vento ; una parte all'uccernpamento predetto, e unn parte in un cortile annesso al sumroenzionato (·onvento degli Af{O· stiniani: esse non offr•i VIi IlO alclll1 notevole inconveniente. Per uso d'111rermeria rur·onn adibili 6 YOIIi d1 mediR e piccola capacità, situoti al piano superio r e dello "cuole. Le cond•zioui in cui questi locali furono consegnati, e r ano talmente tnlproprie all'uso per cui erano destinati, che i o reclamni e ottenni non sol amente il loro aumento da 5 a 6, ma ancora la loro co mpleta riparazione. Non si potè per· queste volla, togliere rad1calmente il ùifello di una latrina sopraslant"', che inquinava Il muro estel'nO. Nel complesso però, tutte le possibili precauzioni igieniche necessarie, non si ebbe a lamentare da questo fallo alcun inconveniente.
Di detti locali 2 o 3 al piu (capaci di 9 o 10 poslt) pre,.entavano le condizioni per potere accogli erE.' individui brsog-oevoli di cura. In uno dei locali vi è anche la comodità di un fornello.
L e condizioni sanitar ie della truppa prima del campo erano state oltime; essa giunse a Bracciano c ne ripartì, pet· ferrovia. Prima però si ebbe c ura di eliminare scrupolosamente lutti gl i indiv 1d ui, la cui opera poteva e,.,.ere inutile pel o;;ervizio, :.!annosa per loro stessi. Durantò la scuola di tiro vi fu una distribuziOne di caffè al n1atlino; una di anice, unito all'acqua, durante ti giorno (un centilitro e mezzo) e una di vino al secondo rancio (250 g.).

La pasta, la carne, tl lardo, la verdura, il calfè ecc., furono acquistati a Bracciano e tutti generi furono costantemente di ottima qualità. An che il pane da munizione é stato falt.o a Bracciano : la sua cottura non era cosi per:'e lta come quella dei pauinci militari; talora la c rosta era troppo colla e poco invece la mollica. La r1uatilà della farina era buona. e il sapore del pane gr·adilo.
Non furono mollo le malattie gravi occorse durante il campo, e queste in parte furono curale all'ospedale milita1't> di Roma , altre all'ospedale c•vile di Bracciano o, per ragioni d'opportunità, all'infermeria stessa. Fl'a le malattie med1che prevalsero le forme g astro-reum atiche febbrili, dovute genernlruer.le a cause comuni, per cui hanno anche ceduto rapidamente in seguito ai dovuti o a opportuna curo. Le poche febbri malariche gia accennale (sei in tutto) guarirono senza lasciare conseguenze
Nulla che meriti di essere accennato riguardo alle malaU•e onalmiche e veneree.
Tra le malallil' chil·urgiche merita menzione il numero di qu e lle traumatiche, piuttosto rilevante. di cui ricorùarò solo le più gt·avi: una ferita del terzo inferio r e della coscia sinistra con g rave e am pio sc heggiamento del femore e partecipazione consecutiva de ll' articolazion P del ginocchio, prodotta da un ca nnello a vile proiettato dal pezzo all'allo dello sparo (gullPigio ne in 4 me"i ci r ca); una ferila di moschetto al torace, tt·asfossa, itlleres!>anle il polmone sinistro, il lra·gitlo della quale decor·sr> lra la parete laler·ale del pello e il cuore completa in 45 giorni); una ferita pure di m oschetlo, i tessuti molli e duri estt·aloradci di destro, anteriormente, complicala a grtsvis!<ima co ntusione del polmone corrispondente, in seguito al!a quale l'infelice fet·ito morl dopo 21 gio rno. Era il capot-aiP Sorice Saverio rimasto vittima della fe1·ocia di un suo infe1•iore, che lo colpiva proditoriamente men t re do rmiva










