
68 minute read
RIVISTA CHIHUBGICA
JoHN MuRPHY di Chicago. - Analisi dl oasi operati ool bottone dl Murphy . - (The Lancet, aprile 95).
Sco•·so il tempo de lla polemica, dei lentalivi e delle limide applicazioni cbirurgicbe, l'autore crede che sia oro di tt·arre le conclusioni da un g ran numer·o di casi operati col suo botton e, esaminandoli pr ima in massa, poi ril evando gl'insuccessi e valulandon e le cause, discernendo cioé quelle atlt ibuibili alla gravità ùella malattia, alle condizioni generali prodotte dalla malattia stessa, da quelle che sono inerenti all'operazione, come gl'insuccessi nel rintracciare il vero punto della lesione, le conseguenze immediate dell'operazione stessa, le cause
Advertisement
Gastro - enterosiom ia per cancro, ravvicinamento lalerale: '27 operati, 9 morti.
Nel primo degli operali venuti a morte v'e ra sta ta i mponente e morragia ripeLut.asi nelie quattro settimane prece-
CBIRGRGII.A denti l'operazione. L'emorragia continuò ancora pe r quattro giorni, malgrado c he l'operazio ne fosse stata compiuta in 7 minull.
Il s e co ndo mori in 48 o r <> per esaurimento.
Il terzo, mollo emaciuto e depresso p1•ima mo r i in 12 ore , il fJUa r lo eb be la stessa sorte.
Xel quinto insucces:sCI si era usato u n bottone troppo piccolo, che non poteva contenere una sufficien te qua ntila di tessuto, onde la tuo1ca in t estmale sfuggi dalla m orsa, ed il conte nuto intestinale si versò nel pe riloneo . Il sesto morto si ebbe per peritoni te ci1·coscritla al terzo giorn o L'autopsia l'ivelò ravvi cinamento perfetto dei ma r gini della ferita, larga ulcera dello stomaco, cancr o del pancreas, regalo ed alt r i o r g ani.
Nel settimo che mo1•ì pe•· esaur imento qua ttro giorni dopo l'operaziou e, il bottone si trovo in sito.
L'ottavo mo1·l al sellimo per peritonite suppu1•ata , il bottone e ra a posto. Nel non o mot·to pe1· periLo nile s ellica, il bollono non era ben c lliu!".o, ed un lembo dello stomaco e1·a sfuggito.
I n conclusione, de' no ve morti, d ue perirono per impet'fetla operazione, quattro per esaurimen to. tre per perilonite da infez10ne durante l'operazione.
Siccome il potet·e ri ge ner ahvo affetti da cancro è mollo indebolito, l'autore scar ifica con una punta d'a go la supe1·ficie per1toneale dello stomaco e ne' punh dove deve a vve nire il contatt o, e passa alcun i punti di sutur·a inle r cisa 8 m PZZO pollice dal bottone, fra J"intestillO e lo stomaco per vin cer e la r ett•a zione de ll'intestino. Preferisce la pos izione tll Von Hacker quantunque possa usarsi anche quella di W òlne r, pel più facile del bottone nell'intestino.
Se il cancr o mvol ge solo una piccola po1•z ione del piloro, il meglio è in c idere il duodeuo a due pollici solto il piloro, cu(·ir e i capt vicini con una s utura Czerny-Lemb e rt, ed i lontani riunirli alla parete posterior e dello stomaco col bottone.
N ello ope razioni di ravvi cinam e nto della parete anteriore s tomaco, il bottone é caduto nello fltomaco quA ltro volte.
Quantunque l'autore abbia sempre usato in queste opera;doni il bottone circolare , ri conosce i pregi dt·l bo ttone o blungo che produce una pi ù la r ga apertura, s i inserisce più facilmente, e passa piu liberllrnente ne ll'intesti no.
Dalle p r ecedenti osservazioni l'autore conclude: che la gastro-euterostomia non dovrebbe m a i essere in infet·mi mollo depe riti ; che in queste opera zioni ò preferihile la posizion e di Von Hacker; che una sutura al dìfuo ri del bottone p uò essere ulile a di min uire la tensione delle viscere; che ne' reslringimenli non maligni del piloro il capo del duodeno dev'essere riunito alla parete pot<leriore dello stomaco; che bisogno somministrar e un nu tr imento liquido all'in fermo, appena passati gli effetli dell'a:1estesia.
Pil o,·ectomia . - Con l'uso del bottone quest'operazion e diviene immune dallo shock, e dal tras udame nto di lìrtuido n el punto di r avvicinamento. Legato il mesen t erio del ca po superior e d ell o stomaco, piloro e duodeno ìn modo da forun grosso peduncolo, mediante tre o qua ttro legat ure, se ne fa la 1•ecisio ne ; poi si lega il mesenterio del cap o infe ri ore all'i s tesso modo, e si sollE-va il pilo r o fuori dell'incisione addomin al e, si avvolge con ga r za, si stringe con robuste pinze ai due estremi, si esegue un'incisione circolAre nello stomaco che r ecide periloneo e muscolare, relraUi questi tessuti di mezzo pollice s'incide la mucosa, s i chiude .questa ra pid amente con una su tura continua, indi la s ieros a muscolare con una sutura alla Le mbert. Poi s i s tringe il <l uoceno fra due pinze e si recide, vi s'intr oduce una metA di b<Jtlone, l'altra m ela si pone nella parete poster1ore dt:>llo stomaco ad un pollice dalla linea di s utura, e le due metà di bottone !!'i incastrano fra loro.
Delle quattro operazioni eseguite in questo modo dall'autore, tre ebber o esito felice, ed il bottone passò se m pre nel du o deno .
Co leeis tiduodeno.stomia . - In :38 cas i di c o lelitia$i fu esegui ta quesl'operaz ione, e non si ebbe che un decesso al ;o g io rn o per con tinua emo rragia del fegato lacerato nel res ezioni per et•nia gangrenata, s u 12 operazioni si ebbero due morti, il primo in 48 ore per pertton ite settica esistente già al momento dell'operazione, il secondo iu 30 ore per autointossicazione da decomposizione di proteidi ritenuti nel canale altmentare. l Hove casi operati per fistola ste rcoracea guarirono lutti ciò che dimostra il g ran vantaggio che ha la ravvicinamento de' capi sul ravvi ci namento laterale . operazione eseguita per tumori maligni non ùà :•s ullah . COSI soddisfacenti, ma é sempr e preferibile agli altr1 metod1, perché in :30 casi si ebbero solo ì morti, com - prese 8 resezioni del ceco. Le morti per infezione d a ll'esterno durante l'operazione, per collasso, per perilonile preesistente, per soverchia grandezza del bottone che aveva perforato l'intestino, per gang rena de' margini compressi troppo dal bottone, per esaurimento.
SPparare le ade r enze. L'obiezione teoretico del bollone che potrebbe cadere nella cistifìllea e rimane r vi, non è stata avvalorala da un sol fatto. l l pericolo d'emorragia è ve 1·amenle imponente e bisogna badar molto alla dil:!cissione delle ade· renze col fegato.
La colecistentero stomia per tumori maligni non dà buom risultati. Di otto operati sette morirouo. Essa è ind1cata nelle ostruzioni del dotto comune. in quella del dotto cistico nelle colecistiti c ron iche con ispessimento delle pareti biliat•i allorché l'infermo è emaciato dalla perdita di bile. E conli'oindirata nella g an gren a della cistifillea. od intestinale.- É questo il vet•o campo d'azione d el bottone nelle t•esezioni per gangrena, per ostruzione intestinale, per ernia, per cura delle fistole fecali, per tumori maligni, perforazioni intestinali traumatiche e patologiche, nelle re;:ezioni del retto.
Per gangrena dell'intestino da ostruzione interna si l• usato il bollone H volte, e si è avuto un decesso avvenuto in 24 o re in un ragazzo debole nel quale l'ostruzione datava da quallt•o sellimane.
Pe r tumori non maligni l'autore ha eseguilo 11 r esezioni, eù l1a avuto due decessi; il dottor Price in sette operaz1oui l1a ottenuto sei guarigioni. Nel p r imo degli operati da ll'autore In perilonite gia iniziata continuò, nel secondo cesso la morte avven ne per· autointossicazione, nel caso sventurato del dotto r Price il malato si perdè per collasso dodici ore dopo l'operazione.
La mortalità per perforazione intestinale sia per ferita d'arma da fuoco che per è se m pre stata grande, e Lucke nella sua collezione di casi trovò cho nelle oper azio ni eseguile nelle prime 12 ore la mortalità ascendeYa a 58,2 p. 100, in quelle eseguite dooo 12 ore a 79,5 p. 100. l n quanto ai proiettili penetrati nell'addome bisogna tenere a calcolo il precedente affaticamento del paziente. le profuse em o rragi e, il colpo che ri ceve ti sistema nervoso, la molleplicità delle perforazioni, che inclut.le la t·esezione di lunghi tralli clell'intestino, o più resezioni, nel qual caso bisogna applicare più bolloni.
Res eÀ ioni del retto. - L'autore ne la eseguile tre con es• to di guarigione.
Dopo una lunga e particolareggiata s tatistica delle operazioni est>guite dall'autore e da altri chi rut·glu ingle;:i col suo bollono, operazioni che complessivamente ascendono a 167, egli viene alle seguenti conclusioni: t• La cicatrice che si oLlieno col bottone di Murphy non si relrae. io Le stesse operazioni nell'intestino c ras:;o richiedono il N. Questi diametri sono di di pollice pel N. J, di 4/6 pel N. 2, di 5/6 pel N. 3, di un pollice pel 1..
2' l calibri ::'{. l e N. 2 servono bene per la colecisteoterostomia.
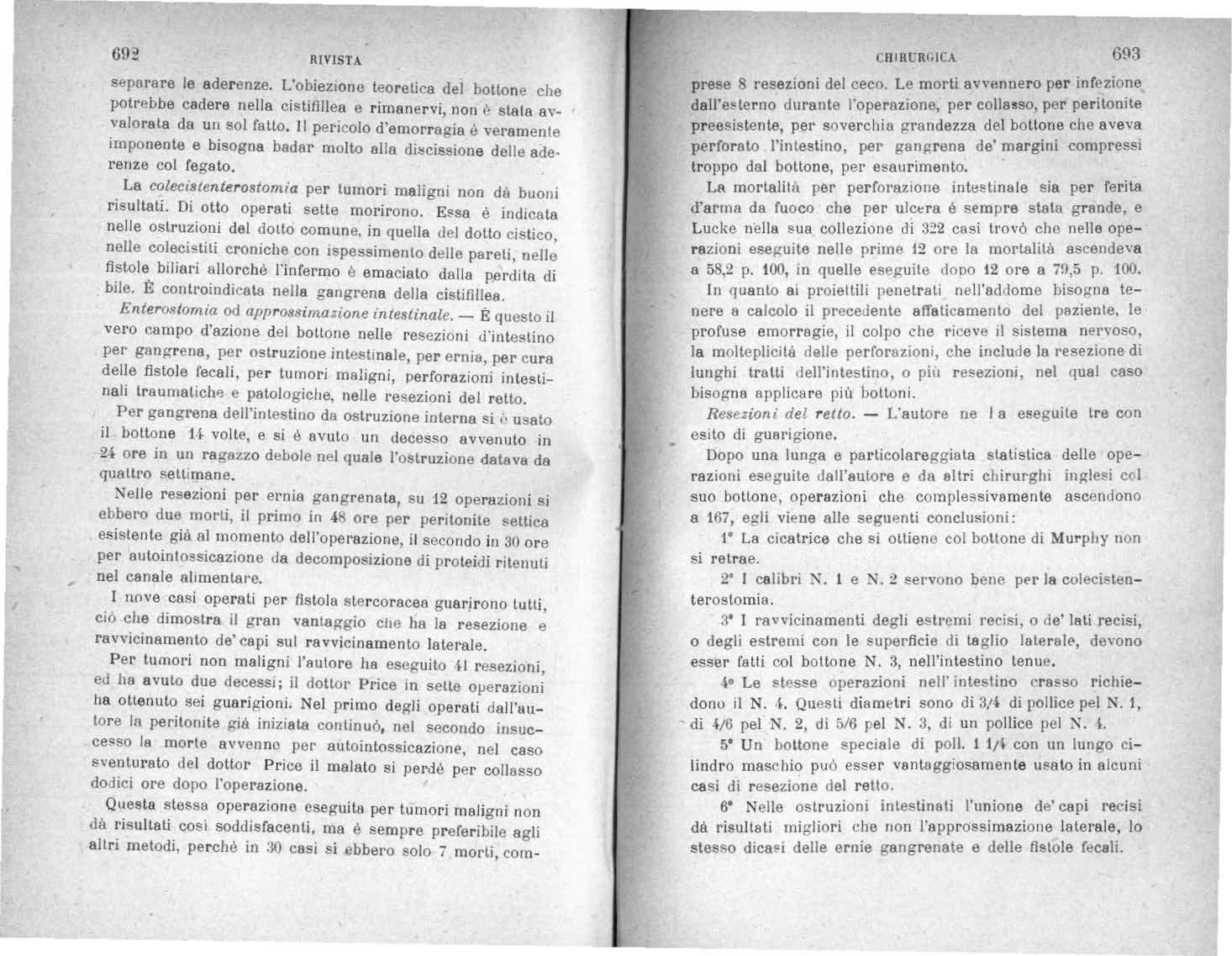
:1• I ravvicinamenti degli estremi re cisi, o cle' lati recisi, o degli estremi con le superficie di ta glio laleralt>, devono esser fatti col bottone N. 3, nell'intestino tenue .
5' Un bottone spectale di poli. 1 1;i con un lungo cilindro masrhio pu6 esser vantaggiosamente u!'a to in alcuni ca s i di r esezione del retto.
6' Nelle ostruzi oni intestinali l'unione de' capi rec isi da risultati migliori che non l'approssimazione lalerale, lo dicaii'i delle ernie gang rena te e delle fistole fecali.
CDJRU RGI CA 695
7' Gl'infermi devon o esser nutriti con a limenti liquidi subito dopo pas ata l'anestesia, e bisogna tosto procurare il movimento intestinale, ed ottenere evacua zioni frequenti.
8' Se il bottone non passa dopo due o tre settim a ne, bisogna esaminare il r etto, perché può esser r itenuto dallosfìntere.
Si è avuto un caso di occlusione del bottone pel'" ostruzione fecale del cilindro, cosa che si può eùlare somminisll·ando un leggero catart1co subito dopo l'ope1·azione.
10o Quando si ripongono le intestina nel cavo dddominale, bisogna in linee parallele onde evitare cu1·ve troppo pronunciate.
11• Nessun caso di ostruzione prodotta dal bottone és la lo finora verificato, ciò prova che l'olliezioue tratta da Choput di Parigi degli esperimenti sui cadaveri è erronea.
12° Non vi é pericolo c!Je l'atrofia da compressione si estenda oltre la linea compressa.
13° L'a desione p ri maria può essere affrettata ne' cast di tumore maligno, abradendo con un ago la superficie peritoneale, ciò che non ?• necessario nei casi non maligni.
Ho Una sutura di sostegno non é mai necessaria per assicurat· l'unione, ma dev'essere usata per diminui r l& tensione, quando le porzioni di viscera raHicinata si trovano in posizione forzata.
15° La m embrana mucosa dev'essere spinta giti cavo del bottone prima di chiuderlo, e se abb o ndante, deve esse re re cisa con le fo1•bici, e mai permette r e che facci& prolt·usione C r a g li occhi del bottone quando si chiude.
16' Me n tre il bottone si può facilmente inserire, le condizioni patologiche che r ichiesero l'ope r azione possono richiedere la più g r ande abilita chii'Ur)!ica per assicurare un l'isultato favorevole.
17' Il bottone dev'essere di metallo non attaccabile dagli se'idi, deve chiude r e io lutli i punti, la pressione elast1ca dev'essere esercitata nellfl metà maschia del boUone e non nella meta femioa, gli o r li della superficie di pressione devouo essere di forma emisferica, la molla elle è solto la coppa di p r essione non dev'essere tr oppo fo rt e. I migliori bolloni sono quelli di Ryan a nd Co. Chicago, Tr uax Greene and Co. Chicago, Geo. Tiemann and Co. New-Jork, \\'. F . Ford aud co. New-J ol'k, Down BroLhers London, Scharp Smilh co. Chicago; Franz Kralzmuller aud Co. Chicago and Berlm.
18' se all'apertura della fisto la dopo il ravvicinamento laterald nppare il bottone, non bisogna spinge rlo contro l'apertura ma bisogna respinf(erlo indietro verso onaslomotica e mandarlo nell'intestino, o far e nelltnleshno un'incisione longitudinale e Lrarlo fuori.
Inoonveulentl poatuml delle eaolaloul 41 omento nen:e operazloul d' ernia. lngutnale . - DoTT. SCAfi. - (Rt(o rm tt medica, N. 4!1 del 1895) .
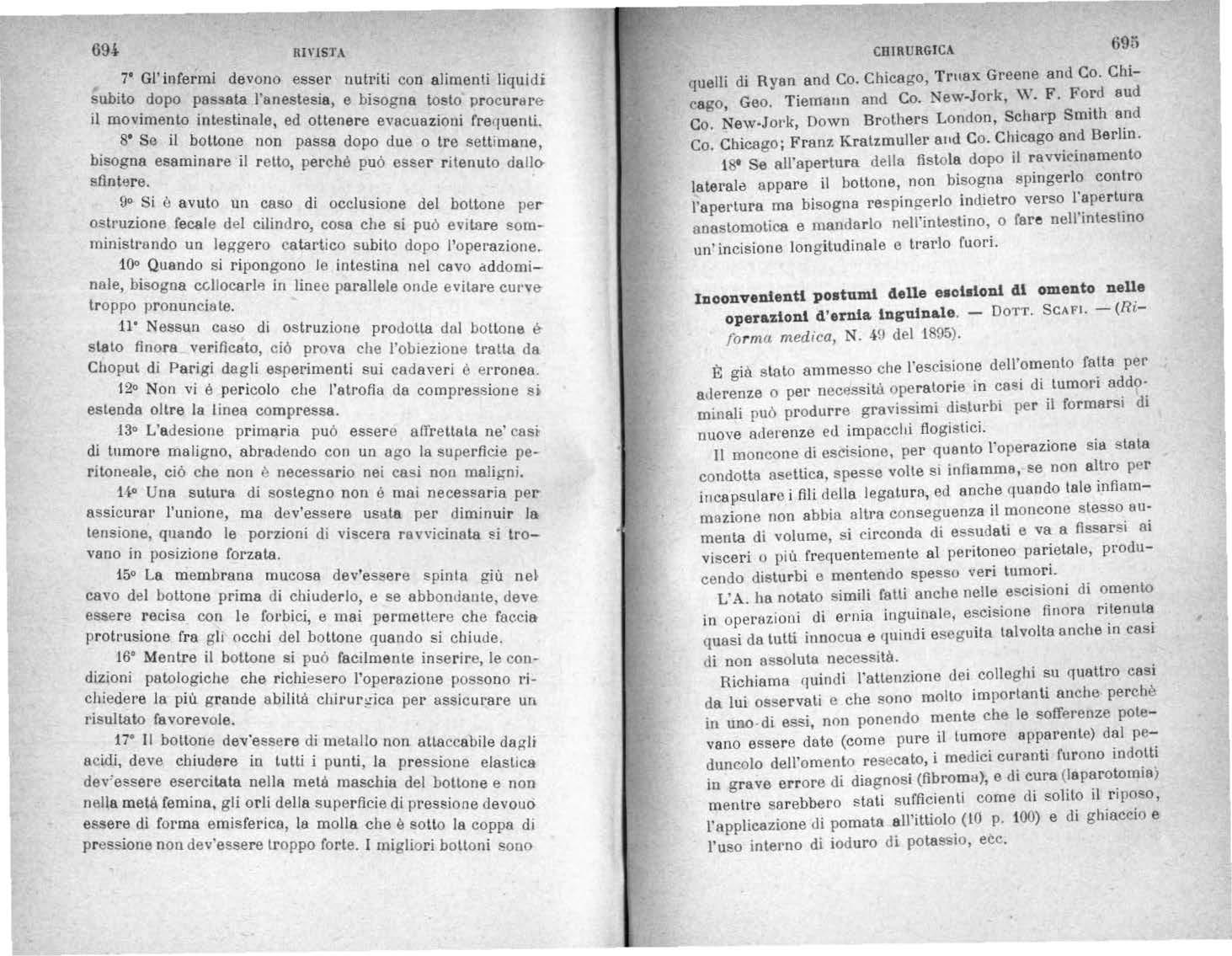
È già stato ammesso c he l'escisione pe1' a tlereoze 0 per n ecessilà operatorie in dt tumori addo· minali può produrre gravissimi dislu t•bi per il formarsi di nuove atlerenze ed impacchi flogistici.
11 moncone di escisione, per quanto l'operazione sia stata condotta asettica, spesse volle SI infiamma, se non allro per incapsula r e i fili della legatu ra, ed anche <Juando tale infiamm azion e non a bbia altt·a conseguenza il moncono stesso. an: menta di volume, si circonda dt essudati e va a flssars1 8 1 visceri o più frequentemente al pe 1·itoneo parietale, pl·oducendo distu rbi e mentendo spesso veri tumori.
L'A. ha notato simil i falli anche neiJe escisioni di omenlo in operazioni di e 1•nia iuguinalll, escisione finora. quasi da tutti innocua e quindi e seg uita tal volla anche 1n cas1 di non assoluta necess1tA. .
Richiama rJUindi l'attenzione ùei colleghi su rJU<t·o cas t da lui osservati e che sono mollo importanti anche perchl> in uno di essi, non ponendo mente che le sofferenze potevano essere date (come pu re il Lumorc apparente) re-: duncolo dell'omenlo rest>cato, i meùici Clll'anti furono in grave errore di diagnos i e ùi mentre sarebber o stati suffic1ent1 come dt sohlo tl r1po o, l'applicazione ùi pomata all'illiolo. (LO p. 100) e di ghiaccio e l'uso intet·no di ioduro ùi potassio, ecc.
Dall'esposizione dettagliala dr questi quattro casi cimici rrsulta evidentemente dimostrato che rescisione dell'omento totale o parziale che essa sia, non del tullo di inconvenienti (tumori addominali, dolori, disturbi, nella digestione ecc.), per quanto aselticamente condotta e si deve perciò limitare ai soli casi rn cui è assolutamente necessaria.
Un'aUra consider·azione d'mdole pr·atira «la sull'arcro. mento si è, cl1e dovendo escid er'e dell' omento sarà sPm;re benP, la le!!alura in modo da avere, tAnti piccoli peduncoli, indipendenti, anziché un grosso ed uni co E vero che in tal modo si polr11nno aver'c tanti centri d'mfiammazione, ma trattandosi di piccoli peduncoli, poco sarà l' e<:suùato che si formerà intorno ad essi o fJuindi meoo probabili ed in ogni caso minori i disturbi postumi; la gran massa degli essudati, in vece, che si formtt 1ntor'n o ad un grosso peduncolo infiammato, dovra senza meno proJurre i gravi inconvenienti di sopra notati.
G.
CHAPUT. - Trattamento delle ferite penetranti dell 'addome. - (Brit. Jled. Journal, 20 aprile
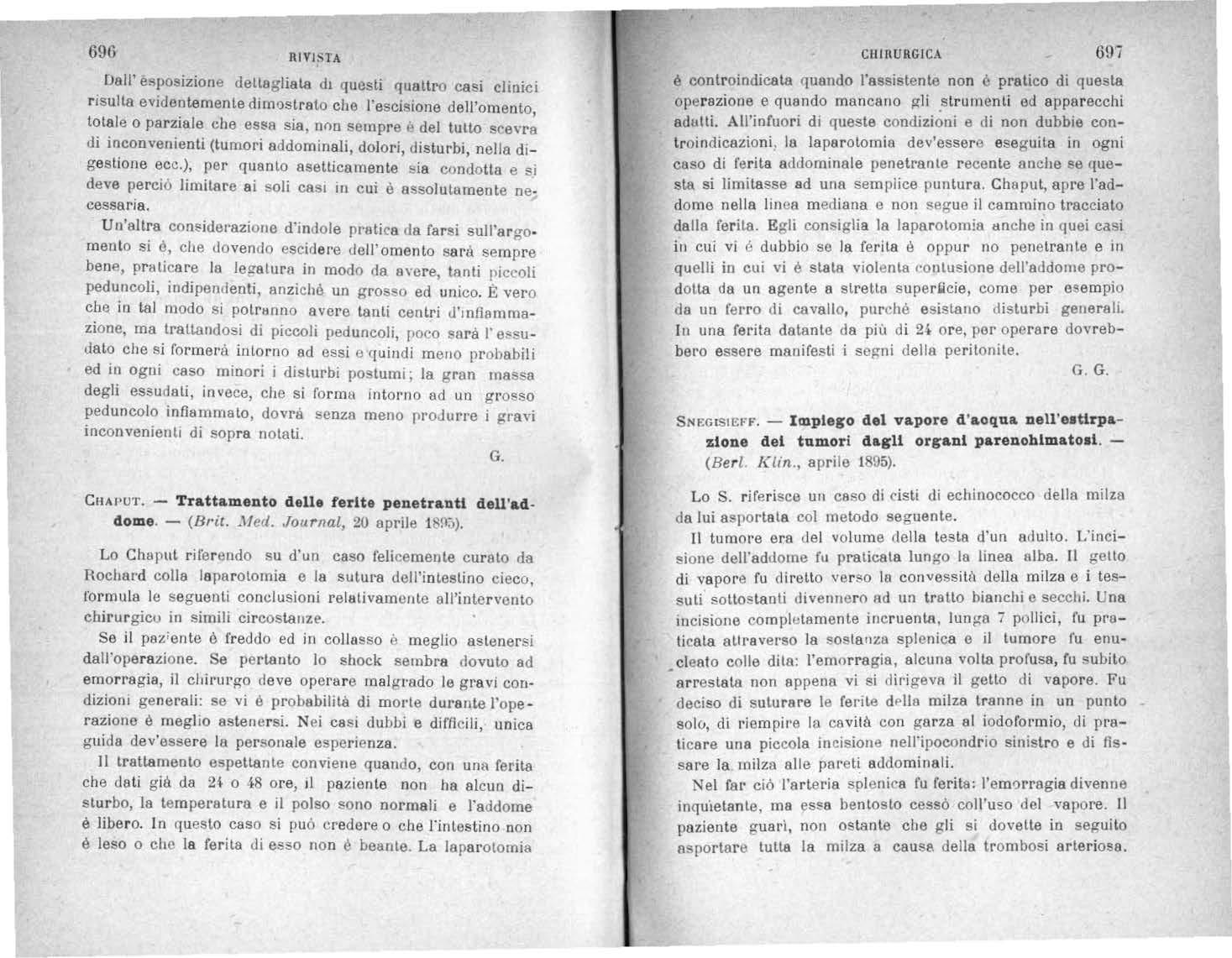
Lo Chapul rife r endo su d'un caso felicemente c uralo da Hochar·d colla la par otomia e la sutura dell'intestino cieco, formula le s e g uenti conclusioni t'elalivarn onte all'intervento chirurgico in simili circostaoze.
Se il paziente é fredd o ed in collasso i> meglio astenersi dall'ope r azione. Se pertanto lo shock sembra dovuto ad emor ragia, il ciJil'Ul'go deve oper'a r e malgt·ado le gravi condizioni generali: se vi è probabilità di mor·te durante l'operaziono é megl io astenersi. N ei casr dubbi e diffi c ili, unica guida dev'essere la personale csperif'nza.
Il trallameolo espellente conviene quando, con unt\ ferita che dati g ié. da 2i- o i8 ore, 1! pa ziente non ha alcun disturbo, la temperatura e il polso sono normali e l'addome è libe r o. In f(Uesto caso si può credere o che l'intestino non è leso o che la ferila di esso non è beante. La Japarotomia è controindicata quando l'assistente non ò pratico di questa ope r az ione e quando mancano gli str umen li ed appa r ecchi a dttlli . All'infuori di queste condizioni e di non dubbie controindicazioni, la laparolornia dev'esserP. eseguila in ogni caso di ferita add o minale penetrante re cente anche l"e questa si limitasse ad una semplice puntura. Chapul, apre !"addome nella linea m ed iana c non !'<egue il cammino tracciato dalla fer ila. Egli conl':rglia la lapa r otomia anche in quei casi .in cui vi ,\, dubbio so la ferita è oppur no penetrante e in qu elli in cui vi é stata violenta contusio ne dell'addome prodotta da un agente a stretta s up e rwcie, come per esempio ùa un ferro di cavallo, purché e sistano distu rbi generali. In una ferita datante da piu di 24 ore, per operare ùovrebbero esse re manifesti i sog-ni della peritonite.
G. G.
SNEGISu,;r:r:. - Impiego del vapore d 'acqua nell'eatlrpazlone dei tumor i dagli organi parenohlmatoai .(Be r l. Klin.., aprile 1895).
Lo S. rife risce un caso di cisti di echinococco della milza da lui asportata col metodo seguente.
Il tumo1'e era del volume clelia lesta d'un adulto. L"incisione dell'addome fu pralicala lun go la linea alba. Il gello di vapore fu diretto ve r so la convessilil della milza o i tessuti solto.,tanti divennero Ad un tratto bianchi e secchi. Una incisione co mpll·tamente incruenlll, 7 p ol lici, fu praticata atlt'averso la soslanzo splenica e il tumore fu enucleato colle dita: l'emorragia, alcuna volta profusa, fu !'IUbito a r r es tata non appena vi si tl ir·igeva il getto di vapore. Fu deciso di suturare le fer·ile dPlla milza tranne in un punto so lo, di r'iempir'e la ca vità con g a r za al iodofOJ'mio, di pt•ati care una piccola incisione nell"ipocondrio sinistro e di fìssar'e la milza alle po1·cti addominali.
Nel far· ciò l'art.eria splenira fu ferita: l'emorragia divenne inqu·retante, ma essa benloslo cessò coll'uso do! vapore. Il paziente guarì, n on oslaole elle gli si dovette io segu ito asportare lulla la milza a cause. della trombosi arteriosa.
RIVISTA
Il vapore da é meglio s ia sopra r iscaldato a 15Qo-200"C. di o r g ani di. consistenza molle il va po re non dev'esse re ad alta pressione ed il s uo getto deve obliquumente sul luogo sanguinante: nelle ope r azioni !<ulle ossa invece il vapore dev'esse r e ad alla pressione.
G. G.
e SCHOLL. - Sleroter&pta. del ca.rcllloma.. (Deuls ehe mecl. Woch., 25 aprile 1895).
E. e S. riCer1scono le loro esperienze circa il trattamento del ca r cinoma mediante il s iero dell'Prisipela.
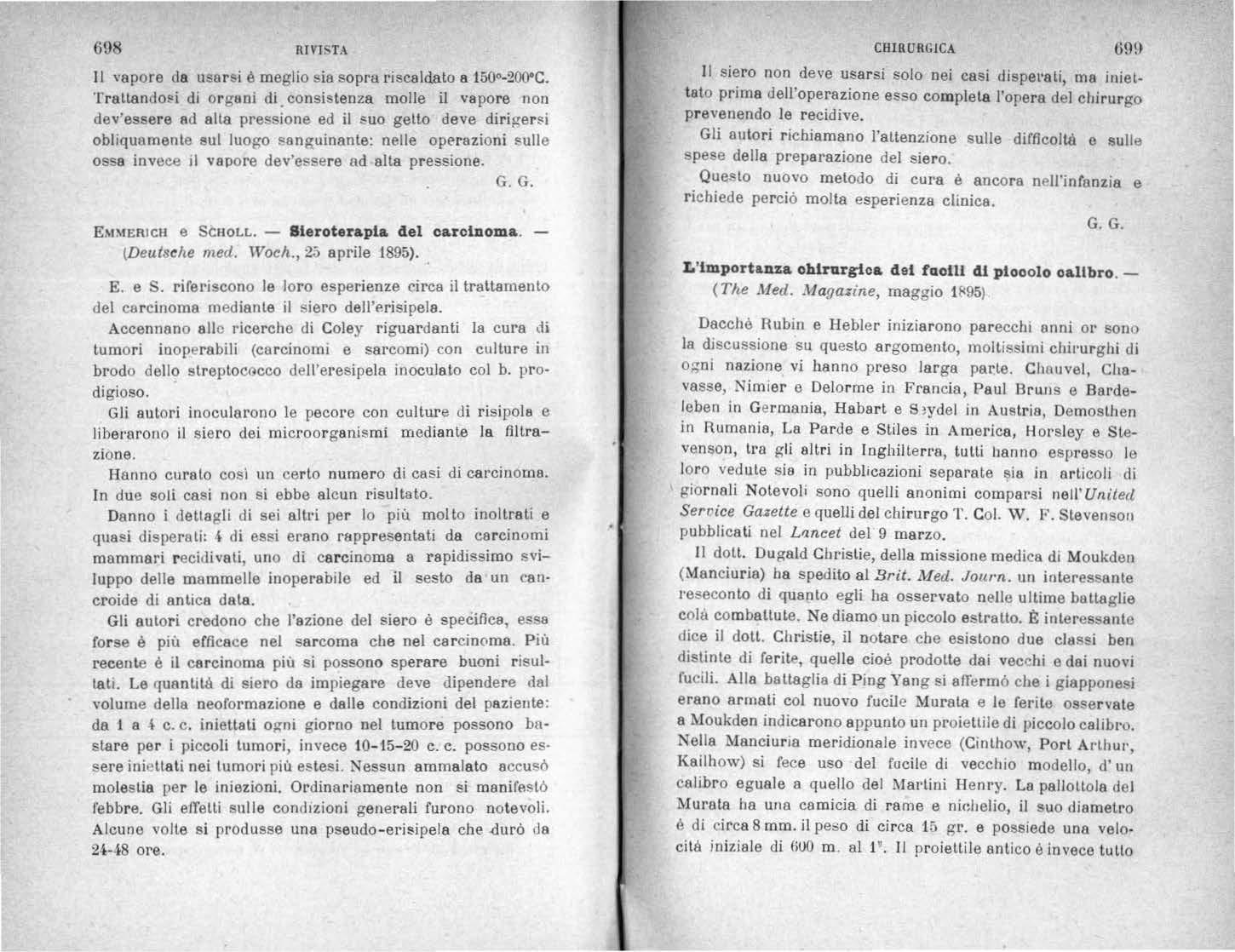
Accen nano alle l'icerche di Coley riguardanti la cura di tumori inope ra bili (ca r cinomi e sarcomi) con culture in brodo dello str eptococco dell'eresipela inoculato col b. prodigioso.
Gli autori inocularono le pecore con culture d i risipola o libel'arono il siero dei microorga nismi median te la flllrazione .
Hann o cu ralo cosi un certo numero di casi di carcinoma. In due soli casi non si ebbe alcun risultato.
Danno i dettagli di sei alli•i per lo più molto inoltrati e quasi disperali: 4 di essi erano rapp r esentati da ca r cinomi mammari r ecitl ivali, uno di ca r cinoma a rapidissimo sviluppo delle mammelle in ope rab ile ed il sesto da un cancroide di antica dala.
Gli autori credono che l'azione del siero è specifica, es!'la fo r se é più efficace nel sar coma che nel ca r cin{lma. Più recente è il ca rcin oma più si possono sperare buoni r isultati. Le quanllla di siero da im piegare deve dipende r e dal volume della neoformazione e dalle condiz ioni del paziente: da 1 a c. c. iniettati giorno nel tumore possono bastare per i piccoli tumo r i, invece 10- 15-20 c. c. possono es· sere inii' Llati nei tumori più estesi. a mm a lato accu!'l ò m o lestia per le iniezioni. Ordinariamente n on si manifAslò febb r e. Gli effetti sulle cond1zioni generali furono notevoli. A lcune volte s i produsse una pseudo - erisipela che -<iurò da 24-48 ore.
Chirurgica
I l siero non deve usarsi solo nei casi d ispet·ali, ma inietta to prima dell'operazione esso com pleta l'opera del chiru r go p r evenendo le recidive.
Gli au tori ri chiamano l'attenzione sulle dirRcolta e sulle spese della preparazione del siero .
Qu e'>to nuovo metodo di cura é ancora nell'infanzia e ri chiede perciò molla esperienza clinica.
G. G.
L 'Importanza. ohlrurgtca. dei faolll di piooolo oa.llbro .(T/te M ed .\Jagazine, maggio 1f<95)
Dacché Rubin e Heble r iniziarono parecchi anni Oi' sono la d1scussione su questo argomento, moltissimi chi1·urghi di nazione vi hanno p1·eso larga parte. Chauvel, Cliavasse, Nim1er e Oelo r me in Francia, Paul Brun s e Bardeloben in Ge rmania , Habart e S in Austria, Oe mosthen i n Rumania, La Parde e Stiles in America, H orsley e Stevenson, tra gli altri in Ioghille rl'8, tutti hanno espresso le lo r o vedute sia in pubblicazioni separate sia in a rt icoli di gio r nali Note voli sono quelli an on imi comparsi nell' Uniled Sert'ice Gazette e qu elli del chirurgo T. Col. W. F. Stevenson pubblicati nel LtJ.ncet del 9 marzo.
Il dott. Du gald Christie, della mis sione medica di Moukden (Ma n d uria) ha spedito al Brit. Med. Jottrn. un interessante reseconto di quanto egli ha osservato n elle ultime battaglie cola co mbattute. Ne diamo un piccolo estrallo. È interessante dice il dolL. Christie, il notare che esisto no due classi ben distinte di rerile, quelle cioè prodotte dai vecl'hi e dai nuovi fucili. Alla battaglia di P iog Yang si affermò che i giapponesi erano armati col nuovo fucile Murata e le ferile osservate a Moukden indicar ono a ppun to un proiett ile di piccolo calibro. Nella Manciu r ia meridiona le invece (Cinthow, P o r t A1·thur·, Kailh ow) si fe ce uso del fuc ile di vecchio m odello, d'un calibro eguale a q uello del Henry. La pallottola del Murata ha uua camicia di rame e ni<:helio, il suo diametro (', di circa 8 m m. il peso di ci r ca 15 gr. e possiede una velocità in iziale di CiUO m . al P. Il p r oi ettile antico é invece tutto di piombo e r1uind1 molto pni molle: il suo diametro è di 11 m m. il peso di circa :30 gr. e la velocità iniziale non é piu della melA di quello nuo,o. Le ferile prodoUe da rtuesti due proiellili differiscono considerevolmente le une dalle altre. Nella ma ggioranza dei casi curati a Moukden gli orifici ue erano piccoli, come puntura, senza contusione o lacerazion e . Xon contenevan o pezzt di abtti e non esisteva apprezzabile differenza tra gli o rifici d'entrala e quelli d'uscila. In un caso il proietltle aveva allraversalo il ginocchio destro dall'interno all'esterno. Benché il ferito avesse dovuto percorrere 200 miglia, le lesioni gua rit•ono perfettamente lasciando la giuntura in perfallo st.alo.
Parecchie volle le ossa et•ano state perforate nettamente senza fratture o sc heggi a: in due casi però l'amaro fu fo rtemente s minuz zato e le sc hegge ossee causarono una feJ'ita nelle parli molli lace ra eù a ma!'gini estrollessi. Si ebbe ro tre casi di ferile penetl'anti del polmone, seguiti da rapida guarigione.
Gli elrelli esplosivi che 11i attt·ibuiscono ai proiettili dotali di gronde velocità non furono mai notati e lo shock non fu notevole.
Parecch i solùatt pnl'lnvano di compagni fe riti all'addom e 1 quali s'accor set•o d'essere stati colpili dopo aver per corso molla strada. Benché la maggioranza delle ferile curale a furono prodotte dal proiettile tli vecchio modello, pure pa1•ecchie do vevano imputarsi al nuovo. Dei primi, ::W furon o estratti dalle varie parti del corpo e le ferile differiscono fortemen Le da quelle già descritte. Esse sono piu grandi, in ispecie quelle d'uscita le quali al cune volle sono lacere, conLu<>e ed est rofi esse. r pezzi d'uniforme s' incontrano di frequente rendendo i le fet•ite settiche con secrez'oni fetide. In un gran numero di casi, le ossa sono malamente fratturale e scheggisle e solo l'amputazione può salvare il paziente.
Il reso co nto del dc•tl. Christie contraddice in molli punti quanto ha affermato !Jemosthen colle sue deduzioni sp erimentali ed ha invece confe1•mato r1uanto hanno asserilo Beuns, llabart, Seyde l circa le fe1·ile nette delle ossa lunghe. Nell e
.,ue comunicazioni all'Accademia di medicina d1 Partgi nel !R!)}, Uemosthen affermò che in 6.) casi di frattura di umane prodotte alltl distanza di 5-HOO metri, egli non ebbe mai ad osservare semplici perforazioni senza produzioni di schegge: il che è contrario all'esperienze del dott. Chrislie. Da cio si deve inferire che gli effetti dei proietlilt incamiciali non si possono d edurre da su cadavP-ri. Da ll'esperi enza aetruislata nella si possono l'icavare le s eguenti conclusioni:
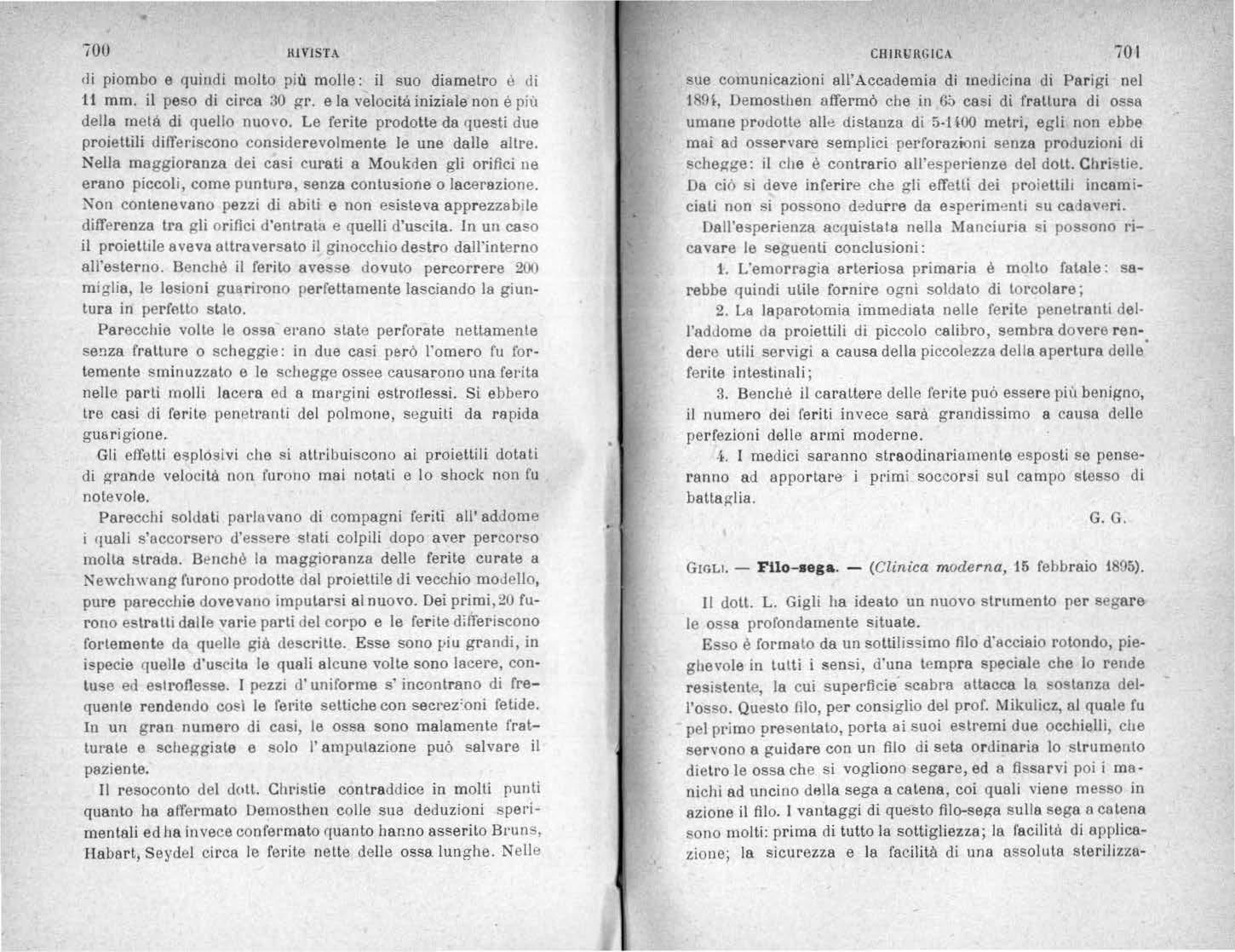
1. L'emorragia arteriosa primaria é mollo fatale: sarebbe quindi utile fornire ogni soldato di torcolare;
2. La laparotomia immedJata nelle fe rite penetranti dell'addome da proiettili di piccolo calibro , sembra dovere rendere utili servigi a causa della piccoleua d ella apertura delle· fet•ite inteslmal i;
3. Benché il carattere delle ferite può essere pii1 benigno, il numero dei ferili invece sarà grandissimo a causa delle perfezioni delle armi moderne.
1-. I medici saranno slraodinariamente espos ti se penseranno ad apportare i primi socco r si su l campo stesso di batlaf.tlia.
G. G.
GIGLI. - Filo- sega. - (Clinica m ode rna, 16 febbraio 1895).
Il dott. L. Gigli ha ideato un nuo,·o strumento per segare le ossa profondamente situate.
Esso é formalo da un sottilissimo filo d'acciaio r otondo, pieghevole in tutti i sensi, d'una tempra speciale che lo rende resi s t ente, la cui superfi cie scabra attacca la bOStanzn dell'osso. Questo nto, p er consiglio del prof. t\likulicz, al quale fu pel p1•imo pre-;entalo, porta ai suoi estremi due occhielli, che servono a guidare con un filo di set.a o r dinaria lo slrumeuto diel i'O le ossa che si vogliono segare, ed a fissarvi pot i manichi ad uncino sega a catena, coi quali viene messo in azione il fil o. l vant.aggi di questo filo-sega sulla sega a catena sono molli: prima di tutto la sottigliezza; la facilità di applicazione; la sicurezza e la facilità di una assoluta sterilizza- zione; la nettezza meravigliosa del taglio, da paragonat•lo p u alla sezione di un tagliente che di una st>ga; non ultimo e non disprez1abile vantag7io 'Tu ello del costo,che permette di avere a disposizio n e un nume r ò grande di strumenti da poterli sostituire a ogni evenienza, cosa impossibile con la sega a catena, a meno di non essere in cliniche ricchissime. riassorbimento completo del nodulo tubercolare od alla sua trasformazione connettivale. i. La involuzione dei noduli tubercolari, dietro la laparotomia. é rapida; ma in generale N' sta sempr·e qualche focolaio che tarda molto a scomparire, per cui l'a d'uopo essere mollo cauti nel parlare di anche quando le apparenze cliniche la farebbero "Upporre completa.
L'applicazione chiru r gica di questo strumento è già largamente provata: ha cor·risposto benissimo in tulle le operazioni fatte sul cadavere e fu già adoperato sul vi ''ente nelle resezioni del mascellare inferiore (per la cui durezza si pott·ehbe di r e operazione di pr ova), nella resezione dell'anca, nella resezione di coste, e il pt·of. Mikulicz più volte lo ha aùope rato anche nella resezione del mascellare superiore.
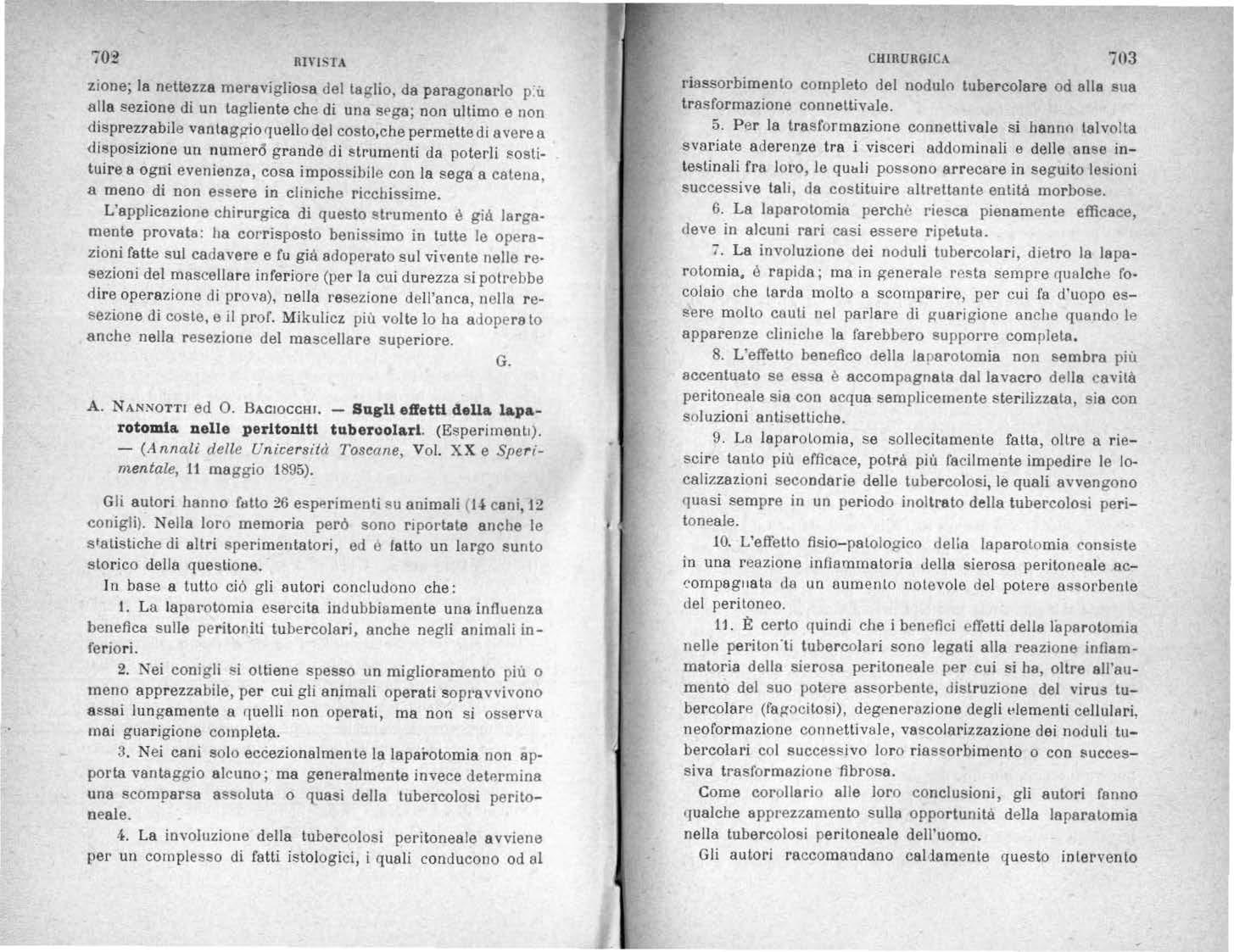
5. Per la trasfo r mazione connettivale s i ha nno talvolta svariate atlerenze tra i visceri addom inali e delle anse intestinali fra loro, le qujjli possono arrecare in segui to lesioni successive tali, da costituire allr•ettante entità morbose.
6. La laparotomia perchè t·iesca pienamente efficace, deve in alcuni rari casi essere ripetuta.
A. N ed O. BAcroccur. - Sugli effetti della l&parotomta nelle perltonltl tuberoola.rl. (Espe r imenLt).
- (A n.nali delle Unicersità Toseane, Vol. XX e Sperimentale, 11 maggio 1895).
Gli autori hanno folto 26 espPrimenti su animali { 14 cani, 12 conigli). Nella loro memoria però sono rrpot·tate anche le s 1at.istiche di all r i sperimentatori, ed o ratto un largo sunto stor ico della questione.
I n base a tutto ciò gli autori concludono che: l. La laparotomia eser·cita indubbiamente una influenza benefica sulle periloniti tubercolari, anche negli animali inferiO r i.
2. conigli !'i ottiene spesso un miglioramento più o meno app r ezzabile, per cui gli animali operati sopravvivono assai lunga mente a quelli non operati, ma non si osserva mai guarigione completa.
3. Nei cani solo eccezionalmente la laparotomia non apporta vantaggio alcuno; ma generalmen te invece delPrmina u na scomparsa assoluta o quasi della tubercolosi periloneale.
4. La iovoluzione della tubercolosi peritoneale avviene pet' un complesso di falli istologici, i quali conducono od al
8. L'effetto benefico della la parotomia non sembra più accentuato se essa è accompagnata dalla'.'acro della ca\'ità peritoneale sia con acqua semplicemente sterilizzata, sia con soluzioni antisettiche.
9. La laparotornia, se sollecitamente falla, oltt•e a riescire tanto più efficace, potrà più facilmente impedire le localizzazioni secondarie delle tubercolosi, le quali avvengono f]Uasi sempre in un periodo inoltrato della tubercolosi peritoneale.
10. L'effetto fisio-patologico della laparolomia consiste in una reazione infiammatoria della sierosa peritoneale ac-:-ompag11ata cla un aumento notevole de l potere Msorbenle del peritoneo.
11. È certo quindi che i bencflci effetti della laparotomia nelle pet•ilon ·11 tubercolari sono legati alla reazrone infiammatoria della sierosa peritoneale per cui si ha, oltre all'aumento del suo potere assorbente, distruzione del virud tubercolare (fagocitosi), degen et·azione degli celluh1 r i, neofo rm az ione connettivale, vascolarizzaz ione dei noduli tubercolari col successivo lo r o rias<>orbimento o con successiva trasformazione fibrosa.
Come corollario alle loro conclusioni, gli autori fanno rJualche appr•ezzamento sulla oppo r tunita della laparatomia nella tubercolosi periloneale dell'uomo.
Gli autori raccomandano caliamente questo intervento operatoriO come quello che, nella maggior parte dei casi ha ti poter'e di determinare una t·apida a completa per•lonPale e consigliano che la Japarolomia sta esegu tla sollecitamente. fretta il p1·ocesso obliteran te; b" la completa oblilerazione Jell' appendtce è una spontanea e p•' rrnanenle cura della malattia; 9• in vista della prolungata e de i pericoli che l'attendere l'obHleraztone spontanea, è indica ta un'operazione radicalE>, la •Jualo deve non appena la diagnosi é divenuta certa.
. Gli autori non sono propensi alle iniezioni inlt•aperJLoneali d1 naftolo canforato od alle inieziont inlravenose di acido pr oposte da qualcuno pe r la cuca della Lubercolost per1toneale.
SeNN. - L ' appendlolte obliterante . - (Jo urn. of l/w Am. m ed. Ass. ).
Il pro f. Seno richiama l'attenzio ne dei medic i su d'una clinicamente e anatomicamente ben definila di appe n· dtctte, ltt quale !in qui venne confusa colle altre e cui egl1 ha dato il nome di appendicitis oblitera ns. I caratteri di questa malattia sono i seguenti: J• l'appendicite obliterante é una forma comparativamente frequente dell'inllammazione t•eciùivante dell'appendice vermiforme; :2• essa è contraddistinta da una progressiva obliterazione del lume dell'appendice, dalla scomparsa tlell'epitE'Iio e del tessuto glandolat·o e dalla produzione di granulaziom emananti dal connettivo sotlomucoso, le quali, trasformandosi in tes!'uto ctratriziale , menano alla chiusura del viscere; 3o le alle r azioni s'iniziano sia nella mucosa dell'appendice , s o tto forma di semplice ulcerazione, s•a processo interRti;dale i linfatici ; 4" sintomi piu costanti che accompagnano questa forma di appendicite sono acute esacerbazioni di corta durata, modica tumefazione della regione, e p<'rstslenza della dolot·abililà di durante le intermis!'ioni; 5o il processo obliterante può cominciare dall'estremo perifel'ico o centrale o da un punto intermedio qual 8 iasi, oppure conlempo!'aneamente da più punti; s· l'oblilerazion e della parte centrale produce la ritenzione d i materiale s e tt.ico, trovando esito nei fintatici determina linfangite e suppurati va; 7• una cir•coscritta peritonite plaSLtca a ccompagna quasi semp1·e que!!t'appendicile e af-
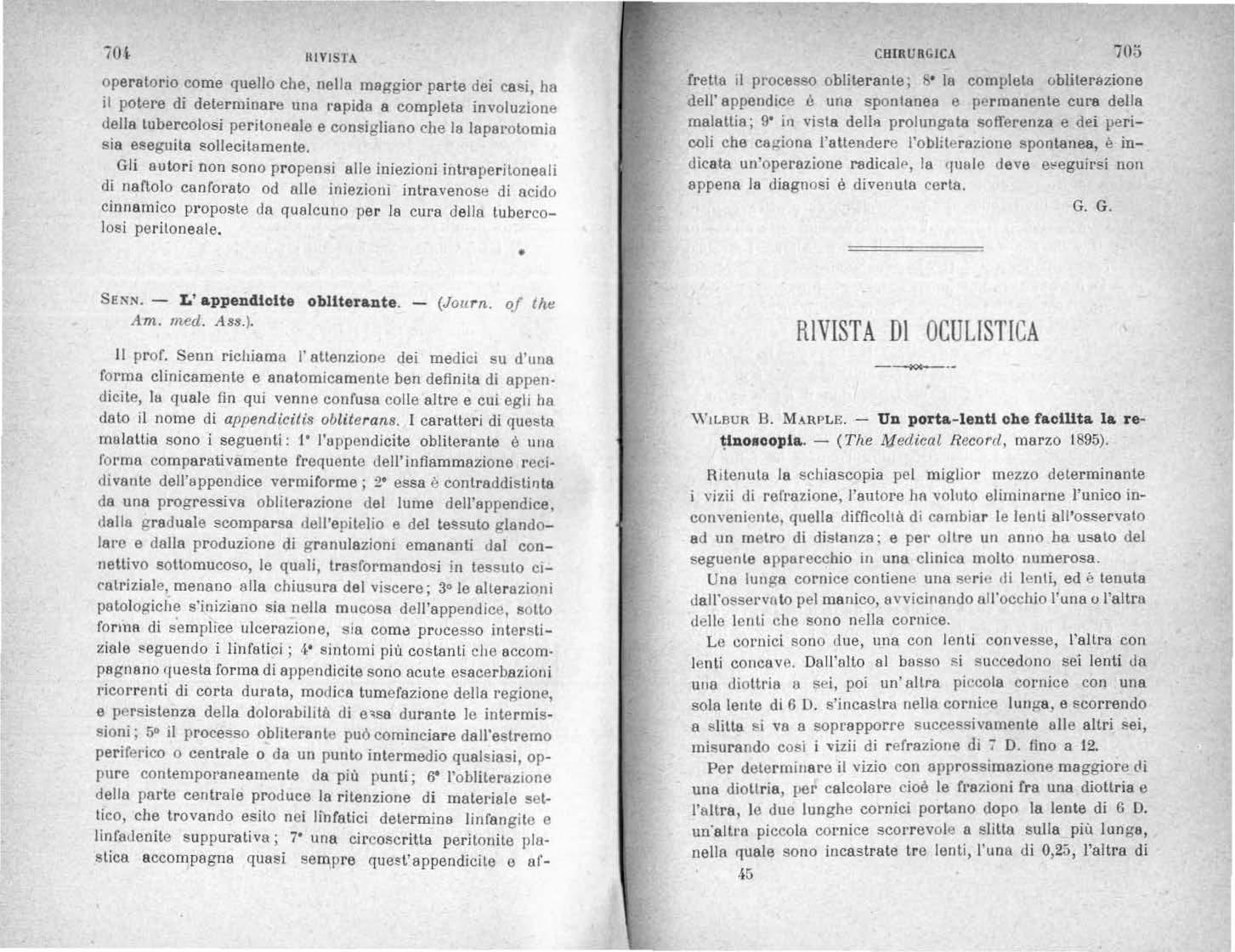
\\'tLBUR B. M ....RPLE. - Un porta-lenti ohe faolllta la retlnoaoopla . - (The },Jedical Record, marzo 1895).
Ritenuta la schiascopia pel miglior mezzo determinante i \'izii di refrazione, l'autore ha voluto eliminarne l'unico inconveni e nte, quella difficoltà di rambiar le lenti all 'osservato ad un metro di distanza; e pet· oltre un anno ba usato del seguente appa1·ecchio in una clinica molto numerosa.
Una lunga cornice una s e rtP di h•nti, ed é tenuta dall'osservuto pel manico, avvicinando all'occhio l'una o l'altra dell e le nti che sono nella corn1ce.
Lo cornici sono due, una con lenti convesse, l'altra con lenti concave. Dall'allo a l basso si succedono sei lenti ùa una dioltr'ia u s l!i, poi un'altra piccola cot·nice con una sola lente di G O. s'incaslra nella cornice luuga, e scorrendo a slilla va a soprappor1•e Rucce!'tsivamE'nle alle altri sei, misurando cosi i vizii di r e frazioue di 7 D. fino a 12.
Per dete r miuare il vizio con approssimazione maggiore t.li una diott r ia, per calcolare cioé le frat.ioni fra una diottria e l'altra, le due lunghe cornici po r tano dopo la lente di G O. un'altr'a piccola cor·nice scorrevol e a slitta stùla più lunga, nella (!Uale sono incastrate tre lenti, l'una di 0,2::>, l'altra di
DI OCUI.ISTICA 707
0,50, la terza di O,i5 D. , ma queste tre ultime lenti sono positive nella cornice delle lenti negative, e negaLive nella cornice delle positive.
Cos1 se un fosse affetto da ipermatropta di D. 3,50, egli porrebbe davanti al suo occhio la lente positiva dì D. 1, l'osservatore vedrebbe che il vizio di r Pfrazione non sa1·ebbe corretto, ed inviterebbe il paziente a guardare attraverso la lente successiva+ D 2, e cosl successivamente fino alla lente di+ D. 4 che sopracorreggerebbe il difetto. Allora si farebbe scorrere sulla lente di+ D. 4 la piccola cornice sino alla lente di- D. 0,25, si vedrebbe an co ra che il difetto sarebbe sovracorretto, si farebbe scorrere la lente di -0,50 e SI arriverebbe cosi ad una giusta correzione, onde s i dedurrebbe il vizio di re frazione essere eguale a+ 4 D.- 0,50 D. - 3,50 D. Sulla piccola co1·nìce che scorre sulla grande -.'è una piccola molla che scalla fuori un bottoncino il quale entra in un occhietto della grande cornice allo rquando la !cute frazionale ricopre esattamente quella a diottrie inte1•e.
Per consiglio del dottor Gruening l'autore ha fatto aggiungere a ciascun lato della cornice un rilievo meLallico onde le lenti non si opachino toccando la fl'onte o la faccia dell'osservato
Lo strumento è fabbricato da l signor Meyrowitz- W est a Nuova Yo r k, Thirly- firsl 20.
SJLVESTRJ.- Sulla our& ohl rurgioa d ella mlopla: g rave.(Accad. med . .fisica fiorentina, seduta del27 maggio 1895).
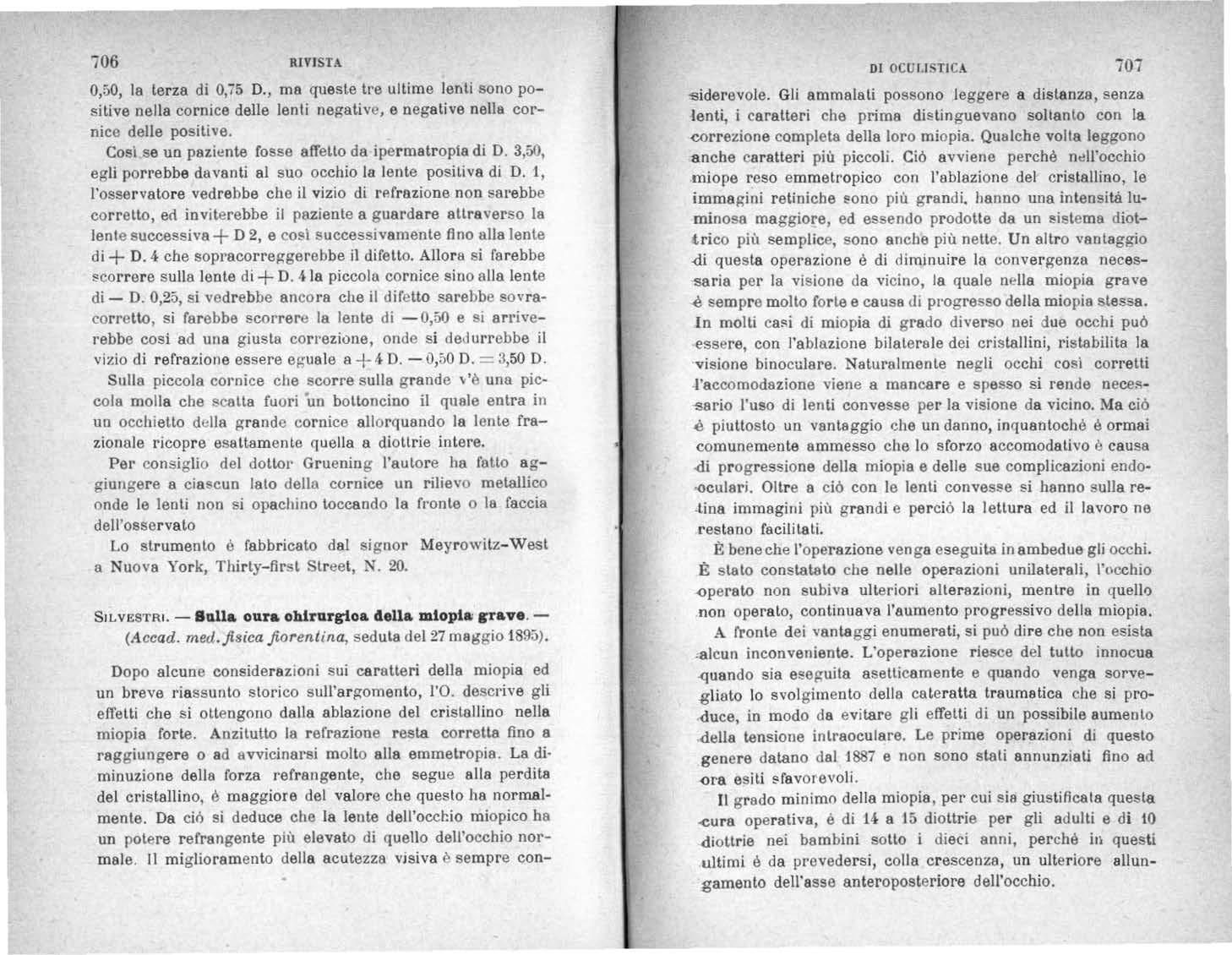
Dopo alcune consideraz ioni sui caratteri della miopia ed un breve riassunto storico sull'ar gomento, l'O. descr•ive gli effelLi che sì ottengono dalla ablazione del c ristall in o nella miopia forte. Anzitutto la refrazione resta corretta fino a raggiungere o ad ùvvicinarsi mollo alla emmetropia. La di· miouzione della forza refrangente, che segue alla perdita del cristall ino, é maggiore del valore che questo ha normalmente. Da ciò si deduce che la lente dell'occl::io miopico ha un potere refrangente più elevalo di quello dell'occhio normale. Il miglioramento della acutezza vJsiva è sempre con-
10iderevole. Gli ammalati possono leggere a distanza, senza i caratteri che prima distinguevano soltanto con la correzione completa della loro miopia. Qualche volta leggono anche caratteri più piccoli. Ciò avviene perché nèll'occhio miope reso emmetropico con l'ablazione del c ristallino, le immagini retiniche eono più grandi. hanno una intensità luminosa maggiore, ed essendo prodotte da un !!istema diottrico più semplice, sono anche più nette. Un alt r o vantaggio <li questa operazione é di diminuire la conve r genza necessaria per la visione da vicino, la quale nella miopia g ra ve sempr e mollo forte e causa di p1·ogresso della mio pia stessa. In molti di miopia di grado diverso nei due occhi può essere, con l'ablazione bilaterale dei cristallini, ristabilita la visione binoculare. Naturalmente negli occhi cosi corretti l'accomodazione viene a mancare e spesso si rende necesl'uso di lenti convesse per la visione da vicino. Ma ciò è piuttosto un vantaggio che un danno, inquantoché è ormai comunemente ammesso che lo sforzo accomodalìvo è causa -di progressione della miopia e delle sue complicazioni endo-oculari. Oltre a ciò con le lenti convesse si hanno sulla re-lina immagini più grandi e perciò la lettura ed il lavo ro ne restano facilitati.
È bene che l'operazione venga eseguita in ambedue gli occhi. È stato constatato che nelle operazioni unilaterali, l'tlCChio ()perato non subiva ulteriori alterazioni, mentre io quello non operato, continuava l'aumento progressivo della mìopia. A f'ronle dei vantaggi enumerati, si può dire che non esista .calcun inconveniente. L'operazione riesce del lutto innocua -quando sia eseguita asetlicamente e quando venga sorve.gliato lo svolgimento della cateratta traumatica che sì produce, io modo da evitar e gli effetti di un possibile aumento ..della tensione inlraoculare. Le prime operazioni dJ questo genere datano dal 1887 e non sono s tati annunz iati tlno ad ora esiti !:>favorevoli.
11 grado minimo della miopia, per cui sia giustificata questa -cura operativa, è di 14 a 15 diottrie per gli adulti e di 10 diottrie nei bambini solto i dieci anni, perché in questi ultimi é da preveder s i, colla c res cenza, un ulteriore allungamento dell'asse anteroposteriore dell'occhio.
L'ablazione del cristallino viene ollenuta principalmente per mezzo della disci!!-ione, ma questo metodo ha l'inconveniente di assai lungo, 1mche perché la maggior parte degli operatori fanno una incisione capsulare m o lto piccola. L 'estrazion e lineare semplice delle masse opache abbrevia notevolmente la dura ta della cura.
Il metodo adoperalo dall'O. nei suoi ultimi casi, che in tutti sono in numero di 6. dei quali due operati ad ambedue gli occhi, è il seguenle:
Determinazione esalta della miopia e dell'astigmatismo per mezzo della schiMcopia o del metodo subiettivo con occhio alropinizzato e misura della acutezza. Discisione am pia e profonda della capsula e della sostanza della lente con pupilla midt'iatica. Cosi il cristallino si opaca rapidamente e dopo pochi gio rni pu6 essere eseguita l'estrazione della ma!'>sima parte delle masse cataralt ose. Com e aLlo finale può occorrere la discisione d ella membrana capsulare. lo tutto la cura non dura più di un mese
L' O. presenta una donna dell'età di :36 anni con una miopia di 16 diottrie all'occhio destro, di 13 al sinistro e V = •t,8 ir,completo da ambedue gli occhi, con correzione. Fu operata dall'occhio d es tro col metodo ora descl'iLlo e sarà in seguito operata dal siniqlr•o. La cura duro un mese preciso e l'esito ru V = 1/ 18 perretlo con + l. Ebbe nei primi giorni macropqia che poi scomparve. Dall'occh io operato si nota un lieve reslringimento concen tr ico del c ampo visivo, dovuto probabilmente a llo spostamento mdietro de l piano pupilla re.
La descr•zione particolareggiata degli aJlri casi sarà fatta nella pubblicazione per esteso. •
FRANK lNGERSOl, PROCTOR. - Un mezzo aempllolaalmo per aoovrire l vizi èl1 refraztooe, e 1' llulufilotenza de l muaoolt oculari. (T/te Boston Medicai and Surgical Journal, 1895).
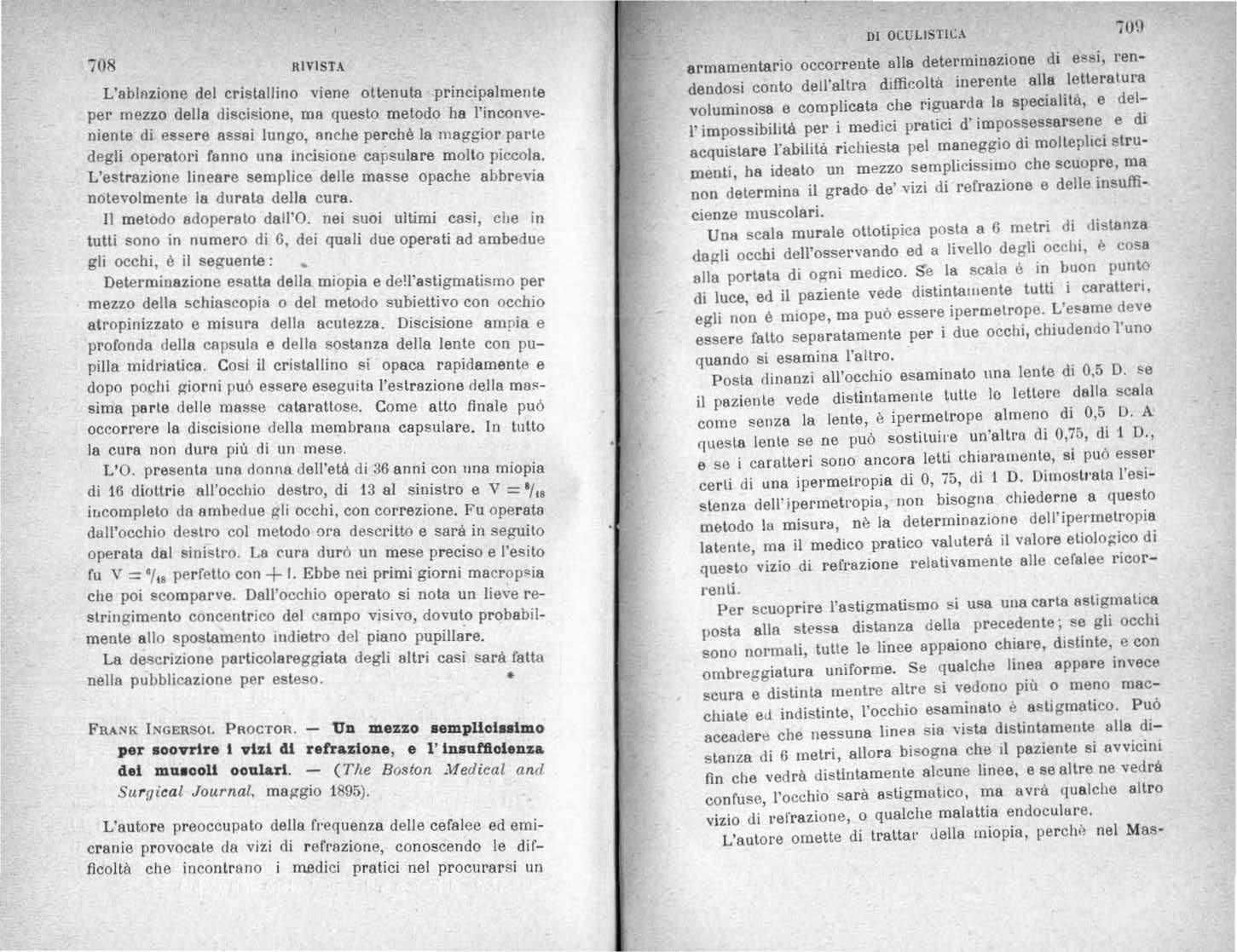
L'autore preoccupato della rr·equenza delle cefalee ed emicranie provocate da vizi di r efrazione, conoscendo le difficoltà che incontrano i medici pratici nel procurarsi un armamentario occorrente alla determiuazrone di rendendosi conto dell'altra difficoltà inerente alla letteratura voluminosa e complicala che riguarda la specialità, e dell' impossibihlé. per i medici prati ci d' e di acquistare l'abilità ri chiesta pel maneggio di molleplrci strumenti, ha idealo un mezzo semplicissuno che scuopre, ma non determina il grado de' vizi di refrazione e delle insufficienze muscolari.
Una scala murale oUolipica posta a 6 metri di ·listanza dagli occhi dell'osservando ed a livello degli occhi, è alla portata di ogni medico. Se la scala ò in buon punto di luce, ed il paziente vede distintaruente tutti i caratter·i, egli nou è miope, ma può essere ipermetrope. L'esame deve esser e fatto separatamente per i due occhi, chiudendo l'uno quando si esamina l'altro.
Posta dinanzi all'occlùo esaminato una lente di 0,5 D. se il paziente vede distintamente tutte lo lettero dalla scala come senza la lente, è ipermeLrope alm ono di 0,5 U. A questa lente se ne può sostituire un'altra di O,ir), di l 0., e se i caratteri sono ancora letti chial'amente, si può esser certi di una ipe1•metropia di O, 75, di l D. Dimostrala l'esistenza dell' ipet·met eopia, non bisogna chiederne a questo metodo la misura, nè la determinazione dell'iper·melropia latente, ma il medico pratico valuterà il valore etioiOf'ÌCO di quettto vizio di refrazione relath•ame nte allo ceralee ••icorl'enti.
Per scuoprire l'astigmatismo si usa una carta astigmatica posta alla stl'ssa distanza della precedente; !.'e glr occhi sono normali, tutte le linee appaiono chiare, drstinte, e con ombreggiatura uniforme. Se qualche linea appare invece scura e distinta mentre allre si vedono più o meno macchiate eù indistinte, l'occhio esaminato è a stigmatico. Può accadere che nessuna linea sia vista distintamente alla distanza ùi 6 metri, allora bisogna che rl paziente si avvicim fin che vedrà distintamente alcune linee, e se altre ne vedrà conruse, l'occ hio sarà a stigmattco, ma avrà qualche altro vizio ùi •·errazione, o qualche malalLia enùocultu·e.
L'autore omette di trattai' della miopia, pe r chò nel Mas- sachllssetl dove egli insegna otlalmologia, la semplicemiopi& é molto rara , perché i miopi conoscono il loro difetto, e perché la miopia produce sintomi ne r vosi in minorgrado dell'ipermetropia e dell'astigmatismo.
Per scuopr ire l'insufficien za muscolare bisogna osserva re parzialmente la camera. L'autore distingue l'exoforia, che secondo Stevens è una tendenza della visuale in fuori, dall'enùoforia che é tendenza della linea visua le in dentro e ' dall' iperforia o tendenza della visuale in alto.
P er esaminare l'equilibrio de' muscoli laterali, egli colloca. una candela accesa a 6 metri dal paziente, ed a livello dei suoi occhi. Chiuso l'occhio s ini s tro il paziente guarda la cande lo col destro. Il medico allora pone davanti all'occhioaperto una bacchetta di vetro dalla grandezza di un lopisr e la tiene orizzontalmente; in tal posizione il paziente vede. una linea verti cale di luce ol posto della fiamma della candela. I n questo momento il paziente apre l'a ltr'occhio, il quale vede la fiam ma della candela, mentre l'occhio destro vede la li nea di luce. Se questa linea luminosa pasM di r ettam en te attraverso la fiamma, i muscoli laterali sono io equilibrio. S e la linea luminos a é veduta a destra della fiammar v' é enJoforia, se é veiuta a sinislt'a v' é exofo ria.
Chiuso l'occhio sinistro e tenuta la bacchetta vert icalmente davanti al si vede una linea orizzontale di linee al posto della fiamma. Se si apre l'occhio sinistro, questo vede. la fiamma, mentre l'occhio destro vede la linea di luce. Se non esiste deviazione verticale degli assi ocula ri, la linea di luce inc r ocierA direttamente la fiamma, ma se la linea sarà :vista al disotto della tìamma, vi sarà iperforia dest r a, se al disopra della fiamma si avrà iperfo r ia s in1stra.
Il g r ado di deviazione degli assi ottici sarà dato dalla distanza fra la linea luminosa e la fh1mma della candela. ogni caso bisogn a aver presente l'osservazione di De Schweinilz, che un equilibrio assoluto de' muscoli esterni dell'occ!Jio è raro quanto l'emmetropia, e che le leggiere deviazioni la terali spesso non hanno a lcuna importanza.
Rivista Delle Malattie Veneree Edella Pelle
Dott. G. PICCARDI. - Appllcazlonl locali 41 traumatlollla nella cura della •Ulllde. - (Gtornale ;ella Reale Accademia di m edi<·ina di Torino, marzoaprile 189!>).
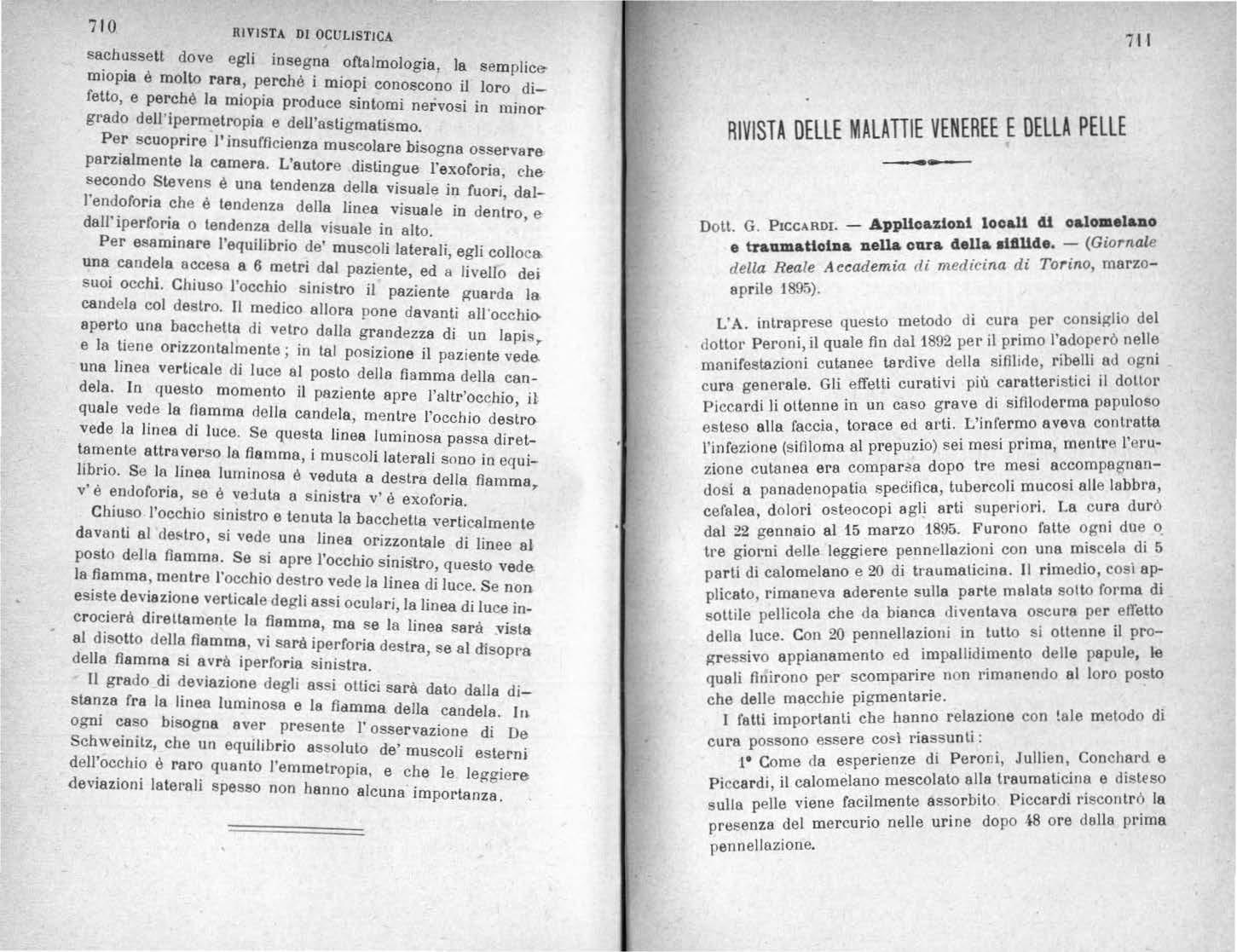
L 'A. intraprese questo metodo di cura_ per' consiglio del dotlor Peroni, il quale fin dal18!)2 per il_prlmO l ·restazioni cutanee tardive della Slf1Me, ribelli ad ogm mam le Gli effetti curativi più caratteristici il dotto1· cur a gene1·a . 1 Piccardi li ottenne in un caso grave. di sifiloderma papu. oso Leso alla faccia torace ed al• ti. L'rnfermo aveva conltatta es ' · · entre l'eru l'mfezione (sifìloma a l p r epuzio) sei mesi mzione cutanea era compar<;a dopo tre dosi a panadenopatin specifica, alle labbra, cefalea, d olori osteocopi a gli a r ti supei'I OrL La durò dal 22 gennaio al 15 marzo 1895. Furono fatte o tre gioi'Di delle leggiere con m_1scela .dr 5 parli di calomelano e 20 di traumalJcma. I l r1med1o, cos1 plicato, riman eva a de r ente sulla parte malata solto forma d1 sottile pellicola che da bianca diventava oscuJ'& per _effetto della luce. Con 20 pennellazioni in tutto SI ollenne Il progressivo appianamento ed impallidimento delle papule, le quali finirono pe r non rimanendo a l loro posto che delle maccllie pigmenta r le.
1 faUi importanti che hanno relazione con !aie m etodo di cura possono essere cosi . .
t• Come da esperienze dt Perom, •. e P . d" ·1 calomelano mescolato alla traumallcura e ICC8 r l, l d" . t Ò la sulla pelle viene facilmente assorbito Plcca r l rlscou r. presenza del mercurio nelle urine dopo 48 ore dalla prima pennellazione.
:20 L'a!'lsor·bimento (probabìlrnenle sotto forma di bicloruro) avviene lentamente e l'organismo rimane mercurializzato anche per un <:erto tempo dopo la cura. Piccardi trovò il mercurio nelle urine dopo 8 dall'ullima pennellazione.
3° Il calomelano, cosi applicato, può sostituire le inirzioni sottocutanee ed intram uscolari (Scarenzio) senza preseotarnP gl'inconveoienli, c col vantaggio di poterne sospendere l'assorbi mento in CA!'O J'tntolleranza lO[.tlienùo l'eccesso che tr o vac;i sulla pelle mc liante lavature. È preferibile poi agli unguenti per pulizia e comodità di applicazion e .
4° S e c\ vera J'ipote:-;i di Pellìzzat•i, che il mercut'io non agisce sull'111fezione generale dell'or·ganismo, ma soltan to sulle manifestazioni sifllitich l', le applicazio ni di caJomelano e traumalicina sarebLero lo più r uz ionali, permettendo di cula sifilide localmente, Mnza satut·are in egual misura tutle le parti dell'o1'gani$mo. c .
Coutrlbuzlone alla. etiologia. della. sUIUde terziaria. _
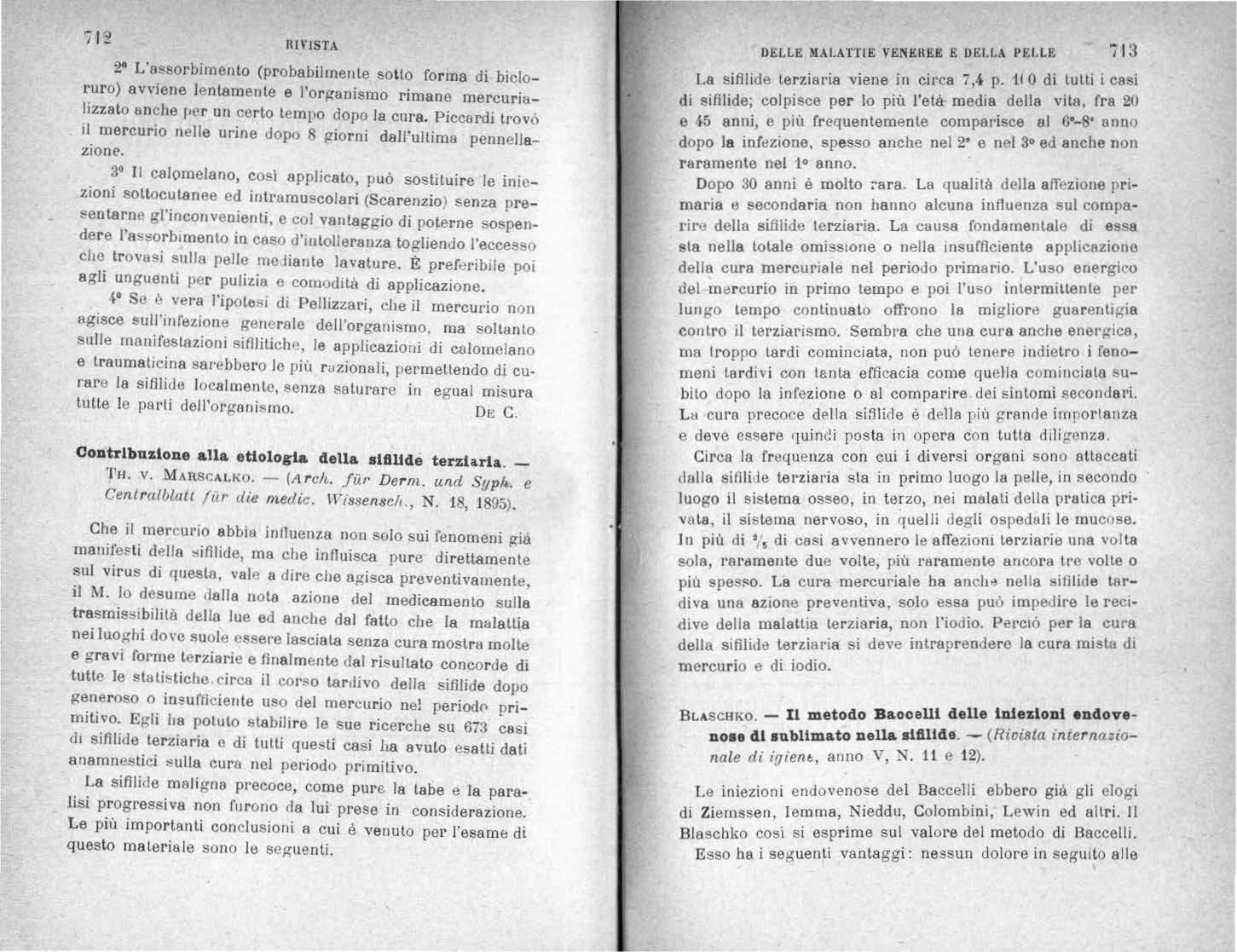
'l'H. v. MARSCALI<O. - (A rch. fur De r m. und Sgplt. e Cenlralblatl /iir rlie medie. W issensch ., N. JS, 1895).
Che il merc urio inOuenza non solo sui fenomeni già manifesti della s ifllid e, ma che influisca pure direttamente sul virus di questa, a dire che agisca preventivamente, il lo dcsurne dalla nola azione del medicamento sulla lrasmissJ bililà dello lue ed anche dal fatto che la malattia nei luoghi dove suole essel'c lasciata s enza cul'a mostra molle e gravi fol'mo te r ziarie e finalmente dal risultato concorde di tutte le slati'-tiche C'it·ca il cor"o tanlivo della sifilide dopo g-eneroso o us o del mercu ri o nel period() primitivo. Eg li l•a potuto stabilire le sue ricerche su 673 casi d1 sifilide terzial'ia e di tutti questi casi ha avuto esatti dati anamnestici curA nel periodo pr1milivo.
La sifilide maligna p1·ecoce, come pure la labe e la paralisi progl'essiva non furono da lui pr·ese in considerazione. Le p i ù importanti conclusioni a cui é venuto pel' l'esama di questo materiale sono la seguenti.
DELLE MALATTIE VEN&REE E DELLA PELLE 7 13
La sifilide terziaria viene in ci1·ca i ,4 p. 11 O di lutti i casi di sifilide; colpisce per lo più l'eta media della vita, fra 20 e i5 anni, e più frequentemente compaPisce al fì•-s• anno dopo la infezione, spesso anche nel 2• e nel 3° ed anche non r aramen te nel 1° anno.
Dopo 30 anni e molto :-ara. La qualità della alli.lzioue primaria e secondaria non hanno alcuna influenza sul comparii'•' della sifìlide terziaria. La causa fondamentale di essa sta nella totale omiss1one o nella Jnsurflciente applicazione d e lla c ura mercut'iale nel periodo primHio. L'uso energico del m e r curio in primo tempo e poi l'u!<O inlermillenle per tempo continuato offrono la migliore gua r e nti gia contro il terzit1r1smo. Sembt•a che una cu1·a anche ene1·gica, ma troppo tardi cominciata, non può tenere indietro i fenomeni tardivi con te.nla efficacia come quella cominciala subito dopo la infezione o al compaPi re tlei sintomi secondari. Lu cuPo pPecoce della si:=ìlicle è della più importanza e deve essere t]uindi posta in opera con lulla
Circa la fr equenza con cui i diversi o r gani sono attaccati dalla sil11ide lePziaJ·ia sla in primo luogo la pelle, in secondo luogo il sistema osseo, in terzo, nei malati della pl'atica privata, il sistema nervoso, in r1uelli deg li ospedali le mucose. l n più di 1 11 di casi a vvennero le affeziom terziarie una voi ta sola, rat•amente due volle, più ra ramen te tre volle o più speS!"O. La cu1·a mercuriale ba an ch " nel la sifilide tardiva una az ione preventiva, solo essa può impedire le recidive della malattia terz1ari a , non l'iodio. Pet•ctò per la CUJ'a della s1tilide Lerzia1·ia si deve intrapr endere la cura mish.1 di mercurio e di iodio.
BLASCHKO. - D metodo Baooelll delle inlezloul eudoveDOie dl 1ubllmato nella sUlUde. - (Rioisla inte rn ct;ionale di anno V, 11 e 12).
L e iniezioni endovenose del Baccelli ebbel'o già gli clogt di Ziemssen, lemma, Nieddu, Colombini, Lewin ed altri. Il Blaschko cosi si esprime sul valore del metodo di Baccelli. Esso ba i seguenti vantaggi: nessun do lore in segUJ lO alle iniez1oni se esse sono falle nelle vene; la dose piccola di mercu rio che si richiede per avere l'effetto cu r ativo; l'esalto dosa mento d e l rimedio; il fatto che tutta la quantità iniettata di far maco viene assorbila; infine la mancanza di ogni sgra· devote fe nomeno concomitante e di ogni s intomo d'avvelenamento.
L'i nconveniente fallo rilevare da taluni, cioè delle difficoltà tecniche ine renti al metodo, si vincerà fa cilmente con un poco di esercizio.
Di g rande va lore è il metodo Baccelli in tutti quei casi in cui non possono som mio istrarsi g randi dosi di mercut•io; cosi nei t isici, negli individui depe riti e nervosi, come pure in quelli nei quali lo g ran di dosi dt mercurio producono fe · nomeni sgradevoli.
L'importanza principale del metodo Baccelli s ta, secondo il Blaschko, nel suo allo significato teorico. Esso ci iosegna come minime dosi di mercurio $Ono in g rado di far scomparire i sintomi della sifilide, e r ende probabile la s u p· j)Osizione che coo gli altri metodi di cura solo una piccola parte del met'CI.lrio intro dotto è assorbito ed entra in e che perciò d'ordina ri o n oi facciamo un colossale spr eco dt mercurio.
Io fine da un altro Ialo é importante il metodo Baccelli, io quanto che esso inaugura in modo tr ionfale la terapia intravenosa. Già prima il Baccelli stesso avea eseguito le iniezioni intr avenose di chinina nella malaria, di lu bet•colioa nella tubercolosi polmooar e, di sublimato in molle infezioni. E già molli clinici si occupano di queste ri cerche tera piche. Per la sifilide molti, dopo la pubblicazione di Baccelli, hanno sperime ntato con buon successo le iniezioni endovenose di su· blimato. È da sperare che anche per a Hl'i farmachi verrà tentata la via seguendo le orme tracciate si splendidamente dal clinico di Roma.
Rivista Di Te Ra Peu Tica
HEU BNEI\ 1 BAGINSKY ed allri. - Bltlaltatl della lleroterapla nella dlfterlte. - (Xlii Co ng ruso di medicina inte rn a tenuto a Monac o dal 2 al 5 a pr ile 1895. Morgagni, 18 ma ggio 1895).
recente conp;resso di medicina interna a Monaco si discusse largam ente sulla sir rotera pia nella difterite. L'argomento è cosl interessante dal lato scientifico e dal Ialo pratico, che ci pa r util e riassumere quella discussion e. Heubner. - Da prima uno sgua r do allo sviluppo successivo delle idee e degli esperimenti che condussero Beh ring alla scoperta del siero antidifle ritico.
Discute pot la qu estione fino a che punto si è autorizzali ad ap plicare al letto dell'amma lato i risultati ottenuti negli animali . Con una ser ie di curve dimostra che il carattere pandemico della difterite, dal lempo in cui é stata iniziata la siero-t erapia, non è affatto peggiorat o.
Da uno sguard o alla sta tistica dei risultati della cura della difterite col siero nel 1891. in tutti gli ospedali di Ber lino, da cui si rileva che la mortalità é ridotta della metà. L'oratore passa quindi a discute r e le s ue proprie osser vazioni che riguardano 207 casi, di c:ui 26 complicali, 18 1 genuini; tutli furo n o curali co l siero.
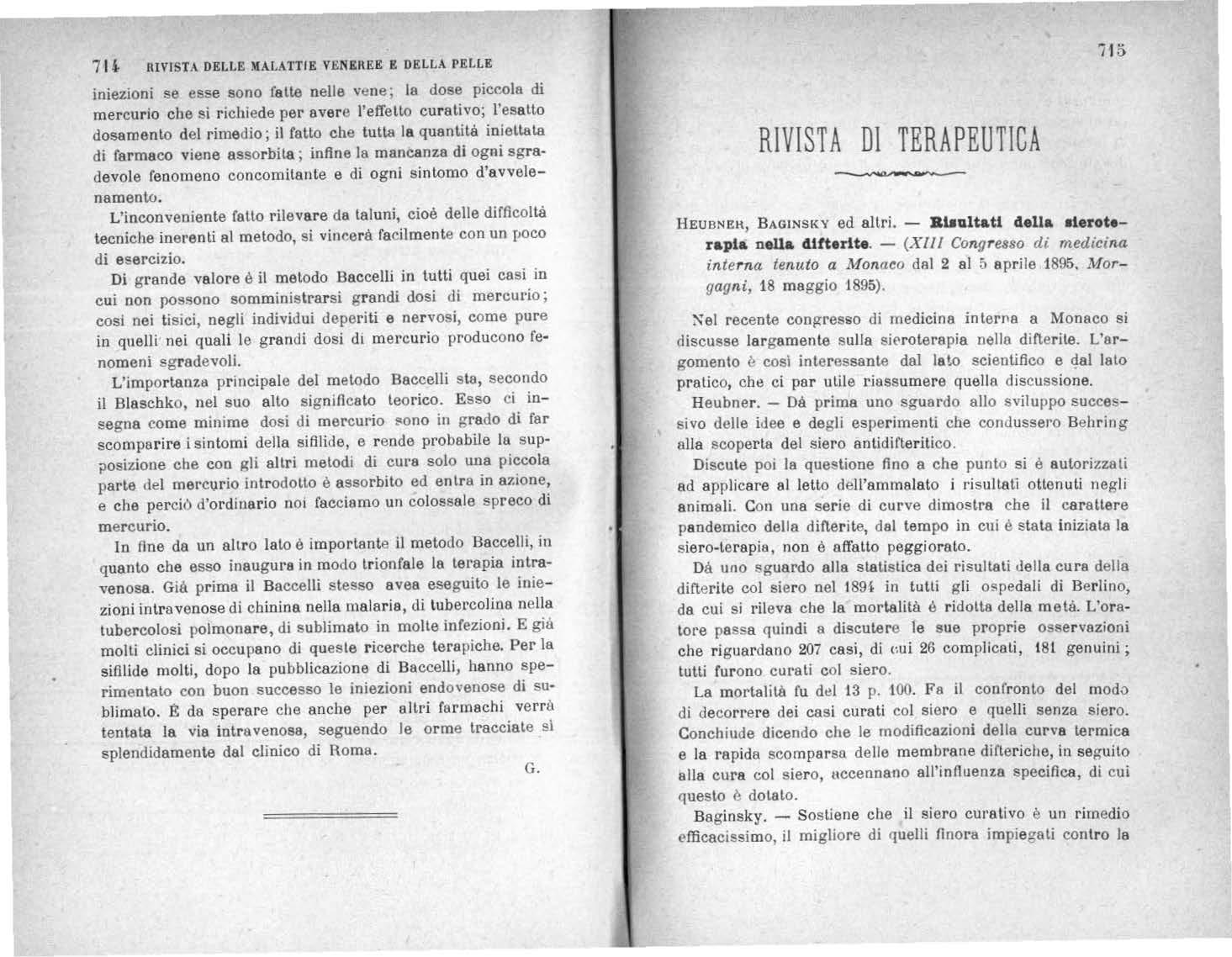
La morLal ilà fu del 13 p. 100. Fa il conrronto del modo di decorrere dei casi curati col siero e quelli senza siero. Conchiude dicendo che le modificazioni della curva termica e la rapida scompar sa delle membrane difler ic he, in seguito alla cura col sier o, ttccennano all'influenza specifica, di cui questo è dotato.
B aginsky. - Sostiene che il sier o cura tivo è un rimedio efficacissimo, il miglio r e di quelli finora impi egali con tro la difterite genuma. Il sier o agisce tanto più efficacemente, quanto più presto esso vie ne usato dopo la comparsa dei primi della difleriLe. È razionale e deve raccomandarsi la pratica dt associare l'uso del siero agli antisettici locali finora generalmente in uso. Dice che con questo metodo di cura combinato gli è t•iuscìto di abba ssa re la mortalità di 1/, L'u!'O del siero non i• seguito da alcun accidente e da a lcuna malattia.
Gli esantemi, le atlezioni articolari, ecc., si sono osservate già nel corso della difterite. indipendentemente dal metodo curativo. Queste manifestazioni nei casi curati col siero, quantunrtue si riscontr ino frequentemente, non sono pericoloso.
L'incertezza delle nostre conoscenze sul modo di agire del siero, non deve avere la menoma influenza sul suo uso in terapia, stanteché la efficacia contro la diflerile è stata stabilita empit·icamente.
V. Widel'i10fer.- Riferisce su 300 bambini dil'terilici curali col siero dall'ottobre del 1894 al febbraio 1895. La mortalità è la del 2:l,7, notevolmente minore della mortalità avuta prima che fosse inli·odoLla la sicroterapia.
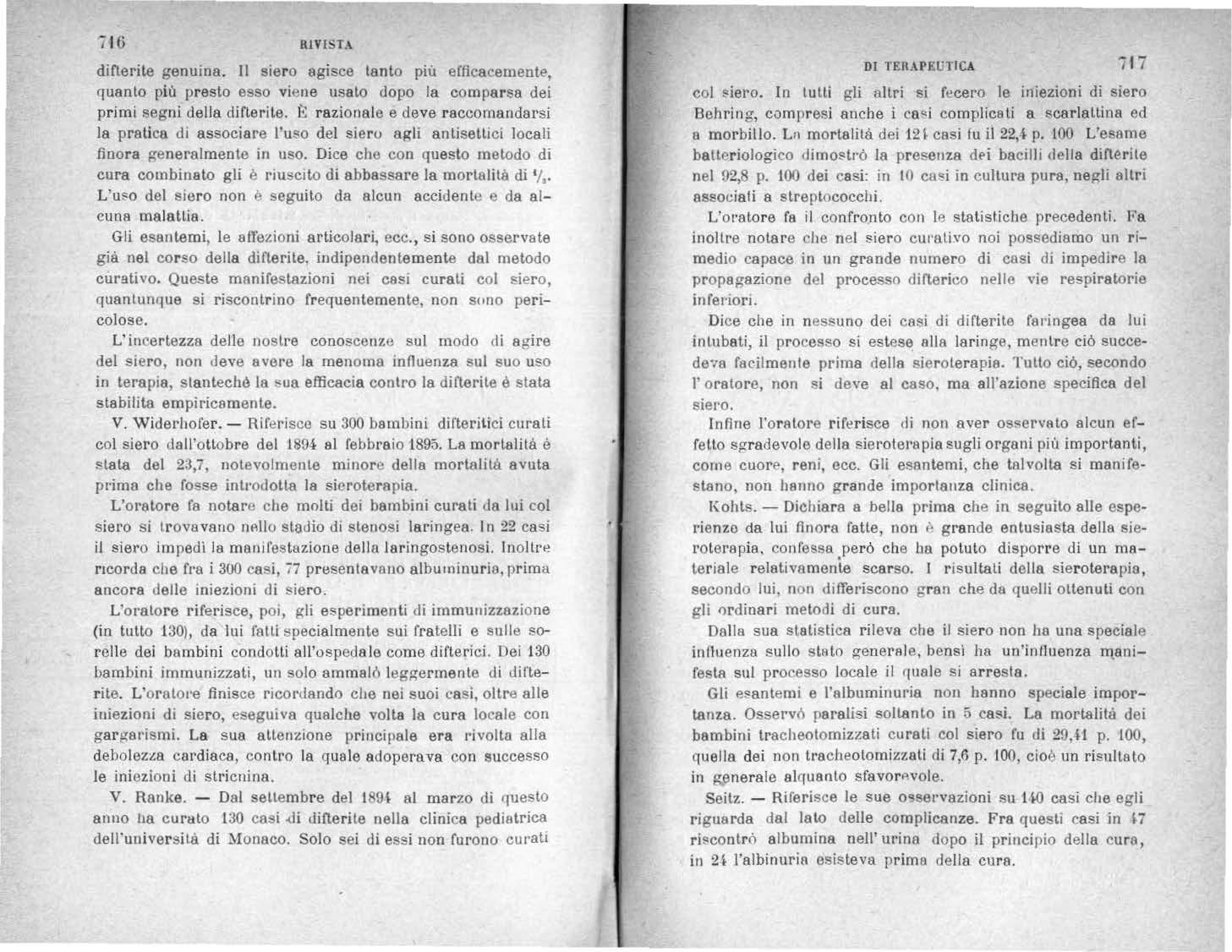
L'ot'f,llore fa che molli dei bambini curali da lui col siero si trovavano Milo stadio di stenosi laringea. In 22 casi il siero impedì la man1fes Lazione della laringostenosi. l uo lll·e r1 corùa che fra i 300 casi, 17 presentavano alburninuria, prima ancora delle iniezioni di siero.
L'ot·atore riferisce, poi, gli esperimenti di immunizzazione (in tutto 130), da lui fntti specialmente s ui fratelli e sulle sorelle dei bambini condotti all'osped ale come diflerici. Dei 130 bambini immunizzati, un solo ammalò leggermente di difterite. L'o rolor·e finis ce ricor·dando che nei suoi casi, oltre alle iniezioni di siero, eseguiva qualche volta la cura locale con La sua allenzione principale era t•ivolta alla deboleu:a cardiaca, contro la quale adoperava con succe sso Je ini e zioni di slricnina.
V. Ranke. - Dal setlembre del l al marzo di questo anno Ila curttto 130 casi .Ji ùillerite nella clinica pediatrica dell'università di Solo sei di essi non furono cut·ah col I n tutti gli altri si fecero le iniezioni di siero Behring, compresi anche i complicati a scarlallina ed o morbillo. Ln mortalità dei casi fu il p. LOO ballPriologico dimostr·ò la presenza dei bacilli della difterite nel 92,8 p. 100 dei casi: in IO casi in cu llura pura, negli altri associali a streplococclti.
L'ot·atore fa 11 confro]lto con le statistiche precedenti. Fa inoltre notare che n e l siero cu J·ativo noi possediamo un rimedio capace in un grande numero di casi di impedire la propagazione de l processo diner ico nelle vie respiratorie infet•iorì.
Di ce che in n ess uno dei ca$i di difterite far·ingea da lui intubati, il si estese alla laringe, m en tre cjò succede·:a facilmente prima della sie roterapia. Tullo ciò, secondo l'oratore, non deve al caso, ma all'azione specifica del sier•o.
Inflne l'oratore riferisce di non aver osservato alcun effetto della siet·otel'apiasugli organi più importanti, comP cuorP, reni, ecc. Gli esantemi, che talvolta si manifestano, non hanno g ra nde importanza clinica.
Kohts. - Dichiara a bella prima che in seguito alle esperienze da lui finora fatte, non l• grande entusiasta della sieroterapia. confessa però che ba potuto disporre d i un materiale relativamente scarso. I risultati della sierotera pio, secondo lui, non d1ffet•iscono gran che da quelli ottenu ti con gli ordinari metodi di cura.
Dalla sua statistica rileva che il sier o non ha una speciale influenza sullo stato generale, bensì ha un'influenza rqanifesta sul processo locale il quale si arresta.
Gli e l'a lbuminut•ia non hanno speciale importanza. Osserv o paralisi soltanto in 5 casi. La mortalita dei bambini tracheotomizzali curali col siero fu di 29,41 p. 100, quella dei non tracheotomizzati di 7,6 p. 100 , cioA un in generale alquanto sfavorrwole.
Seitz . - Riferisce le sue o<Jservazioni su t W casi che egli riguarda dal Iato delle complicanze. Fra questi casi in n riscontrò albumina nell'urina dopo il principio della c ura, in 2t l'albinuria esisteva pr im a della cura.
Dl TBRAPBUTICA 7 19
Dalle sue osservazioni l'oratore conchiude che non si può am'?etlere che la l>ierotera pia abbia un'influenza nociva sui rem e nepp_ore. sul In lutto osser vò 8 essi di paralisi. Il tumore dt mtl_za eststeva solo ,in 5 casi, era più frequente ad prtma delle iniezioni che dopo .
Però gli esantemi sono più frequenti in s eguito alla sieche prima. Nondimeno essi non espongono gli infe rmt ad alcun pericolo.
In tre casi complicati, venuti in cura relativamente tard i notò che la convalescenza fu m olto prolungata. NeÌ majlgiOr nume r o dei casi però la gua rigione f•t rapida. Infa osservare che la sieroterapia non fece affatto peggiOrare le malattie che si complicavano alla dineri te, come pertosse, polmonite, vizi cardiaci, tubercolosi, ecc.
Ha curalo 60 casi col siero di Behring. Dichtara che l e sue osserva zioni non parlano nt'> in favore né contro la sieroterapia. La mortalita fu del 20 p. 100. La du· rata media della malattia fu di 14 giorni.
Confrontando questi risultati con quelli ottenuti nei tempi trascorsi, l'oratore non nega che quelli sono alquanto più favorevoli: non di meno é possibile che ciò sia un fallo puramente accidentale . Un numero di osservazioni cosi scarsi) non serve a dimostrar nulla.
Trompp . - Riferisce sulla presenza delle dinerite e di bacilli analoghi ai difterici sulle muco se dci bambini, fondandosi sulle osservazioni fatte in occas ione d' una infezione familiare.
Nei bambini co n dinerite laringea si trovavano frequentemente bacilli diftertci virulenti anche su altre mucose in cui . ' non st notava alcun fenomeno morboso. Simili casi possono essere la sorgente delle infezioni domestiche.
L'oratore fa rilevare che, in conseguenza di ciò i mezzi fino r a in uso per la disinfezione delle abitazioni e oogelti contenutivi !!ono insuffi cienti ad evitare il contagio. eRehn.- Riferisco il risultato delle sue osservazioni e di qu ell e di a lcuni suoi colleghi. Nel siero, egli dice, abbiamo un potente rimedio che d'ordinario in poche o r e arresta il processo morboso, senza spiegare alcuna influenza nociva sull'organismo .
La durata della malattia, curata col siero, é di 6-8 giorni; nei casi di controllo non curati col siero la durata é di 14 giorni. Osserva che in un caso curato con i mezzi locali ordinar i egli vide manifestarsi le stesse affezioni articolari che sono state notate consecutivamente alle iniezioni di siero. Riti ene opportuna la cura locale ollre a quella del sier o. Rauct•fuss. - Riferisce sui risullati ottenuti in i casi nell'ospedale Oldenburg di P ielr oburgo, risultati favorevoli alla sieroterapia, giacché la sua statistica mostra una differenza del 21 p. 100 in favot·e del siet·o. Il migl io ramento t•apido dell o sta to generalo e l'arrestarsi del processo, in seguito alle iniezioni, dimostrano che il siero ha un'azione
Treupel. - Riferisce i risulta ti delle sue osservazioni farmacologiche sugli e/Tetti del siero di Behring.
Iniettava ai conigli ed ai cani :>otto la pelle 200, 600 fino a 1500 unità immunizzanti. In nessun caso si notò lesione nel sito della iniezione, tanto meno (lruzioni cu tanee.
Lo sta to generale degli animali è buono, la pressione sannon è notevolmente modificata. NeU'urina si riscontra albumina ; ciò però non autorizza ad ammettere una nefrite , perchè mancavano elementi morfologici nell' urina. Questa lieve albuminut·ia può anche essere fisiologica.
J endrassik.- Acc·enna alla differenza clte esiste tra il principio della immunizzazione e quello della guarigione. I suoi esperimenti negli an imali dimost r ano che il siero ha un potere protettivo già a piccole dosi, me ntre la virtù curati va del si ero animali è quasi nulla. Pare che i buoni risultati ottenuti in pratica dipe ndano dalla rapida immunizzazione dell'organismo.
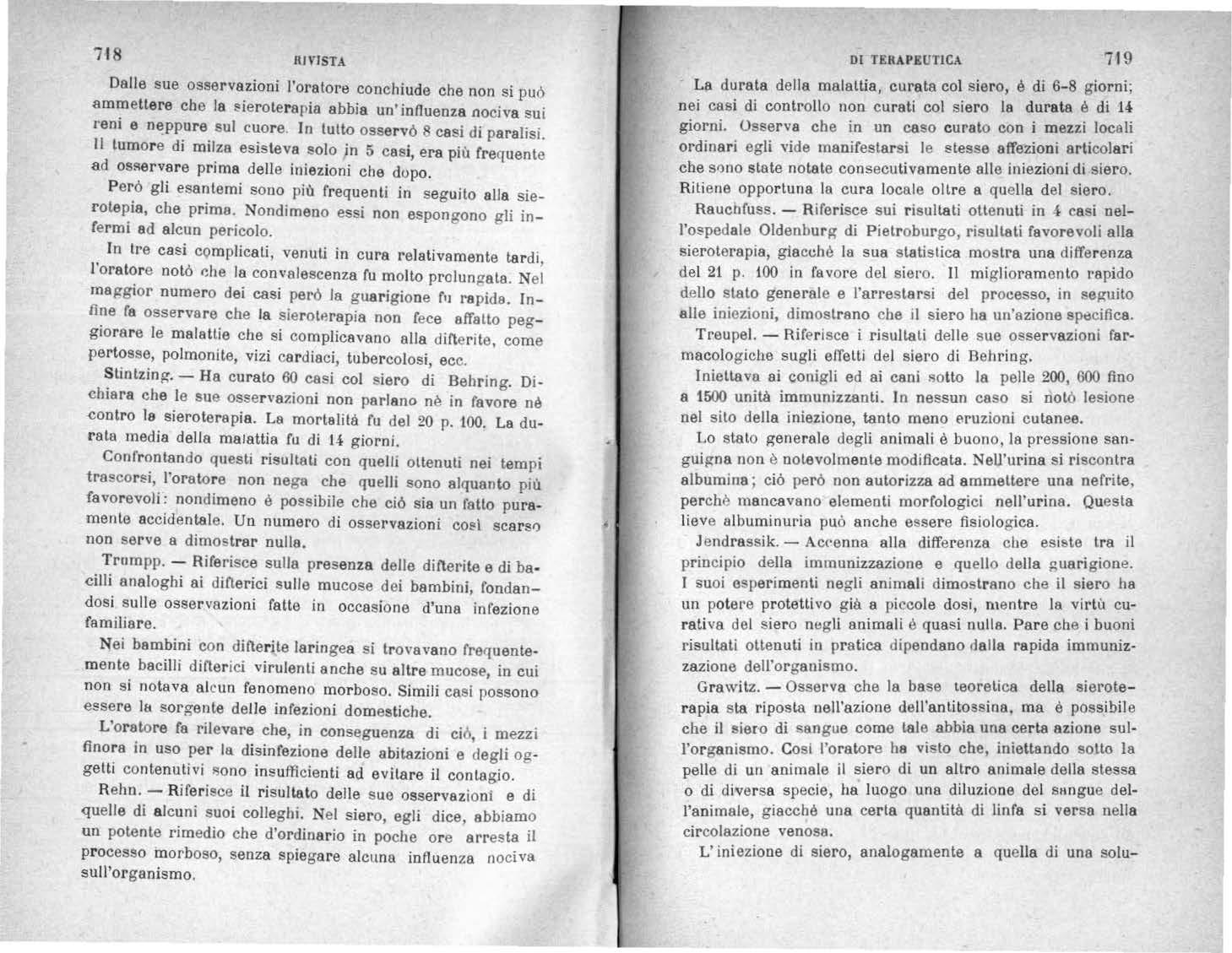
Grawitz. -Osserva che la base teorelica della sieroterapia s ta riposta nell'azione dell'antitossina, ma é possibile che il siero di sangue come tale abbia una certa azione sull'organismo. Cosi l'oratore ha visto che, iniettando sollo la pelle di un animale il siero di un altro animale della stessa o di diversa specie, ha' luogo una diluzione del SHngue dell'animale, giacché una certa quantità di linfa si versa nella circolazione venosa.
L'iniezione di siero, analogamente a quella di una solu- zione salina, agisce da diuretico. Anche estl'aendo il sanguP da una vena di un dinerico :, ore dopo un'iniezione tli siero, trova aumento del contenuto d'acqua del sangue, che si può valutare all'i p. 100.
Siegert. - Fa notare cbe, mentre prima nella clinica periiatrica universitaria di Slrasburgo l'albuminuria si presentava in J/7 dei casi di difterite, essa si manjfesta nei malati curati col siero di Oehring nel 51 p. 100 dei casi.
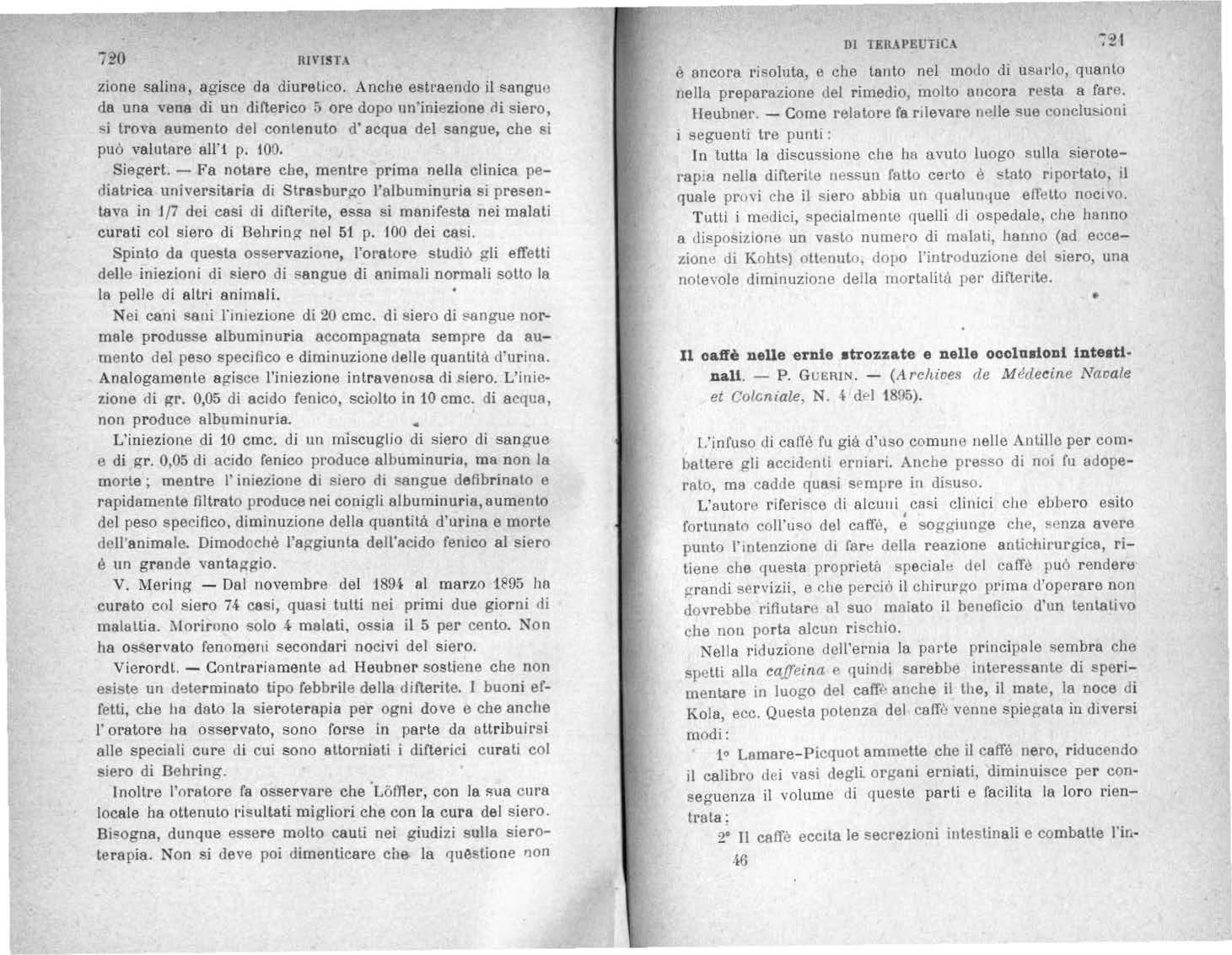
Spinto da questa osservazione, J'or•atore studiò gli effetti delle iniezioni di siero di sangue dj animali normali sotto la la pelle di altri animali.
Nei cani sani l'mtezione di 20 eme. di siero di !:'-angue normale produsse albuminuria sempre da aumento del peso specifico e diminuzione delle quantità ù'urina. Analogamente a gisce l'iniezione di siero. L'inirzione di gr. 0,05 di acido fenico, sciolto in 10 eme. di acqua, non produce albuminuria.
L 'i niezion e di tO eme. di un miscuglio di siero di e di gr. 0,05 di acido fenico pr•oduce albuminuria, ma non la morte; mentre l' imezione d t siero dr sangue de fibrinato e rapidamente filtrato p r oduce nei conigli albuminuria, aumento del peso specifico, diminuzione della quantita d'urina e morte dell'an imale. Dimodoché l'aggiunta dell'Acido fenico al siero é un grande vantaggio.
V. Mer·ing - Dal novembre del 1894 al marzo 1ll95 lta curato col siero 74 casi, quasi tutti nei primi due giorni di mah1ttia. solo 4 malati, ossia il 5 per cento. ha osservato fenomeni secondari nocivi del siero. Vie r ordt. - Contrari a mente ad Heubner sostiene che non un ù9terminato tipo febbrile della clinerite. l buoni effetti, che ha dato la sier oterap ia per ogni dove e che anche l'oratore ha osservato, sono for·se in parte da att ribuirsi alle speciali cure d i cui sono attorniali i ilifterici cural i col siero di Behring.
I noltre l'oratore ra osservat•e che ·u)IY!er·, con la !>Ua c ura locale ha otLenuto t'il!ullati migliot•i che con la cura del siero. Bic: ogna , dunque essere molto cauti nei giudizi sulla sieroterapia. Non si deve poi dimenticare che la '}uestione rron è ancora I'Jsoluta, e che tanto nel motlo .:li u Ml'lo, fJUanto nella del rimedio, molto ancora r esta a fare. lleubner·. -Come relatore fa rtlevare nelle sue eonclm,ioni
1 segueult tre punti:
In tutltt la discussione che ha avuto luogo sulla siel'oter·apia nella difterite nessun fallo cer·lo è l"tato rtportato, il quale provi che il l->te r o ab bia un qualun'lue elfelto noctvo.
Tut ti i modici, l'lpecialmenw quelli ùi ospedale, che ltanno a disposiztone un numet·o di malati, hanno (ad eccedi K obtt") ottenuto, dopo l'introduzione del siero, una noleYole diminuzto:le della mortalità per diflertle.
Il oa.ffè nelle ernle 1trozza.te e nelle ocola•lonl i n tel tlnall. - P. G uE:R IN. - (A rehioe,, de M écle cine Navale et Colcniale. N. i- dt>l 1895).
L'infuso di caiTé fu già d'uso comutHl nelle Antille per com · battere accidenti e r•niar i. Anche pr'e!lso di nni fu adoperalo, ma cadde sempre in disuso.
L'autot'l-' riferi sco eli alcuui casi c linici ello ebLero esito fortunato coll'ut"o del caffè, e che, !wnza avere punto l'ltltenzione di della reazione anti chir•urgica, riti ene cl1e questa prop ri età 1:\peciale de'l caffe può rendere grandi set•vizii, e r.lte perciò il prima d'opera re non dovrebbe t•ifiulare ul suo mu tato il beuefìcio d'un tentativo che non porta alcun ris chio.
Nella riduzione dcll'er·nia la ptH'le principale sembra che spelli alla caffeina e quindi sarebbe iuteressante dj sperimenta r e in luogo del cafl'l· anche il the, il male, la noce di Kola, ecc. Questa potenza del calfr'> venne in diversi modi:
1o Lamare-Picquot ammette che il caffè nero, ri ducendo il calibr·o dei vasi degli orga ni erniati, iliminuisce per conseguenza il volume di queste parti e facilita la loro rien- trata:
2• Il caffè ecctta le secrezioni intestinali e combatte J'in·16 delle feci diluendo le materie conlenut.e nell'an"& erniata;
3• Secondo Cellarier il calft• eccita nello strato muscolaru dell'intestino rlei movimenti che dispiegano l'ernia e la lirnno dall'anello verso la cavila dol venLt·e facendola così rieulrare.
Le due prime ipotesi sono state abbandonale, e la piu parte degli sperimentatori hanno accettalo l'opinione di Cellarier.
L'autore ritiene che gli insuccessi avuti talvolta nPlla prat•ca Ji questo metodo siano da addebitarsi alla cattiva qualità del caffè adoperato, e che i'acru"a di fat· pet·dere un tempo non sia giusta, poiché la riduzione ddll'e••nia nou si fa mai attendere piu ui quattro ore, tempo che in ogni modo è quasi l'emprc necessario per preparare quanto occorre per l'inter,ento chirurgico, per trova re un aiuto, somministrare il cloroformio, ecc.
Nei casi in cu1 non si potesse usare la via dello stomaco, si pott·ebbe riconere o ai clistot·• che agi•·ebbero for·se più direllameute sulla contratlilila inle:>tinale, o alla caffeina per iniezioni ipoùermiche.
Circa le dosi e il modo di somminislrarle, il Durand conSI!;liava di fare un infuso di 250 g rammi di polvere di caffè da prendersi a tazze, una ogni quarto d'o ra , ciò che equivale presso u poco a 250 grammi di polvere in 720 grammi di acqua. L'autore si limita a prescrivere del caffè fortissimo, più fo!'te assai di quollo che il paziente è solito prondore: questa raccomandazione basto per quelli che prendono abitualmente caffè forte, ma per le persone non abituale sarà bene non sorpassare la dose ind icata da Durand sotto pena d1 veder sopraggiungere dei disturbi tossici .
Per injeziono ipodermica è prudenza di saggiare la tolleranza del malato con una prima iniezione di 50 centigrammi e, se questa é ben soppo rtata, aumentare t·apidam"'nte fino a grammi 1,50 o anche 2 grammi. G.
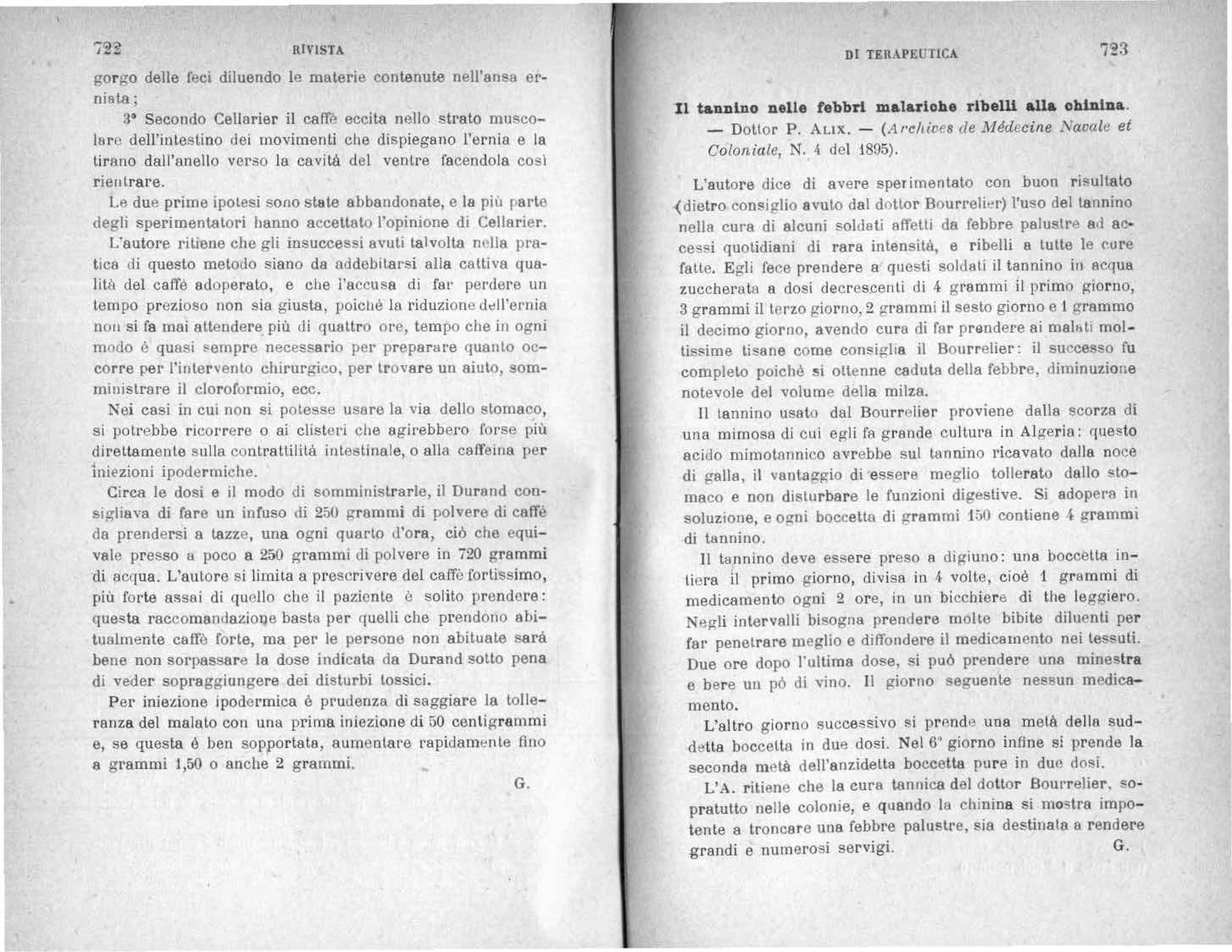
Il tannlno nelle febbrl malarlohe rlbelll alla obl.nina
- Dottor P. ALIX. - (Arcltioes de Médccine ,\avale et Coloniale, N. 4 del 1805).
.
L'autore dice di avere sperim entato con buon ri!"ultato (dietro avuto dal dottor Bourreli,..r·) l'u-.o del tannino nella cura di alcuni soldati aff'elli da febbre palu"tre a•l ac· ce.;;"i quotidiani di rara intensità, e ribelli a Lutle le C'ore falle. Egli fece prendere a quobti soldati il tannino in acqua zuccherata a dosi decrescenti di 4 grammi il primo 3 g rammi il lt>I'ZO 2 :;rrammi il sesto gio rn o c l il decimo giorno, avendo cura di far prendere ai ti moltisane come consi::rha il Bourrelier: il succe!ISO fu completo po1ché s1 ottenne caduta della febbre, diminuzior.e notevole del volume della milza.
Il tannino usato dal BourrPlier proviene dalla scorza di una mimosa di cui egli fa g rande cu ltura in Al ge ria: questo acido mimotnnnico avrebbe sul tannino ricavato dalla noce di galla, il vanl&Jlf.'(io di essere meglio tollerato dallo rnaco e non disturbare le funzioni digestive. Si adopera in soluzione, e boccetta di li>O contiene idi tannino.
11 tannino deve essere preM a una boccetta inliora il primo f!iorno, divisa in 4 volte, cioè 1 grammi di medicamento ogni 2 ore, in un bicchiere di the intervalli bi"ogna prendere molle bibite dilu!'nli per far penetrare meglio e diffondere il medicamento nei le""uli. Due ore dopo l'ultima dose, si può prendere una mines tra e bere uu pò di vino. Il !leguent.e nessun medicamento.
L'altro giorno successivo si prPnd,· una metà della suddetta bocceltn in due dosj. Nel 6" giorno infine si prende la seconda roPlà dell'anzidetta boccetta pure in due do"'·
L'A. ritiene che la cnra tannica d el dottor Bourrelie r , sopratulto nelle colonie, e quando la clunina si mo;;tra impotente a tr onca r e una febbre paluslt•e, sia destinala a rendere grandi e numei·osi servigi. G.
La gallioina, nuovo rlmecUo per le malattie degli ooohl.
CARLO M r:;LLINOER. - der Sehw. Aer.zte, K. 8, 1897>).
L3 gallicina è l'eter e melilico dell'acido gallico, il quale si oltiene col riscaldamento di una soluzione di ac•do gallico o di tannino nell'etere melilico con acido cloridrico o acido solforico concentrato. Dalla soluzione alcolica si ottiene cl'islallizzato in prismi rombiCI privi d1 acqua, e dalla soluzione acquosa calda col t·afTreddamento in aghi so ttilissimi bianchi come ne\'e. Questa ultima che é lA forma più adattala per uso medico fonde, come l'allra in cristalli rombici, a 200-202' e si scioglie facilmentf: ollrec!Jè nell'acqua bollente, ancùe nell'alcool metilico ed elilico e nell'etere.
La cos tituzi one chimica di questo etere metilico dell'acido gallico, la quale J'icorda quella della r esorcina e del pirogallolo fece pensare che esso avesse la stessa favo r evole azione s ui cata r ei e sulle malattie della pell e . Ma la g allicina ha sul pi1·ogallolo il vantaggio di non esseee velenosa . Il M eltin ger la trovò uLilo Jll'incipalmente nei catarri congiuntivali e nelle malatti e degli occhi affini alle malaLUe cutanee. Finora l'ha usata solamente in polvet'e spargendola con un pennello una o tlue voltP il giorno nel sacco congiuntivale come si suoi fare col calomelano. l l solo disturbo notato in al cuni malati fu un senso di bruciore che cessava dopo pochi minu ti con qualche freddo, e cl1e può anche esser e evit.sto con la instillazione di alcune gocce di una soluzione di cocaina al 2 p. 100.
Il ha usato la gallicina in più di duecento casi di catarri, di infiammazioni flittenuJari e di chera titi superficiali con ottimo risultato. L'ho t1·ovata pu re utile negli stati cal8r1·a li che s uccedono a lle grandi infiammazioni purulente; ma specialmente la ra ccomanda nell'eczema della congiuntiva, nelle cosi delle infiammazioni flittenula ri e nella cheratite superficiale. Sopra it calomelano avrebbe il va ntaggio di poler si usare anche nell e infiammaz ioni fiillenulari con aumentala s e cr ezione, agendo favorevolmente s u tulli e due questi stati, laddov e l'aumentata secrezione costituisce controindicazione per l'uso de l calomelano.
B ERTl\\ND. - Sul lacooslo e aul suo potere oaaldante . -
(P rogres médi,.al, 7 e 11 , 1895).
Il Jaccosio sarebbe una nuova diastasi scope rta dal Bertrand , e di cui egl i riferisce in un !'UO lavoro le nuove t>d im portantissime proprietà.
T utte le finora studia tP hanno la pr oprietà di produrre idratazioni e sdoppiamenti, come l'mvel'tina, fermt!nto solubile del lievito di birra, sdoppia pet• 1rlratazione la moleco 'a di saccar osio in glucosio e levulosio, mater1e 7.uccherinc dirl'Llamente fermenlescibili che si trasfor mano in alcool ed acido carbonico. Il laccosio invece proprieta inverse; esso determina una ossidaziou e.
Questu nuova diastasi deriva dall'albero da lacca del Tonchino, ed é so lto la sua azione che si produce la lacca, la bt!ila vernice nera tanto conoseiuta e tanto la quale ri s ulta dalla ossiJazio11e di un co r po, il lacco lo, cho pe l' l'in· sie me delle sue reazioni si avvi ci na a certi fenoli poliatomici: facendo agire il laccosio su di esso o su co rp 1 analoghi, come l'id r ochinone o il pir oga llolo, in pr esenz a dell'Os:Jigeno, si ha ossidazione intensa, e l'ossigeno scompa re e vien ::-ostiluito da acido carbonico.
Tale fenomeno si ra vvicina quasi ad una artificiaie, e fo r se ra pp r esenta ciò che c::uccede nella l'e<:pirazione dei vegetali: esso si riscontra difatti 111 un gran numero di piante, e può ossidare molti corpi ch e "l trovano nelle piante medesime, come l'acido gallico ed il tannino. s1 tratterebbe qu indi di falli nuovi non solo, ma di una grande importanza per la chimica non solo ma per la fìsiologla generale.
Lo slPsc;o fermento fu dal Lui det scoperto nella mela del quando tagl!a o si !-'Chiaccìa q•Jesta mela, essa pr ende all'aria una tinta rossa ca r attel'istica dovuta all'o!:lsidazione del tannin o l' influenzu di un ferm e nto, di s irut to il fermento, ad colla collura. rossi<l azione non ha più luogo.
Le propr ietà oss idanti di ques ti fe rm enti sono dimostrate -con pa r ecr.hi e 'ari p roc edimenti. Da ques ti impo rtanti ssi mi
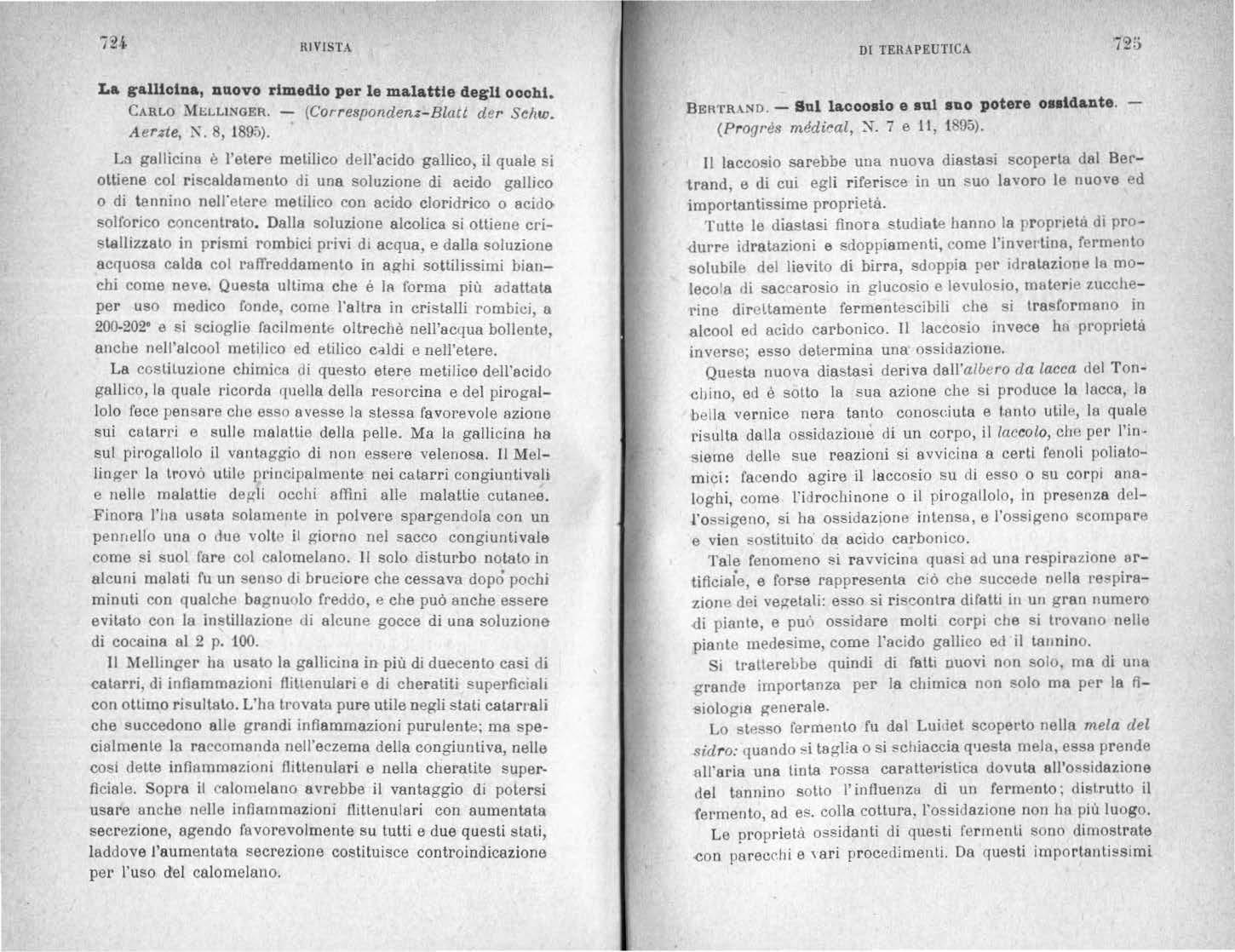
Dl TERAPEUTICA
fatti, che gene1·alizza oo la scoperta del Bedrand, emerge incontes tabile la conclusione che esistono due gruppi di diastasi aù effetti opposti; le primE', che erano le sole conosri ute flno1·a, determinano delle idrata:.ioni c de g li sdoppiamenti; le altre, la cui esistenza viene ora svelata dal Bortraod, hanno la proprieta di eiTettuare uelle ossid azioni. Parrebbe pertanto legilLimo di assegnare anche a questi dut:: gruppi dei nomi che rammentino le loro prop ri età gen 1-ra li: si avre bbero cos1 le Idrolasi e le O.<uJidasi come punto di pal·tenza per una classificazione razionale de lle diastasi.
BL UM. - Trattame nto de lla oole lltl u l . - (Jfunf'!tn. r1.ec1 l\'och., marzo 189il).
Blum l'i chiama l'attenzione dei medici pratici sul valo1•e terapeutico dei grandi clisteri di olio cii oliva nel trattamento della colica biliare. Queste iniezioui l'cltali possono essere sostitUite alle dosi gene r ose di olio datP. per bocca , alle quali gli ammalali si riflutono e che possono disturbare le funzi oni dello stomaco. Oltt•e colagoga probabile, l'olio di oliva ha un leggtero pote re lassali\'O. L'auto r e le prescrizioni di Fleiner n l'l da r e ' IUet>ti cfi-.;leri: 100 o 500 cc. di o l1o d'oliva pu1·o caldo sono dapprincipio ogni g iorno a in seguito a più lungni intervalli, iniellati. L'autore ne ha ha avuto ottimi t'isultati in 5 casi.
G. G.
RA UUITSCHEK. - Il bicloruro di mercurio nella tosse con· vuWva . - (Therap. Mon.aisli.).
Il H. conoscendo gl'insuccessi dell' or·.linario trattamento della tosse convulsiva si decise a usare nei suoi tre bambini il bicloruro di mercul'io. Dopo avPt' imbevuto un batuffolo di cotone di una "Oluzione ùi 0,10 p. 100 di sniJlimato corro"ivo, lo mtrodu"se nella bocca e ne sp remè il liquido sullu bAse della lingua facendolo cost giuoget•e all'epiglottide e alla laringe, in seguito lo estrasse spennellando l'ugola, le ton si lle e il velo pendolo. Ciò fu praticato o ani giOrno o d a gi&rni alterni a seconda della gravità de l caso oltenendo si ottimi r rsultali non :;olo nei tre casi soprnccenoati ma anch e in 1i altri bambini curati allo stesso modo. Il noLossi già al 2• e 3o giorno del lrallamento_ e ammalati guarirono completomente o quasi in 8-1 i- g10r n!. Un sembrò etDsere arrestalo nel suo sviluppo con cmque applicazioni della soluzione. .
L 'autore cred e che non debba temersi alcun <'fi'ello tosstco.
G G.
HoLscueR. _ 11 carbona to di guaia.ool o . - (Brit. ::'>led .
Journ., 12 gennaio 1895 o Berl. klin.. Woch., 3 dicembre 18941
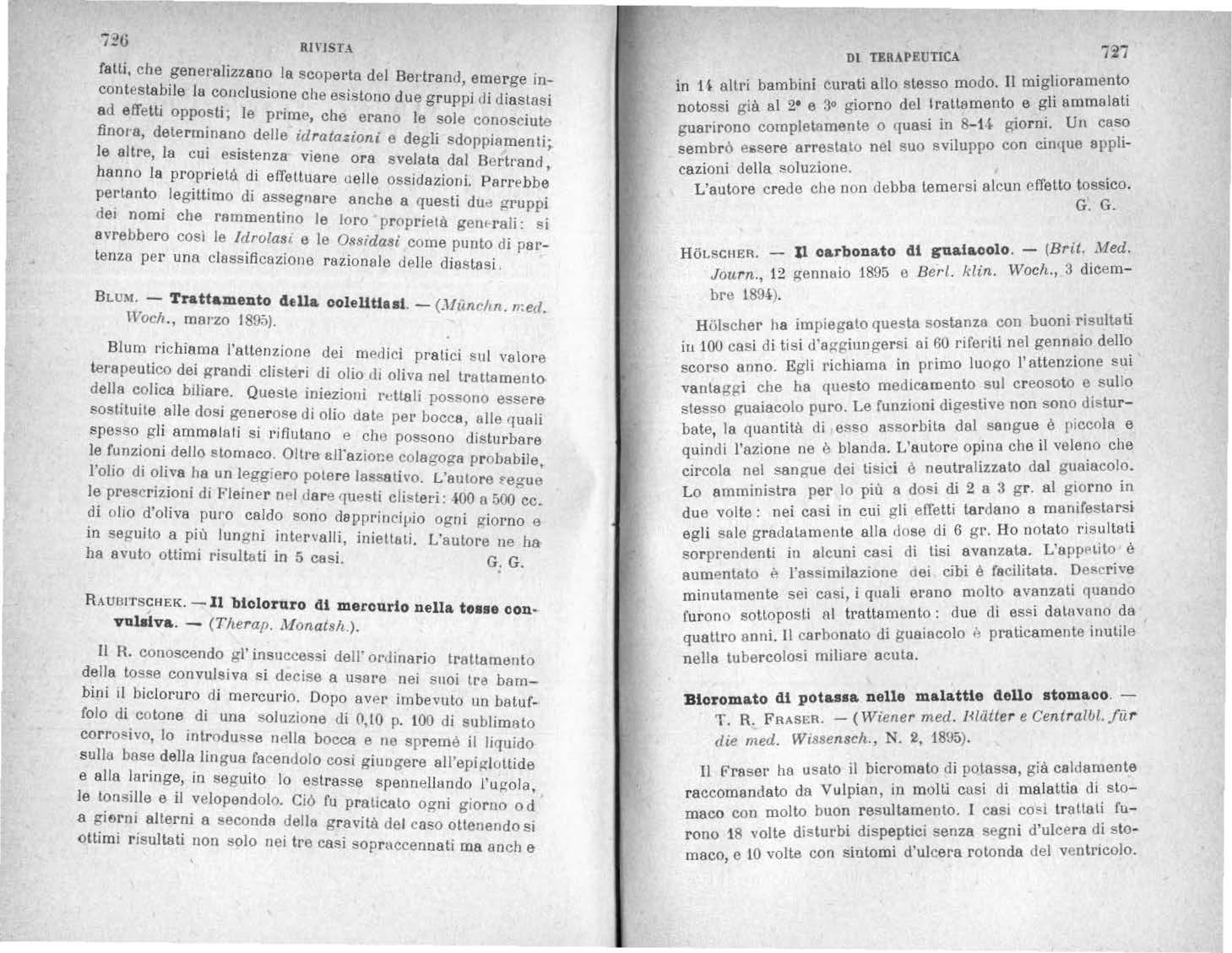
HiJlscher ha impiegalo questa sostanza con buoni sulteti iu 100 casi di tisi ai 60 riferiti
O Egli. l'l'chiama in primo luogo l attenZione sul SCOI'SO ann · u11 vaola""'i che ha ques to medicamento sul creosoto e. s o puro. Le funzion i digestive non sono disturbate la quantità di esso assorbita dal sang ue è p1ccola e quin,di l'azione ne è blanda. L'autore che il vele?o che circola nel dei lisici è neulrahzzalo dal g111uacol? .
Lo amministra per lo più a dosi di 2 a a g r . al g1_o rno due volte: nei casi in cui gli eiTetti tardano a egli sale g radatam ente alla tinse di 6 gt'. Ho notato "Orp1·endenti in alcuni ca!'li di lisi avanzata. é ;umentato t> !'a!lsimilazione oei cibi è facilitata. minuta mente sei casi, i quali erano mollo quando furono sottoposti al trattamento: due ùi ess1 · 11 ca r bo nato d.i "'Uaiocolo ,-.. praticamente 1nutlle quattro aom. t"> ne1la tubercolosi miliare acuta.
B icromato di potass& nelle malattie dello stomaco . ::-
T. R. FRA SER. - ( Wi ener med. l<liltler e Centralul. Jur the med. Wrssensch., N. 2, 1895).
Il Fraser ha usato il bicromato di polassa, gia caldar:nente d to da Vulpian io molli cusi di malattia dJ slo- raccoman a , . Olto buon resullamenlo l casi co>'i trattat1 fll- maco con m · . rono 18 volte disturbi dispeptici senza !legn i d'ulcE-ra eh s tomaco, 0 10 volte con sintomi d'ulcera rotonda del vcolr1colo.
Jiivjs1a
In Lull1 i 28 casi il medicamento fu uc:ato da solo fatta eccezione dei purganti, la azione polé t-'ervata con esattezza. fu dalo alla dose tl i 5 mtlligrammi tino a 1 centigr•nmmo tre volle al a digiuno
I_o s tomaco fosse, ptù che poss1bile, vuoto. Si uso ot·a tn soluziOne, ora in pillole. Quando fu necessarto, me.nte con l_e dosi p!ù fu fatto pr ender e nel siroppo del t olu o nel stroppo d arancto per correggere il sapo r e.
Nelle 8emplici d ispepsie, anche nelle più piccole dosi, agi molt<) favorevolmente: lOI'-e in breve tempo il flnlor(' il _di il vomito e la alla e RoGER. - Sie rotera pta. della febbre puerperale. - (Società di btoloyra di Parigi, Gazz. m,Pr/. di Torino, 30 maggio l'iella s eclula del 23 febbraio Charr·•n e Roger fecero una comunicazione sopra un loro tentativo di sieroieratJia n ella 'ebbre tmerpern.le. Prendendo punto eli partenza da quanlo avevan o tn pr·ece lenli esnet•imlwli coustalalo. che cior'> s 1 può, vaccinando gli animali co nLJ·o lo :otreptococco, conferit·e al loro s ier<• il potere eli allcnuure il virus e di comlllltte rn e il suo (18:12), vollero vedere se l'ini ezione uell' uomo del siero tollo da un a11imale oppo rtunamente Jll'!•parato ad hoe, pole\'a eser cita re be nefica influenza sull' infezioue pie mica, della qu al e pe r caso affetto. Siccome pero pet• l'uomo occo rron o r1uanlila di sie ro co-sì gli autori ric or sero ag li eq utni e scelsero u 11 mulo: PrPse 'luind i delle colture in brodo di eresipela, dell'età di lO grorni, concentrarono il li rruid o a ba g nomaria sino a r•idurlo ad 1/to del suo volumo primitivo; questo Lirruido t'esiduo portarono quindi nell'autoclave alla temperatura di 115• e senza filtrarlo, così che in si trovano i microbi e Le loro tossme. Lo iniettarono quindi in una vena òel mulelto alla dose di 30 cc. per volla, fece r o in tullo otto iniezioni, a quindici giorni di dìst8nza l'una dall'alt r a. Il mulello ricevette perciò iu lulto 240 cc. di liquido concentrato, pari a 2400 cc. di coltura sterilizzata. iniezioni non produssero u e!\su n disturbo all'animale e quindici gi or ni dopo l'ult1ma dì esse, estralto il sangue e constatato elle il rispettivo siero avf'va proprietà cu rativo come Il siero dei conig-l i vaccinati, pensarono di spet·imentorlo nell'uomo. Il 6 febbraio fecero infatti la prima iniezione col c;iero da loro preparato arl un· amm alata affetl.h da mfezione puerperale a forma selticemica, senzs localizzazioni. L'ammalata aveva una ip!'rterm1a di C, m a gli cc. di mìettati furono senza risultAto; atl ogni modo l'ammAlata non ne aveva punto sofferto. Il giomo segu!'nle eggendo ancora la temperatura a }00 praticavano unA seconda iniezione !'gualmente di 8 cc., dAlla qua le pero n on si ollenne•·o rilevanti risultati; il giorno appresso la temperatura et·a discesa al mattino a :l9°,;{, mn alla sera et·a ancora risalita a 40•,5. Fecero allora una terza ini ezione, ma. que!'lla volla, di 2:, cc. eJ. il giorno seguente la temperatura discese 11 :r;•,; al mat tino, e 38.,8 alla sera; slato buono, orine però non ancora abbondanti. Il p:iorno appresso ( 10 febbt·aìo) l'ammalala aveva al mattino 37 , e que;:;la tempe!'atura non fu più superata. Nel giorno ùeHA cnm111ùcazione ella eru complelamenle guarita. Tralla si io que"to caso, osservano r.:Ji autori, di una mera ? Non >;i può dire: solo ullerior·i ricet•che potranno permettet'P dì rispondere in modo esauriente a questa domanda.
In quelle di"pep.,ie che accompagnano rauemta e nella costipazione non ha alcuna influenza, come pure non ha favorevole azione nei cnst dt ulcer·a llCula dello maC'o cou vomito N on i11fìuisce in alcunA guisa sulla Occo rt·e poi nolat·e che il bicr·omato di potassa posstede una forte azione antipukirla , cosiccht'l l• probabilmente questa una delle cuuso della s ua benefica ozione sulle affezioni dispepticlll'.
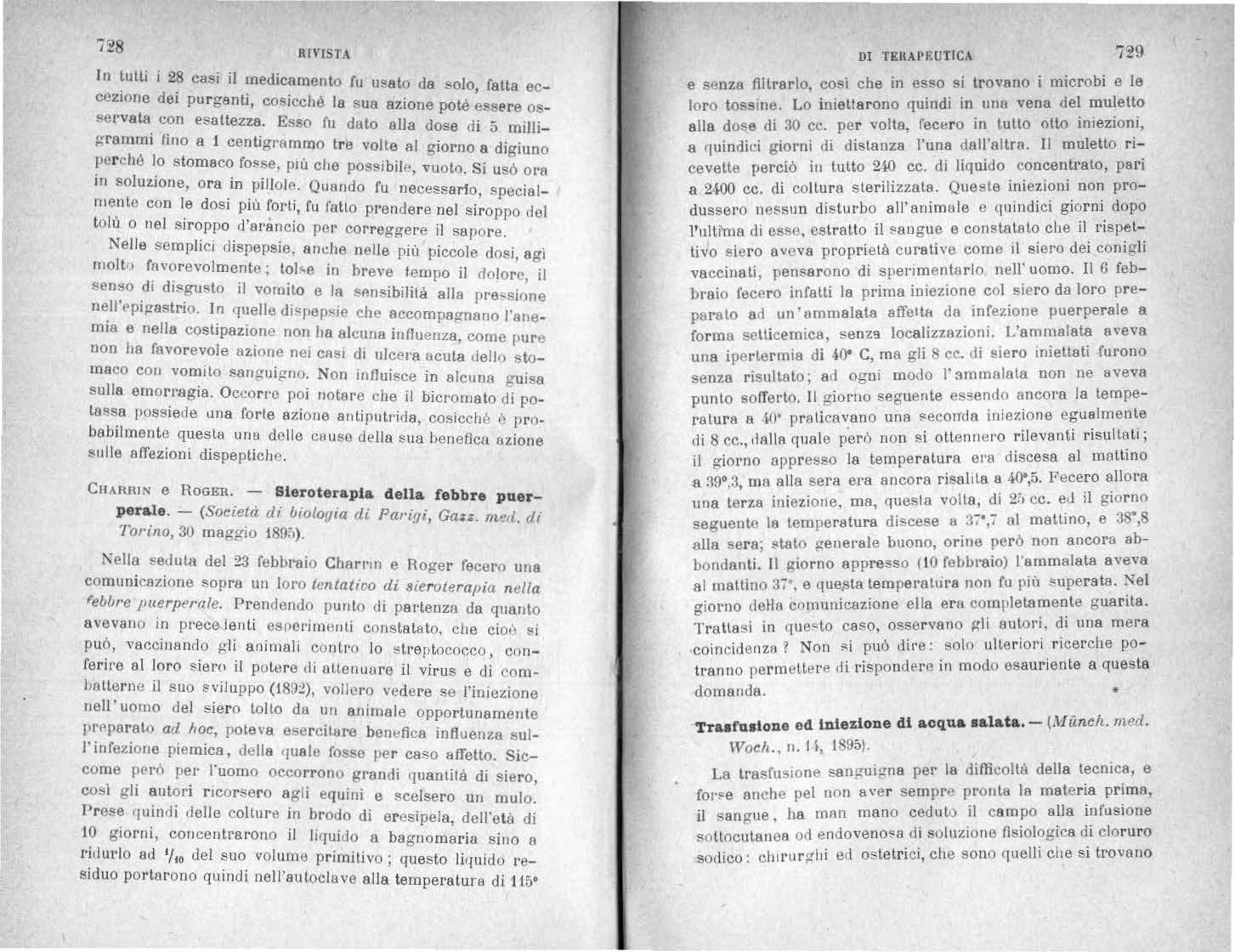
Tra•fu•tone e d llllezione dl a.oqu& salata . - (Miineh. meri. lVoclt., n. H, l 95).
La lrasfu::;ione per la difficolta della tecnica, e fot·"e Anclw pel non aver sempre pronta la materia prima, il sang-ue, ha man mano cedut•) il c ampo alla infusione od endo venO"Il eli !'luluzi one fisiologica dì clorur o 15odico: cluru r ghi e rl ostetr ici, che sono quelli che si trovano più so ve nte a fronteggiare casi di anemie acute e gravi tant() da ri chiedere un intervento imm edi ato, ricorrono , si può di r e, senza ecc-ezione, di ar11Ua salata. Voo Ziemssen resta invece pa rtig1ano della tr asfus ione s an guig na e della piu antica di lulte , 'Jue lla che si pratica d a braccio a braccio con sangue non delibrinalo: secondo lui la soluzione di cloruro soJ ico non av1•ebbe che un effetto passeggero di poche or e, sovra tullo nei casi di an em ie croniche da perdite ripetute di sa ngue. A san zionare tesi l'l porta un caso di anem1a g r ave da gaslh'orragie r1pelule elle mi glio r ò subito con un'infusione di acqua salata ; ma dopo 12 ore ricadde in modo che fu nl'cessaria la lrasfus1one sanguigna, c!Je produsse un benessere perm anente, ed un migliOI'amenlo progressiYoquantunque lento - nella crasi
Di E Mwjcd Militar E
n aervlzlo unitario nella apeclizlone clel Maclagaaoar.
- (Pr og r ès méclical, N. 10, del 1805, .
Questo g io r nale riporta molte notizie ed i nfo rmazioni sulle disposizioni del Ministero della guer ra per le a ssegnazioni del personale, le dotaz10111, le riserve di g u erra del materiale s anitario per la spedizione del .Madagascar, di cui accenmamo a qualcuna delle più 1mpo r lanli.
Tu lli gli uomini, g r aduali e truppa destinati a far 1arte della spe.IJzione, sen za alcu n a eccezione, devono subi r e una speciale e diligente visita medica, in cui il per·ito deve rivolg:er·e speciale attenzione allo stato degli o r gan i r espiratori, del cuore, dell'adJome, (fegato e mi lz a ) : con escl usi one di colo r o che p r esentano segni di im paludismo, di infezi one venerea o sifl liti ca, degli e rni osi.
Ogni utlicia.le od soLL'ufficiafe o soldato del corpo di spedizione è munito di un pacche tto di medicazione seco11do il prescr·itto de lla decisione ministeriale 27 g no 18!H; soltan to, invece di esser dis tribuito in pl'ecedenza
E SERVI ZlO \fEDI CO MILITAR&
e po rtato dai singoli individui durante ti via gg:io, il pacchetto da med ica zione non dovrà esser e conseg nato che al momento dello sbar co al Mad agascar.
P er li materiale sanitario, il cor·po di spedi zione di: ambulanze N. 1, per divisioni di fanteriu con circa 7000 medicazioni, 1:32 barelle, 10 coppie di portantine e 20 di cacolets ; ambulanze N. 2, per divisioni di cavalleria e tr uppe mobtli per la difesa dei fo r ti, con 800 medicazioni e 22 barelli!; ambulanze 3, per truppe operanti in monla!.!na : il materiale pesa 908 chilogt·ammi, ti contenuto in cesti a cassa e portato da 22 muli da basto, e contien e 1200 medicazioni: il trasporto de i feriti malati é puro alo con muli; ospedali di campagn a , quattro per divisione, ognuno dei f'}uali può assicu r a r e il trattamento di 100 malati o fer1t i per tre mesi d i cu ra.
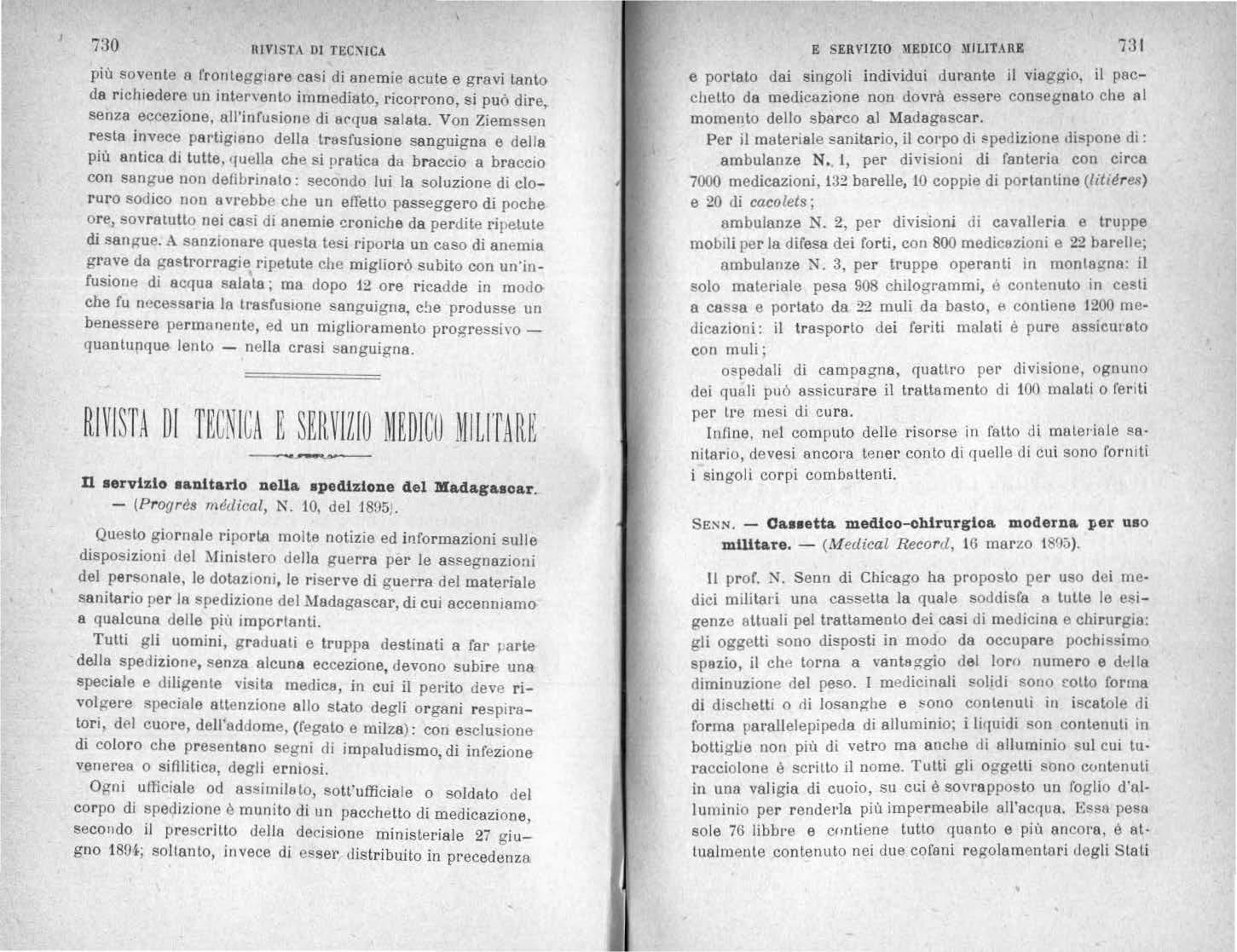
Infine, nel computo delle riso r se in t'allo di ma le1·iale sa · nitarw, devesi ancot·a tener conto di 'luelle di cui sono fornili i singoli co rpi combattenti.
- Oaaaetta. medioo-ob!rurgloa. moderna per uso miUtan. - ( M edical Record, 16 mar.:o l % ).
Il pr o f. N. Senn di Chica go ha proposto J.>er dei medici militari una cassetta Ja quale soddisfa a Lulle le el>igenzl} a ttuali pel trattamento d ei casi di medicina e chi rur gia: gli oggetti disposti in modo da occupar e poch ic;simo spazio, il che torna a \'aotaggio d e l lo r o nume r o e ddla rliminuzionP del peso. l mPdicinali !:'olid1 tollo forma di o di losanghe e sono contenul1 1n di fo r ma parallelepipeda di alluminio; i liiJUidi contenuti in bottiglie non più di vetro ma a nche di alluminio sul cut turacciolone é scritto il nome. Tutti gli c<•ntenuli in una valigia d i cuoio, su é un roglio d'alluminio per r ende l'la piu impe rm eabile all'a cqua . E!'lsu pesa so le 76 Jibbt·e 6 contiene tutto quanto 6 più ancot•a, é aL· Lualm en te conleuuto nei due cofan i regolamentari dogli Stati
Unili, i l'fUali pesano 185 libbre. Ai lati della cassetta "-Ono fis!"ale due robu"-le maruglie le quali per·rneltono al suo Irasporto muli o cavalli. 11 coutenulo della cassetta !'• di!;I?Osto m1ve scompartimenti numerati siccbè riesce facile a posto dopo usalt. La casseLla ba le dimensioni d 1 12 '/s X 1:! '/,X 29 pollici.
Oltre alla cassetta il prof. Senn ha fallO adottare. u.na busta ciUI·urgiCA tascabile. Essa misura l 'l X2 'J, X 5 poii1C1 e pesa solo 19 once: contiene sette pinze uno per le operazioni sul cran 1o, pinzetle e souda per estraz10.'.'c dei p:o,eUili, un r aschiatoio, un catetere roultrplo e per eseguire nrnputazioni o lapar?lo.m1e .. fuU1 quesli oggetti sono contenuti in una b.usta .dt la r]uale in caso di può es"-ere d t soluzwni antisettiche. l bistut•i e i coltelli sono tuth costruiti io ruodo che le lame si possono separare dal manico metallico per curare con una perretta
G. G.
Il aervblo milita re del medl ol e le riforme d e ll 'insegn a mento medico. - (Pro:7rès .'vlédical, Hl).
Una recente decrs1one del ùella gaerra in Franmolto l'avorevolmente accolta n el mondo medico, :Stabich·e· gli studenti 111 medicina che compiono 11 lo r o '-'ervrzto. m1htare siano posti o disposizione del medico capo del pet' esse re ut1lizzali pet• i bisogni del servizio sarutarw e secondo la rispettiva attitudine e capacita.
La m isura è t•i conoscìula buona ma incompleta, e si vor·venisse completala accordando agli studenti di tnerlic uto il permesso di ritardare il "-Orvizio fino a 25 o 26 anni etA in tutti laur•eati e coll'obbligo allora di ur: anr1o dt serv1z1o come di 2• classe di riserva.
fJUe!."lO un SÌStl•llJ8, per la loro preparazione al .guerra, molto superi ore all'alluale, poichf> ora i dt t•tserva non ho11no alt r a prepot•azione por la rrrobrlrtazlOne che il tempo pasMlo al r eggimeuto come soldalt e le chiamate per l'istl'uzione: e tutti sa nn o quanto ,1ueste
E SERVIZIO 'IKDICO li!LITAIIE 7:13 siano brevi e rat•e, e come viene impiegato il tempo di servizio sotto le armr !."Otto rl punto dr vista medico. la degli aides-majors di 2" dell'alli vita, di carriera, o come dicesi da noi .è ,·eramenle l;lrano che dopo cinque anni di medietna sr dra un solo gallone ad un dottore, mentre assai pi'ù per eta, glt allievr di Fontainebleau lasciano la scuola col di lul)gotenente. Al Val-de Gràce tutti gli ellievi essere aides-majo rs di 2" classe. come a Fonsono sottotenenli. e al loro uscire dalla scuola nomtnalt dr J• classe, come altri tenenli. Il servizio non ne soiTrrrebbe sia per•chè esso é uguale nei due gra di, sia perchè vr Mrebbero sempre quelli di seconda cla-.se destinali, dopo un an.no, a passa.re alla ri .,erva, e la Francia proJuce tanti doLtort da sopperu·e u ognr e,;igenzl':l di servizio.
L'organizzazione del sistema che !'.J desidererebbe vedere sarebbe as!'ai semplice. Al finire d'ogni anno scolastico, in agosto, lutti gli studenti ua medicina che si laurearon o sarebbero nominati aùles-mojors di 2• classe di riserva e distribuiti m tutti 1 corpi dell'es<'t'cito dove compirebbero lutto il servizio rniziandosi cosi alla pratica deUa medtcina e della vita militare. Corsi ;;peciali, confet·enzP, eserc1zi pratici a completarne comprenderebbero l'amministrazione e i regolamenlt militari, patologia e igiene militare, manovre d'ambulanza, ser,·rzio i11 campagna, equitazione.
Distribuili in lutti i corpi essi imparerebùE.>ro a conoscere dei metJic1 mililar1, e ne \'edrebbero e potrebbero apprezza rne le dillìcoltà, amar<:!zze, e rientrati nella vita civile essi :;ti udicherebbero meno SP-veram enle i medici m ilitari di cart·iera, che du rante un anno intiero essi avrebbero visto all'opera, costrelli a contenlare lutti in unt1 volta il comando. le trup pe, l'op111ione pubblica od il m ondo medico, missione molto difficile e di cui coloro che non ne furono mai in caricati non hanno lu menoma iLiea.
L'anno di servizio terminerebbe colle manovt·e, a cui questi giovani medici pre nù .. r ebbet·o parte pr·ima di e"-sere congedati. L'autore enumera e dimostra i vantaggi di questo sbtema: migliore preparazione al set•vizio di guerra pei medici di riserva che ora non ne ri cqvono a lcun a: miglioramento del servizio sanita rio nei co rpi dove i medici militari in !."ervizio attivo verrebbero aiutali da lutto questo nuov.:> annuale elemento destinato poi alla riserva: la..;ciando i nuovi giunti al servizio nrlle guarnigioni, mentre quelli dell'anno precede,nte prima di essere congedati prenderebbero parte alle manovre, si cosi sempre dei medici subalterni rn servizio tanto o':)lle g ual'ni g io ni che m campagna, e lutti avrebbet·o la stessa progressione di gli stessi metodi, la stessa pratica.
Questa r·iforma dovrebbo esset•e accompagnatA da allre misure non meno necessarie, non meno utili all'esercito e che ne det·iverebbero come conseguenze logiche e dirette.
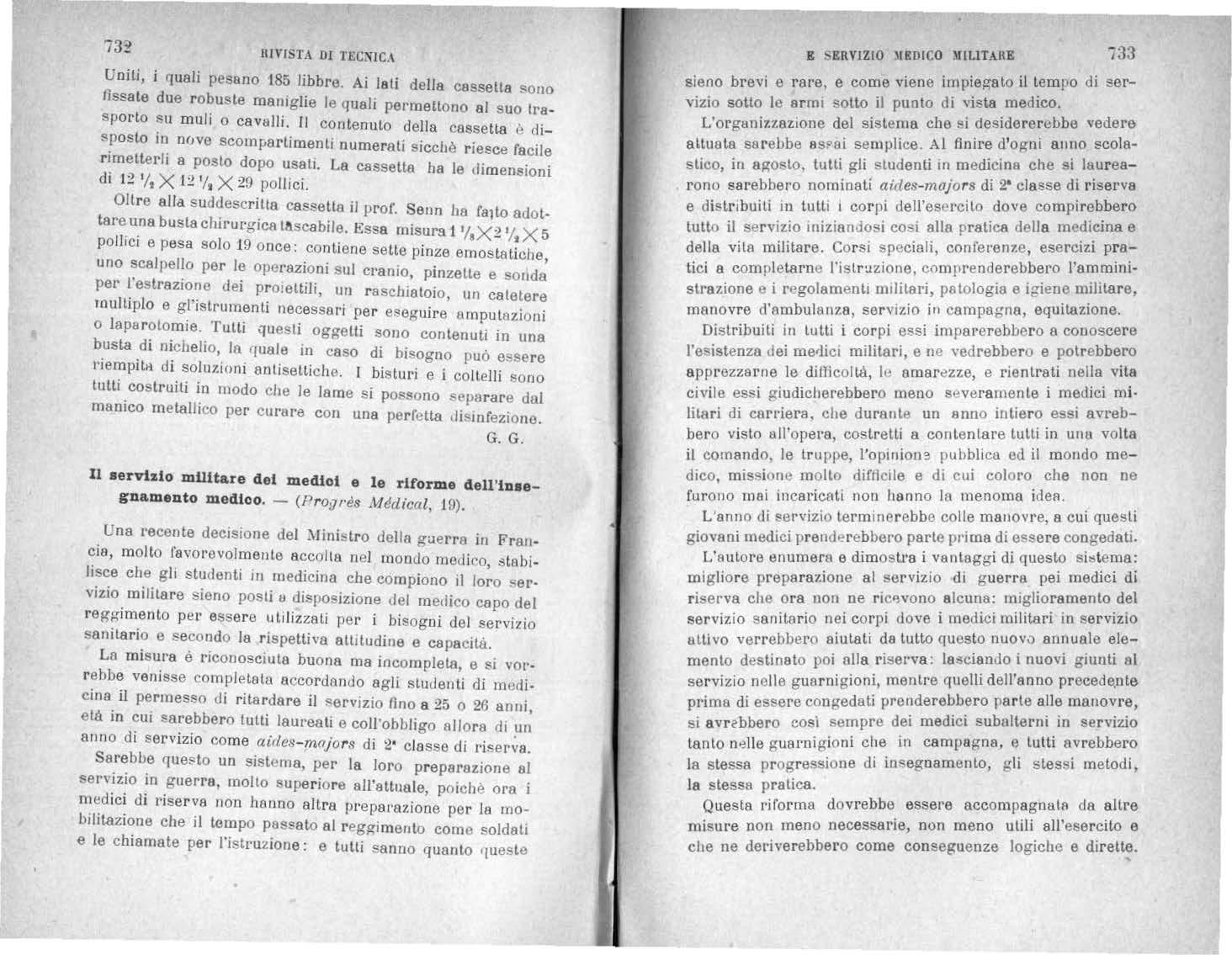
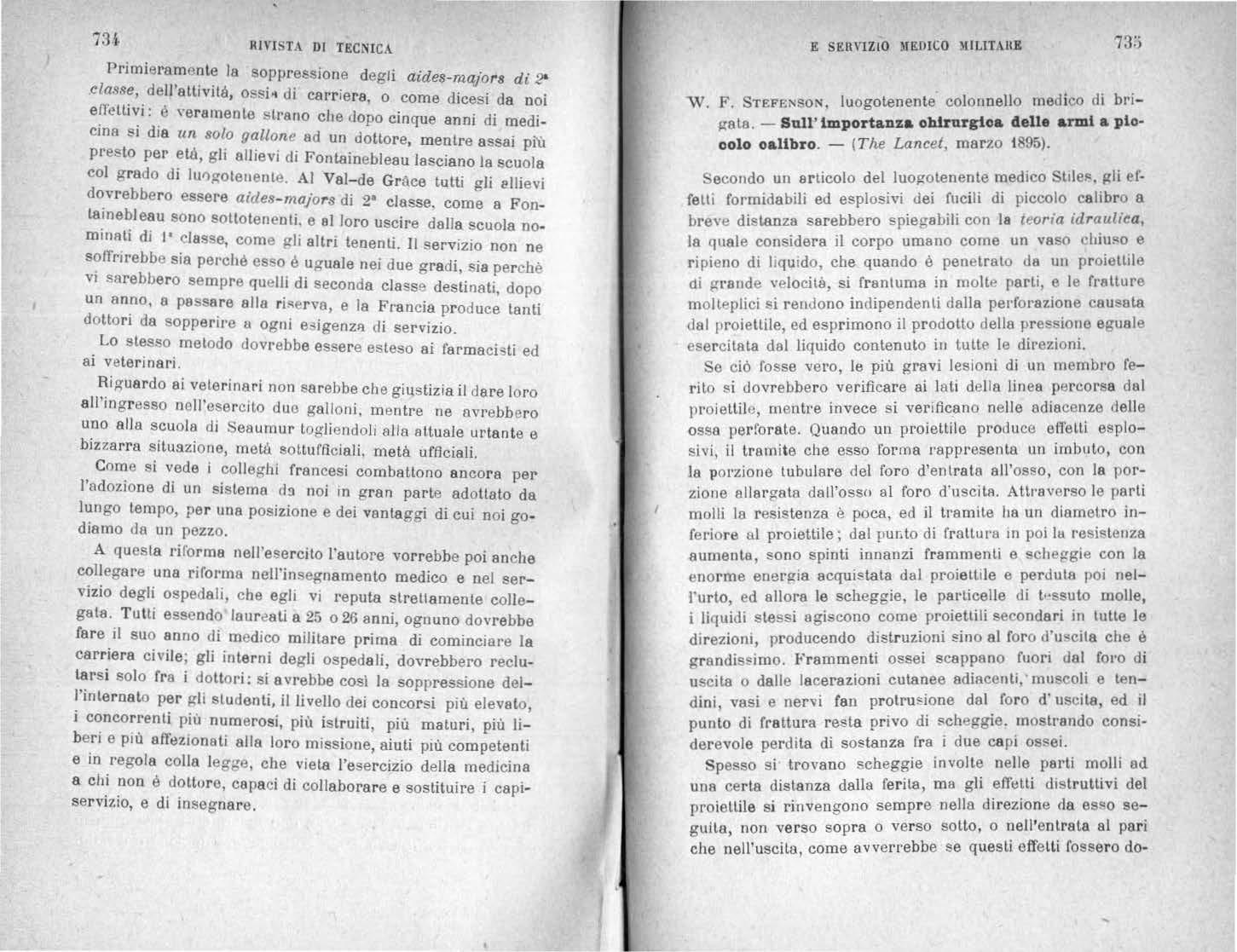
Lo stesso metodo dovrebbe essere esteso ai farmaci'lli ed ai veteri nari.
Ri guardo ai veterinari non sarebbe che giijstizia il dare loro all'ingresso noll'eser·cito duo galloni, mentre ne avrebbero uno alla scuola dr Seaumur t(Jgliendolt alla attuale urtante e bizzarra situazione, meti.t sottufficiali, metà ufficiali.
Com e si vede i colleghi francesi combattono ancora per l'adozione di un sistema d!l noi 10 gran parte adottato da lungo tempo, per una posizione e dei di cui noi godiamo tla un pezzo.
A questa riforma nell'esercito l'autore vorrebbe poi anche collegare una riforma oell'im;egnamento medico e nel servizio degli ospedali, che eglt vr reputa strettamente collegata. Tutti essendo a 25 o 26 anni, ognuno dovrebbe fare ti suo anno di medtco militare prima di cominciare la carriera Ci\'ile; gli interni degli ospedali dovrebbero reclu. ' tars r solo fra i dol lor·i: si avrebbe così la soppressione delper ,rlt studenti, il livello dei concorsi p1ù elevato, l concorrenti più numerosi, più istruili, più maturi, più lib e.ri e prù alla loro missione, aiuti p1ù competenti e m regola colla che vtela l'esercizio della medicina a chi non é dottore, capaci di collaborare e sostituire i capiservizio, e di insegnare.
W. F. STEFENSON, luogotenente colonnello medico di bri- Sull' lmporta.nz& ohtrurgto& delle armi &plooolo oallbro. - ( The Lancel, marzo t895).
Secondo un articolo del medico Strie!'<, !Xli effelti formidabili ed esplosivi dei fucili di piccolo calibro a breve dislanza sarebbero spiegabili con la teoria idraulica, la quale considera il corpo umano come un vaso e ripieno di lrqUtdo, che quando é penetrato da un proiettile di {.tt'ande ,·elocità, si frantuma in molle parli, e le fr·atture molteplicr si reudono in dipendenti dalla perforazione cauo::ata dal proiettile, ed esprimono il prodotto della pre!'!'<iOne eguale eser citala dal liquido contenuto iu tutte le dit·ezioni.
So ciò fosse vero, la più gravi !estoni di un membr·o ferilo si dovrebbero verificare ai lati della linea percorsa dal proiettile, mentre invece si vertfìcano nelle adiacenze delle ossa perforate. Quando un pt·oietlile produce elfelli esplosivi, il Lramite che esso forma t•appr·csenta un imbuto, con la pot•zione tubulare de l foro d'entrata all'osso, con la porzione alla l'gata dall'osso al foro d'uscita. Atlravrrso le par•li molli la resistenza è poca, ed il tr·amile ha un diametro infel'iore al proiettile; dal puulo di fraltut•a 111 poi lu aumenta, spinti innanzi frammenti e scheggie con la eno rm e enel'p:ia acquistata dal proietltle e perduta p01 nell'urto, ed allora le scheggia, le pal'licelle di l•·ssuto molle, i liquidi stessi agiscono come proiettili seconda ri 10 tutte le direzioni, producendo distruzioni sino al roru d'u..,cila che è grandis.::rmo. I<'rammenLi ossei scappano fuori dal fo•·o di uscita o dalle la cerazioni cutanee adiacenti, e lt>ndini, vasi e nen·i fan protrusione dal foro d'uscita, ed rl punto di frattura resta privo di scheggia. mostrando considerevole perdtla di sostanza fra r due capr osser.
Spesso si trovano scheggia involte nelle parli molli ad una certa distanza dalla fe r ita, ma gli efl'elli dtslruUivi del proiettile si rinvengono sempre nella direzione da esso seguita, non verso sopra o verso sotto, o nell' entr ala al pari che nell'uscita , come avverrebbe se questi effetti fossero do- vuti alla pressione idraulica, e come accade nelle esperienze di tiro su tubi di staguo r1piE>ni di liquido. In una parola. gl1 etrelti esplos1vi dei tiri a breve distanza sono dovuti direttamente al proiellile, indirettamente all'azione delle particelle dei tessuti, O!"Sa, parti molli e liquidi spinti innanzi con grande velocità.
Questa è l" opinione di Longmore, e nell'i stesso senso Delorme riconosce che si é attribuila troppa importanza alla teoria idraulica, acc ettabil e per gh organi cavi co me lo stomaco, la vescica, il cuore, ma non pe1· gli solidi conlenenti pochi liquidi come il cervello, lu milza, il fegato, i r e n i, nei quali bisOgni!. assegnar molla pat·te alla sostanza solida spinta innanzi.
Bruns dopo 11umet•osi espe rimenti conclude che gli effe tti dislrultivi della pressione idraulica sono proporzionali alla resistenza delle pareti, quindi ritiene ché relativamente al cranio , la teoria idraulica sia sufficiente a spiegare le numerose fraLlure di esso . Egli aggiunge, che siccome i proiettili con invilupp1 di rnetHllo clut•o raramente si deformano, col'li meno facilmente 1 moderni pi'Oieltili banno effetti espio<> i vi.
L'aut01·e, continuando la critica del lavoro di Stiles, concorda con l'opinione da lui espressa cirl'a il fatto c-he fino alla distanza di 1800 metr1. le devastazioni pt·odotte nelle o::.sa sono in ragione inversa della distanza, ma oHre i 1800 metri, diminuisce l'energia acquistata dal proie lllle, e le comminutive divengono più frequenti, perc hé il proiettile segue allora la parte declive della sua trai e ttoria, e colpisce o])liquaroento, cwé con la sua maggior
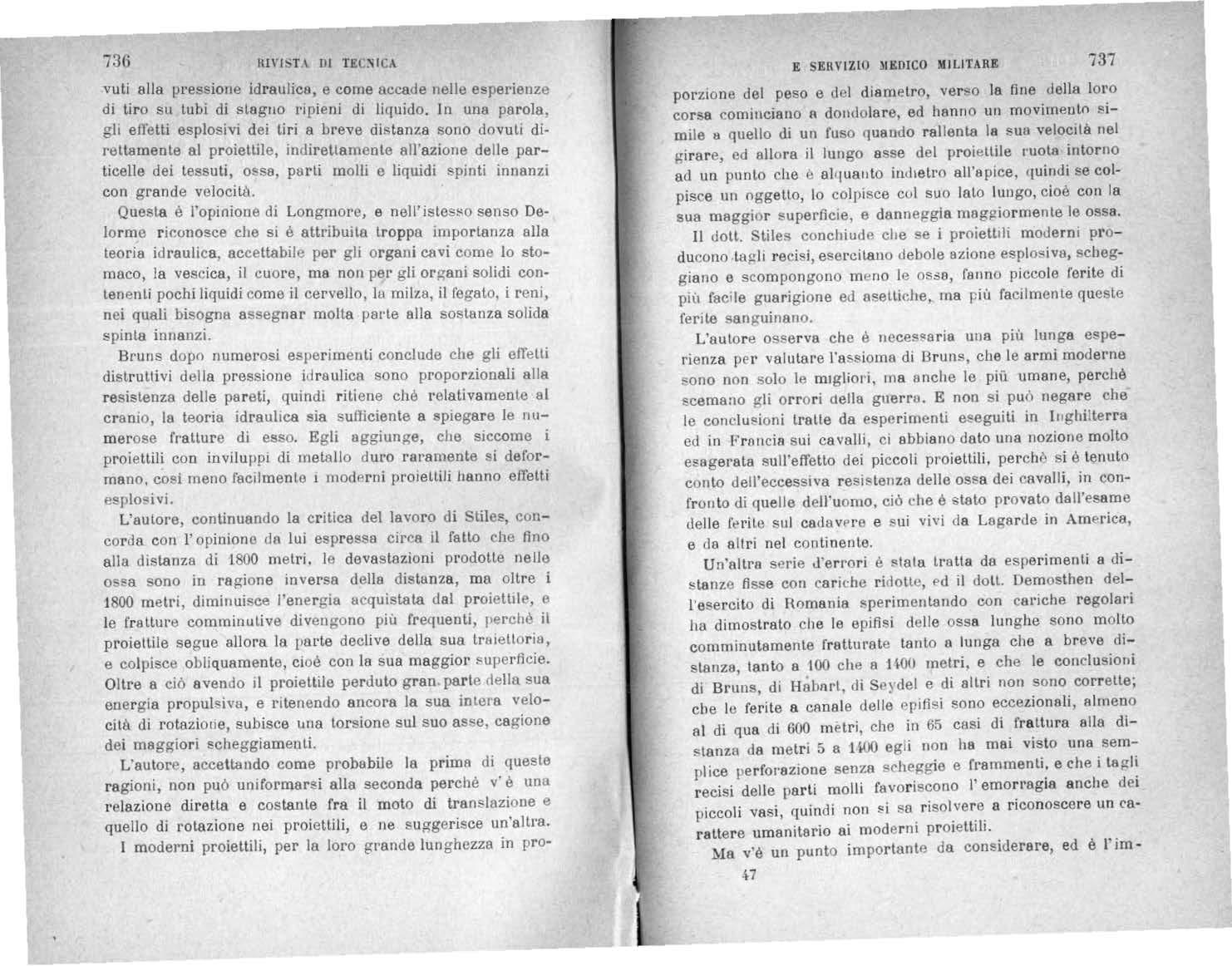
OILre a ciò avendo il proielLile perduto gran parte 1lella sua energia propul.. iva, e ritenendo ancora la sua in lcl'a velocità di rotazioue, subisce ana torsione sul suo as«e, cagione dei maggiori scheggiaroeuli.
L'autore, accetlando come pi'Obabile la primA di queste ragioni, non può un1formarsi alla seconda perchè v· é uo tt relazione diretta e costante fra il moto di trans lazione e quello d1 rotazione nei proiettili, o ne suggerisce un'allt•a.
1 moderni proiellili, per la loro gl'ande lunghezza in pro-
E SEL\VIZtO MEDICO MILI TARE 731 porzione del peso e del diametro, la fine della loro corsa cominciano a dondolare, ed hanno u n movimento !"imite 8 quello di un fuso quando rallenta la suo veloc1tà nel gi r are, ed allora il lungo asse del proiettile ruota intorno ad un punto che è alquanto in..hell'o all'apice, 'Juintli se colpisce un oggetto, lo colp1sce col suo lato lungo, cioè con la sua maggior superfic1e, e le ossa. Il doU. Stiles conchiude che i proiettili modern1 producono tagli recisi, eser·cilano debole azione scheggia no o scompongono m t- no le os3a, fanno piccole ferile di più facile guarigione ed nselliche, ma più fac1lmente queste ferile
L'autore os!"erva che è ucces"aria una più lunga esperienza per valutare l'assioma di Bruns, che le armi moderne !"ono non s olo le llllgliori, 1na anche le piu umane, per ché scemano gli orro r i cella guerrtl. E non si può negare che le con clu!:tioni lralle da esperimenti eseguiti in Iughilterra ed in Francia sui cavalli, c1 abbiano dato una nozione molto esage1•ata sull'effetto dei piccoli proiettili, perchf'l si è tenuto co nto dell'eccessiva delle ossa dei cavall i, in confronto di quelle dell'uo mo, ciò che é stato provato dall'esame delle ft>l'ilO sul cadavPre e l'lUi vivi da Lagarde in America, e da altri nel continente. Un'altra st>rie J"e r rori è stata tratta da esperimenti a ùislanze llsse con cari<"he rirloUt•, Pd il dott. Oemosthen dell'esercito di f\omania sperimentando con ca1·iche regolal'i ha dimostralo che le epifisi delle ossa lunghe sono mollo comminutamente rratturate tanto a lunga che a b r eve distanza, tanto a 100 che a l t.{)() metri, e che le conclusioni di Bruns, di Hahnrl, di Seydel e di altri non sono corr ette; che le ferile a canale delle epifisi sono eccezionali, almeno al di qua di 600 mPtri, cho in o5 casi di . alla dìt ... da metri 5 a 1 W() eg 1 i non ha mal v1sto una sem!0 anz" . r plice perforazione senza !::'rheggie e f1•ammenli: e che 1 recisi delle parti molli ravori"cono l' emor1•ag1a a nche de1 piccoli vasi, quindi non si sa . a rico n oscere un carattere umanitario ai mod e rm pr01etl1h. . , . .Ma v'è un punto importante da considerare, ed é l 1m-










