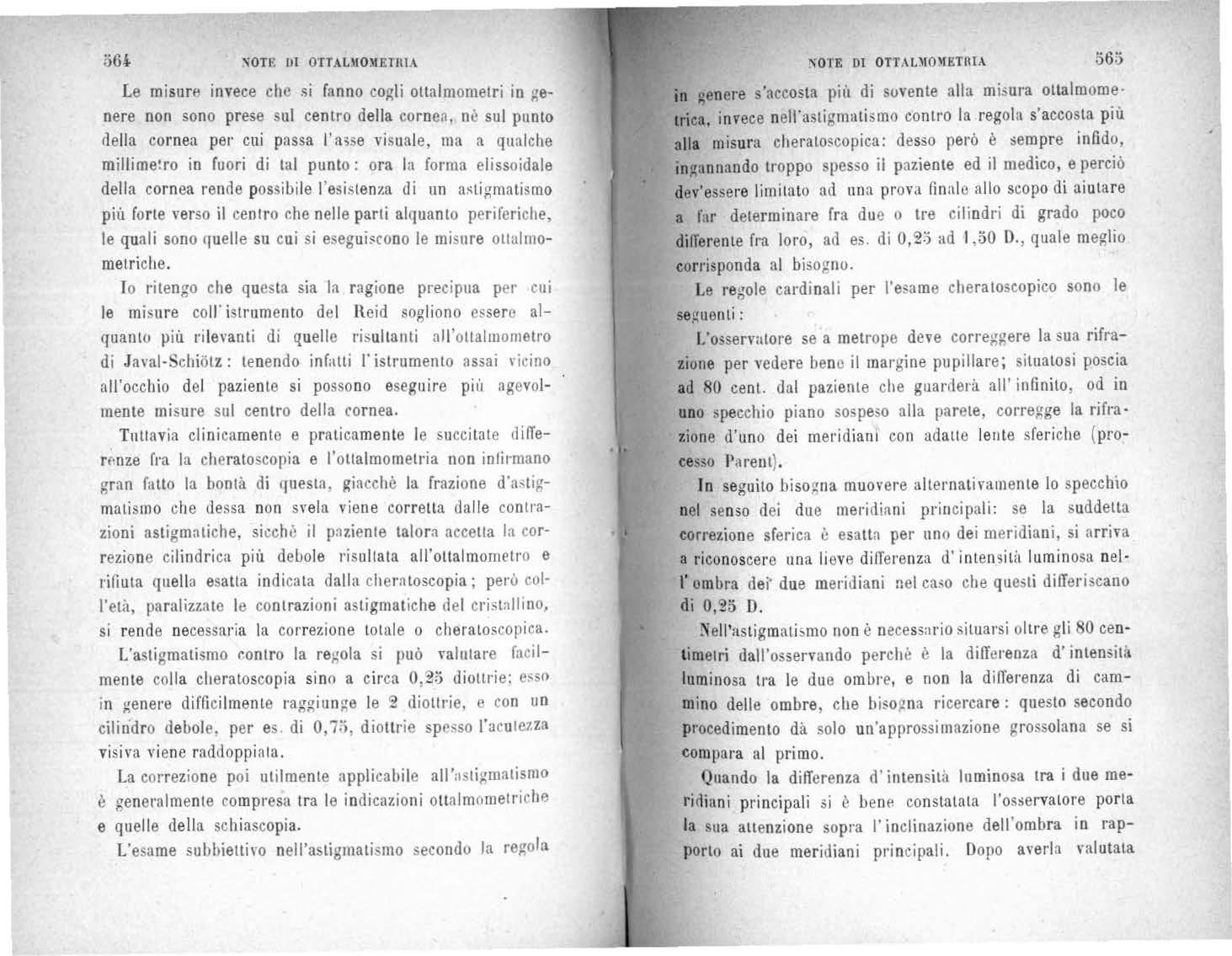
18 minute read
DI OTTALllOMETI\lA
Le misurf' invece ch e si fanno cogli otlalmometri in ge· nere non sono prese sul centro della co rn en . nè sul punto clelia co rnea per cui passa l' a; se vi sual e, ma a qualche millime:ro in fu ori di tal punto: ora la forma elissoidale della cornea rende possibile l'esistenza di un astigmatismo più forte verso il centro che nelle parti alquanto periferiche, le quali sono quelle su cui s i eseg ui Ho no le misure oualmometriche.
l o ritengo ch e questa sia la r ag io ne precipua per cui le mi sure co ll' istrum ento dol Reid sogliano esser e alquanto più rilevanti di quelle risultanti al l'ottalmometro di Javai-ScbiO tz: tenendo infatti l' istrumento assai 'ici no all'occhio del paziente si posso no ese guire più agevo lmen te mi sure su l centro della ro rnea.
Advertisement
Tnllavia clinicamente e prati camente le succi tat e differ f· nze fra la cherato scopi a e l' ottalmom etria non infirmano gran fallo la bontà di questa. gi acchè la frazione d'a,.,tigmati smo dessa non svela viene corr etta da lle co ntrazioni astigmatiche, sicchè il pnziente talora acceua la cor· rez ion e ci lindri ca più dei.Jole risultata all'oualmom etru e rifiuta quella esatta indi ca ta dalla chc rnto sco pia; però coll'età, pa ralizzate le con trazi oni astigmatiche del cristallino, si r ende necessaria la corr ezione total e o cherato scopica.
L' asti gmatismo ro ntro la regola si può valutare fa cilmente co lla cheratoscopia sino a circa diott rie: esso in genere difficilmente le 2 diottrie, e co n un cilindro debol e, per es . di 0 , 7 :), diottrie spesso t'acutezza vi siva vi ene raddoppi111a.
La correzione poi utilmente ap pli cabi le all'a,;tigmntismo è ge net·almenl e co mpresa tra le indicazioni ottalmomelrJehe e quelle della sc hiascopia.
L'esa me subbiettiro nell'astigma ti smo second o la regola in ge nere s'nccosta pilt di sovente alla mis ura ottalmome· trica, invece nell'astigmatismo contro la regola s'accosta più alla misura cherato:-copica: desso però è sempre infido , troppo spesso il paziente ed il medico, e perciò dev'essere li mitato atl una prova fio:d o allo scopo di aiutare a flr determinare fra due o tre cili nd ri di grado poco differente fra loro, atl es. di 0,25 ad l , 50 O. , quale corrisponda al bisogno.
Le regol e ca rdinali per l'esa me chera tosco pico sono le seguenti:
L'osservatore se a metrope deve co rregge re la sua rifrazione per vedere bene il margi ne pupillare ; si tuatosi posc ia ad 80 ceol. dal pazient e che guard erà all' infinito. od in uno specchi o pian o sospeso alla pa rete, corregge la rifra · zion e d'un o dei meridiani co n adatt e leute sferi che (pro· cesso P<lrent) . l n seguito hiso ,e: na muov ere alternativam ente lo s peccbto nel senso dei du e meridia ni priu ci pali: se la suddetta correzione sferica è esa lt n per uno dei meridiani, si arriva a ri co noscere una li eve difl'et·enza d' inten sitil lumino sa nell' ombra dei· due merilliani nel ca.;o che quest i differiscano di 0,25 D. non è necessario si tuarsi oltre gli 80 cen· tim etri dall'osservando per chè è la differenza d' intensità lumi nosa tra le du e ombre, e non la differenza di cammino delle ombre, che bis o).! na ri ce rcare: questo secondo procedimento dà sol o un 'approssimazio ne grossolan a se si compara al primo.
Quando la differenza d' inteosittl lumin osa tra i due meriòi ani p rincipali si è ben e constatala l' osservatore porla la sua attenzione so pra l'inclinazione dell'ombra io rapporto ai due meridiani prin cipali. Dopo averla valutata appt·ossimativament e si t11a avanti l'occhio un ci lindro concavo debole, il cui asse corrisponda allo spostamento de ll'ombra nel meridi ano pi tt rifra nge nte, ed a tentoni cerca d'ottene re l'ugua glianza delle ombre nei due meridiani, sia cambiando il ci lindro, sia modi6candonA l'inclinazione.
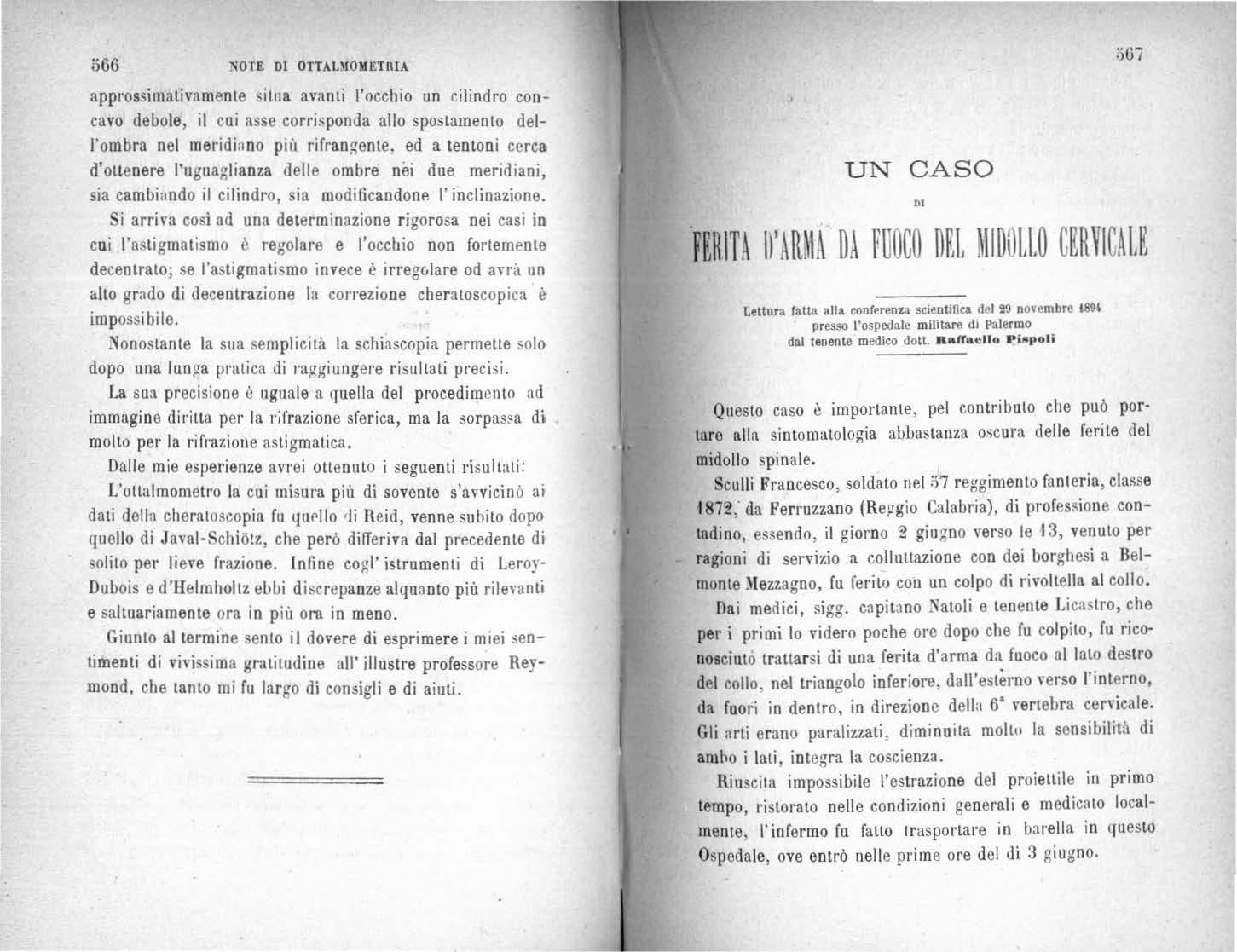
Si arriva cosi ad una determinazione ri gorosa nei casi in cui l'astigmatismo è regolare e l'occuio non fo rtemente decentrato; se l'astigmatismo in vece è ir regulare od ana un alto grado di decen trazione la correzio ne cher atoscopica è im possibile .
Nonostante la sua !'emplicità la schiascopia permelle solo dopo una lunga pratica di raggiungere r isultati precisi.
La sua preci sione è uguale a quella del procedimento ad immagine diritta pc•· la rifrazione sferi ca, ma la sorpassa dio molto per la J'ifraziou e astigmatica.
Dalle mie esperienze avrei ottenuto i segue nti risultati:
L'o llalmom et•·o la cui misura più di sovente s'avvicinò ai dati dell a cheratoscopia fu lJ.Urllo •li Reid, venne subi to dopo quello di J aval - ch i<Hz , che però differiva dal precedente di so lito per lieve frazione. In fine cogl' istrumenti di Lero)Dubois e d' Helmholtz ebbi discrepa nze alquanto più rilevanti e saltuariamente ora in più ora io meno.
Giunto al termin e sento il dovere di esprimere i miei sentimenti di vivi ssima gratitudine all'illust re professore Reymood, che tanto mi fu largo di consigli e di aiuti.
D'ARMA DÀ FUOCO DEL MIDOLLO
Leltura fatta alla conferenza scientifica del !9 noHmbre 189\ presso l'ospedale militare di Palermo dal teoente medico dott. aaO'ae ll o PiHpoli
Qu esto caso è importante, pel con tributo che può portare all a si ntomato logia abbas tanza oscura delle ferite de l midollo spin ale.
Sculli Francesco, soldato nel :n r eggimento fant eri a, classe i 872 ,' da Ferru zza no Calabria), di professione co ntadino, essendo, il gior no 2 gio::rno vet·so le ·J3, venu to per ragion i di servizio a colluttazion e co n dei borghesi a Belmonte ..\lezzag no, fu ferito con un colpo di rivolte ll a al collo .
Dai medici, sigg. ca pitano Natoli e te nente che per i primi lo videro poche ore do po che fu colpilo, fu riconosci uto tratta rsi di una ferita d'arma da fuoco al lato destro del collo. nel triangolo inferiore, dall'estèrno verso l'interno, da fuor i io dentro, in direzio ne della 6• ' 'er tebra cervical e. Gli arti erano paralizzati, dimin uita molto la sensiliilità di amh o i lati, integra la coscienza .
R iusc ita impossibile l'es t razio ne del proiettile in primo tempo, ristorato nelle condizio ni ge nerali e medic:ltO lo calmente, l'infermo fu fatto trasportare in ()arella in questo Ospedale, ove entrò nell e prim e ore del di 3 giugno.
Sella no ue da l 2 al 3 fu eseguito due volte ti cateterismo dell'u ret ra, e si es trassero in lutto circa 800 cc. d'urina ma· croscopicamen Le nor male.
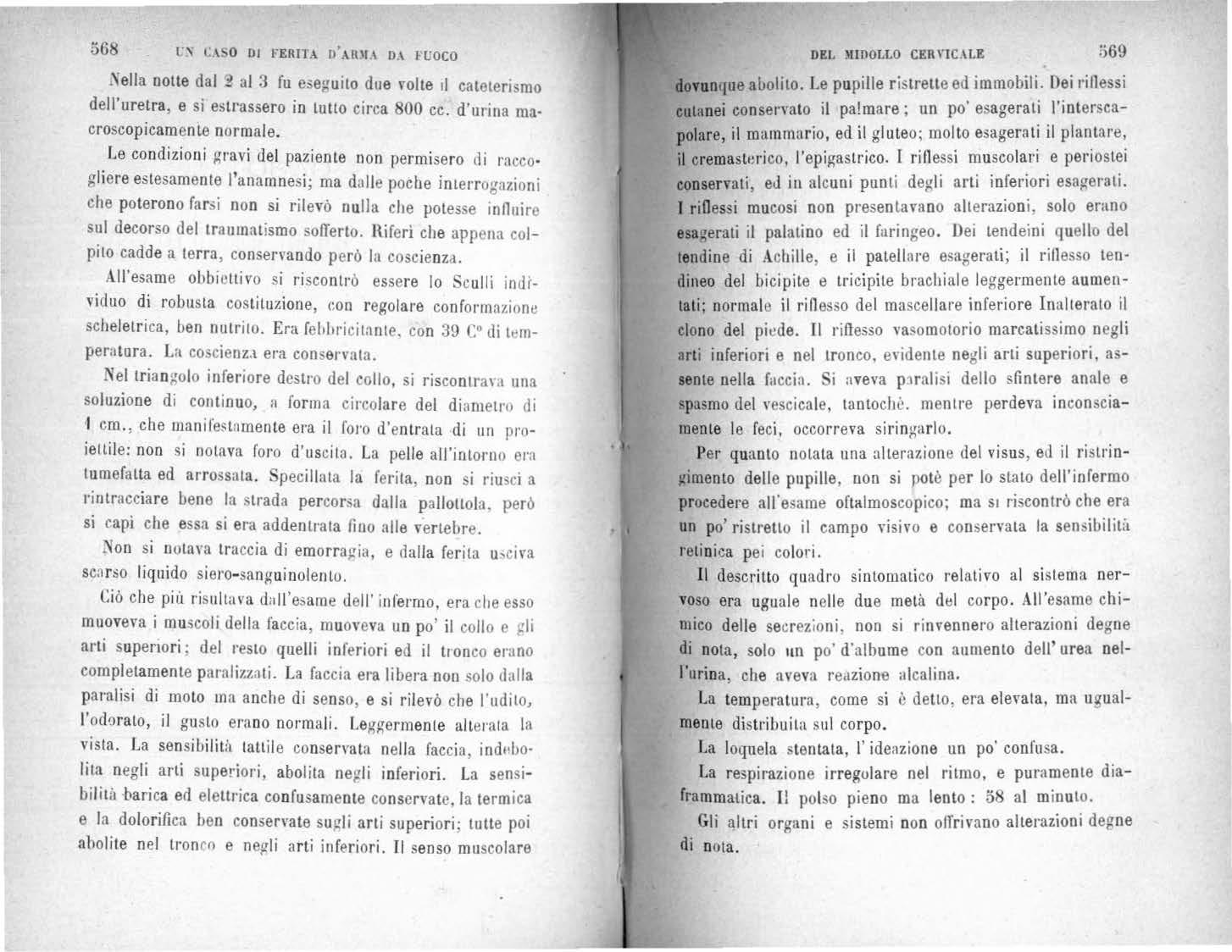
Le condizioni gravi de l pazien te non permise ro di racco · gl iere estesamente l' anamnesi; ma dulie poche i nterrogazioni che poterono fa rsi non si rilevò nulla che potesse mOuire sul decorso del traumatismo soO'erto. Hiferi che appena colpito cadde a te rr a, conservando però la coscienza.
All'esame ohbiellivo si riscontrò essere lo Sculli inùrvirluo di robusta costituzione, <:on rego lare conformazione scheletrica, ben nutnto. Era febbricitante. con 30 co di Lt'mpera t ura. La coscienz.1 era conservata.
Nel tria n.;:olo inferiore destro del collo, si riscontra'<t una soluzione di continuo, rt forma circolare del diametro di l cm., che manifestamen te er·a il foro d'en trata di un proiett il e: non si notava foro d'uscita. La pe lle aiJ'inlomo (.Ira tumefal ta ed ar rossata. Specillata la ferita. non si riuscì a rintracciare l>ene la strada percorsa dalla pallollola. però si rapi che essa si era addentrata fìno alle vertebre. s i notava traccia di emorragia, e dalla ferita sca r so liquido sier·o- sang uinolento.
Ciò che più risultava da ll 'esame de ll'infermo, era che esso muo veYa i muscoli della faccia, muoveva un po' il collo e gli ar ti supeno ri: del resto que ll i infer ior i ed il tronco erano completam ente paralizzati. La faccia er'll libera non solo d,dJa paralisi di mo to ma anche di se nso, e si rilevò che l'udito, l'odor ato, il gusto er·ano normali. Leggerm en te alterala la vista. La se nsibili tà taUile conservata ne lla faccia. indi'bO· lita negli arti superiori, abolita inferiori . La sensibi litit ba rica ed elettrica co nfusamente consen-ate, la termica e la dolo r ifica ben conserva te sugli arti supe riori; tulle poi aboli te nel tronco e ar ti inferiori. Il senso muscolare donn•(Ue auo lito. Le pu pille r i ·tret te ed immobili. De i riflessi cutanei cons en •ato il pa! mare; un po' esagerati l'i nt erscapolare, il mamm ari o, ed il gluteo; mol to esager a ti il pian tare, il cremastnri co, l'epigas trico. [ r iOessi musco lari e periostei conservati, eJ in alc uni punti degli at·ti inferiori esagerati. 1 riflessi mucosi non presentavano alterazio ni. solo erano il palati no ed il faringeo. Dei Lendeini quello del tendin e di Achille, e il palellnre esagerati; il riflesso Lendineo del bicip ite e tr icipile braclliu le leggermente aumentati; normal e il rifl esso del mascellare inferiore I nalterato il clono de l piede. Il riflesso vasomotorio ma r calissimo negli arti inferi ori e nel tronco. eridente negli arti su periori. assente nell a faccia. Si aveva p1ralisr dello sflntere anale e spasm o de l \'escica le, tantochè. mentre perdeva inconsciamente le feci, occorreva si rin ga r lo.
Per quanto uolala una a lterazione del vis us, eù il r islrin)(imento dell e pu pille, non si potè per lo stato dell'infermo procedere all'e:>ame oftalmoscopico; ma st risco ntrò che era un po' ri stretto il campo Yisivo e conservata la sensibililtt retini ca pei co lori.
Il descritto quad ro sintomatico re lativo al siste ma nervoso era uguale ne ll e due metà dal co r po . Al l'esame chimico delle secrezioni. non si rinvennero alterazioni degne di no ta, solo un po' d'albu me con aume nto dell ' urea nell'urina , che ave va reazione alcal ina.
La temp erat ura, come si è dello, era e levat a , ma ugualmente distrib uita sul co rp o.
La loquela :; tentata, l' idenzione un po' confusa. La res pirazione irre golare nel ritmo, e puramente diarramm atica. Il po lso pieno ma le nto : 58 al min uto.
Gli altri orga ni e sistemi non offrivano alterazioni degne cii nota.
DI FERITA o' ARMA. DA FUOCO
Non prese cibo durante il gi orn o. Alla sera il paziente si agg ra-vò e la temperatura sali a .i.0°.
La mallin a del di seguente il malato presentava questo di nn o\·o: er a dimin.uila la reazio ne inlìammatoria all'apertur-a eslern a delh ferita, da cui sco lava sempre sier o san · guinolen to; la temperatura er·a salita a 40°,2 ed insieme coll'aume nto della lempe rat ura, il respiro et·a fatto più celere, mentre il polso dava ap pena 60 ballute al minuto. La co· scienza un po' oiTusca ta. Ave va perduto sponta neamente le feci, mentre era stato necesc;ario iringa rlo per vuotare la vescica: l'urina conteneva albu me, aumentata l'urea ed il peso specifico, ed nve\'a reazione alcal in a .
Alla sera nuov o elevamt nlo lermi co ( 40°,5) Passò la nulle agiwtn, ed ebbe delirio.
La mallinn del o era peggiorato, perchè non so lo la temperatura er·n sa lita a 40°,8, il respiro era fall o stenlato ed il po lso più depresso, ma gli ar ti superiori . dal lo stato di paresi, erano anch'essi cad uti in stato di paralisi, e le sensi hilitit vi erano puro abolite. [ a cosc ienza essendosi assa i offuscata , fu imposs ibi le un pi ù attento dell' inferm o, solo si co nstatò che i r ifl essi si manlenevano come fu detlo nel primo esame . Provato a da re all'ammalato qualche alimento. si ebbero dist urbi di deglutizione. Si notò pure un marcato di priapismo. Yerso la se ra la tempera tura sal i a i. l o : par lava a sten to. L' urina, estr-atta col ca tete ri smo oiTriva uoa più decisa reaz io ne alcalina A J'nrea era salita al i) " '•. Al mauino de l di 6 il peggio ramenlo era g ravissi mo. Anche la vescica paralizzata, temperatura 41 °.:), polso 111O, pi ccol o, r es piri 38, su perficiali; da lla ferita usciva trarcia di pus. Alle natiche cominciavan o le les ioni da de cu bilo. Tulli i rifless i appe na visibili, persistente il priapismo, osservato il giorno prima.
DEl. MJ OOLLO CRil \' ! CALE
Le condi zio ni si aggravarono sempre più, e nIla 7 la coscienza et·a perduta completamente, la paral1 s1 dt moto e di senso generale su tutto il co rpo , te mperatura 41 o ,8 fe nomeni riflessi aboliti, scomparso il uniche manifel'tazioni della vita erano il respiro frequente ed accompaS!o ato da gemito in spirnto r io, ed il .pol so dicroto e La tempera tura sulla sah fino a u • ed il polso si fece impe rce tt ibile. Comparve un sudore freddo, e qualche ora dopo questo (o re 21), il malato mori.'
Riferirò della necro5copia quello solo che rij.(U:lrda ti traumati-mo Il pro ietli le , colpito il col lo nella p.me più nlta deltri an"olo inferiore cioè nell'angolo form ato dall'o moioideo colla po;z io ne clavi co lar e dello stcrn ocleidom astoid eo si nd.dt-ntrò atLmverso to scateno anteriore e i tessuti so llostanl t, fino ad intacca re il lun ghissimo del collo all'altezza dello
Y6T tebra cervicale. In que - to tragitto non ferì i grossi vasi diramanti si dal tronco tireo-cervi cale, cui passò necessariamente vi ci no, trua li l' arteria tireoidea inferiore, l'at·teria cerv icale su periore e più di t utte l'arteria cervi ca le asce den te nè tacerò il nervo fr enico, ma furono com promessi vasi nervi di secondari a importanza. Co lpì In s• cervicale nel corpo, al davanti sub ito del tu bercoto anterior e. della apofi·i trasversa, per modo che l'arteria vet tehrale l'lmase ille'a . La vertebra fu perforata e non fratturat1. ed il proiettile, per !a resistenza incontrata nella pa rete ossea al punto d' ingresso, fece qui vi un infossamen to, e sulH movimento di r otazion e da destra in avanti, per modo da dt:;porsi perpendico larmente all'asse passante pel ca nale verte· hrale. I n questa posizione lo t·itrovammo all'altezza della vertebra, che del reslt> era illesa, e per estrado fu necessn i'I O di sa rti colare la 7" cervi cale dalia sottostautc TI proiettile a,·eva un ca libt·o di 3 mm . Nel cadav ere la via LE\nuta dal o'AIIMA DA FUOCO proit!ttife era segnata dal delle parti molli .·orpile. e vi si notava leggera tra ccia di suppurazione; una 0 due goccie di pus erano raccolte attorno al foro scavato nella Il midollo. sia al disopra cùe al disotto del punto colp1t0, presentava un pro cess o Oog:istico ac:utissimo e<l era spappofato. l'er fa penetrnzione del proiettil e nel cana le vertehrafe, e pe! suo spostamento verso l'avanti, il midollo fu sin da pr1ma compl etamente distrutto, alla qunle meccanica dist 1·uzione si unì poi fa disorganizzazione prodotta dalla mielite traumatica.
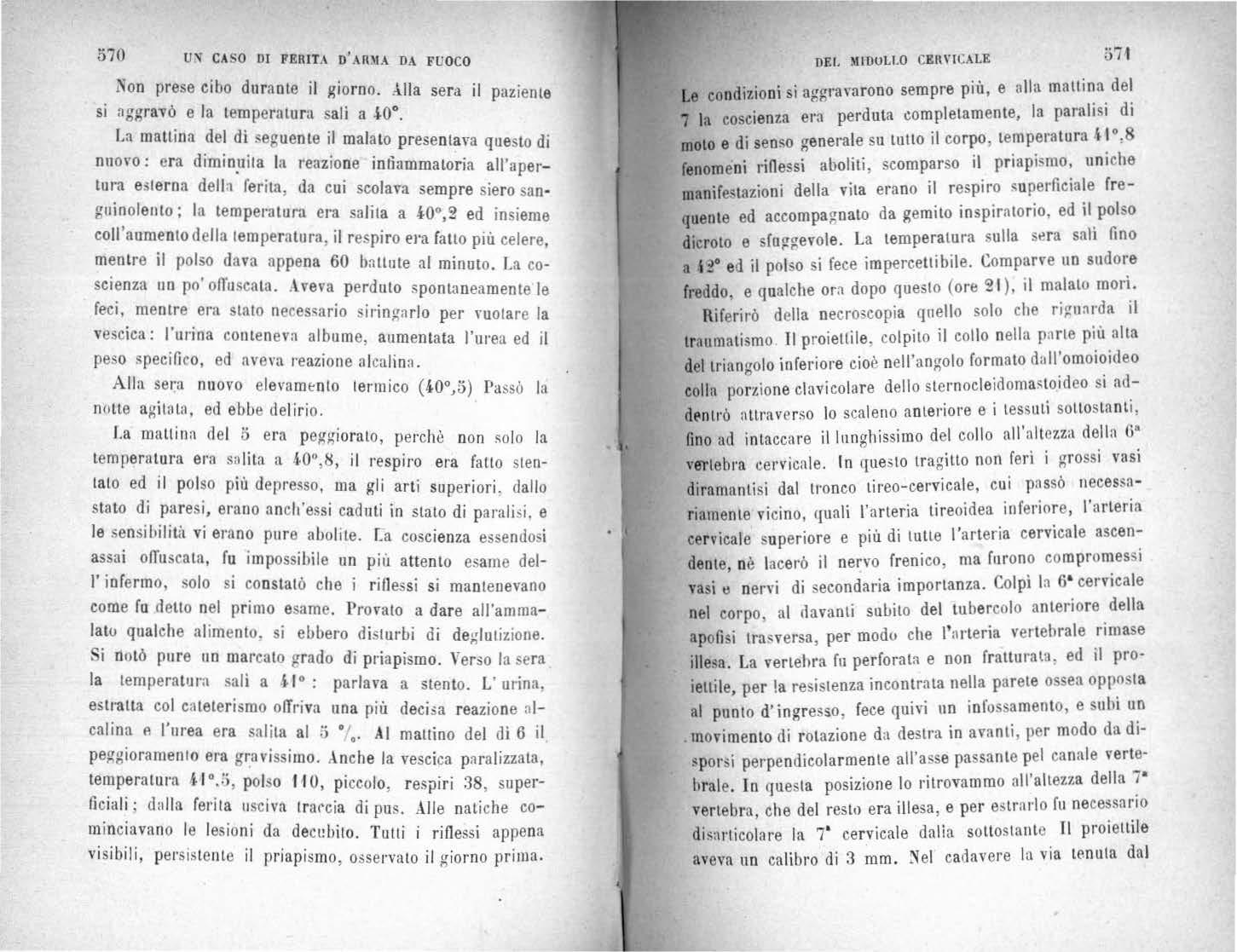
La .pallottola era scesa fino nella 1• verteb ra, perchè pel propno erasi infos sata snf miclollo, tanto più che questo fu 1·eso pw cedevole dall' infiammazion e .
. l n si tentò cautame nt e l'estrazione del proIettile con l t1ra pa lle, ma non riu sce ndovi si pens ò di arrivare sulla vertebra colpila con un taglio come quell o che si conduce per legare l'arteria vertebrafr , o posteriormente con un processo an alogo a quell o pe1· eseguire fa lamnectomia. Consigliava a farlo fa :;peranza r he il midollo non fosse din•ttamente per penetrazione del proiettile nello speco rertelm:tfe , ma s1vvero che fa venebra fosse soltanto frattural a, e che i fenomeni della lesion e mido!Jarr dipen dessero da compressio ne eserci t11la e dal co1·po estraneo e da scheggie ossee. Si opponeva a questo per vero fa dill'usion e dei sin tomi, ma era ammellere che alcuni di es si dipendessero dalla commozione del miùollo, risentita anche .1 distanza dal punto colpito. Si abbandonò però l' idea di un atto operativo, che, come mostrò fa necroscopia, sareùlJe riuscito inutile. Fm da principio la diagnosi di sede io nlteua della lesione e fa sua natura non erano ùa discutersi conoscendosi la vertebra fesa e la ca usa ledente, come 'p11re
DEL mOOLLO CBUVIC\1 E 573 era chiaro che il midollo orizzontalmen te era tullo com· promesso, cssPndo i sintomi difTu si ed uguali nelle due metà del rorpo. Piuttosto restnno ad e delucidarsi alcuni l'alli.
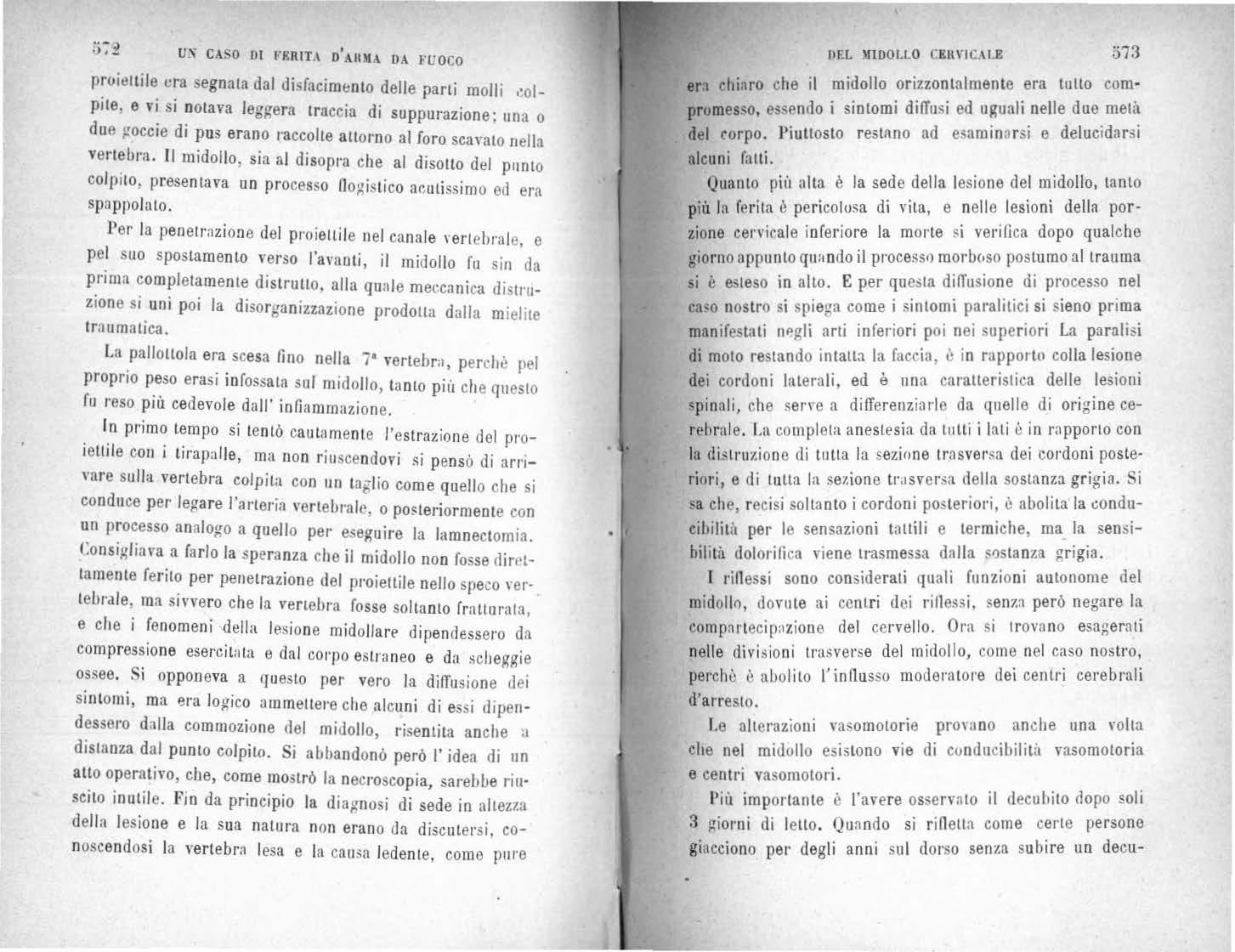
Qua nto più alla è la sede della lesio ne del midollo, tanto più fa ferita è pericolosa di vita, e nello lesioni della porzi one cervicale inferiore fa morte :'\i veri!lca dopo qualche giorno appunto quando il process•l morbc•so postumo al trauma si è esteso in alto. E per qu esta diffusione di processo nel nostro si spiega come i sintomi paralitici si si ano prima manifestati nP gl i arti inferiori poi nei supe ri ori La parali si di moto restando intatta fa faccia, è in rappo1t<1 colla lesione de i cordoni laterali, ed è una caratteri stica delle lesioni che se n ·e a dilfereozinrle da quelle di origine cereb rale. La com pl eta anestesia da tutti i lati é in t·npporto con fa di tutta la sezione trnsve1·sa dei co rdoni posteri or i, e di tutta fa sez ione tras versa delln sostanza grigia. i che, re cisi soltanto i co rdoni è abolita la t:onducihilitit per le sensazioni tatt ifi e termi che, ma fa sensibilità dolorifi ca viene trasmessa dalla ::')s tanza grigia. l rifl essi sono considerati quali funzioni autonome del midollo, dovute ai ce nLri dei rill essi, senza però negare fa comp:trtecipnzion e del cervello. Ora si tro,·a no esagerati nelle clivisioni tmsverse del midol lo, co me nel caso nostro, é auo li to l' inOusso moderatore dei centri cerebral i d'arre sLo.
Le allerazioni vasomotorie pro\'ano una \'olta che nel midollo esistono vie di w ndn cibil ità rasomotoria e cen tri va somolo ri.
Più importante è l'avere osse rv ato il decuhito òopo soli 3 :;:iorni di fello. Qu ando si rifl etta come cert e persone gi acciono per degli anni sul dorso senza subire un declL-
DI F&llll'A o 'AR)lA DA FU OCO biLo, s1 deve ammettere che non sia la sola pressione su quel Lrallo di cu te che produce la ca ncrena, ma che sia necessaria una seconda circostanza per la sua produzione. Il presen tarsi rapido fa presumere che di pende da una condizione nutritiva dei tessuti, che può essere anormale o perchè sono anorma li gli umori nutritivi , o perchè è anormale il hH'Ol'O dei regola tori trofici.
Ora se in nn uomo aff<• Llo sano, che so[erse di una distruzione traumatica del midollo , si determina in pochi giomi un decubito, parmi che si debba pensare ad una alterazio ne dei regolatori trofici causata dalla lesione stessa del midollo. E a meH iio appoggiare questa teoria. molto discussa, viene il fallo che il decubito si presenta anche · unilaterale, se uni laterali furono le les ioni spina li. I l caso presente viene in appoggio alla esis tenza del centro cilio · spinale di Budge, il qua le, essendosi fi n da pri ncipio mostrata l' alterazi{)ne della pupilla (ristretta}, giacet·ebhe nel trauo cervicale inferiore, mentre Bemard lo avrebbe po sto a li· vello della seconda vertebra. Ciò sarebbe la conseguenza della distruzio ne di questo ce ntro. mentre come effetto di un semplice stimolo, si avrebbe invece la dilatazione.
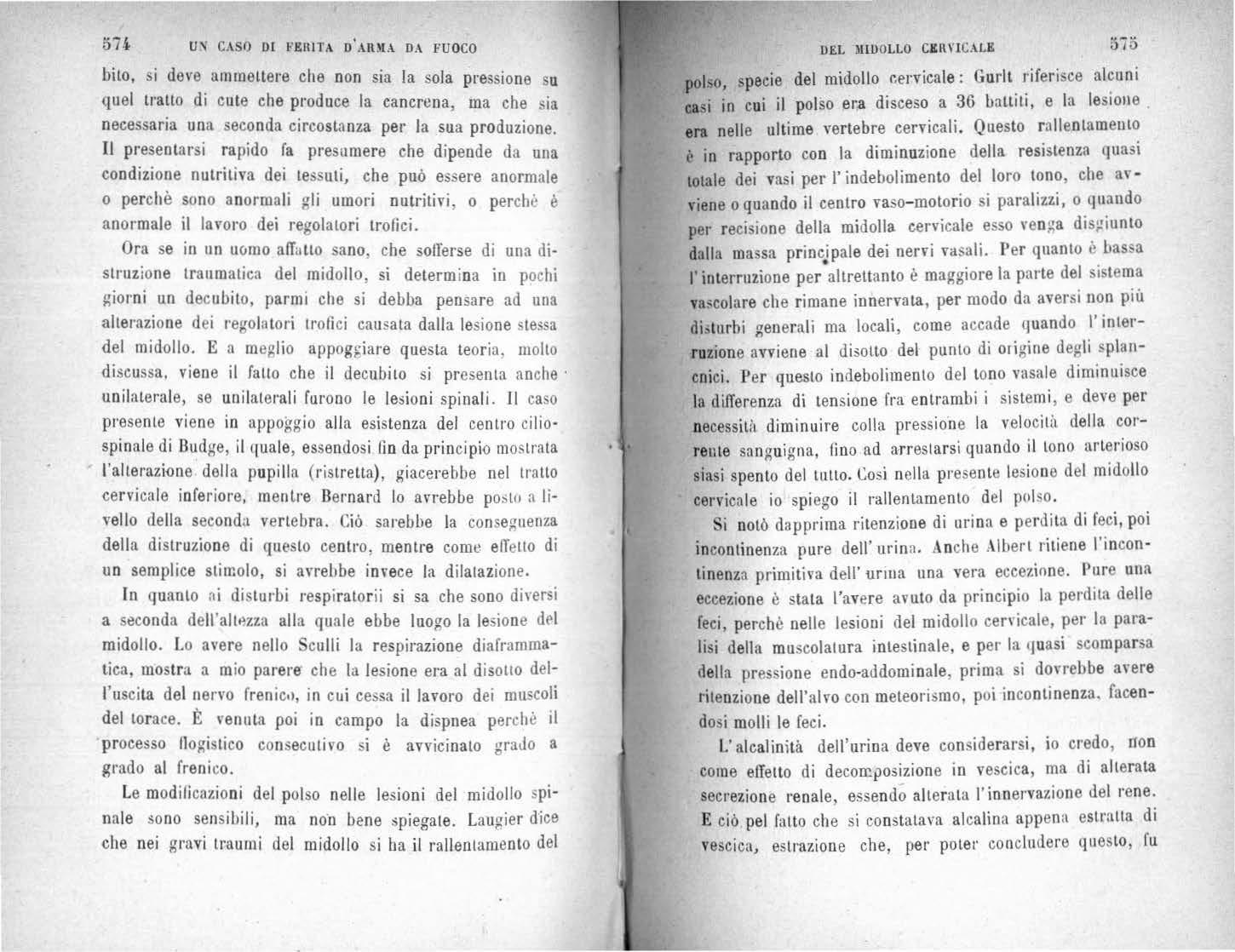
[ n quanto ai disturbi respiratorii si sa che sono dirersi a seco nda dell'allt>zza alla quale ebbe luosro la lesione del midollo. Lo avere nello Sculli la respirazione diaframmatica, mos tra a mio parere che la lesione era al disollo del· l' usci ta de l nervo frenicol, in cui cessa il lavoro dei muscoli del torace . È ve nuta poi in campo la dispnea perchè il p rocesso flogistico consecutivo si è avvicinalo graJo a grado al frenico.
Le modificazio ni del polso nelle lesioni del midollo spinale sono sensibili, ma Mn bene spiegate. dice che nei gravi traumi de l midollo si ba il rallentamento del polso, specie del midollo cervicale : Gurll riferisce ca"i in cui il polso era disceso a 36 battiti, e la les1o 11 e era nell e u!L ime ver tebre cervicali. Questo r allentamelllo è in rap port o con la di mi nuzione della resistenza quasi total e dei vas i per I' indebolimento del loro tono, che avvien e o qua ndo il centro vaso- moto r io si paralizzi, o quando per r ecisione della midolla cervicale esso ve nga dalla massa pr incipale dei nervi >asali. Per quanto t' bassa l' interrulione per •altrettanto è maggiore la parte del sistema va5col are che rimane innervata, per modo da aversi non piu di 3turb i gene r ali ma locali, come accade tjuando l' interruzion e avviene al disotto del punto di origine degli splancnici. Per questo indebolimento del to no vasa le diminuisce la differenza di tensione fra entrambi i sistemi, e deve per necess ilf1 dimin uire colla pressione la velocitit della corrente sa nguigna, fi no ad arres tar si quando il tono arterioso siasi spento del tutto . Cosi nel la presente lesio ne del midollo cervica le io spiego il rallentamento del pol so .
Si no tò dapprima ritenzi one di uri na e perdita di feci, poi in co ntinenza pure dell' urin n. Anche .\lberl ritiene l'in con · tinen za primitiva dell'urina una vera eccezione. Pure una eccezione è stata l'ave re avuto da principio la perdita delle feci, perchè nelle lesioni del midollo ce n icale, per la para· lis i della muscolatura intestinale, e per la IJuasi scomparsa della pressione endo-addomi nale. pr ima si dovrebbe açere ri te nzio ne dell'alvo con meteori smo, poi incontinenza, facendosi molli le feci.
L'alcalinità dell'urina deve considerarsi, io credo, t1on come effetto di decoreposizione in vescica, ma di alte rata sec rezio ne re nate, essendo alte r ata l' io nervazione del rene.
E ciò pel fat to che si co nstatava alcalina appena estraila di vescica, estrazione che, per poter concludere questo, fu prati cata alcune volte a brevrssimo intervallo, e con Je opportune precauzioni onde non portar nulla in vescica che aller·asse la reazione.
L'a umento deiJ'u rea può essere s tato io rapport o con hl. febbre, ma è da ritenersi aocbo in rapporto con la diminnita pressione arteriosa, per la quale decresce la quantità dell'acqua. ma non del pari diminuisce la secrezrone dei principi solidi, specialmente dell'nrea . •
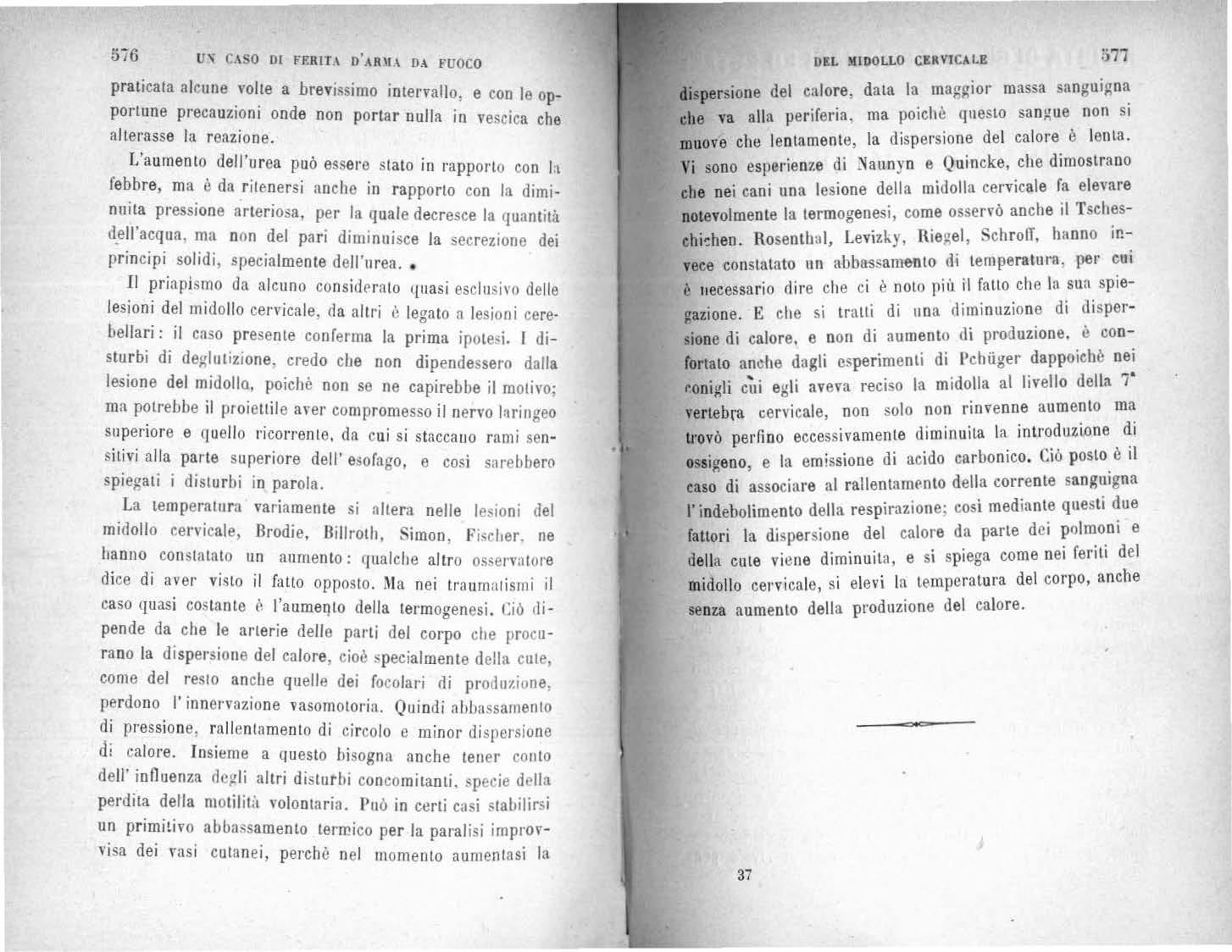
Il priapismo da alcuno consid<'rato t[uasi esclusivo delle lesioni del midollo cervicale, da altri è legato a lesioni cere· bellari: il caso presente conferma la prima ipote::i. r disturbi di deglutizione. cr·edo che non dipendessero dalla lesione del midolla, poichè non se ne capirebbe il motivo; ma potrebbe il proieuile aver compromesso il nervo l:tringeo superiore e quello ri corrente, da cui si staccano rami se nsitivi alla parte superiore dell' eso fa go, e cosi sarebbero spiegati i disturui in parola.
La temperatura variamente si alte ra nelle del midollo cervi cale, Brodie, Billroth, Simon, ne hanno constatato un aumento: qualche altro dice di aver visto il faLto opposto. Ma nei traum ali srni il caso quasi costante è l'aumef]to della termogen esi. Ciò elipende da che le arterie delle parti del corpo che procurano la dispersione del calo re, cioè specialmente della cute, come del resto anche quelle dei focolari di produzione, pe rdono l' inner·vnzione vasomotorin. Quindi ahuassamento pressio ne. r allentamento di circo lo e minor dispersione di calore. a Questo bisogna anche tener conto dell'influenza itc:,:li altri distutbi conco mitanti. specie della perdita della motilitit volontari a. Può in certi casi staùilir5i un primit ivo termico per la paralisi improvvisa dei vasi cutanei, perchè nel momeoto aumentasi la
D!L MIDOLLO CERVICALE dispersione del calore , data la massa che va alla periferia. ma poicltè questo sa ngue non sr muove clte lentamente, la dispersione del calore è len ta. Vi sono esperienze di :'{aunyn e Quincke, che di most rano che nei cani una lesione della midolla cervicale fa elevare notevolmente la termogenesi, come osservò anche il Tschesehi-;hen. Rosenthal, Levizky, R ie:.tel, SchrolJ, hanno invece constatato un abbassamento di temperatura. per· cui è uecessari o dire che ci è noto più ìl fallo che la sua spiegazione. E che si tratti di una diminuzio ne di dispersione di calore, e non di aumento di produzione. è confor talo a nllhe dagli esperimenti di Pchiiger dappoiehè nei ro nigli Clti egli aveva reciso la midolla al livello della 7" vertebra cervicale, non solo non rinvenne aumento ma trov ò perfino eccessivamente diminuita la introduzione di ossicreno e la emissione di acido carbonico . Ciò posto è il n ' • easo di associare al ra llentamE-n to della corrente sangurgna l'indebolimento dell a respirazione : cosi mediante questi due fattot·i la dispersio ne del calore da parte dei polmoni e della cute viene diminuita, e si spiega come nei feriti del midollo cervi cale, si elev i la t('.mperatura del corpo, anche se nza aumento della produzione del calor e.










