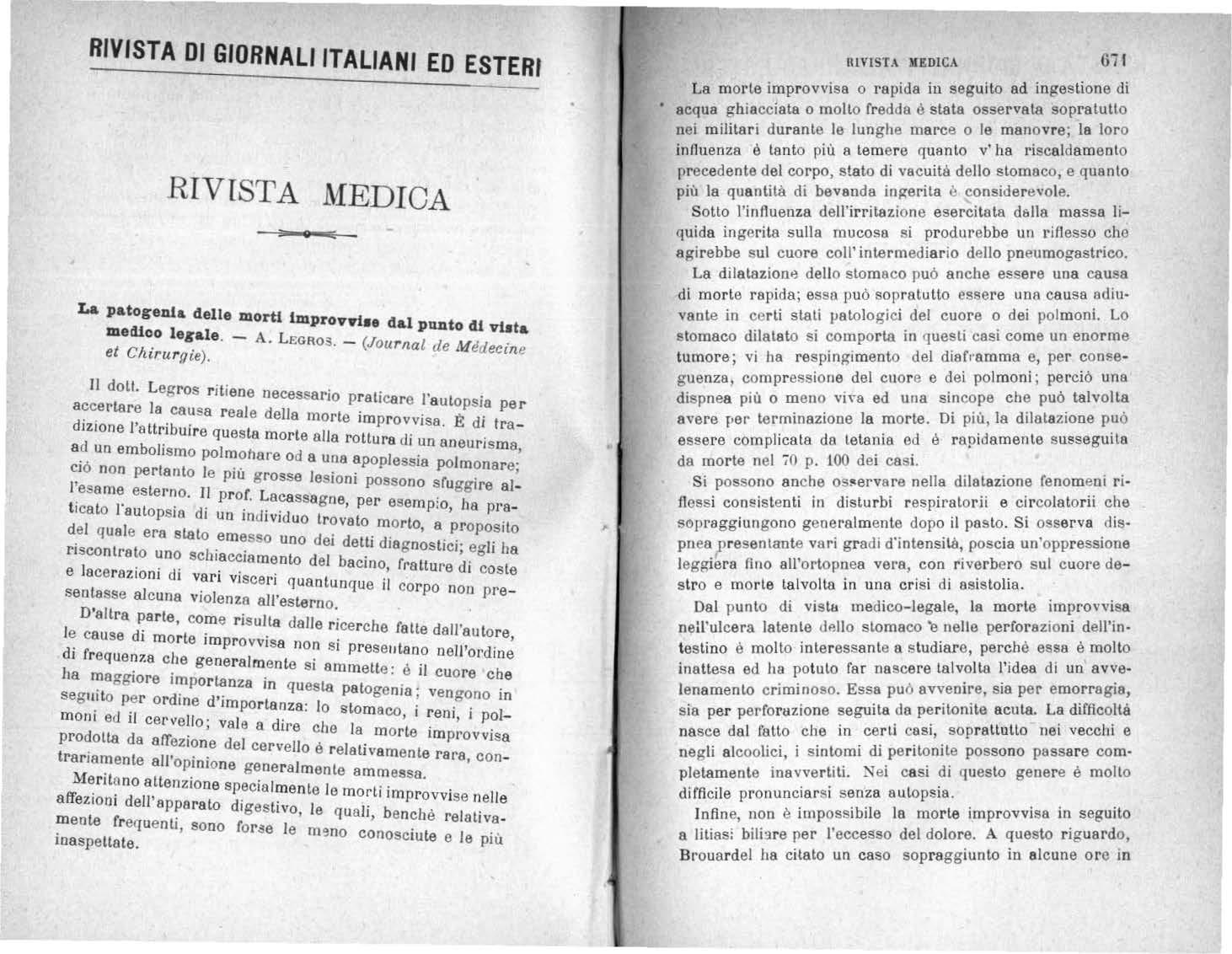
29 minute read
RIVISTA MEDI CA
La patogenla delle morti lmprovrile dal t medloo legale . - A pun o di vilta et eh · . ) · :>. - (Jou rna l cle M édecine trurgte .
Il dott. Legros r it iene necessario p raticare accertare Ja ca " 1 -la per . . u a r ea e delia morte improvvisa di tr ques ta morte alla roHura di un :i6 od a una apoplessia polmonare;' l' pe o le PJU g rosse lesion i possono sfuggire a lesame esterno. 11 p r of. Lacassague . t icato l'autops ia di uo individuo l rer esemp:o, ha pradel qual e era stato emesso uno o. m o rto, a _ riscontrato uno sch'a . e deth d•agoostlcl; egh ha ' cclamento del bacino f tt d' e la cerazioni di · . . • ra ure 1 coste vari VISceri quantunque il c seotasse alc una violenza all'esterno orpo non p reD'allra parte come . Il d ·. ' rJsu a alle r 1cer che fatt d Il' le cause di morte im . . e a autore, di frequen7.a che g prolvvlsa non s t pres eutano nell'ordine · enera m ente si ammetl è .1 ha maggiore importanza . e: . ' cuore che segui to pe r ordine d'impo lln palogenla; ven gono in . r anza. o stomaco i r . . l monl ed il cervello. val e a d' ' enl, l po- ' ll' e che la m o rte · · prodotta da affezione de l cervello é r . Impt'ov v,sa trar iamente all'op' . ela llvam ente rara , con. _mto ne ge neralmente ammessa. Merito no attenzione special men t l . . . affezioni dell ' apparato digest' le e mo:tl Improvvise nelle me nte fr err ue nt' , t vo, e quali, bencb è relativa., '• sono •Or.5e le c . inaspe ttate. o noscw te e le pi ù
Advertisement
La morte improvvisa o rapida iu seguito ad ingestione di acqua ghiacciala o m o llo fredd a é osservata sopra lutlo nei militar i durante le lunghe mar·ce o le man o vre; la loro influenza é tanto più a tem er e quanto v'ha riscaldamento precedente del corpo, stato di vacuità d ello stomaco, e quanto più la qu a ntità di bevanda inf(erila è considere vole.
Sotto l'influenza dell'irrita zione esercitata dslla massa liquida inge rita su ll a mucosa si produrebbe un r iflesso che ag irebbe s ul cuore coll'intermediar io dello pneumogastrico.
La dilatazioM de llo stomaco può anche essere una causa di morte rapida; essa può sop ratulto essere una causa adiuvante in ce rti stati j.latologici del cuore o dei po lmoni. Lo s tomaco dilatato si compor ta in questi casi com e un enorm e tumore; vi ha respingimento del diaframma e, per con!'eg uenza , compressione del c uor e e dei polmoni; perci6 una disp nea più o m eno vt>a ed una sincope che pu6 talvo lta avere pe1' terminazione la m o rte. Di più, la d ilatazione può e ssere complicata da tetania ed é r ap idamente s usseguita da morte nel iO p . 100 de i casi.
Si possono anc he OS!lervare nella dilatazione fenomeni r ifl essi consistenti in distu rbi r espiratorii e circolatorii che sop raggiun go no generalmente dopo il pasto. Si osserva d is · poea p resen tan te vari gradi d'intensità, poscia un'opp r essione leggiera fluo all'ortopoea vera, con ri ve rb e ro s ul c uore destr o e m orte talvolta in una cris i di asistolia.
Dal punto di vist& medico-legale, la morte improvvisa nell'ulcera latente dP-llo stomaco 'e nelle perfor azton i dell'int estino é molto inter essante a s tudiare, perch é essa é mollo inattesa ed ha pot uto far nascere talvolta l'idea di un avvele nam ento criminoso. Essa può avven ire, sia per emorragia, sia per perforttzione seguita da per itonite acuta. La difficoltà nasce dal fatto che in cerLi casi, sop rattutto nei vecchi e negli alcoolici, i sin tomi di per ito nite po ssono passar e compl e tamente inavver titi. Nei ca si di questo genere é mollo difficile p r·onunciarsi s enza autopsia.
Infine, non è impossibile la mo rte imp r ovvisa io seguito a liliasl bil i!.lre per l'eccesso del dolo r e. A ques to ri g uard o, Brouard el ha citalo un caso sop ra ggiunto in alc une ore m una g iovane che morì in seguito a rlolo1•i addominali molto violenti sopraggiun t i dopo l'ingestione di un bicchiere d1 acqua ghiacciata che essa credette avvelenala. All'autopsia si t rovò un calcolo fermaLos• nell'a mpolla di Valer.
La morte impr ovvisa può quindi essere osservata assai soventi in differenti forme delle affezioni del tubo digestivo. Né devesi dimentica r e che essa è a::csai frequente nelle affezioni dei reni in seguito ad uremia e che essa si presenta cosi mollo più che nelln affezioni cerebrali.
Legros ha 1..ure insistito sul punto che un gran numero di congestioni o di apoplessie polmonari mortali sono state prepa r ate da malattie precedenti e sovenli latenti dell'apparato circolator io o cl1e essA sono s otto la dipendenza di due cause mollo speciali; aderenze pleurali e lo stato di ripient-zza del ventricolo.
Le aderenze pleurali sono infatti mollo frequenti negli individui che muoiono subitaneamente; si riscontrano nella proporzione dell'SO p. 100. Gli individui i cui polmoni sono cosi imprigiouati come in un busto sono in imminenza di morte impr ovvisa. Per la molestia che esse apportano alla libera dilatazione della gabbia toracica, queste a derenze favoriscono singolarmen te le sincopi. Lo stesso dicasi del lo stato di ripienezza dello stomaco cbe impedisce la circolaZIOne e può dar luogo a congestioni polmonari o cerebrali.
Del metodo anatomo - ollnioo nella me41otna m entale.Lezione d'apertura della clinica delle malattie mentali: del dott. A. JoFFROY. - Médical, N. 48).
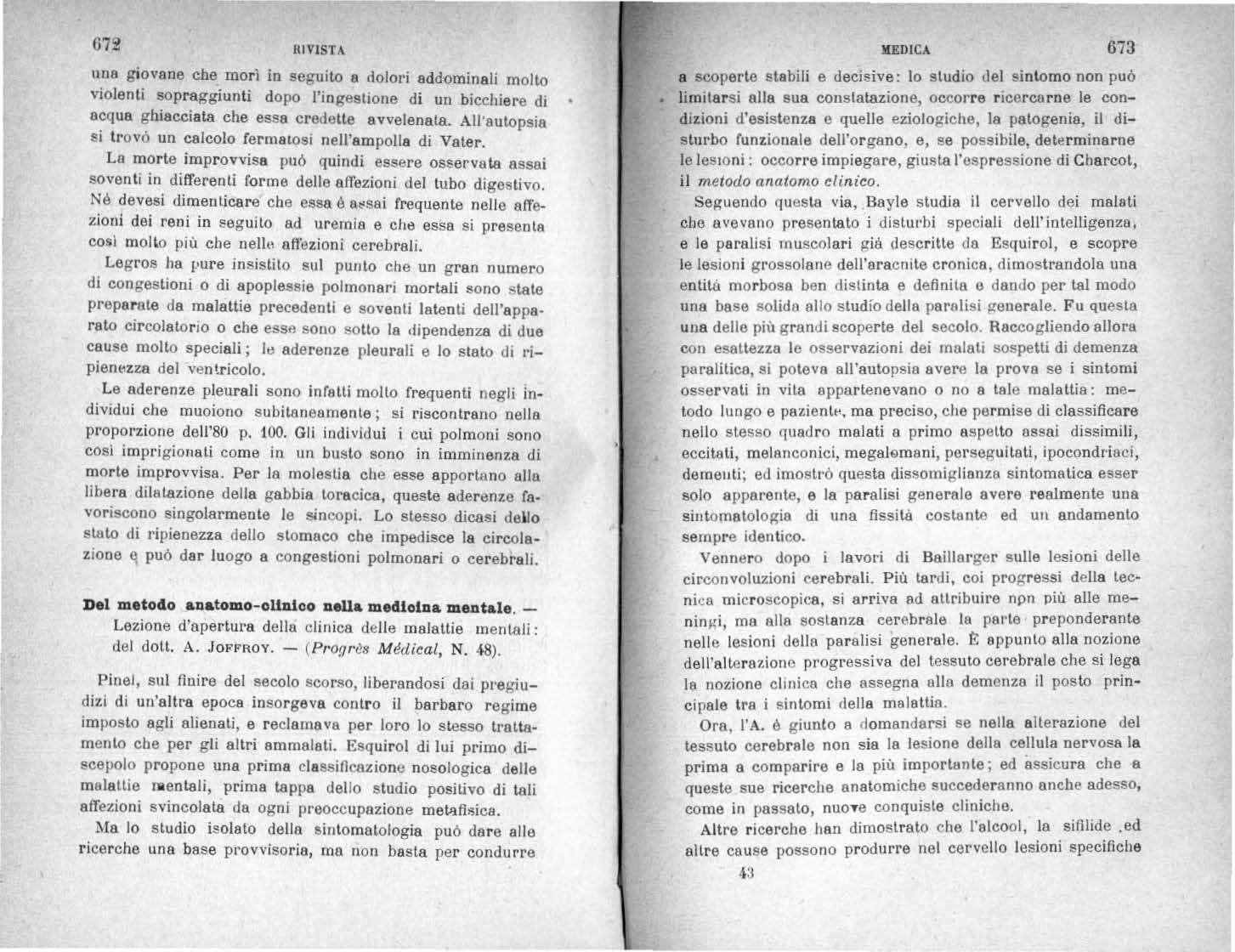
Pine!, sul finire del secolo scorso, liberandosi dai pr•egiudizi di un'altra epoca insorgeva contr o il barbaro regime imposto agli alienati, e reclamava per loro lo stesso trattamento che per gli altri ammalati. Esquirol di lui primo discepolo propone una pr ima classitlcazione nosologica delle malallie lllentali, prima tappa dello studio positivo di tali affezioni svincolata da ogni pr·eoccupazione mewfisica. Ma lo studio isolato della sintomatologia può da r e alle ricerche una base provvisoria, ma non basta per condurre a scoperte stabili e decisive: lo studio del sintomo non può li m itarsi alla sua constatazione, occorre r iccrca r ne le cond izioni d'esistenza e quelle eziologiche, la patogenia, il disturbo funzionale dell'organo, e, se possibile, dete r minarne le lesroni: occorre impiegare, giusta l'espressione di Ch a rcot, il metodo anatomo clinico.
Seguendo qu esta via, Bayle studia il cervello dei malati che avevano presentato i dislur•bi speciali dell'intelligenza, e le paralisi mus colari già descritte da Esquirol, e scopre le lesioni grossolane dell'aracnite cronica , dimostrandola una entità morbosa ben distinta e definila e dando per tal modo una base s olida all o s tudfo della paralis i g enerale. Fu questa una delle più grandi scoperte del sec olo. Racco g liendo allora con esattezza le os servazioni dei malati s ospetti di demenza paralitica, si poteva all'autopsia avere la prova se i sintomi oss ervati in vita appartenevano o no a tale malattia: metodo lungo e paziente, ma preciso, che permise di classificare nello stess o quadro malati a primo aspetto assai dissimili, eccitali, melanconici, megaJgmani, perseguitati, ipocondf'iaci, derneuti; ed imosl1·ò questa dissomiglianza sintomatica esser solo apparente, e la paralisi generale avere realmente una siuto matologia di una fissita costante ed un andamento sempre identico.
Vennero dopo i lavori di Baillarge r sulle le sioni delle circonvoluzioni cerebrali. Più tardi, coi progressi de lla tecnica micros copica, si arriva ad attribuire npn più alle meningi, ma alla sostanza cerebrale la parte prepooderante nelle lesioni della paralisi generale. 11: appunto alla nozione dell'alle r azione progressiva del tessuto cerebrale che si lega la nozione clinica che assegna alla demenza il posto principale tra i s intomi della malattia .
Ora , l'A. é g iunto a domandarsi se nella allerazione del tessuto cerebrale non sia la lesione della cellula nervosa la prima a comparire e la più importante; ed assi cura che a queste sue ricerche anatomiche succederanno anche adesso, come in pass ato, nuo Te co nquiste cliniche.
Alt re r icerche han dimostrato che l'alcool, la sifilide .ed altre cause possono produrre nel cervello lesioni specifiche ddf01·enli e diflèrauziabili 1la della paralisi mentre i sintom1 che presentano I(Ueste malallie si avvitinano tanto a quelli della par·alisi da rendere la dia!!OO!'i dit:. ficile ed incerto, non all'inizio ma in Lullo il decorso dell'atl'ezione.
Allorche nel 1861, nroca !>pinst! piu innanz1 che i la nella localizzazione liwrlarulone esattamente la sede alla ter•za circonvoluzione frontale fece il Jll'imo pusso nella da delle localizzazioni c•er·cbrali, CO!'tt feconda di importanti risultalr.
Allorché IIitzig c Fert'ier dimostrarono più lardi l'eccilabrhtà dello corteccia rar·cbrale ttlla corrente elellr ica, c trovarono una zona la cui eccitazione produceva movrmenli, e questi movimenti erano limilatr a qualche parte delle merniJra o della faccia secondo i punti eccitali, si intr·avide la possibilità, di conosce:-e lt! funzioni special i devolute a ciascun dipar·timento <·t·r obralc.
Fu so lo però passnntlo dal lahoralorio di fisiologia ulla cliuica ed all'unatornia patolog-ica, che la •1uesLrone polé avere una t>Oiuziono pratica, e le bellu ricerche di Charcol e d1 Pil1·es dimostrarono che uell'uomo, come neglr animali, a deter·minali lOI'l'itori clelia co 1·Ler.cia cerebrale erano devolute funzioni motrici, e fii potè, ra' viciuando le storie climclae ed i ri"-ullati necr·o!'copici, dAiimitare questa zona motri <·o, e disLinguere in e!'sa dei centri secondarr ueLLi e precio;;i pr·e«iedono ai movrrncntr delle membra :superior i od 111fenorr, della faccia, della lingua, ecc. Fu pPr fa molilit.a una sco· perla del metodo analorno - clmico, simile a quella di Broca per la funzione del l 'na lesione dellobulo parielale-infcrior e sinistro si trova accompagnala daii'Ìinpossibilité di leggere ma non di seri- vere, e, la. lettera appena tl'acciata, il malato non può più riconoscerla.
Fin 'lUi però non si h·attava che di locali zza7ioni della mot.lila, •! la scoperta di Broca era ancora diECUS!'a poiché sr presentavano o.:;senationì r·igorose in cui e<;istevan o distur·bi afasic1 senza alcuna alterazione della circonvoluzil)ne di Broca, allorché compar·vero i lavori di \\'ernicke e Kussm au l, e più lardi quello meravi glioso di Cltat·cot a farci conoscere le a l'asi e sensoriali.
Con una lesione della prima cit•convoluzione temporale sinisll·a i malati avevano perJulo la facollA di comprendere •1uanto si diceva, ma si pole,·a ancora comunicare con loro mediante la scrittura.
In altri ca!'i in cui Yi era !;lata perdrta della facoltà di 10cr•ivere, continuando a compren.iere la parola pa r lata ed a poter !.'Cri vere si riscontrava la lesione lìmllala alla seconda cirt'onvoluzione frontale sinistra.
Oall'anali<>i di fJUesli drversi disturbi de' la parola, della lettura e della scrittura, Charcot giunse u dimostrare il meccanismo del linguagrrio. ed il concor"o che \'o!'lservazione melodica delle lesioni organiche del cer,ello può recare alla psicologia. Egli ci dice che la parola é un elemento complesso, in cui si nuò riconoscere, negli individui educalr, al· meno quallro elementi fondamentali, e cioé l'immagino comm emo rativa uditiva, l'immagine visuale, e due elementi motori, l'immagino motrice d' articolazione data dalla ripetizion e tlei ID0\'1menli necessari a pronunciare la parola , e l'immagine motrice g rafica data dalla dei movimen ti n ecesstu•i pe1· scrivere.
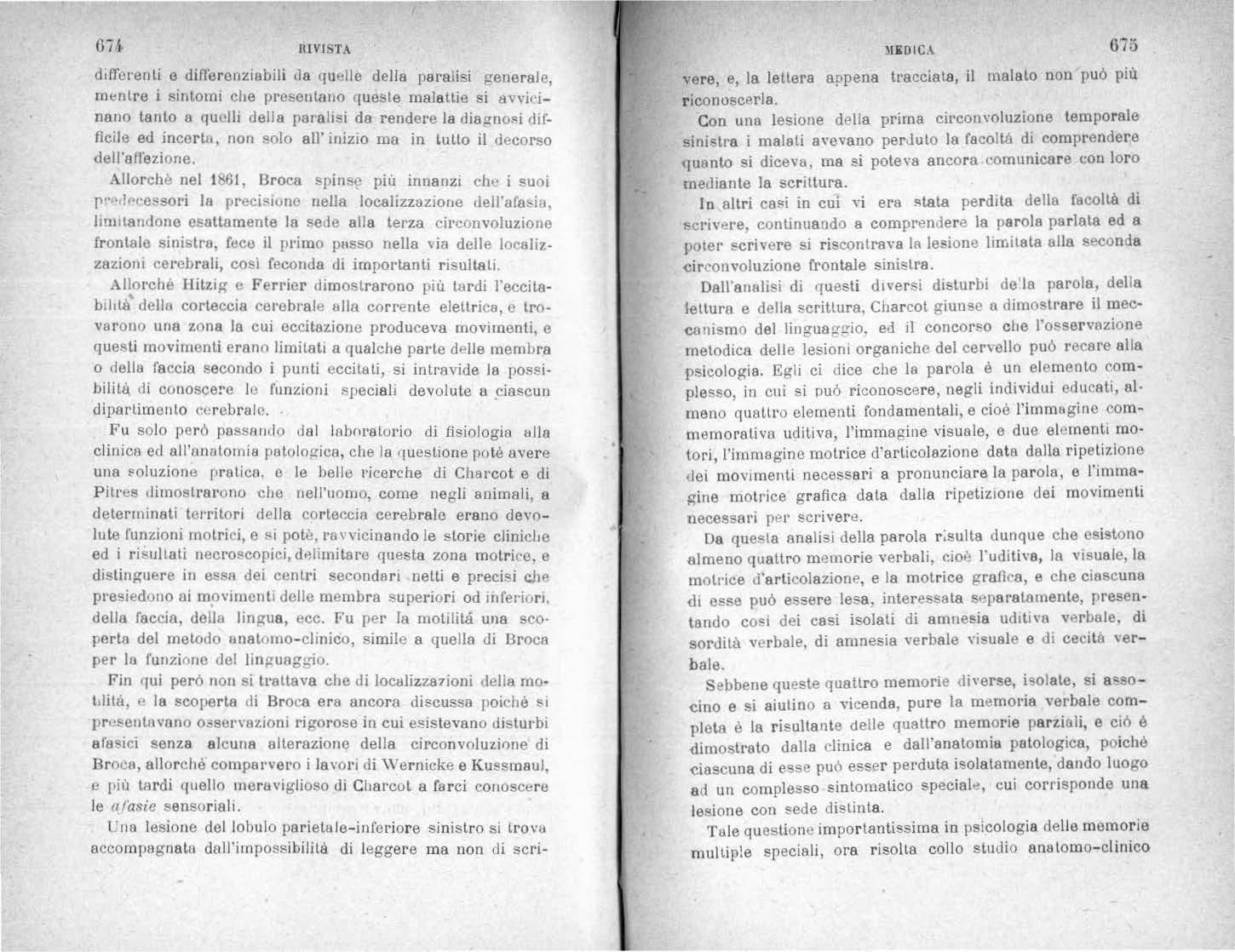
Da questa analisi della parola r ;sulla dunque che esistono almeno quallro memorie verbali, c:roè l'uditiva, la ''rsuale, la motr·ice d' articolazione, e la mot r ice grafica, e che ciascuna d1 esse può essere lesa, interessata separalamente, presentando co"i dei casi isolati di amnesia udrtiva verbale, di sordità verbale, di amnesia verbale visuale e dr cecità verbale.
Sebbene queste fJUatlro memorie di\·erse, si a<>socino e si aiutino a vicenda, pure la memoria verbale completa è la risulla n t e delle quall r o memorie parziali, e crò è dimostralo dalla clinica e dall'anatomiu patologica, poiché ciascuna di e'>se puo esser perduta isolatameule, dando luogo ad un complesso sintomatico cui conisponde una lesione con sede di!.'linta.
Tale queslione impo r tantissima io psicologia delle memorie mu\Liple speciali, ora r isolta collo studio anatomo-clinico delle localizzazioni cerebrali, era stata gia intraveduta da Gratiolet, il quaiP contro l'opinione dei suoi tempi, ammetteva una memoria speciale corrispondente a ciascun senso.
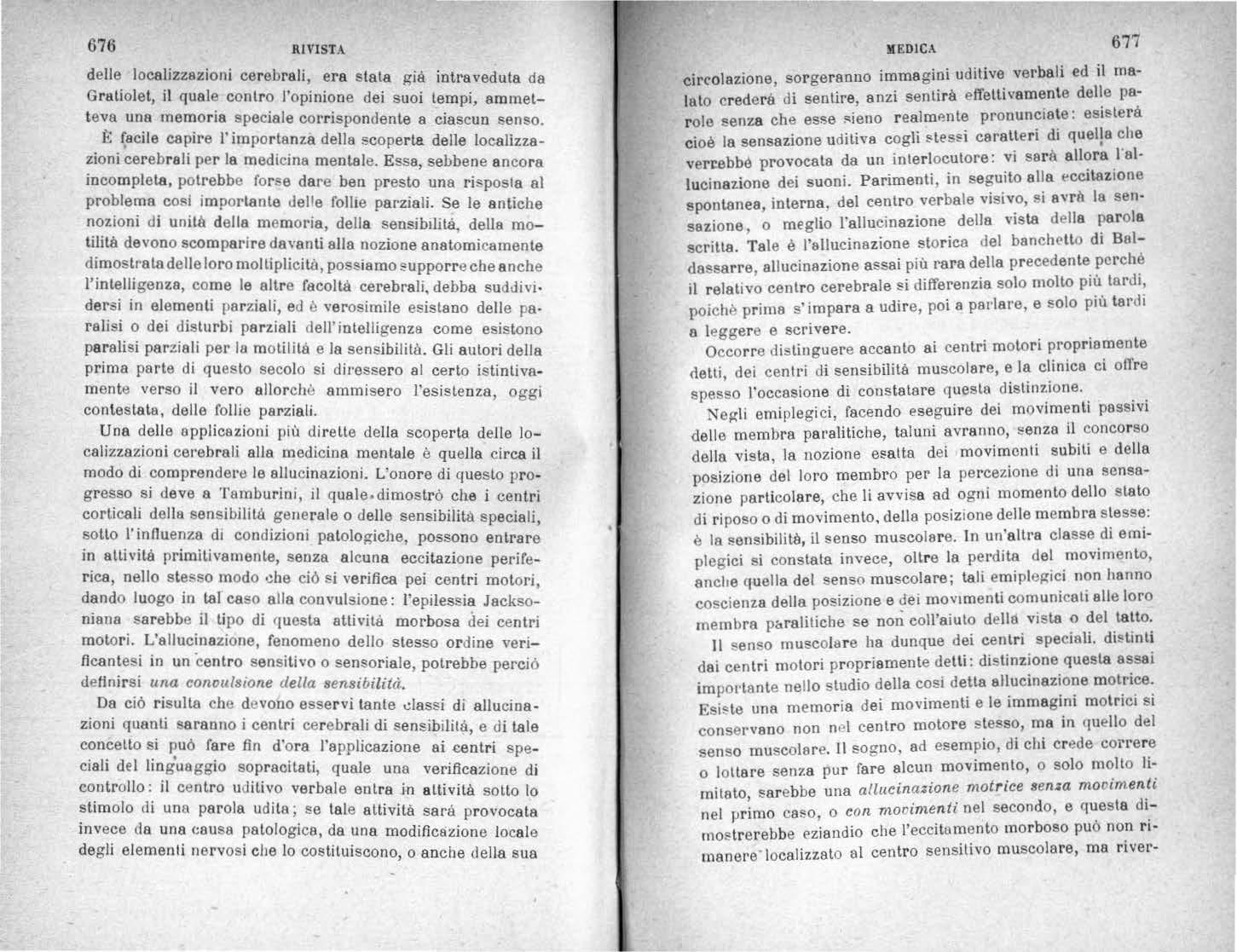
È facile capire l'importanza della scoperte delle localizzazioni cerebrali per la medicina mentale. Essa, sebbene anco ra incompleta, potrebbe forse dare ben presto una risposta al problema cosi importante ùeJie foibe parziali. Se le antiche nozioni d i unitA della memoria, della sensibilità, della motilità devono scomparire davanti alla nozione anatomicamente dimostrata delle loro molliplicità, possiamo supporre che an che l'intelligenza, come le alt r e facoltà cerebrali, debba suddivl · dersi in elementi pa rziali, ed è verosimile esistano delle pa· ralisi o dei disturbi parziali dell'intelligenza come esistono paralisi parziali per la motilità e la sensibilità. Gli autori della prima parte di questo secolo si dil'essero al certo istintivamente verso il ve ro allorché ammisero l'esistenza, oggi contestala, delle follie parziali.
Una delle applicazioni più dirette della scoperta delle localizzazioni cerebrali alla medicina mentale è quella circa il modo di comprendet•e le allucinazioni. L"onore di questo progresso si deve a Tamburin1, il quale.dimostrò che i centri corticall della sensibilila generale o delle sensibilità speciali, sotto l'influenza d1 condizioni patologiche, posMno entrare in allività primiLivamente, senza al cuna eccitazione periferica, nello stesso modo •!he ciò !l'i verifica pei centri motori, dando luogo in tal caso alla convulsione: l'e pilessia Jacksoniana sa rebb e il tipo di IJUCsta attività morbosa dei centri moto ri. L'allucinazione, fenomeno dello stesso ordine verificante si in un cent r o s ensi Livo o sensoriale, potrebbe perciò definirsi una coMuls,one clelia sensibilità.
Da ciò risulta che d e vono esser vi tante dassi di allucinazioni quanti saranno i centri cer eb rali di sensibllita, e di tale concetto si può fare fin d'ora l'applicazione ai eentri speciali del lin guaggio sopracitati, quale una verificazione di controllo: il centro uditivo verbale entra in attività sotto lo stimolo di una parola udita; se tal e attività sarà provocata invece da una causa patologica, da una modificazione local e degli elementi nervosi cl1e lo costituiscono, o anche della sua circolazione, sor geranno imma gini uditive verbali ed il maIalo credera d i sentire, anzi sentirà effetlivamente parole senza che esse !'lieno realmP.nle pronunc1ate: es1slerà cioè la sensazione u ditiva cogli stessi caratteri di quella che provocata da un interlocutor•e: vi sarà !"allucinazione dei suoni. Parimenti , in seguito alla t-ccltaZJOne spontanea, interna, del centro verbale visiv.o, avrà la sen· sazione O meglio l"allucinazione della VISta della parola scritta. è l'allucinazione storica del banche llo di Baldassarre allucinazione assai più rara della precedente perché 11 centro cerebrale si differenzia solo mollo più tar•di, poichè prima s'impa ra a udire, poi a pa1·lare, e solo più tard1 a leggere e scrivere. . .
Occorre distingue r e accanto ai centri motor1 propr1amente detti dei centr·i Ji sensibilita muscolare, e la clinica ci olTr e l'occasione di constatare questa . .
Negli emiplegici, facendo eseguire dei mov1menl1 paSSIVI delle membra par•alitiche, taluni avranno, senza il co ncorso della vista, la nozione esalta d e i movimenti subiti e della posizione del loro membro per la perce;don e di una sensazione particolare, che li avvisa ad ogni momento dello s tato di ripos o o di m ovimento, della posizione delle m e mbra s tesse: è la sensibilità, il senso muscolare. In un'allra classe di emiplegici si constata invece, ollr e la perdita del movimento, anche quella del senso muscolare; tali non hanno coscienza della posizione e dei mov1menti com uni cali alle loro membra paralitiche se non coll'aiuto della vista o del tallo. 11 <:enso muscolsre ha dunque dei centri speciali. distinti dai centri motori p r opriamente detti: distinzione questa assai im por·tante nello studio della cosi de.tla mot:ice: Esi!>le una memoria dei mo"imenlt e le 1mmag1m molr1c1 SI conservano non n o> l centro motore s tesso, ma in quello del senso muscolare. 11 sogno, ad esempio, di chi cri>de 0 lottare senza pur fare alcun movimento, o solo mollo hmitato, sarebbe una allucinazione motrice sen.:a mooimen.ti nel primo caso, o con movimenti nel secondo, e (Juesta dt.rnos trerebbe eziandio che l'ecci tomento morboso può r imanere localizzato al centro sensilivo muscolare, ma rtver- sarsi sulle regi oni adiacenti, eJ inoltre rhe i ùue ceutri > motore e sensitivo muscolare, dt!vono es'>P r e "icini. l fenomeni ùel sogno sono gli Rle"si che si verificano allo stato di veglia nella allucinazione con o senza follia. 11 linguaggio inle1·iore, rl del pensiero é la sensa1ione interna di una parola, di una f1•ase, pronunciata senza averne udito il suono, senza averno fallo i necessari movimenti delle labbra e della lingua: é l'allucilta;ione r:erùale motrice se n.; a mooimento, in cui l'eccitazione dei centri motori corticali della funzione del linguaggio si riversa, iO\·ade i centri deliA !'ens1bilila muscolare Jove sono immagazzinate le immau:ini motrici d'articolazione. Se l'eccitazione sara più forte, il malato ripelE-rA le parole ùel suo linguaf!gio interno, e si aHà la allucina:ione ce r bale motrice con mocrmento. t'o qui il ca"o di riferire tutte l<' s<·operte nella medi cina mentale col soccorso dell'anatomiu solo rautore r 1corJa le ricerche di Parcbappe Rulle dell'idiotismo, i lavori di Marce sulla semle, ere. Nl· l'ossPI'Vozione clinica fu meno atllva eù efficace nel suo concOI'SO: essa si vale di tutte le scienze, mn talvolta le pr:cede, 0 può in !al caso condurre u scoperte. 1-'u così clte il prot'. Laségue, os!':ervatorB _fino e dPJicnlo, in una memoria del delrrw rll percostituendo tra i numerost malolt che delle idee di persrcuzione in un dato momento tlella malattia, come ed e rwll' alcodi-;mo nella parali"i genErale, un gruppo succ , t"t . l nola ben dcOnito, in cui il delirio per'lt>culivo C'n'l l Ulsce. a . riomlnanlP é nellamenle or!:(anizzato in "tslema logiCO, "l fortifica co'l decorso di questa malattia cronica e "lon bastava però a'ler sepat·ato dal del ltpemaniaci di Eslluirol questa categoria ben dtstmta, occorr eva cercare le or·igini e l'andamento di questa nuova bosa P fu presto rilevata la parlicoluritù che nel prun_t delirio insorge assai rapidamente. menlt'P che secondi st a s!li"te ad un vero periodo prodromico dirfìdenza, l'ansietà, e le interprPlazioni lardi nalle allucinazioni: e più Ja tnalaltiO progredisCe, p1U delirio si completa e si fortifica. . h .. la d preCIS8ll- FU questa la scoperta di LasPgue, c e pm r '• . dola, diiTel·enziava il delirio ùi pet'f\Pcuzione,_ d lt ùa ll e idee va"he di persecuztone che SI hanno nel! ole bncuto·"'o più lardi ancora distingueva da questo coo 1smo su • ·t l. er<>e ru o dei veri perseguitati' qu*'lllO do i persegui a l·p . . g l'andamento e la sinlotnatologla sono allatto culOrl, IO CUI l' Il · · del l . . e e·l 111 CUI non si riscontra mai a u cmaztone • 1 IVel" , ' l'ud ilo. d" d. t di · Questa importante scoperta fu il p r elu to l s u . e rtcerche rho si proseguono ancora dopo anm, e tra devonsi segnala r e i la,ort di 1Iagoau, che cui · · eccellenza o dimostrano come questa malatt:a per che non termina che colla vita, finrsce abttualmenle con due nuove fasi: il delirio ambizioso e lu demenza.
L'a llucinazione ve rbale motr1re, come la verbale uù1tha e quella vic;uale, ba per sede un centro !'ensitivo nella sua torrna più semplice, può invadere anche i centri motori r•t'OPI'iam en te delli, ma so lo secondaria1nente e per propagazionl:'.
Questa propagazione della allucinazione può effelluarsi non solo ai centri vicini, OJa anche a ùi"tanza, nei centl'i p1ù () meno lontani; cosi succede che all'allucinazione della vista si unisce quella dell' uùJto, che nel deli r io cronico di persecuzione si constala prima l' alludna.tione ,-erbai e utlith·a, quindi la verbale mol•·ice senza movimento e piu tarJi anche con m ovimento.
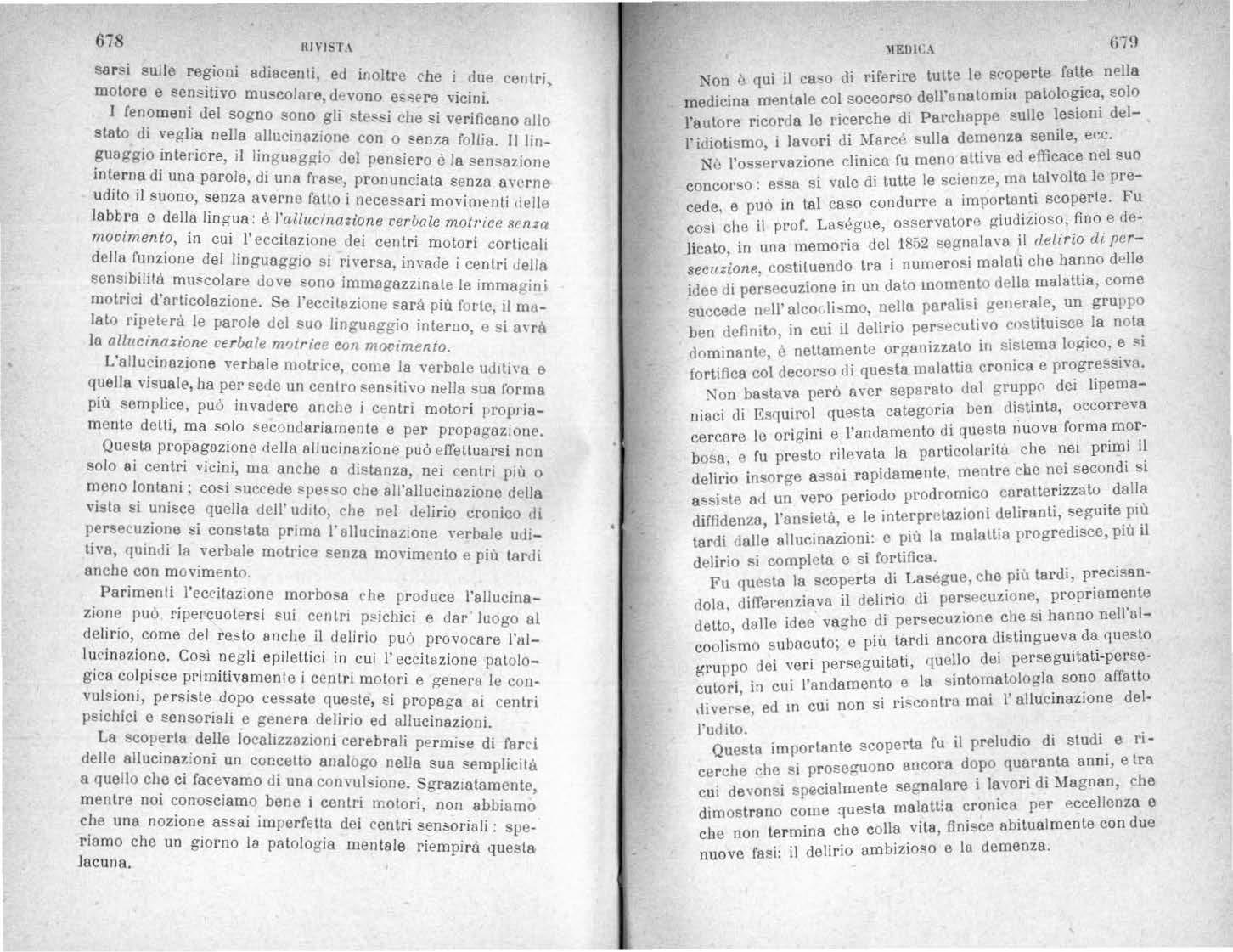
Parimenti l'eccitazione morbosa rhe p r oduce l'allucrnazione può ripe1·cuotersi sui Cl'rrt•·i psichici e dar · luogo al delirio, come del re sto anche il delirio può provoca re ralludnazione. Così negli epilellici in cui l'eccitazione patologica colpisce p1·imitivamenle i centri motori e genera le conpersiste dopo cessato quesle, si propaga ai centri psichici e sensoriali e genera delirio ed allucinazioni .
La scoperta delle locahzzazioni cerebrali perm ise di fare i delle allucinaz:oni un concetto analogo nella sua semplicità a quello che ci face\"amo di una convulsione . Sgraz1atamente, m entre noi conosciamo bene i centri motori, non abbiamo che una nozione assai imperfetta dei centri sensoriali : speriamo che un giorno la patologia mentale riempirà questa Jacuna.
Infine anche nella questione, tanto di attualità. della r·esponsabili lir. negli alienali, il nostro secolo notevoli progressi, per quanto vi si a ancora molto da fare. N on siamo certo più al medio evo, in cui si condannavano gli alienali alla morte, ma anche al presente non dr rado si chiama delitto ciò che è unicamente follia. La questione della legale degli aliensli é esclusivamente medica; é questione di diagnosi, é la differ enziazione clinica del pazzo dal delinquente; pl'oblema spesso difficil issimo, talora impossibile a risolvere.
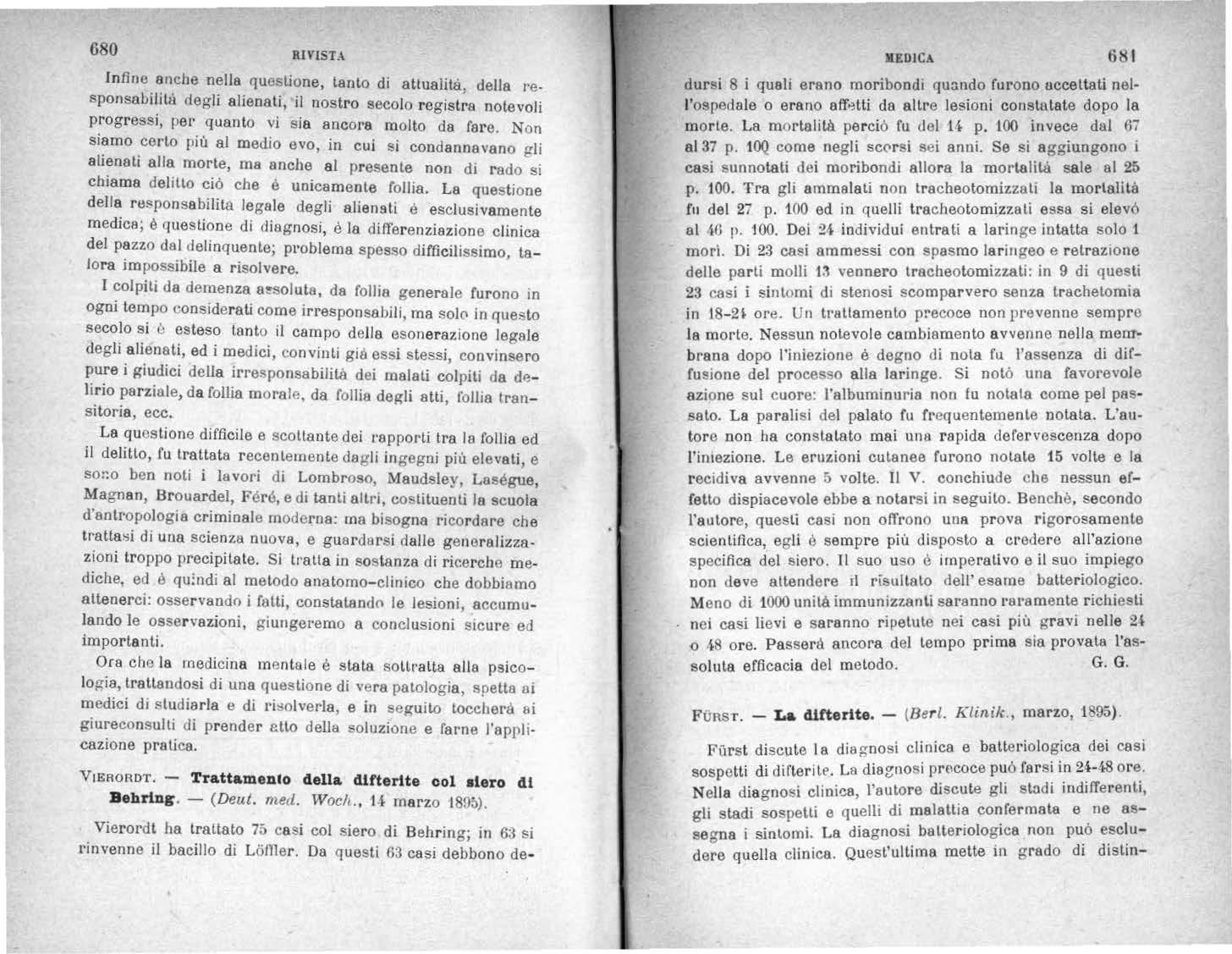
I da demenza al!solula, da follia generale furono in ogm tempo considerati come irresponsabili , ma sol0 in questo secolo s i è esteso tanto il campo della eson er azione legale degli alienati, ed i medici, convinti già essi stessi, convinsero pure i giudici della irresponsabilità dei maiali colpili da delirio parziale, da follia mo rale, da follia degli atti, follra transitori a , ecc.
La ques tione difficile e scollante dei r·appOl'li lra la follia ed il delitto, fu trattata recentemente dagli ingegni più elevati, e so::o ben noti i lavori di Lombroso, Maudsley, Laségue, Magna n, Brouardel, F é ré, e di tanti altri, costituenti la scuola d'anlropologra criminale rnorlerna: ma bisogna ricordare che tr·attasi di una scienza nuova, e dalle generalizzazioni troppo precipitate. Si tr·alla in sostanza di ricerche mediche, ed é qu:ndi al metodo anatomo-clinico che dobbiamo attenerci: osservando i falli, constatand(l le lesioni, accumula ndo le osser vazioni, giunger·emo a conclusioni Sicure ed importanti.
Ora che la medicina me ntale é stata !SOLLratta alla psicologia, trattandosi di una questione di ve ra patologia, spella ui medici d1 f:tudiarla e di l'i8olverla, e in seguit.o toccherà ai giureconsulti di pre nde r e.tto della soluzione e farne l'applicazione pratica.
VrERORDT. - Trattamento della difterite col alero d i Behring. - (Deut. med. Wocl!., 14 ma rzo 18%).
Vierordl ha trattato 75 casi col sier o di Beh r ing; in 6:l si rinvenne il bacillo di Lolner. Da questi 63 casi debbono de - dur8i 8 i quali erano moribondi furono accettati nell'ospeda le o erano da a!Lre lesioni const.ulate dopo la morte. La mo1•talità per ciò fu del H p. 100 invece dal 67 al37 p. 10Q come negli sc<>r s i sei anni. Se si aggiungono i casi sunnotali dei moribondi allora la mortalit.à sale al 25 p. 100. Tra gli ammalati non lracheotomhzali la morlalilà fu del 27 p. 1 00 ed in quelli tracheotomizzati essa si elevò al 1ll p. 100 Dei 2-i individui entrati a laringe intatta solo 1 mori. Di 23 casi ammessi con spasmo laringeo e re Lraz10ne delle par ti m olli venner o tracheolomizzati: in 9 di questi 23 easi i sintomi di stenosi scomparvero senza trachetomia in ore. Un traHamenlo p:-ecoce non pr·evenne sempre la morte. Nessun notevole cambiamento av venne nella membrana dopo l'iniezione é degno òi nola fu l'assenza di diffusione del processo alla laringe. Si notò una favo1'evo le az ione sul cuore: l'albuminuria non lu notata come pel passato. La pa ral isi de l palato fu freq uentemente nolata. L'autore non ba constatato mai una ra pida defervescenza dopo l'iniezione. L e eruzioni cutanee furono notate 15 volte e la r ecidiva avvenne 5 volte. Il V. conchiude che nessun effett.o dispiacevole ebbe a notarsi in seguito. Benc hé, s e condo l'autore, questi casi non offrono una prova rigorosamente scientifica, egli é s empre più disposto a c1•edero all'azione specifica del siero. Il suo uso è imperativo e il suo impiego non d e ve attendere Il risultato dell'esame batteri ologico. M eno di 1000 unità immunizzan ti saranno t•at·amente richiesti nei casi lievi e saranno ripetute nei casi più g r avi nelle 2i o 48 ore. Passerà ancora del tempo prima sia provata l'assoluta efficacia del metodo.
G. G.
FùRST. - La difterite. - (Be r l. Klinik, marzo, 1 95)
Fiir s t discute la diagnosi clinica e batte r·io logìca dei casi sospetti di dii'Lerìtt>. La diaznosi prE1coce può farsi in 24- 48 o r e. N ella dia gnosi c linica, l'autore discute gli stadi indifferenti, gli stadi sospelti e quelli di malattia confermala e ne assesma i sintomi. La diagnosi batteriologica non può esclude;e quella clinica. Quest'ultima mette in grado di disLin- li guere con una certa approssimazione le forme semplici dalle altre. L'esame batteri.ologico può farsi in 12-24 ore e la presenza del bacnio non è prova assoluta di difterite come anche la sua asse11za non la esclude. L'aulOl'O conchiu,Je che un soddisfacente esame batteriologico é quasi impossibile ne lla pratica pdvata. Si dovrebbe ro istituire dei gabinetti s peciali per eseg uire simil i ricerche. QuesL' esame batteriologico ò dal punto di vista scientifico, pratico e statistico di capitale importanza. Il risultato di esso non deve attendersi pP-r poter adoltare il trattamento e le misure proDlatliche.
Il lratLamento !ocale ùe lla difterite colla miscela di ferro e toluolo di Lortler dev'essere adottaLo; avendo cura di pr elevare una pseudo membrana per l'esame batteriologico. Disgraziatam ente questo me todo non può usarsi da tutti nei casi di difterite naso-faringea e faringea. Ogni peonellazione della miscela sarà seguita da gargarismi per prevenire il bruciore. L'antitossina specifica è da usarsi rruando il processo non tÌ Limitato al sito d'invasione e quando il trattamento locale è impossib1le. La sua inutililà si manifesta ne lle infezioni settiche seconda ri e, nelle difterite dei bronchi; essa poi non va esente da pericoli.
G. G.
P . BLAIKIE SMJTII. - Trattamento dellapolmonite acuta mediante gll archetti a ghiaccio . - (Brit. Med. Journ., 11 maggio 1895).

L·autore fu indo tto a trattare la pol monite acuta in questo modo dall'tmporlante statistica d el dott. vV. Soltan Fenwick il quale fac endo uso delle spugnature fredde ebbe una mortali la del 10 p. 100 menti'e trattando la polmonite nei modi conosciuti la morlalilà ra ggiunse il 23 p. 100.
Lo Smith ha usato il suo processo in cinque casi di polmonit e acuta e non ebbe a deplorare nessun morto. Esso si esegue nel seguente modo. Il paziente, con in dosso una camicia da notte di cotone, è posto a letto con un lenzuolo che ri copre il materasso. Sul tronco e sulle gambe son situati due larghi a rchetti estendentisi dalle spalle ai piedi. A
I{Uesti archetti sono ap pes i da sei ad otto secchietli ripieni Ji ghiaccio; un termometro é altaccato all'archello superiore e entrambi i trabi cco li sono protetti prima da una coperta, poi da tela impermeabile ed infine dall'ordinaria coltre. I seccllielli sono rifo rniti di ghiacc io non appena questo comincia a liquefal'si (circa ogni 2 e 3 ore). La temperatura dell'aria solto i lrabiccoli e quella de l paziente ò presa ad intervalli regolari: il trattamento si continua finché la temperatura del corpo non è divenuta normale. Tutti i casi trattati a questo modo erano di polmonite stenica acuta comp licati a pleUT'ile in individui dell'eta dai 30 ai 40 anni. L'autore cura di notare la temperatura della sala, quel la dell'aria sotto i trabiccoli e quella del paziente ogni 4 o r e. Notò anche la temperatura delle coperte prima si gli archetti o dopo esse r ne stati rimossi a cuta ullimata, cioè la temperatura del letto preparato sul modo ordinario. Ril evò infin e la temperatu ra sotto i trabiccoli prima che vi s i sospenòessero i secchielli di ghiaccio e gli effetti prodolli su questa tempetatura dell'uso del ghiaccio.
Il 1" ca::>o si r1ferisce ad un uom o di 30 anni che fu ri coverato all'ospedale uel 1' gio rno di malattia. Aveva polmonite che aveva impegnato tutto il polmone sinistro complicala a pleurite. Il polso e1·a a lOG,.le r espi ra zion i 41, e la temperatura 39",5 C. (l03• F. ; In questo caso, prima che si istituisse il trattamento antipiretico la lempet·atura dell'aria solto le coperte e ra di 3L",ll (8&° F): dopo 4 ore essa si ab· a (72' l') e dopo altt·e quattro ore d'uso del gbjaccio discese a 16°,67 (G Z° F.): durante Lutlo il lraLtamentv (8 giorni) essa oscillò tra 15o,5 e 210,11 (60° e 70° F.) Appena rimo ssi i secch ielli di ghiaccio la tempe1·attJra del !ello sali a 27•,2 (81' F.). La tempe ratura de l corpo no n subj a lcun marcato abbassamento essa graòa lamenle ed alcune volle a sbalzi diminuì. li po lst>, le respirazioni non sembrarono di essere praticamente influenzale dal trattamento.
Il 2o caso è quello d'un uomo che e ntrò nell'ospedal-e a l 4o giorno d·una polmonite del lobo s up eriore destro anche complicata a pleurite. La temperatura ùel !ello era di 2G•,7 (80' F.) e quella del paziente di circa "u• (105°,4 F.). Riem-
" piti i secchielli di ghia ccio, dopo due oro la temperatura del !eLlo discese a 22•,8 (73• F.) ma la temperatura de l corpo non subì alcun mutamento. Fin o all'So giorno, in cui avvenne la crisi, coll'uso con tinuo del ghiacc io la temperatura del letto oscillò tra 18•,3 e 23",:{ (65• e 74• F .) rimosso questo la temp e ratura s a ll a 31•,5 t87• F .). I n q ues to caso gli effetti del traLlam ento sulla tempe r atura del corpo non furono mollo m anifes ti. Nel pomeriggio di tre giorni consecutivi il termo· metro sor pa ssò i '10°,5: ma all'8• giorno esso discese bt'uscamen te alla cifra normale. L'i nfluenza de l ghia ccio sembrò p i ù evidente sulla respirazione e sul polso, poiché con una temperatu ra di 40•,5 quella cr esce 30-35 al minuto, questo sì mantenne a 100 batti ti . per l'es iguo numero di casi osser vati, lo Smilh non possa ascrive re a questo trattamento, rigorosamente, e seguilo, alcun deciso m iglioramen to pure egli è d'opinione che esso ha esercitato una no tevole az ione sulla temperatura de l cor po impedendone l'aumento. Anch e il polso e la respi1·azione furono benefica me nte influenzale poiché i m o li del cuore non furono mai nè frequ e nti né deboli e la respi raz ione n on fu mai caul'a di preoccu pazione.
Di norma, g li ammala t i s i se ntivano b ene solto questo ll'altamento. Uno o due di essi si lamentar o no d i freddo ai pied•: ma l'uso di certe calze fece cessa r e ogni molestia. In un paziente si ebbe un p rofuso sudore che molLo lo tormentò l' u s o continuo de l ghiaccio fece cessa1·e questo dis l 11r bo. N ei primi ca s i si n otò qualche inconveniente dov uto all' a ccumulo d i vapore acquoso s u lla super ficie dei s ecchielli che a goccia cade va corpo degli ammalati: ad esso r ipa rossi coprendo i secch ielli con pezze di lana. Quale é il m eccanismo d'azio ne di questo Lraltamenlo? Lo Smilh lo fa dipendere e d ell'a ria confinata solto gli archelli e dai seccbiell i d i ghiaccio. La tempe r at ura al di solto dei tra biccoli fu abbassata di molto col sempli c e loro uso e l'abbassamento d ivenne m o lto maggiore co ll'introduz ione dei seccnielli di ghiaccio. È dubbio quale di questi due fattori abbia esercitato maggior influenza. Lo Smilh incl ina a ere· de r e che l'uso d ci trabiccoli ruramente e semplice m ente sia stata piti efficace dell a liquefa zione del gh iaccio .
L 'autore conclude, pu r convenendo che !l numero dei suoi casi è troppo e siguo per dare alle r mazioni re c ise, raccomanda ndo l'uso deg li a r chetti a ghiaccio come una forma mite di trattamento antipiretico, conveniente a casi di poim onile s tenica acute, di facile applicazione, non vio lento nei suoi eflelli e n o n spossanle per gli ammalali.
G. G.
JUoerohe statlltlohe sull'ezlologla delle tabl . - BeReNr. (Journal de M éd eeine el de Cltirur{lie, febbrai o 1895).
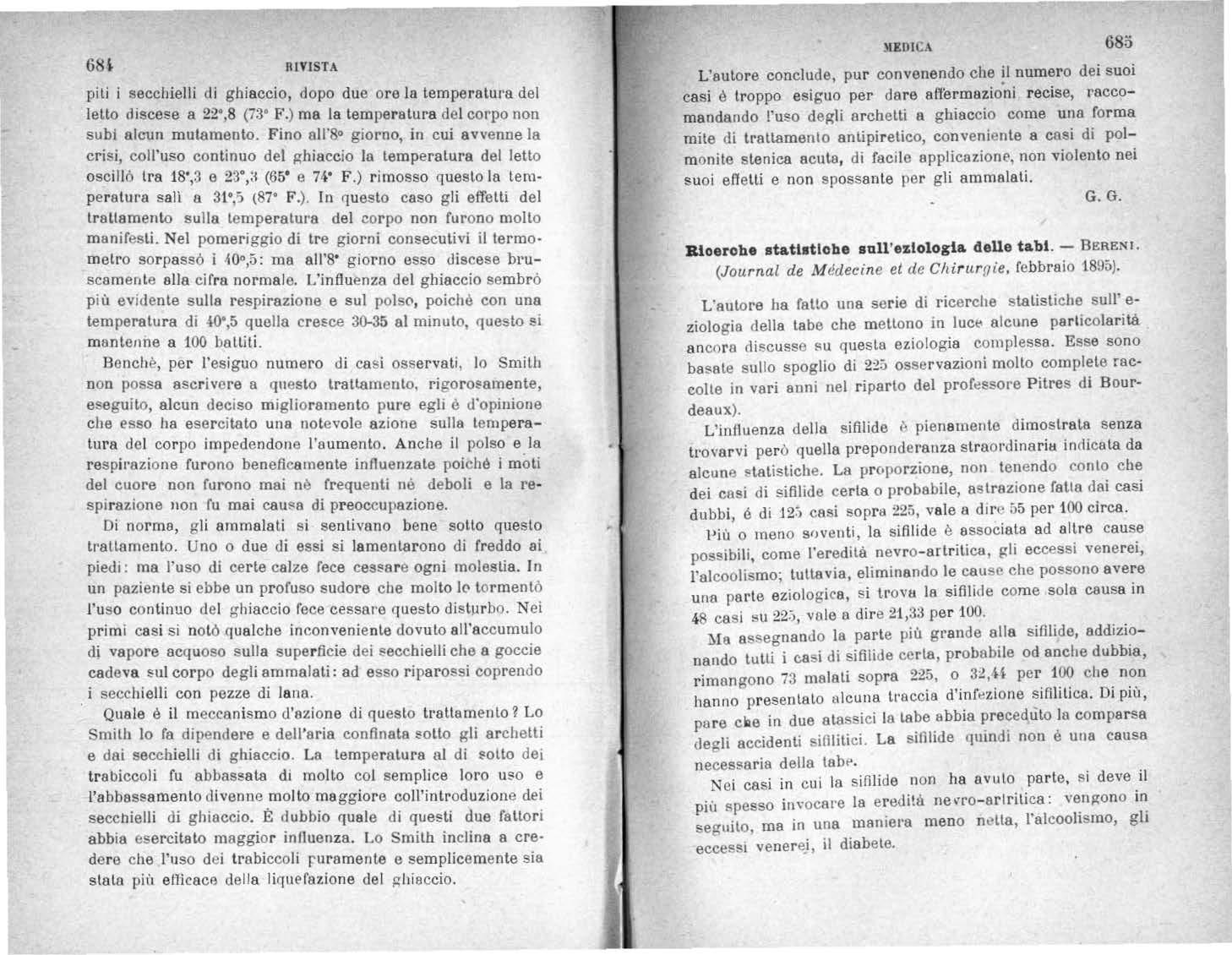
L'autore ha fatlo una seri e di rice rche statistiche sull'ez iologia della labe che me ttono in luct- alcune part icolarità ancor a discusse !IU questa eziologia complessa. E sse sono basale sullo spoglio di 225 osse rvazioni molto complete raccolte in vari anni nel r iparto del P itres d i B ourdeaux).
L'inlluenza de lla sifilide 1\ piena mente d imostrata senza tt·ovar vi per ò quella prepond eranza slr aord ina ril:l inclica la da a lcu ne !'tatistiche. La p r oporzione, non len en do conto c he d ei casi di sifilide certa o probabile, astrazione fatta dai casi du bbi, é di J2:) casi sopr a 225, v al e a di r <' 55 per 100 circa.
Piu o meno S'>venti, la sifilide è associale a d altre possibili, come l'eredità nevro -arlritica, gli eccessi ve n e re1, l'al coolismo; tuttavia, elimin a ndo le cause che possono una pe rl e eziologica, si trova la sifilide come sola causa 111 48 casi su 22:>, vale a dir e 21,33 pe r 100. . . . .
a ssegnand o la p arte più grande a.lla sifilide, nando lutti i casi di sifilide ce rta , p r obab1le od anche dubb1a, rimanaono 73 malati sopra 225, o por 1 00 ch e. hanno.,presentato alcu na t1·eccie d'infnione s ifìlili ca . D1 p1ò, pa r e c lil e in due atassici la .a bbia la comparsa òegli accidenti silìlilici. La s1fìhde qmnd1 non è una ca usa necessa ri a della tabf'. . .
Nei casi in cui la si fìlide non ha avuto parte, l'li deve .'1 più spesso inYOCAt'e la ne"ro - arlrilica: seguito, ma in una manie1·a meno l'alcoohsmo, gh eccess1 il diabete.
Rl\'JSTA
Ue r.:mi r ich iama anche l'attenzione sopra una causa secon· dAria che pare abbia ogit.o m m odo m ol to chiaro su alcuni malati, predisposti per la maggtor parto sia dalla sifilide, sia dalla loro eredita, vale a dire il fredd o inten so e prolungato. Questo fa llo è sta to osserva to in pa r ticolare in vecchi militari i quali hanno i primi feno meni tabelici dopo un freddo prolungato.
Infine B e renì ha fatto una r·icerca, (]no ad ora nou stata falla, quella cioè relativa alla dt<>cendenza dei labetici. Pare che la tabe non eserciti alcuna tnfiueoza dannosa immediata sulla discendenza tabelica. l malati, la cui funzione gene ri ca è s tata ri ;;:potta ta, producono in generale bambini sani, in buona salute.
chi garantisce che più lardi, questi bambini non sara nno colli da una nevropatia qualsiasi?
LA \!ARQUE. - Compltoazlonl gentto -urlnarle dell' Influenza . - (Jou r nal de métlecine et de clti r •tr[Jie, febbraio 1805).
Si nota sovente nell' mlluenza una infiammazione passef<g ie t·a dei reni, una glomerulite le{lgierrz con albuminuria transito r ia. È l'azione più attenuata del w leno rlell' influenza sui reni: le orine contengono tracce d'albumina per qualche giol'no senza che però l'andamento della tnalaiLta subist:a la minima modifìcaz·one. M a ollre a ques1a lieve albuminuria cbe dipende, secondo lulte le appar·enze, rlallintensita della febbre di inizio e dell'infezione, possono os!';ervaro ve r e nejriti , ne.friti gr avi, ch e possono fin dal primo momento es po rre il malato ai pericoli dell'insufficienza orinaria.
Vi so no casi in cui il malato soccombe r apidissimamente all'uremia. Ma questo esito fatale è fortunatamente l'eccezione; la prognosi delle nefriti da inilueoza é orJmariamente più benigna, la maggior parte di esse g uariscono, ed alcune passano allo s tato subacuto od allo stato cronico. Esse possono comparire fin dall'inizio dell'influenza, ma la maggior parte nel suo declinare o durdnte la convalescenza.
\IKDICA G87
Esse or,linar iamente due fo r mo: la (orma emor·ra(Jica o la forma albuminos a. :-.rei primo l'ematuria s i presenta come ti primo fenomeno della neft•ite. Ma ptù comunemen te le nefrili dA influenza assumono il ti po de l male di Brighi, vAle a dit·e della n.e.frite albuminosa con. edema piu o meno n sJ.ugblOZZO Dell& febbre tlfolde& . - 0AUREILL .\N(Journal de médecine et de chirurgie, marzo 18!l5).
Questi casi sono ordinariamente benigni per l e conKeguenze; ma può acca ere elle la nefrile diventi s ubacuta od anche cr·onica e che la si svolga allora come il male di Bright ordinario.
La le<>ione rena le dell'illllnenza non ,., sempre localizzata ai tubi urmiferi che formano la sostanza del rene; può e<> tender s i alle parli vicine e determinare inOammazioni dei calict e dei bacineltt od an che del tessuto cellulare che avvolge il rene.
Le complicazioni possono pure interessare la vescica; sono stati citati vat•i cast ùì tnfettiva con emalut•ia. Fu puro noLato che cistiti pr·eesislenli sono s tate aggravate dall'influenza.
L'influenza può an chb, in cer·ti cast, determinare infiammazioni dell'uretra simulanti l'urelrile blenormgiCf\ e si vede allora che lo scolo scom pa t·e contemporaneamente alla malattia primitiva.
Anche nella donna possono ris conlrar si lesioni del canale dell'uretra.
Si possono pure osservat·o sia contompot'aneamenle a ll'ut'elrito, sia isolatamente, lesioni del testicolo e nei suoi annes,i. Nè può d'altronde r ecar meraviglia 11 fatto di r iscontrar e l'orchite nel cot·so dell'influenza, malattia infettiva, se f-Ii pensa alle orchìti degli orecchioni, tlelle ton<::illiti del vaiuolo, della scarlattina e della febbre tifoidea.
Questa complicazione è stata rariss imamente osservata e fino ad ora non descritta P studiata pa rticolareggiala mente. L 'aulot·e ha r iunito alcuni casi molto interessanti in una sua tesi, e tra gli altri l'osservazione di un pr ofessore della facoilà di Bordeaux in cu i il sin ghiozzo ha presentato un 'intensità del tutto straordinaria. Analizzando e confrontando questi diffe r enti fatti, Daureillan ha potuto dare una descriz ione di questo sintomo poco conosciuto.
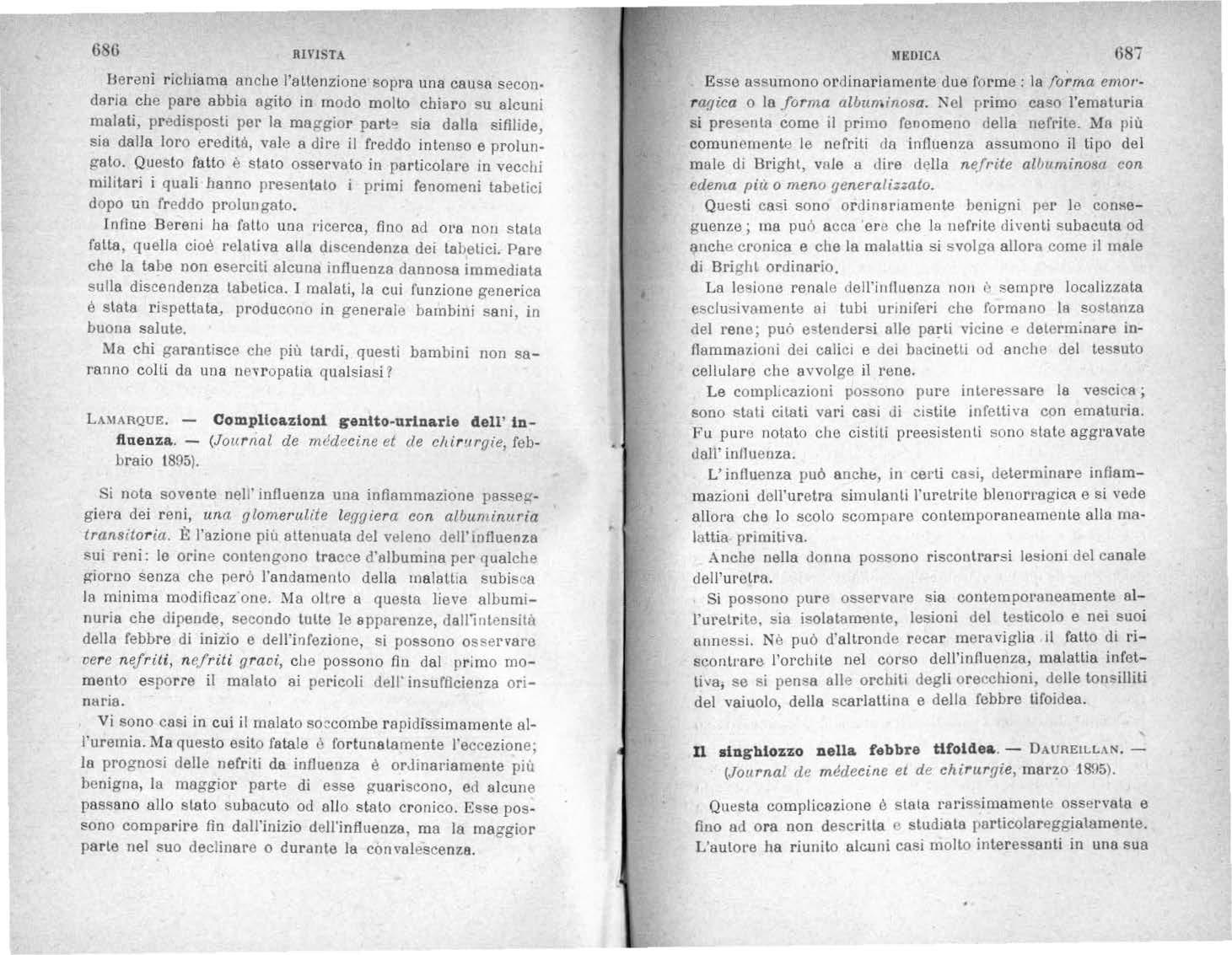
È da notare anzi tutto che il singhiozzo nou fu m ai osser· vato nell'ini zio della febbre . ma io un pe ri odo avanzato della m ala ttia, in generale da l t5• al 200 giorno.
Pare che ques to singhiozzo si pr esenti solto due fo rme, nte rmittente e continua, sia di giorno, sia di notte, allo stato d i veglia o cessando durante il sonno.
JJ singhiozzo s i presenta dappr·ima sotto for·ma di piccoli accessi isolati, separati da lunghi intervalli di remissione, e così ra ri che essi passano r[uasi inavvertiti non solo al me-dico, ma anche a quelli che assistono iJ malato. Io questo m omento, il malato si alimenta ancora come ordinariamente, il singhiozzo non disturba che debolmente le sue funzioni e permette il sonno.
Ma ben tos to, gli accessi si fanno più frequenti e avvicinandosi sempr e più cominciano a diventare subentranti, impedendo al malato di godere un sonno ripa•·atore. Compaiono i vomiti biliosi , dovuti al singhiozz o; il morale del malato è coJpito; il sistema neevoso tutto intiero ne risen te il c.ontraccolpo. 11 soggetto é abbattuto tan to dal punto di vista fi sico che da quello morale : l'intensità del singhiozzo ra ggiunge il suo apogeo. Esso per de la s ua forma intermittente per assumere il tipo continuo, non lasciando al malato che alcuni istanti di dilazione. E:;so assume sovenli anche la l'orma di c r isi che finiscono con un accesso di vomiti. È talvolta così intenso da manifestarsi an clte durante il sonno.
Dopo aver rag-giunto il suo apogeo co me intensita, questo fenomeno diminuisce in seguito gradatamente. E sso però può prolungarsi molto tempo, perché in un caso ha durato due mesi ci r ca. La sua prognosi deve essere molto riservata. I n una maniera generale: il singhiozzo cb o sì presenta nel corso della febbre tifoidea è certamente grave e deve pr·eoccupars al più allo g rado il clinico . Talvolta quasi insignificante esso cede facilmente ad un tr attamento ben di- r etto; tal volta al contrario, la sua intensità é tale che a gg r·ava singolarmente l'affezione al punto di m ettere io pericolo la vita del malato. è possibil e a priori affermare a l')ual g rado esso si ar1•este rà; s i ùovrà semp1·e tener conto dello stato gene raJ e del soggetto, della gravezza degli altri sintomi della malattia. I compensi tel'apeutici da usare sono sovratuLto l'elettrizzazione d.,ei nervi fr e nici, la r efrige razione e principalmente Jlavviluppamento ùel tronco con una flanella inumidita e l'applicazione sul la r egione del collo di compresse imbibite di un liq uido composto di 1- parLi di mento lo e ùi 30 parli di etere e d i clo roformio .











