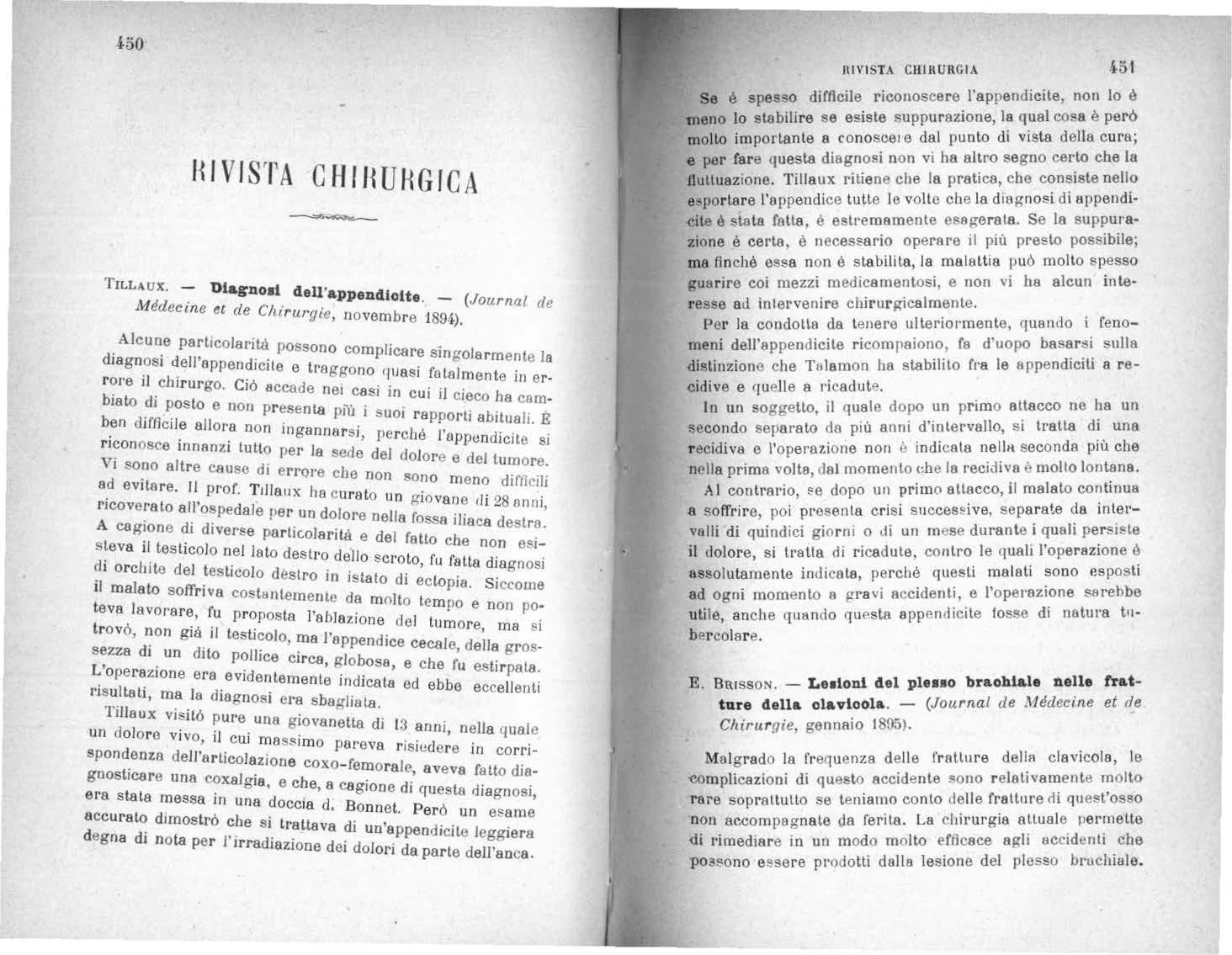
70 minute read
BIVISTA CHfBUHGIC A
TILLAUX. - 'Dlagnoat dell'appendtotte . - (Journal de M édeeine et de Chirurgie, novembre 1894).
Alcune parlicolarita possono complicare singola rm ente la diagn osi dell'appendi cit e e tra ggo no quasi fatalmente in err ore il chirurgo. Ciò accade nei casi in cui il cieco ha cambiato di pos to e non pr esenta piU i suoi ra ppo rti abituali. E ben difficile allor·a non ingannarsi, perchè l'appendicite si ricon osce innanzi lutto per la sede del do lo r e e del t umore. Vi sono altre cause di e rr ore che non son o meno dirtìcili ad evita re. Il prof. T J!Iaux ha c urato un g io van e di 28 anni, ricov e rato all'ospedale pe r un d olo r e nella fossa iliaca destra. A cagione di diverse partic.olarita e del fallo che non esisteva il te s ticol o nel lato destro dello scroto, fu fatta dia gnosi d i orchite del tes ti colo destro in istato d i ectopia. Siccome il malato soffriva cost11ntementc da mol to tempo e non po· teva lavo!'are, fu p r oposta l'ablazione del tumo r e, ma si tro vò, n on gia il testicolo, ma l'appendice cecale, d ella grossezza di un dilo pollice ci r ca, globosa, e che fu es tir pala.
Advertisement
L'o perazione e ra evidentemente indicata ed ebbe e ccellenti ri s ultati , ma la d iagnosi era sbagliata.
T illaux visitò p ure una giovanetta di l!l ann i, nella quale un d ol o r e vivo, il cui pareva r isiedere in corrispondenza de ll'articolazion e coxo- femo ra le, aveva fatto diag nos ticare una coxalgia , e che, a ca gione di questa di agn osi, era stata messa in una doccia d. Bon net. Però un es:ame a ccu rato dimostrò che si trattava di un'append icite leggiera degna di n o ta pe r l'irradiazione dei dolor1 da parte dell 'anca .
d' ·t non lo é é e sso difficile riconos cere l'ap pen ICI e, 6 Se sp . u puraziooe la qual cos a è per meno lo stabili re se esiste s PdA' punto' di vista della cura; . l te a conoscei e tu mollo Impor an . . ha altro s e g no certo che la ta di agnosi n on v1 e per rare ques . . l l ratica c h e con s iste nello Jl ulluazione. e la d iag nosi di uppendil'a ppendice tutte esa erata. Se la suppuracile é sta ta falla , é estre m.amenle ,e più presto possi bile ; t · neces"ar10 operar zione è cera , e , b'l'la la malattia p uò molto s pesso ma finché e ssa n on é sta 'l , on vi h a alcu n inleguarlre coi mezzi e n a ù inlerveni r e clurur g•caltlm.,eon•·tme.en te nuando i fenod tl da tenere u er • • Pe r la con o a fa d'uopo basar si sulla meni dell'appendicite fl'8 le appendiciti a redistinzion e che ha s cidive e quP.Jle a l'i cadu t e. a t•ftcco ne ha un ' l le dopo un pr•m o ....
In un s oggetto, ' anni d'intel·vallo, si tratta d i una secondo sepa rato p•u .. d 'ca la nelltt secon da più che r ecidiva. e l'operazione la recidiva è mollo nella pr•ma volta, da l mome . Ll co i l malato conllnua Al contrario , !i'e dopo a da inler. . , e nta c r•s • a l'loffr1re, po • P 1 es . . durante i q uali per siste . . . d' . g'o r n1 0 tt 1 un m ese valh di qum ICI l . . ntro le qua li l'operazione é il dolore, s i tl'alla cl• ri cadute , co t' malati sono esposti · d· t perché ques l assolutamente 1n •ca a , . 'd t' e l'operazione sarebb e . L a ,.,ra v1 acc1 en •, ad ogm momen o r l' ' te fo sse di natu•·a tlluti le, anche quando questa app eni ICI d l lea•o braohtale nelle frat - d Ile rr atlure della c la vicola, la Malgrado la fr eq u en za te "Ono r elativamente molto -complicazioni di ques to. a cc• e u l .l Ile fratture eli quest'osso ll llo s e temamo co n o l e l'are sopra u . La cllirurg ia alluale permette n on accom pagnale da ferlla.l ftìcace aali accidenti c he d . . d . e . n un mod o m o to e .., .
E. BarssoN. - Le•lontl e P (Journal de Médeeine et de ture della olavtoo a .Chiru roie, gennaio 1895).
1 r·1me tar 1
1 . de l plesso bntcluale. po s!"ono e sse re prodo tti dalla e s lon e
In falli, le lesioni del plec:so brachiale cosft . l .. f l l . . l UISCOnO a pm ' requen e a piU interesf;tllllt>, dtll punto di vista clinico e terapeut•co, ùdle c,)mplicazioni della fratlurn eia . l Q t l u VICO are. ues e eslon• d i natura e di causo molto diverse Alcune sono immediatamente posl-traumflliche le. fi lla semplice coutuc:ione ùel plesso sen;a c uue persistente di le altre o lia l nel cbello t:e1·voso del frammento esterno 0 d' 1 . distaccata. 1 una se 1egg1a
. Alcune secondarie pr ecoci do vute al ve r samento s•ero - sangUJgno nel focolaio del)a. ft·attura.
Altr.e sono seconda r ie Larclive, dovute all'evol uzione di urt callo. possono far preved ere lo spostamento conslùerl!vole ùel ll:amme nli o la difficolta dell l • tenzione. a or o con -
In tutti i casi i fenqmenl, variai)ili nella loro intensila inte ress an o la mot•lità, la sensibilitu e la troficita . '
La molilita ('. o meno les a , talo r a in un incom· pl e to, l.a paralisi essendo limita ta ad un certo numero .ti mu scoli, appartenenti s ia all'uno !;ia all'altro ..le· . l l l' t · · ' 1• 1 nerv1 (earo, sJa a dtversi sullo stesso c:oagetto ln so b · · ' r- • mrna, t tStJ't· UZJOne dei ù istUJ·bi moto ri.
Gli acciùeoti generalmente piu nella sfera del mu scolo cutaneo, del radiaiP, d el mediano che nella del cubtl!lle. - erR
La é meno d Il t ll. · · e a motilihi; in u . • .' la fac cia interno, la cui sensibilità dipende dai prum:n er·vi intercoslali, è se mpre ai trofici, desq uamazi c.mi, caduta delle un g hte, ulcerazlom ere., ec:si sono pure molto va . bT . l stesso dicasi dei dolori. rta l l , o
L'evoluzione degl' 'd t' d' • • t llCCl en l •pende unicamente dalla loro causa anatom1ca.
Quell.i ùovuli alla comusione del plesso, ad UIIB scheggia, st maOJfestano subito dop o l'accidente. quell' che ;anno per il versamento sier o - sanguigno 'compaliono do po 4 o 5 gtOrn•; quelli che sono provocati dall ' ipertro tìa el callo o dalla mobilità di una pc:eudo art r . . d - os1s1 pro ucono uiotto tardi, dopo a lcu rte sell•malle od an che dopo !'iù mesi e più anni. Una volla slaoi\Hi, essi 'si 'svolgb-no in duè 'modi ò 1 tTere nti, secondo la loro causa. Gli accidenti dovuti alla contusione del plesso o ad un versamento siero-sanguigno, si a poco a poco. finiscono per scomparire, lattcia n do però per fJualche giorno dolore sul tragitto di uno o di d ue nervi, formicolio, cd una grande suscettibilità del membro agli agenti vuln eranti e snpratutto ai cambi amenti d• tem· pe rat ura. Quando la causa degli accidenti é permanente, frammento esterno, scheggia, callo o pseudoarlrosi, essi vanno al con trario af!'s:rravandosi cd allo r a hanno quasi fa• talmente per esito l'tmpotenza completa del membro.
È quindi asso lutamente indicato ric orrer ù ad una cura energica , tanto più rhe t'i!mlta dal lavoro d i Brisson che t utte le volle c h e n <Hl s i ù lnrJalo lrop!Jo ad operare, gli interventi sono sempre s tati fav o revoli nei loro risultati.
P er cui quando !'i tratta di accidenti immediati, provocati tlalla punta d el frammento esterno o di! una scheggi 1, si inle1·ve rra subilO re«ecando n o civo e sulu1·ando i f••ammenti.
Quando si tratta di accidenti da callo ipertrofico, la r ese· z ione di questo callo e la s utura sono egualmente IndicAti. forse «l'l'ebbe il caso, quando le condizioni della fratturA, possono ftlr prevedere la formazione d i un callo ipertroflco, J i operare senza aUcnd c l'e la sua fo1·mazione.
P er la stessa r agione, gli accidenti nervo si secondari i, r apiùi, dovuti ad un versamento s iero-sangu igno nel focolaio <Iella rraltura, dev ono essere trallali coll'evacuazio ne del v er ::: a mento o con la sutura; è il solo mezzo per evitare l' inRhbamenlo del plesso nel tessulo cicatriziale.
La sola vari età ò• lesione del plesso brachiale per fratt ura della clavicola, che ri ehiede una geandP riserva lerap eulica, è la contusione semplice. Sarà necessario fare la con un esRme molto accurato del fo colaio della fr a ttu r a e delle parli circostanti.
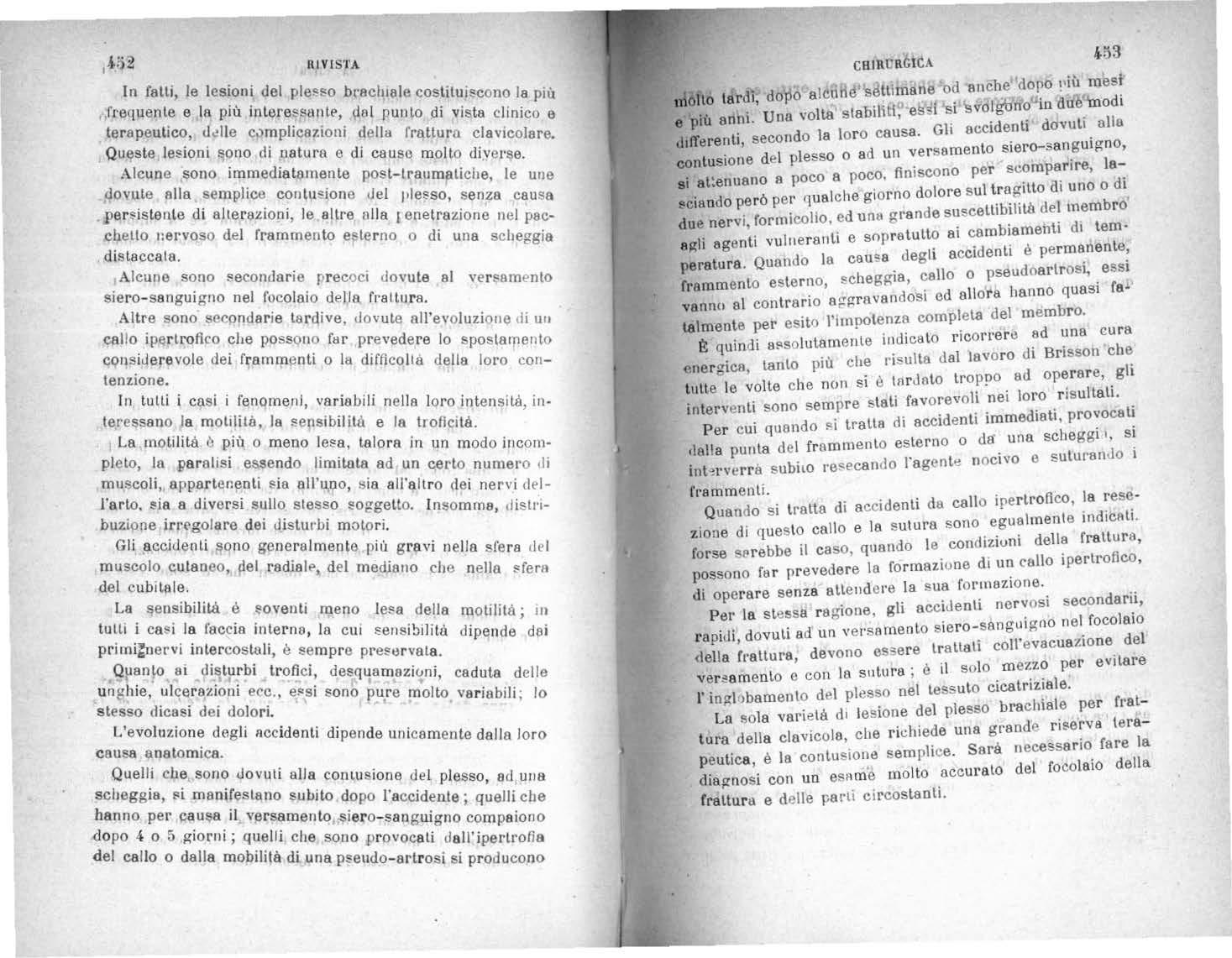
CR iltUBG ICA.
J . GREIG S MtT H. - È l'&ppo•lztone 4el perltoneo &l perltoneo un errore ohlrurgloo ? - (Brii . ,\.fed. Journ., fJ g en· nai o 1895).
Il prof. Greig Smith si fa questa domanda e rispond e affermativamente. Negli ultimi due anni egli ha operato in modo, quand o era possibile, da t·iunire il peritoneo non al pe ritoneo, come é s tato fin qui qua!:i consigliato, ma alla superficie delle fer•ile o a quella fibr osa di esso. Riferisce nel s uo scriLLo molli casi in c ui ha agito con questo intendimento e viene alle seguenti conclusioni. Uove si desidera di assicurare un'az io ne pronta, forte e permanente la sutura sier o -fibrosa m 1ghor e della siero-sierosa; dove invece l'unione non deve essere ta nto forte o pcrmunenle può adotlat·si la sutura siero-sierosa. La sutura fìhrofib r osa, lanlo buona rruanto lo siero-sierosa, non lo è quanto la La sutura fìbro-nbr·osa e la sier o - sierosa si possono quindi usare nella chius ura della fel'ita par·ielale, nella l!ur·a dell'ernia ombelicale e ventrale c nella colpoislerectonda.
La sutu ra siet·o-flbrosa o apposizrone ct'una supel'fìcie perilo:neale alla ferila è indicata nella gastrostomia. istet·opes"lll, enlerostomia, colo to mia, colecistotomia ed in tutte quelle altt·e numet•ose operazioni le quali implican o il drenaggio di cisti od ascessi.
Il prof. Smith ftJ voti che qu e$lO s u o consiglio sia seguito poichè esso si fondo non solo su llo pr·atica ma anche sulla teoria. L' umone siero -siet·osa avv ien e r·apidamenle ed in poche ore es:oa. è a tenuta d'a r ia e d'acqua. Ma quest' uni one meno r apida di quella che avvi ene lrtt il pe t·iloneo (\ una superfici e ruvida. Ciò s i spie!!tl fa cilmente coll'islologia . Lo str ato di giovani cellule linloidi che s i trova lt•a le superflcte siero!>e ha poca coes1one e separato com'esso è ùa un doppio s tr·alo di endotelio dai vasi, è lento a ùive rm vero tessuto di g t·anulazione , e ciò s'intzia, cessa l'essudazione della linfa. Tali adesioni spesso scompaiÒno e se rimangono quasi sempre diventano sottili e !:!li rate . D'altra perle il li n fatico che si fo r ma primariamente tr•a le supt-rtìcie sierost< e fibrose aderisce più for·temente perché hA maggiori punti di con- ta - (Med. News, nov. 18fH). D m•mORE. - L amineoto1D .
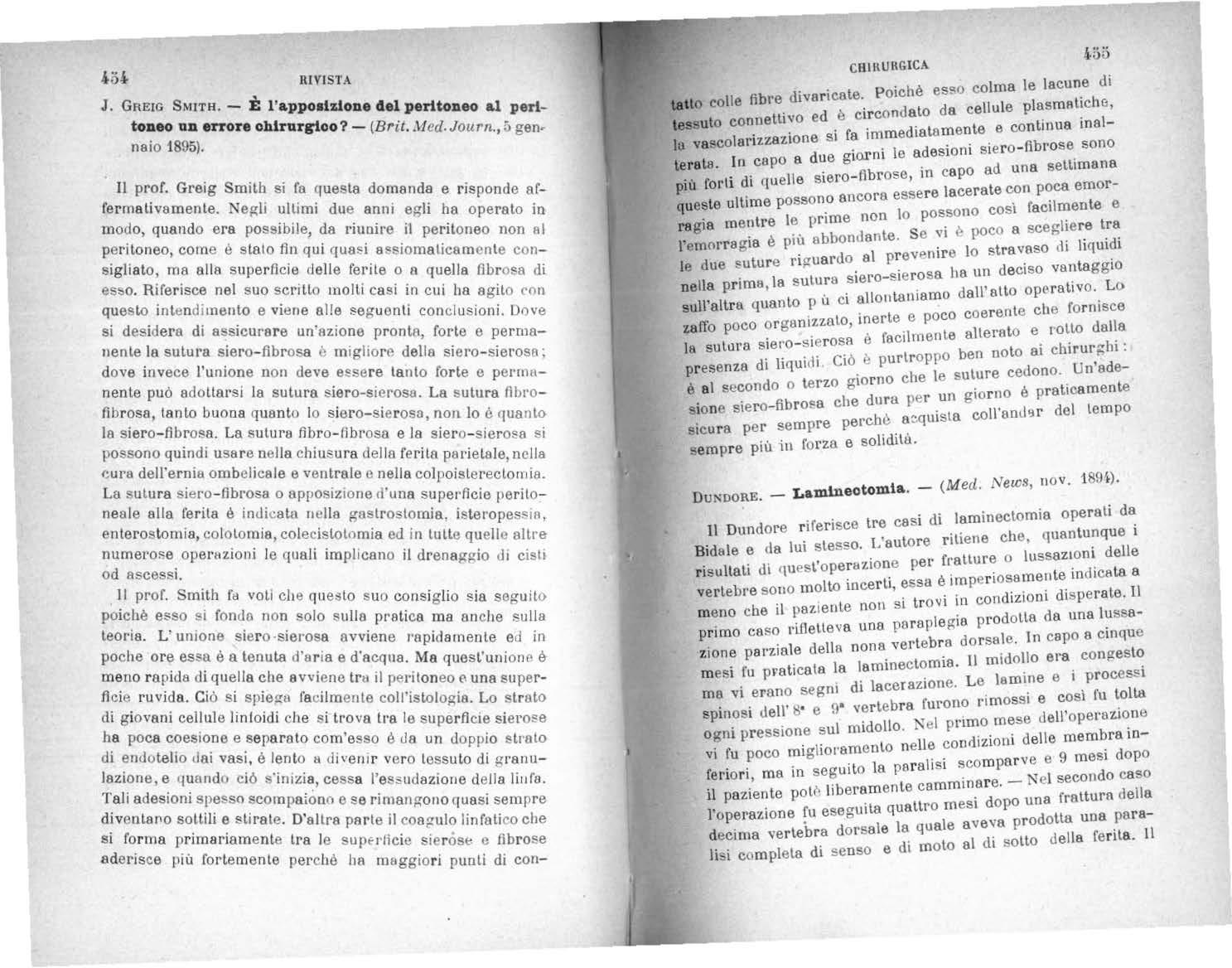
. . . hè sl'IO colma le lacune di a- l lO colle fìb t•e ùtvartcate. Potc e • l l'c ho ... . d è cir condalo da cellu le p asma ' ' tess u to e . immediatamente e continua inalla vasc olal' tzza ztone SI ni lo adesioni sie r o - fibrose sono \e r& ta. In capo a due g to.r . ad una sellimana più fo t•li di quelle siero-fibrose, con poca emor. ossono an co ra esser queste ul ltme P n lo ossono così facilmente e ra gia prime no e vi ,, poco a sceglie re tra )'emorr agia è sbbontJalnt IO straV8S0 di liquidi le due Il !ZUardo. a p. sa ha un deciso vantaggio · 1 c:ulura stero-stero n e ll a pr tma , a. dall'alto operat1vo. Lo , l p ù ci allonlantamo . s ull altr a quan o . co coerente che forn1sce zaffo poco o r gani.zzato, alterato e rotto dalla la sulu r·a siel'o-stProsa e act ben nolo ai chi rurghi : . . . l' c·ò è purtr oppo Pr esenza dt hquH 1 1 dono Un'adea· no che Je suture ce · è a l secondo o terzo oiOr gio rn o è praticamente siero-fibrosa che dura per .unl coll'anJ'.lr del tempo . sempre perchè a c:tcu r a per : e mp r e piu in forza e soliditù.
· di 1 min ectomia operati da Il Dundore ri ferisce tre casr . h tunque i Bidale e da lui stesso. L'autore rtl!ene : delle r isullati di pet· indicAta a ve r tebre so_u o molto lOcerlt, vi in condizioni disperale. Il meno che ti non st tr ol e ia prodotta da una lussap r imo caso t·ifieUeva una po r apb g d sale In cap o a cinque · 1 d 11 ona ver·te ra or · z1one pat·zJa e e 0 n . . Il midollo era con!Xeslo m l'si ru pl·aticala la L e !eroine e i processi ma vi erano segm dt laceraziOne. . · · ru tolla a l br fUl'OrlO r tll\OSSI e COSI spinos i i)' e 9 e a • 1 rtroo mese dell'oper'azione ogni pressiOne sul mtdollo. Ntl p _, . . . delle membra io. · l e lle CO D•JlZlOlll vi fu poco mig horameo 0 n 9 mesi dop o t l ar alisi scomparve e fe ri or i, ma 111 segut 0 a P . r e _Nel secondo caso ,.. 1·b mente cammma · il paziente pol•· t era . d po una frattura della . ·la quattro mest o l'oper·aztone fu esegut una para. l l d ecima vertebra dorsa e a. q 1 di solto della fe r ila. Il lisi completa di sen so e dt moto a midollo fu tr·ovato diviso e i due monconi distavano circa un pollice l'uno dall'a ltro. La morte avvenne dopo un mese Il terzo paziente fu operato per· fr·attura della 9• dorsale nel le pl'ime 2,} ore del Lraumalismo. 11 midollo fu tro:a!o gravemente lacerato. Le lamine e ì processi spmosi 8 .' 9• .e 10• ve rt eb ra furono aspor•tati. La ferila opera.c1calr1zz6 al 12' g io rno ma il paziente non ebbe alcun mrghorameoto e mori tre sellimane d opo l'operazione.
KiiSTER - Trattamento operativo dell'ulcera ga•trt oa . - (Brii. M ed. Journ., l2 genn aio L895). •
Kilsler ·r·ifer•isce un secl)nd o caRo dr ulcera curata con successo coll'apertura dello stomaco, colla cauler1zzazione ignea e la Il paziente Pra un uomo di 42 anni, emacialo il quale eia sci anni soffriva di dolo r i allo stomaco e vomito. Nella primavera dello scorso anno tanto la mate1•ia vomitata quanto le feci e ran o ro 1·temHnte tinte di sangue. Il 27 giugno, lo stomaco fu allo .scoperto un'incisiOn e m&lia na della pa 1·ete a 1J. dommal e al d 1sopra clell'ombelico: si lr'ov ò un'ul cera nella parete posteri o re del visce re in del pilor o.
Falla un· incisione nella parete ante riore pa rall elamente alla grand e cilr·vatura, i bordi ne furono forte mente divartCHti e l'ulcer a fu ca usticata col termocaute ri o. Si stab ili 111 seguito una comunicazione tra lo stomaco e il digiuno. La tendenza all a fu m ollo disturbata per la frequ ente distensione dello s tomaco p r odo tta dalla sec1·ezione d'un liche ri chiese la feequ en te lavatura doll' o r garto ner pl'rmr cmquo giorui dall'aLLo operativo. O!LI'e a c iò un forte accumulo di sangue e di sie ro nella fed ta esterna nécessaria la rimozioné di alcuni puntt di sutura e il divadelle fe rite. Quando il pazienle fu dim Psso in capo a Rer settimane (>l'a liBer o da allo stomaco e in grado di mangiare cibi solidi e IJ cruidi seoza alcun inco?veniente. Due mesi più lardi er·ll semp r e in buona salute e tl peso del c01·po er·a considerevolmente aum e ntato.
Chirurgica
LANGEN BUC H - Be.eslone dello atomaoo . - (Deut. med. Wo ch., 27 dicembre
Lan genbuch riferisce due casi di resezione qua s i totale dell o stomaco:
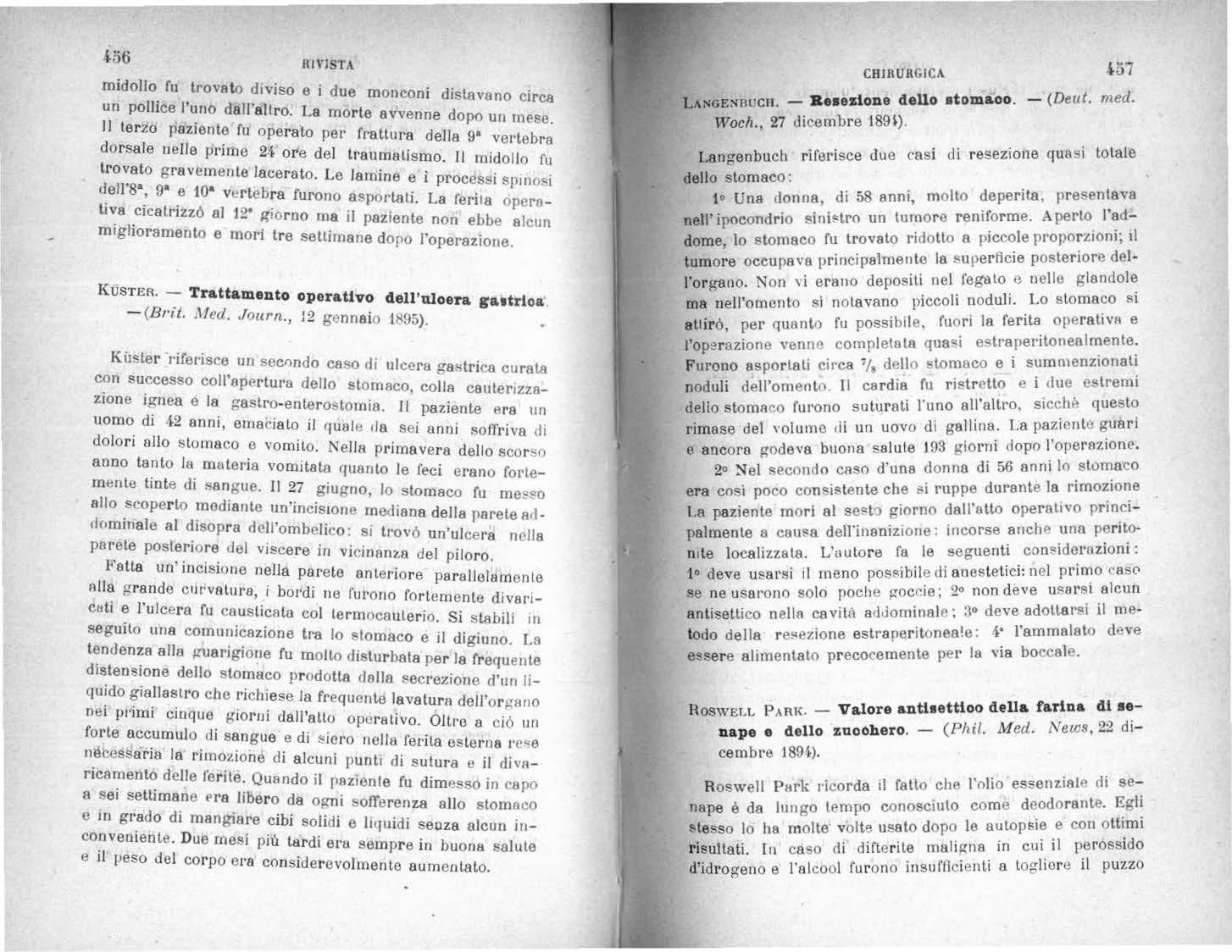
1o Una donna, di 58 anni, mollo deperita, preo::en tava nell' ipocondrio sini .. tro un tumore reni forme. A perlo l'addome, lo Rtomaco fu trovato l'id ollo a piccole propo rzioni; rl tumor e occupava principalmente la Ruperflcie posteriore dell'organo. Non vi erano depositi nel fegato e n elle ma n ell'omonto si n o tavano piccoli noduli. Lo stomaco SI attirò, per quanto fu possibile, fuori la ferita operativa e l'oper azione venne comp letata quao::i
F urono asportali cir·ca ifs dello stomaco e 1 summenz10nal1 noduli dell'omento. Il cardia fu ri s tr e tto e i due es tremi dello stoma co fur·ono suturati l'uno all'allro, srcchè questo rimase del YOlumo eli un uov o di gallina . La paziont\3 guari e anco1'8 godeva buona salute JH3 giorni dopo l'operazione.
2o N el secondo caso d'una donna di 56 anni lo era cosi poco consistente che :;i ruppe durante la rimozione La paziente mori al se!>to giorno dall'atto operalrvo principalmente a dell'inanizi one: 111corse aucb e una peri ton rte localizzata. L'autore fa le seguenti con!>ide1·uzioni: i o deve u sarsi il meno di anestetici: nel p1·imo c·as0 se ne usar·ono solo poch e goc,.ie; 2° non deve alcun anti settico nella ca vite\ adJominal r; deve il meto do della r e!'ezione estt·aperito nea!e: 1· l'ammalato deve alimentato p r ecocemente per la via boccale.
RoS,VEI.L PARI<. - Valore antlaettloo della farina di •enape e dello znoòhero . - (Phil. Me d . News, 22 dicembre 1891-).
R oswell l'icorda il ratto che l'olio essenzialP di senape è da lungo conosciuto come deodorante. ste sso lo ha molte volte usato d opo le aulope:ie e con ottrm1 ri sultati. In ca so di difte r ite maligna in cui il pe t·ossido d'idr ogeno e l'alcool fu l'ono in su rlì cie nti a to g lìerc il puzzo alle sue dita, vi r iuscl perfettamente usando la comune farina di senape. Egli la raccomanda in tulti i casi in cui debbono toccarsi ferite o scoli e specialmente in casi urgenll quando manca ogni altro disinfettante. Egli raccomanda inoltre Il zucchero ed all'erma che le fr·atture complicate possono curarsi con buoni effetti collo zucchero in polvere. Nola che mentre le soluzioni diluite di zucchero formano un mezzo di cultura pei batteri, le forme patogene non vegetano nelle soluzioni concentrate o negli sciroppi. Egli considera per ciò il zucchero come un altro utile antisettico speciolrnenle quando non se ne banno allri a disposizi one.
CHII\U RGJCA.
G. G.
F ARRe. - Tratt amento del tlo doloroso della facola,(Ga.a ette des Hopitaux, N. 102).
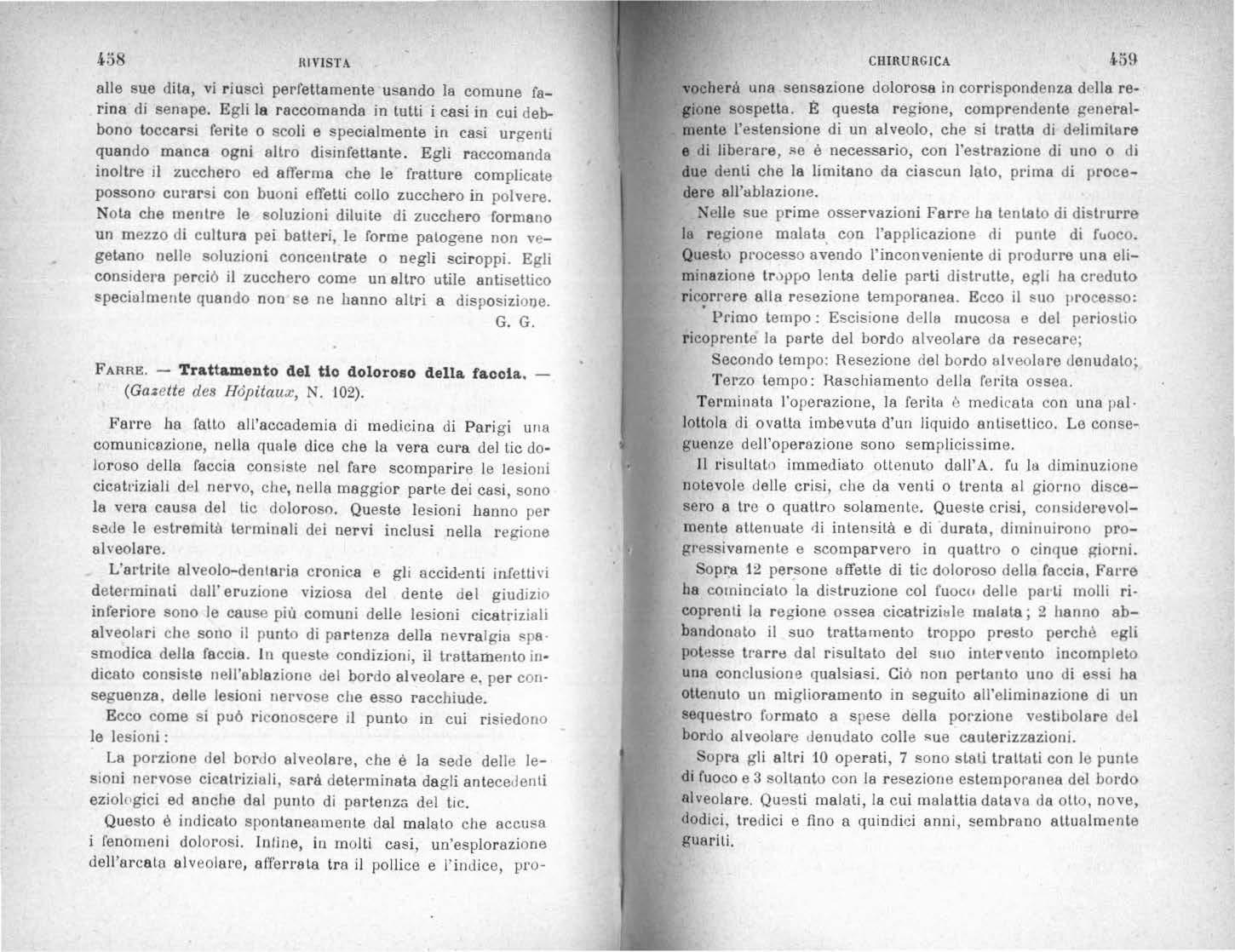
Farre ba fallo all'accademia di medi cin a di Pari ai una .., comunicazione, nella qu a le dice che la vera cura del tic doloroso della faccia consiste nel fare scomparire le lesioni cicatr·iziali d t- 1 nervo, che, nella maggior parte dei casi, sono la vera causa del tic doloros0. Ques te lesioni hanno per sade le estremità terminali dei nervi inclusi nella regione alveolare.
L'artrite alveolo-dentaria c ronica e gli accidt!nli infettivi d eter·minati dall'eruzione viziosa del dente del giud izio inferiore sono le cause più comuni delle lesioni cicatriziali che sono il punto di pa rten za della nevralgia !'pa· smodica della faccia. In qut>ste condizioni, il Lratt.amento indicato consiste nell'ablazione ùel bordo alveolare e, per c on· seguenza, delle lesioni net·vose che e sso racchiude.
E cco come si può r iconoscere il punto m cui risiedon o le lesioni:
La porzione del bordo alveolare, che è la sede delle lesioni nervose cicatriziali, !òarà determinata dagli antecedenti eziol<•gici ed anche dal punto di partenz;;. del tic.
Questo é indicato spon taneamen te dal malato che accu!òa i fenomeni dolorosi. lnline, in molti casi, un'esplo r azione de ll 'a reala alv eo lare, al1'errata tra il pollice e l'inllice, pro- voche r à una sensazione dolorosa in corrispondenza della regione sospetta. g questa r egione, comprendente g-eneralmente l'estensione di un alveolo, che si tratta di di'limitare e ùi liber·are, Re è necessario, con l'estrazione di uno o di du e che la limitano da ciascun lato, pr·ima di procedere all'ablazion e. sue prime osservazi oni Farre ha tentato di distru rr e la r egione malata con l'applicazione eli punte di fuoco. Quest1.' pr·ocesso avendo l'inconveniente di pr·odur·re una eliminazione tr,)ppo lerrta delie parti distrutle, eglr ha creduto r it·?rr•ere alla r esezione temporanea. Ecco il suo pr·ocesso:
Primo tempo : Escisione della mucosa e del perioc;tio ri coprente la parte del bordo alveoltlre cJa resecare;
Secondo tempo: 1\esezione del bordo »lveolare denudalo;
T erzo tempo: RaschiamenLo della rer·ila ossea.
T erminata l'operazione, la fet•it» (• medicata cou una pal· loltola di ovatta imbevuta d'un liquido antisettico. Le conseguenze dell'operazione sono semplicissime.
Il r•isullato immediato ottenuto dall'A. fu la diminuzione notevole delle crisi, che da venti o trenta al gior·no disceMro a tre o quattro solamente. Queste crisi, considerevolmente attenuale rii intensità e di durala, dirninuirouo progr·essivamente e scomparvero in quattr·o o cinque giorni.
Sopra 12 per sone affette di tic doloroso della faccia, Fat-re ha corninciato la dis-truzione col fuoco delle par·ti molli ricopren ti la r egione ossea cicatrizittle malata; 2 hanno abbandonalo il suo trattamento troppo presto perché egli pot esse dal risultato del suo intervento incompleto una conclusione qualsiasi. Ciò non pertanto uno di ec;si ha ottenuto un miglioramento in seguito all'eliminazione dr un sequestro formaLo a spese della porzione vesLtbolare bordo alveolare denudalo colle cauterizzazioni.
Sopra gli altri 10 operati, 7 sono stati tt·atto.ti con le punte di fuo co e 3 soltanto con la resezione estemporanea del bor·do alveolare. Questi malati, la cui malattia datava da otto, nove, dodici , tredici e fino a quindici anni, sembrano attualmente guarili.
ScutiLLER. - Oomunlcazlonl oblrurglohe •u l reumatl•ml oroulol artloolarl. - (Cent ralblatt .fii,r die medicinischen N. 39).
Sulla bac:e di un proprio materiale di 116 pazienti, l'Autot·e divide le infiammazioni articolari croniche reumati c he io tre gruppi. Il primo di essi (forma semplice) car·atte rizzato dalla membrana sinoviale iogros!'ata, cronicamente info_rt:mente vascolarizzata, nbbraccia 92 pazienli, croè 38 uommr e donne. La somma delle arlicolaz•oni colpite giunse a 33t, di cui 167 spelltlno alle estr•emità superiori e 164 a quelle inferiori e in totale furono 72 i pazienti nei quoli contcmporanenmenle era slala colprta più di arlJCOhizione. Le arlit!OlazJorri più att11 ceale furono quelle del ginocchio, ùel piede c delle dila dellt: mani quindi quelle d ella mano, ciel gonuto , dblla spalla delle dei piedi, Jel !arso, dell'anca, ecc. In 20 malati, quali fu una sola arlicolazionc malata, volle fu colpita un'arti colazione del ginocchio, i \'Olte s oltanto un'articolazione de lla ed un'ar·ticolazione del piede, 1 volla la artico lazione del gomito, della mano, della dita della mano e delle dita dei piedi. In circa 1/, de' maiali ebbero aflezioni si mmetr•iche delle stesse articolazioni.
Il secondo si diffe ren zia soltan lo grAdualmente cl al primo, e<>so la forma g r ave di reumatismo arti colare c ronico con numer·osi arruffamenti della capsula . ,\LI esso appartengono 15 casi, 6 uomini e O donne e solamente
2 fu attaccaLa una sola articolazione. I n più di ', clr questo gruppo la malattia si manifestò in ambedue i lati.
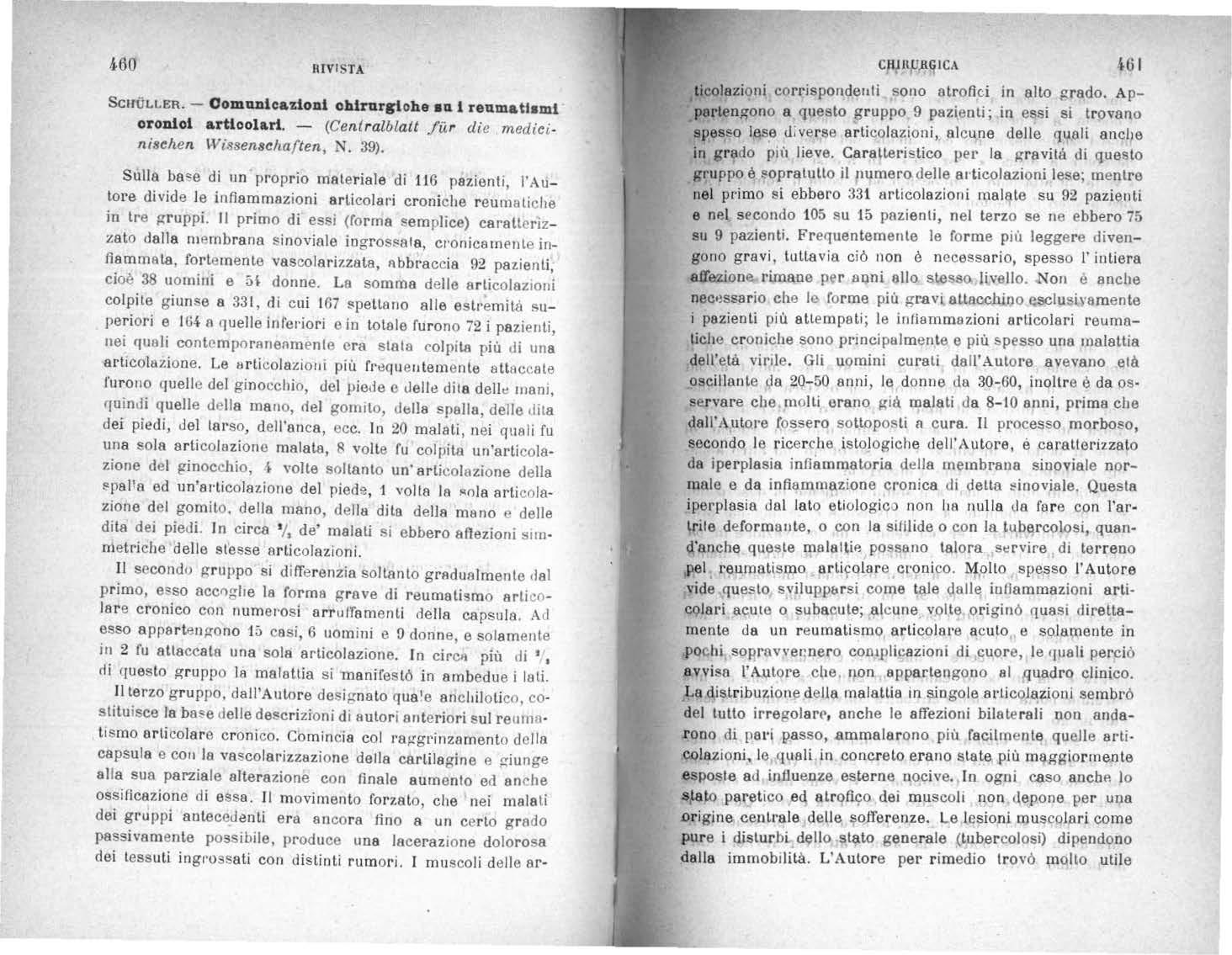
Il terzo g ru ppo, dall'Autore designalo qua 1e anclril otico costituisce la ba S'e delle descrizioni di autori anteriori sul reu;n n· lrsmo articolare c r onico. Comincia col r'&)Cgrinzamento dolla capsula e cou la vascolarizzazione della cArtila gine e alla sua parziale alterazione con finale aum ento ed an c he ossificazione di essa. Il movimento forzalo che nei malati dei aoleccJenli e r a ancora lino a' un c erto g r ado passivamente possibile, produce una lacerazr o ne dolorosa de i tessuti ingr·ossati con distinti rumori. I muscoli delle ar-
CHJRU,RqtCA 461
&icolazioni corrispondeuli sono atrofici in alto grado. Appartengono a questo gruppo 9 pazienti; in essi si tr ovano spesso lese ù;ve r se articolazioni, alcune dello quali ancl1e in grado prt'l lieve. CaraHeristico per la di questo gruppo é sopratulto il numero delle ar·ti colazioni lese; mentre nel pl'imo si ebbero 331 articolazioni malate su 92 pazienti e OP.! secondo 105 su 15 pazienti, nel terzo se ne ebbero 75 su 9 pazienti. Frequentemente le fo rme più leggere divengono gravi, tuttavia ciò non è necessario, spesso l' ioLiera a1J'ezione rimane per anni allo stec:so livello. .Non e anche nec•!ssario che le forme più gravi atlaccbino esclusivamente i pazienti più. aUempati; le infiammazioni articolari reumatich e croniche sono pr·•ncipalmente e più s-pesso una malattia de ll'età virrle. Gli uomini curali dall'Autore avevano età oscillante ùa 20- 50 anni, le donne da 30-60, inoltre è da osservare che molli erano g•a maiaLi da 8- 10 anni, prima che dall'Autor·e fossero sottoposti A cura. Il processo mo r boso, secondo le rice rch e istologiclte dell'Autore, è da iperplasia infiammatoria della membrana siooviale normale e da infiammazione cronica di çlelta :! ioovial e, Questa iper·plasia dal lato etiologicv non ha nulla da fa r e co n l'artri te de formaute, o con ta sililide o con la tubercolosi, quand'an che queste talora di ter reno ,pel reumatismo arLi çol are cr·onico. M,olto spesso l'Autore vid e questo sviluppb r si come tale (,[alle iulìammazioni articolari acuto o subacute; alcune volte originò rtuasi direttame nte da un r eumati smo arlicolar·e acuto e sola.tnente in pochi soprav,·er.oero cootplit!Bzioni di cuore, le l[uali perciò avvisa l'A.ulore che non appar·tengono al .quadro clinico. La distribuzione d ella malattia rn s.ingote al'licoJazioni sembt•ò del lutto irregol ar t', anche le affezioni bilaterali non andar ono di pa t·i passo, ammalarono più facilrnenle qu elle articolazioni, le q1,1ali in concreto erano sta te più. maggio r mente e sposte ad infl u enze esterne nocive. In ogni caso aocbA lo paret1co ed at r ofico dei mus colt non depone per una ori g ine centrale delle sofferenze. Le lesioni mus co ll).ri come p ure i disturbi dello slaLo ge nerale (tube r colosi) dipendono da lla immobilit-à. L'Auto r e per rim edio tr ovò molto utile il praticato secondo l'a r te ùal medico. Fra i e doccte dà la preferenza a quelle applicazioni che allernano l'azione del cald o con q11ella del fredJo. 'Molto uttli le docce • scozzesi •. I n 5 casi gravi, n e i quali 4 volle fu attaccato il ginocchio ed 1 volta il gomito l'Aut ore praticò l'arlrectomia. ' si compone di due parl i, cia!>cuna delle quali é cost1lu1la da un corto cilindro metallico cavo che ad una porta un rialzo circolare r.onvesso alla tes ta d'un fungo.
LANDERER. -ll bottone di llarphy nella enteroatomoal e le aae modUloaztoni. - (Centralb ./ur Chir. , N. 13).
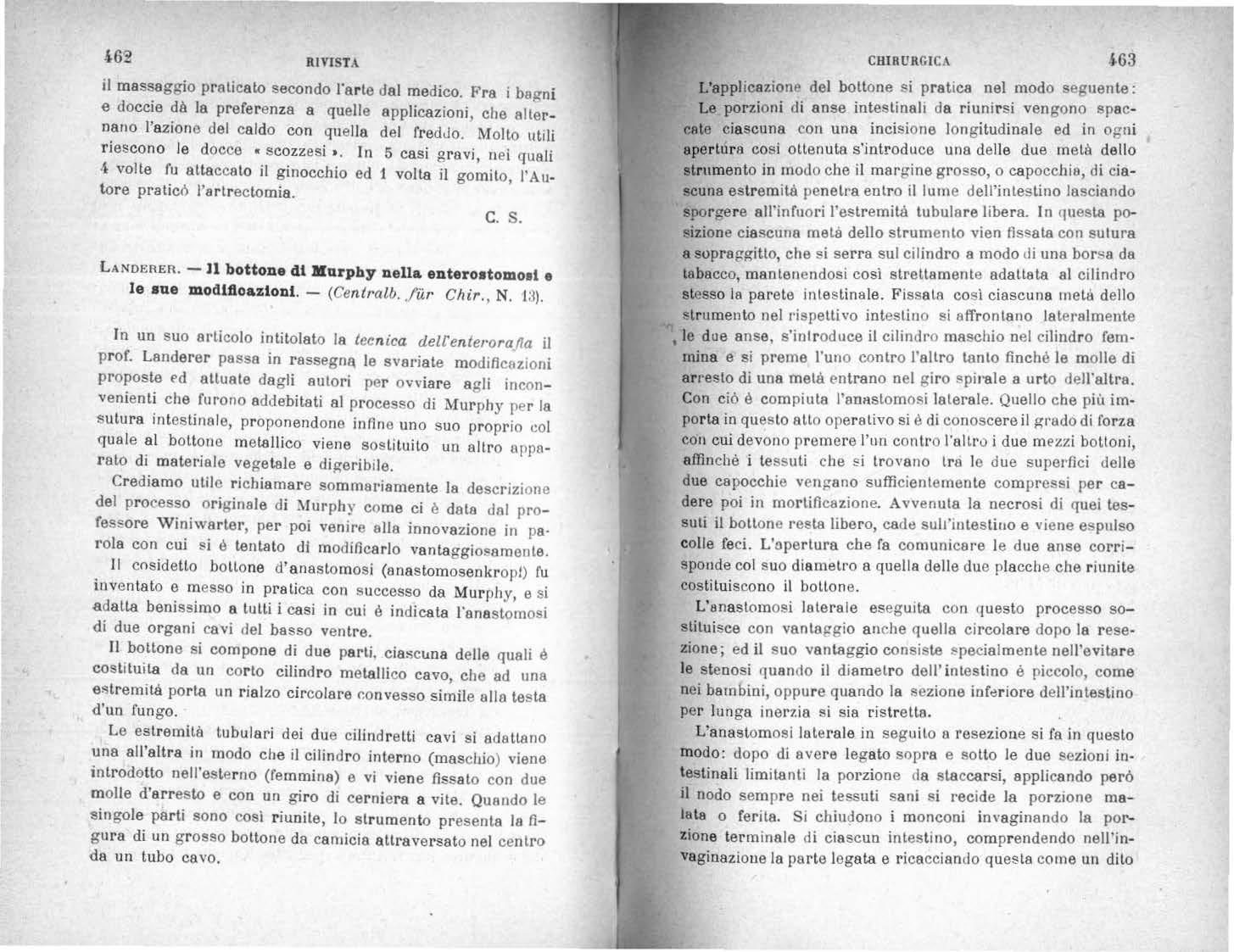
In un suo at'licolo intitolato la t ecnica dell'enl er orajla il p r of. Landerer passa in rassegn& le svariate modifl ca z io ni proposte Pd attuate dagli autori pe r o vvia r e agli in conche. furono addebitati al processo di Murphy pe r la sutura 1ntesttnale, proponendone infin e uno suo proprio col quale al metallico viene sostituito un allro appar ato di mater1ale vegetale e digeribile.
Crediamo utile r ichiamare sommariamente la des c riz io n e del originale di co me ci è dala dal profes s ore Wtntwarter, per poi venire alla innovazione in pa· rota con cui si é tentato di moditlcarlo vantaggiosamente.
. Il cosidetto bottone d' ana stomosi (anastomosenkropl) fu 1nven tato in pratica con successo da Mur phy, e si adatta bentsstmo a lulti i casi in cui è indicata ranastomos i di due organi cavi del basso ventre.
Le eslremiLà lubulari dei due cilindretti cavi si adattano all'altra modo che il cilindro inte rn o (maschio) viene ultrodotto nel! este rno (femmina) e vi viene fissa lo con due m olle d'arresto e con un gi ro di cerniera a vile. Quando le singole parti sono così r iunite, lo str umento presenta la figura di un g r osso bottone da canlicia attraversato nel centro da un tubo cavo.
L'applicazione del bottone si pratica nel modo seguente: Le porzioni di anse intestinah da riunirsi vengono spaccate cia scuna con una incisione longitudinale ed in apertura cosi ottenuta s'introduce una delle due metà dello strumento in modo che il margine grosso, o capocchia, di ciascuna estremità penetra entro il lume dell'intestino lasciando all'infuori restremita lubulare libera. I n lfUCSta po!'lizione ciascuna metà dello strume nto vien con sutura a soprag-gitto, che si serra sul cilindro a modo di una bor!ia da tabacco, manten e ndosi cosi strettamente adattata al cilindro stesso la parete intestinale. FissaLA cos ì ciascuna ll'leté dello !'tr umento nelt•ispeltivo intestino si a ffrontano late ralmente , le due a nse, s'inlroduce il cilindro maschio n e l cilindr o femmina e si preme l' un o contro l'altro tanto finché le molle di a r r·esto di una metà entrano nel giro a u rlo de ll'allra. Con ciò é compiuta l'aMslomosi laterale. Quello che più importa in questo allo operativo si é di conoscerei! gr·ado di forza con cui d evono premere l'un contro l'altro i due mezzi botton i, affi nché i tess uti che si trovano lra le due superfici delle due capocchi e ve ngano sufficiente mente compressi per cadere poi in mortificazione. Avvenuta la necrosi di quei tessuti il bottone resta libero, sult'mtestiuo e viene e s pulso c olle feci. L'operlura che fa comunicare le due anse corrisponde co l suo diametro a quella delle due placch e che riunite costituiscono il bollone.
L'11nastomosi laterale ese gutta con questo p r ocesso sostituisce con an c he quella circolare dopo la resezione; ed i l suo vantaggio consi s te !-tpecialmente nell'evitare le s lenosi quando il diametro dell'intestino é piccolo, come nei bambin i, oppure quando la sezione dell'intestino per lunga inerzia si sia ristretta.
L'anastomosi laterale in seguito a resezione si fa in questo modo: dopo di avere legato sopra e sotto le due sezioni intestinali limitanti la po rzi one da staccarsi, applicando però il nodo sempre nei tessuti sani si recide Ja porzione malata o ferita. S1 chiudono i monconi invaginando la porzione ter minale di ciascun intestino, compr endendo nell'invaginazi oue la parte legata e ricacciando questa come un dito di guanto rovesciato, e riun endo poi i margini delle "'uperfici s ie rose di ciascun moncone con suturtt a sopraggilto; quindi i due monconi, ridotti cosi a due tubi ciechi a cui di sacco, si aff'rontano colle loro superfici laterali e si esegursce sui medesimi renterostomia nel m odo s udd escritlo.
Questo é il processo originale di Murphy, che nelle diver.,e mollificazioni di enteror•afla proposte da Neuber·, Wolfler, S e no , Baraçz ed altri gode contra s tabili vantaggi.
Però non è da tacersi che di fronte ai loqati buoni r·i">ul· tali di questa su tura come ci vengono riferiti dagli I'Ulori americani e tedeschi, stanno anche degli insuccess i e degli esrti infausti.
In alcuni casi, per es., il bo ttone ha cagiona to una mortale peritonite, ostruzione inlestr na}e e perforaziOne (Oawbarn. Annals of Surgery, febbrai o 1895). Gli inconvenien ti del bottnne di Mur·phy stanno specialmenLe nel suo volum e e nel suo peso, che r e ndono ditljcile il suo passaggto cd uscrla dall'intestino, specialmente altraver·so la val vela del Bauino; n ella necessità di un processo di cha può dar luogo a perforazioni. Da ullimo il bottone di M ur•phy non i> sempr e a disposiz ione di ogni mellico. Il prof. Lande rer hu immaginalo un p r ocesso (però fino ad o r a sp•·rJmenlato solo sugli animalr) col quale egli intende di o tte· nere Wl8 sollecita adesione evitando g li inconvenienti del processo di Mur pby.
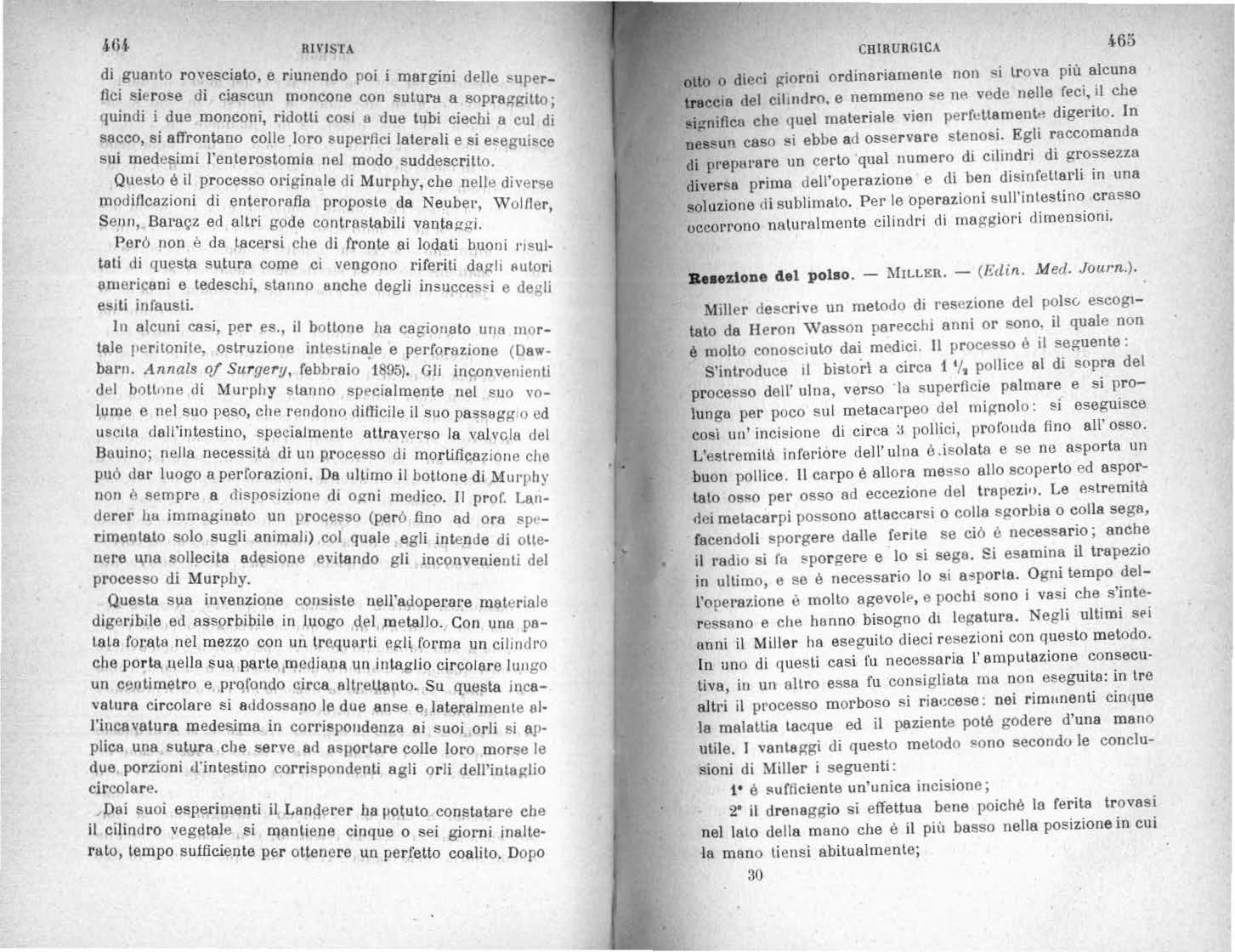
Questa sua invenzione consiste nelraJoperal'e malt> riale dige ribile ed assorbibile in Juogo del Jn e tallo. Con una patata fo1·ata nel mezzo con un treq uQ.rti forma un c il indr·o che porta .4ella sua. parte mediana Ul"\ intaglio lu ngo un c9ntimetro e pt•ofondo ci rca altr·ettanto. Su questa incavatura circolare si a ddossano le due an se e lateralm ente al· l'incavatura medesima in corrispondenza ai suoi orli si ap· plico una sutura che serve a d SSROrtare colle loro m orse le due porzioni d'intestino corrispondenti agli o r li dell'intaglio circolare.
,Oai suoi esperimenti il I.anqe r e r ha potuto constalat•e che il cilindro vege tale si Jl'lantiene cinque o sei giorni inalterato, tempo sufficiente p& r ottenere un perfetto coalilo. Dopo ollo 0 diel'i ordinariamente non -.i trova più. trecc1a ùel cilindro, e nemmeno !'e vede nelle che tt i••nificu che 11ue l materiale vien dtget'tto. In n;ssun caso si ebbe a d osservare slenosi. Egli r accom anda di pr·ep111·are un certo qual numero. di di dive r s a prima dell'operazione e dt ben 10 una sol uz ione di sublimato. Per le operazioni sull'intesti no crasso uccot•rono cilindri di dimensioni.
Beaezlone del polso. - l\hLLER. - (Edi fl.. M ed. Jourfl..).
Miller desc r ive un metodo di del polsc, escogitato da Il eron ·wasson pa r ecchi anni or sono, il quale non é molto conosciuto dai medici. Il procec:so è il seguente:
S'introdu ce il bistorl a circa 1 1/ , pollice al di st•pra del p rocesso dell' ulna, verso la superficte e si lungo per poco su l metacarpeo del mignol o: s t esegUisce così Il li' in cisione di circa a pollici, pr orouda fino all'osso. L'esteemità infel'iòre dell' ulna é . is olata e se ne asporta un b uon pollice. Il carpo é allora mes!<O allo scoperto ed tato 08110 per osso ad eccezione del trapczi•l. Le e!<lremrlà dei metacar pi posso no attaccat•si o colla sgor bia o colla sega, facend o li sporgere dalle ferite se c iò è necessario; anche il rad io si rn spo r gere e lo si sega. Si esamina il trapezio in ultim o e se è necessario lo si a:3porta. Ogni tempo dell'o oe ra7.i; n e 0 mollo agevoiP, e pochi sono i vasi che s'inte· e che hanno bisogno dt legatura. ultimi sPt anni il Miller ha eseguito dieci r esezion i con questo metodo. In un o di questi casi fu necessat·ia L'amputazione tiva in un allro essa fu consigliata ma non esegwta: IO Lre al tt·i il processo morboso si r iMcese: nei rimunenti cinque la malattia tacque ed il paziente poté godere d'una man o utile. 1 vantaggi di questo m etodo !<Ono secondo le conclusioni di Miller i seguenti:
1• é !'lufticiente un'unica incisione;
2• il drenaggio si effettua bene poiché la ferila tr ovasi n el lato della mano che è il più basso nella posizione in cui la man o tiensi abitualmente;
3• la r•isullante cicat ri ce è appena visibile e spet to dell a m ano è pe r fettamente no rmale·
4• l'opera zione è d i m ollo fa cile
Sulla dlftùllone nell' Interno dell' occhio - L B
V\ · · ELLARMINOFF e '· Craeje' s Areh.J. ophtalm. e Centr al/Jlalt j. dte medie. Wissens ch., N. 12, 189:S).
Gl i au tori sul rondamento d'u ri g ran nume r o di ri ce r che sono .a l che dive r s i sta ti patologici della parte anlell91 e dell o cc hio sp ecialrnenle dellA c la o r nea aume no sc.em ano la diffusione dei lirruidi nell'inte r no c Infia mma zioni acute della cor nea che sono accoma e do di tessuto aumeotJO!no la diiTusibil là a;menlo di questa in una cornea rn stato patologico lreLlo rapporto con la estensione la profondita 'l • r 10do e la s · d 1 ' ' ' ree processo patologico. Quanto più esteso e p rofo ndo patologico acuto del tessuto corneale tanto p1u forte sar·à il gr·ado di ditli . sioni · usrone. N elle leoperaLrve della cornea il grado di diffusione d' d dallo stato del le l d' rpen e . , ssu o l crcatrr ce che riu nisce i margrni Nelle cicatrici r ecenlr la diffusione è aume ntata· e be.no non a giscono in modo a rez: diffu siOne in confronto a quella normale staziona ri e della co rn ea (degenerazione di lmlnUISCOilO Ja diffusione. 'l d d' dipende d Il . . . l g ra o ' questo indebolimento sibilità d a/ cl e lla supe r ficie cicatr izia. La dill'u. . . eg t occhi con più o meno grande degenerazione ctcatrlzta della cornea c..limin ui sce a poco a poco c o rr ispon-
RIVISTA DI OCU LISn CA
<dentemenle alla r e lrazione e al ra gg r inzamen lo del tessuto .4à cieatrice . Se le fe rite operatorie della cornea sono compli cate a pr ocessi infiamma to ri (suppu razione, infiltra zione ), ta diffusione è au mentala in ragiOne della g rav ezza de ll a eompl icazione.
Nel tempo in cui sta formandosi la cicatrice, la diffusione pure aumentala: ma quando la cicAlrtce é completamen te organiua ta e comincia a raggrinzarsi, la diffusione si indebollsre. Il coloboma at·lificiale dell'i r ide non h A alcuna azione nè sulla' diffusione nella camera anteriore n•• su · quel le nel co rp o vitreo. L'au m ento ddla pression e introculare (a dim inuire la dtffusione. Cosi si spiega l'rndebolimento della azi o n e de i miolici nei proces::i glaucomatosi a cuti. La azione della temperatu r a sulla ditrusiooe non A stata abbastanza esaminata; l'aumento ò i e ssa osservato dopo l'azione delt•aoqua cald11 ò da attribu irsi a lla alterazione de ll'epitelio della CO I'n ea. La corr e nte di diffusione non r aggiunge il COI'po vitreo né nei casi not·mali nè in quelli patologici , quando la IPn t.e non è lesa . N egl i occh i afach ici la cor re nte di tl ill'u !l'ione il corp o vit r eo. l'\ e lla afa c hia co m pli ca la da qualehe processo patologico della cornea si a!Le ra la cifful'i one nel oorpo vit1·eo secondo la specie c.lella complicHzion e. Il e o r po della len te con i due foglielti della ca ssu la, la zonula in tegra e la membrana ialoidea opp on go n o un g ra nde ostacolo alla co r 1·enle di diffusione dei liquid i dalla camera anteriore ol corpo vitreo.
Pror. SCHMIOT-RIMPLER. - Tracoma e congiuntivite follicolare; loro trattamento oon la pinzetta manganatrice . - (Berliner klinisc!te W ochenschrUt, N. l , 1895).
È gener al m ente che il tra com a e la congi unlivite follicolar e sia no la malattia o l'una d e riva n te dall'altra. Ma le basi ;:ulle quali questa identità ,i fonda, la batteriologica, l' in tossicazione mi c r obicn delle g lan-dole linfalic he, non sono s icu r e. Nfl maggi ot· valo r e ba il processo anatomo- patologico, analogo in pr inci pio allo du e form e cl iui cbe, né l'afferma7..ione che alla co ngi untivite fo l-
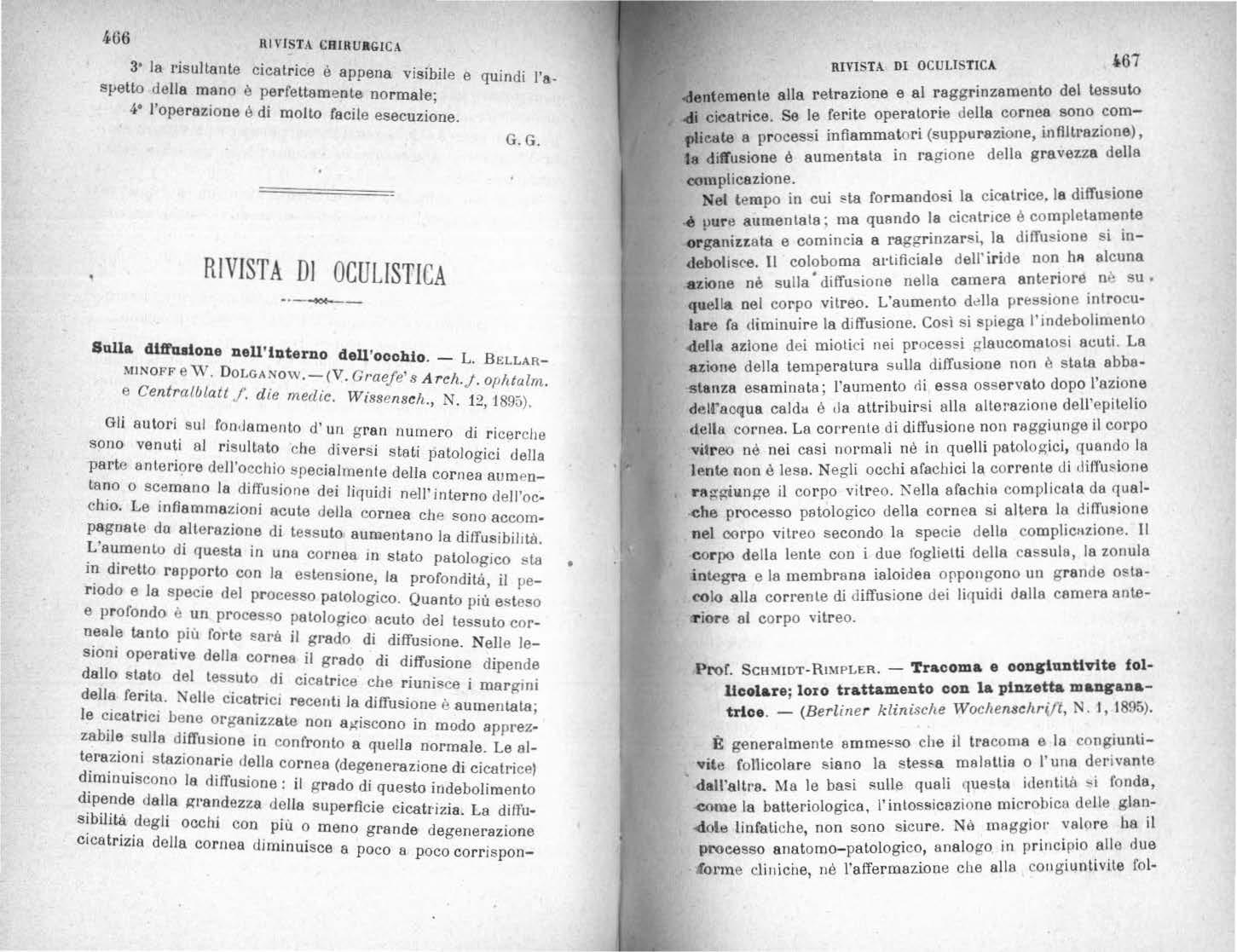
DI oCULISTICA
succeda il tracoma, perché, se la congiuntivite è A"enuma e non succede all rn iufezione, ci6 non si osserva mai. Con numerosP altre l'A. sostieDFl che lA congiuntivite follicolare non ha nulla di col tracoma o in altri che le du e forme sono del tutto distinte: merosissimi esempi dimostrano che il Lracoma è attaccaticcio e se l'altitudine presenta condizroni favorevoli alla sua dirninuzio ue, C'i6 può dipendere dal fatto che in luoghi elevati é minore la densità della popolazione.
Spesso la dia gnosi differen zi8l e fra la folli· colare e il tracoma e fa cile; talora é dirticile a primo aspetto; spesso in ambedue le forme , ma più frequentemente nel tracoma esistono lesi on i corneali e più specialmente panni tr acomatosi con diminuzione più o meno dell'acutezza visiva .
La cura della congiuntivite follicolare é di gran lun ga ptu semplice di quella del tracorna. L'uso di compresse bagnate con soluzioni di acetato di piombo o di acido borico, o l'azione diretta dell'acetato di piombo eompletamente neutralizzato o l' istillazione di deboli solt:zi oni di piombo, di zinco e di altri a stringenti servono a calmar·e le sofrerenze subiettive. Se non v'é ipel'enia, il Loccame nlo di1• e tto con la pietra di i'OIfato di 1ame a gevola il riassorbimento dei granuli. Ma questo rimedio dev e essere usato con parsimonia (una vo lla aliA seuimana) e con ci r cospezione, altrim en ti potrebbe essere alla congiu ntiva più di dan no c he di giovamen to. Se i folli coli fosse r o numet·osi e g r ossi, giove1•ebbe moJti,=.stmo lo schiacciarnento di essi con la pinzetta mangana tr ice . Di partico lare impo1·tanza è l'arra pura anche nella cam e r A da letto.
te r apia del traco ma, l'auto r e oltr e le comprPsse fr edde, gli astringenti per frena1·e o moderare una tumefazi one troppo forte e l'infiltrazione del tessuto congiuntivo, oltre l'azio11e trritante del solfato di rame in cannelli o in soluzione in casi di ipe r e nia troppo debo le, fa principale a ssegnamen to sullo schiaccia mento o sull'asportazion e dei granuli tracomatosi. Egli usa da due anni e con vanlaggio la pinzetta manganatl'ice di Knapp pe r schiacciare le gra- l . nr· Coli questa pinzetta o con altra analoga modificata no az1o . · 11· 1· ra 'bile d'• comprimere e spremere ' •O rco • g • dall' A é posst . noiosi. in ogni sede delle palpebre. Durante n on è uasi mai necessario di ricorrere all'anestesra generale, q odo rJuasi sempre bastevole quella locale delle palpebre esl!e l' · è ne d . l la con<>;na T e rminata opt- razJ o neottenuta me tan e """ · . . ce"sa ri o ùi lavttre le palpebre con tlt s ubltm.alo ( l . flOOO) o con a cqua clorata e di far uso rh co m pr esse. gh•acper frenare la r eazione Talora è Jt in appresso la piccola operazione. Qualt fino r a l A. ha ottenuto un migliorame nto nelle alteraztom palpebre e talora an c he della cornea, ma nessuna guarlgtone . . . do l'uso della pinzetta manganall·tc<' flmttva. In ogm m o . . . . . d . mi<7Jiori teattamenti curativi meccamct costrtm sce uno et ., del tracoma.
Att LS l'R OM. - Estlrpa.zlone del sacco l a orlmale - (Brii. M ed. Journ., 26 gennaio L895).
Ahlstrom dice che l'espe t•ienza ha ampiamente dimostralo che il p•ù insignificante trauma, il quale non avrebbe alc.un effetto su d'un oro:ltio sano, pu6 a ve r e con seguen ze g ravrssime se ar.cade in un occhio a sacco la cri male sano. Causa di ci6 si e tr ova ta e!:'sere l'infezion e de lla fer•la prodotta dai batteri della secrezione del sacco. L'autor·.e ese· guilo l'estirpazione del sacco per le seguenti affez10m : i l tubercolosi del sacco o del canale;
2) oblilerazione del sacco dovuta a malattia delle parlt limitrofe: fi s tole lacrimai i; .
4) come operazwne preliminare a quella che SI praticar e poi sul bulbo oculat·e quando non vi er a tempo di curar l'affezione del s acco. L'io <(isione cutanea deve meno a tre millimetri dall'an golo interno p er evitare • vast an gola r i e dev'essere condotta dal mezzo del ligamento pebrale interno in bas!:' O ed alquanto in fuori per l'estensiOne di ci r ca 2 centimetri.
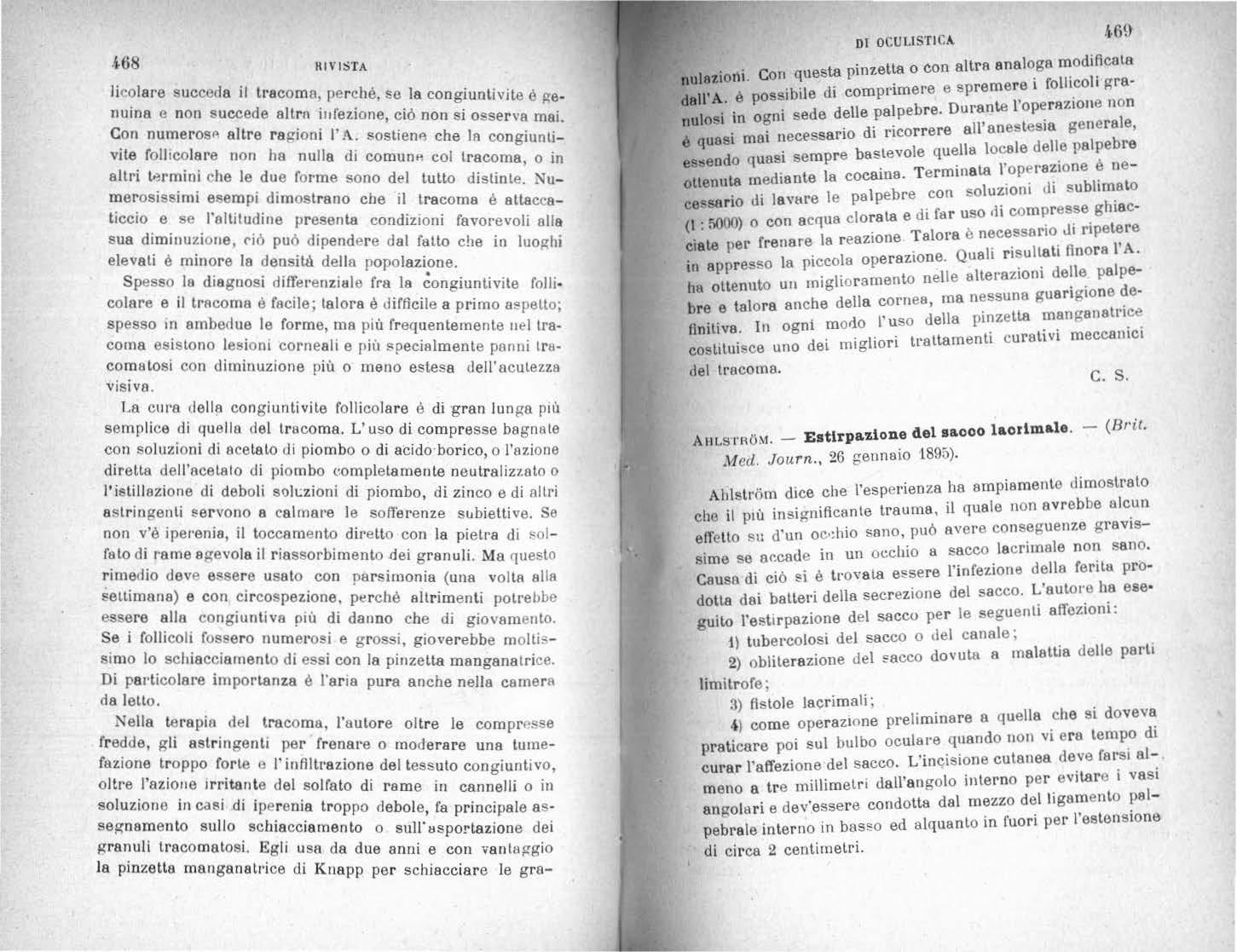
lUV!STA DI OCt:USTICA
Il sacco deve, per quanto è .. per l'infeztOne d Il asportarsi inlattf» più agevole colla prev,·a . et !:Id e.rJta : la dissezione t- resa 10 ro uz1one d' man. Una qualche difficoltà ,. una sonda di &winterna del sacco l& q" al e ads m_con tra n e l dislacco della metà · er•sce al per· l" SJ esegue meglio colle , b ' . •os •o del naso: esso . •Or •c•. Se la par t d l sottile e deve asporla . . . e e e sacco è troppe> rs1 a PICCOli p · è r aschia•·e la cavità per cl . . . ezzJ, cosa impol'tante t . 1e non v1 r 1m 1 eho. L'emorrllgia durante l'o a c una parte d'apiquietante : si doma meglio Il é alcune volle inda co tone. L"autore uc: t co e pmzette di P èan ricoperte , a re r· ll occorre \'e ne aag· •u os to !•r ofoude e se "' mnge Ulla superfl . l L" . plelata coll'obliterazione J Il . e. opera zione ocomt • e e v1e lacr1maJ 1 d' . cau eno. La cicatrice . Il . me •ante ll terrnor •su ante ò p1ccola.
RIV ISTA DELLE MALATTIE VENEREE EDELLA PElLE
Cura delle malattie della bltmato al bagno CIOn la oatatoreat d1 •umed h 00 • - K. ULMANN (w· . oc ens . e Cent r albl r . . - len. N. 12, 1895) . · J ur dte med. Wissens ch .,
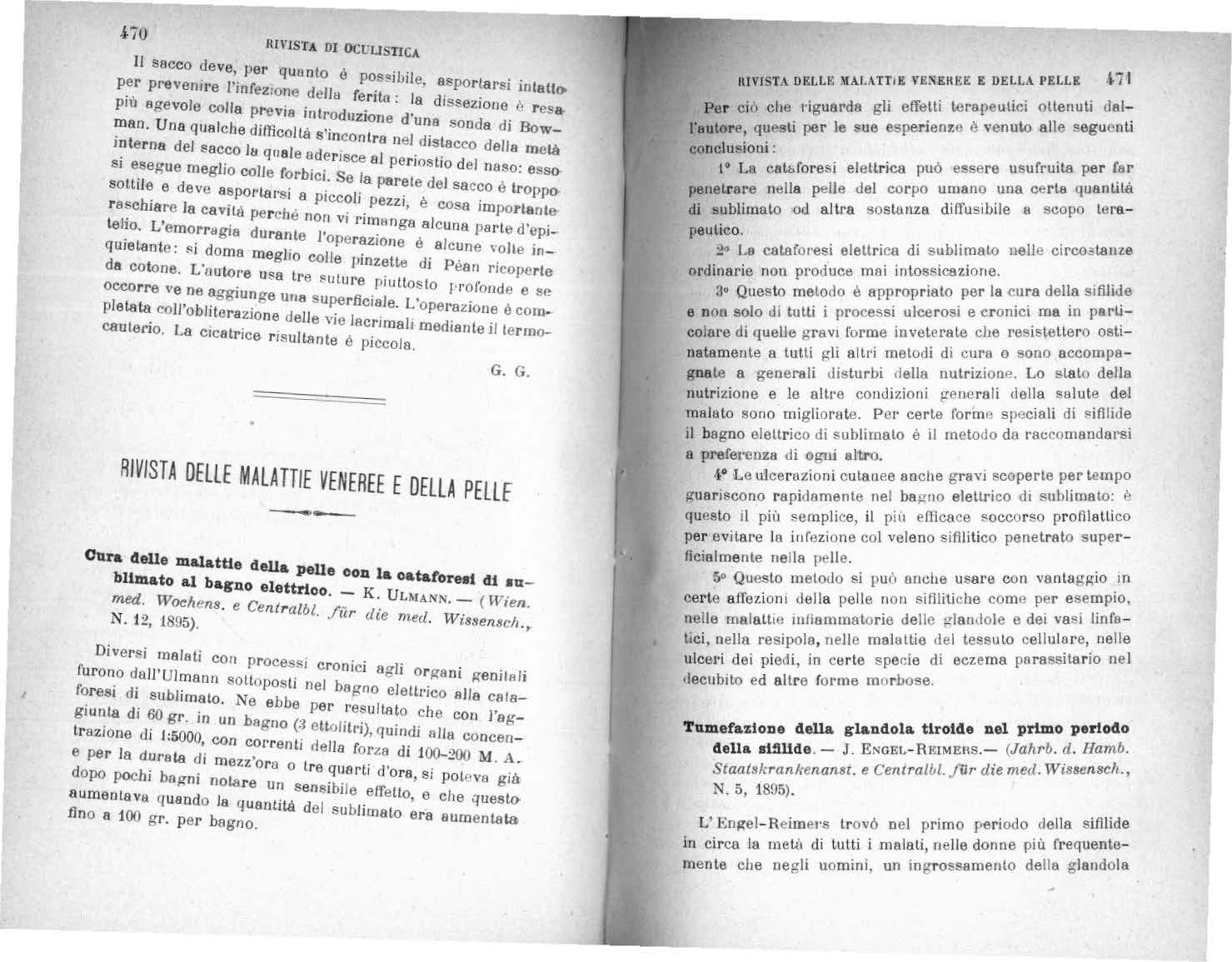
Divers· 1 • ' ma ali con processi . . . sottoposti aglt genitali forest dJ sublimato N bb agno elettrJco alla calagiunta di 60 gr ,·n . •be e e per resultato c h e con l'ag. un agno tt r . . trazione di 1:5000 co ·. e o,,,.,), fJUindi alla concen' n cot•rent• rlella r, e per la durata r ' orza di 100-20(1 M "< ' mezz ora o tre . ' . . • . dopo pochi bagni nota d ora, Sl polPva già re un senstbile etfi lt aumentava quando la quantita d . e o, e che queste> lino a 100 gr. per bagno. el sublJmato era aumenta ta
1\!VlSTA DELL E MALATTIE VENEREE E DELLA PELLE 47 1
Per ciò che l'iguarda gli effetti Lerapeulici otlenuti dall'autore, questi per le sue esperienze è venuto alle seguenti conclu!'ioni : t
• La caloforesi elettrica può essere usufruita per far penetrare nella pelle del corpo umano una certa quantità di sublimato od altra sostanza diffusibile a scopo terapeulico.
2• La catafo•·esi elellrica di sublimalo neUe ci rcos tanze ordi na1·ie non p1•oduce mai
3• Questo metod o é approp r iato per la cura della sifilide e n on solo di tutti i processi ulcerosi e c r onici me. in parlicolal'e di queUe grav1 forme inveterate che resisteUero ostinatamente a tutti gli alt•·i metodi di cura o sono accompagna le a generali dis turbi della nutrizione. Lo stato della nutrizione e le alt••e cond izioni generali clelia sa lute del malato sono migliorate. P e1· certe spc>ciali di "itilide il bagno elettrico di sublimato è 11 metodo da raccomaoda•·si a prefe1·cnza di ogni altro.
4° Le ulcernzioni cutanee anche gravi scoperte per tempo l(uar1scono rapidamente nel baguo elettrico di sublim alo : è questo il più semplice, il più efficace s occo rso pro(ì]atlico per evitare la i11rezi o ne col veleno sifìlitico penetrato superlìcialmente nella pelle.
5• Questo metodo si può anche usare con vantaggio m cert e atfezion1 della pelle non sifìlitiche per e se mpio, nelle malalt1e infiammatorie delle e dei vasi linfatici, nella resipola, uelle del tessuto cellulare , nelle ulceri dei piedi, in carte s pecie di eczema parassita r io nel decubito ed altre forme morbose.
T umefazione della glandola tiroide nel primo periodo della sifilide . - J. ENGEL-REIMERS.- (Jah r b. d. Hamb. Staatskrankenanst. e Central&l. j Ur die med. Wissensch., N. 5, 1805).
L' Engei-Re im PI'S trovò n el primo periodo della sifilide in circa la metà di tutti i maiali, nelle donne piu frequentemente elle negli uomini, un ingrossamento della glandola tirorde che poteva solo riferirsi alla silìlide. Essa con s isteva in un gozzo di medioc r e g rand ezza, o, e d era il ca!"o piu frequente, eeano solo ingrossati i lobi laterali della glandola rimanendo il medio inalterato. Sempre si trattava di tumefazione molle, affatto senza dolor•e, che non incomodava punto i maiali, la maggior pal'te dei quali neppure se ne er1111 0 accor·ti. E s!"a compariva durante il secondo periodo di incubazione o conlemporaueamonle ai pr•irni costituzionali e non pare che vi avesse al cuna inlluenza diretta il Lt·ate al pari delle tum e fazioni delle glandole lmfaltche, sr drleguava lentamente nel corso di alcuni anni ma nelle piu tarde recidive malattia non provava alcur; L'autore ceede possibile che in casi rari possa for •8 e pru tardr essere il punto di partenza di geavi malattie della tiroide e del mixedema .
Un oaso eU atrofia slmmetrloa della pelle . - F. ZrNSStm - (Arch . fur Dermat. w1<l Suph. e Cent ra lb. Jtir die med. Wissensch., N. 5, 1805).
Questo ca!"o fu oo:servt1to n ella clinica del prof. Less;er in B e rna. Una ragazzina di i2 anni aveva s;ulla faccia dor coaJe delle ma ni fino alla punta d<>llo d1la numerose chiazze lisce atrofiche prive di pigmento o di peli, quanto una lenticchia, lt1 pelle intomo sembt•uva più fortemente IJigm e nlata del normale, le unghie e ran o sottili, alquanto f'eagili con tenui solchi longiludinali. T anto sul lato dOJ•sale quanto sul palmar·o appar•ivano d el le piceole squamme, mancava ogni disturb o s;ubiettivo. Alte i·azioni d e l tullo simil1, ma p i ù gravi si lrovavaoo super·ficie dOI'Sale di entrambi i piedi; i focolar aLI'ofìCI e1·ano qui più estesi che nelle mani e mani ft•· stamente aflondali. L e uugbi e o1·ano un poco spess1tc ron molti solchi longi lu dinali e trasver·sali. La sensibrlila 1· lu motilitil er·ano normal i, non esisteva alcuna atrofia dei muscoli n t• delle ossa. L ' affezione si sviluppò in 5-6 anni senza pr·eced ente locale o generale malattia o dopo piu non cambi ò . Grà la distl'ibuzione simmetrica dell'atrofia sull'ultima parte di
OILLE \ lALATTI.E \'ENERU E DELLA PELLE
&ulle le estremitA depone per la sua o rigine nervosa, ed il eoncP-tto più probabile e quello di un disturbo centrale nel dom inio delle vie tr ofìche.
LAN Z. - Ortloarla ed lttlolo . - (Brit. Med. Journ., 26 gennaio J895).
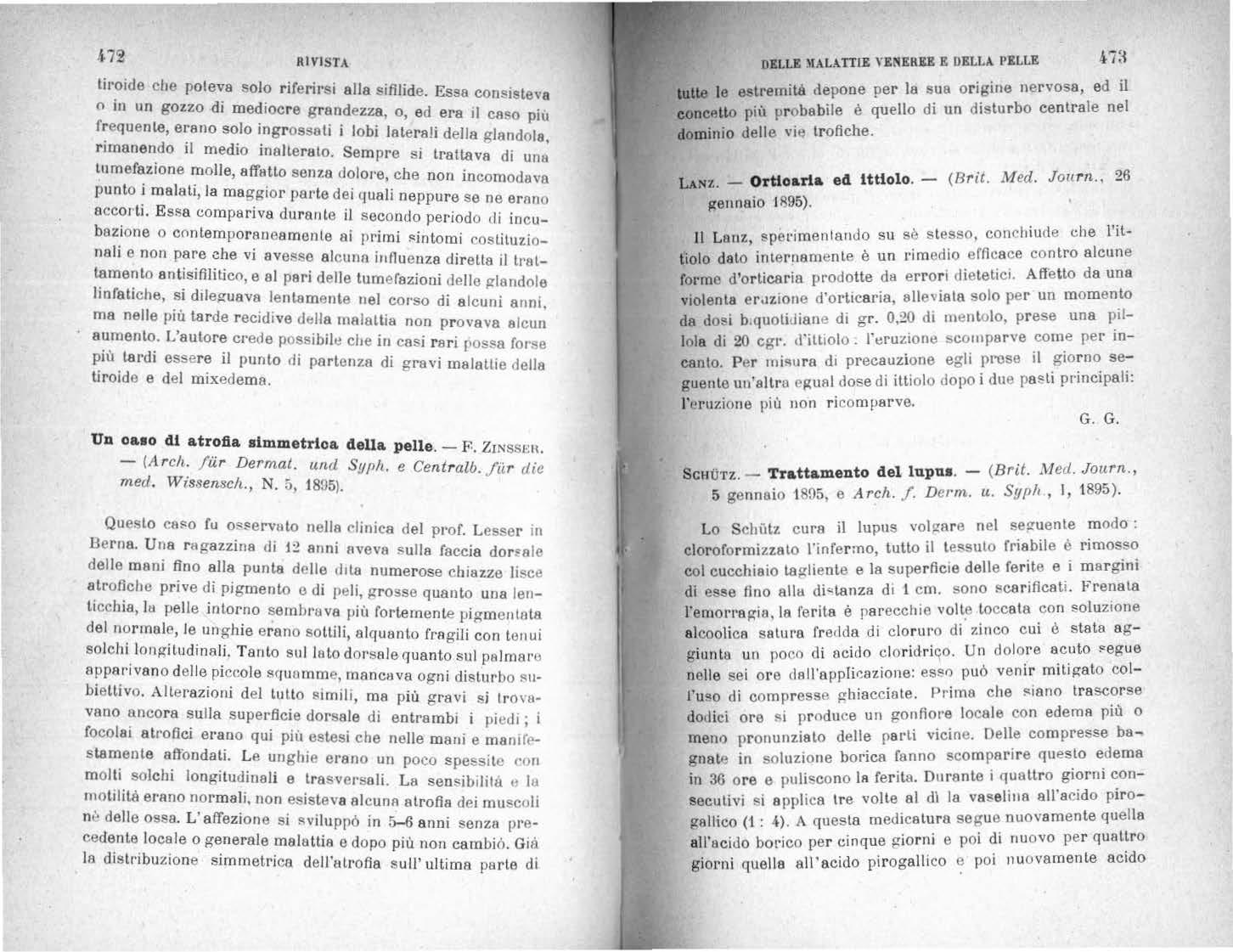
11 Lanz, sper·imenlando su sè stPsso, conrhiutle che l'iltiolo dato inle rname nte è un rimedio efficace contro alcune forme d'orticaria prodotte da error 1 diPteticJ. Affetto da una violenta er·ùzrone d'orticar ia, alle' iata solo per un m omento da dosi b.quoti Jiane di gr. 0,20 di men to lo, prese una pillola di 20 cgr·. ,J'ilt1olo . 1\:ruzr one sco111pa rve come per incarlto. Pt>r miqura di precauzione egli pt'Ose il gio rno seguente un'altro egual dose di iltiolo dopo i due pasti principali: l'1•ruzi one più non ri compaeve.
G. G.
Scu un.- Trattame nto del lupus. - (Brit. M ed. Jonrn., 5 gennaio 18!>5, e Arch. f. Der m. u. Syph, l, 1895)
Lo Schutz cura il lupus volgare n el se!l'uenle modo : cloroformizzato l'infermo, tutto il t e!'.sulo friabile è rimosso col cucchiaio tagliente e la superfic re delle ferite e i margini di esse Ono aliti di«lanza di 1 cm. sono Feenala l'emor·ragia, la ferita é paeccchie volte to ccata con soluzione al coolica satura fredda di clo rur·o di zinco cui ò stata aggiunta un poro di acido c lo ridri qo. Un dolore acuto !'egue nelle sei ore esso può venir mitigato coll'uso di compresse g-hiacciate. Prima che !'.lano trascorse dodici ore !li p r oduce un g:onflor·e locale con edemA piu o meno pronunziato delle par·Li vicin e. Delle compresse bagnai.P in soluzione borica fanno scomparire questo edema in 36 o re e pulic:cono 111 ferita. Durante i quattro giorni consecutivi sr appli ca tre volle al d\ la vaselina all'acido pir ogallico (1: 4) . A questa medicatura seguo nuovamente quella a ll'acido borico per cinque gio r ni e poi di nuovo per quattro gio1·ni quella all'acido pi r ogallico 7 poi nuovamente acido borico per tre giorni e finalmente un'ultima applicazione di acido pirogallico viene falla per due o tre alll'i giorni. La cicatr izzazione si ottiene rapidamente col iodoformio oppure con uoa pomata all'acido borico. La durata del da 2 1 /, a 3 mesi e ne derivt1 una bella cica!J'ice. Se avviene la r ecidiva si ripete il tr atta m ento. L'autore afferma che i r isulta ti oltenuli con questo suo metodo sono di gran lunga super iori a que!li avuti con qualsivoglia altro. I l trattamento è applicabile al lupus della cuttl, per quello de lla mucosa, come gengive ed ugol11, Schut.z raccomanda l'uso d'una soluzione acquosa (20 a 30 p. 100) d1 clo ruro di zinco. G. G.
Rivista Di Tera Peutica
J. Bll.LINGS. - Impiego dell'e1tratto di midollo d 'o..a..
- (Bull. John.s Hop r ins Hosp ., novembre 1tl94).
B. r iferisce sui ri;;ultati da lui ottenuti usando l'estratto di midollo d'ossti nel trattamento di varie fuc'rne d'anemia.
Il prepa rat o ch'egli usa è uu estrat Lo glice ri co ollenut(\ facendo macerAr in un r efrigec·atore per tre o quattro giorni dodici cos tole di pecora pesta te in un mortaio u quindi passate per panno. La dose impiegala era di un d J•amma (c1rca 4 g r. ) tre volle al gio r no. Le sue conclusioni sono che gli eflelli furono ottimi in due casi di clor osi ma completamente nulli nell'anemia perniciosa. Nola che l'usa del lllidollo d'ossa oon deve considerarsi analogo a ttuello dell'estrMLo di tiroide nel mixed ema, poicbè in ryuesl'ultima mal a ttia l'utrofia dPIIa glandola tiroide sugge r isce Il tentativo di supplire a r tificialmente alla defici ente sul\ sec1'ez 1one . Nell'anemia pec•nicìol'a al contral'io vi è piuttosto aumento del midollo delle ossa e inoltre la formazione dei globuli rossi del midollo Ol'seo è più una molliplicazione cellulare che una secrezione . .Kei
RIVI STA DI TERAPEliTICA
easi riferiti da altri o<>!lervalori i quali ottennero buoni eulta ti dal midollo, egli dice che la d1agnosi non fu prec1sa e inoltre s i usò contempor aneamente l'arse nico. alla clorotoi, il Billings conclude che il midollo d'ossa ag1sce pel suo contenuto in ferro ed é dubbio se e!'so l'ia più erflcace dei comuni preparati marziali: un caso di clorosi guarì colru!'. O delle pillole di Blaud perfettamente come un aiLro tratta to col midollo d'ossa.
G. G.
B uCJ{ e v ANDERLENDI::N. - Il 1alofene nelle aft'esloDi nevralgiche . - (R r rt. Med. Journ., 19 gennaio 1895).
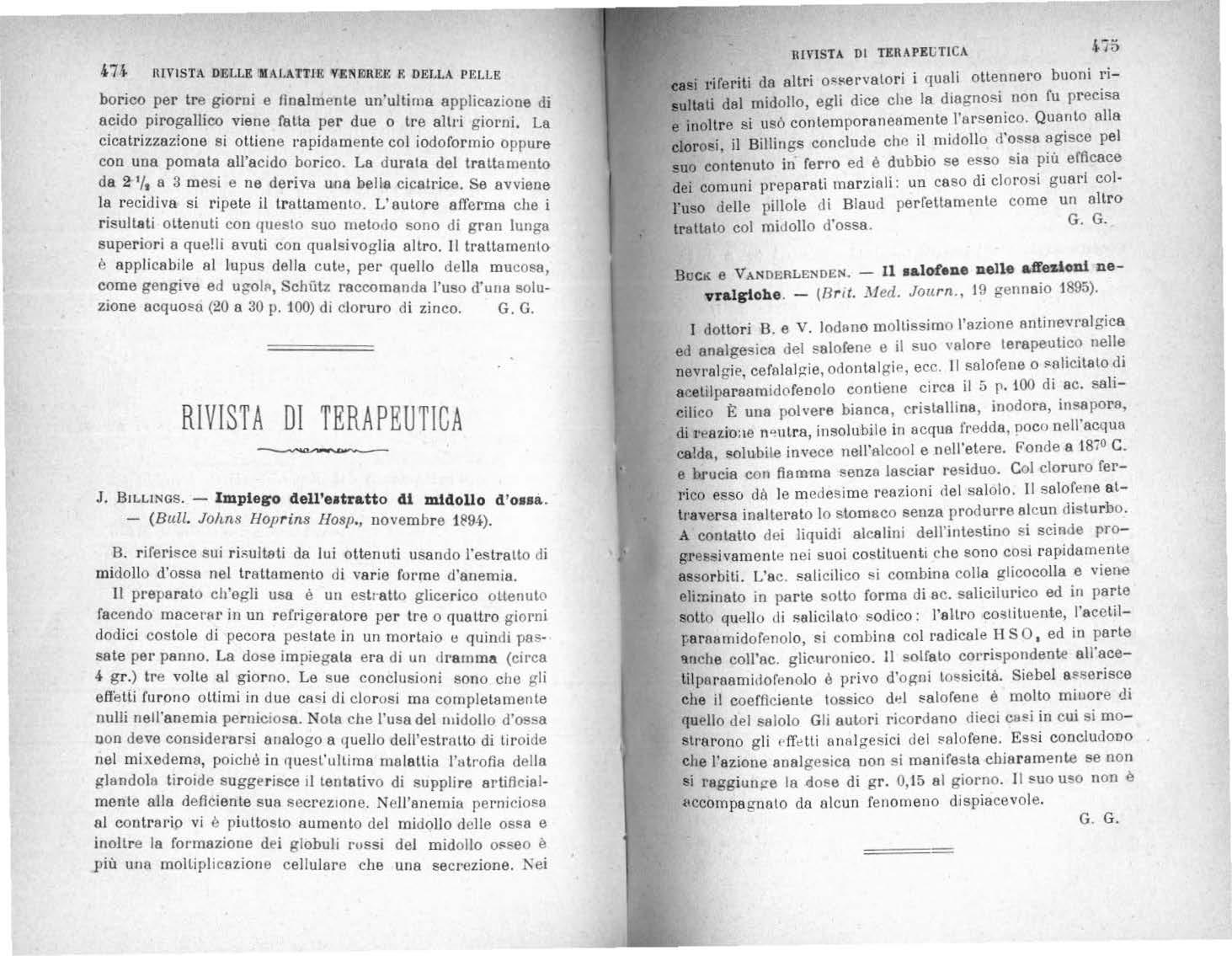
1 dotto r i B. e v. lodano mollissimo l'azione Rnlinevl'aigica ed analgesica del salofene e il suo ,.aJore nevral g ie, cefnlal:zie, odontalgiP, ecc. Il salofene o l'ahc1tato a celilparaam idofeoolo contiene circa il 5 r· iOO di . ac. sahcihco È una polvere bianca, cristallina , inodora, wsapo ra , di r t>azioae n<>ul r a, insolubile in acqua fredda, noco nell'acqua calda , solubile invece nell'al cool e nell'etere. Ponde a 18i° C. e brucia con fiamma senza lasciar residuo. Col clorur o ferric o esso dà le m edesime reazioni de l salolo. l l saloft'ne a lt c·ave r sa inallel'ato lo stomaco senza produrre alcun di-;lu rb o. A contatto dei liquidi alcalini dell'intes tin o !'i scinde progre ssivam ente nei suoi costituenti che sono cos1 r·apidamenle assor biti. L'se. salicilico 8i combina colla glicocolla e viene eli:r:inalo in pa rte solto forma di ac. salicilut'ico ed in parte sotto quell o di salicilalo sodico: l'altro costituente, l'acelilparoa midofenolo, si combina col radicale Il SO, ed in pa rte 11nche coll'se. Il solfa to c01·rispondente all'acetil parnamidofenolo è pi'ivo d'ogni Siebel &!"se ris ce che il coefficiente tossico d.,f salofene é mollo minore di qu ello del Gli autori 1·icordano dieci in cui si mosll·arono g li pffelli ana lg esici del E'alofe ne. Essi conclutlooo che l'azion e analgesica oon si manifesta chiaramente se non si la dol'e di g r . 0, 15 al gioeno. Il !.'uo uso non è da olcun fenomeno dispiacevole.
G. G.
Notizie angli stablllmentl mtutarl aanttaril deUa otttà. dl Budapest, del dott. CLAUDIO SFORZA, mHgg-iore medico.
Reale ecl imperiale ospedale della guarnigione di Butf,tJieM N. r:. - L'area totale dei fabbricati e dei giardini an· nessi i• di 3 ,600 tu q. l n t!SSa sorgono 6 grandi fsbbricati pl'incipali isolali.
L'ospedale funziona fino dal L87i, cosicché può considerar·si un ospedale moderno a padiglioni separAti.
Di f1·onte all'ingresso principa le, ad est, trovasi ti fdbbricato dell'amminislrazioue, il quale, oltt•e agli uffici amministrativi contiene la sala delle ispezioni e Lutti i locali neces<>ar·i per il servizio arnministl'ativo.
Dietro il fab bri cato olell'amministr·azione é posto il padiglione per J.!li ufficiali, nel pianter r eno del fJUale trova!"i ia farmacia e nei due pi an i soprastanti le camer•e di ammalA li da 1 a 3 letti e la sala di lettura.
Ai due lati del padiglione dt>gli ufficiali, a nord e a !"lld, ll'Ovansi due grandi padiclioni per la cura dci malat i di truppa.
Il paòiglione a sud contiene nei sotterranei le scuolt> di istr•uzione per la truppa di sanita, nel piano terreno il pet· i malati veneJ'ei e siflliti.::i; n el primo piano i locali pel' la cura delle malattie mediche, n.-1 secondo quelli per· la cura delle malattie infe ttive.
Le camere per ammalati e le rispettive sale contengono da 2 a 22 lelli; vi sono inoltre locali per bagni separati e per alcuni altri servizi accessori.
Il fabbr·icato a nord contiene nei sotterrane i il corpo di guardia ed i magazzini; nel piano ter1·eoo il riparto poi ma-
RIV ISTA Ol TRCNJCA E SERVIZIO MRDICO MILITARE 47i
lati in !'Unizione e per gli alienati; nel primo piano il riparto per le malattie chirurgiche e nel second() quello per le malattie degli occhi. Anche questo fabbricalo contiene ambienti per 2 a 22 leUi l Regiments ar zt (capitano).
Questi tre fabb r icati per ammalati non sono solamente collegali fra lo ro, ma anéhe con qnelln dell'amminist r azione, mediante co rr idoi coperti.
Dietro il padiglione per gli ufficiali trovasi il fabbricato dell e macchine con la cucina ed i bagni per gli ufficiali e p er la truppa.
Dietro ll fabbricalo delle ad ovest, eri a gran distanza da esso trovasi il padi.!thone per i cadaveri con le r elalt ve sale mortua1·ie, la cappella ed i locali per 1 gabinetti di anatomia patologica e di batteriologia. Vi è pure un locale separato per le disinfezioni.
In mezzo ai gia rdin i. fra questo padiglione e quello delle macchin e, .tr·ovasi una baracca riscaldabile per ammalali con 16 Ietti, 5 dot·mitoi in legno con so la copertura, ove dormono all'aperto per 7 od 8 mesi dell'anno i granulosi. Ognuno di ricoveri contiene 20 letli. Vt é inollre una baracca Dòcker, la ghiacciaia, ed un deposito per il carbone.
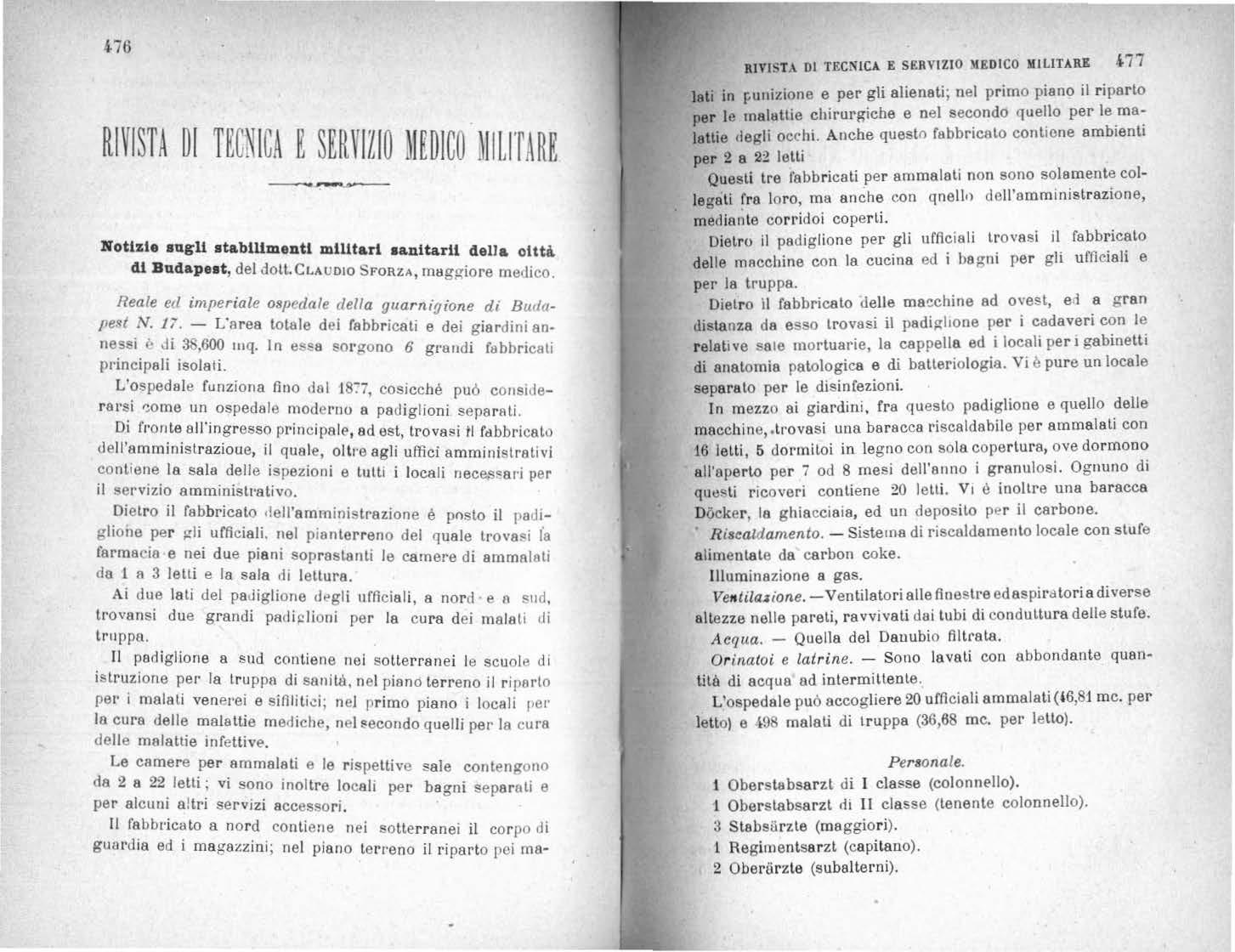
Riscaldamento. - Sist.ema di riscaldamento locale con stufe a limentate da carbon coke.
Ill uminazione a gas.
Vett tila.;ione.- Ventilatori alle fineslt·e edaspirstoria diverse altezze nelle pareti, ravvivati dai tubi di conduttu ra delle stufe.
Acqua . - Quella del Da nubio filtrata.
Or inatoi e latrine. - Sono lavati con abbondante quantità di acqua ad intermillenle.
L'ospedale può accogliere 20 ufficiali ammalati(, 6,8J mc. per letto) e 498 maiali di t ruppa (36,68 mc. per letto).
Per&onale.
1 Oberstabsar zL di I classe (colonnello).
1 Oberslabsarzl rli I I classe (Lenente colonnello).
3 Stabsurzte (maggio r i).
2 Oberurzte (subalterni).
RIVIST.\ DI TECNICA
Inoltre 3 ufficiali e H8 uomini della truppa di sanità, di più un capitano di r t>tlore di conti, un ufficiale contabile e 3 impiegali borgltesi.
Oltre i laboratori di anatomia patologica e di batlet•ioscopia, ogni r iparto ha un suo ,::rabinello particolare per le l'icerche ed osservazioni relative ai malati che vi sono in cut'fL
Ben rispondente allo scopo è il gabinetto annec;so al riparto di chirurgia per la preparazione del materiale asettico, per la sterilizzazione degl'istrumenti e per qu an to possa occorrere per medicature ed operazioni .
Anche gli altri annesl:!i ai ripat•li delle malattie degli occht e di me<iiciua, il gabinetto di èlettro-terap1a non lasc iano nulla a desiderar", ma sop rattutto ammirevole i> quello per la cura e per la protesi dentaria. È un vero gabinetto da specialista, fornito di tutti i mezzi e di tutti gli apparecchi necessari con sale di cura per solda Li, sotturtlciali, ufticiali o loro
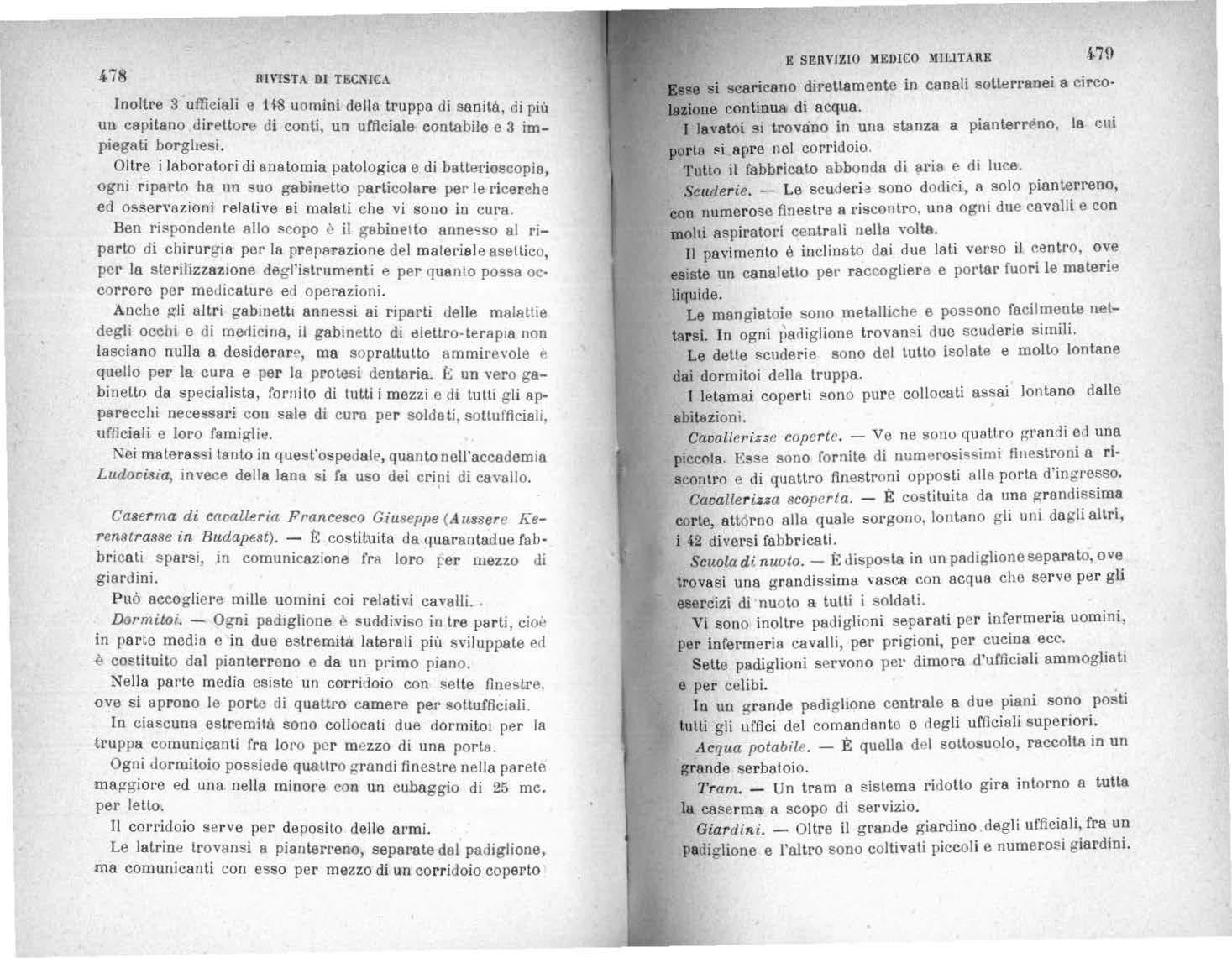
'ei materassi tanto in quesl'ospeùalt>, quanto nell'accademia invece della lana si fa uso dei cripi di cavallo.
Caserma di caoalleria Francesco Giuseppe (Ausse r e Kerenstrasse in Budapest). - costituita da quarantadue fabbricali sparsi, in comunicazione fra loro re r mezzo di giardini.
Può accoglier•e miUe uomini coi relativi cavalli. Dormiloi. - Ogni padiglione è suddiviso in tre parti, ciot'• in parte media o in due estremità laterali più sviluppate ed costituito dal pi anterreno e da un primo piano .
Nella pat•te med ia esiste un corridoio con sette finestre. ove si aprono le porto di quattro camere pe1· soltufflciali.
Io ciascuna estremilù sono collocati due dormito1 per la truppa comunican ti fra IOI'O pe r mezzo di una porta.
Ogni ùo rmitoio possiede quattro grandi finestre nella parelA ma!!'gio1'0 ed una nella minor·e con un cubaggio di 25 mc. per letto.
Il corridoio serve per deposito delle armi.
Le latrine trova n si a pianler1·eno, separate dal padiglione, ma comunicanti con esso per mezzo di un corridoio coperto
Be se scari cano direttamente in canali sot Lerranei a ci r colazione co nt in UI\ di acqua.
1 la va to i s1 trovano in una stanza a pianterréno, la r.ui por l11 t> i ap r e ne l corridoio.
Tullo il fabb r icalo abbo n da di al'ia e di luce.
S cuderie . - Le sono dodici, a solo pianterreno, con nu mer ose finestre a riscontro. una ogni due cavall i e con molti aspiratol'i centr ali nella volta.
11 pavimento é inclinato dai due lati il r.entro, esiste un canaletto per raccogliere e portar fuori le malerte liqu ide .
Le man gi atoie sono metalliche e possono facilmente n.eltar si. I n ogni pacliglione trovanc:i •iue scuderi e simili.
Le dette scuderie sono del lutto isolate e mollo lontane dai dormitoi d ella truppa.
1 letamai coperti son o pure collocati assai lontano dalle abi tazioni.
Caoall ari:u c coperte . - Ve ne sono quattro gl'andi ed una p iccola. Esse sono fornite di numerosic:sirni finestroni a r isconlro e di quaLlro finestroni opposti alla porta d'ingresso. Cavalle r izza scoperta. - È costituila da una grandissima co r te, att.Orno alla quale sorgono, loulànO gli uni daFtli altri, i 42 diversi fabbricali.
Scuola di nuoto. - C: disposta in un padiglione separato, o ve trova si una grandissima vasca con acqua che serve per gli esercizi di nuoto a tutti i soldali .
Vi sono inoltre padiglioni separati per infermer ia uomini , per infermeria cavalli, per prigioni, per cucina ecc.
S ette padiglioni servono per dimora d'urflciali ammogliati e per celibi.
In un g r ande padiglione centrale a due piani sono posLi lut ti g li uffici del comandante e <legli ufficiali superiori.
Aequa potabile. - È queUa del sottosuolo, raccolta in un gra nde ser batoio.
Tr am. - Un tram a sistema ridotto gira intorno a tutta ht caserma a scopo di servizio.
Giardini. - Oltre il grande giardino degli ufficiali, fra un padiglione e l'altt•o sono coltrvali picc oli e numerosi g iardini.
.1ccademia nlilitare Ludooiria. - Nella VIli zona della ciLtà di Budapest, in fondo alla strada tilloi-ùl ed in mezzo ad un parco di piit di 200 mila mq. di estensione, popolato da albe1·i e p1ante di ogni gran dezza e adorno di gia1·tlini e d i un grazioso la ghello artificiale, formalo da un canale del sorge un fabbricato monumeotale, a ferro di cavallo, cluu'<o, con sotterranei, pianterreno e due piani
I n. qu.esto r isiede la R. Accademia mi litare pe1• glt alltevt ufflc1alt in numero di ·360.
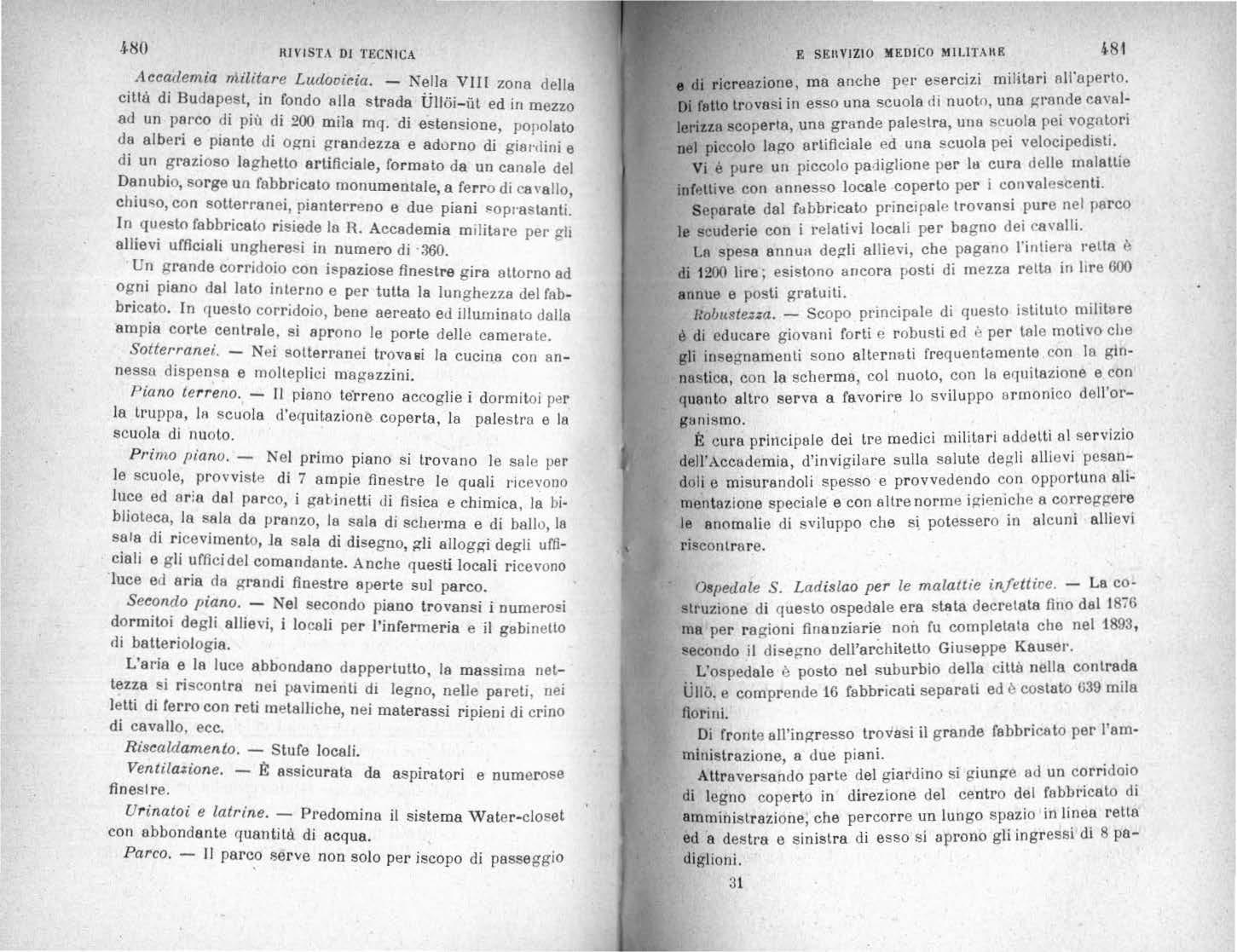
Un grande corr1doio con ispaziose finestre gira attorno ad piano dal lato interno e pe r tulta la lunghez za del fabbricato . In questo corridoio, bene aereato ed illwninato dalla ampia corte centrale, si aprono le po rte delle camet·ate.
Sotterranei. - Nei sotterranei trovasi la cucina con annesso ci ispen!IQ e molleplici magazzini.
!Jiano te rr eno. - Il piano te·rreno accoglie i dormitoi la tt·uppa, In scuola coperta, la palestra e la scuola di nuoto.
Pr imo piano - Nel primo piano si tr ovano le sale par le scuole, provvistt> di 7 ampie finestre le quali ricevono luce ed a r:a dal parco, i gabinetti tli fisica e cl1imica, la !liblioteca, la sala da pra11zo, la sala di sche1·ma e di ballo, la sala di r icevimento, Ja sala di disegno, gli alloggi degli ufficiali e gli urflci del comandante. Anche ques ti locali ricevono luce eù aria da grandi finestre a pert e sul parco.
Secondo piano. - Nel secondo piano trovansi i numero5i do rm iloi degli allievi, i locali per l'infermeria e il gabinello di batteriologia.
L'aria e la luce abbondano dappel'lullo, la massima nettezza si ri scontra nei pa,·imenli di legno, nelle pareti , nei letti di ferro con r eti metalliche, nei materassi ripieni di cri no di cavallo, ecc.
Riscaldamento. - Stufe locali.
Ventila.:ione. - 11: assicurata da aspiratori e numerose finestre.
Or inatoi e latrine. - Predomina il sistema Wate r- closet con abb ond ante quan tità di acqua.
Parco. - Il parco non solo per iscopo di passeggio
E SEIIVIZI O MIWICO MILI TA II K 4.81 e d i ricreazione, ma anche pe1· e;:e r cizi militari All'aperto . 01 fatto tr o va ;:i in esso una scuola di nuoto, una g1•ande ca,•a llerizza una grande pafec::,tra, una rei vognlori nel piccolo artificiale ed una scuola pei velociped1sti
Vi e pure u n piccolo padiglione per hl cura delle rnal.atlle in (o>llive con unnesso locale coperto per ì con valec::,cenll.
S eparate dal fubbricalo princi pale trovansi pu r e nel parco le scuderie con i relali,·i local i per bagno dei cavalli.
LA spesa annuH de::di allievi, che pagano l'intier·a r·etta P di 1200 !tre ; esistono ancora posti di m ezza retta in lire 600 annue e posti gratuiti.
Uoùuste.:.za. - Scopo principale di questo istituto militare è di educare giovani forli e robu;:li ecl i> per la le moli vo che gli ins egnamenti sono alternali frequenlamente con la gmcon la scherma , col nuoto, con lA efJuilazione e con quanto altro serva a favorire Io sviluppo 11 rm o ni co dell'organi s mo. . .
È c ut·a pr incipale dei Lre medici militari addetti al serv1z1o de ll'AcMdemia, d'invig il are sulla salute degli allievi pcsandoli e misurandoli spesso e provvedendo con opportunA alimentazione speciale e con altre norme igieniche a correggere le an o m alie di sviluppo che si potessero in alcun i allievi l padiglioni ha nno ti solo pianterreno, elevalo alquanto dal suolo e perciò dal cor ridoio si accede ad essi ascendendo meutre direttamente clai giardini si può dis cendere nei sotterranei di ciascun padiglione, ove si trovano le camere per il r iscaldamento dell'aria
Ospedale S. Ladislao per le malattie infettire. - La costruzione di questo ospedale era s t.ata decretata fino dal 1876 ma per r agioni finanziarie n on fu completala che nel 1893 , il dell'archi tello Kause1·.
L'ospedale è posto nel suburbio della cillà nella contrada Olio. e comprende 16 fabb r icali separati ed t> costato 639 mila tlorini.
Di Cronle all'ingresso lrovasi il g ran de fabbricato per l'amministrazione, a due piani.
Attrave r sando parte del giardi n o si acl un cor r1d 010 di legno coperlo in direzione del ce ntro del fabbricalo di amm inistrazione che percorre un lungo spazio in linea retta ed a dest1·a o di esso si aprono gli ingressi di 8 padiglioni.
Tipo del padiglione. - Ogni ha, in comspoudenza all' ingr·esso, uua te rrazza coperta, e provvista di numerose finestre, per convalescenti; quindi entra in uno p r ima sala di malati di 16 le tti, con finestr·e a riscontro in modo che corrisponda una finestra ad ogni due letti.
Attraversata la sala principale, s i giunge in un corridoio ove si aprono lo porte di piccole stanze per infermieri, per bagni, per vestiario e per latrine (Waler closet).
Nella parte poster·iore trovansi altre quatlro camere per malati di cui due grandi con letti, una prccola con l lello ed infine una !!ala per convalescenli. Alla estremità posteriore trovasi una terra zza sco per Ltt.
Riscaldamento. - Ad at•ia riscaldata nei soltar r anei.
Jn c iascuna sa la trovansi numerosi e grandi vPnlllatorr ctmtraJi n el ht parte mediana del c:;oflìllo, che s1 aprono con adatti spodelli di basso in allo e dall'inte r no all'esterno in modo che si può regolare a piacere la ' 'enti lazione tlel sopratletto.
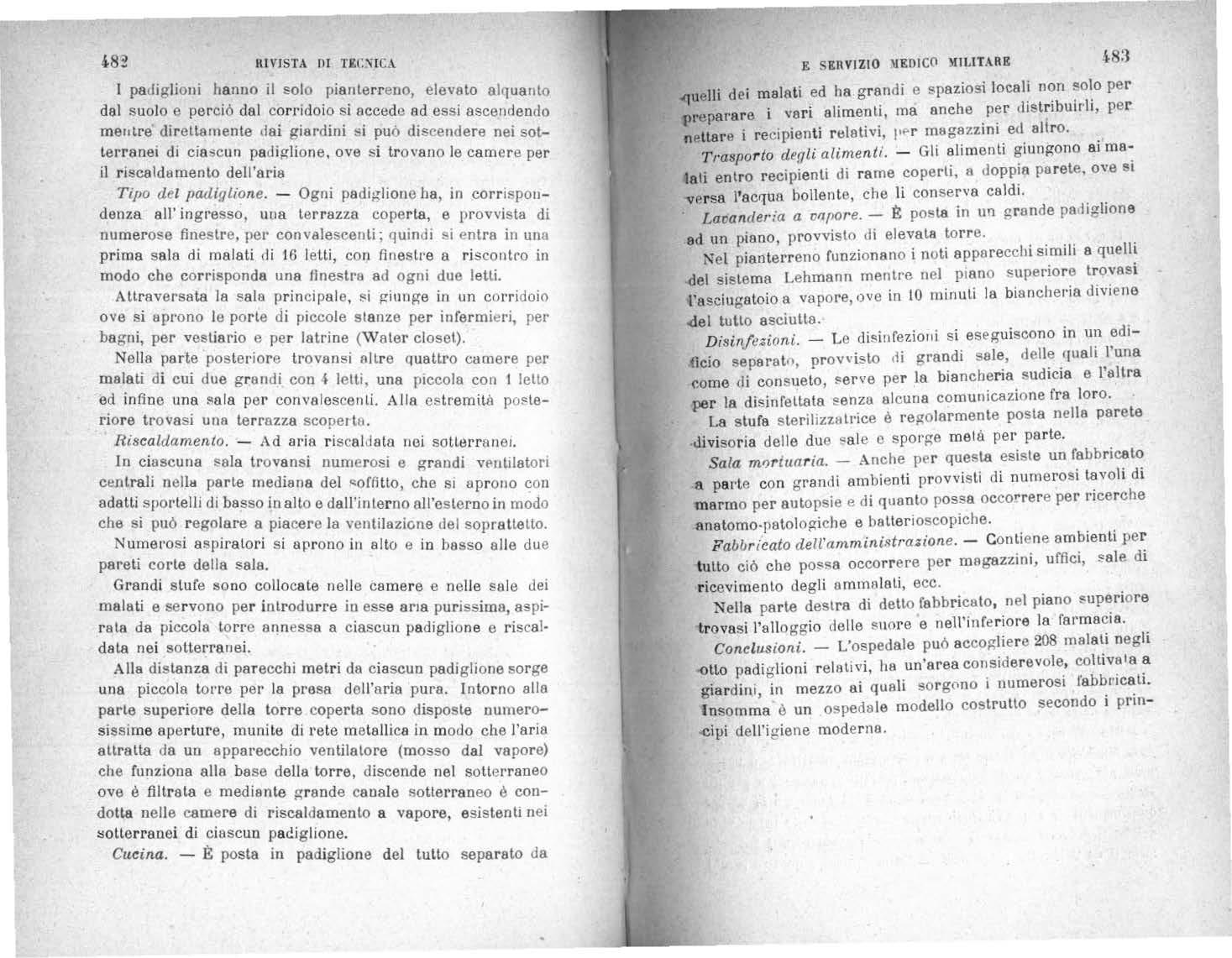
Numet·osi aspira tori si arrono in alto e in basso alle due pareti corte della sala.
Grandi stufe sono collocale nelle camere c nelle sale dei malati e servono per introdurre in esse arta purissima, aspirala da piccola tot•r•e annessa a ciascun padiglione e ris caldata nei sotterranei.
Alla distanza di parecchi metri da ciascun padiglione sorge una piccola tol"re pet• la presa doll'aria pura. l ntorno alla parte superiore della torre coperta sono disposte oumerosissime ape r ture, muni te di re te metallica in modo che l'aria attratta da un appa1·ecchio ventilatore (mosso dal vapore) che funziona alla base della tor r e, discende nel sotte rrane o ove è filtrala e mediante g r ande canale sotterraneo è condotta nelle camere di riscaldamento a vapore, esistenti nei sotter r a ne i d i ciascu n pa è.iglione.
Cucina. - È posta in padiglione del tutto separato da
E SER VIZIO VKOICCI lf iLIT ARE
41 uelli d ei ma la ti ed ha g r andi e !>paziosi per preparare i va ri ali m enti, ma anebe tlist r tbuu·h, per n t> ttare i r ecipienti r elativi, J•Pr magazzrn1 ed altro. .
Tra spo r to de[Jli alimenti. - Gli alimenti giungono 81 ta l i entr o r ecipienti di rame coperti, a do ppia parete, ove SI v Pr sa J'a crpln bollente, che li conserva caldi. . .
Lacanderia a ollpore. - È posta in un g rande padtghone ad un piano, provvisto di elevala torre. . . . . .
Nel pianterreno funzi onano i noti apparecch i Sl.mtli a sistema Lehmann mentre nel ptano superiOre trovas t a vapo1•e, o ve in lO minuti la biancher·ia drviene .del tutto asciutta.
Disinfezioni. - Lo disinfezio11i si eseguiscono in un edifi cio !'eparatn, prov,·isto di grandi sale, .r1uali ,l'una co me di consuelo , ser,•e per la biancher ia sud1c1a e l allra per la d isinfettata s enza alcuna comunicazione fra lo r o.
La stufa steriltzzatrice è posta nella parete divisor ia delle due " &le o spor·ge melA pe1· par te.
Sala mfJriuar ia. - Anche pl'r questa esiste un fabbricato 8 pa 1-te con n-randi ambienti provvisti di numerosi tavoli di marmo per e di quanto possa occorrere per ricerche anatomo patologiche e batlerioscopiche. . . .
Fabbricato - Contrene ambrenlt pe r t u llo ciò che possa occorr ere per magazzini, uffici, di r icevimento deg li ammAlali, ecc.
Nella perle destra di detto fabbr icato, npl piano trovas i J'aiJorraio delle suore e la fat•maCia.
Conelusio:t - L'ospedale può accogl iere 208 malati negli -otto padiglioni r elat1vi, ha un'area considerevole.' giard in•, in mezzo ai quali sorgono i numerosr I nsomma è un ospedale modello costrutto secondo 1 prrnei pi dell'i g iene moderna. g
SERVIZIO li.E
Il 1ervlzlo l&nltarlo nelle operazioni contro R& l llltangaaolà. .
Rela'l. i one preiU'nfala a S. H il Go ver natorP lllll;J(Jior {J(ntralf Baralitri, comanllan le il corpo tU dal lcnmte mtdico Moz:zelti do ttor Eliseo In caricalo IUtla Glore:lone del ltrviz ao lttnaltar !o.
Il corpo di operazione, che, r iunitO il 25 dicembre in Ad\-Ugri, f ece il 28 la dimostrazione su Adua e cbe dipoi, nei giorni 19 e 14 gennaio ha combattuto a Coatit contro l'esercito di Ras Mangascià, era forte di ci rc a 3800 militari indigeni con 42 graduati e soldati di truppa bianchi e 65 urtlciali italiani. Formato su tre battaglioni (2', 3· e ciascun di questi aveva al suo seguito il proprio urilciale medico (te nenti Coppola Nicola, Mozze tti Eliseo, Yirdia Tommaso), insieme al rispettivo caporal maggiore aiutante di sanità. tNottari Arnoldo, Guerrini Pietro, Volpi Antonio ). A disposizione, inoltre, dello scrivente, che era stato incaricato della direzione del servizio san itario e del comando della sezione, eran stati assegnati nove as<.-ari, scelti fra quelli clte meglio comprende\·ano
In lingua italiana e che avevano qualch e pratica del servizio speciale cui venivano addetti.
Ciò per q uan to riguarda il personale sanitario.
Quanto al materaale, ogni ufficiale medico di battaglione, oltre le borse di sanità. regolamentari, a.vea, come di consueto, portato scco. ne lla proporzione dei mezzi di trasporto di c ui al momento della parte02a egli poteva disporre, quella quantità di medicinali e di oggetti di medicazione che la sua esperienza gli faceva ritene re maggiormente necessari. Ma, piil che su altro, in caso di combattimento, ciascuno faceva assegnamento sul materiale della sezio11e dì san i t à leggiera per le truppe d' .J..frica, che venne condotta ol seguito della col onna operante.
Durante il tempo in cui il oorpo di operazione fu in campagna, non si verificarono tr oppo rrequenti le malattie di seria importanza. Parecchi e rano gli individui cbo al mattino si presentavano alla visita medica, ma la maggior parte andavano affetti, o ai piedi li be da piaghe o da a l tro lesioni esterne consimili, le q uali, a e gam , . . se richiedevano qualche cu ra non impedivano, in vio ordinaria, at pazienti di pl'('stare egualmente servizio. . .
Fra le malattie d'altra natun predominarono quelle dtpendentt da influenzo reumatiche o predominarono in modo speciale negli ascari mueulmani siccome quelli che di solito son nati e cresciuti t n regioni più calde di queliB dell'altipiano. E f1·a gli asca ri musulmani se ne mostrarono più predisposti quelli che facevano dei presidi stanziati alla costa, inquantochè essi al diverso e 1 pm freddo ambiento non aveva no potuto acquistare neppure una eggiera e temporanea acclimatazione.
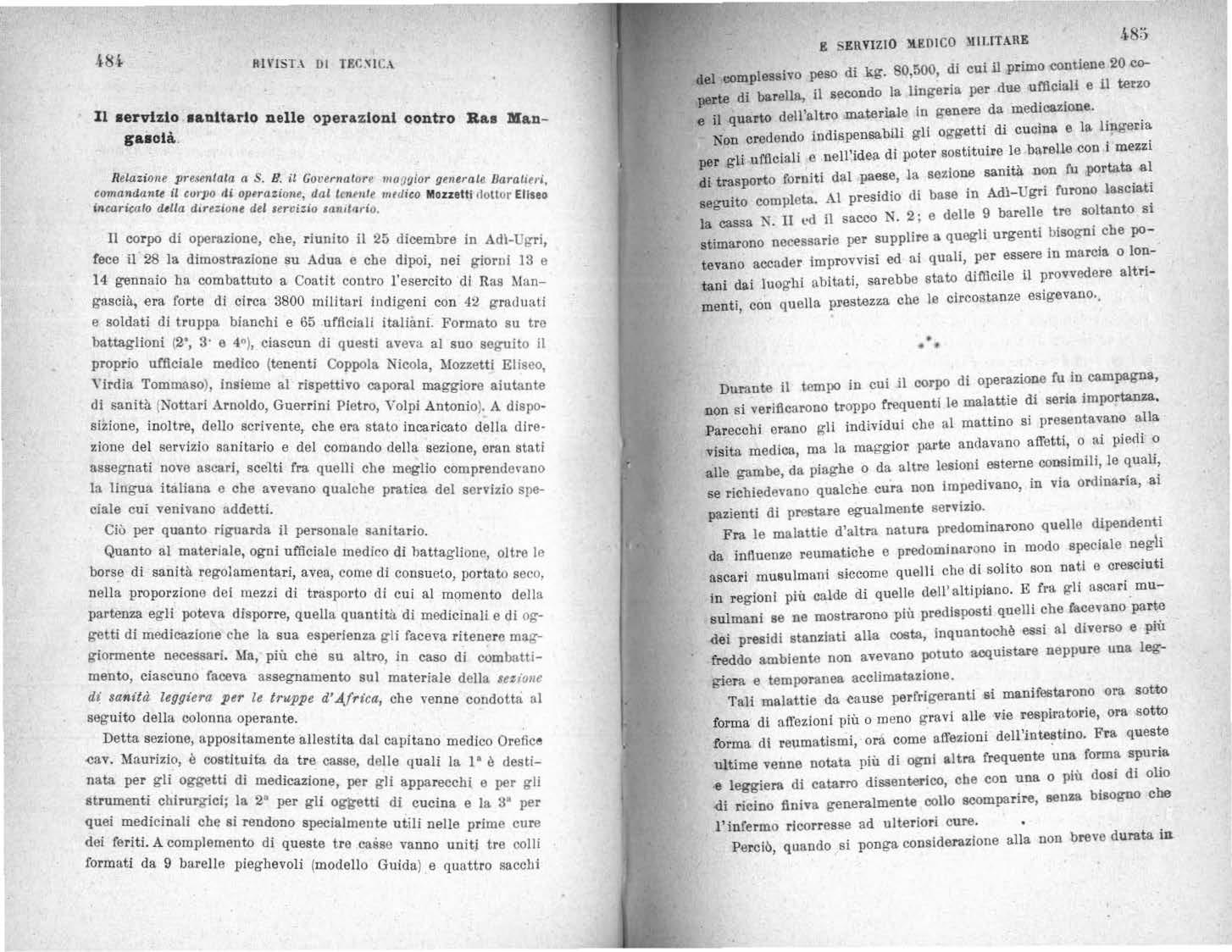
Tali malattie da cause perfrigeranti si manifestarono ora sotto forma di affezion i più 0 meno g ravi alle vie respirato rie, ora. sotto forma di reumatismi, orà come affez ioni dell'intestino. Fra ultime venne notata più di ogni altra frequente una forma e leg,.; era di cotarro dissenterico, cbe con uua o più dosi d1 olio e• b' o cbe di ricino ftniva generalmente oollo scoml)arire, senza !Sogn l'inferm o ricorresse ad ulteriori cu re. • .
Perciò, quando si ponga considerazi one alla non breve durata 111 c ui il co rpo di operazi one stette in campagna; q uando si rifletta alle lunghe e cele ri marcie che esso ha dovuto compiere e sJ consideri che, collo sbilancio di temperatura esistenti in qu esti paesi tra il giorno e la notte, le truppe han sempre bivaccato, èmestie ri concludere. che l danni nello stato di salute degli asca r i furono lnsignitlcanti e che mino r i, fo rse, non si sarebbe potuto. aspettare.
E ' IIWICO mUTAIIE .}87
rovvedano con solleci u me t d . e nel miglior dan te di compa!!,"ma, P . · gli amici commtlitom. modo, che sta loro a por a,. o del com battimento, i feriti o a Pe r tal guisa, fin dal d ti o trasportati a braccia · · mulettt de1 lP'& ua
Il corpo di opera zione che il giorno 12 aveva pernoLtato a Coatit, nel mattino del 13 mosse pe r tempo all'attacco del nemico che si vedeva accampato a pochi chilometr i di distanza.
A differenza di tutti gli altri muletti cb c po r tavano le salmerie dei reparti, i quattro della sezione si sanità non rimasero in Coatit, ma si accompagnarono alla colonna attaccante. Questo di farli seguire fu giudicato il miglior consiglio, perchè, se il nemico o non accettava tosto il combattimento o cambiaTa posizio ne o prendeva la via della fuga, il luogo dell'azione si sarebbe alquanto spostatoe non si avrebbero avuti vicini quegli oggetti di medicazione che pe r l 'occonenza era bene tener sotto mano.
Nella breve marcia d'attacco la sezione di sanità camminò fra il grosso e la riserva e, non appena fu iniziato l 'attacco, essa stabill la sua sede immediatamente dietro il poggio scelto dal Governatore comandante in capo il corpo d'operazione c donde si dominava e si osservava tutto il campo d'azione. Un posto meno avanzato, in riguardo al sistema di con1batt e re cbe sogliono usare gli A bissini, parve inopportuno, tanto più che quello scelto si raccomandava per i seguenti motivi: era in posizione centrale, si trovava abbastanza a riparo dalla fucileria nemica, si giudicava il phì sicuro, stava in prossimità della truppa ed era tosto reperibile per cbl doveva ad esso ricorrere.
Non fu preventi vamente data alcuna. circa il trasporto dei feriti dalle tlle combattenti alla sezione di sanità. llen si sapeva come i feriti leggleri, che non si sentono in grado di r imaner più a lungo al loro posto, si dirigano spontaneamente al luogo di cura, ed era del pari noto come. per quelli più g ravi, ..quand o pur la cosa sia effettuabile e nulla osti da parte del coman- pledJ o montati SUl di sanità dove fu pra. discreto n um ero alla seziOne ' afftuirono ID • ·v rovvisoria con quel materiale che, tlca ta la medicaziOne occlus i a P . disparte nello scopo l'attacco s'era messo m ' all'atte di partire pe r l' ' 'l carico dai muletti anche per d i non esser costretti a tog ; ndo i quadrupedi permanenblsogni di lieve momento. Coa ' e.ne d' poRizione era sempre . l so di cambiamento l , temente carichi, n e ca - n frappo rre indugi di sorta. . . d' - in mov1mento senz . . l porsi do n Comando, per In mtnaCCIIl Nonostan te tale prccauzJOno, quan tro spostò l e forze di de· d 1 e ico sul fianco s1ms , d i ni<'S'ira mento e n m . . d'resse all'indietro verso . d l'altura su CUI stava, SI • s tra e, lasc1an o ' t 01 metter tutti i fe riti 10 · di sani t.à occ\lpa a n Coatit, la seziOne ' 't 'tardò di appena tre o ali t arsi tosto dal BI o, n condizlom di on an Q t brevissimo e inevitabile rl· q uattro minuti la sua partenza. he pochi passi sulla via che tardo ebbe per conseguenza c ' to . quanto i due altri colleghi, · d' eguire tan IO avevano intenzwne 1 8 ' . 0 nell ' impossie uniti c1 trovamm che s'erano in precedenza a m . prefissa, avenclo dei forti bilità di più oltre procedere nella dir . . . più che pros. . l d vanti e deg.-h altri g r uppi, g r uppi di nemiCI su a ' 11 Fu in quel momento d t 0 ed anche alle spa e simi, sul l ato es r t N 1 c N. 3 cadde colpi to h tava le casse to · che il mu letto c e por 1 tto ferito non grave- che un second o mu e dal piombo neDllcO 0 d . de' colli dì cui andava ca- 'ed Ila fu""' sbarazzan OSI l mente si d1 e a ' .,,. d do il sentiero e mar- d uletti abban onan rico. l rì manenu ue rn ' rsa s u e giù per le (l' 'to in dìreztone trasve , ciando al nostro se.,m . . salvo a raggiungere, alture poterono con difficoltà me.tterst m
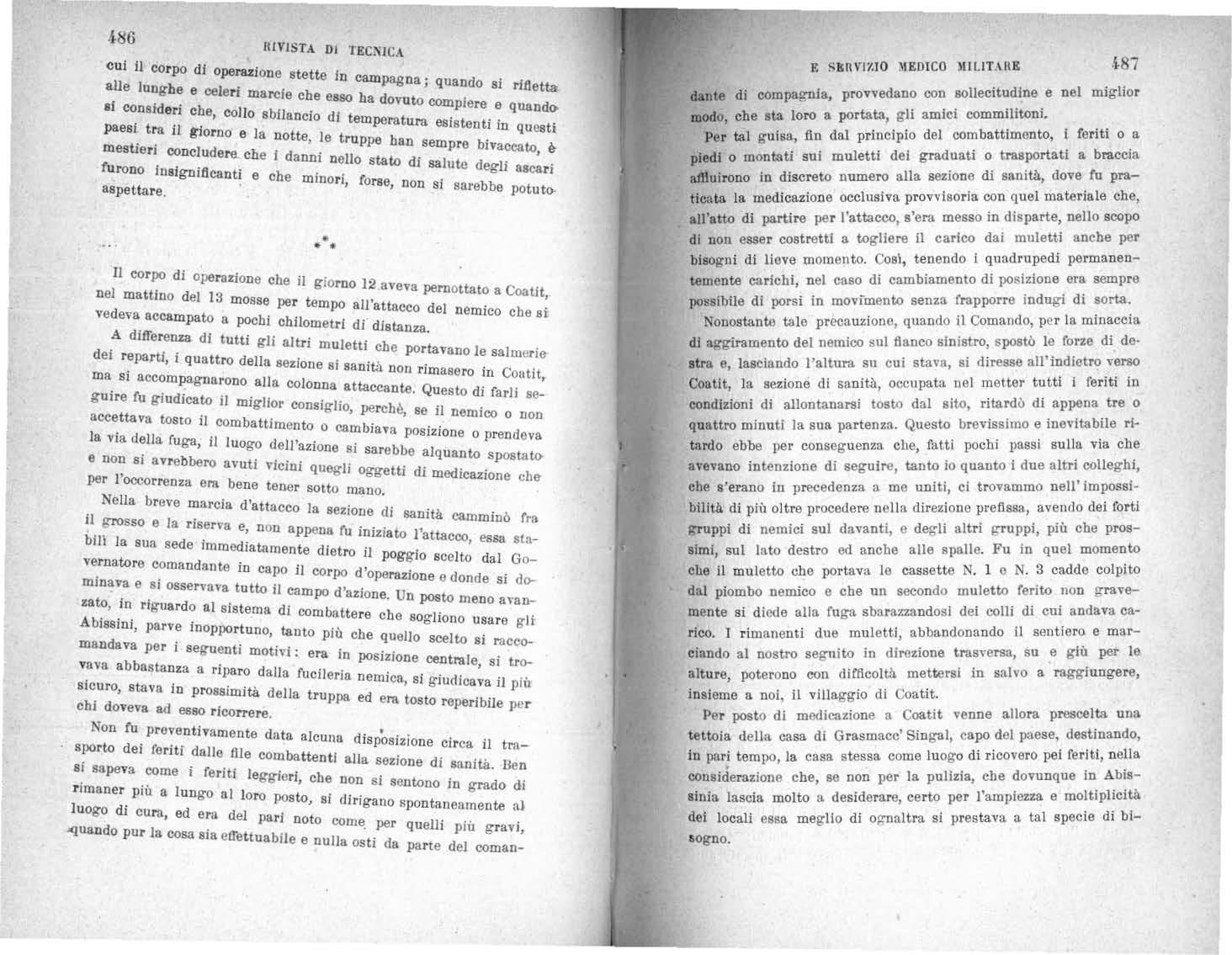
'
. .1 'llaggio dì ('oat1t. insieme a no1, J VI · . allora prescelta una · a Coat1t venne
Pe r posto di me<hcaztOne 's· ""'-l capo d el paese, destinando, tetto . ù Ila casa di Grasmacc m.,-' 't' ella 1a e di ·covero pei fer1 1, n tessa come luogo rl in pari te mpo, la casa s li . che dovunque in Abis• h se non per la pu Zia, à considerazione c e, l'a npiezza 6 moltiplicit s i oia lascia molto a desidera re, certo. per tal a a ta l specie di bidei locali essa meglio di SI pres v sogno.
I feriti, cui nei giorni 13, 14 e 15 si prestò cura, furono in totale 212, quasi tutti colpiti d'arma da fuoco. D'arma bianca se ne ebbero due o tre soltanto e fra essi va compreso il tenente Soliani Raschini sig. Vittorio, il quale presentava alla spalla destra una lesione estesa dai 6 agll 8 centimetri e cosl profonda dr\ interessare in legger gradD anche l 'osso sottostante.
Dei 212 feriti 8 e ran stati colpiti alla testa, 6 al collo, 45 al tronco, 63 alle estremità superiori e 90 alle inferiori. I fratturati più o meno gravi, ascendevano a 51, 28 del quali andavano affett{ da lesioni ossee alle eatremità inferiori.
Tenendo calcolo delle lesioni in sè stesse, i fratturati più importanti erano i 10 del femore; ma in riguardo al cattivo aspetto delle ferite, alla notevole scomposizione dci frammenti ed allo stato generale: dei pazienti, di g-ravezza sopra gli altri maggiore si presentavano coloro che, sul campo di battaglia la mattina del 15, erano stati per due giorni privi di medicazione e, per colmo di sventura, si trovarono nella dolorosa necessità di dover lottare ancora per l'esistenza, facendo tutti gli sforzi possibiii per sottra..rsi alle fiamme, a cui, per larghi tratti, erano in preda le folte ed alte erbe del luogo dove s'era combattuto nelle prime ore del giorno 13.
Tra i feriti della testa era notevole un fratturato del mascellare inferiore e fra quelli del collo uno a cui il proiettile aveva traforato la trachea. Per quest'ultimo bastò praticare, mediante sutura, l'occlusione dei fori di entrata e di uscita, perchè i gravi sintomi dispnoici dapprima migliorassero o poi nel due giorni successivi, iìnissero collo scomparire, tanto che l'infermo potè compiere il viaggio d'Asmara a cavallo di muletto.
Sui 45 militari che vt:nnero medic.'\ti per ferite al tronco, Hl avevano delle lesioni superficiali, mentro nei rimanenti 26 si riscontl·avano delle ferite penetranti in cavità. Durante i primi tre giorni si verificarono 2 decessi per f!)rite al torace e tJ per ferite penetranti all'addome. Fra gli ul timi stan compresi i tenenti Sanguinati Glo. Battista e Scatrarotto Giovanni, dei quali il primo pre-sentava il forarne di entrata del proiettile nella regione ipoga.strica destra e nel secondo si rilevava lo stesso forarne di entrata sulla linea mammellnre della regione toracica destra, a quattro dita traaversa sotto il capezzolo.
La morte del Sanguinati avvenne per lesione dell'intestino, lesione che, anche prima del rapido insorgere dei sintomi ca.ra.tterlsUci, si riteneva. probabile in riguardo al tragitto del 'Proiettile cbe aveva il suo foro di uscita in corrispondenza della regi one iliaca deltra. Allo Scalfarotto fu praticata l'estrazione del proiettile postcriol'JPente nella regione lombare destra, cosiccllè la morte deve esser stata causata da una lesione più o meno estesa del fegato.
Dopo la medicazione occlusiva degli individui che, come si è dianzi detto, richiesero soccorso sul campo di battaglia, la prima medicatura al sublimato e jodoformio, fatta da me e dagli altri colleghi riuniti nello stesso locale, venne eseguita su tutti i feriti con quella maggior diligenza che le circostanze di luogo e di tempo permettevano. Malgrado la perdita della parte migliore della sezione, il materiale sanitario fu nel primo giorno e anche nei successivi sempre sufficiente, essendo i rifornimenti arrivati sempre a tempo, puntualmente e in larga misura.. Perchè, caduto nelle mani del nemico, fece soltanto difetto il materiale per gli apparecchi contentivi di immobilizzazione e il sostituirlo alla meglio con i mc;zzi li per Il improvvisati costò qualche fatica e m>n lieve dispendio di tempo.
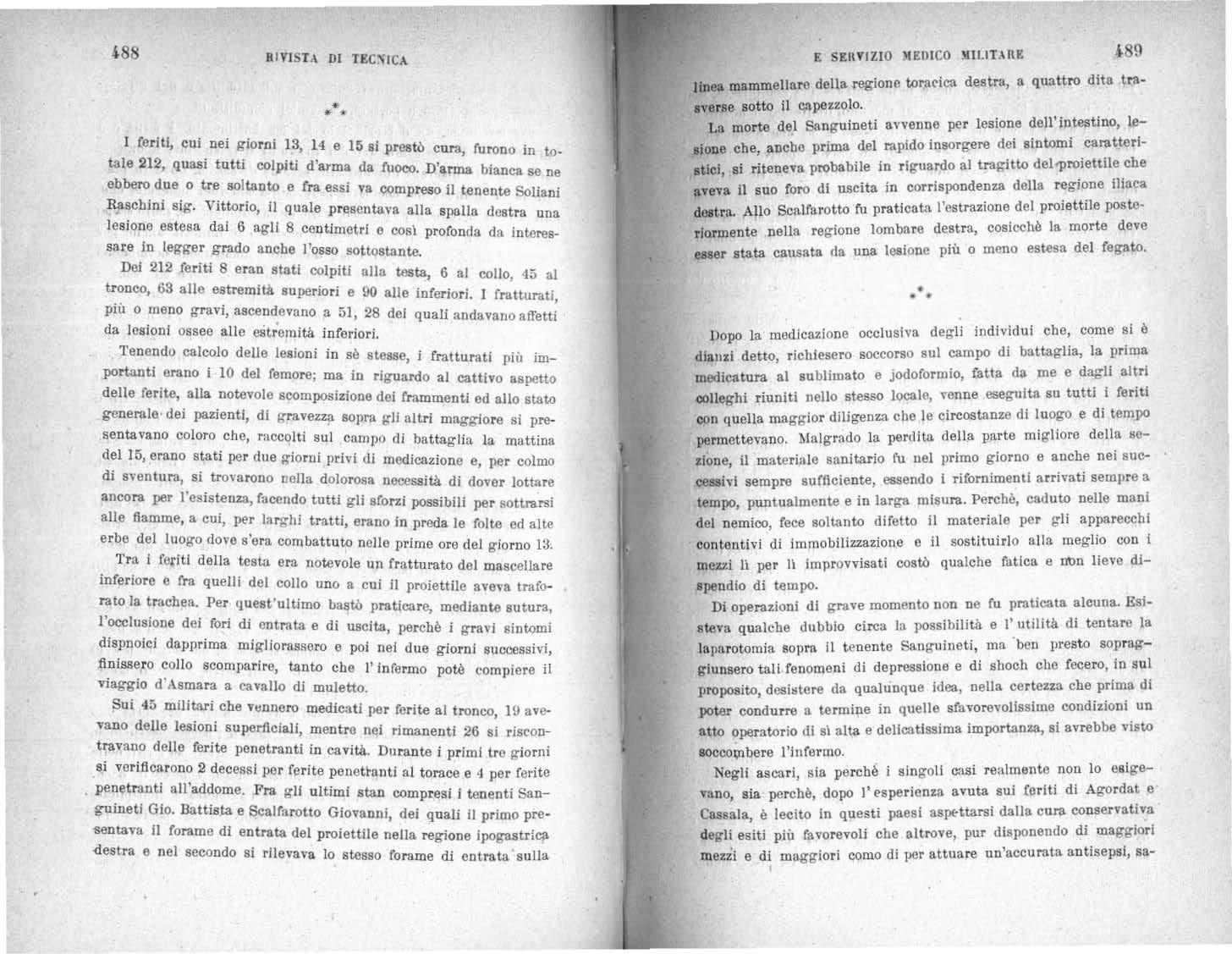
Di operazioni di grave momento non ne fu praticata alcuna. Esisteva qualche dubbio circa la possibilità e l'utilità di tentare la laparotomia sopra il t ene nte Sanguinati, ma ' ben presto sopraggiunsero tali fenomeni di depressione e di sboch che fecero, in &Ul proposito, dcsit!tere da qualunque idea, nella certezza che prima di poter condurre a termine in quelle sfavorevolissime condizioni un atto operatorio di sl alta e delicatissima importanza, si avrebbe visto 80CCOQ1bere l'Infermo.
Negli ascari, sia perchè i singoli casi realmente non lo esigevano, sia perchè, dopo l'esperienza avuta sui Ceriti di Agordat e Cassala, è lecito in questi paesi aspt-ttarsi dalla c ura conservativa degli esiti più favorevoli che altrove, pur disponendo di maggiori mezzi e di maggiori como di per attuare un'accurata antisepsi, sa- rebbero, credo, insperati, anche nelle l'ratture più complicate, non venne proposta la demolizione del membro, limitando il ufficio all'asportazione delle scheggia ossee e ad una disinfezione per tanto più scrupolosa, per quanto più grave appariva la. lesione:
In confronto degli altri due combattimenti testè ricordati, in questo di Coatit non s'ebbe a praticare che pochissime estrazioni di proiettili. Le ferite, complicate o meno a frattura., si presentanno quasi tutte a canale completo e sol rarissime erano quelle a fondo cieco. Ciò che mi fa dedurre come il munizionamento dei soldati di }.fangascià fosse per qualità superiore a quello dei dervisci.
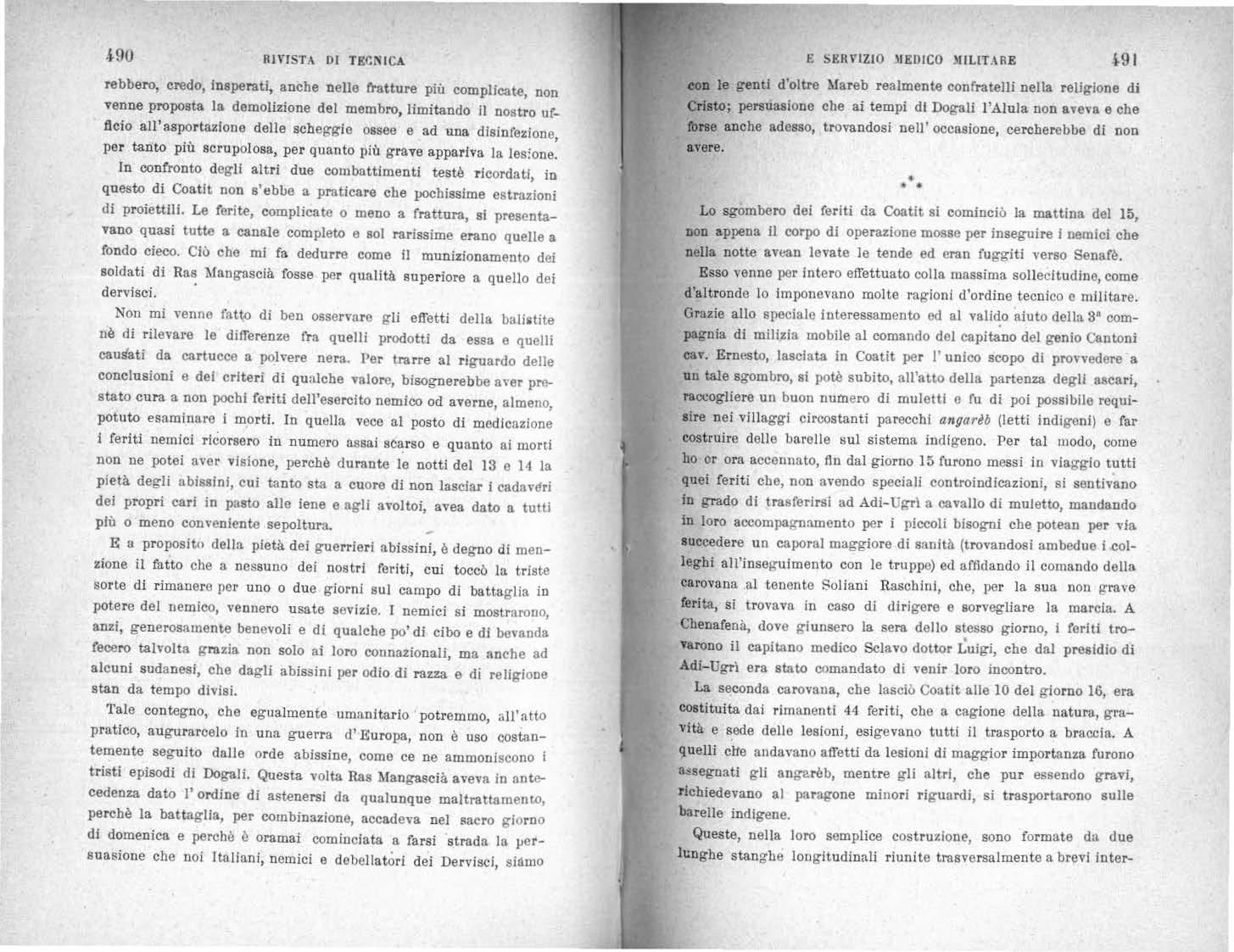
Non mi venne fatto di ben osservare gli effetti della bali&tite nè di rilevare le dilferenze fra quelli prodotti da essa e quelli causati da cartucce a polvere nera. Per trarre al rigu ardo delle conclusioni e dei criteri di qualche valore, bisognerebbe a'er prestato cura a non pochi feriti dell'esercito nemico od averne almeno , l potuto esaminare i morti. In quella vece al posto di medicazione i feriti nemici rièorsero in numero assai e quanto ai morti non ne potei aver visione, perchè durante le notti del 13 e 14 la pietà degli abissini, cui tanto sta a cuore di non lasciar i cadavE!ri del propri cari in pasto alle iene e agli avoltoi, avea dato a tutti più o meno con\'Cnlente sepoltura.
E a proposito della. pietà dei guerrieri abissini, è degno di menzione il fatto che a nessuno dei nostri feriti, cui toccò la triste sorte di riman ere per uno o due giorni sul campo di battaglia in potere del nemico, vennero usate sevizie. I nemici si mostrarono, anzi, generosamente benevoli e di qualche po' di cibo e di bevanda fecero talvolta grazia. non solo ai loro connazionali, ma anche ad alcuni sudanesi, che dagli abissini per odio di razza e di religione stan da tempo divisi.
Tale contegno, che egualmente umnnitario potremmo, all'atto pratico, augurarcelo In una guerra d'Europa, non è uso costantemente seguito dalle orde abissine, como ce ne ammoniscono i tristi episodi di Dogali. Questa volta Ras Mangascià aveva in nntl'cedenza dato l'ordine di astenersi da qualunque maltrattamento, perchè la battaglia, per combinazione, accade,·a nel giorno di domenica e perchè ò oramai cominciata a farsi strada la. versuasione che noi Italiani, nemici e debellatÒri dei Dervisci, siamo eon le genti d'oltre Mareb realmente confratelli nella religione di Cristo; persuasione che ai di Dogali l'Alula non aveva e che tbrse anche adesso, trovandosi nell'occasione, cercherebbe di non avere.
Lo sgombero dei feriti da Coatit si cominciò la mattina del 15, non &p pena il corpo di operazione mosse per inseguire i nemici che nella notte avean levate le tende ed eran fuggiti verso Senafè. Esso venne per intero effettuato colla massima sollecitudine, come d'altronde l o imponevano molte ragioni d'ordine tecnico c militare. Grazie allo speciale interessamento ed al valido aiuto della s• compagnia di milizia. mobile al comando do! capiW:no del genio Cantoni cav. Ernesto, lasciata in Coatit per l'unico scopo di provvedere a un tale sgombro, si potè subito, all'atto della partenza degli ascari, raccogHere un buon numero di muletti c fu di poi possibile requisire n ei villaggi circostanti parecchi anga1·èò (letti indigeni) e far costruire delle barelle t;Ul sistema indigeno. Per tal modo, come ho or ora accennato, fin dal giorno 15 furono messi in viaggio tutti quei feriti cbe, non a.vendo speciali controindicazioni, si sentivano in grado di trasferirsi ad A.di-Ugrì a. cavallo di muJetto, mandando in loro accompas.,"'lamento per i piccoli bisogni che potean per via succedere un caporal maggiore di sanità (trovandosi ambedue i colleghi all'inseguimento con le truppe) ed affidando il comando della carovana al tenente Soliani Raschinl, che, per la sua non feri ta, si trovava in caso di dirigere e sorvegliare la marcia. A Cbenafenà, dove giunsero la sera dello stesso giorno, i ferili troYa rono il capitano medico Sciavo dottor Luigi, che dal presidio di Adi-Ugri era stato comandato di venir loro incontro.
La seconda carova.ua, che lasciò Coatit alle 10 del gio rno 16, era costitui ta dai rimanenti 44 feriti, che a cagione della natura, graVità e sede delle lesioni, esigevano tutti il trasporto a. braccia. A quelli clte andavano affetti da lesioni di maggior importanza furono a:.segnati gli ange.rèb, mentre gli altri, che pur essendo gravi, r ichiedevano al paragone minori riguardi, si t rasportarono sulle barelle indigene.
Queste, nella loro semplice costruzione, sono formate da due lunghe stanghe lougitudinali riunit o trasversalmente a brevi inter- valli da baston.i della lunghezza di un cubito. Quando gli infermi vengano su di esse ben assicu r ati con legacci non si prestano troppo male ai trasporti, e benché, trovandosi nel caso fortunato di poter scegliere, si debba in via ordinaria accardar sempre la preferenza agli angarèb, pur tuttavia n elle barelle in parola non bisogna disconoscere il vantaggio di esigere una minor quantità di po r tato ri o di trovar, grazitl alla loro poca larghezza, facile passaggio per i ristretti sentieri che fa d'uopo qui percorrere. Sono, poi, do' unque, da. tutti e presta mente fattibili.
La marcia di questa seconda carovana procedette piuttosto lentamente, a cagione dello scarso numero di portatori che mancavano dj ricambio e a cagione dei riguardi dovuti agli infermi che· per la maggior parte e r ano fratturati o oon lesioni interne. Ad Adis-Adi, distante un ora di cammino da Chenafenà, non si fl'iunso che verso il tramonto e quindi si decise di pernottarvi. Nel matdel 1'7, approfittando d ella luna in pieno, ci mettemmo in via assai per tempo ed in quel giorno, per il concorso di nuovi portatori, l a carovana potè marciare più spedita, arrivando ad AdiUgrl verso le ore 16.
Du r ante il viaggio di circa 60 chilomet ri, da Coatit ad Adi-Ugri, non si ebbe alcun decesso nè si verificò alcun serio inconveniente. Le due carovane fe r iti percorsero un terreno privo di strade (sE> con tal nome oi rlreriamo a quelle che cosi chiarnansi in Italia, permanentemente montuoso, che presentava dei passaggi ora malagevoli per la. loro ripidità. e ristrettezza, ora intricati dalla vegetazione, ora Rolo appena adatti per individui che potassero marciar e isolati. Gli infermi ciù nonostante n on muovevano lamenti e non mostravano neanc h e di provar sofferenze. Ma un siffatto relativo benessere, più che alla. in sè s tessa dei mezzi di traobe alla destrezza ed abilità d e i portatori, più che alle attenztom di chi li accompagna va, ritengo indubbiamente si deva attribuire alla tolleranza ed insensibilità speciale, di cui in genere godono gli indigeni di queste regioni.
Dal presidio di Adi-Ugri, dopo uno o du o giorni, di riposo e dopo una dili gente e, in proporzione dei maggiori mezzi, anche più appropriata medicatura, fatta in unione dei colleghi capitano Sciavo e tenente Gi melli, i feriti sgombrarono nei giorni 18, 19 e 20 al luogo d i !or stabile cura in Asmara. Quivi se non erro, giunsero in numero d i soli 154, essendosi accordato il permesso ad alcuni ascari affe t ti da lesioni insiguitl.can ti di rimanere alle loro compajl'llie e non avendo potuto esimersi dal non aderire alle insistenti d omande di parecchi famigliari dei gregari delle bande assoldate, i qua li vivame n te desiderarono di tener vicini e presso di loro in cura i propr i congiunti, invece di farli entrare alla nostra lontana infermeri a, dove, a cagione della distanza, ben di rado avrebbero potuto visitarli e dividere, in certo qual modo, seco loro le pene del male.
RIVI STA D 'I G I E NE
Kuov a atufa per dlalnfezlone a. olrcola.z lone d ' una oorre nte dt vapore aotto pre11lone, dei doltori VAILLARD e B essoN. - (Reoue r. 8, 189.l).
1J dottp r Vailht r d pr ofessore a lla Scuola d el Val-de-GrAce, ed il do tto r Besson addetto al labor·alor io di batte ri ologia della scuola medesima, partendo dal concello c h e la circolazion e di una correnle di va pore solto pr·essione è il più si curo di tutli i mez:.d di disinfezione, l>i s ono proposti d i tro vare la forma più semplice per costrurre una s tura basand osi a ppunto sul principio sov r aenuncialo.
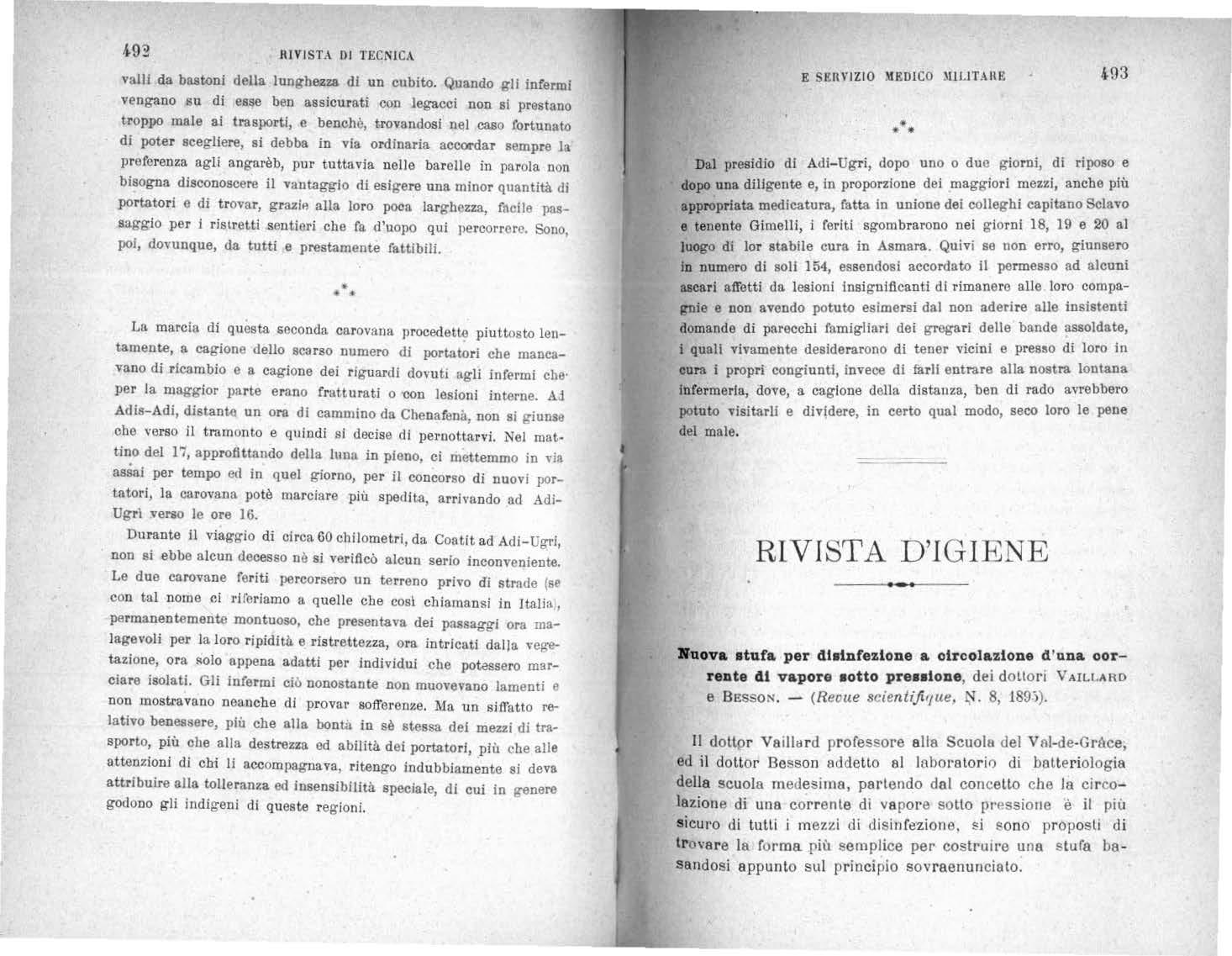
D'IGIENE
Es!>i riescirono egregiamente nel loro intento colla stufa di ora ci la quole hll i seguenti preg i: maneggto efficacia certa, funzionam ento Cfuasi che escluùe f]Ualsiasi errore e pericolo, prezzo ml ltss•mo.
L'apparecchio si co mpone di due parti distinte e separabili : a) il fo r nello in lamiera contornato da terra refrattaria che forma uno zoccol o su cui posa la stufa; , b) la pt•r.p riamenle detta in lamiera di acci aio ga l· che comp ren do nello stesso corpo il generato r e dt vapor e e la camera di
L'apparecchio che nra descriviamo ha nel suo in..,ieme la forma verticale, mi\ può esse1·e d1 forma e dimensione ehver sa, e secondo la sua destmazione puo esse r e fisso o locomobile.
Non potendo riprodurre su questo gio rnale le flgure illustroti,·e, invece di una descrizione dettagliata, ci limiteremo a dare un'idea schematìca di questa stufa la quale é d'una g rande semplicilà.
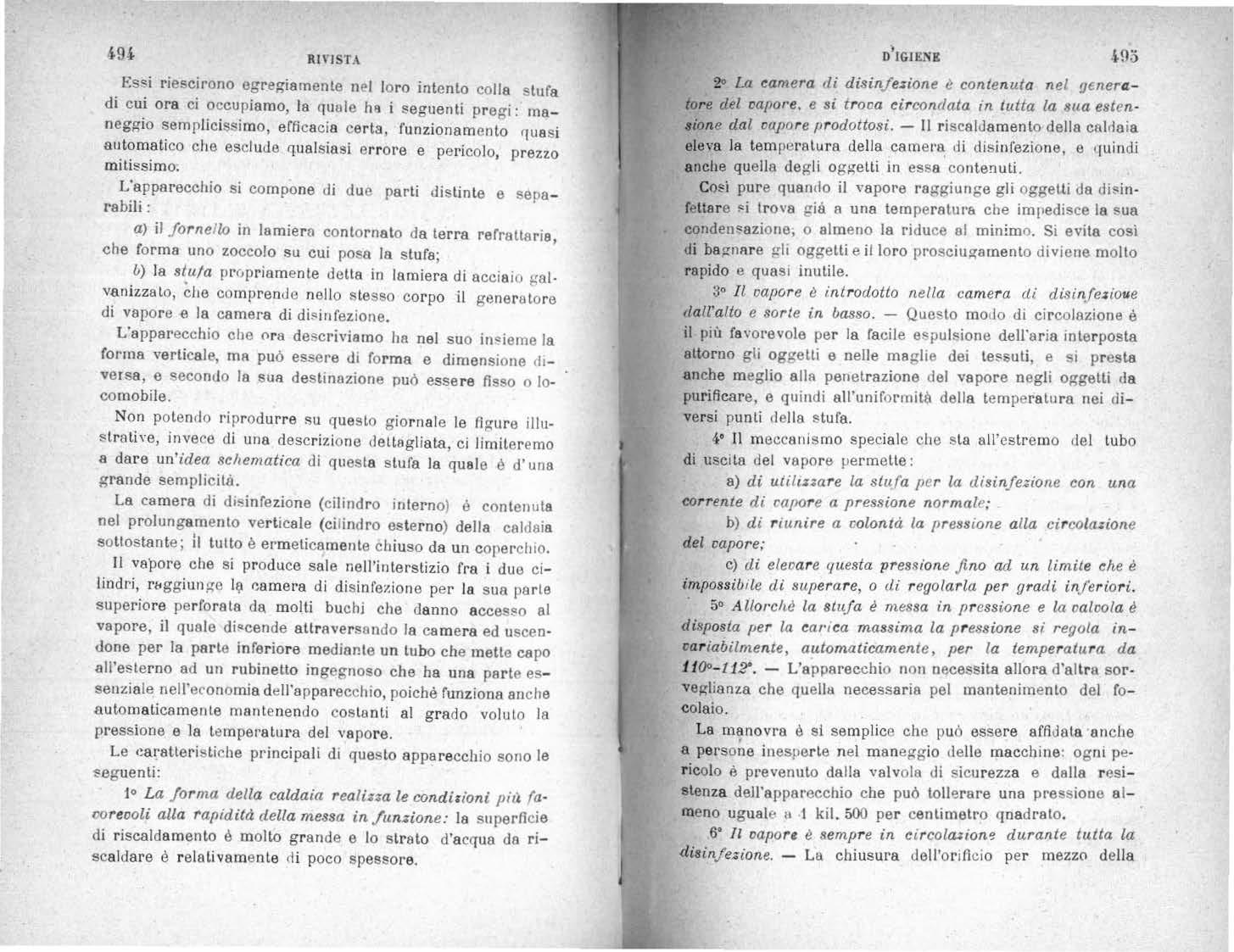
La camera di (cilindro interno) è contenuta nel prolungamento verticale (ci li ndro es terno) della caldaia sottostante; il tutto è e•·meticamente chiuso da un coperchio.
Il va}:lore che si produce sal e nell'interstizio fra i due cilindri, rttgg iun::tc r.amera d i disinfezione per la sua parte superiore perforata da molti buchi che danno accesso al vapore, il quale di"cende altrl\v er sando la ca m era ed uscendone per la parte inferiore mediar.te un tubo che melle capo all'esterno ad un rubinetto ingegnoso che ba una parte senziale nell'eco nomia dd l'apparecchio, poichè funziona anche automaticamente mantenendo cos tanti al gr ado voluto la pressione e la del vapo r e.
L e earatteristiche principali di questo appare cchio sono le
1° L a forma della caldaia realiz:a le condi rioni pitì. (acoreooli alla rapidità della messa in fu nzione: la superficie di riscaldamento é molto g r ande e lo strato d'acqua da riscaldare é r elativamente òi poco spessore .
20 La camera di disinfe.:ione è conlemda nel acner tttore del oapore. e si t ro oa ci rcondata in tutta la 11ua est ension e dal oapo r e p r odottosi. - Il riscaldamento della caldaia eleva la tem per·atu r a dell a came 1'a di disinfezione, e quindi anche qu ella degli oggetti in essa co ntenuti.
Cosi pure quando il Yapore raggiunge gli oggeUi da fettare !'i trova gia a una temperatura che impedisce la sua o almeno la riduce al min!mo. Si evita così di ba gnAr e {.:'li oggetti e il loro prosciugamento diviene molto rapido e quas1 inutile.
3• Il vapore è ;n.t r odotto nella ca mera cti disin..fe::io ue dall'a lto e sorte in. basso. - Que.,to modo di circolazione é il più favo•·evole per la racile ec;pulsione dell'aria JOterposta attorno gli oggetti e nelle maglie dei tessuti , e si pr esta anche m eglio alla penetrazione del vapore negli oggetti da purificare, e quindi all'uniforrnit$ della tem peratura nei diversi punti della stufa.
4• Il m eccauismo speciale cho sta all'estremo del tubo di uscita del vapore permette: a) di utilt:z.:are la p er la disinfe:;ione con una co rrente rli rapo r e a pressione normale ; b) di r iunire a oolonlà la pressione alla ci r colazione del vapore; c) rli eleva r e questa pressione fino ad un limite che è imp ossibile di supe rare, o eli r egola rla per gradi infe r io r i.
5° A llorchè la stnja è messa in pressione e la calcola è dispos ta per la cari ca massima la p ressione si regola inca r iabilmente, automaticamente, per la tempe r atu r a da fl {}o- 1 1.2". - L'apparecchio non necessita allora d'al tra so rv eglianza che quella necessaria pel mantenimento del focolaio.
La é si semplice cho può essere affidala anche a persone inesperte nel maneggio delle macchine· ogni pericolo è p!'evenulo dalla valvola di sicurezza e dalla r esistenza dell'apparecchio che può tollerare una pressione a lmeno uguale- u l kil. 500 per centimell'o qnadrato.
6• ll oapore semp r e in durante tutta la <lisinfe::ione. - La chiusur a de ll'orJftcio per mezzo della valvola non è infatti lalmt>nte er•metica ùa non dare alcuna uscita al vapore; que«lo esce sempre, debolmente in principio, p1ù abbondantemente in seguito, in modo da una corrent.., il che l'efficacia della stufn. Infatti tutti gli studi fatti sulle di$infezioni hanno st.abililo che l'espulsio ne dèll'aria conten uta n egli oggetti t'Osliluisce un fallo essenziale, poiché la pr esenza ddl"ar·ia ost.acola la perwtro· zione del va po r e, e l'elevazione u111forme della temper·atur·a negli oggett i e quindi razione microbicida. go Dal punto di vista della sua st rultt4ra la stura non ha alcun meccanismo fragile o di maneggio delicato. Gh accesso ri sono abbastanza massicci, resistentiss!mi, e con spo r genza mirlima. Non vi è che un solo tubo che serve pet' l'uscita del vapore ed è inaccessibile dal di fuori. Le avarie possono essere riparate senza bisogno di mecca· nici speciali: so lo la valvo la di sicurezza e quella moderatri ce d ell'uscita del va!Jore se fossero contorte da scosse violente esigere bbero d'essere sostituite, il che riesce facile tr attandosi di pezzi indipendenti. .
In fJUesta stufa sono appunto realizzate tutle le condizionr più favo r evoli per la espulsione dell'aria, vale a dire: l"rscaldamento preventivo oggelli, transito del vapol"e dall'allo al basso, aumento di pr essione e circolazione continua del vapore.
7o La disposi:ionc dell'appare cch io e/w assicura il riscaldamMlo tlel cilind ro interno (cam e ra di disin.(ezion e) permette tli l'asciugamento degli oggetti. - Allorclti• si è aperLo il rubin etto e levato il coperchio la cor-reute del vapore cessa di traver·sare gli oggetti e la camera di dis infezion e diventa uua specie di bagno-maria che permette il prosciugo mento.
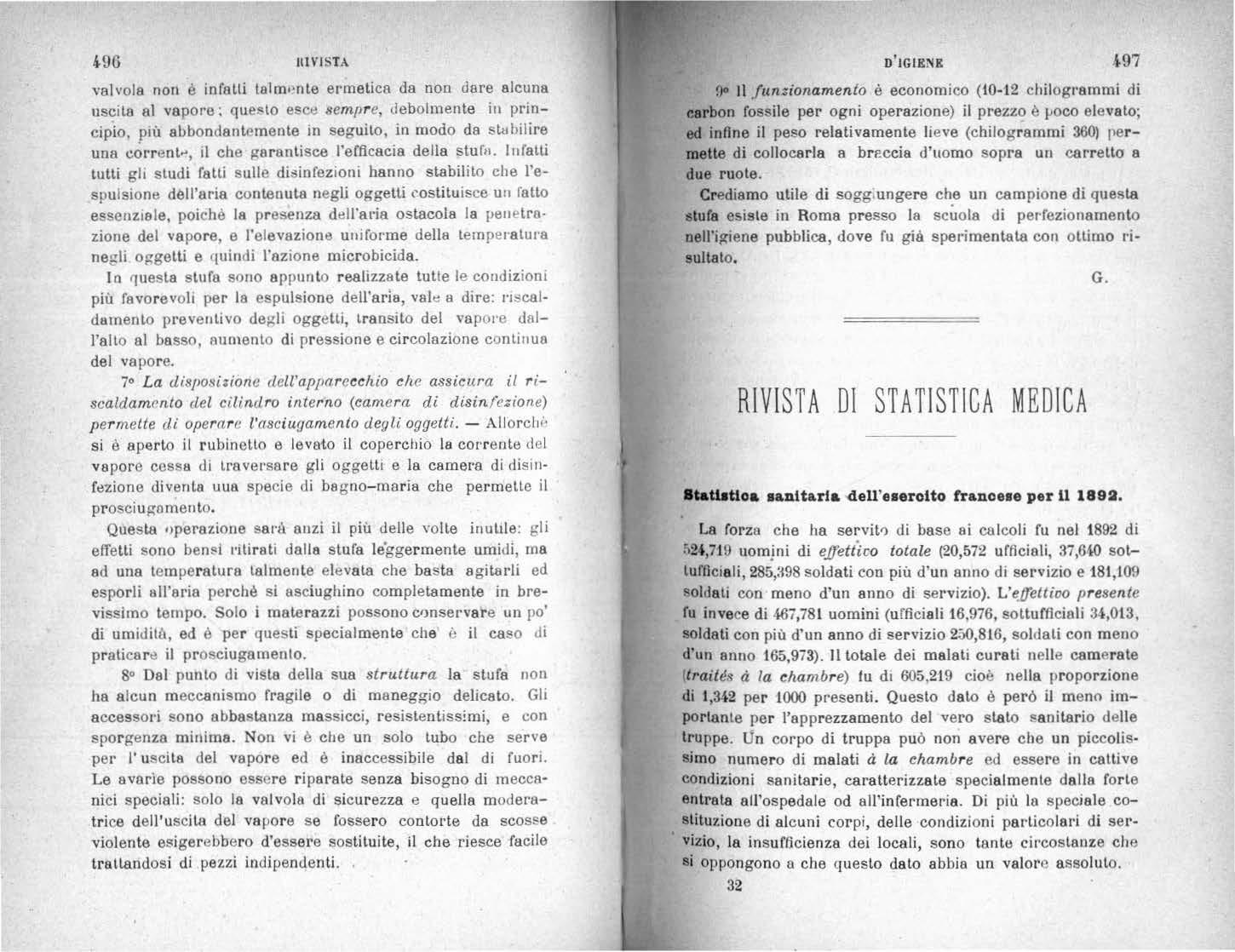
Questa •>perazione sani anzi il più delle volLe iuullle: gli effetti sono bensì t•tlirati dalla stura le'ggermente umidi, ma ad una temperatura talmente elevata che basta agitarli ed esporli all'aria pe r ché si asciughino completa mente in brevissimo tempo. Solo i materazzi possono c•>nservare un po' di umidità, ed è per questi specialmen te che e il caso di praticare il prosciugamenlo.
!)o ll .fun:;iona mento è economico (t0-12 c hilogrammi di earbon fossile per ogni operazione) il prezzo è fiOCO elevato; ed infine il peso relativa mente lieve (chilo g rammi 360) permette d i collocarla a brP.ccia d'uomo sopra un carrello a due r uote.
Credia mo utile d i sogg:ungere che un campione di questa $lU fa esiste in Roma presso la scuola di perfezionamento pubblica , dove fu già sper·imenlata con ottimo risulta to .










