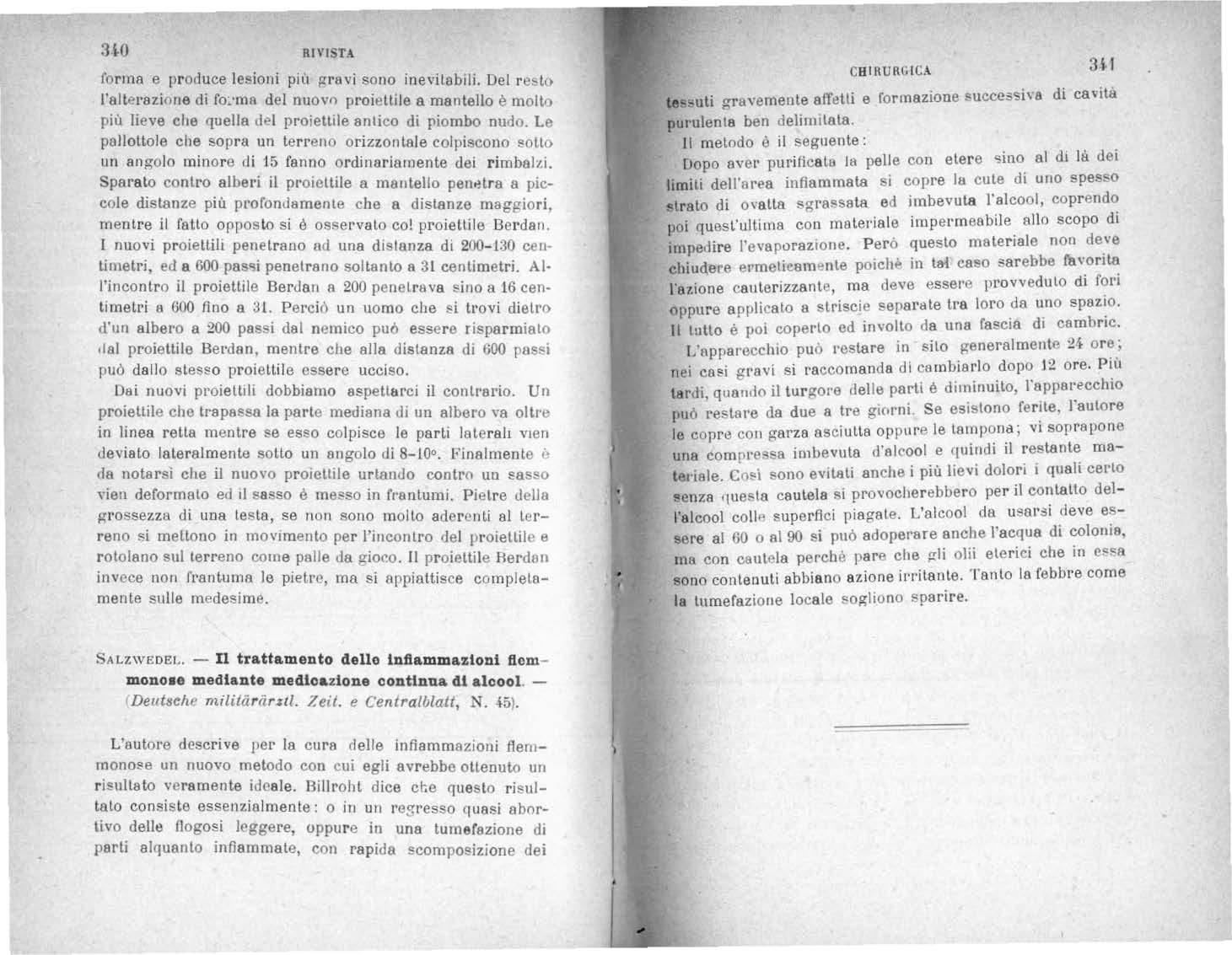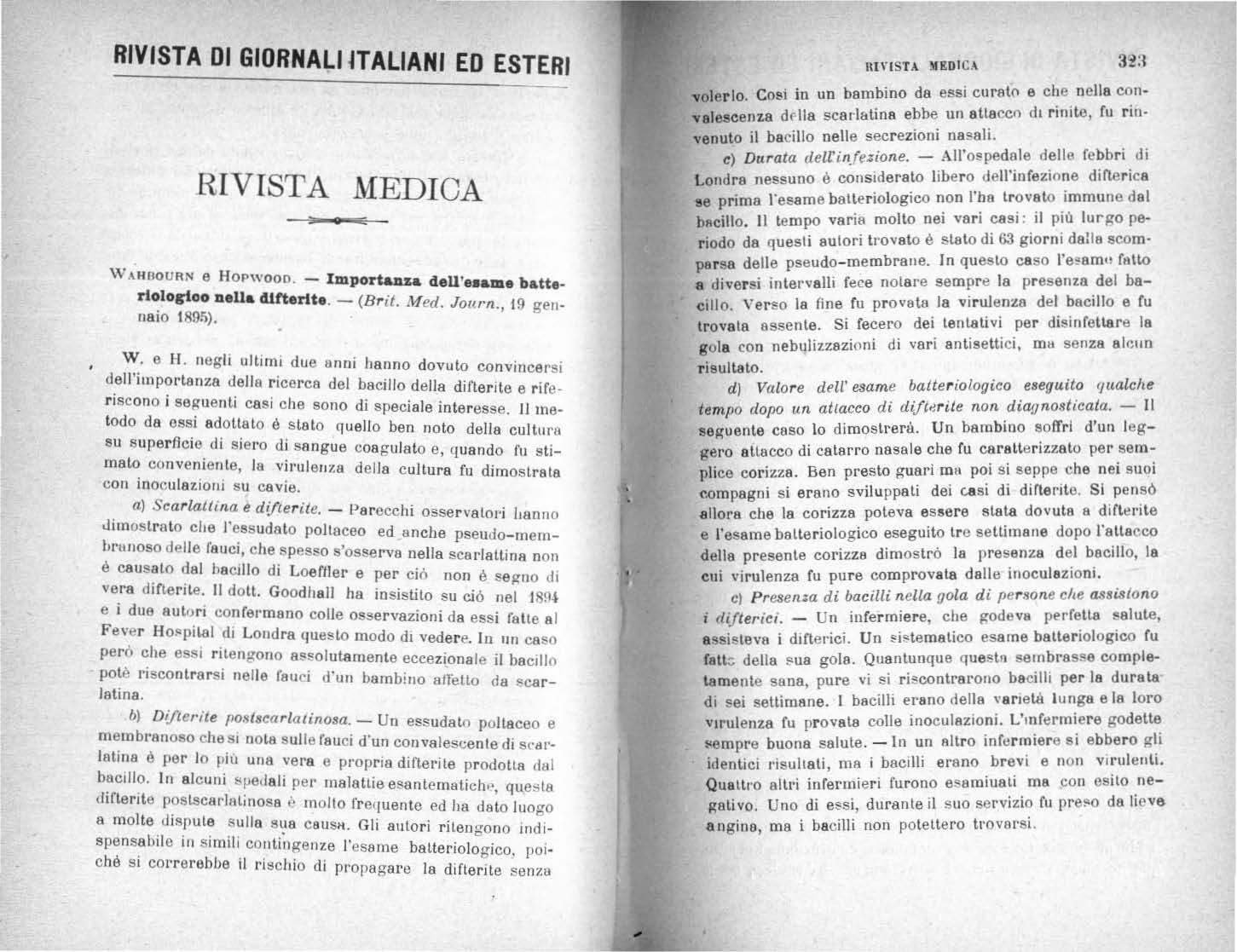
29 minute read
RIVISTA ME DI CA
\VAHBOURN e fi OPWOOO. - lmport&nza dell'e•ame batte· rtologtoo nella dtfterlte . - (Brit. M ed. Jo 1,rn., Hl gennaio 1R9!'i).
W. e H. nogli ultimi due anni hanno dovuto convincersi tlell'impoi·tanza della rice•·ca del bacillo della difterite e riferiscono i seguenti casi che sono di speciale inter esse. 11 metodo da essi ad ottato è stato quello ben noto della cultut•a su superfi cie di siero di sangue coagulato e, q uand o fu stimato conveniente, la viJ•uleuza della c ultura fu dimostrata con inoc ulazioui su cavie.
Advertisement
a) Sca rlattina e difte r ite. - Parecchi osservalol'i hanno dimostrato che l' ess udalo pollaceo ed anche pseudo-mernbrunoso delle fauci, che spPsso s'osserva nella scal'latlina non è causato dal hacìllo di Loeftler e per cio non è segno di vera difterite. Il dotl. GoodhaH ha insistito su ciò nel 1894 e i due aut•J rt confet·mano colle osservazioni da essi falle a l Feve r Ho<>piLal dt Londra questo modo dJ vedere. In nn caso pero che ritengono assolutamente ecceziona le il bacillo l'iscontrarsi nelle fauci d"un bambiuo stretto da latina.
b) Difterite Un e ss udato poltaceo e memb•·anoso che::>t nota s ull e t'auci d"un conva lescente di sedrlatiua è por lo più una vera e propria difterite prodolla dal In alcuni pe1· malattie esantematich», questa <hftertte postscadatinosa molto fre•[uente ed ha dato luogo a molte dispute su lla sua Gli autori rilen cro no ind 1in si mili conti;1genze l'esame poiché SI COI'rerebhe il rischio di pl'Opagare la dtfterite senza c) Durata tlelfin.fe;ione. - All'ospedal e delle febbri di Lo ndra nessuno è considerato libe ro dell'infezione dinerica se prima !"esame batteriologico non l'ha trovato immune dal bAcillo. 11 tempo varia molto nei va r i casi· il più !urgo per iodo da questi autori trovato é stato di 63 gio rn t da:ta scomparsa delle pseudo-membrane. l n questo caso l'e.,am" f14\lo 8 diver si interv alli fece notat·e sempre la presenza del bacillo. Yerso la lìne fu provata la vi r ulenza del bacillo e fu trova ta assente. Si fecero dei tentativi per disinfe tta re la g ola con nebulizzazioni di vari antisetti ci, ma sen za r isultato. dj Valore dell'esame batter iologico eseguito qualche temp o dopo un. attacco di non diaonostieala. - Il seguente caso lo dimostre r à. Un bambino soffri d'un legallacco di catarro nasale che fu caratte rizzato pe1• semplice cori zza. Ben presto g uar ì m a poi si seppe che nei suoi c.om pagni si erano sviluppati dei casi di dinerito Si pensò allora che la corizza poteva esMre stata dovuta a dtftet·ite e l'esame batteriologico eseguito tre settimane dopo l'alterco della presente corizza dim ostrò la presenza d e l bacillo, la cui virulenza fu pure comprovata dalle inoculazion i.
C) Presen•a di bacilli nella nola di pe rsone e/te 1 d(fterici. - Un infe rm iere, cbe godeva perfeLla salute, &'!si ..teva i dlftet·ici. Un ..tematico esame batteriologico fu fatlv della gola. Quantunque que!>ln sernbras!"e completame nte sana, pure vi si riscontrarono bacilh per la durala dt ..ei settimane. l bacilli erano della varteta l unga e la loro v1rul enza fu pr ovata coll e inoculaz1oni. godette buona salute. -In un alLro infermiere si ebbero gli identici •·isullati, ma i bacilli erano brevi e non vtrulenti. Qua ltro alt J•i infermieri furono e sa miuali ma co n esito negativo . Uno di essi, durante il suo servizio fu preso da liC'v& an gina, ma i bac illi non poleltero trovarsi.
BABES e TALASESC U.- Pro1Uusle traUaJDeDt 4 U terlte (B ·t M 0
• a 411. - r t . ecl. Jou r n. 12 g ennaio 1895 e Roum .
•'Jéd. N. 1, '
B. e i numerosi esperimenti faLli da vari osall'attenuazione ,del virus difterico mediante Il trlcloruro di iodo, il calol·e, e colla coltura tn estratto di limo. Ma lo scopo Pl'm<'ipale delle loro l'icerche era di immunizzare degli animali che po· d , fornrre · . 1 ove,ano . vaCl'IOO m gran copia. Eccone i l'isullall: colla con c ultura di bacillo difterico allenuato in roùo dr Lim O e quindi riscaldato a 6:)o C. per 15 minuti s· può proJurre l'lmmuni ta. sicché l'an · lma le . ' ' •. . • puo resrslere aJ che ,nJubbiamente sar·ebbe riuscita fatale. mediante Il calore e il tricl oruro di iodo le culture virulente.sono in vaccino, ma le ioocul azioni debbono essere conllnuale lun go tem po.. con questo metodo le pe,.or·e acqu·l stano l'im ' ta · . . '. mun l . m tre mesi e 11 lOI'O sier o, ini ettato nello le cavie. Il fllt r ato di cullura di batrattato con soluzione di iodo e ioduro otasSICo (soluzione di Luf,rol) nelle p r opor zioni <li J . 3 l 2 d l· 1 e amministralo in dos d' 1 5 . · ' · ' e ùi .i 0 · e 1 a gramml con intervallo . . a giorni, lmmumzza conigli e cavie da un' mfezione thfle rlca due volte piu forte dell'o d' . Q · . . r mario. uesto metodo ha Il vantaggro di costante e più rapido. Lo sleS$0 metodo può io ani mo li più g r andi, i quali aven rlo una v olta acqwstato l Immunità sono in g r ado di forni r e gue che può es ere usato in clinica per la p r ofi lassi e la cura della difterite nei bambini.
BREMER. - Diagnosi del 4labete m e cU&Dte l 'esame 4 el s&Dgue. - (Brit. Med . Jou rn . 12 gennaio 1895 e Cblait f. med. Wis.<t., 8 dicemb r e 189i ). .
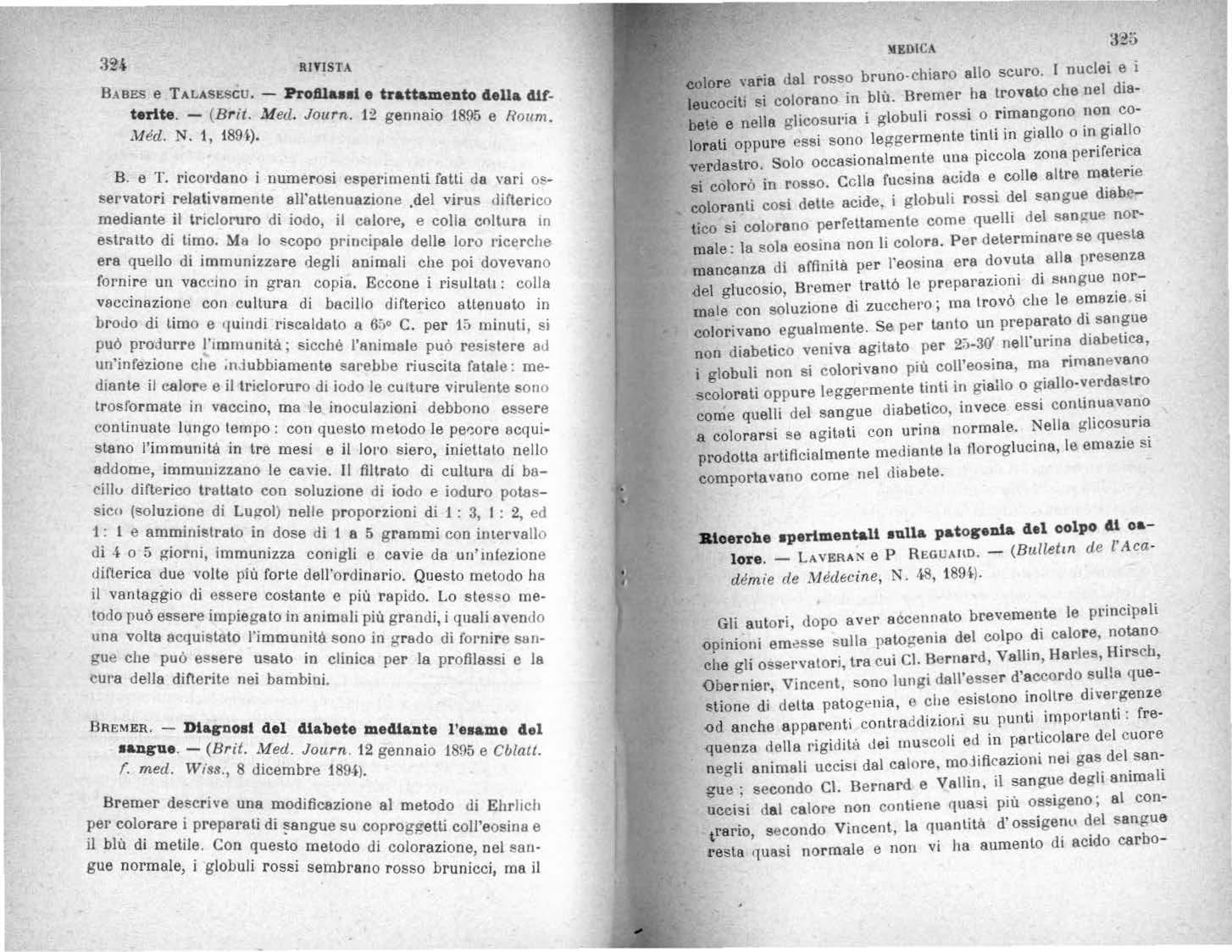
Bremer de.scr ive una modificazione al metodo di Ehr hch pr eparati di su coll'eosina e J u l m etlie. Con questo metodo di colorazione nel qarlg ue normale · 1 b 1· · ' - ' 1 g 0 u 1 ros si sembran o rosso br · · ·1 UnlCCI, ma l eolor e varia dal rosso bruno-chiar o allo scuro. nuclei e i leucociti si colo ra no in blù. Bremer h a trov a to c he nel diabe te e nella glicosm·ia i globuli r ol'si o riman gono non color a li oppure t>ssi sono leggermente tinti in giallo o in gi all o ve r dastro. Solo occasionalm ente una piccola zona perirerica si color ò in r osso. Cella fucsina acida e colle altre materie color anti cosi dette acide . i globuli rossi del sangue diabt>t ico si colora no perfettamente come quelli òel norma le: la sola eosina non li colora. P er determinare se questa mancanza dì affinità per l'eosina era dovu ta all a pr esenza del glucosio, Bremer trattò l e p r eparazioni di sMgue normale con soluzione di zuccht> I'O; rna lrovò che le emazie si colorivano egualmente. Se per tanto un prepar a to di sangue non di abeti co veniva ag italo per 2:>-30' nell'urina diabetica, i globuli non si coloriva no piu coll'eosina, ma r imaneva no scolorati oppure leggermente tinti in giallo o giallo-verdastr o come quelli òel sangue diabetico, invece essi continuavano a colorarsi se a g itati con urina normale. Nella glicosuria prodotta a1·tiflcialmente mediante la llo roglucina, le emazie si comportavano corne nel diabete.
Bloerohe sperimentali 1111la pato geDla 4el oolpo 4l oalore . - LAVERAN e P REG UA ilD. - (8u/lettn de l'Académie de Méclécine, N. 48,
Gli auto r i, dopo a ver accennalo brevemente le pri ncipali ()pinioni sulla patogenia del colpo d i calor e, notano che gli osservtttor i, tra c ui Cl. Be r nard, Vall io , Harles, llirscb, Obernier, Vincent, sono lungi dall'esse r d'accordo sulla stion e di detta patogt>nia, e che esistono inoltre divergen z e anche a pparen t i co utradd iz.io11i su p unt i impOI'lanti: frequenza tlolla l'igidità d ei muscoli ed in particolare d el cuore negli animali uccisr dal calo r e, mojificazioni nei gas de l sangu e: secondo Cl. Bernard e Vallin, il san gue degli animali uc c isi tlal calo1·e non con tiene ctuasi piu ossigeno; al cont r ario, s econdo Vincent, la quantità d' ossigem• del sangue resta quasi normale e non vi ha aumento di ac ido carbo- nico, quantunque la respirazione diYenti sempre più lent& nell'ultimo periodo.
Essi quindi hanno giudicalo utile r ip re nde• e tali ricerche mettendosi nelle cond izioni in cui si producono d' ordinat·io nei sol dati gli accidenti del colpo di calore. P erciò, invece di far agire il calore bruscamente e sopra animali io riposo, hanno sottoposto a temperature proRressi,·amentP degli animali, alcuni dei quali erano in riposo, mentre gl i allri erano assoggettali ati un laYoro faticoso.
Un g ra n numero l.li fatti che la futica ha sove nti una gran parte nella palogenia del colpo di calor e Nell 'e!'rrcito è quasi sempre il fantaccin o che ne è colpilo, ed è quasi sempre durante le marce che si producono gli accidenti. Nella cavallel'ia i cavalli sono co lpili mollo più soventi degli uomini, falla eccezione per i corazzieri, l'elmo e la co r azza favorend o il colpo di calore.
Ma era importante slabihre, con esperienze, come ed io quale grado 111 fatica fav o risca l'azione del calore.
Gli autori hanno fallo costruire un apparecchio c he •·e mmenta quello che ha servito a Regnard per determinare la parte che ha la fatica nella pat,1genia del male di mC'nlagna, ed hanno fatto la maggio r parte dei lot•o espe rim e nti sui cani.
Risulta dagli esper·imenli che il cane che lavora è l•iù rapidamentE\ colpilo da accidenti gravi ed anche mortali, !'i prolunga suifìcienlemeule resperi e n7.a, del cane in ripO!"O.
Essendo la pr oduzione degli accidenti del colpo di cal or e facilitala dall'esercizio, fa d'uopo sopprimere n e i paesi caldi per quanto è possibile le cause di fatica; se si tralla di una truppa in marcia, si rallenterà l'andatura e si farann o l'iposar·e soventr gli uomini. Da m olto tempo d'altronde peri enza ha dimostrato la necessrLà di tali provvedimenti.
Non v'ha dubbio che l' eser l"izio prolungato aum enta la t e mperatura in terna e che gli effetti dell 'ese rcizio vengono ad aggiunget•si a quelli del calore. Risulta dall e e!"perienze latte che la temperatura dr un cane che lavora in un'lllm osfer a calda mollo più rapi d amente 4f> g radi di quella di un cane e!"poslo ·alla stessa temperatura , ma che tlo r tntluenza del lavoro, la temsia in r·iposo, e che so l . . lentamente che quando lo si eleva, ma molo pru anima le lavora elfelti della fatica sulla tempeHill e r , che ha s tu ra o g.' h ·nsistito più specialmente d l soldato in marcta, a ' Ilo ralura e . . ed assestata favo r isce mo sul fallo che un L" impedendo il J'alfreddapiù la produzione deg lt ace• en r, m ento del corpo. , . d" a causa adiuvante del L'esercizio prolungato e qurn ' un tesso una causa di . l perchl" esso è per se s . colpo dr ca ore , hè solto l'azione combmata rrscaldamento del corpo, e pere 'la temperatura del corpo dell'esercizio e de l calore . compatibrle co! funziosi eleva ra pidamente ad un gl'a o rn namento . . constala come Negli uomini morll. d: c o nsideanimali che sono ucct<; J dal ca ore. l l momento clelia mor e. r evole della tempe ratura a che li uomrni e animal i
:\1a non basta constatare g leva al disopra dei muoiono quand o h\ loro sr e l lo per quale . . a reare rn qua m o' ' gradi ; Ì' nece!'sat·ro rtc · · 1 morte meccanrsmo a. : venuti nella conclusione Dai falli osse rvalr gh . . produce il colpo dr che nelle condizioni rnècu• coagulazioue deUa l le non "l s preaa n con calore, a mor .. !"auto-in tossicazione: pare · · · con l'a«hs•ta no ro n · mtosrna. ne - ' d" , one diretta ecmlaote · 1 o rseguenza ' un azr ' che e!lsa s•a a c ' -. d l al or·e sul siP.te ma nervoso. dapprimu' poscia par·allzzante e c
' mlv& nell' urina. dopo la. gua.rlLa. persl•tens& dell a.lb u D tt BARD - (Journcd ...lo ne delle nefrltl a.oute . - o . b- 1 . SCI\)
.,. d C'l · rnie novern re · · de Méd ecine et e uru , ' . . h" amalo l'attenzione alcun t Già Cuffer e Gaston ' . mollo tempo clopo una - pra alcuor casr rn eu•, d" anm or sono so quantità notevole 1
. onstala ancora una ncfrile acuta, SI c . che non è però incomalb umioa eire persiste nelle o rm e e . . d "chinrat.o nel·
' f lla s anità Esst hanno • palibile con una per.e . . i deve rare una prognosi lamenle che, in que• cast, non s
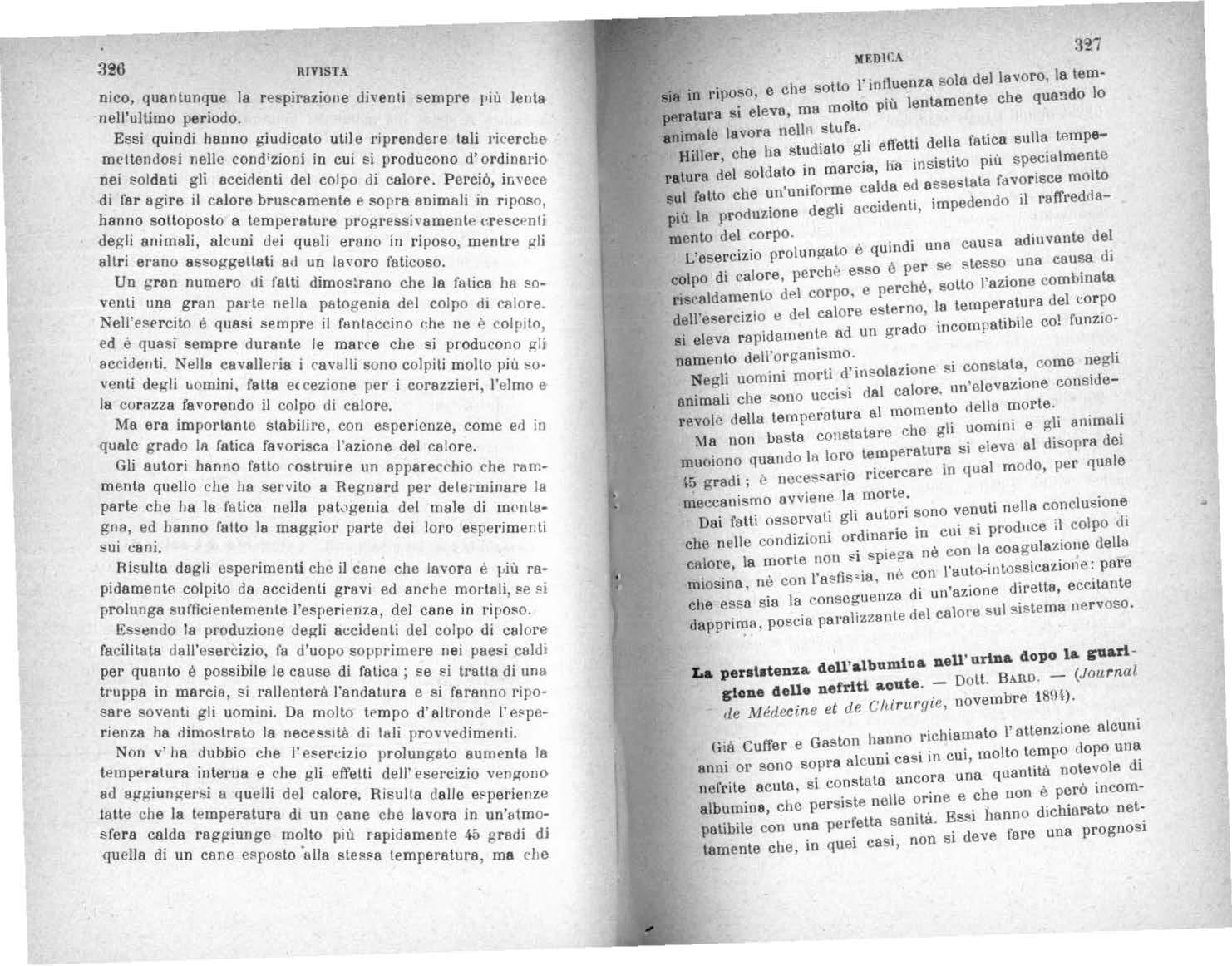
IHVISTA )IEDICA
grave e che, se si cievono consigl iare agli individui al cune precauzioni, non e però necessar10 indebolirli inutilmente, ob bl igandoli a res tare in camera e sottomettendoli ad un severo regime; essi mettono in guardla i medici conh·o una medicazione assolutamente intempestiva ed inutile. E ssi al· tr1buiscono la benigoila di questo s tato al fallo che la nefrite, che era stata primitivamente diffusa, generalizzata , e divenuta ulteriormente locaHzzala f> parziale.
Pur dando di questi fatti una interpre tazione alquanto differente, Bard cit.a casi analog hi e dimos tra in che cosa questa albuminuria. che ha perduto la sua g ravezza, difl'e r isca da i casi di nefrite in evoluzione.
Lo studio dei falli dimostra cile questa albuminuria pre· senta una certa fis s1 tà ed i' meno sensibile alle cause occasionali di aumen to, com e la fatica o gli eccessi di alimentazione; ma la diagnosi differenziale risulla meno dai reno· meni che si constatano in quei che da quelli che non si constatano. Il carattere essenziale consiste nel fatto che l'albuminuria costituisce il sol o fenomeno patologico o sservato ; l'analisi rivela , con l'assenza di 'poliuria, la presenza degli elementi ordina ri dell'orina in una quanl it.a che rimane nei limiti fisiologici ; non si con!'tatano elementi dì desquamazione delle cellule fermentate; non cellule libere anormali, uon cilindri, o tutt'al più qualche cilindro ialino . Non s i riscontrano neppure dislurbi de lla salute generale, non secchezza anormale della pelle, non ipertensione arte · riosa e per di più ness un riper cuoli m ento sul cuore, nou ipertrofla, nè rum ore di galoppo.
Rivista Chirurgica
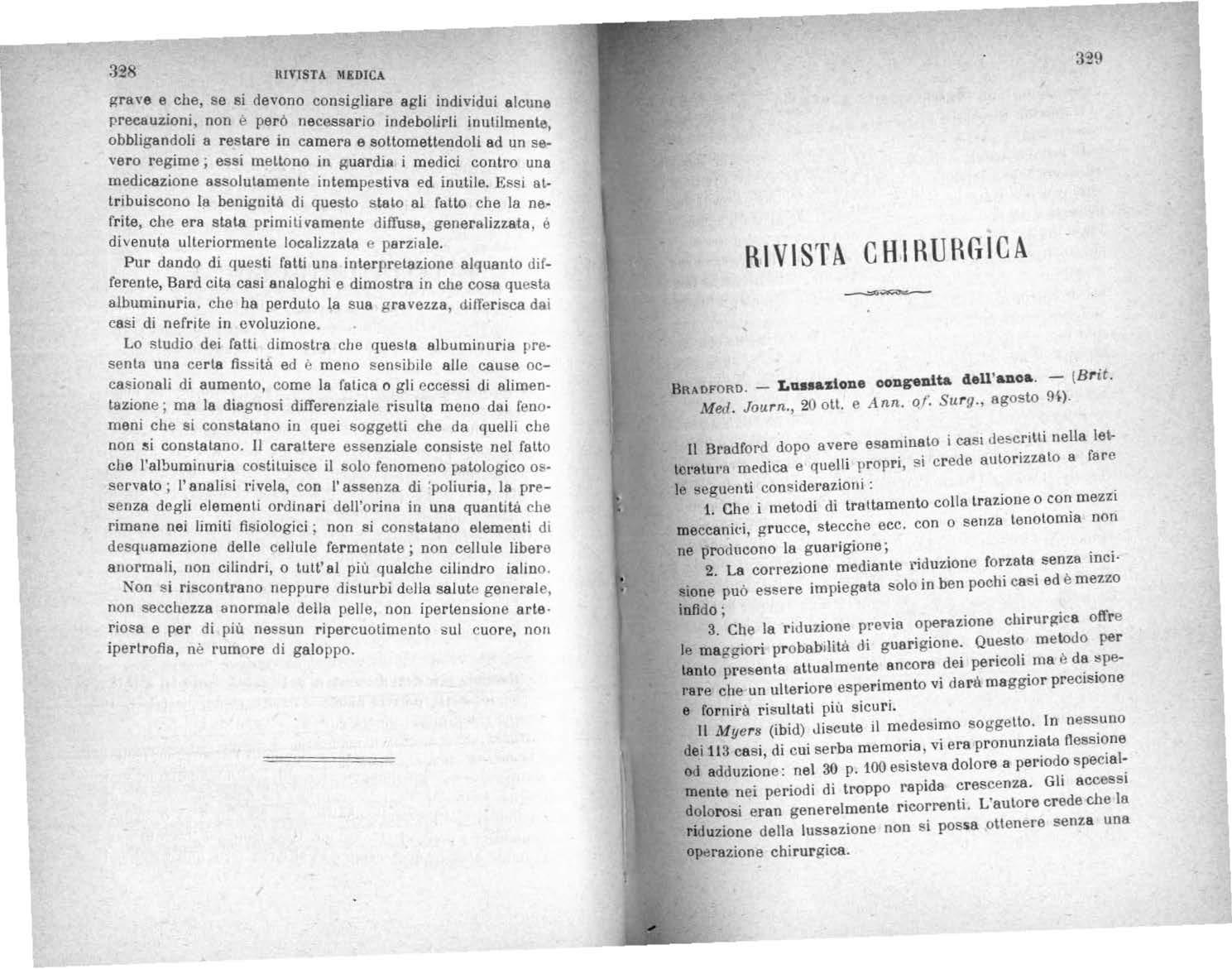
L1UI.&-•one oongenlta dell'&no&. - (B r it.
RAOF ORO. - -
Jou.rn., 20 oll. e A nn. of. Surg., agosto 9 )
Il Br•adford dopo avere esaminato i ca st de5c.rìlli nella lettcr·atur·n medica e quell i p r opri, !li c r ede autorizzalo a fare le aegueuti : .
1. Ch e i metodi di trattamento colla trazione o mezzt . con 0 seuza tenotom1a non mecca nid, grucce, steccne ecc. ne producono la guar igione; . . e med · ,ante t..;duzione forzata senza mct·
2. La cort·ezton ·' . . sione puo essere impiegata solo in ben pocht cast ed è mezzo infido; . h' · offr e
3 Che la riduzione previa operazione c Jrurgtca · . , . d' ·g·o 1e Questo metodo per le mag,.iort probabth lA 1 guar1 t r · . lanto p;esenla allual mente an cora dei pericoh. ma è ra r e che un ulleriore esperimento vi da rà maggiOr preCisiOne e fornirà risultati più sicuri.
Il Mye rs (ibid) Jiscute il medesimo soggetto .. In det113 casi, di cui serba memoria , vi e ra od adduzione: nel 30 p. 100 esisteva dolore a spectal: 'd cresc enza Gh accesst mente nei periodi di troppo rapt a , · dolorosi era n generelmenta ri correnti. L' autore cr ede che la riduzione della lussazione non si possa ottenere senza una chi rur gica.
J AMES MuRPuY. - Bpleneotomla, guarigione. - (Brit. M ed. Journ., 3 nov. 1894).
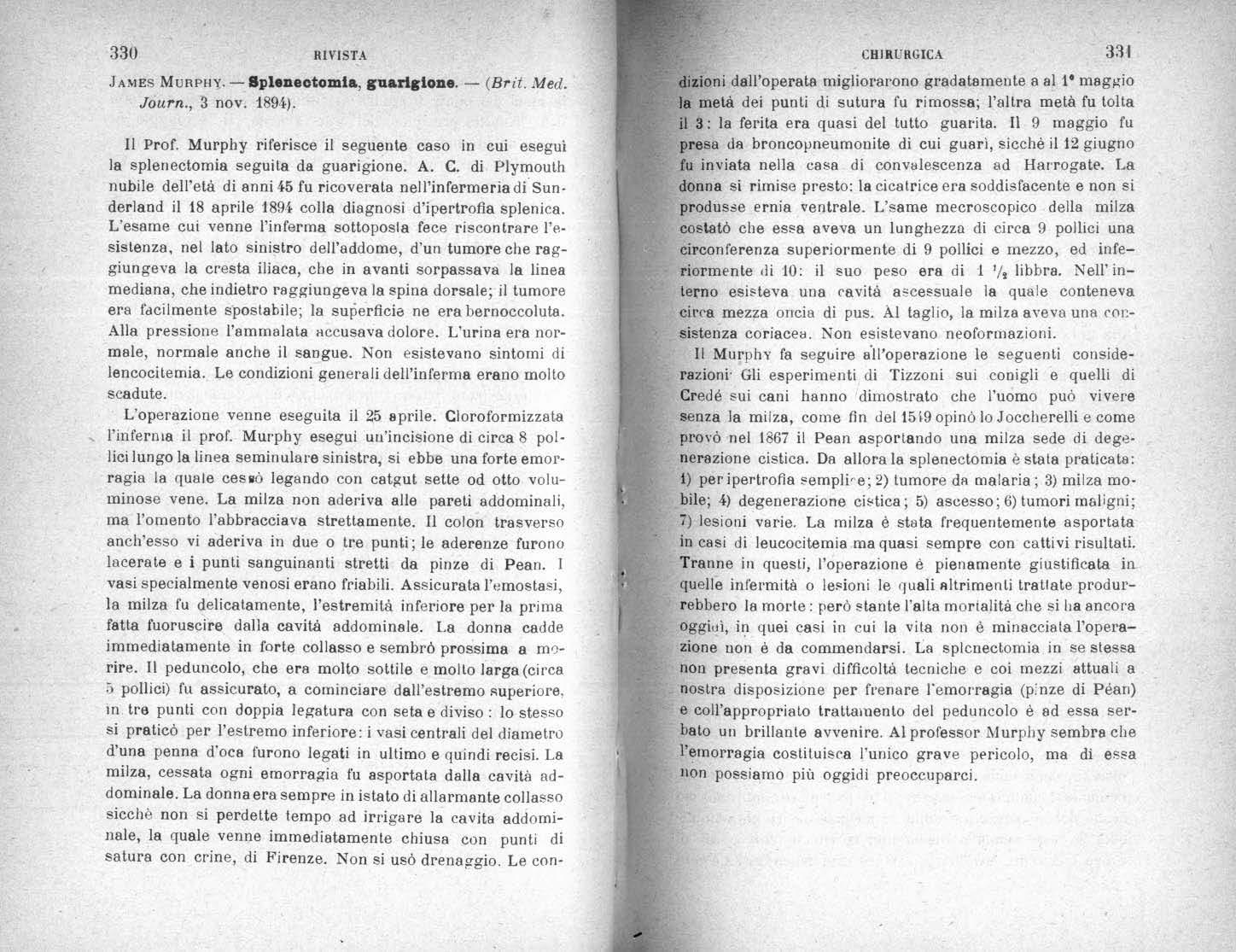
Il Prof. Murphy riferisce il seguente caso io cui esegui la splenectomia seguita da guarigione. A. C. di Plymouth nubile dell'ehi di anni 45 fu ricover·ala nell'infermeria d( Sunderland il L8 aprile 1894 colla diagnosi d'ipertrofìa splenica. L'esame cui venne l'inferma sottoposla fece riscontrare l'e· s istenza, nel lato sinistro dell'addome, d'un tumore che raggiungeva la cr·esta iliaca, che in avanli sorpassava la linea mediana, che indietro raggiungeva la spina dorsale; il tumore era fdcilmente sposlabile; la superfici;; ne era bernoccoluta. Alla pressione l'ammalata accusava dolore. L'urina era normale, normale anche il sangue. Non esistevano sintomi di lencocilemia. Le condizioni gener·ali dell'inferma era no molto scadute.
L'operazione venne eseguita il 25 apt•ile. Cl oroformizzata l'infernta il prof. Mur·pby esegui un'incisione di circa 8 poi· lici lungo la linea seminular·e sin is tra , si ebbe una forte emor· ra gia la quale ces wò legando con cat:.tut sette od otto voluminose vene. La milza non aderiva alle pareti addominali, ma l'omento l'abbracciava strettamente. 11 colon trasve t·so anch'esso vi aderiva in due o tre punti; le aderenze furon o lacerate e i punti sanguinanti stretti da pinze di Pean. l vasi specialmente venosi erano friabili. Assicurata l'e mosta si, la milza f'u delicatamente, l'estremità infe riore per la prima fatta fuoruscire dalla cavità addominale. La donna cadde immediatamente in forte collasso e sembrò prossima a rire. 11 peduncolo, che era molto sottile e molto larga (circa pollici) fu assicurato, a cominciare dall'estremo Ruperi ore. in tre punti con doppia legatura con seta e diviso: lo stesso si praticò per l'estremo inferiore: i vasi centrali del diametro d'una penna d'oca furono legati in ultimo e quindi recisi. La milza, cessata ogni emorragia t'u asportala dalla cavità addominale. La donna era sempre in istato di allarmante collasso sicché non si perdette tempo ad irrigare la cavita add o minale, la quale venne immediatamente chiusa con punti di satura con crine, di Firenze. Non si usò drenallgio. Le con· dizion i dall'operata migliorar·ono gradatamente a al t• maggio la mela dei punti di sutura fu rimossa; l'allra metà fu tolta il 3 : la ferita era quasi del tutto guar·it.a. Il 9 maggio fu presa d6 broncopneumooite di cui gua r ì, sicché il 12 giugno fu in viata nella casa di convalescenza ad Har-rogatE'. La donna s i rimise presto: la cicatrice e ra soddisfacente e non si produ s:>e ernia ventrale. L'same mecroscopico della milza costatò che essa aveva un lunghe zza di circa 9 pollici una circonferenza superior·mente di 9 pollici e mezzo , ed inferi or mente di 10: il suo p eso era di l 1/ 1 libbra. Nell'interno esisteva una ravilà a:: cessuale la quale conteneva cirra mezza oncia di pus. Al laglio, la milza avevo una ror:sisteoza coriacea. Non esistevano neoformazìoni.
Il Mur·pbY fa seg1.1ire a'woperazione le seguenti considera zion i· Gli esperimenti d i Tizzoni sui conigli e quelli di Credé sui cani banno dimoslt·ato che l'uomo può vi vere senza la miil:a, come fin del opinò lo J occherelli e come prO\'Ò nel t867 il Pean aspor·tando una milza sede di Jegt3· nerazione cistica. Da allora la splenectomia è stata praticata: t) per ipertrofìa sempli"e;
2) tumore da malaria; 3) milza mo· bile; 4) degenerazione ci!:'tica; 5) ascesso ; 6) tumori maligni;
7) lesioni varie. La milza è s tata frequentemente asportata in casi di leucocitemia ma quasi sempre con cattivi risullali. Trann e in questi, l'operazione é pienamente giustificata ir1 quelle infermità o lel"ioni le quali altrimenti lrallate produrr ebbero la mot·le: però stante l'alta m o rialita che si Ila ancora oggittì, quei casi in cui la vita non è minacciata l'operazione uon é da commendarsi. La splcnectomia in se stessa non presenta gravi difficolta tecniche e coi mezzi attuali a nostra disposizione per f1·enare remor·ragia (p:nze di Péan) e coll'a ppropriato trattamento del peduncolo è ad essa set·ba to un brillanle avvenire. Al professor Murp hy sembra che l'emorragia cosliluisra l'unico grave pericolo, ma di essa Hon possiamo più oggidi pre occuperei.
0AURtAC. - Delle ferite penetranti dell'addome .(P rog rès médical, N. 25).
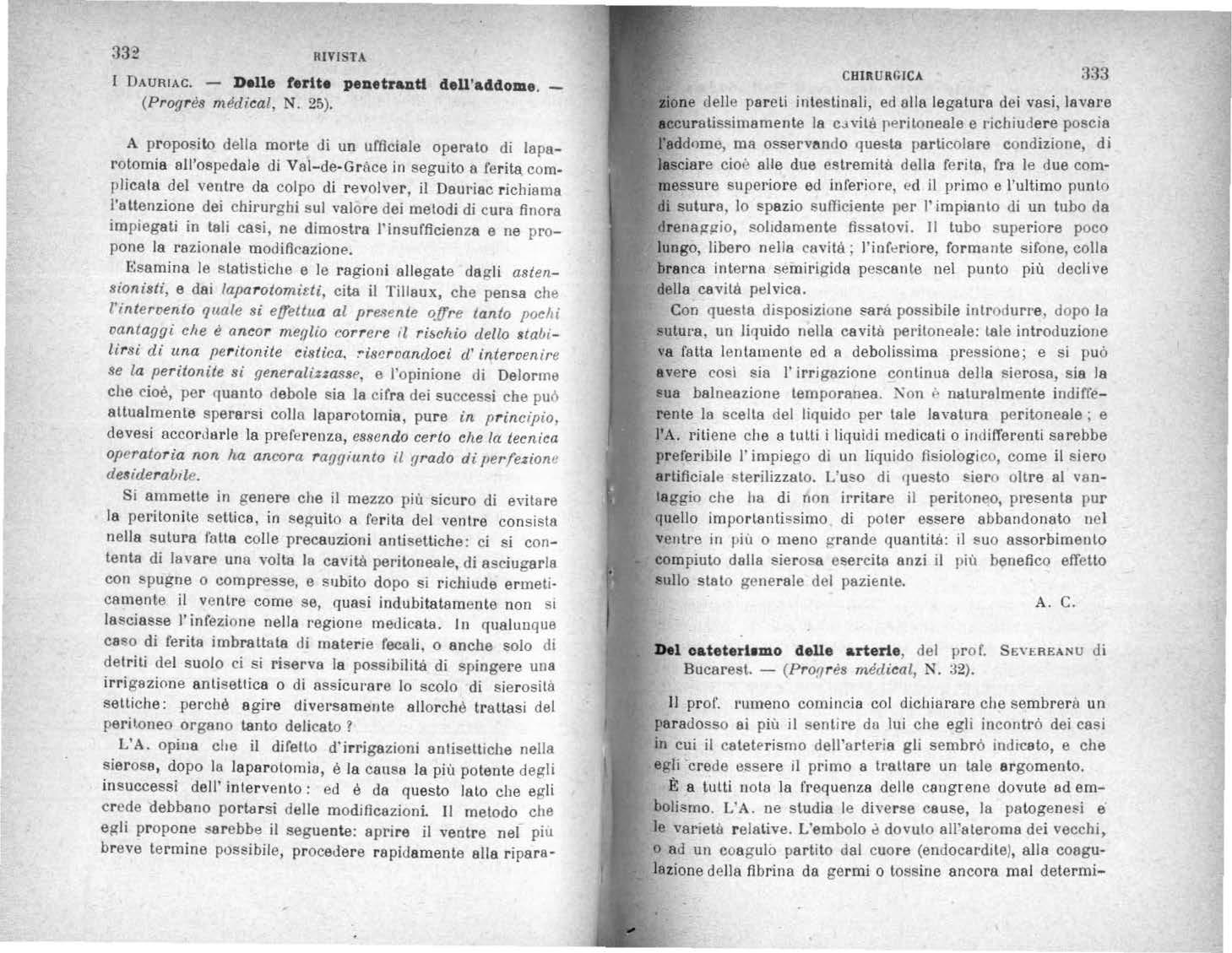
A pr oposito della morte di u n ufficiale operato di Ja par otomia all'ospeda le di Va l-de- Gr Ace in seguito a fe r ita. complicala del ventre da colpo d i r evolve r , il Daut•iac r ichiama l'a ttenzione dei c hirurghi sul valore dei metodi di cura finora impiegati in tali casi, ne dimostra l'insufficienza e ne propone la razionale modificazione.
Esamina le f'llatistiche e le r agion i allegate dagli astensionisti, e dai lapa r otomieti, cita il Tillaux, che pensa che l'interoenlo quale si effettua al pre.<rente o..(fr e tanto pochi oanlaggi che è anco r me{Jlio rorrere il rischio dello ata bcli r si di una pe r itonite cistica, d' interoenire se la peritonite si generalizzaBse, e l'opinione di Delorme che cioè, per CJUanto debole sia la cifra dei successi che può attualmente spara rsi colla lapa r otomia, pu r e in p r incipio, devesi acco r ,lar le la essendo certo che la tecnica operato r ia non ha ancora r aggiunto il urado di deside r a/n le.
Si ammette in genere che il mezzo piu sicu r o di evitare la perilon ite settica, in seguito a fe r ita de l ve nt r e consista nella sutura fatta colle p r eca uzioni antisettiche: ci si conlenta di lavare u na volta la cavità peritoneale, di asciugarla con spugne o compresse, e Sllbilo dopo si richiude e rmeti· camenle il ve nl re come se, q uasi indubi ta ta men te non st lasci a sse l'infezione nella regione medica la. l n qualunque caso di ferila imb r attala di mate r ie fecali, o anche solo di det r iti de l suolo ci si r iserva la possibi lità di spingere una irr igazione an tisellica o di assic urare lo scolo di sier osilà selliche: perché a gire diversam eu le allo r ché L r atlasi del periloneo organo tanto delicato ?
L'A. opina che il difello d'i r rigazion i antisettiche nella sier osa , dopo la lapar otomia, è la causa la piu potente degli in successi de ll' in ter vento: ed è da qu e s to Ialo che egli c r ede debb a no po r ta r si dalle modificazionL Il metodo che egli p r opon e .sarebbe il seguen te: apri re il ve nt r e nel piu b r eve te r mine possibile, p r oceder e r ap idamente alla r ipara-
Chir Urgica
zion e delle pare ti in testinali, ed alla le gat ur a de i vas i, la vare a ccura tissimamente la cJvità peritoneale e l'ichiudere poscia l'addom e, ma osserva ndo questa particolare condizione, di lasciare cioe alle due estr emità della ferila, fra le due com· messUI'e supe1·ior e e d infer iore, ed il primo e l'u ltimo punto di su t ur a, lo spazio sufficiente per l'impianto di un tubo da dr enal!l!io, solidamente fissatovi. Il tubo s uperio r e poco lun go, libe r o nella cavita; formante sifone, colla bran ca in terna semirigida pescante nel punto più declive della caviLA
Con questa disposizione sara possibile introd urre , dopo la sutu t·a , un liquido nella cavità pel'itoneale: tale int r oduzione va fa lLa lentamente ed a de b olissima pressione; e si può a ve re cosi sia l'irrigazione continua della sierosa, sia la @Ua balneazione temporanea. l\on t-> naturalmente indiffer ente la scella del liquido per tale la vatura pe r itoneale; e l' A. ritiene che a tutti i liquidi medicati o indifferenti sarebbe prefer ibile r impiego di un liquido fisiologi co, come il sie r o a rti ficia le ster ilizzato. L'uso di questo siero oltre al ' 'a nta ggio che ha di non irritare il perito neo, pt•esenla pur quell o impo r tanti!isirno di poter essere abbandonato nel v enke in più o meno quantità: il suo assorbimento com piuto dalla sierosa esercita anzi il più benefico effetto llull o stato generale del paziente.
Del oatetertemo delle arte rie , del prof. SEYt:REANU di B ucarest. - (Proa r es médical, N. 32).
Il p r or. l'Umano comincia col dic h ia r a r e che sembr er à u n paradosso ai più il sentire du lui che egli in contr ò dei casi in cu i il catel!'rismo dell'arteria gli semb r ò indrca lo, e che e glt c r ede essere il primo a tralla r e un tale argo m en to.
È a t utti u o ta la fr equenza delle caogr eno dov u te ad embol is mo . L'A. ne studia le dive r se ca use, la patogenesi e le va r1età r elalive. L'embolo d dovuto all'ateroma dei vecchi, o a ù un c oagulo pa r ti to dal cuore (endocardtle), alla coagula zion e de ll a fib r ina da ge r mi o tossine ancora mal determi- nate (fo rm e o infine da un'attitudine viziosa delle membra a lungo prol u ngata e spess o ripetuta . In generale il coagulo si arresta a li veli() delle b iforcazi oni arte r iose: sono più frequenti in cor ris p o nde nza d ella biforcazione dell'omerale al o della poplitea, prod uce ndo lA cangrena de lla man o e dell'avamb r accio, o del piede e della ,:.ram ba.
P e•· avere un buon risultato occorrE> eseguire l'am putazione dov P si la pulsazione delle arterie , Mcrificando un lungo segmento dell'arto ancora inlallo: amputando solo ai confini della pa rte cangrena ta i lembi si mortiflcano e occorre o ripetere ramputazione o a spettare una cicatr1:>.zazion e !leconda ria .
Fu in tali casi che l'A. ebbe l' idea di disoslrui re con una sonda i rami di bifot•cazione della poplilea che non si sentiva pul s are che all'anello del 3• addullo r e. Su un uomo tli GO ann i con cangr en11 da embol is mo, che aveva inva ao la g am ba senza tendenza a limilai'Si, ed in cui l'arteria non pulsava che mollo in allo, anziché all'es tremità dell a cosciA, egli volle amputare la gamba al pun to d'elezione. Durante l'operazione non ebbe Hlcun getto di sangue , solo pochissima emorragia, qua"i capillare. Con sonda Charrière precedentemente preparate, e ben di!:;infett.ate con alcool E'd acido feni <'o, e introdotte uel lume delle arterie per t ulla la loro lunghez7.a, si ec:egui1·ono dei movime nti di va e vieni: il sangue co minci ò a fluire ai lati d e lla sonda, et! estrella questa, l'ouda c:anguigna spinse fuori parecchi coa !{uli cilindrici, conservanti la forma e il c a libro detrarteria ; la c o rrente ristabill e IPa:ali i vasi, remorragia capillare divenne più copio<>a. i tessuti p1ù color a ti. 1 lembi non sr can· ;rrena r ono e si ebbe r iunione per prima intensione.
Di p01 l'A. in tutti i casi di amputaz•one per cangrenA da oblilera zione ùei vasi pratico se mpre 11 cateterismo, ed ehbe s-> mpre a f••licita r sene. D'o 1·ùinario la sonda penetr a completamente n e l lume dell'arteria; ma talora non si può penetr·arvi. e ciò é causalo dalle aderenze già contratte dal coagulo colle pareti dol vaso: in questi casi non è rar o ve· dere il le mbo mortificarsi in tutto o in par te.
Chiiwrgica 335
L 'A. modestamente dichiara che per quanto poca importanza possa avere questo p r o cedimento, tuttavia è grazie n! medesimo che egli potè ottenere buoni risultati in casi mollo gravi, e crede che la nut r izione df>i lembi si •lebba m fl r an parte Al ristabilimento della circolazione ottenuta col cateter ismo delle arterie. Egli conclude il suo lavoro pregando i colleghi a verificare questo suo processo e giudicare personalmente se esso meriti u n posto nella chirur[.{ia operati va.
A. C.
TA UO&R. - Sopra. alcune pa.rttcola.rltà delle ferite prodotte d& prolettW a. ma.ntello d 'aool&lo . (Cent rallJ/att fU. r chiru rgie, N. 42).
Taubet· rife1·isce il I'isultato dei suoi ultimi es perimenti. spa r ò con cartuccie compl ete da guerra austriache e pru'3sian e se 1•v endosi p er di cadave1•i iniettati ùi l"resco. ad ogni sperimento di til'o fu tenuto conto delle condizioni meteo rologich e (temperatura, vento ecc.) alle quali l'autore non piccola importanza. Gli spe 1•imentatori per la maggio r parte trovano che il proietti le Mi\ nnlicher non si deforma colpendo il bersaglio. Seco ndo gli esperimenti di T auber, sopra 100 proiettili sparati se n e trovar ono quindici allerati nella forma, il qual fHllO fu con s tatato 11nche da Delorme. Sparando alla distanza d i 100-!300-000 ed an che a 1000 m. il d elle fe1·ite p r endeva una fo r ma cili ndri ca. Ma se il proie ttile nel s uo incentrav a un O!llacolo, oppu r e se il col po era sparato a maJ!l!io re distanza, il canale assum eva. specialmente nelle ossa, la forma di cono colla base r ivolta indietro. L'auto r e mostrò due c ran il un o dei 'l uali mostra va una fraLLura a fOJ'O l'altro era l'ldotto in feamroenti, ciò che il TaubPr spiega ammettt>ndo che sia avvenuto un incontro del proie ttile con un ostacolo a g r andì distanze, oppure ammettendo certe anAtomiche condizioni. Analoghe differenze mostraron o preparati di femori con ferite p1·odotte -sparan do a distanze diverse.
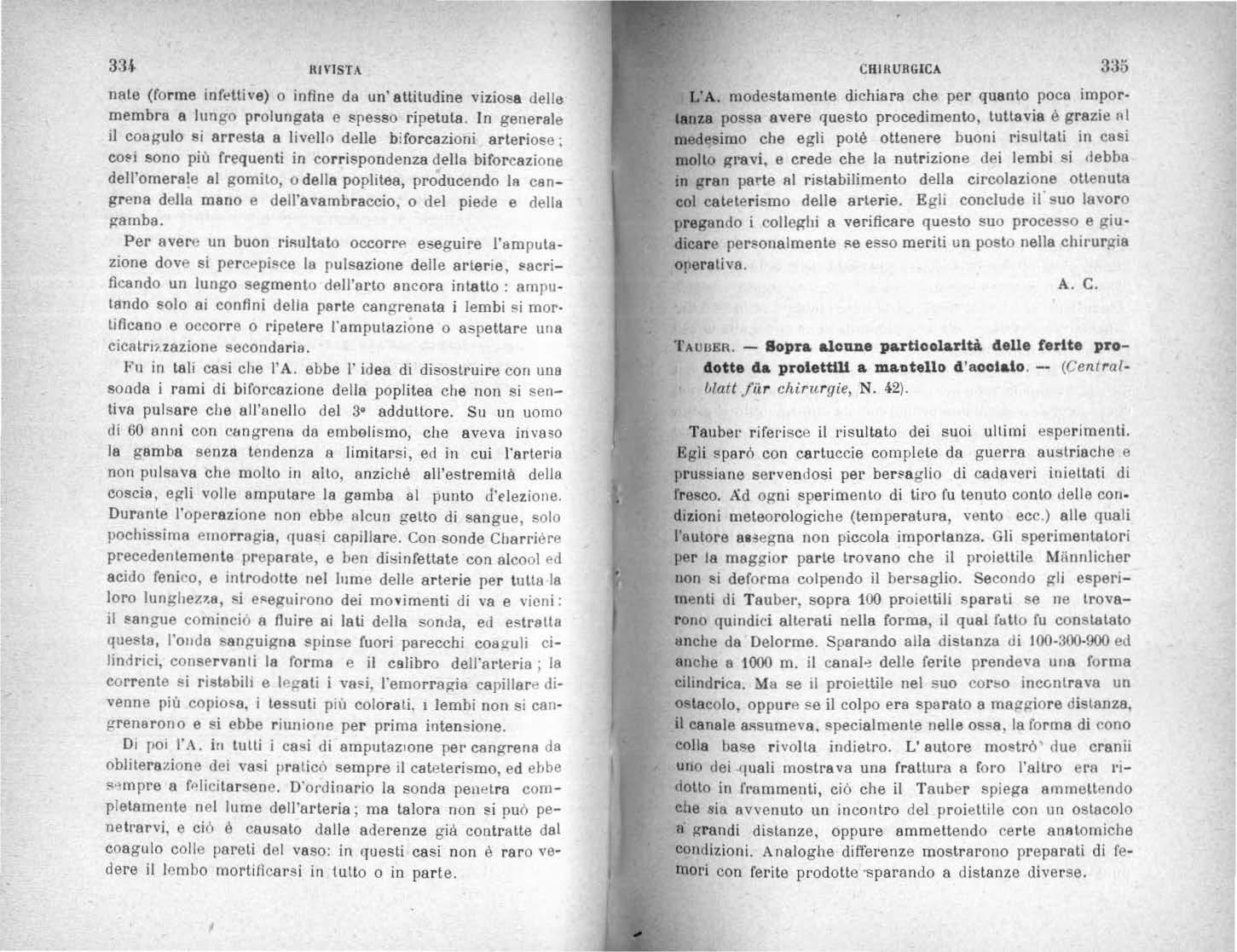
EBER\fANN. -Sulle l81loDlde1 OI!&Dlo prodotto dal prolet · tUe a mantello. - (Cenlralblatt fùr Chi r urçie, N. i2) il p:oteltile dopo uvere In porr.ione
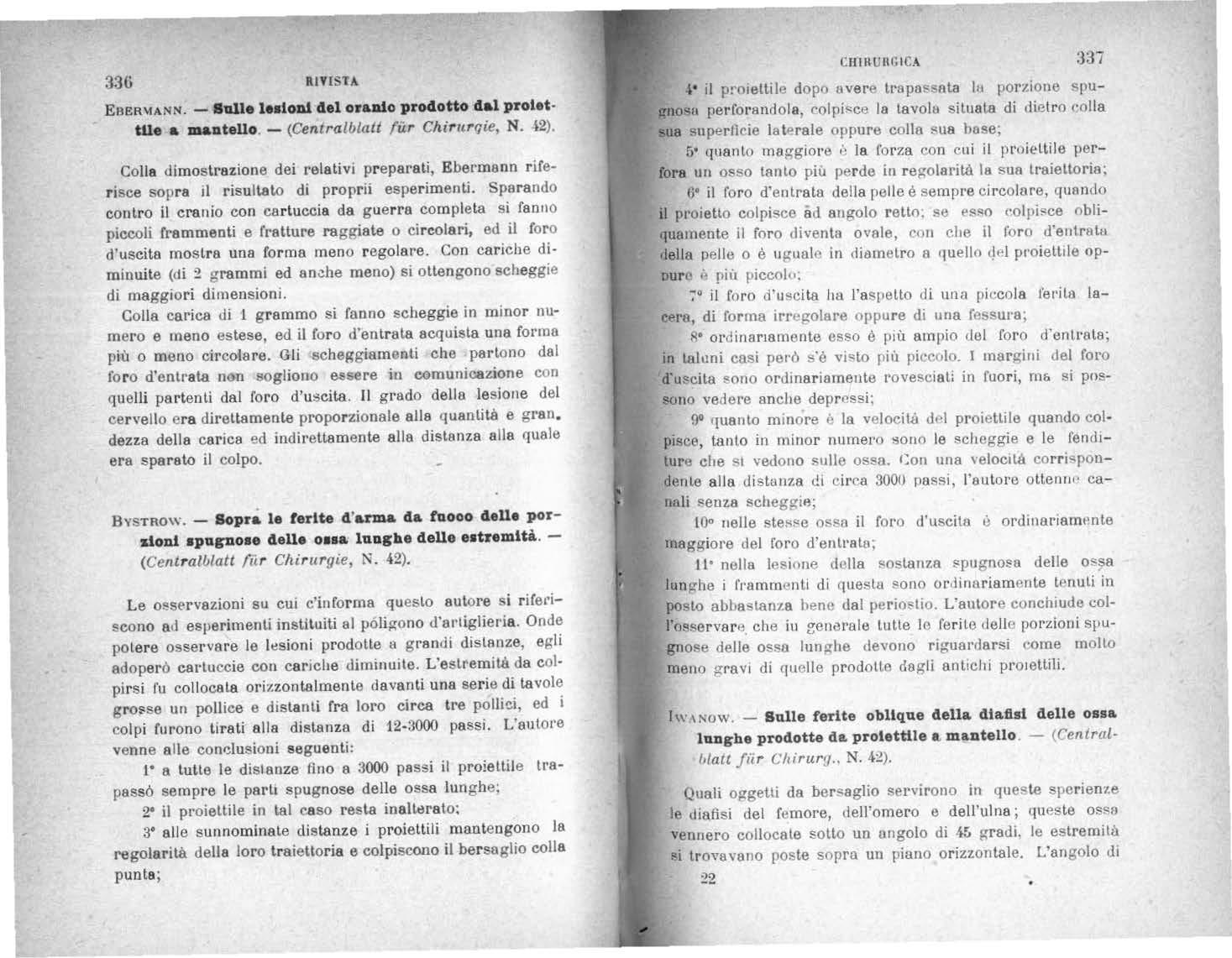
Colla dimosLrazione dei 1•elatìvi preparati, Ebermann riferisce sopr a 1l ris u ltato di proprii esperimenti. Sparando contro il cranio con cartuccia da gue r ra completa sì fanno piccoli frammenti e fratture o circolari, ed il foro d'uscita most r a una forma meno r egolare. Con cariche di· minuite (di 2 grammi ed meno) si ottengono scheggia dì maggiori dimensioni.
Colla carica di 1 grammo si fanno scheggia in m inor nu· me r o e meno estese , ed il foro d'entrata acquista una f01•ma più o meno circolare. Gli scheggiamenti che partono dal foro d'entrata non sogliono essere in comunicazione con quelli partenti dal foro d'uscita. Il grado della les ione del cervello e ra direttamente proporzionale alla quanlilà e gra n. dezza della carica ed indirettam ente alla distanza alla quale era sparato il colpo.
A'OO"" perfo1•and ol a , colpi"ce la tavolt1 situata di dietro l'Olia sua !iUperlicie oppure colla base;
5• quanto maggiot•e i\ la forza ron cui il prc)ietti le perrora un tanto piu pf> r de in re golarità la sua traiettoria: li• il foro d'entrata della pelle è sempre circolare, r[UI!ndo il pt'oietlo colpio:;ce ad angolo r eLlo. se c·olpisce obli•luameute il Coro diventa ovale, con che ti foro d'entrAla
•Iella pelle o è in diametro a quelln dPl pl'oiettlle opnur <' ... piu piccolt•.
7v il foro ha l'aspelto di utHI pir·cola ltwila lac.,ra, di forma irrt•golare c1ppure di una
H• ordinariamente esso è fHÙ ampio rlel foro d'entrata; in tal uni casi pe1·ò s'è vi.;to più pi<'colo. l margini del foro d'ul'cita sono ordmar iamente J•ovesctal• in fuo ri , m& SI posl'ono vedere anche deprr!ssi;
9o ']Uanto mmore e la velocit8 d..l proiettile quando col· pisce, tanto in minor numero sono le schcggie e le fendltur" che vedono sulle ossa. t:on una veloc1tA corr i.;pondente alla c.listanza d1 ci r ca 300() passi, l'au tore ottenlll' canoli l'enza scheggt";
BvsTROW. - Sopra le ferlte d 'arma da fnooo delle p orsloul spugnose delle ossa lunghe delle estremità . -
( Ce11t r alblatt (1i.r Chirurgie, •. 42)
Le osservazioni su cui c'informa questo autore s i rife,·i!!cono a cl esperimenti msliluiti al poligono d'artiglieria. Onde potere osservare le ltJsioni prodo tte a g ran di distanze, egli adoperò cartuccie con car1che diminuite. L'estremità da colpirsi fu collocala orir.zontalmente davanti una ser ie di g r o$se un pollice e d1stanti fra loro circa tre pollici, ed l colpi furono t1 r ati alla distanza di 12-3000 passi. L'auto1•e venne alle cont!lusioni seguenti: t• a tutte le dista nze fino a 3000 passi il proiettile tra· passò semp1·e le parli spugnose delle ossa lun ghe:
2• il proiettile in tal caso res ta a• alle sunnominate distanze i p r oiettili mantengono la regolarità della loro tr aie tto ria e colpiscono il bersaglio colla punta ; tOo nelle sles!<e O!'Sil il foro d'uscita ù ot•dinariamenle magg iore del fOI'O d'entJ•attl; l w \NOW. - Sulle feri te o blique d ell a. dla.fisl delle oss a. luu g he prodotte d& prole ttlle a. m a nte llo . - (Cen.t ral· l1/alt Jiir Chirury .• N. 42).
1t· nella lf>stone della Mslanza spugnosa delle Ol'Sa i frammenti di questa sono Ol•,linariameule tenuti in posto abhastanta henc dal perio,..lio. L'autore conchiudo coll'osserva r t-l. che iu zenarale tulle le fe riLe de lle porzioni spudelle ossa lunghe devono rigua1·darsi <·ome mollo men o grav 1 di quelle prodolle dag li anl1Ch1 pi'Oietlili.
Quali oggetli da servirono in sperie01.e )p diafisi del ùelJ' omero C dell'ulna i queste OSS8 vennero collocate !!Ollo uo angolo di 45 gradi. le estremità si trova vano poste sopra un piano orizzontale. L'angolo ù1
CHIRIJRf.ICA
i:l g :ad i perché in gue1-ra in causa dei fr equenh s1 verificano in grande quanlilà di queste obflrrue. scopo di dal'e un'esalta defìoi z ioo e d elle partid1 ferile, ogni diafìsi fu divis a m tre sezion 1: una sezion e a ssil e e due sezio11i laterali.
Ecco le l ) P er· la enorme forza viva del nuovo proiettile l'autore non potè ottener e a lcuna frattura a fo r o. i ) l proieltilt defo rma ti agiscono co n effetti esplos 1vi. lO) l ''llSi ed i ne r vi per lo più r estano iulattr eccettuali ca si in cui !; i esplica l'az ione elSplo!'> i va del p r·oi,etlile. li ). A l. femo r e ed .all'omero 11 fo r o d'entrata puo risultare pru p1ccolo del diametro del proiettile.
2) r .che colpiscon o obliquamente spiegano az1on e p1u d1Sli'Utl1va che rru clli chr col piscono direttamente.
:J) Xon fu ma1 osservata pc•netl'a zione del proiellile nell'osso.
Il numero delle scbeggte c r esce col della carica .
5) Anche aum e ntando la lontananza si agqrava la lesione.
H) Le g r avi con tu sio ni e 1·ano prodotte so lo ùa colpi di r1mbalzo.
X) La ti bia e l'ulna si cornpor·ta no diversame nte ciel femore.
. fl) Le sporgenze e scabr cuo delle ossa favor·iscono l'az1one esplo:;iva d<•i proiettili.
PAUI.ow. - Sull'importanza della terra , dell'acqua , delle pietre e degli alberi quali mezzi eU protezione contro le ferite del proiettile a mantello. - (Cent ralblatt (1ìr C'hiru r u., N. -i2).
Si a ccen na th1 Pau low all'impor·Lanza dt>l quesito :>ulla cltfesa dei posti di medicazione contro le lesioni causote rla1 p.roiettili a mantello nelle fu t ure guerre e in pari tempo ci SI fanno conoscere gli esperim enti che ci devono dire in mi s ura la ler1·a. l'accrua, 1-!ii e cc., da uoa parte i lt:lrra pieni artificia li con n ltr e operd di difesa dalrallra possono proteggere il co mba ttente dai nu ov i pr oie ttili .
C()ll'aiulo d i Leboulang:er efiii ha va lutata e determinala esattamente la fo rza dellt> ca r iche ed ha lr o"ato -ehe il p ro iettile ad una distanza di 30 spa rat o da una carica comple ta contro una tavola di 36 pollici la perfora; con una cari ca di 2 g rammi ne perfo r·a una di 27 •;, pollrci; con un gra mmo e'/ , uua di l 'i, con un g•·arn mo una di 8 1/ , , e .l all'I n con tr o colla c ar ica d1 m ezzo g rammo 11 pr oiettile può 'ft!rmarsi nella canoa dell'arma. X el co l pi r e l'acqua solto un più piccolo di go le palle rimbalzano, qualunque s1a la carica , e r imbalzauJo J•nssono c·a usarP g r a\'t fe rile Lo spessore dello slralo d'acqua anche d1 un centi me tro non prote gge da llllll ferilu di rimbalzo, come fu dimost r alo dai gua sti pt•esen lati da una tav o la che servì ùi bersa g li o imm ersa nell'acqua. se l'angolo di del proiettile tli s· opp ure suptwiore ad 8° il pr oiettile all ora non fa rim balzo ma precipit a al fondo; poi nPII 'acqua vi e una leggera ondulazione esso puo usci1•ne per t·imbalzo e p r cJdur·re ancora de lle fe1•itc. Srlll rand o cont1·o ripar1 d i sabbia u m ida o di crelu, la Corta della ca r ica n o n mflui;;,ce sul gr·udo ò1 pt>nelrazione del p1·oiellile 111 quel male ria'e. Con una car ica completa e alla di s lanzn d1 3UOO pass: il p 1·o ir llile, dopo d'e:-:<:ere penetrato per la p r orondilu di - o,v; m. non può più Lrapassa1·e una la vola postH diet r o il Lerrapjeno; ma in esso p1·oieltile uon penetl'a al òi là •li r.o cen\im P.Lri la del te r rapieno. La manl:allza di uua ap· pr t>zzahile d1versitit n e lla pene1razio11e de l proiettile ne l terr apie no, con t·ar iclw di rorza si puo c:piega re cotrammeltere che il pr01eltdo spar·ato a p1o•ua cnr1<'a, colpendo rtuel be r c:aglio pel'dA mollo della sua l'orzi\ ' ' iva e c·IJe proceda innanzi il'rPgolarm..nle, co11 ch13 la terra eh<' dlllnan zl al proietti le vrene l'ortemt>nle comp r essa offt·eu do CO!!I al fH'oiellile una maggior" r el'is lenza. Con ca1·icl:e 1 iu deboli il proiell1le prendi' un decorso l't'gola r <?. l terra· pieni a parPti perpend icolari sono q uel11 clte proteggono m e_lio, allrimenli i r im baLli per i •1ua li il proiell.le SI de - forma e pr oduce lesioni più gravi sono in evitabili. Del J'alLPrazione di fo:·mn del nuovo proiettile a ma ntello è moll•} più lieve che quella Jel proiettile anlico di piombo nurlo. Le pallottole che sopra un terreno orizz ontale colpiscono solto un angolo mino r e di 15 fanno o r dina r iamente dei ri mbalt.i. Sparato contro albe r i il proiettile a mantello a piccole distanze piil pt•ofondamente che a distanze maggio ri, ment r e il fatto oppos to si è osset•valo co! proiettile Berdan. te!<-,ut i gra\'emente affetti e formazione "uccessi'a di ca vita put·ulenla ben delimitala. li metodo ò il seguente: Dopo avet· purifica ta Ja pelle con etere <>ino al di là dei limi ti deii'AI'ea infiammata si copre lu cute Ji uno spes!-<O !'tr ato di o'alta !'.grassata ed imbevuta l'alcool, coprendo p oi I'(UesL'ultirna con materiale impermeabile allo scopo di im pedir e l'evaporazione. P erò questo materiale non de.''e c h iudere el'melicam,nte p01chl> in la! caso sarebbe favortta l'az ione cauterizzante , ma deve esser·e provveduto di fot•i o ppure applicalo a striscie separate tr•a loro da uno spazio. 11 tutto e poi coperto ed involto da una fascia d1 cambric. L'apparecc hio può r·estare in si lo generalmente 2.i o r e; nei casi gravi si t'accomanda di cambiat•lo dopo 12 o r e . P iù ta rJi, quando il delle parli é dilllinuito, rappat·ecchio pu ò da due a tre gi(ll'ni. Se esistono ferile, l'autore lo copr e co11 garza asciutta oppurP le tampond; vi soprapone un a compl't><;sa imbevuta ù'a lrool e quindi il restante mate 1·iale. Cos• ev1lali anche i pii! lievi dolori 1 quali cet·to !" en za questa cautela !'.i provocherebbero per il contatto dell'alcool col!P superfici piagale. L'alcool da deve essere al 60 o al 90 s i può adoper·are anche l'acqua di colonia, m a con cautela perchè che g-li olii eterici che in C!<'ll'\ sono conten u ti abbi a no a zione i1·ritanLe. Tanto la febbre come la tumefazione locale sogliono sparire.
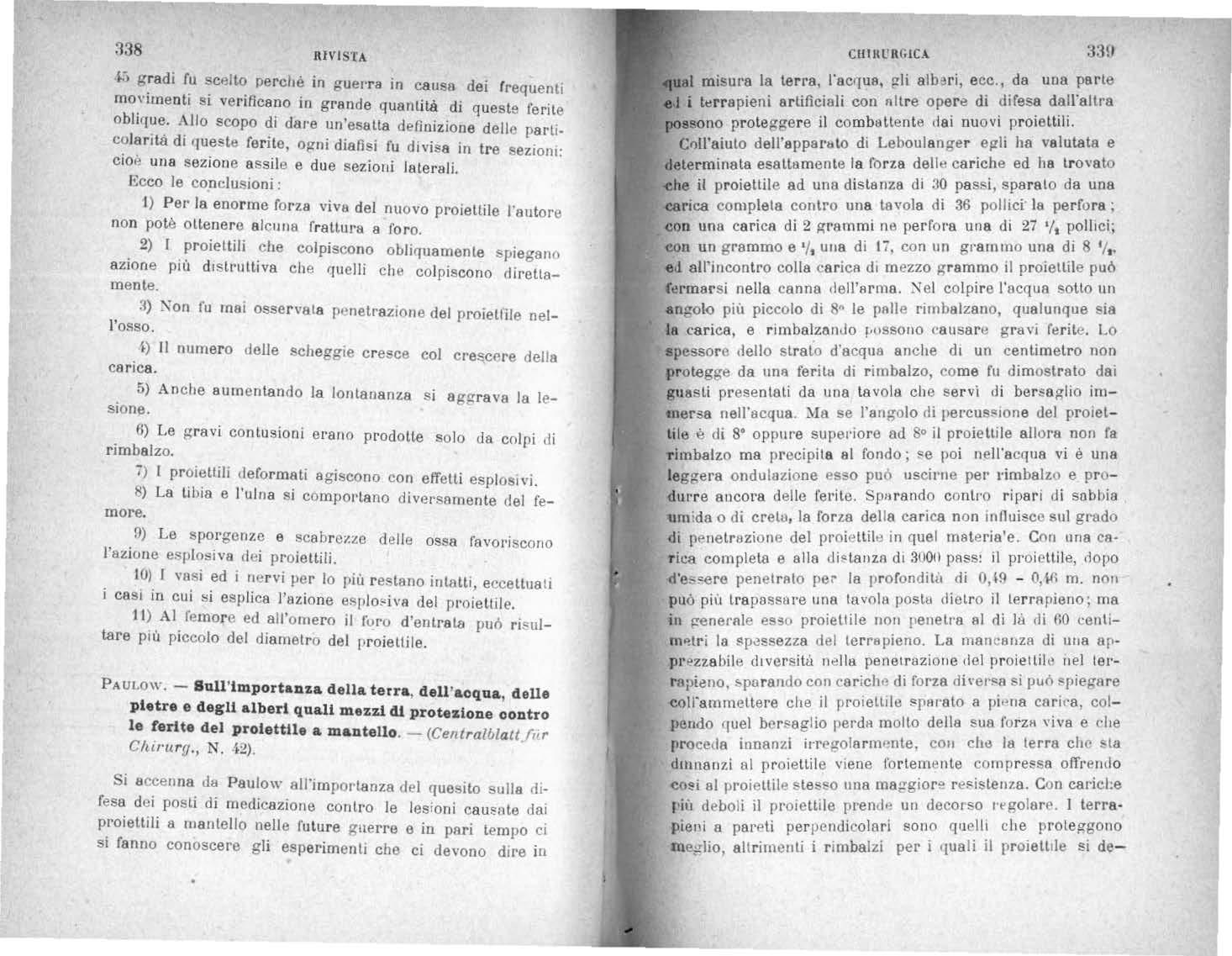
I nuovi proiellili penetrano ad una dl'llanza di 200-1:30 centimetri, ed a 600 pasc;i penetr ano sollanto a 31 cenlimetri. All'incontro il p r oiettile Berdau a 200 penetrava sino a 16 centunetri a 600 fino a 3l. Pei·cio un uomo cbe si trovi dietro tl'un albero a 200 passi dal ne mico puil esse re nsparmiato .tal proiettile Bet·dan, mentre che alla distanza d1 600 passi può dallo stesso proiettile essere ucciso.
Dai nuovi proielt1li dobbiamo aspetlat•ci il contr·ario. Un che trapassa la parte mediana Ji un albero va ollt'e in linea retta mentre se esso colpisco le parti laterali v1en deviato lateralmente soLlo un angolo di 8-10°. Finalmente ì· da notarsi che il nuO\'O pro1eltile urtanJo contro un sasso vien deformalo ed 11 sasso è me;oso in f1·antumi. Pietre della g t'O'lsezza di una se non sono mollo aderenti al terr eno si mettono in movimento per l'incontro del proiettile e rotolano sul terreno co1ne palle Ja gioco. Il proiettile Herdan invPce non l'eanturna lo pietre, ma si appiattisce completamente sulle medesime.
SALZWEDEt - Il trattamento dello infiammazioni ftemmono•e mediante medio&zione continua di alcool.' Deulseht• mililii.r iirztl. 7. eil. e Ceniralùlatt, N. 45).
L'autore descrive per la cura delle infiammazioni flemmonose un nuovo metodo con cui egli avrebbe ottenuto un r isullato veramente idea le. Rillroht dice che questo ri sultato consisto essenzialmente: o in u11 regeesso quasi abortivo della flogosi leggere, oppure in una tumefazione di parli alquanto infiammate, con rapida scomposizione dei