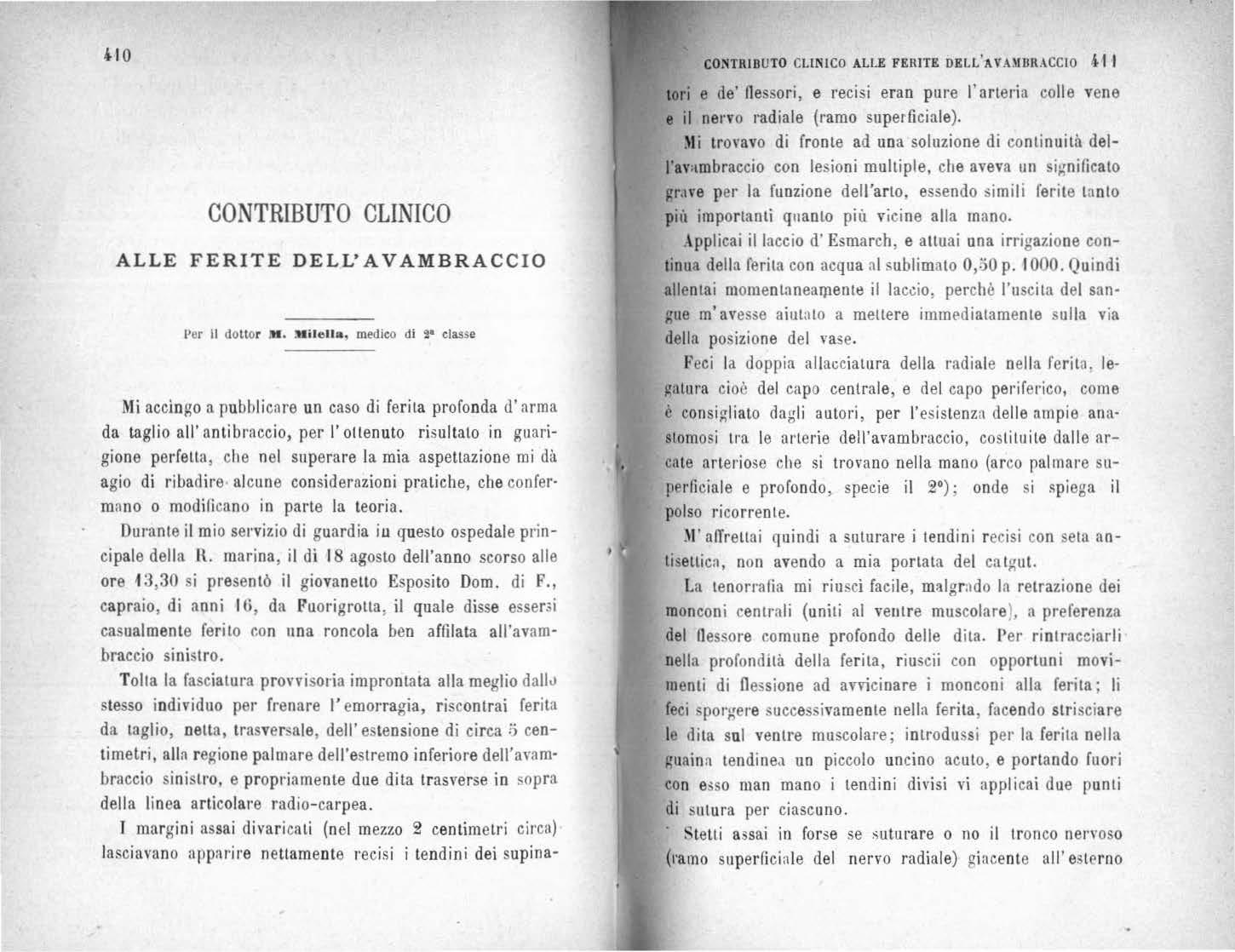
37 minute read
CONTRIBUTO CLINICO
ALLE FERITE DELL'A V AM B RA CCI O
Per Il dottor M. Mi l e ll a, medico di i• classe
Advertisement
Mi accingo a pubblicnre un caso di ferita profonda d' nrma da taglio all' antibrnccio, per l'ottenuto risul tato in guarigione perfetta, che nel superare la mia aspettazione mi dà agio di ribadire alcune con siderazioni pratiche, che confer· m:mo o modifi ca no in pa1·te la teoria.
Durante il mio servi zio di gunrdia iu q uesto ospedale principale della R. marina , il di 18 agosto dell'anno scorso alle ore 13 , 30 s i presentò il gio vanetto Esposito Dom. di F., capra io, di anni Ili , da Fu origrolla, il quale disse esser3i casualmen te ferito r.on nna roncola ben affila ta all'avambraccio si ni stro.
Tolla la fasc ia tum provvi soria improntata alla meglio dallv stesso individuo per frenare l' emorragia, risc ontrai ferita da taglio, netta , trasversale , dell'estensione di circa i) centim etri, alla regione palmare dell'estremo inferiore dell'avaro· braccio sinistro, e propriamente due dita trasverse in sop r a della lin ea articolare radio- carpea.
T margioi assai divaricati (nel mezzo 2 centimetri circa) la sc iavan o appar ire nettamente recisi i tendini dei supina-
CONTRIBUTO CLINICO ALLE FERITE DELL'AVAMBRACCIO 411
tori e de' Oes so ri , e recisi era n pure l'arteri a colle vene e il nervo radiale (ramo superficiale).
trovavo di fronte ad una soluzione di contin uità deiJ'av•trnbraccio con lesio ni multiple, che aveva un significato per la funzione dell'a r to, essendo :>i miti ferite tanto più importanti qnanto più vi ci ne alla mano.
Applicai il laccio d' Esmarch, e attuai una irriga1.ione continua dell a ferita co n acqua nl sublimato o,:.>o p. 1000. Quindi allentai il laccio, perchè l'uscita del san· gue m'avesse aiutato a mettere immt>diatamente su lla via della posizione del vase.
Feci la doppia al lacciatura della radial e nella fe r ita. lecioè del ca po centrale, e del capo periferico, come è consigliato dagli autori, per l'esis tenza delle ampie ana· slomo si Ira le arterie dell'avambraccio, costituite dalle arcate arteriose che si trovano nella mano (arco pal mare s upt>r·flciale e profondo , specie il 2°): onde si spiega il polso ri co rr ente .
.\1' afTrettai quindi a suturare i tendini r ecisi con seta antisettica, non avendo a mia portata del ca tgut.
La tenonalìa mi riu scì fa cile, m:}lgrado la relrazion e dei moncon i centl'nli (uniti al veutre muscolare ), a preferenza del Oessore comune profondo delle dita. Per· rintra cciar li nella profon datà dell a ferita, r iu-cii co n opportuni movimenti di fi e'si one ad avvicinare i monconi alla ferita; li feci sporgere successivamente nell a ferita , facend o stri sciare le dita sul ventre muscolare; introdussi per la ferit a nella guain a tendine.1 un pi cco lo un cin o acuto, e portando fuori con e3so ruan mano i tendini divisi vi applicai due punti di ·utura per ciascuno.
· Stetti a ssai in forse se suturare o no il tron co nel'voso (ramo su perfi ciale del nervo radiale) all' estl' rno dell'arteria. Mi conte nta i ùi far venire ad immediato coni mon co ni del nervo di \'iso, dando all 'arto una po. srz1one conv eni ente, como dirò in seguito, afOn chè, rilassan do le parti , i due monconi r·estassero tra lor o avvicinali.
Yeoni nella determinazi on e di non fare la sutu ra del nen·o ' non per tema di svolgimento di processi infiammntnn violenti, es ·endo·i veritìcati de' casi di con LAn 1lenza alla diffusio ne, e in ci rcostanz e partico lari (infezione con bacilli di Nicolai'er) anche il tetano; ma la credetti non necessaria. poiclrè anche l'esperimen to (Landois, Eulenbu q:r) ha dimo · st rat o che non avviene mai la r iun ione per p1·ima intenzioue de' monconi di un nervo sut umto.
Av viene però la cic atr·izzazione, come è avvenuta nel no,;tro caso . co nfermandosi nell'uom o l' e' perimento eseauilo neali l" ,. animali di inn es ti anche di pezzo di ner vo di nltro ar11ma le r.on ripristino della funzione del nervo diviso. Dunqu e pe r tale fe r ita di ne r vo r·ecentissima, ho osser·vato ripristinar;;i la funzione de l detto nervo; ho veduto la mano tornare nelle condizioni norma li, co me desc r iverò appre.;so.
E qui cade acco ncio rip ortare gli ultimi studi sperimentali co mpiu ti intorno alla rigenerazione dei nervi perife · ric i del pr·of. Morpurgo, pubb licati testè « Alli dell'Accademia . d. Se. med. e nal. eli Ferrara » (111 18!H).
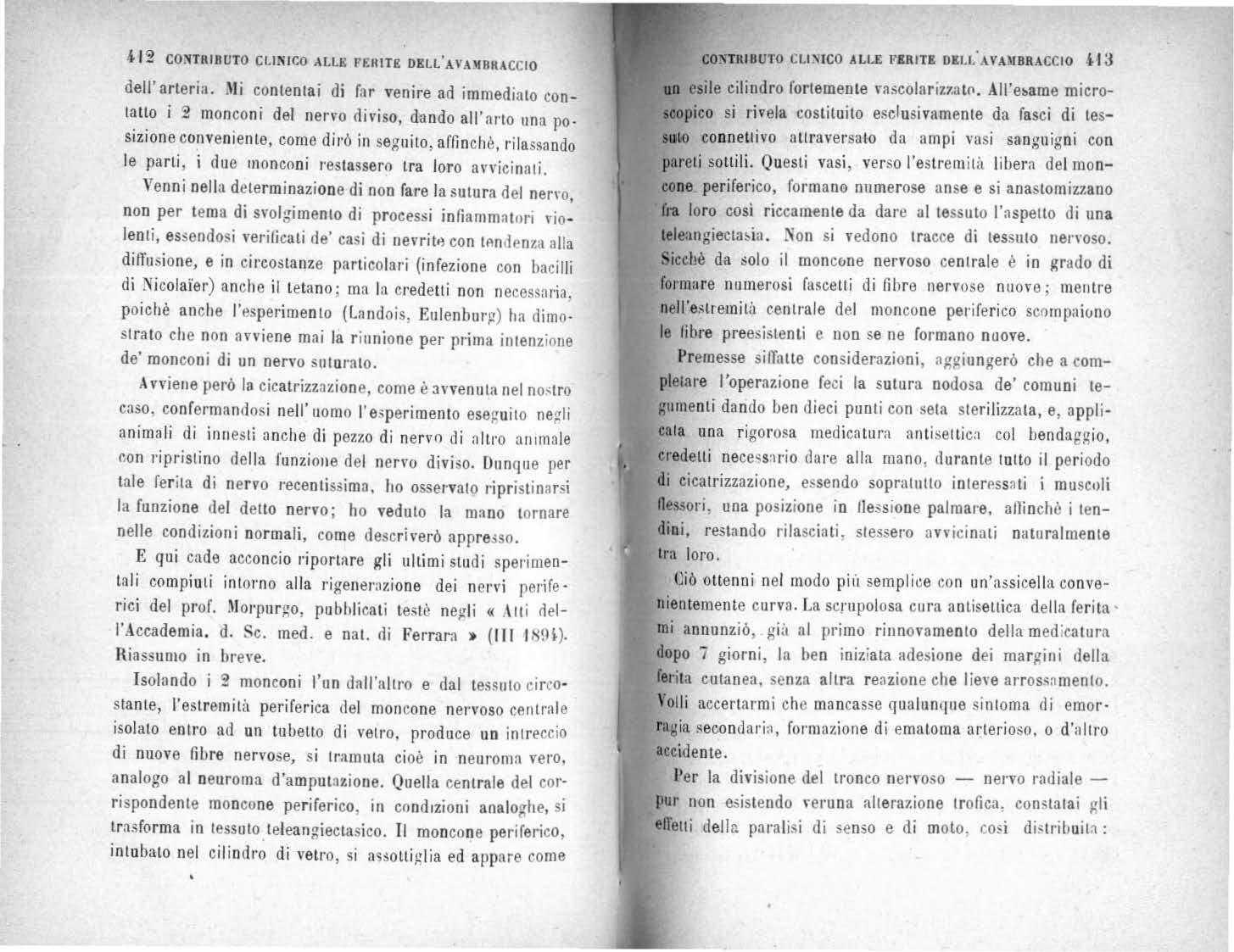
R iassumo in breve.
Isol a ndo i 2 monconi l'u n dall'altro e dal tes:>uto stante, l' estr emitit periferica del mon cone nervoso centrale isol ato entro ad un tuoeuo di vet ro, produce un intr eccio di nuove fibre nervose, s i tr·:unuta cioè in neurom a vero, analogo al neuroma d'a mputazione. Quella centrale del corrispondente monco ne per iferico. in co ndrzi oni ana loghe, si tra sforma in tessuto te leangiectasico. Il mo nco ne periferico, int ubato nel cilind ro di ve tro, si ed appare come
110 rsile cilindro fo r temen te microscopico si riv ela costituito e:;clusi vamente da fasci di tesMIO connett ivo aurave rsato da ampi vasi sanguig ni co n pareti sottili. Questi vasi , verso l'estremiltt libera de l monco ne perifer·ico, formano numerose anse e si anastomizzano fra loro così ri ccamente da dare al tessuto l'aspetto di una teleangiecta!>ia . Non si vedono tracce di tessuto nenoso. icchè da solo il moncone nervoso ce ntral e è in grado di formar e numerosi fascetti di fibre nervose nuov e : mentre nell'e;;trern itit centrale del moncone periferico scompaiono le lìbre preesisten ti e non se ne formano nuove.
Premesse siiTa tte considerazioni, che a completare l'operazione feci la sutura nodosa de' comu ni tegumenti dando l>en dieci punti con seta steri lizzata, e, applicala una r igo ro&.a medicatura an ti se tti ca col bendaggio, credelli dare alla mano, durante tutto il peri odo di ci catrizzazione, sopratntto interPssati i musc1>li nessor i. una posizione in flessione palmare, allinchè i tendini , restando rilasciati, stessero avvici nati naturalme nte tra loro .
Ciò ottenni nel modo pift semplice con un 'ass icella co nveniente men te cur va. La scrupolosa cura antisettica della ferita mi annunziò , giit al primo rinnovamento della medica tura dopo i giorni, la ben iniziata adesione dei della fer·ita cutanea, enza a lt ra re azione che lieve arrossamento. Volli accel'larmi che mancasse qualunlJUC sintoma di emor · ragia seco ndarht, formazione di ematoma arterioso, o d'al tro accidente.
Per la divisione del tronco nervoso - nervo radialepur non esistendo çeruna alterazione troficn. con,tatai t•li • r" effetti delle. paralisi di senso e di molo. cosi : ipoestesia alla ente dell'eminenza te nare; ipoeste si a alla ente della faccia dorsale del pollice, della ·l" f3lange dell'i ndice, e della metà estem a o radiale del medio.
In quanto alla motilità erano diffìcoltati i movimenti attivi di su pinazione, per la recisione de' tendini del lungo e corto supioatore, che ricevono rami dal nervo radiale; so pratullo mancanti i movimenli di flessione delle dita e del pollice in ispecie, per l'avvenuta rer.!sione de' rispettivi tendini; e difeuavano puranco i movimenti di e"te nsione per la pamlisi nervea parziale; sicchè si a\·eva per co nseguenza la forma pi ù evidente di paralisi della mano .
Questi i falli co nstatati nell'ago::to in presenza di colleglli del R. ospedale di marina.
Dopo 7-8 sellimane, ()Ssia alla meta di ottobre , presentni nuovam ente ai co lleghi il giovan etto Esposito completamente guarito.
:Xotavasi una cicatrice lineare, liscia, levigata. non retratta, libera, sconente, punto aderente a' tessuti soltostanti. La pelle della mano normale, non assolligliata , non fredda nè lisr: ia, di colorito normale, se nza alterazion e dellt' un ghie e de' peli. ·
L' arto , di venuto dapprima un po' magro pe1· l'inazio ne de' muscoli, l'i acq oistò il suo normale volume, avendo fallo eseguire de' movimenti a tempo opport uno, dopo anenuta la cicalrizznzione della ferita.
I movimenti aLLi vi delle dita si ristabilirono llento sto dopo l'elellrizr.azio ne dei muscoli (20 se dute di corrente far adica). Il callo conn ettivo formatosi atlorno ai monconi dei tendini divisi si venne isolando dalle lievi aderenze che aveva prima coi tessu ti circostanti, e sel've attualmente di mezzo d'unione fra i monconi de' tendini recisi.
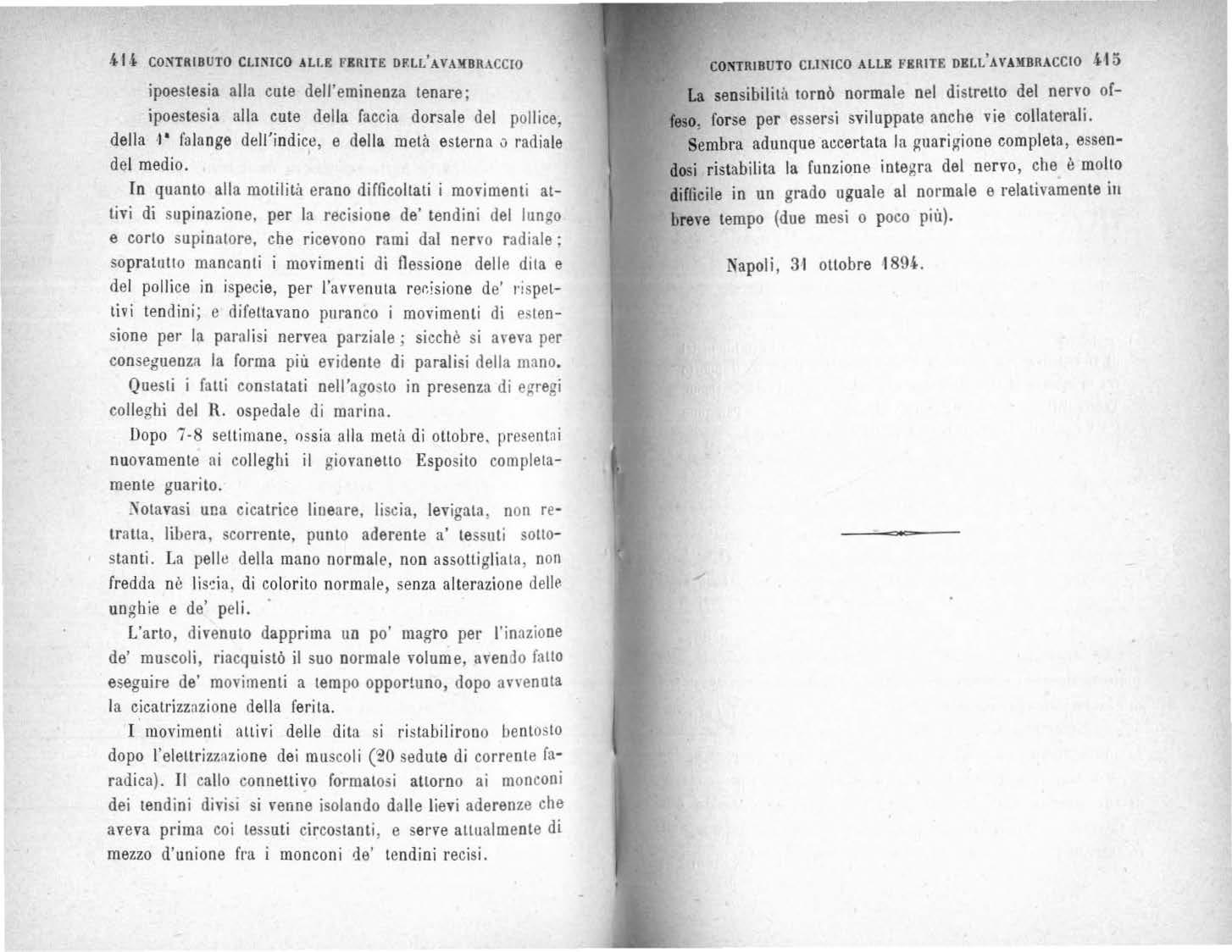
CONTRIBUTO CU'iiCO ALLE FBRITE DILL'AVAMBRACCIO 4. 15
La sensibiliti1 tor nò normale nel distretto del nervo offeso , fo rse per essersi sviluppate anche vi e collaterali. Semb ra adunque la guarigione completa, esse ndosi ristabilita la funziona integra del nervo, che è molto diflì cile in un grado uguale al ool'male e relativamente in breve tempo (due mesi o poco più).
Note Di Otta L Mome Tria
Del dott. Giae ome Luee io l a , capitano medaco l'iotrc r ò le est l!'iodiquer les Jlnc»C> de nou• nou s h:Hons d'ajouter que, pour ceux qui >C resigner a commetlre erreor' d'une demt-dioptrie ces llnesies tliilt:lraissent, eL l'otlhtalmométrie oc prtlsente a ocun e difficulté. h vAL.- lnlroduclion aux mimuirts lt'ophlalmométl'ie.
Descrizione sommaria e sguardo comparativo fra gli ottalmometri di Helmholtz, Javal-Schiotz, Leroy-Dubois e Reid. - Rapporto fra le misure ottalmometriche e la correzione dell'astigmatismo. Teorie dell'accomodazione nella visione astigmatica. - Paragone fra i risultati ottalmometricl o quelli della schiascopia.
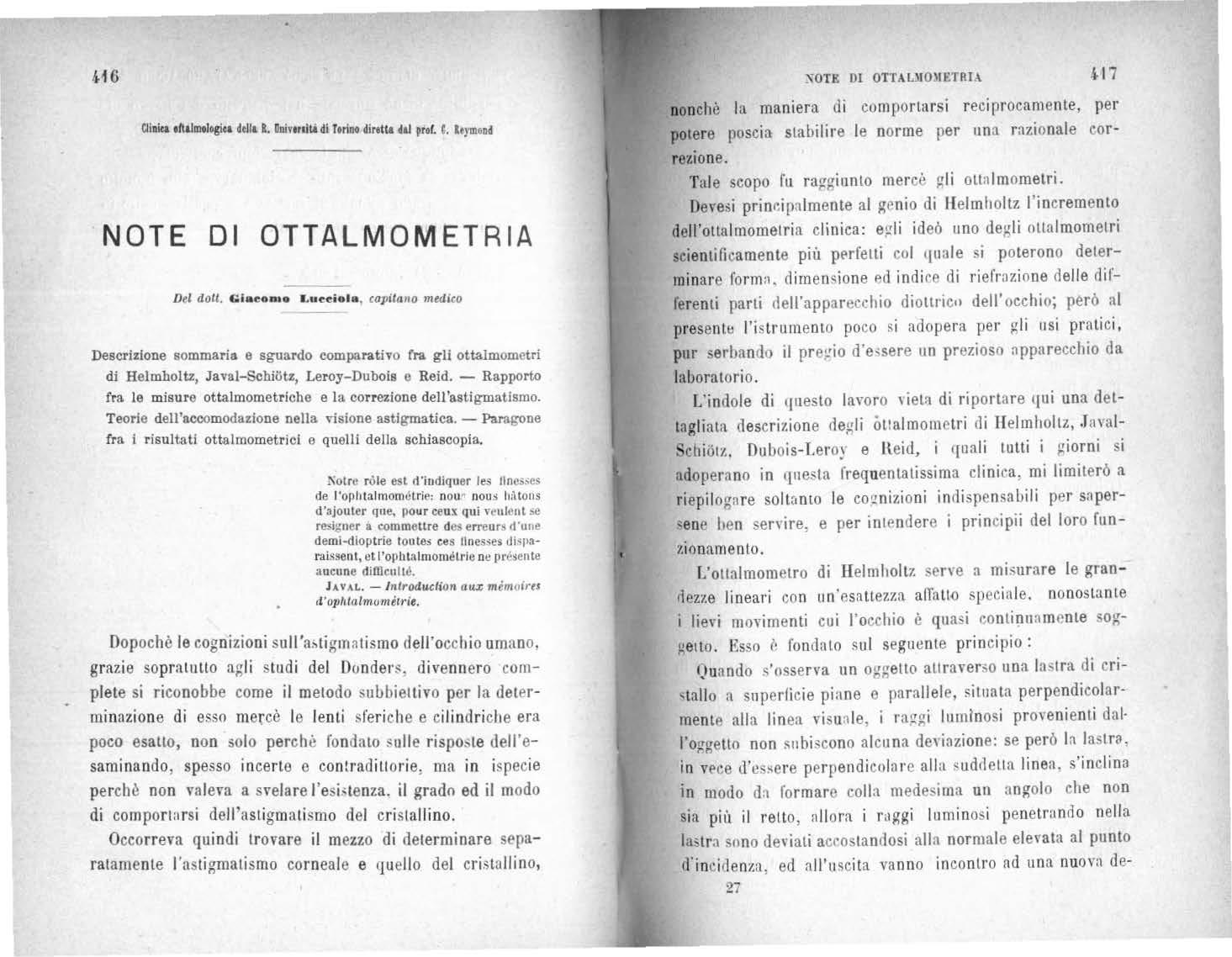
Oopochè le cognizioni sulf'a,..tigmatismo dell'o cc hio umano, grazie sopratutlo agli studi del Oonders. divennero complete si riconobbe come il metodo subbiettivo per la determi nazio ne di esso metcè le len ti sferiche e cili ndr iche era poco esano, non solo perchè fondato :'ulle r ispo:> te dell'esamina ndo, spesso incerte e contrad illorie, ma in ispecie percbè no n valera a svelare il grado ed il modo di compo r tarsi dell'astigmatismo del cristallin o.
Occorreva quindi trovare il mezzo di dete rminare separatame n te l'a stigmatismo cor neale e •1uello del cri5tallino, nonchè la manie ra di componarsi reciprocamente, per potere poscia stabilire le norme per una razi onale correzi one.
Tale scopo fu mercè ollalmometri.
Uevesi al gt'nio di li elmh oltz l'incremento dell ' olla lmometria clinica: egli id eò uno degli ollalmometri sc ien tificamente piti pPrfetti col tftJale si poterono determi nare forma , dimen.;ione Pd indirf' di riefr nz ione delle rliffe renti parti dell'apparecchio diollric•l dell'occhio; però al p resento l'i strumento poco si adopera per gli usi prati ci, pur serbando il pre!!io d'e'sere un prezioso npparecchio da labora torio.
L'i ndole di questo laYoro 'ietn di rip ort are <fUi una dettagl iata rlescrizione degli òttalmometri ili Helmltoltz, .JH\alScbiotz, e Jteid, i rraa li tutti i giorni si adoperano in t!tte:-ta rreq nenlalissima clinica, mi limiterò a ri epilogare soltanto le cognizioni indispensabi li per saper' ene hen seni re , e per intendere i principii del loro fun1.ionamento.
L'ottnlmometro di Helrnholtz se r ve a misurare le granrlezze lineari co n un' esa ttezza all'atto spec ial e . nonostante i lievi movimenti cu i l' occhio è rontinn1mrnte sogget to. Esso fondato sul seguente prin cipio:
IJu ando "'osse rva un oggello allraver;:;o una lo"tra di cria superficie piane e parallele, situata perpendicolarmente alla linea visu:1le. i raggi lumtno si provenienti dal· l'oggetto non snbi;:;cono alcuna deviazione: se però la la:;tra. in VPt'e d'esse re perpendicnlnre alla !".udrlell::t linen. s'inclina i n modo da forma r e colla no angolo che non sin più il retto , allora i n1ggi luminosi penelranrlo nella. lastra sn no deriati acrostandosi alla normal e ele,•ata al punto d' incidenza, ed all'uscita vanno incontro ad una nuovn de- viazione io se nso iover3o, allo ntanandosi cioè dalla normale al punto d'emergenza. l piedi del sostegno sono perpendicolarmente attraversati da viLi che servono alla livellazione dell'istrumento. Tn una scatola metalli ca quadrangolare annessa allo estremo anteriore dE'l can nocch ial e, c girerole intorno al suo asse longitudioale, ::ono situate le due ln slre rli cristallo summen;do nale , sovrapposte per uno ùei lati e moYibili mercé meccan ismo speciale in senso inverso e proporzionale attorno
Ne segue che il raggio subisce una deviazione parallela alla sua direzione primith·a, e l'oggetlo si vede spostato latern lm ente. Se, io luogo d'una sola di queste cosi dette la stre deviatrici, se ne adopera no. due identiche e sovrapposte per uno dei lati, le quali merrè speciale mecca ni smo possa no girare io senso inverso l'una suJI'altra. si no a descrivere a piacere una rotazion e intera. si producono anche ne•lla seconda lastra i suddetti fenomeni di rifra1.ione rispetto ma in inverso, percbè inverso t' il movimento delle due la stre. , uccede cioè che guardando l'otrgetto attraverso 11ueste, in maniera però che la linea di loro !iepa razione passi pel ce ntro ti ella pupilla, l'occhio 1 otlrit aur·<werso le due lastre, e se e,;so sono invece d'una sola immaginr dell'oggello ne appa-· riranno due.
La distanza fra le due immagini dipende dallo spe,sore e dall'indice di rifrazion e delle la stre. non che dall'an.,olo , d'incidenza del rag!!io luminoso, onero, ciò ch e inrlit·a la stessa cosa, dall' d'inclinazione che si da alle lastre.
L'ottalmometro di Helmhollz consta d'un sostegno a tr11 pi edi su cui è montato nn tubo a cannocchiale movibil e in senso verticale e laterale.
NOTK DI OT 1'.\LXO'tlKTRIA
all'asse verticale; la lastra superio re corrisponde alla metà superiore e quella inferiore alla metà inferiore d'un obbiettivo esistente nel cannoccbiale.- lnn nozi a questo. e perpendicolarmente al suo asse, si dispone un reg ulo graduato lungo ci rca un metro, il quale può girare in modo da essere adattato nella direzione di tutti i meridiani; sul meties imo si si tuano tre piccoli specchi spo3tabili a volootit ed ior.li nabili io tutti i sensi: servono a riflettere sull'o :chio da osservare la luce d' una lnmpada collocata al di sopra della testa dell'esaminando.
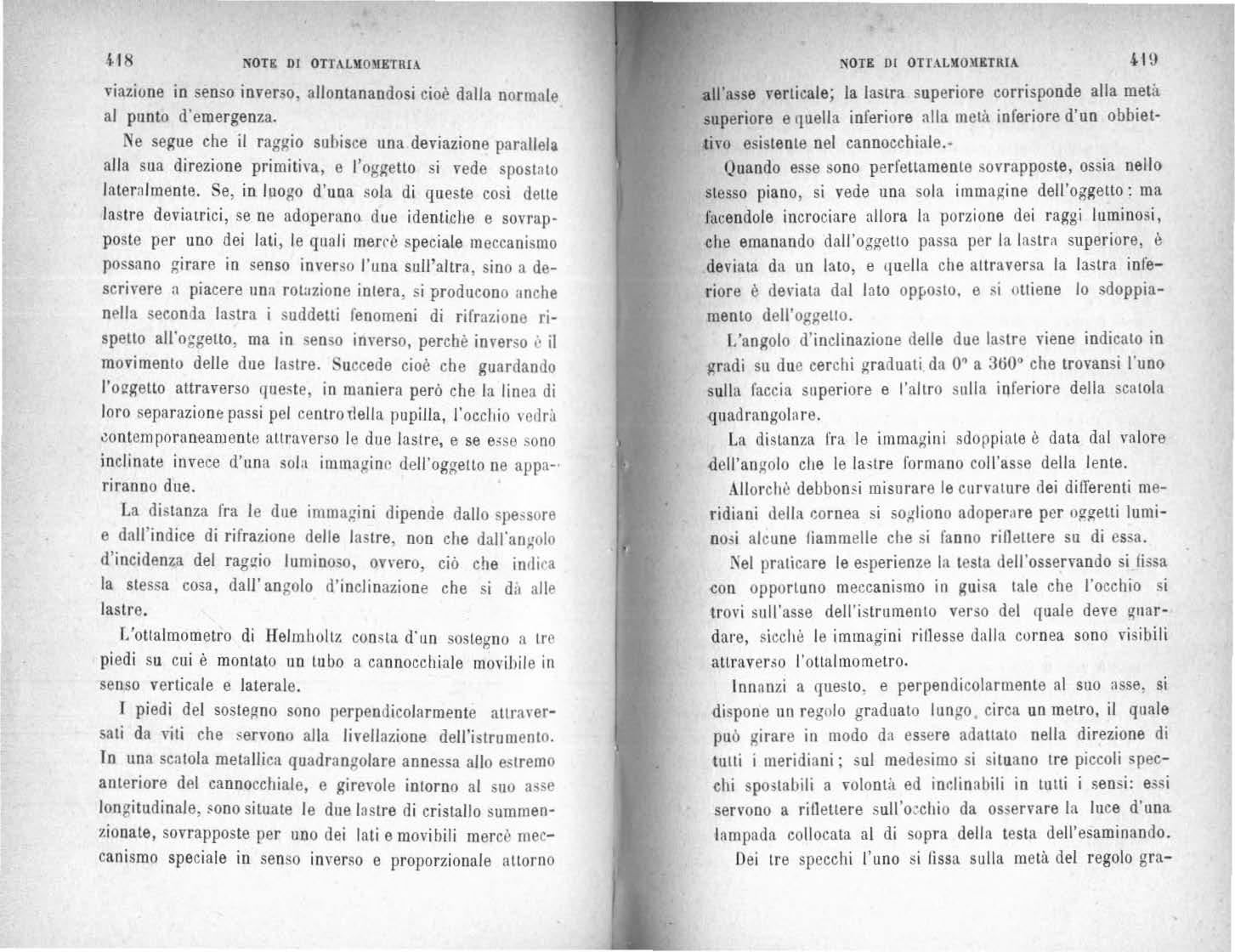
Quando esse sono perfeLlamente sov rapposte, ossia nello stesso piano, si vede una so la immagine dell'oggetto: ma facendole incrociare all ora la porzione dei raggi luminosi, che emanando dall'oggetto passa per la lastra superiore, è deviata da un lato, e tfuella che attraversa la lastra inferiore è deviata dal lato opfio.sto, e si ou ieoe lo sdoppiamento dell'oggello.
L'angolo d'inclinazione delle due lastre viene indicato in gradi su due cerchi graduati da a :360° che trovansi l'uno sulla faccia superiore e l'altro su lla inferiore della scatola quadrangoln re.
La distanza fra le immagini sdoppiate è da ta dal \'alore dell'angolo elle le la:;tre formano coll'asse della lente.
All orchè misurare le cu rv atu re dei diiTereoli meridiani della r.oroea si sogliono adoper.1re per OS!gelli lumino3i alcune liammelle che si fa nno riflettere su di essa. :\el praticare le la testa dell'osservando si fissa con opportuno meccanismo in guisa tale cbe l'occhio si tr ovi sull'asse dell ' istrumento verso del quale deve dare, siccltè le immagini riflesse dalla cornea sono visibili attraver;;o l'ol tal mometro.
Dei tre specchi l'uno si fissa sulla metà. del regolo gra- duato che corrisponde alla destra ilell'llsservatore e gli altri dne sulla mP.tà opposta ; ma per procede re alle misurazioni è che In l oro si faccia con norme determi nate, che si conosraoo cioè le dista nze intercedenti fra ciascuno di es:;i ed il centro di rotnziooe del regolo.
. A. le scopo. nelle nostre esperi enze, seguendo la pratica d t \\ OIDO\\. altlttamo colloca to lo specchio di destra a 21> cendi distanza dal ce ntro di rolazione, e degli specchi dt stntstra l'uno abbiamo fissal o a 12 '/'l centimetri e l'altro a 37 ' • centimetri da/ centro mPdesimo, si cchè ciascuno di restava distante l t • 1 ce ntime tri d:ll punt o del regolo sul quale è segonta la divisione corrisponJent e a 25 ceotimelri.
Note Di Ottalmometria
Per de termi nar e un raggio di curvatura d'uno dei .meridiani pri ncipali della cor nea, supponiamo de ll 'orizzontale. si proiettano su d'essa le immagini della lampada riflesse dai tre specchi, dopo aver disposto il regolo tt-.1sve rsalmente, poscia si dispone l'otLalmometro ed il suo oculare in mani era da \'edere nettamente le fiammelle sulla co t nea, ed in fi ne !>i girano le lastre si no ad otlenere lo sdoppiamento, e si fa la leltuna sulla scala graduala.
..
Pe.r ev.itnre di dofer dare in ogni osserYazione agli specchi l mclmaztone necessa ria onde riflellano sulla cornea l' im111agin e della linmma della lampada. Helmhohz ideò una 1:pcciale disposizione.
Si rl 55a cioè la lampada ad una distanza costante, e si situa il rego lo cogli specchi io maniera che ciascuno d'essi occupi se mpre un piano tangente ad una superficie sferi ca immaginaria , il cui ce ntro si trovi esattam ente nel mezzo della di,.tanza ch e separa la lampada dall'occhio esaminalo.
Pet· oggetto di cu i si vuole sdopp iare l'immaoine si adola distanza che intercede fra lo destra ed ti punto medio fra i due specchi di si nistra, dista nza chE> pel modo come ahùiamo dispo,ti gli specchi è di 50 centimetri .
Si fanno girare le lastre di cristallo sino a che l'imm agine sdoppiata dello specc hio di destra :si si1ui esattamente nel mezzo dello spazio c he separa gli specchi di sinistra e cosi la distanza tl i i.iO co nti metri mppres eoterà la dezza dell'oggello di cu i si misnra l'immagine .
Perchè i ri sullati sie no della maggiore esattezza possibile è necessario ripetere più Yolte la manovra dello sdoppiamento, ovvero si porteranno le lastre nei quattro settori di cerchio, girandole cioè sino a che aùbiano espletata un'intera rotazione, e si prenderit la media dei risultati otte nuti nell e qua ttro posizio ni.
Chiamando h la grandezza tlell'oggetto, ossia In distanza fra lo specchio di destra ed il punto intermedio a quelli di si nistra, a la distanza fra l'oggetto e la cor nea, la grandezza dell'imma., ine riflessa, 1' il di curvatura misuralo, c si ha: iccome nelle nostre esperienze abbiamo situato l'oualmometro ad l m. 25 di dista nza dall'occhio c)SServato, e siccome la grandezza Jell'oggetto per la suddetta disposi1.ione degli specchi è di iiO ceni. si hn ch11 lt della formula t'== 5 e q uin di r == 5 X
La grandezza dell'immagi ne noi la conosciamo dal valo re lin ear e corrisponde nte al grado di rotazione delle lastre oc· co rso per ottenere lo sdop pi ame nto: ora tutti i valori lineari ai .di rotazione necessarii per ottenere gli sdopptamenlt van so no in apposite tavo/e calcolate dal prof. A/bertolti ( l ), e perciò dopo aver letto sulla scala dell' olla/mometro il g rado di rotazione, si riscontra in delle quale valore lin eare corri spond e, e si moliplica per 5, e cosi si conoscerà il valore del raggio di curYalllra.
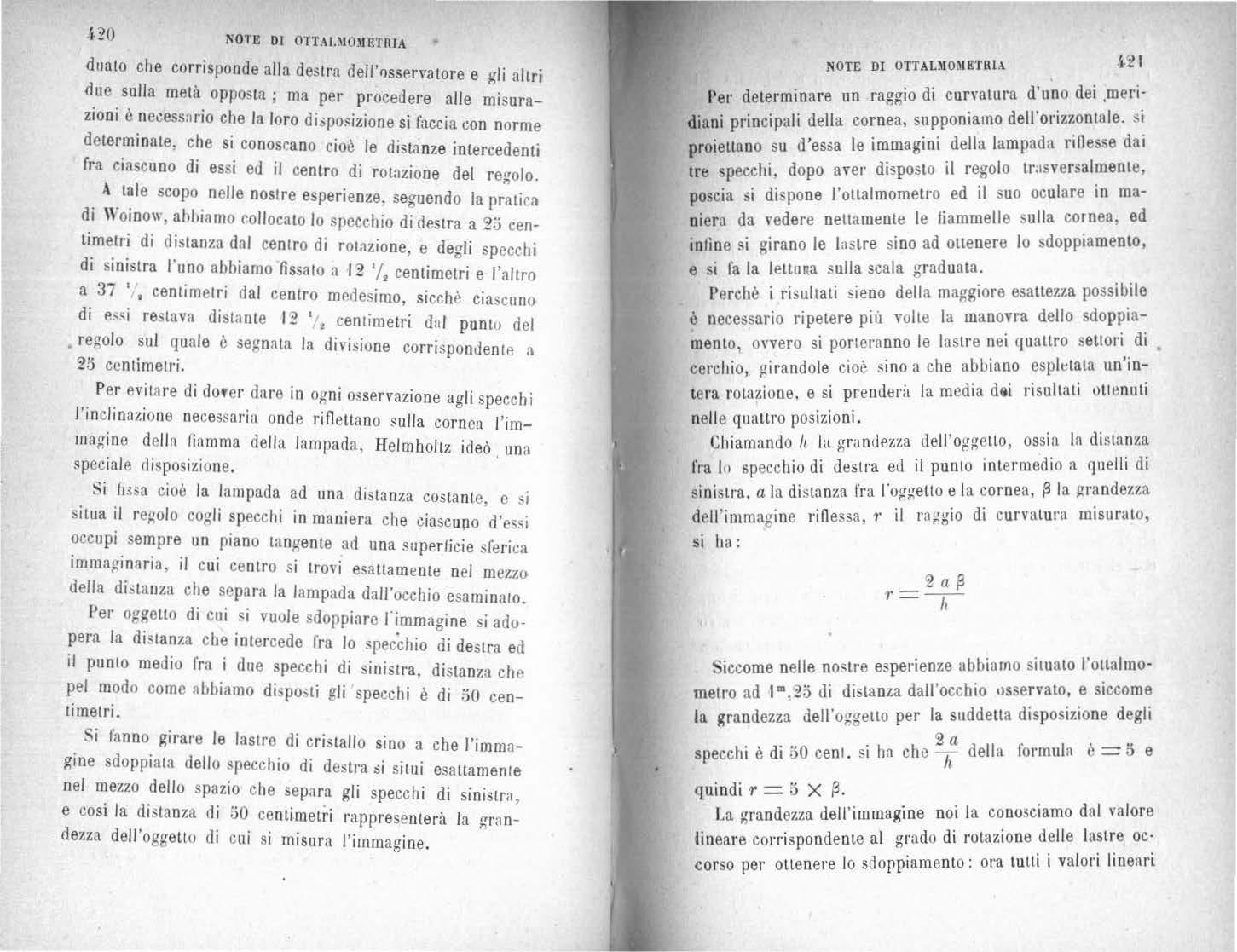
Devesi poscia determinare il rapporto tra il raggio di cu rvatura delln corneae la sua riefrazione misurata in diollrie . qui il ragionamento dello TschE'rning col quale si amva a conoscere La/e rappor·to:
La cornea considerata come superficie rifrangente ha un indi ce di rifrazione n e due distanze foca/i principali, l'anteriore, i/ cui valore si sa dalla diourica oculare essere 7'
. n 1' e la poslen ore ugual e a 11 1, lAquali si calcolano entrambe a part ire dalla superli cie.
La differenza fra le due distanze focali è ,., il che signifi ca che la distanza fra il fuoco posteriore ed il ce ntro è eauale a quella Ira il fuoco anterio re e la superfic ie. ,
Se vuolsi paragonare l'eiTetto della cornea a quello di una le nte posta nell'ar ia hi;;og nerà che essa sia situata al centro della co rn ea. ed abb ia una disranz·1 uguale alla dis tanza focale anteriore della cornea.
Si avrà adunque per questa lenlè
Se si suppone n== ·l ,3:37:.>, cifra assai veriliera determinata da .lavai, si ha r F ==o e r è espresso in millimetri lo sarà anche F, e chiamando J' il valore in diourie della lente si nvra l"' IOOO•n x== F == - 1'-,- == - r- ' ma il raggio noi lo conosci:lmo, quindi eseguendo la divi sione finale si determinerà x ossia il valore in diottrie del ra ggio di curvi}.tura misurato.
Per mi su rare poscia il raggio di curvaLuro dell'altro meridiano principale dalla cornea, il quale sup poniamo verticale, si r uota il regolo in senso verticale facendo andnre in alto lo specchio di destro, si gi rn pure la scatola quadrangolare dell'ottalmometro sino a che la sua faccia superi ore diventi inferiore, e si procede pel resto nella maniera seguita pel meridiano orizzontale , si no a determinare in diottrie il valore del raggio di curvatura.
La differenza dei due valori in diottrie dei di curvatura indi cherà il dell'a tigmatismo corneale.
( l ) ALDKRTOLLI IUNIOR.- Gradufl;ionf dtll'otlalmo111etro di Helmhollz. Alti dolla regm accademia delle scienze di Torino, 30 aprllc:: 1882. inveco non solo penet rò nella pratica. ma si rese indispensabile. eli J a&al - Schiut::. - [l còmpito fu lvro a"evolato da Javal o , chiotz i quali, convinti delle diOìcollil che all'uso pr.1tico presentava il classico istrumento di Helmbollz, costruirono nel 1880 il loro primo ottalmometro che modificat·ono nel t 88n: riuscirono con esso n risolvere il problema di determinare i raggi di cunatura della cornea ed il suo astigmati,;mo senza calcoli, a volontil della luco diurna o di quella artifictale.
L'ottalmometro di Helmholtz ha re·o senza dubbio servizi grand issimi alla scienza, e riguardo voi all'astiJ:mntismo ha fatto riconoscerA che nella maggioranza dei casi e;;so è la conseguenza d'una costruzione asimmetrica della superficie corne ale . Però il suo impiego r iesce piuttosto malaj?evole, richiedendo una camera oscura, lu ce disposta in manie ra misnroziooe e calcoli multipli; forse a cnusa di tali diffi coltà l'oltalmom etria non òivenne tosto fnmigliar·e.
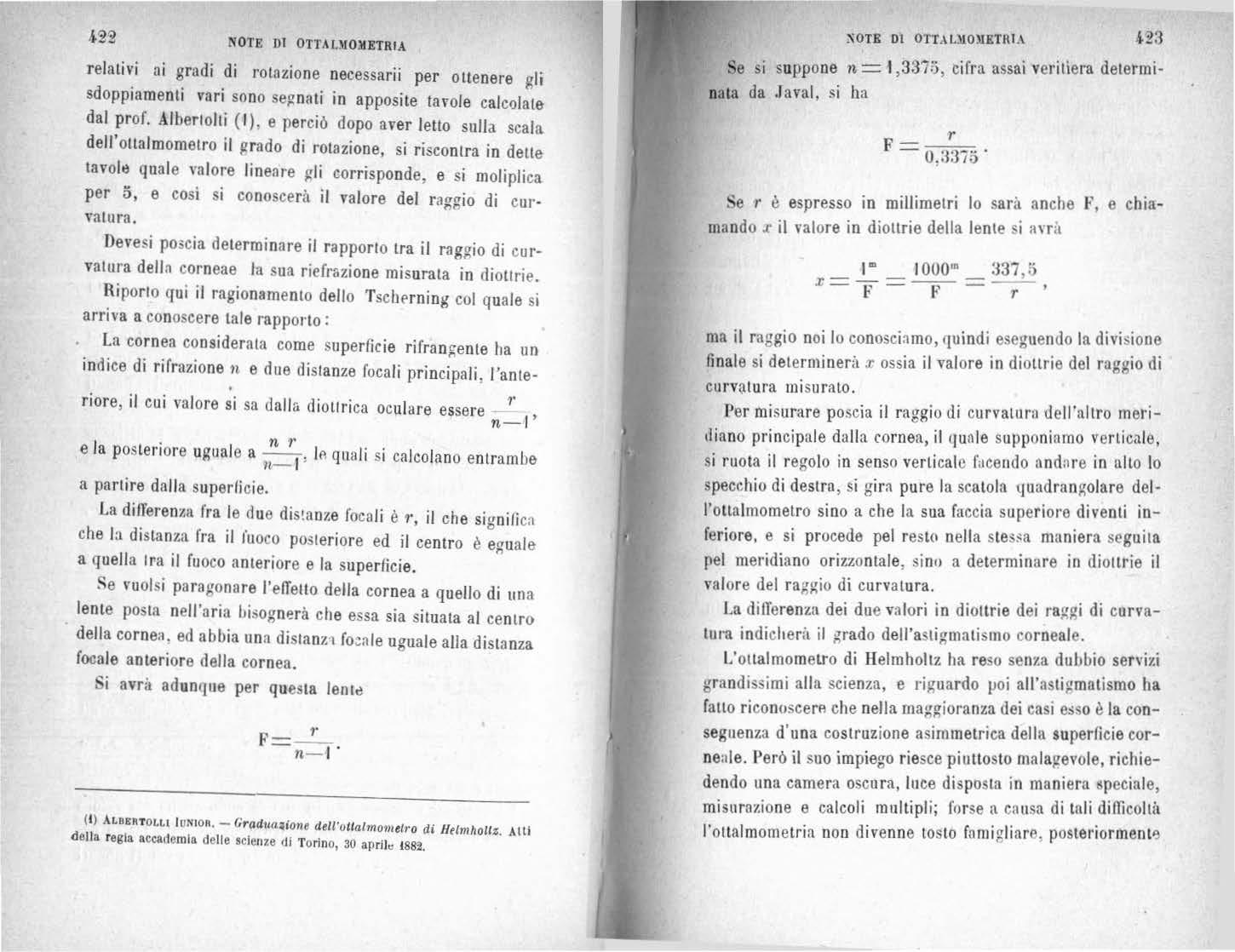
' i venne infatti a conoscere ch e l'astigmatismo non i· sempre esclusivamente corneale: Dohrowolsky prima e poscia Lero', .lavai, ed altri furono conco rdi uell'ammeuere che ;Ilo stato fisiologico il cristallino possa modificare simmetricamente le sue curvature. Contemporaneamente il )lartin pubblicò num erose osse rv azioni su indi\ idui in cui la contrazione asimmetrica del muscolo ciliare. l'impord'un anormale funzionamentu. era ca}:ione di slariati disturbi patologici.
Orbene la ùi dette co ntrazioni non può farsi senza l'ottalmometro, e perciò i cultori c1'oculistica se ntirono il bisou no di familiarizzarsi coll'olla lm ometria.
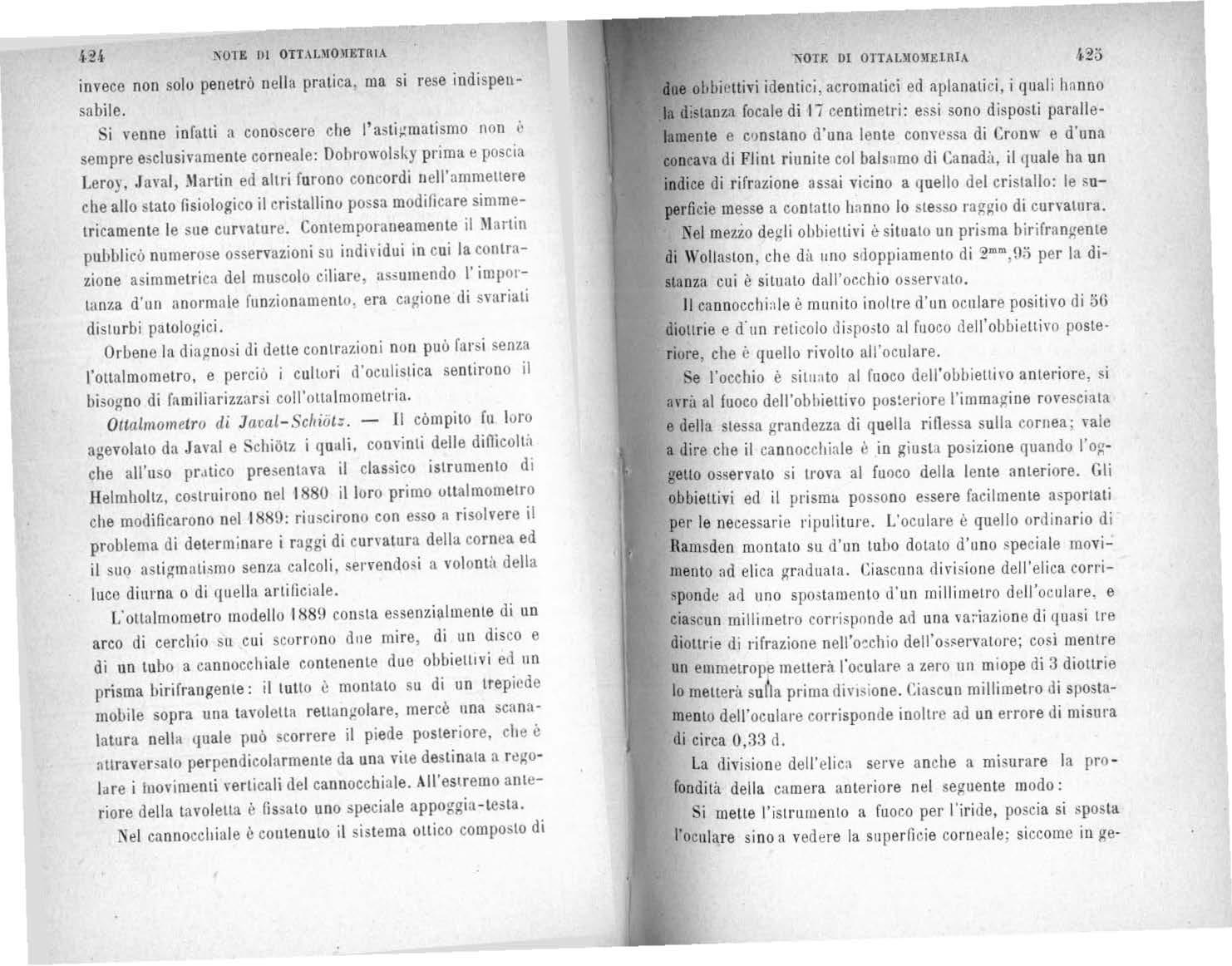
L'oualmometro modello 188H consta essenz ialm ente di un arco di cerchio su cui sco JTt >no dne mire, di uu disco e di un tub o a ca nnocchiale co ntenente duo obbietttvi ell un prisma birifrangente: il tutto è montato su di un trepicde mobile sopra una tavoletta rettanj.!olare, mercè una scanalatura nella quale può scorrere il piede posteriore, cht! è aura ver sato perpendicolarmente da un a vite destinala a rego·
J• i lnovirue nti \'erticali del cannocchiale. All' eslremo anteri ore della tavoletta i• fissato un o speciale a ppoggia -testa.
Nel ca nooccltia le è conte nuto il sis tema ollico composto di
'\OfF. DI OlTALliOlf.&liUA
o!Jbil'ltivi identici , acromatici ed nplanatici, i qual i hnnno la d:stanza focale di 1/ ce ntimetri : essi so no disposti parallelamente e c•Jnstano d'u na lente com·cssa di Cronw e d'una co ncava di Fii n t riun ite col bals .1m0 di Ca nadit, il !Juale ba un indice di rifr azione assai vicino a •tue llo del cristallo: le superfi cie messe a hnnno lo stesso raggio di cunatura .
Nel mezio ollhiellivi è situato un prisma birifrangente di Wollnston. che dii uno sdoppiamento di ?mm.u:> per la dista nza cui è situato dall'occhio osservato.
Il cannocchiale è munito inoltre d'u n ocnlare positivo di 5G di ou rie e d'un reticolo al fuoco dell'obbiettivo poste· ri ore , che è quello rivolto all'oculare.
Se l'occhio è situato al fuoco dell'obbielliro anteriore, aHà al fuo co dell'obbiettivo l'immagine rovesctala e della stes a grandezza di quella riflessa sulla contea: vale a dire che il ca nnocchiale t\ in giust1 po5izione f)uando l' oggeuo osservato si trova al fuoco della lente Gli obbiellivi ed il prisma possono essere facilmente asportati pe r le necessarie ripuliture. L'oculare è quello ordina r io di Ramsden montato su d' un tuLo dotaLo d'u no specia le movime nto ad elica graduala. CiasCllna divisione dell'elica conisponde arl uno spostamento d'u n millimetro dell'oculare. e ciascun millimetro co r risponde ad uoa va:-iaziono di quasi t1·e diottrie ùi rifrazione cosi mentre un emmetrope metterà l'ocularE\ a zero un miope di 3 diottrie lo mellerà. sul11a prima dins ·one. Ciascun millimetro di spostamento dell'oculare corrisponde inoltre ad un errore di misura di circa 0,33 d.
La divi sione dell'elica serve anche a misurare la profon dità della camera an terio re nel :seguente modo :
Si mette l' is lrumen to a fuoco per l'i1·ide, posci a si spos ta l'oc nlare sino a vedere la snperfi d e cornea le: siccome in ge· nerale l'oggetto è uguale all 'i mmagine rormata dall'obbiettivo cosi lo spo ·tamenLo dell'oculare sarit uguale alla profonditit della camera nnteriore. metit sinist ra dell'arco trovasi un foro per li,.snrYi stabil me nte la corrispondente mira.
La stessa misura si ottiene mi glio mettendo l'ottalmometro a fuoco pet· l'iride, e spostando l'oculare sino a vedere distin tamente le delle mire.
Il ca nn occhia le è avvitato in un tubo fissato sul SO$tegno verticale dell'istrumenLo: un 'i ncisione snl culmine ùi 11uesto tubo funziona come una mira. da fucile , guida cioè a dirigere il can nocchiale verso l'occhio dell'osservando.
Sulla tavol olla orizzontale di sostegno, ollre la succen · nata scanalatura in cui scorre il piede posteriore dell'ottalmometro, avvene un'al tra più innanzi che serve quando vuoisi ottenere uno sdoppiamen to pari alla metà. del preceden te; ma a tale scopo è però necessario anche un obbiettivo di ri cambio.
L'arco di cerchio su cui sono le mire rappresenta la quarta parte d'una circonferenza: il suo raggio interno è di z90 mm. e l'esterno di !J J:.> mm.
Quando l'imumenlo è situato nella sua giusta posizio ne per prendere un'osservazione l'arco è co nce nlri C•) colla cornea dell'osservato.
Su ciascuna metà dell'arco a partire dal centro è segnata una scala divi ·a io gradi da ooa 40°.
I l pri sma rifrangente di Wollaston è ca lcolato in modo che ciascun grado segnato sull'arco corrisponde ad onn diottria.
Sulla metiL de5tra del margi ne interno dell' nrco esiste un'altra scala che indi ca la grandezza del r nggio di curvatura in millimetri.
Pe r·pendicolarmente all'arco vedesi un grande indice bianco
NOTE DI OTIALli OMETR! \
cbe riOettendosi sulla cornea dell' serve a segnnre uno dei numer·i de lla co rona bianca del disco.
Sull 'arco sono scor revoli due mi re bianche antep oste a. due reuangol i di velluto nero: il campo nero serve a r endere per contrasto più nette le corneali delle mire. I retta n· gol i di velluto possono scorrere verticalmenre dent ro le cornici delle mire, permette di fare sparire a volontit br.l proiettAta da essi sulla divisione dell'arco di ce rchro.
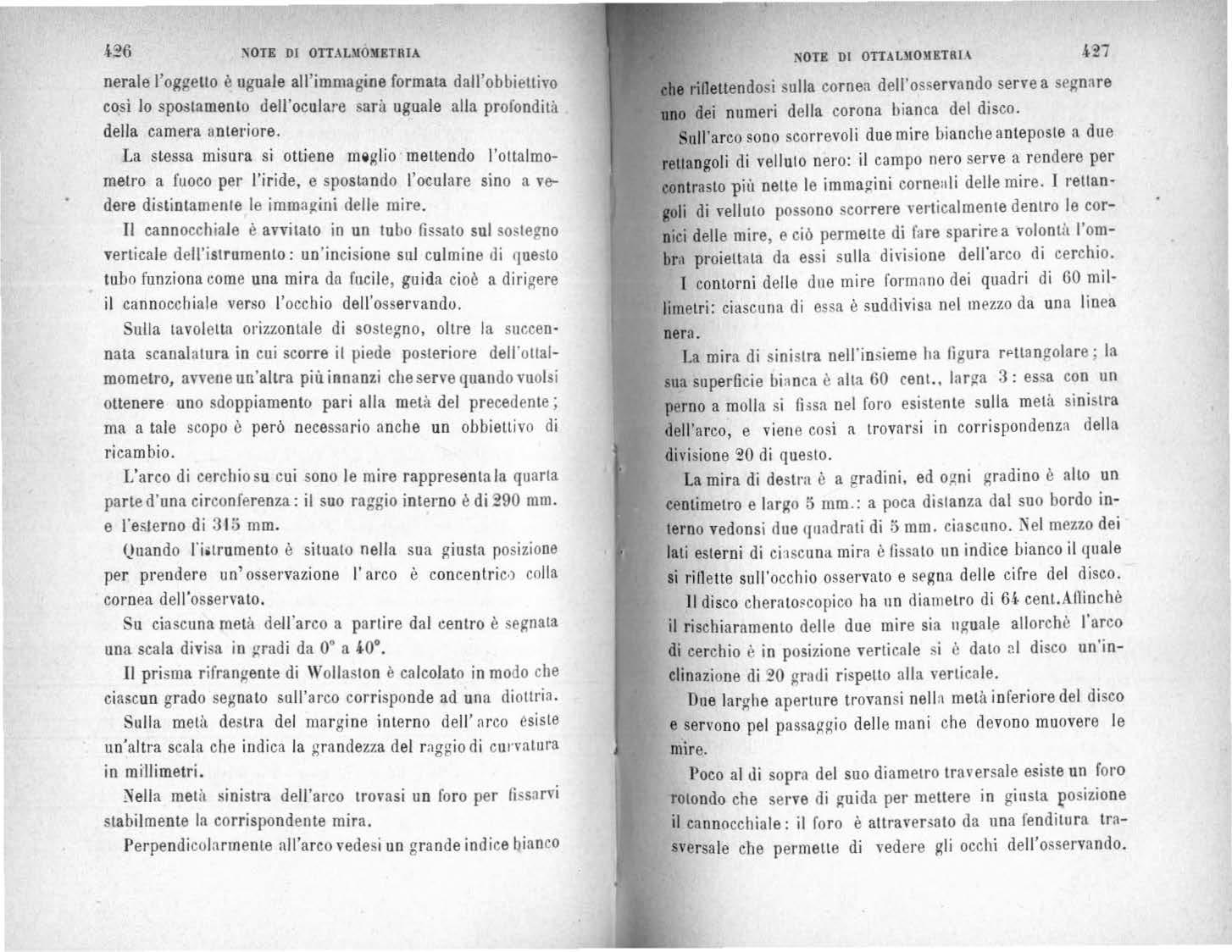
I contorni delle dne mire formnno dei quadri di 60 millim etri: ciascuna di essa è suddivisa nel mezzo da un a lin ea nera.
La mira di si ni stra nelrin sieme ha lìgura la sua snperficie bianca è alla 60 rent., 3: essa con un pern o a molla si fissa nel foro esistente sulla metà si ni stra dell 'a rco, e vien e cosi a trovarsi in corris pondenza della division e '20 di questo.
La mira di destra è a gradini, ed ogni gradi no è alto un centimetro e largo 5 mm.: a poca distanza dal suo bordo interno vedon si due IJlt:ldrati di 5 mm. ciascn no. mezzo dei lati esterni di ci :1scuna mira è fissato nn indice bianco il quale si rill elle sull'occhio osservato e seg na delle cifr e del disco.
Il disco ha un diametro di 64 cent.Ailinchè il ri schiaramento delle due mire sia uguale allorch è l'arco di cerchio i' in posizione verti ca le si è dato :! 1 disco un'inclin azione di :?0 gradi rispetto alla verticale.
Due larghe aperture trovan si nell a metà inre riore del disco e servono pel passaggio delle mani che devono muovere le mire.
Poco al di sopra de l suo diametro traversa le esiste un foro rotondo che serve di guida per metLere in giusta (>Osizione il cannocchiale: il foro è allraversa to da una fenditu ra trasversale che permeue di ved ere gli occhi dell'osse rvando.
NOl'E DI OTTALMOMRTIIIA
Sul dis co e::.istono dei cerch i conce nlri ci bianr.hi allrave t·sa ti da rag gi . Essi ;wardati dall a posizione che occupa se l·vando sembrano equidistanti perchè i loro ra gjai crescono secondo la legge delle tange nti.
La num erazione dei circoli arriva sino a gradi. onde il disco inti ero occupa un ' est ensione di 90".
[ ce rc hi corri spondent i a l ()• e 30° so no più larghi degli altri , ed nppariscono più nelli nell e immagini co rn eali. n questi due cerchi go oo dei num eri che indicano i meridiani da (l a 360, e lungo i ra;:gi si t uati a 45° trovansi dei numeri bian chi i quali determinano in grad i i cerchi concentrici.
Qu esta doppia graduazi one se rve a stabilire un punto 1li fi ssazione all'occhio osservato per fare l'oualmometria in fuori della linea ' ' isua le . Può utilizzarsi anche pet· far e la perimetl'ia.
Fra i cerch i di e 45° esi ste una larga co rona bian ca la quale porta delle di\'isio ni io gradi e delle cifre di 15' in 15• gradi, cifre che so no scritle a r ovescio sul di$CO per poi apparire diritte nell e immagini corn en li: esse invece ùi proseguire da o• a 360• sono rip etute due volte da 0° a l so•.
Sul Ialo :;ini st r o del diametro orizzontale del disco \'edon-i le cifre 35, ti-O, i.;), 50 di ottri e.
Allorchè per lo sdoppiam enlo de lle immagini corne:tli i cerchi cosi numerati divengon o tange ntr a loro stessi in un meridiano qualsiasi, cifre indicano il polere rifrangt}n le in diotLrie della co rn ea in detto meridiano.
Sullo stesso diametro or izzonta le, ma ùal lato op posto del disco, si leggono le cifre 3, i·, 5 mm . le qunli possono servire a mis urare il diametro pupillare a co ndizi one però che l' iride sia bene illuminata: il num ero del cerc hi o clte coincide co lla pupilla indi ca il diam etro de lla pupilla in millimetri.
Ai lati dell'nppo}!gia-testa sono fissaLe due \i li su cui si adattano due becc hi a per l'illuminazione artificial e. che riesce meno bene di quella diurna, e deve r,;se r e perciò ausiliata da un riflettore speciale . Occorr e pure difendere dal calore la testa dell'osservando sogra un foglio di carla.
L'istrumen to s'adopera nel segnenLe modo : lo si situ a su d'un tavol o rimpett o ad una line:>tra: l'osservando volgendo ad essa lè spall e siede su d'uno sgabello di cui può variare in modo co nveni ent e l'altezza c ;; i accosta per comodamente il mP-nt o su ll 'apposita mentoniera ed adattare la fronte al cnnlorno superi or e della finestra
L'osser va tore, assicuratosi della per lella ori zzontalitit de l pi ano de gli occhi del paziente, gli cop re co n un op ercolo esistente sull'appoggia-tes ta l'occhio che de v'esse re osservato per "eco ndo; quindi gli raccoma nda d1 fissare allentamente il cent ro del tubo e òi te nere bene l'occhio aperto, altri menti le cij:!lia posso no masche rare parte della imm ,Lgi ne del elisco.
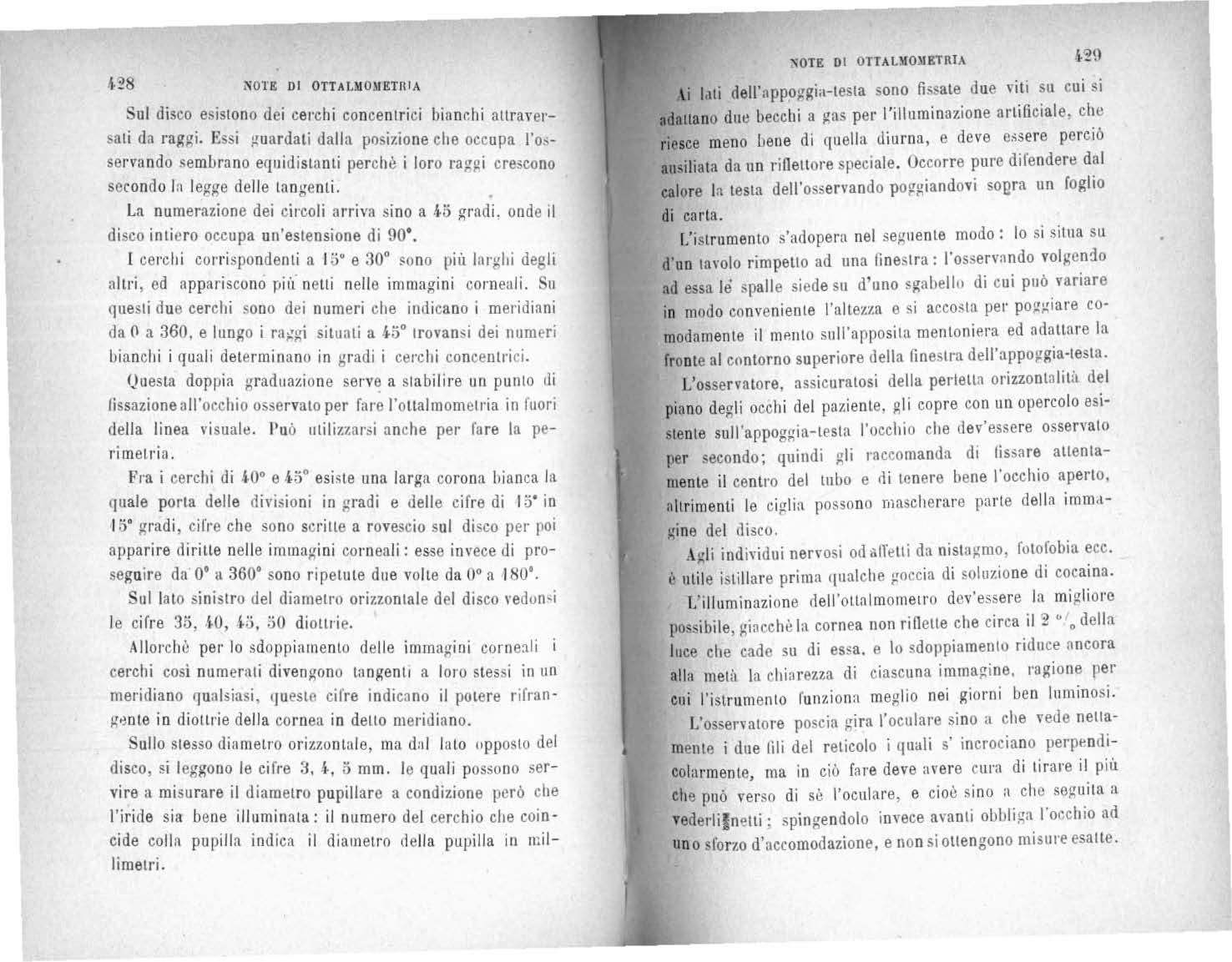
Agli individui ner\osi od atTelli da oistu:,:mo. fotofobia ecc. è nlil e i' lill are pri ma qualche di soluzio ne di cocai na .
L'ill uminazi one òel l'o ttalm ometro dev'ess ere In mi gli oro possibile , giacchè In cornea non riflette che circa il 3 " o della luce che cade su di essa. p lo sdoppiamento riduce nncora alla metit la chi nrezza di ciascuna ragione ver cui l' istrum ento funzi onn meglio nei giorni ben luminosi.
L'osservatore poscia gi r a l'oculare si no a che vede nettament e i dne lìli del r eticolo i qual i s' incrociano perpendicol ar mente, ma in ciò fHe deve avere C'ura di tirare il più ch e può verso di sè l'oculare , e cio è !\i no a che segui ta a. vederliln elli: spin ge ndolo invece aranti obbliga l'occhio ad un o sforzo d'accomodazione, e no n si ottengo no misure esatle.
Di spon e poscia l'a r·co orizzontalmente e, lasciando lissata la mira di sinistra sul numero 20, procede alla ricerca dell'occhio da esaminar·e . Sit ua 1e mani sui due piedi anteriori dell'isu·umento e lo sposta lateralmente sino a che, guardando aura verso la fessura orizzontale del disco, ,·ede l'occhio. l nùi mira attraverso il can nocchia le, e se non vede l'occhio imprime movimenti di laleralilil all'istrumento e gira anche conveni entemente la vite del piede posteriore per ben dirigeré il tub o verso di quello: arri\'a cosi a vedere l'im magin e del disco, per r·endere la quale della maggiore chiarezza possib ile rim uove leggermente l' ottalmometro in av<mLi. in dietro, a destra, a sinistra ,;econdo il bi so,.:no. In tanto si::come tirando a sè l' istrumento l'im· magin e s'in nalza, e spinge ndol o avant i si abbassa, ricondurla nella sua giusta posizion e girando opportunamente la vite del piede.
Si ved ra nn o allora disegnarsr sulla cornea due dischi parzialmente sovrapposti, e nel mezzo del campo di so· sco rgonsi le due mire ; però sui IJordi del di sco se ne ved ono altre due cho devono apparire Gatte quando l'olla lmometro è beo ce ntralo .
Se l'occhio in esame è astigmatico le linee nere che auraversano le mir·e non av ranno la stessa direzione, ed allora s i ce rca di co ndur ve le gi rando co lla mano sini stra il tubo dell'ollalmomet ro in un verso o uell'altro, seco nd o che oc· corra, e con tempora neamente colla mano diritta si fa scorrere la mira a gradi ni sino a che ht sua immagine arriVI quasi a conta tto di tjuella r·ettangola t·e.
Questa ope razione ri chiede molta prati ca ed aLLenzione perchè i bord i dell e im magini delle mire non sogliano essere neu i a ca usa di aberraz ioni dovute al pr isma.
Giunti a lJuesto punto devesi dare all'ist ru mento la sua giusta posizion e, e perciò lo si lira a sè quanto piu si può, cioè fino a che le immagi ni delle mire segu itano ad apparire ben distin ti'.
Si legge allora la cifra segnata dal gra nde indice. ed all'osservando di fìssar·e bene il ce nt ro de ll' orilicio del tubo , s'imprime a questo un di 90 gradi , c cosi uno degli indi ci delle mire cadril sul numero segnato precedentemente dal grande indice.
Allo rchè dopo qu esta rùt azio ne di 90° non vi è il giusto liv ello lo si ottiene girando di qualche grado di qua o di là .
Se vi è astigmatismo secondo la !'egola, il che vuoi dire d1 e il meridi ano piit rifran gente ò verticale o quas i. le mire appai ono più o meno sovrapposte. e la sovrapposizione si manifesta per una tinta biauca su alcuni dei gradini dell a mira di destra.
Si contano allora i gradini bianchi sovrappC\sti; ciascuno di es si corrisp onde ad una diottria di as tiwnatismo. e le frazion i di cr radi no indicano frazioni òi diottria.
La posizione del meridiano vi ene indicata dal numero segnato sul r.o ntor no del di sco dagt i indici dell e mire o dal indice allo r chè si fanno le letture.
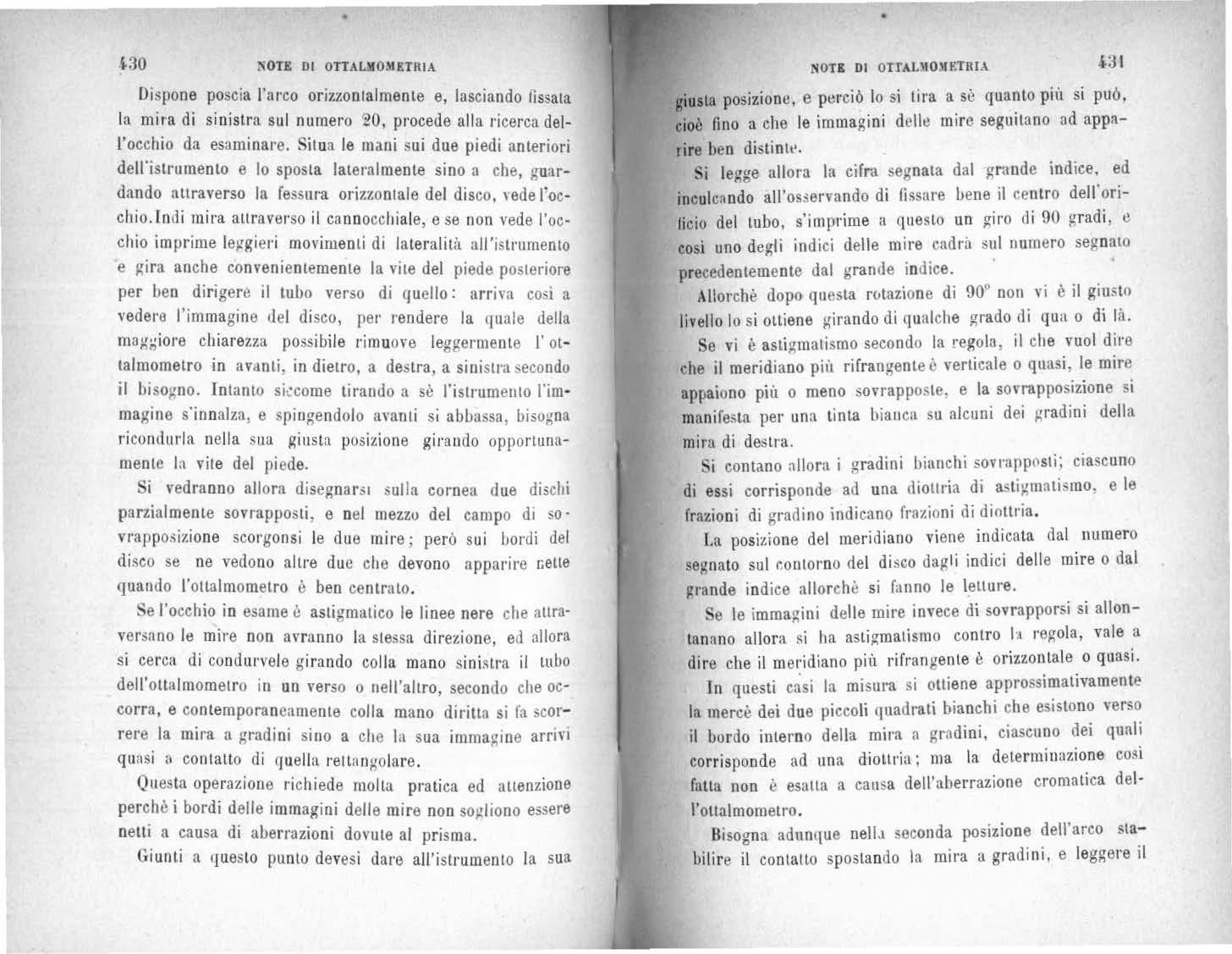
, e le delle mire invece di sov rapporsi si allontan ano allora si ha astigmatismo cont ro b regola, vale a dire che il meridiano più rifrangente è orizzo ntale o quasi.
In questi la misura si ottien e approssimativamente la mercè dei due piccoli quadrati bianchi che esistono Yerso il bordo interno della mira a gr;1d in i, ciascuno dei quali co rr is po nde ad una diottria; ma la determinazione cosi fatta non è esatta a cansa dell'aberrazione cromatica de ll'ottalmometro .
Bisogna adunque nel !.\ seconda posizione dell'arco stabilire il contatto sposta ndo la mira a gradini, e leggere il d'astigmatismo dopo avere ri condotto l'arco nella poSIZIOne presso a poco orizzontale . li numero di diollric corrispo nd enti ni ra!.!J.:i di curvatura dei meridiani s i ouiene aggiungendo 20 alle cifre indicate dalla mira a gradini, e ciò perchè la mira è fissata sul numero 20 nella metà si nistra dell'aro·o. Può succedere che nella prima dell'arco de ll r otta lmom etro le lin ee n ere orizzon tali che allraversano le mire sieno esattamente nella stessa di r ezione: ciò indica che non vi è as ti gmati smo , a me no che non si s ia cnduti proprio su un o dei meridiani pri ncipa li, la trnal cosa c;a ril controllata col vedere se le mire si sovrappongono o si :1lluutanano quando si gira l'a rco di 90 gradi . enendosi di questa proprietà (lei fuoco si può cos truire l' im magin e d'un dalo ogge tto, de term inare la grandezza di essa ed il raggio di curvatura dello specchio.
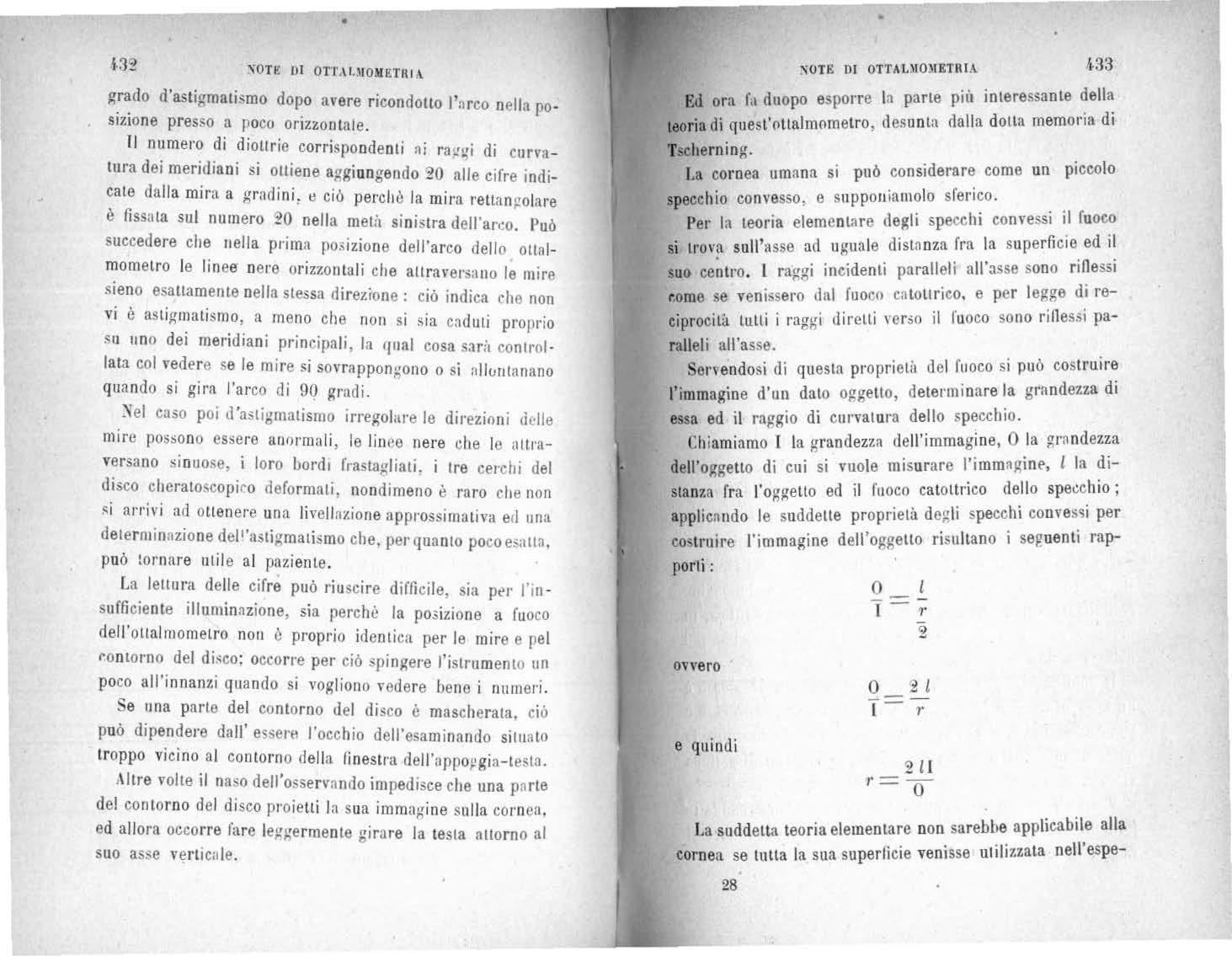
Xel caso poi d'astigmatismo irregol.1re le direzioni dl'lle mire possono esse re anormu li , le lin C'e nere che le altraver·sano si nuoi;e, i loro bordr frastagliati, i tre cerchi del disco chc ratoscopiro defo rmati , nond imeno è raro eire non a rrÌ\' i ad otten ere una livellrr7.io ne approssimativa ed una dete r min:1zione dell'astigmatismo che, per quanto poco può tomare util e a l paziente .
La lellu ra delle cifre può riu scire dif(ìcile, sia pt>r· l'in· suffi cie nte illumin azione, sia perchè la po.>izione a fuoco dell'ollalruom eLro non è proprio id enti ca per le mire e pe l roDLorno del disco: occo r re per riò spinger·e l'istru mento un poco all'innanzi quando si vog li ono vedere beno i numeri .
Se una parte del con torn o ùel disco è mascherata. ciò può dipendere dall' esser·a l'occhio dell'esaminando situato tr oppo vi cin o al con tom o de lla linestra rlell'appo).!gia-testa.
Altre volte il na:;o dell'osse r vando impedisce che una parte del con torno del disco proiett i la s ua immugioe sulla cornea. ed allora occo rre fa re legge r mente girare la testa atto rn o al s uo as,;e verti cale .
Ed ora f;t duopo espo t'l'e la parte più interessa nte della teori a di quest'ottalmom etr o, desunta dalla dotta memoria di Tsc herni ng.
La cornea umana si può co nsiderare come un piccolo specc hio convesso , e suppou iarnolo s feric o.
Per la teoria eleme ntare degli specchi convessi il fuoco si trova sull' asse ad uguale distn nza fra la su perficie ed il suo ccntr·o. 1 raggi inci denti parall eli all'asse sono r ifle ss i r. ome se veni ssero dal fuoco ca loll ri co. e per legge di reciprocila tulli i raggi dir·eui ver$0 il fuoco sono r·ifles:;i para lleli all'asse.
Ch iamiamo l la grandez za dell'immagine, O la grn ndezza dell'ocrae tto di cu i si vuole mi surare l'immagi ne, l la di,, sta nza fra J'oggello ed il fu oco ca tottrico dello speec bio ; applicando le suddelle proprietà specch i per co,t ruir·e l' immagine dell'oggetto risu ltano i sepuenti rapporti :
La suddetta teoria elementare non sarebbe app licabil e alla cornea se tulla la sua superficie venisse utilizzata nell'espe- rirnento, e ciò a causa dell'auerraziona di sferir:ilà, per la le sue parti più periferiche hanno il fuoco situato a prù di due millimet ri in avanti di qu Pllo fo1·mato dalle parti ceutrali, e quindi le immagini sarobuero tanto in·egolari da potersi distinguere. Ma per fortuna a noi importa sluso_lta_nto la piccola sezione centrale utilizzata per la vrsrone drstmta che é situala all'intorno della lin ea visuale ad una di stan za di 1"' "',2 sezio ne che dà immngi ni uelle.
Intanto nemme no per una rale zona ci r cosc ritta le suecitate formule so no del tollo esat te, e perciò l'rstrumento costruito in base all e stesse ha bisogno d'una piccola corr ezione, non di meno per co mprendere il suo funzionamento tali form ul e so no pin che ade:.{n ate.
La ragion e per la qualo nell'ottalm urnetro lo mire son o situate su d'nn arco di cer·chio sla appunto nella co noscenza del mod o di formazione dell 'im magi ne d'un oggeuo r iflesso da uno specch io co n\' esso: questo in vero non dir un 'rmmagi ne simile all ' oggetto; cos i ati esemp io una linea diritta per·pendi colare all'asse dello specchio ha per immagine una parte d' una elliss i convessa in aya nti. uno dei cui fu ochi è il centro dello specchio: cjuindi pll r d Vere un ' immacrine rettilinea occorre che l' oggetto abbia un a forma in maniera che il s uo centro sia lontano da llo specchio più dell e sue due esLremità.
Il solo oggetto che dit un 'im magine simile a sè stesso ò un nrco di cerchio concerrtrico allo specchio, e perciò esso è stato adotta to nell' oUalmometro per sostenere le mire le quali banno co sì una posizione obliqua rispetto alla linea visuale.
Veniamo adesso all'appli ca zione prati ca delle suddette formule per dimostrare come si gi unge a determin are il r aggio di curvatu t' d dei meridiani corn ea li.
Riprendiamo la formula
O indi ca . come s i è dello, l' oggello il quale nell ' ollalmometro è rappr esen tato dallo spazio compre so tra i bor·di interni delle mire; l rnpprese nta l'immngine di questo oggetto, che si può amme uer e situato al fuo co dello sp acchio corneal e, ed l è la dista nza dall'oggello all 'i mmagine, vale a dire al fuoco.
Se il ca nn occ hiaie dell'istrumento è hen messo a fuoco per oUenere l'immagin e rifl essa, la di stanza fr·a questa e l'obbiettivo è invariabi le ed uguale alla distanza fo cale deiI'obbi elli vo anteriore cioe a ?!.7 cenl. Trovand osi il bordo antel'iore dell'a rco del l'ou,.Im ometr o all a stessa di stanza dall'occhio e da della lente, si ha che a nche l== 27 cen t. e co.;i si è assicura ta la costa nza di l senz a aver di misurare la di stan za fra l'occhio osservato e l' istrumento.
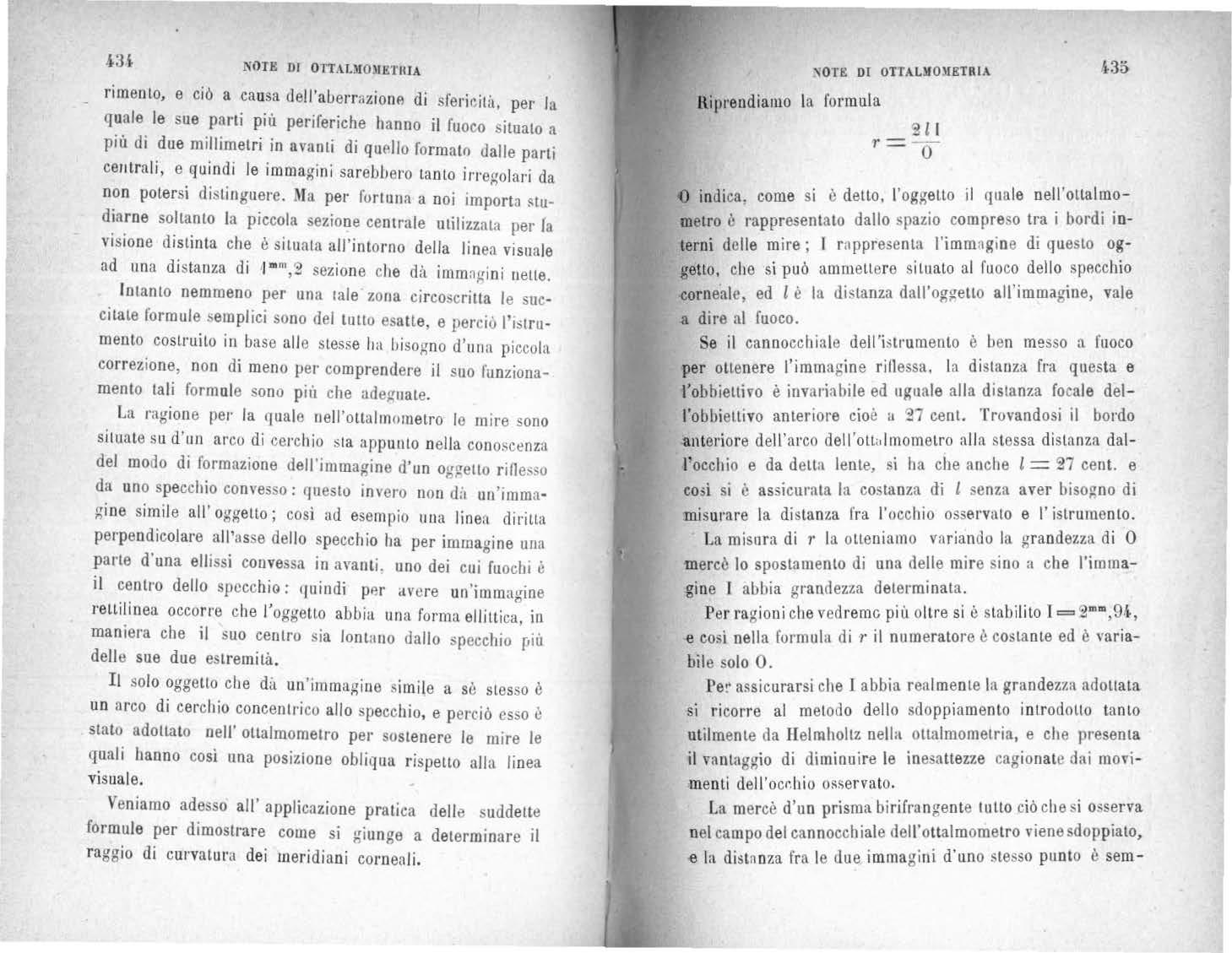
La misura di r la alle niamo variand o la grand ezza di O mercè lo spostamento di una delle mire si no a che l'immagin e l abbia g ran dezza determi nata .
Per ra gioni che ved remc più oltre si è stabilito I= 2m"' ,94, e cosi nella formu la di r il nume rato re è costante ed è va riabil e solo O.
Pe•· assicurarsi che l abbia r ealmente la grandezza adottata si ri corre al melodo dello sdo ppiam ento introdollo tanto utilmente da IIelmholtz nella ottalmom elria, e che presenta il vantaggio di diminuire le in esattezza cagio na te dai movimenti dell'ocr.hi o
La mercè d'u n prisma birirran ge nte tutto ciò che si osserva nel campo del ca nnocchiale del l' ottalmome tr o viene sdo ppiato, ce la dis tanza fra le due immagini d'uno stesso punto è sem- pre la medesima (2•m,9.&.). Si fa variare la grandezza degli oggelli sino a che l'immag in e .;ia uguale allo sdoppiamento, e quindi al momento del co ntat to si ha l == 2mm,94..
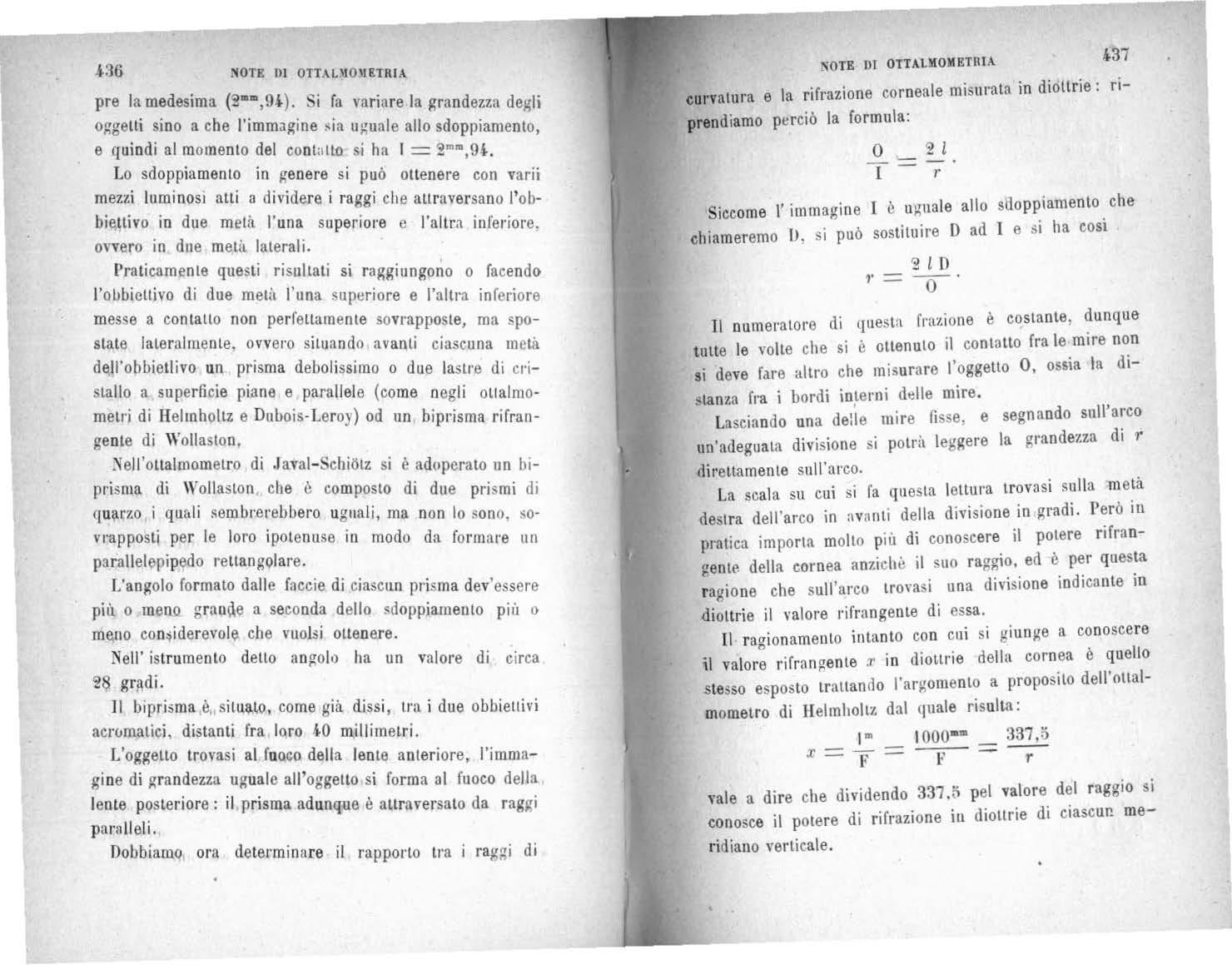
Lo sdoppiamento in gen ere si può ottenere con vari i mezt:i luminosi atti a dividere i raggi che allraversano l' obbiettivo in due metà l'una superiore e l'altra inferiore. O\'Vero in dne metit laterali.
Praticamente ques ti risultati si raggiungono o fnceod() l'oubiouivo di due metil l'una e l' al tra inferiore mes se a contallo non perfettamente sovrapposte, ma spostatE) lateralmente, ovvero situando avanti ciascuna metà dell'obbietlivo un prisma debolissimo o due last re di ct·ista llo a supe r ficie piane e parallel e (come negli oltalmometri di Hel mholtz e Dubois- Lero)) od un bipt' isma rifrange nte di Wollaston, di Javal-Schi<Hz si è adoperato un biprisma di Woll aston ch e è composto di due prismi di q uar zo i quali sembrerebbero uguali, ma non lo son o, sovrapposti per le loro ipolenuse in modo da formare un parallelepipedo rettangolare.
L'angolo fo r mato dalle fac cia di ciasctm prisma dev'essere più o meno gra nde a seconda dello sd oppiamenlo piit o me.no con:$iderevole che vuolsi ollenere.
Nell' istrumento dello angolo ha un valot·e di circa 28 gradi.
11 btpri.sma è, siLUI),lO, come già dissi, tra i due obbieuivi acrùmatici, distanti fra loro 4.0 m,illimetri.
L'oggeLto trovasi al fuo co della lente anteriore, l'immagi ne di grandezza uguale all'oggetto si forma al fuoco della len te poster-iore: il prisma adunque è attraversa to da raggi paralleli.
Dobbi amo ora determin are il rapporto tra i rag qi di curvatura e la rifrazione cor neale misurata in diottrie: npre ndiamo perciò la formula:
Siccome l'i mmagine I è uguale allo sdo ppiamento che chiameremo U, si può sostituire D ad l e si ha cosi
Il num eratore di lJUes ta frazione è costante, tutte le volte che si c ottenuto il conta tto fra le _m1re si deve fare altro che misurare l'oggetto O, ossta la distanza fra i bordi in,temi delle mire. secrnando sull'arco l) la gra ndezza di 1'
Lasciando una delle mire fis ·e , e un'adeguala divisione si potrit leggere direttamen te sull'arco.
La scala su cui si fa que sta lettura travasi sulla me tà destra dell'arco in :m11Hi della divi sio ne io gradi. Però in pratica importa mollo più di conoscere il potere rifran••ente della cornea il suo raggio, ed è per questa che sull 'arco trovasi una divisione indicante in diottri e il valore rifrangente di es sa.
[l racri onameuto intanto co n cni si giunge a conoscere \1 valor: rifrancrente .r in diottrie della cornea è quello ste3so esposto l'argomento a proposito dell' ollalmometro di llelmholtz dal quale ri sulta: t m l ooo•m 337,5
J.' == F == F ::::;: -r vale a dire che dividendo 337,5 pel valore del raggio SI .1 d't r·1f·1·az1·one in diollrie di ciascur. me- conosce 1 potere ridiano verticale.
DI OTTAL'1 0METRIA
Hisulta dalle molteplici misurazioni che il poterE> rifrangente della cornea varia in genemle fra 40 e 4·7 diottrie e che un a dilferenza d'una diottria corri sponde una differenza di raggio inferiore a due decimi di millim e tr o.
Sostituendo nella formula sopra riportata, quale base dei calcoli, al raggio il potere rifrangente della cornea si ba:
O 2 l 3 l.r ---- o-_-l .rn_, 1 - 1• - ;:n-7 u ovvero ,;, 337 ,:j come si (• giunti a dete1·minare la cifra 2m•,94-.
. Noi abbiamo visto che il valore di D è stato stabilitodJ 2mm,94, si ottiene così cbe la grandezza lin eare l'arco co rr ispondente ad una diottria sia precisamente uguale ad un grado: non devesi quindi fare altro che muni1·e l'arco d'una semp li ce divisione in gradi.
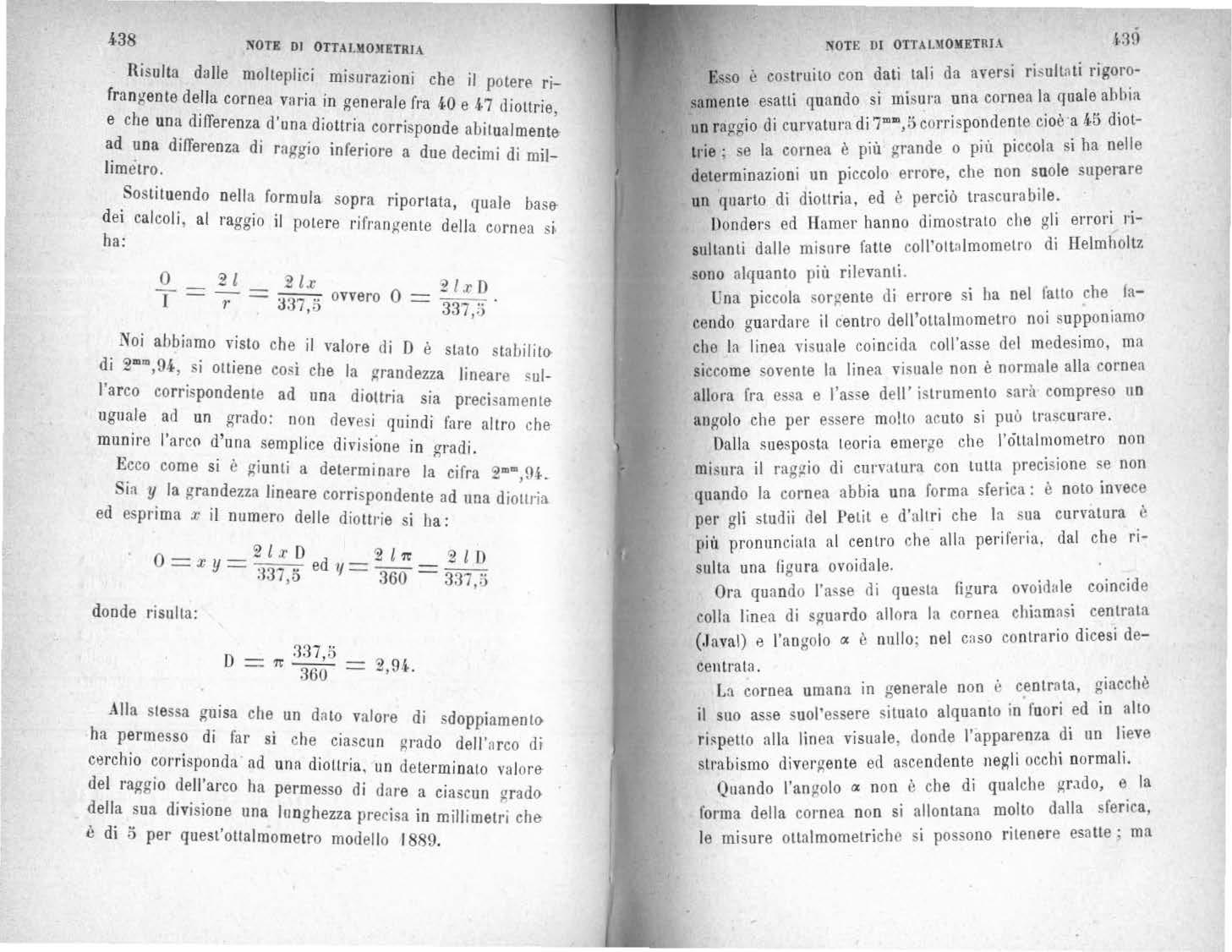
Sm Y la grandezza lineare corri sponde nte ad una diolll'ia ed esprima x il numero delle diottrie si ba:
O- _2lx D 2l n Ql f) - x y - '137 .. ed lf == -3- == -"'• ,<> 60 337,:) donde risulta: é con dati tali da aversi rigorosamente esalli quando si misura un a cornea la quale abbia un di curvatura di 7mm,o corrispondente cioè a 45 diottrie ; se la cornea è più o più piccola si ha nelle determinazioni un piccolo enore, che non suole superare un quarto di diottria, ed è perciò trascurabile. n onders ed 11amer banno dimostralo che gli errori risultanti dalle misure fatte coll'ottalmometro di IIelmh ol tz sono alquanto più rilevanti.
O 337,5 -n--- ':)9' - 360,...
Alla stessa che un d:Ho valore di sdoppiamento ha permesso dr fa1· si che ciascun dell'nrco di cerchio co rrisponda ad un Adiottria, un determinato valore de l raggio dell'arco ha permesso di dare a ciascun grado della sua divisione una lunghezza precisa in millimetri che è di 5 per quest'ollalmomet ro modello 1889.
Una piccola :;orgente ùi errore si ha nel fallo che tacendo tT Uardarc il centro dell'ottalmometro noi supponiamo o che la linea. visua le coincida col l'asse del mrdesimo, ma sicrome sovente la linea visuale non è normale alla cornea allora fra cs:;a e l'as-.e dell' istrumento sat'it compreso un an golo che per esse re mollo acuto si può trasc ur ar·e.
Da ll a suesposta teoria emerge che l'ottalmometro non misura il rag!!io di curvatura con tutta precisione se non quando la cornea abbia una forma sfe1 ica: è noto invece per gli studii cle l Pe tit e d'altri che In sua curvatura più pronunciata al centro che alla periferia. dal che risulta una figura ovoidale.
Ora qua ndo òi questa figura ovoiclale coincide colla linea di sguardo allora la cornea chiamasi centrata (.l ava i) a l'angolo ex è nullo: nel c3sO contrario dicesi decentrata.
La cornea umana in generale non è centrnta, giacchè il suo asse suol'essere situato alquanto in fuori ed in alto alla linea. visuale. donde l'apparenza di un lieve strabismo divor,gente ecl ascendente negli occh i normali.
Quando a non (\ che di qualche grldo, e la forma della cornea non si allonta na molto dalla sferica, le misure ollalmometrichc c;i possono r itenere esatle : ma se l'occhio è forte mente decentrato il disco cherntoscopico per la posizione centrale dello sgua r·do non nppare più fo rmato da cerchi perfeuamente rotondi, bensì ovoidali colla particolaritit che l'immagine del cerchio centrale del disco è più vicina alla porzione interna cbe a lJUella esterna degli altr·i cerchi del disco, e la rifrazion e corneale diviene astigmatica senza cbe perciò si }JOssa dire che la co rne.l è astigmatica.
Quest'astig matismo da deccntrazione si riconosce pl'l carattere che nel meridiano di minor cu rv atura le mire danno delle immagini di grandezza ineguale. L'inoguagliauza di grandezza. è :-opr atutto sensihil e nel piano di sdoppiamento, e si riconosce facilmente per mezzo di due m1re rettangolari situate ad uguale distanza da una parte e dall'altra del cannocchiale dell'ottalmometro, e l' una al di sopra l' nltra al di sotto del piano di sdoppiamento.
Per ce ntrare una cornea si può cominciare col girare l'arco dell'ollalmometro sino a che si sia nel meridiano di più J.(rande raggio di cnr\'atura; in questo momento non 'i sarit più di slivello , e resta a far muovere l'occhio nel piano di sdoppiamento sino a che il raggio di curvatura sia minimo, ov,·ero si no a che le mire rettangolari sieuo della stessa grand ezza.
Gli osservatori non hanno tenuto semp re sufficientemente conto della decentrazione, ma bisogna invece in ogni caso guardare se posizio ne senza dislivello le mire sieno di ug uale grandezza, o dare un o sguardo all' intersez ione <lell' immagine della corona del disco cheratos co!Jico coll' immagine dell'obbi ettivo, ed assicurarsi se nelle due immagi ni prodotte dallo sdoppinm ento queste intersezioni -.so no simili (.JaYal. au.r m.émoi?·es d'Op!ttalmométrie).
Un altro fallo da tene rsi presente è lluesto che secondo le statistiche di chiotz l'occhio normale possiede un astigmatismo corneale diretto di circa ± o,:i D, e forse anche di ± 0,75 secondo Javal. . .
Questo difetto per lo più si ri 5con tra situato sr mmetrrcamente in ambo gli ma or,corre quando si prendono le misure della co mea d'un individuo assicurarsi sempre se vi è simmetria verir.cando se il totale dei due anaoli è unuale a l O gradi. ('>
Seco ndo Pfalz la si mm etria è tanto meno esatta qnrrnto più il valore dell'astigmatismo dei due occhi s'allonta na dalla
(Juand o 111 un a persona i due occhi hanno lo stesso grado d'astigmatismo i meridiani di più grande e di più piccola curvatura so no uguali fra loro; quando invece il dell'asti.,matismo è difierente allora i :neridiani orizzontali rl l' soo liono dill'erire fra loro men o di 11uel li vertica '· ,..
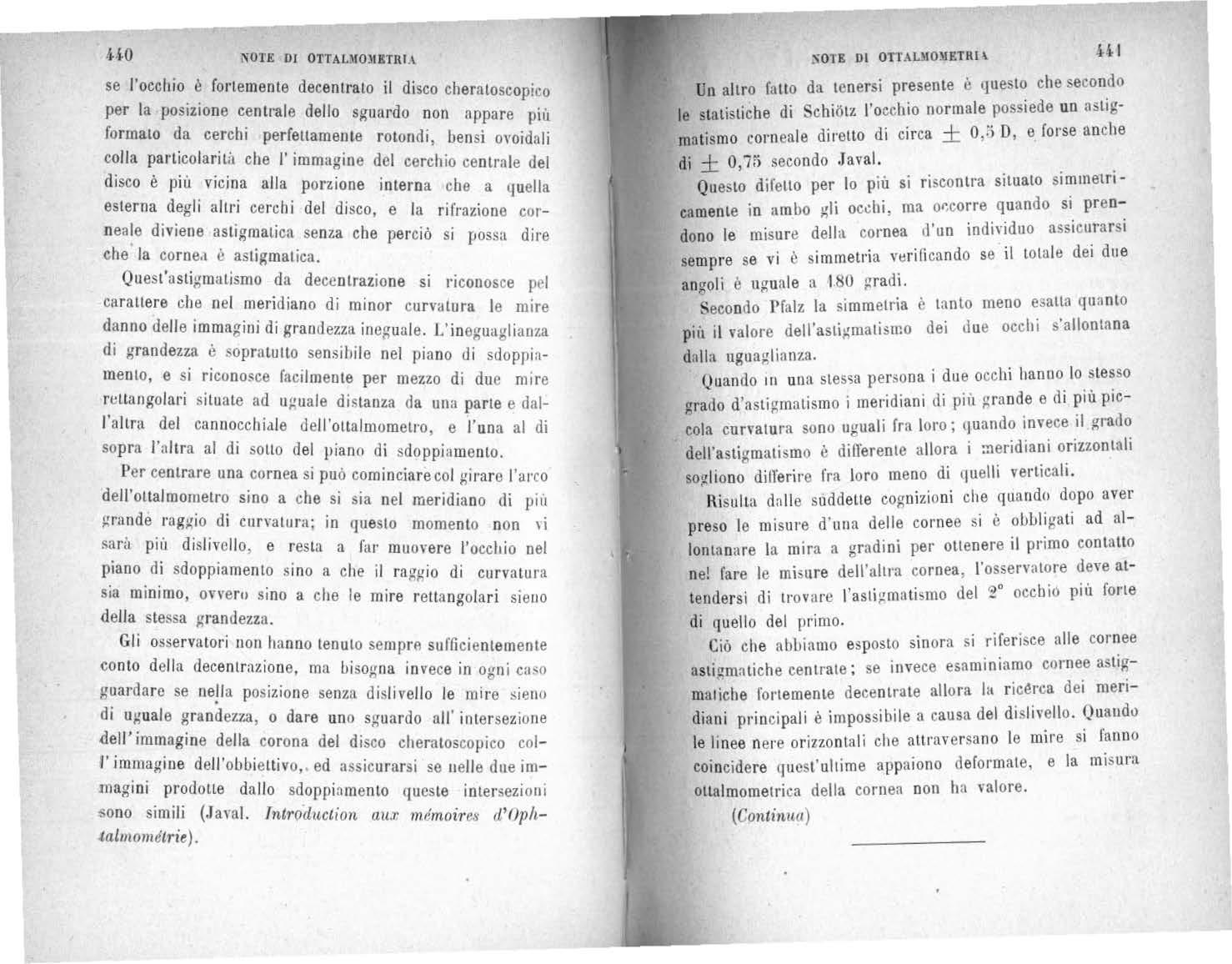
Risul ta dnlle suddette cognizioni che quando dopo aver preso lo misure d'una delle comee si è ad allonlnn are la mira a gradini per ottenere il primo contatto ne! fare le mi:;u re dell 'altra comea . l' osservatore deve attendersi di trovare del 'to occhio più forLe di quello del primo.
Ci ò che abbiamo espos to sinora si riferisce alle cornee astig_matiche centrate; se invece esaminiamo co rnee astigmatiche fortemente decentrate allo ra ltt ri cérca dei meridiani prin cipali è impossibile a causa del di slivello. Quaudo le linee nere or izzontali che attraversa no le mire si fanno coincidere quest'ultime appaiono derormate, e la misura ottalmometl'ica della co rue n non hn valore.
(Continuo )










