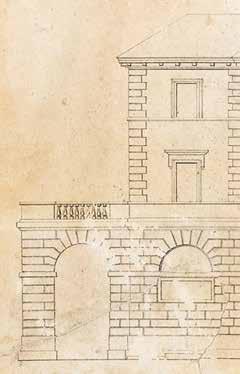25° Rivista di divulgazione culturale e artistica del territorio marchigiano | Sped. in a.p. - 70% - Filiale di Ancona
ISSN 1127-5871
ARTE | STORIA | ARCHEOLOGIA | LETTERATURA | SOCIETÀ | MUSICA | SCIENZE
Celebrato il Divin pittore a 500 anni dalla sua morte
Raffaello Magister dell’armonia Alla bellezza delle sue opere si contrappone un’Italia in guerra
NUMERO
70/71|2020 LUGLIO
L’editoriale
3
Una prova durissima reagiamo con saggezza
A
di Donatella Menchetti Presidente de Le Cento Città
Questa emergenza ci ha portato a riconsiderare i valori essenziali della vita con le sue precarietà e fragilità
l termine di questo anno di presidenza, vissuto con grande sofferenza e angoscia per la pandemia che ci ha così duramente colpito, vorrei offrire alcune considerazioni maturate durante le interminabili giornate di lockdown. Si è parlato molto su ogni mezzo di informazione, unici strumenti che in tempo di clausura permettevano il contatto con il mondo esterno. Virologi, epidemiologi, clinici, governanti, giornalisti, psicologi, educatori, opinionisti si sono prodigati in consigli, suggerimenti, linee guida, spesso contrastanti. Questa durissima prova ci ha portato a riconsiderare i valori essenziali della vita con le sue precarietà e fragilità. La storia non è mai scritta in anticipo. Ha tragitti imprevisti con sorprese inimmaginabili. E’ sempre stato così. Continuerà ad esserlo, nonostante i progressi della scienza e della tecnologia. Un susseguirsi di fioriture e declini. Ma noi , legati solo all’oggi, senza proiettarci oltre il domani, ce ne siamo dimenticati . Come sopravvivere a queste devastazioni ,a queste miserie? Ci vengono incontro i grandi maestri come Dante. ”State contenti umana gente al quia”, ossia fatevene una ragione, rimessi al mistero dell’Essere. E’ necessario dunque reagire con saggezza puntando sulla prevenzione, formazione, educazione, cultura, capacità. In questi giorni bui ho sentito spesso la metafora della guerra. Non solo per i numeri, spaventosi, ma anche per quello che sarà di noi, soprattutto dei
più poveri, quando ci troveremo con una economia decapitata. Dovremo ricostruire. Oggi la nostra società è quanto mai impreparata e divisa . Serve maggior umiltà e consapevolezza. Consapevoli che l’attuale rete ospedaliera non è in grado di affrontare simili emergenze se alle spalle non è strutturata una medicina territoriale preparata, efficiente, capillare. I tagli recenti andavano fatti in altre direzioni, incidendo maggiormente sulle spese, sulle speculazioni, sulle corruzioni, sulle clientele. Infine un pensiero ai nostri anziani nelle cosiddette “case di riposo”. Vecchi emarginati dalla società che vanno ad occupare le corsie di questi luoghi, per lo più non idonei a gestire le fragilità dell’anziano. lo hanno ampiamente dimostrato i contagi di questi mesi. Pensare, invece, che il contatto con i giovani è necessario non solo quando il vecchio ha bisogno, ma anche prima quando il bisogno non è impellente ed è magari reciproco. Era questo il dono più bello per gli insegnanti, dare sapere e ricevere vita. Educare e ringiovanire con i propri studenti. A conclusione di queste brevi riflessioni un pensiero di Pascal:” L’uomo non è che una canna, la più debole della natura, ma è una canna pensante. Non c’è bisogno che l’universo intero s’armi per schiacciarlo. Un vapore, una goccia d’acqua basta ad ucciderlo… Tutta la nostra dignità sta nel pensiero. E’ con esso dunque che dobbiamo rialzarci.” ¤
Il punto
4
Da venticinque anni il racconto delle Marche
V
di Franco Elisei Direttore de Le Cento Città
Nell'immagine, la copertina del primo numero della rivista pubblicata nel 1995
enticinque anni fa il primo numero. E da un quarto di secolo “Le Cento città”, edita dall’omonima associazione, continua a valorizzare le Marche, a ricordare i protagonisti della nostra regione, a promuovere l’identità di una realtà laboriosa, ricca di artisti, ma troppo spesso schiva di fronte ai riflettori della cronaca. Sarà la storia a riconoscerne le eccellenze. E “Le cento città” da venticinque anni ne ripercorre i segni e si impegna in iniziative culturali. Un percorso che ha visto all’opera autori di prestigio, professionisti di valore, nel solco tracciato dai suoi fondatori. Il professor Giovanni Danieli ebbe non solo l’intuizione ma anche la capacità di trasformare le idee in fogli che negli anni hanno ospitato saggi, riflessioni e articoli su arte, ambiente, scienze, letteratura ed economia di un territorio che merita attenzioni e progetti. E quale miglior occasione per celebrare i tanti anni di impegno intellettuale della rivista se non quella di rendere omaggio a Raffaello Sanzio, il divin pittore, nei suoi 500 anni dalla morte? Al “magister dell’armonia” Cento città ha voluto dedicare oltre 30 pagine con autorevoli firme. Di Raffaello si è scritto probabilmente tutto, noi abbiamo voluto leggerlo non solo tramite alcuni aspetti della sua arte e della bellezza delle sue opere, ma anche attraverso il contesto storico in cui viveva e nel corso dei secoli successivi. Ci siamo concessi una libertà: nell’ultima di copertina abbiamo voluto imitare il gesto di molti street artist, imponendo a Raffaello la mascherina
anti Covid. Non vuole essere un’operazione irriverente nei confronti del maestro del Rinascimento ma un tentativo di attualizzazione della rivista che non poteva mostrarsi distratta di fronte all’emergenza sanitaria che il mondo sta vivendo e che ha strappato alla vita anche due straordinari soci de Le cento città. Una pandemia affrontata su queste colonne con il consueto approccio scientifico. Ma anche sotto il profilo mediatico e dell’interpretazione artistica legata alla ricaduta sociale delle limitazioni. A comprendere i linguaggi dell’arte sono dedicate altre corpose pagine: da Caffè a Logli scomparso proprio recentemente, fino al suggestivo articolo in cui Piattella descrive l’arte di Licini. Un artista che racconta un altro artista. Straordinario. Ma spazio anche alle donne protagoniste della scuola come Maria Montessori o della società come la “Dama Bianca” nell’anniversario della morte di Fausto Coppi, ovvero ai personaggi dell’arte che hanno avuto e hanno un legame con le Marche: da Fellini che pensava ai “vitelloni” fanesi a Francesco Guccini che a Mondolfo ha trovato la sua metà. E tanto altro: restauri di residenze reali scoperte, ritrovamenti e voli. Non pindarici ma reali, dall’aeroporto di Fano che ci trasporta sulle ali della sua storia. Centoventiquattro pagine di articoli, riflessioni, analisi, ricerche che vanno ad aggiungersi alle migliaia di fogli raccolti e conservati in un quarto di secolo da Le Cento città. Il viaggio della conoscenza continua. ¤
Il ricordo | 1
5
Berardi uomo di cultura lottò per il suo “Atleta” INESAURIBILE L’IMPEGNO PER L’OPERA DI LISIPPO
P di Giovanni Danieli
Scrittore storico dell’arte amministratore anima del carnevale di Fano e tra i fondatori de Le Cento città
ersonaggio di vasta cultura e dai molteplici interessi, Alberto è stato docente, scrittore, opinionista, storico dell’arte e del teatro, critico letterario, animatore impareggiabile di riunioni e convegni, nonché uomo politico, schierato nelle file del glorioso Partito repubblicano d’antan, Assessore alla cultura, prima nel Comune di Pesaro poi nella Provincia di Pesaro Urbino, anima del Carnevale di Fano. De Le cento città è stato uno dei tre Padri fondatori insieme a Hermas Ercoli ed a chi scrive; è stato membro nel 1995 del Comitato promotore dell’Associazione e, al mio fianco, vice Presidente del primo Consiglio direttivo nel 1996; Presidente nel biennio 20002001, nell’aprile di quest’ultimo anno guidò il primo di una lunga serie di viaggi culturali che Le cento città annualmente organizzano; fu meta il Salento ed è a quella visita che si riferisce l’immagine fotografica di Romano Folicaldi nella quale Alberto offre alla padrona di casa ospitante la torta augurale dell’Associazione. Fu l’Uomo che, consapevole del depauperamento che eventi storici avevano indotto nel patrimonio artistico marchigiano, diede vita ad una serie di azioni per sensibilizzare l’opinione pubblica e tentare il recupero dei beni dispersi; tra queste il progetto strategico La tela
strappata ed i numerosi convegni che l’Associazione dedicò all’iniziativa, nel dicembre 95 a Fano, poi a Macerata nel 96, quindi a Pesaro nel 98, ancora a Fano nel 2007. Sempre teso a “ricucire” La tela strappata, già nel 95 costituì tra di noi un gruppo di lavoro guidato da Grazia Calegari di cui facevano parte l’indimenticata Silvana Mariotti e Graciela Galvani Rocca, gruppo che preparò una serie di proposte operative coronate da buon successo. Altro esempio di questo suo impegno per la salvaguardia del nostro patrimonio artistico fu la sua lunga inesauribile azione in favore del recupero della statua di Lisippo casualmente rinvenuta nel tratto fanese della costa adriatica; questo impegno fu portato avanti per moltissimi anni sempre con molta determinazione sino a culminare nel 2007 nella presentazione di un Esposto alla Procura del Tribunale di Pesaro a nome della nostra Associazione; ne fu artefice Tullio Tonnini, avvocato di grido, in quell’anno nostro presidente oltre che amabilissima persona. Ed ancora, nella primavera del 2015 quando, in occasione del riconoscimento a Fano di Città culturale dell’anno, tenne un’appassionata relazione sul ritorno a casa del suo Atleta. Fu la sua ultima presenza tra noi. Alberto, personalità e insieme carisma, intelligenza e passione, lealtà ed amicizia. Scompare con Lui una delle menti migliori della Regione Marche. Siamo vicini a Luciana in questo momento in cui si sentirà improvvisamente così sola. ¤
Il ricordo | 2
6
Amodio non solo medico ma simbolo di umanità VITTIMA DEL COVID-19, UN VERO AMICO PER I PAZIENTI
U di Marco Belogi
Sempre sorridente e di profonda ironia Amante della storia della medicina aveva collezionato strumenti radiologici del primo Novecento
n addio fugace ma intenso, anche a nome di tutti i soci de Le Cento Città, è stato quello a Carlo Amodio dal bordo della strada che l’avrebbe portato al cimitero di Sant’Ippolito, paese di origine di Donatella. Attimi rubati in tempo di pandemia. Meritava di più! Amico vero, collega prezioso, socio generoso, era giunto negli anni ‘80 nelle Marche dalla cittadina pugliese di Rutigliano appena conseguita la specializzazione in radiologia e da questa nostra terra non si era più allontanato.
desiderio di conoscenza a tutto campo. Amava soprattutto la storia, anche quella della medicina, tanto marginale nella società odierna. Con questa passione aveva recuperato nelle varie sedi ospedaliere non più attive, come Mondolfo, Mondavio, Pergola, apparecchi radiologici del primo Novecento le cui foto sono inserite nella mia pubblicazione sulla Storia dell’Ospedale Santa Croce. Compatibilmente con i suoi fitti impegni professionali, spesso era presente alle nostre uscite mensili, interessato alle
Mondavio, Fossombrone, Fano sono gli ospedali in cui ha diretto in modo esemplare e moderno la radiologia. Al sapere medico ha saputo da subito coniugare una profonda e simpatica umanità, tanto da essere chiamato per nome dai suoi pazienti. Sempre disponibile alle richieste degli ammalati, conosciuto e stimato per i suoi meriti professionali, partecipava attivamente anche alla vita sociale della città. Da oltre un decennio era entrato con entusiasmo nella nostra associazione per il suo
bellezze della nostra Regione, sempre sorridente con la sua profonda ironia. Per questa sua umanità al suo letto sono accorsi molti colleghi, che si sono prodigati in modo encomiabile nella cura delle complicanze di questa maledetta infezione virale. Purtroppo sono risultate vane le nostre speranze! Carlo lascia un grande vuoto e un ricordo indelebile. In questo triste momento ci sentiamo tutti vicini alla nostra presidente Donatella e alla sua famiglia. ¤
Argomenti
7
Sommario 11
La pandemia | 1
Covid, cause ed effetti Oltre 180 Stati coinvolti DI GIORGIO SCALISE
15
La pandemia | 2
Epidemie nella storia morti e fosse comuni DI GIORGIO SCALISE
17
La pandemia | 3
Le parole della guerra contro il nuovo nemico DI FRANCO ELISEI
19
La pandemia | 4
La street art reagisce “Je ne suis pas un virus” DI FEDERICA FACCHINI
22
Le donne protagoniste | 1
Montessori “rivoluzionaria” ha reso il bambino protagonista DI PAOLA CIMARELLI
26
Le donne protagoniste | 2
“Dama bianca” sfida alle leggi morali DI SIMONETTA MARFOGLIA
31
Il cinema
Fano e i suoi “Vitelloni” nei pensieri di Fellini DI MASSIMO PULIANI
35
La musica
Guccini marchigiano istruttore a Villa Marina DI JACOPO ZUCCARI
Argomenti
8
Sommario 39
Il video
Spot Rai, atto d’amore per i versi de “L’infinito” DI CLAUDIO SARGENTI
42
L’anno Sanzio | 1
Raffaello, il trionfo dell’armonia Così la realtà diventa sublime DI GRAZIA CALEGARI
49
L’anno Sanzio | 2
Il mito di Raffaello nella letteratura DI NANDO CECINI
55
L’anno Sanzio | 3
La mano di Raffaello nella predella di Fano DI DANTE PIERMATTEI
60
L’anno Sanzio | 4
Raffaello e l’incisione amore a prima vista DI LUIGI BENELLI
63
L’anno Sanzio | 5
Guerra “corta e grossa” negli anni di Raffaello DI RICCARDO PAOLO UGUCCIONI
73 74
L’anno Sanzio | 6
Scalpore per la vendita del disegno raffaellesco L’artista
Nell’Apocalisse piena di ironia ondeggia tutta l’anima di Caffè DI GRAZIA CALEGARI
Argomenti
9
Sommario 78
La scomparsa
La pittura lucida e visionaria di Logli DI ARMANDO GINESI
83
L’artista incontra l’artista
Angeli ribelli di Licini messaggeri cosmici DI OSCAR PIATTELLA
87
Le mostre
I paesaggi liciniani morbidi profili fermani DI DANIELA SIMONI
90
Le mostre
Oscar Piattella disgregazione e unità DI ALBERTO MAZZACCHERA
91
Il personaggio | 1
Cecco d’Ascoli, una vita tra scienza e mistero DI ALBERTO PELLEGRINO
97
Il personaggio | 2
In astrologia la chiave per svelare l'universo DI ALBERTO PELLEGRINO
99
Archeologia
Le strategie di caccia dei nostri antenati DI STEFANO FINOCCHI
101
Ritrovamenti
Baia della Scalaccia resti romani sommersi DI GAIA PIGNOCCHI
Argomenti
10
Sommario 105
Residenze reali
Il soggiorno breve di Girolamo Bonaparte DI FABIO MARIANO
109
La ricostruzione
La forza della devozione supera anche il sisma DI SERGIO PALMA
113
Consiglio regionale
Biblioteca, un forziere di cultura delle Marche DI CLAUDIO DESIDERI
116
Passato e futuro
Aeroporto di Fano, oltre un secolo sulle gloriose ali della storia DI STEFANO MASCIONI
121
Un frutto antico
Melograno, simbolo di feconditĂ e di morte DI MARCO BELOGI
123
Uno sguardo alla natura
Mirto, vigore agli atleti e bellezza agli egiziani DI ETTORE FRANCA
Illustrazione di Sergio Giantomassi
La pandemia | 1
11
Covid, cause ed effetti Oltre 180 Stati coinvolti I CORONAVIRUS ATTUALMENTE NOTI SONO ALMENO SETTE
I di Giorgio Scalise
l 2020, anno bisestile, ci ha portato l’ansia da Covid-19 (SARS-CoV-2 ). Userò sempre il termine ansia al posto di paura, perché mi sembra più razionale e meglio descrittivo. I Coronavirus (chiamati così per le punte a forma di corona che sporgono dalla loro superfice) che oggi conosciamo, sono almeno sette (i primi identificati fin dagli anni sessanta). Quattro di questi, i coronavirus comuni, (229 E, NL 63, OL 43, UKU 1 ) sono agenti di malattie respiratorie comuni del tratto respiratorio superiore (febbre con tosse, raffreddore, bronchiti etc.); tre invece sono i più recenti (SARS-CoV, che causa la nota
“Severe Acute Respiratory Syndrome”, Mers CoV causa della mortale “Middle East Respiratory Syndrome”, e infine il Covid-19 causa della presente epidemia. Questi tre ultimi possono causare gravi polmoniti virali, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale, CID; morte. Normalmente i Coronavirus si trovano negli animali,
mammiferi quali pipistrelli, cammelli, zibetti, pargolini, ma possono evolversi e passare all’uomo e da questo agli altri uomini. La provenienza del virus Covid-19 dai serpenti venduti a scopo alimentare nel mercato di Wuhan (insieme ad altri animali vivi selvatici) appare improbabile perché l’acido nucleico completo del virus non è stato ritrovato in quello dei serpenti, se non per piccole parti. Improbabile anche la creazione del virus e poi l’uscita voluta o per errore dai laboratori di Wuhan. La trasmissione da uomo a uomo avviene attraverso le goccioline di saliva che si creano starnutendo o tossendo, ma anche attraverso contatti diretti personali (ad esempio le mani non lavate ed infettate dalle goccioline di saliva) ed anche da contatti su superfici in cui il virus può sopravvivere anche 6-9 giorni. L’OMS sottolinea che il contagio da uomo a uomo avviene da un soggetto con sintomi (raffreddore, tosse, febbre), ma anche da soggetto portatore del virus , senza sintomi. La storia dell’epidemia da Covid-19 è iniziata nel Dicembre 2019 a Wuhan (città di 12 milioni di abitanti nella provincia di Hubei), quando il dottor Li Wenhiang, oculista, insieme ad altri sette medici, segnalò sui media una strana epidemia di gravi polmoniti virali nell’ospedale in cui lavorava. Avvicinato dalla polizia locale, fu minacciato ed arrestato per procurato allarme. Solo nei giorni seguenti, fu liberato, considerato un eroe e fatto tornare al suo lavoro in ospedale. Purtroppo il dottor Li Wenhiang contrasse il virus e morì nei primi giorni del
La pandemia | 1
12
IN ITALIA
Febbraio 2020 dopo una serie di false notizie sul suo stato di salute. Secondo uno studio molecolare dell’Università di Milano, in realtà il virus era già presente nella seconda metà di Ottobre e raddoppia-
Lo stato dove è scoppiata l’epidemia e quelli in cui si è diffusa, dovrebbero applicare le “raccomandazioni temporanee” indicate dall’OMS.
Data
Contagiati
07/02/20 21/02/20 23/02/20 02/03/20 03/03/20 09/03/20 10/03/20 20/03/20 04/04/20 30/04/20 05/05/20 10/05/20 16/05/20 14/06/20
3 2 Turisti cinesi e 1 italiano rimpatriato da Wuhan 1 A Codogno il paziente 0 forse tedesco proveniente da Monaco * 1.694 34 984 Lombardia, 263 Veneto, 285 Emilia Romagna, 38 Marche (Pu) ** 6.387 366 Tutta Italia zona protetta 10.149 631 41.035 3.405 124.630 15.362 Inizia una lenta diminuzione dei dati 205.463 27.962 *** 218.268 30.395 224.760 31.763 236.989 **** 34.345 Firmato contratto per vaccino italo-inglese (fine anno)
* ** *** ****
Deceduti
Zone rosse nel Lodigiano e a Vo Euganeo (Pd) Zone rosse in Lombardia e in 11 province (inclusa Pesaro e Urbino) Decreto libera Italia su misure economiche (Parziale riapertura: visite ai congiunti, onoranze funebri). Ritorno al lavoro di 4,5 milioni di lavoratori; cassa integrazione; sostegno alle famiglie; bonus 800 euro alle partite iva etc. L'Europa sospende il piano di stabilità; la Bce mette a disposizione fondi europei; Mes incondizionato; Coronabond In questo giorno solo 338 nuovi contagiati e 44 decessi
Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sporgono dalla loro superficie visibili al microscopio elettronico
va i contagi ogni 4 giorni. Intanto il 31 Dicembre 2019 la Commissione Municipale di Wuhan segnalava all’OMS il focolaio di polmoniti virali ad eziologia ignota ed il 9 Gennaio 2020 ricercatori cinesi identificavano il nuovo Coronavirus e rendevano pubblica la sequenza genomica. L’OMS dopo una prima valutazione di rischio globale moderato, il 30 gennaio dichiarava l’emergenza globale con rischio molto alto per la Cina e alto a livello globale. Benché i casi fuori dalla Cina non fossero molti al 30 gennaio, l’OMS invitava i paesi con sistema sanitario debole a prepararsi all’epidemia rinforzando i propri sistemi di prevenzione. Bisogna ricordare che l’emergenza sanitaria globale è un evento sanitario che rappresenta: • Un rischio per la salute anche di altri stati oltre a quello di partenza. • Richiede una risposta globale.
Seguire alla data odierna l’andamento dell’epidemia è molto difficile, perché i numeri variano di giorno in giorno e perché gli stati sono passati dalla segnalazione dei casi positivi a quelli più numerosi, anche dei soggetti con sintomatologia. Noi fermeremo l’osservazione al 14 Giugno 2020 (7.670.887 contagiati e 427.097 decessi nel mondo), cercando di arrivare a qualche conclusione a quella data. L’11 Marzo 2020 l’OMS, finalmente, dopo esitazioni i tipo economico, ha denominato l’evento in corso una pandemia,tenuto conto del coinvolgimento ormai di più di 100 stati. Impressionanti sono i 705 casi contagiati ed i 7 morti sulla nave da crociera con 3711 passeggeri (35 italiani) ancorata a Yokohama in Giappone in quarantena. Episodio concluso il 2 Marzo con l’ultimo sbarco del comandante italiano. Naturalmente all’epidemia è legata una grave crisi economica, collegata alla chiusura
La pandemia | 1
d) chi ha una infezione acuta delle vie respiratorie, dovrebbe stare a distanza di almeno uno o due metri e coprire gli starnuti e i colpi di tosse. e) ricoverare in rianimazione i casi gravi. f) ricoverare comunque i casi a media gravità per il pericolo di grave
IN CINA
Data
NELLE MARCHE
delle fabbriche, del turismo e degli scambi commerciali (L’inflazione in Cina a Gennaio è balzata al 5,7% annuo rispetto al 4,5% del Dicembre 2019. Al di fuori della Cina la General Motor americana sospenderà la produzione per mancanza di componenti provenienti dalla Cina, il prezzo del petrolio è diminuito del 25% per il minor consumo da parte della Cina. Per quanto riguarda il trattamento l’OMS segnala alcuni risultati, non scientificamente provati, con l’associazione Lopinavir/Ritonavir (farmaco contro l’HIV) e Remdesivir (farmaco contro l’Ebola), il Plaquenil (farmaco contro la Malaria), il Tacilizumab (farmaco per l’artrite reumatoide), l’eparina (per prevenire la CIC) ed altri ancora. Quindi l’unica terapia è quella di supporto con eventuale ricovero in rianimazione per i casi più gravi e con ossigenoterapia, antibiotici per le sovrapposizioni batteriche, reidratazione, cortisonici (?) tracheotomia (se necessaria ), eparina, terapia per eventuale insufficienza renale. E’ in corso una sperimentazione controllata con plasma iperimmune di soggetti guariti, i cui risultati sembrano promettenti. Non esiste attualmente un vaccino anche se se ne può prevedere la disponibilità tra 6 mesi-un anno. Perciò l’unico intervento utile è quello della prevenzione. L’OMS raccomanda in generale di: a) evitare il contatto stretto con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute. (distanziamento sociale) b) lavarsi frequentemente le mani. (Possibilmente con soluzioni gelificate di Amuchina o alcool etilico al 96%) c) evitare contatti con animali selvatici o di fattoria.
13
Contagiati Deceduti
21/01/20 291 6 07/02/20 31.221 637 24/02/20 77.262 2.599 07/03/20 * 10/03/20 80.958 3.162 15/04/20 ** 30/04/20 83.944 4.512 16/05/20 84.038 4.637 14/06/20 84.335
Segnalato nuovo focolaio a Pechino
* **
La Provincia di Hubei verso 0 contagi Segnalati i primi casi di "ritorno" immediatamente circoscritti
Data
Contagiati Deceduti
27/2/20 05/03/20 08/03/20 10/03/20 24/03/20 30/04/20 10/05/20 16/05/20 14/06/20
3 0 479 13 * 394 18 2.736 231 6.247 906 6.493 958 6.642 982 6.758 ** 993
* **
Pu 1.371; An 751; Mc 368; Fm 139 Pu 2.490; An 1.805; Mc 1.010; Fm 431; Ap 281 Pu 2.650; An 1.830; Mc 1.056; Fm 455; Ap 287 Pu 2.727; An 1.853; Mc 1.092; Fm 455; Ap 289 Pu 2.754; An 1.875; Mc 1.133; Fm 469; Ap 290
Zona rossa la provincia di Pesaro-Urbino Nessun decesso, solo 4 nuovi positivi
peggioramento. g) rafforzare nei pronto soccorso le misure di isolamento per le infezioni respiratorie. h) utilizzare sempre mascherine e guanti nei luoghi ristretti e sui mezzi pubblici. In Italia dal 30 Gennaio 2020 sono stati interrotti i collegamenti aerei con la Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan; negli aeroporti, anche interni, tutti i passeggeri sono sottoposti a controllo della temperatura con isolamento dei malati e monitoraggio dei contatti stretti nelle due settimane
Normalmente i coronavirus si trovano negli animali come pipistrelli cammelli, zibetti e pargolini
La pandemia | 1
Secondo uno studio molecolare dell’Università di Milano il virus in Cina sarebbe stato già presente a ottobre
14
successive all’arrivo. Inoltre è stato attivato il numero 1500 a cui rispondono sanitari formati per ogni tipo di domanda relativa Coronavirus. Un protocollo comportamentale è stato scritto e divulgato in comune dalla Società Italiana di Malattie Infettive e da quella dei medici di Medicina Generale. Viene sottolineato che la comunicazione corretta è fondamentale per esorcizzare la paura sociale inevitabile nella popolazione. Il caso sospetto segnalato dal medico di Medicina Generale dovrà essere avviato direttamente al reparto di Malattie Infettive, senza passare dal Pronto Soccorso. Per i contatti o per i famigliari del malato, è consigliato: 1) collocare il soggetto sospetto in camera singola, limitando il numero di assistenti e riducendo al minimo lo spazio condiviso. 2) l’assistente dovrà indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani, evitare il contatto con i fluidi corporali del malato ed eliminare i materiali utilizzati dal malato per coprire i colpi di tosse o gli starnuti. 3) pulire le superfici toccate con candeggina (il virus può resistere sulle superfici per6 - 9 giorni) e lavare la biancheria in lavatrice a 60-90 °C. 4) Tutti i membri della famiglia vanno considerati contatti e mantenuti per almeno 14 giorni in isolamento. Attualmente l’OMS definisce caso sospetto un paziente con severa infezione respiratoria e/o con contatto con paziente
Covid-19 positivo o sospetto tale nei 14 giorni precedenti. Il contatto è chi assiste un caso di infezione da Covid-19 o è nella stessa classe del malato ,o ha viaggiato con lui o vive nella stessa casa. I contatti debbono essere seguiti per 14 giorni (forse 24) dalle autorità sanitarie, i loro movimenti limitati, le visite evitate e su di loro va effettuato il test di laboratorio (tampone faringeo e/o il test sierologico per la ricerca degli anticorpi). In conclusione: la nuova infezione da Covid-19 si caratterizza per: a) alta diffusibilità per via aerea e per contatto b) gravità della sintomatologia che richiede il ricovero ospedaliero c) la mortalità grave d) la riduzione dei nuovi casi testati in Cina contrasta con la comparsa di nuovi focolai a Pechino I provvedimenti da prendere attualmente sono: 1) Prevenire la diffusione e limitare il passaggio da uomo a uomo (anche mediante la App immuno Covid sul telefonino, i contatti con contagiati, il lavaggio frequente delle mani) 2) Identificare ed isolare al più presto i nuovi casi 3) Identificare e ridurre i casi con trasmissione da animali selvatici 4) Identificare un trattamento efficace e al più presto un vaccino 5) Diffondere notizie veritiere ed evitare la disinformazione 6) Ridurre l’impatto economico attraverso interventi multisettoriali. ¤
La pandemia | 2
15
Epidemie nella storia morti e fosse comuni STESSE CRITICITÀ NEL TEMPO: POCHI LETTI E SANITARI
di Giorgio Scalise
In alto, un'immagine d'epoca con il soccorso di un ammalato
L’
epidemia da Coronavirus potrebbe essere paragonata a molte epidemie da virus influenzali avvenute nel ‘900. In realtà ci sono alcune differenze tra i due tipi di epidemie. Le epidemie da virus influenzali di ceppo diverso si sono manifestate nel ‘900 almeno 4 volte: La spagnola (sottotipo H1N1) così chiamata perché per prima segnalata dai giornalisti della neutrale Spagna,scoppiò negli anni 1918-1920,provocò dai 50 ai 100 milioni di morti (mortalità del 10-20%), causò morti soprattutto nei giovani adulti defedati da guerre, scarse condizioni igieniche e insufficiente alimentazione. La causa di morte principale fu la eccessiva risposta immunitaria (tem-
pesta citochinica). Gli anziani furono risparmiati perché protetti da anticorpi acquisiti in una precedente epidemia dell’800 causata dallo stesso virus. Originatasi nel Kansas (USA) fu diffusa in Europa dai soldati americani nell’estate e autunno del 1918. L’alta mortalità era anche legata alle sovrapposizioni batteriche non controllabili dagli inesistenti antibiotici. L’andamento nel 1918 fu caratterizzato da due ondate successive, La seconda più letale della prima, ma verso la fine del 1920 il numero dei nuovi casi cadde bruscamente e il virus perse virulenza e letalità in seguito a diverse mutazioni. L’asiatica (sottotipo H2N2) proveniva dalla Cina; scoppiò
La pandemia | 2
Dalla spagnola all’asiatica, dall’influenza di Hong Kong all’aviaria e alla suina In un secolo milioni di vittime
In alto, nel dicembre del 1918 veniva chiesto ai passeggeri di indossare le mascherine sui mezzi pubblici. Qui sopra, due donne a passeggio con il volto coperto
16
negli anni 1956-1958 e causò da 1 a 4 milioni di morti. L’influenza di Hong Kong (sottotipo H3N2) del 19681969 causò tra i 750.000 e 2 milioni di morti. L’influenza aviaria (sottotipo H5N1) del 1996-1997 si trasmetteva solo dal pollame all’uomo: furono uccisi milioni di polli! La suina (sottotipo H1N1) del 2009-2010 (dal Messico), si trasmetteva dal maiale all’uomo e causò circa 20.000 morti. Probabilmente trattandosi dello stesso virus della spagnola, si autolimitò per la presenza di immunità residua in molti soggetti anziani. Per le ultime 4 epidemie la mortalità fu ridotta in seguito all’introduzione del vaccino e al miglioramento delle cure. Da notare che le epidemie da virus influenzali possono avere anche due o tre ondate successive con mortalità crescente; in ciascuna ondata invece la mortalità è decrescente. La mortalità varia anche da regione a regione (per la spagnola in Europa poteva variare tra il 5-10%,ma in India raggiunse anche il 21,9%).In tutte le epidemie influenzali le conseguenze furono le stesse: carenza di posti in ospedale, di forniture ospedaliere e di personale medico ed infermieristico. I morti restavano insepolti o messi in fosse comuni. La popolazione manifestò sfiducia nelle istituzioni e prevalsero egoismo, illegalità e autoritarismo. Le gravi conseguenze economiche legate anche alla perdita di posti di lavoro si manifestarono per parecchi anni dopo. Il mondo scientifico si deve impegnare a prevenire le epidemie da virus influen-
zali con diversi interventi: 1) Vaccinazione o soppressione degli animali da cui originano i virus e vaccinazione delle persone che lavorano a contatto degli animali. 2) Misure di distanziamento sociale, isolamento, protezione con DPI delle persone. Limitazione viaggi e assembramenti. 3) Produrre un vaccino efficace tenendo conto che occorrono da 6 mesi ad un anno per sviluppare, sperimentare e produrre almeno un miliardo o più di dosi (tenendo conto che la massima risposta si ha con due dosi successive). 4) Anche senza ottenere una cessazione dell’epidemia occorre rallentarla con l’individuazione di farmaci antivirali, interventi sugli allevamenti degli animali da cui origina il virus, raccolta dati epidemiologici rapidi e loro elaborazione. Infine per sottolineare l’importanza della ricerca scientifica nella conoscenza delle pandemie virali, voglio riportare i successi di alcuni ricercatori americani su un report del CDC. Costoro sono riusciti a prelevare dai polmoni di “Lucy” (donna dell’Alaska, morta nella epidemia di spagnola del 1918,il cui corpo si era conservato perfettamente sotto i ghiacci) l’RNA del virus. Hanno sequenziato il virus e lo hanno ricostruito in condizioni di sicurezza, dimostrando che era di origini aviarie, causava nei topi le stesse alterazioni polmonari dei morti per spagnola e che la virulenza era legata alla particolare emoagglutinina non presente in nessuno degli altri virus influenzali. ¤
La pandemia | 3
17
Le parole della guerra contro il nuovo nemico ABUSO DELL´ALFABETO MILITARE NELLA SFIDA AL VIRUS
di Franco Elisei
E
mergenza, prevenzione, allarme, precauzione, psicosi e prudenza. Sono termini che si sono ripetuti quotidianamente nei giorni più critici della pandemia da Covid-19 in una escalation di notizie ma anche di contraddizioni e fake news con inevitabili reazioni a catena che hanno superato a volte la realtà scientifica e concreta dei fatti. Con il rischio che la percezione superasse la realtà stessa. E mai come in questi frangenti l’informazione si è assunta una responsabilità altamente professionale. Così pure le istituzioni, chiamate ad altrettanta delicata responsabilità. In questo contesto si è sviluppata un’altra particolarità: l’uso sempre più frequente di metafore belliche per descrivere la situazione pandemica. Si è parlato di ospedali in trincea, del fronte del virus, di economia di guerra, di medici al fronte, di eroi, di coprifuoco e di una lunga battaglia da vincere con tutte le armi disponibili, contro un nemico subdolo e sempre in agguato. Un vero e proprio bagaglio di termini che evocano conflitti bellici. Lo stesso appuntamento pomeridiano con la Protezione civile che sciorinava dati di decessi e contagi, assomigliava a un vero e proprio bollettino di guerra. La malattia stessa è apparsa come un atto di guer-
ra, dove emergeva la percezione negativa che chi cadeva diventava automaticamente un perdente, uno sconfitto, invaso dal nemico. Interpretazione ovviamente da rigettare. Ne è derivata una “infopandemia” che ha coinvolto anche leader politici e stimati virologi. Nell’ambito delle figure retoriche si è fatto uso a piene mani di metafora, enfasi e iperbole. “Siamo in guerra” è stata l’affermazione più usata. Lo ha scandito più volte il presidente francese Emmanuel Macron e lo ha ripetuto anche il governatore di New York Andrew Cuomo. Per Boris Johnson il virus era “un nemico insidioso che insieme possiamo battere”. Trump non è stato da meno: “Stiamo combattendo contro un nemico invisibile e vinceremo”. Lo stesso premier italiano Giuseppe Conte, ricordando Churchill, ha fatto riferimento all’ora più buia, richiamando l’Italia ad “essere unita”, e i cittadini a sventolare “orgogliosi il Tricolore”….“insieme, con forza e coraggio per sconfiggere questo nemico”. Un uso e abuso di figure retoriche, applicate con disinvoltura anche nelle cronache sportive, capaci di aumentare la drammatizzazione delle parole e di creare un immaginario collettivo che agisce sui comportamenti sia dei comunicatori che dei fruitori del messaggio. Il ricorso all’alfabeto militaresco innesca una forte capacità di mobilitazione. Ma anche di persuasione aumentando tensione e apprensione. Più forte era il monito e più diventava convincente la necessità di restare a casa, facendo leva maggiormente sull’aspetto irrazionale che su quello della
La pandemia | 3
La pandemia descritta come un atto di guerra con metafore che hanno drammatizzato la situazione
Nella pagina precedente, l'immagine iconica del periodo acuto della pandemia. Sopra i convogli militari destinati al trasporto funebre delle vittime del Covid 19
18
consapevolezza di ognuno. Le parole hanno un effetto immediato, emotivo che inducono a percezioni che spesso distorcono la realtà. I termini malattia, epidemia, contagio sono già metafore potenti. Più che linguaggio bellico forse erano necessari maggiori riferimenti alla solidarietà e responsabilità. L’uso delle parole giuste aiuta a comprendere meglio il fenomeno, altrimenti il messaggio diventa equivoco. E in guerra emerge sempre la tentazione di provvedimenti drastici e manovre restrittive al limite dei diritti. In guerra nessun
sacrificio è eccessivo. Dal concetto di conflitto nasce anche l’idea dell’altro come un nemico, che ha rischiato di diventare il potenziale untore. Non solo il virus. L’uso di un linguaggio esasperato porta ad alimentare la paura, rischia di scatenare sentimenti di intolleranza e di diffidenza più che di solidarietà. In un convegno con la presenza dell’allora inviata di guerra Giovanna Botteri chiesi se era possibile usare parole di pace per descrivere un conflitto. La risposta, a sorpresa, fu affermativa. Senza dubbi. E la pri-
ma parola che viene in mente è speranza. Da questa emergenza, alla fine, sono emersi diversi insegnamenti: quanto siano importanti le applicazioni tecnologiche, i concetti di prevenzione e revisione della politica sanitaria, in particolar modo dei presìdi di base e del rapporto tra i modelli pubblici e privati. E quanto serva più Europa. Non solo, è apparso evidente quanto pesi un miglior bilanciamento tra economia e salute, insieme, contro un altro virus, quello della burocrazia. E, non ultimo, quanto sia auspicabile il recupero di un tempo più a misura d’uomo. Guardare la realtà con occhi diversi a quelli dell’esclusivo profitto. Progetti che si legano emotivamente a quell’immagine di grande suggestione che ha rivestito molte pareti di ospedali: un angelo con la mascherina e camice che culla un’Italia fragile e in cerca di protezione. Più che una guerra è una sfida piena di sofferenza. Una sfida che vede la comunità scientifica e i media chiamati responsabilmente a divulgare conoscenza. Che permetta di prendere decisioni con la più ampia consapevolezza. Della guerra, in realtà, abbiamo visto immagini che la ricordano molto da vicino, come la mobilitazione dell’esercito, non in armi ma in ruoli di profonda solidarietà. Quei camion militari che custodivano le bare delle vittime del virus è stata un’immagine di solitudine e di morte da fermare il cuore, potente nella sua drammaticità. Della guerra, questo sì, è rimasta la paura di morire. E il dolore per chi non c’è più. ¤
La pandemia | 4
19
La street art reagisce “Je ne suis pas un virus” LA CREATIVITÀ COME VACCINO CONTRO LA SFIDUCIA
I di Federica Facchini
A Trastevere, ritratto di famiglia in gabbia fotografata da un panda in libertà (opera di Harry Greb)
l coronavirus ha sicuramente stravolto la quotidianità – in moltissimi casi anche la vita - di milioni di persone e nell’isolamento forzato dell’#iorestoacasa non è passato giorno senza che il pubblico sia stato inondato da un’esplosione tanto informativa quanto di intrattenimento, guidata prevalentemente dalla rete e dai social network. E in tempi così difficili anche il mondo della cultura contemporanea ha reagito e l’arte in particolare - che nei secoli si è trovata più volte ad attraversare guerre e pesti-
lenze - ancora una volta ha rivelato la sua capacità calzante di essere testimonianza, critica, rivelazione, a volte anche riproduzione stucchevole, ma malgrado tutto ha saputo donare un po’ di piacere e stimolare curiosità. E se la pandemia ha costretto le fiere, gli eventi, gli appuntamenti culturali ad essere
rinviati a data da destinarsi, in molti casi anche all’anno prossimo, a spegnere le luci sulle mostre (anche quelle di livello internazionale) sottratte agli sguardi del pubblico, negli ultimi due mesi musei e istituzioni culturali hanno prodotto un’ingente quantità di materiali virtuali, attraverso social e siti, offrendo approfondimenti, focus, incontri, mostre virtuali, lezioni, interviste, visite on line alle collezioni, documenti d’archivio, in alcuni casi davvero molto interessanti. Allo stesso modo gli artisti, anche in un momento storico come questo, in cui milioni di persone si sono dovute mantenere fisicamente separate, nell’individuale e soggettiva interpretazione della realtà hanno saputo trasmettere, comunicare, diffondere messaggi attraverso canali, modalità e linguaggi differenti, aprendosi a tutte le forme di espressione… più o meno consentite. Sì, perché mentre le strade erano vuote anche gli street artists hanno interpretato il Covid 19 con opere poetiche o irriverenti, romantiche o sarcastiche, che hanno tappezzato muri di tutte le città del mondo, e che per la loro originalità, ironia e intelligenza sono diventate virali. Messaggi di grande impatto emotivo che resteranno a memoria di una strana guerra combattuta da tutti, indistintamente. Ci sono tributi a medici e infermieri, ci sono baci blindati dalle mascherine, fumetti o famosi quadri del passato rivisitati in spirito da quarantena. Da New York (Tom Bob) a Los Angeles (Mr. Brainwash e Teachr1), da Amster-
La pandemia | 4
Il mondo della cultura contemporanea ha reagito alla pandemia con i suoi linguaggi e le sue diverse forme di espressione
In alto, il celebre "Bacio" di Hayez reinterpretato da TVBoy con mascherina e gel disinfettante in mano Qui sopra, Maupal, ridisegna Tom & Jerry con un monito di distanziamento fisico
20 dam (Fake) a Parigi (JR), da Londra (Lionel Stanhope) a Bristol (Bansky), da Glasgow (Rebel Bear), a Hamm, Germania (Kai ‘Uzey’ Wohlgemuth), da Copenaghen (Welinoo) a Mumbai (Tyler), da Venice Beach (Pony Wawe) a Teheran (Xamoosh) da Itu (Brasile, Eduardo Kobra) a Doheny, West Hollywood (Corie Mattie)… questi murales hanno voluto trasmettere all’unisono la forza, la speranza, il coraggio per aiutare le rispettive comunità ad affrontare una battaglia inaspettata. A Roma, era solo l’inizio di febbraio quando la poster artist Laika MCMLIV ha creato un'opera in via Principe Amedeo, che voleva essere un messaggio di solidarietà con la comunità cinese in Italia quando il coronavirus era ancora un problema solo in Cina, mentre in Italia in molti temevano ed evitavano le comunità e i negozi asiatici. Ritrae una donna cinese con il volto di una ristoratrice nota nel quartiere. Una scritta recita "C'è in giro un'epidemia di ignoranza... Dobbiamo proteggerci!!!". E, sul cartello,
"Je ne suis pas un virus", non sono un virus. Anche TVBoy, siciliano di nascita ma spagnolo di adozione, noto per i suoi lavori realizzati con stencil o stikers, a Milano già il 28 febbraio ha deciso di reinterpretare i
due protagonisti del celebre “Bacio” di Hayez (conservato all’interno della Pinacoteca di Brera) con mascherine e gel disinfettante in mano. Il lavoro non ha aspettato molto per essere vandalizzato, perché è stato rovinato nell’arco di 24 ore dalla sua realizzazione. Ancora a febbraio, l’artista aveva realizzato a Barcellona una reinterpretazione moderna della Gioconda di Leonardo. Raffigurata nell’atto di farsi un selfie, anche in questo caso il volto della Monna Lisa era coperto da una mascherina. Sulla cover dello smartphone era ben riconoscibile un logo che faceva riferimento al Mobile World Congress (MWC) – il più grande evento sulla telefonia mobile che si sarebbe dovuto svolgere a Barcellona a febbraio e cancellato a causa dell’emergenza sanitaria. Il murales, infatti, era stato battezzato “Mobile World Virus”. E successivamente nello stesso posto della Gioconda, il 13 marzo, lo stesso TvBoy ha
La pandemia | 4
messo l’immagine dello Zio Sam, personificazione degli Stati Uniti, ma con la bandiera dell’Europa sul cappello e la mascherina, sotto campeggia la scritta “I want you stay home”: voglio che resti a casa. “È un poster simile a quelli che pubblicizzavano il reclutamento di nuovi militari negli USA, spesso accompagnati al claim “Uniti restiamo in piedi, divisi cadiamo” ma TvBoy questa volta ha voluto parafrasarlo con un concetto diametralmente opposto: “Se siamo divisi restiamo in piedi, se ci uniamo cadiamo”. Ancora a Roma, ma a Trastevere, Harry Greb ha proposto Human Family: un ritratto di famiglia in gabbia, naturalmente con mascherine e a fotografare gli umani, per una volta davanti alle sbarre anziché dietro è un panda. A due passi dal Vaticano, Maupal ha creato un'opera che ha come protagonisti Tom & Jerry che si trovano a “Un metro” l’uno dall’altro, per dar rilievo ad un comportamento
21
che deve diventare un’abitudine per tutti i cittadini. A Padova AlessioB ha reso omaggio a tutto il personale sanitario che si è speso a rischio della propria salute per contrastare il virus, rappresentando una bella Wonder Woman che indossa il camice e la mascherina tricolore. E sempre sua quella con E.T. che invita a stare a casa. A Pompei invece dove vive e lavora Nello Petrucci, nella notte tra il 10 e l'11 marzo, su un muro nei pressi di un centro commerciale, è apparso Sweet Home, che ritrae i Simpson con mascherine davanti alla Tv per rilanciare l'invito a stare a casa (Stay Home). E questi sono solo una piccola parte rispetto ai tanti altri e di dimensioni maggiori che sono spuntati in giro per il mondo. Tutti con un unico obiettivo, quello di veicolare un messaggio di unione, conforto, ispirazione e speranza. L’arte come passione, come vaccino potente contro la disperazione e la sfiducia. ¤
In alto, una donna cinese disegnata a Roma da Laika MCMLIV con cartello emblematico Qui sopra, una bella Wonder Woman con camice e mascherina tricolore a Padova (AlessioB)
Le donne protagoniste | 1
A
di Paola Cimarelli
lla scuola elementare, il problema di matematica era il momento topico della competizione fra noi alunni. La maestra, che esprimeva una didattica piuttosto rigida e militaresca, derivata anche dalla frequentazione di un certo ventennio, ci spronava alla gara, quasi fosse una performance atletica. Ci distribuiva sulla superficie della grande classe, per non farci copiare, inginocchiati sul pavimento e appoggiati sulle piccole sedie usate come tavolino. Dalla dettatura del problema aritmetico alla sua risoluzione non passavano, in
media, mai oltre i cinque minuti. In sottofondo, c'erano le sue parole che scandendo i cognomi, ci spingevano uno contro l'altro per vincere la gara. Chi risolveva per primo il quesito scattava dalla sua posizione e correva alla cattedra per la correzione. Andavo bene in questa materia, ero nel gruppo degli "eletti", di coloro che a turno erano i vincitori. La soddisfazione era grande, il gusto della vittoria certificata da quel 10 in rosso sul quaderno, dal sentirsi parte di quelli erano per tutti i piÚ bravi. CosÏ come però era altrettanto amaro il sapore della sconfit-
23
Montessori “rivoluzionaria” ha reso il bambino protagonista SCIENZIATA, PEDAGOGISTA, EDUCATRICE E FEMMINISTA NATA 150 ANNI FA A CHIARAVALLE HA ELABORATO UN NUOVO PENSIERO DELL’INFANZIA
ta, da ricordare per il resto della giornata. Incupisce, da adulta, ripensare a tutto ciò, a questa educazione disfunzionale basata, fin dall'infanzia, sulla competizione invece che sulla collaborazione. L'opposto di quello che è il "metodo Montessori" in cui è il bambino al centro del progetto educativo che lo accompagna, lo affianca in uno sviluppo che parte dalla sua naturale curiosità, vero motore dell'apprendimento. Maria Montessori crea la sua rivoluzione culturale rendendo il bambino protagonista della sua crescita, riconoscendolo come persona.
Impensabile, talvolta ancor oggi, e avveniristico. Nel 2020 di Maria Montessori, nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona, si celebrano i 150 anni della nascita, avvenuta il 31 agosto 1870. Fra le prime laureate in medicina in Italia, viene esaltata e criticata, allo stesso tempo, come cattolica, per le sue ipotetiche simpatie fasciste, ma forse soprattutto perché donna, innovatrice, femminista, coraggiosa. Scienziata, pedagogista ed educatrice, nella sua vita ha conosciuto anche il dolore di essere una madre che non vede crescere il suo bambi-
no, nato il 31 marzo 1898 dal forte legame sentimentale e professionale con Giuseppe Montesano. Le pressioni della famiglia, della madre Renilde in particolare, non lasciano spazio alle nozze sembra per non limitare la promettente carriera di Maria Montessori. Il piccolo Mario viene affidato ad una famiglia vicino Roma, dove i Montessori vivono. Maria continua ad occuparsi del bambino finché nel 1913 lo prende finalmente con sé ristabilendo il legame famigliare con il figlio che, negli anni, diviene anche uno dei suoi principali collaboratori. Mon-
Le donne protagoniste | 1
È stata tra le prime laureate in medicina in Italia e candidata per tre volte al premio Nobel per la pace
Nelle foto sopra, la visita della Montessori a Chiaravalle nell'ottobre del 1950 Nella pagina a destra in basso l'educatrice ad Ancona mentre riceve un omaggio floreale
tessori comincia, nella capitale, il suo lavoro educativo con i bambini con problemi psichici. Apre il 6 gennaio 1907 la prima “Casa dei bambini” nel quartiere popolare di San Lorenzo a Roma insieme ad un gruppo di appassionati allievi e collaboratori. È l’inizio della grande rivoluzione del suo pensiero pedagogico dedicato a tre fasce d’età, i piccoli dai 0 ai 3 anni, dai 3 agli 11 anni e poi gli adolescenti. La “Casa dei bambini” è il luogo simbolo dove si sviluppa il concetto di “aiutami a fare da solo”. È l'ambiente educativo che favorisce l’autonomia e che deve essere scientificamente organizzato e preparato ad accogliere i bambini, sulla scelta e l'uso del materiale di sviluppo, sulla ridefinizione del ruolo e della funzione dell’educatore. Non ci sono lezioni frontali, l'educatore si siede accanto al bambino e lui apprende toccando, sperimentando, creando perché lo sviluppo dell’intelligenza passa attraverso le mani. “La mia esperienza personale – afferma Montessori - mi ha dimostrato che
se, per condizioni particolari di ambiente, il bambino non può far uso della mano, il suo carattere rimane ad un livello molto basso, resta incapace di ubbidienza, di iniziativa, pigro e triste, mentre il bambino che ha potuto lavorare con le proprie mani rivela uno sviluppo spiccato e forza di carattere”. Il bambino, scrive Montessori, “non è debole e povero",
24 "è padre dell’umanità e della civilizzazione, è il nostro maestro anche nei riguardi della sua educazione. Questa non è una esaltazione fuori misura dell’infanzia, è una grande verità”. Da zero a tre anni, il bambino è nell’età dell’oro, quella in cui “crea dal nulla la nostra stessa realtà. In questa fase della sua vita incarna i caratteri della nostra specie, in particolare quelli del movimento, del linguaggio, del pensiero”. L’educatore montessoriano, quindi, non si pone “nei confronti del bambino piccolo come maestro e pedagogo perché sa di non poter determinare e neppure indirizzare il processo con il quale il bambino forma e crea il suo stesso sviluppo”. Lo accompagna, con specifici percorsi pedagogici, in quelli che sono i quattro piani di sviluppo della "lunga infanzia umana" descritta da Montessori, uno ogni sei anni, con mutamenti progressivi che riguardano l'età dagli zero ai 24 anni. “Montessori considerava l'originalità di ogni essere umano un valore per l'umanità intera - scrive Grazia Honegger Fresco nel libro dedicato alla pedagogista di cui è stata allieva -, così come ciascuno costituiva un irrinunciabile contributo di crescita per il gruppo famiglia o nido o classe” sostenendo che “a ogni periodo evolutivo deve corrispondere, da parte degli adulti, un insieme di risposte adeguate” ossia “stimoli delle capacità autocostruttive dell'individuo che si rendono evidenti in ogni fascia d'età”. Tre i percorsi pedagogici per lo sviluppo dell’individuo. Il primo tende a “sensibilizzare gli adulti al rispetto della vita che si evolve in ciascun essere umano tramite un’osservazione mai invasiva”, un “processo continuo di attenzione all’altro” scrive Honegger Fresco. Il secondo percorso del progetto Montessori prevede di “preparare per ogni età l’ambiente
Le donne protagoniste | 1
adatto”, con oggetti e mobili attraverso cui “bambini o ragazzi possano scegliere ciò che è loro necessario per ‘costruirsi’ e via via costruire i rapporti con gli altri” perché “l’ambiente preparato è come un ‘maestro indiretto’: se si sbaglia, ci si riflette su e si ricomincia”. Il terzo percorso vuole rispondere “ai fenomeni che caratterizzano le diverse fasi di crescita”, come il bisogno di continuità dei piccoli, di giustizia della seconda infanzia, il desiderio di cambiamento e di avventura dell’adolescenza. Dopo l'anticipo della mostra "Toccare la bellezza" alla Mole Vanvitelliana di Ancona, in cui il progetto educativo ha incontrato la creatività di Bruno Munari e l'originalità del Museo Omero, le celebrazioni promosse dalla Fondazione Montessori di Chiaravalle per i 150 anni della nascita della scienziata sono in corso di rimodulazione a causa dell’emergenza sanitaria. Il culmine dovrebbe essere il 31 agosto, il "Natale" Montessori, con l'appuntamento nella rinnovata casa di nascita nella cittadina marchigiana, luogo interattivo per scoprire il suo pensiero e il suo mondo. Gli appuntamenti della Fondazione sono coordinati dallo psichiatra e scrittore Vittorino Andreoli, autore di diverse antologie su Montessori. A giugno si sono svolti due incontri di formazione per docenti, “Marche Montessori: un’aula grande quanto una regione”, per la diffusione del metodo montessoriano, organizzati con Università di Macerata, Opera nazionale Montessori ed Eurocentro. "Nella pedagogia moderna esiste un primo e un dopo Montessori - dice Alfio Albani, presidente della Fondazione -, è grazie a lei se oggi ci sono le scuole dell'infanzia. È un confine imprescindibile come quello segnato da Sigmund Freud per la psicologia. La sua è una figura eccezionale,
un carattere determinato che sceglie di laurearsi in medicina e antropologia, quando chi poteva studiare, fra le donne, arrivava in genere alla quinta ginnasio o al liceo, e che ha concepito e disegnato un pensiero di educazione, dei diritti dell'infanzia e di pace". Il suo, aggiunge Albani, "è una strada di ricerca e di studio mosso da una grande spinta e passione nel pensare che il bambino è il padre dell'uomo contribuendo, con il suo percorso educativo, ad un nuovo umanesimo. Un esempio su tutti è il diritto del bambino ad essere aiutato a fare da solo, ad apprendere secondo la sua indole e i suoi tempi". Questo cammino, che diffonde il seme dell'ascolto di ogni individuo, porta Montessori ad essere candidata ben tre volte al premio Nobel per la pace e alla diffusione del suo metodo, in Italia e in tutto il mondo, dove sono migliaia le scuole che lo trasformano ogni giorno nell’opportunità di vedere sbocciare l’individualità e l’unicità di ogni bambino. ¤
25
Nel 1907 apre la “Casa dei bambini” a Roma dove si sviluppa il concetto di “aiutami a fare da solo”
Le donne protagoniste | 2
U di Simonetta Marfoglia
La loro storia sfida preconcetti morale comune e leggi dell’epoca La rivoluzione culturale è alle porte ma non ne gioveranno
n autografo, la firma “Fausto Coppi” vergata su un biglietto e un invito. La richiesta viene da una giovane coppia, sposata da poco: lui è il medico Enrico Locatelli, lei è la moglie, Giulia Occhini. Pochi forse oggi ricordano il suo nome, tanti ne conoscono il soprannome: “la dama bianca”, evocativo quanto basta per simboleggiare un’Italia conformisticamente bifronte, quella a cavallo degli anni ’50, ancorata al passato quanto timorosa eppure tentata dal futuro. Ma il giorno dell’autografo il decennio deve ancora essere scavallato: è il 1948, l’anno, per inciso, delle elezioni politiche destinate a cambiare il corso della storia con la vittoria della Dc di De Gasperi sul Fronte Democratico Popolare che ha i suoi leader in Palmiro Togliatti (Pci) e Pietro Nenni (Psi). E’ l’8 agosto e su un percorso di 265 chilometri si svolge la 28esima edizione della corsa ciclistica “Le Tre Valli Varesine”: Fausto Coppi è già il cam-
pione che poi sarà celebrato ovunque come “il campionissimo”, lo tallona Gino Bartali. Coppi arriva primo, Bartali secondo. Non è la prima volta, non sarà l’ultima di una sfida dove i ruoli si alternano e che diventerà paradigmatica per capire la contrapposizione di un’Italia povera e contadina che esce ferita dalla Guerra affacciandosi guardinga sul boom economico prodromo della rivoluzione sociale degli anni ’60. Intanto l’8 agosto si festeggia la vittoria di Coppi e nel tripudio di applausi, mazzi di fiori e spumanti aperti, arriva quella richiesta di autografo. Che non sarà galeotto come forse piacerebbe a chi si ispira al Sommo Poeta ma ci mette del suo per modificare le storie personali dei protagonisti, stravolgendole con l’intensità drammatica che è propria dell’epica, tale da farle assurgere alla cronaca, alla storia e al mito contemporaneo. Tuttavia quell’8 agosto non succede nulla, al di là delle formalità di rito, della cono-
27
“Dama bianca” sfida alle leggi morali L'AMORE TRA GIULIA OCCHINI E FAUSTO COPPI NELL'ITALIA DEGLI ANNI '50
scenza e della gentilezza. O forse no. Chissà. Giulia Occhini, non ancora “La dama bianca”, è giovane e bella. Ha 26 anni ed è sposata con il medico condotto di Varano Borghi, Enrico Locatelli, acceso tifoso di Coppi. Curiosità: Enrico Locatelli chiese a Giulia Occhini di sposarlo ad Ancona e nella vita della donna Ancona ricorrerà più volte compreso come suggestivo sfondo alla scandalosa quanto proibita storia tra lei e “il campionissimo” dove il fatto privato diventerà lo specchio in cui gli italiani riflettono sé stessi e i mutamenti in embrione. Giulia Occhini, per tutto il periodo della Guerra, dall’ottobre del 1940 all’ottobre del 1945, risiederà infatti ad Ancona ospite degli zii Dina e Carlo Caimmi. Ad Ancona vive (in via Urbino), studia e riceve la proposta di nozze di Enrico, a quel tempo fresco dottore e ufficiale sanitario di stanza alla caserma Paolini di Fano, che ha conosciuto a Senigallia. E’ l’agosto del 1945:
la guerra è finita da poco. C’è voglia di futuro. Un mese dopo, a settembre, la coppia si sposa a Loreto per poi trasferirsi a Varano Borghi, in provincia di Varese dove l’anno successivo hanno una figlia, Loretta detta “Lolli”. Tre anni di serenità, almeno in apparenza, fino a che Coppi non accetta l’invito a essere ospite in casa Locatelli. Il dottore è un suo acceso tifoso e a quella giornata ne seguiranno altre, insieme a scambi epistolari con la moglie del medico. Anche Coppi, 29 anni, è sposato. La moglie è Bruna Ciampolini e hanno una figlia, Marina. Una relazione extraconiugale nell’Italia democristiana e papalina del dopoguerra è qualcosa ancora da nascondere, da vivere nell’ombra tra sotterfugi e reticenze. Una storia che oggi finirebbe in qualche pagina di gossip destando al più curiosità e commenti social a beneficio degli hater, a quei tempi suscita scandalo e deve passare sotto le forche caudine
dello stigma sociale. Il divorzio arriverà solo negli anni ’70 e ci vorrà un referendum che dividerà una volta ancora l’Italia forse mai del tutto uscita dalla contrapposizione tra Guelfi e Ghibellini. Non solo: negli anni ’50 che marcano il salto da un Paese agricolo a industriale l’abbandono del tetto coniugale per adulterio è un reato che viene punito con il carcere. E Giulia Occhini ne conoscerà l’umiliazione. Ma Giulia Occhini e Fausto Coppi si amano: a dispetto della società, delle vite private, dei ruoli. Lei la moglie del medico, lui il campione. Per lungo tempo il segreto resta circoscritto. Incontri fugaci, fughe romantiche a Capri, discrete apparizioni a fine gara. Ma il muro del silenzio si va a sgretolare. Nel 1953 la donna viene notata al suo fianco al termine della tappa dello Stelvio durante il Giro d’Italia e successivamente sul palco della premiazione del Campionato del mondo di Lugano vinto nello stesso anno da
Le donne protagoniste | 2
La Dama bianca lega il suo destino ad Ancona dove è stata ospite durante la guerra e poi costretta al domicilio coatto
Alcune immagini pubbliche del rapporto sentimentale tra il campionissimo Fausto Coppi e Giulia Occhini che fece scandalo nell'Italia degli anni '50
Coppi. E’ il momento in cui cessa di essere Giulia Occhini e diventa “la dama bianca” a furore di media. Un giornalista francese, Pierre Chanyche, che scrive per “L’Equipe” conia sornione l’appellativo: “Vorremmo sapere di più su quella signora in bianco (la dame en blanc) che abbiamo visto vicino a Coppi con un montgomery color neve”. E nulla sarà più come prima. L’Italia scopre dalle pagine dei giornali che “l’Airone”, “il campionissimo”, “l’uomo solo al comando” ha una doppia vita e che non sempre immagine pubblica e profilo privato in una stessa figura coincidono. Ma scopre anche che è una madre e moglie a concupirlo. E questo l’Italia degli anni ’50 non può concepirlo, tantomeno accettarlo. Le figure di Coppi e della Occhini sono moderne, disturbanti, contraddittorie. Anticipano i tempi, li precorrono. Pure troppo. Sfidano i preconcetti, la morale comune, persino la legge con quell’amore proibito che destabilizza l’unità familiare portatrice di quei valori su cui si fonda l’Italia democristiana. Ne pagheranno le conseguenze. Anche se ti chiami Fausto Coppi e hai un Paese ai tuoi piedi che ti idolatra. Ma è su Giulia Occhini che ricade il peso della colpa. E’ lei l’adultera. Su di lei deve essere apposta la lettera scarlatta. Non c’è nulla di romantico in quel soprannome, “la dama bianca”. Non c’è nulla di romantico nell’essere additata, osteggiata, punita. Non c’è nulla di romantico nel dovere andare in carcere per non rinnegare ciò che ami. La relazione diviene di pubblico dominio nel giugno del 1954, una settimana dopo la conclusione del Giro d'Italia, quando entrambi lasciano le rispettive famiglie per andare a convivere a Villa Carla, a Novi Ligure. La loro unione è una sfida troppo sfacciata ai costumi sociali dell’epoca e
28 la legge è dalla parte del marito. L’uomo denuncia la moglie per abbandono del tetto coniugale e carabinieri sono chiamati ad accertare che i fatti siano come li esponga Locatelli. E’ la notte del 13 settembre 1954 quando due militari dell’Arma bussano a Villa Carla e chiedono di entrare. Sono imbarazzatissimi ma la procedura li obbliga a verificare un eventualmente tradimento. Non avendo colto i due in flagrante devono eseguire la cosiddetta prova del “letto caldo” tastando cioè le lenzuola e i materassi. E Giulia Occhini viene sorpresa in “flagrante adulterio” . Seguiranno i giorni più bui della coppia. Giulia Occhini viene arrestata. “La dama bianca” è la peccatrice da condannare. Persino il Papa si scomoda. Lo ieratico e sofferente Pio XII condanna la relazione, l’indignazione lievita. E l’opinione pubblica, così saldamente borghese nel senso più consunto del temine, è pronta a scagliare pietre dimenticando in fretta la parabola evangelica. Le porte della galera si aprono per Giulia Occhini ad Alessandria dove sconta quattro giorni di carcere. Ed è in questa fase tormentata che Ancona si riaffaccia di prepotenza nella vita della donna. Ancona che ha fatto da cornice alla sfortunata storia con Enrico Locatelli torna ora con Fausto Coppi, un legame d’amore che tuttora si rievoca tra chi ha memoria, anche perché, facendo dei calcoli del tutto empirici quanto approssimativi, c’è chi è pronto a giurare che l’unico figlio della coppia – Faustino, fatto nascere nel 1955 a Buenos Aires in un giorno di maggio proprio per sfuggire alle leggi italiane che non avrebbero permesso al bambino di portare il cognome del padre in quanto illegittimo e figlio della colpa – sia stato concepito in terra dorica con la baia di Portonovo a fare da sfondo a
Le donne protagoniste | 2
quel legame così scandalosamente travolgente. I giudici impongono all’adultera il domicilio coatto nella casa della zia che l’aveva accolta da sfollata e studentessa con l’obbligo della firma settimanale ogni domenica in Questura e nei giorni della lontananza forzata Fausto Coppi obbliga di fatto alla sua squadra, la Bianchi, il ritiro a Portonovo per allenarsi sui saliscendi del Conero. Gli scorci del Conero, il mare che ruba al cielo l’azzurro, le morbide colline delle Marche, la passione oltre le regole… una trama che sembra attingere a piene mani a quei fotoromanzi che stanno soppiantando i romanzi rosa sul piano della narrativa popolare, se non fosse per l’amarezza che stilla dalle memorie di Giulia Occhini. “Ad Ancona – racconterà – quando uscivo per andare a fare la spesa, le donne sputavano dove passavo. Io chiudevo gli occhi e tiravo dritto senza piangere. Ero incinta di Faustino, ma sarei morta piuttosto che far vedere che soffrivo”. Un dolore fiero che si nutre di orgoglio e coraggio.
Nel marzo del 1955, il processo penale condanna entrambi: Fausto a due mesi di carcere e Giulia a tre, ambedue le condanne saranno poi sospese con la condizionale. Né il matrimonio in Messico, non valido in Italia, né il lieto evento in Argentina, dispongono al perdono sociale. Ormai non si parla più del “campionissimo” per i suoi meriti sportivi ma solo per le vicende legate alla sua storia d’amore moreuxorio e la gloria delle sue vittorie è oscurata dalle ombre che si allungano sulla sua vita privata mentre Giulia Occhini, per aver osato anteporre al tradizionale modello femminile “Dio, casa, famiglia” una figura di donna più libera ed emancipata, e per questo più sovversiva e pericolosa, continuerà a essere severamente giudicata per avere abbandonato marito e figli, scegliendo di inseguire e irretire un uomo famoso e a sua volta sposato con figli. La narrazione perbenista è servita e non ci sarà indulgenza nemmeno nel momento più tragico che arriverà pochi anni dopo, con la morte improvvisa per ma-
29
Il campionissimo impone alla sua squadra il ritiro a Portonovo per allenarsi sulle strade del Conero
Le donne protagoniste | 2
Sulla Dama bianca ricade il maggior peso della colpa Accusata di lasciare il tetto coniugale subirà l’umiliazione del carcere
laria del ciclista ad appena 40 anni. Si è all’alba degli anni ’60: un nuovo decennio progressista si sta imponendo da oltreoceano, con il Kennedy pensiero, le battaglie per i diritti civili e la parità tra uomo e donna. E’ l’America a tracciare il solco del rinnovamento insieme all’Inghilterra dei fermenti giovanili. Ancora una manciata di anni a sulla scena irromperanno i Beatles e le minigonne di Mary Quant. In Italia i mutamenti sociali e di costume si rifletteranno anche nell’evoluzione del diritto di famiglia: si inizia a rivedere la normativa sulla patria potestà (Giulia lotterà per anni per poter rivedere i figli del primo matrimonio) e fra il 1969 e il 1974 la legge sul divorzio avrebbe completato il proprio iter. La rivoluzione culturale è alle porte ma l’amore tra Fausto e Giiulia non farà tempo a beneficiarne. Durante un viaggio in Africa il campione si ammala di malaria, ma al ritorno in Italia, ricoverato in ospedale, i medici curano quei sintomi come se fossero una banale influenza. Nessuno dei sanitari che lo ha in cura pensa a somministrargli del chinino che lo potrebbe salvare. Il 2 gennaio del 1960 Fausto Coppi entra in coma e muore poco dopo. “Fausto Coppi si è spento, vittima di un morbo misterioso” strilla il Corriere della Sera e a leggerlo oggi, 60 anni dopo, ai tempi del Covid, quel titolo risuona vagamente straniante e inquietante. Mentre il campione muore, al capezzale ci sono i suoi familiari ma non c’è Giulia a tenergli la mano e ad assisterlo, quando si presenta all’ospedale viene allontanata
30
per far posto alla moglie per legge la ancora legittima consorte. Anche al funerale rischia di non esserci spazio per la donna che gli è stata accanto sfidando e frantumando le convenzioni: arriva in chiesa con un velo nero a nascondere i lineamenti, si accomoda tra le ultime file ma il sacerdote – così raccontano le cronache del tempo – non la vorrebbe al rito e cede solo dopo accorata insistenza. Dopo la morte di Coppi, i riflettori della cronaca si attenuano: Giulia Occhini, determinata quanto riservata, resterà a Villa Carla, rinominata Coppi, a crescere il figlio Faustino. Tenterà la strada delle creazioni di moda fondando anche un maglificio che riecheggia al “campionissimo” ma non c’è prescrizione per il suo peccato, nessuna compassione o clemenza, anche se il mutamento dei tempi contribuiranno a spurgare la storia d’amore dai livori moralistici, smussandone la durezza giudiziaria e accrescendone l’aurea sentimentale. La parabola terrena di Giulia Occhini, già duramente provata dalla perdita per leucemia della figlia “Lolli” ad appena 35 anni, si concluderà il 6 gennaio del 1993 dopo quasi un anno e mezzo di coma in seguito alle lesioni subite in un incidente automobilistico avvenuto proprio davanti a Villa Coppi il 3 agosto 1991. Sulla sua lapide viene indicata con il nome di Giulia Occhini Coppi e il figlio Faustino racconterà che non è stato semplice nemmeno ottenere quella iscrizione. Neanche da morta si voleva perdonarle quell’essere così determinata, emancipata e innamorata. ¤
Il cinema
31
Fano e i suoi “Vitelloni” nei pensieri di Fellini L'AMORE DEL REGISTA PER LA CITTÀ DELLA FORTUNA
F di Massimo Puliani
Federico Fellini in un momento di concentrazione durante le riprese di uno dei suoi famosi lungometraggi
ellini è come dire Rimini. Eppure Fellini ha sicuramente avuto un amore, più amori nei confronti della città di Fano. Non si tratta di un rapporto fra le pieghe della leggenda o della fantasia, ma di piccole storie vissute, rapporti intimi e frequentazioni, con scritti e immagini che ci portano inequivocabilmente ad asserire che Fellini considerava Fano una sorta di Rimini pre-moderna, senza quel fremito turistico di massa che stava nascendo dopo la guerra. In questo momento in cui ricorre il centenario della nascita di uno dei massimi registi della storia del cinema, propongo qui un viaggio con Fellini a Fano: sarà un viaggio a tappe, attraverso l’infanzia di Federico vissuta a Fano, città culla di un immaginario che avrà riverberi fantastici e tipologie di maschere in alcuni film della storia del cinema mondiale.
Amarcord è una parola che i fanesi pronunciano (quasi) uguale ai romagnoli. Mi viene in mente la bellissima poesia di Tonino Guerra I madéun che nel film del 1973 è stata però “italianizzata” con I Mattoni. Il muratore dal soprannome Calzinazz declama: “mi nonno fava i mattoni / mi babbo fava i mattoni / fazzo i mattoni anca mé / ma la casa mia ‘ndo’è?”. Una chiave di lettura per capire quanto Fano era nella testa di Fellini è la citazione che Mastroianni fa nel film La dolce vita (1960): “Sei di Fano, scommetto che sei di Fano” dice Marcello. Siamo nel finale della festa, esattamente a 2 ore e 45 minuti, con il celebre refrain della musica di Nino Rota, e Marcello si rivolge ad una bella ragazza, bionda e procace, mentre le appiccica delle piume nel suo volto. E la donna risponde: “No, vicino Fano”. E Marcello: “Da bambino mi ci hanno messo in collegio a Fano”. Realtà o Immaginazione? Dei Fellini è certa la frequentazione a Fano. Il fratello Riccardo, di un anno più giovane, è sicuro che fece le elementari nel 1927 nel Collegio dei Padri Carissimi, al centro di Fano, oggi denominato “Sant’Arcangelo” (cit. Claudio G. Fava ne "I Film di F.Fellini", ed. Gremese, 1987 e Tullio Kezich “Federico Fellini: la vita e i film” Feltrinelli 2002). Della presenza di Federico a Fano invece abbiamo la sua diretta testimonianza (e poi fellinianamente aleggiano su di lui i “si dice” sulle fu-
Il cinema
Federico in un primo momento voleva Fano come sfondo per il suo film poi fu scelta Rimini
32 ghe e le “escursioni sessuali” giovanili!). Fellini laico e cattolico, credente e miscredente, trasgressivo, visionario…. Su Filmcritica, Pasolini nel 1960 scrive un saggio dal titolo “L’irrazionalismo cattolico di Fellini”. E anche quella celeberrima scena del film 8 e mezzo (1963), girata sulla spiaggia dove appare la Saraghina, erotica prostituta che balla per i ragazzini che poi verranno accalappiati da due preti con abiti talari, è un mix di questi temi. Federico e Riccardo erano molto uniti. E sembra di rivederli, i due fratelli, che “giocano” con “la Saraghina che – dichiara Fellini in “Fare un film” (Einaudi 2006) - era una prostituta gigantesca, la prima che ho visto nella mia vita, sulla spiaggia di Fano dove passavo le vacanze estive nel collegio dei Salesiani. La chiamavano così perché i marinai ottenevano i suoi favori dandole qualche chilo di pesce del più modesto, appunto le saraghine. Con noi che eravamo bambini, si accontentava di pochi soldi…”. La saraga è un pesce che in base alle sue dimensioni, viene chiamata sardone o sardina o alice e a Fano si mangia arrosto con mollica, olio, aglio e prezzemolo “a’scotadita”, cioè talmente calda da scottarsi le dita! Anche il giornalista fanese Nestore Morosini (da un suo post su Facebook del 2017) conferma: “Ho parlato tre o quattro volte con Fellini quando la redazione sport del Corriere della Sera aveva bisogno di un suo colorito commento sul calcio. Quando seppe che ero di Fano, mi disse di aver studiato al Sant'Arcangelo”. Quindi Fellini ha studiato al Collegio o – come di lui – ci passava le vacanze estive? Sulla attribuzione dei Vitelloni, film del 1953 che si vorrebbe ricondurre a personaggi ed un clima fanese, la questione si fa più complessa poiché lo
sceneggiatore del film Ennio Flaiano ne rivendica la paternità abruzzese. Il critico Massimo Mida, in Cinema (1952) scrive che Fellini prima de La Dolce Vita porterà a termine un film sulla provincia, ambientato a Fano, sui cosiddetti “vitelloni”, cioè quei giovani che nelle piccole città trascorrono le ore al caffè, pigramente, consumando senza un’occupazione, i loro anni più belli. Un’analisi della provincia che Fellini, per sua naturale inclinazione, porterà sul terreno della satira, di una satira asciutta pur nell’impegno umano che l’informa. Una satira che si limita, non senza abbandonare un disegno ambizioso, a frugare nell’intimo dei personaggi, a scoprire le pieghe più riposte nell’animo dei piccoli borghesi protagonisti. «Eppure la provincia - afferma Fellini - conserva più della città, proprio per la sua vita sonnolenta, proprio per il ritmo disteso della sua esistenza, la possibilità di un raccoglimento interiore e
Il cinema
quindi di un miracolo. Di quel miracolo che i personaggi della provincia sembrano sempre attendere, immersi in una sorta di ipocrisia che nasconde e sommerge i loro slanci più genuini”. I cinque Vitelloni sono interpretati da Alberto Sordi, Franco Interlenghi, Franco Fabrizi, Leopoldo Trieste e Riccardo Fellini. Guido Piovene nel suo celebre “Viaggio in Italia” del 1956, di cui si può ascoltare l’edizione radiofonica nella piattaforma www.teche.rai.it, riconosce che i “vitelloni” non hanno un padre d'origine, ma “hanno piuttosto origine in tutte le patrie. La storia e la cronaca di questa nuova maschera, così come l’abbiamo definita, ha comunque le origini per molti lati proprio a Fano. Infatti il regista cinematografico Fellini che conosce molto bene Fano e i fanesi, in un primo tempo voleva dare al suo film come sfondo Fano; poi fu scelta Rimini ma la cosa non cambia di molto o per niente”.
33
Invece con Viaggio con Anita sarà proprio Fano e non Rimini ad avere la sua ideale collocazione cinematografica. Ma di quel soggetto, datato luglio 1957 e firmato da Fellini e Tullio Pinelli (ma è cosa nota a tutti che c’è anche la mano di Pasolini in quel testo) si dispone solo la sceneggiatura in versione inglese, un dattiloscritto incluso tra le carte del Maestro, e una pubblicazione su “Cinema” e sulla rivista “Il Marcovaldo”. Vi si narra del viaggio in cadillac da Roma a Fano di Guido e della sua amante, con fermate nei paesaggi di Arezzo e San Sepolcro, per ammirare la Madonna di Piero della Francesca, e di un tappa alla Gola del Furlo. Il protagonista, uno scrittore di fama, ennesima proiezione autobiografica di Fellini, era partito da Roma poiché la sorella Gina di Fano lo aveva informato della grave malattia del padre. Alcune parti della sceneggiatura raccontano luoghi fane-
Nel “Viaggio con Anita” la destinazione è Fano e non Rimini. Voleva la Loren e Gregory Peck ma l’opera rimase sulla carta
Nella pagina a sinistra, Gilietta Masina nel film La strada Di seguito Marcello Mastroianni con la ragazza di Fano nel film La dolce vita e una scena della saraghina in 8 e 1/2 In alto il regista in relax e qui sopra la nota Gradisca di Amarcord
Il cinema
Di Fellini è certa la sua frequentazione a Fano dove andò a scuola e in vacanza E fu protagonista di numerose “fughe” giovanili
In alto, Federico con il fratello Riccardo e qui sopra il regista con l'oscar alla carriera tra Marcello Mastroianni e Sofia Loren
34
si, al ristorante, al mare. Il protagonista Guido rivede in una mostra di un fotografo l’immagine stinta di Gradisca (l’avvenente personaggio femminile di Amarcord), una bellezza che per anni aveva costituito il sogno erotico suo e degli altri ragazzi. La storia del protagonista nel film è la storia di un riavvicinamento alla madre dopo la morte del padre, la crisi di coppia con Anita e soprattutto la rivisitazione onirica dell’infanzia e dell’adolescenza. Tutti queste vicende mettono Guido di fronte a se stesso e all’avvenuta transizione verso l’età matura, con un fondo di nostalgia ma anche di ottimistica apertura al futuro. Palesi alcuni punti di contatto con 8 e mezzo, a partire dal nome del protagonista, Guido. E ancora più evidenti sono i legami con La dolce vita. Nel 1989 Fellini dichiarò in un'intervista rilasciata a Virgilio Fantuzzi su La Civiltà Cattolica, che “il soggetto cinematografico, forse il più bello che ho scritto, ma che poi non ho realizzato, s'intitolava Viaggio con Anita. L'ho venduto tanti anni dopo, un po' vergognosamente, a Grimaldi, che lo ha fatto realizzare a Monicelli, ma è diventato tutto un'altra cosa. Se ho un pentimento è riferito al fatto di non aver realizzato quel film”. Scrive su questa sofferta storia di sceneggiatura di un film mai realizzato che mette al centro Fano, Claudio G. Fava nel suo libro già citato: “ a Los Angeles nel periodo in cui Fellini riceve l’Oscar per “La Strada” il regista racconta a Gregory Peck la trama di Viaggio con Anita nel ricordo
del viaggio a Rimini fatto da Federico nel 1956 per essere al capezzale del padre morente. Dopo l’accettazione di Gregory Peck, sembra ormai sicuro che Fellini potesse iniziare le riprese (per il mercato americano), con protagonista Sophia Loren nel ruolo del titolo. Ma improvvise vennero le difficoltà: De Laurentis litigò con Carlo Ponti e Ponti oltretutto venne accusato di bigamia per il matrimonio messicano con la Loren. Senza la Loren, Federico non volle girare il film con un’altra attrice e il progetto si fermò”. Tullio Kezich in “Fellini, la vita e i film (Feltrinelli, 1987) scrive che “si può dire che il film è una lettera d’amore a Rimini pudicamente indirizzata a Fano”. Fellini amava Fano perché rispecchiava la Rimini della sua adolescenza. Scriveva di Fano ma pensava a Rimini. Ma Rimini negli anni Cinquanta (quando appunto Fellini scriveva la sceneggiatura Viaggio con Anita) stava perdendo la sua intima natura “provinciale” poiché la città era tesa a candidarsi come capitale del turismo di massa (mentre Fano si sta candidando a Capitale della Cultura Italiana per il 2022). Se è vero che la sceneggiatura è un’altra cosa rispetto al film, Viaggio con Anita è il pieno riconoscimento dell’amore del regista verso questa cittadina. E per Fano è un ambìto orgoglio essere stata nei pensieri visionari di Fellini. Chi ama Fellini sa che questo racconto cinematografico ha la forza della scrittura dei sogni. E quindi, producendo immagini e visioni è …. cinema. ¤
La musica
35
Guccini marchigiano istruttore a Villa Marina FORTE IL RAPPORTO TRA IL CANTAUTORE E IL PESARESE
G di Jacopo Zuccari
Francesco Guccini protagonista anche nelle Marche
uccini e le Marche. Un rapporto tanto consolidato nel tempo quanto forte nei ricordi e negli affetti. Per il Maestrone di Pavana – terra di confine con l’Emilia in provincia di Pistoia -, cantante, scrittore di gialli e fumetti, profondo conoscitore della cultura italiana il 2020 non è un anno qualsiasi. Il 14 giugno Guccini ha compiuto 80 anni, il 25 giugno 2012 allo stadio di Bologna la sua ultima apparizione nelle vesti di cantante. Guccini non nasconde il suo amore per una regione che gli ha dato tanto in termini umani. «Sono nato e cresciuto come uomo di montagna e mi considero tale tuttora – anticipa Guccini – tuttavia col passare del tempo ho potuto apprezzare le bellezze di una regione veramente al plurale: il cibo, la cultura, il paesaggio, i dialetti, le tradizioni, lo sport. Una bella regione le Marche». Chiediamo a Guccini di inquadrare le Marche partendo dalla pri-
ma volta che l’ha conosciuta. Guccini, quando è entrato a contatto con la realtà marchigiana e in che occasione? «Erano i tempi del boom economico, io appena 28enne ero stato mandato nel 1958 a Pesaro in qualità di istitutore in un collegio, l’ex colonia Villa Marina. Era il periodo ottobre-dicembre. Son stato pochi mesi, un rapporto breve in una città di mare senza tuttavia l’atmosfera dell’estate. Il mare d’autunno è sempre un pò triste. Era triste per me in realtà dover fare l’istruttore in questo collegio, portavo i ragazzi alla mattina poi il pomeriggio ero libero per andarli a riprendere. Si trattava di un collegio per orfani di postelegrafonici. Non avevo lo spirito giusto diciamo perché avevo a quel tempo una «morosa» a Firenze e quindi appena potevo e c’era un giorno di libertà me ne scappavo via col treno. Era lungo anche come viaggio, si doveva prendere la coincidenza a Bologna e fermarsi da lì verso la Toscana. Mi ricordo di Pesaro una bella villetta liberty sul lungomare in viale Trieste. Allora non mi piaceva tanto come stile ma poi riguardandola l’ho rivalutata».
La musica
Sposato con Raffaella di Mondolfo il maestrone di Pavana ha viaggiato tra Pesaro e San Benedetto
36 Dunque, non aveva avuto a quel tempo modo di conoscere Pesaro come città? «Allora no, non ebbi possibilità di osservarla bene. L’ho rivista quando sono tornato a Pesaro per i concerti e anche prima, già nel 1970. Avevo un’amica che conosceva il direttore di un ospedale psichiatrico: il dottor Renato Cocchi. E feci nella struttura uno spettacolo. Non ero ancora molto conosciuto nel ’70 in verità. Una collega di università conosceva questo dottor Cocchi. Avevo un amico pesarese che incontravo spesso: faceva camicie per uomo ed era sempre del gruppo degli amici di Coc-
chi. Feci uno spettacolo e andò così: una delle pazienti, un’anziana e robusta signora se ne uscì con una frase «la voglio sposare, la voglio sposare» correndo verso di me. Fortunatamente venne fermata da due inservienti belli robusti».
Sopra il cantautore a San Benedetto del Tronto ospite di Gabriella Fenocchio, autrice del commento "Canzoni" A destra, un altro momento della conviviale nelle Marche e subito sotto, durante la presentazione del suo libro "Dizionario delle cose perdute" nella città delle palme
Tra l’altro le Marche sono state ampiamente rappresentate tra i musicisti che hanno lavorato con lei. Penso a Flaco, il chitarrista di origine argentina e marchigiana insieme. «Le Marche non le conoscevo. Dopo, col tempo, attraverso mia moglie Raffaella e con gli amici che vivono vicino al
confine con l’Abruzzo, a San Benedetto del Tronto le ho girate parecchio. Andiamo spesso in vacanza da quelle parti. Flaco il mio chitarrista aveva il nonno di Osimo, provincia di Ancona. Insieme a mia moglie Raffaella, i suoi familiari che abitano a Mondolfo ho visitato tante altre città e cittadine graziose, soprattutto Senigallia e Mondolfo». Quali sono le caratteristiche che più le piacciono del paesaggio marchigiano? «Le Marche sono dolci e lievi. Ci sono il mare e l’entroterra. Ad esempio, diversamente dalla Liguria che vede il mare e subito dopo la montagna, dalle vostre parti ci sono colline basse e ondulate e poi l’appennino. Mi sono rimaste impresse le tante case coloniche isolate, rivestite di un colore tipico chiaro a mattoncini. Danno un tocco estetico che le rende uniche. Ammetto che io non sono un marinaro, provengo dall’entroterra. Sono prevenuto ma riconosco che sono davvero belle le Marche. Puoi viaggiare in questi paesini ognuno con la sua rocca fortificata. Buffa la differenza che ho notato tra le cosiddette Marche del nord e le Marche del sud. Cambiano proprio la lingua e le espressioni. I linguisti hanno tra l’altro spostato l’isoglossa dei dialetti del nord. Una volta c’era una linea linguistica famosa quasi come la linea gotica, che andava da La Spezia a Rimini. L’isoglossa è stata abbassata recentemente: l’isoglossa dei dialetti settentrionali italiani si trova attualmente sull’asse Carrara-Senigallia. Dunque Senigallia fa parte dei dialetti del nord Italia. Il che fa riflettere perché ad esempio Mondolfo che è a pochi chilometri di distanza più a nord si trova in provincia di Pesaro mentre a
La musica
Senigallia siamo già in provincia di Ancona eppure ha una parlata ancora in parte nordica». E del capoluogo che ricordi ha? Conosce Ancona e ha conosciuto colleghi o amici anconetani? «Ai tempi dei primi dischi quando mi trovavo a Milano, ero solito andare a mangiare in una trattoria toscana. E qui mi ritrovavo con un amico giornalista e insieme a un giudice, un magistrato che arrivava sempre con la figlia. Avevano una parlata tipica con la cadenza anconetana. Allora non la notavo certamente tanto come potrei farlo ora. Le differenze dialettali col tempo ho imparato a riconoscerle. Ad esempio il senigalliese mi sembra già diverso dall’anconetano. È una caratteristica tipica delle Marche questa pluralità di parlate e intonazioni. A Mondolfo si sente ancora abbastanza bene l’influenza romagnola, si avvicina al pesarese. Con gli amici del ’70 facemmo un giro da Pesaro fino in osteria a Cattolica, passando dunque in Romagna. Scoppiò a un certo punto della serata tra il gruppo dei pesaresi e i romagnoli una discussione accesa, forte. Cercai di rabbonirli in qualche modo e cominciai a cantare: gli animi fortunatamente si placarono e tutto passò in fretta. Mi sono sentito come Orfeo tra le belve». Lei che vive abitualmente in Toscana in provincia di Pistoia, a Pavana, sente nostalgia delle Marche? E del cibo cosa pensa? Con mia moglie ricordiamo spesso i primi tempi quando andavamo a mangiare il pesce a Senigallia. Non è che mi sia mai piaciuto tanto devo dire, però sicuramente apprezzo un piatto di vongole. D’estate poi è la stagione del pesce ed è un cibo che mi
37 gusta. Da giovane ero più «sospettoso» rispetto ai molluschi». Ha avuto modo di conoscere attori e personaggi famosi delle Marche? «Sì ho avuto modo di conoscere Neri Marcorè: molto simpatico e bravo. Sapevo che era marchigiano e proveniente da una cittadina della provincia di Fermo (Porto Sant’Elpidio). Sono stato ospite di casa Leopardi. Visitai il palazzo dei pronipoti e uno di loro ci mostrò una sua collezione di motorini modello Vespa. Ho dato un’occhiata naturalmente al colle dell’Infinito. Ho dormito, se non sbaglio, nella foresteria della dimora nobiliare dei Leopardi». Ha respirato l’aria del poeta… «Sicuramente ogni scrittore o poeta è influenzato dal paesaggio che lo circonda. Al di là della cultura familiare e del momento storico in cui vive, c’è il segno di ciò che vede, guardando dalla finestra attorno. Un paesaggio di una dolcezza incredibile e al tempo stesso sentiva quella che potremmo definire come una «sonnolenza» del paesaggio. Un grande poeta, è stata una persona coltissima che purtroppo non ha vissuto a lungo». Conosce altre città? Ha visitato Ascoli Piceno? «Ad Ascoli Piceno prima di fare il militare sapevo che c’era una scuola di allievi ufficiali di complemento dell’esercito. Fui dirottato non ad Ascoli ma a Lecce. Conosco certamente Pesaro, dopo i concerti con gli amici si andava a cena fuori nella zona dei colli intorno alla città. Nei primi anni Settanta, quando c’erano le feste tra il 1 e il 4 novembre si andava a fare una mini vacanza. Arrivammo con degli amici
“Sono nato e cresciuto come uomo di montagna ma ho apprezzato le bellezze di una regione veramente al plurale”
La musica
In un ristorante di pesce nacque una lite furibonda tra lo staff di Guccini e l‘oste per un conto spropositato
Sopra, Guccini in amichevole conversazione con Enzo Iacchetti
38
ad Ancona e io che non mangiavo pesce mi servirono le triglie fritte. Me lo ricordo ancora. Era difficile come ho detto che mangiassi piatti di mare. Allora feci un tentativo, che per me era come osare…l’inosabile! Non ero neanche molto pratico, figuriamoci ho visto per la prima volta il mare a 12 anni. Il ristorante si trovava nella parte alta della città, nella zona dove sorge la chiesa del patrono. C’era una trattoria in cui mangiai queste triglie fritte. Io che odiavo il pesce fritto, se non è pesce pulito non lo mangio. Mia madre mi diceva sempre in dialetto che ero «schinchignoso» con il pesce, cioè schizzinoso. Comunque, poi ho continuato a mangiare pesce: con la stessa compagnia visitammo l’Istria e Barcellona. Sempre a proposito di Ancona ai tempi dell’Osteria delle Dame il mio primo chitarrista, che purtroppo non c’è più, si chiamava Giorgio Massini ed era anconetano. Un ottimo musicista, si avvertiva che aveva proprio la musica dentro. Potevi dargli qualsiasi strumento e si metteva a suonare. È stato mio chitarrista per una stagione, prima di Flaco Biondini. Nel ’72-73 se non ricordo male. Ogni tanto portava i suoi amici marchigiani che venivano a Bologna. Avevamo fatto una bella compagnia». Cosa contraddistingue i marchigiani? Ritiene siano gente concreta e con spirito imprenditoriale? «E’ una regione molto attiva dal punto di vista economico, adesso purtroppo a causa dell’emergenza del
coronavirus ci saranno tante incognite sulla stagione balneare che è uno dei tratti tipici dell’economia locale e non solo. Rischia di essere una tragedia per tutti nella riviera adriatica dalla Romagna alla Puglia. Ma non dimentichiamoci dell’agricoltura e delle fabbriche. Ci sono imprenditori che hanno fatto grandi cose come i Della Valle». E dal punto di vista sportivo? Lei da appassionato di calcio cosa dice delle Marche? «La prima volta che andai a San Benedetto del Tronto nel ‘78, trovai una bacheca con i colori rossoblù, identici a quelli del Bologna calcio. Scoprì allora che la Sambenedettese aveva gli stessi colori sociali del Bologna e mi ricordo se non sbaglio che all’epoca la squadra era in serie B. Poi c’è la pallacanestro, la Scavolini è stata grande squadra di basket così come la pallavolo adesso con Macerata-Civitanova. Vorrei ricordare un episodio curioso: dopo un concerto a San Benedetto del Tronto un amico, che faceva il ginecologo a Bologna, decise di portarci in una trattoria di pesce. «Si mangia benissimo e si spende poco» ci garantì. Facemmo una gran abbuffata e al momento del conto l’oste ci portò una cifra spropositata . Ne nacque una lite furibonda tra noi, il nostro amico ginecologo, lo staff e l’oste. Entrambe le parti arrivammo quasi a chiamare i carabinieri. Poi alla fine la spuntammo noi con un gran sconto e la situazione si risolse a nostro favore». ¤
Il video
39
Spot Rai, atto d’amore per i versi de “L’infinito” PER CELEBRARE I 200 ANNI DELLA POESIA DI LEOPARDI
U di Claudio Sargenti
na voce inconfondibile, quella di Mina, per “chiudere” una poesia entrata ormai nel cuore e nel patrimonio culturale un po' di tutti e particolarmente cara a noi marchigiani. Quel “naufragar m’è dolce in questo mare” è un verso stampato nella nostra memoria oserei dire fin dai banchi di scuola, da quando cioè si inizia a leggere, a comprendere, ad amare Giacomo Leopardi e i suoi scritti. E così, risentire quelle parole pronunciate da una voce inconfondibile, forse la “voce” più riconoscibile e certo anche più rappresentativa della canzone italiana, come è quella di Mina non poteva non lasciare il segno. Del resto, tutto lo spot con i versi de “L’Infinito” realizzato da RAI Cultura e trasmesso dalle reti del Servizio Pubblico negli ultimi giorni del 2019, è una sorta di atto d’amore verso il grande poeta di Recanati. Un atto d’amore certo della RAI, che ancora una volta si è dimostrata all’altezza della sua fama, ovvero di
essere la più grande azienda culturale del Paese, ma anche un atto d’amore dei cantanti, 22 in tutto, compresa Mina, che si sono prestati a leggere, gratuitamente, ciascuno un verso de “L’Infinito”, ma anche di chi ha pensato e voluto il video per chiudere, nel migliore dei modi, le celebrazioni per i 200 anni della lirica forse più amata, certamente la più conosciuta di Giacomo Leopardi. Singolari alcuni “retroscena” su come è nata l’idea dello spot. A raccontarli è stato il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini. Così secondo il Ministro l’iniziativa è stata presa durante un incontro con il Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella era appena rientrato da Recanati dove si era recato per visitare i giardini e l’orto de “L’Infinito”, appena restaurati, oltre ad altri luoghi leopardiani. E proprio durante una conversazione, tra Mattarella e Franceschini, si sarebbe deciso (ma qualcuno è arrivato a pensare che lo spot sia stata un’idea dello stesso Presidente) di mettere a punto qualcosa di spettacolare per celebrare e ricordare in maniera degna il bicentenario della poesia di Leopardi. Da subito c’è stato il coinvolgimento della RAI unito alla voglia di fare qualcosa di diverso e di originale destinato però a lasciare il segno: far recitare, più che leggere, i versi dalle “stelle” e dai beniamini della canzone, i più affermati, i più apprezzati dal grande pubblico oltre che dai giovani che, gratuitamente, appunto, hanno “prestato” la loro voce per fare uno straordinario regalo a quel ragazzo di due secoli fa
Il video
40 che, dalla sua Recanati, immaginava “interminati spazi” oltre la siepe. Ha preso corpo così un’operazione culturale che ha ben pochi precedenti. Assieme ad un’altra novità. Perché i ventidue cantanti hanno recitato in maniera anonima. Alcuni erano facilmente riconoscibili, certo. Ma altri no. Così chi voleva dare un nome a quelle voci, non poteva non ascoltare e riascoltare più volte lo spot e dunque la poesia. Una sorta di “gioco”,
L’originale iniziativa con voci “donate” gratuitamente da ventidue cantanti nasce da un colloquio tra ministro e Mattarella a Recanati
ma dal grande valore didattico. Una bella intuizione. Non c’è che dire. “L’idea – ha spiegato lo stesso ministro Franceschini – è stata quella di chiedere a tutti i grandi della canzone italiana di donare la loro voce senza farsi riconoscere. Si è trattato – ha aggiunto il Ministro – di una dichiarazione d’amore per la poesia da parte dei suoi eredi diretti”. Poi i nomi, alcuni giorni dopo la fine della programmazione, sono stati rivelati. Ci piace ricordarli: Laura Pausini, Zucchero, Giorgia, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Ligabue, Paolo Conte, Renato Zero, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Paola Turci, Antonello Venditti, Gianni Morandi, Patti Pravo, Jovanotti, Roberto Vecchioni,
Ivano Fossati, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Adriano Celentano. E Mina, appunto. Al di là delle voci è il video che è stato confezionato in maniera a dir poco eccellente, almeno secondo chi scrive queste righe. Va aggiunto, ad onore del vero, che forse il giudizio è influenzato dalla giovanile “passione” per Leopardi maturata sui banchi del liceo. Ma non si può fare a meno di notare, ad esempio, la musica suggestiva che fa da sfondo ad un video dai toni chiari in cui, tra voli di nuvole e uccelli, scorci di collina e mare, un uomo di spalle scruta l’orizzonte, mentre vengono recitati i versi inconfondibili. Da un punto di vista storico ha fatto sapere la direzione di RAI Cultura, si è voluto recuperare il manoscritto originale della poesia, conservata dal Comune di Visso dove è tornata dopo essere stata in mostra a Recanati. Composta tra la primavera e l’autunno del 1819, la versione utilizzata per il video è quella che approdò alle stampe solo sul finire del 1825, quando apparve insieme con la “Sera” sulla rivista “Il Nuovo Raccoglitore” nella rubrica “Poesia”. Ma esiste, lo ricordiamo, anche un’altra stesura de “L’Infinito”, conservata alla Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III”, dove è stata esposta in occasione proprio del bicentenario. Fa parte di un fascicoletto su cinque bifogli spessi, rigati e dai margini irregolari. I quindici endecassilabi sciolti, introdotti dal titolo “L’Infinito”, sono scritti ordinatamente al centro della pagina con tratto nitido e sottile, in un inchiostro marrone dal fondo molto scuro. Poche le correzioni, concentrate in pochissimi versi e compiute con un inchiostro più denso e un pennino dalla punta più spessa. Va aggiunto, per dovere di cronaca che il manoscritto
Il video
di proprietà del Comune di Visso ha rischiato di essere trafugato. Dopo il terremoto, è stato riposto e conservato in una cassetta di sicurezza di una filiale di un istituto di credito a Pieve Torina. Un gruppo di malviventi, giusto pochi giorni dopo la fine della programmazione RAI, ha rapinato la banca e scassinato il caveau, ma non ha riconosciuto o comunque ha risparmiato i manoscritti di Leopardi compresa dunque la “preziosa” poesia. Niente, per fortuna, è andato perso o solo danneggiato. Scampato il pericolo, l’amministrazione comunale ha preso l’impegno di far tornare le opere nel Museo di Visso quando la piazza con negozi e chiesa saranno completamenti ristrutturati. Probabilmente, si spera, già a fine anno. Dunque, dicevamo, un capolavoro eterno della poesia italiana al quale la RAI e il Ministero dei Beni e delle Attività culturali hanno voluto rendere omaggio in maniera a dir poco inusuale e che ha trovato subito il plauso, il sostegno, il favore del pubblico. I social, infatti, sono subito impazziti sia nel cercare di dare un nome alle voci, sia nel formulare commenti. E così c’è chi ha ringraziato “… chi ha avuto l’idea e chi ha donato la voce a questa poesia immortale” e chi ha sottolineato come “…. l’interpretazione che ne hanno dato questi cantanti è meravigliosamente emozionante, fino alle lacrime.” La prima versione dello spot (poco più di un minuto in tutto) è stata visionata e ascoltata in esclusiva dal Presidente della Repubblica, dimostrando ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, la vicinanza e la sensibilità di Mattarella nei confronti delle Marche. Abbiamo già parlato della sua visita a Recanati. Ma non si possono non ricordare gli incontri, non rituali, avuti con gli sfollati e in più occasioni,
41 nelle zone colpite dal terremoto. E ancora. Il cenno fatto alla nostra regione anche nel discorso di fine anno, quando ha parlato, ad esempio. delle celebrazioni per Raffaello che vedranno proprio Urbino e le Marche in prima fila. Oppure quando ha fatto riferimento, nello stesso discorso, ad un dono particolare ricevuto da alcuni ragazzi in visita al Quirinale. Una sedia avuta dagli ospiti della “Locanda Centimetro Zero”, un’asso-
Ministero dei Beni culturali e Rai hanno voluto rendere omaggio in modo inusuale al capolavoro di Leopardi
Aperti gli appartamenti privati Conclusa la fase più acuta (e drammatica) della pandemia è proseguita l’opera di recupero del patrimonio storico e culturale legato al grande poeta marchigiano. Per iniziativa dei discendenti della Famiglia, alla vigilia dell’estate, sono state aperte per la prima volta in due secoli, le stanze private di Giacomo nel palazzo Leopardi a Recanati. Sono state restituite al pubblico (visite previa prenotazione telefonica) la galleria con le collezioni d’arte, i giardini di ponente e di levante, il salottino dove i fratelli Leopardi giocavano, la stanza da cui Giacomo contemplava “le vaghe stelle dell’Orsa”, citate ne “Le Ricordanze”, oltre al settecentesco scalone d’ingresso e al salone azzurro con i dipinti degli antenati. Particolarmente suggestiva la camera da letto con il piccolo scrittorio di Giacomo restaurata insieme alle camere dei fratelli, nell’ala del palazzo soprannominato le Brecce. ciazione attiva da alcuni anni a Spinetoli e che impiega 22 giovani con diversi gradi di disabilità. Quella sedia, ha ricordato il Presidente la sera del 31 dicembre, reca scritto “quando perdiamo il diritto di essere differenti perdiamo il privilegio di essere liberi”. Quella libertà che Leopardi sognava e immaginava oltre la “siepe”. Forse, chissà, può anche essere azzardato paragonare i versi de “L’Infinito” con la scritta sulla sedia donata al Presidente. Ma è certo che queste sono le Marche: una terra di grandi geni (Leopardi, Raffaello, Rossini solo per citarne alcuni), ma anche terra di grande accoglienza, solidarietà ed ospitalità. E sicuramente, una regione di spiriti liberi. ¤
A sinistra, alcuni fotogrammi dello spot Rai con versi dell'Infinito declamati da 22 artisti In alto, le pagine con i famosi versi scritti di pugno da Leopardi
L’anno Sanzio | 1
L di Grazia Calegari
e celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Raffaello si sono aperte con una rosa rossa, posata sulla sua tomba al Pantheon, dove lui stesso aveva chiesto di essere sepolto. Sulla lapide, l’amico Pietro Bembo gli dedicò la famosa iscrizione: “Qui giace Raffaello dal quale, mentre era in vita, la Natura temette di essere vinta e, quando morì, temette di morire anch’essa”. Raffaello morì il 6 aprile 1520,
giorno del suo trentasettesimo compleanno, un Venerdì santo. La morte, come ricorda Giorgio Vasari, arrivò dopo quindici giorni di malattia, iniziata con una febbre “continua ed acuta”. Questo cinquecentenario viene celebrato con un numero impressionante di eventi e di mostre a livello nazionale e internazionale. Cito una delle prime che hanno preceduto l’anniversario: si è realizzata a Urbino nel 2009, il catalogo si intitola “Raffaello e
43
Raffaello, il trionfo dell’armonia Così la realtà diventa sublime CON LA SUA PITTURA VINCE LA SFIDA CON LA NATURA MADONNE UMANE E DOLCISSIME LA DOLCEZZA TRASFERITA ANCHE NEI COLORI
Urbino”. Dieci anni dopo, nel 2019 si è tenuta l’esposizione “Raffaello e i suoi amici”, e dal 19 luglio 2020 fino alla fine dell’anno si aprirà una mostra su Baldassarre Castiglione, per ricostruire la vita della corte di Urbino da cui Raffaello si muove e deriva. A Roma, alle Scuderie del Quirinale fino al 30 agosto duecento capolavori come la “Madonna del Granduca” e la “Velata” dalla Galleria degli Uffizi, altri dai Musei vaticani, il Louvre, la National Gallery di Londra, quella di Washington, il Museo del Prado, il British Museum, la Royal
Collection. Raffaello Santi era nato a Urbino il 6 aprile 1483 alle tre di notte, come scrive il Vasari, da Giovanni Santi, pittore e letterato, e da Magia di Giovanbattista Ciarla. La data della nascita sarà anche quella della morte, sempre di venerdì santo, (o almeno così ci racconta il Vasari), mentre il cognome diventerà “Santius” per volere dello stesso Raffaello. Nel 1491 perde la madre, nel 1494 il padre Giovanni che era titolare di un bottega molto attiva e lascia erede universale il fratello don Bartolomeo e l’undicenne figlio
Raffaello. “Strano caso quello di Urbino allo scorcio del Quattrocento: a una prima, e superficiale visione sembra infatti che quella cultura così originale e fortemente connotata che, con la personalità di Federico da Montefeltro, aveva fatto della città uno dei poli artistici del Rinascimento, stesse andando esaurendosi, ripiegandosi su se stessa. Eppure, a uno sguardo più ravvicinato,oltre a non rispondere pienamente ai dati reali, tale analisi sembra tralasciare un segmento di storia assai importante. A Urbino accade infatti un
L’anno Sanzio | 1
Nell’aprile di 500 anni fa Sanzio il divin pittore moriva nello stesso giorno e mese in cui era nato
44 fenomeno che è quanto meno da rilevare: la città genera alcuni degli artisti più straordinari, creatori e insieme simboli delle nuova stagione artistica. Raffaello, Bramante, Girolamo Genga, Timoteo Viti, nascono a Urbino o nelle immediate vicinanze e per tutti è evidente un comune imprinting: quello dell’assolutamente unico confluire di materia preziosa e senso dello spazio, di gesto artistico e acuta coscienza del suo stesso realizzarsi, di ardua ricerca e “sprezzatura”, che costituisce la cifra ineguagliabile del mondo urbinate.” (Maria Rosaria Valazzi, Raffaello e Urbino, cat. Mostra Urbino 2009, p.52) E a Urbino, in una parete di casa Santi, conservata splendidamente come abitazione del ‘400, si può vedere un piccolo affresco con la Madonna col Bambino. Partiamo da qui. Il padre si faceva spesso aiutare dal figlio bambino, gli era d’insegnamento e lo stimolava. Quella cavità d’ombra dipinta sul muro, quel gusto circolare del piccolo spazio col profilo incastonato della Madre che legge, la grande sfera della testa del Bambino, sembrano ricordare sia il mestiere del padre che gli inizi del figlio, piccolo aiutante come forse accadrà più tardi nel Duomo di Pesaro, dopo la morte del padre nel 1494, quando sarà la bottega del Santi ad eseguire verso il 1512-13 l’affresco con la “Madonna col Bambino fra i santi Pietro e Girolamo, in alto Cristo deposto tra angeli.” Raffaello potrebbe essere intervenuto dopo la morte del padre, nel 1498-99, in alcuni punti di qualità più alta rispetto a quella degli alunni operanti nella bottega del Santi, come nei visi della Madonna e del Bambino, nel viso e nel corpo di Cristo.
All’età di appena diciassette anni il giovane è denominato “magister”, come risulta dal contratto di allocazione per la pala d’altare nella cappella Baronci di Sant’Agostino a Città di Castello. Non sono molto chiari gli anni del suo esordio e della sua formazione, che mi limito a indicare nell’influsso di Pietro Perugino a Fano in Santa Maria Nuova, dove anche Giovanni Santi aveva eseguito due opere, e del Pinturicchio a Siena. Ma credo che sia stata soprattutto la scuola di suo padre, continua e affettuosa, a determinarne fino dalla più tenera età lo slancio di partenza. Nella mancanza di documenti certi, tralascerei il problema degli “alunnati” e passerei direttamente alla pala di Città di Castello del 1504, quel “Matrimonio della Vergine” eseguito per la chiesa di San Francesco e oggi conservato a Brera. “Ma qui colpiscono la figure che esprimono il respiro dello spazio generato dalla profondità della materia cromatica. L’analisi minuta del dettaglio ha un tratto epico e il grande dipinto umanistico denota la bravura della mano ma anche l’ambiguità della proposta in esso implicitamente contenuta. Con Il Matrimonio della Vergine Raffaello dimostra di essere il pittore più bravo e capace. L’opera è eccelsa,ma la cultura che vi è sottesa potrebbe essere sospetta di un vizio di sterilità perché completamente rivolta verso il passato.” ( Claudio Strinati, Raffaello, in Art e Dossier, 1995) Ma credo ci siano già in questa costruzione apparentemente semplice, che ha come perno centrale il tempio memore di quello della “Città ideale di Urbino”, degli elementi ideali e simbolici tipici del Raffaello successivo. Lo schema teorico di figure ideali come il cerchio e il se-
L’anno Sanzio | 1
micerchio (ottenuto con le pose dei piedi in basso e delle figure al di là del Sommo Sacerdote), poi del Tempio centrale circolare che spalanca la piccola porta verso uno spazio infinito declinato dalle colline laterali, rappresenta simbolicamente il concetto nuovissimo del rapporto tra l’uomo e lo spazio, o meglio l’equilibrio umanistico tra l’uomo e l’infinito. E l’orizzonte è abbassato per dare l’idea semplice e solenne di una dilatazione circolare che amplia il concetto già ribadito nell’Urbino di Federico da Montefeltro e di Piero della Francesca, per fare un nome soltanto degli artisti, filosofi,scienziati, umanisti italiani e fiamminghi chiamati a quella corte dal sovrano umanista e uomo d’arme. Raffaello a Firenze gli anni delle Madonne Dal 1504 al 1508 il giovane si sposta a Firenze, che lo attrae fatalmente come grande cen-
45
tro, come incubatrice del Rinascimento. Sono gli anni di tante notissime Madonne col Bambino e di molti Ritratti, insomma del Raffaello più famoso, dolcissimo e universale. Guardiamo la Madonna del Cardellino (1507) oggi agli Uffizi. Come in tante altre composizioni del tema (circa 30) lo schema Madonna – Bambino – San Giovannino è un triangolo, simbolo dell’ ASSOLUTO perfettamente dominante, ideale e centrale in una natura immensa e tutta visibile, dagli alberelli fino agli ultimi particolari dei campi, delle acque, del ponte, del cielo e delle nuvole. Nessuno dei tre protagonisti ci guarda, sospesi come sono in un’ intimità domestica e assoluta, imponente e quotidiana, con i bambini che sembrano giocare con il cardellino, ma Gesù è più pensoso e triste forse perché quello è il simbolo della sua futura morte. O guardiamo un ritratto come “La Muta”, passata
Muore a 37 anni all’apice del successo Le sue spoglie riposano al Pantheon Una rosa rossa per dare il via alle celebrazioni
In apertura del servizio un dettaglio dell'affresco con Tolomeo e Strabo nella scuola d'Atene A sinistra in alto, Madonna con bambino un piccolo affresco conservato nella casa Santi a Urbino e di seguito Matrimonio della Vergine (Milano, Brera) In alto, Madonna del cardellino (1507) oggi agli Uffizi Di seguito, La muta dipinta verso la fine del soggiorno a Firenze
L’anno Sanzio | 1
A Roma un’altra sfida della sua carriera artistica C’è tanto Raffaello in Vaticano con le numerose “Stanze”
46
alla galleria Nazionale delle Marche a Urbino nel 1927, e dipinta verso la fine del soggiorno a Firenze. Un ritratto supremo, nel quale il pittore è determinato a dare del personaggio uno scandaglio interiore in quella donna riservata, che s’immedesima con gli schemi geometrici ideali del monile triangolare e degli sbuffi bianchi sulle maniche. C’è una coscienza del lavoro assoluta in Raffaello, in quella Firenze dominata culturalmente dal Neoplatonismo ma dove lui giovane pittore compenetra dentro ogni tema la forza del realismo e della natura su schemi ideali, mentre Leonardo e Michelangelo vanno per altre strade. O guardiamo il “Ritratto di Agnolo” e quello di “Maddalena Doni” (Galleria palatina), imponenti nella loro fisicità resa con un realismo (le grinze accanto agli occhi, i gioielli) ancora una volta storico, dinanzi a una natura altrettanto storica, emblemi
perfetti del Rinascimento fiorentino e italiano. E’ ancora a Firenze quando data e firma, nel 1507, la tavola con il “Trasporto di Cristo” oggi alla Galleria Borghese. Non una semplice Deposizione, ma un Trasporto più ampio, un’azione collettiva realistica, con il peso fisico dei personaggi espressi ad uno ad uno, coi gesti, i lamenti, i gemiti, gli urli sommessi, gli svenimenti. Ma in tanto soffrire sul corpo morto di Cristo, che è stato portato giù da quella scala appoggiata alla croce centrale sul colle lontano, Raffaello riesce a costruire la scena su uno schema regolare a X , fluida e mobile nella grandiosa prospettiva del paesaggio, ancora una volta infinito. A Roma un'altra grande sfida A partire dal 1508 Raffaello inizia un’altra grande sfida nella sua carriera artistica: si sposta a Roma, dove lavora
L’anno Sanzio | 1
47 Le Stanze Vaticane e la scelta di Giulio II
per papa Giulio II da quell’anno al 1513 e per papa Leone X dal 1513 al 1520, la data della morte. Il suo lavoro non è mai continuativo, non si rivolge ad un’opera sola: Raffaello si applica con i numerosi alunni passando dalle tele o dalle tavole dei ritratti e dei temi sacri, agli interventi nei cantieri degli affreschi. C’è un’inquietudine in questo metodo che scalfisce l’immagine del pittore ‘perfetto’, reso un po’ stucchevole rispetto alla gigantesca inquietudine di Michelangelo e alla fluida ricerca scientifica e multiforme di Leonardo. Ma credo sia proprio in quest’aspetto misterioso e sfuggente, quasi una fuga continua e affannata, la sua grandezza. Una tensione verso il sublime in ogni opera, frammentata e martellante, ripetuta per i trentasette anni della vita, tra gli spostamenti e l’apparente splendore del successo anche economico.
Verso la fine del 1507 papa Giulio II decise di ristrutturare le Stanze al secondo piano perchè non accettava gli ambienti e le decorazioni precedenti. Il discorso è molto complicato e mi limito a ricordare la successione delle Stanze per altro notissime e a riassumerne qualche valore e significato. La Stanza dell’incendio di Borgo, La Stanza della Segnatura, la Stanza di Eliodoro, la Sala di Costantino sono la ‘summa’ voluta dai due pontefici, resa per immagini chiarissime da Raffaello. Rappresentano la traduzione visiva di concetti come la Filosofia nella Scuola di Atene (1509), enorme rappresentazione del mondo classico, con le figure che personificano le materie che è necessario conoscere per affrontare un vero dibattito filosofico: astronomia, geometria, aritmetica e geometria solida. Al centro , assorti nel dibattito, avanzano Platone e Aristotele. La definizione dei personaggi è quello di veri ritratti; mi limito qui a riconoscere Leonardo in Platone, Michelangelo in Eraclito, Bramante in Euclide. Così la Filosofia, che è ricerca razionale del Vero, impone che le Arti plastiche siano unite alle Arti liberali, nella più solenne, ideale e globale raffigurazione della cultura umanistica che sia stata mai eseguita. Nella Stanza della Segnatura è raffigurata la Disputa del sacramento, che rappresenta la Chiesa trionfante in alto e la chiesa militante in basso: è la Verità rivelata, nella chiarissima sua universalità. Sono concetti tradotti in immagini nella maniera più complessa e insieme più facile: per la prima volta, a Roma, avviene la sintesi definitiva tra cattolicesimo e umanesimo. Il motivo dominante del
In alto, un particolare del "Trasporto di Cristo" (1507) oggi alla Galleria Borghese A sinisra, la "Trasfigurazione" posta accanto al letto di morte di Raffaello e completata dai suoi allievi. Oggi alla Pinacoteca Vaticana Qui sopra, affreschi delle stanze vaticane e in ultimo un particolare della liberazione di San Pietro
L’anno Sanzio | 1
A Urbino in una parete di casa Santi si può ammirare un piccolo affresco di Madonna con bambino
Sopra, il Ritratto di Agnolo e quello di Maddalena Doni (Galleria Palatina) emblemi del Rinascimento fiorentino e italiano
48
ciclo, destinato alla fruizione privata del pontefice, è l’esaltazione del Vero, del Bene e del Bello.Quest’ultimo concetto è reso visibile nel Parnaso, (Stanza della Segnatura) dove Apollo, al centro di un boschetto, suona la cetra circondato dalle Muse e dai poeti della Classicità, del Medioevo, del Rinascimento. E arriviamo all’ultima opera, non compiuta: la “Trasfigurazione” oggi alla Pinacoteca Vaticana, portata a termine
dagli allievi. Commissionata a Raffaello nel 1517 per la cattedrale di Narbona dal cardinale Giulio de’ Medici, vescovo di quella città, fu poi sistemata nella chiesa di San Pietro in Montorio. Tutti i personaggi si rivolgono verso l’evento principale della trasfigurazione di Cristo, mosso da una leggera brezza, rischiarato dalla luce fredda della luna e reso drammatico da un sapiente chiaroscuro che si intensifica nella parte inferiore. Il centro di questa composizione asimmetrica fa capo al bambino indemoniato che è appena stato colto da una
terribile convulsione, e con il braccio indica Gesù, il liberatore di tutti i mali. Ma questo piccolo ossesso nella densa oscurità non è certo l’unica interruzione a scalfire la sublime, quasi continua volontà di rappresentare l’Armonia in Raffaello. Il realismo della stanza di Eliodoro Torno a citare le Stanze Vaticane, in particolare la Stanza di Eliodoro (1513) di cui ricordo la parete con La liberazione di San Pietro dal carcere. Le tenebre, il sonno dei soldati, i bagliori di luce sulle loro armature, l’angelo al centro potentemente illuminato mentre libera il vecchio San Pietro, la grata del carcere, il realismo delle azioni raccontate: tutto era diversamente realistico in quel racconto, e a sinistra in alto c’era una tenera mezza luna sul cielo carico di nuvole che in parte la ricoprono. Quando Raffaello morì improvvisamente il 6 aprile, il quadro della “Trasfigurazione” era quasi terminato e gli fu posto accanto al letto di morte nella sala dove lavorava: “La quale opera, nel veder il corpo morto e quella viva, faceva scoppiare l’anima di dolore a ognuno che quivi guardava.” (Vasari) E se noi oggi riguardiamo tutta la sua pittura, distinguiamo la straordinaria capacità di raccontare sia la realtà sublime che quella drammatica, senza tralasciare niente della vita, anzi guardando sempre alla natura senza tempo, ai cieli di Urbino dai quali era partito, all’aria della città di Federico da Montefeltro che noi conosciamo bene. ¤
L’anno Sanzio | 2
49
Il mito di Raffaello nella letteratura IL MAESTRO NARRATO DA AUTORI URBINATI TRA '800 e '900
P di Nando Cecini
(Collezione Nando Cecini Foto Luca Toni)
er un grande pittore come Raffaello, è naturale che esista una vasta bibliografia alla quale riferirsi. Sono diventato vecchio, non ho più né la salute né la forza di girare per le biblioteche e per di più non sono capace di usare il computer; pertanto mi avvalgo dei testi della mia raccolta, ben consapevole della parzialità di questa ricerca bibliografica. Mi limito quindi a segnalare alcune voci di stretto ambito urbinate. Una letteratura locale dovuta ad autori urbinati o nata per celebrare nel luogo natale il “genius loci”. E’ nel corso dell’Ottocento che viene risaltata appieno la figura di Raffaello. Il marchese Antaldo Antaldi, di no-
bile origine urbinate, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, sollecita la traduzione italiana della fondamentale monografia dello studioso francese Quatremere de Quency, Istoria della vita e delle opere di Raffaello Sanzio di Urbino (Milano, Sonzogno, 1829), opera che aveva fatto conoscere Raffaello in tutta Europa. Nello stesso 1829, per non essere da meno, viene pubblicato in Urbino un Elogio di Raffaello dello studioso Luigi Pungileoni, pieno di amor di patria. Ma il vero artefice di un effettivo rilancio del culto raffaellesco, è stato il conte Pompeo Gherardi. La data fatidica è il 1869. Nel corso dello stesso anno il Gherardi fonda l’Accademia Raffaello, tuttora
L’anno Sanzio | 2
Il vero artefice del rilancio del culto raffaellesco è stato il conte Pompeo Gherardi che fonda l’Accademia a Urbino
50 prestigiosa ed operante, con le relative pubblicazioni e le feste annuali per le ricorrenze genetliache del pittore, scadenti in primavera tra marzo e aprile. Inizia la pubblicazione del settimanale Il Raffaello, per sostenere, tra l’altro, la sottoscrizione nazionale per l’acquisti della casa natale dell’artista e ancora l’erezione di un monumento commemorativo, cose poi realizzate nel tempo. Sempre nel 1869 partecipa con un gruppo di amici urbinati alla fondazione, assumendone anche la direzione della Rivista Urbinate di Scienze Lettere ed Arti, compilata, si legge nel sottotitolo, “da alcuni amici della scienza nell’intento di cooptare all’avanzamento dei buoni studi e alla diffusione del sapere”. La stampa era curata dalla tipografia del Metauro; il gerente editore proprietario era l’urbinate Elpidio Righi che ne assunse i costi. Nel 1870 ricorrevano i 350 anni della morte di Raffaello. La Rivista Urbinate gli dedica un fascicolo doppio (IV-V, 1870) con alcuni contributo specifici. Si incomincia con il discorso di Niccolò Tommaseo, in quel tempo uno dei più illustri letterati italiani, letto “nella solenne tornata dell’Accademia Raffaello la mattina del giorno 6 aprile 1870”. Un lungo discorso con tutti i dati canonici correlati gli uni agli altri da un filo di matrice moralistica così riassumibile, “se la natura e l’arte si collegarono (come il Bembo ne scrive con lode degna) a far lui singolare, più singolare ancora lo rende l’essere vissuto felice più che dei nobili affetti sentiti, dei nobili affetti ispirati”. Per concludere poi con una bella metafora “tanto è il pittore della sua bellezza che viene tranquilla nell’anima come piogge mite sui fiori”. All’alato discorso del Tommaseo segue un lungo saggio di impronta positivistica, Quali
metodi e quali esempi seguitasse Raffaello negli studi dell’arte, del professor Pietro Selvatico. Altrettanto significativo l’omaggio del sacerdote scienziato Alessandro Serpieri, Le opere di Raffaello considerate nella loro espressione e potenza morale. Ma per Raffaello non poteva mancare anche un omaggio poetico. Ci pensò il prolifico direttore Pompeo Gherardi nel fascicolo VIII (giugno 1870) della Rivista con una serie di Epigrammi e Iscrizioni dedicate a “I Capolavori di Raffaello”. Si tratta di quindici componimenti tra notazioni artistiche e slanci poetici d’un animo romantico, che non poteva non amare Raffaello d’un amore sviscerato. Questi i versi per la Trasfigurazione, l’ultimo quadro di Raffaello, In questa tavola/ ov’è spiritualità umanità/ nel Cristo trasfigurato/ negli apostoli nell’ossesso/ tentò Raffaello/ tutto compendiare le glorie passate/ e meglio che sempre/ disegnare colorire ombreggiare/ con doppia ardita maniera/ quasi presago/ non rimanere al suo genio/ maggior perfezione/ da mostrare alla terra. Sempre preso dal sacro furore, il Gherardi, nella plaquette dedicata a I grandi artisti d’Italia (Urbino 1874) offre a Raffaello la XXVI iscrizione di questo tenore: A gloria perpetua/ di Urbino – dell’Italiadell’Arte/ i cieli fecero nascere/ Raffaello Sanzio/ che con divino pennello/ mai superato forse non superabile/ potente disegnatore/ coloritore incantevole/ compositore unico più che raro/ animò pareti tavole tele/ emulando natura/ che gelosa del Prometeo novello/ a soli XXXVII anni/ lo faceva rapire dalla morte/ alla terra meravigliata. Infaticabile scrittore, nello stesso periodo, trovò il tempo per stendere una monografia, Raffaello Sanzio, cenni biografici, pubblicati sul settimanale
L’anno Sanzio | 2
da lui fondato in numerose puntate con interventi divulgativi, che poi raccolse nel volume Della vita e delle opere di Raffaello Sanzio di Urbino (Urbino 1874). Passaggio fondamentale per le feste di Raffaello è rappresentato dagli Atti del IV centenario della nascita di Raffaello (Urbino 1887). Feste celebrate per ben dieci giorni tra il marzo e l’aprile del 1883. Oltre la gente e le autorità di Urbino, con la banda musicale e le fanfare militari, arrivarono in molti: senatori, deputati, sindaci da svariate città italiane, rappresentanti di Accademie anche estere e sopra tutti oratori e poeti. Non mancarono concerti, rappresentazioni teatrali, ricevimenti e banchetti nei saloni del Palazzo Ducale. Tra gli oratori merita un cenno il deputato cavalieri Marco Minghetti, già primo ministro, che così concluse, a suo dire, “Raffaello effigiando il naturale con la massima verità e la bellezza nelle forme più elette risponde a tutte quelle parti dell’umano spirito che tengono al divino e perciò fu dal consenso universale chiamato il divino Raffaello”. Altrettanto significativo il discorso scritto dal conte senatore pesarese Terenzio Mamiami, che vecchio e ammalato non potè pronunciarlo, ma lo raccolse in una pubblicazione, Parole e Poesia, aggiungendovi anche un poemetto di alcune centinaia di versi. A proposito di poesie sono ben dodici i contributi in italiano e in latino. Da ricordare almeno Enrico Panzacchi, amico del Carducci e Giacomo Zanella, autori di fama nazionale. Sempre sul finire dell’Ottocento si presentò un’altra occasione per celebrare il mito di Raffaello, l’inaugurazione del monumento bronzeo a lui dedicato, il 23 agosto 1897 e allora collocato nel cuore della città e nella piazza tra il Duomo e il Palazzo Ducale. L’orazione ufficiale fu tenuta
51 dall’affermato studioso d’arte Corrado Ricci sul tema, Raffaello e la varietà delle scuole pittoriche. Dopo aver parlato di Venezia, Firenze, Bologna, Milano, Roma, Perugia, si sofferma su Urbino. Tra le tante osservazioni, molto significative quelle sul paesaggio. Il Ricci sottolinea poi il rapporto tra Raffaelo e Baldasar Castiglione che “amava il pittore non soltanto per le sue opere e la sua virtù, ma perché ne aveva seguito, con tenerezza paterna, lo sviluppo dei primi anni, dal tempo in cui si trovava a Urbino. Raffaello era dunque per lui la vivente immagine della leggiadria, della bontà, della bellezza fiorite in quella corte dei Montefeltro quando i più alti spiriti vi s’accoglievano protetti dal grande Guidobaldo e da Elisabetta Gonzaga animatrice d’ogni nobile espressione”. Nello stesso 1897, Corrado Ricci affida un nuovo intervento Urbino e Raffaello, alla più prestigiosa rivista culturale del tempo, la Nuova Antologia (anno XXXII, fasc.16, Roma 1897). Rivolgendosi a un vasto pubblico eterogeneo, Ricci descrive la città di Urbino, la sua storia, il suo territorio. Dedica gli ultimi paragrafi alla vita e alle opere di Raffaello, soprattutto al carattere e alla bontà, citando il Vasari, primo biografo dell’artista: “Ogni pittore che conosciuto l’avesse, o anche chi non lo avesse conosciuto, se lo avesse richiesto di qualche disegno che gli bisognasse, egli lasciava l’opera sua per sovvenirlo”. I due interventi, ancora degni di una lettura, il Ricci li ha raccolti in una fortunata pubblicazione La gloria di Urbino, ovviamente riferita a Raffaello, edita dallo Zanichelli in Bologna nell’elegante elzeviro del 1898. Su ben altri valori, di minor respiro, si colloca l’Omaggio a Raffaello Sanzio nell’inaugurazione del suo primo monumento. Azione teatrale per
Per Raffaello non poteva mancare nel 1870 anche un omaggio poetico con quindici componimenti
L’anno Sanzio | 2
Ojetti ricorda che nel 1920 fù l’influenza spagnola a impedire le celebrazioni dell’anniversario del maestro
52 musica (Milano 1897) scritto dal conte urbinate Luigi Nardini, appassionato ricercatore storico nonché segretario permanente dell’Accademia Raffaello. Quando scrive la pièce teatrale, il Nardini è ancora un giovane pieno di romanticismo. Alterna i tre atti dedicati all’amore, al genio, alla morte di Raffaello, a quattro parti che si rifanno al classico modello del teatro greco: l’Oracolo di Delfo, l’Olimpo, l’Erebo e il Parnaso. Il rapporto tra le due azioni sceniche è formale con una forzatura immotivata. Più leggibile la parte dedicata a Raffaello, all’amore per la Fornarina, raccontato come un innamoramento da fotoromanzo e la sua immatura morte circondato dal pianto degli allievi. I versi saltellanti richiamano i libretti delle opere liriche tanto di modo in quel tempo. Se il nume tutelare del culto raffaellesco nell’Ottocento è stato Pompeo Gherardi, per la prima metà del Novecento é l’urbinate Luigi Renzetti, non per nulla emerito presidente dell’Accademia Raffaello e fondatore della rivista Urbinum (1914-1945), portavoce ufficiale della stessa. Sono decine i suoi rendiconti delle feste raffaellesche e i saggi dedicati al pittore, sempre improntati a una attenta divulgazione e riassunti nella monografia dedicata a Raffaello Sanzio e i suoi tempi (Urbino 1934). Nello stesso anno vennero tenute, nell’ambito delle Celebrazioni Marchigiane tre importanti relazioni. Il 1 settembre 1934 nel salone del Trono del Palazzo Ducale, il principe dei giornalisti italiani, Ugo Ojetti tenne una memorabile orazione. Nell’introduzione Ojetti ricorda i tempi difficili del primo dopo guerra, quando nel 1920 non fu possibile celebrare il quattrocentesimo anniversario della morte. Con questo discorso veniva sanata una grande ingiustizia. Merita una citazione il rife-
rimento all’unico quadro di Raffaello presente nella Galleria Nazionale delle Marche, trasferito da Firenze a Urbino su ordine diretto di Mussolini dopo le pressanti insistenze del presidente Renzetti. “Ed eccoci a Firenze Raffaello dipingere ritratti e Madonne. E forse il primo dei ritratti da lui dipinti a Firenze è questo vostro ritratto di gentildonna chiusa e casta, la quale, tanto è netto il carattere espresso dalla posa e dal volto, dai grandi occhi tranquilli, dalla bocca serrata, dal lungo collo senza palpiti, freddo come il marmo d’una colonna, dal velo che copre le sue spalle robuste, dalla mano destra che pesa sul polso della sinistra come a trattenere ogni gesto inconsulto, è stata dal popolo soprannominata la Muta”. La seconda guerra mondiale termina nel 1945. Sulle rovine materiali e morali, inizia la ricostruzione. Anche l’Accademia Raffaello fa la sua parte. Nel novembre del1945 muore il presidente Luigi Renzetti, oggi ingiustamente dimenticato; gli succede il conte Petrangolini. Scompare anche la rivista Urbinum. Nel 1950 sarà sostituita da Raphael; la nuova serie, la terza nel tempo, durerà per cinque numeri fino al 1957. Tra i discorsi delle annuali ricorrenze genetliache, merita un cenno, L’arte di Raffaello di Vincenzo Golzio (Raphael, 3, 1952) che tratta il tema abbastanza inedito della fortuna critica di Raffaello nel corso dei secoli, concludendo con una felice citazione sull’essenza del pittore “che solo amore e luce ha per confine”. Carlo Bo, rettore dell’Università di Urbino, assume la presidenza dell’Accademia nel 1962, tra le tante iniziative, chiama a Urbino per celebrare Raffaello uno dei più illustri e ammirati pittori del momento, il siciliano Renato Guttuso, che tiene la sua relazione nel salone del trono del Palaz-
L’anno Sanzio | 2
zo Ducale il 17 maggio 1964. Nel presentarlo, Carlo Bo, con affettuosa ironia, sottolineava che per un grande artista come Guttuso, in quello stesso palazzo in altri tempi, si sarebbero tenute ben altre cerimonie, ma purtroppo le situazioni erano cambiate. Se oggi la città di Urbino non è praticamente in grado di commissionargli nulla, pure si può permettere il piccolo orgoglio di averlo chiamato qui a rendere testimonianza delle sue qualità critiche, misurandosi con l’Artista in cui si identifica la città. Guttuso ha titolato il suo discorso con eccessiva modestia Appunti su Raffaello (Raphael, 1, 1965), in realtà è stato un intelligente excursus sull’opera del pittore con molti giudizi personali come l’affermazione “Raffaello è un pittore difficile”, sfatando quel mito della semplicità e immediatezza della sua opera. Nel corso degli anni Settanta nella critica d’arte era sorta la moda delll’Antirinascimento.
53
Al contrario, Guttuso, si dichiara convinto assertore dei valori classici, incarnati dalla pittura di Raffaello che “più di Leonardo e più di Michelangelo è l’uomo in cui tutti gli elementi del Rinascimento si concentrano in sommo grado”. Sono in fine acute anche le osservazioni sulla falsa rivalità tra Raffaello e Michelangelo, entrambi, per Guttuso, eccezionali interpreti di quel tempo irripetibile. Anche Carlo Bo, in qualità di presidente dell’Accademia, ha avuto occasione di dire la sua sul grande urbinate. L’occasione è stata la ricorrenza del V centenario della nascita di Raffaello nel 1983. Anno coinciso con la grande mostra nelle sale del Palazzo Ducale, Urbino e le Marche prima e dopo Raffaello, seguita dal convegno internazionale di Studi su Raffaello, tenuto tra Urbino e Firenze nell’aprile 1984 con contributi di alto valore storico critico. Aprendo il convegno a Urbino, Carlo Bo indugia con geniale
Renato Guttuso chiamato a Urbino nel 1964 da Carlo Bo affermò a sorpresa che “Raffaello è un pittore difficile”
L’anno Sanzio | 2
Bo invitò anche a riflettere su quanto Urbino deve a Raffaello tema che ritenne mai affrontato nel modo giusto
54
intuizione, diventato di fatto un urbinate, su quanto deve Urbino a Raffaello e aggiunge che questi argomenti “non sono mai stati affrontati come sarebbe giusto”. Infatti è notorio per Bo che Raffaello “abbia contribuito a dare nei secoli la parte più consistente e nobile della storia di Urbino”. Fatalmente la città nel corso dei secoli era decaduta, diventando una piccola città dello Stato Pontificio, dimenticata da tutti. Solo il nome di Raffaello la manteneva viva nella memoria non solo tra gli artisti e gli studiosi, ma anche nel popolo. Sul finire del Novecento forse i tempi possono cambiare, anche per Urbino, “ Se non può più ricreare il miracolo del Palazzo, la sua conferenza di spiriti eletti, se non si può prefigurare l’apparizione di un nuovo Raffaello, si può però cercare di predisporre una città, di costruire una casa in modo da sapere quando si pronuncia il nome di Raffaello che cosa c’è dietro, in modo da sentire il nostro debito”. La figura e il mito di Raffaello urbinate, come segno di speranza e di un avvenire migliore. Nel convento di Montefiorentino nell’Alto Montefeltro, agosto 1983, Carlo Bo ha parlato di Raffaello, bellezza e verità (Il Nuovo Leopardi, n.10, Urbino 1983). Partendo dalla affermazione di Jacques Maritain di quanto sia desueto parlare di bellezza a proposito dell’arte, quanto parlare di verità a proposito di filosofia, Carlo Bo afferma, “Queste parole di Maritain mi tornano alla memoria pensando a Raffaello e più precisamente al rapporto fra bellezza e verità che mi ha sempre suggestionato quando si trattava
di riassumere in una frase le impressioni nuove e antiche suscitate al pittore urbinate”. Il suggestivo discorso si sviluppa così sui canoni della bellezza e della verità insiti nella pittura di Raffaello per raggiungere una significativa conclusione, “C’è un antefatto filosofico e teologico, insomma spirituale che sarebbe per lo meno vagliato e scrutato in modo da poter sostenere con assoluta certezza che i due termini di bellezza e di verità non sono contrapposti ma identici atti di fiducia e di speranza in Dio”. Sempre nel contesto dei cinquecento anni della nascita di Raffaello, 1983, anche l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, ha voluto partecipare con un’elegante pubblicazione sotto forma di un libro agenda affinchè, come ha scritto il curatore Mario Omiccioli, la presenza del pittore accompagni per ogni settimana l’appassionato lettore. Omiccioli, scrittore di grande fantasia e poco riconosciuto nei suoi autentici valori letterari, ha scritto un lungo saggio con una lettura personale delle vicende raffaellesche. Curiosa per un pittore dell’infinito come Raffaello, la collocazione geografica. Nasce tra i monti di Urbino, apprende l’arte tra Perugia e Firenze, città circondate da colline, infine Roma, la città dei sette colli. Torna sorprendente l’epigrafe di Augusto von Platen, “Acciò che Sanzio il cielo più presso toccare/ Fu la sua culla qua sopra le nuvole”. Tutte città tra cielo e terra, tutte città dell’Italia centrale tra Marche, Umbria, Toscana e Lazio, Raffaello “visse solo nelle mediate terre d’Italia”. ¤
L’anno Sanzio | 3
55
La mano di Raffaello nella predella di Fano SI IPOTIZZA ACCANTO AL PERUGINO NELLA PALA DI DURANTE
A
di Dante Piermattei
Qui sopra, un particolare della Predella di Fano Nella pagina successiva Perugino e Giovanni Santi, raffronto del particolare della Madonna con Bambino nella Pala di Durante Fanese e dell’affresco della Cappella Tiranni di Cagli, circa 1490-’92
proposito della formazione artistica di Raffaello, Giorgio Vasari, nel suo trattato del 1550 “Le vite de' più eccellenti pittori, scultori, e architettori”, racconta che Giovanni Santi, grande ammiratore del Perugino, gli chiese di prendere con sé, nella sua bottega di Perugia, il figlio bambino per educarlo, meglio di quanto potesse fare egli stesso, al mestiere della pittura. Ma, come vedremo più avanti, le cose dovettero andare un po’ diversamente, salva la sostanza di un rapporto di contiguità innegabile tra i modi stilistici maturi dell’uno e i primi acerbi dell’altro. Pietro Vannucci, detto “Il Perugino”, è a Fano nel 1488. Il
21 aprile, firma il contratto per dipingere la Pala con la Madonna in trono con Bambino e Santi per la chiesa del Convento di Santa Maria Nuova in San Lazzaro. I committenti, stabilito espressamente che il lavoro deve essere fatto in loco, s’impegnano a fornire, oltre al pagamento,
“vitto e alloggio gratis per lui e un suo garzone”. La Pala, detta anche Pala di Durante Vianuti dal nome del finanziatore fanese, dovrà avere in alto una lunetta col Cristo in pietà. Sotto ci sarà una predella con le Storie della Vergine. Chi era mai l’anonimo garzone? Raffaello? Ma lui nel 1488 era appena entrato nel sesto anno di età e a quell’età cosa poteva fare? Già, però allora, come del resto adesso per la scuola, attorno a tale età, i bambini venivano messi a bottega perché crescessero imparando un mestiere. Vero, ma Raffaello già frequentava quella di suo padre Giovanni Santi a Urbino, perché avrebbe dovuto venirsene a Fano? E’ notizia risaputa che il Santi se lo portasse dietro nei suoi spostamenti per ritrarlo nelle corti angeliche di quanto andava dipingendo, e in modo che il fanciullo familiarizzasse con gli ambienti di lavoro. Giovanni aveva un’ammirazione sconfinata per il Perugino i cui modi si sforzava di imitare pur senza riuscire a infonder loro la stessa suprema grazia. Il Vannucci e il Santi si trovarono a lavorare fianco a fianco alla fine degli anni Ottanta nel Convento degli Osservanti a San Lazzaro nelle Pale praticamente gemelle per dimensione, il primo con l’Annunciazione, il secondo per la Visitazione, entrambe conservate tuttora a Santa Maria Nuova. Ne ho dato conto nel mio “Perugino, Giovanni Santi e Raffaello a Fano” del 2009. Ma Giovanni tornerà certamente nella non lontana Fano, capolinea marino della valle del Metauro, a vedere perlomeno i
L’anno Sanzio | 3
57
L’anno Sanzio | 3
Fin dal Seicento si parla della collaborazione dell’allora 14enne nell’opera realizzata per il convento di Santa Maria Nuova
In alto, Perugino, Pala con la Madonna, Bambino e Santi detta anche Pala di Durante Fanese 1497 Chiesa di Santa Maria Nuova, Fano Qui sopra, Perugino Pala dell’Annunciazione, 1488/9 Chiesa di Santa Maria Nuova, Fano A destra, particolari della Predella di Fano
58 cartoni della Pala con lunetta e predella dall’ ‘88 in poi. Non v’è dubbio perché della posa della Madonna peruginesca in trono farà tesoro per illustrarne una sua, più campagnola, nell’affresco della Cappella Tiranni a Cagli (1490-’92). Dunque, come scrive Pietro Scarpellini nella sua pregevole monografia sul Perugino (1984), questi veniva a Fano d’estate per i bagni, ospite del Convento a pochi passi dalla battigia. Nell’estate del 1489 doveva trovarcisi a lavorare per portare a termine la Pala dell’Annunciazione e forse a cominciare quella prevista dal contratto notarile. Così, come aggiunge sempre Scarpellini, univa “l’utile al dilettevole”, dipingendo e potendo rinfrescarsi in Adriatico. Lì, nel cantiere fanese degli Osservanti, assieme all’Annunciata e alla grande Pala tripartita, non sappiamo esattamente quando, nascerà dallo stesso cartone preparatorio di quest’ultima, anche la sua quasi esatta replica, limitata alla parte centrale, ora al Convento dei frati minori di Santa Maria delle Grazie di Senigallia. Un’opera pagata dai Peruzzi di Fano, gli stessi che già avevano sostenuto la spesa per la Pala dell’Annunciazione in memoria di Galeotto Peruzzi, Pontiniere del Metauro, ne abbiamo raccontato la fin allora sconosciuta vicenda nella pubblicazione del 2009 che riproporremo in nuova aggiornata edizione quest’anno per il Cinquecentenario della scomparsa di Raffaello. Nei saltuari soggiorni balneari e di lavoro fanesi del Maestro c’era anche Raffaello? Più sì che no. Dove, se non a Fano, avrebbe appreso la lezione del Perugino, dato che non si trovano documenti ad avvalorare la versione del Vasari su come l’urbinate ne sarebbe stato allievo a Perugia e Firenze?
A Perugia, nel periodo della formazione giovanile dell’urbinate, la bottega del maestro ancora non esisteva e a Firenze Raffaello si recherà, in modo documentato, con una calda raccomandazione al Gonfaloniere Pier Soderini della duchessa Giovanna Feltria della Rovere, soltanto nell’autunno del 1504, “per imparare”(sic). Relativamente al fatto che poi Raffaello non rientri nel seguito dei documentati pittori allievi della bottega del Perugino, John Shearman, nel suo libro “Raphael in Early Modern Sources 14831602”, London 2003’, riporta un documento, datato 4 ottobre 1511, in cui Papa Giulio II cita: “Dilecto filio Raphaeli, Johannis de Urbino scolari.” Lo stesso Shearman rileva come le parole del Papa costituiscano il primissimo ed unico riferimento nell’arco della vita di Raffaello, alla sua formazione artistica e quanto esse siano state trascurate nonostante la loro importanza. Segnala inoltre come possa rivestire peculiare significato il fatto che Perugino, il quale aveva lavorato alle Stanze Vaticane fino a poco tempo prima, nella pronuncia del Pontefice, non trovi alcun accenno come maestro del Sanzio. Peraltro nei numerosi documenti pubblicati da Pietro Zampetti, rivelatori della presenza del Sanzio pressoché costante a Urbino almeno fino a quando, nel 1500, si trasferirà diciassettenne a Città di Castello per assumere importanti incarichi come riconosciuto e stimato “Maestro” per dipingere lo Stendardo della Trinità, e la Pala Baronci con L’incoronazione di San Nicola da Tolentino per la chiesa di Sant’Agostino. E in seguito la Pala Mond o Crocifissione Gavari nonché, per ultima, la tavola con Lo sposalizio della Vergine del 1504.
L’anno Sanzio | 3
Al riguardo, Zampetti non solo svolge argomentazioni convincenti, ma le avvalora sulla scorta di risultanze che dimostrano come il giovane figlio di Giovanni Santi non poté essersi mosso più di tanto da Urbino e dalla bottega paterna nella quale, dopo la morte del titolare avvenuta nel 1494, continuò a lavorare con il suo collaborante Evangelista da Pian di Meleto. Raffaello, che aveva già perso la madre all’età di otto anni, alla scomparsa del padre Giovanni, era appena undicenne e si trovò a dover affrontare la responsabilità di mandare avanti la florida bottega del padre. Dovette crescere in fretta e farsi uomo anzitempo. In questo ebbe l’appoggio del fedele aiuto Evangelista da Piandimeleto e del proprio zio Don Bartolomeo Santi al quale suo fratello, per espressa volontà e nominandolo esecutore testamentario, aveva affidato la tutela del figlio. Sul fatto che Raffaello avesse assorbito i modi pittorici del Perugino facendoli propri, e perfezionando quelli trasmessigli dal padre Giovanni, si può essere certi, al punto che sempre il Vasari affermava, stavolta in maniera del tutto incontestabile, “come non si riuscisse a distinguere le opere se fossero state fatte dal maestro o dall’allievo”. Ma di un tale rapporto di prossimità si giovò anche il maestro. Già Longhi, Oberhuber, il richiamato Zampetti e altri, hanno posto in luce come, in particolar modo, nella Predella della Pala di Durante si avverta un clima nuovo fatto di fresche invenzioni rispetto a quanto il pittore pievese aveva già prodotto nella sua maturità. Quando Perugino assunse l’incarico di fare il dipinto, Raffaello aveva sì sei anni, ma allorché lo concluse, firmandolo nel 1497, il Sanzio ne compiva quattordici e, a diciassette, è bene ribadirlo, poté già assumere, come “Ma-
59 gister Raphael”, l’alto incarico per dipingere la Pala di San Nicola da Tolentino a Città di Castello. Si è anche sostenuto che Raffaello avrebbe potuto apprendere la maniera del Perugino solo imitandolo senza averlo frequentato, ma la congettura non regge. Non è del tutto impossibile che Perugino possa esser stato per qualche sconosciuto motivo a Urbino e che lì il giovane Raffaello l’avesse incontrato, ma del passaggio del maestro nella città ducale non rimane alcuna traccia documentata e già questo rende l’ipotesi implausibile. Il pievese era già in fama di “Divin pittore” e pur soltanto una sua fugace presenza sarebbe stata annotata e rimasta in qualche memoria. Invece a Fano, non proprio a due passi da Casa Santi, nella salita sul Monte a Urbino, ma nemmeno troppo lontana, con un viaggio sufficientemente agevole, meglio ancora se in estate con la marina prossima al cantiere di lavoro, beh… un rapporto di contiguità e di apprendimento a favorire “un’imprinting” di qualità decisiva per fare di un ragazzo già superdotato un genio eccezionale, poteva starci e crediamo debba esser avvenuto. Nella tradizione storiografica locale fin dal Seicento si parla della collaborazione del Sanzio in alcune parti della magnifica Pala di Durante, il dipinto tripartito del Perugino, particolarmente nella cimasa col Cristo in Pietà e nelle cinque Storie della Vergine illustrate alla sua base. Dunque: ci può essere almeno nella Predella fanese la mano del “quattordicenne” Raffaello? In buona compagnia rispondiamo di sì. E, per come gli fosse cara come propria, a quella si rifece ormai diciannovenne, nell’inventare, rinnovandole, alcune scene per la Predella della Pala degli Oddi, aprendone ancor di più gli spazi alla luce. ¤
E proprio a Fano secondo Zampetti il giovane pittore urbinate avrebbe appreso lezioni da Vannucci detto “il Perugino”
di Luigi Benelli
R
affaello e l’incisione, un binomio imprescindibile. Il maestro urbinate aveva ben capito le potenzialità della stampa, capace di tradurre le sue conquiste formali e prospettiche tanto da fondare una bottega di incisori pronti a veicolare le immagini. Nei primi anni del ‘500 gli spostamenti erano chiaramente difficili, vedere le opere de visu era facoltà di persone facoltose. Quello che poteva circolare agilmente era la stampa, in grado di raggiungere ogni luogo italiano e non solo. Raffaello si servì di questo mezzo per comunicare al meglio il suo lavoro pittorico. Del resto il divin pittore aveva appese nella sua bottega le xilografie e i bulini di Albrecht Durer. Il maestro urbinate non incise personalmente, ma si affidò a esperti. A Roma entrò in contatto con il bolognese Marcantonio Raimondi, il più valente incisore a bulino in Italia. Marcantonio si forma guardando il segno netto di Albrecht Durer e quello sottilissimo ì di Luca Di Leida. A Bologna il suo linguaggio tecnico è fatto di
L’anno Sanzio | 4
Raffaello e l’incisione amore a prima vista L’ARTISTA CAPÌ SUBITO LE POTENZIALITÀ DELLA STAMPA E SI AFFDÒ AI PIÙ VALENTI ESPERTI IN ITALIA
Raffaello si servì di questo mezzo per comunicare al meglio il suo lavoro pittorico
Nella pagina precedente Il giudizio di Paride In alto, Il suicidio di Lucrezia e qui sopra La strage degli innocenti (Incisioni di Marcantonio Raimondi su disegno di Raffaello)
62
contorni netti e contrasti forti, ma durante il viaggio a Firenze e poi a Roma, si perfeziona. I contorni non sono più ingessati, le linee diventano più curve e sottili, il tratteggio incrociato è modulato per generare volumi, contrasti di luce e ombra e l’aggiunta del puntinato genera morbidezza nelle forme. A Roma recepisce il linguaggio classico di Raffaello, l’armonia della composizione, la perfezione delle proporzioni. Nel secondo decennio del ‘500 l’editore Baviero De Carrocci aprì per conto di Raffaello una bottega di incisione, una vera iniziativa commerciale. Qui arriveranno negli anni successivi incisori come Agostino Veneziano, Marco Dente, il Maestro del Dado, Jacopo Caraglio, Enea Vico, Giulio Bonasone. Gli incisori replicarono soprattutto i disegni di Raffaello, mentre solo nei decenni successivi furono tradotti anche i dipinti e gli affreschi del maestro. Si trattava di modelli in cui dovevano emergere il coerente studio del corpo umano, la prospettiva e i volumi tipici di quel rinascimento matematico urbinate. Raffaello realizzò disegni appositamente per essere tradotti a stampa come la Strage degli innocenti, il Morbetto, il Quos Ego o il Giudizio di Paride. Per Raffaello il disegno è un’arte autonoma e intellettuale così come la sua trasposizione sul rame. Il legame tra Raffaello e l’incisione è indiscusso. I documenti dicono che Raffaello ritenesse opera sua i fogli che uscivano dalla bottega dell’incisione. Dal 1515 sulle stampe appare una tavoletta che indicava
la produzione della scuola di Raffaello, indipendentemente da chi fosse l’incisore. Non solo, incaricò l’editore Baviera De Carrocci di continuare a stampare le lastre devolvendo i proventi a beneficio della Fornarina. Giorgio Vasari, ne Le Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri (1568), parla del rapporto tra Marcantonio e Raffaello. “Arrivato in Roma, intagliò in rame una bellissima carta di Raffaello da Urbino, nella quale era una Lucrezia romana che si uccideva, con tanta diligenza e bella maniera, che essendo subito portata da alcuni amici suoi a Raffaello, egli si dispose a mettere fuori in istampa alcuni disegni di cose sue, et appresso un disegno, che già avea fatto, del giudizio di Paris, nel quale Raffaello per capriccio aveva disegnato il carro del sole, le ninfe de’ boschi, quelle delle fonti e quelle de’ fiumi, con vasi, timoni et altre belle fantasie attorno. E così risoluto furono di maniera intagliate da Marcantonio, che ne stupì tutta Roma. Dopo queste fu intagliata la carta degl’innocenti con bellissimi nudi, femine e putti, che fu cosa rara; et il Nettuno con istorie piccole d’Enea intorno, il bellissimo ratto d’Elena, pur disegnato da Raffaello, et un’altra carta dove si vede morire Santa Felicita bollendo nell’olio, et i figliuoli essere decapitati”. Gli incisori replicano i modelli delle Logge Vaticane, degli Arazzi, il ciclo di affreschi della Farnesina. E ancora gli affreschi della Stanza dell’Incendio di Borgo in Vaticano, della Stufetta Bibbiena. ¤
L’anno Sanzio | 5
63
Guerra “corta e grossa” negli anni di Raffaello IL RINASCIMENTO SCORRE TRA VIOLENZE E CAPOLAVORI
L di Riccardo Paolo Uguccioni
Particolare della Pala di Brera o Pala Montefeltro di Piero della Francesca, 1472 conservata nella Pinacoteca di Brera
a splendida armonia della pittura di Raffaello Sanzio si colloca su un crinale storico tumultuoso, sia in Italia che a Urbino. Siamo nell’apogeo del Rinascimento, quando le arti raggiungono un culmine sublime, ineguagliabile; ma sono anche anni terribili e sconvolgenti, quelli delle cosiddette guerre d’Italia. Non che prima il mondo fosse in pace. Si legga – ponendo particolare attenzione alle frasi della fascia inferiore – la scritta che, nel cortile del palazzo ducale di Urbino, annuncia ai viventi e ai posteri la gloria di Federico di Montefeltro: Federicus Urbini dux Montisferetri ac Durantis comes / sanctae Ro: Ecclesiae confalonerius atque Italicae confoe / derations imperator hanc domum a fundamentis / erectam gloriae et posteritati suae exaedificavit // qui bello pluries depugnavit sexies signa contu / lit octies hostem profligavit omniumque praeliorum victor / ditionem auxit eiu-
sdem iustitia clementia li / beralitas et religio pace victorias aequarunt ornaruntque; ovvero – con qualche licenza – “Federico, duca di Urbino e conte del Montefeltro e di [Castel] Durante, gonfaloniere di santa romana chiesa e comandante supremo della federazione italica, costruì questo edificio dalle fondamenta a gloria sua e della sua discendenza; lui che più volte combatté in guerra, sei volte riportò le insegne del nemico, otto volte lo sconfisse e, vincitore di ogni battaglia, aumentò il suo dominio; la sua giustizia, clemenza, generosità e devozione eguagliarono con la pace le sue vittorie, e le abbellirono”. Splendido esempio di scrittura autocelebrativa, dove le virtù dinastiche e politiche si intrecciano strettamente con le glorie militari, di cui Federico mena legittimo vanto pur dichiarando che le sue qualità personali e umanistiche hanno eguagliato e corredato – nella pace, e con la pace – la sua straordina-
L’anno Sanzio | 5
La fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento non è solo età d’arte L’Italia è campo di feroci scontri
64
ria fama di condottiero. Ne siamo consapevoli, e infatti il pensiero va al suo mecenatismo, alla sua sete di conoscenza, ai suoi rapporti con i sapienti e gli artisti del tempo; quella scritta è pienamente concorde con la grazia elegante della sua residenza urbinate («che non un palazzo, ma una città in forma di palazzo esser pareva», come ne scrisse il Castiglione) e con la magia intima e simbolica dello studiolo. Il Quattrocento in Italia non è un’epoca di pace
In alto, L'entrata di Carlo VIII a Firenze (Galleria degli Uffizi) In alto a destra, un'immagine di Papa Alessandro VI Borgia eletto quando Raffaello aveva 9 anni Di seguito, un ritratto di Federico da Montefeltro con il figlio Guidobaldo (Galleria Nazionale delle Marche)
Resta però il fatto che l’Italia del secondo Quattrocento, di cui convenzionalmente ricordiamo la politica d’equilibrio fra i maggiori Stati della Penisola (Napoli, Roma ovvero la Santa sede, Firenze, Milano e Venezia) non è affatto un’età di pace. Usando lo stesso Federico
come “indicatore”, dovremmo ricordarne – oltre alla lunga lotta mortale, quasi nutrita di astio privato, con Sigismondo Pandolfo Malatesti signore di Rimini e di altre terre – le continue e ben remunerate condotte (i cui proventi hanno consentito l’edificazione del palazzo ducale e hanno dato a Urbino l’impronta che ha) ora al servizio del re di Napoli e ora del papa (ma anche contro), il sacco di Volterra nel 1472 al soldo della Repubblica fiorentina (cioè di Lorenzo de’ Medici), fino alla partecipazione alla guerra di Ferrara, che contrappone Ercole d’Este a Venezia e durante la quale il duca d’Urbino, ormai sessantenne, nel 1482 muore. Ma qualunque vita di condottiero del Quattrocento italiano si volesse esaminare e usare come “traccia” – da Bartolomeo Colleoni a Francesco Sforza – sempre si trove-
L’anno Sanzio | 5
rebbero tracce significative di liberalità e di sangue, di ardimento omicidiario e di dotta munificenza. Durante la vita di Raffaello da Urbino, però, in Italia qualcosa cambia radicalmente. Le guerre cui partecipava Federico di Montefeltro erano per così dire guerre “interne”: Venezia contro il papa, Milano e Napoli contro Firenze, e così via, e attorno agli Stati più grandi si affollano i potentati minori (Mantova, Urbino, Ferrara, Camerino, Rimini, ecc.) in un comporsi e ricomporsi di alleanze. È l’equilibrio, bellezza!, diremmo oggi. In effetti è un caos equilibrato ma ribollente, nel quale si muovono personaggi celebri come il magnifico Lorenzo de’ Medici, o Sisto IV della Rovere, o Francesco Sforza duca di Milano e suo fratello Alessandro, primo signore sforzesco della linea di Pesaro: un caos temperato, insomma, nel quale a nessuno Stato italiano viene permessa una eccessiva espansione. Papa Alessandro VI e i primi anni di Raffaello Con le cosiddette guerre d’Italia tutto cambia, nel decennio finale del Quattrocento in Italia succede qualcosa di un’intensità mai vista. Nel 1494 Raffaello ha 11 anni, Alessandro VI Borgia è papa da due, Cristoforo Colombo sta scoprendo le Americhe. Ma in quello stesso anno il re di Francia Carlo VIII, incautamente messo in gioco da Ludovico Maria Sforza detto il Moro (“incautamente” lo diciamo noi, aiutati dalla facile scienza del senno del poi) varca le Alpi con un esercito immenso per rivendicare il regno di Napoli. Un intruso, con un esercito che nessuno può fermare. Come è potuto accadere?
65 È successo che, mentre Federico di Montefeltro (che continuo a usare come paradigma di principe mecenate e condottiero) combatte le sue guerre e abbellisce Urbino, al di là delle Alpi si è venuto creando un regno poderoso. A metà del Quattrocento si è conclusa la guerra dei Cent’anni e la Francia ha finalmente respinto gli inglesi. Nella fase finale di quell’eterno conflitto i re Valois hanno accentuato la supremazia della corona: hanno imposto a tutti i non privilegiati la taille, una tassa sul reddito che viene riscossa a scadenza fissa dagli ufficiali del re (è la prima imposta diretta permanente dai tempi dell’impero romano), sicché la corona adesso ha una cospicua massa monetaria a propria disposizione e non deve farsi finanziare la guerra da assemblee rappresentative come gli Stati generali (che infatti lentamente cadranno in disuso, fino all’infelice riconvocazione del 1789); grazie alle risorse economiche la corona assorbe le armate mercenarie e feudali presenti nel regno e costituisce un esercito poderoso permanente, diviso in più armate: una facoltà che ai re inglesi non sarà mai consentita. Inoltre nei decenni finali del ‘400 la Francia ha assorbito per devoluzione la Provenza, per matrimonio la Bretagna e dopo la morte in battaglia del duca di Borgogna Carlo il Temerario, nel 1477, ha annesso diverse aree dello Stato borgognone. Il regno di Francia è adesso uno Stato poderoso, esteso per 450.000 kmq, ricco e armato. I suoi re si guardano attorno, sognano la supremazia in Europa e di avviare nuove crociate (la crociata a noi pare un tema medievale e invece nelle corti e in letteratura è un vagheggiamento reiterato
Federico di Urbino condottiero e mecenate muore un anno prima della nascita di Raffaello
L’anno Sanzio | 5
66 e vivissimo, per attuare il quale il mezzogiorno d’Italia è la base ideale). Non si deve dimenticare del resto che nel 1453, appena quarant’anni prima, gli ottomani avevano preso Costanti-
è armato di cannoni, non più di pesanti bombarde più terribili che micidiali. I cannoni sono armi di nuova concezione, fuse in un solo corpo, che sparano proiettili non più di pietra (che si infrangevano nell’impatto) ma di metallo, dunque molto più penetranti nelle muraglie delle fortificazioni. Negli anni in cui Raffaello dipinge i suoi primi capolavori, l’Italia si trova a sperimentare una guerra «corta e grossa», per dirla con il Machiavelli, la cui prima vittima è Fivizzano in Lunigiana. La furia francese contro Fivizzano
Caduto il dominio borgiano venne eletto papa Giulio II E per lui Raffaello dipinse le stanze della Segnatura
nopoli (e nel 1480 Otranto in Puglia), quindi sono percepiti come un pericolo. Si aggiunga per i re francesi il ricordo dei legami di sangue tra gli Angioini e i Valois, e il gioco è pronto… Insomma, l’esercito francese che nel 1494 varca il Moncenisio è forte di circa 30.000 uomini. Per fermarlo occorrerebbe che gli Stati italiani si coalizzassero, ma è stato proprio il reggente Sforza di Milano, Ludovico il Moro, ad aver incoraggiato e fomentato l’impresa, nell’illusione di consigliare e guidare lo sprovveduto sovrano d’Oltralpe (ma le cose andranno del tutto diversamente). Inoltre l’esercito francese
I francesi si stanno aprendo la strada verso sud e si trovano davanti Sarzana, moderna fortezza fiorentina troppo forte anche per la loro artiglieria, e allora aggrediscono Fivizzano, che è lì nei pressi: ne forano le mura con l’artiglieria, irrompono e sterminano difensori e abitanti. Così gli Stati italiani sperimentano qualcosa di terribilmente nuovo, la famosa furia francese (la fureur française). Racconta Francesco Guicciardini: «Accostatosi a Fivizano, castello de' fiorentini, dove gli condusse Gabriello Malaspina marchese di Fosdinuovo loro raccomandato, lo presono per forza e saccheggiorno, ammazzando tutti i soldati forestieri che vi erano dentro e molti degli abitatori: cosa nuova e di spavento grandissimo a Italia, già lungo tempo assuefatta a vedere guerre più presto belle di pompa e di apparati, e quasi simili a spettacoli, che pericolose e sanguinose». È una dimostrazione di voluta ferocia, uno schiaffeggiare la nuora perché suocera intenda, e infatti Firenze cede subito il passo.
L’anno Sanzio | 5
Così la Penisola italiana si accinge a entrare in sistemi imperiali altrui; fallito dopo alcuni decenni il tentativo francese, ci sarà una lunga pace spagnola; poi un altrettanto lungo predominio austriaco, con un intermezzo napoleonico che accenderà nei cuori degli italiani il bisogno di indipendenza; cioè saremo giunti ai tempi di Garibaldi e di Cavour. Luigi XII rivendica i diritti su Milano Le cronache del tempo raccontano dapprima il facile acquisto del regno di Napoli, poi la ritirata del re di Francia quando alle spalle gli si forma una coalizione italica (ed europea), che però a Fornovo non gli chiude il passo. Tornato nel suo regno, Carlo VIII muore. Ma i francesi tornano in Italia nel 1499 con Luigi XII, che rivendica i suoi diritti sul ducato di Milano per via di una parentela con i Visconti e che, prima di varcare le Alpi, prepara il terreno meglio del suo predecessore: a Venezia cede Cremona e i territori vicini; agli Svizzeri il Canton Ticino; addomestica il papa Alessandro Borgia creandone il figlio Cesare duca di Valentinois (sarà perciò chiamato il Valentino) e assecondandone certe ambiziose imprese in Romagna e nelle Marche. Sono guerre che proseguiranno poi al sud, perché Luigi XII di Francia si accorda con Ferdinando di Aragona (che dal 1469 ha sposato Isabella di Castiglia) contro gli Aragona di Napoli, cugini invisi a Ferdinando; poi sulla divisione del regno di Napoli francesi e spagnoli verranno alle mani e alla lunga i primi saranno sconfitti. Mentre Raffaello dipinge le sue madonne serene, si svolge dunque in Italia un complicato e lunghissimo
67 scontro internazionale tra i regni di Francia e di Spagna, nel quale intervengono anche l’Impero, gli Svizzeri e altri attori ancora: una guerra interminabile, inframezzata da paci, tregue, cambi di alleanze e da mille episodi collegati, che vede la Penisola solcata da eserciti d’Oltralpe; la guerra, apertasi nel 1494 con l’entrata in Italia di Carlo VIII, si concluderà decenni più tardi: nel 1530 (o se si vuole addirittura nel 1559, con la pace di Cateau Cambresis tra Spagna e Francia). Nel Risorgimento, come è noto, quel complesso di fatti sarà interpretato come l’inizio del “servaggio italiano”, ma l’Ottocento è caratterizzato da una straordinaria (e quasi patologica) sensibilità per le vicende d’Italia, che prima non esisteva e che molto si sarebbe attenuata poi, dopo l’enfatica sottolineatura nazionalista operata dal Fascismo. Così episodi modestissimi e pressoché irrilevanti (la disfida di Barletta, ad es.) diventeranno paradigmatici nel futuro patriottismo.
Mentre Raffaello dipinge le sue madonne in Italia si consuma un complicato scontro tra i regni di Francia e Spagna
La furibonda battaglia di Garigliano Il conflitto ha per oggetto immediato il controllo della Penisola, ma anche la conduzione della crociata – ideale ancora vivo – in Terrasanta e la guerra contro il Turco (che – non si deve dimenticare – nel 1480 ha occupato Otranto in Puglia), e di riflesso la supremazia in Europa. Non possiamo narrare tutte le sequenze di quegli anni, che pure vedono furibonde battaglie al Garigliano (1503), ad Agnadello (dove nel 1509 Giulio II spegne il sogno veneziano di creare una repubblica di san Marco estesa dal Friuli alla Romagna), a Ravenna (1512), a Melegnano (1515),
A sinistra, Papa Giulio II (Giuliano della Rovere) eletto nel 1503 Sopra, Guidobaldo da Montefeltro figlio del grande Federico
L’anno Sanzio | 5
Sotto Francesco Maria nel 1513 nasce lo Stato di Urbino dalla Valmarecchia a Senigallia da Pesaro a Gubbio eccetto Fano
68 alla certosa di Pavia (dove nel 1525 un altro re di Francia, Francesco I, viene addirittura catturato), in mezzo alle ambiguità di tutti gli Stati italiani e ai contorcimenti di Alessandro VI e di Giulio II, che in mezzo a tutto ciò perseguono loro politiche familiari. Ci sono però due episodi, sui quali dobbiamo soffermarci, perché a vario titolo coinvolgono Urbino. Quando Raffaello nasce, duca di Urbino è da un anno Guidubaldo di Montefeltro, figlio del grande Federico. Guidubaldo è l’ultimo di quella casata perché non avrà figli (suo successore sarà, per adozione, Francesco Maria I della Rovere, figlio di sua sorella Giovanna). Guidubaldo milita ininterrottamente al servizio della Santa sede, anche quando sul soglio di Pietro sale Alessandro VI Borgia. Ma la condotta di quest’ultimo è estremamente “politica”, ovvero adattabile alle circostanze, ovvero spregiudicata e – diremmo oggi – familista. Cesare Borgia, figlio del papa regnante, è nato nel 1475 e ha seguito dapprima una carriera ecclesiastica divenendo vescovo e perfino cardinale (grazie al papa-papà). Poi, deposta la porpora, dal 1499 avvia un ambizioso programma di conquiste con l’occupazione di città sulle quali la Santa sede vanta un’alta sovranità: Imola, Faenza, Forlì, Cesena Rimini, Pesaro e altre ancora. Sfruttando l’amicizia della Santa sede con il re di Francia Luigi XII, che gli “presta” degli armati, il Valentino stravolge l’area fra Romagna e Marche e consolida il suo dominio: nel maggio 1501 in concistoro il papa lo crea duca di Romagna. Può Urbino sopravvivere? Nella primavera del 1502
Cesare Borgia muove le sue genti contro i Varano di Camerino e progetta di togliere Arezzo alla repubblica di Firenze. Da Spoleto, dove ha il quartiere generale, chiede al duca di Urbino il prestito di alcuni pezzi di artiglieria per le imprese di Camerino e di Arezzo; chiede inoltre libero passo alle sue truppe. A Urbino non si sospetta nulla (o si simula di non sospettare?), Guidubaldo di Montefeltro consente alla richiesta e gli invia pure in dono un bellissimo corsiero. La duchessa di Urbino, Eleonora, è assente: sta addirittura accompagnando a Ferrara Lucrezia, figlia del papa e dunque sorella del Valentino, che va in sposa a Ercole d’Este. Ottimo clima familiare, dunque. Il 18 giugno 1502 Cesare Borgia da Nocera invia duemila fanti a Cagli, come da accordi pregressi: senonché, entrati in città da amici, questi la occupano. Altri mille uomini del Borgia muovono da Fano a occupare Fossombrone; altre truppe del Valentino sono dislocate a Verucchio e in Romagna. Da alleata, Urbino si trova in una morsa. Guidubaldo, colto di sorpresa, privo di adeguate truppe e consapevole che Urbino non resisterebbe a un assedio, fugge insieme al nipote (e futuro erede) Francesco Maria della Rovere e raggiunge rocambolescamente il territorio veneto. In autunno ci sarà un tentativo di riconquistare il ducato. Narra una cronaca: «Addì 8 d'ottobre venne la novella che s'era avuto San Leo e San Marino e Tavoleto, e che tutto Montefeltro, Ugubio e Cagli erano tornati alla devozione del signor Guido Ubaldo, il quale s'era partito alli 21 di giugno, e così senza vederlo e senz'altro aiuto tutto Urbino si levò in armi». Dieci giorni più tardi Guidubaldo rien-
L’anno Sanzio | 5
tra in città, acclamato. Ma dietro Cesare Borgia c’è il papa, e né Firenze né Venezia vogliono rompere con la Santa sede (e neanche il re di Francia): così nonostante il favore popolare – che nulla conta – la posizione di Guidubaldo resta fragile e in breve il Borgia si impadronisce nuovamente di tutto il ducato, tranne la rocca di San Leo che resisterà fino al ritorno del Montefeltro, che avviene nel 1503. Giulio II nemico mortale della famiglia Borgia In quell’anno il dominio borgiano si dissolve. Il colpo mortale al potere del Valentino viene dalla morte del padre, Alessandro VI, avvenuta improvvisamente il 18 agosto. Dopo un breve interregno, il 31 ottobre 1503 viene eletto papa il cardinale Giuliano della Rovere, che prende il nome di Giulio II e che, essendo nemico mortale dei Borgia, ordina l’arresto di Cesare (è già tanto che gli risparmi la vita). È per Giulio II che Raffaello
69
dipinge le splendide stanze della Segnatura, dove tra l’altro compare la celeberrima Scuola di Atene. Per colmo di malasorte, mentre il padre moriva, Cesare Borgia è stato seriamente malato e non è riuscito a imporre la sua volontà ai cardinali. Racconta il Machiavelli: «E lui mi disse, ne’ dì che fu creato Iulio II, che aveva pensato a ciò che potessi nascere morendo il padre, e a tutto aveva trovato remedio, eccetto che non pensò mai, in su la sua morte, di stare ancora lui per morire». Nella concezione di Machiavelli, dunque, al Valentino ha fatto difetto la fortuna, padrona delle sorti, non il personale valore. Dobbiamo ricordare che quel che veniamo sommariamente narrando è intriso di sangue: se una morte è conveniente e utile, si esegue senza esitare, come tante volte Nicolò Machiavelli ci ha narrato. Conquistata Urbino, per es., Cesare Borgia ha fatto decapitare due o tre persone, tra i quali messer Dolce de’ Dotti, se-
E’ il tempo di guerre continue inframezzate da paci, tregue, cambi di alleanze e mille episodi collegati
A sinistra in alto, un presumibile ritratto di Cesare Borgia e di seguito Francesco Maria I della Rovere (Galleria degli Uffizi) Qui sopra, un dipinto che riproduce la battaglia di Garigliano del 1503
L’anno Sanzio | 5
Scontri intrisi di sangue: conquistata Urbino Cesare Borgia fece decapitare e incendiare
70 gretario di Guidubaldo; nelle varie rivolte ci sono paesi incendiati, gli avversari fatti prigionieri sono talora trucidati, con equanimità, da ambo le parti. Il tempo del Rinascimento corre tra violenze e grazia, entrambe perfette. Il secondo episodio che coinvolge Urbino, all’interno della tempesta chiamata guerre d’Italia, avviene qualche anno più tardi. Guidubaldo di Montefeltro muore nel 1508, a trentasette anni, e gli succede il nipote ex sorore opportunamente adottato, Francesco Maria della Rovere, già signore di Senigallia e del vicariato di Mondavio, che nel 1513 per concessione del papa Giulio II della Rovere aggiunge ai suoi domini la città di Pesaro. Si è così costituito lo Stato di Urbino come resterà per oltre un secolo, esteso dalla Valmarecchia a Senigallia e da Pesaro a Gubbio, ma senza Fano che rimane un’enclave della Chiesa. Senonché, subito dopo aver concesso Pesaro al nipote, nel 1513 Giulio II muore. E il papa successivo è Giuliano de’ Medici, ovvero Leone X, che continua la politica nepotistica e familistica del tempo, ma a favore dei suoi familiari. Per il Della Rovere l’aria cambia. E siccome il ducato di Urbino non è uno Stato sovrano, ma un feudo della Chiesa, a trovare un pretesto per dichiararne fellone il duca ci vorrà poco. Intanto viene risollevata una torbida storia di qualche anno prima, relativa all’uccisione del cardinal Alidosi da parte dello stesso Francesco Maria: il duca di Urbino ne era stato prosciolto, anche per intervento dell’allora zio-papa Giulio II. In aggiunta, Francesco Maria è accusato di tradimento per non aver inviato i soldati richiesti, per presunti
accordi segreti con i nemici della Chiesa; ecc. Il duca è citato in giudizio a Roma, e sebbene a discolpare il figlio adottivo si presenti Eleonora Gonzaga, vedova di Guidubaldo da Montefeltro, il 14 marzo 1516 una bolla pontificia lo dichiara decaduto per reiterata fellonia. Nel 1516 Lorenzino entra in Pesaro Così nella primavera 1516 l’esercito pontificio-mediceo muove da Romagna, Umbria e Toscana. Lorenzo de Medici (detto Lorenzino per distinguerlo dal Magnifico, che era suo nonno) con cavalli e fanti entra nello Stato di Pesaro verso Gradara; altri armati muovono su Gubbio, altri ancora valicano gli Appennini e raggiungono Castel Durante. Non c’è possibilità di difesa, né alleati su cui far conto: il 30 maggio 1516 Urbino e Fossombrone sono occupate, il duca si ritira a Pesaro e da lì parte in esilio per Mantova: «così il ducato di Urbino insieme con Pesaro e Senigallia venne in quattro giorni soli all’obbedienza della Chiesa», si legge nella Istoria d’Italia di Francesco Guicciardini. Resistono per qualche tempo le fortezze di Pesaro, San Leo e Maiolo. Poi nella rocca di Pesaro la guarnigione assediata abbandona il proprio comandante, che ha resistito troppo a lungo e che viene quindi giustiziato (qui non esistono convenzioni di Ginevra che tutelino gli arresi: se il vincitore è arrabbiato per la strenua resistenza, si vendica); poi si arrende Maiolo; San Leo viene infine presa, dopo tre mesi d’assedio, grazie a un’avventurosissima scalata – così racconta il Guicciardini – della parete a vertiginoso strapiombo. Intanto, nel settembre 1516, lo zio-papa Leone X assegna
L’anno Sanzio | 5
il ducato di Urbino al nipote Lorenzo de’ Medici, lo stesso cui Machiavelli dedicherà il Principe. Sembra finita. E invece non lo è. Da Mantova, segretamente sostenuto dal re di Francia, Francesco Maria recluta numerosi mercenari rimasti in Italia senza stipendio dopo la pace di Noyon (una delle tante tregue delle guerre d’Italia, dopo le quali migliaia di armati si trovano “in libertà”) e con quelle truppe, ma senza denaro, muove alla riconquista, giustificando per lettera la sua azione ai cardinali e alle principali città del ducato: non fidandosi del popolo, la guarnigione pontificia che presidia Urbino espelle dalla città i maschi che, teme, appoggeranno gli attaccanti. Lorenzo de’ Medici ha il comando supremo delle truppe pontificie, ma per la sua modesta esperienza viene affiancato da più abili condottieri. Quella che segue è la cosiddetta guerra d’Urbino, contrassegnata dalla grande combattività delle due parti e dal valore
71
di Francesco Maria, sempre in difficoltà di risorse. Ci sono famosi episodi, come l’assedio di Mondolfo, che è uno dei pochi successi medicei (ma Lorenzo de’ Medici viene gravemente ferito da un’archibugiata); come la durissima battaglia dell’Imperiale, alle porte di Pesaro, che secondo il Guicciardini causa centinaia di morti. I saccheggi di Pergola Mondolfo e Fossombrone Il grande letterato osserva, nella sua Istoria, che nell’esercito mediceo-pontificio ci sono tumulti e diserzioni, mentre quello roveresco, che pure patisce penuria di paghe, manifesta maggior solidità. Se non è detta per spirito di parte, questa osservazione suona a lode di Francesco Maria. Ma resta il fatto che nel frattempo terre e città – oltre a Mondolfo anche Fossombrone e Pergola – patiscono violenti e saccheggi. Francesco Maria tenta di portare la guerra in Umbria e nella Marca, e perfino in Toscana verso
Sotto Leone X le fortezze del ducato vengono assalite da “Lorenzino “ che conquista San Leo scalando la parete a strapiombo
A sinistra, Papa Clemente VII e qui sopra un particolare del dipinto di Raffaello in cui Papa Leone X è tra i cardinali Giulio de' Medici e Luigi de' Rossi (Galleria degli Uffizi)
L’anno Sanzio | 5
Quando il divin pittore ha 9 anni Cristoforo Colombo sta scoprendo l’America e Carlo VII si accinge a varcare le Alpi
72
Anghiari: ma è una guerra che lui non può vincere e che intanto distrugge le finanze del pontefice e ne compromette il prestigio. Così vengono intavolate trattative di pace, che nel settembre 1517 concludono la guerra d’Urbino. Il papa pagherà gli stipendi ai soldati rovereschi (che sono italiani, tedeschi, guasconi e spagnoli), i quali in un termine prefissato si disperderanno; Francesco Maria raggiunge Mantova con tutte le sue robe, l’artiglieria e con la celebre libreria di Federico di Montefeltro; il pontefice assolve dalle censure e perdona tutti. Medici a Urbino Governo breve
In alto, un'immagine di Cristoforo Colombo che scopre le Americhe
Il conflitto si è protratto otto mesi, «con gravissima spesa e ignominia dei vincitori». Il governo mediceo di Urbino dura solo due anni, e qui possiamo disinteressarcene. Lorenzo de’ Medici muore
nel maggio 1519 senza eredi maschi (ha solo una bimba, Caterina, futura regina di Francia) per cui il ducato è formalmente devoluto alla Santa sede. Poi nel 1521, scomparso Leone X, Guidubaldo della Rovere recupera lo Stato, che rimarrà alla sua Casata per oltre un secolo. Per allora Raffaello sarà scomparso, lasciandoci opere di luminosa e struggente bellezza, così in antitesi con la durezza dei tempi in cui vive. Muore in tempo per non accorgersi, forse, della grave fenditura che con la Riforma sta squarciando la Cristianità; per non vedere la guerra che continua a rombare non solo nella sua Urbino lontana ma in tutta la Penisola, dalla Lombardia alla Puglia, e che nel 1527 – sotto un altro papa Medici, Clemente VII – causerà perfino un evento fuori di ogni immaginazione: il sacco di Roma. ¤
L’anno Sanzio | 6
73
Scalpore per la vendita del disegno raffaellesco DISCUSSA ANNI FA DALLA BIBLIOTECA OLIVERIANA DI PESARO
N
ella Biblioteca Oliveriana di Pesaro è custodito un disegno di Raffaello di 216x90 mm, raffigurante al recto una figura acefala panneggiata e al verso una figura maschile nuda. Il disegno proviene dalla più vasta collezione Antaldi, in parte dispersa per vendite già nel XIX secolo, a interpretare e ricostruire la quale lavora da tempo immemorabile un’équipe guidata da Anna Cerboni Baiardi. Può essere che le modeste dimensioni e la semplicità di esecuzione abbiano salvato in altri tempi questo foglio,
Disegno attribuito a Raffaello figura acefala e figura maschile nuda
mentre altri esemplari della collezione, per così dire più vistosi, sono stati venduti e acquistati, prendendo altre vie. Il verso del disegno, ha scritto Anna Forlani Tempesti, «è quello che più immediatamente palesa le qualità raffaellesche per la delicata vivezza con cui è segnata
la giovane figura»; potrebbe essere un disegno preparatorio per la figura del Cristo risorto nella Resurrezione oggi a San Paolo del Brasile. Una datazione proposta da Roberto Longhi, e comunemente accettata, assegna il duplice disegno agli anni 1501-1502. Del “Raffaello dell’Oliveriana”, esposto nel palazzo Montani di Pesaro assieme ad altri disegni nella mostra Da Raffaello a Rossini. La collezione Antaldi: i disegni ritrovati fra agosto e ottobre del 2001, si parlò con qualche malinteso clamore anche nel 2010, quando il consiglio d’amministrazione della fondazione Ente Olivieri-Biblioteca e Musei Oliveriani ipotizzò di alienare qualche parte del proprio patrimonio per meglio salvaguardare il resto, e tra gli oggetti di cui si discusse la vendita ci fu il disegno raffaellesco. Con il ricavato della cessione si ipotizzavano progetti di ricerca, l’assunzione di personale qualificato, l’apertura di un laboratorio di tecnica del restauro, ecc., tutte attività di alto profilo. La notizia trapelò e suscitò per qualche tempo l’interesse della stampa. Alcuni oggetti di cui si ipotizzò la cessione, fra cui il disegno del Raffaello, vennero fatti stimare da una casa d’aste di Milano, e i risultati parvero molto lusinghieri. Poi la proposta si esaurì perché, sebbene del tutto lecita e ipotizzata nel totale rispetto della normativa vigente, quella vendita sarebbe stata una scelta estrema, quasi contro natura per una biblioteca di conservazione. ¤
L’artista
di Grazia Calegari
In alto, l'Apocalisse di Nino Caffè quadro del 1959 con quattrocento pretini che affollano piazza San Pietro (Collezione Elio Giuliani Foto Luca Toni)
U
n importante collezionista pesarese, il giornalista Elio Giuliani che possiede tra l’altro oltre quattrocento pezzi tra quadri, sculture e ceramiche del ‘900 di Pesaro e provincia, ha recentemente acquistato un’opera di interesse particolare. L’autore è Nino Caffè, un protagonista del secolo a livello locale e nazionale, nato ad Alfedena (L’Aquila) nel 1909 e morto a Pesaro nel 1975. Mi soffermo a parlare di un’opera sua soltanto, ma la collezione Giuliani ne comprende diverse di un livello tale che meriterebbe
una conoscenza globale, resa parzialmente possibile a Pesaro solo in poche occasioni. I primi contatti con la città di Pesaro Nino Caffè compì i primi studi all’Aquila e all’età di dieci anni si trasferì con la famiglia ad Ancona, dove seguì la scuola di Ludovico Spagnolini e lavorò successivamente per l’antiquario Guerrieri facendo imitazioni di quadri antichi e paesaggi decorativi seicenteschi. Nel 1926 ebbe i primi contatti con la città di Pesaro e nel 1930 vi si tra-
75
Nell’Apocalisse piena di ironia ondeggia tutta l’anima di Caffè NEL QUADRO SONO DISEGNATI QUATTROCENTO “PRETINI” CHE DIVENTERANNO IL SUO SOGGETTO CARATTERISTICO E LO RENDERANNO FAMOSO
sferì definitivamente. Durante questi anni frequentò gli studi di alcuni artisti locali per approfondire meglio la tecnica del disegno; nel 1928 entrò a far parte del “Gruppo sindacale marchigiano artisti” iniziando ad esporre le sue opere. La prima Mostra del Sindacato fu allestita ad Ancona, organizzata da Vittorio Morelli, allora presidente: con Caffè esposero tutti gli appartenenti al Gruppo, tra i quali Gallucci, Carnevali, Pagliacci, Bettini, Zicari, Bazzali e Cancelli. Nel 1931 iniziò ad esporre alle varie mostre sindacali
Marchigiane e Intersindacali Nazionali di Roma, Firenze e Napoli. Dal 1934 espose alle Biennali veneziane e alle Quadriennali nazionali romane, fiorentine e napoletane fino al 1938. Nel 1935 si diplomò presso l’Istituto d’Arte di Urbino, studiando ed imitando con interesse i pittori impressionisti. Il periodo che va dal 1946 al 1950 segna un momento particolare e importante per Caffè: le attenzioni che Irene Brin e Gaspare Del Corso cominciano a rivolgere alla sua arte gli danno la possibilità di iniziare le esposizioni
alla Galleria l’Obelisco che divenne un luogo di incontri culturali, nel particolare momento di ripresa della vita del dopoguerra. In questo periodo Caffè aprì un piccolo studio in piazza Arquati a Roma, e nel 1946 allestì una personale alla Galleria Gianferrari di Milano. Nel 1948 tenne una mostra a Pesaro alla Casa Rossini, dove venivano esposti per la prima volta piccoli quadri raffiguranti “i pretini”, che diventeranno il suo soggetto caratteristico e lo renderanno famoso. Nel 1958 trasferisce lo studio di Roma
L’artista
La scena si svolge in piazza San Pietro con l’obelisco al centro Nel fondale senza colori risalta la tenera nuvola rosa a sinistra
76 da piazza Arquati a via Gregoriana, da dove s’inserisce meglio nell’ambiente artistico e culturale di Roma. Nel 1963, per motivi di salute, chiude lo studio di Roma. Le sue mostre personali continuano nel 1962 alla Galleria Ghelfi di Verona con grande successo e proprio il Ghelfi diventa il suo più attivo mercante d’arte. Nel 1971 espone alla Galleria Gianferrari di Milano, a Montecatini, a Verona, Genova, Palermo, La Spezia. Nel 1973 le esposizioni alle Gallerie Pier della Francesca di Arezzo e Boccioni di Milano ampliano la sua popolarità. Negli ultimi periodi della vita Caffè diventa mercante, critico e agente pubblicitario di se stesso continuando a esporre in altre mostre collettive e personali fino al 1975, anno nel quale cessa di vivere per infarto a sessantasette anni. (da Patrizia Mignani, voce in Arte e immagine tra ottocento e novecento, catalogo mostra, Pesaro 1980 ) Il quadro esposto all'Obelisco di Roma
Sopra, l'artista Nino Caffè A destra alcuni particolari dell'opera L'apocalisse
Caffè dipinge questa tela nel 1959 e la espone a Roma in una mostra alla galleria L’Obelisco, fondata da Irene Brin e Gasparo del Corso, che ha avuto il merito di essere stata la prima galleria aperta a Roma subito dopo la guerra, per costituire uno dei poli più attivi degli anni cinquanta e sessanta. Coppia inconsueta e di respiro internazionale, Gasparo del Corso ma soprattutto Irene Brin, giornalista e corrispondente di Harpers’ Bazaar, diedero un’impronta profonda all’attività intellettuale e anche mondana della galleria. Nel corso di trent’anni di attività, nelle sale de L’Obelisco in via Sistina sono state esposte le opere dei più importanti pittori della generazione di anteguerra (Morandi, Sironi,
de Chirico, Balla, Campigli), e anche quelle dei più giovani Afro, Capogrossi, Fontana, Burri, Pomodoro. Ma soprattutto il pubblico ha potuto vedere, spesso per la prima volta, i lavori di stranieri come Matta, Magritte, Gorky, Rothko, Moore, Calder, Dalì, Bacon, Rauschemberg, Grosz, Picasso, Dubuffet, per citare solo alcuni nomi dell’avanguardia e della sperimentazione internazionale. In tanto pullulare di iniziative e di movimenti di artisti e compratori, nel 1959 L’Obelisco decide di aprire una sede a New York con una mostra di Nino Caffè: tra i quadri inviati c’è anche questa “Apocalisse”, tema che Caffè replica almeno tre volte. Il catalogo che accompagna l’esposizione è di uno scrittore allora di moda in quel mondo di cultura internazionale: l’inglese Graham Green (1904-1991) , autore di romanzi, racconti, opere teatrali da cui furono tratti film di cui spesso ha curato personalmente la sceneggiatura. Cito soltanto “Orient Express”, “Il terzo uomo”, “La croce di fuoco”, “Idolo infranto”, “Un americano tranquillo”, “In viaggio con la zia”, tra i cinquanta titoli della sua produzione cinematografica. E di Greene era anche il catalogo della mostra di Caffè a L’Obelisco di New York; questi argomenti entravano anche nei video dell’Istituto Luce, tra il 1959 e il 1960. Dentro “L’apocalisse” quattrocento pretini Caffè descrive metà dei portici di piazza San Pietro, la grande cavità con l’obelisco al centro, l’inizio e la fine del porticato, le grandi statue in alto, una decorazione fantasiosa all’interno del portico, la luce che sbatte violentemente a destra nell’evento apocalittico che si abbatte
L’artista
sul Vaticano. Ne fa un fondale teatrale senza colori, perché risalti meglio quella tenera nuvola rosa a sinistra. Riempie la piazza di circa quattrocento pretini, il soggetto che lo sta rendendo famoso e riconoscibile: un tema che piace molto per l’ironia, per la bravura dell’autore nelle tantissime invenzioni, perfette nell’atmosfera di quella Roma che rinasce tra mondanità, denaro, potere politico e religioso. Ma nelle tantissime piccole tele di Caffè le scene sono animate da un limitato numero di pretini, non da una vera folla vociante come questa, che ondeggia come un oceano. Un anno dopo, nel 1960, esce “La dolce vita”di Federico Fellini e mi piace ricordare anche la sontuosa amarezza della sua Roma e le sue maschere stravolte dal potere politico e religioso. Non so se i due si conoscessero in quell’ambiente di artisti, giornalisti, scrittori, cinema-
77
tografari, tra Irene Brin e Graham Green. Loro provinciali, uno di Rimini e l’altro di Pesaro-Urbino . Ma guardiamo questa “Apocalisse”, perché la solita ironia di Caffè qui mette in scena i quattrocento pretini in cinemascope, li fa giocare, correre, litigare, tirare i cappelli che svolazzano nel cielo come uccelli. Ne fa una massa enorme, ondeggiante, che diventa livida e tragica, perché il tema è apocalittico, e la Roma felliniana in quella piazza perde l’ironia dei piccoli gesti scanzonati e acquista la tragicità di un destino comune, che si allarga forse dai pretini all’umanità . Ma trasportata a New York per inaugurare con le altre opere di Caffè la filiale de L’Obelisco, penso che quest’opera sia diventata negli States un emblema di Roma, grandezza e potere dissacrato, vitalità mondana e voglia di vivere nell’Italia degli anni sessanta. ¤
I pretini in cinemascope giocano, corrono litigano, tirano i capelli e svolazzano Una massa enorme livida e tragica
La scomparsa
Il di Armando Ginesi
Famose le sue isole volanti sradicate dalla terra che guardano dall’alto estrinsecando il desiderio di una verità più alta
30 maggio scorso è scomparso a Pesaro un grande pittore, Mario Logli. Nella sua pittura non può non i individuarsi due sue ascendenze linguistiche, attive all’interno di quello straordinario fenomeno di pluralismo espressivo che ebbe origine agli inizi del XX secolo, a sua volta preparato dalla grande innovazione, concettuale e stilistica, dell’Impressionismo. Esse sono la Metafisica e il Surrealismo. La Metafisica è quell’indirizzo pittorico delineatosi attorno alla produzione artistica di Giorgio De Chirico nel 1917, di Carlo Carrà nello stesso periodo e un po’ più tardi di Giorgio Morandi, esteso poi alle tendenze di Valori Plastici. Nella linea dechirichiana la Metafisica si nutre di premesse culturali e filosofiche riconducibili a Friedrich Nietzsche, Artur Schopenauer, Otto Weininger, unite a suggerimenti di pittura, classicista e visionaria al tempo stesso, tratti da Nicolas Poussin, Claude Lorrain,
Arnold Böcklin, Max Klinger, Caspar David Friedrich. Il tutto risolto con esiti da atmosfera magica e sospesa, pur espressi dall’assoluta aderenza di ogni particolare narrativo alla realtà delle cose. Questa linea espressiva è stata certamente, assieme al Dada, premessa del successivo Surrealismo, come ha più volte riconosciuto lo stesso teorico del movimento André Breton. Esso si è fondato sui meccanismi dell’inconscio e della casualità originando immagini quanto più possibile autonome rispetto alle leggi della logica e di tutte le regole conseguenti. Le premesse culturali della tendenza furono certamente le teorie psicanalitiche di Sigmund Freud e l’utopia che rincorreva il sogno di una umanità libera da ogni tipo di costrizione: economica e sociale (Marx), di pensiero e psichica (Freud). Insieme, le due avanguardie citate, sono gli antecedenti di quella pittura di realismo ipnotico, di spazio illusionistico,
79
La pittura lucida e visionaria di Logli L'ARTISTA URBINATE SI È SPENTO IL 30 MAGGIO SCORSO CONTINUI I SUOI RIFERIMENTI ALLA CITTÀ DEL RINASCIMENTO
di trompe-l’oeil, che connota il racconto visivo di quel formidabile narratore che è stato Mario Logli. Il quale – non si dimentichi – è nato e si è formato ad Urbino, prima di prendere la strada di Milano dove aveva posto la residenza da più di sessanta anni. Praticamente tutta la letteratura critica che lo riguarda rileva e sottolinea questo dato anagrafico-culturale. Paolo Volponi, ad esempio, scrive come la sua pittura sia “immancabilmente urbinate”, “ossessivamente urbinate”; gli fa eco Valerio Volpini, riferendosi agli urbinati in genere, i quali “la magia e la follia della città […] la portano dentro come una malattia perpetua”. Carlo Bo parla di una Montefeltro che “ha una sua verità, una sua autenticità e, come Urbino che lo rappresenta, è molto di più di una memoria storica”. Quella Urbino che, aggiunge Silvio Locatelli, “è un piccolo mondo incantato”, popolato da Raffaello Sanzio, Luciano Laurana, Federico
Barocci, Francesco di Giorgio Martini, Paolo Uccello, Luca Pacioli, Baldassarre Castiglioni, i quali, nota sempre l’autore, “sono lì” perché “non hanno mai lasciato quel loro piccolo mondo incantato”. I continui riferimenti ad Urbino, città fantastica e pregna di magia che fu una capitale europea del Rinascimento ed oggi è scrigno di una straordinaria memoria non nostalgicamente statica ma dinamicamente fattrice di cultura, questi riferimenti, dicevo, meglio consentono di mettere a punto una corretta lettura dell’eccezionale qualità pittorica di Logli. Perché vivere e formarsi ad Urbino (come Logli ha fatto), amarla (come Logli costantemente l’ha amata), vuol dire nutrirsi di altri stimoli, far proprie, per elaborarle, altre suggestioni. Come quelle offerte dal dipinto La città ideale (che sia del Laurana, di Piero della Francesca o, secondo le ultime attribuzioni, di Leon Battista Alberti, poco importa), dalle opere di Piero (La Flagellazio-
ne, in primis) e di Paolo Uccello: tutte conservate nel prezioso Palazzo Ducale e che accostano la metafisica ante-litteram dei primi due autori alla visionarietà del terzo. Ma è la stessa Urbino ad essere metafisica (come Ferrara e, in parte, Macerata): è quel suo Palazzo inteso come modello di perfezione architettonica, come geometria che si fa pensiero e sentimento; è la nebbia che in autunno fascia la città – penetrando nelle vie, nei vicoli e nelle piazze – e la rende misteriosa e sublime; è lo stesso vento che, soffiando, sembra talvolta suonare strumenti a fiato indefinibili. Urbino è alchemica, è magica; è colta. Ecco allora che Logli, nutritosi con i cibi spirituali che questa città dispensa quotidianamente, allarga i propri orizzonti proprio in nome della cultura e così studia e approfondisce i vari movimenti della pittura europea e internazionale. La sua propensione per la precisione, per la nettezza, per la perfezione, per la chiarezza e
La scomparsa
Elementi di realismo ipnotico spazio illusionistico e di trompe-l’oeil connotano il racconto visivo dell’artista
80 il nitore, ancorché per l’inesplicabile fascino della magia (non c’è contraddizione tra i due atteggiamenti, come nota acutamente Rossana Bossaglia che, in uno scritto del 1996, dice di Logli: “non soltanto padroneggia […] gli elementi rappresentativi che sceglie nel fecondo incontro tra memoria e fantasia, ma conferisce loro […] una spinta e una dimensione onirico-visionaria dove il proprio bagaglio intellettuale, la forbitezza formale si liberano da ogni sofisticato compiacimento e si fanno liricità pura”), lo inducono a guardare con vivo interesse alla cultura della visione precisa, netta e chiara del Vedutismo settecentesco, ma anche all’icasticità disegnativa e alla pennellata stesa e tirata del neoclassicismo alla Jacques-Louis David. Senza dimenticare il bravissimo pittore prussiano Jacob Philipp Hackert (1737-1807), esponente della linea analitica della pittura di paesaggio, che interpreta la natura come riflesso di una “legge oggettiva, eterna e immutabile che governa il divenire del cosmo” (Enrico Gatta). Come già detto, l’artista urbinate, pur affascinato dalle seduzioni della perfezione formale, non perde mai di vista il sentimento dell’indefinibile, la malia che deriva dal mistero, l’imponderabilità dell’incommensurabile. Così egli inclina anche verso gli atteggiamenti romantici dei pittori monacensi, i già citati Böcklin, Friedrich e Klinger (c’è una tela di Logli del 1984, intitolata Città fossile, che emana gli odori e i sapore arcani dell’Isola dei morti di Arnold Böcklin. Sicché il nostro artista riesce ad essere nel medesimo tempo – come ha scritto Volpini – “lucidissimo e visionario” e le sue opere diventano luogo privilegiato di incontro felice tra il sogno e la realtà. Perché se è vero che egli ai luoghi preferisce le idee, come ha notato Carlo Bo, è altrettanto vero che egli proietta sulla tela le “immagini interio-
ri del cuore”. Ma torniamo al Surrealismo, come ad una delle referenze “moderne” del pensiero visivo di Logli. Acclarato, senza alcun dubbio, ch’egli sia più attratto dalla poetica della Metafisica (che è una poetica del senza: senza tempo, senza suono, senza vive presenze umane) che da quella surrealista propriamente detta, va precisato che ci sono almeno due fasi della produzione logliana le quali si sono fatte carico dei postulati teorici e formali della sur-réalité cioè di quella realtà superiore che André Breton individuava nel punto d’incontro tra il sogno e la realtà, dove entrambi cessavano di essere dimensioni dicotomiche per farsi cosa altra: surrealtà, appunto. Queste due fasi, a mio avviso, sono rappresentate dalla serie degli Invasori del 1974-75 e quella di Dopo i trionfi del 1982-84. Nella prima la fantasia creativa di Logli immagina personaggi meccanici, a metà tra l’antropomorfo e lo zoomorfo, che Marco Valsecchi chiama “incarnazioni malefiche”. Essi rappresentano vere e proprie minacce alla nostra coscienza, alla nostra vita, soprattutto a quella futura. Si tratta di mostri che hanno formato un “esercito occulto” (Valsecchi) per impadronirsi “subdolamente dell’umanità”. Sono le minacce dell’inquinamento che Logli immaginava già nel 1974 ed oggi – se ci riferiamo all’inquinamento ambientale – sappiamo quanto questi invasori si aggirino, minacciosi e aggressivi, nefasti, nelle vie delle città del mondo afflitte dal problema dei rifiuti e dal rischio di rimanerne sommerse, oppure nelle nostre una volta splendide campagne invase adesso, al pari dei fiumi, dei laghi, dei mari e finanche dei ghiacciai, da veleni chimici d’ogni sorta che minano l’esistenza umana, animale e vegetale, prefigurando la distruzione dell’intero orbe terraqueo.
La scomparsa
Ancora una volta all’arte è stato concesso il dono della profezia in virtù della quale si precorrono i tempi, si parla avanti e al posto di (questi, etimologicamente, sono i significati della parola profezia) e Mario Logli, per farlo, non poteva servirsi solo della Metafisica, che è astratta e mentale, ma doveva per forza penetrare nei meandri del sentimento, stimolando e trovando anche risposte emotive alla rappresentazione orrifica, per dare spessore alle sue denunce (ché tali sono le opere della serie degli Invasori), mai gridate però, perché lo strepito, l’urlo, l’epiteto non appartengono alla sua forma mentis, mentre gli è propria la riflessione meditata, l’idea, anche quando queste ultime sono suscitatrici di emozioni (l’inquietudine, la paura, il ribrezzo), come accade in questa fase espressiva. Il Surrealismo è poi lambito anche da un’altra serie di dipinti, quelli denominati Dopo i trionfi, nei quali l’artista sembra voler invitare alla riflessione sulla caducità della condizione umana. Così personaggi illustri – tratti dalla ricca iconografia storica urbinate – come il mitico Federico da Montefeltro, Sigismondo Pandolfo Malatesta, Federico Ubaldo detto Federichino, la Muta e via dicendo, dopo essere stati solenni e fieri dei loro meriti storici, si decompongono e si sgretolano sotto l’ingiuria del tempo. Una specie di concretizzazione, in immagine, dell’ammonizione che proviene dal mondo dell’oltretomba, “Hodie mihi, cras tibi. Perché nulla, nella storia, è imperituro ed eterno. Ecco un altro momento in cui, nel laboratorio sempre attivo dell’anima di Logli, sembrerebbe che la compostezza mentale venga, almeno in parte, messa in forse dal dinamismo sentimentale, che la regolarità e la lucidità dell’idea sia scossa, anzi scrollata, dalla fluttuanza e dall’imprevedibilità delle emozioni in libera
81 uscita. Tuttavia, nonostante questi due momenti di surrealtà pur importanti, la quasi totalità dell’agire pittorico di Logli si muove all’interno delle ipotesi metafisiche. Così la geometria, il fascino della Divina Proporzione, della Sezione Aurea, della matematica di Luca Pacioli e dei suoi solidi platonici (come il perfetto cuborombododecaedro, la sfera, la piramide, il poliedro in genere, nelle loro molteplici modulazioni) sono momenti di grande verità metafisica. Quanto lo è l’uovo, elemento alchemico per eccellenza, simbolo della reazione e della vita (si vedano, in tanti quadri di Logli, le forme ovoidali – come quelle poliedriche – che pendono dall’alto, al pari del magico e simbolico uovo dipinto lungo l’asse centrale della cosiddetta Pala di Brera di Piero della Francesca, corrispondente al volto ovoidale della Vergine, punto di fuga dell’intera costruzione prospettica. Come lo sono i labirinti, veri e propri schemi antropologici, simboli dell’esistenza umana che può uscire dalle limitazioni, dalle censure e dalle paure (Minotauro), mercé il filo di Arianna (arte, ideali, etica) che consente a Teseo (uomo) di ritrovare la via della speranza e dell’amore. Si può dire che il pittore di Urbino abbia creato opere nelle quali ha compiuto una svolta stilistica – ma anche ideale – piuttosto rilevante. Non rinunciando mai ad aprire quelle che proprio un illustre studioso recanatese, il compianto Franco Foschi, ebbe a chiamare le “finestre dell’anima” di Logli (comparate a quelle da cui Giacomo Leopardi derivava il piacere di “guardare il cielo attraverso una veduta confinata, una finestra appunto, una porta, una casa passatoia, perché da ciò nasce il desiderio d’infinito”), l’artista ha visitato quelle che lui stesso ha voluto definire “le stanze possibili della memoria”. Così ha iniziato
La fantasia creativa di Logli immagina figure meccaniche che minacciano la nostra coscienza e personaggi illustri che si sgretolano
In apertura del servizio alcune delle famose opere dell'artista Nella pagina a fianco, Dama di cuori anni ‘80, Mario Logli In alto, Armando Ginesi con l'artista Qui sopra, Città sognata
La scomparsa
Non si può leggere Logli senza considerare l’influenza nella sua pittura della Metafisica e del Surrealismo
Qui sopra, Il Cavalier dello Speron d'Oro del Ducato di Urbino, 1982
82
un nuovo modo di raccontare attraverso una sintesi per immagini nelle quali Recanati sostituisce Urbino, in cui le icone del sublime poeta si accostano a quelle dell’ indimenticabile tenore Beniamino Gigli, anch’egli recanatese Così la realtà della memoria si fa mito e il sogno sembra tramutarsi in realtà. Cadono le barriere tra verità e finzione onirica, mentre fenomeni di spiazzamento si alternano e convivono. Recuperando il tema delle Isole volanti, ove Urbino viene “sradicata dalla terra marchigiana, in volo nel cielo, su una nuvola bianca, una culla d’ovatta, morbida, affettuosa o fantastica nel tramonto della sera quando nell’anima affiora l’ancestrale paura del buio” (Silvio Locatelli), il pittore fa volare Recanati, la stacca da terra – dove resta una voragine di forma corrispondente, come dire il suo vuoto contenitore, la sua teca - e la solleva verso l’alto, nel cielo solare o notturno. A proposito delle Isole volanti, quasi tutta la letteratura critica parla di isole che se ne vanno chissà dove, che volano via dall’esistente. E se invece esse semplicemente si alzassero non tanto da perdere il contatto con la terra, ma in modo sufficiente per guardarla dall’alto, estrinsecando il desiderio dell’artista di una verità più alta e di un destino migliore ? E se fossero il traslato iconico di una volontà di ascensione – anche in senso religioso, perché no? – verso una localizzazione che stia “oltre”, magari che assomigli alla “Gerusalemme celeste”, immaginata attraverso il filtro del ricordo delle rocche della sua esistenza (quelle nelle vicinanze di Urbino, di San Leo e di San
Marino) che affiora dai sotterranei della sua memoria personale. Ma in che cosa consiste la svolta stilistica? Nel rinunciare, in parte, all’icasticità, alla definitezza, alla nettezza del segno; nel pompare aria dentro le dipinte atmosfere metafisiche rarefatte; nel rinunciare parzialmente alla chiarezza del vero pensato e visto per sostituirlo con la vaghezza, con lo sfasamento, con la provvisorietà delle icone poeticamente sognate; nell’abbandonare una pittura a pennellate tirate e a superfici cromaticamente lisce per collocare al loro posto una materia del pigmento di colore più approssimata ma più vibrante, proiezione di un minor pensare rispetto ad un maggior sentire; nell’accentuare gli spiazzamenti dovuti agli accostamenti di realtà inconciliabili dal punto di vista razionale, come i solidi geometrici conviventi con le icone evanescenti, con le vibrazioni cromatiche, con un disegno che a volte si presenta icastico e chiaro e a volte si trasforma in pittura materica. Forse questa serie appositamente creata per Recanati, per Beniamino Gigli, ma in definitiva anche per Giacomo Leopardi e per l’alone poetico che avvolge il bel centro collinare del maceratese, definisce un nuovo momento espressivo della lunga avventura pittorica di Mario Logli. Un momento nel quale il sentimento tende a prevalere sull’idea, la suggestione emozionalmente dinamica di una figurazione semi-espressionistica a sorpassare quella astrattamente statica della Metafisica, il pensare e il sentire a farsi modalità più vicine tra loro fino, talvolta, a fondersi . ¤
L’artista racconta l’artista
83
Angeli ribelli di Licini messaggeri cosmici OSCAR PIATTELLA NARRA IL PITTORE MARCHIGIANO
S di Oscar Piattella
iamo nel 1958. Osvaldo Licini viene premiato alla Biennale di Venezia. Ha 64 anni. Poco dopo, la tragedia della sua morte. Egli, con quel premio internazionale è considerato come una cerniera che segna il passaggio dall’arte informale alle nuove e febbrili ricerche degli anni successivi. Sempre nel 1958 la Galleria dell’Ariete a Milano, diretta da Beatrice Monti, organizza una mia personale. Avevo 26 anni. Le mie radici erano ben salde in quel crogiuolo degli anni ’50, anche se più per le idee di fondo che per i risultati ed esiti formali: la mia pittura è stata sempre costruita strutturando chiaramente la superficie. Quel mondo delle materie, dei “gesti”, della totale cancellazione della figura ormai si stava esaurendo. C’era nell’aria come una necessità di orientare le urgenze dell’arte più verso i problemi della “pittura dipinta”, di reinventarsi un rapporto nuovo tra vita e pittura, cercare un’ansa dove far approdare la volontà di potenza per ricostruirne un senso.
Osvaldo Licini aveva già iniziato questo viaggio nei primissimi anni ’30. Monte Vidon Corrado era il paese dove abitava e mi piace pensare ora che non fosse troppo lontano da me. Era nota la sua storia, la sua figura, la sua pittura, ma dopo il prestigioso premio emerse e partì come uno dei suoi famosi “missili”. Ricordo che qualche anno prima vidi due sue opere esposte in una collettiva di cui anche io facevo parte. Era in un paese delle Marche ma non ricordo quale fosse. Assalito da mille dubbi, immerso in quel clima di incertezze a cavallo tra gli anni ’50-’60, mi avvicinai alla sua pittura germogliata quasi miracolosamente a pochi chilometri da me. Una pittura discreta, ma chiara di luce interiore e non così conosciuta come avrebbe meritato. Notai subito che le sue opere nascondevano in filigrana quel rapporto forte con il paesaggio, espresso figurativamente fino alla fine degli anni ’20: a 32 anni aveva deciso di risiedere in maniera definitiva nella sua casa a Monte Vidon Corrado, suo paese natale. Un ritiro per indagare lontano dal mondo i misteri della pittura? Egli era lassù, come un dio sulla sommità dell’Olimpo, io a 26 anni sprofondato invece in un clima di ricerca, a Cantiano, ai piedi del Monte Catria, per me sacro perché evocava la Sainte Victoire di Cézanne. Osvaldo Licini aveva fatto scelte coraggiose, indagando le forme della sua terra e la profondità del suo cielo, lontano da quelle esperienze parigine che lo avevano formato; egli fece della riflessione sulla pittura l’unico scopo della sua vita e fu
L’artista racconta l’artista
Licini è considerato una cerniera che segna il passaggio dall’arte informale alle nuove e febbrili ricerche degli anni successivi
per me un maestro di profonda moralità per la concreta determinazione del suo pensiero riguardo la realtà e l’essenza dell’arte. In quegli anni di crisi per me capii subito che questo artista mi avrebbe potuto aiutare a risolvere i problemi di quel momento e a rivedere il lavoro che stava vacillando nonostante avessi già raggiunto dei risultati di una certa importanza. Non volevo riferirmi soltanto alle sue opere, anche se poi è da qui che ha avuto inizio l’esame critico, storico, formale, ma a quelle situazioni che ritengo appartengano a quel secondo tempo della pittura che custodisce i segreti e le storie più personali se non addirittura più intime della vita dell’artista, che lo fanno essere là, sulla “terrazza” della propria casa, mentre sogna di iniziare la scalata verso il cosmo, inconsapevole di ciò che lo muove. Non ero anche io lì, con quelle geometrie che esprimevano un suo desiderio di astrazione, con quelle forme antropomorfe che fluttuavano nello spazio, lontane dalla geometria della tradizione? Forse talvolta anche Licini faticava a rendere nei suoi dipinti la vastità della sua visione cosmica? Ma il cosmo che è arrivato a intrigare la mia pittura non ha un’altra origine? Pensando alla geometria come una componente importante del nostro percorso, la differenza la diceva bene Antognini nella sua antologia “Scrittori marchigiani del Novecento” pubblicata nel 1971, quando nel retro di un mio disegno commentava: «nei suoi quadri, non è licinianamente, la geometria che diviene sentimento, ma il sen-
84 timento che diviene geometria… dove sentimento va inteso come vibrazione poetica, adesione emotiva alle cose». E forse non è solo così, perché il cosmo di Licini nasce dal suo sguardo immaginante, il mio dall’impossibilità di poter immaginare ciò che forse è proprio così: cioè il cosmo che ora tesse le trame del mio mondo affonda le radici in scoperte scientifiche di grande attualità che sorprendono la mia ragione e destabilizzano la mia immaginazione. Quello di Licini è una vasta dilatazione della sua stessa figura che, avvolta da un magnetismo ipnotico, provoca la risonanza di profondità celesti illuminate da argentei bagliori lunari: tutto avviene come su un palcoscenico teatrale illuminato da mirabili luci. Ma, forse l’amore per quel cielo notturno intriso di tutti i blu più densi e trasparenti, per quei metafisici “azzurri-cobalto-oltremare” della luce del giorno, l’amore totale per quello spazio curvo sopra di lui, altrettanto fisico come quei fili di terra che lo sostenevano, quell’amore, lo tratteneva dal volare ancora più in alto, oltre la convessità del cielo? L’amore per la sua terra insomma, quasi sempre accennata con un filo di colore compatto o espressivo, con una linea retta o ondulata, frangiata, alla base dell’opera, l’amore per quell’evidenza in parte sognata, era talmente immenso da indurlo a rischiare di non poter dire l’assoluto del cosmo, di non poterlo esprimere, quel cosmo, in tutta la sua “reale” astrazione, in tutta la sua limpida, cristallina sorgenza? Perché è evidente che così, lo spazio (il cosmo), perché abitato sconfina nella figurazione, nella narrazione! E allora il mio sguardo che cosa cercava in quei fondi dilatati o pressati, abitati da “ospiti” come pilastri di una geometria ordinatrice, in quei fondi che sembravano conferi-
L’artista racconta l’artista
re un significato plastico nuovo alla pittura? Ero ammirato da quelle vibrazioni cromatiche, da quelle variazioni semplici per l’aggiunta di quantità minime di colore ogni volta diverso da quello fondamentale, a dire così che ogni più piccola frazione, ogni centimetro di quel “creato” ha un suo proprio sospiro, una sua propria parola appena bisbigliata. Lì cercavo il secondo tempo di ogni elemento, il motivo della sua scaturigine. Ma da dove nasceva il discreto andamento di quelle linee che qualche volta erano mondo e qualche altra volta geometria? Avanzavo con un forte desiderio di poter comprendere l’evidenza di ogni “corrugazione”,
tori di sé stessi. L’afasia non aiuta a capire ciò che preme nel nostro cuore. La solitudine può aiutare a fare più profondi i nostri pensieri, ma può farli anche sprofondare nel buio del niente. Voglio dire che non dovrebbe esistere opera dove non accade nulla: ciò che accade, il pittore vuole che venga all’aperto. Non dice così Licini? Il pittore di Monte Vidon Corrado, in quel mio frangente, mi trasferiva la sua intransigenza dichiarata con fermezza e severità, ben visibile nell’espressione minacciosa dei suoi angeli volanti. Ma erano volanti o forse in tensione, più sentinelle del suo “MONDO Vidon Corrado” che angeli di un mondo surreale, metafisico,
di ogni ripensamento: quelle inceppature conservavano la naturale qualità di ogni artista che non fa fatica a mantenere nei suoi occhi quel colore e se lo costringessero a esprimersi con un semplice segno, quel segno, quell’accenno, quel rivolo nero di grafite rivelerebbero tutto il suo mondo poetico, la materia di cui è fatta la sua carne. Era talmente dichiarata la “naturalità” della pittura che ogni minimo intervento per portare a compimento l’opera non sembrava eseguito da alcuna mano, ma nato lì, per necessità propria, come un bellissimo fiore che nessuno ha piantato. E così nascono i suoi angeli volanti su quei vasti scenari, messaggeri cosmici, interlocu-
primordiale? Primordiale era la sua pittura! Apparteneva, io dicevo, al prima dell’origine. Ma allora, le amalassunte, le numerose splendenti amate lune non erano tutte autoritratti? Ma non è sufficientemente chiara la rassomiglianza con alcune fotografie e soprattutto con quelle degli ultimi anni fatte nel suo alto nido? Sì, mi dicevo, perché l’opera dell’artista se è tale deve essere soprattutto anche il suo ritratto. Era sempre più evidente qual era l’eredità che dovevo estorcere alla sua pittura, alla sua figura, ai suoi anni per il mio nuovo inizio: il suo sguardo, la sua profondità che sezio-
85
C’era nell’aria una necessità di orientare le urgenze dell’arte e di reinventarsi un rapporto nuovo tra vita e pittura
In apertura del servizio Angelo ribelle con il cuore rosso A sinistra in alto, lo studio e sotto Osvaldo Licini con l'olmo Qui sopra, la camera dell'artista con l'archipittura e un particolare dei suoi materiali di pittura e disegno
L’artista racconta l’artista
Osvaldo Licini aveva fatto scelte coraggiose indagando le forme della terra e la profondità del suo cielo
Sopra, Amalassunta Luna olio su tavola, Lendinara collezione privata
nava ogni porzione di realtà, la sua tensione quotidiana, la concentrazione sul tessuto della pittura. Era poi la parola, l’intervento della parola altra, emblema, metamorfosi della poesia, mito dichiarato “plasticamente”, immersa, recitante tra gli altri attori silenti ma non muti, lì, come fari all’estremità di un molo a salvare vite dal buio di un “mare” in tempesta. Ma la scontrosa, irriverente parola “merda” sparpagliata come poche altre sulle sue tele, e in disegno su una infinità di carte d’occasione, non ha assonanza con la romantica parola “mare”, quella strisciolina blu-cobalto che pur si deve scorgere da qualche cima dei Sibillini e del Monte Catria? Licini mi insegnava che è questo che deve fare la pittura con la sua parola sempre all’inizio e sempre sottaciuta. Sì, è necessario perché è la nominazione che estrae dalla realtà la parte astratta in lei nascosta, che toglie all’evidenza la sua scorza visibile e la ri-vela non
86
tanto per darle un più di senso ma per concedere a ciascuno la libertà e la propria visione del mondo. Ecco, al di là di tutte le interpretazioni della pittura e dei modi di Licini, essi mi invitavano a un’amicizia spontanea portandomi a pensare che proprio la sua pittura aveva la forza di farmi essere lì senza esserci mai stato, lì, al centro di ciò che è rimasto, tolta la fatica, il sacrificio, il rischio, per un risultato di cui perdevo continuamente il senso. Al di là delle considerazioni formali, erano questi i pensieri che la sua vita mi ispirava, ciò che la sua cima mi suggeriva da lassù e dai sentieri della sua pittura. Voglio dire ora che l’opera stessa, nonostante la sua bellezza, non poteva che essere svelata se non per mezzo di una parola severa, con il farsi poetico della sua esistenza. Era da lì, da questa voluta amicizia e attraversando il suo spazio che dovevo essere accompagnato lungo la mia via. Non è stato così semplice riprendere il largo dopo l’approdo nel solco di Licini. Ma ora lo ritrovo soprattutto nella consonanza dei nostri sentimenti che Goethe spiega con “affinità elettive” e nella comunanza dei nostri boscosi e riservati Appennini, da dove si può scorgere ancora un filo di mare cobalto-pallido, non tanto nell’illusione di non aver patito il confino, o di una mai perduta libertà, ma per la convinzione che da queste nostre cime la linea sognata di quell’orizzonte è sufficiente ad assicurarci il senso dell’incompiuto così dello spazio come del tempo che appartengono sia all’atto della pittura che al compiersi della nostra vita. ¤
Le mostre
87
I paesaggi liciniani morbidi profili fermani UN TEMA MOLTO CARO ALL'ARTISTA MARCHIGIANO
S di Daniela Simoni
i inaugura il 27 giugno (fino all’1 novembre) a Monte Vidon Corrado “La regione delle madri”, una grande mostra sul paesaggio nell’arte di Osvaldo Licini, promossa dalla Regione Marche e organizzata dal Comune di Monte Vidon Corrado e dal Centro Studi Licini. I luoghi hanno sempre un particolare significato in relazione all’arte: basti pensare a ciò che rappresenta Giverny per Monet o Aix-en-Provence per Cézanne, o ancora ad Arles per Van Gogh. L’arte di Licini si sostanzia della suggestione del paesaggio marchigiano, del suo paesaggio. In quella che oggi è la casa museo Osvaldo Licini, nella piazzetta in cima al cocuzzolo su cui è arroccato il paese, Li-
cini era nato il 22 marzo 1894 da una “famiglia di contadini proprietari”, come scrive nel questionario Scheiwiller nel 1929. Qui i genitori da bambino l’avevano inspiegabilmente lasciato alle cure del patriarca, il nonno paterno Filippo una volta trasferitisi a Parigi, tenendo con loro la sorella Esmeralda nata due anni dopo di Osvaldo nella ville lumiere. Il nonno Filippo era perito agronomo e aveva avuto la capacità di cogliere il suggerimento datogli dal maestro di Osvaldo riguardo le sue doti artistiche e di farlo iscrivere all’Accademia di Bologna. A Monte Vidon Corrado Osvaldo torna durante le pause estive negli anni dell’Accademia di Bologna e qui nel 1913 scrive i
Le mostre
Nella “regione delle madri” un’esposizione al Centro studi e Casa museo con 90 oli e 30 disegni
Nella pagina precedente Colline marchigiane, olio su tela Comune di Moncalvo Qui sopra un intenso ritratto dell'artista A destra dall'alto Personaggio, olio su tela collezione M. Carpi, Roma e Paesaggio, (con interventi successivi) Monte Vidon Corrado Casa Museo Osvaldo Licini
88 Racconti di Bruto. Poi, dopo il periodo dell’Accademia di Firenze, la chiamata alle armi, il ferimento sul Podgora inizia un decennio in cui Licini, dal 1917 al 1926 si divide tra la Francia e le Marche, lì frequentando il vivace ambiente artistico parigino, esponendo al Salon d’Automne, al Salon des Indépendent, alle Cloiserie de Lilas, incontrando nei caffè di Montparnasse Picasso, Cocteau, Modigliani, al suo paese frequentando gli amici del cenacolo intellettuale fermano, i Catalini, Acruto Vitali, insegnando alle scuole tecniche di Fermo e finendo nei guai per amore della giovane Ave. Nel 1925 conosce al Cafê du
Dôme di Parigi la giovane pittrice svedese Nanny Hellström, originaria di Göteborg che era lì per studiare all’Académie Julian e seguiva le lezioni di André Lothe. Per lei è amore a prima vista, i due si fidanzano. Ed è lì, nella casa di famiglia, che torneranno nel 1926 per sposarsi il 20 dicembre di quell’anno e condividere l’isolamento in un luogo caratterizzato da una dimensione di arcaica naturalità. A trentadue anni Licini dunque compie la sua scelta con un atto di assoluta libertà: Monte Vidon Cor-
rado è per lui il luogo della creazione. Quel silenzio, quel paesaggio che ha impressa la medesima cifra cosmica delle leopardiane colline recanatesi, la scansione del tempo dettata dall’avvicendarsi delle stagioni e dai lavori agricoli come nei portali delle cattedrali medievali, creano la condizione favorevole per assimilare e rielaborare in una personalissima sintesi le suggestioni letterarie, filosofiche, pittoriche che coglieva attraverso letture, scambi epistolari con amici intellettuali, viaggi in Europa, visite a mostre e siti artistici. “Adesso guardiamo dalle finestre crescere la primavera e i cambiamenti rapidi del cielo e dei verdi, e ci divertiamo come a teatro” scrive Osvaldo Licini all’amico Felice Catalini il 5 aprile 1932, includendo in quel plurale la condivisione con sua moglie della fascinazione per il paesaggio marchigiano, tema dominante nella fase figurativa, in quella astratta e nel figurativismo fantastico. Nei dipinti di Licini degli anni venti il paesaggio è uno dei generi più frequenti: il morbido profilo delle colline fermane, le pezzature agricole sovrastate dall’azzurro del cielo, la pura geometria delle case coloniche sono rese attraverso un’elaborazione interiore e una cifra pittorica influenzata della lezione di Cézanne, Van Gogh, Matisse. Negli anni trenta la levità che già era emersa nei paesaggi del decennio precedente, la linea obliqua delle colline, l’essenzialità cromatica vengono sublimate in forme geometriche astratte, come “Il bilico”, nelle liriche geometrie nate dal sentimento. Le enigmatiche creature che viaggiano nei cieli dei dipinti liciniani del figurativismo fantastico, elaborate negli anni quaranta e cinquanta, campeggiano tutte sopra l’orizzonte notturno trac-
Le mostre
ciato dei Sibillini, così come lo si vede da Monte Vidon Corrado. Le Amalassunte, i Personaggi, gli Olandesi volanti, gli Angeli ribelli e quelli aquilone nascono dalla visionarietà poetica di Licini che costantemente si lascia ispirare dalla suggestione del paesaggio natìo. In continuità con l’attività espositiva del Centro Studi Licini, intrinsecamente legata ai progetti di ricerca e di approfondimento riguardo la conoscenza della figura e dell’opera dell’artista, questa mostra è la prima interamente legata al genere del paesaggio nel percorso liciniano. La rassegna - curata da Daniela Simoni, da tredici anni alla guida del Centro Studi, in collaborazione con Stefano Bracalente, Nunzio Giustozzi, Stefano Papetti, Mattia Patti, Massimo Raffaeli - indaga il rapporto tra Licini e il paesaggio marchigiano, le vedute francesi e quelle svedesi, le fonti pittoriche e quelle letterarie, il paesaggio descritto nelle lettere e quello disegnato o dipinto, l’interiorizzazione del paesaggio fino alle proiezioni cosmiche degli ultimi anni. L’esposizione costituisce inoltre occasione per riflettere sulla cronologia delle opere degli anni venti e per pubblicare documenti inediti importanti per comprendere il passaggio alla fase del figurativismo fantastico. In mostra anche alcune opere mai esposte prima come il Paesaggio italiano (1921) del Centre Pompidou, e altre raramente presenti nelle rassegne degli ultimi anni come le Colline marchigiane (1927) del Comune di Moncalvo, Paesaggio marchigiano (1925) di collezione privata, Personaggio (1945) e Studio per angelo su fondo giallo (1956) della collezione M. Carpi. La gestazione delle opere del figurativismo fantastico affonda le radici nell’adesione per la prima volta effettiva da parte dell’eretico Licini a
89 Valori Primordiali, il movimento del teosofo e studioso di filosofie orientali Franco Ciliberti fondato su una metafisica spiritualistica che fondeva diversi orientamenti, pitagorismo e neoplatonismo, la concezione archetipica junghiana e il mito, il tutto finalizzato a ricercare “il primordio della civiltà contemporanea”. La definizione “La regione delle madri” che compare nel titolo della mostra è desunta da una lettera che l’artista scrive a Ciliberti nel 1941 descrivendo in chiave simbolica la gestazione delle sue creature fantastiche. La mostra, che comprende circa 90 oli e 30 disegni, si articola nelle due sale del Centro Studi, nella sala al pian terreno della Casa Museo dove Licini teneva le opere ultimate e negli spazi espositivi della cantina. Al Centro Studi saranno esposti i dipinti figurativi degli anni venti: paesaggi, marine italiane e francesi che sono sempre espressione dell’elaborazione interiore del dato reale. Nella Casa Museo, che per l’artista è stata “laboratorio di arte sperimentale”, si entrerà simbolicamente nella “regione delle madri”, nella “landa dell’originario”. Qui, sulla base di quella che Birolli definisce “temporalità circolare” nell’arte di Licini, saranno allestiti dei percorsi che, partendo ciascuno da un dipinto figurativo, accompagneranno il visitatore attraverso la fase geometrico-astratta e quella del figurativismo fantastico, indagando la sostanza geometrica, la cifra dell’enigma, lo sguardo sui Sibillini, i microcosmi liciniani, l’antropomorfizzazione del paesaggio fino all’epifania degli angeli ribelli. In catalogo, edito dalla casa editrice Electa, contributi di Daniela Simoni, Stefano Bracalente, Mattia Patti, Bianca Lucia Maglione e Stefano Papetti. ¤
Monte Vidon Corrado è per l’artista il luogo della creazione in cui rielaborava le sue suggestioni culturali
Le mostre
90
Oscar Piattella disgregazione e unità
A
In alto, Piccolo muro e cielo rosso 1959, materiali vari su tela di seguito Polittico per Pesaro acrilico su tavola Nella foto più grande l'artista mentre lavora nel suo studio
d uno straordinario artista sperimentatore quale è Oscar Piattella (1932) è dedicata la mostra alla Pescheria di Pesaro (fino all'11 ottobre 2020). L'olio su tela del 1955, posto a chiusura del catalogo di mostra, svela in nuce la precoce intuizione del tema del muro che nel volgere di pochissimi anni subisce una elaborazione in grado di condurre alla felice, matura serie esposta nel 1957 alla Galleria l'Ariete di Milano, con l'autorevole introduzione di Franco Russoli. Sono anni densi di confronti che ampliano gli orizzonti in una dimensione internazionale, e che portano rapidamente verso un'espressione compiuta ed originale. Nel nuovo Millennio, il suo cammino sapienziale lo ha condotto in una dimensione spirituale da dove si può partire per immaginare le forze dell'universo: così le sue tavole si sono popolate dapprima di stelle ed infine dei segni degli spazi cosmici. In questa rinnovata fase, in cui ha saputo trovare una nuova sorgente creativa gli è stato di grande aiuto l'essere tornato a ragionare su-
gli esempi del Rinascimento matematico urbinate. Da qui ha tratto insegnamenti che attengono le ricerche sulla profondità e lo spazio. Il rigore con il quale egli progetta ogni sua opera fin nei minimi dettagli, il ricorso alla matematica e all'emersione del "fraseggio geometrico", si allenta e scompare con l'immissione del colore sulla tavola. A condurlo è una magistrale padronanza delle tecniche e l'aver saputo sviluppare ulteriormente e raffinare equilibrio formale e armonia cromatica. Quell'ipnotico rincorrersi di punti, di linee, di quadrati, di rombi, di onde in armonica alternanza cromatica cela un lavoro duro e senza tregua che magistralmente sfuma sui bordi in un non finito, che ha la potenza del rimando all'infinito universo. Più ci si pone con occhio libero dinanzi alle opere dell'ultima produzione di Piattella, più cresce la sensazione che si stia entrando in un territorio di confine, un fertile inesplorato spazio liminare della pittura; di una pittura autentica, capace di emozionare. Alberto Mazzacchera
Il personaggio | 1
91
Cecco d’Ascoli, una vita tra scienza e mistero UNA ESISTENZA ECLETTICA, AVVOLTA NELLA LEGGENDA
L di Alberto Pellegrino
Fu poeta, filosofo scienziato, astrologo e astronomo avvolto da leggende come quella di essere stato partorito in un prato
a vita avventurosa di Cecco d’Ascoli, poeta, medico, filosofo, scienziato, astronomo e astrologo, è per molti aspetti avvolta nel mistero, poiché la conoscenza delle diverse fasi della sua esistenza e di alcuni specifici avvenimenti deriva da fonti contrastanti e spesso inquinate da riferimenti leggendari. Il destino di Cecco è segnato dalle fiamme del rogo e dalla damnatio memorie imposta dalla Chiesa, che ha proibito la lettura, la diffusione, la riproduzione a mano e, più tardi, a stampa dei suoi libri. Su queste opere è calato per circa sei secoli un silenzio tombale, per cui si ritornerà a parlare di questo autore solo nei primi anni dell’Ottocento. Eppure la sua vicenda umana, affascinante e tragica, ha un’importanza fondamentale per la storia del Medioevo, perché Cecco d’Ascoli è un personaggio del suo tempo per quanto riguarda l’astrologia e alcune conoscenze scientifiche, ma è un intellettuale dei tempi nuovi, quando afferma che l’uomo è al centro dell’universo, che l’amore per il sapere rappresenta la vera nobiltà dell’uomo. Francesco Stabili detto Cecco d’Ascoli nasce ad Ancorano di Ascoli intorno al 1269 da un certo Simone che sembra fosse un ricco mercante di tessuti. Cecco, fin da adolescente, studia filosofia, teologia, matematica, scienze naturali, astronomia e astrologia. Nel 1287 entra nel Monastero di Santa Croce ad Templum di Montefortino, dal quale si allontana dopo due anni probabilmente per divergenze dottrinali. Successivamente sembra di sia andato a studiare medicina presso la Scuola
Medica Salernitana, la prima e la più importante facoltà di medicina d’Europa, dove s’insegnavano non solo le scienze mediche e la chirurgia, ma anche teologia, filosofia e diritto. Ritornato ad Ascoli, vi rimane poco tempo prima d’intraprendere la sua vita errabonda e avventurosa, mantenendo un immutato amore per il luogo natale che chiama “Oh madre bella, oh terra mia asculana”. Cecco non è altrettanto benevolo verso i suoi concittadini che condanna per i loro vizi e peccati: “Oh Ascolani, uomini incostanti, /Tornate ne li belli atti lucenti…/Ché da lo cielo siete ben disposti... /Oh bel paese co li dolci colli! / Perché no ’l conoscete, o gente acerba, /Con gli atti avari invidiosi e folli?/Io te pur piango, dolce mio Paese;/Ché non so chi nel mondo ti conserba,/Facendo contro Dio cotante offese” (L’Acerba, Secondo Libro). La leggenda di Cecco e la magia La vita di Cecco rimane sempre avvolta da un alone di mistero che deriva dalle diverse leggende nate intorno alla sua persona durante la giovinezza trascorsa ad Ascoli. La prima leggenda (riportata da Angelo Colocci) riguarda sua madre, che avrebbe praticato i culti e le cerimonie orgiastiche in onore della Dea Ancaria, protettrice degli animali e venerata dai Piceni al pari della romana Diana. Persino Cecco sarebbe stato partorito su un prato, dove un tempo sorgeva il tempio dedicato alla dea. Un’altra leggenda riguarda direttamente il poeta, che avrebbe costruito in una sola notte con l’aiuto del Demonio quello
Il personaggio | 1
Nel suo soggiorno a Firenze si narra di un leggendario diverbio con Dante sui contenuti della Divina Commedia
92 che ancora oggi si chiama il Ponte di Cecco o del Diavolo, una costruzione di epoca romana che scavalca il torrente Castellano. La fantasia popolare considera Cecco un negromante e questa nomea di praticare la magia nera lo accompagnerà per sempre, traendo origine da una pergamena del 1297, conservata nell’Archivio comunale di Amandola, nella quale il Priore del Monastero di S. Leonardo presenta a un giudice di Macerata una denuncia contro Francesco Stabili accusato di aver commesso dei “malefici”. Si ritiene che egli frequenti il lago di Pilato, considerato “consacrato ai demoni” e un luogo di riunione per i negromanti, mentre in realtà Cecco condanna i riti magici: “Ti voglio dir come nel foco /Fanno venir figure i piromanti…/con l’ossa delli morti i negromanti,/con l’acqua gli idromanti son congiunti…/ Questi maligni spiriti che sanno/Delli elementi le virtù celate…/Sicché, chiamati con li lor tributi/D’umano sangue e con morti gatti,/con unghie, capelli, e altri vuti,/e con le dinà, carne, mirra e ‘ncenso/con olio d’aloè e altri patti/fanno questi atti” (L’Acerba, Quato Libro). Il primo soggiorno fiorentino
Qui sopra, un ritratto di Francesco Stabili dellto "Cecco d'Ascoli A destra in alto, il ponte dedicato allo scenziato, poeta e astrologo A seguire, la statua a lui dedicata
Verso la fine del Duecento Cecco d’Ascoli arriva a Firenze, una città che è diventata uno dei più importanti centri economici italiani e ha visto emergere la “gente nuova” costituita da artigiani, mercanti e banchieri, si tratta di una élite degli affari e delle professioni che vuole limitare il potere della nobiltà di origine feudale e pretende di partecipare al governo cittadino, che viene esercitato nella nuova istituzione denominata Consiglio dei Priori delle Arti. Cecco d’Ascoli sceglie Firenze perché attratto dalla straordinaria fioritura di artisti e di
letterati come i poeti del Dolce Stil Novo, che formano la setta dei Fedeli d’Amore e scrivono componimenti poetici sul modello dei trovatori provenzali, nei quali la donna “angelicata” diventa oggetto di un amore spirituale che nobilita l’animo del poeta. Cecco entra probabilmente in relazione con questi ambienti letterari, anche se mostra di non condividere i loro modelli culturali e poetici. È in questo periodo che sarebbe nato il leggendario diverbio tra Cecco e Dante, un dissidio non certo determinato dall’invidia o dal mancato apprezzamento per la Divina Commedia (Gianfranco Contini è arrivato a definire L’Acerba “l’Anti Commedia”), ma dal fatto che l’Ascolano, pur riconoscendo il valore dell’Alighieri, non condivide i contenuti del suo poema che colloca personaggi e avvenimenti in una dimensione ultraterrena. Cecco è un razionalista ed ha una diversa visione scientifica, filosofica e teologica del mondo, per cui nell’Acerba si limita a prendere le distanze da Dante, quando afferma che nel suo poema “non si canta al modo de le rane,/Qui non si canta al modo del poeta,/Che, immaginando, finge cose vane./Ma qui risplende e luce ogni natura,/ Che a chi intende fa la mente lieta;/Qui non si sogna per la selva oscura.../Non veggo qui squartare a Dio le fiche;/lascio le ciance e torno su nel vero/ Le favole mi fur sempre nemiche”. Cecco è lontano da quella cultura rigidamente codificata secondo il modello enciclopedico del Tesoretto di Brunetto Latini, perché è l’esponente di un realismo scientifico che, agli inizi del Trecento, sta aprendo nuovi orizzonti e sta logorando il rapporto tra teologia e filosofia. Infatti, è uno dei primi a cogliere la necessità di una separazione tra scienza e fede, la cui unione ha finora consentito alla Chiesa di guidare la cultura e di con-
Il personaggio | 1
trollare le coscienze. Rispetto ai poeti stilnovisti, egli ha una diversa concezione dell’amore e della donna, argomento cui dedica il capitolo IX del Libro IV del suo poema, rifiutando l’amore aristocratico dei trovatori provenzali e l’amore angelicato dei toscani. Per lui l’amore è bello e nobile; è un fatto naturale se nasce da una favorevole disposizione delle stelle, mentre diventa turpe e volgare quando si allontana dalla pratica della virtù. Esiste pertanto un amore celeste secondo il quale la Donna è il simbolo della bellezza e della conoscenza ed esiste un amore terrestre che è un’unione indissolubile di corpo e anima, di virtù e peccato, che può diventare una sfrenata passione, riducendo la donna una “Femmina” dove confluiscono tutti i mali del mondo. Cecco d’Ascoli a Bologna Secondo una tradizione non confortata da una documentazione storica, Cecco avrebbe lasciato Firenze nel 1309 per trasferirsi nel 1311 a Parigi per esercitarvi la professione medica, entrando nella cerchia del grande medico pavese Guido di Stazio degli Alberghetti. Nel 1314 Cecco è presente nella città di Bologna, sede di una delle più celebri università europee, dove conquista in breve tempo una notevole fama di astrologo e di medico. La sua arte divinatoria gli assicura la stima del popolo e dei rappresentanti della classe politica, che sono soliti consultarlo prima di prendere importanti decisioni sul governo della città. Secondo alcune fonti, sembra che nel 1316 Cecco venga chiamato ad Avignone per curare il papa Giovanni XXII ammalato di podagra. Nel 1317 risiede sicuramente a Bologna, dove trova un ambiente ostile creato dall’illustre. medico fiorentino Dino Del Garbo. Nel 1324 gli stu-
93 denti lo eleggono docente di medicina e nello stesso periodo Cecco inizia a comporre L’Acerba e a scrivere diversi trattati di astronomia, astrologia e medicina. A questo punto Dino Del Garbo denuncia l’a-
scolano per le sue teorie e l’Inquisitore Lamberto da Cingoli apre un’inchiesta, dopo avere ascoltato alcune sue lezioni e la testimonianza di alcuni studenti. Sulla base degli elementi raccolti, il Tribunale dell’Inquisizione processa e condanna il 16 dicembre 1324 Cecco d’Ascoli per eresia. La sentenza impone la pena di una confessione generale, la recita quotidiana di trenta paternostri e avemarie, il digiuno ogni sabato per un anno, l’ascolto domenicale della predica nella Chiesa dei Frati minori, il sequestro di tutti i libri, il pagamento di settanta libbre di monete bolognesi e l’allontanamento a tempo indeterminato dalla cattedra universitaria. Cecco decide allora di lasciare Bologna, vista l’ostilità degli ambienti ecclesiastici e politici determinata anche dal fatto che egli si sarebbe schierato a favore del partito ghibellino contro la Curia romana, sostenendo i diritti delle istituzioni popolari e le rivendicazioni degli strati sociali più deboli. Nel 1327 Cecco d’Ascoli accetta la nomina di astrologo e medico di corte da parte di Carlo Duca di Calabria, che nel 1325 è stato proclamato signore di Firenze. Cecco ar-
Francesco Stabili detto Cecco è un razionalista con una diversa visione scientifica filosofica e teologica del mondo
Il personaggio | 1
Nel periodo bolognese Cecco conquista una notevole fama di astrologo e di medico; venne chiamato a curare il Papa ad Avignone
94 riva in città preceduto dalla fama di uomo esperto nella “scienza d’astronomia, ovvero di negromanzia”, dotato della capacità di predire “molte cose future, le quali si trovarono poi vere”, come scrive lo storico fiorentino Giovanni Villani. L’Ascolano è convinto che attraverso gli astri si possano studiare le forze che regolano l’universo, che influenzano la vita e la salute degli individui, che sia possibile conoscere il futuro, leggendo correttamente i segni scritti nel cielo. Questa proclamata capacità divinatoria è la sua principale credenziale presso Carlo d’Angiò, il quale nutre forti preoccupazioni a causa della guerra intrapresa contro i ghibellini guidati da Castruccio Castracane, seguace dell’imperatore Ludovico il Bavaro. Cecco gode anche della fama negativa di eretico, che fa nascere l’ostilità nel cancelliere di corte Raimondo vescovo di Aversa, a sua volta influenzato da Dino Del Garbo, che aspira al titolo di medico ducale. Alla ostilità del potere politico ed ecclesiastico si aggiunge, come riferisce un’anonima Cronaca fiorentina, il responso astrologico che il duca Carlo chiede a Cecco sul futuro della figlia Giovanna: dalla lettura degli astri l’Ascolano avrebbe sentenziato per quella bambina di due anni una futura vita “di disordinata lussuria” e questa previsione sarebbe stata accolta dal padre come un insulto. Il tempo, invece, avrebbe dato ragione a Cecco, perché quella bambina sarebbe diventata a Napoli la Regina Giovanna I detta la Pazza (1343-1381), che avrebbe sposato quattro mariti e condotto un’esistenza dissoluta fino ad essere scomunicata dal papa Urbano VI e finire strangolata in una congiura di palazzo. Il 31 maggio 1327 il poeta è arrestato e processato da un tribunale ecclesiastico per avere scritto “un trattato sopra la spera, mettendo che nelle opere di so-
pra erano generazioni di spiriti maligni, i quali si potevano costringere per incantamenti sotto certe costellazioni a potere fare molte meravigliose cose” (Giovanni Villani, Nuova Cronaca, Libro X, capitolo XL, 1322/1348). L’Inquisitore Accursio Bonfantini, arcivescovo di Cosenza, accusa Cecco di eresia per la sua dottrina astrologica, usando la quale lo scienziato avrebbe stabilito la data esatta della nascita e della morte di Gesù; avrebbe affermato che le stelle possono limitare il libero arbitrio, per cui gli influssi degli astri avrebbero condizionato la venuta sulla terra e le azioni compiute da Gesù durante la sua vita. Nonostante Cecco sostenga che nelle sue opere non vi sia alcuna traccia di eresia, il Tribunale dell’Inquisizione riconosce i suoi errori contro la fede e lo condanna al rogo. La sentenza viene eseguita il 16 settembre 1327 in Piazza Santa Croce e sembra che Cecco abbia gridato prima di essere arso vivo “L’ho detto, l’ho inse-
Il personaggio | 1
gnato, lo credo”, divenendo un martire del libero pensiero al pari di Giordano Bruno. Dopo la morte, tutti i suoi beni posseduti ad Ascoli, Macerata e Firenze sono confiscati; viene imposto il divieto di leggere, trascrivere e diffondere le sue opere e si ordina che i tutti suoi scritti siano bruciati. Agli altri protagonisti della vicenda non tocca una sorte migliore: il 30 settembre 1327 muore il suo nemico Dino Del Garbo, nel 1328 muore anche il Duca Carlo di Calabria e immediatamente si diffonde la leggenda che queste morti sarebbero state provocate da un incantesimo di Cecco per vendicarsi di tante persecuzioni. L’eredità di Cecco d’Ascoli. Nonostante alcune sue convinzioni scientifiche possano oggi apparire ingenue e legate a una visione medioevale, Cecco d’Ascoli ha anticipato determinate idee dell’Umanesimo: ha distinto nella Natura il piano
95
della realtà e il piano dell’occulto; ha valorizzato l’intelletto umano e la libera ricerca; ha messo in evidenza il valore dell’individuo di fronte agli elementi del Cosmo; ha precisato che Dio ha creato i Cieli e la Terra per l’uomo, per cui esiste un piano divino, al quale si può arrivare solo attraverso la fede, che rimane separato dal piano terreno, il quale diventa terreno d’indagine scientifica per l’uomo. Cecco nel suo poema L’Acwerba studia l’habitus dell’uomo e delle altre creature terrestri sotto il profilo morale, psicologico, fisiologico e mostra di avere una visione originale della realtà rispetto al pensiero filosofico e alla concezione scientifica del Medioevo, perché sostiene l’esistenza del libero arbitrio, difende il libero pensiero e il valore della conoscenza, l’unica dote che può assicurare all’uomo l’immortalità: “Non può morire chi a saver è dato/Né poter vivere, ovvero in difetto,/né da fortuna può esser dannato;/ ma questa vita e l’altro mondo
Nel 1324 il tribunale dell’Inquisizione lo condannò per eresia e tre anni dopo lo mise al rogo bruciando i suoi scritti e confiscandone i beni
A sinistra, e a pagina 94 due dettagli del poema l'Acerba In alto, Cecco d'Ascoli mentre tiene una lezione a Firenze nel dipinto di Giulio Cantalamessa
Il personaggio | 1
96
Cecco d’Ascoli era convinto che attraverso gli astri si potessero studiare le forze che regolano e influenzano la vita e il suo futuro
perde/chi del saver ha sempre in dispetto/perdendo il bene de lo tempo verde” (Libro II, capitolo VII, 25-30). Cecco è quindi uomo più moderno rispetto a Dante, perché vive su una linea di confine tra il mondo totalizzante delle certezze medioevali e l’avanzare dell’età nuova che sarà segnata dall’avvento dell’Umanesimo. Egli afferma che alla base della speculazione filosofica e scientifica deve esserci il metodo della ricerca e della sperimentazione, le quali devono essere guidate dal dubbio: “Non è virtù non dubitar del mondo…Ormai risorga in te la mente nuova/Del dubitar per veder la prova”. Sostiene la superiorità della nobiltà d’intelletto rispetto alla casta aristocratica e rifiuta il determinismo del Fato, perché è convinto che spetti all’uomo e non alla Fortuna la conquista del sapere: “Non è fortuna che ragion non vinca…Essendo in
libertà l’alma creata/fortuna in lei non può, se contradice… Lo intelletto/mai a fortuna subiate non deve…Contra a fortuna ogni uomo po’ valere, /seguendo la ragion nel suo vedere”. Per Cecco “principio d’ogni bene è conoscenza”, per cui l’amore per il sapere rappresenta il valore supremo per ogni uomo e costituisce la strada maestra per condurre alla perfezione. La grandezza dell’Ascolano sta nel valore dato alla continua ricerca della verità, alla forza creatrice dell’uomo impegnato nella conquista del sapere e nella scoperta dei segreti della Natura. Egli anticipa in un certo senso l’insaziabile desiderio di conoscenza che possiedono il Dottor Faust di Marlowe e il Faust di Goethe, proponendosi come l’uomo “nuovo” che vuole affermare il principio della libertà di conoscenza considerata una prerogativa e un diritto di ogni essere umano. ¤
Il personaggio | 2
97
In astrologia la chiave per svelare l’universo SECONDO IL POETA-SCIENZIATO PUÒ INFLUENZARE LE SCELTE
L’
Scrisse L’Acerba un compendio enciclopedico di 4.865 sestine in cui si parla anche di fisica e meteorologia
Acerba è la più grande opera scientifico-didascalica del Trecento. Divisa in cinque libri, ognuno suddiviso in capitoli per un totale di 4.865 sestine. È un’opera che ha un alto valore didattico, perché il suo autore vuole impartire un insegnamento rigorosamente razionale sulla base di quelle “verità” scientifiche da lui ritenute fondamentali. Si avverte in Cecco lo sforzo di rendere viva e comprensibile una materia difficile se non addirittura oscura per i non “iniziati”, a cominciare dal titolo del poema, che è stato considerato per diverso tempo un oggetto misterioso. Ad esso sono stati attribuiti diversi significati come acervus, che significa un cumulo di argomenti vari; oppure La Cerva considerata un simbolo d’intelligenza e di scienza. Nel 2002 Marco Albertazzi ha fornito la soluzione più semplice e logica di questo mistero: il termine Acerba è la riduzione del titolo completo Acerba etas (“Acerba vita”) ed è riferito alle questioni inerenti alla vita terrena dell’uomo che è appunto “acerba” rispetto a quella “matura”, che si può raggiungere soltanto dopo la morte. L’Acerba ritorna alla luce nel 1820 con un’edizione alquanto arbitraria a causa di errori e lacune come accadrà per altre edizioni successive. Solo nel 1971 Basilio Censori e Emidio Vittori curano una edizione più affidabile, perché basata sul Codice Eugubino del 1376, ma l’edizione più attendibile è quella pubblicata nel 2002 da Mario Albertazzi, che si è basato sullo studio sistematico di oltre quaranta manoscritti e codici a stampa. L’Acerba è un compendio enci-
clopedico, fondato sulle conoscenze scientifiche del tempo, sul pensiero filosofico di Aristotele e Tommaso d’Aquino, dei filosofi arabi, dove si tratta una materia eterogenea che comprende astrologia, astronomia, fisiognomica, scienze naturali e zootecniche, medicina, filosofia, psicologia, dottrine morali e teologia. Cecco sceglie la forma poetica e la lingua volgare in contrapposizione al latino usato allora per la divulgazione accademica. Egli vuole favorire l’autonomia e la libertà del sapere, per poter indagare la natura con ogni strumento messo a disposizione dalle varie scienze, superando il confine tra lo studio razionale del mondo e la comprensione delle forze occulte che animano l’universo. Per il poeta-scienziato la chiave per cercare di svelare il mistero dell’universo sta nell’astrologia, che permette di prevedere gli eventi e di tracciare il destino degli uomini nella convinzione che la disposizione degli astri possa influenzare le scelte degli esseri umani. Questo influsso astrale, anche se non incide in modo assoluto sul futuro degli uomini, può agire sul loro equilibrio psico-fisico, per cui i tratti del volto, il temperamento, il carattere degli individui sono determinati dai corpi celesti e le stesse le malattie possono essere causate dalla posizione e dagli influssi degli astri che bisogna saper interpretare per individuare le cure necessarie. Infatti ogni individuo è un “microcosmo” in continua osmosi con il “macrocosmo”, per cui ogni organo del corpo umano è collegato alle quattro componenti dell’universo: l’aria, il fuoco, la terra e l’acqua. Cecco sostiene però
Il personaggio | 2
Cecco è tra i fondatori della scienza fisiognomica collegando le sembianze umane a psiche e morale dell’uomo
In alto, una pagina miniata del poema l'Acerba di Cecco d'Ascoli
98
che l’uomo non è in balia degli astri, i quali non possono limitare o addirittura eliminare il libero arbitrio, perché ogni essere umano è dotato dell’intelletto, della coscienza e della volontà che gli consentono di distinguere il bene dal male e di scegliere il bene nonostante gli influssi negativi delle stelle. Egli si contrappone alla visione della Chiesa, secondo la quale l’influsso delle stelle potrebbe aver determinato la nascita, la predicazione, i miracoli e la morte di Gesù, togliendo ogni merito alla sua discesa sulla Terra per salvare l’umanità dal peccato. Nei quattro Libri de L’Acerba (il quinto è rimasto incompleto a causa della morte dell’autore) si parla di astrologia, fisica e meteorologia; si esaminano specificatamene l’ordine dei cieli, le sostanze presenti in natura, l’ordine degli elementi, le eclissi del Sole e della Luna. Sono definite sia le Virtù della Giustizia, Fortezza, Prudenza, Temperanza, Liberalità, Umiltà, Castità, Costanza e Nobiltà, sia i peccati di Avarizia, Superbia, Lussuria, Invidia, Gola, Vanagloria, Ipocrisia, Ira e Accidia. Si sostiene che l’uomo è un essere ragionevole in continua lotta contro le influenze negative del Fato. Pertanto l’astrologia è collegata alla filosofia morale, per cui il trionfo della virtù sul vizio è il risultato della “guerra” degli individui contro gli istinti perversi che provengono dal mondo esterno in un continuo scontro tra libero arbitrio e fato cosmico. Cecco è uno dei fondatori della scienza fisiognomica, perché collega le sembianze umane alla psiche e alla morale dell’individuo, ritenendo che i tratti del volto
possano indicare gli elementi positivi e negativi in un individuo: “Crespi capelli con ampie fronti,/con gli occhi piccinini posti dentro,/con memoria e ragion sono congionti;/fanno disdegno ne l’alma superba…/ ma pure d’umiltà si mostra acerba…L’ampia forma d’aquilino naso/viver desia dello bene altrui…Il concavato ed anche il naso fino,/ciascun di questi a lussuria s’accosta…/ chi lo ha sottile nell’estremo aguzzo,/ovver rotondo con l’ottusa posta,/movesi all’ira; superbo è chi possiede l’ampie nari”. In zoologia analizza i simboli degli anfibi e dei rettili, dei quadrupedi feroci o mansueti e collega la questione morale a un bestiario secondo il quale la vita spirituale è simboleggiata dalla fenice, l’intelletto attivo dall’aquila, il candore dell’anima dal cigno, il rimpianto per il peccato dalla tortora. Attribuisce particolari virtù terapeutiche ad alcune pietre preziose come il diamante, il corallo e lo zaffiro considerate fra “le più degne o più ricche di virtù”. Egli affronta i temi dell’Amore, della Vita attiva naturale e della Vita attiva spirituale, della Fede, della Speranza e della Carità, della Rinuncia e della Contrizione, della Confessione e della Penitenza, dell’Ignoranza e del Furto, dell’Ingratitudine e dell’Invidia, dell’Egoismo e Altruismo, del Peccato e del Pentimento, della Preghiera e della Remissione dei peccati. tratta il problema del bene e della felicità del genere umano; riprende, infine, l’argomento dell’amore che può degenerare nella lussuria e nel peccato come sostiene nella celebre “Invettiva contro le donne”. ¤ a.p.
Archeologia
99
Le strategie di caccia dei nostri antenati TRACCE DI INSEDIAMENTO PREISTORICO A TOLENTINO
L di Stefano Finocchi
Dall'alto una sezione di scavo In evidenza il Paleosuolo di età mesolitica e archeologi al lavoro nel sito
e indagini di archeologia preventiva, finalizzate alla realizzazione del nuovo polo scolastico “F. Filelfo” in località Contrada Pace di Tolentino, coordinate dalla Soprintendenza ABAP delle Marche (dott. Stefano Finocchi e dott. Paola Mazzieri) ed effettuate dalla società ArcheoLAB di Macerata (dott. Alessandra d’Ulizia, dott. Davide Visentin, dott. Alessandro Potì, dott. Arianna Cocilova), hanno restituito consistenti tracce di occupazione dell’area durante il Mesolitico antico (9.5007.000 anni a.C.). Si tratta del periodo preistorico intermedio fra Paleolitico, l’epoca delle grandi glaciazioni, e il Neolitico, in cui avviene il passaggio a un’economia basata su agricoltura e allevamento e la conseguente sedentarizzazione delle popolazioni. Il Mesolitico rappresenta un momento particolarmente significativo della nostra storia più antica, sia per il definitivo adattamento degli ultimi gruppi di cacciatori-raccoglitori europei alle condizioni climatiche e ambientali create al termine dell’Ultima Glaciazione, sia per la presenza di importanti cambiamenti socio-economici e tecnologici. Per l’area marchigiana, il sito di Contrada Pace rappresenta il primo contesto Mesolitico indagato in maniera estensiva e secondo i più elevati standard scientifici. Finora, infatti, il Mesolitico era noto nelle Marche solo grazie al rinvenimento di industria litica recuperata da Delia Lollini nei primissimi anni ‘70 in Contrada Lucciano di Pievetorina, riferibile a un momento cronologico più recente. Il sito di Contrada Pace si contraddistingue per le ecceziona-
li condizioni di conservazione garantite dai fanghi alluvionali deposti dal fiume Chienti, che hanno sigillato e preservato integralmente le tracce dell’antica occupazione umana dell’area. Grazie allo scavo stratigrafico, infatti, è stato possibile riconoscere la superficie su cui i cacciatori mesolitici camminavano, i focolari che hanno acceso e i punti in cui hanno svolto particolari attività, quali la scheggiatura della selce per produrre strumenti da lavoro e armi da caccia, la macellazione delle prede e la lavorazione di materiali organici come legno e osso. Siti caratterizzati da un analogo stato di conservazione sono rari nella penisola e indagini della stessa accuratezza sono state applicate raramente in passato in contesti all’aperto. Il sito di Contrada Pace rappresenta un insediamento all’aperto, occupato per un periodo limitato da gruppi di cacciatori-raccoglitori del Mesolitico antico (facies culturale del Sauveterriano) e poi sigillato da vari livelli alluvionali fini, che, come già detto, ne hanno consentito lo straordinario stato conservativo. Nello specifico delle testimonianze messe in luce è stato possibile individuare una serie di concentrazioni di evidenze diverse. Un primo settore si identifica come un’area dedicata alla lavorazione della selce e alla produzione di armature per le armi da caccia. Il settore più centrale dell’accampamento si caratterizzava invece per la presenza di focolari e di aree con resti di lavorazione della selce, oltre a tracce legate alla macellazione e al processamento delle prede di caccia. Un terzo settore ha
Archeologia
Emersi a Contrada Pace importanti reperti del periodo Mesolitico in condizioni eccezionali di conservazione
In alto alcuni reperti: 1-2) nuclei a lamelle; 3-4) lamella; 5-6) microbulini; 7-9) punte a dorso; 10-13) triangoli; 14) grattatoio; 15) bulino; 16) troncatura
100
restituito un accumulo di conchiglie di terra (escargotières) esteso su una superficie di circa 10 mq formato da numerosissimi gusci di gasteropodi terrestri (Helix pomatia) associati ad abbondanti manufatti litici e frammenti ossei, carboni e ciottoletti alterati. Tra tutti i materiali rinvenuti particolarmente rilevanti sono i resti ossei, che presentano un grado di preservazione nettamente migliore rispetto a quelli restituiti da altri settori di scavo: il rapido seppellimento infatti li ha protetti dai normali fenomeni di weathering che caratterizzano il suolo. La presenza di elementi significativi quali denti e mandibole e in generale di frammenti ossei di grosse dimensioni consentirà, in fase di studio, un elevato tasso di determinazione e quindi la possibilità di ricostruire in dettaglio le strategie di caccia dei gruppi mesolitici che hanno occupato il sito. Esempi di escargotières datati tra il Pleistocene finale e l’Olocene sono noti da vari contesti archeologici dell’areale circummediterraneo, in particolar modo
da siti del Nord Africa, della Penisola Iberica, dei Pirenei e del Vicino Oriente. Nonostante questo, evidenze simili non sono affatto comuni nel territorio italiano. L’escargotière era attigua a un’area dove è stato possibile riconoscere tracce più consistenti di sistemazione antropica, laddove la superficie posta fra due ceppaie sradicate (tipo wind-throw) e una pianta degradata sembra essere stata sfruttata per l’organizzazione di uno spazio con al centro un ulteriore focolare impostato al di sopra di un piano di sistemazione realizzato in argilla. Nel sito, i manufatti in pietra scheggiata sono ben preservati e presentano margini freschi e assenza di patine post-deposizionali, mentre quelli organici (carboni, resti di fauna, malacofauna terrestre) non sono stati completamente dissolti dall’acidità del suolo, come accade frequentemente nei contesti preistorici all’aperto. Lo scavo estensivo del deposito ha consentito di riconoscere un’organizzazione articolata dello spazio insediativo, unica nel suo genere in tutta la penisola per l’ampiezza su cui è stata messa in luce e la varietà delle strutture evidenziate, quali focolari e accumuli di materiale litico e faunistico. L’eccellente stato di conservazione del sito, l’ampiezza messa in luce dallo scavo stratigrafico, la varietà delle strutture evidenziate e la ricchezza del materiale recuperato (diverse migliaia di manufatti litici e scarti di lavorazione), ne fanno sicuramente uno dei ritrovamenti più importanti e significativi a livello italiano ed europeo per la ricostruzione dei modi di vita dei nostri antenati preistorici. ¤
Ritrovamenti
101
Baia della Scalaccia resti romani sommersi A SUD DI ANCONA L'UNICA PESCHIERA DELL'ADRIATICO
N di Gaia Pignocchi
el tratto di costa a sud di Ancona, sotto il quartiere di Pietralacroce, si cela una delle più importanti testimonianze di epoca romana, scoperta nel 2001 poco al di sotto della superficie del mare, ma in realtà visibile da sempre, soprattutto dall’alto, sporgendosi dal ciglio della falesia lungo il sentiero 313 (stradello della Scalaccia) dove uno spettacolare punto panoramico offre la magnifica veduta sulla baia della Scalaccia. Nelle giornate di mare calmo e trasparente in quel tratto di mare basso e riparato tra la costa e le bianche scogliere parallele ad essa è possibile vedere una struttura a reticolo sommersa. Si tratta di una peschiera romana del tipo ex petra excisa, cioè scavata direttamente nella roccia, particolarmente raccomandata per l’efficacia produttiva da Columella, il grande teorizzatore dell’ittiocoltura, vissuto nel I sec. d.C. Indagata a cura del nucleo subacqueo della Soprintendenza ai Beni archeologici delle Marche guidato dalla dottoressa
Maria Cecilia Profumo in collaborazione con il circolo Komaros Sub di Ancona, la struttura è stata accuratamente documentata e studiata e rappresenta una presenza unica per la costa adriatica italiana. Misura 32 metri in larghezza e 13 in lunghezza per una superficie di 416 mq ed è composta da cinque vasche, una più grande a nord-ovest (vasca A) e le altre quattro (B,C,D,E) accoppiate al centro e verso sud-est. Disposte su due file parallele alla linea di costa e realizzate tra la piattaforma rocciosa ai piedi della falesia e una fila di scogli emergenti in parte di frana che fungeva anche in antico da barriera frangiflutti. Assai importante la scelta del luogo, una baia riparata ma non troppo chiusa in modo da garantire protezione dalle mareggiate e un costante ricambio di acqua di mare. Molto importante era anche la presenza di acqua dolce attraverso sorgenti o vene per mantenere il giusto grado di salinità delle acque. Le vasche della peschiera sono scavate nella piattaforma rocciosa costituita da marne calcaree e sono prive di qualsiasi tipo di opera in muratura artificiale, solitamente realizzata in opera cementizia. Le vasche sono collegate fra di loro e con il mare aperto da una serie di canali che convergono verso la vasca B, che è la più profonda e presumibilmente la più importante. La vasca A è la più grande (8.80x4.20 m), ma la B, la più profonda, sembra essere la principale del complesso in quanto il sistema di canali ha una pendenza convergente verso di essa.
Ritrovamenti
102 Nel fondo della vasca A, in prossimità dell’angolo orientale, è stato ricavato un pozzetto semicircolare delle dimensioni di 2.00x0.70 m e profondo 30 cm, forse una piccola vaschetta realizzata per permettere a particolari specie di pesci di nascondersi o ripararsi dalla calura. Le vasche sono divise da setti estremamente regolari, larghi 2.10 m, tagliati dai diversi canali che mettono in comunicazione le vasche fra loro. I setti che dividono le vasche presentano un gradone interno, una sorta di banchina ricavata
Ai piedi del quartiere di Pietralacroce poco sotto la superficie del mare si celano vasche usate per contenere pesci
nella roccia che consentiva di potervi camminare e quindi osservare, alimentare o catturare i pesci. Le pareti delle vasche sono conservate per un altezza minima di 100 cm e massima di 190 cm, misura quest’ultima che sembra coincidere con quanto consigliato da Columella che suggerisce di mantenere una profondità di almeno due metri circa (sette piedi d’acqua), anche se esistevano vasche meno profonde per l’allevamento di particolari specie di pesci, come ad esempio le sogliole. I canali di comunicazione che collegavano le vasche tra loro e con il mare aperto consentivano la circolazione continua
dell’acqua all’interno della struttura. Anche di questo ne parla Columella: "Lo stagno marittimo veramente ideale è quello disposto in modo tale che ogni successiva onda del mare scacci la precedente e non lasci che l’onda vecchia rimanga entro il chiuso....". Inoltre da un lungo canale posto ad est confluiva acqua dolce da una vena che creava una miscela adatta per conservare, ma anche per attirare i pesci dal mare aperto nella peschiera. L’acqua dolce era indispensabile alla vita della peschiera. L’aquatio, ovvero la miscela di acqua dolce e acqua salata, permetteva infatti di attirare i pesci e alcune specie in particolare, come le orate, i cefali e le spigole. Questa tecnica permetteva non solo di controllare il gradiente di salinità adatto ai vari tipi di pesci allevati, ma anche di facilitare la cattura di quelle specie che nei mesi estivi cercano refrigerio in acque fresche e poco salate e di ossigenare l’acqua del vivaio per garantire un allevamento intensivo di grandi quantità di pesce. I canali di comunicazione con l’esterno e tra le vasche erano solitamente dotati di cataratte (clatri), saracinesche calate dall’alto e dotate di fori per controllare il flusso dell’acqua e soprattutto per impedire l’uscita dei pesci. Nella peschiera della Scalaccia sembrano mancare le tracce delle saracinesche descritte da Columella, spesso conservate in altre peschiere romane o testimoniate dai solchi sulle pareti dei canali. A tale proposito M.C. Profumo ha ipotizzato che “nel nostro caso non solo non si sono conservate le grate, ma neanche i loro solchi di posizionamento. Tale assenza è giustificabile con il fatto che la zona è stata per molto tempo e assiduamente frequentata ed eventuali resti archeologici (come le saracinesche in bronzo o anche in altro
Ritrovamenti
materiale) sarebbero stati certamente riutilizzati. L’erosione marina o le concrezioni possono facilmente aver cancellato le tracce dell’impostazione delle stesse grate, anche se non si può escludere che la chiusura avvenisse con qualche sistema mobile, come è stato ipotizzato per la peschiera Nicolini a Sorrento, o in materiale deperibile”. Oltre ad assicurare un’acqua mai stagnante, la peschiera della Scalaccia, per la sua favorevole posizione lungo un tratto di costa rocciosa, ricreava anche l’ambiente marino congeniale ai pesci proprio grazie alla presenza di scogli coperti da alghe o piccoli anfratti. Il fondo delle vasche era probabilmente ricoperto di scogli e vegetazione marina per ricreare l’ambiente più idoneo e naturale per i pesci. Ad avvalorare questa ipotesi contribuisce il rinvenimento, all’interno delle vasche, non solo di scogli, ma anche di pietre calcaree disposte con una certa cura e del pozzetto nella vasca A. La peschiera era dunque progettata per riprodurre un ambiente ideale per i pesci, al riparo dal moto ondoso e dal sole. Le vasche potevano servire per accogliere diverse specie ittiche o pesci in differenti stadi di sviluppo oltre che per garantire un luogo riparato e favorevole per la deposizione delle uova. Varrone (De re rustica, III, 17, 4) paragona le vasche “loculate” alla tavolozza usata dai pittori per tenere divisi i loro colori: allo stesso modo così i pesci potevano essere separati per specie e per età. Consueta e raccomandata era infatti la suddivisione in vasche, disposte intorno a un grosso bacino rettangolare, destinate ad accogliere diverse specie ittiche ed esemplari in differenti stadi di sviluppo. In età romana le peschiere erano spesso in relazione a ville marittime di ricchi romani dei ceti più elevati, che prefe-
103 rivano il pesce di mare al pesce d’acqua dolce e la pratica dell’otium in dimore sontuose dotate di ogni lusso e confort dove poter soddisfare anche la dispendiosa passione per l’itticoltura. Non mancano aneddoti e battute ironiche contro questa costosa moda dell’aristocrazia romana che spendeva somme esagerate (multa pecunia) per garantirsi vivai riforniti di ogni tipo di pesce che spesso neppure consumava, ma che allevava per puro piacere o per rifornire le tavole di imperatori con prodotti ittici ricercati che potevano fruttare anche guadagni considerevoli o comunque procurare la benevolenza dei potenti. Non è escluso un utilizzo pubblico o privato di queste strutture come vivai di allevamento ittico o di temporaneo deposito del pescato per mantenere fresco il pesce prima di venderlo nei marcati urbani o alle ricche mense private e non è casuale la concentrazione della maggior parte di questi vivai, alcuni anche di grandi dimensioni, nel tratto di costa tirrenica immediatamente a nord e a sud di Roma. In prossimità della Scalaccia, e comunque lungo quel tratto di costa, non risulta nessun rinvenimento di età romana e neppure le ricerche effettuate dalla Soprintendenza, rese difficili anche per la presenza di vegetazione sempre abbondante e per l’inaccessibilità di alcuni terreni di proprietà privata, hanno rilevato tracce della presenza di insediamenti abitativi. La peschiera della Scalaccia di Pietralacroce è unica lungo il versante adriatico della nostra penisola, mentre particolarmente numerose sono lungo la costa tirrenica, dove il loro censimento ha evidenziato che la correlazione tra villa marittima e impianto di piscicoltura, pur costituendo il caso più ricorrente, non è tuttavia esclusivo. Le peschiere tirreniche possono essere infatti anche svinco-
Contenitori scavati nella roccia e collegati fra loro nei quali confluiva anche acqua dolce adatta per attirare orate, cefali e spigole
In apertura del servizio la struttura a reticolo della peschiera visibile nelle condizioni di mare calmo A sinistra, rilievo planimetrico della peschiera romana della Scalaccia Qui sopra, due panoramiche della baia dallo stradello della Scalaccia
Ritrovamenti
In età romana le peschiere erano spesso in relazione a ville marittime di ricchi romani dei ceti più elevati
Sopra, I due stradelli (313 e 313b) che scendono alla Scalaccia
104
late da strutture private e in questi casi è possibile ipotizzare un loro utilizzo come bacini di temporaneo deposito del pescato per mantenere fresco il pesce che veniva trasportato via mare o via terra, verso i mercati urbani e le mense private. I romani allevavano murene, orate, anguille, triglie e persino pesci tropicali come lo scaro (pesce pappagallo) e le ricche famiglie romane o i personaggi di rango elevato, che predilige-
vano il costoso pesce di acqua salata, spesso prendevano il soprannome da alcune specie di pesce di cui erano particolarmente ghiotti. Giovenale, poeta satirico del I secolo d.C., narra della pesca di un enorme rombo avvenuta proprio davanti al porto di Ancona e al tempio di Venere. Il pescatore che lo catturò con la sua rete, per timore di essere denunciato dagli ispettori che controllavano il pescato (chi pescava qualcosa di eccezionale doveva donarlo immediatamente alla tavola imperiale), pensò di consegnarlo personalmente all’imperatore
Domiziano il quale convocherà addirittura un consiglio dei principi per decidere come cucinare l’enorme rombo vista la mancanza di una pentola altrettanto grande per contenerlo. Le peschiere romane sono anche oggetto di studio da parte dei climatologi in quanto rivestono un ruolo importante nell’ambito degli studi finalizzati alle variazioni del livello del mare negli ultimi millenni come conseguenza dei cambiamenti climatici che uniti agli effetti tettonici dell’innalzamento o abbassamento del terreno hanno influenzato in maniera diversa l’abbassamento delle varie emergenze di questo tipo monitorate lungo le coste mediterranee. Rilevando infatti la profondità attuale della base di queste strutture, oggi completamente sommerse dal mare, si può calcolare l’innalzamento marino avvenuto negli ultimi duemila anni, che nel caso della peschiera della Scalaccia è di circa 1,50 m. In particolare la zona di Ancona, nonostante sia zona sismica, non presenta movimenti tettonici di rilievo tali da provocare fenomeni di subsidenza che possano aver determinato il lento e progressivo abbassamento del fondo del bacino marino che anzi si sarebbe sollevato solamente di 0,1 mm l’anno. Le misurazioni effettuate nella peschiera della Scalaccia hanno fornito l’indicazione che negli ultimi due millenni il livello del mare si è innalzato di circa m 1.50 principalmente per effetto dell'eustatismo, l’innalzamento su scala globale del livello dei mari, con un aumento medio di circa 0,7-0,8 mm l’anno. ¤
Residenze reali
105
Il soggiorno breve di Girolamo Bonaparte IL FRATELLO DI NAPOLEONE IN VILLA A PORTO SAN GIORGIO
L’ di Fabio Mariano
L’edificio fu costruito e poi dedicato dal principe di Montfort alla moglie Caterina innamorata di quei luoghi
Il libro curato dall'architetto Fabio Mariano con i disegni di Ireneo Aleandri per l'editore A.Livi di Fermo
occasione del restauro dei disegni di Ireneo Aleandri per la Villa Bonaparte al Porto di Fermo, custoditi dalla benemerita Società Operaia ''Giuseppe Garibaldi’ ‘di Porto S. Giorgio - sovvenzionato dalla Regione Marche - ha ricollocato sotto i riflettori uno dei segni territoriali più originali dal lascito della pur breve ma incisiva dominazione napoleonica in terra marchigiana. Incisiva soprattutto per le illuminate novità indotte nella sonnolenta gestione amministrativa dello Stato pontificio, riforme che prolungheranno i loro effetti razionalizzanti ben all’interno della Restaurazione; riforme che - vogliamo osservare - furono ampiamente ripagate con le vaste razzie di opere d’arte perpetrate dai francesi sui patrimoni ecclesiastici e patriziali, che presero la via su centinaia di carri verso Milano e Parigi, e solo in parte recuperati. La frequentazione del regale esule Girolamo Bonaparte a Fermo ed al suo Porto, ospite del deferente patriziato locale e l’innamoramento della moglie Caterina per le bellezze naturali e paesaggistiche dei luoghi determinarono la decisione di edificare qui la sua Ville de Plaisir nelle Marche. Un occasionale monumento, seppur poco vissuto, che venne a rappresentare uno scampolo di vita privata parigina nel Piceno, progettato da un architetto come Ireneo Aleandri che certamente accolse le indicazioni ed i desiderata del napoleonide, producendo un unicum architettonico che ben venne ad inserirsi in quell’originale tassello della storia dell’architettura che a suo
tempo individuammo e descrivemmo, partendo proprio dall’opera dell’architetto settempedano, e che definimmo: ’’ l’Architettura del Purismo nello Stato pontificio’’. Ma chi era l’insolito committente? Girolamo Bonaparte era nato ad Ajaccio il 15 novembre 1784, figlio del generale Carlo Maria Bonaparte e di Maria Letizia Ramolino; era il fratello più piccolo di Napoleone, il quale non mancò di promuoverlo e manovrarlo a fini politici, come d’altronde fece con tutti i suoi familiari anche nella vita privata. Dopo che nel 1805, su richiesta di Napoleone, il suo matrimonio americano venne annullato, Gerolamo fu destinato a sposare nell’agosto 1807 Caterina Sofia Dorotea di Württemberg (San Pietroburgo,1783 – Losanna,1835), figlia del re Federico I, venendo subito dopo nominato dal fratello re di Westfalia. Seguì Napoleone sia nella Campagna di Russia e sia, dopo i Cento Giorni, a Waterloo, dove non si distinse certo per talento militare in nessuna delle due sfortunate spedizioni, anzi dell’ultima viene dalla storiografia ritenuto uno dei maggiori responsabili. La caduta definitiva del fratello, costrinse Girolamo ad allontanarsi dalla Francia ed a rientrare alla corte del suocero, tentando di rimettersi in sella come genero di Federico di Württemberg. Nel giugno 1816, poco prima di morire, questi lo nominò principe di Montfort. Da allora risiedette alternativamente a Vienna e a Trieste. Tuttavia, il ministro Metternich non tollerava la presenza di un Bonaparte in
Residenze reali
La villa, grazie al restauro dei disegni dell’arch. Aleandri rispolvera la presenza napoleonica nelle Marche
Sopra, la facciata est di villa Bonaparte dopo il recente restauro Sotto, il Salone d'Onore, i decori di Antonio Panfili prima dei recenti restauri In alto a destra, il prospetto della villa reale Sotto, Sebastian Weygandt Re Girolamo e la regina Caterina di Westfalia, 1810 (coll.privata)
106 una città marittima dell'impero austriaco e, il 26 marzo 1823, Girolamo fu costretto ad abbandonare Trieste: dopo aver ottenuto il permesso dalle autorità pontificie, proseguì il suo esilio a Roma dove lo attendevano la madre ed altri membri della famiglia imperiale. Dopo la morte di Napoleone venne perseguitato come tutti i napoleonidi ma - per la generosità del papa marchigiano Leone XII - si era potuto rifugiare nello Stato Pontificio con i tre figli e la moglie Caterina. Dal 1825 il principe di Montfort iniziò a frequentare Porto San Giorgio e Fermo, ospite della nobile famiglia Trevisani e dei conti Maggiori. Dal 1829 al 1831 Girolamo abitò con la famiglia a Porto San Giorgio, nella nostra villa, da lui fatta edificare e dedicata alla moglie Caterina che si era innamorata dei luoghi: “Il paese è un incanto – scriveva in una lettera Caterina – e tutti i paesi che ho percorso non fanno che aumentare questa impressione; inoltre i vicini rendono Porto Fermo ancor più piacevole”. Girolamo giunse al Porto di Fermo già nel giugno del 1825, ospite del conte Antonnicola Trevisani, che ebbe modo di conquistarlo alle bellezze naturali del luogo: una cittadina che stava proprio allora riorganizzandosi nel proprio ampliamento urbanistico razionale verso le terre conquistate al litorale (i ‘’relitti del mare’’) con un moderno piano urbanistico impostato dall’architetto Pietro Augustoni. La Villa Bonaparte (detta anche Villa Caterina o Villa Montfort, infine dei Pelagallo) a Porto S. Giorgio è da classificare tra le emergenze più significative nel patrimonio delle ville marchigiane e nel catalogo professionale dell’architetto sanseverinate Ireneo Aleandri, sia per qualità architettonica ma anche per l’indubbio prestigio del com-
mittente. Il progetto fu esteso, probabilmente già dal 1825, dal giovane Aleandri, già reso famoso per il suo costruendo Sferisterio a Macerata. Per dedicarsi a tempo pieno al nuovo prestigioso e remunerativo incarico (con uno stipendio di quaranta scudi mensili) l’architetto abbandonò senza indugio la direzione del cantiere maceratese ad altri, completando i suoi disegni in pochi mesi per presentarli quindi personalmente al Principe. Il complesso del cosiddetto “Palais Royale” fu edificato velocemente, dal 1826 al 1829, nell’angolo S-E della antica cinta urbica, in una zona di orti a ponente dell’ultimo incasato urbano, dove s’incontravano le cortine che collegavano lo snodo della Turris Magna ad est col Navale (che fu in parte inglobate nella villa) ed a nord con la Rocca Tiepolo, abbattendo tra l’altro su quest’ultimo fronte la porta terranea principale del Porto di Fermo (poi ricostruita più a nord come Porta Nuova), con ingenti movimenti di terra e terrazzamenti per adattare la costruzione l’impervia orografia discendente dal Monte
Residenze reali
Cacciù. Tipologicamente l’edificio presenta una classicheggiante pianta a “C”, aperta ad ovest su di un cortile quadrato dove venne recuperato un preesistente pozzo. Una planimetria in gran parte condizionata dalle massicce preesistenze fondali, sia delle fortificazioni tardo duecentesche sia della seicentesca Villa Trevisani, che vennero evidentemente inglobate e riusate funzionalmente, come si evidenzia dalla lettura attenta degli spessori murari e degli orientamenti irregolari della planimetria del complesso, resi ben leggibili nei disegni restaurati e qui pubblicati. Il suo prospetto principale è invece rivolto ad oriente, affacciato verso il mare, su di un panorama all’epoca completamente libero. I tre ordini di facciata nascondono in realtà quattro livelli, essendo i primi due (piano terra e mezzanino) affacciati sotto l’intradosso stesso del portico, mentre il salone d’onore superiore raggiunge gli 8 metri di altezza. Quest’ordine del piano nobile presenta tre ampie porte finestre incorniciate in travertino ascolano, scolpite
107
dai fratelli Angelini, scorniciate da timpani su mensole di stile sangallesco, che rimanda a quelle aleandriane del Palazzo Margarucci a Sanseverino. Sentiti cantonali bugnati a cuscino compattano il prospetto per tutta la sua altezza, mentre otto vistosi ed evocativi fregi in terracotta con ricche panoplie di trofei marziali (Gerolamo era stato comandante supremo dell’esercito francese a Waterloo) - modellati e patinati a finto travertino da Domenico Paci, originario sangiorgese. Al piano nobile, articolato con un salone d’onore a doppia altezza, ritmato agli angoli da binati di paraste corinzie, con la sala da pranzo e con due salottini simmetrici laterali. Notevole, sovrasta questo salone una luminosa volta in camorcanna lunettata e finemente decorata a tempera in “stile Impero” con decori marziali ed araldici al centro della volta con gli stemmi reali di Westfalia e del Wurttemberg, probabile opera di Antonio Panfili. Sul lato sud, tramite una rampa ed un terrazzo quadrato, un altro ingresso permette agli ospiti di giungere dal parco diret-
L’edificio divenne per pochi anni luogo privilegiato delle riunioni politiche della revanche dinastica tra Marche e Regno di Napoli
Residenze reali
Girolamo iniziò a frequentare Porto San Giorgio dal 1825 ospite delle famiglia Trevisani e dei conti Maggiori
In alto, Icnografia del Piano nobile e qui sopra Aleandri Ireneo ritratto nel suo studio
108
tamente alla quota del piano nobile, forse anche per la modestia architettonica dello scalone d’onore, condizionato dalle preesistenze e visibilmente inadeguato al contesto. Sul lato nord-ovest un articolato sistema di scale svolge funzione di snodo tra la residenza e i volumi di servizio, collegando il terrazzo trapezoidale addossato alla villa con l’Orangerie. Edificio questo anch’esso disassato rispetto alla villa a causa delle preesistenze fondali e previsto originariamente dall’Aleandri, ma realizzato solo in seguito dall’architetto fermano Giambattista Carducci per i nuovi proprietari Pelagallo. La villa, divenuta il luogo privilegiato delle riunioni politiche della revanche dinastica bonapartista tra Marche e Regno di Napoli, rimase solo per pochi anni soggiorno della famiglia Bonaparte a Porto San Giorgio: infatti, dopo i nuovi moti rivoluzionari del 1831, Gerolamo venne internato nel Regno di Napoli per mano delle truppe pontificie su esplicita richiesta di Ferdinando di Borbone a Gregorio XVI. La villa venne allora requisita dal Demanio pontificio, quindi acquistata nel 1834 dalla Camera Apostolica per 23.000 scudi (n’era costata ben 65.000!). Nel 1836 fu rimessa all’asta e acquistata nel 1837, con tutti gli arre-
di originali, dalla famiglia del conte Luigi Pelagallo (per solo 10.000 scudi), sua ultima proprietaria blasonata. La Collezione dei disegni dell’architetto Ireneo Aleandri relativi al suo progetto architettonico per la Villa Bonaparte a Porto S. Giorgio è oggi di proprietà della Società Operaia di mutuo Soccorso ''Giuseppe Garibaldi'', fondata il 20 dicembre 1864 a Porto S. Giorgio. La collezione consta di due cartelle di disegni di vario formato, su carta pesante da disegno. Il ductus è proprio del disegno tecnico d’architettura di quel periodo: essenziale, molto preciso e nitido. La costruzione geometrica è accennata a grafite, l’esecutivo delle strutture da mantenere è ripassato a penna con inchiostro di China nero a campitura; secondo la convenzione grafica tuttora vigente le demolizioni murarie sono acquerellate in giallo e le ricostruzioni in rosa. Particolarmente interessanti e significative risultano le planimetrie del piano terra e del piano nobile in quanto ci rendono edotti del complesso lavoro di cuci-scuci esperito dall’architetto per destreggiarsi fra le preesistenze murarie sia della residenza Trevisani sia delle strutture fortificatorie. La pubblicazione integrale del fondo grafico, illustrata in una nitida veste editoriale, auspichiamo possa permettere una lettura più puntuale del monumento, del suo complesso inserimento fra le preesistenze secolari del luogo, delle scelte costruttive e distributive, del gusto del vivere di un’epoca, aggiungendo un ulteriore tassello alla storia dell’Architettura nelle Marche. ¤
La ricostruzione
109
La forza della devozione supera anche il sisma RIAPERTO AL CULTO IL SANTUARIO DELLA BEATA MATTIA
I di Sergio Palma
l 23 dicembre dell’anno appena trascorso è stato riaperto ai fedeli il Santuario della Beata Mattia Nazzarei annesso al Monastero di clausura di S. Maria Maddalena in Matelica, al cui interno è custodito sotto l’altare maggiore il corpo incorrotto della Santa, che è molto più di un mito o di un simbolo per la Città di Matelica, perché è ancora al centro di un culto che si è protratto nel tempo e che è tuttora saldamente radicato nella popolazione matelicese. La Chiesa è stata resa inagibile dal terremoto che ha colpito l’Italia centrale nel 2016, ma con fede e coraggio la Comunità delle Clarisse, che vive in clausura nel Monastero, ha dato inizio ai lavori di consolidamento, di adeguamento e decoro liturgico senza avere la certezza che il finanziamento pubblico sarebbe arrivato in tempo per il 28 dicembre 2019, data di inizio delle celebrazioni del 700° anniversario del transito in cielo dell’amata Beata Mattia. Raccolti in poco tempo quattrocentomila euro
Una sottoscrizione pubblica cui ha partecipato anche l’Eni ha permesso la raccolta di fondi per i lavori alla chiesa
Si è fatto pertanto ricorso a una sottoscrizione pubblica che ha coinvolto i fedeli e una primaria compagnia italiana, da sempre vicina alle necessità del Monastero, per cui è stato possibile raccogliere i 400.000 euro necessari per restituire alla Chiesa l’eleganza delle sue architetture barocche, lo splendore delle sue dorature, l’umile fascino delle sue pitture, tra le quali è possibile ammirare sopra l’altare maggiore il dipinto che rappresenta Maria Maddalena del pittore jesino Domenico
Valeri (1701-1770). Mattia, figlia di nobile famiglia, entra in Monastero a diciotto anni il 10 agosto del 1271 e nel momento del suo ingresso in Monastero si è trovata dinanzi un Crocefisso conservato nel Santuario e datato da Luigi Serra tra la fine del XII ai primi decenni del XIII secolo. Nell’interpretare questo incontro, Chiara Augusta Lainati scrive: ‘’Anche il suo sguardo si incontra con quello del Crocefisso e in quello sguardo Mattia legge tutto: la sofferenza, la povertà la carità……dare tutto quello che si ha………salire la croce con Lui senza esitazione’’ Il Monastero, la cui edificazione è stata collocata dagli storici tra il 1225 e il 1232, ha subito dei gravi danni con il terremoto del 30 aprile 1279, quando fonti coeve attestano che due terzi degli edifici di Camerino sono andati distrutti, mentre Cagli, Fabriano, Matelica, San Severino Marche, Cingoli, Nocera Umbra, Foligno e Spello sono rimaste "diroccate". Nel 1279 Mattia diviene Abbadessa del Monastero e nel 1286 si verifica a Matelica una fusione tra le Benedettine del Monastero di Sant’Agata che si uniscono alle Clarisse del Monastero di S. Maria Maddalena, lo spirito dell’ora et labora si fonde con l’ideale evangelico-pauperistico del francescanesimo. Secondo una consolidata tradizione si ritiene che in quella occasione il carisma di Mattia esercitò una indiscussa attrattiva, rendendo possibile l’incontro delle due comunità. Dopo una vita di clausura dedicata alla preghiera, alla penitenza e all’assistenza spirituale di molti matelicesi, Mattia muore il 28
La ricostruzione
La profonda devozione per la badessa del monastero è aumentata nel tempo anche per i miracoli compiuti
110 dicembre 1319. La sua chiesa viene ampliata nella seconda metà del XV secolo, come si può desumere dalla datazione del campanile, ma poco rimane oggi di quell’intervento a parte una piccola partitura architettonica con volute vegetali tipiche del periodo, che fanno pensare a una datazione intorno alla seconda metà del XV secolo secondo l’ipotesi avanzata dallo storico Antonio Trecciola. L’ampliamento della chiesa è stato reso necessario dall’infinita devozione per Mattia che viene testimoniata una tela dell’Annunciazione, databile alla fine del XV secolo, dove la suora viene rappresentata già coronata da un’aureola, “come già fosse santa ed è inclinata e protesa con le mani giunte verso la Vergine Maria quasi a implorare protezione per le sue figlie, che numerose sono state accolte nel suo Monastero” (Padre Giancarlo Mandolini, 2013). Tutti i particolari costruiti con maestria La profonda devozione per Mattia è continuata ed è aumentata nel tempo sia per i miracoli compiuti e per le grazie concesse, sia per l’umore sanguigno notato sul suo corpo come sostiene C. Acquacotta quando scrive che nelle Memorie di Matelica nel 1536 ‘’… si vide per la prima volta diramare dalle aride spoglie della santa Concittadina quell’umore sanguigno……’’, un fenomeno che si è nuovamente ripetuto all’apertura dell’urna della Beata il 13 maggio 1759 in presenza del Vescovo di Fabriano e Matelica. Nello stesso anno viene inserita sopra l’arco del presbiterio una targa in latino che, nella sua traduzione italiana, ricorda la presenza significativa della Beata in “Questo tempio antichissimo, dedicato a Santa Maria Maddalena, riedificato poi dalla Beata Mattia, di nuovo ridotto
a miglior forma l’anno del Giubileo 1750”. La Chiesa, come da tradizione è divisa in due aule, una più grande per i fedeli e una più piccola (il Coro monastico) giustapposta alla precedente, dove le Suore assistono alle funzioni religiose. Se si osservano poi i particolari, si nota come ogni decorazione, dalla più piccola voluta, al capitello, alla colonna, è costruita con maestria, quasi a far sembrare il sacello una piccola bomboniera accuratamente cesellata, rendendo la testimonianza di un Barocco già entrato nella tempesta del Rococò. Paradigmatici sono la cantoria e i coretti addossati all’abside semicircolare della controfacciata. L’anonima cromia grigia del fondo della balconata della cantoria è movimentata dall’oro degli intagli che, raffinatissimi, vanno a scandire gli spazi e ad alleggerire la struttura, trionfando in alto nella grata e nella ricchezza delle volute della sommità della cassa d’organo. La medesi-
La ricostruzione
ma decorazione, con la stessa altissima qualità di esecuzione, si trova anche nei coretti, sorretti da mensole a volute e arricchiti, nella balaustra, da teste d’angeli. Queste vere e proprie opere d’arte di intaglio si inseriscono organicamente nella struttura architettonica della chiesa tanto da far pensare che il responsabile della progettazione sia stato l’architetto ticinese Maggi (Antonio Trecciola, 2005). La salma ha rischiato di essere disintegrata Il processo canonico per la beatificazione di Mattia comincia nel 1759, quando è approvato il suo culto basato sulla “fama della Santità della vita, delle virtu’ e dei miracoli, …, “sopra il prefato immemorabile di Lei culto”, con queste parole: “diciamo, decretiamo, dichiariamo e definitivamente sentenziamo che risulta esercitato il culto e la pubblica venerazione verso Mattia Nazzarei, culto di cui non c’è memoria dell’inizio,
111
e che tuttora viene tributato”. Il 27 luglio 1765 il pontefice Clemente XIII la dichiara Beata e ne approva il Culto ad immemorabili, concedendone l’ufficio e la Messa. Un grave affronto è perpetrato contro le sacre spoglie della Beata, quando il 6 ottobre 1811, durante il governo napoleonico, viene compiuto nottetempo un sacrilegio con l’estrazione del corpo fuori dell’urna, caricandolo sopra un carro e trasportandolo a Macerata per ordine del prefetto. Per il costante interessamento delle autorità matelicesi e per le incessanti preghiere dei fedeli la salma viene restituita e rientra nella sua chiesa il 1 gennaio 1812. Si è certamente tratto di un evento straordinario se la salma non si sia disintegrata. Molte grazie vengono sempre attribuite alla intercessione della Beata Mattia e tra esse va segnalata quella elargita recentemente e registrata a Napoli il 15 gennaio 1984 in favore della bambina Anna, di-
Durante il governo napoleonico la salma della beata fu sottratta e trasferita a Macerata ma il paese si mobilitò e venne restituita
A sinistra, la facciata della chiesa dopo il restrauro (Foto di Erminio Burzacca) Qio sopra, Annunciazione, dipinto su tela di scuola marchigiana fine XV secolo Nella pagina seguente, altare maggiore con la tela dedicata alla Maddalena e attribuita al pittore jesino Domenico Valeri (Foto di Erminio Burzacca)
La ricostruzione
Trentasei anni fa una bimba affetta da una grave leucemia guarì senza spiegazione medica aveva una reliquia della beata con sé
112
chiarata dai medici inguaribile e in condizioni disperate per una grave forma di leucemia. Dopo una preghiera dei familiari e della piccola, che aveva tra le mani una reliquia della Beata, la bambina si è sentita guarita e anche nel controllo, eseguito presso l’ospedale, i medici devono riconoscere “un cambiamento radicale inspiegabile a livello scientifico”. Così la bambina e la sua famiglia hanno voluto venire a Matelica verso la fine del 1984
per ringraziare di persona la Beata Mattia (Amedeo Bricchi 1986). Le memorie per le grazie ricevute per intercessione della Beata sono testimoniate da una collezione di ex voto custodite nel Monastero ed anche Enrico Mattei è stato profondamente devoto alla Beata Mattia, una venerazione che egli era solito dire di avere appreso sulle ginocchia di sua madre, tanto che a ogni rientro a Matelica faceva sempre visita al Monastero. Nel 1956 l’on. Mattei conferisce incarico all’architetto milanese Perogalli per effettuare un sopralluogo al complesso monastico, per cui si arriva in breve tempo alla ricostruzione e all’ammodernamento dell’intero Monastero attraverso un finanziamento dell’Eni e di tutte le Società collegate. I presidenti dell’Eni devoti alla Beata Mattia In occasione del suo onomastico del 13 luglio 1962, tre mesi prima della sua morte, la Comunità delle Clarisse inviano i loro auguri al ‘’Pregiatissimo Signor Enrico per inviare un particolare augurio dal Suo e nostro monastero” e sarà questo l’ultimo contatto diretto tra l’on. Mattei e il Monastero. Negli anni successivi anche gli altri Presidenti dell’Eni Marcello Boldrini e Raffele Girotti, originari di Matelica, sono stati profondamente devoti alla Beata Mattia e attualmente l’Eni ha significativamente partecipato all’opera di consolidamento e recupero che ha permesso di riaprire ai fedeli la chiesa-santuario in tempo per le Celebrazioni del 700° anniversario del Transito in Cielo. ¤
Consiglio regionale
113
Biblioteca, un forziere di cultura delle Marche RICORRE IL 50° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DEL CENTRO
N di Claudio Desideri
Specializzata nei settori amministrativo giuridico, economico ma anche storico e sociale con migliaia di volumi
el giugno del 1970 si tennero le prime elezioni dei Consigli regionali delle 15 Regioni a statuto ordinario. Con notevole ritardo si diede concreta attuazione a quanto la Costituzione Italiana aveva stabilito nel 1948 nell’articolo 5: “La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;..” e con più precisione quanto specificato nel Titolo V con l’articolo 114: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.” Il Consiglio regionale delle Marche, una volta eletto, approvò il proprio Statuto a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. La deliberazione fu poi approvata dal Parlamento italiano divenendo legge della Repubblica, la n.345 del 22 maggio del 1971. Lo Statuto fu il primo atto legislativo regionale, la fonte primaria di tutto quanto la Regione Marche avrebbe fatto in futuro. Ma ancor prima che lo Statuto fosse vigente il Consiglio regionale aveva deliberato una serie di atti interni indispensabili al proprio funzionamento. Tra
questi, nel 1970 con la deliberazione n.18 del 29 settembre, aveva stabilito la creazione di un Centro di documentazione regionale con il compito di “provvedere alla raccolta sistematica di tutte le pubblicazioni, atti e documenti che agevolino l’esigenza di consultazione dei consiglieri, fornendo loro strumenti critici e di analisi per il miglior adempimento delle proprie funzioni.” Il Centro di documentazione nasceva quindi con il compito esclusivo di supporto all’attività legislativa del Consiglio. Un patrimonio così ampio di atti, documenti legislativi, libri, riviste, banche dati non poteva però restare chiuso su sé stesso e così il Consiglio regionale decise di aprire la struttura a tutta la comunità civile marchigiana fornendo a chiunque lo chiedesse, aiuto e supporto per studi, ricerche e tesi di laurea. Il Centro fu suddiviso in settori funzionali: documentazione, biblioteca, emeroteca, biblioteca marchigiana. A definire quelli che poi saranno i pilastri della futura Biblioteca del Consiglio fu il direttore Sandro Urbani, che dedicò il suo impegno a far sì che il Centro, divenuto nel tempo Ufficio documentazione e biblioteca, fosse in grado di dare le migliori risposte al bisogno di informazione che il personale della Regione ed i cittadini richiedevano. La struttura, una volta aperta al pubblico, divenne luogo sempre più frequentato da professionisti, studenti, semplici cittadini. Dopo la direzione trentennale di Urbani fu chiamata a dirigere la Biblioteca Simonetta Ceccarelli che dedicò molte delle sue energie al consolidamento e ampliamen-
Consiglio regionale
114 to della Biblioteca Marchigiana che è uno dei patrimoni culturali, storici e sociali più importanti nella nostra regione. Oggi, Direttrice della Biblioteca è Alberta Ciarmatori che con passione si dedica a questa struttura e ci ha fornito dati e documenti necessari a comprendere meglio il valore inestimabile di questa istituzione. Il prossimo giugno 2020 ricorre il 50° anniversario della nascita della Regione Marche e quindi della nascita
Conserva il patrimonio librario e documentale del Consiglio regionale e consente l’accesso alle banche dati
della Biblioteca del Consiglio regionale che negli anni si è evoluta da luogo di conservazione e prestito ad una forma più attuale e moderna di conoscenza arricchendosi di molteplici attività che l’hanno portata ad essere un punto di riferimento culturale per tutte le Marche. Entrando nei particolari possiamo dire che la Biblioteca conserva il patrimonio librario e documentale del Consiglio regionale, consente l’accesso bibliografico e alle banche dati, esegue il prestito e fornisce documentazione a chi ne fa richiesta. In particolare è specializzata nelle materie più attinenti all’attività e alle competenze della Regione,
quindi nei settori amministrativo, giuridico, economico ma anche storico e sociale. Per legge è depositaria legale per tutto il territorio regionale. Una legge che obbliga l’editore a consegnare una copia di tutto quanto è edito nelle Marche. Questo fa si che la Biblioteca è un forziere di cultura regionale unico nel suo genere dove ogni libro scritto da un marchigiano in qualsiasi ambito dello scibile o che racconta del nostro territorio è tutelato e conservato per i cittadini di oggi e per le future generazioni. Documenti che chiunque “senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità o condizione sociale” può conoscere e consultare. L’enorme patrimonio di cui dispone è suddiviso in più sezioni: la sezione giuridica con oltre 25.000 monografie, 231 periodici correnti, cd rom e 23 banche dati specialistiche nei settori giurisprudenziali, della dottrina e della bibliografia giuridica, della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti, della legislazione europea, nazionale e regionale. Materiale cui accedono cittadini, studenti e giovani professionisti. Come già detto sopra la sezione più “preziosa” è la Biblioteca Marchigiana che conta oltre 12 mila monografie, tutte pertinenti alla storia, alla cultura e all'arte del territorio regionale, e 400 periodici correnti curati da Comuni, associazioni e istituzioni regionali, fonti insostituibili per meglio interpretare le esigenze e le culture locali. Vi sono poi i Fondi speciali, biblioteche donate alla Regione che formano una raccolta a sé stante e indivisibile rispetto al resto del patrimonio librario: il Fondo Santarelli, donato dallo storico marchigiano Prof. Enzo Santarelli, composto da oltre 6.500 volumi di storia, politica e società; il Fondo Barca, donato dagli eredi di Luciano Barca, noto giornalista, scrittore e
Consiglio regionale
politico italiano, costituito da circa 6.000 monografie, riviste, saggi e appunti dello stesso Barca; il Fondo Jaques Maritain, donato dal Prof. Giancarlo Galeazzi, costituito da circa 3.000 volumi in italiano e francese riguardanti la figura e l’opera del famoso filosofo francese con opere di studiosi italiani e autori marchigiani ispirati dal filosofo. La Biblioteca del Consiglio regionale aderisce al Sistema Bibliotecario regionale, attualmente organizzato in due poli: Marche Nord e Marche Sud. Tutto il patrimonio della Biblioteca è ora consultabile attraverso la piattaforma BiblioMarcheNord, il catalogo unificato delle biblioteche delle province di Ancona e Pesaro e Urbino, costituito dal patrimonio di biblioteche di diversa tipologia e dimensione: universitarie, comunali, statali, di istituti, fondazioni e associazioni con circa 1 milione e mezzo di notizie. Il Sistema bibliotecario consente agli utenti l’accesso ai documenti extra Polo del territorio nazionale quindi accedere al servizio di prestito interbibliotecario e document delivery. Le biblioteche che aderiscono al Sistema regionale condividono una stessa piattaforma, SebinaOpenLibrary, per tutte le operazioni di gestione dei servizi (iscrizioni, prestiti, catalogazione, ecc.) Accanto a questo “mare di conoscenza” messo a disposizione degli utenti, la Biblioteca del Consiglio regionale svolge una attività di comunicazione istituzionale e promozione dell’attività consiliare. In particolare coordina e gestisce progetti per giovani cittadini: “Conoscere il Consiglio”, “Visita a Palazzo”, “Vieni in Biblioteca”, “Alternanza scuola/lavoro”, “Percorsi di competenze trasversali e di orientamento”, “Laboratori per la progettazione di proposte di legge”. Iniziative che nel 2019 hanno coinvolto oltre mille ragazzi.
115 Sono azioni formative rivolte alla legalità, interculturalità, pari opportunità che rendono la Biblioteca uno spazio in cui è possibile sperimentare e contribuire a costruire una società migliore fatta di cittadini attenti e responsabili. Vi è poi l’attività di divulgazione e valorizzazione dei libri in deposito legale presso la Biblioteca, “Libri Fuoriteca”, con la presentazione di opere di autori marchigiani e incontri con gli autori. Azioni svolte anche per i “Quaderni del Consiglio”, la collana editoriale dell’Assemblea legislativa con testi scritti da autori marchigiani o che parlano delle Marche. La Biblioteca organizza mostre e attività culturali, in particolare in occasione di giornate o eventi speciali. Da più di venticinque anni partecipa al Salone Internazionale del Libro a Torino ed è stata la prima istituzione pubblica marchigiana a partecipare a quello che è considerato uno degli eventi più importanti legati al libro in Europa. Fa parte della Cittadella della Cultura, lo spazio compreso all’interno del Consiglio regionale, che vede in un’unica sede la Biblioteca, l’Associazione Marchigiana Attività Teatrali, il Consorzio Marche Spettacolo, la Fondazione Marche Cultura e la Fondazione Orchestra regionale Marche. Nel 1995 l’Unesco ha approvato il Manifesto sulla biblioteca pubblica: “via di accesso locale alla conoscenza costituisce una condizione essenziale per l’apprendimento permanente, l’indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell’individuo e dei gruppi sociali”. La Biblioteca del Consiglio regionale, con le sue collezioni ed il suo personale altamente qualificato, risponde appieno a questi intenti essendo luogo capace di adempiere ai bisogni conoscitivi che la Comunità marchigiana costantemente richiede. ¤
La biblioteca gestisce progetti svolge un’attività di comunicazione istituzionale e promozione dell’attività consiliare
Nelle immagini alcuni spazi all'interno della biblioteca regionale delle Marche e i partecipanti ai progetti organizzati dai responsabili della struttura
Passato e futuro
U di Stefano Mascioni
n volo lungo oltre un secolo. E’ quello dell’aeroporto più antico delle Marche, lo scalo “Enzo e Walter Omiccioli” di Fano, un gioiello della storia aeronautica marchigiana che ha messo le sue prime radici nel 1913 e che oggi è più vivo che mai. Mentre l’aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio” fu realizzato a partire dal 1929, già l’11 marzo del 1913, la “Città della fortuna” viveva la sua prima, acerba emozione aeronautica. Impegnato nella pioneristica trasvolata Venezia-Roma a bordo di un Bleriot, il pilota austro unga-
rico nato a Trieste e naturalizzato italiano Gianni Widmer (1892-1971) si trovò con la sua macchina volante in panne proprio mentre stava sorvolando i cieli fanesi. Dopo un atterraggio di fortuna nella zona del mare, nel quartiere orti, Widmer rimase in città per una ventina di giorni, necessari per recuperare i pezzi e riparare il Bleriot; Widmer fu accolto ed osannato come un eroe, considerando che i fratelli Wright avevano fatto il primo volo della storia con una macchina “più pesante dell’aria” solo nel 1903. Widmer decollò di nuovo intor-
117
Aeroporto di Fano oltre un secolo sulle gloriose ali della storia È LO SCALO PIÙ ANTICO DELLE MARCHE, UN VERO E PROPRIO GIOIELLO INTITOLATO AI PILOTI ENZO E WALTER OMICCIOLI PLURIDECORATI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
no ad aprile del 1913 da una spianata in piazza d’Armi, nei pressi dell’attuale stazione ferroviaria, dando inizio a una storia straordinaria. Negli anni a seguire, ci fu qualche altro episodio aeronautico, ma bisognerà attendere la prima guerra mondiale per lo sviluppo del primo vero e proprio “campo di atterraggio”, ultimato nel settembre del 1917 proprio nella zona dove sorge ancora oggi. Il governo fascista puntava molto sull’aeronautica come mezzo di sviluppo e propaganda e con il favore dei gerarchi, il primitivo aeroporto fanese crebbe d’importanza
di anno in anno, fino ad essere “promosso” nel 1930 a “campo di fortuna e manovre aeree” diventando tappa ufficiale, il 25 e 26 agosto, del primo “Giro aereo d’Italia” dove il podestà invitò tutta la popolazione “cittadina e rurale” per “memorabili giornate aviatorie alle quali parteciperanno gli assi della Aviazione Italiana”. Quello che era un aeroporto appena abbozzato, divenne una realtà aeronautica vera e propria nel 1936, quando si decise la costruzione di una struttura ben attrezzata su un’area complessiva di circa 67 ettari, che comprendeva
anche una scuola piloti. I lavori accelerarono con l’avvicinarsi del secondo conflitto mondiale e nel maggio del 1940 l’aeroporto di Fano era ormai completo, con l’edificazione di imponenti hangar in acciaio e muratura e caserme annesse per l’alloggio degli allievi piloti che arrivavano da tutta Italia. Il 5 settembre del 1940, Benito Mussolini in persona volle visitare la nuova struttura, incontrando le centinaia di allievi piloti e l’intera comunità radunatasi per l’occasione. Tra loro anche i fratelli fanesi “Walter ed Enzo Omiccioli”, medaglia d’oro al
Passato e futuro
Nel 1940 Mussolini volle visitare la struttura che il governo fascista attrezzò con hangar e alloggi per allievi piloti
Nella foto in alto, un momento della visita di Benito Mussolini all'aeroporto di Fano e la targa commemorativa di Enzo Omiccioli Medaglia d'Oro al Valore Militare
118 valore militare, ai quali è stato dedicato l’aeroporto nel 2017. Durante la seconda guerra mondiale, l’aeroporto di Fano crebbe moltissimo in termini di importanza strategica, anche perché collocato perfettamente all’interno della linea gotica; sulla sua pista atterrarono centinaia di aerei tedeschi prima e degli alleati poi. Consapevoli del valore strategico dell’aeroporto, nel luglio del 1944, i tedeschi in ritirata verso nord danneggiarono profondamente la pista fanese e demolirono gli alloggi e le caserme proprio per evitare che una struttura così importante cadesse in mano nemica perfettamente efficiente. Una volta impadronitisi dell’aerodromo però, gli anglo americani lo rimisero subito in funzione e i fanesi, increduli, poterono vivere per mesi osservando un intenso traffico di velivoli che segneranno il destino del conflitto. Spitfire, Hurricane, Thnderbolt e B25 decollavano proprio da Fano per dirigersi sulla Germania e portarla alla capitolazione finale. Con la fine della guerra, l’aeroporto di Fano entrò in una fase difficile, di semi abbandono. L’Italia pensava a far ripartire le imprese, alla ricostruzione e la struttura rimase silenziosa fino al 1953, quando l’Aero Club Pesaro scelse l’aeroporto di Fano come propria sede e come struttura scolastica, riprendendo le lezioni di volo ma questa volta dedicate esclusivamente a piloti civili, che avevano scelto l’aeronautica come propria passione e attività ricreativa. Si deve all’interessamento del pesarese Carlo Cucchi, funzionario provinciale con la passione del volo, pilota durante la seconda guerra mondiale, la sistemazione della pista in erba. Con l’economia che riprendeva e il “miracolo italiano” che motorizzava il Paese, il numero dei brevetti rilasciati crebbe moltissimo, specialmente negli anni 60, tanto che nel
marzo del 1962, anche Maddalena Schiavi, prima pilota donna fanese, conseguì le sue ali, rendendo lo sport aeronautico ancora più popolare e diffuso. Nel 1963, all’aeroporto di Fano arrivarono anche le Frecce Tricolori, che si esibirono in una straordinaria serie di acrobazie aeree. Con gli anni ’70, arrivò anche lo sviluppo dell’attività di paracadutismo, una specialità oggi fiore all’occhiello dell’aeroporto. Basti pensare che nel 1977 persino la gloriosa brigata Folgore effettuò una serie di lanci d’addestramento proprio nell’aeroporto fanese. Gli anni 80 consacrarono la fama dell’aeroporto di Fano, dal quale partirono moltissimi piloti in grado di competere e vincere il giro d’Italia aereo e il campionato mondiale, sia individuale sia a squadre. La vecchia struttura fascista però era ormai obsoleta e incapace di contenere tutti gli aerei e tutti i piloti e i paracadutisti che frequentavano lo scalo, fu così che nel 1995
Passato e futuro
venne inaugurato il nuovo aeroporto che sorge esattamente dove si trova ancora oggi, dedicato in un primo momento al pilota fanese Enzo Omiccioli e poi, nel 2017 in occasione delle celebrazioni per il centenario, anche a suo fratello Walter, entrambi gli Omiccioli sono piloti pluridecorati. Enzo in particolare, maresciallo di terza classe, fu insignito della medaglia d’oro al valore militare alla memoria. Il 3 febbraio del 1941 nei cieli di Gondar, in Etiopia, affrontò da solo uno squadrone di sei Gloster Radiator britannici, salvando aerei e piloti italiani a terra, ma pagando l’atto eroico con la vita. Un grande terminal, composto prima da due poi da tre ampi hangar, completato da una moderna aerostazione con servizi e un attivissimo ristorante. Proprio nel 2017, venne fondato l’Aero Club Fano (nel frattempo l’Aero Club Pesaro aveva chiuso i battenti) evoluzione del precedente Fly Fano Club, che organizzò le celebrazioni del
119
centenario e lanciò la nuova manifestazione “Paradrenalina” evento dedicato ai disabili, che ogni anno sono ospiti della struttura e possono passare una giornata speciale, volando sul mare con gli aerei e i piloti dell’Aero Club e della Eagles Aviation Academy. Proprio la Eagles Aviation Academy è oggi una delle più importanti scuole di volo italiane, una struttura d’eccellenza che sotto la direzione del comandante Davide Cecchini, forma piloti professionisti che poi trovano lavoro nelle linee aere di tutto il mondo; una realtà fondamentale sia per la vitalità dell’aeroporto sia per l’offerta di posti di lavoro sicuri ai giovani che intendono vivere di aeronautica. Altro cardine della vita aeroportuale fanese è l’associazione Ali Marche, interamente dedicata all’attività di paracadutismo, che ha raggiunto ormai importanza a livello europeo e che viene utilizzata anche per girare film e trasmissioni televisive che parlano di paracadutismo o
Da Fano, dopo la ritirata tedesca decollarono gli aerei anglo-americani diretti in Germania Poi momenti difficili fino al 1953
Al centro pagina, il dirigibile svizzero in sosta a Fano nel luglio 2004 Dall'alto, Maddalena Schiavi, la prima pilota fanese nel 1962; il pilota istruttore Carlo Cucchi (a sinistra) con il meccanico Pedini infine una foto del centro di controllo aereo realizzato dagli alleati che utilizzarono l'aeroporto come base per i bombardamenti
Passato e futuro
120
Negli anni, oltre alla scuola di volo si sviluppò anche l’attività di paracadutismo, che ha raggiunto livelli europei
In alto l'aeroporto di Fano oggi Qui sopra di seguito, un momento di Paradrenalina; il sindaco Massimo Seri riceve il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Generale S.A. Alberto Infine, un'altra immagine dello scalo fanese
che vedono nel paracadutismo un’attività primaria. A Fano l’aeronautica trova applicazione in tutte le sue sfaccettature e oltre a poter vantare una primaria associazione aeromodellistica, titolare di una delle poche piste in cemento italiane espressamente dedicata al volo dei radio modelli, lo scalo fanese è un punto di riferimento fondamentale per l’addestramento dei piloti del 15° stormo SAR di Cervia, il reparto elicotteri specializzato nel soccorso aereo in tutto il Paese, che interviene h24 e con ogni condizione di tempo in caso di calamità naturali ed emergenze. Gli ultimi investimenti della Regione Marche sono andanti proprio nella valorizzazione della struttura aeroportuale in termini di supporto alla protezione civile e alle emergenze sanitarie, tanto che in questi mesi verranno completati i lavori di adeguamento per permettere l’atterraggio del servizio eliambulanze della Regione anche di notte. Insomma, quella dell’aeroporto di Fano è una storia
lunga oltre un secolo, fatta di continui passi avanti e sviluppi, la comunità aeroportuale attende da molto tempo la realizzazione di una pista in cemento e asfalto, che migliorerebbe molto la sicurezza e la praticabilità della pista ma che ancora non si è riusciti a realizzare per la mancanza di una politica di sviluppo chiara. Il progetto infatti è quello di mettere l’aeroporto “Fratelli Omiccioli” a servizio del turismo aeronautico e dell’arrivo di piccoli aerei, anche business, che potrebbero contribuire alla crescita turistica e imprenditoriale del territorio, permettendo anche alla scuola di volo di fare il definitivo salto di qualità. Gli oltre 100 ettari del sedime aeroportuale, intorno al quale sta nascendo anche il parco urbano, che la città attende da anni, sono un patrimonio ricco di storia e di significati, pronto a sfidare il tempo e a guardare allo sviluppo futuro con un grande passato. L’aeroporto più antico delle Marche, può davvero aiutare la regione ad attrarre turismo sostenibile. ¤
Un frutto antico
121
Melograno, simbolo di fecondità e di morte OGGI È UNA DELLE PIANTE PIÙ PITTORESCHE DEI GIARDINI
di Marco Belogi
L’
albero del melograno, botanicamente Punica granatum, produce un frutto che i latini chiamavano malum punicum ovvero melo fenicio perché ritenevano provenisse dall’area siro-fenicia, dove la mitica Side, nome greco della melagrana, veniva considerata l’eroina fondatrice di Sidone. In realtà proviene da una zona che si estendeva dal Punjab, in India, ai territori a sud del Caucaso; ma fin dall’antichità si era diffuso in Asia Minore e poi nei paesi mediterranei. Oggi è una delle piante più pittoresche dei nostri giardini dove offre incanti misteriosi e pieni di fascino dalla primavera all’inizio dell’inverno quando perde repentinamente le foglie caduche di un giallo brillante. All’inizio della bella stagione spuntano foglioline
La pianta proviene da una zona del Punjab, in India fino ai territori a sud del Caucaso diffondendosi nei paesi mediterranei
di un colore rossiccio che poi trascolora nel verde. Nel segno dei gemelli sbocciano i primi fiori, simili a campanule, che si aprono come una stella a sei punte: anch’essi di un rosso vermiglio. Dai
fiori fecondati nascerà il frutto simile a una grossa bacca, regale e feconda che, maturando in autunno, assumerà varie gradazioni di rosso, mentre al suo interno serba innumerevoli semi sanguigni. Secondo i numerosi miti arcaici la melagrana è un attributo della Grande Madre, regina del Cosmo, nel suo duplice ruolo di Colei che dà la vita e Colei che la toglie. Simbolo, dunque, sia della Fecondità sia della Morte, tant’è vero che melegrane d’argilla si sono trovate nelle tombe greche dell’Italia meridionale. Nell’iconografia classica la dea Core-Persefone viene spesso ritratta con il fiore o il frutto del melograno. Core, infatti, scende periodicamente negli inferi, ovvero muore come vergine per trasformarsi in madre. Come la luna diventa periodicamente nera unendosi al sole durante il novilunio, così Core scende ogni anno negli inferi per congiungersi con Ade a ri-generare il Cosmo. Mito dunque della tradizione precristiana che vede la melagrana come simbolo del rinnovamento del cosmo, nella sua perenne rigenerazione ad opera della Grande Madre nel ciclo eterno di vita-morte-vita genera. Gli innumerevoli grani del frutto hanno da sempre evocato fecondità e abbondanza. Per questo i Romani ornavano il capo delle spose con rametti di melograno; e ancora oggi nel Vietnam si canta “la melagrana si apre e lascia venire cento figli”, mentre in Turchia la sposa getta a terra la melagrana: avrà tanti figli, si dice, quanti sono i chicchi usciti dal frutto. Questo mito pagano della melagrana non poteva non esse-
Un frutto antico
122
I romani ornavano le spose con rametti di melograno per evocare fecondità Nell’Antico Testamento è simbolo di femminilità
Nella pagina precedente Madonna della melagrana Beato Angelico, Museo del Prado e in alto un particolare della stessa opera Qui sopra, Madonna melagrana di Sandro Botticelli
re accolto anche nel mondo cristiano. Il frutto si ritrova nell’Antico Testamento quale simbolo della Femminilità, ma anche della Fecondità e della Prosperità. San Giovanni della Croce, grande mistico e dottore della Chiesa, nel Cantico Spirituale fa dire alla Sposa, simbolo dell’anima, che si rivolge all’Amore, ovvero a Cristo: “godiamoci l’un l’altro, Amato |e andiamo a rimirarci nella tua bellezza…|e gusteremo il succo di melegrane”. Il succo della melagrana è ciò che l’anima riceve dalla conoscenza dell’Amore di Cristo. Come d’altronde afferma nel Cantico dei Cantici l’Amata al suo Diletto: “Là tu mi ammaestrerai, e io ti darò una bevanda di vino aromatico, e il succo delle mie melegrane”. Con queste brevi premesse diventa facile l’interpretazione della Madonna
del Granato del Carpaccio e la Madonna della melagrana del Botticelli. Diverso invece il significato profano della melagrana a cui poeti del Novecento si sono ispirati. Carducci nello struggente ricordo del figlio scomparso, suo “estremo unico fior”, lo rivede nel giardino con la mano tesa verso l’albero del verde melograno dai bei vermigli fior. D’Annunzio volle nel vestibolo della Prioria, al Vittoriale degli Italiani, sopra una colonna di pietra, dono della città di Assisi al poeta, un canestro colmo di melegrane. Quei frutti, in vetro, in pietra, in rame, dipinti o dissecati, sparsi in ogni stanza, non erano una decorazione casuale. Rappresentavano la sua fecondità artistica tanto da intitolare nel 1898 un ciclo narrativo, mai portato a termine, “i Romanzi del melograno”. ¤
Uno sguardo alla natura
123
Mirto, vigore agli atleti e bellezza agli egiziani TRA MITOLOGIA, LEGGENDE ARABE, PITTORI E POETI
I di Ettore Franca
I romani con le bacche di mirto insaccavano le carni E nel Medioevo si maceravano i fiori per ottenere l’acqua degli angeli
l mirto (Myrtus communis) è un arbusto spontaneo della macchia mediterranea ed ha la corteccia e i rami rossiccio-grigi, le foglie piccole e verdi; fiorisce a giugno con fiorellini biancastri che produrranno bacche blu-scuro con le quali si prepara un liquore digestivo. Infondendo i germogli e si ottiene il “mirto bianco”. I fiori non producono nettare ma i loro oli essenziali, contribuiscono al miele di altre piante e, macerando i fiori per le proprietà balsamiche, dal medioevo si otteneva l’acqua degli angeli o, fermentando le bacche col miele e l’acqua si preparava il vino di mirto, progenitore del liquore di oggi. La gastronomia sarda, col mirto aromatizza le carni, il “maialetto”, “sa taccula„ - uccellagione bollita- e le olive in salamoia; col mirto si conciava il cuoio, si profumava bian-
cheria mentre i Romani con le bacche del mirto insaccavano le carni (myrtarium), oggi “mortadella”. Per i Greci il nome “μύρτος” deriva da Myrsine, la fanciulla uccisa da un giovane da lei sconfitto nei giochi e che Atena, impietosita, trasformò nell’arbusto. Altri dicono che Dioniso, per liberare la madre Selene dagli Inferi, l’aveva barattata col mirto che, da allora, decorava le tombe. Secondo la mitologia, Afrodite - dea della bellezza - nata dal mare sulla spiaggia di Cipro, venne presa di mira dai satiri e la poveretta dovette nascondersi in una macchia di mirto. La pianta fu prediletta dagli atleti perché portasse vigore mentre gli Egiziani la usavano per abbellirsi durante le feste. Secondo Ovidio, invece, Afrodite-Venere, nata sul mare di Citara, oggi Forìo d’Ischia, sulla spiaggia si coprì col mirto,
Uno sguardo alla natura
124
Per i greci il nome deriva da Myrsine la fanciulla uccisa da un giovane da lei sconfitto e che Atena trasformò nell’arbusto
preso a simbolo di vittoria durante la stand ovation quando il Senato col “mirto di Venere vittoriosa” incoronava il vincitore di una guerra, se era stata una … guerricciola. Plinio ricorda il “myrtus coniugalis” propiziatorio nelle feste nunziali come sono ancora i rametti nel bouquet della sposa. Una leggenda araba vuole che Adamo, cacciato dal paradiso, come souvenir avrebbe sottratto un mirto. Collegato alla femminilità lo ricorda Archiloco, poeta del VII sec. a.C.: “Con una fronda di mirto giocava ed una fresca rosa, / e la sua chioma le ombrava lieve e l’omero e le spalle”, ma i richiami continuano in molti altri poeti fra i quali
Poliziano ne Il regno di Venere dove “… el mirto, che sua dea sempre vagheggia, di bianchi fiori e verdi capelli orna” e Foscolo, ne “All’amica risanata”, con “…e quella a cui di sacro / mirto te veggo cingere …”, o “La pioggia nel pineto” di D’Annunzio dove “… piove sulle tamerici / salmastre ed arse / piove sui pini / piove sui mirti / divini…”. In pittura, il mirto è nella “Venere e Cupido” di Lorenzo Lotto, dove Cupido, scanzonato e irriverente richiamo all’erotismo, fa pipì nella ghirlanda di mirto e sul ventre di Venere. E compare nel “Nascita di Venere”, del Botticelli dove la fanciulla accorre col rametto dell’arbusto o ne “L’Unione felice” di Paolo Veronese. ¤
L’associazione
125
LE CENTO CITTA’ Associazione per le Marche Fondata nel 1995 “L’Associazione si pone lo scopo di promuovere e coordinare studi ed azioni finalizzati a rafforzare l’identità culturale della Regione Marche e a favorirne lo sviluppo economico e sociale attraverso la conoscenza e la valorizzazione delle realtà esistenti, il recupero e la tutela del passato, la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, la partecipazione al dialogo culturale interregionale ed europeo, nonché con le comunità marchigiane all’estero.” (Art.3 dello Statuto)
Presidenti
Giovanni Danieli
(marzo 1995 – dicembre 1996)
Catervo Cangiotti
(gennaio 1996 – dicembre 1997)
Folco Di Santo
(gennaio 1998 – dicembre 1999)
Alberto Berardi
(gennaio 2000 – dicembre 2001)
Evio Hermas Ercoli
(gennaio 2002 – dicembre 2003)
Mario Canti
(gennaio 2004 – luglio 2005)
Enrico Paciaroni
(agosto 2005 – dicembre 2006)
Tullio Tonnini
(gennaio 2007 – dicembre 2007)
Bruno Brandoni
(gennaio 2008 – luglio 2008)
Alberto Pellegrino
(agosto 2008 – luglio 2009)
Walter Scotucci
(agosto 2009 – luglio 2010)
Maria Luisa Polichetti (agosto 2010 – luglio 2011)
Ettore Franca
(agosto 2011 – luglio 2012)
Natale Frega
(agosto 2012 – luglio 2013)
Maurizio Cinelli
(agosto 2013 – luglio 2014)
Giovanni Danieli
(agosto 2014 – luglio 2015)
Luciano Capodaglio
(agosto 2015 – luglio 2016)
Marco Belogi
(agosto 2016 – luglio 2017)
Giorgio Rossi
(agosto 2017 – luglio 2018)
Mara Silvestrini
(agosto 2018 – luglio 2019)
Le Cento Città Direttore responsabile Franco Elisei Direttore editoriale Maurizio Cinelli Comitato editoriale Marco Belogi Fabio Brisighelli Claudio Desideri Giordano Pierlorenzi Claudio Sargenti Mara Silvestrini
Anno XXV
Direzione, redazione amministrazione Associazione Le Cento Città redazionecentocitta@ gmail.com
Progetto grafico Poliarte Accademia di design Ancona Coordinamento progetto grafico e impaginazione Prof. Sergio Giantomassi Stampa Errebi Grafiche Ripesi Falconara M.ma Presidente Le Cento Città Donatella Menchetti
Sede Via Asiago 12 60124, Ancona Poste Italiane Spa spedizione in abbonamento postale 70% CN AN Reg. del Tribunale di Ancona n.20 del 10/7/1995 Rivista riconosciuta come bene culturale di interesse storico dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
70/71|2020
“...Raffaello dal quale, mentre era in vita, la Natura temette di essere vinta e, quando morì, temette di morire anch’essa”
25° dal 1995