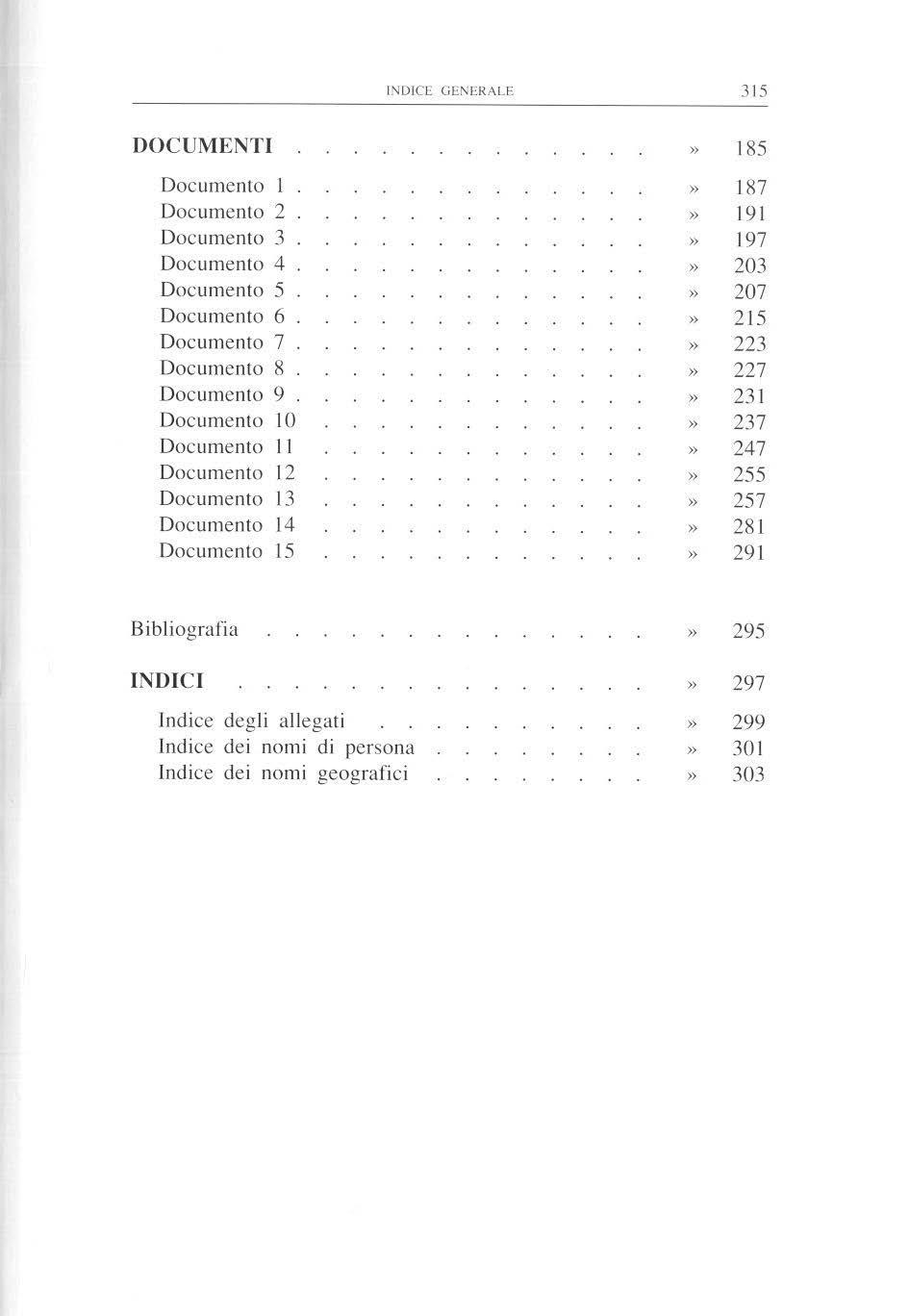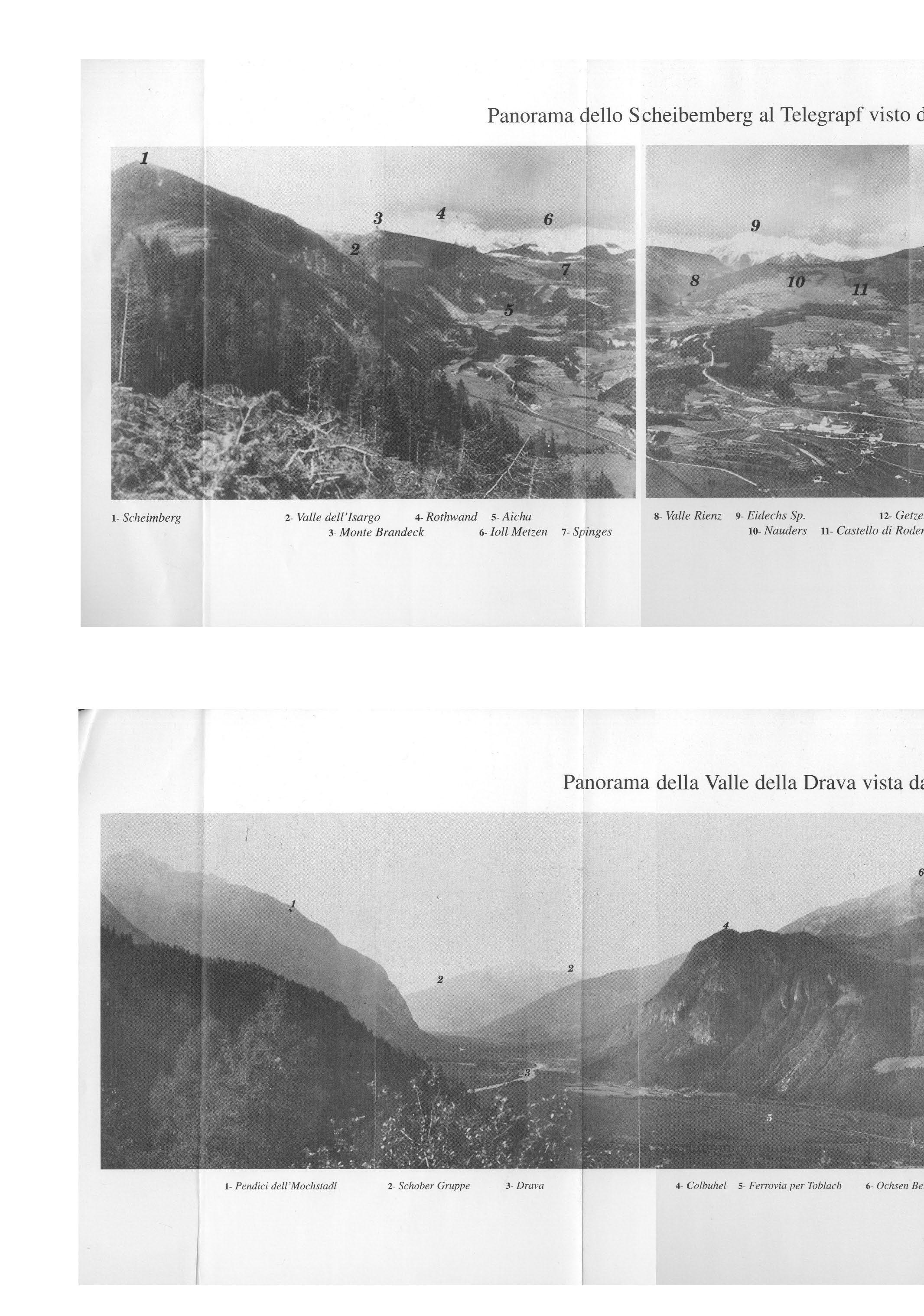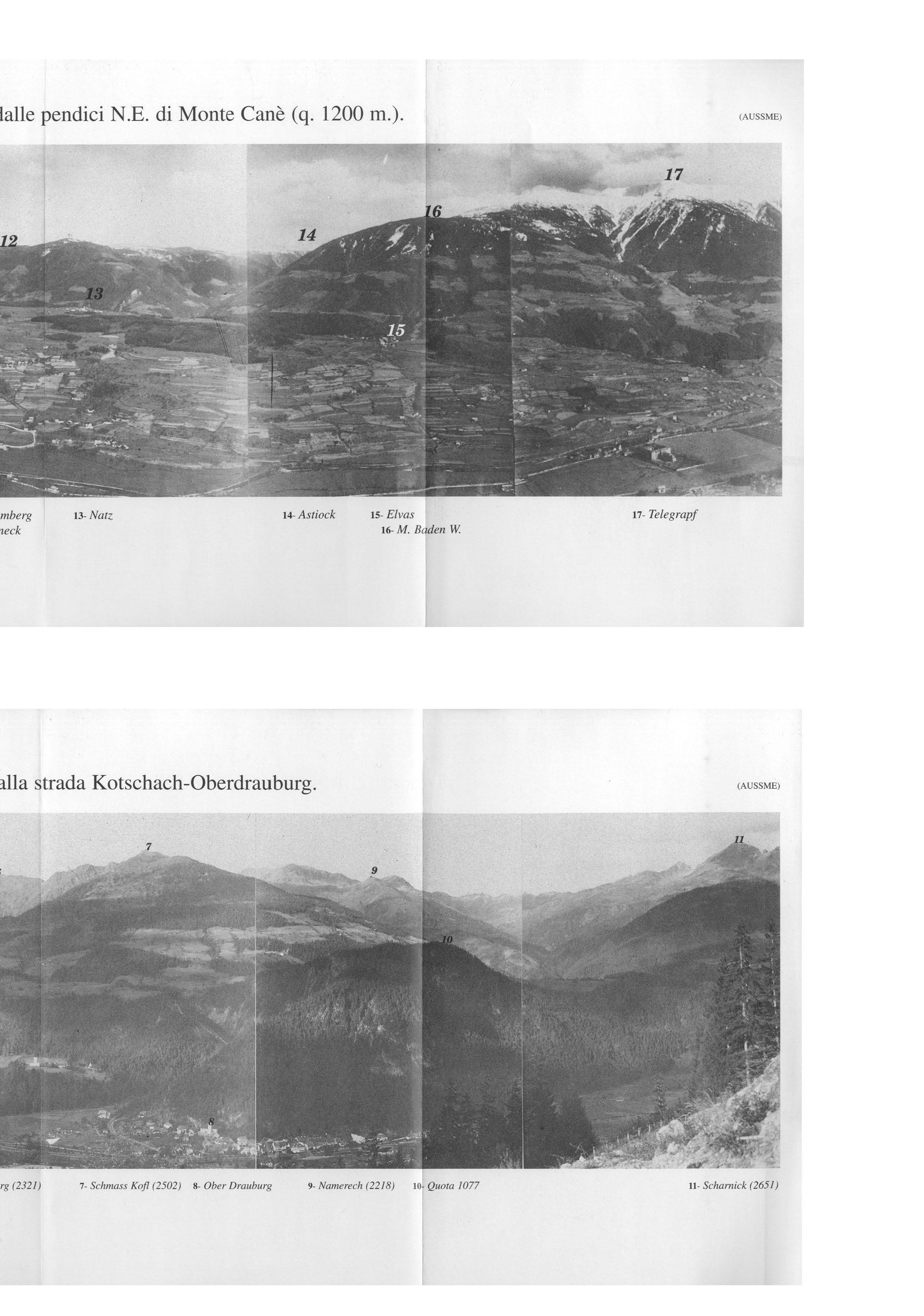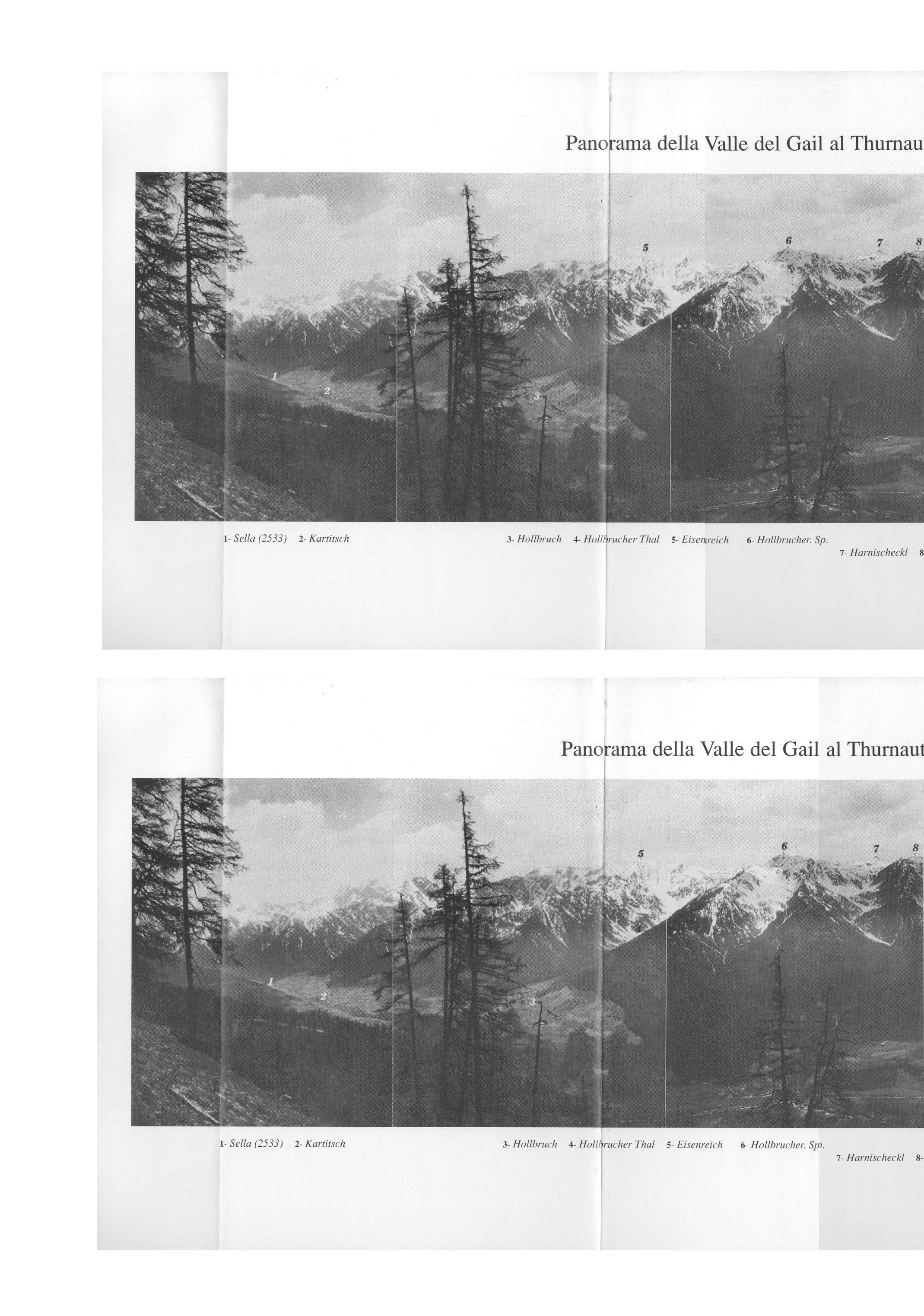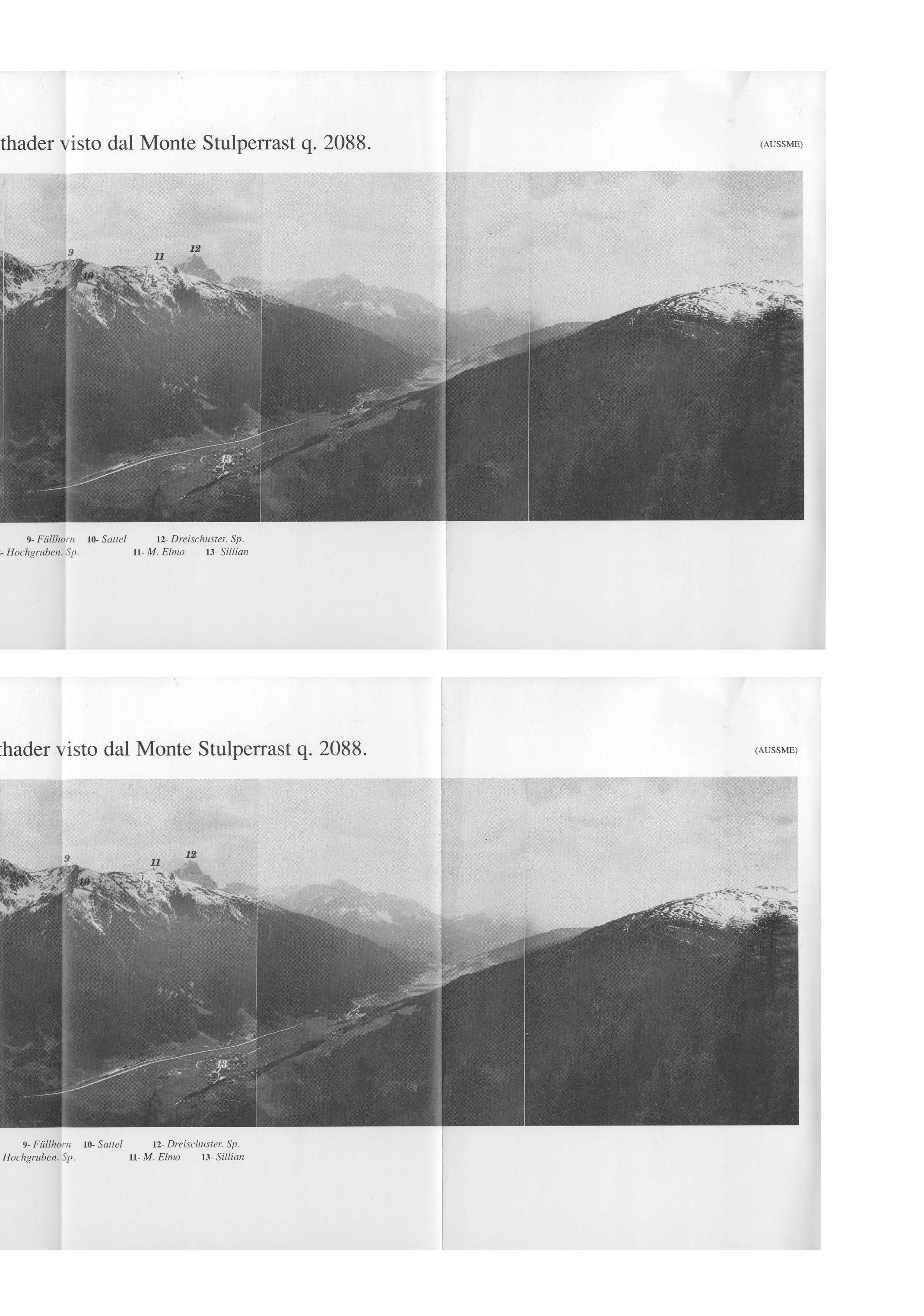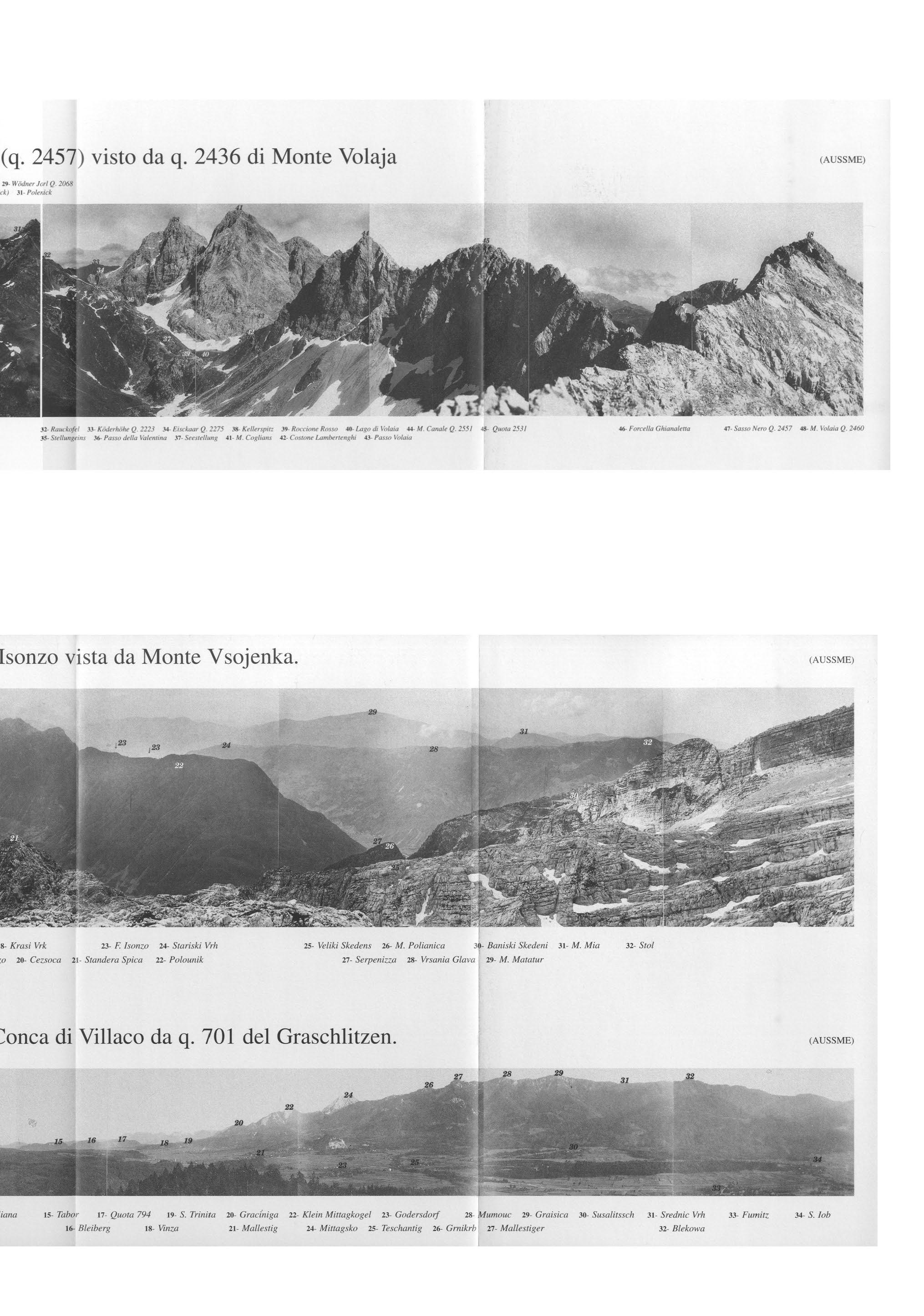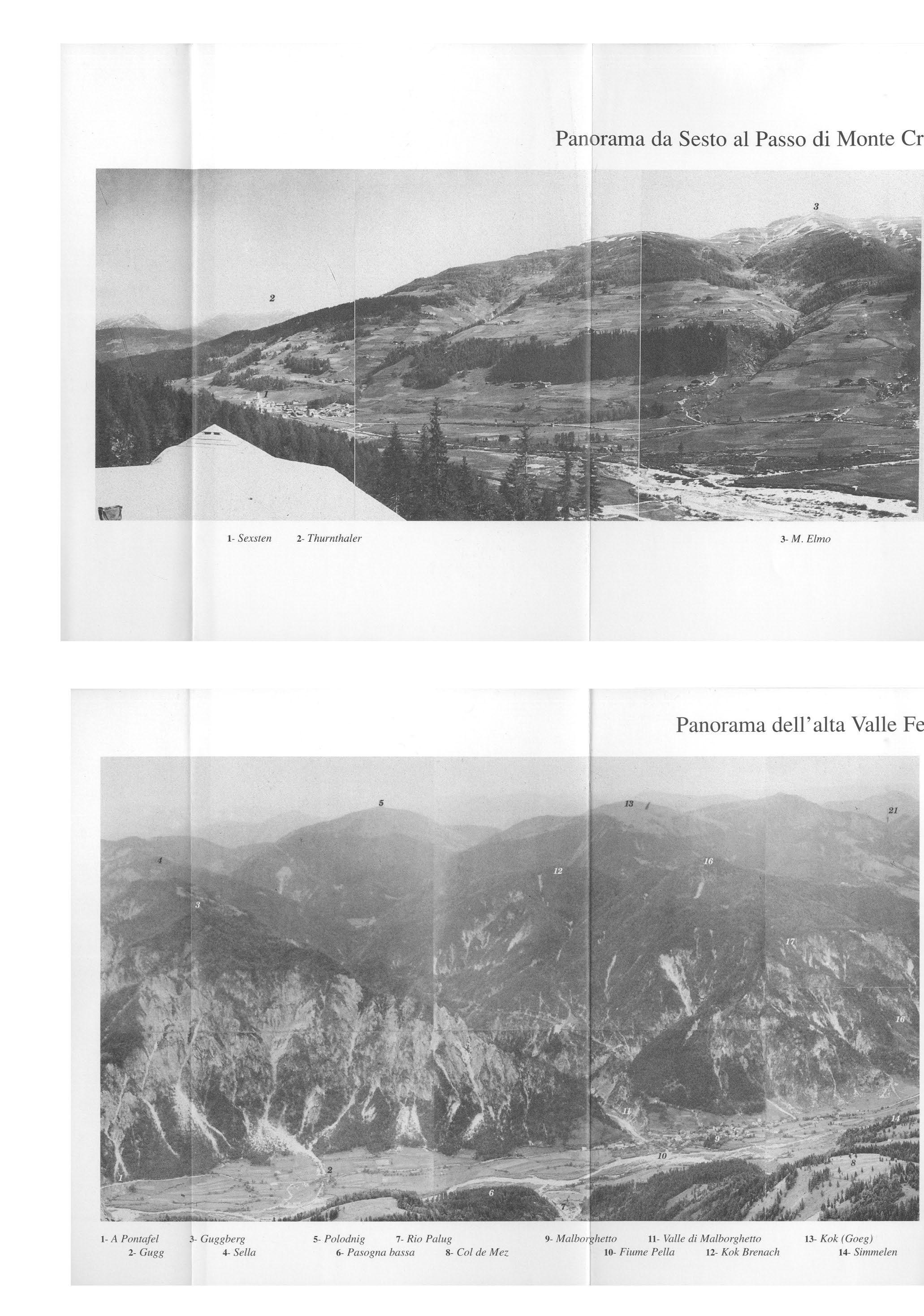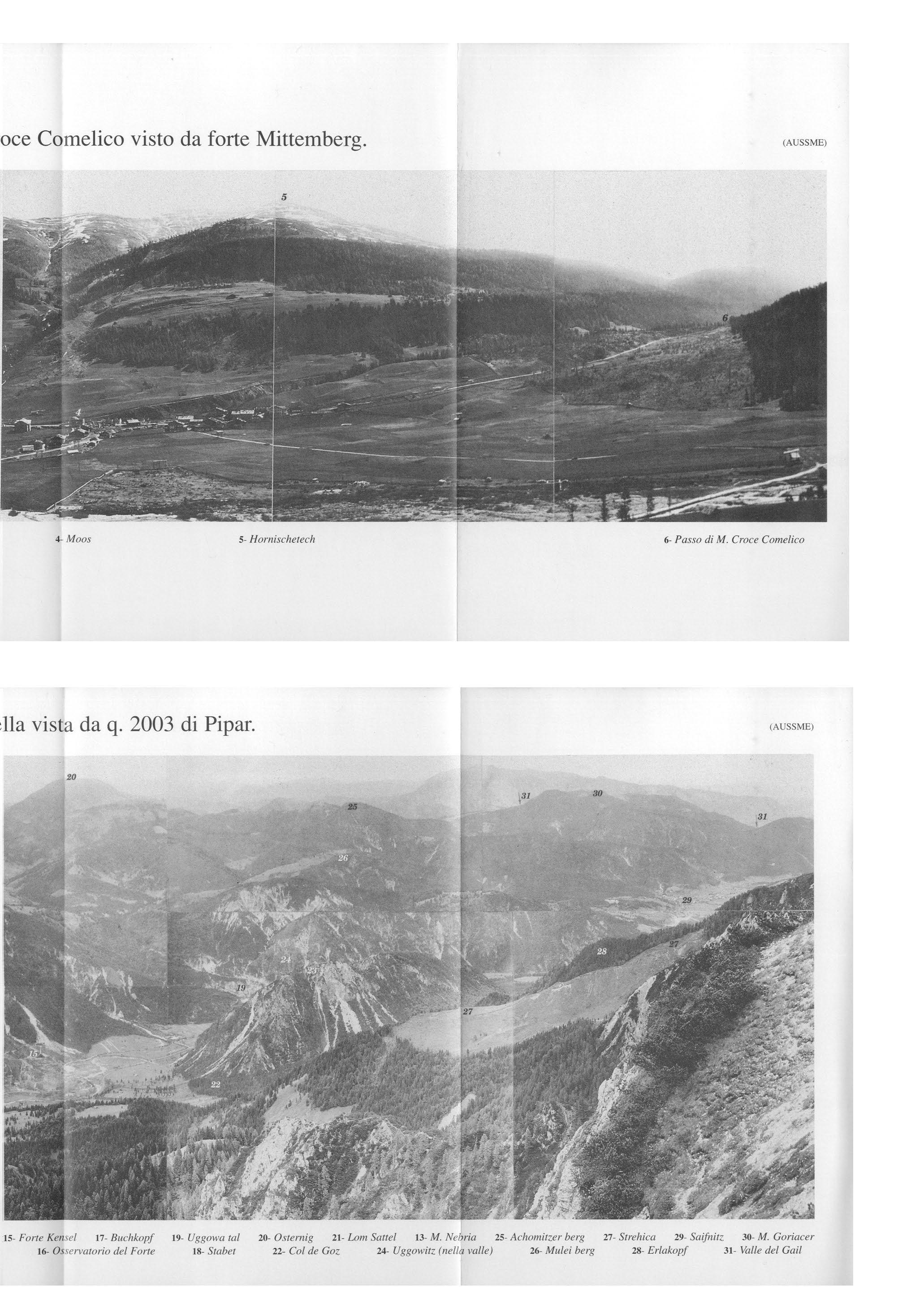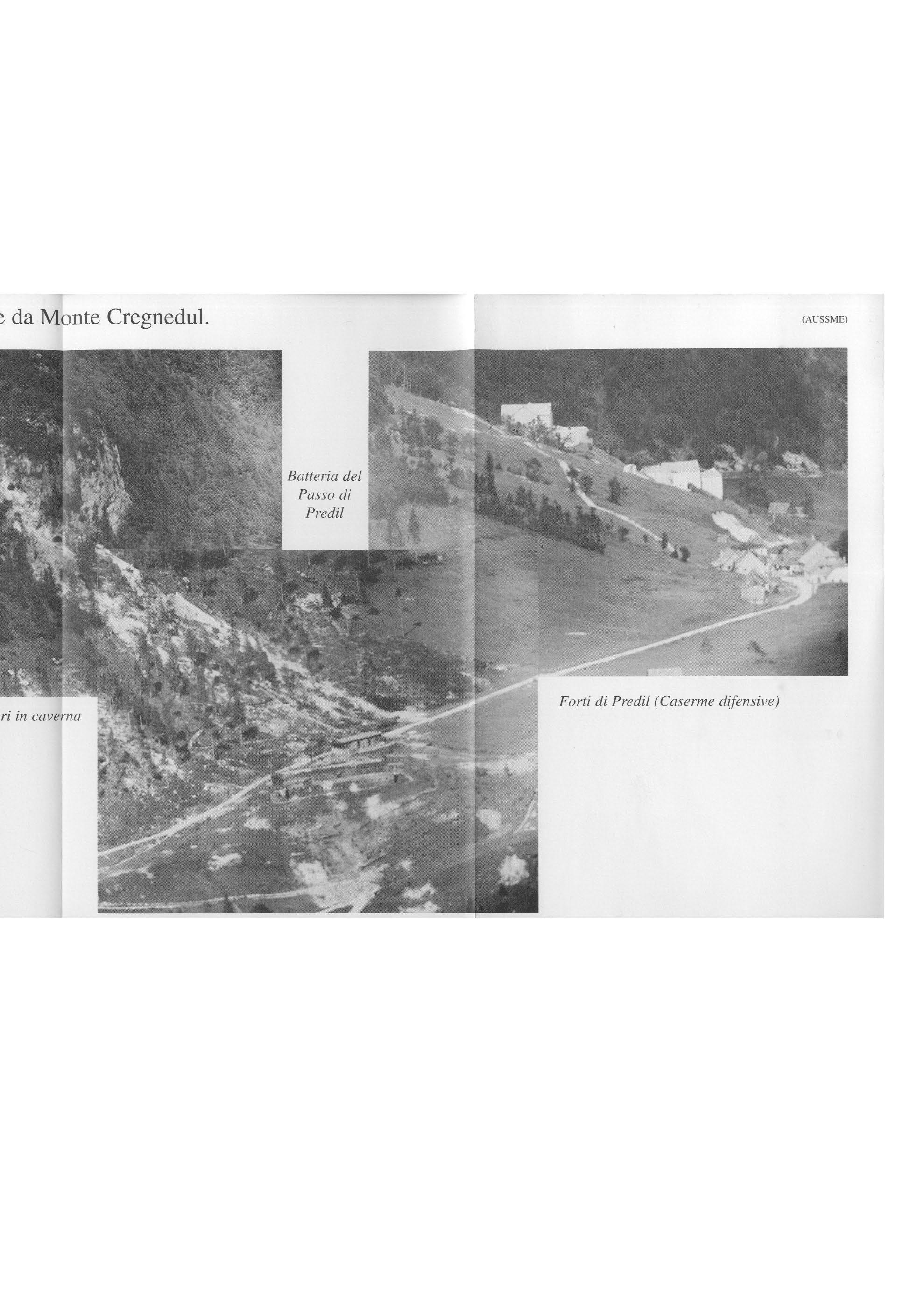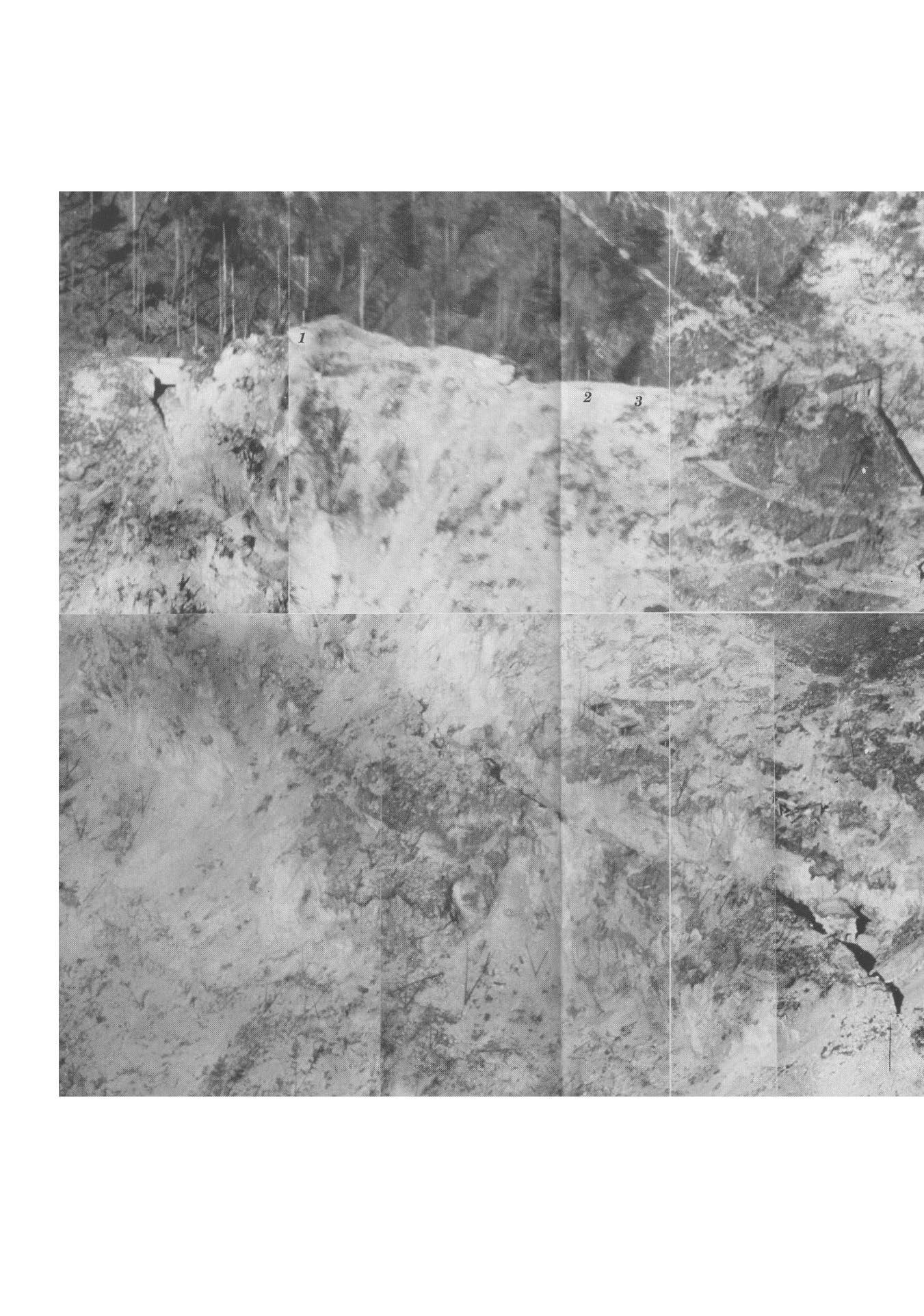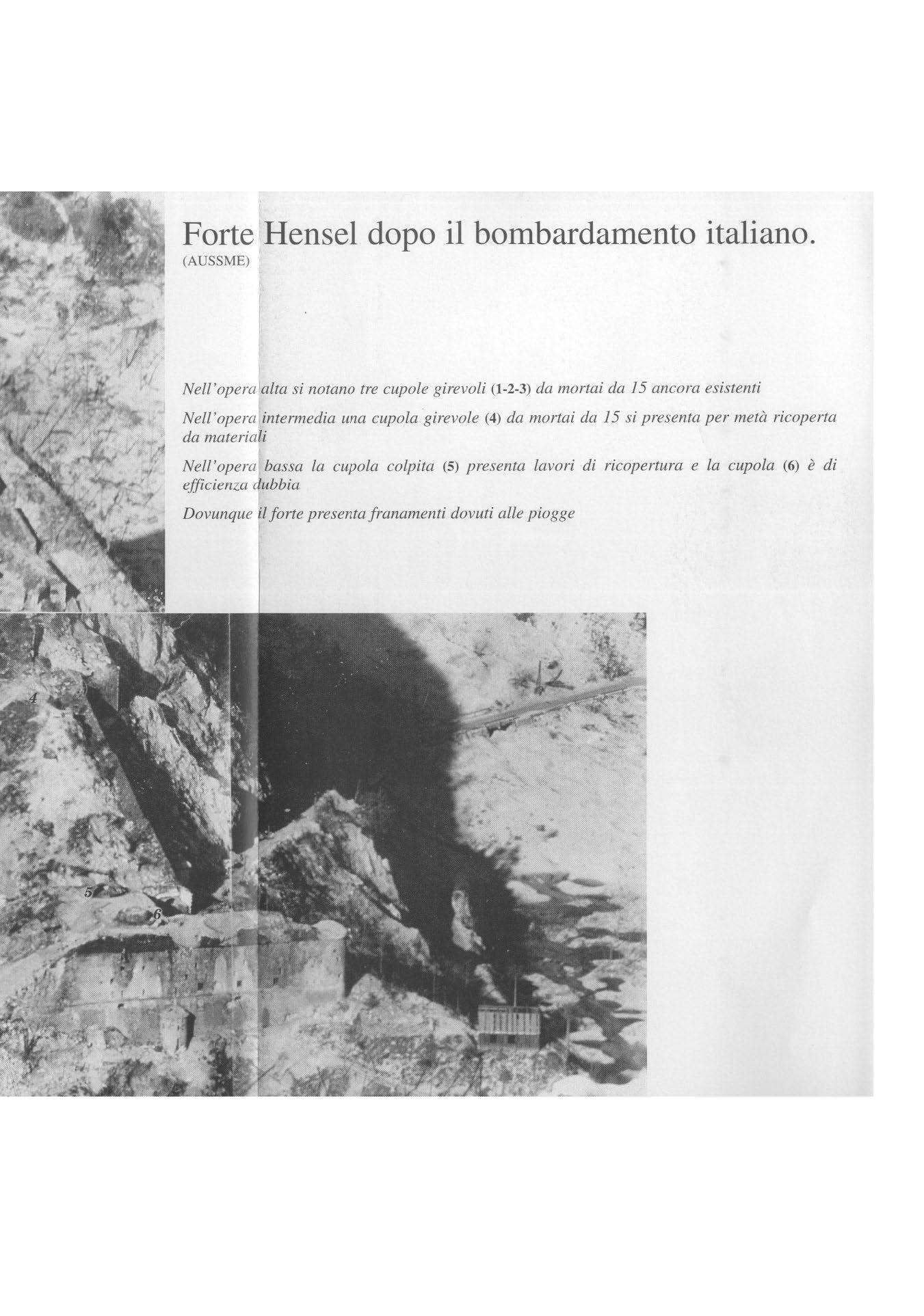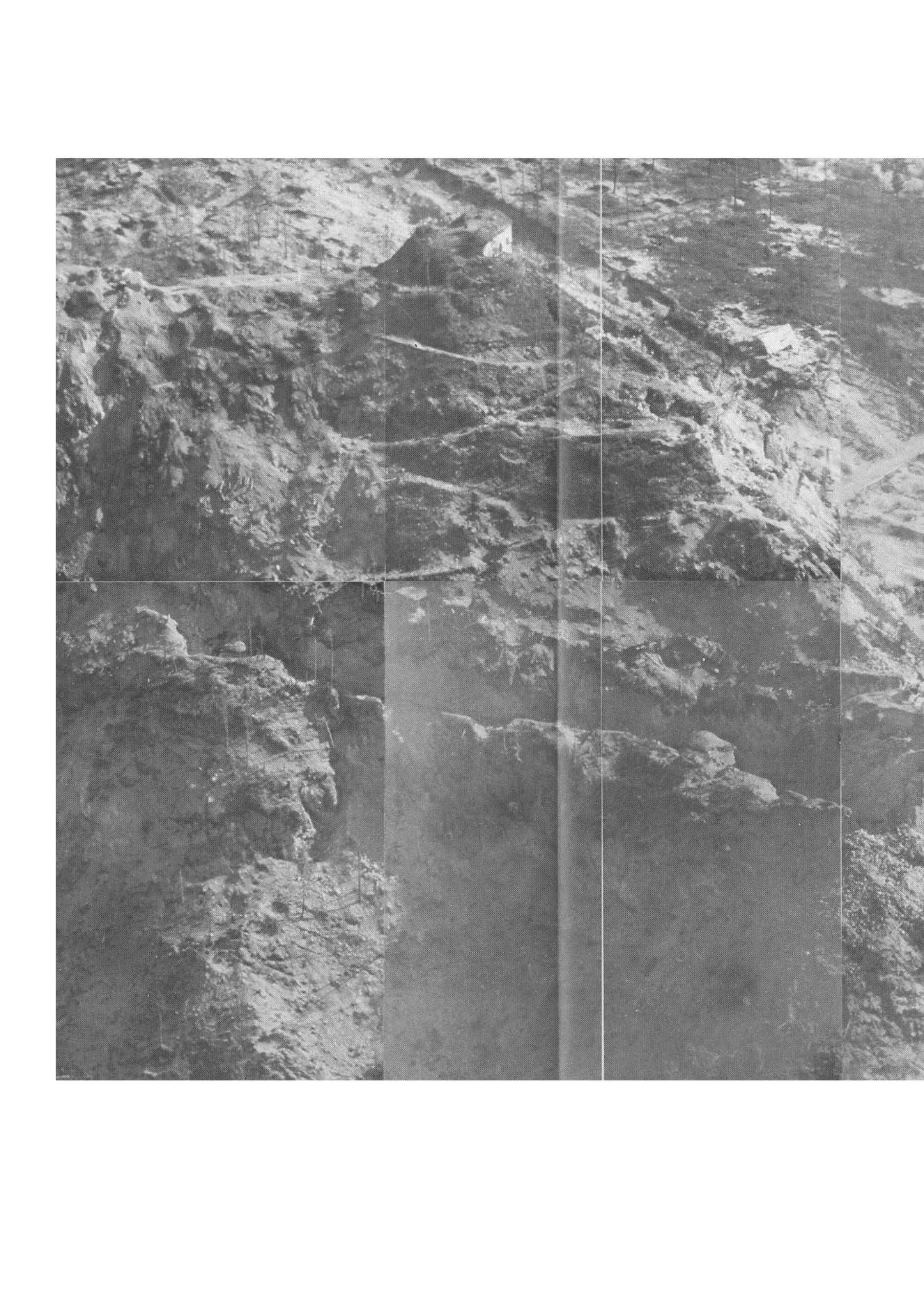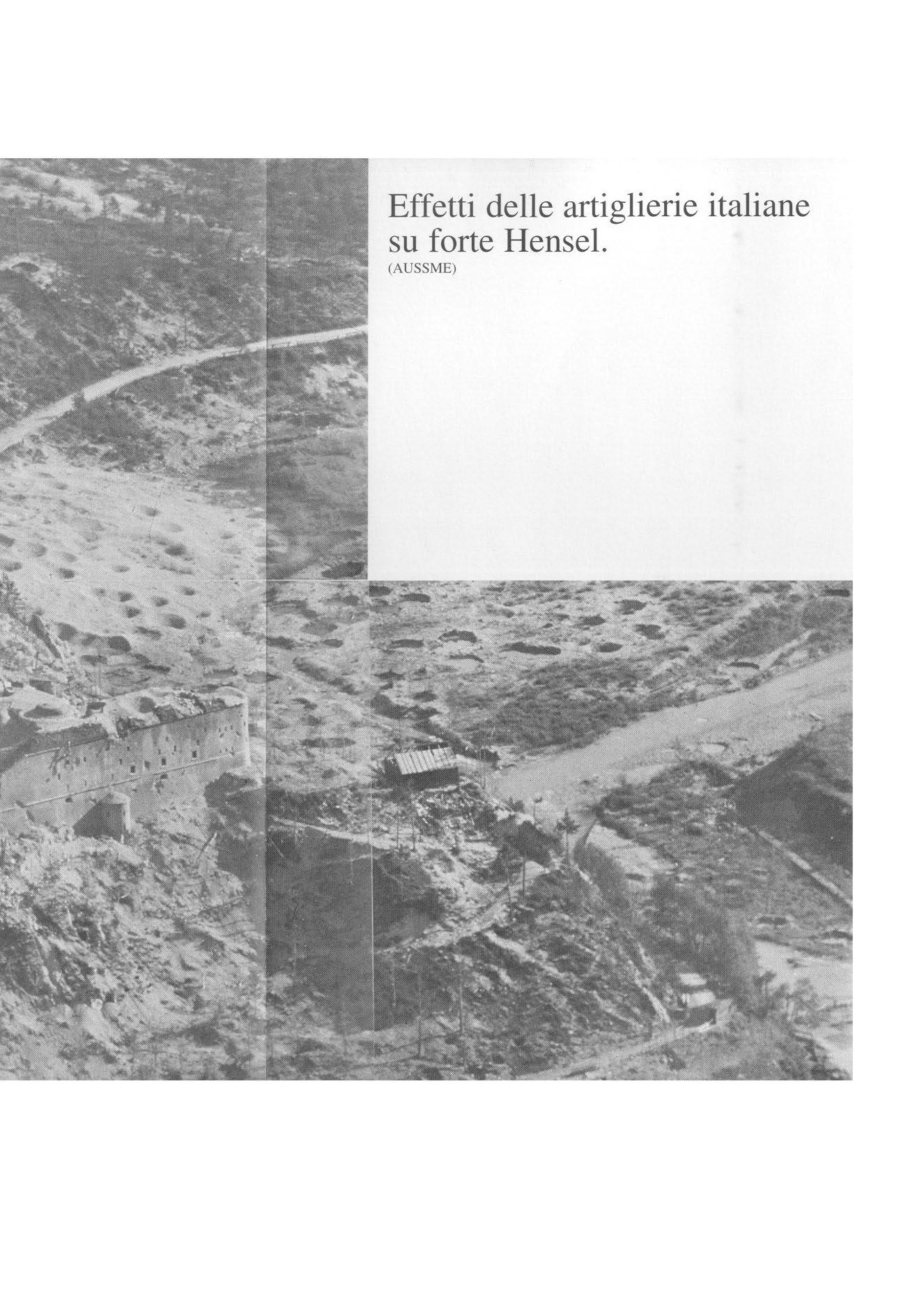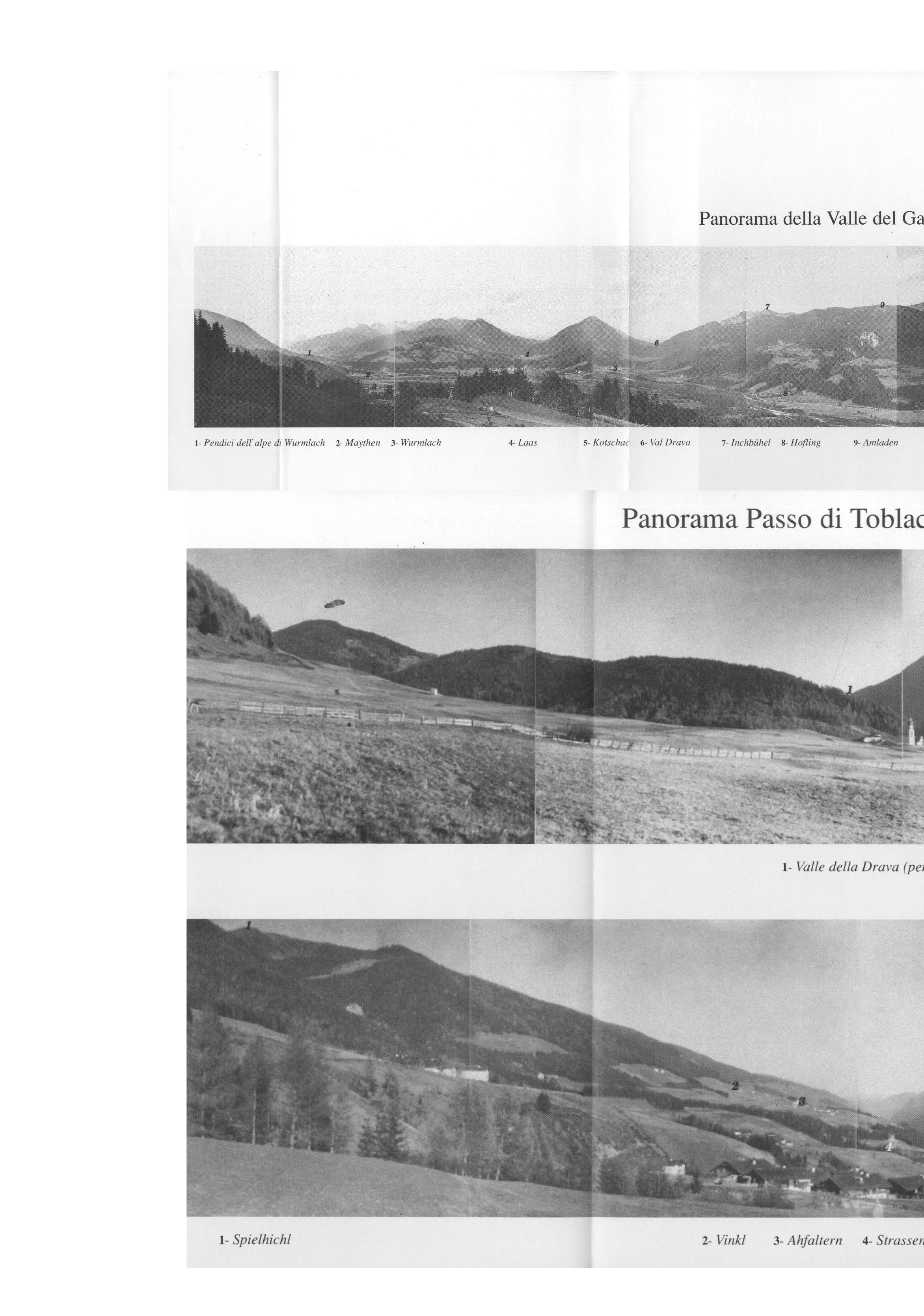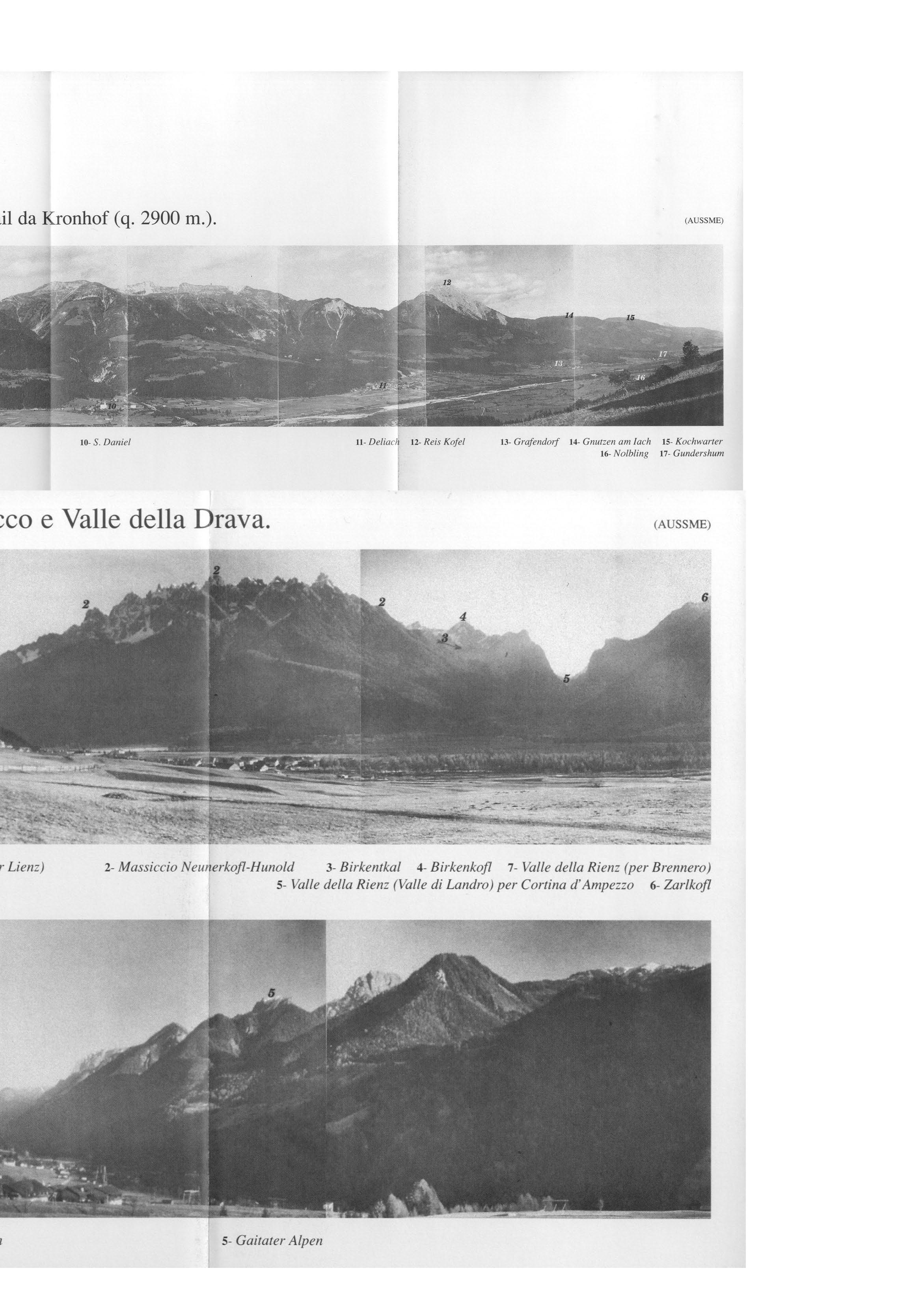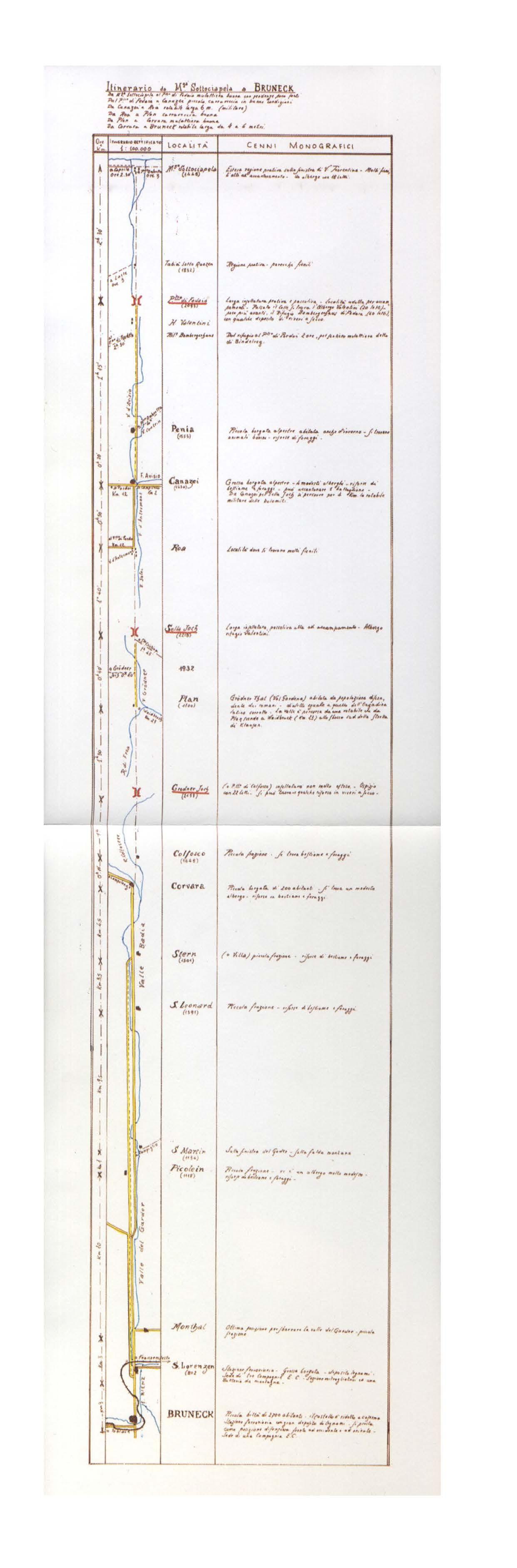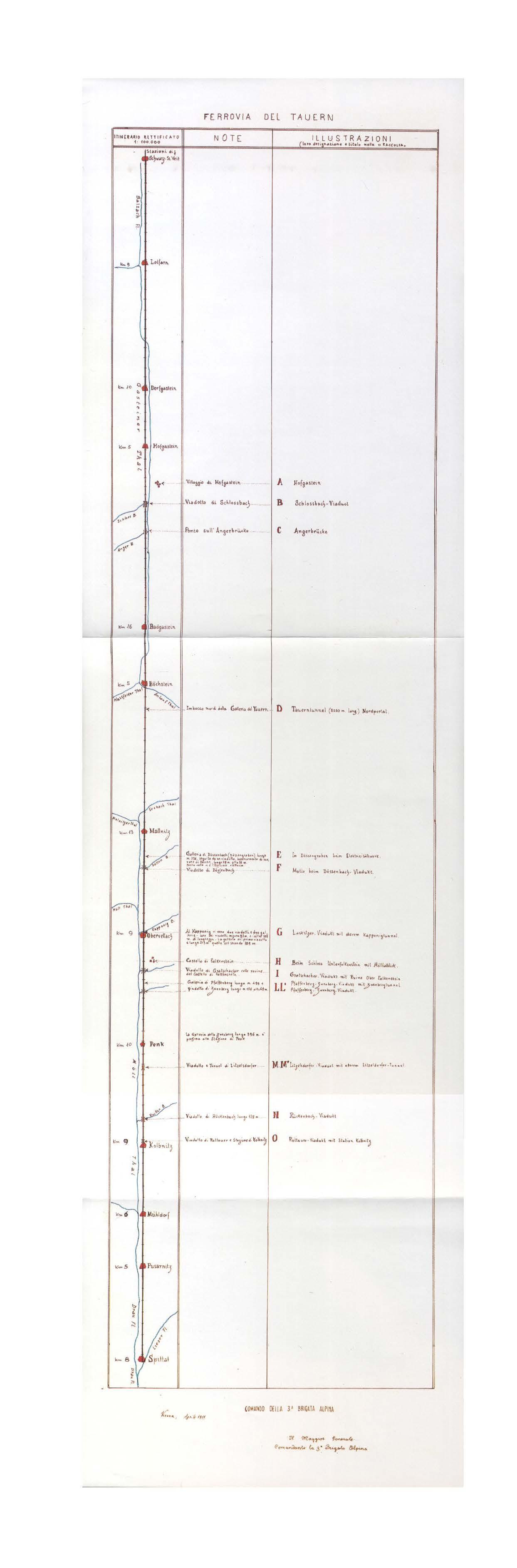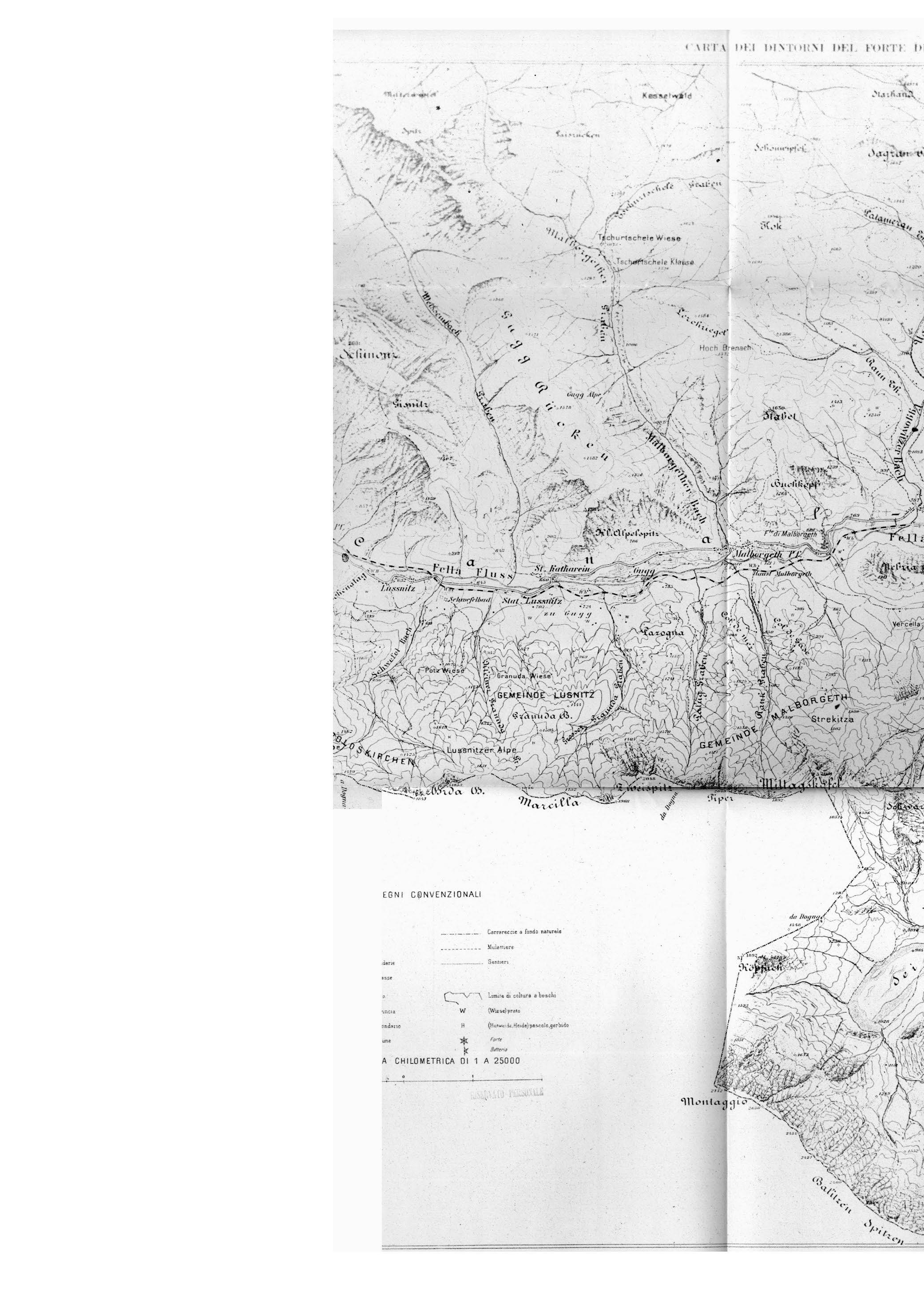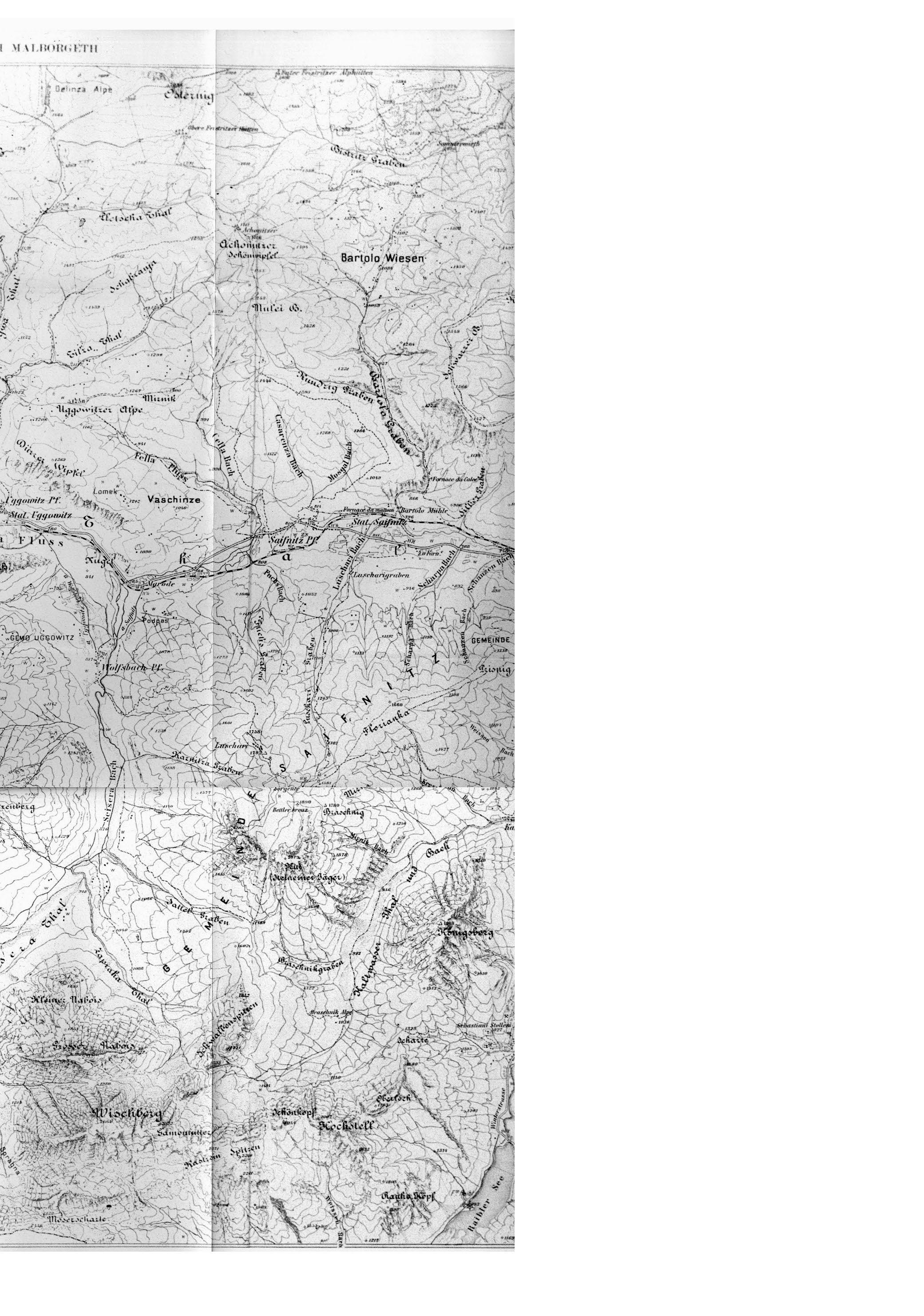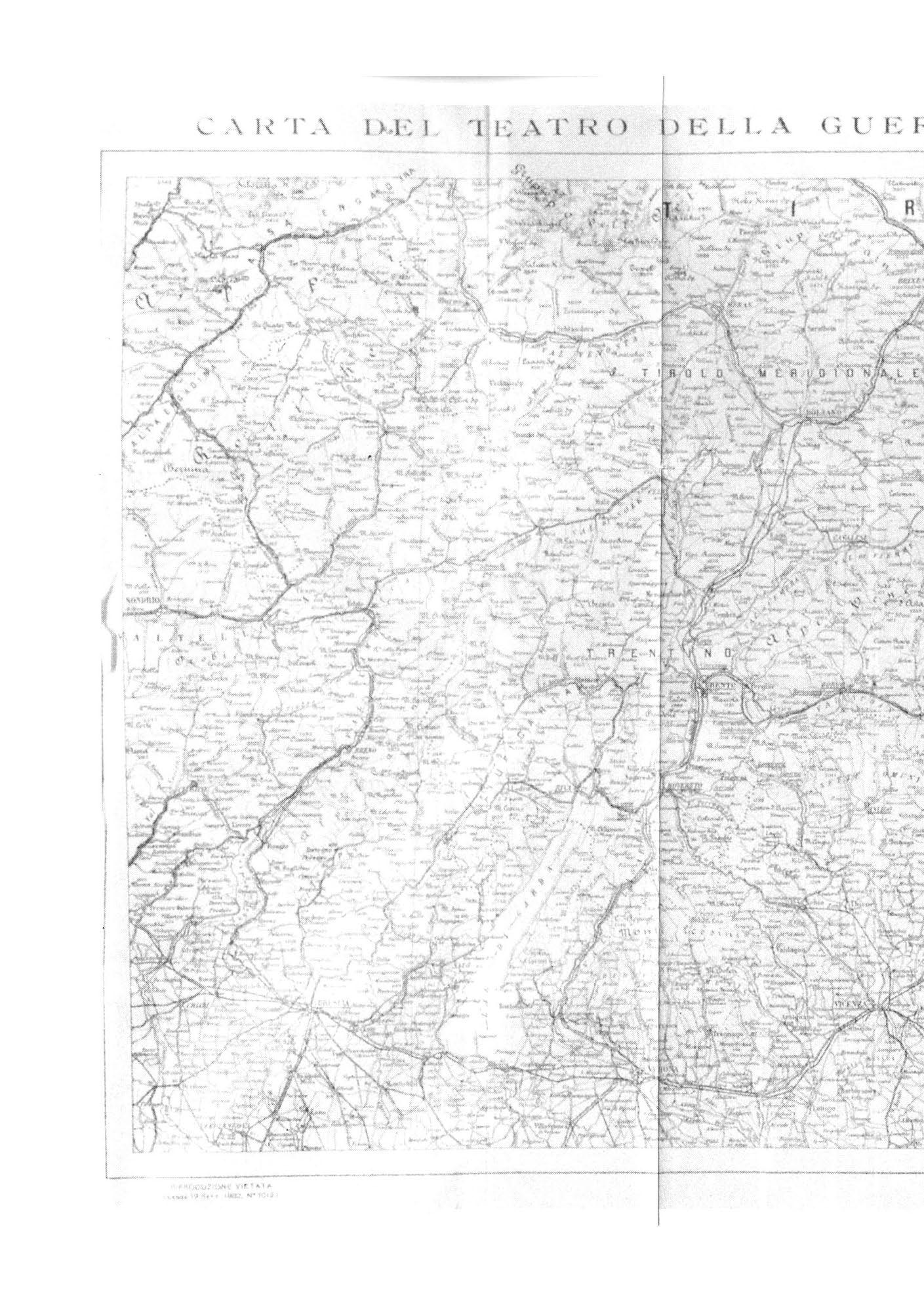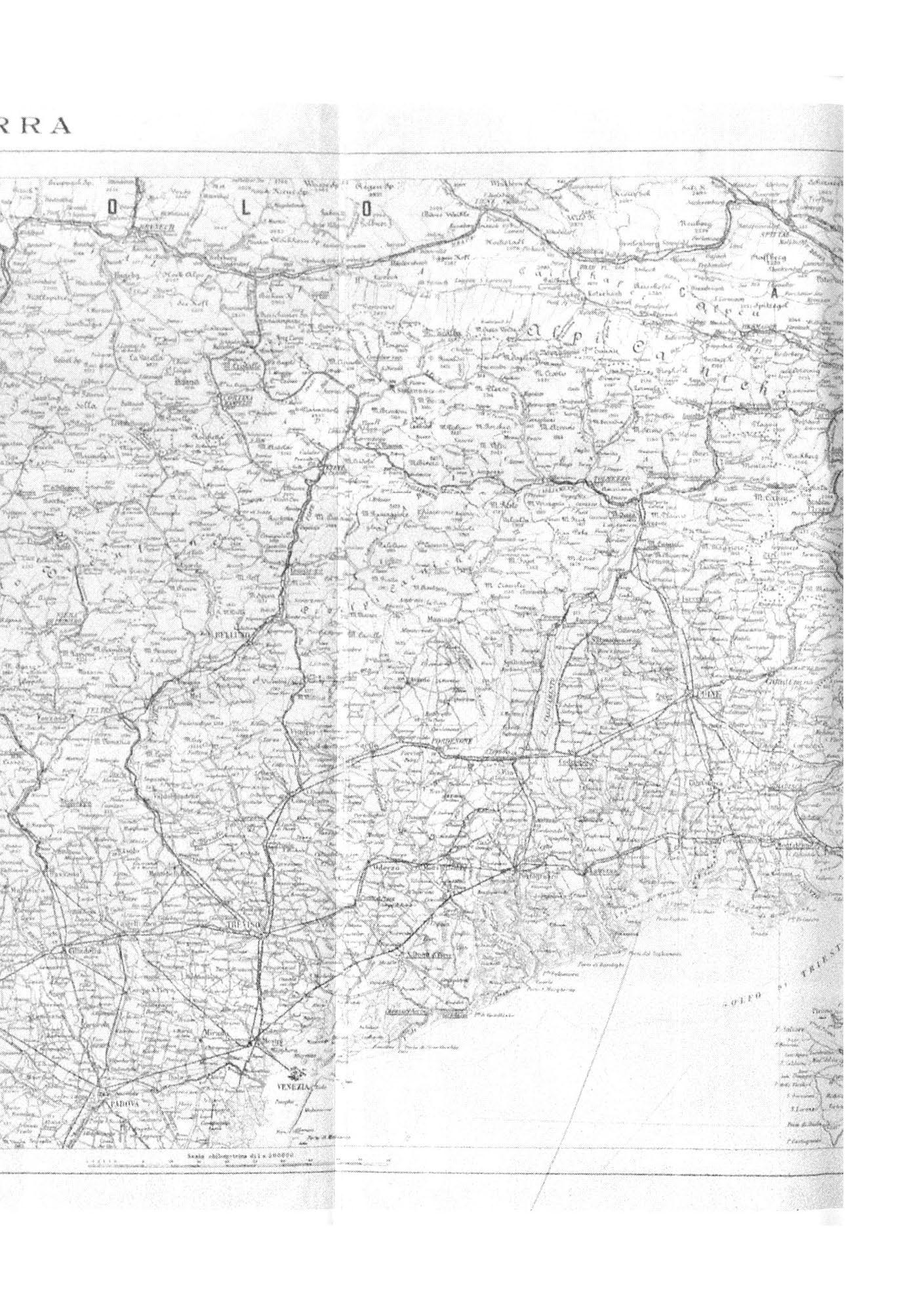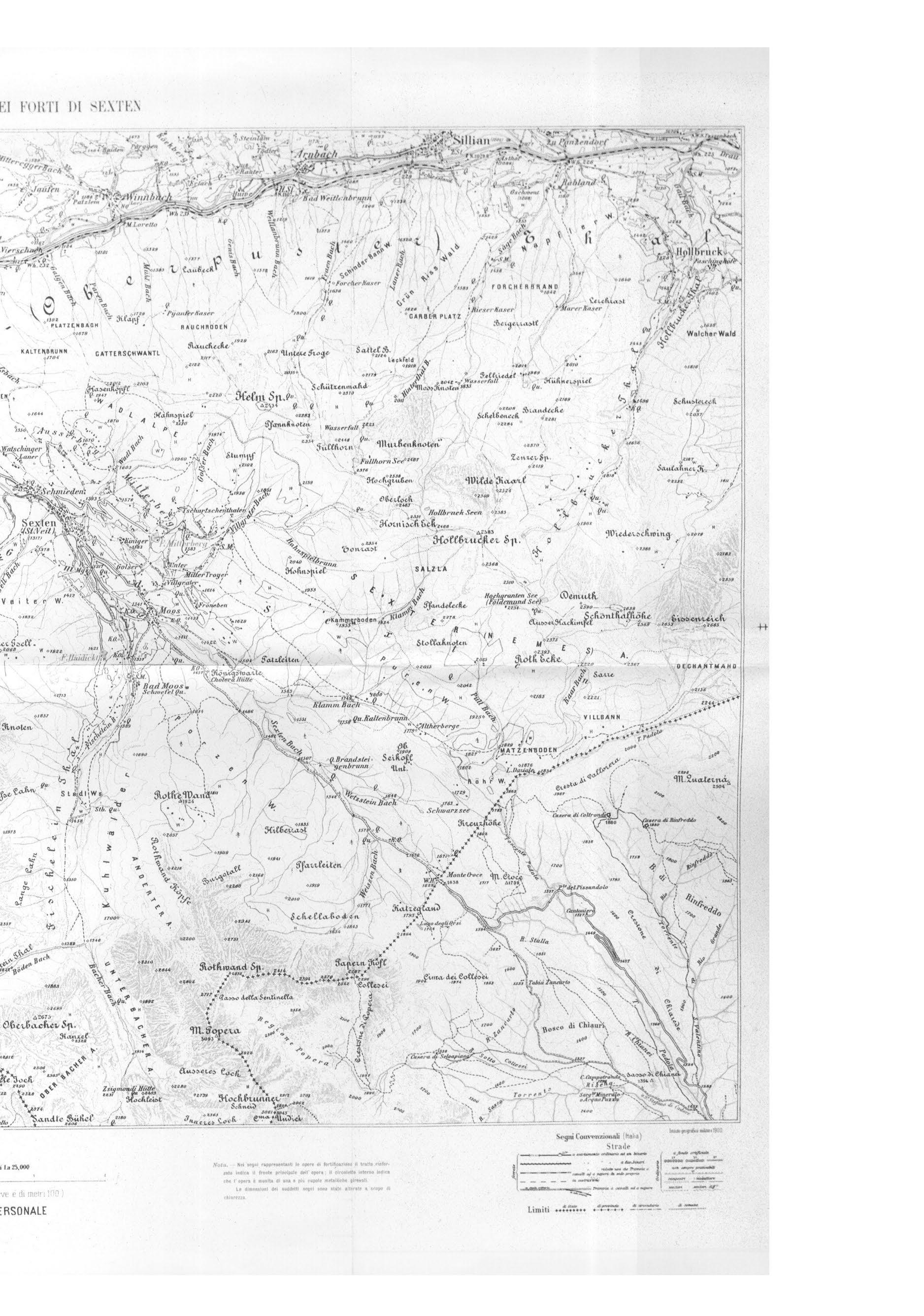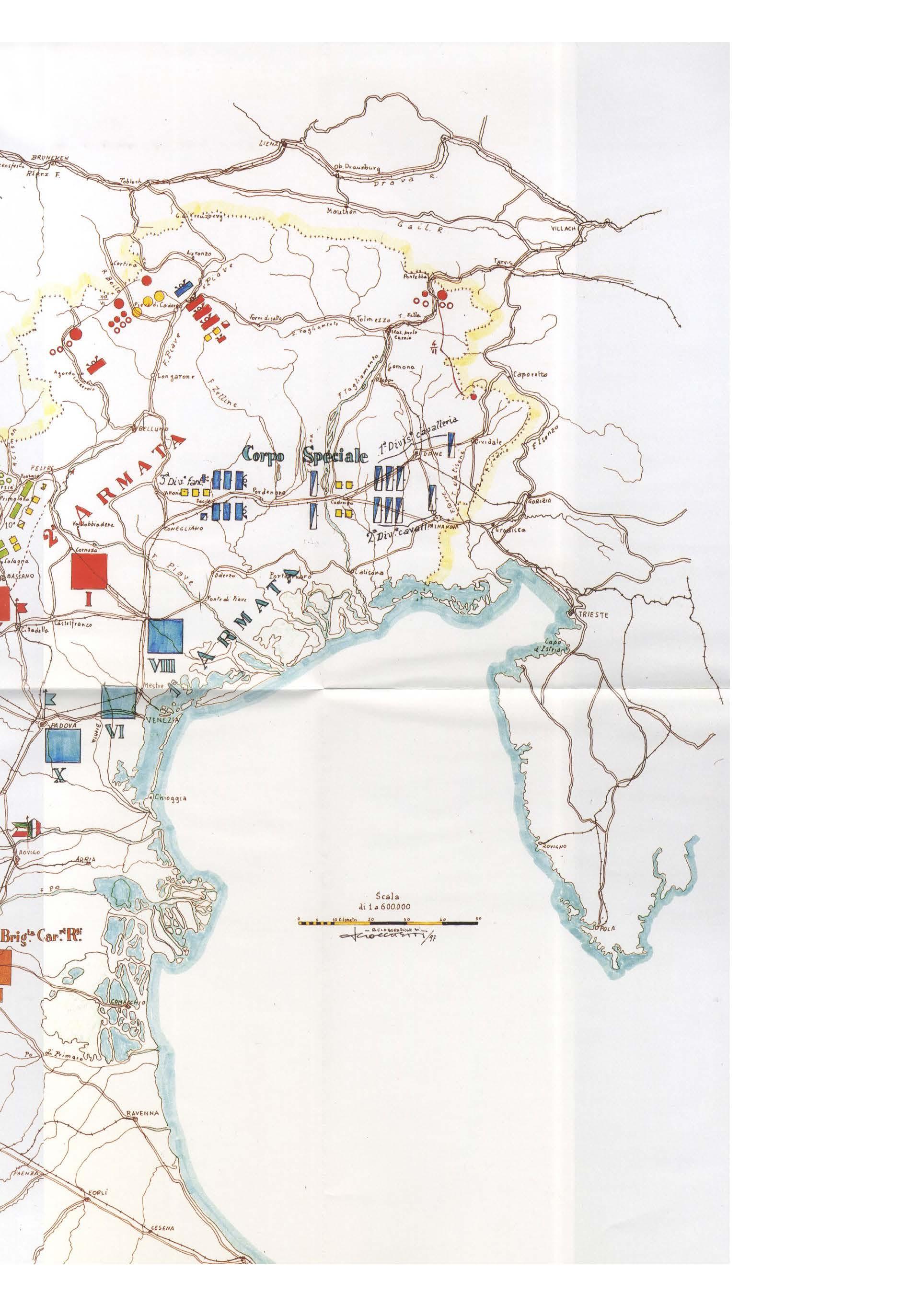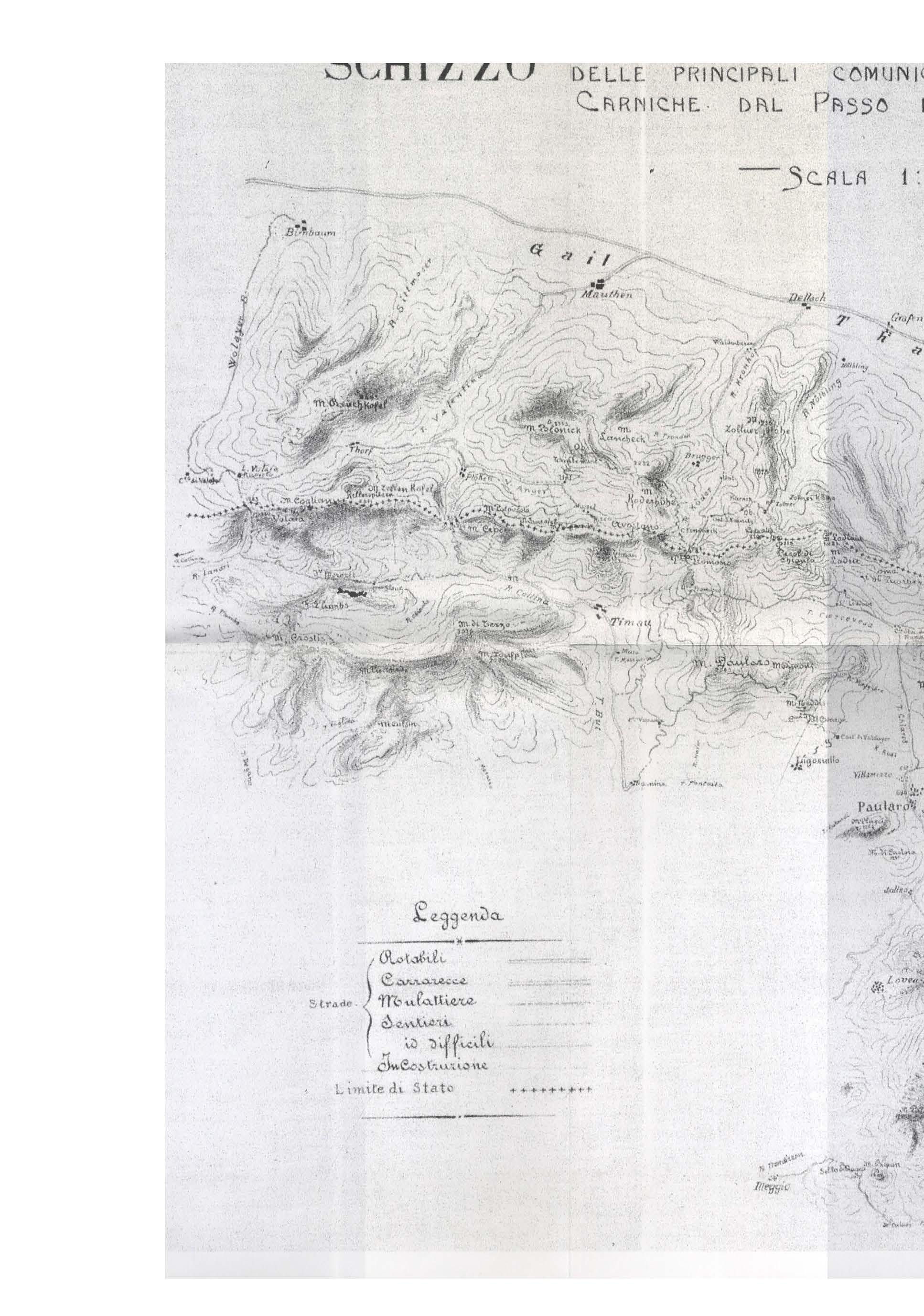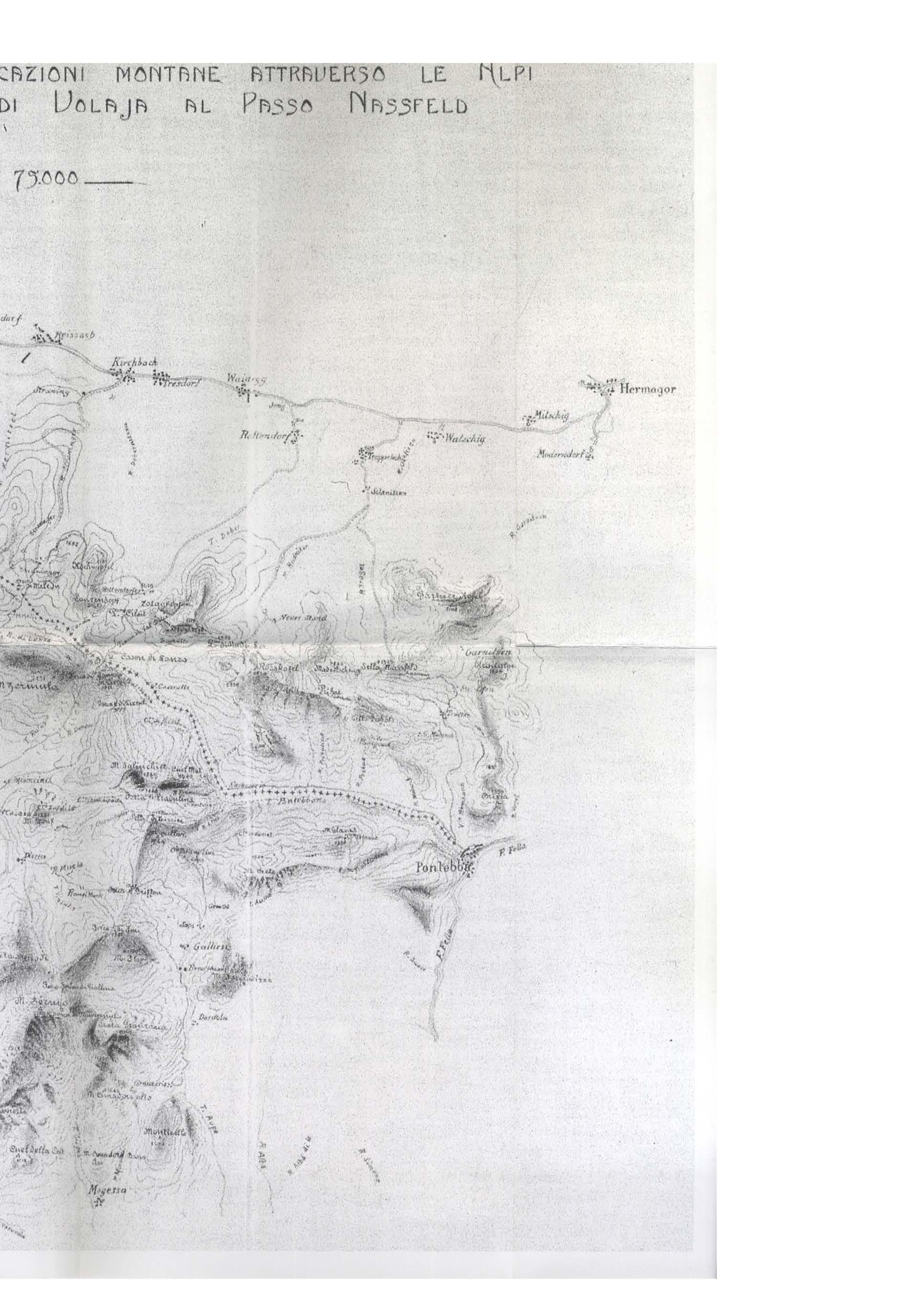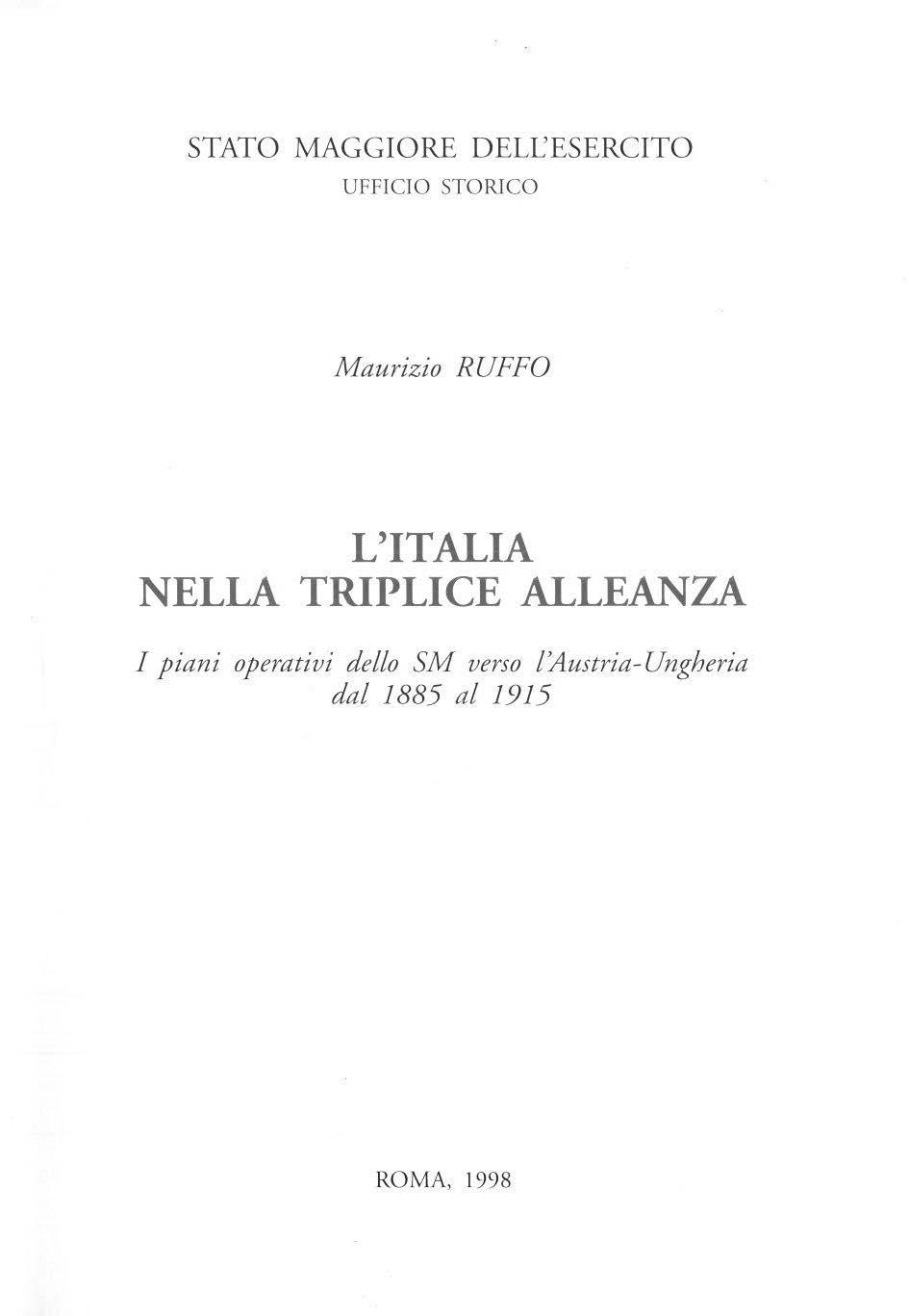
I piani operativi dello SM verso l'Austria-Ungheria dal 1885 al 1915
ROMA, 1998
Maurizio RUFFO
L' i11dividua z ione della prorenien:a della minaccia alla propria integrità territoriale ed istitu:ionale è priorità assoluta di uno Stalo moderno.
Essa, infalli, è diretta conseguenza delle linee di politica es/era e determina la pianificazione operativa difensil'a ed offensiva.
S0110 così presi in considera:ione i possibili 1eatri operativi in1eressanti i Paesi confinanti e, in particolari situa z ioni geopolitiche e so c ioeconomiche, vengono stipulati tratrati di al/ean : a o patii di non aggressione.

È il caso della giol'Clne Itali a che, sorta nel 1861 e completa/a nella sua integrità territoriale nel 1866 co11 l'annessione del Vene/o e nel 1870 co11 /'acquisi z ione di Roma, stipula 11el 1882 un'alleanza - la Triplice - con la Germania del Bismarck e con il secolare nemico, /'Austria - Ungheria. in chia1·e antifi'an c ese ed anlirussa.
Tale alleanza, u1ile per aspetti dirersi a tutti e Ire i co11traenti, presen1ava, per quanto atteneva i rapponi italo -aus/riaci. numerosi elementi di reciproca dijfiden::a che portarono i rispetti1 •i Stati Ma1-:giori a considerare sempre più seriamente la possibilità di un conflitto.
L'autore esamina il lungo la vom dello S1ato Mag{?iore Italiano che dallo studio del gen . Cosen z , aflraverso i successivi agg iornam enti del gen. Saletta e del gen. Poi/io. si concreti: z ò infine ne/l'ordine di opera:ioni n. I del 16 ma{?gio 19/5, con il quale l'Esercito Iwliano entrò in guerra.
L ' opera non mancherà di essere appre::a/a dal lettore che conosce hene le valli delle Alpi orientali ed il 1alore impeditivo delle fortifirnzioni i vi erelfe con grande dispendio di risorse fina11:iarie.
Tuttavia anche chi si accosta per la prima l'Olla alla problematica di un piano operativo. troverà interessante scoprire come FeniFano risolti i problemi inerenti la ricogni z ione in terrilorio nemico in un'epoca del tulfo pril'a dei sofisticati sislemi elellronici attuali, e come le capacità delle Fie di comunica z ione e del traspor/o ferroviario. in particolare, condi:ionarnno pesantemente le possihilità di schierame1110 di grandi masse di uomini.
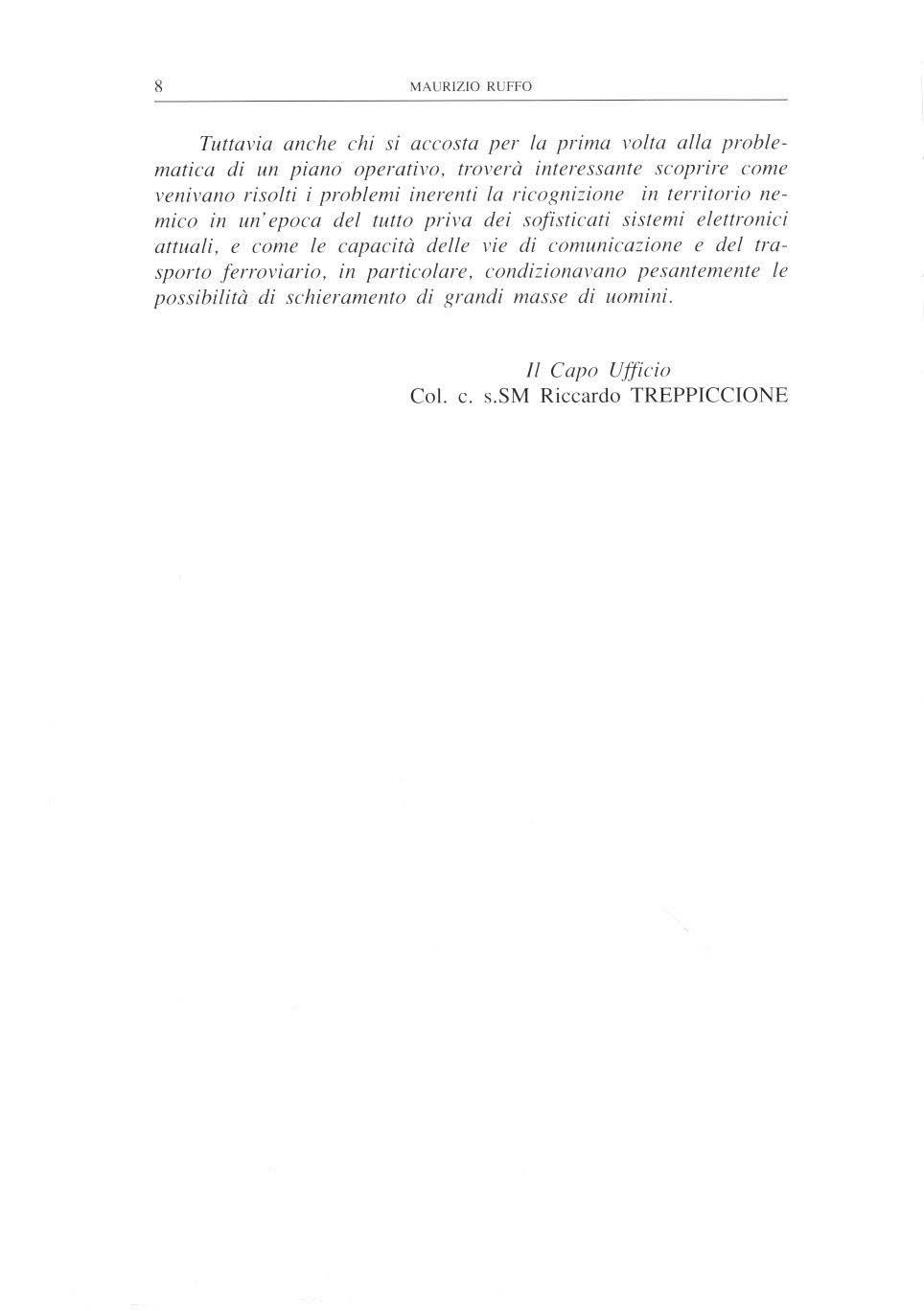
Nell'apprestarmi alla compilazione di quest ' opera che tratta un periodo di storia non solo italiana , ma direi europea per qu e lle che furono le conseguenze che portarono alla definizione di un nuovo assetto degli stati in Europa, non più basato sugli imperi multinazionali, ma sull ' affermazione delle individualità nazionali, m i sento in dovere di rivolgere un pens iero di gratitudine a tutti coloro che non solo mi hanno incoraggiato nell'affrontare il difficile tema , ma hanno costantemente sostenuto la mia fatica quotidiana.
Un grazie di cuore va a tutti i colleghi ed amici dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito per la preziosa collaborazione fornitami in ogni frangente ed in particolare al Capo Uffic io Col. c. s. SM Riccardo Treppiccione; agli Ufficiali addetti alla I" sezione Cap. a. Michele Tedeschi e Cap. f. (cr.) Filippo Cappella no; al Cap. a. Sa lvatore Orlando ed al Cap. f. Antonio Di Ganci, ali' A. Daniele Prinari ed il D ott. Alessandro Gionfrida tutti della 2" sezione; ali' A. Fernando Battisr.a della Segreteria.
Un sincero pensiero va a l Dott. Pro f. Antonello Bi agini dell'Università la Sapienza di Roma, all'Ing. Flavio Russo di Napoli, al Col. f. (a lp. ) (aus.) Paolo Riccioni Presidente della Sezione di Rom a dell'Associazione Nazionale Alpini cd all'A. Aldo Caligaris per l 'i ncondiziona to e fattivo aiuto prestatomi in ogni momento della stes ura di quest'opera.
Per ultimo la mia più viva riconoscenza a ll 'amico fraterno Gen. B. (aus.) Gian Piero Sciocchetti di Trento , autore degli spendidi schizzi che impreziosiscono questa mia fatica.
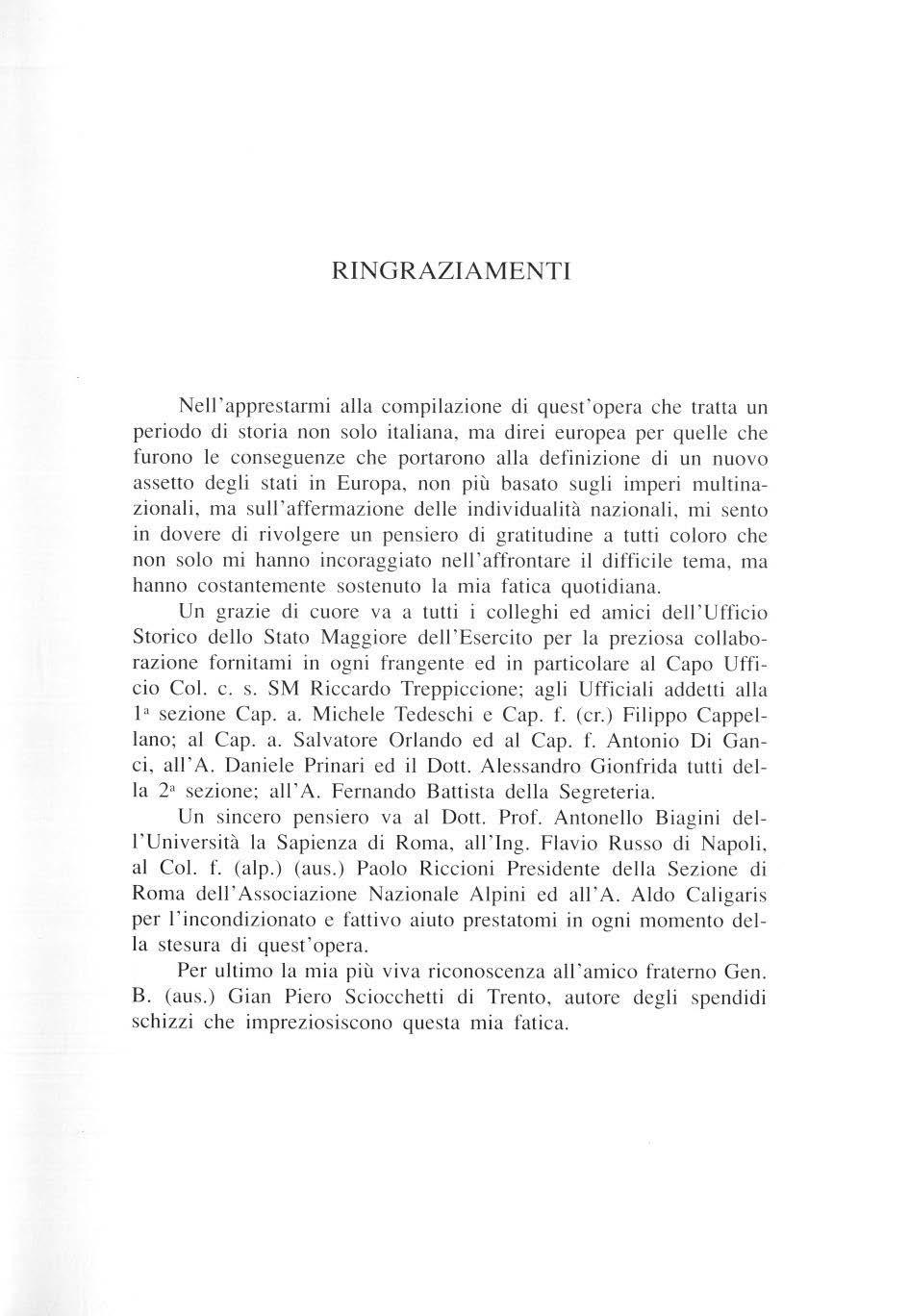

La conclusione delle trattative tra i plenipotenziari italiano, tedesco ed austriaco che portarono alla firma, a Vienna il 20 maggio 1882 , ciel trattato del la Triplice Alleanza, apparve, come può se mbrare ancora oggi, agli occhi e al cuore cli molti italiani come la rinuncia al completamento dell'unità nazionale in cambio di un appoggio politico e di una sicurezza in campo internazionale che, per la corona ed il governo, apparivano allora prioritari su ogni altra aspirazione.
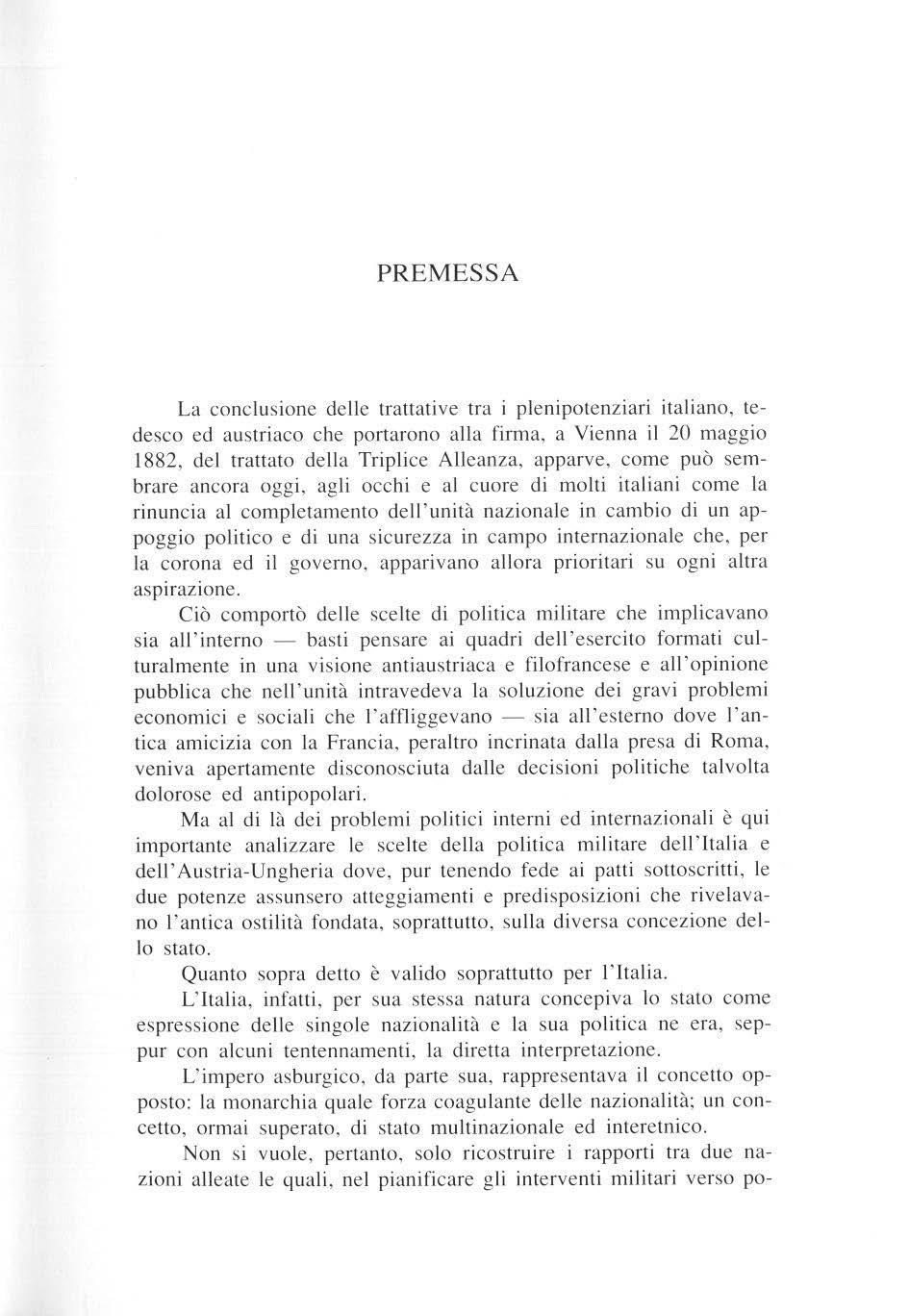
Ciò comportò delle scelte cli politica militare che implicavano sia all'interno - basti pensare ai quadri dell 'ese rcito formati culturalmente in una visione antiaustriaca e filofrancese e all'opinione pubblica che nell'unità intravedeva la soluzione dei gravi problemi economici e sociali che l'affliggevano - sia all'esterno dove l'antica amicizia con la Francia, peraltro incrinata dalla presa di Roma , veniva apertamente discono sc iuta dalle deci s ion i politiche talvolta dolorose ed antipopolari.
Ma al di là dei problemi politici interni e d internazionali è qui importante analizzare le scelte della politica mi Iitare cieli' ltalia e dell'Austria-Ungheria dove, pur tenendo fede ai patti so tto sc ritti, le due potenze assunsero atteggiamenti e predisposizioni che rivelavano l'antica ostilità fondata, soprattutto, sulla diversa concezione dello stato.
Quanto sopra detto è valido soprattutto per l' ltalia.
L ' Italia, infatti, per s ua stessa natura concepiva lo stato come espressione delle singole nazionalità e la sua politica ne era, seppur con alcuni tentennamenti, la diretta interpretazione.
L'imp ero asburgico, da parte sua, rappres en tava il concetto opposto: la monarchia quale forza coagulante delle nazionalità: un concetto, ormai s uperato , di stato multina ziona le ed interetnico.
Non s i vuole, pertanto , solo ricostruire i rapporti tra due naz ioni alleate le quali , nel pianificare gli interventi militari verso po-
tenziali aggressori, studiavano anche misure cautela ti ve net rispettivi confronti. ma , a prescindere dalle int erpretazioni s ugli scopi e le finalità della Tripli ce Al leanza, si desidera delin ea re. nel particolare. la pianificazione dello stato maggi o re italiano ve rso l'impero danubiano nell'ambito dei trattati di alleanza ed in confom1ità degli atteggiamenti militari da qu es to assunti.
Concepire un disegno cli g uerra o di opera.doni I è l 'n ttività principe di uno stato maggiore in tempo di p ace per poter organizzare nella maniera o ttimal e le forze. provvedere al loro addestramento, pianifi ca re il loro sc hieram en to e porl e in grado di conseg uire il risultato prefissato.
Il piano. come comunemente è definito, rappresenta quindi lo scopo che s i vuol raggiungere mentre le operazioni so no il mezzo per con segu irlo.
È c hiaro. pertanto , come vi debba essere un perfetto accordo tra fine e modalità per raggiungere l'obiett i vo ipotizzato, pena il fallimento dell'impresa.
In g uerra le difficoltà ma gg iori non consistono nell'ideare una brillante operazione, rna nel calco lare co n esattezza l'in sieme dei particolari necessa ri per la sua realizzaLione.
Quello c he venne predisposto d allo stato maggiore ital iano non fu quindi , a lm eno ini z ialment e, un piano nell'accezione del tc nnine, ma uno st udi o di condotta e tale rimarrà, come vedremo, fino alla fine di agosto d e l 19 I 4 quando. iniziandosi a definire con certezza l 'o ri e ntam e nto del paese verso l ' Intesa, iI ge neral e Cadorna espose con una m e moria operativa i s uoi intendim e nti per la condotta di una guerra contro l 'Aust ria- Ung he ria.
1 Disegno di guerra e disegno tli opera7ioni potrebbero essere considerate due co~e di,1in1e. ma nctru~o comune dicendo di,egno di guerra ,i comprende l'uno e l'ahro. La differen1a consiste nel fatto che. concepito un di~egno di guerra. cioè lo ,copo finale che si vuole raggiungere. c,so può c~sere pcr,cg uit o con ~variate comhinazio ni di manovre o co n sv ariati di,cg ni d'operat ioni.
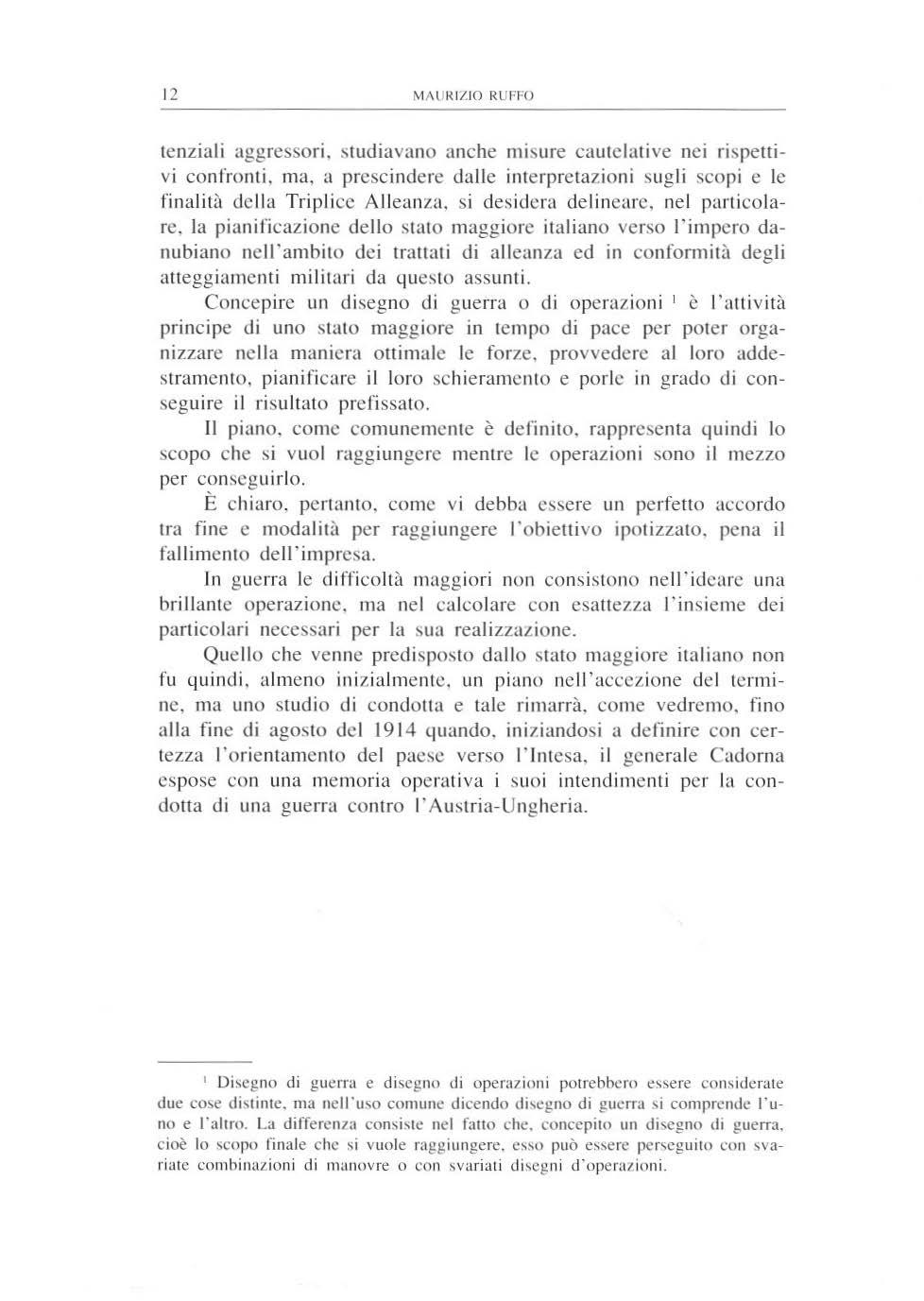
Il Trattato di Santo Stefano del 3 marzo 1878 che a Yesilkoy 1 la Russia aveva imposto alla Turchia e nel quale era contemplata la creazione di una grande Bulgaria autonoma, era una palese violazione sia degli interessi asburgici, la cui Monarchia aveva mire espansionistiche verso la Bosnia - Erzegovina, sia di quelli inglesi che vedevano nella Bulgaria un avamposto russo verso Costantinopoli e l'Egeo e la contemporanea avanzata russa in A rm enia, come la prima tappa verso il golfo di A lessandretta ed il Mediterraneo.
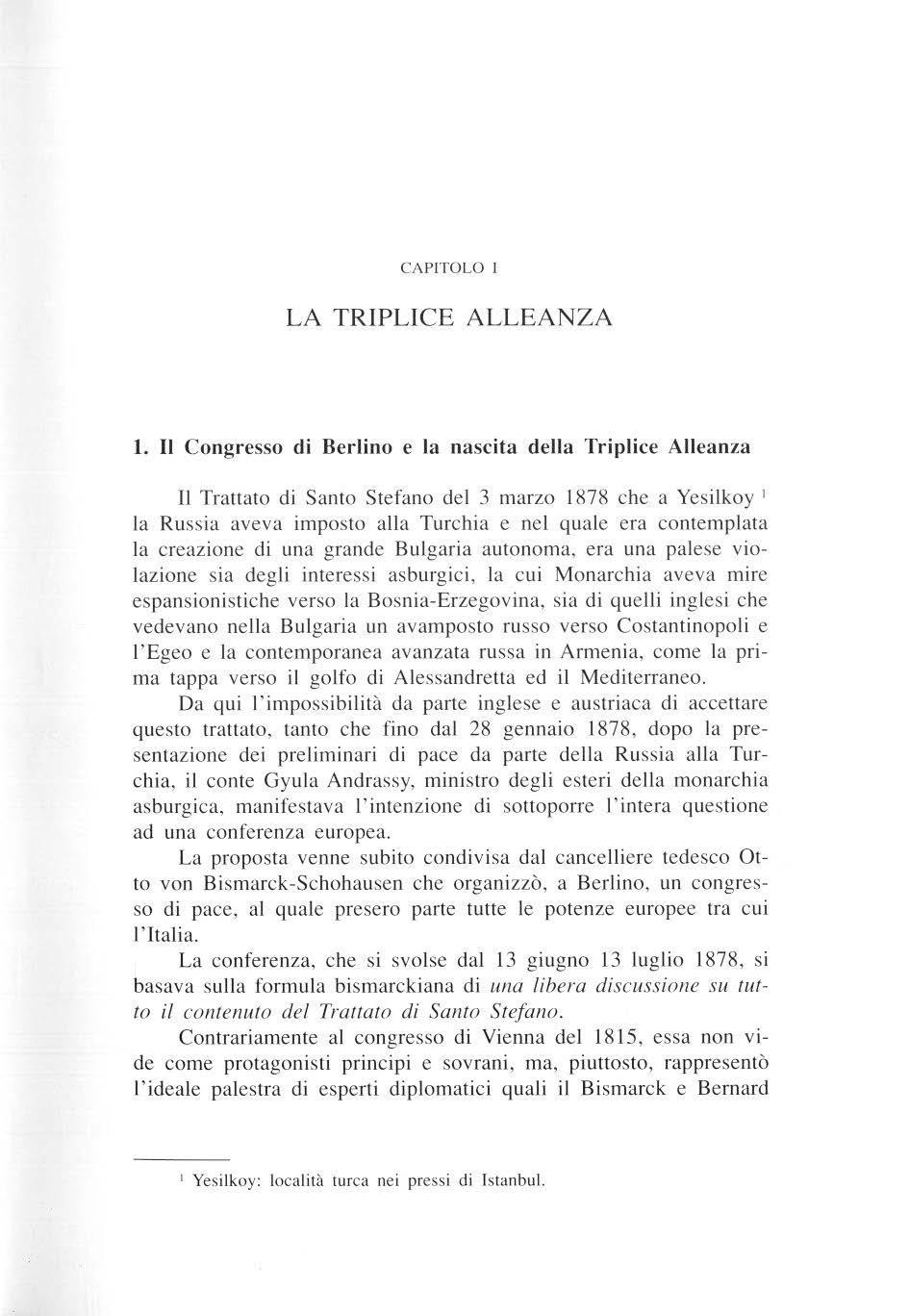
Da qui l'impossibilità da parte inglese e austriaca di accettare questo trattato, tanto che fino dal 28 gennaio 1878 , dopo la presentazione dei preliminari di pace da parte della Russia alla Turchia, il conte Gyula Andrassy, ministro degli esteri della monarchia asburgica, manifestava l ' intenzione di sottoporre l'intera questione ad una conferenza europea.
La proposta venne s ubito co ndivi sa dal cancelliere tedesco Otto von Bismarck -Schohausen che organizzò, a Berlino , un congresso di pace, al quale presero parte tutte le potenze europee tra cui l 'Italia.
La conferenza, che si svolse dal 13 giugno 13 luglio l 878, si basava sulla formula bismarckiana di una libera discussione su tutto il contenuto del Traila/o di Samo Stefano.
Contrariamente al congresso di Vienna del 1815, essa non vide come protagonisti principi e sovrani, ma, piuttosto, rappresentò l ' id eale palestra di esperti diplomatici quali il Bismarck e Bernard
von BUlow per la Germania, il conte Andrassy per l'Austria-Ungheria, Gorciakof per la Russia, Disrael i (Lord Beaconsfielcl) per l'Inghilterra, Waddington per la Francia ed il conte Luigi Corti per l'Italia.
Le discussioni si protrassero a lungo, vertendo, in modo partico lare, sulla nuova sistemazione dell'area balcanica dove si scontravano i contrastanti interessi di Russia, Austria, Inghilterra e dei popo li ivi residenti; tutti a scapito della Turchia.
11 22 giugno le trattative, pur tra grandi difficoltà ed estenuanti discussioni, ebbero un primo importante impulso con la rinuncia, da parte inglese, alle pretese inerenti i confini dei due stati che sarebbero sorti dalla divisione della grande Bulgaria, ottenendo, in cambio, che la parte meridionale non fosse chiamata, come era desiderio dei Russi, Bu lgaria meridionale, bensì Rumelia Orientale, che il controllo politico e militare di essa spettasse, pur con alcune limita zio ni, al sultano e che l 'occ upa zio ne ru ssa in Bulgaria fosse so lo di nove mesi.
Successivamente venne affrontata la questione della Bosnia-Erzegovina. Alla tesi russa dell'autonomia delle due provincie si contrapponeva l'Austria-U ngheria che, per la sua s icurezza e per la pacificazione durevole della zona, ne rivendicava il controllo militare ed amministrativo; inoltre la monarchia danubiana richiedeva la possibilità cli mantenere delle guarnigioni e di costruire strade militari e civili nel Sangiaccato cli Novi Pasar 2 per garantire la libertà e la sicurezza delle comunicazioni tra l'impero ed i nuovi territori.
Nonostante le proteste turche e qualche riserva russa , l'AustriaUngheria riuscì nel suo intento anche se non le fu concesso niente di piì:1 di quanto chiedesse all'inizio del congresso stesso.
L 'artico lo 25 del trattato finale recitava: Le province di Bosnia ed Erzego,·ina saranno occupate ed amminis1rate dal!' Austria -Ungheria. Non desiderand o il governo austo -ungarico di incaricarsi dell'amministra z ione del Sangiaccato di Novihazar. che si es/ende tra la Serbia ed il Montene[!,ro in direzione sud - est fino al di là di Milrovitza, continuerà a funzionare I' amminis/razione otlomana. Turravia. onde assicurare il mantenimento del nuovo Staro politico del pari che la liherrà e la sicurezza delle 11ie di comunica:ione, I' Austria-Ungheria si riserva il diriflo di tenere f!,uarnigione e di avere si rade militari e commerciali su tu/fa /' estensione di questa par-
2 Novi Pasar era anche della Novibazar c. ne l proseguo sa rà indicata sempre con quest ' ultimo toponimo
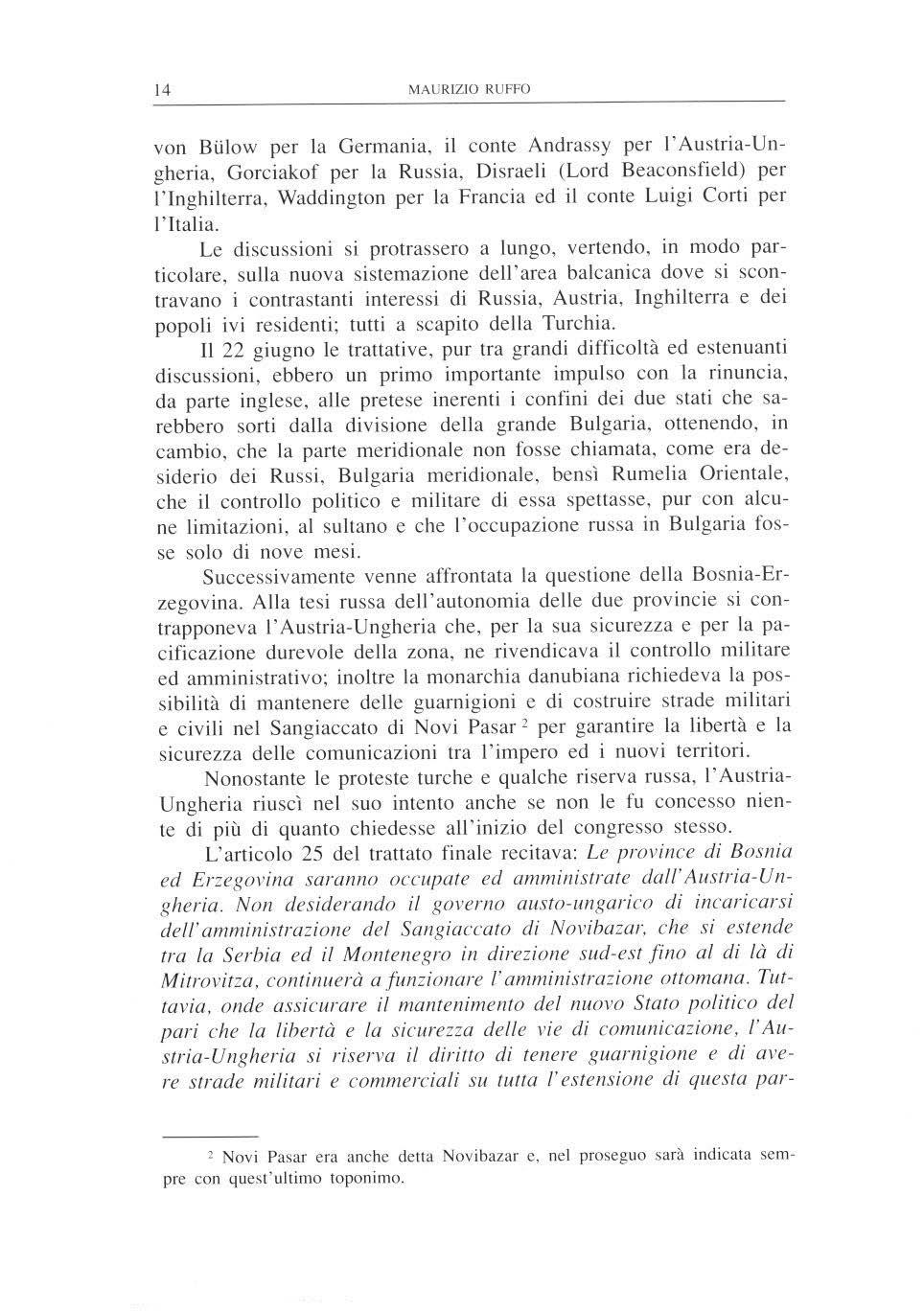
I. - ''L a soc ietà pe r i l mantenime nto de l la pace'' chiamata com une mente dai t re Stat i la ''Tr ipl i ce A ll ea nza''. (Sc iocchett i Trento).
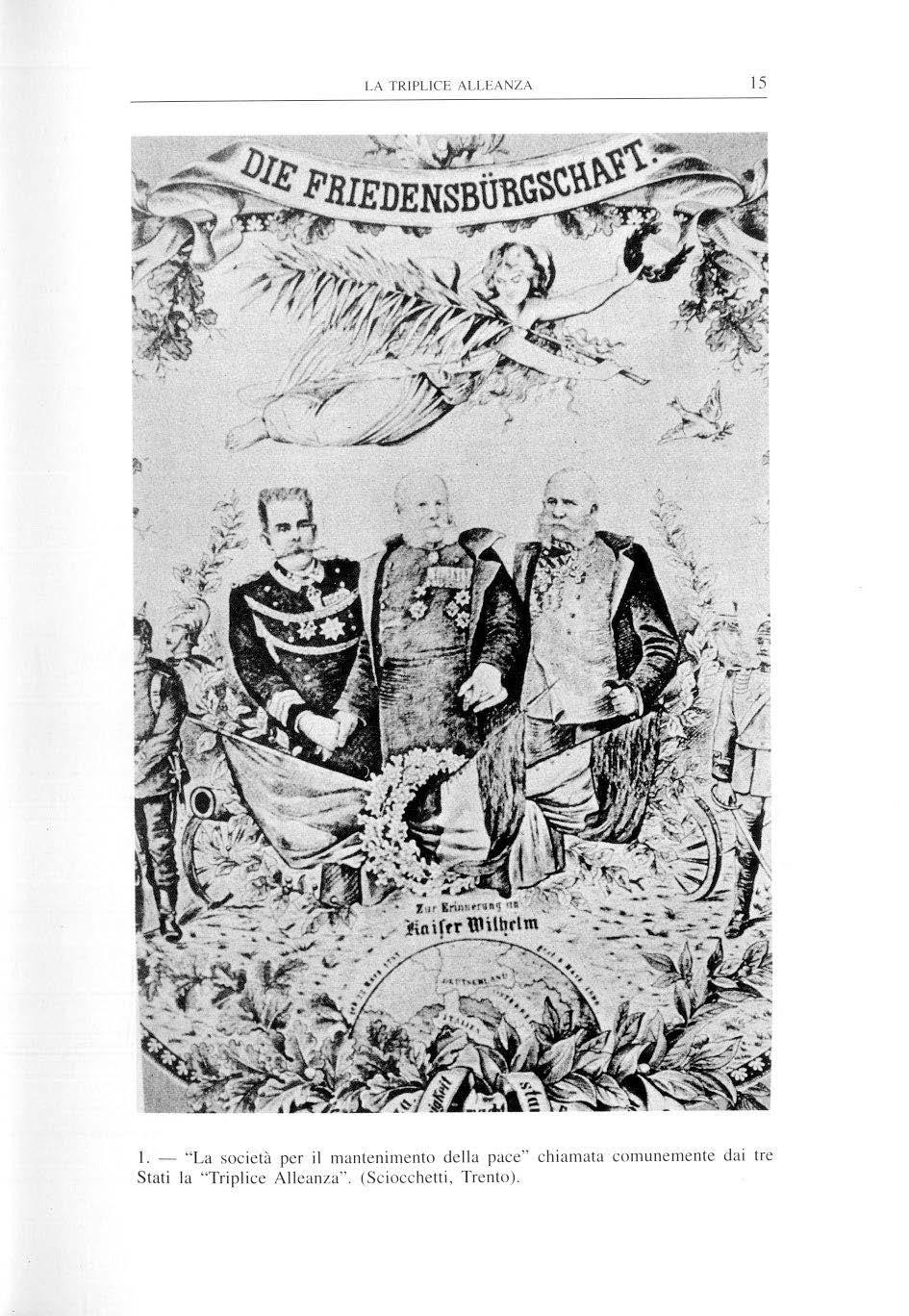
te vilayer di Bosnia. A tale scopo i governi d'AustriaUngheria e di Turchia si riservano di inrendersi sui particolari.
Anche l 'Inghilterra ebbe i suoi benefici riuscendo ad impedire la discussione s ul diritto in g lese, contestato dalla Ru ssia, di libero transito attraverso i Dardanelli-Bosforo e la sovra nità sull'isola di Cipro sottratta alla Turchia.
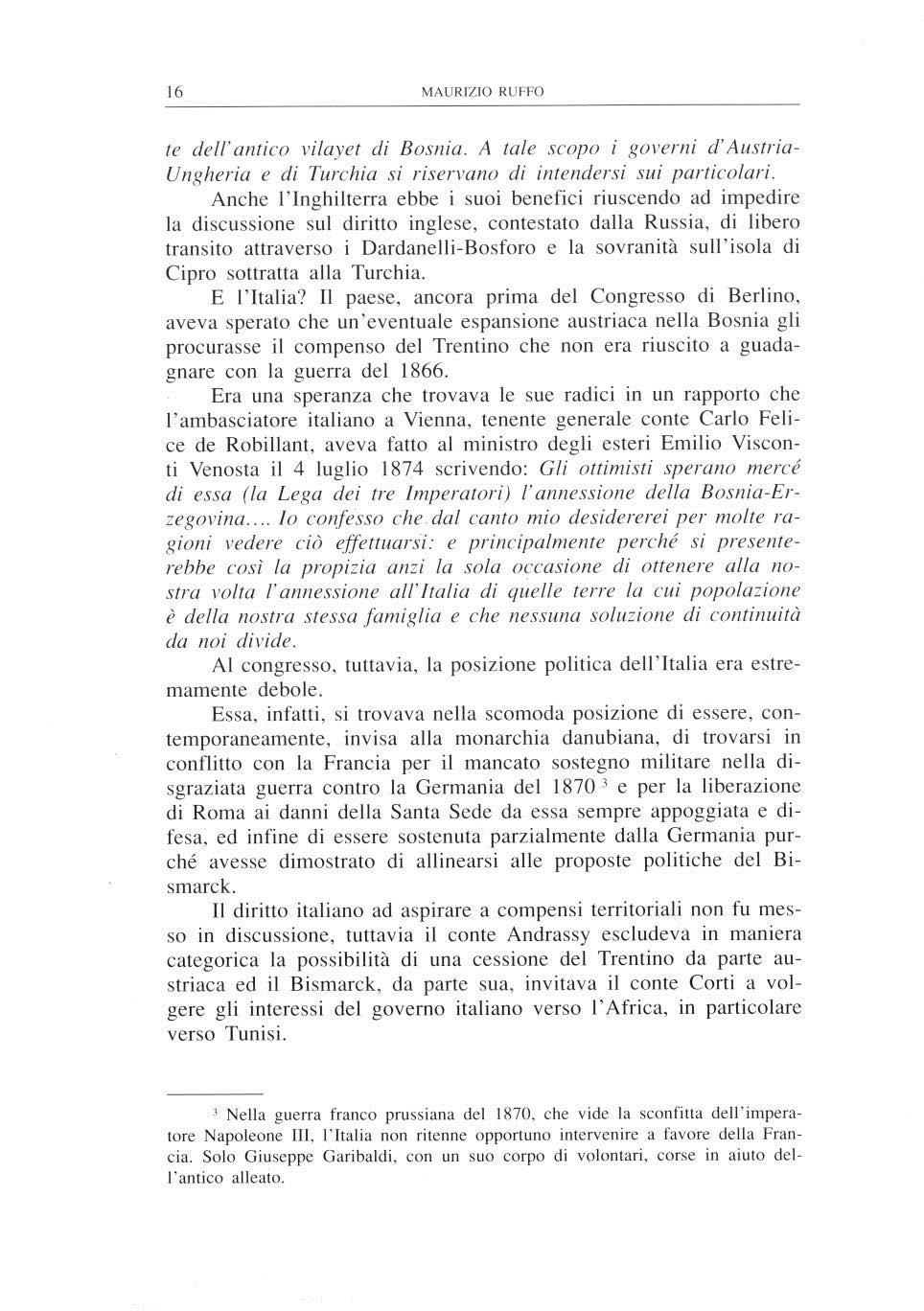
E l'Italia? Il paese, ancora prima del Congresso di Berlino, aveva s perato che un'eventuale espansione austriaca nella Bosnia g li procurasse il compenso del Trentino che non era riuscito a guadagnare con la guerra ciel 1866.
Era una speranza che trovava le sue radici in un rapporto che l'ambascia tore italiano a Vienna, tenente generale conte Carlo Felice de Robillant, aveva fatto al mini s tro degli esteri Emilio Visconti Ve no sta il 4 luglio 1874 scrivendo: Gli ottimisti sperano mercé di essa (la Lega dei tre imp eratori ) l'annessione della Bosnia - Erzegovina .. .. lo confesso che dal canto mio desidererei per molte ragioni vedere ciò effettuarsi: e principalmenre perché si presenterebbe così la propiz ia an zi la sola occasione di ottenere alla nostra volta l'annessione all'Italia di quelle terre la cui popola zione è della nostra stessa famiglia e che nessuna solu zione di continuità da noi divide.
Al congresso, tuttavia, la posizione politica dell ' Jtal ia era estremam en te debole.
Essa, infatti , si trovava nella sco moda posi zione di essere, contemporaneamente, invi sa a ll a monarchia danubiana, di trovarsi in conflitto con la Francia per il mancato sos te g no militare nella disgraz iata guerra contro la Germania del 1870 3 e per la lib erazione di Roma ai danni della Santa Sede eia essa se mpre appoggiata e difesa, ed infine di essere sosten uta parzia lmente dalla Germania purché avesse dimo s trato di allinearsi alle proposte politiche de l Bismarck.
Il diritto italiano ad aspirare a compensi territoriali non fu messo in discussione, tuttavia il conte Anclrassy esc ludeva in mani era categorica la possibilità di una cessione del Tr entino da parte aust riaca ed il Bismarck, eia parte sua , invitava il conte Corti a volgere g li interessi del governo italiano verso l'Africa, in particolare verso Tunisi.
1 Nella guerra franco prussiana d el 1870 , che vide la sconfitta del! ' imperatore Napo leone III, l 'Ita lia non ritenne opportuno intervenire a favore della Fra nc ia. Solo Giuseppe Ga rib aldi, con un s uo corpo di vo lontar i. corse in aiuto del!' antico alleato.
Lo scopo di tutla questa situazione era quello di suscitare una conflittua li tà insanabile fra l'Italia e la Francia e, nel contempo, di avvicinare e legare definitivamente la monarchia italiana alla Germania.
Il conte Corti, da parte sua, non poté accettare la so luzione propostagli, sia per non cedere sulla quest ione delle terre irredente sia per non aumentare i già notevoli motivi di attrito con la vicina repubblica francese per la que s tione romana.
L ' It alia quindi , che aveva partecipato a l co ng resso co n il fermo propo s ito di far ritorno d a esso con le mani ne tte, ne uscì a mani vuote mentre la Fran c ia , c he era riuscita ad ottenere il co nse nso dell ' Tn g hilte rra e de ll a Germania , ne approfittò per occ up are T unisi il 12 magg io 18 81 4
• Tu nis i : il via l ibera alla Francia per l'occ upazio ne de ll a Tu ni s ia da parte di In ghi lterra e Germa ni a aveva lo scopo di impedire ali' Ita lia il pi eno controllo d e l Canale di Sicilia da u na parte e d i dis t og liere la Fra ncia eia aspirazion i di riv incita in Europa dall'altra.
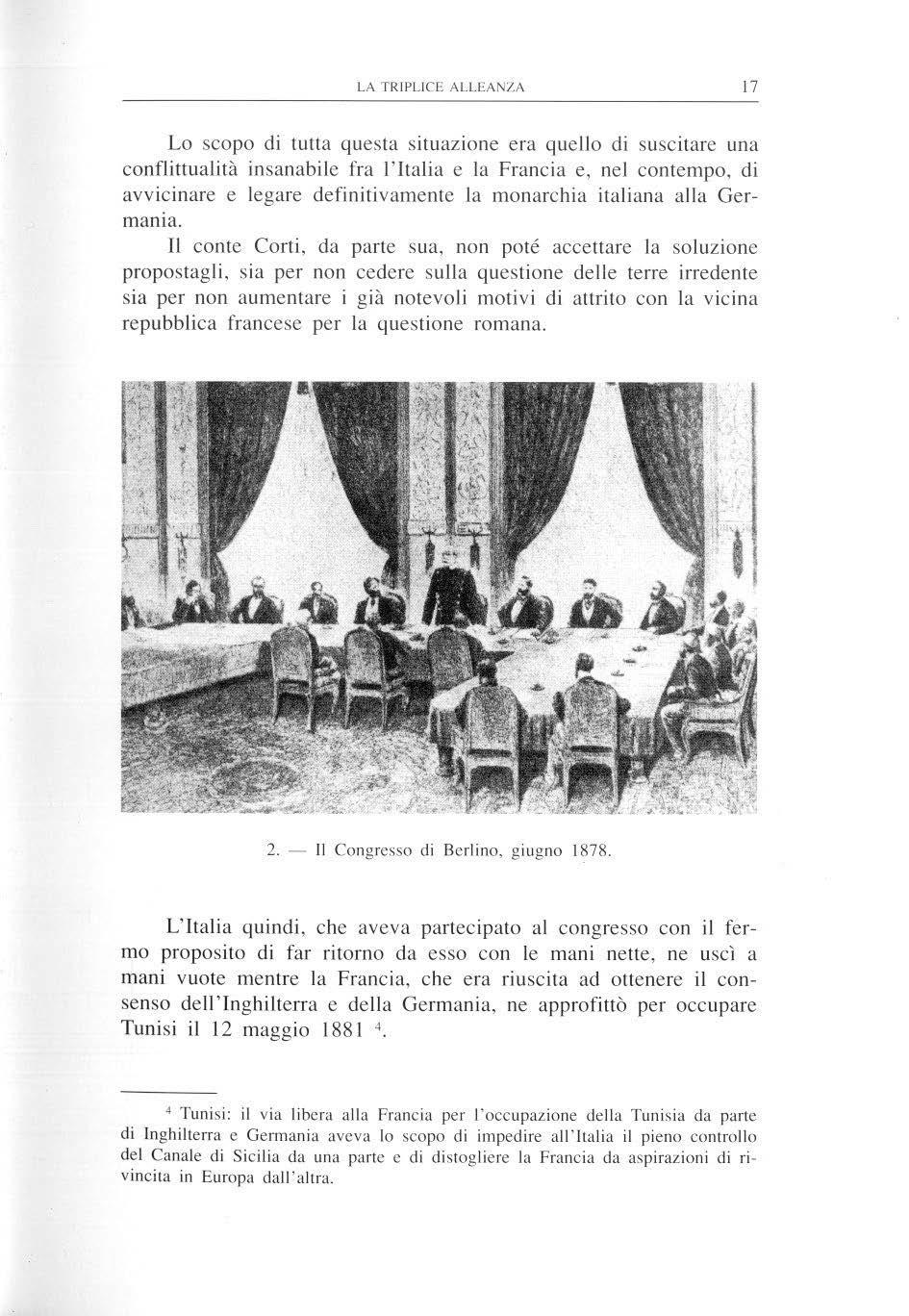
Sul Congresso di B erl ino P ietro Si i va scrive che: Per qua1110 riguarda la poli1ica europea si può dire che dai giorni di Berlino si preparò la Triplice Allean:a e si delinearono anche le circos1a11:e che porteranno alla formo:ione della Duplice intesa franco-russa. lnfa11i Bismarck, legando a sé /'Aus1ria (facendole assegnare la Bosnia e I' Er:egm·i11a) geflò le basi del/' allean:a, che fu stre11a formalmente /' 011110 dopo. e olla quale poi, sotto /' impressione del colpo di Tunisi. aderì nel 1882 /"Italia; mentre per contro, /' irrira:io11e russa contro la Germania, 1·ivo dai giorni delle delusioni di Berlino. cominciò ad orientare la Russia verso l'a\'\'ersaria della Germania, e cioè lo Francia \
L'asp irazione del cance ll ie re tedesco mirante a costruire u n sistema di equilibrio europeo che impedisse alla F rancia ogni aspiraz ione d i riva lsa e lo sceg li ere un rapporto priv i legiato con la monarchia danubiana. ar restando le aspirazioni russe nei Balcani, portò ad una situazione per molti aspetti più instabile di quella che ~i presen tava a ll a v ig il ia de l Co ng resso d i Be rlin o.
Pe r conso l idare la situazione creatasi e con l'aspirazione di essere l'artefice dei destini dell' E uropa, il Bismarck provvide a stip ul are, ne l 1879, u n pa tt o d i a ll eanza a nti russ a con l 'A ust r ia-Ung he r ia che prevedeva la neutralità della na7ione contraente se l'offesa fosse g i un ta da una potenza diversa dalla R ussia.
Ques to patto sortì l'effe ll o des iderato spi ngendo la R uss ia a r istabi lire relazio n i amichevoli co n gli I mperi cen t ral i . tanto da r inn ova re, ne l 188 1, la Lega de i Tr e Imp eratori 6
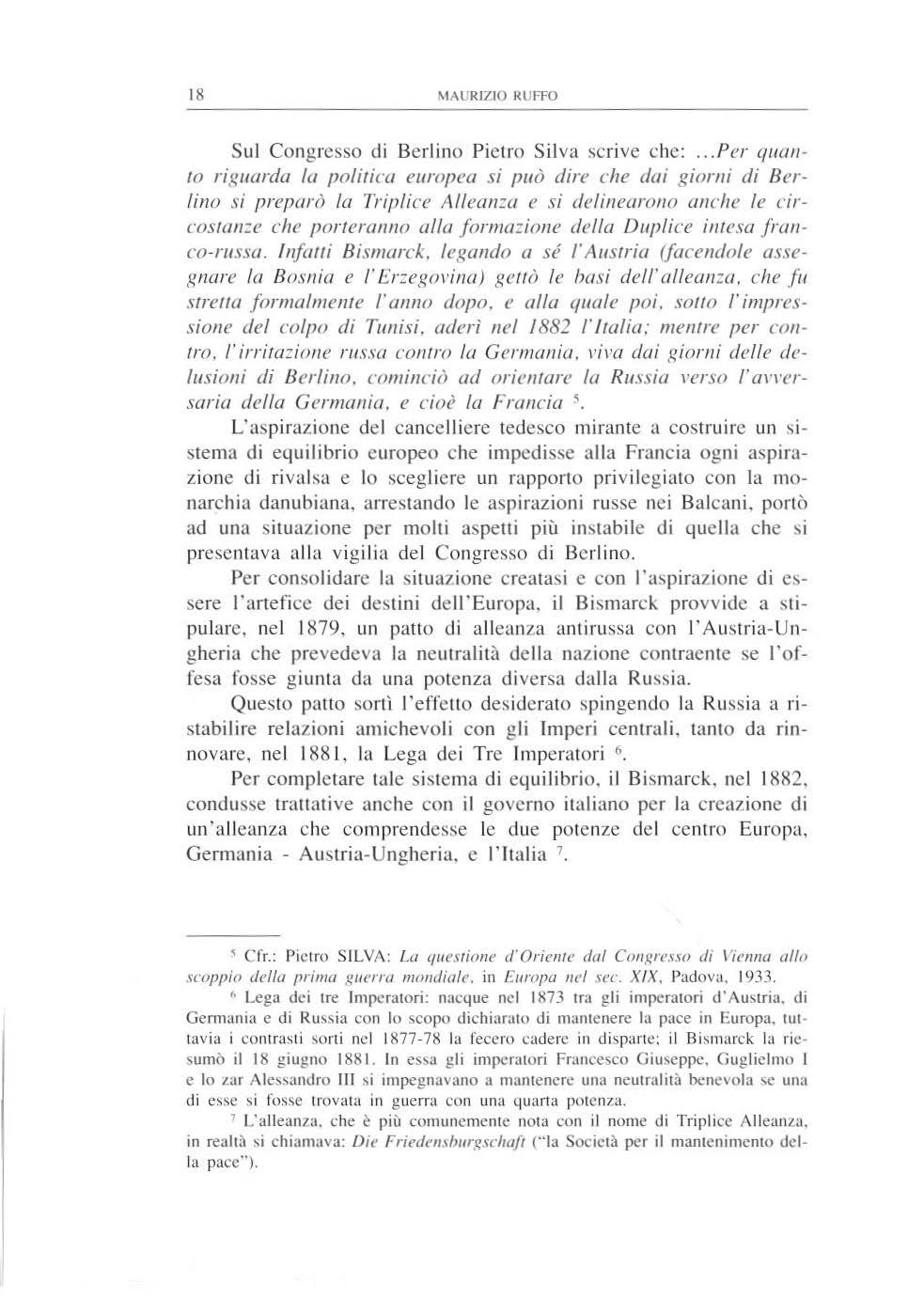
Per comple t a re ta le sistema di equil ibrio. il B isma rck, nel 1882. condusse tra11ative anche con il governo it aliano per la creazione di un 'a ll eanza c he co mpr e nd esse le d ue po te n ze de l ce n tro Eu ropa, Germania - Austria-Ung heria. e l' It a l ia 7
Cfr.: Pie tro S! LVA: La q11esrio11e d'Orienre dal Congresso di \'ienna allo .vcoppio della prima guerra 111011diale. in Europa nel sec. XIX, Padova. I 933.
1 ' Lega dei ire Imperatori: nacque nel 1873 tra gli imperatori d'Austria. di Gem1ania e di Ru~sia con lo scopo dichiaralo di man1enere la pace in Europa, 1utt avia i con tras ti sorti ne l 1877 -78 la fecero cadere in dispa rt e: il Bis marck la riesumò il 18 giugno I 881. In essa gli imperatori Francesco Giusepp..:, Guglielmo l e lo ,:ar Alessandro lii i.i impegnavano a mantenere una neutralità benevola ,e una d i esse si fosse trovata in gue rra con una quarta po1c nza.
7 L"alleanza, che è più comunemen te nota con il nome di Trip lice Al lean,a. in realtà si chiamava: Die Friedell.\/111rgsclwf1 ("la Società per il mantenimento della pace").
L'a ll eanza, di per sé innaturale , trovò nei t re paesi motivazion i completamente differenti, ma ne ll a stesso tempo complementari.
La Germania , da parte sua , s ì re nd eva pienamente conto che, in un even tu a le confl itto con la Fra nci a, no n avrebbe potuto fare assegnamento su ll 'appoggio de ll ' Imp ero asb urg ico o su lla Ru ssia e desiderava impedi re che, in una probabile crisi balcanica, l ' It a lìa sos te nesse la Ru ss ia co ntro la monarchia danubiana.
L'Au s tria avve rti va la necess it à d i ass icurarsi i confin i italiani del 1866 per co ntra s ta re l ' irrede nti s mo italian o semp re v ivo nel Trentino e nella Venezia Giulia, di difende r s i dalla amb iz ion i ru sse nei Balc ani e d i creare un fronte mona r chico conse r vatore in grado dì opporsi a l propagars i delle sempre più diffuse idee socialiste
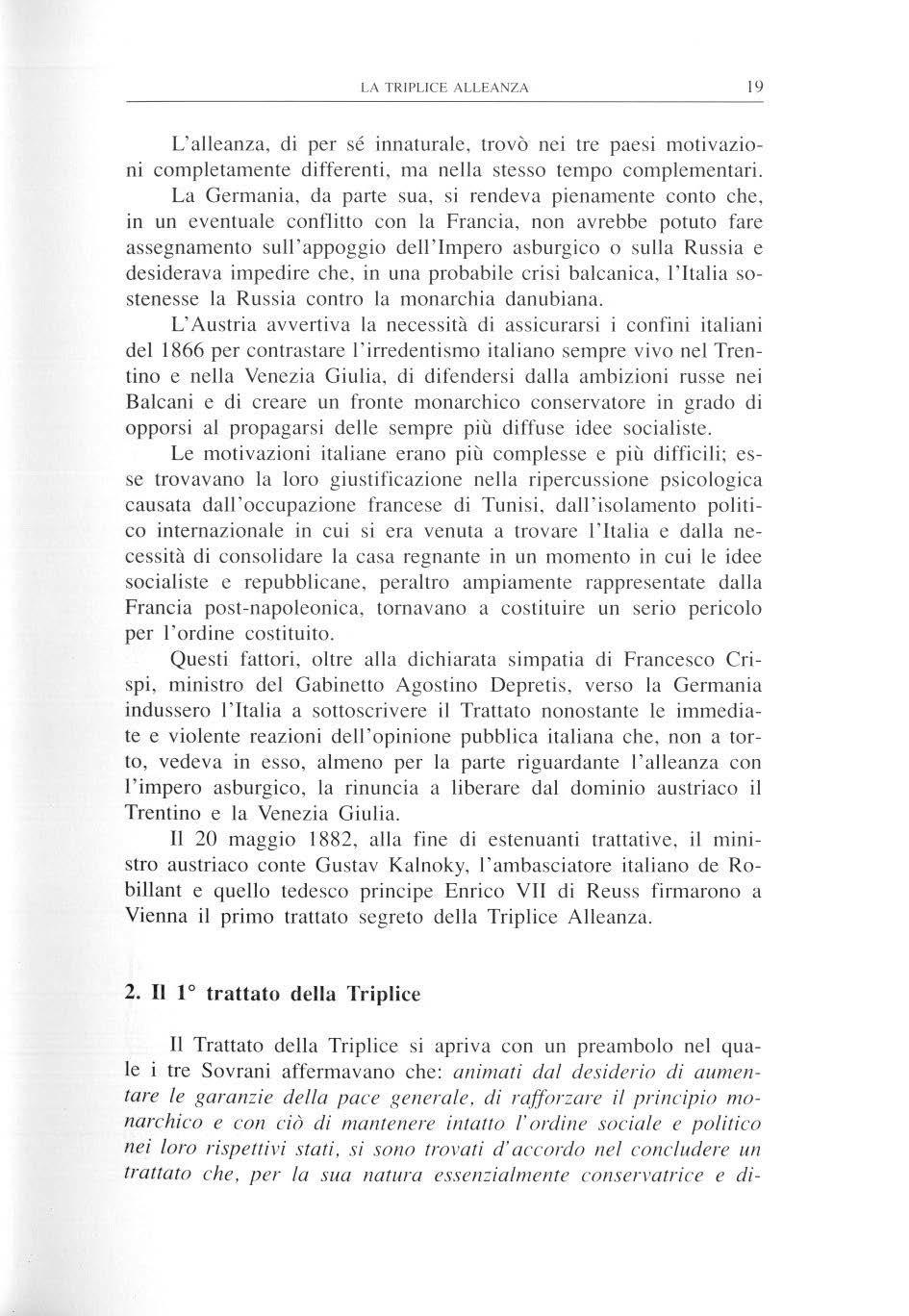
L e m ot iv az io ni italiane e ra no più comp lesse e più difficili: esse trovavano la loro giustificaz ione nella ripercussione psicologica causata d all'occupazione francese cli Tunisi, dall'isolamento politico in te rn az iona le in cui si era venuta a trovare l'Italia e dalla necessità di co n sol idare la casa regnante in un momento in cui le idee socialiste e repubblicane , peraltro a mpiam ente rappresentate da l la Fran c ia post-napoleonica, tornavano a cos tituire un se ri o pericolo per l'ordine costituito.
Questi fa tt o ri , o ltre alla dichiarata si mp at ia di Francesco Crìsp i, ministro del Gabinetto Agostino Dep ret is, ve rso la Germania indussero l ' Italia a sottoscrivere il Trattato nonos t an te le immediate e violente reaz ioni dell' o pinion e pubblica italiana che , non a torto, vedeva in esso, alm e no per la parte ri g uardante l 'a llean za co n l ' impero asburgico, la rinuncia a liberare dal d o mini o austriaco il T rentino e la Venezia Giuli a.
Il 20 ma gg io I 882, a ll a fine di es tenu anti trattative , il minis tro austriaco conte Gustav Kaln o ky, l'amb asc i a tore itali a no de Robillant e qu e llo tede sco principe Enrico VII di Reu ss firmar o no a Vienna il primo trattato seg r e to de ll a Trip l ice Alleanza.
2. Il I O tr a tta t o d e ll a Tripli ce
Il Trattato d e lla Triplice si apriva co n un preambolo ne l quale i tre Sovrani affermavano c he : animati dal desiderio di aumentare le ga ran z ie della pace generale, di rafforzare il principio monarchico e con c iò di mantenere in1ar10 /'ordine soc ial e e politico n ei loro rispe tti vi sta ti , si sono trovati d'accordo nel conclude re un lratlato ch e, per la sua natura essenz ialm ente consenarrice e di-
fe11sil'a, 11011 persexue altro scopo che di premunirli contro i perico li che potrehhero minacciare la sicure:::a dei loro Stati e la tranquillità dell'Europa.
Quindi, nominati i pl e nipotenziari a cui toccava l'onere di redigere g li olto articoli di c ui era co mpo s to il patto, si passava al c uore del trattato vero e proprio con. alla fine e su chiara richies ta italiana proiettata per la sua s tessa posizione geos trat egica in una visione più mediterran ea e di amicizia verso l' Inghilterra, una dichiarazione es pli ci ta di ogni singo lo contraen te che le stipula.lioni del traltato non potevano. in alcun caso. essere dirette contro l'Impero hritannico.
Nell'articolo primo le parti contrae nti si promcltevano pace ed amicizia e si impegnavano a non entra re in nessuna alleanza od impe g no diretto contro una di esse ed a procedere ad uno scambio di idee su ll e questioni politiche ed economiche che potessero presentarsi. s i promettevano. inoltre. il mutuo appoggio nei limiti dei ris pe ttivi int e re ss i.
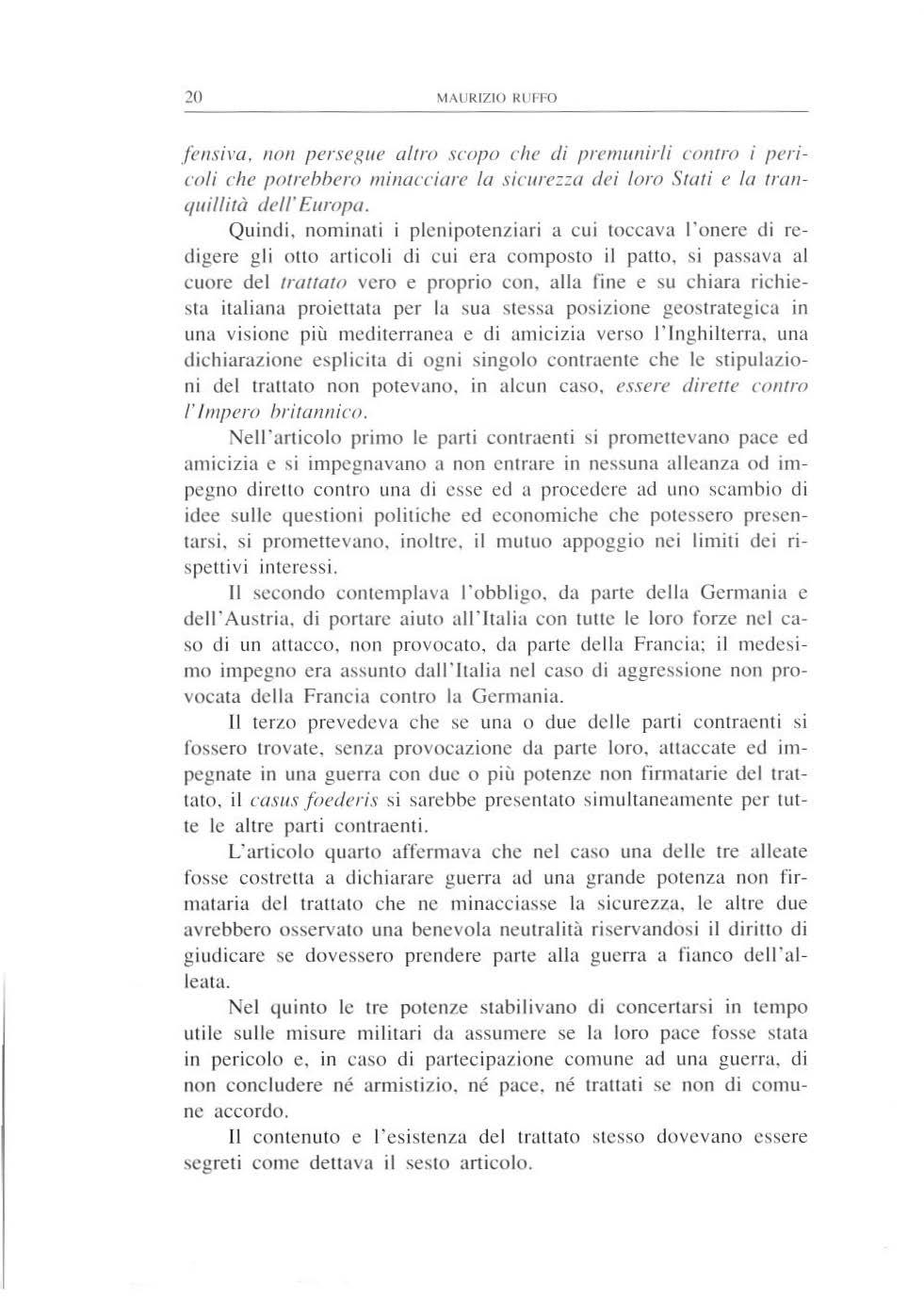
Il secondo contemplava l'obbligo. da parte della Germania e dell"Austria. di portare aiuto all 'It alia con tulle le loro forze nel caso di un attacco, non prov oca to, da parte d e lla Francia; il m edesimo impegno era assunto dal!' Italia nel caso di aggressione non provocata della Francia co ntr o la Germania.
Il terzo prevedeva che se una o due delle parti contraenti si fossero tr ova te, senza prov ocazio ne da parte loro, altaccate ed impegnate in una guerra con due o pit1 potenze non firmatarie del trattato, il ca s us foederis si sarebbe pre~entato simultaneamente p e r tutte le altre parti contraenti.
L·anicolo quarto affermava che ne l caso una delle tre alleate fosse costretta a di<.:hiarare g uerra ad una gra nde pot e nza non firmataria del trattato che ne minacciasse la sic urezza , le altre due avrebbero o~servato una benevola neutralità ri serva nd osi il diritto di giud icare se dove sse ro prendere parte alla g uerra a fianco d e ll'alleata.
'e l quinto le tre pot e n ze stabilivano di conce rtars i in tempo utile su ll e misure militari da assumere se la loro p ace fosse stata in pericolo e , in caso di partecipazione comune ad una guerra. cli non conclude re né a rmi st izi o . n é pace . né trattati se n on di comune accordo.
Il conten ut o e l 'esistenza del trattato stesso dovevano esse re segre ti come detta va il sesto articolo.
Per ultimo gli articoli sett imo ed ottavo prevedevano che la durata de l patto fosse di cinque anni a partire dalla data delle ratifiche e che le stesse fossero ratificate a Vienna entro tre settimane 8 • li Trattato, anche se non portava a grossi vantaggi per l'Italia aveva il merito di ridurre la questione romana ad un fatto interno, togliendo alla Francia la possibilità di una sua intromissione o di un intervento militare che avrebbe fatto scattare immediatamente l'impegno del sostegno militare tedesco.
È anche vero che ana logo obbligo l'Italia r aveva nei confronti della Germania in caso di attacco francese, ma non quello di sostenere l 'Austria in caso di attacco da parte della sola Ru ss ia.
In oltre l'alleanza stipu lata offriva all'Italia sia la poss ibilità di lib erarsi dal suo pericoloso isolamento, prendendo posto come grande potenza a l fianco dei due Imperi, che la garanzia da ogni attacco a ustriaco.
Il principale merito dell'alleanza era il suo carattere difensivo bene evidenziato nel preambo lo e nel testo di quegli articoli che disponevano che il casus Joederis sì presentasse solo nell'even tu alità di aggressione non direttamente provocata da una delle parti contraenti.
L'alleanza implicava ovviamente tutta una serie di misure di collaborazione in campo militare, da ass umersi d'intesa con le autor ità militari a ll eate, che , in verità, nei primi anni di vita dell'alleanza non furono particolarmente intense; ciò anche perché gli Stati e ran o gelos i ss imi della propria indipendenza.

Il primo rinnovo fu firmato a Berlino il 20 febbraio 1887, m a la s ua s tipula era avvenuta, co m e previsto dal Tra ttato iniziale, dopo un quinquennio in c ui gl i avvenimenti politici inte rna z ion al i avevano non solo qua s i resa s up erfl ua l'a ll ea nza, ma ne avevano messo in discussione tanto la val idit à quant o l 'esis tcnza.
L' Italia era malcontenta per la mancata restituz io ne a R oma della v i si ta de l R e U mb e rto a Vienna e, sop ra tt utto , perché era stata lasciata a l di fuo ri delle intese e deg li incontri fra i tre Imp era tor i. Si contrapponeva l 'i nsoddisfazione degli I mper i a ll ea ti per l 'irred e nti smo italiano, mai sopito, come dimostra l 'a rresto e la co n-
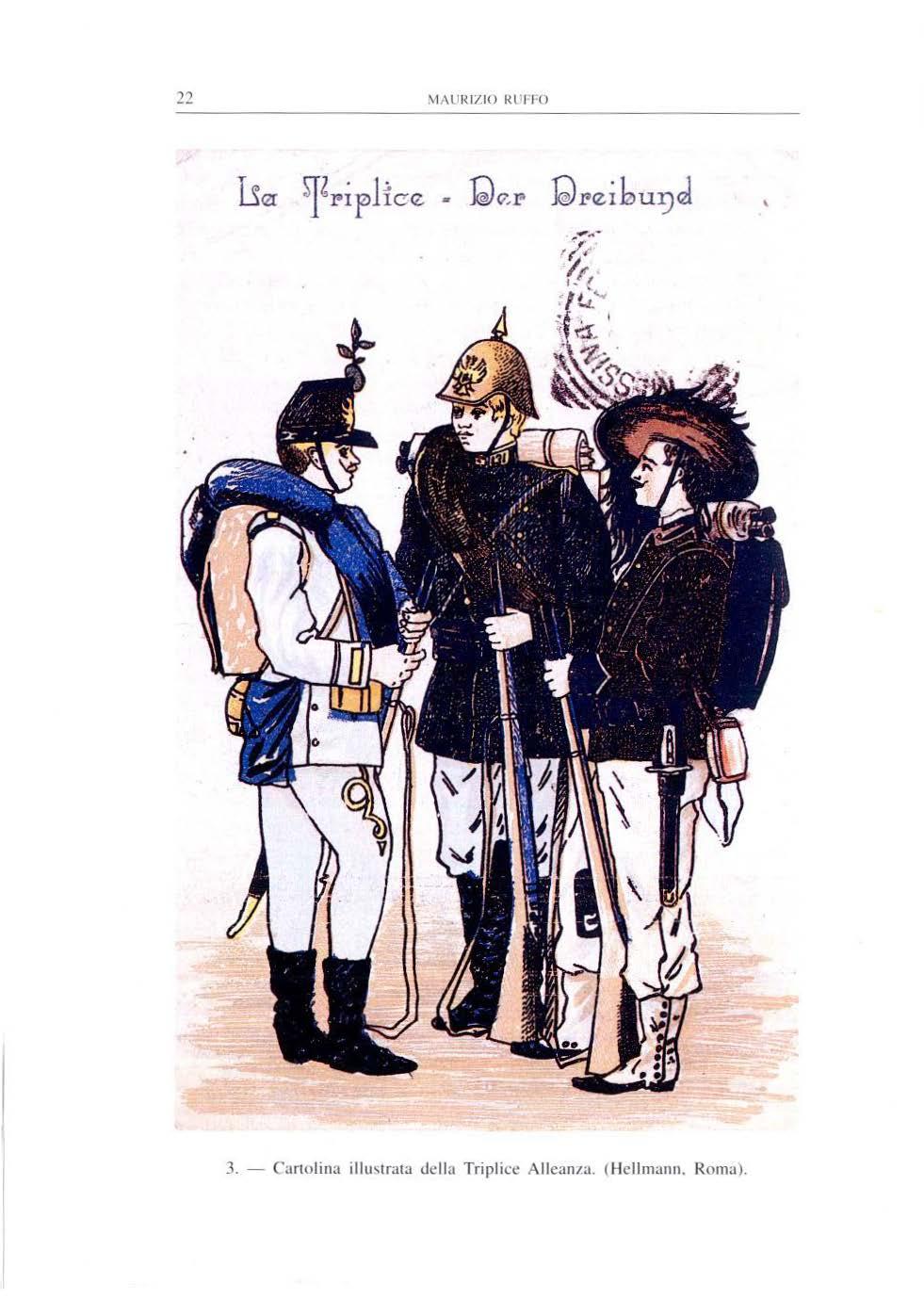
danna a morte di Guglielmo Obcrdan 9 a Trieste nel 1882 ed il discorso in onore dell'esule trentino Giovanni Prati 10 • morto a Roma il 9 maggio del 1894, tenuto a l Senato il 12 maggio dello stesso anno dal Presidente Sebastiano Tccchio, e per lo scarso apporto di forze c he l'Italia apportava ali' Al leanza.
In oltre l'occupazione di Massaua, avvenuta il 5 febbraio 1885, su consiglio degli Inglesi ed ali' insaputa degli alleati contribuiva a far crescere un certo senso di sfiducia tra i membri della Tripli ce.
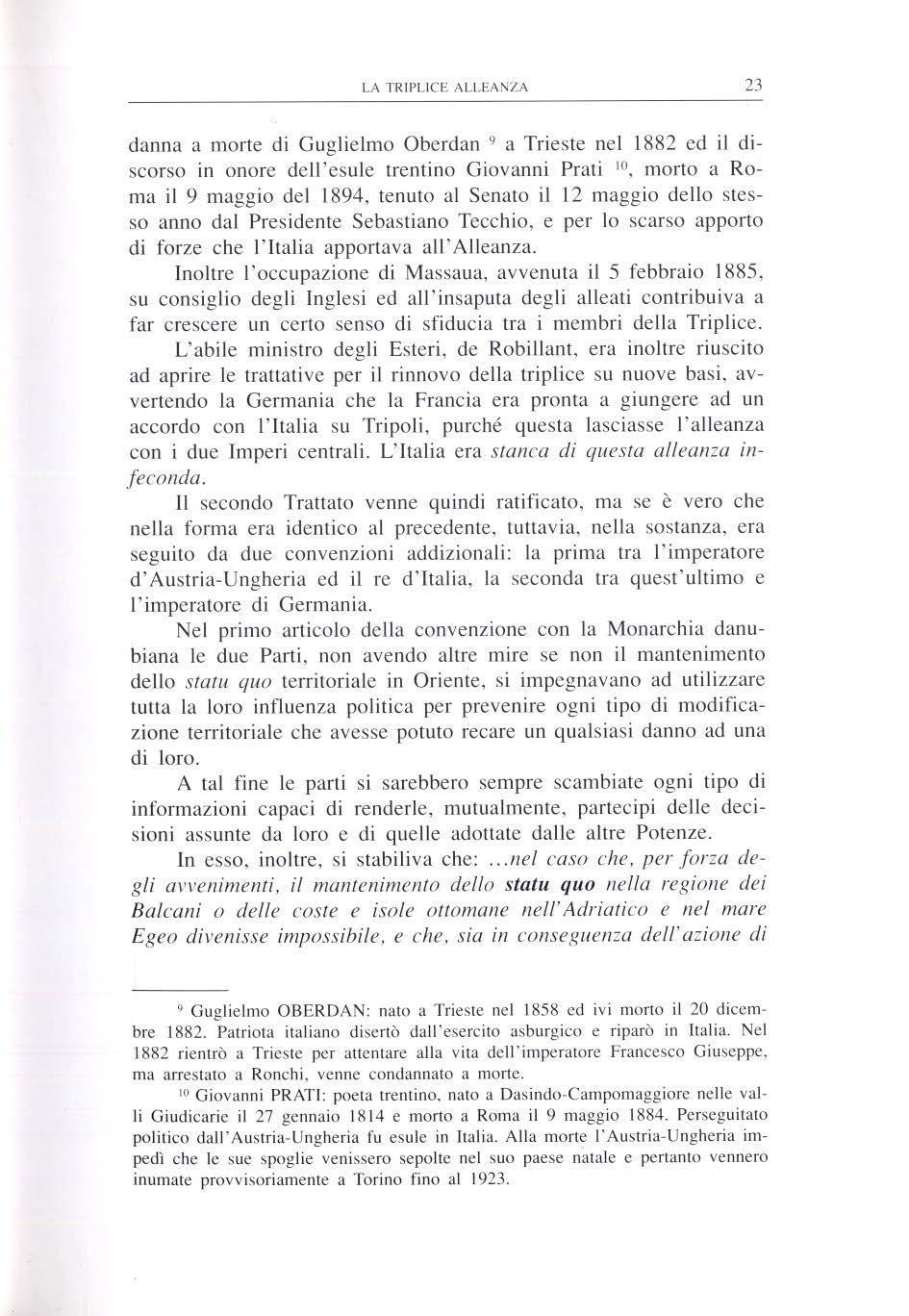
L'abile ministro degli Esteri, dc Robillant, era inollre riuscito ad aprire le trattative per il rinnovo della triplice su nuove basi, avvertendo la Germania che la Francia era pronta a giungere ad un accordo con l'Italia su Tripoli, purché questa lasciasse l'alleanza con i due Imperi centra li . L 'Italia era s1anca di questa aL/eama infeconda.
11 secondo Trattato venne quindi ratificato. ma se è vero che nel la forma era identico al precedente, tuttavia. nella sostanza, era seguito da due convenzioni addizionali: la prima tra l ' imperatore d'Austria-Ungheria ed il re d'Ita li a, la seconda tra quest'ultimo e l'imperatore di Germania.
Nel primo articolo della convenzione con la Monarchia danubiana le due Parti, non avendo allre mire se non il mantenimento dello statu quo tenitoriale in Oriente, si impegnavano ad utilizzare tutta la loro influenza politica per prevenire ogni tipo di modificazione territoriale che avesse potuto rec~u·e un qualsiasi danno ad una di loro.
A tal fine le parli si sarebbero sempre scambiate ogni tipo di informazioni capaci di renderle, mutualmente. partecipi delle decisio ni assunte da loro e di quelle adottate dalle altre Potenze.
I n esso, inoltre, si s tabiliva che: .. . nel caso che, per forza degli avvenimenti, il mantenime11to dello sta tu quo nella regione dei Balcani o delle coste e isole o/tornane e nel mare Egeo dii·enisse impossibile, e che, sia in conseguen:a cieli' azione di
9 Guglielmo OBERDAN: nato a Tries te ne l 1858 cd ivi morto i l 2 0 dicembre 1882. Patriota ita lia no disertò dall ' es erc ito asburgico e riparò in Italia. Nel 1882 ri e ntrò a Trieste per attentare alla vita dcll' imperawre Frances co Giu seppe. ma arres tato a Ronchi. venne condannato a morte.
10 Giovanni PRATI: poeta trentino. nato a Dasindo-Campomagg iore nelle valli G iudicarie il 27 gennaio I 8 14 e morto a Ro ma il 9 maggio 1884. Perseguitato po litico dal l ' A us tria- Ungheria fu es ule in Ital ia. A ll a morte r Au stria-Ungheria impedì che le s ue spogl ie ven issero sepo lte nel suo paese nata le e pertanto vennero inumate provvisoriamente a Torino fino a l 1923.
una ter:a poten:a. sia altrimenti. /'Amtria-Ungheria o /' l tc,lia si 1·edessero n ella necessità di modificarlo con w,a occupa:ione temporanea o perm a n ente da parte Lo ro, questa occ11pcr::io11c 110 11 avrà luogo se 11011 dopo t111 accordo pre1·e11tÌl'o fra le due sopraddeue poten:e. accordo hasato sul principio di w1 compenso re ciproco per og ni 1•a11raggio t errit oriale o a lt ro che ciascuna d'esse oue11esse in più dello statu quo aflual c. e tale do dare sodcli.lfa:io11c ai /i interessi e alle pretese ben fondate delle due parti 11 •
Gli artico li terzo e quarto de ll a conve n zione con la Ge rmani a prendeva no in esa m e i cas i in cui era da considerarsi va lid a l' eventuale richie s ta di casus helli da parte italiana, in caso di co nflitto contro la F ranc ia , per salvaguarda re la propria p os iz io ne nel Medit erra neo e le p ossibil i rive ndi cazioni terri torial i per gara ntirsi le fronti e re verso qu es ta a g ue rra co nc lu sa; in pa rti co lare i du e articoli rec itavano :
Art. lii - Se a1 ·,·e11isse che la Fran cia facesse alto di estendere la sua occ11pa : io11e o il s uo proteftorato o la su a so1·ranità. so tto qualunqu e fo rma , sui ter ritori nord -afri ca ni, s ia del 1·ilayet di Tripoli. sia rnarocchino. e che in co11seg11r11:a di tal folto /' I talia. per safraguardare la sua posi:io11e 11el Mediterraneo, credesse dol'er essa stessa i11trapre11dere un ' a:ione sui de/li territori 11ord-africa 11i. oppure ricorrere, sul territorio francese in Europa, ai me::i estremi. la stato di guerra che ne seguirehhe fra I' Italia e la Fran cia costituirehhe ipso facto , su domanda e a carico co mun e d ei due all ea ti. il casus foederis co11 tutti gli effet ti pre,•isti dagli articoli li e \I del suddetto trattato del 20 maggio I 882, come se simile e1·entualità 1·i fosse con t emp lata espressame11te.
Art. IV - Se la fortu11a di qualunqu e gue rra intrapresa in co mun e contro la Francia portasse l'Italia a cercare delle garan : ie territoriali 1·erso la Francia. per la sicure::a delle frontiere del regno e della s11a posi:io11e marittima, come a 11 che in vista della stabilità della pace, la Genna11ia 11011 1•i porrà alcuno ostacolo e al bisogno, e in misura compatibile con la circostan:e, si applicherà a facilitare i me:zi di raggiungere un tale scopo 12
11 Cfr.: Giulio CAPRT . / 7rauat i se~reu delfa Triplice i\lfean:a. Zanichelli, Bolo gna 1922. pa g. 47 -48
11 Cfr.: Ibidem pag. 50-5 l.

Ques te clausole aggiuntive, fermamente contestate da l! ' AustriaUng heria che non ammetteva ingerenze dell'Italia nei Balcani , furono il capolavoro del R obillant che, sfr ullando la si tuazione interna zi onale 13 , costrinse il Bi smarck non so lo a non opporre difficoltà alle richieste it a li a ne per qua nt o riguardava sia la questione dei compensi sia l 'appogg io nel Mediterraneo ed in Nord-Africa, ma anche a conv incere il primo ministro asburgico Kalnok y ad accettarle.
Gli ann i che se pararono il primo rinnovo dal secondo furono caratte ri zzati da una febbr il e attiv it ~1 diplomatica che vide tutti g li stat i e uropei impeg nati nella stipula di trattati bilaterali qua li l' intesa anglo - italiana del 1887 ed il trattato ru sso-tedesco di controass icura z ione del 1887, ma reso d i dominio pubblico so lo ne l 1896.
Il I 892 vide il seco ndo rinnovo della T riplice che, sos tan zialmente ricalcò il precedente, fondendo in un unico re sto i tre document i del 1887 ed includendo, co n l 'a rti co lo nono. la disponibilit à ted esca a sos tene re l ' Italia nel mant.enimento d ello statu quo territorial e ne lle regioni nord-africane del Mediterraneo quali la Cirenaica , la Tripolitania e la Tunisia .
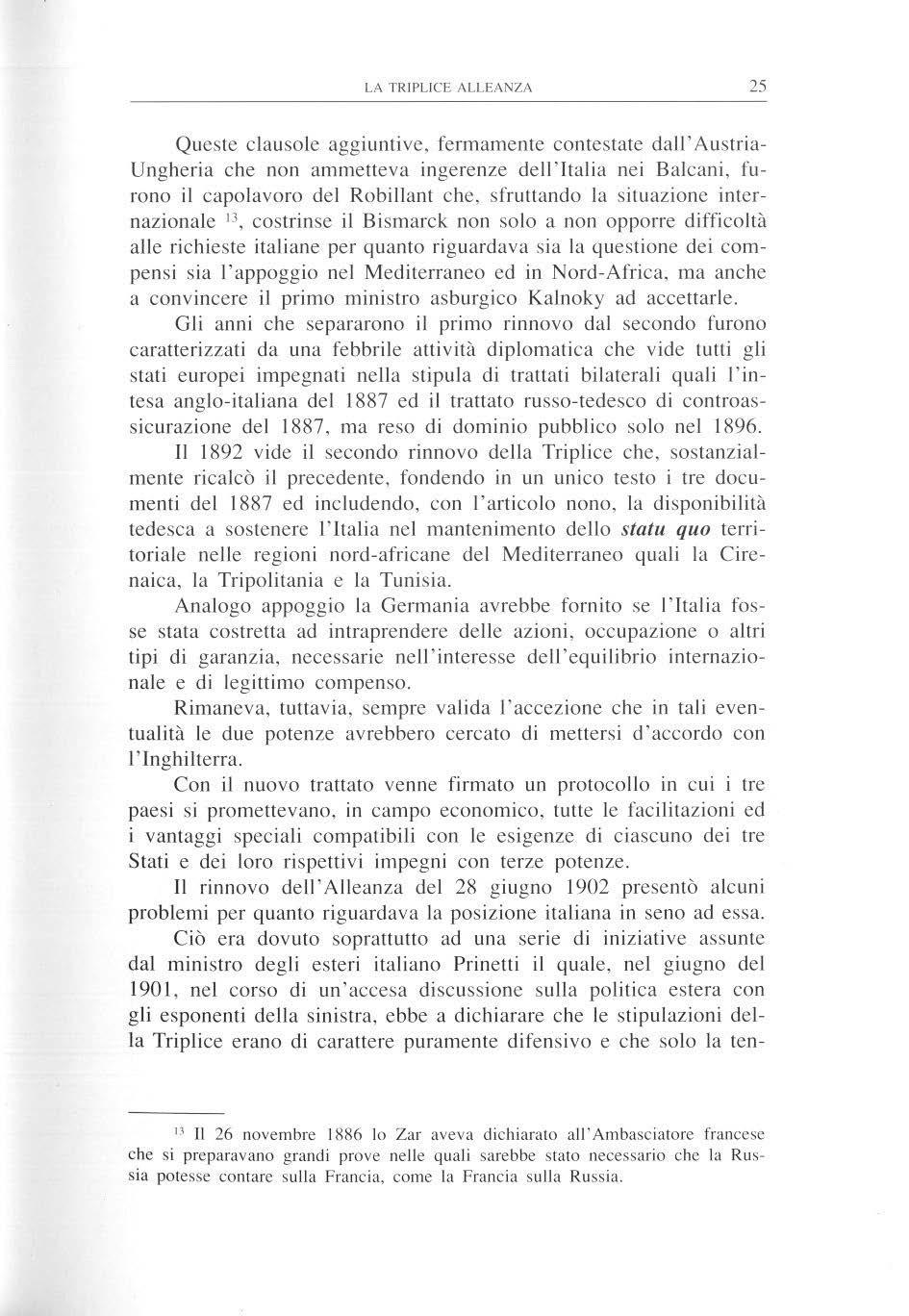
Analogo appoggio la German ia avrebbe forn ito se I 'Ttal ia fosse stata costretta ad intrapre nd ere dell e azioni , occupazione o altri tipi di garanzia, necessarie nell'interesse dell'equ ili brio int ernazional e e di le g ittim o compenso.
Ri maneva, tuttavia , semp re valida l 'accezione che in tali eventualit à le due potenze avrebbero cercato di mettersi d'accorcio con l ' l nghilte1Ta.
Con il nuo vo trattato ve nn e firmato un protocollo in cui i tre p aes i s i promettevano, in ca mpo eco n o mic o, tutte le facili t azioni ed i van tagg i specia li compa t ibili con le esige nze di ciascuno dei tre Stati e d ei loro ri s pettivi impeg ni con terze pote nze .
Il rinn ovo dell ' Alleanza del 28 g iu gno 1902 prese ntò alcun i problemi per quanto ri g ua rd ava la posizione italiana in se no ad essa.
Ciò era do vu to sopra ttutt o ad una se rie di ini z iativ e ass unte da l mini s tro degli esteri italiano P rin e tti il qual e, ne l gi ugno del 1901 , ne l corso di un'ac cesa di sc ussione s ull a politica estera con gli esponenti d e ll a s in is tra, e bbe a dichiarare c h e le s tipula zio ni d e lla Tripli ce e rano di caratte re puramente dife ns ivo e che s olo la ten-
i, l i 26 nov e mbre 1886 lo Zar aveva di ch iarato ali' Ambasciatore fran cese c he s i preparavano grand i prov e ne ll e q ua l i sareb be stato necessario che la Ru ss ia po tesse con tare s ulla Fra nci a , come la Fra ncia s ull a Ru ss ia.
d e nza di qual c he uom o politi co, il C ri s pi , le av eva dato, in pa ssato. apparenza offe n s iva: in o ltre. affermava c he da tempo ne era ch iaro lo spi rito pa cifico , ev id e nz iato d a l fatto c he le più intim e re/a:ioni con la Francia era no perfettamente conciliabili col pa tto d e lla Tripli ce
A que s to s i aggiunse c he lo sp aura cc hio d e lla qu es ti o ne roma na tornava ad affacc iars i per una ser ie di ini ziat ive dipl oma ti c he della Sa nta Sede che aveva ch ies to a ll"impera to re Gugl ielmo Il di interven ire dir e ttam e nt e con tr o l ' It a li a e, o tt e nuton e un rifiuto , di non cons id erare un even tu ale intervento francese co m e un 'agg ress ione a d una potenza della Triplice.
Qu esti fatti , uniti ad un a s itu azione ge ne ral e internaziona le c he s i s t ava evolvendo e nella quale r Aust r ia-Ung he ri a era emp re più impeg nata ver so i Bal ca ni. no nch é le pretese fran ces i che miravano non so lo a co no sce re i ter mini de ll'alleanza . m a anche, qualora vi foss ero, la cance ll az ione de ll e conve n zioni milit a r i o degli a tLi re lati vi, misero i ne goz iatori italiani in un a pos i z ion e così d e lic a ta da non poter ava nza re a lc un a richiesta di modifica al T rattato che fu rinn ova to ne l testo precedente.
D 'a ltra part e, s ull a sce na e urop ea, la posizione politi ca itali ana era la più delicata. bas ti pensare che un 'eve ntual e penetrazion e russa verso i Balcani co n il co nseg ue nte co ntroll o degli S tretti da par te di questa, avreb be re leg ato il paese ad un ruolo seco ndari o nel Mediterraneo trovandosi compresso fr a la zo n a d'influenza francese ad occ id e nt e e qu e lla ru ssa ad oriente.

In c hi ave politica. pertanto, l ' It alia aveva assoluto bi sog no dell' ap pogg io della G e rm ania più c he q uesta di quello italiano.
Infatti se un eve ntual e ritiro d e ll'Itali a dalla Triplic e avrebb e co mp o rt a to non pochi problem i alla Germania. nei co nfro nti dell a quale la Fran c ia avrebbe potut o uri li zzare an c he una parte delle forze di s loc.:a te s ul confin e it a li a no, e a ll ' Austria - Un g he ria c he av rebbe d ov ut o di s locar e un ma gg io r num e ro di unità s ul co nfine con l ' Italia a tutto detrim e nto dell e forze de s tin a te a pres idiare i confini con la Ru ss ia. le du e potenze, e in s pec ial modo la seco nda, s i se nti vano s uffi c iente m e nte fo rti da poter fare anche a m e no del1'a ll ea ta.
da ril eva re, inoltre, c he i documenti fin qui de scr itti. pur trattand o di un·a11eanza difen s iva e di sos teg no r ec ipro co tra i tre paes i e pur esse ndo ri go ro s am e nte seg reti , non conte nevano accordi di caratte re militare c he , d'altra parte, sare bbero s tati d e l tutt o norma li in si tu az ioni a nalo g h e.
Tuttavia, pur essendo i vertici militari, almeno quelli italiani, all'oscuro de l testo del Trattato, esisteva, pur sempre, una convenzio ne mi li tare, concl usa il 28 gennaio 1888 ed espressamente richiesta dal Crispi al Bismarck, tra lo stato maggiore italiano e quello tedesco.
In tale convenzione l'Italia si impegnava , in caso di guerra delle potenze della Triplice con la Francia e la Russia, ad inviare sul Reno un'armata composta da sei corpi d'armata , negli anni successivi ridotti a cinque, e tre divisioni di fanteria, poi ridotte a due.
È altresì eia tenere presente che, per quanto il trattato avesse carattere difensivo, era evidente che, nel caso in cui le potenze alleate fossero attaccate, la loro condotta di guerra fosse, sul la base de ll e esigenze esc lu sivamente militari, di natura offensiva.
Nel caso in cui, poi , una delle potenze attaccanti fosse la Francia, la migliore convenienza cli carattere militare presupponeva che l 'ese rcito it aliano non operasse tutto al confine italo - francese, dove le difficoltà dovute a lla natura montuosa della regione ed alle fortificazioni ivi esistenti avrebbero re so lente e costose le operazioni, ma che una parte considerevole, anziché rimanere inattiva in Italia, agisse nel settore ritenuto decisivo o principale, il Reno , a fomco dell'esercito tedesco.
Questa convenzione ebbe valore fino al 190 l quando il capo di stato maggiore tedesco , generale Alfred von Sc hli effen, di fronte alla prospettiva di essere privato non solo dell'apporto dei 200.000 Italiani previsti sul Reno, ma cli correre anche il rischio che I ' I tali a passasse nel campo avverso, affermava, con grande rincrescimento , di poter rinunciare a ll'impiego delle forze dell'alleata nel d elica ti ssimo setto re rena no.
Questa decisione era s tata , peraltro, negoziata con molta cautel a dal capo cli stato maggiore italiano, tenente genera le Tancredi Saletta, che aveva rappresentato il parere sfavorevo le del r e Vittorio
Emanuele III, nella sua veste di presidente del comitato della difesa na z ionale , ad inviare s ul Reno tant a parte delle migliori forze italiane ritenute indispensabili per proteggere il paese e le sue coste.
Con il rinnovo della Triplice de l 1902 l'orizzonte e urop eo, soprattutto p e r quanto ri g uardava i rapporti fra le potenze alleate e le a ltr e, se mbrava rischiararsi.
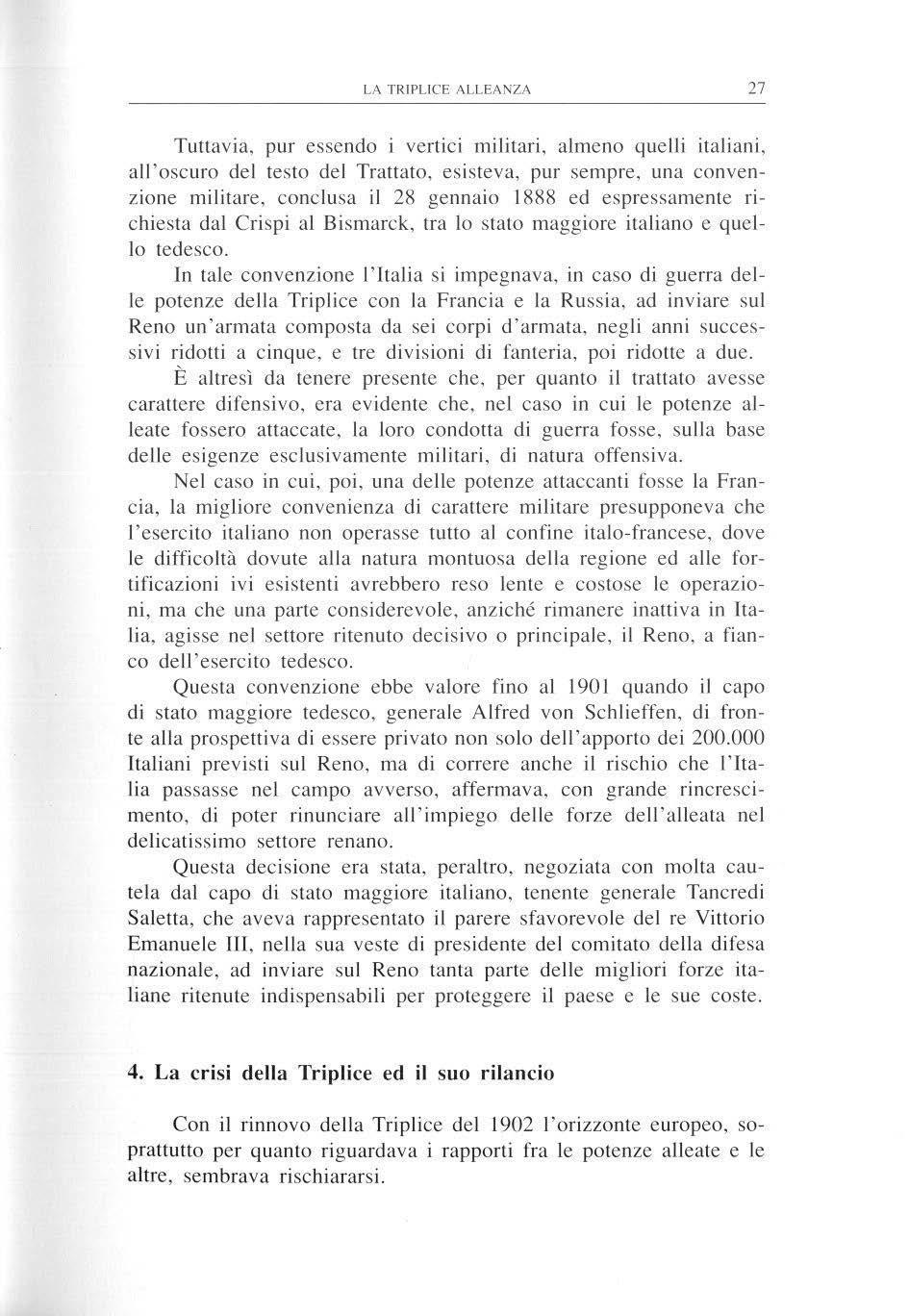
La Germania era riuscita. seppur con alcune incomprensioni. a tenere I· Italia nel l'alleanza senza peraltro dover cedere niente di più che una dichiarazione di appoggio per gli interess i italiani nel Mediterraneo.
L'Austria-Ungheria non solo era riuscita a non impegnarsi in maniera formale nel caso di un connitto sul fronte occidentale e nelle questioni nord-africane, ma, ed era la cosa a cui teneva in maniera particolare, aveva 011enuto di non dovere includere l'eventuale annessione della Bo,nia-Erzegovina nei casi di compensazione territoriale all'Italia cd in particolare di non includere in tale compensazione il Trentino.
L' It alia si era vista riconoscere ancora una volta un a11eggiamento benevolo e non ostile degli alleati nei confronti dell' l nghiltcrra cd una certa libertà cli manovra per riallacciare dei rapporti di buon vicinato con la Francia.
In realtà l'imperatore Guglielmo Il conduceva una politica di poten,a nella quale, oltre ad una posizione di primo piano sul continente, mirava a contras tar e l'In ghilterra come potenza navale, sp into dal convincimento che quest'ultima intrigasse ai danni della Germania.
Questa convinlione aveva indotto la Germania a sviluppare una politica a tutto campo nell a quale cercava un'intesa con la Ru ss ia , per spingerla verso oriente a minacciare gli interessi giapponesi ed inglesi. e un riavvicinamento con la Francia per ind urla a volgere l'a11cnzione verso l'Africa tralasciando ogni proposito di rivincita o rivendicazione su Il ' Alsazia-Lorena.
In realtà la Russia non ritenne opportuno staccarsi diplomaticamen te dalla Francia e qucst ·ultima riuscì ad accordarsi con ringhiltcrra s ulla base di un reciproco sostegno diplomatico nella sparti zione del Nord-/\ frica: al la Francia l ' int ero se tt o re occidentale, all'Inghilterra l'Egitto.
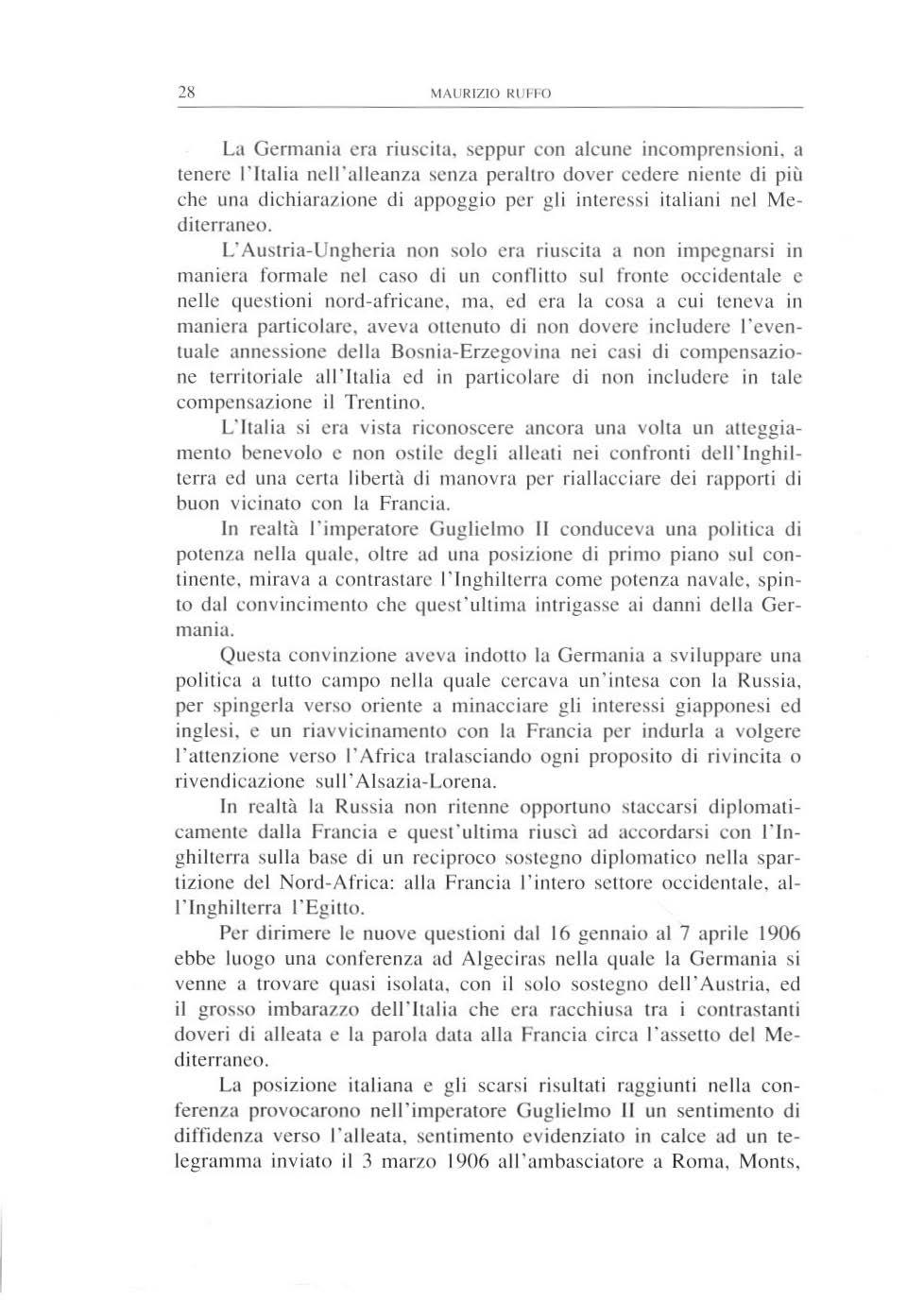
Per dirimere le nuove questioni dal 16 gennaio al 7 a pril e 1906 ebbe lu ogo una confere nza ad Algeciras nella quale la Germania si venne a trovare quasi isol a la. con il solo sos tegno dell'Austria, ed il grosso imbarazzo dell' It alia che era racchiu<;a tra i contras tanti doveri di alleata e la parola data alla Francia circa l'assetto del M editerran eo.
La posizione italiana e g li scars i ri sultat i ra ggiunt i ne lla conferenza provocarono nell'imperatore Guglielmo Il un sentimento di diffidenza verso l'alleata, sentimen to evide nziat o in calce ad un telegramma inviato il 3 mar zo 1906 all'ambasciatore a Roma , Monts,
in cui si legge: Nella Bihhia è scritto che nessuno può sen•ire due padroni: tanto meno rre! La Francia. l'Inghilterra e la Triplice' Ciò è assolutamente escluso. Ne risulta che l'Italia sta col gruppo Anglo-Gallico. Faremo bene a tenerne co1110. Questo alleato se 11e ,·a in fumo 14 •
Tale convinzione fu ribadita I' 11 marzo seguente: L'Italia rimarrà con noi soltall!o finche saremo amici Se 11011 sarà nuo\'amente cosl uscirà dalla hiplice 15.
Nel contempo il legame tra la Germania e la Monarchia danubiana andava sempre più consolidandosi fino al punto che, secondo l'ambasciatore austriaco a Berlino, il Kaiser avrebbe dichiarato che: qualora l'Italia aprisse le ostilità contro /'Austria-Ungheria. coilierehhe con ,·ero entusiasmo l'occasione di piombare unito all'Austria su di essa con tulta la sua potenza militare 16 • Tuttavia, le assicurazioni italiane verso la Germania e I 'atteggiamento conciliante del primo ministro tedesco Bernard von Bi.ilow, convinsero il Kaiser a proporre, in occasione della visita a Vienna nel giugno 1906, ali' imperatore asburgico di inviare al re d'Italia un messaggio di saluto.
La proposta fu accolta con entusiasmo da Francesco Giuseppe nella considerazione che in caso di rottura con l'Italia era l'AustriaUngheria la più esposta.
Sulla base di tali considerazioni, nel convegno di Vienna non solo non si parlò di una denuncia o di una modificazione dell 'alleanza, ma, considerata la situazione generale, si ritenne necessario unire il più strettamente possibi le l' It alia alla Triplice, specialmente a ll a luce de l! 'avvicinamento ing lese alla Francia che poteva compo r tare l ' uscita dell 'Ttal ia dall'alleanza stessa in virtù deg li stretti legami di questa con l'impero britannico.
In ta le ci r cos t anza la dip lomazia viennese, in teressata non solo a non alienars i l'allea to ita l ia no, ma anche ad avere ottimi rappor t i con l'I ngh il terra, ritenne oppo r tuno convincere la Germania non so lo a non denuncia re il T rattato, così come era nel la s ua ult ima form u laz ione, ma di lasciar passare l '8 lu g lio I 907, te r m ine ul timo utile per de n unc iarne la va lid it à, r innovando lo automaticamente.
14 Cfr.: Luigi ALBERTJNI. Le origini della guerra del 1914, vo i. I. Bocca, M ilano 1942, pag 182.
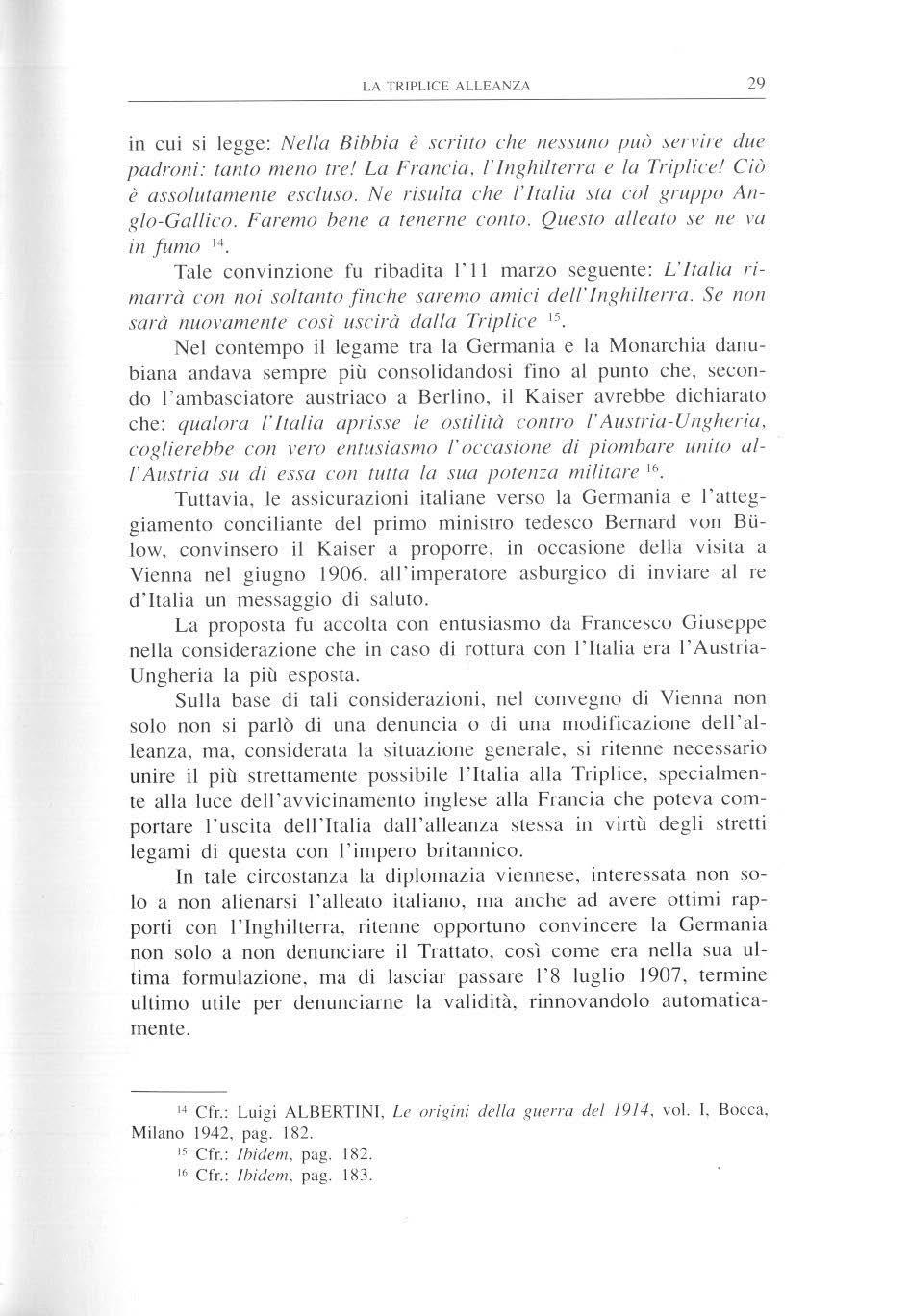
15 Cfr.: Ibidem. pag. 182.
16 Cfr.: Ibidem. pag . 183.
Nonostante il rinnovo della Triplice la situazione europea era ben lungi dall'essere rasserenata: l ' Italia non voleva assolutamente rotture con l' Tnghi Iterra; la Germania appoggiava I' Austria - Ungheria nella sua politica balcanica e la Monarchia danubiana, mentre conduceva una politica di repressione dei moti irredentistici e negava la possibilità di un'università italiana a Trieste come richiedeva il ministro Tommaso Tittoni , portava avanti l ' aspirazione di annettersi la Bosnia-Erzegovina.
Tale progetto si basava sul l'impossibilità di intervento della Russia , il cui esercito era in piena riorganizzazione dopo le sconfitte subite ad opera de l Giappone, dato il minimo s viluppo delle coste bosniache e la presenza di un so lo porto in zona a cui potersi appoggiare con la flotta.
inoltre il capo di stato maggiore dell ' esercito asburgico , generale Franz Conrad von Hotzendorf, rappresentava più volte , nel corso del 1908, al ministro degli esteri Alois Lexa von Aehrenthal la necessità cli stringere accordi sempre più stretti, in campo militare, con la Germania per essere in grado di fronteggiare efficacemente un eventuale intervento armato della Russia.
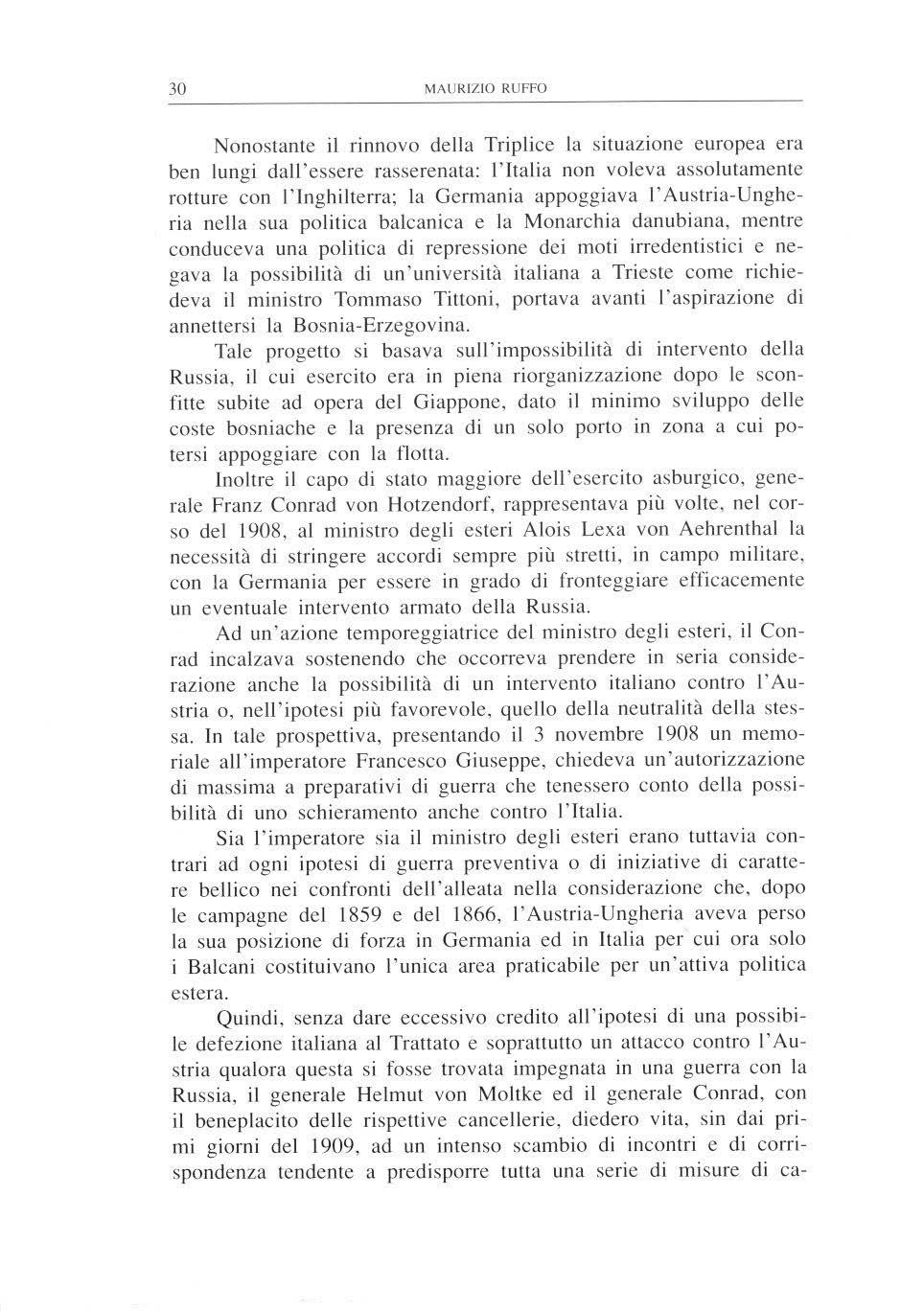
Ad un ' azione temporeggiatrice del ministro degli es teri , il Conrad incalzava sostenendo che occorreva prendere in seria considerazione anche la possibilità di un intervento italiano contro l' Austria o, nell'ipotesi più favorevole, quello della neutralità della stessa. In tale prospettiva, presentando il 3 novembre 1908 un memoriale ali ' imperatore Francesco Giuseppe, chiedeva un'autorizzazione di mas s ima a preparativi di guerra che tenessero conto della possibilità di uno schieramento anche contro J'Ttal ia .
Sia l'imperatore sia il ministro degli esteri erano tuttavia contrari ad ogni ipotesi di gue1Ta preventiva o di iniziative di carattere bellico nei confronti cieli 'a lleata nella considerazione che, dopo le campagne del 1859 e de l 1866, l'Austria- Ungheria aveva perso la sua posizione cli forza in Germania ed in Italia per cui ora solo i Balcani costituivano l 'unica area praticabile per un 'attiva politica estera.
Quindi, senza dare eccessivo credito all'ipotesi di una possibile defezione italiana al Trattato e soprattutto un attacco contro I' Austria qualora questa si fosse trovata impegnata in una guerra con la Russia, il genera le He lmul von Moltke ed il generale Conrad, con il beneplacito del le rispettive cancellerie, diedero vita, sin dai primi giorni de l 1909, ad un intenso scambio di incontri e di corrispondenza tendente a predisporre tulla una serie di misure di ca-
rattere operativo per fronteggiare al meglio I 'eventualiti1 di una guerra europea che si andava s empre piì:1 delineando all'oriz z onte.
In tal e contesto la dichiarazione tedesca che co nsid erava casus foederis l'eventuale mobilitazione ru ssa in appoggio alla Serbia, qualora l'Austria, s tanc a delle continue provoca z ioni se rbe , avesse deciso di invade rla, rappresenta il mutam en to politico delle basi s tesse della Triplice Alleanza, ideata dal Bi smarck in c hia ve esclusivamente difensiva e divenuta, inve ce, offensiva.
L 'Ita lia , pur provata dal disastroso te rre moto cli Messina del 28 dicemb r e 1908, s i era imp egnata, tre anni dopo, nell'impresa libic a con il pretesto dichiarato di prevenire l 'es pans ion e france s e nel NordAfrica , in r ealtà con il timore che la Germania, dopo il falli mento diplomatico avuto in Maroc co, avesse in animo di dare vita ad un 'es pans ion e in Tripolitania.
La sua condotta , tuttavia , offriva ali ' Austria la poss ibilità di so ll evare eccez ioni in qu an to , come sc riv eva Aehre nthal ali 'ambasciatore austriaco a Be rlino: sarebbe stato fac il e pro va re c he aa contraria allo spirito ed alla leuera dell'Alleanza la g uerra intrapresa dal!' Italia in Tripolitania sen:a preav visarci , gue rra da conside rars i come una scossa al/" imp ero ottomano ed allo statu quo 17 •
Il ministro degli es te ri as burg ico era inv ece così li eto che l ' Italia s i fosse imp egna ta in Africa, distogliendo la propria attenzione dall'Adriatico ed accrescendo l 'a ttrito con la Francia, da oppors i con decision e alle proposte del ge n. Conrad c he voleva che s i approfittass e d e lla favorevolissima si tua zio ne per una resa dei conti con l'alleata infedele.
Il Conrad, soste nuto dall'arcidu ca ereditario Francesco F e rdinando e dall 'ambiente militare ne lla s ua visione anti itali ana 18 , sosteneva che l ' Italia con l'impresa cli Libia non so lo non s i ind eboliva , ma andava rafforzandosi economicamente e militarme nte ed aspirava ad impadronirsi dei te rritori italiani della monarchia, a dominare l'Adriatico e ad impedire che l'Au s tria si espandesse nei Balcani per potervi , in un secondo momento , s o s tituirvi la propria influenza.
Tale visione non e ra condivisa dal ministro degli esteri a ustriaco che il 22 ottobre 1911 , con un memoria le ali 'imperatore Franc esco Giu sep pe , ribadiva come n e l 1902 1'Aus tria si era impegnata a lasciare mano libera ali 'Italia in Tripolitania e come il Trattato non potesse essere den unciato prima d e l lu g lio 1913.
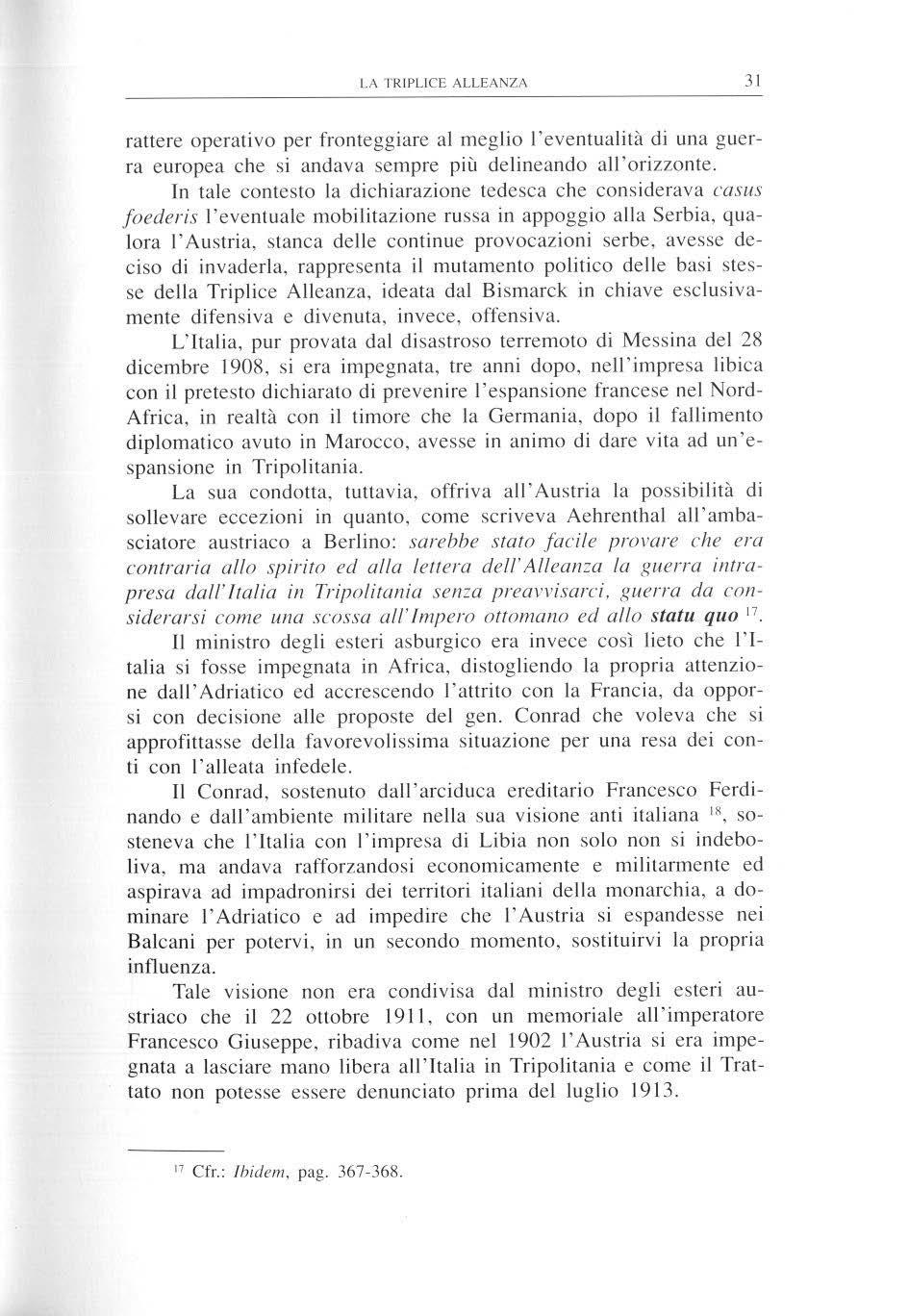
L'imperatore, che condividendo le tesi ciel suo ministro degli esteri, era anche fautore cli una politica di pace , ad un ulteriore memoriale del Conrad del 15 novembre oppose un netto e deciso rifiuto ad una guerra preventiva contro l'Italia.
Il Conrad , il 30 novembre , presentava all'imperatore un nuovo memoriale anti italiano, nel quale sosteneva tra l'altro che il mini s tro deg li esteri non rappresentava con sufficiente energia gli interessi dello stato; era la classica g occia che fa traboccare i I vaso e i l 3 dicembre Francesco Giuseppe, sentendosi indirettamente offeso, rimuoveva provvisoriamente 19 il Conrad dall'incarico di capo di stato maggiore generale cieli 'esercito imperiale e re g io 20
La notizia dell e destitu z ione del Conrad, nonostante l'appoggio cieli' Arciduca ereditario, provocò in I talia un moto generalizzato cli pareri favorevoli che favorirono il ri s tabilirsi delle re la z ioni diplomatiche fra i due paesi ed aprirono la strada verso I' u Iteri ore rinnovo della Triplice.
Il rinnovo, quinto ed ultimo, avvenne il 5 dicembre 1912, un anno e mezzo circa dalla sua scadenza natural e fissata per I ' 8 lug l io 1914.
Aci esso aspirava princ ipalmente i I presidente del consig lio Giovanni Giolitti che gi~t dal luglio aveva iniziato le trattative per il r innovo anticipato, anche se nelle sue memorie s i legge che: già durante la iuerra lihi ca la Germania e /'Austria a1'evano avanzato la proposta del rinnovo anticipa/O; e quella proposta ci era per\'enuta appunto su hit o dopo gli in c identi sorti fra noi e la Francia
' ~ L'avversione d el Conrad ve rso l ' Italia è testimo niata dalla let1 era n. I Ris. Pers. i n data 25 gennaio 1908 de l l'adde!lo mi l itare a Vienna. Cap. di stato magg iore Sigray di S. Marza no conte Vi tt orio. al ca po di stato maggio re Gc n Saletta ne ll a quale si evidenz i a una g rossa sfi ducia nei fi ni po l itici dell ' I ta l ia, nella sua fedeltà alla T ripl i t:e e nella sa ld ezza dell'ese rt: i to italiano. A USSME, F4, 6 1, b usta I.
19 Ant: he se alc uni autori co me il Pc ter Fiala sostengono che il Conrad fosse staio r i mosso provvi soriamente, in realtà i l genera le rima se esclu so dalla ca rica di capo d i s1a10 maggiore per un anno, da l 3 d ice mbre 1911 al 12 d icembre 1912.
20 Da l 1867 l'Austr ia- Ungheria era articolata in una parte austri aca ed una ungherese co n alcuni minis tri comuni a tutte e due le parti; per q uesto motivo I 'ese rc ito era diviso in:
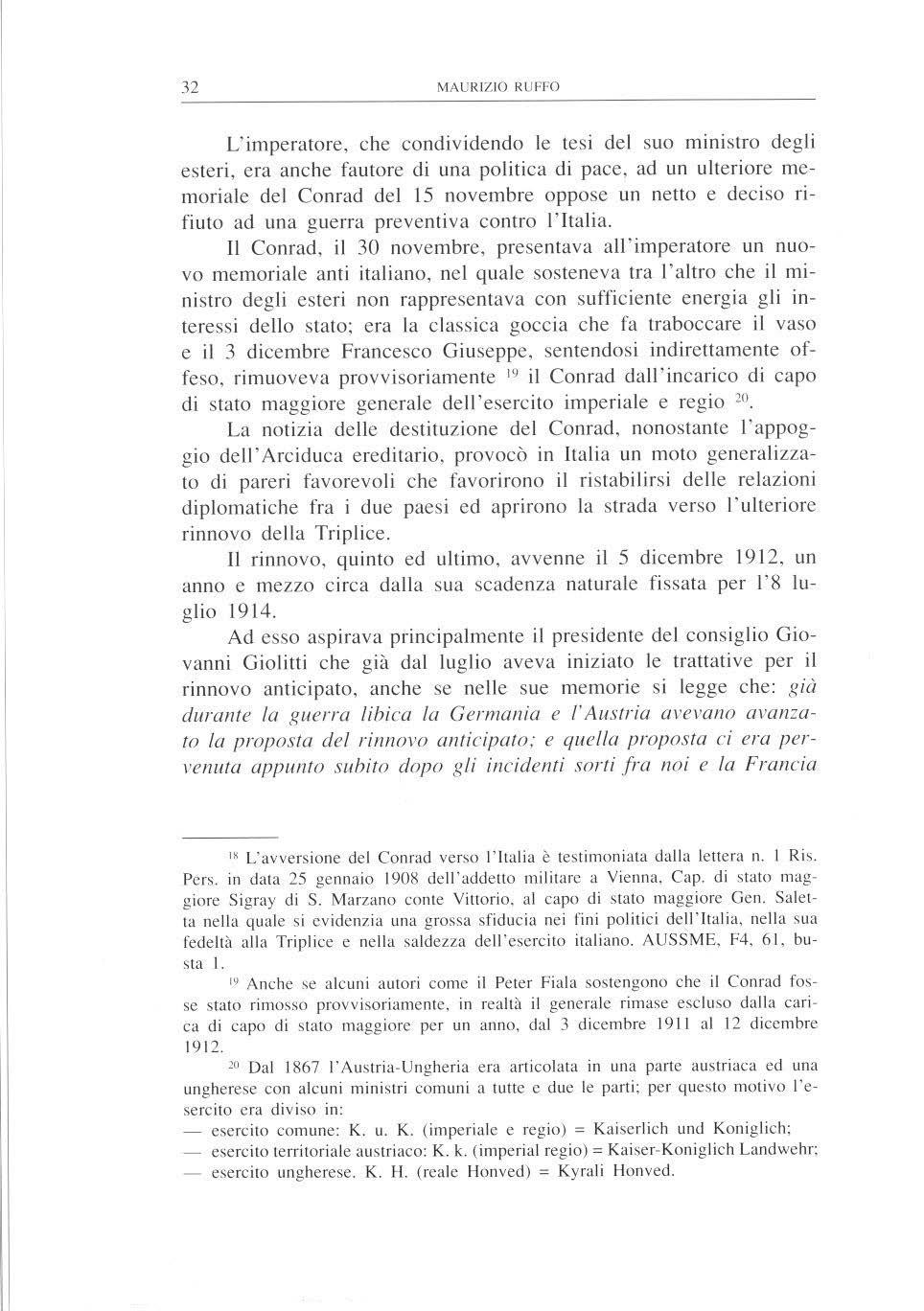
- esc rt:ito comune: K. u. K. (im peria le e regio) = Kai serl it:h und Konigli ch:
- ese reiw territor iale au stria co : K. k. (imperi al regio)= Ka ise r- Konig l ich Landw eh r:
- esercito ungherese. K. H. ( reale H onved) = Kyra l i Honved.
p er il fermo e la 11 1s11a del Manouba e del Carthage 2 1 , s uscita ndo vivi consensi sia ne ll a G e rmania c he ne Il' Austria.
I negoz iati furono condotti a Vi e nna , co n la scopo di prolunga re l'alleanza di 12 anni senza modificarne il testo; tutt avia, avendo la guerra libi ca alterato la s itua z ione nel Nord-Africa, s i rit e nne opportuno adattare il trattato a ll a nu ova s itua zione e tale adattament o sa re bbe s tato oggetto di un protocollo, da a nn ettersi a l testo d el 1902, che g li alleati avrebbero prese ntat o a Roma.
Le trattativ e, ini ziates i so ll o i mi g liori a uspici furono più volte s ul punto di arenarsi , sia per la politica a vol te al tal enan te da par te italiana s ia per l ' irri g idim e nto de ll ' Austria ed in parti colare del s uo nu ovo ministro d eg li ester i, il conte Leo pold Berc ht o ld , succeduto all 'Ae hre nth a l deceduto nel febbraio 191 2, che vedeva in un ritardo del rinnovo il timore di nuove richieste italian e a scapito del]' Aus tri a, c he per tratt ato doveva aiutare l'Italia con tro la Franc ia se nza ricevere a lcuna contropart it a, ed il risorgere delle sp int e irredentistichc.
In o ltr e a comp licare ult eriormen te le trattative c'era la crisi balcanica con le richieste serbe di un ' accesso all'Adriatico ai danni dell'Albania, inaccettabili da parte austriaca, ed i rapporti semp re più tes i co n la Ru ss ia c he però ponevano l 'A us tria in un a si tuazione di fficile, s tre tta co m 'era tra la necessità di man tene re la propria lib e rtà d'azione nei Balcani cd il desiderio di avere la frontiera occidentale sic ura.
Di que s ta situazione ne trasse vantaggio, anche se in fe r iore a quanto si sa r eb be potuto ottenere co n un a politica più accorta e soprattutto più decisa, il ministro d eg li este ri march ese A nronio di San Giuli an o che, aiutato dal ministro degli es te ri ted esco, in un incontro a Berlino, riu scì a red ig e re un testo accettabile anche dal Go ve rn o asburgico e che ven ne firmato a Vi e nna il 5 dicembre 19 J 2.
U clima di fidu c ia instauratosi co n la firm a d e l rinnov o del la Triplice venne tutt av ia g uastato da ll a noti zia che il 12 di ce mbr e, sull'onda d e lla c ri s i balcanica e co n g li au s pici de ll 'a rcidu ca e r editario , il genera le Con rad era stato richiamato a li' incarico di capo di stato mag g iore de ll 'ese rcito impe riale e regio .
2 1 Cfr. G IOLITTI, II, pag. 4 75. Il Ma11011ha e il Car1/tuge: erano d ue navi mercam ili ba1tenti bandiera francese che d uran te la nav igaz ione da Mars ig l ia a T uni s i, ve nn ero intercettate d al le unità della floua it aliana. ispez ionate pe rch é sos pettate d i trasportare pe rsona le e material i be lli c i ve rso la Tunisia e dir o tt ate verso il porto di Cag liari per esse re rilasciate u na vo lta s barca to il ca ri co incriminato.
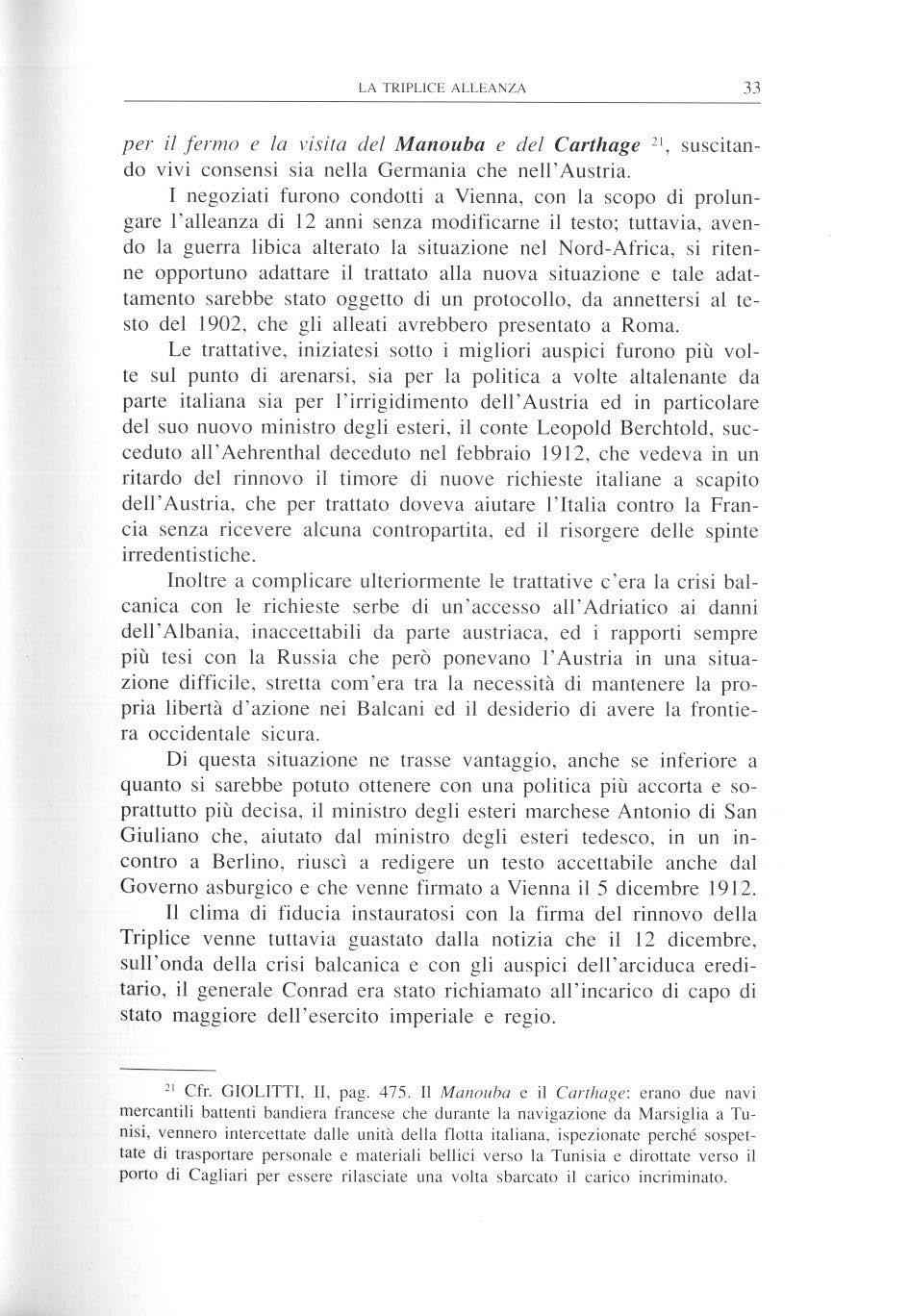
Nel mentre le diplomazie lavoravano i vertici militari delle tre nazioni d e lla Tripli ce, pur privi, almeno quelli italiani come abbiamo già acce nnat o. di direllive precise da parte d ei gove rni . ce rcava no di dare ai singo li s trumenti militari una uni cità di condotta ne lle varie ipotesi operative che si e rano venute d e lineando.
Il tene nt e gene ral e Alberto Po lli o, capo di sta to maggiore dell'esercito italiano, pur sos te ne nd o l 'impossibilità momentanea di inviare la 3" armata s ul R eno a causa s ia dell'impegn o I ibico sia della n ecessità, più vo lt e rappresentata, di avere dell e forze a disposizio ne per difendere le cos te da eventual i a tta cchi francesi. cercava del le soluzio ni di co mprome sso c he ribadi sse ro in modo conc reto l'impegn o italian o nell'alleanza.
In tal e ambito propose, se approvato dal governo. un invio iniz ial e s ul Re no di due di v is io ni di cavall e ri a in attesa di poter inv iare i cinque corpi d'arm a ta promess i nel 1888; an c he se se s i trattava di poche truppe. rappresentava pur sempre una testimonianza di partec ipa lio ne a1tiva. in campo militare, all'a ll eanza, ed il capo di s tato ma gg iore tede sco ne applaudiva l ' inte n z ion e, nel l ' intima convinzione c he e sa preludesse, da parte italiana. a ll 'inv io de l magg ior num ero possibile di unit à s ul fronte del Re no.
Alle g randi manovre dell 'ese rc ito tede sco dell'a gos to -se lt cmb re 191 3, alle quali era s taro invit a to insieme al capo di staro m aggiore aus tri aco. ed acco lto con gra nd e cordial it i1. il gen. P ollio, sollec itato dallo s tato maggiore te de sco perché rinnova sse la convenzione del J888, prome tteva l'invio di tre corpi cl 'armat a eve ntualm e nte au m e nt ab ili e due di visioni di cava ll eria. invece dei cinque corpi e del le due di v isio ni co nt em plate nella co n ve nzi o ne s te ssa.
Il gen. Pollio , poi , ne lla sua intima e lea le convin z ione triplicis ta. s i era inoltre spi nt o a co nfid are all'addeuo militare tedesco a Ro ma. Kl e is t, di esse re di spos to ad inviare delle forze in appoggio alla stessa A u st ria s ul fronte se rb o o s u qu e llo rus so.
Il I O lu g lio. alla vigi lia dell a g ue 1Ta e uropea , il ge neral e Poliio mori va impro vvisa m en te a Torin o, lascia ndo g li imperi cen trali se nza quel ge nera le s ul qua le avevano fondat o le loro maggiori s peran ze in ca o di co nflitto.
Al Pe llio. il 10 dello s tesso mese. successe il tenente generale Lui g i Cadoma 22
22 Gi.mni Ro cca nel volume Cadoma. Oscar Mondadori. a pag. 49 afft:nna che: // mattino del 27 l11filiO 1914 il generale Cadoma pre11de1·a 11JJicial111e11te pos.\l'JSO degli uffici riserrati al capo di stato maggiore.
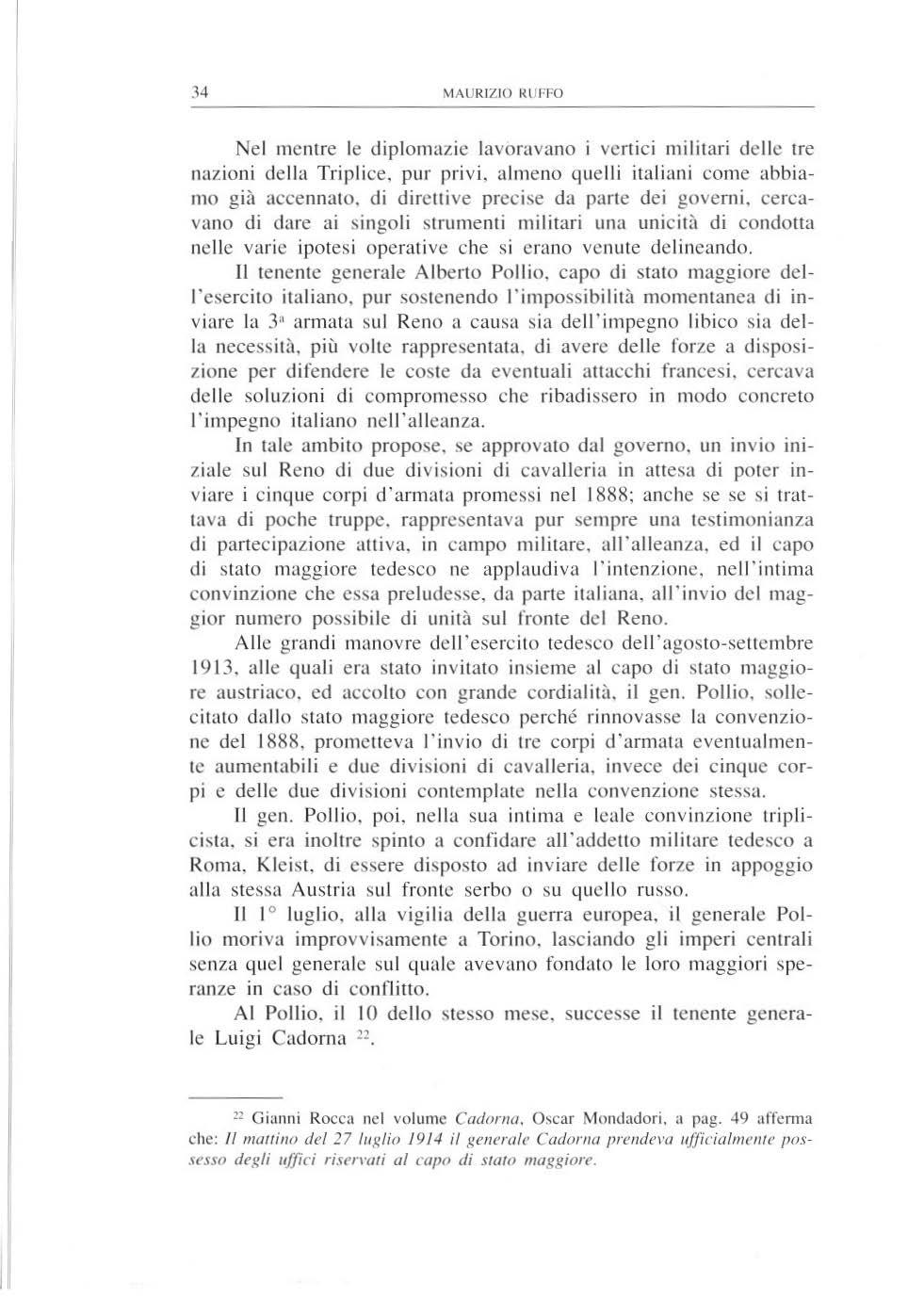
Archiviato , dunque , il rinnovo della Triplice , il governo austriaco rivolse nuovamente la s ua atten z ione verso i Balcani ed in particolare vers o l'Albania dove il principe tedesco Wilhelm von Wied, insediato s ul trono , di e tro s uggerimento dell'imperatore Guglielmo, s ul finire del I 913 e che svolgeva una politica prevalentemente austrofila, venne cacc iato da una rivolta popolare rifugiandosi poi in Italia.
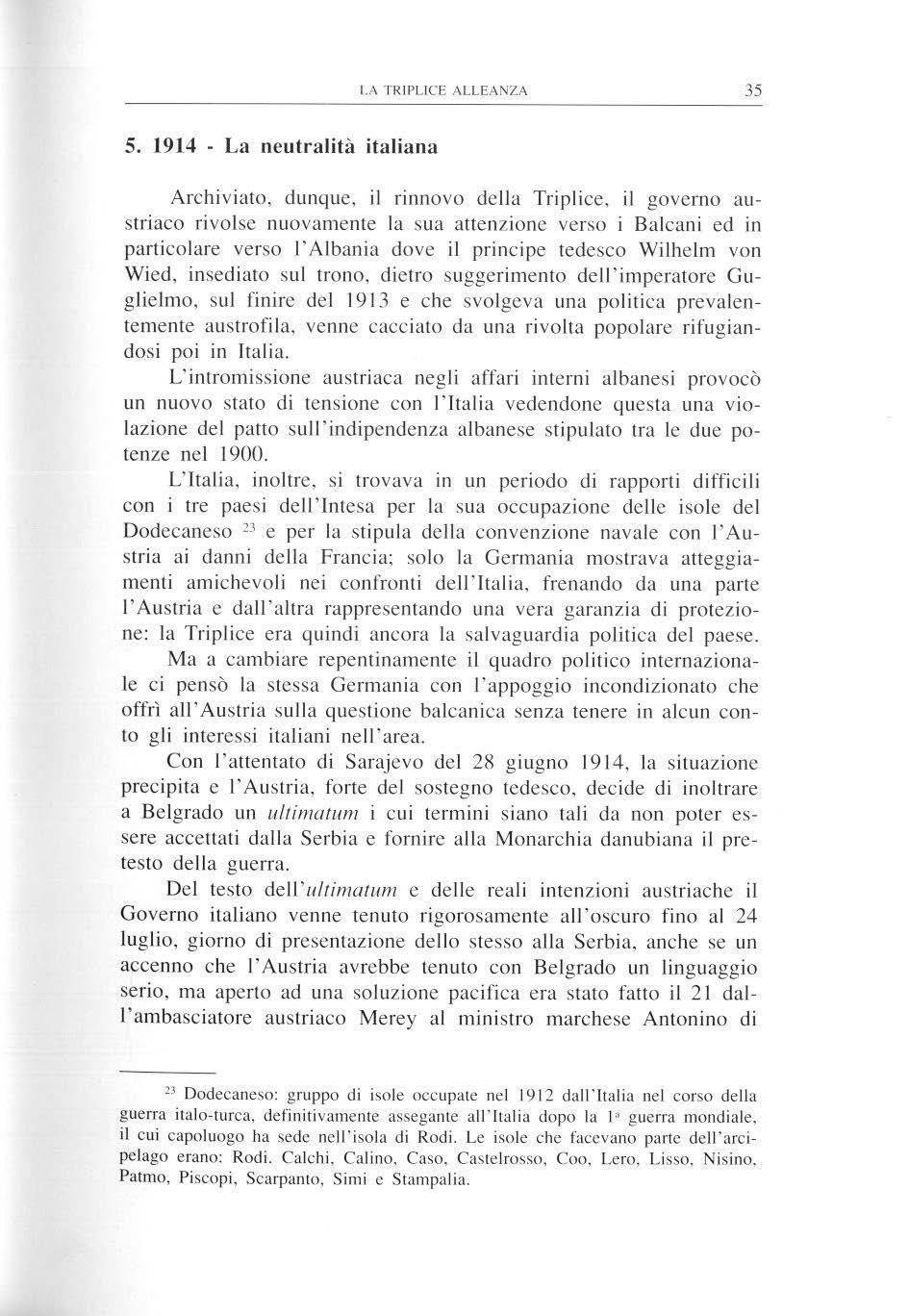
L'intromissione austriaca negli affari interni albane s i provocò un nuovo stato cli tensione con l 'Ita lia vedendone questa una violazione del patto s ull'indipend e nza albane s e s tipulato tra le due potenze nel I 900.
L' Italia, inoltre, si trovava in un periodo cli rapporti difficili con i tre paes i dell'Inte sa p e r la sua occupazione dell e iso le del Doclecaneso 23 e per la s tipula della convenz ione na vale con l ' Aus tria ai danni della Francia; solo la Germania mo s trava attegg iamenti amichevoli nei confro nti del! ' Italia, fre nando eia una parte l' Austria e dal!' a ltra rappre se ntando una vera gara n zia di prote z ione: la Triplice era quindi a ncora la s alvaguardia politica d e l paese.
Ma a cambiare rep e ntinament e il quadro po liti co internazionale ci pensò la s te ssa Germania co n l 'a ppoggio incondizionato c he offrì all'Austria s ulla que s tione balcanica se nza tenere in alcun conto g li interessi ita li ani nell 'a rea
Co n l ' attentato di Sarajevo del 28 g iugno 1914, l a s itua zione prec ipita e l ' Aust ri a, forte del sosteg no tedesco, decide d i inoltrare a B e lgrado un ultimatum i cui te rmini s iano tali da non po te r essere accellati dalla Serbia e fornire alla Monarchia danub iana il pretesto del la guerra.
D e l te s to dell'ulrimarum e d e ll e reali inte nz ioni a ust riach e il Governo italiano venne tenuto rigorosamente a ll 'oscuro fino al 24 lu g lio, giorno di prese nt azione de ll o s te sso alla Serbia, anche se un acce n no c he l 'Austria avrebbe te nut o con Belgrado un lin g ua ggio se rio , ma aperto ad una soluzione pacifica e ra stato fatto il 2 I dall 'a mb asciatore aus tri aco Me rey al mini s tro ma rchese Antonino di
23 Dodeca neso: g ruppo di isole oc c upa te ne l 19 12 dall'Italia ne l corso della gue rra ita lo -turca, defin itivame nte as sega nte ali' Ita lia dopo la t • g uerra mondial e, il c ui ca poluogo ha sede ne ll'isola di Rodi. Le isole che face va no parte d e l l 'a rcipe lago era no: Rodi. Ca lch i, Cali no, Caso, Cas te lrosso, Coo, Lero , L isso, Nisino, Patmo, Pis c op i, Scarpamo, Simi c Stampalia.
San Giuliano. se n za, tuttavia , a ut o ri zzar lo a diffon d er lo agl i o rga ni di s iampa.
L'acca dut o irrit ò il m1n1stro, c he pa rl a nd o co n l ' ambasciatore tede sco . rapprese nt ò la sua g rande meravi g lia per la mancata intesa preve nti va con gli a ll ea t i e di chia rò , nel contempo, che ra vv isa nd os i l 'az io ne asburgica co me un ofio di aggressio 11 e . l' I talia avre bbe declinato og ni respo n sa bilità in caso di interven to d e lla Ru ssia ed av rebbe assu nt o un att egg iamento di neu t rali t à
Il di San Giuli a no , in olt re , dichiarava che l ' Italia s i sa rebbe app e llata alf' arti colo etti mo dell'alleanza circa un eventuale vantaggi o territ o riale.
Le vic e nd e politiche europee, c he seg uirono , furono ab bas t anza co nfu se e co mpl esse e l' It a lia , pe r mante n ere la propr ia neu tralità e libertà d ·az io ne, s i appellò a l la man ca n za del casus Joederis, c he tutt avia implicava un a ne ut ra (it à benevo la ne i confront i d eg li alleati e ne a pp rofittò pe r ~o lle varc il problema dei compensi c he per i I gove rn o italian o, ri g uardavano prin c ipalm e nte i ter ritori itali ani a ncora so tto il dominio asburgico.
La qu e tione d el confine con 1•A ustria ven ne affrontata la prima vo lt a, il 9 dic embre 19 14, all ' inizio d e l conflitto, co n un a lettera del mini s tro degli ester i. barone Gi org io Sidney Son nin o, all'ambasciatore ita li ano a Vienna per invitarlo a rappresentare a l gove rn o austriaco che l'avan za ta dell 'A us tria - Ungh e ria in Serbia ri e ntra va ne i cas i prevbti d all'articolo se ttimo ciel tratt a to della Tr iplice e c he quindi correva, eia p a rr e dell'Austria /"ohhligo del pre,·io accordo con /' flali a e robhligo dei compe nsi, per il turb a m e nt o da essa ca u sato ne ll' e quilibri o balcanico.
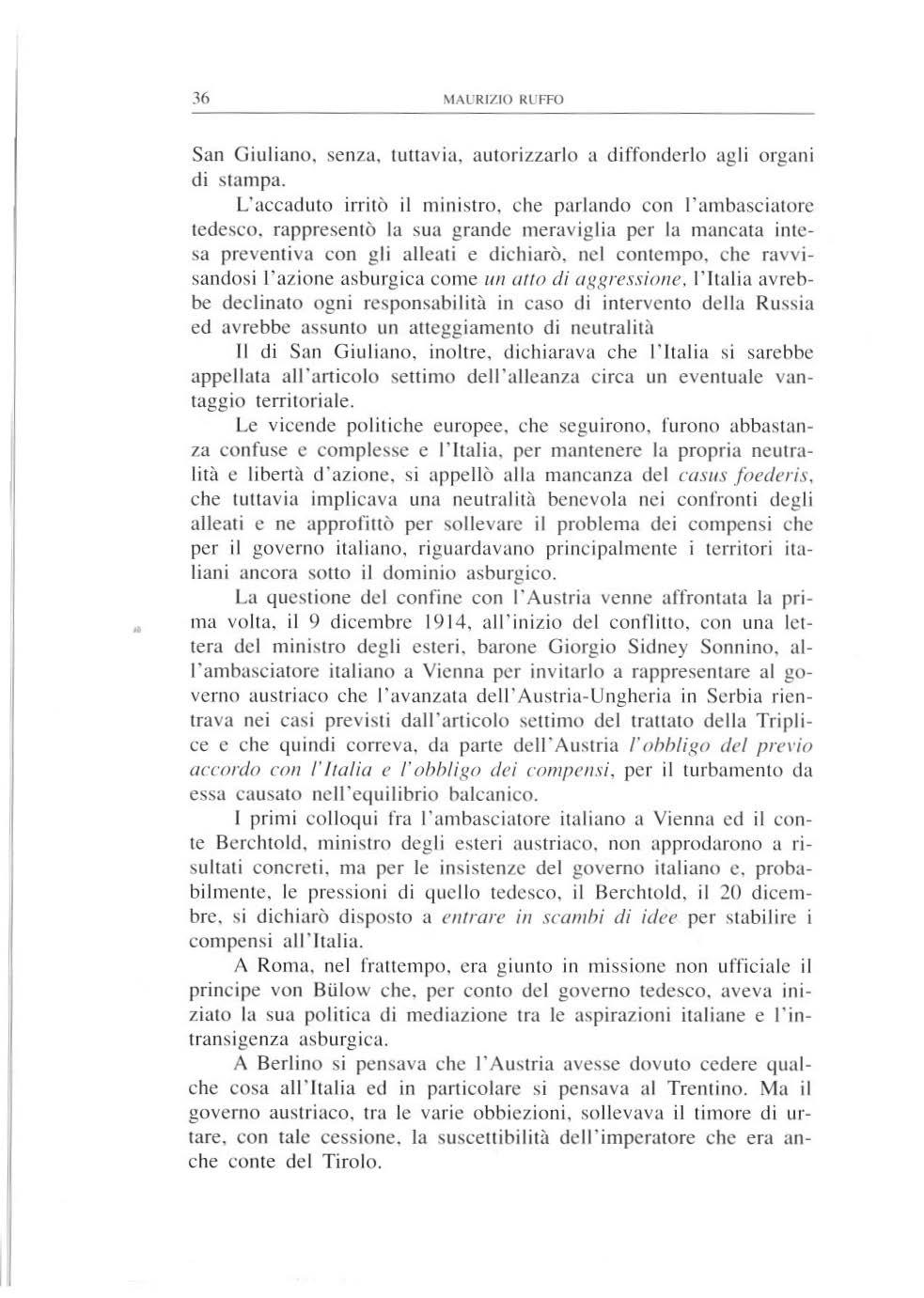
I primi co lloqui fra l'ambascia to re italiano a Vienna cd il co nte Be rc htold, mini s tro de g li es teri a us tri aco, no n appro d arono a riult a t i conc re ti. ma pe r le in sis te n LC del gove rn o italiano c. probabilmen te, le press io ni di qu e llo ted esco, il B e rch to ld , i I 2 0 di ce mbre , s i dichiar ò di s posto a entrare in scambi di idee per s tabilire i c ompe ns i all' Italia.
A Rom a, nel fratt e mp o. era g iunto in mi ss ion e non uffici a le il prin ci pe von Biilow che per conto del gove rno tedesco, aveva iniziato la s u a politi ca di media z ion e tra le asp ira z io ni it a l iane e l'intran s ige nza a s burgi ca.
A B erli n o s i pensava c he l'Au s tria a vesse dovu to cede re qua lc he cosa all'Italia e d in particolare s i pe nsava a l Tre ntin o. Ma il governo austriaco, tra le va ri e obbi ez ioni , so ll evava il tim o re dì urtare, co n tal e cess io ne la s u sce1ti bi lità d c li ' impera to re c he era a nche c onte d e l Tirol o
Per superare l'im passe si pen.sò di limitare la cessione al so lo territorio costituente l 'a ntico principato vescovile di Trento 24, ma il ministro Sonnino, non essendo a perfella conoscenza dei confini di tale principato, preferì non pronunciarsi.
In realtà da una parte si cercavano sempre nuovi pretesti per rimandare la soluzione del problema pur ammettendo, in linea di massima, il dirillo dcli' Italia ad ottenere dei compensi territoriali. ma non sottratti da quelli della duplice monarchia; dall'altra, il governo italiano si dichiarava costretto. a safraguardia della propria dignità, a ritirare ogni proposta o ini zia tiva di discussione.
11 4 marzo l 9 I 5, in una nota ufficiale al governo austriaco, le autorità italiane ribadivano il loro punto di vista, e cioè che esse esigel'a110 compensi per il fatto stesso dell ' inizio di un 'azione militare cieli' Austria-Ungheria nei Balcani, ma che nessuna proposta o discussione di compensi potern condurre ad un accordo se non avesse prospettata la cessione di territori già posseduti dal/' AustriaUngheria.
li governo italiano si sforzava, in tale modo, di attuare le rivendicazioni nazionali senza uscire dai limiti del trallato della Triplice, al quale era ancora legato. ..
Solo il 9 marzo ci fu una prima apertura austriaca con la dichiarazione di di s ponibilità a trattare la cessione di territori del1'impero all'Italia, ma la cessione sarebbe dovuta avvenire solo a guerra conclusa.
A tale proposta, la cui realizzazione sarebbe stata garantita dalla Germania, il governo italiano oppose un netto rifiuto, giustificato anche dal la successiva indicazione austriaca del territorio che sarebbe stato ceduto ali' ltalia.
Anche le successive proposte austriache non furono ritenute all'a ltezza delle aspettative italiane così che il governo fu costretto ad assumere la drastica decisione cli denunciare il trattato della Triplice A ll eanza.
I paesi cieli' Intesa, al contrario, intuirono la reale portata politica della neutralità italiana: essa, infatti , significava permettere alla Francia cli impiegare parte delle forze dell'annata delle Alpi contro le armate germaniche e, grazie al mancato blocco del Mediter-
24 li prin cipato vescovile di Trento. soppresso ed annesso al i' Austria ne l 1803. Nel periodo de l la sua massima estensione co mprendeva anche gran parte dell'od ierna pro vi ncia di Bol zano Il vescovado (Diocesi), invece, esc l udeva quasi per intero la Valsugana, il Primiero cd al tri 1e1Tit0ri de l l'odierno Trentino.
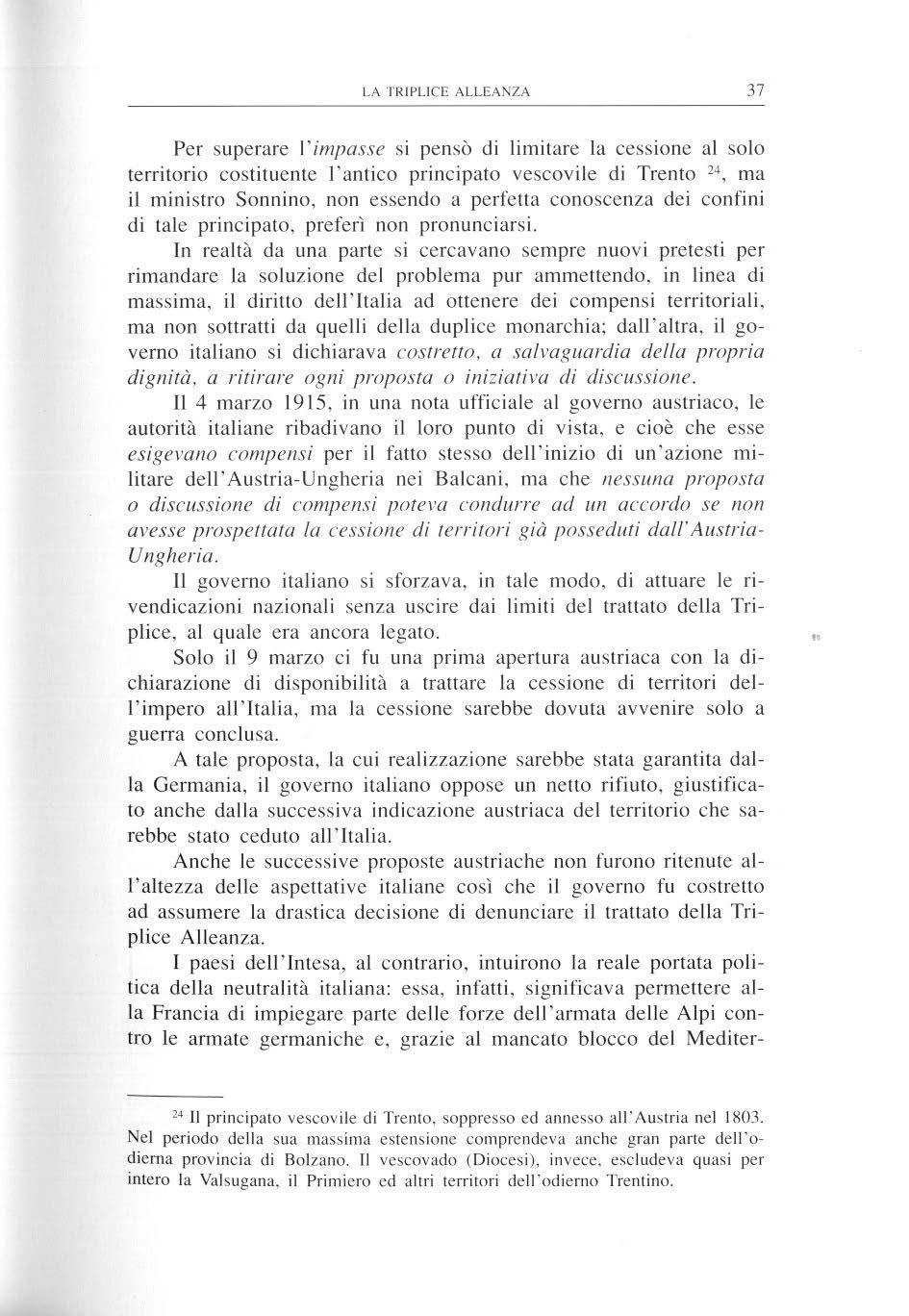
raneo, di riportare in patria gra n parte delle tru ppe co lonia li ; alla Ru ssia di fronteggiare un minor numero di u nità austriache data la necess it à cli ques t ' ultim e cli provvede re a rinforzare le difese lun go il confine con l ' It a li a; a ll ' In g hilt erra, infine , l a piena lib ertà cli azione nel bacino ciel Mediterraneo.
I me s i c he seg uiron o alla dichiarazione di neutra lit à se rvirono da una parte a ll ' Itali a per dare avv io ad una profonda ri s trutturaz ion e e preparazione dello st rum ento militare, tenendo se mpre prese nte la doppia opz ione che le s i presentava: scendere in gue rra al fianco deg li antichi alleat i della Tr iplice o con le potenze dell'Intesa co ntro g li imperi ce ntrali accusat i non so lo di aggressione, ma di aver tradito lo sp irit o del l ' alleanza , dal l 'a ltr a, a quel! i de ll ' Intesa, per ric ercare, inizia lm en te, un dialogo e quindi dare avvio ad u na trattativa c he portasse l'Italia nel loro schieramento.
Fu rono trattati ve difficili sia per la po s iz ione un po ' ambigua assu nta clall ' Italia c he non solo non si era se ntita in animo di sconfessare s ubit o ed apertamente la Triplic e, basti ricordare che il 2 agosto del I 914 il governo italiano s i era impegnato ad osservare una benevola neutra ! ità verso g li imperi centra li e che aveva accolto la dichiarazion e austr iaca de l 25 de ll o s tesso mes e rela ti va a ll 'accog li m e nt o dell'interpretazione italiana del l ' articolo se ttimo, ma s tava a guarda r e, con viva trepidazione, l 'evo lv ersi de ll a s itu azione milit are a l fine di fare la sce lt a cli campo più uniform e con i propri in teressi na zio n ali non escludendo la neutra lità comple ta fino a lla fine d e l co nflitt o , fa tt i sa lvi i compens i territoriali c he le sarebbero toccati con la co nqui sta eia parte austriaca della Serbia.
Tutt avia, co m e abbiamo v is to. le tratta ti ve con g li impe ri centrali era no a ndat e tropp o a ril e nto tanto c he, il 21 aprile, il mi nistro deg li es teri , barone Sidney Sonnino, s i v id e costretto a dichiarare che le co ntropropo s te a us triach e non cost itui va no una ba se s ufficiente pe r c r ea r e il des id era to acco rdo , tanto più che l 'Aus tria - Ung he ria rimaneva ferma ne l proposito cli nega re l'immediata occupazione , da part e it a lian a, dei territori da ceders i. Le trattati ve e ra no, pertanto , da considerarsi definitivam e nt e tron ca te.
li 3 marzo cie l 1915 c inqu e torpediniere a ustr ia c he compio no un piccolo s ba rco ad A nti vari : è il pretesto c he il Sonnino a ttendeva per dichi arare nulli g l i imp eg ni a ss unti il 2 e d il 25 agosto cieli' a nno precedente e d il gio rno s uccessivo, dopo J' e ne rg ica nota
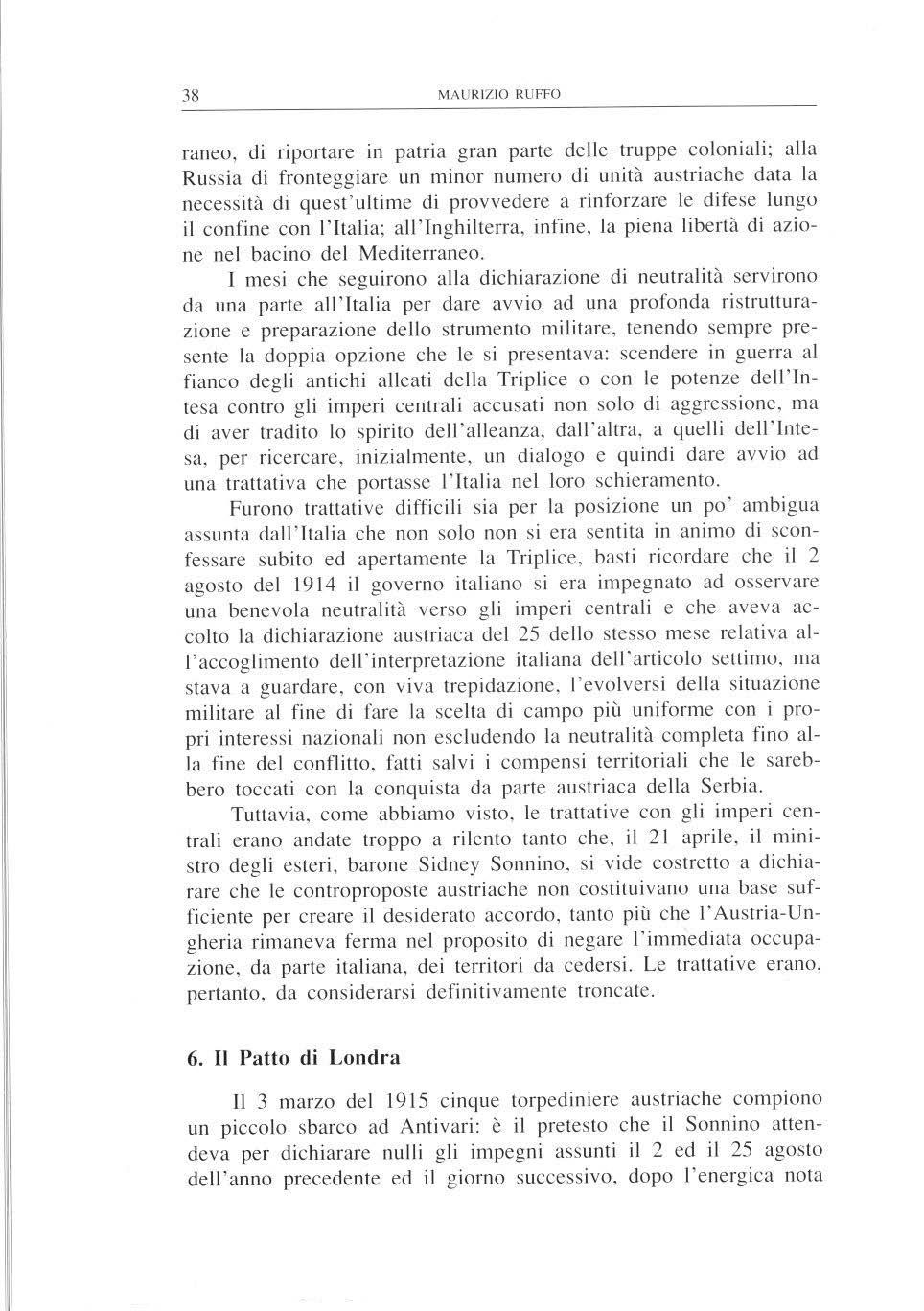
di protesta al governo di Vienna alla quale aggiungeva la preci saz ion e che i compensi non so lo dovevano esse re escl us i va m en te le terre it.aliane so tto il dominio asburgico. m a che tali r.erre dovevano esse re cedute su bito. da va ordine all'ambasciatore a Londra, Imperia li, di ini z iare le trattative per un impegn o militare it.aliano al fianco dell'Inte sa.
li momento, forse, non era dei più fe li ci s t an te la s itua zione s trate g ica: l'Austria aveva s ubito , nel! 'aut unno , un rovescio s ul fronte se rbo parzialmente a ttutito d a lla vittoria, unitam e nt e alle forze tedesche, co ntro i ru ss i in P o loni a; inoltre l 'offe ns iva del febbraio nei Carpazi, id e ata dal Conrad, contro le forze russ e non so lo era fallita , ma questi. con un ·energica con troffens iv a, avevano cos tr e tt o gli austriaci ad una difesa quasi disperata s ui valichi montani per impedirne il dilagare nella so tt os t an te pianura magiara.
Tutt avia, nonostante l'iniziale op posizione russa c he non rit enev a più essenziale il con tributo italiano alla lotta comune, la Francia e l'In g hilt e rra, con maggior intuito politico-s trat egico, pro seg uirono ne ll e trattative nelle quali il Sonnino, in cons id erazione della s itua z ione genera le, non ritenne opportuno ava n za re proposte che non potessero essere co ndivi se; non ri chiese per ese mpi o. la c itt à di Fiume, ritenen dol a lo sbocco naturale al mare di un 'A us tri a - Unge ria che, se ppur gra nd e m e nte ridim e nsio nat a dalla gue rra non sare bbe sco mpar sa .
L e tratt.ativ e proseguirono a lun go pe r la posizione ru ssa che. in nome dell e difesa del pa n s l avis mo , s i opponeva alle richie s te ita1ia n e che riguardavano i I futuro assetto del! ' Adriatico in parti co lare e d el Me dit e rran eo in ge nera le Finalmente il 26 a pril e 1915 , a Londra. veniva firmato l 'accordo che leg ava i destini dell'Italia all' Int es a ne lla guerra co ntro gli imperi centrali.
11 patto 2 5, il cui te s to fu prese ntato al parlamento italiano , ne ll ' originale francese. il 4 m a rz o 1920 ne l Libro Verde fu anticipato, in una versione non esatta, dai bol sc he v ic hi nel 1917 e letto, in una pess ima tradu z ion e italiana ricca di e rrori e di sviste, dall'on. B evione alla Carnera il 13 febbraio I 9 I 8 , era composto di un memorandum articolato in 16 articoli co n note es plicativ e a cui seg uivano le dichiara z ioni de i quattro P aesi firmatari de l! 'acco rdo di non concludere un a pace separata nel corso della guerra.
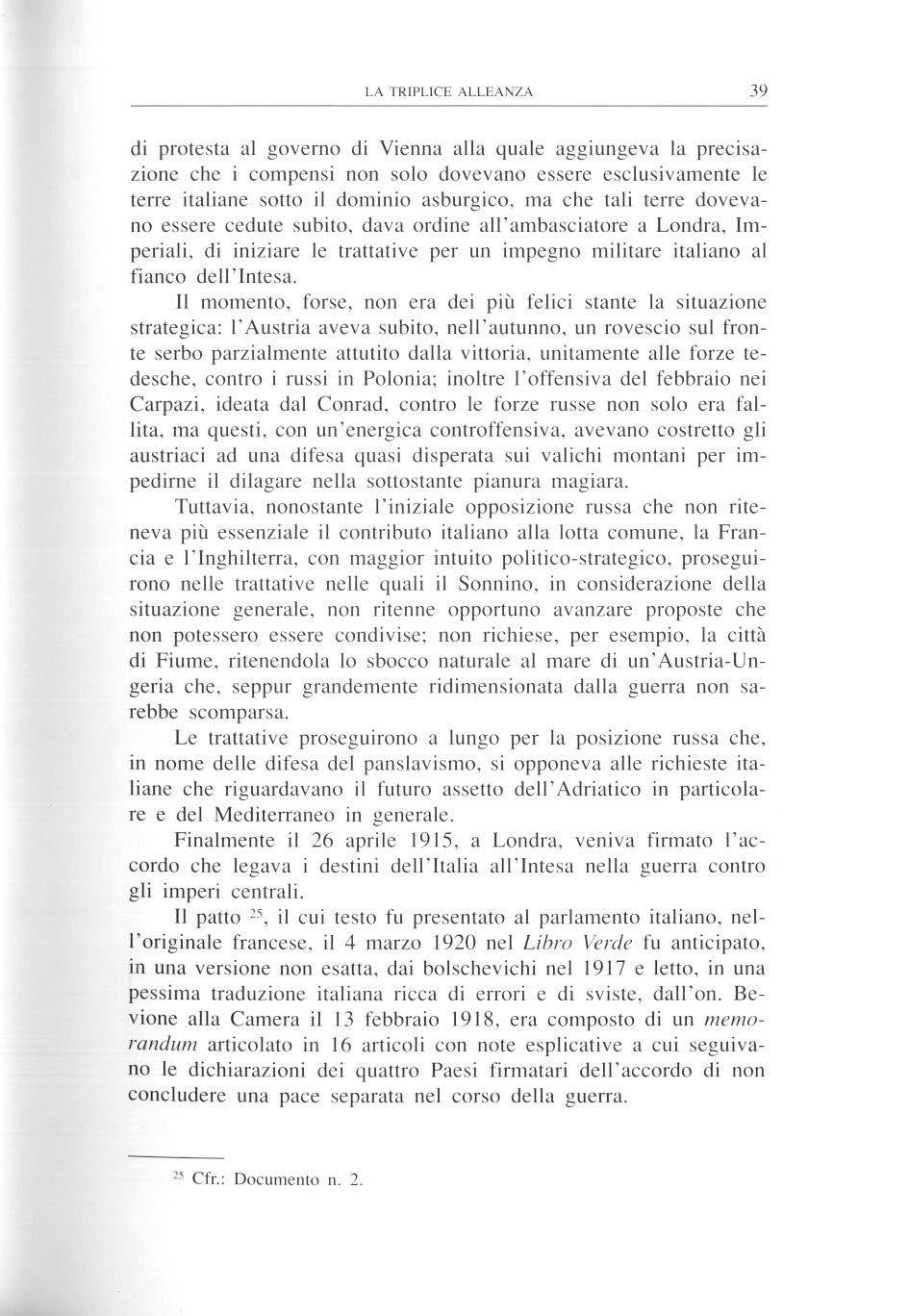
In esso si prendeva in cons id erazione la necessità che da parte ru ssa, qualora questa po tenza decidesse di sv iluppare lo sforzo ma gg ior e con t ro la Germania , fo sse ro mantenute s u ll a fron te asburg ica un numero dì unità ta le da impedire a li ' Aus tria -Ung her ia dì concentrare tutt e le s ue forze co ntro l' It alia; l'impegno dell'Ttalìa di impi ega re tutto il proprio potenziale militar e con tro i com uni nemi c i e l'a tt iva co ll abora z io ne dell e notte fran cese ed inglese con qu e ll a italiana pe r la comple ta distruzione di quella aus tri aca e, quant o meno, fino alla fine della guerra.
L'accordo , inoltre , contemplava i co mpen s i italiani, da inse rire ne l trattato di pace, definiti in mani e ra precisa ne lle not e che ne rip orrava n o i punti topo grafici sa li enti e tutte le altre questioni che ri g uard ava no il futuro asseuo europeo, m editerraneo ed african o.
L' It alia, infine , s i impeg nava ad en trare in g uerra con tutto il suo potenziale a l fian co della Fran cia, dell'In gh ilterra e della Ru ssia quanto prima e co munqu e e nt ro e non oltre un m ese dalla firma del patto.
7 . L'org aniz zaz io n e d e ll 'ese rcit o e l o s tudi o d e ll e o p e raz i o ni s ull a fronti e ra N.E .
Come abbiamo accennato g li accordi della Triplice e ra no di tipo politico e fino al 1888 non si era parlato di intese a livello militare pe r fare fr o nte comune ed in maniera coord inata ed efficace ai comuni nemi c i.
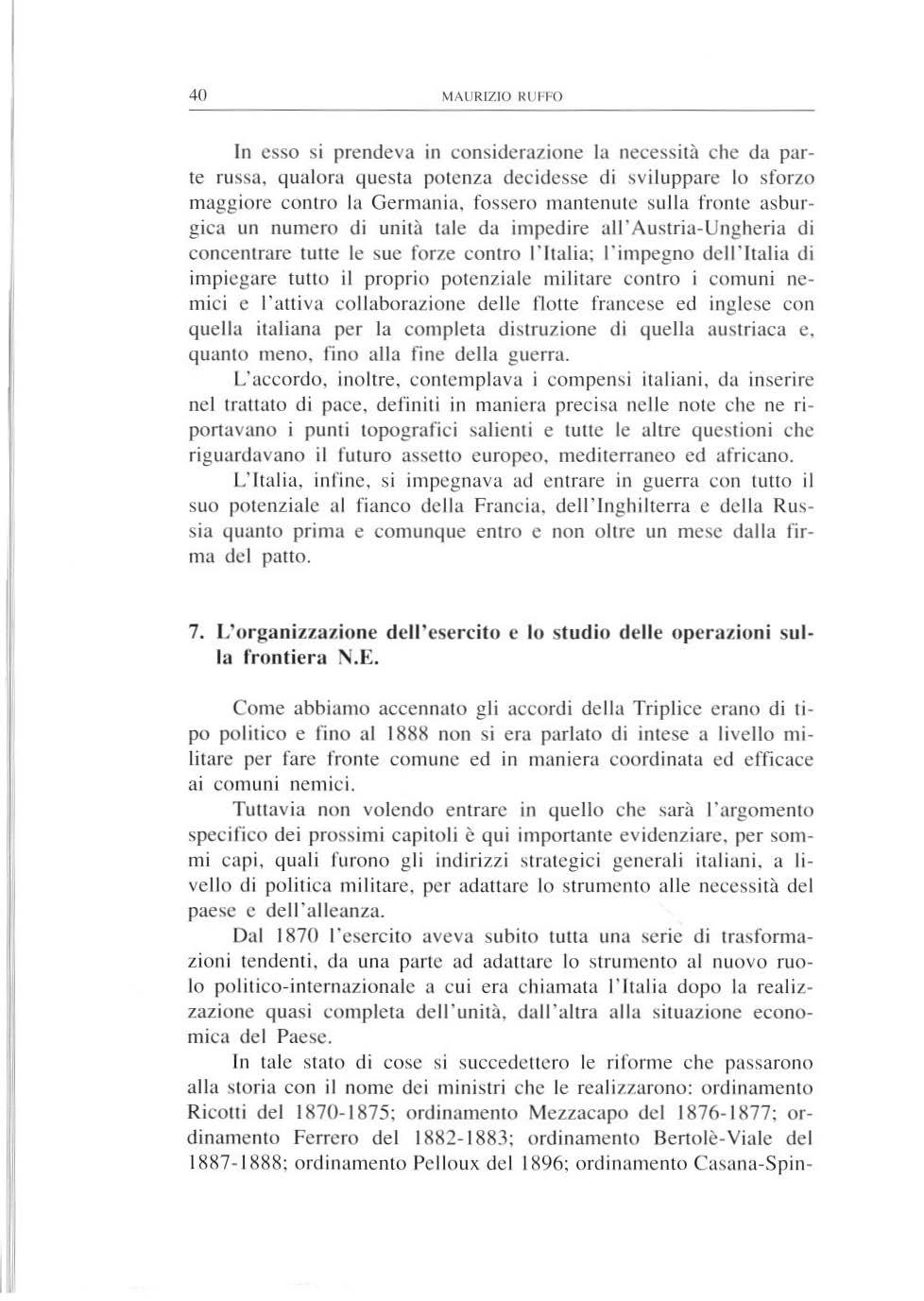
Tuttavia non volendo en trare in quello che sarà l 'argome nt o specifico dei pross imi ca pit o li è qui importante ev id e nzi are, per so mmi capi, q uali furono g l i indirizzi s trategici ge nerali italiani, a live ll o di polit ica militare , pe r adattar e lo s trumento a ll e necessi tà d e l paese e dell'alleanza.
Dal 1870 l' ese rcito aveva s ubit o tutta una se rie di trasformaz i oni te nden t i, eia u na par te ad adattare lo strumento a l nuovo ruolo politico- inte rnazionale a c ui era c hiamata l ' It alia dopo la reali zzazione quasi com pleta dell'unità. dall'altra al la s itu a.l io ne eco n omi ca del Paese.
In ta le stato d i cose s i s ucced e ttero le riforme che pa ss arono alla s tor ia con il nome de i ministri c he le rea l izzarono: ordinamento R ico tti del I 870-1875; o rdin amento Mezzacapo del l 876- 1877 : ordinam e nto Ferrc ro del 18 82 -1883 ; o rdinam en to Berrol è-V ialc del 1887 - 1888; ord inamen to P c ll o ux de l 1896; ordinamen to Ca sa na-Spin -
gardi del 1908 - 1913; per giungere, infine all'esercito mobilitato dal gen. Caclorna.
Dei vari ordinamenti è i nteressante quello attuato dal ministro Ferrero che, dopo il congresso cli Berlino , nel quale si era evidenziata la debolezza ita l iana in campo internazionale, e l'adesione alla Triplice, rendendosi conto dell ' insufficienza del numero delle unità de l l'esercito, aumentò il numero dei corpi d'armata portandoli a 12 ed elevando il numero delle divisioni da 20 a 24; inoltre creò il comando militare della Sardegna e diede un notevole impulso alle truppe da montagna 26 •
Con l'ordinamento Bertolè-Viale la forza dell'esercito venne ulteriorment e accresciuta per effetto dell'inizio della spedizione colonia le in Africa; tale ordinamento durò sostanzialmente inalterato fino al 1896 anche perché i tre mini s tri succed utisi dovettero affrontare grossi problemi di carattere economico non essendo ancora il paese in grado di fare fronte ai gravosi impegni che derivavano dalle imprese coloniali e con i problemi derivanti dalle lotte sociali che s tavano turbando la vita politica italiana dell'epoca.
11 4 ottobre 1908, a dare un impulso ad una presa di coscienza naziona le sui problemi della dife s a, fu l'improvvisa notizia dell'annessione della Bos nia-Erzegovina, che l'Au s tria - Ungheria già occupava da l 1878, tra i tanti territori ereditati dag l i Asburgo.
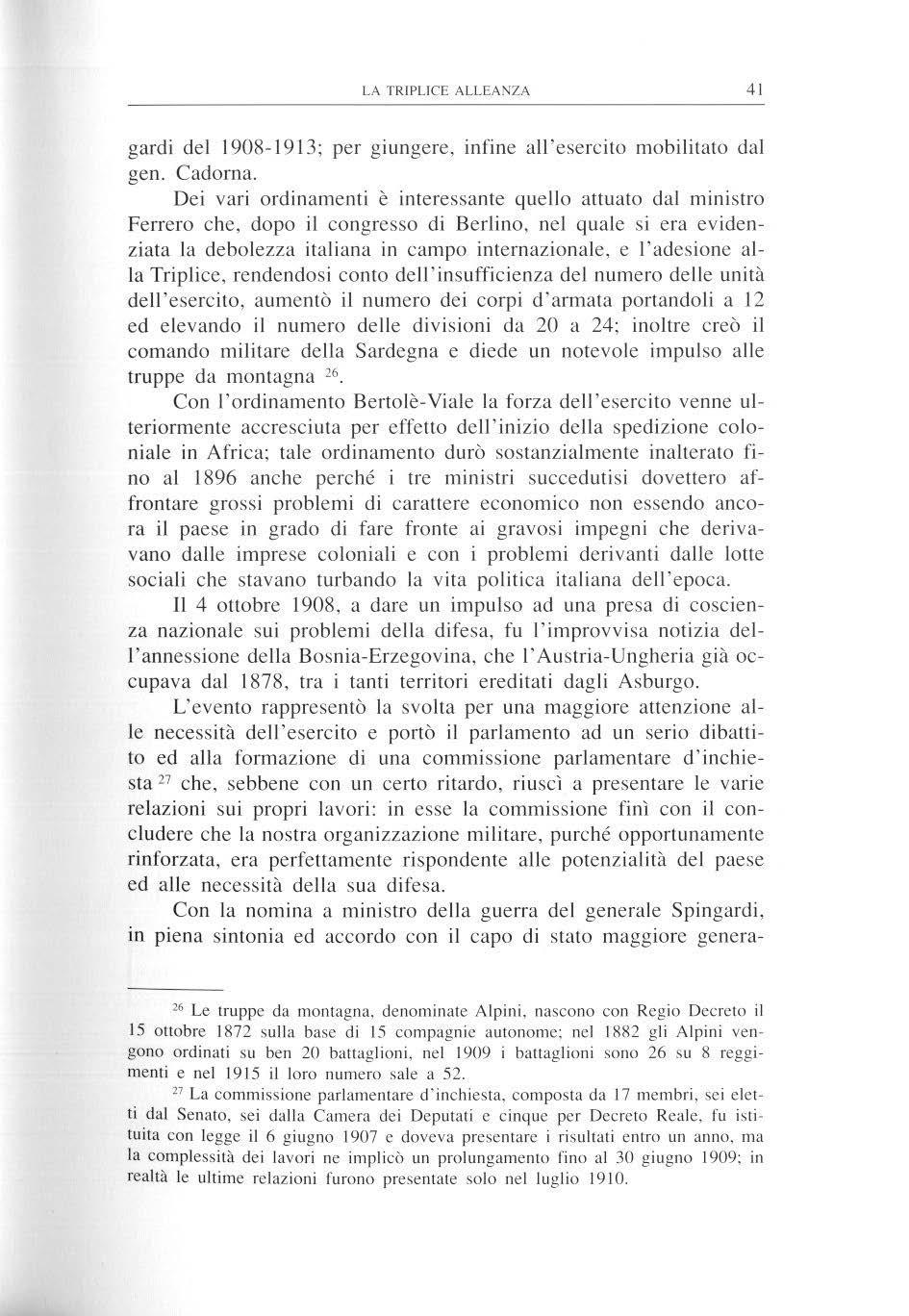
L 'eve nto rappresentò la svo lta per una maggiore attenzione alle necessità del l 'esercito e portò il par lamento ad un serio dibattito ed alla formazione di una commissione parlamentare d ' inchiesta 27 c he, sebbene con un certo rita r do, ri uscì a presentare le varie re laz ioni sui propri lavori: in esse la commissione finì con il concl udere che la nostra orga n izzazione militare, purché opportunamente rinforzata, era perfettamente rispondente alle potenziai ità del paese ed a ll e necessità de ll a sua difesa.
Con la nomina a ministro de l la guerra del generale Spingardi, in p iena sintonia ed accordo con i l capo di stato maggiore genera -
26 Le truppe da montagna, d enominate Alpini. nascono co n Re gio Decreto i l
15 01tobre I 872 su lla base di 15 compagnie auto nome: nel I 882 gli A l pini ve ngono ordinati su ben 20 batta glioni , ne l 1909 i ba1taglioni sono 26 su 8 reggimenti e ne l I 9 I 5 il loro numero sa le a 52.
27 La commissione parlamentare d'inchiesta, composta da 17 membri , sci eletti dal Senato, sei da ll a Camera dei Deputati e cinque per Dec reto Rea le, fu istituita con legge il 6 giugno l 907 e doveva pre sen tare i r isultai i en tro un anno. ma la comp lessità dei lavor i ne impl icò un prolungamento fino al 30 giugno 1909: in realtà le ul t ime rela z ioni furono presen tate solo nel l ug l io I 9 IO.
le Pollio, si concretizzò un nuovo programma di riforme dell'organizzazione militare del paese nei suoi molteplici aspetti. tecnico (ordinamento della difesa mobile, quadro di battaglia dell'esercito, organico dei quadri, forza in tempo cli pace, ordinamento della difesa permanente), morale (limiti e norme per l'avanzamento, aspetti disciplinari), sociale (reclutamento) e finanziario (bilancio).
Questo programma però, come d'altra parte era già avvenuto precedentemente, fu condizionato dall'improvviso scoppio della guerra italo-turca che ne causò dei naturali sconvolgimenti, primo fra tutti quello che non potè essere portato a compimento nei tempi previsti.
È inoltre interessante notare che il problema dell'organizzazione difensiva del paese con la costruzione di opere fortificate lungo i confini, a cui si era posta particolare attenzione sin dal 1899, era demandata alle proposte inoltrate al capo di stato maggiore dai singoli corpi d'armata territoriali. i cui lavori non sempre erano proceduti con unicità di indirizzo.
Nel 1903 il ministro della guerra. tenente generale Giuseppe Ottolenghi, in considerazione della particolare attività esercitata dal1' Austria - Ungheria lungo il confine con l'Italia (frequenza di ispezioni da parte di alti ufficiali; costituzione di speciali depositi di armi, munizioni ed equipaggiamenti vari; lavori di potenziamento della fortificazione permanente, lavori di miglioria nelle comunicazioni stradali e ferroviarie con Trieste ed ammodernamento della rotabile delle Dolomiti), aveva sollecitato 1·attenzione del governo sul problema della sicurezza del confine orientale, illustrando le ri levanti deficenze della nostra organizzazione difensiva lungo tale frontiera, alle quali era necessario provvedere quasi ex nm·o ed in tempi estremamente rapidi.
Ma il problema finanziario generale era tale che non c'erano fondi per la sistemazione delle frontiere fino al 1908 quando, nel dicembre, venivano poste le basi di un programma di lavori difensivi da realizzarsi con la massima sollecitudine possibile e comunque entro la fine del l 913.
Ne l giugno del 1913, scaduto il quadriennio previsto per I'attuazione, seppur incompleta, del progetto Spingardi-Pollio, si presentava la necessità di procedere ad un nuovo programma che consentisse la completa attuazione del precedente.
Tale necessità diveniva sempre più urgente in quanto tutti gli stati europei, preoccupati dalla questione balcanica che, come abbiamo già visto, nel 19 12 si era riaffacciata all'orizzonte, stavano
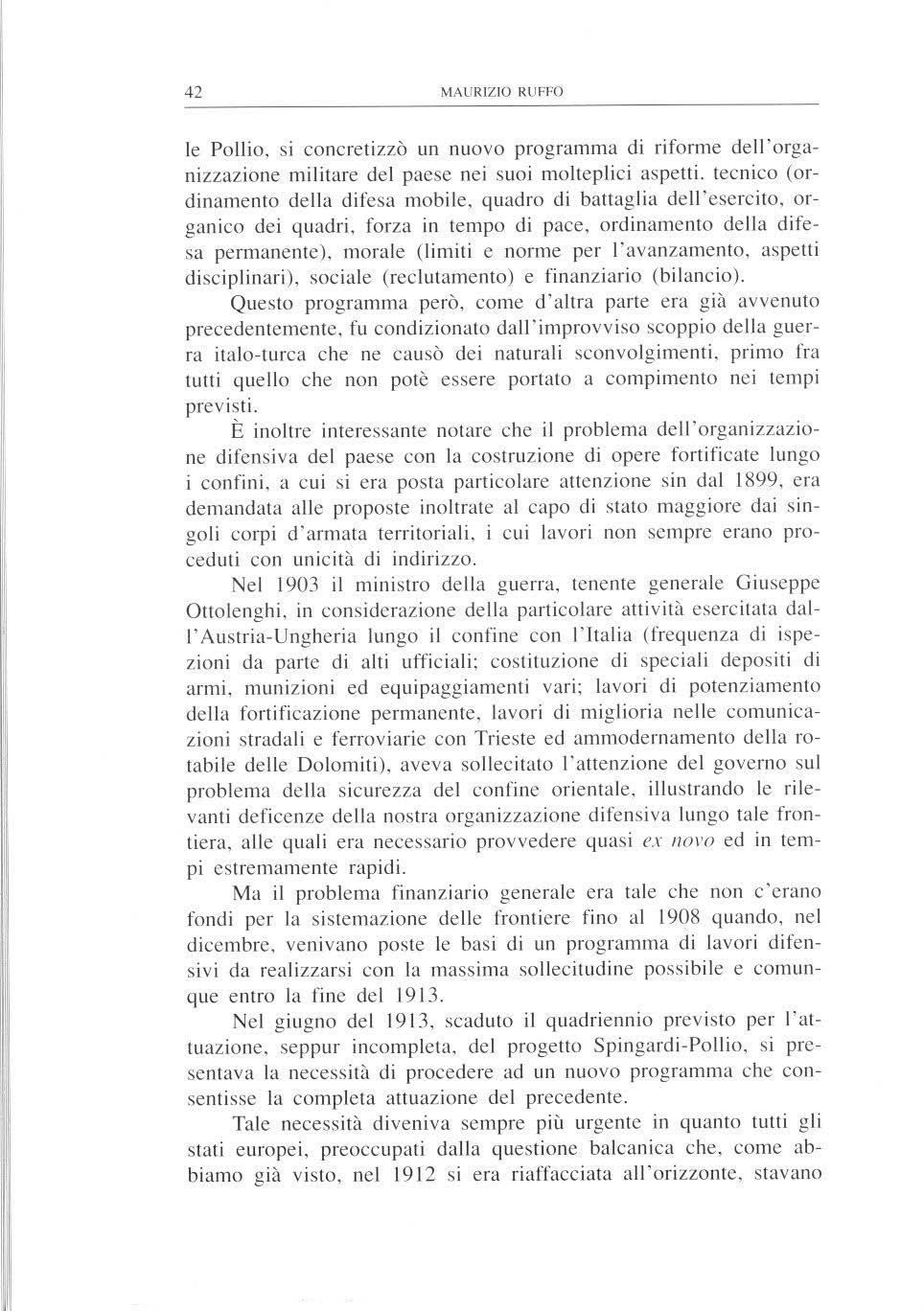
procedendo al riarmo al limite delle possibilità consentite dalle risorse nazionali, demografiche, economiche e finanziarie.
Per fare fronte alla nuova situazione il ministro Spingarcli aveva presentato, sin dal l'apri le del 1913, al capo del governo un nuovo programma inteso non tanto ad aumentare l'entità dell'esercito quanto a comp letarlo ed a consol idarlo.
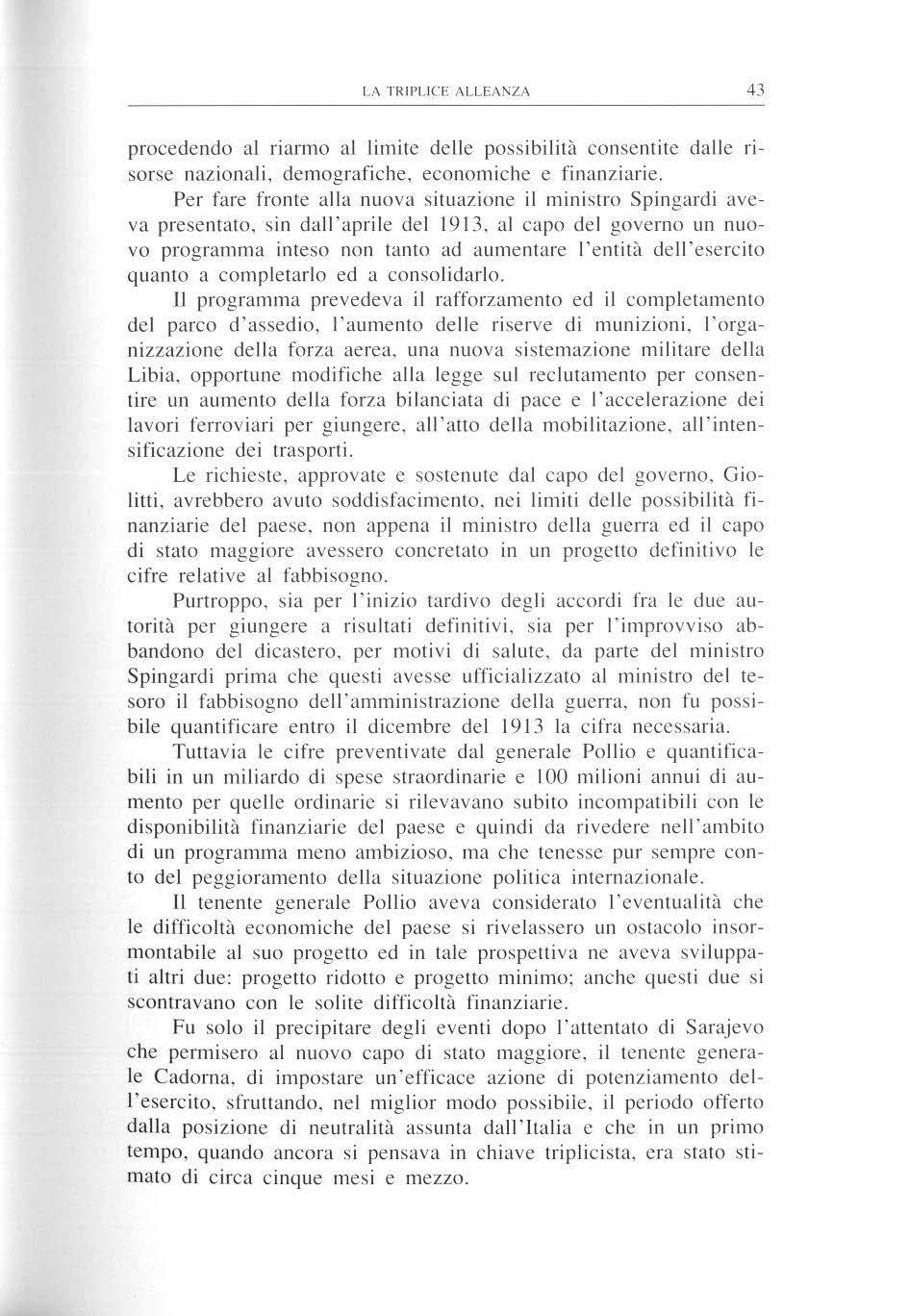
Il programma prevedeva il rafforzamento ed il completamento del parco d'assedio, l'aumento delle riserve di munizioni, l'organizzazione de l la forza aerea. una nuova sistemazione mii itare della Libia, opportune modifiche alla legge sul reclutamento per consentire un aumento della forza bilanciata di pace e l'accelerazione dei lavori ferroviari per giungere, al l 'atto della mobi I itazione, al I' intensificazione dei trasporti.
Le richieste, approvate e sostenute dal capo del governo, Giolitti, avrebbero avuto soddisfacimento, nei limiti delle possibilità finanziarie del paese, non appena il ministro della guerra ed il capo di stato maggiore avessero concretato in un progetto definitivo le cifre relative al fabbisogno.
Purtroppo, sia per l'inizio tardivo degli accordi fra le due autorità per giungere a risultati definitivi, sia per l ' improvviso abbandono ciel dicastero, per motivi di salute, da parte del ministro Spingardi prima che questi avesse ufficializzato al ministro del tesoro il fabbisogno dell'amministrazione della guerra, non fu possibile quantificare entro il dicembre del 1913 la cifra necessaria.
Tuttavia le cifre preventivate dal generale Pollio e quantificabili in un miliardo di spese straordinarie e I 00 milioni annui cli aumento per quelle ordinarie si rilevavano subito incompatibi li con le disponibilità finanziarie ciel paese e quindi eia rivedere nell'ambito di un programma meno ambizioso, ma che tenesse pur sempre conto ciel peggioramento della situazione politica internazionale.
li tenente generale Polli o aveva considerato l'eventualità che le difficoltà economic he ciel paese si rivelassero un ostacolo insormontabil e al s uo progetto ed in tale prospettiva ne aveva sviluppati altri due: progetto ridotto e progetto minimo; anche questi due si scontravano co n le so lite difficoltà finanziarie.
Fu solo il precipitare degli eve nti dopo l 'attentato di Sarajevo che permisero al nuovo capo di stato maggiore, il tenente generale Cadoma, di impostare un'efficace azione di potenziamento dell 'ese rcito , sfr uttand o, nel miglior modo possibiìe, il periodo offerto dalla posizione di neutralità assunta dall'Italia e che in un primo tempo, quando ancora s i pensava in ch ia ve triplicista. era stato stimato di circa ci nqu e mesi e mezzo.

1. Il pi a no d e l tenente ge ne ra le Enrico Cosenz
Come abbiamo visto, con la stipula del Trallato della Triplice l ' Italia si era sc hierata decisamente in chiave antifrancese ed in tale direzione lo stato maggiore si era orientato, predisponendo studi e piani sia per quanto riguardava il confine con la Francia sia per quello con la Svizzera.
Quest 'u ltima in particolare perché, nono s tante la s ua posizione di neutralità e le ollime relazioni che intercorrevano con la Germania e con l'Austria , poteva rappresentare un serio pericolo per la possibilità che offriva alle forze francesi di incunearsi tra i tedeschi e gli italiani prendendo, specialmente questi ultimi, s ul fianco; inoltre attrav erso il s uo territorio s i snodava la linea ferroviaria del S. Gottardo di massima importanza strategica perché costituiva, per le forze italiane destinate ad operare in Alta Alsazia al fianco cli quelle tedesche, la via più breve per raggiung e re la regione dei Vosgi 1 •
Lo s tato maggiore italiano, inoltre , non riteneva opportuno limitar s i a st udiare piani di operazione nei confronti della Francia , ma, in via del tutto cautelativa, oltre che predisporre un attivo controllo della frontiera italo -sv izzera, volgersi anche ad oriente, verso l 'alleata Austria , per predisporre un progetto di mobilita zione verso la frontiera Nord-Est ed adottare le misure ritenute più idonee nel caso di un conflitto isolato austro - italiano.
Si riteneva, infatti, che l'idea del generale Ricotti, d e l 1870, di radunare tutto l'esercito in una wna centrale della pianura pa-
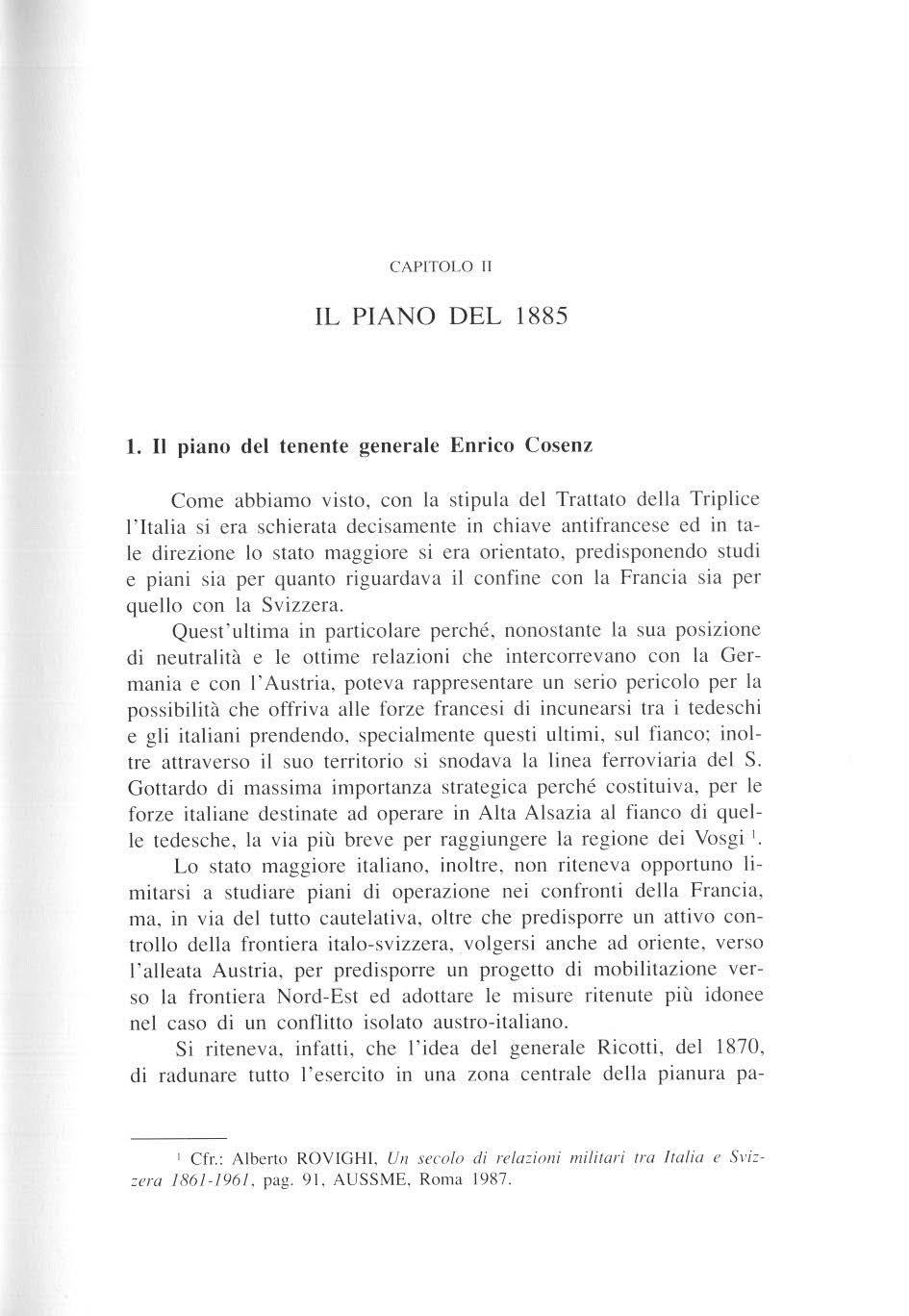 1 Cfr.: Alberto ROYIGHl. Un seco lo di rela:io11i mi/ilari ira /1alia e Svi::era /861-1961. pag. 9 1, AUSSME, Roma 1987.
1 Cfr.: Alberto ROYIGHl. Un seco lo di rela:io11i mi/ilari ira /1alia e Svi::era /861-1961. pag. 9 1, AUSSME, Roma 1987.
dana. individuata nella zona Pi ace n za-Stradel la, per poter fronteggiare la minaccia da qual s ia s i direz ione proven isse, fosse s up erata dai tempi e da ll e circostanze: necessitava quindi l'approntamento almeno di uno studio su come condurre delle operazioni sia difensive s ia offensive verso l'Aus tria portando tali o perazi o ni il più vic in o possibile a ll a frontie ra friulana.
Nella primave r a del 1885. pertanto. il tenente generale Co~enz, primo capo di stato maggiore dell'esercito, impartiv a ad un uffi c ia le di stato m agg io re. il tenente co lo nn el lo Ett ore Viganò 1• il seguente ordine: \ oi dm ete andare sui posti per determinare alla fi'o111iera ji-iulana 11110 successione conti nu a di luoghi. che cos tituis co 1111a h11011a fronte difensira 1·erso Est; ed anrhe p('r la P ontebhana. rerso Nord: in modo che. se fosse occupata da una parte del 11osrro esercito, e 1·01n•e11e1·olme11te ril!{or:ata co11 la\'Ori forr~ficatori da cos tmirsi ce lermente, - si jànni co là 11110 fone barriera per pmte:ione del fianco e del tergo del reswnte del/' esercito. che fosse diretto ad agire offe11sil'ame11te collo :;copo di porre stabile piede he11 addentro nel Tirolo cisa lpin o e nell'alto Cadore. - Questo 1·ostm 1111m·o studio di topografia militare. condotto per detl'rminare. diremo così. la Porta d'Italia al Friuli. sarà complemento degli altri st udi c h e si so n o già farri. co n mire offem'Ìl'e. s ull e lin ee di opera:ione che 1·a11110 nel Tirolo cisalpino e aflomo a Tohlach -' (oggi Dobbiaco).
L'uffi c iale si mise subilo a l lavoro seguito cos tant e m e nte ed in prima persona d al capo di s ta to maggiore il quale. pretendendo che lo studio fosse approfondi to in ogni dettaglio. inte r veniva più volte ne lla s tes ura d e ll o s tesso tanto eia in v itare il ten e nt e colonnello Vi ganò ad effe ttu a re num erose ri cog ni zio ni sul teat ro opera ti vo spesso ripetute. per approfondire ulteriormente quei particolari del ter-
1 Ettore VIGANÒ: generak. m1111stro, \cnatore. nato a Trada1c (Va) il 27 april e 1843 e morto a Firenze l'il ago~to 19 :D. Nella \ Lia ca rr iera mi litare. inili ata da so ld a to vo lontario nell'eserc it o meridionale nel 1860. ha ricoperto via via numerosi incarichi sempre più pre~tigiosi tra i quali il comando del 4° reggimento alpini, la direzione ddl'lstiiu to Geografico Militare, il comando del la brigata Rav e nna , i l gove rnatorat o de ll' Eri trea c d il coma ndo della d ivisione militare te rritoria le di Ancona prima e di Genova poi Nel 1906 è nominato ,cnatore del Regno. carica che lascia nel 1907. l'anno succe,,ivo è nominato comandante dcll'8 ° corpo d'armata. Ne l 1917 lascia il servizio per limiti d'età.
1 Cfr.: Enore VIGANÒ. la nostra Guerra, Le Mo nni e r. Fire nze. 1920, pag. 117.
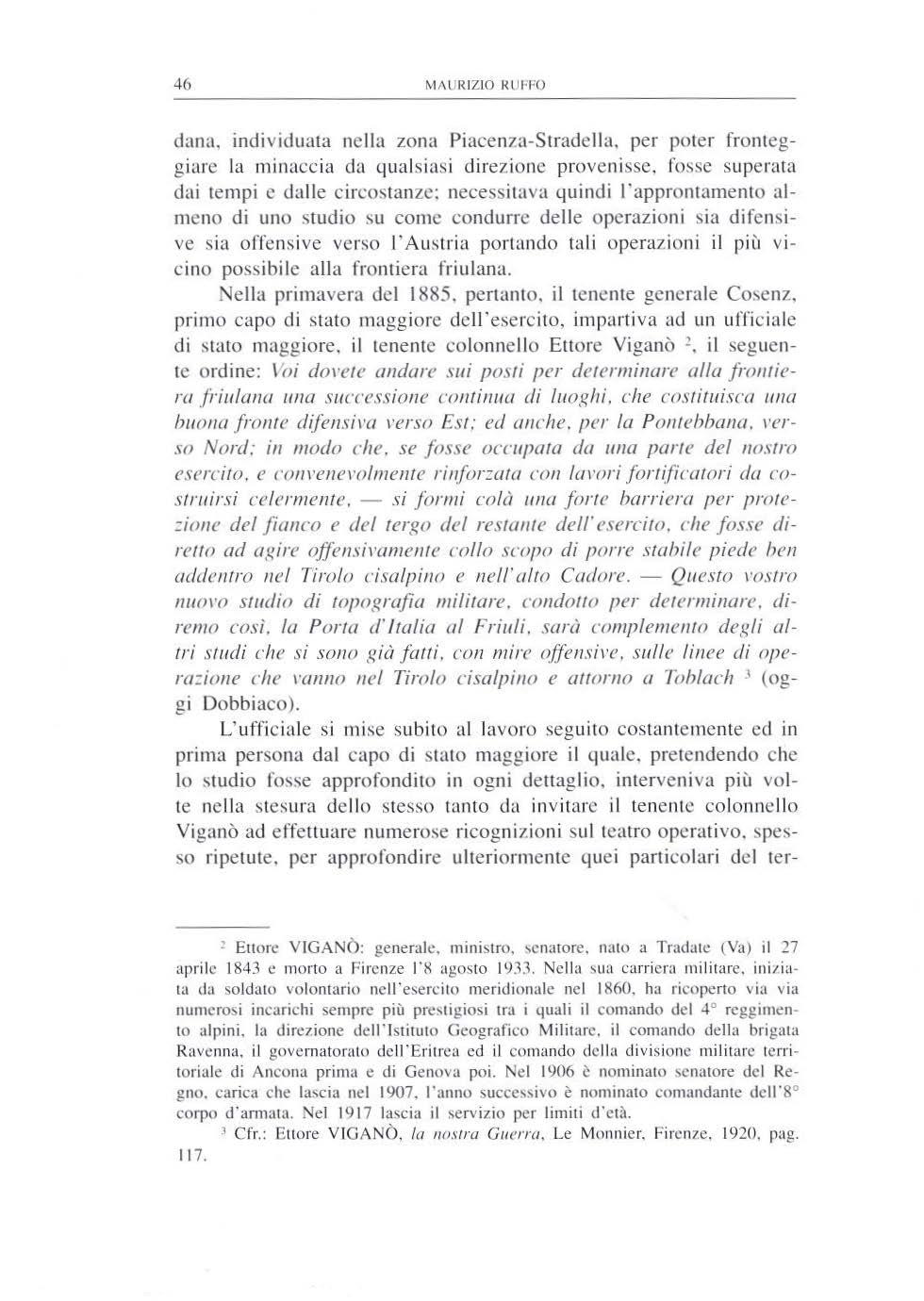
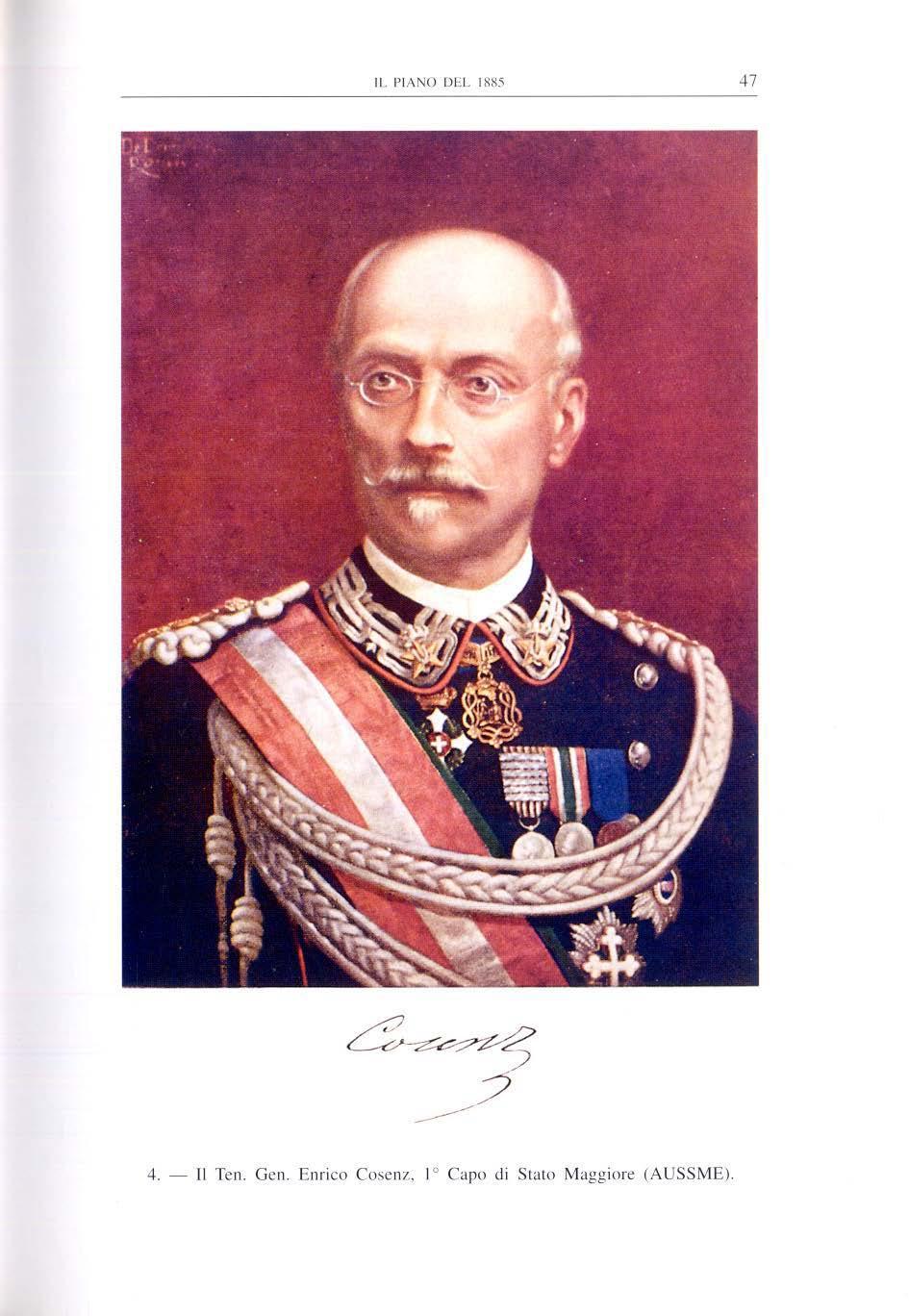
rcno che avrebbero potuto cos tituire elementi della massima importanza per l'impostazione e lo sviluppo della mano vra .
Il piano, più noto sotto il titolo di Studio circa la difensiva e l' offensil'a Nord-Est, era articolato in sette paragrafi nei quali venivano rispettivamente prese in esame le condizioni genera li dell'Italia di fronte a li' Austria, le condizioni iniziali dell'offensiva austriaca, il compito del corpo spec ial e, la radunata dell'esercito, le condizioni inizia li della lolla ed il passaggio dalla difensiva a li 'offensiva, la ritirata da effettua r si in caso di rovescio sulla linea difensiva del Piave e, per ultima, lo svolgimento di un'azione offensiva italiana verso Est.
Esso assumeva una notevo le importanza per tre distinte ragioni , la prima delle quali perché, come abbiamo detto, cambiava radicalmente il concetto del generale Ricotti 4 che presupponeva il concentramento dell'esercito nella zona di Stradella - in posizione centrale nell'ambito della pianura padana - da dove, a seconda di dove s i manifestava la minaccia, interverire.
La seconda perché, nonostante l 'alleanza con l'impero asburgico conclusa tre anni prima, il secolare nemico rappresentava pur sempre una possibile minaccia ed un comandante illuminato, come il generale Cosenz, ed il suo stato maggiore 5 aveva il dovere di tenerne conto.
La terza, infine, perché il trattato della Triplice non era stato accompagnato eia alcuna intesa militare che stabil isse in termini chiari gli impegni, e quindi l'entità delle forze ed il loro sc hi eramento, delle tre nazioni contraent i; le prime intese, infatli, verranno raggiunte solo nel 1888.
L'analisi dettagliata del documento assume quindi una particolare importa nza perché rappresenta, o lt re che il primo studio organ ico sulle possibili operazion i s ul fronte orientale, la base dei s uccessivi agg iornamen ti sia in termini di condotta delle operazioni vere e proprie c he cli mobilitazione e radunata nel particolare scacch iere.
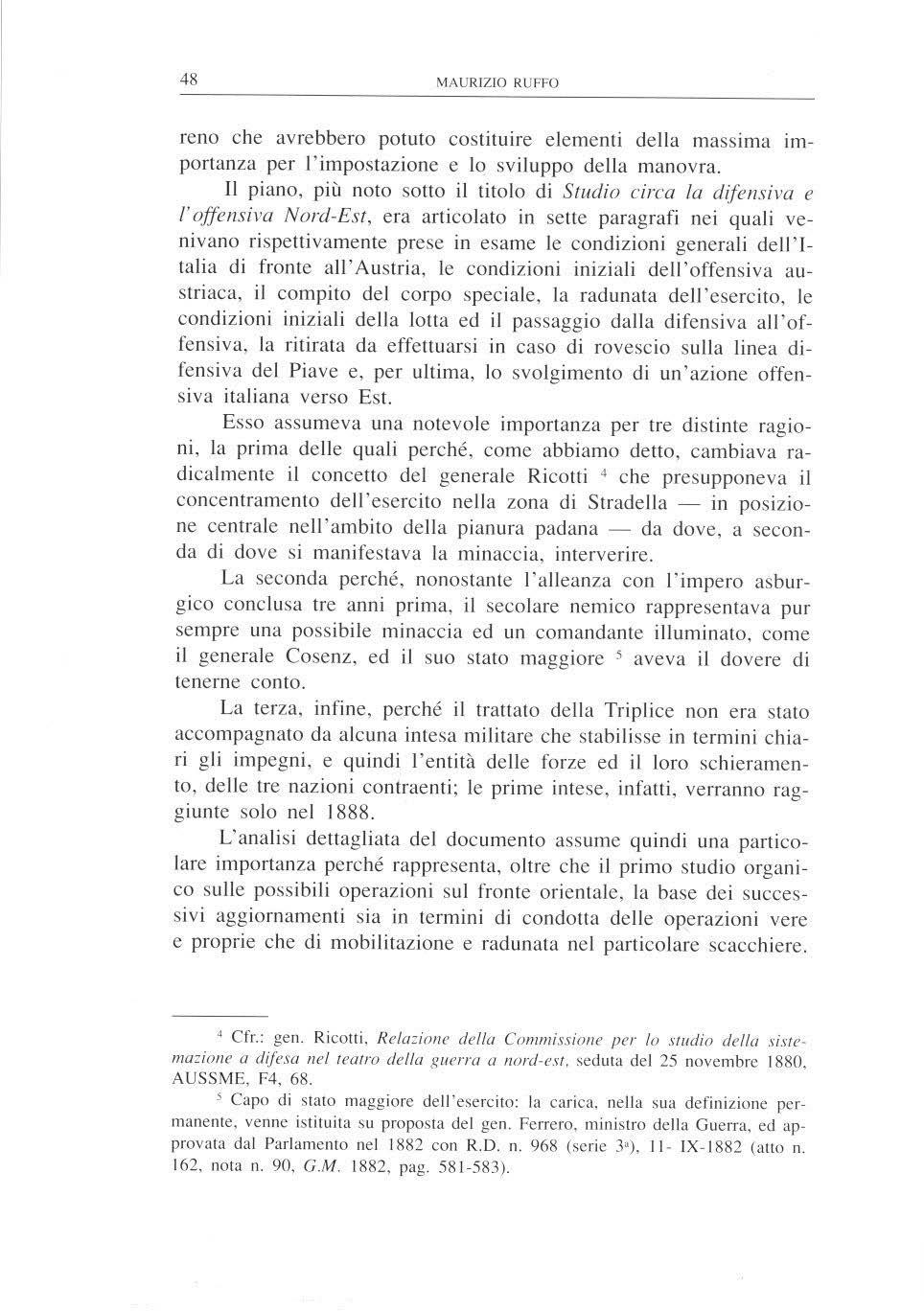
4 Cfr.: gen. Ricotti. Rela:in11e della Co111111issio11e per lo srudio della sisrema:ione a difesa n el rea 1ro della guerra a nord -esr. seduta del 25 novembre 1880, AUSSME, F4, 68.
5 Capo di sta to maggiore de ll'esercito: la carica, nella sua definizione permanen te, venne isti tuita su proposta del gen. Ferrero. ministro della Guerra, ed approvata da l Parlamen to ne l I882 con R.D. n. 968 (serie 3a), 11 - IX -1882 (atto n . 162, nota 11. 90. G.M. 1882, pag. 581-583).
a. Condizioni generali dell'Italia di fronte all'Austria.
In questo primo paragrafo il Cosenz analizza le condizioni generali dell' Italia di fronte all'Austria-Ungheria individuando, due possibili motivi per una radunata clcll 'eserciro su lla frontiera NordEst: una guerra localizzata tra l ' Italia e l'Austria e una guerra con quest'ultima in cui l ' Italia sia alleata cli un'altra potenza.
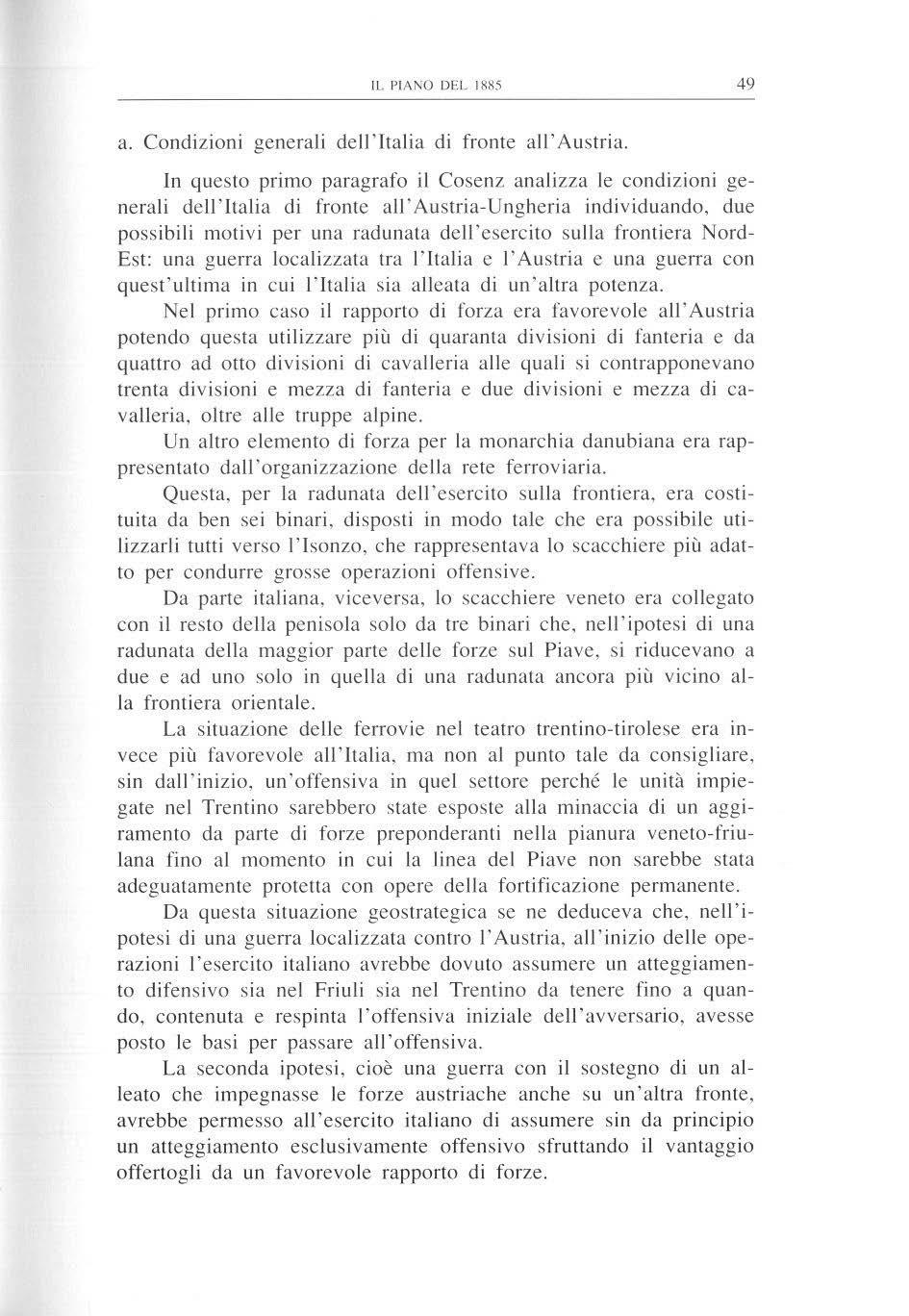
Nel primo caso il rapporto di forza era favorevole all'Austria potendo questa utilizzare più di quaranta divisioni di fanteria e da quattro ad otto divisioni cli cavalleria alle quali s i contrapponevano trenta divisioni e me zza di fanteria e due divi s ioni e mezza di cavalleria, oltre alle truppe alpine.
Un altro elemento di forza per la monarchia danubiana era rappresentato dall'organizzazione della rete ferroviaria.
Questa, per la radunata cieli' esercito sulla frontiera, era costituita da ben sei binari , di spost i in modo tale che era possibile utili zza rli tutti verso l'Ison zo, che rappr esen tava lo scacc hi ere più adatto per co ndurre g ro sse operazioni offensive.
Da parte italiana, viceversa, lo scacc hiere veneto era collegato con il resto della penisola solo da tre binari che, nel!' ipotes i di una radunata della maggior parte delle forze s ul Piave, si riducevano a due e ad uno solo in quella di un a radunata ancora più vicino alla frontiera orientale.
La s itua zione delle ferrovie nel teatro trentino-tirolese era 111vece più favorevole a ll 'Italia , ma non aJ punto tale da consigliare, sin dall'inizio, un 'offe nsiva in qu el se ttore perché le unità impiegate nel Trentino sa rebbero s tat e es pos te alla minaccia cli un aggiramento da parte di forze preponderanti nella pianura veneto-friulana fino al momento in cui la linea del Piave non sarebbe stata adeguatamente protetta con opere della fortificazione permanente.
Da questa s ituazione geostrategica se ne deduceva che, nell 'ipotesi di una guerra locali zza ta contro I' Austria, a ll ' inizio delle operazioni l'esercito italiano avrebbe dovuto assumere un atteggiamento difensivo sia nel Friuli sia ne l Trentino da tene r e fino a quando, contenuta e re s pinta l 'offensiva inizial e dell'avv ersa rio , avesse pos to le basi per passare all'offensiva.
La seco nda ipote s i, cioè una guerra con il sostegno di un alleato che impegnasse le forze austriache anche su un'altra fronte , avrebbe permesso all'esercito italiano di assumere sin da principio un atteggiamento esclusivamente offensivo sfruttando il vantaggio offertogli da un favorevole rapporto di forze.
b. Condizioni i ni z ia l i dell'offe nsiva austriaca.
Nel secondo paragrafo si analizzavano quelle che era no le condizioni iniziali di un 'offensiva austriaca prendendo, come punto di partenza per lo s tudio, l'ordinamento e la mobilitazione dell 'csercito asburgico più aggiornati.
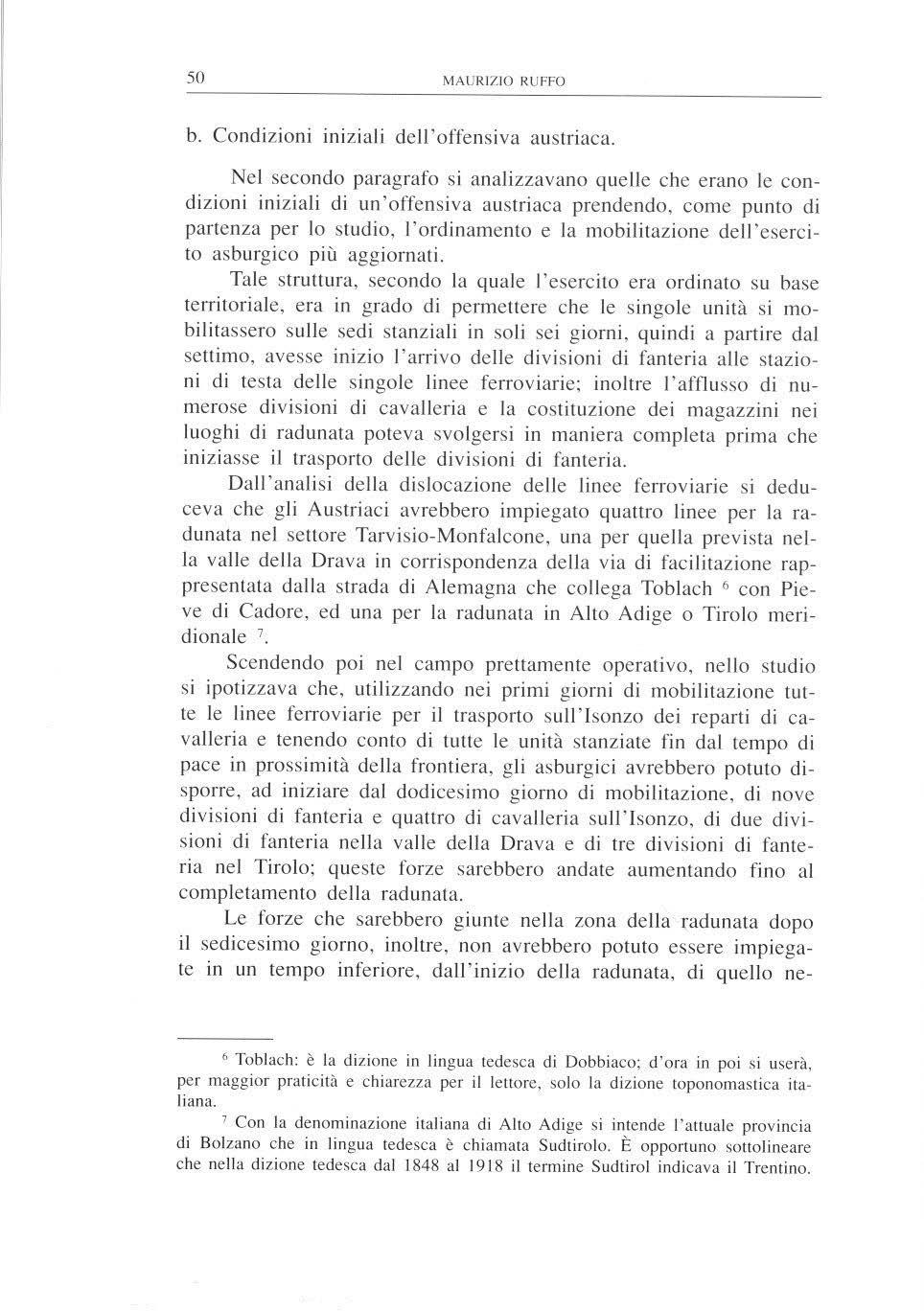
Tale struttura, secondo la quale l'esercito era ordinato su base territoriale, era in grado di permeltere che le singole unità si mobilitassero sulle sedi stanziali in soli sci giorni, quindi a pa11ire dal settimo, avesse inizio l 'arrivo delle divisioni di fanteria alle stazioni di testa delle singo le linee ferroviarie: inoltre l'afflusso di numerose divisioni di cavalleria e la costituzione dei magazzini nei luoghi cli radunata poteva svo lgersi in maniera completa prima che iniziasse il trasporto delle divisioni di fanteria.
Dal l'analisi della dislocazione delle lince ferroviarie si deduceva che gli Austriaci avrebbero impiegato quattro linee per la radunata nel setto re Tarvisio-Monfalcone, una per quella prevista nella valle del la Drava in corrispondenza della via di facili razione rappresen tata dalla strada di Alemagna che co ll ega Toblach 6 con Pi eve di Cadore, ed una per la radunata in Alto Adige o Tirolo meridiona le 7
Scendendo poi nel campo prettamente operativo, nello st udio si ipoti zzava che, utilizzando nei primi giorni di mobilitazione tutte le linee ferroviarie per il trasporto s ull ' Isonzo dei reparti di cavalleria e tenendo conto di tulle le unità stanziate fin dal tempo di pace in prossimità della frontiera, gli asburgici avrebbero potuto disporre, ad iniziare dal dodicesimo giorno di mobilitazione, di nove divisioni di fanteria e quattro di cavalleria suJl'lsonzo, di due divisio ni di fanteria nella valle della Drava e d i tre divisioni di fanteria nel Tiro lo; queste forze sarebbero andate aumen t ando fino al completamento della radunata.
Le forze che sa rebbero giunte nella zona della radunata dopo il sedicesimo giorno, inoltre, non avrebbero potuto essere im piegare in un tempo inferiore , dall'in izio deJ!a radunata, di quello ne-
6 Toblach: è la diz ione in l ingua tedesca di Dobbi aco; d'ora in po i si userà, per magg ior praticità e chia rezza per il lettore, solo la dizione toponoma sti ca ital iana.
7 Con la denominazione italiana di A lto Adige si in tende l'auuale provinc ia di B olzano che in l i ngua tedesca è chiamata Sud tirolo. È opportun o sottol ineare che nell a dizion e tedesca da l 1848 al 19 18 il termine Sud tirol i ndicava i l Trentino.
cessar io al l'esercito italiano cli completare, a s ua vo lt a, l a mobilita z ion e e lo sc hi e rament o di tutte le proprie unità.
L'eventualità poi che un attacco condotto nella pianura friulana , con le forze disponibili al dodicesimo giorno, e tende nt e a me ttere in difficoltà la mobilitaz ion e e lo schieramen to de ll e unit à italiane s ul Pi ave avesse un esito felice era considera ta pressoché nulla.
Questo conv in c ime nto deri vava dalla consideraz ion e che la dis tanza, per via o rdinaria , tra i terminali ferrovia ri di Tar v isio , Laibach 8 , Adelsberg o San Pietro e Nabresina dalla lin ea del fium e Li venza, naturale base di parte nza per un 'azione offensiva verso il Piave, osc illa tra i ce nt o ed i duecento e più c hilom e tri e, anche ammettendo che gli a us tri aci avessero trasportato fino alle s ta z ioni più vicine le di vis ioni di fanteria e in quelle più lonta ne l'artiglieri a e d i ca1Ti aggi, g li sa rebbe ro stati necessari a lm eno a ltri o tto gio rni p er completare il trasporto delle unità ed il loro sc hi era ment o su l L ivenza.
In tale ipote si, a partire dal ventesimo gio rno , g li imperiali avrebbero potuto disporre, sulla lin ea del Li ve nza, di no ve divisioni di fanteria e quattro cli cavalleria con le quali potere dare vita ad un'azione offe nsiva il ventune s imo g iorn o.
Nello s tesso tempo l 'eserc ito it a li ano, concentra to si nel Veneto secondo il piano di radunat a predisposto per l o scacc hi e r e NordEst, sa re bbe stato in grado di schierare lun go il Pi ave quindici divisioni di fanteria e due e mezzo cli cavalleria co mpl e tamente mobilitate se nza, peraltro , distogliere le forze destinate alla difesa ava nzata verso il Tirolo M er idionale o l 'A mpezzano 9
La sic urezza rappresentata dallo schieramento italiano s ul Pi ave era poi s upportata dalla co ns idera z ion e che se anche g li austriaci avessero utili zzato tutte le se i lin ee feIToviarie di cui dispon e vano , non sare bbe ro riu sc iti comunque a disporre cli più cli nove divi s ioni cli fanteria o ltre alle quattro di cavalleria alla se ra del decimo giorno e quindi non avrebbero potuto attaccare la linea del Piave prima del diciannovesimo , giorno in cu i l ' Ita li a avrebbe potuto contrappoITe ben ventitrè divisioni di fanteria e due e mezza di cavalle ria co mpl etamen te mobilitate.
8 Laibach era il nom e ted esco di L ubi a na; da ora in avanti s i userà, per maggior com prensione il termine italiano.
9 I confi ni del Tiro lo Meridionale co rri s po nd eva no a quelli de ll' a ttual e prov in cia di Tre nto, me ntre Co rtina e Livinallongo erano tirol es i

Da queste considerazioni lo stato maggiore italiano riteneva pertanto che, iniziandosi contemporaneamente la mobilitazione nei due paesi, gli austriaci non avessero grandi possibilità di disturbare, attraverso la pianura friulana, la radunata e lo schieramento delle unità sul Piave se non con azioni di cavalleria, evenlualmente sostenuta dai primi reparti di fanteria affluiti nella zona.
Per quanto riguardava il settore tirolese o ampezzano le opere della fortificazione permanente austriache esistenti e la partico lare conformazione ciel terreno davano sufficienti garanzie che le forze ivi dislocate sarebbero sta te in grado di arrestare eventuali azioni offensive tenden t i a rendere più difficoltosa la mobilitazione e la radunata dell'esercito italiano.
In questo paragrafo il Cosenz definiva i compiti del Corpo speciale 10 che, sin dal tempo di pace, era dislocato tra il Veneto ed il Friuli.
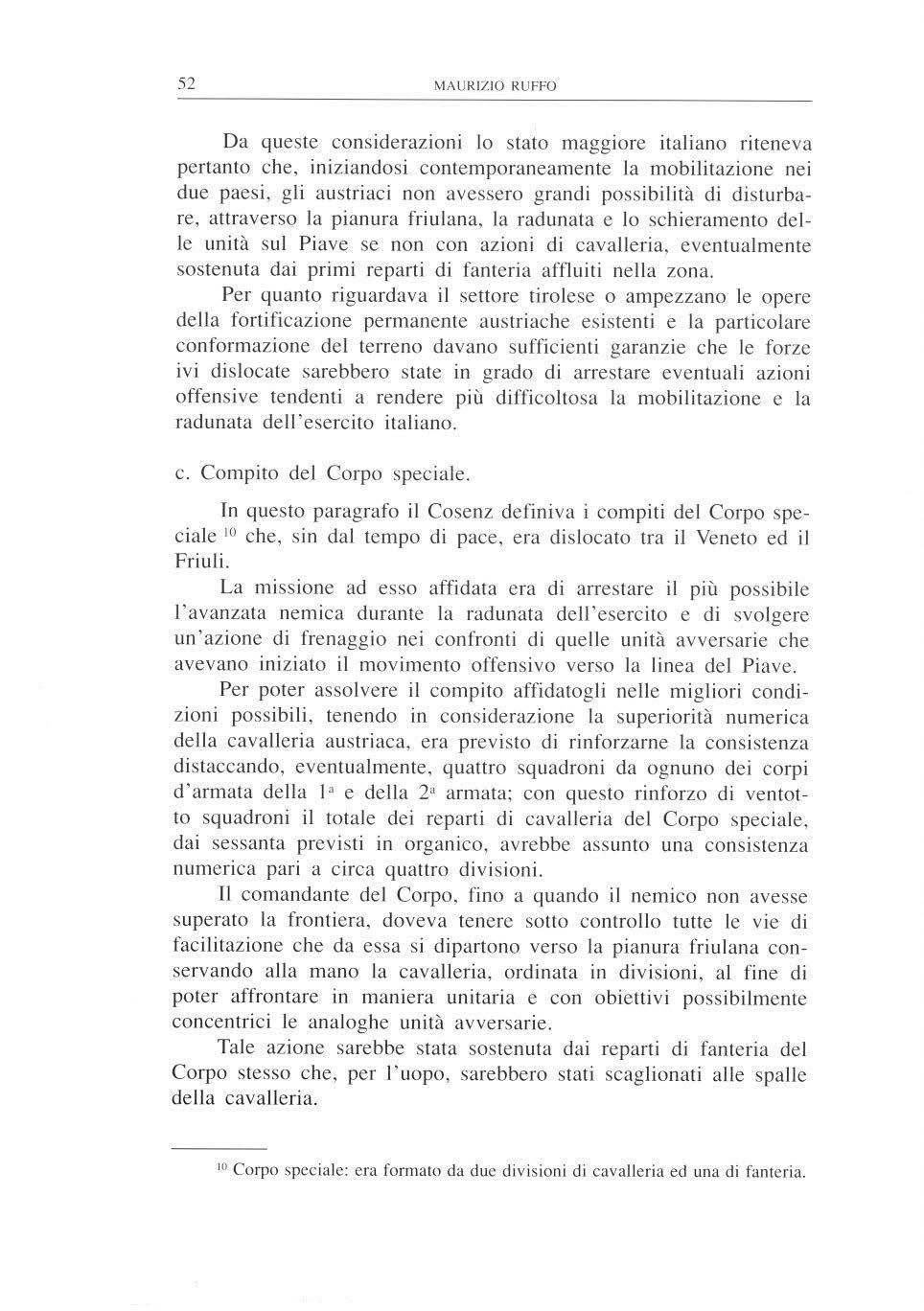
La missione ad esso affidata era di arrestare il più possibile l'avanzata nem ica durante la radunata dell'esercito e di svolgere un 'azione di frenaggio nei confronti di quel le unità avversarie che avevano iniziato il movimento offensivo verso la Iinea del Piave.
Per poter assolvere il compito affidatogli nelle migliori condizioni possibili, tenendo in considerazione la superiorità numerica della cavalleria aus tri aca, era previsto di rinforzarne la consistenza distaccando, eventualmente, quattro squadroni da ognuno dei corpi d'armata della I • e della 2" armata; con questo rinforzo di ventotto squadroni il totale dei reparti di cavaller ia del Corpo speciale, dai sessanta previsti in organico, avrebbe assunto una consistenza numerica pari a circa quattro divisioni.
Il coma ndan te del Corpo, fino a quando i I nemico non avesse s up erato la frontiera, doveva tenere sotto co ntroll o tutte le vie di faci lit az ion e c h e da essa si dipartono verso la pianura friulana conse rva ndo alla mano la cavall eri a, o rdinata in divisioni, al fine di poter affrontare in maniera unitaria e con ob iettivi possibilmente concentrici le analoghe unità avversar ie .
Tale azione sa rebbe stata sosten uta dai reparti di fanteria del Corpo stesso che, per l'uopo, sarebbero stati scaglionati alle spa ll e della cavalleria.
In particolare alla fanteria spettava il compito di arrestare la penetrazione della cavalleria avversaria qualora fosse riuscita, con l'appoggio di reparti di fanteria ed in particolar modo di cacciatori , a sopraffare quella italiana; compito secondario era poi quello del controllo dei punti di attraversamento del Livenza predisponendone la distruzione in caso di necessità.
Queste attività dovevano es sere svolte senza correre alcun nschio di esporsi a rovesci facendosi agganciare ed impegnare da grosse formazioni di fanteria.
Terminato i I suo compito di scaglione di presa di contatto e frenaggio 11 , il Corpo speciale sarebbe defluito attraverso le posizioni difensive poste sul Piave che, nel frattempo , si sarebbero andate conso l idando con l ' afflusso di tutte le unità mobi l itate.
La divisione di fanteria, i due reggimenti di bersaglieri e l'artiglieria da campagna, una volta trafilati oltre il Piave , si sarebbero riordinati nella zona di Serravalle passando alle dipendenze del comandante della 2• armata; la cavalleria , da parte sua, si sarebbe ritirata sul tratto pianeggiante del Piave ad eccezione dei ventotto squadroni avuti in rinforzo che sarebbero tornati nei rispettivi corpi.
d. Radunata dell'esercito e successivi spostamenti.
Nel mentre il Corpo speciale era impegnato nell ' azione di frenaggio, la radunata dei corpi d ' armata di prima linea si sarebbe effettuata , come previsto dai piani di mobilitazione e radunata in vigore, nel modo seguente:
VI corpo
I • armata
Mestre (dis t acca il rgt. bersaglieri al Corpo specia le)
VIII corpo T reviso X corpo
(distacca il rgl. bersaglieri alla difesa del Cadore)
Padova (distacca il rgt. bersaglieri al Corpo speciale)
11 Scag l ion e di pres a di contallo e frenag gio: term in e moderno per in dicar e quel l e forze des tinate a svolgere un 'a zione di logo r amenLo e ritardo ne i confronti dell'allaeeante. al lo scopo cl i permettere al le un i tà destinate alla difesa cli organizzare nel mig lior modo possibi l e le posizion i su cui imperniare l'azione difensi va.
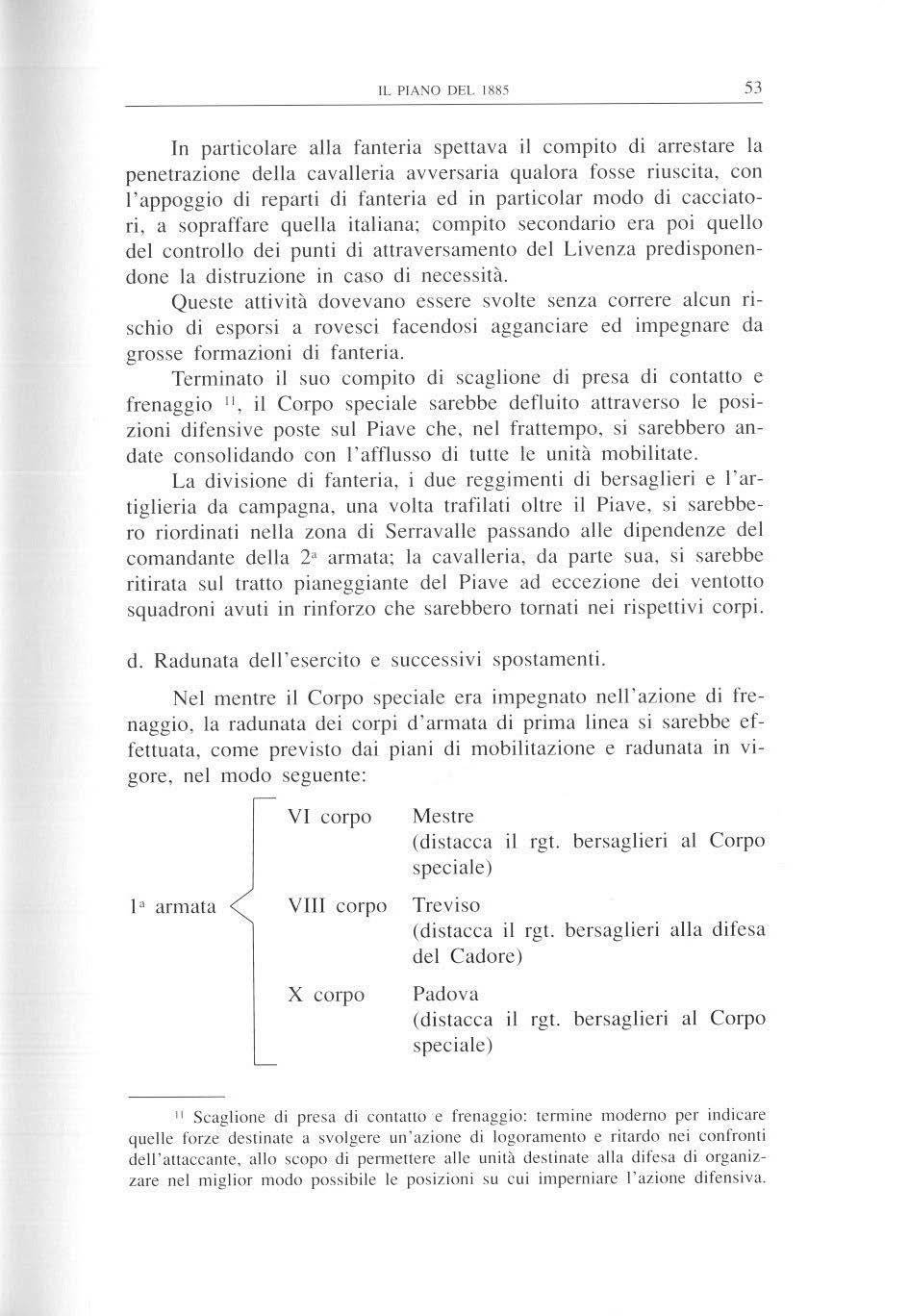
2d armata
I corpo Cornuda
(distacca il rgt. bersaglieri alla difesa del Cadore)
1V corpo Bassano (distacca il rgt. bersaglieri alla difesa del Cadore)
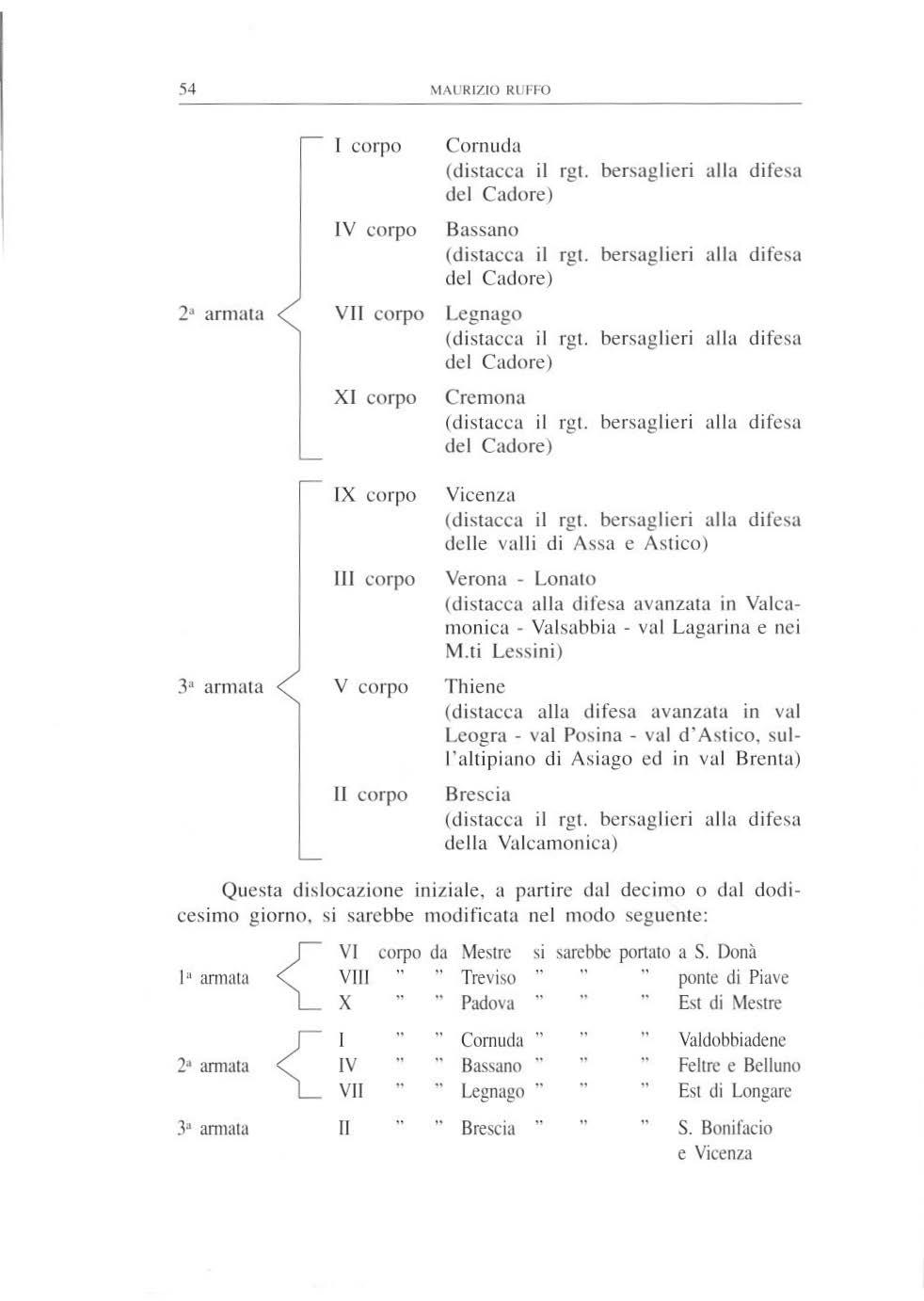
VII corpo Leg na go (d istacca il rgt. bersag li e ri alla dife sa del Cadore)
XI co rpo Cre mon a (distacca il rgt. bersaglieri alla difesa del Cadore)
TX corpo Vicenza (dis ta cca il rgt. bersaglieri alla d i fesa delle valli di Assa e Astico)
lll corpo Verona - Lonato
(distacca alla difesa avanzata in Valcamonica - Valsabbia - val Lagarina e nei M.ti Lessini)
3" armata
V co rpo
Il corpo
Thiene (distacca alla difesa avanzata in va l Leogra - va l Posina - val d'Astico, sull 'a ltipiano di Asiago ed in val Brenta)
Brescia (di s tac ca il rgt. bersaglieri alla dife1,a de lla Valcarnoni ca)
Questa dislocazione ini z iale, a partire dal de c imo o dal dodicesimo giorno. s i sarebbe m odi ficata nel modo seg ue nt e:
I " annaia
VI corpo da Mestre s1 sarebbe portato a S. Donà
Vlll " Tre viso ,. ponte di Pia ve
X " Padova .. Est di Mestre
" Comuda " ., Valdobbiadene
2a armata
3• annata
IV .. Bassano .. Feltre e Belluno
VII " Legnago Es t di Longare
Il .. Brescia .. S. Bonifacio e Vicenn
A decorrere dal quindicesimo giorno era previsto il tra spo rto ferroviario del Xl corpo d'armata da Cremona al Ponte della Priula utilizzando le due lin ee ferroviarie : Cremona - Brescia - Verona - Vicenza - Cittadella - Treviso e Cremona - Mantova - Dossobuono - L egnago - Rovigo - Padova - Treviso.
Alla notizia certa di un'avanzata in forze da parte austriaca s ul Tagliamento e del conseguente ripiegamento de l Corpo speciale verso il Piave, il X corpo d'armata si sarebbe portato da Me s tre verso Meolo e Roncade, mentre il VII s i sarebbe mes so in marcia da Longare su Treviso per poi ri sc hierarsi a San Biagio e il IX da Vicenza si sarebbe portato a Villorba.
Questi due ultimi corpi, al termin e del rischieramento , sarebbero stati posti alle dirette dipendenze del comando s u premo.
Al termine di questi movimenti s i sa rebbe avuto su una fronte di 45 Km. , compresa tra San Donà e Scrravalle. uno schieramento composto da otto corpi d'armata e due divisioni e mezza di cavalleria con il rinforzo di alcune opere di campagna armate con bocche da fuoco da 12 mm.
La 4• armata inizialmente sarebbe stata composta da corpi d 'armata formati interamen te o qua si con truppe della milizia mobile e si sarebbe radunata su lla destra del Po , successivamente i corpi d 'armata sarebbero s tati schiera ti in prima lin ea, trasportandoli per ferrovia , in quei settori dove la s ituazione del momento l'avrebbe richiesto, con il conseguente riordinamento delle s in gole arma te.
Infin e il Cosenz aveva previsto che, qualora l 'azione austriaca si svo l gesse con la massima intensità conto la lin ea ciel Pia ve e non si manifestasse la necessità cli rinforzare la difesa avanzata del Tr entino, oltre a lla 4• armata si sarebbe potuto portare sul fronte più minacciato anche il 11 corpo d 'a rmat a in modo tale da avere in linea ben dodici corpi d'armata.
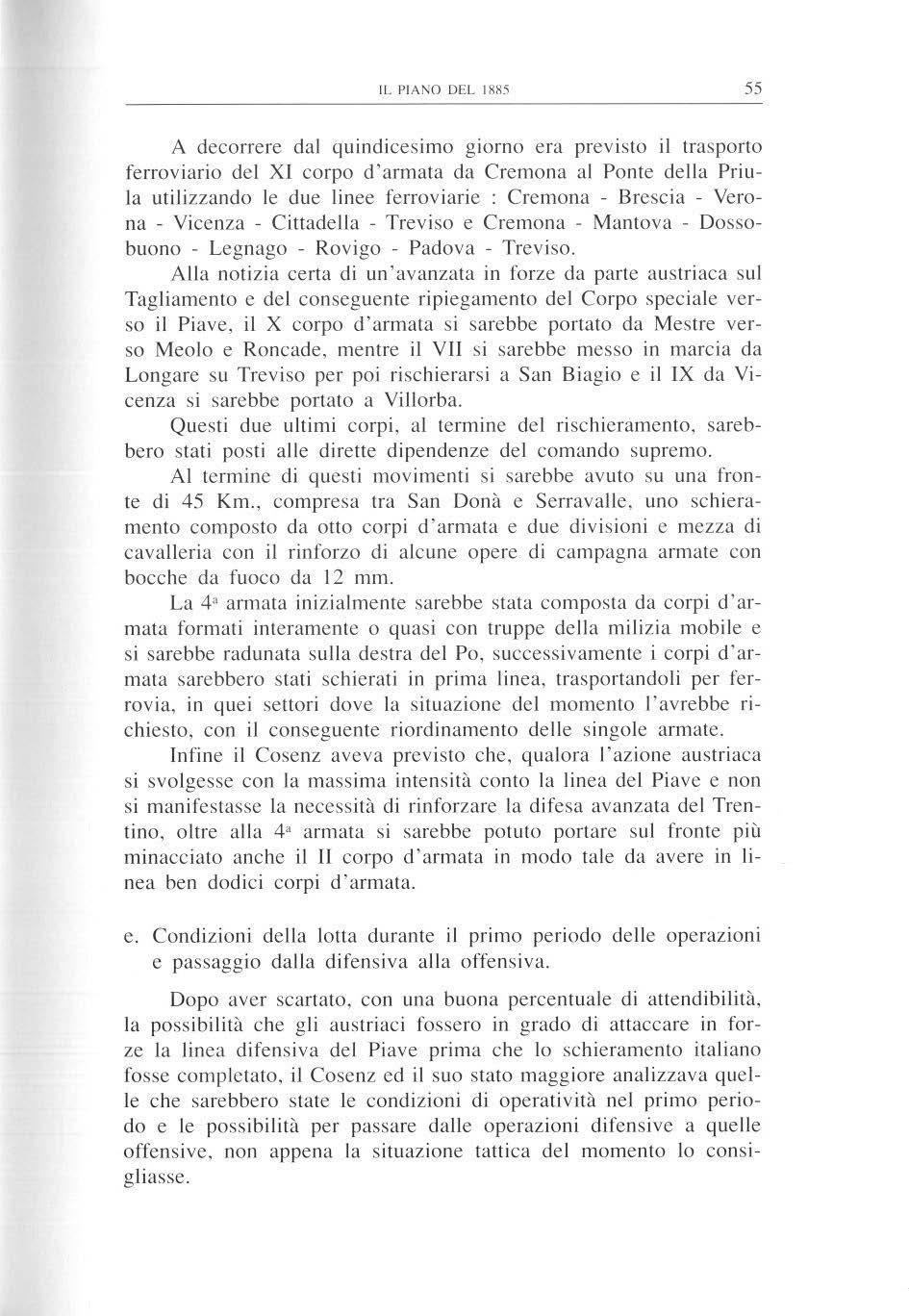
e Condizioni della lotta durante i I primo periodo delle operazioni e passaggio dalla difensiva alla offensiva.
Dopo aver scartato, con una buona percentuale di attendibilità, la possibilit~t che gli austriaci fossero in grado cli attaccare in forze la lin ea difensiva del Piave prima che lo schieramen to italiano fosse completato. il Cosenz ccl i l suo stato maggiore a nali zzava quelle che sa rebbero state le condizioni di operatività nel primo periodo e le possibilità per passare dalle operazioni difensive a quelle offensive, non appena la s itu azio n e tattica del mom e nt o lo consigl i asse.
La prima ipotesi analizzata era che sarebbe stato opponuno co nsi derare se riam en te la necess ità d i non impegnarsi a fond o s ul Pi ave qualora g li asburgici. per aver mob ili tato con qualche giorno di a nti cipo o per altre cause no n definibili a priori, avessero atracc.:a to prim a c.: he i co rpi della 4·' arm a ta fo ssero a ncora g iunti sul fiume e che, nel con tempo. quel trailo di Pi ave s tesso. che presenta un m in ore os t aco lo ad un· avanzata in forze perc hé compreso tra le alture d e l M on te ll o e il mare, per un'estensione di c irca 35 c hilom e tri , fosse difeso eia so li se i co rpi d'armata a ran g hi ridotti
Ma, al contrario, cedendo terreno. acquisire la certeaa di fronteggia re l'azione offens iva dopo poc hi giorni co n forze notevolme nt e s up e riori , co ntand o a nche s ul fa tto c.: he un forte presidio dell e alture di C oneglia n o avrebbe dato un grosso vantagg io alla difesa it al ian a.
Infatti se g li austriaci avesse ro a ttac ca to co nt empo ran eame nte le c.:o llin e di Conegliano ed il basso Pi ave si sarebbero trovati in una situalione sfavorevole perché racchiusi in una specie di tenag li a; era quindi m o lto più probabile attendersi un'a z ione preve ntiva ve r so le a lture per poi procedere risolutamente con un attacco frontale su l Piave.
Nell'operare in questo modo avrebbero la nec ess it ~ t di impiega re il g rosso dell e forze su ll' a la destra limit a ndo a d attività di solo c.:o ntr ollo lo schiera m ento sulla linea del basso Piave.
In questa ip o tes i l 'estenso re dello s tudi o era d el parere che a lla difesa s i sare bbe prese ntata l 'opportunità di compensare la propria infe ri orità con un 'ard it a az ion e offensiva. prevedendo il superamento del basso corso del Pi ave con cinque co rpi d'a rm a ta co n obie lliv o la lin ea Od e rzo -Co neg lian o, pe r avvo lgere da sud le forze nemiche.
Tuttavia, qual ora quest'atione non si fosse potuta effe ttu a re per vari motivi e g li austriaci fossero riu sc iti a c.:o nquistare le alture di Conegliano, la lo ro posizione non sa reb be sta ta s icura perché espos ta ad una co ntro ffensiva delle forze italiane dislocate nella conca di Bellun o il c ui co ntrollo assumeva, in tal e co ntes to. un 'e no rm e ril eva nz a stra teg ic.:a per le ampie possibilità d i mano vra offerte a lla di fesa .
L a co nq uis ta da parte a us tria ca de l ridotto del Cadore, co n proven ienze co nce ntri c he dall e valli d e lla Drav a e del T agliamento, era co n s id e rat a poi alquanto improbabile. se prima il grosso delle forze imperiali no n fosse g iunto s ull a Li vcnza . per la forza natural e di de tto ridott o, acc resci uta dalla num e rose for tifi cazioni presenti o in v ia di completamento. e la cons is tef17a delle unità sch iera te in loco.

Tutte queste condizioni rafforzavano il convincimento che, prima di procedere ad un attacco consistente sul Piave , l'avversario avrebbe dovuto svolgere tutta una serie di operazioni preliminari e preparatorie.

TI tempo necessario da esse richiesto avrebbe permesso la completa radunata e sc hieramento delle unità italiane che, in caso di attacco, avrebbero agito in maniera controffensiva con una manovra avvolgente condotta con le mede s ime modalità esecutive s u descritte e cioè attacco sul basso Piave se i I nemico concentra le s ue forze verso le alture di Conegl ian o; attacco dalle alture se l'avversar io agi sce contemporaneamente contro di esse e nella pianura.
Per quanto riguardava la dife sa della frontiera montana compresa tra i I passo del Tonale e la valle del Tagliamento , qualora alla 3• armata, incaricata del presidio del delicato settore, fossero stati tolti due corpi d'armata per destinarli a rinforzare le unità poste a dife sa della linea del Piave , rimanevano sempre delle forze, dell 'en tità di quattro corpi d'armata 12, che, in considerazione delle particolari condizioni morfologiche del terreno e de l le opere del la fortificazio ne permanente già costruite o in via di completamento lungo i punti più sens ibili , sarebbero risultate sufficienti ad assolvere il compito loro assegnato.
Ad incrementare la capacità di difesa di queste forze si considerava il fatto che, per i tre quinti, esse fossero concentrate nel tratto che va dalla va ll e dell ' Adige alla Valsugana, tratto ritenuto più vu ln erabile e direttamente incidente sul se ttore Pia ve; ad esse si sarebbero potute aggiungere le forze ciel 11 co rpo d 'armata dislocato tra San Bonifacio e Vicenza e orientato, come ipotesi d ' impiego prioritaria, s ul Piave qualora le forze poste a difesa della frontiera con il Trentino risultasse ro sufficienti.
Questa co ndizione era, peraltro , legata alla capacità dei comandanti delle unità destinate alla difesa della Valtellina, della Valcamonica, della Valsabbia, del Cadore e dell'alto Tagliamento di esercitare un 'attiva so rv eg li anza se nza farsi paralizzare da piccoli nuclei avversari .
12 L e forze d es tinate al la difesa dell'arco alpino risultavano così composte: 2 corpi d'armata com pleti (con i ri spellivi reg gimenti be rsag lieri). 8 reggimenti bersa g lieri. 6 regg im enti alpini pe rmanenti. 8 batterie da montagna permanenti. 2 ballerie da montagna d i mili zia mobile. tulle le com pagnie alpine di milizia mobile. quelle di milizia ten·itorialc al pina della frontiera Nord-Est. per un to tale di circa 4 corpi d'armata.
Su come comportarsi per evitare questa eventualità lo s tudio del Cosenz è estremamente chiaro, in esso, infatti, si legge: .. .sarà indispensabile che essi attivino un buon sen•i::.io di spionaggio, pagando largamente le notizie che s i possono 1·er!{icare esatte, che non si riducano alla ina zione sotto il pretes10 di far risparmio di forze e di 1•ite, ma eseguiscano contro i pochi nemici alfacchi più o meno vivi secondo le circostanze per assicurarsi dell'entità di essi. e siano sempre pronti ad accorrere in soccorso dei pumi più o meno lontani che venissero attaccati, ogni qualvolta abbiano poche forze nemiche di .fronte e 11011 siano legali da ordini formali. A questa condizione sollanto essi potranno rendere rilevanli seni::.i e contribuire al buon esito della guerra.
Per alcuni traf(i del fronte montano la dffesa dovrà prendere un·ardita offensil'a nel territorio nemico allo scopo di raggiungere taluni obbiettivi l'icini che ne agevolino il comp ito difensivo e preparino il passaggio alla ojfe11sfra a fondo da attuarsi quando la lotta sul Piave ahbia sortito esito .felice 13.
Fra g li obbiettivi vic ini di più rilevante importanza era stato individuato l'altipiano di Lavarone, il cui possesso era fondamentale sia ai fini della difesa ciel tratto di confine compreso fra la val L eogra e la val Sugana, sia come base di partenza per un attacco a l campo trincerato cli Trento 14 e per avere la piena disponibilità del II corpo d'armata per l'impiego sul Piave.
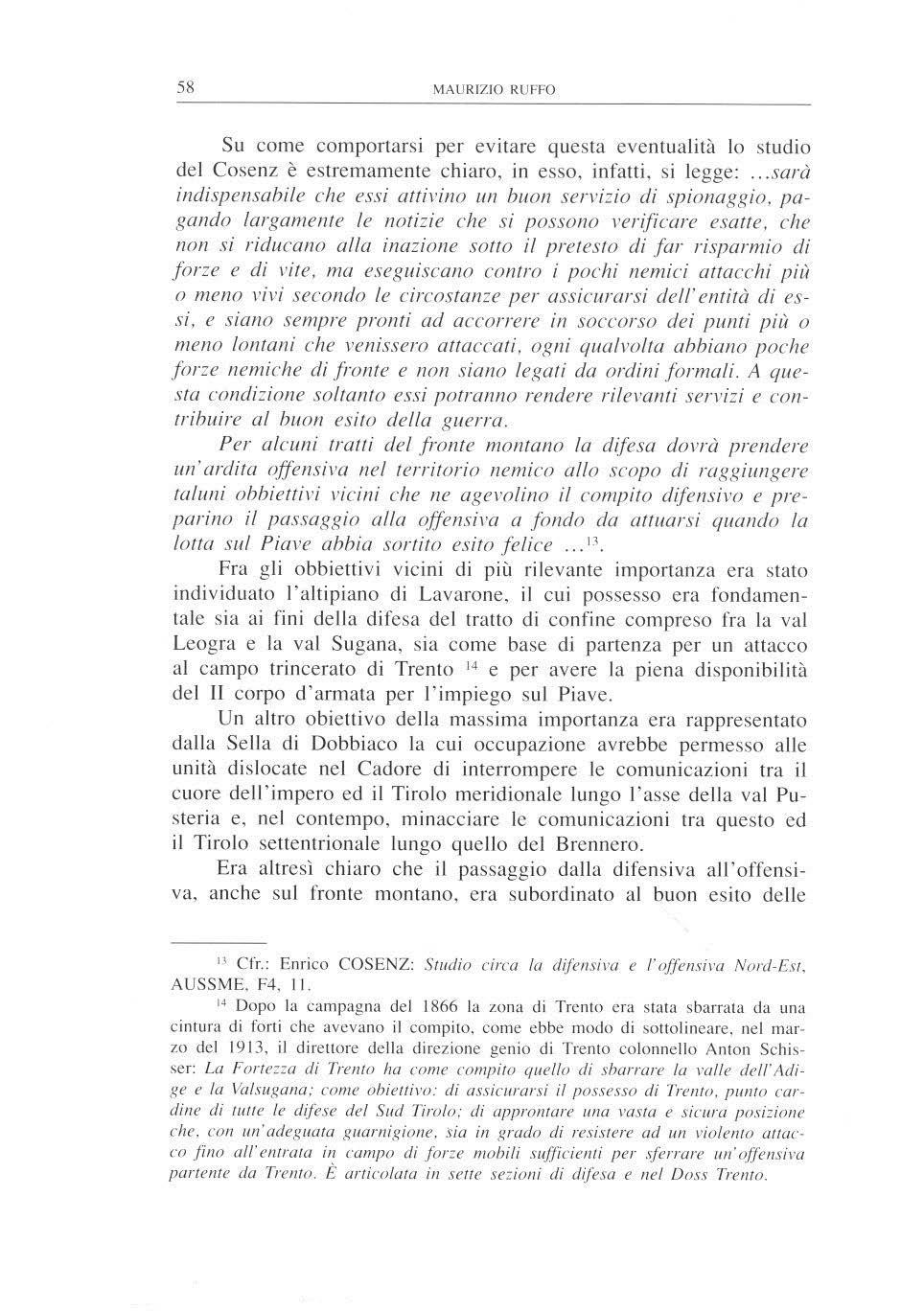
Un altro obiettivo della massima importanza era rappresentato dalla Sella di Dobbiaco la cui occupa zione avrebbe permes so alle unità dislocate nel Cadore di interrompere le comunicazioni tra il cuore dell'impero ed il Tirolo meridionale lungo l'asse della val Pusteria e, nel contempo, minacciare le comunicaz ion i tra questo cd il Tirolo settentrionale lun go quello ciel Brennero. Era altresì chiaro che il passaggio dalla difensiva all 'offe nsiva. anche sul fronte montano , era subordinato al buon esito delle
circa la dife11sil'a e /"offensim Nord-Esr, AUSSME ,
14 Dopo la campagna del 1866 la zona di Tre1110 era staia sbarrata da una cintura di forti che avevano i l com pito, come ehbe modo di sotto l ineare. nel marzo del 1913. il direttore della direzione genio di Trento co lonnello Anton Schisser: La Forte::a di Trento ha r-ome compito quello di sbarrnre la ml/e dell'Adige e la Valsugana; come obielli\'O: di assicurarsi il possesso di 1ì·enro. punto cardine di 1111/e le difese del S11d Tirolo; di appro111are 111w 1•asta e sicura posi2ione che . co11 1111'adeg11a1a g11amigione. s ia in grado di resistere ad un 1•iole1110 a11a1 ·co fi110 al/"enrraw in campo di for : e mobili suf(ic iemi per .1ferrare 1w· ojfe11si\'(/ partente da Trento. È arricolata in selle se: ioni di difesa e nel Doss Trento.
operazioni d'arresto sul Piav e al quale era necessario far seguire immediatamente un'offensiva per impedire che il nemico si attes ta sse s ul fiume Liv e nza.
Infine , nel condurre l'azione offensiva sul Pia ve s i riteneva opportuno far sostenere l'attacco sulla fronte e su ll a sinis tra dello sch ieram ento, in direzione delle alture di Aviano, da un'azione sussidia ri a s ulla destra, condotta con truppe sbarca te tra le foci del Livenza e del Tagliamento .
All'uopo sa rebbe stato necessario predisporre tali forze a Vene z ia , a rmate in modo leggero , con una capacità operativa e logis tica limitata a pochi giorni e g uid ate, nel dedalo dei canali e elci corsi d'acqua presenti nel settore, eia compagnie di lagunari.
f. Ritir a t a clell 'Ese rcito in caso di rovescio s ul Piav e.
In questo paragrafo lo s tudi o pre nd eva in esame il caso in cui, a seg uito di un rovescio s ull e posi z ioni difensive della linea del Pia ve, si fosse reso necessario procedere ad una ritirata su un'altra posizione idon ea ad arrestare la pro g ressio ne avve rsaria e riacquis tare la lib e rtà d'azione necessaria per intraprendere un 'azione controffen s iva.
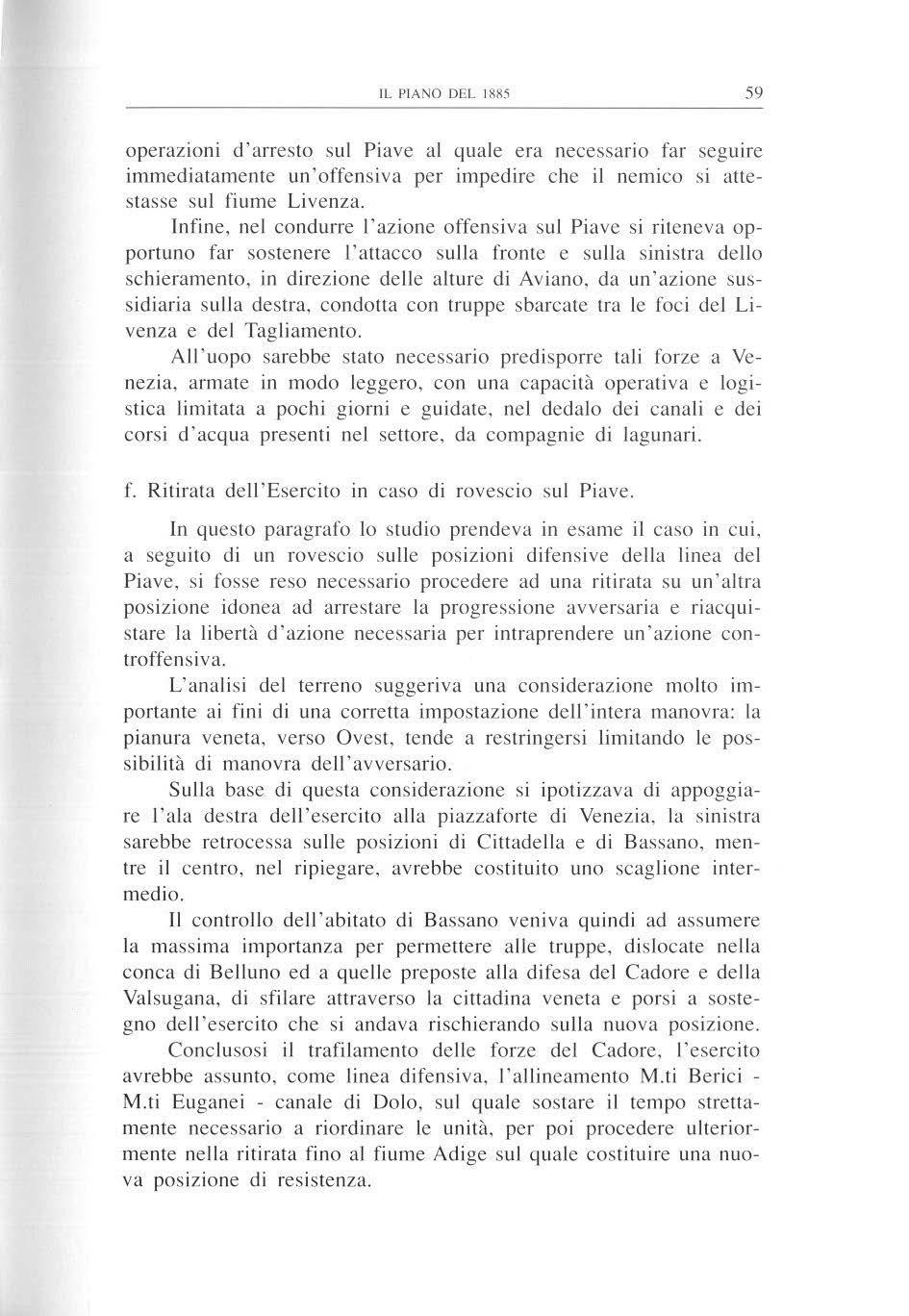
L 'a nali si del terreno sugge riva una cons ider azio ne molto importante ai fini di una corretta impostazione dell'intera manovra: la pianura veneta, verso O vest, tende a restringersi limit ando le possi bilità di manovra de ll 'avversa rio.
Sulla base cli qu es ta co ns id eraz ione si ipotizzava di appoggiar e l'ala d es tra ci e li 'ese rcito alla piazzaforte di Venezia, la si ni stra sa re bbe retroc essa sul le posizioni di Cittadella e di Bass ano , me ntre il centro, ne l ripiegare, avrebbe costituito uno scaglione intermedio.
Il controllo del l 'abitato di Bassa no veniva quindi ad assumere la ma ss ima importan za per permettere alle truppe, dislocate ne lla conca di Belluno ed a qu e ll e prepos te alla di fesa de l Cadore e della Valsugana , di s filare attraverso la cittadina veneta e porsi a sos teg no dell 'ese rcito che si anelava ri sc hierando s ull a nuova posizione.
Conclusosi il trafi l amento d elle forze del Cadore , l'esercito avrebbe assunto, come linea difensiva, l 'all ineamento M.ti BericiM.ti Euganei - canale di Dolo, su l quale s o s ta re il te mpo stre ttamente necessa rio a riordin are le unit à, per poi procedere ulteriormente nella ritirata fino a l fiume Adige s ul quale cost ituire un a nuova pos izione di resi s ten za.
Tale manovra, che comportava tra l 'altro l'abbandono della difesa del confine montano ad est di Verona. avrebbe sortito l'effetto di poter fronteggiare su ll 'Adige l'avversario con ben 15 corpi cl 'arma ta, reputando, nel contempo, che la difesa ad Ovest del lago di Garda e quella dello sbarra mento di Rivoli sarebbero s tate assicurate dalle unità a lp ine permanenti, da quelle di milizia mobile e dalle forze di mili zia territoriale 15 •
La scel ta di que s ta posizione era leg ata alla considerazione de ll 'a lto valore impeditivo rappresentato dal corso dell'Adige e daJJa disponibilità cieli' ampia rete stradale che permetteva di condurre un 'eccellente azione difensiva, basata s ulla manovra delle forze opportunamente scaglionate in profondità 16 ed in grado di sostenersi a vicenda sia con funz ioni di rincalzo che per favorire manovre aggiranti sui fianchi.
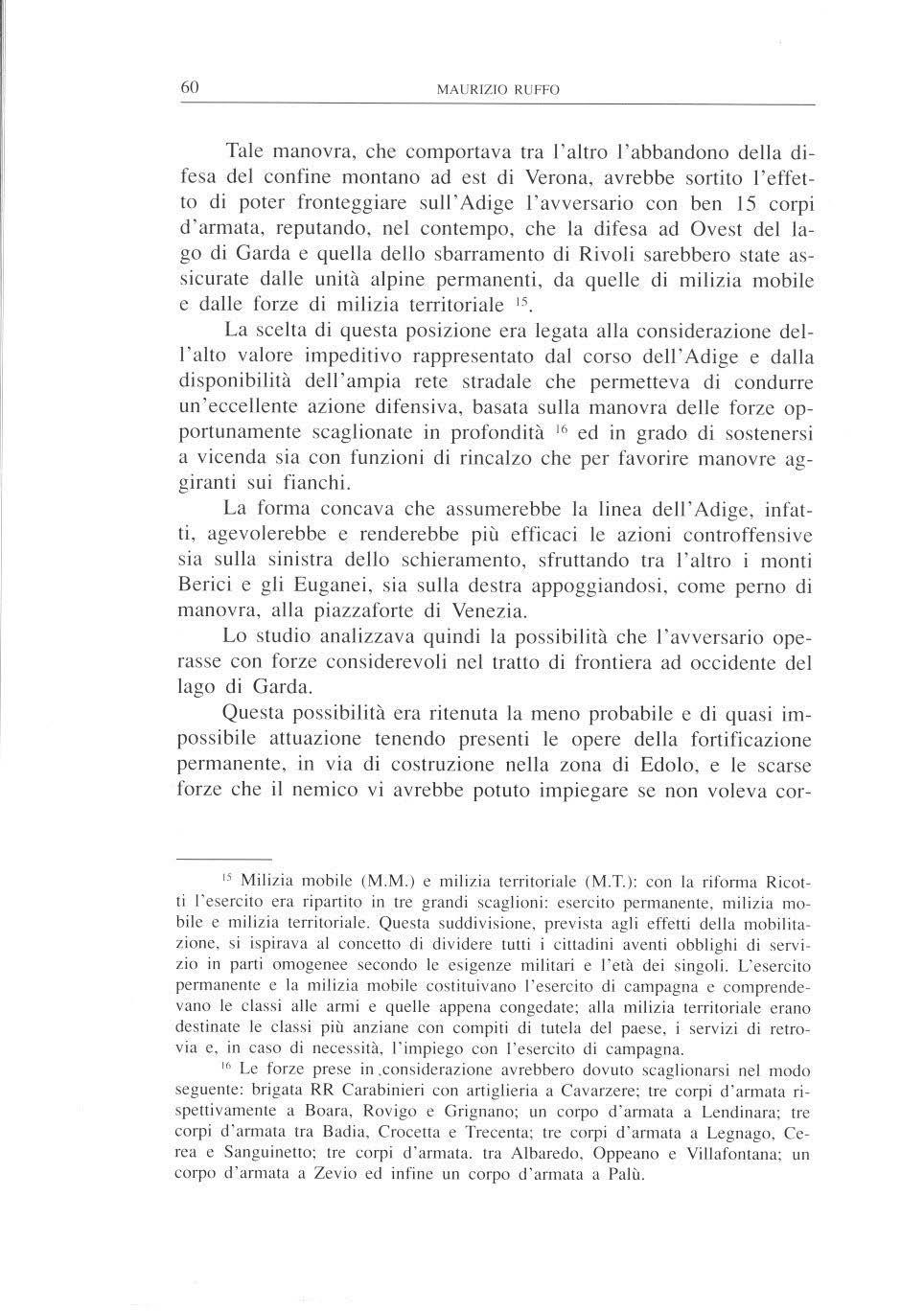
La forma concava che assumerebbe la Iinea del!' Adige, infatti, agevolerebbe e r en d e rebbe più efficaci le azioni controffensive sia s ull a sinistra dello sch iera mento , sfruttando tra l'altro i monti S er ici e gli Euganei, s ia sulla destra appoggiandosi, come perno di manovra, a ll a piazzaforte di Venezia.
Lo st udio analizzava quindi la pos s ibilità che l'avversario operasse con forze considerevoli nel tratto di frontiera ad occidente del lago di Garda.
Questa possibilità era ritenuta la meno probabile e di qua s i impossibile attuaz ione tenendo presenti le opere della fortificazione permanente, in via di cost ru zione nella zona di Edolo , e le scarse forze che il nemico vi av rebbe potuto impiegare se non vo leva cor-
15 Mi l izia mob i le (M.M.) e milizia territoria le ( M.T.): con la riforma Ri cotti l 'esercito era ripart ito in tre grandi scag l ioni : ese rc ito pe rmanente, mi l izia mob i le e mi l izia territ oriale. Questa suddivisione, prevista ag l i effetti della mob i l i taz ione si ispirava al co ncetto d i dividere tuui i c ittadini ave nti obblighi di serv iz io in pa rti omogenee secon do le es igenze mil it ari e l'e tà d ei sin go l i. L'eserc ito permanente e la milizia mo bil e cos titui vano l'esercito di campagna e comprendevano le classi alle armi e quelle appe na congedate; alla miliz i a terr itoria le erano des ti na te l e classi più anziane con comp iti di tute la del paese. i ser v iz i di re trovia e, in caso di necessità, l ' imp iego con l'esercito d i campagna.
1< • Le forze prese in cons iderazione avrebbero dovu to scag l io narsi nel modo segueme: bri gata RR Carab ini eri co n artigl ieri a a Cavarzere; tre co rpi d'annata rispettivamente a Boara, Rovigo e Grignano; un co rpo d'annata a Lendinara: tre corpi d'armata tra Bad i a. Crocetta e Trece nta; tre corp i d'arma ta a Legnago, Cerea e Sanguinetto; tre co rpi d'armata. tra Albaredo, Oppeano e Villafontana; un co rp o d'a rmata a Zevio ed infin e un cor po d'arma ta a Palù.

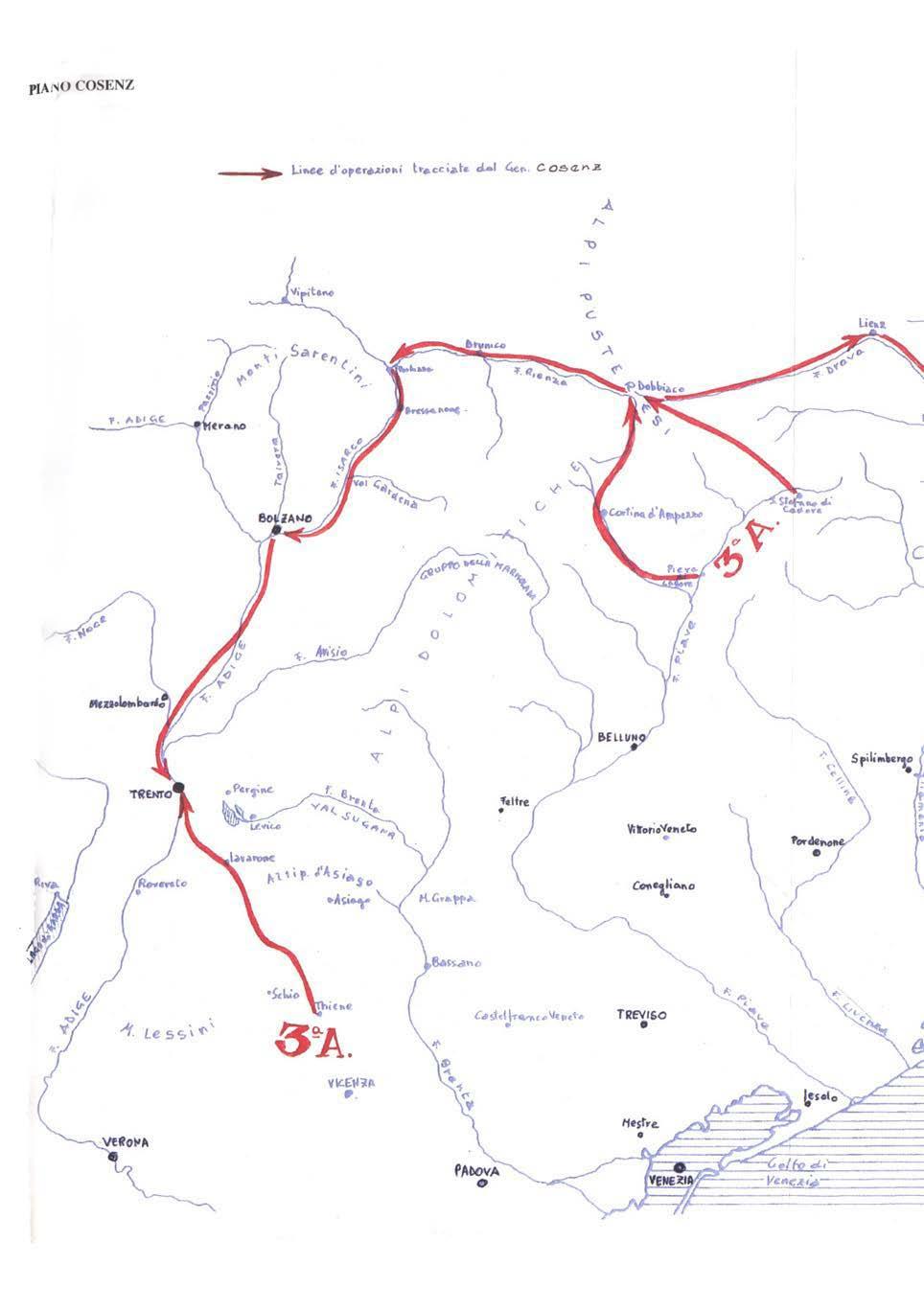
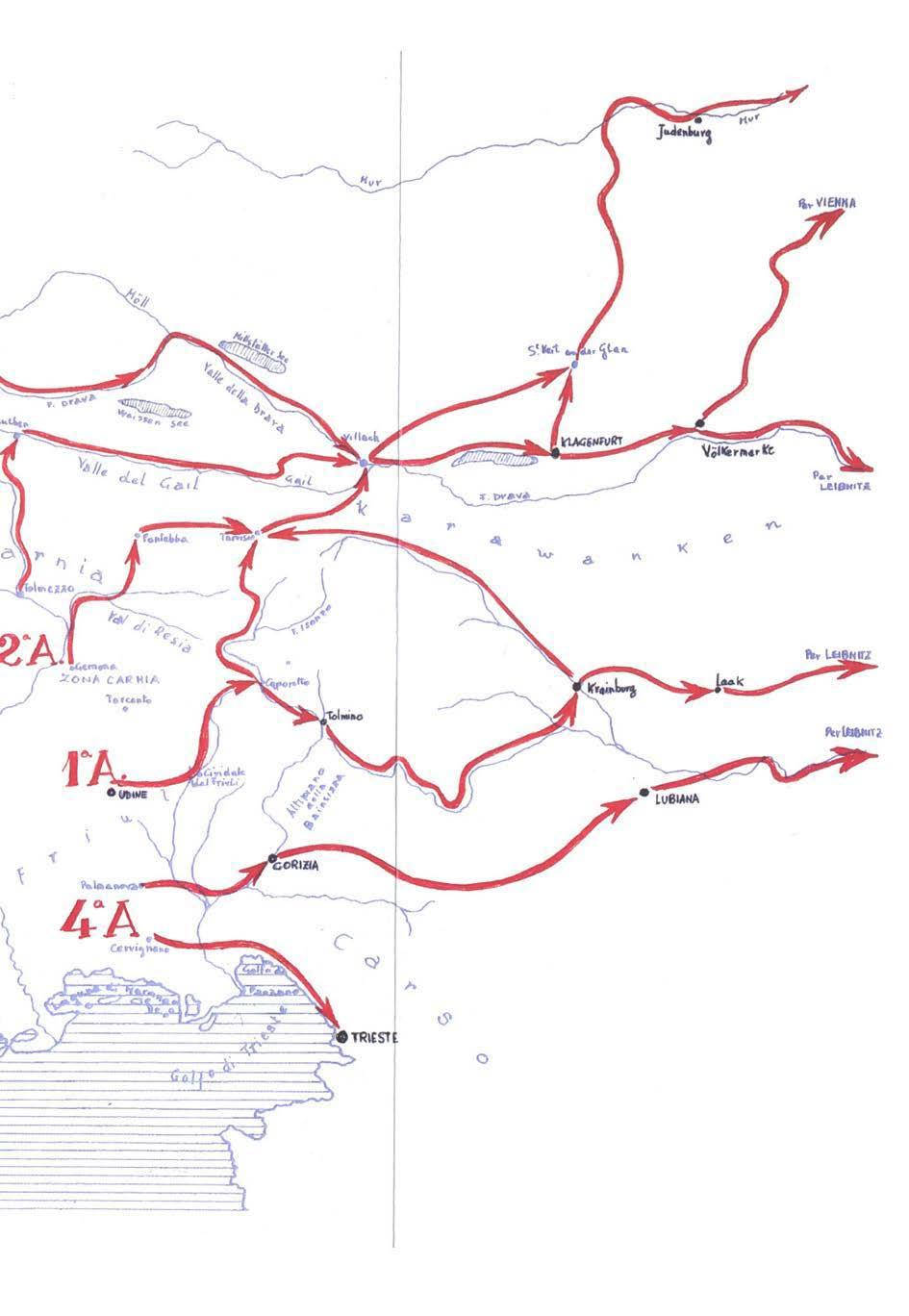

rere il rischio cli indebolire le unità schierate sulla I inea cieli' Adige per orientarle a ll a conquista del la Yalcamonica, della Valtel li na e della Valsabbia.
g. Svolgimento dell'offen s iva ita li ana verso Est.
Terminata l'analisi delle operazioni difensive, lo studio prende in esame l'eventuale svo lgersi di operazioni offensive italiane verso es t, articolandosi armonicamente nei vari momenti per il lustrarne gli aspetti più salienti e di maggior intere'>se ai fini dell'assolvime nto del compito ricevuto.
Le ipotesi post e a base de ll a poss ibi lit à di condurre azioni offensive erano due. la prima che una parte delle for7e dell'AustriaUngheria fosse impegnata su un ·altro fronte. la seconda che l'offens iva dell'esercito impe riale si fosse arrestata sulle posizioni difensive italiane.
Tuttavia poiché nel secondo ca')o le operazioni offensive dipendevano di rettamente dall'andamento della lotta fin qui condotta e non erano cond izionate in maniera sostanziale dal terreno e dalle condizioni della viabilità che, probabilmente. non sarebbero muta le di molto da quelle che si porcva immaginare per la prima ipotesi, s i riteneva più utile, ai fini della condotta de ll e operazioni, analizzare la seconda.
L" esercito austriaco. nell'assumere la sua disposizione difensiva, si sa rebbe basa to s ul co ncetto di rallentare il più poss ibile l'avanzata degli I taliani. logorandone il più possibile le forze. in atte~a che le muta te condizioni generai i non gli permettessero di ass umere. a s ua vo lt a, l" offensiva.
Questa visione strategica avrebbe fatto supporre che g li austriaci lasciassero poche forLe mobili nel Trentino dove le numerose ope r e de ll a fortificazione pe rm anente. sussid iate da una difesa attiva. sarebbero risultate sufficien ti a dare un tempo d'arresto ad un 'offensiva: analogamente si sarebbero comportat i lungo le direttri c i operative cli Pontebba e del Pred ii, sba rrate dall e fortificaLioni di Malborghetto 17, di F litsch e del Predii 1i1
La maggior parte delle forze verrebbe. invece. co ncent r ata sul basso I so n zo per co prire quella parte del territorio dell' I mpero, non
17 Per le carat1crb 1iche del forte cfr.: documcn10 n. 3.
iR Per le cara11cr is 1ic he dei forti di Predi i e d e ll a chiusa di F litsch cfr.: documento n. 4
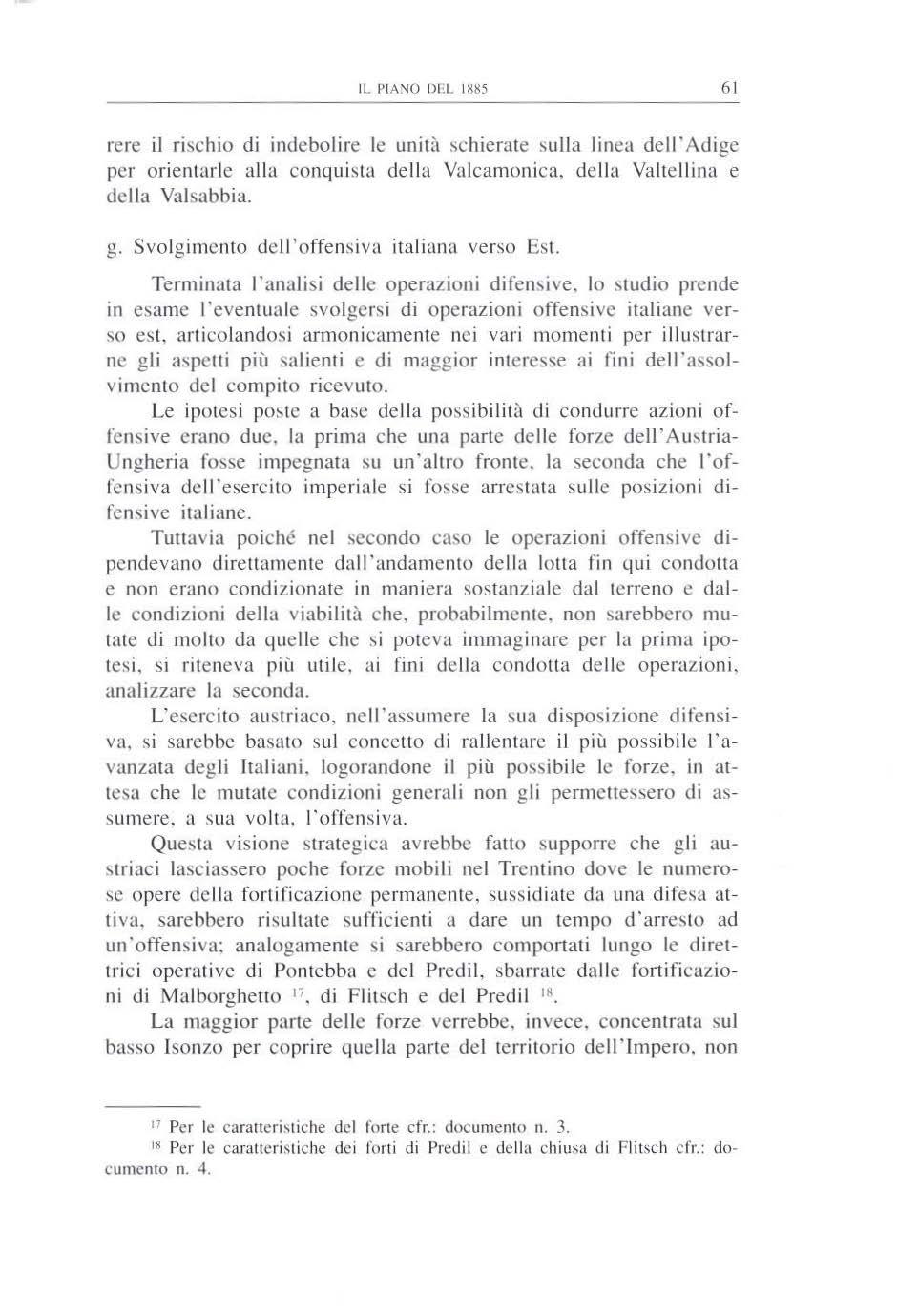
5. - Malborghetto (UD). rone llense l. Cos tr ui to nel I 809 tra le q uo te di 780 e 858 s.l.m. da l Cap i tano del Genio Friedrich Hense l. A ncora non ul timato ru attacca to da preponderanti t ruppe francesi. fu conq ui stato. dopo tre giorni di assa lti nonostante 1· er oica rcsis tenLa del Capitano Hen~el e dei suo i uomini. Quello che restava del fo rt e ve nne demo l ito dagl i austriaci nel 18 I 2. Ricostruito da l Capit ano Cas imi r Bie lawski tra i l 1848 ed i l l 850 aveva una guarnigione di 8 -900 uo mini e 30 can n oni Tra l'autun no del 188 1 cd il 1884 ven ne comp leta meme ristruttura lo su progetto del Col on nello del Genio conte Gu1.tav Geltlern- Egmond L u Arcen, entrò in funzione col nome di forte Hensel. I l suo armamento all" ini Lio tie lla G r ande Guerra consisteva in: b locco A: 2 obic i corazza ti PH M05 da IO cm. in rnpole corazzate M80. 4 cnn noni i n ca~amatta M04 da 9 cm .: b locco B: .:I cannoni MSchK J\1180 da 12 c m ., 4 canno ni M80 d a 12 cm . in batte ria corazzata. La difesa v ic in a era ass icura ta tra mite 7 mitragl iat rici t\,10 J\1107 da 8 111111. e 6 ri fle ttori. La sua guarnigio ne era for mata eia 21 u ffici al i e 567 uomini (Sc i occ hc tti. Trento).
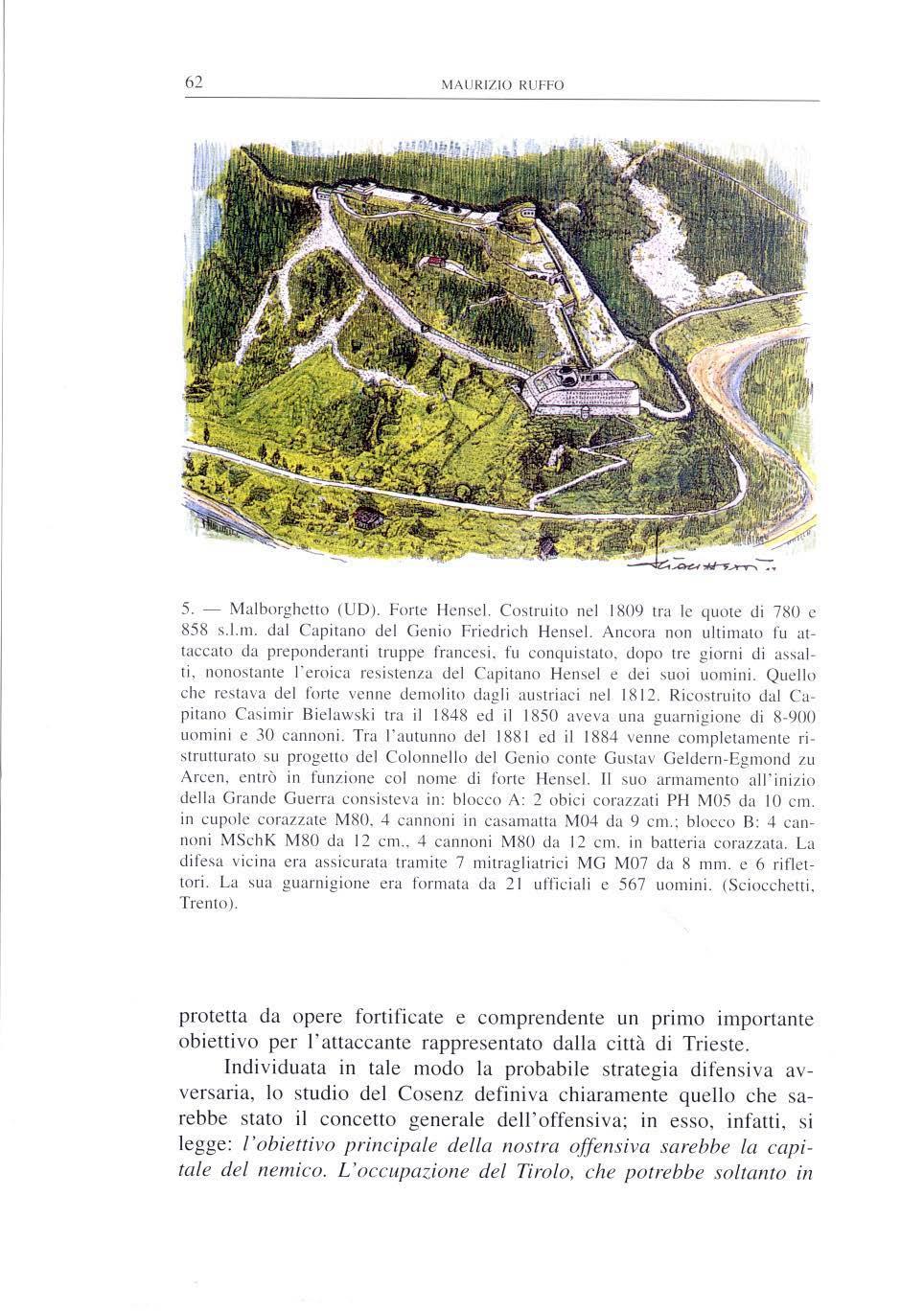
protetta da opere fortificate e comprendente un primo imp o rtant e ob ietti vo per l 'a ttaccante rappresentato dalla c ittà di Tri este.
[ndi viduata in tale mod o la probabile stra teg i a difensiva avve r sa ria , lo studio d e l Cosenz d efi niva chiaramente que ll o che sarebbe s tato il concetto ge nerale de ll'offe ns i va; in esso , infatti, s i legge: l'obiettivo principale della nostra offensi va sarebbe la capital e del nemico. L 'occ upa zione del Tirolo, c h e potrebbe soltanto in
modo accessorio ii(fluire sull'esito .fi11ale della !{lletTCI, sarehhe 1111 oggetri, •o secondario. 11w però 11eceswrio 19 •
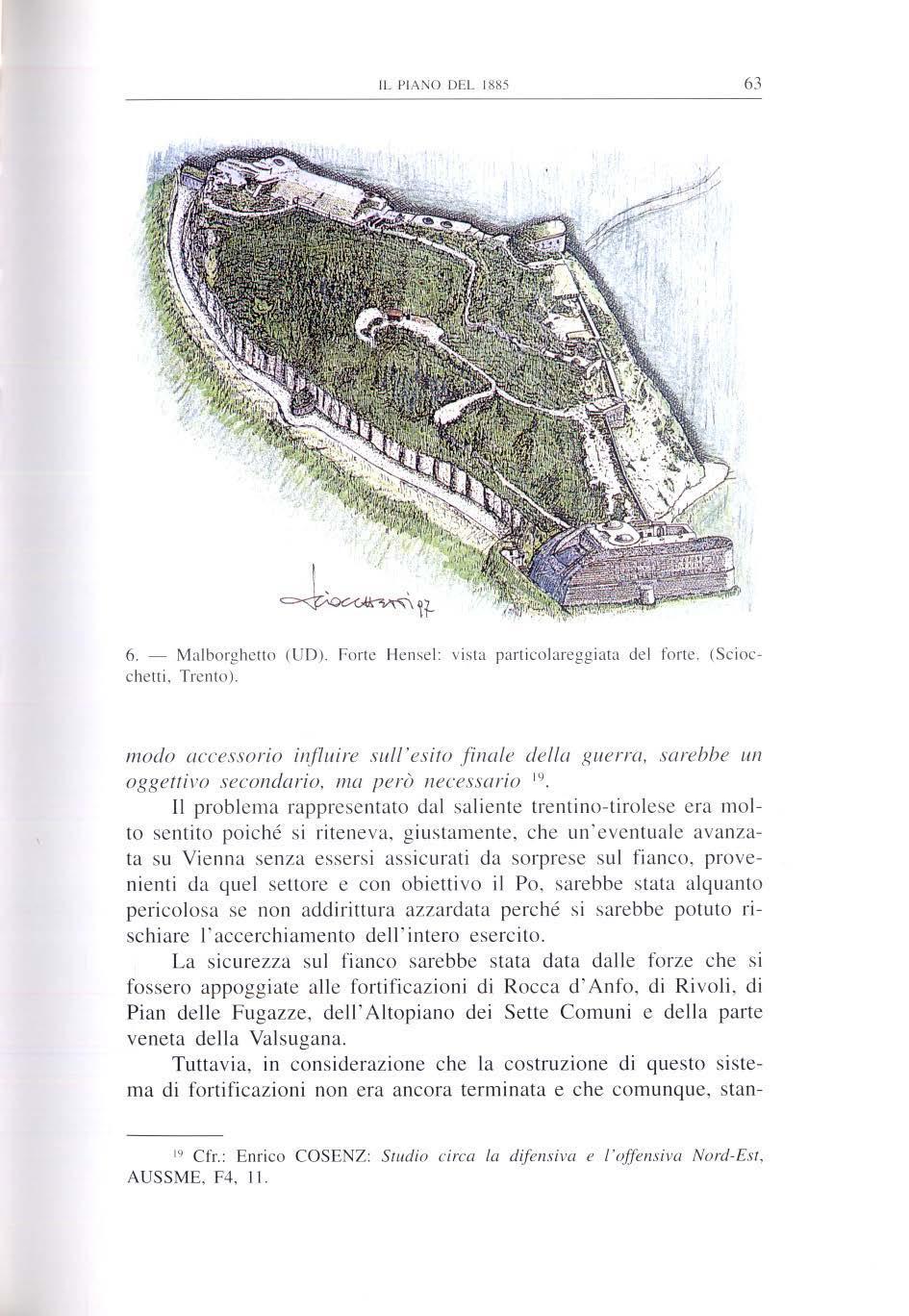
Il problema rapprese ntato da l sai ie nte t re n ti no - t iro lese era molto se nt ito po ic hé si r ite neva. g iu sta m e nt e, c he un ·eventuale avanzata s u V ie nn a se nza esse rs i assic urati da so rprese su l f ia nco, p roveni e nti da q ue l se t to re e con ob iettivo il Po. sarebbe stata a lq uanto pe ri co losa se non addir ittura azza rd ata pe rc hé s i sa rebbe potuto r isc hi are l'acce rc hi a m e nto de ll 'i nt e ro ese rc it o
La s ic urezza s ul fia nco sa reb be s t a t a data d a lle fo r ze c he si fossero a p pogg ia te a ll e fo rt ificaz io ni d i R occa d' A n fo, d i Ri vo li . di Pi a n d e ll e F ugazze, de ll 'A lto pian o d e i Se tt e Co muni e de ll a pane ve neta de l la Va ls uga na .
Tutta v ia . in c o ns id eraz ione c he la cos truz io ne di qu es to s is tema di fo rtifi caz io ni non era a ncora te rmin a t a e c h e co munqu e, s t an -
te la grande estensione del fronte da prl!sidiare. sarebbe staro necessario impiegare una notevole entità di forze. si rit eneva più proficuo impiegare tali forze per la co nquista del Tirolo meridional e garantendosi un miglior controllo del d elicato '>Cttore con un numero inferiore di unit t1 a tutto va ntagg io del teatro principale. Per ottenere l o scopo prefis sa to sarebbe stato necessario occupare, ini;ialmentc. l'altipiano di Lavaronc e la co nca di Dobbiaco: eia quest'ultima posi,i:ione procedere all' espug nai'ion e del 1•opera forti ficara di Fortcaa w (in tede sco Franzensfeste) ed al l 'occupazione della conca di Boli:ano (Bozen in tedesco) per passare. quindi. alr accen.:hiamenro del campo trincerato di Trent o. a cui prenderebbero pane anche le forze radunatesi in Valtellina, Valcamonica e Valsabbia. che agirebbero in c hiave offensiva non appena fossero in condizione di operare in tal senso.
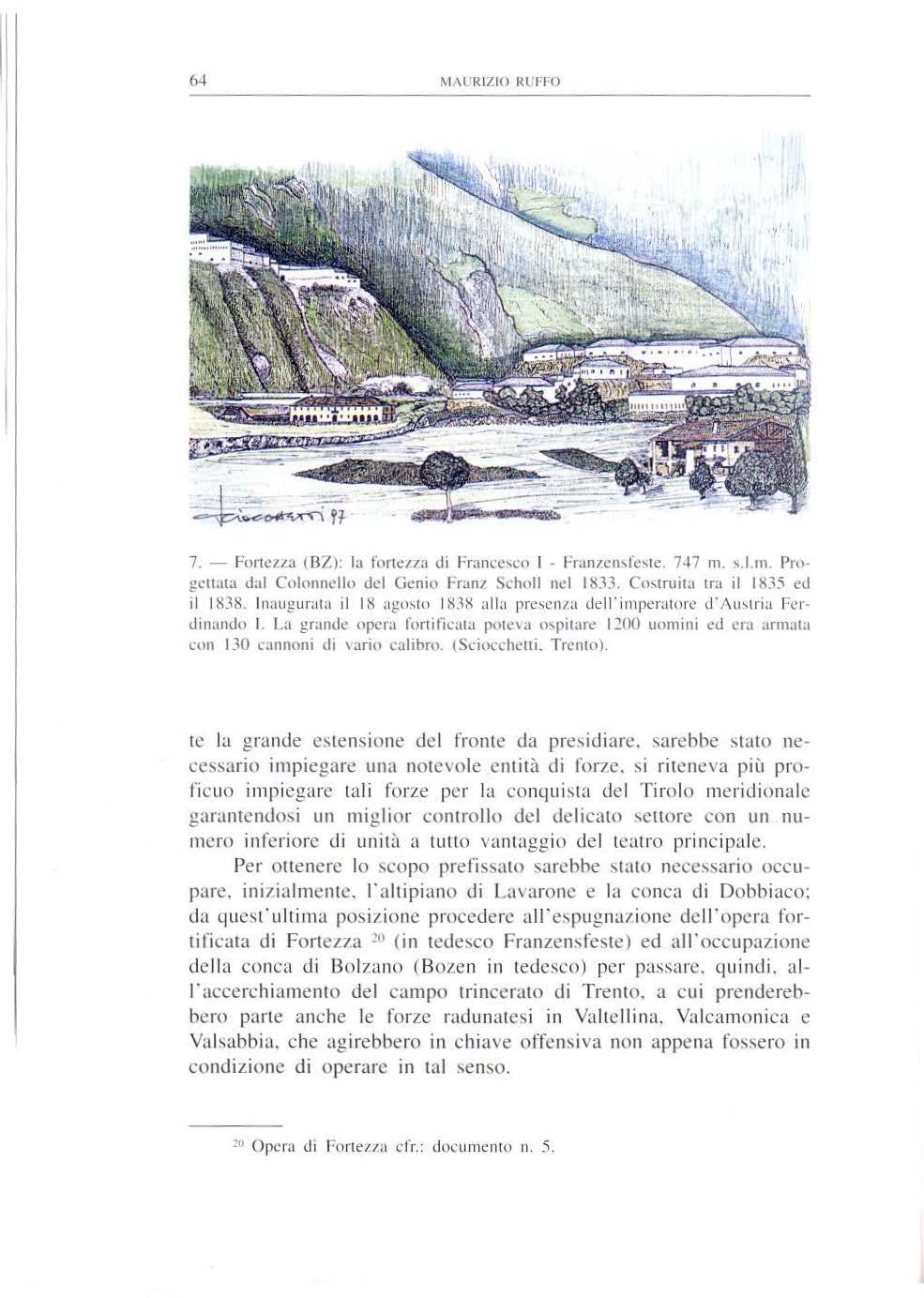
In caso di insuccesso delle opera7ioni offensive il livello cli for tifi cazioni. esistenti nel settore . garantirebbe una notevole s icurezza per la possibilità di appoggiarsi ad esse e contrastare con efficacia la controffensiva nemica: so lo i I so tlo settore cadorino avrebbe richiesto un certo numero di forze per impedire uno sbocco nella pianura veneta.
Dopo aver provveduto alla sicurena nel settore trentino-tirolese. il grosso del t 'eserc ito sa rebbe stato impiegato su li 'Isonzo per superare il nucleo principale delle forze avversarie. In questo caso sa rebb e stato tuttavia indispensabile assicurare i t fianco si nistro da possibili controffensive imperiali provenienti da T arvi<;io a11rave r so la valle del Fclla.
Gli obiettivi immediati da raggiungere sarebbero stati fissati. rispe11ivamente nella conca di Lubiana, attraverso il Carso, e n e lla conca di Klagenfun. attraven,o Tarvisio ed il passo del Predii.
Poiché i due scacchieri sono legati tra loro dalle vie di comunicazione che cor ron o lungo la val le della Sava e la catena del Karavanka ' 1• lo studio prevedeva di spingere rapidamente forze considerevo li a Krainbur g. allraverso Tolmino. per intercetlare ques ti assi di comunica7ione e separare le forLe avversarie: inoltre ques te forze. fiancheggiando s ull a sinistra le unità destinate ad operare sul Carso, avrebbero potuto concorre re alrespugnazione delle difese frontali dell'avversario su llo s tesso Ca rso avvolgendole sul toro fianco de<;tro.
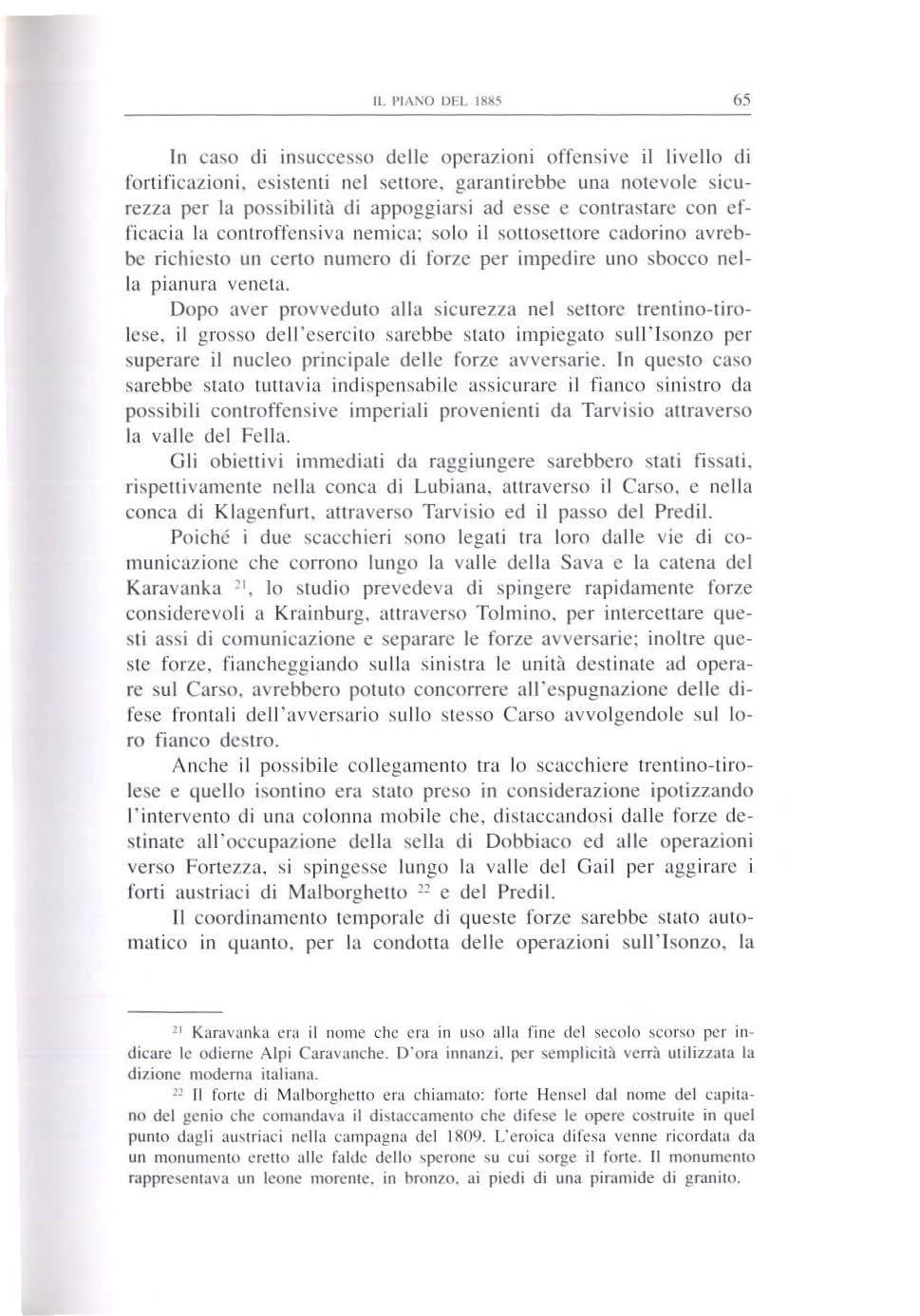
Anche il poss ibile co lle ga mento tra lo scacchiere trentino-tirolese e quello isontino era stato preso in considerazione ipotiZ7ando l ' interv e nto di una co lonna mobile c he. distaccandosi dalle forze desti nat e all'occupa7ione della sella di D obbiaco cd alle operazioni verso Fortezza, si s pin gesse lungo la valle de l Gail per aggirare i forti austriaci di M alborg h elto n e del Predii.
Il coordinamen to te mporale di queste forze sa rebbe stato automatico in 4uanto. per la condotta delle operaLioni su ll"Isonzo. la
'
1 Karavanka crn il nome che era in uso al la fine de l seco lo scorso per indicare le odierne Alpi Caravanche. D"ora innanzi. per semplicità verrà utiliuata la di1ione moderna italiana.
ii Il forte di Malborghcno era c hi amato: forte H ensc l dal nome de l capitano del genio che comandava il distaccamenlO che difese le opere coMruite in quel punto dagli atP,l ri aci nella campagna del I 809. L'eroica difesa venne ri corda ta da un monumento cretto al le fa lde dello ~perone su cui sorge il forte. Il monumento rappre~entava un Icone morente. in bronzo. ai piedi di una piramide di granito.
maggior parte dell'esercito avrebbe dovuto essere concentra to nel Friuli e tale concentramento non sarebbe avvenuto se non qualche giorno dopo l'inizio delle operazioni contro i I Trentino; inoltre, per il s uperamento de ll e fortifica z ioni di Malborghetto, di Flitsch e del Pred ii sa reb be stato necessario un ce r to lasso di tempo c he , presumibi Imente, avrebbe permesso alle fo r ze operant i nelle valli della Drava e del Gai! d i concorrere efficacemente alla loro caduta.
Era poi da tenere presente che contro questo sistema fortificato av rebbe potuto operare anche una parte d i quelle forze de s tinate ad operare nella conca di Lubiana le quali. raggiu nto l'obiettivo di Krainburg-Lubiana e non potendo procedere verso Vienna finché l'avversario era in possesso della co nca di Kl agenfu r t, avrebbero risa lito l'alta valle della Sava in direzione di Wulzen e Tarvisio.
La conquista, ad opera del la 2" armata, degli sbarramenti di Malborghetto e del Predii veniva pertanto ad assumere un'importanza decisiva se si conside r ava che, in caso di neces sità. la ritirata di g ran parte d elle forze a ust ri ache da l Carso sarebbe avvenuta s ull a conca di Kl age nfurt , attrave rso i pass i delle Alpi Caravanche. ed un 'azione d ell'ala destra itali ana in d irezio ne d i Klagenfurt attraverso le Alpi Caravanc he avrebbe comportato dei grossissimi rischi se non s i fosse avuta la possibilità di una rapida apertura delle com unica z io ni dirette tra K l agenfurt cd il Friuli a tt raverso Pontebba ed il Pred ii.
L 'az ion e congegna t a prevedeva un 'azione d iretta contro le fortificazi o ni d a parte delle fo r ze operanti lun go la va l Fella, un 'agg ir a m e nto da Nord -Ov es t da parte delle forze provenienti d al Ti rolo lun go le va lli d e l Gail e de ll a D rava ed un'aggiramento da Sud con le forze che ri saliva no l 'alta va lle della Sava.
In seg uito a que s t o piano le truppe della difesa a ttiv a de i forti sare bbero s tate costrette a ritirarsi abbandonando li a ll a so la difesa passiva.
Con una si mil e operazione tutt e queste forze concorrerebbero non solo al superamen to degli s barram enti fortificati dell'alta va ll e d e l Fella, ma all'occupazione d e lla cittadina di Villach c he rapp r esenta il Iato più debole de ll a piazzaforte d i Kl age nfurt.
U n 'a ltra operazione fondamentale da affidare ali 'ala d es tra con il s upporto dell'azione d e ll a squ a dra nava le e ra costituita, un a volta che le unità fossero penetrate ne l Carso, dall'occupazione cli Tri es te ; città che, oltre a ll 'a lti ss imo s ig nificato politico che rappresentava, costituiva un porto dalle enormi potenzialità in grado di svolgere un'indi s p e n sa bil e azione logi s tica a favore delle forze operanti in una region e poverissima come è il Carso.


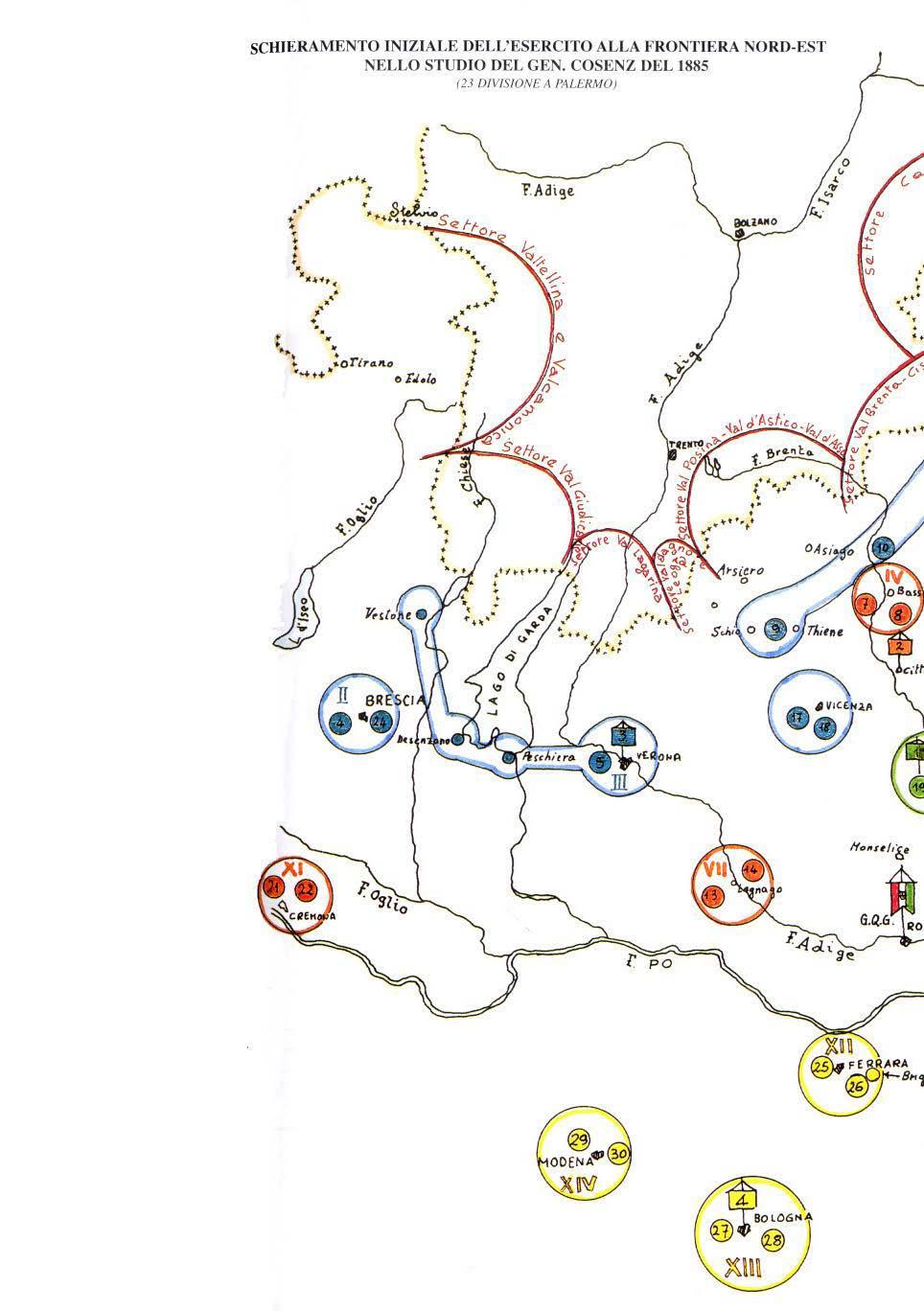
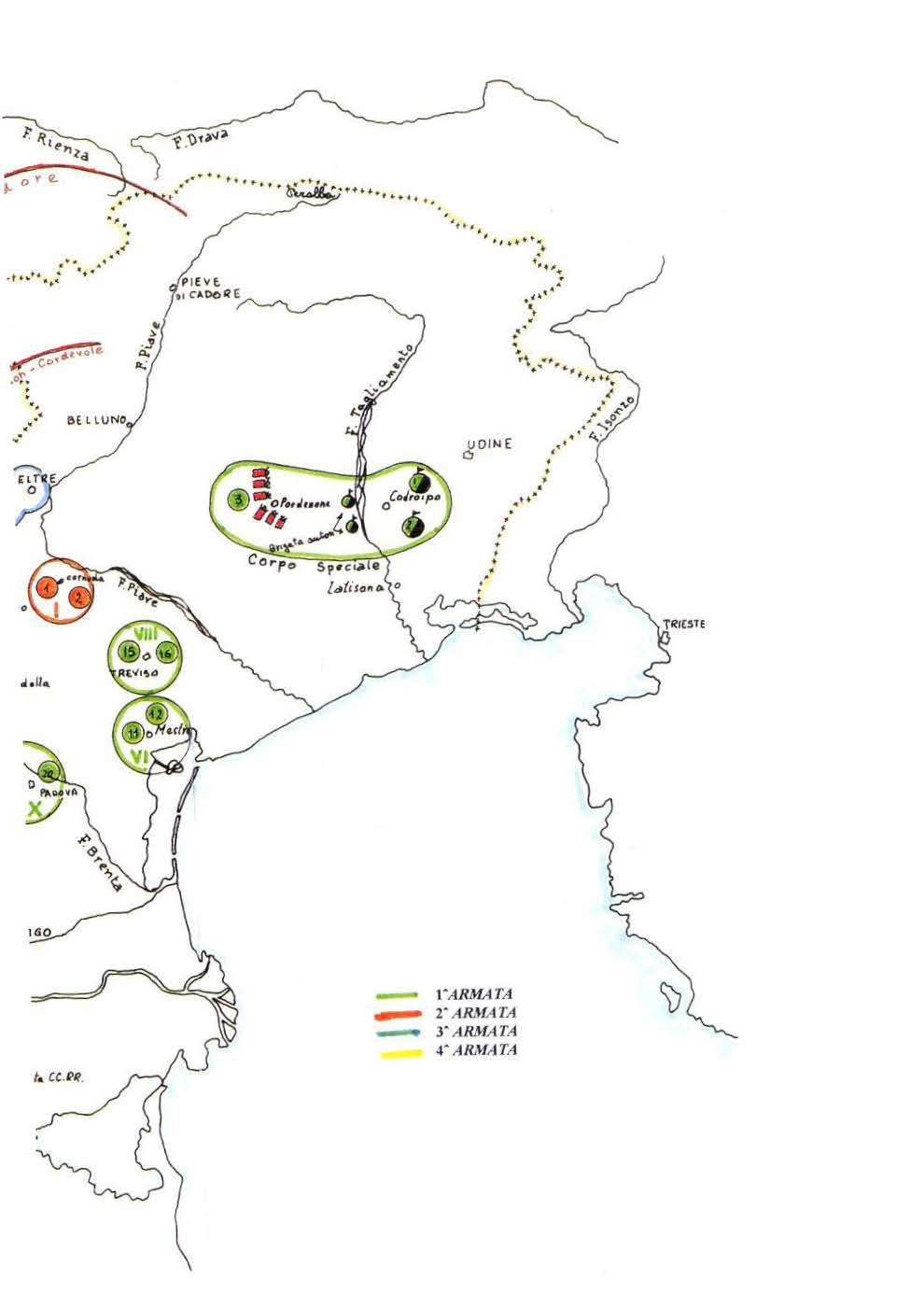

Inoltre, ne!J 'eventualità che una controffensiva austriaca riuscisse a sopraffare le forze operanti contro i forti dell'alta va lle del Fella ed a sfocia re nella pianura friulana , l'esistenza di una base log ist ica del! 'importanza del porto di Trieste permetterebbe alle forze sc hierat e su l Carso di essere al imen tate e di operare contro le forze penetrate in Friuli chiudendole, in cooperazione con le forze provenienti dal Tirolo, in una gigantesca tenaglia.
Superate le fortificazioni di Malborghetto e del Predii ccl occupata Villach, sarebbe stato compito delle forze operanti contro Kla genfurt agevolare alla destra dell ' esercito il supera mento delle Alpi Caravanche minacciando, per la sponda destra della Drava , il rovescio del passo cli Loebel.
Ra ggiunto questo risultato, il centro avrebbe dovuto marciare, attraverso l 'ab itato di Feldkirchen, verso il fronte Klagenfurt - St. Veit, mentre l'ala destra, pur controllando la conca cli Lubiana, s i sarebbe portata in posizione idonea per investire da Sud, con la maggior parte delle s ue forze, la piazzaforte di Klagenfurt.
Conquistata questa posizione il centro e la destra si sarebbero portate s ul fiume Mur tra Loben, Bruck, Gratz e Lcibnitz da dove proseguire direttamente su Vienna.
Per essere in grado di attuare queste ipotesi di operazioni offensive era altresì necessario introdurre alcune modifich e nella formazione di guerra dell 'csercito ed in particolare nella composizione delle singole armate.
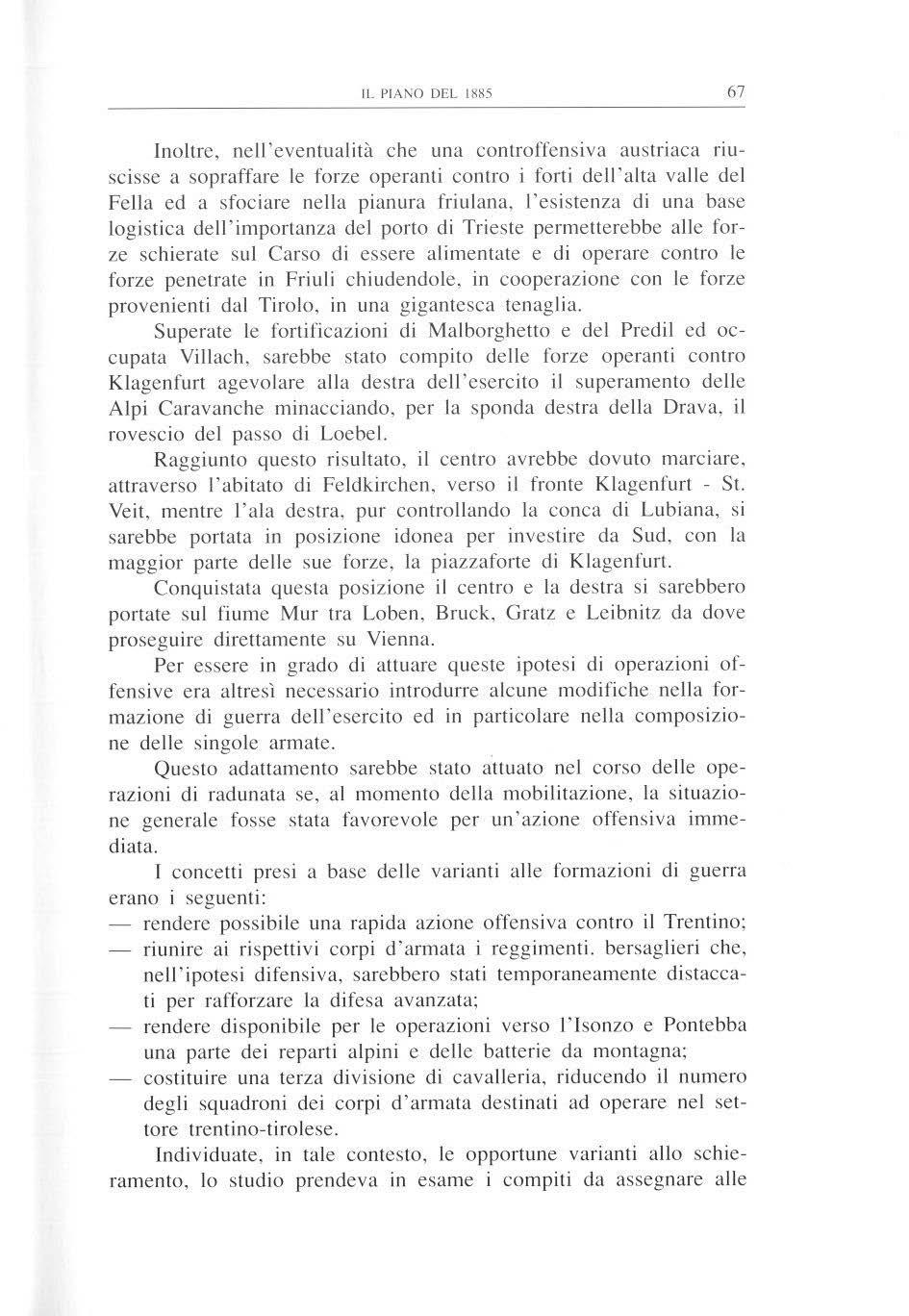
Ques to adattamento sa rebbe stato aùuato nel corso delle operazioni di radunata se, al momento della mobilitazione, la s ituazione generale fosse stata favorevole per un'azione offensiva immediata.
T concetti presi a base delle varianti alle formazioni di guerra erano i seguenti:
rendere possibile una rapida azione offensiva contro il Trentino ; riunire ai rispettivi corpi d'armata i reggimenti. bersaglieri che, nell'ipotesi difensiva, sarebbero s tati temporaneam en te distaccati per rafforzare la difesa avanzata; rendere disponibile per le operazioni verso l'lsonzo e Pontebba una parte dei reparti alpini e delle batterie da montagna; costituire una terza divisione di cavalleria, riducendo il numero degli squadroni dei corpi d'armata destinati ad operare nel settore trentino-tirolese.
Individuate, in tale contesto, le opportune varianti allo schieramento, lo studio prendeva in esame i compiti da assegnare alle
singole armate: la I a e la 4", formate ciascuna da quattro corpi d'armata e da una divisione di cavalleria, avrebbero dovuto operare sul basso I sonzo; la 2", composta da tre corpi d'armata ed una divisio ne di cavalleria, lun go le direttrici Pontebba e Predii in direzione di Klage nfurt ed infine la 3~, comprendente quattro corpi, con obiettivo l 'occupazione del Trentino e del Tirolo.
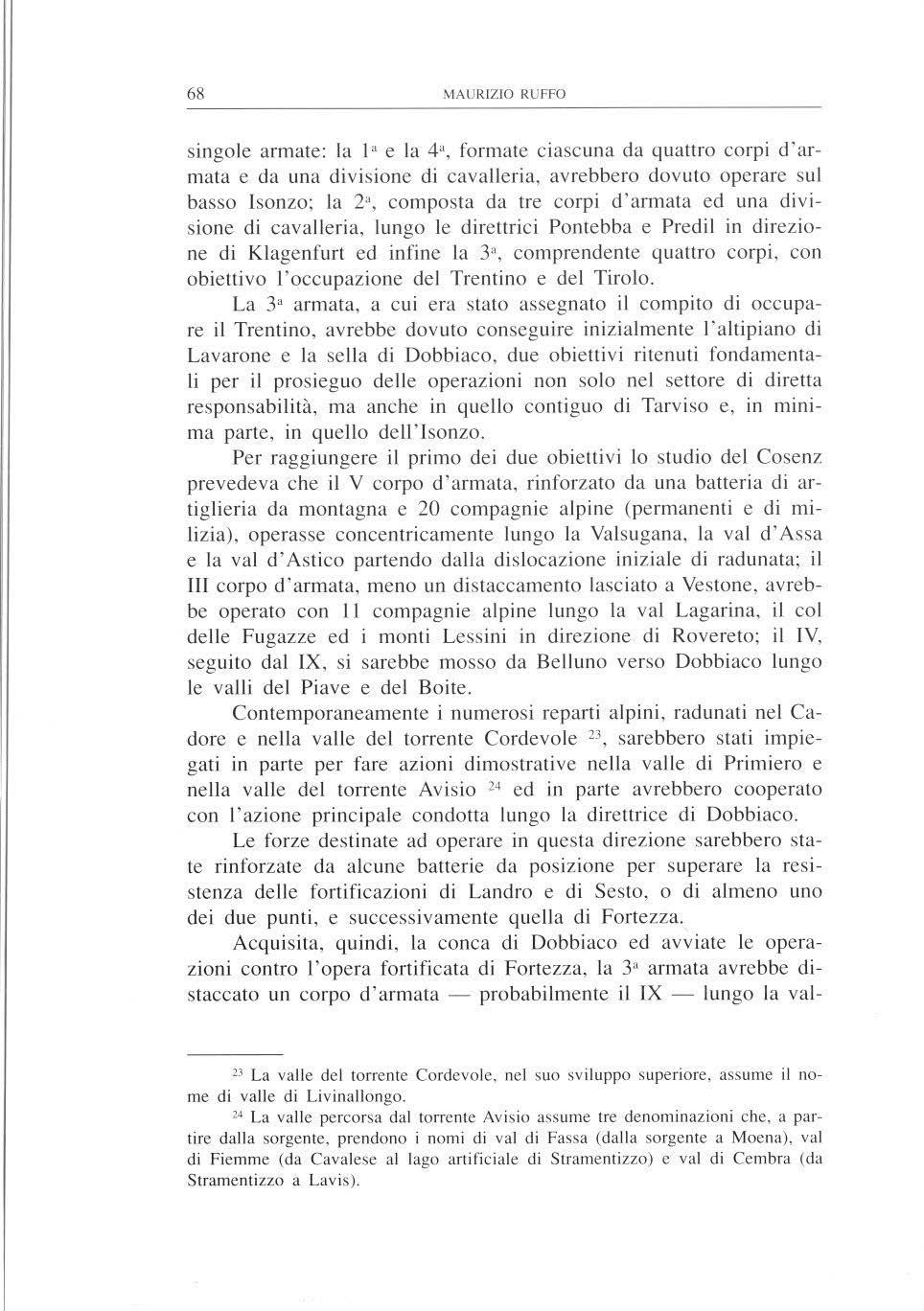
La 3" armata, a cui era stato assegnato il compito di occupare il Trentino, avrebbe dovuto conseguire inizialmente l 'altipiano cli Lavarone e la sella cli Dobbiaco , due obiettivi ritenuti fondamentali per il pro sieg uo delle operazioni non solo nel settore di diretta responsabilità, ma anche in quello contiguo di Tarviso e, in minima parte, in quello dell'Isonzo.
Per raggiungere il primo dei due obie1tivi lo studio del Cosenz prevedeva che il V corpo d'annata, rinforzato da una batteria di artiglieria eia montagna e 20 compagnie alpine (permanenti e di milizia), operasse concentricamente lungo la Valsugana, la val cl' Assa e la val d' Astico partendo dalla dislocazione iniziale di radunata; il III corpo cl ' armata, meno un distaccamento lasciato a Vestone, avrebbe operato con 11 compagnie alpine lungo la val Lagarina , il col delle Fugazze ed i monti Lessin i in direzione di Rovereto; il IV, seguito dal IX , si sa rebbe mosso da Be llun o verso Dobbiaco lungo le valli del Piave e de l Boite.
Contemporaneamente i numerosi reparti alpini, radunati nel Cadore e nella valle ci e l torrente Cordevole 23 , sarebbero s tati impiegati in parte per fare azioni dimostrative nella valle di Primi ero e nella valle ciel torrente Avisio 24 ed in parte avrebbero cooperato con l'azione principale condotta lun go la dire ttrice di Dobbiaco.
Le forze destinate ad operare in que sta direzione sarebbero state rinforzate da alcune batterie da pos izione per s uperare la resis tenza delle fortificazioni di Landro e di Sesto, o di almeno uno dei due punti, e s uc cessivamente quella cli Fortezza.
Acquisita, quindi, la conca di Dobbiaco ed avviate le operazioni contro l ' opera fortificata di Fortezza , la 3a armata avrebbe dis taccato un corpo d'armata - probabilmente il IX - lungo la val-
23 La valle del torrente Cordevo le. nel suo sv iluppo s upe riore. assume i l nom e di valle di Livinallongo.
24 La va ll e perco rsa da l tor re nte Avisio assume tre denominazioni che, a partire dalla so rgente, prendono i nom i d i val di Fassa (da lla so rgen te a Moena), val d i Fi e mm e (da Cavalese a l lago artificiale di Stramentizzo) e val di Ce mbra (da Strame nti zzo a Lavi s).
le della Drava cd una colonna leggera lungo quella ciel Gai! per concorrere, da Nord-Ovest, alle operazioni della 2" armata in direzione di Tarvisio.
Alle forze dell'armata, schierate tra il passo dello Stelvio ed il lago di Garda, sarebbe stato affidato il compito di attirare l'attenzione cli una parte delle forze della difesa attiva del campo trincerato di Trento, senza lasciarsi paralizzare eia piccoli distaccamenti avversari e di concorrere, in un secondo tempo, all'accerchiamento dello stesso.
A tal fine si sarebbe potuto rinforzarle con unità della milizia mobile tratte dai presidi delle piazzeforti dell'interno.
Il compito successivo della 3• armata sarebbe stato l'espugnazione delle fortificazioni che costituivano il campo trincerato di Trento; all'uopo le sarebbe stato assegnato un parco d ' assedio.
La l ", 2• e 4" armata, approfiltanclo delle prime operazioni in atto da parte della 3", si schiererebbero fra il Tagliamento e l'Isonzo effettuando il movimento parte per via ordinaria e parte con i trasporti ferroviari, disponendosi sul terreno in modo tale che la 4 • armata costituisse l'ala destra e la l " il centro; la 2• armata, destinata ad operare in maniera specifica in direzione cli Villach costituirebbe l'ala sin istra del grosso delle forze.
Lo schieramento cli quest'ultima grande unità potrebbe essere modificato se , mobilitazione e radunata durante, il comando supremo, a seguito del flusso di notizie in arrivo sulla dislocazione delle forze avversarie, intuisse che gli austriaci lasciassero poche truppe a difesa degli abitati cli Villach e di K lagenfurt preferendo concentrare le forze sul bas so Isonzo; in tale caso solo una parte dell'armata sarebbe utilizzata a protezione ciel fianco sinistro mentre la massa sarebbe tenuta a disposizione per concorrere, in caso cli necessità, alle operazioni della t• e della 4" armata.
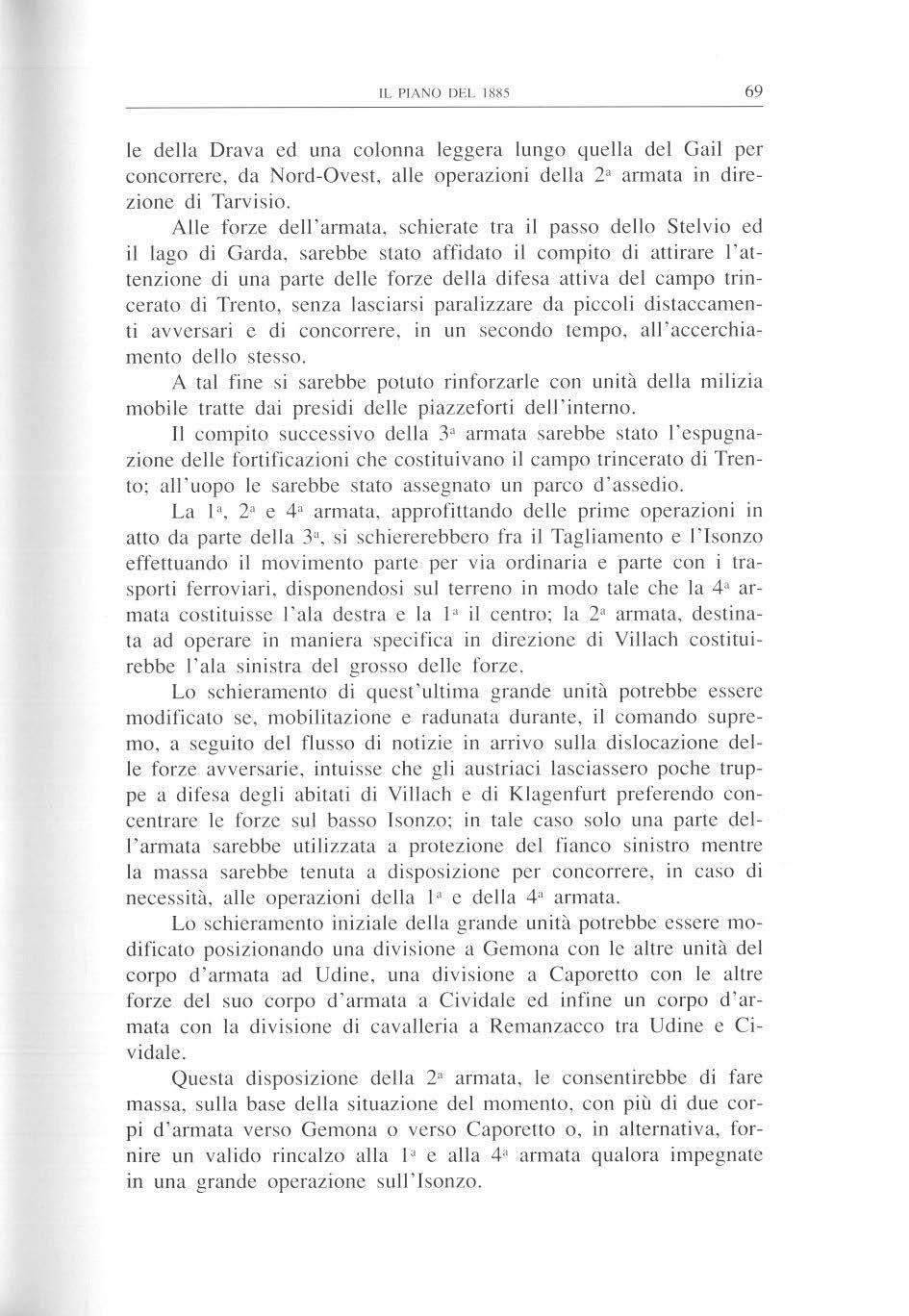
Lo schieramento iniziale della grande unità potrebbe essere modificato posizionando una divisione a Gemona con le altre unità del corpo d'armata ad Udine, una divisione a Caporetto con le altre forze del suo corpo d ' armata a Cividale ed infine un corpo d'armata con la divisione cli cavalleria a Remanzacco tra Udine e Cividale.
Questa disposizione della 2• armata, le consentirebbe di fare massa, sulla base della situazione del momento, con piì:i di due corpi d'armata verso Gemona o verso Caporetto o, in alternativa, fornire un valido rincalzo alla I • e alla 4 • armata qualora impegnate in una grande operazione sull ' Isonzo.
Inoltre l'ottimo svi lu ppo delle vie di comunicazione avrebbe agevolato gli spostamenti delle singole divisioni con la so la eccezione di Caporetto dove l'esisten za di una sola via avrebbe permesso l'afflusso di una divisione per volta.
Anche lo schieramento della l a e della 4" annata sarebbe stato agevolato dalla ricchez za delle comunicazioni ro tabili e dalla natura stessa del terreno, tanto che era anche parso opportuno presupporre che l'avversario, anziché accettare battaglia sul basso Isonzo, s i attestasse in una posizione più arretrata ali' interno del Carso, per esempio lungo la fronte Prawald - Zoll.
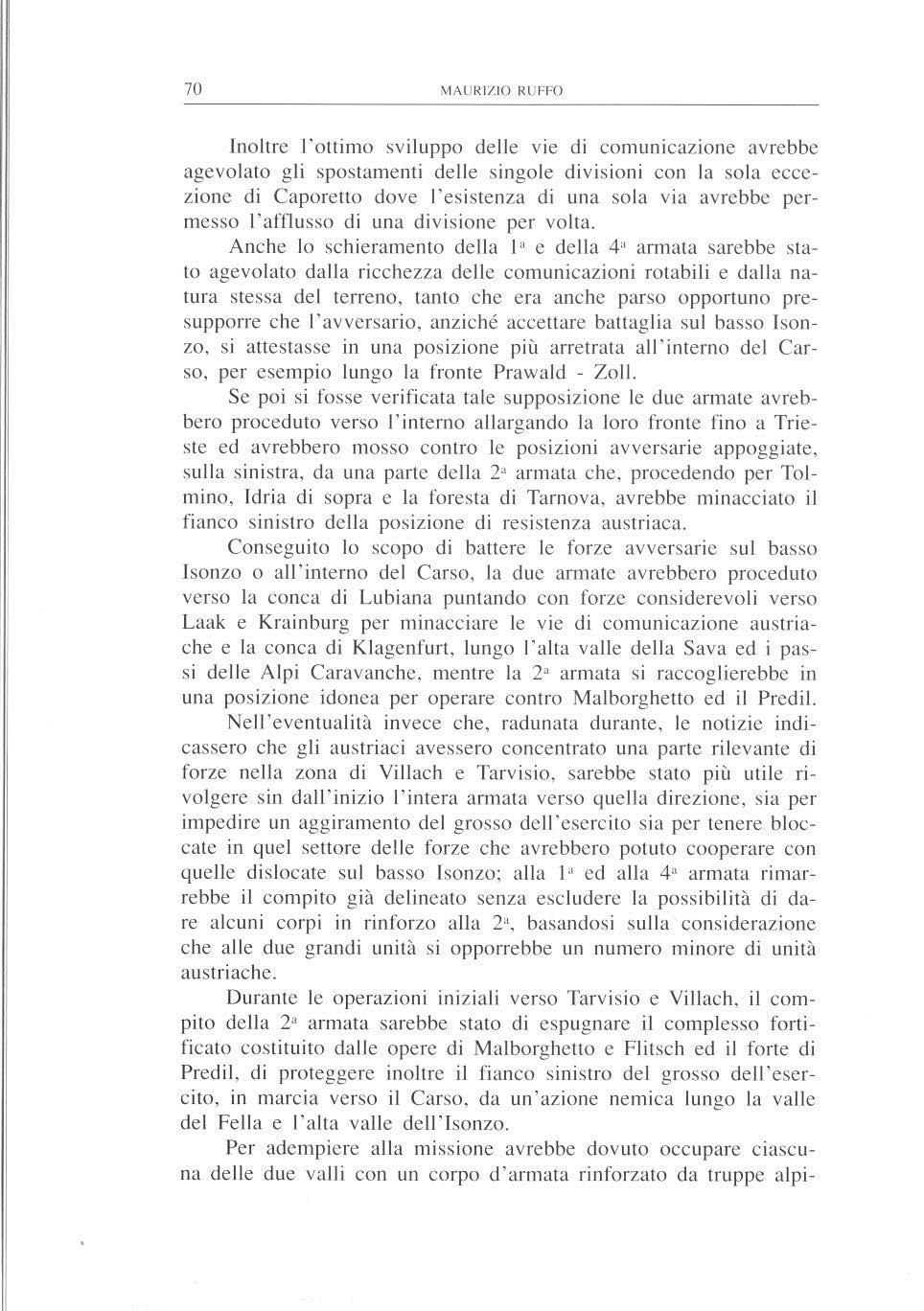
Se poi si fosse verificata tale s uppo siz ione le due armate avrebbero proceduto verso l ' interno allargando la loro fronte fino a Trieste ed avrebbero mo sso contro le posizioni avversarie appoggiate, s ull a sinistra, da una parte d e lla 2' armata che, procedendo per Tolmino, Id r ia di sopra e la foresta di Tarnova, avrebbe minacciato il fianco sinistro della posizione di resistenza austriaca.
Conseguito lo scopo di battere le forze avversarie s ul basso Isonzo o all'interno del Carso, la due armate avrebbero proceduto verso la conca di Lubiana puntando con forze considerevoli verso L aak e Krainburg per minacciare le vie di comunicazione austriache e la conca di Klagenfurt, lungo l'alta valle della Sava ed i passi delle Alpi Caravanche, mentre la 2" armata si raccoglierebbe in una posizione idonea pe r operare contro Malborghetto ed il Predii.
Nell'eventualità invece che, radunata durante , le notizie indicassero che gli austriaci avessero concentrato una parte rilevante di forze nella zona di Vi ll ach e Tarvisio, sarebbe s tato più util e rivolgere sin dall'inizio l'intera armata verso quella direzione, sia per impedire un aggiramento de l grosso dell'e serc ito s ia per tenere bloccate in quel settore delle forze che avrebbero po tut o cooperare con quell e dislocate sul basso I sonzo; alla l " ed alla 4 " armata rimarrebbe il compito già delineato se nza esc lu dere la possibilità di dare alcuni corpi in rinforzo a ll a 2", basandosi sulla considerazione che al le due grandi unità si opporrebbe un numero minore di unità austriache.
Durante le operazioni ini z iali verso Tarvisio e Villach, il compito della 2" armata sarebbe stato di espugnare il complesso fortificato costit ui to dalle opere di Malborghetto e Flitsch ed il forte di Predii, di proteggere inoltre il fianco sinistro del grosso dell 'esercito, in marcia verso il Carso, da un 'azione nemica lun go la valle del Fella e l'alta va ll e d e ll'Isonzo.
Per adempiere alla missione avrebbe dovuto occupare ciascuna delle due valli con un corpo d 'a rmata rinforzato da truppe alpi-
ne e provvisto dei mezzi necessari per attaccare con s uccesso gli sbarramenti, respingere le forze della difesa attiva avversaria e collegare tra di lor o le due unit à occupando i valloni di Dogna e della R acco lana e d il co ll e di Prevalle su Nevea.
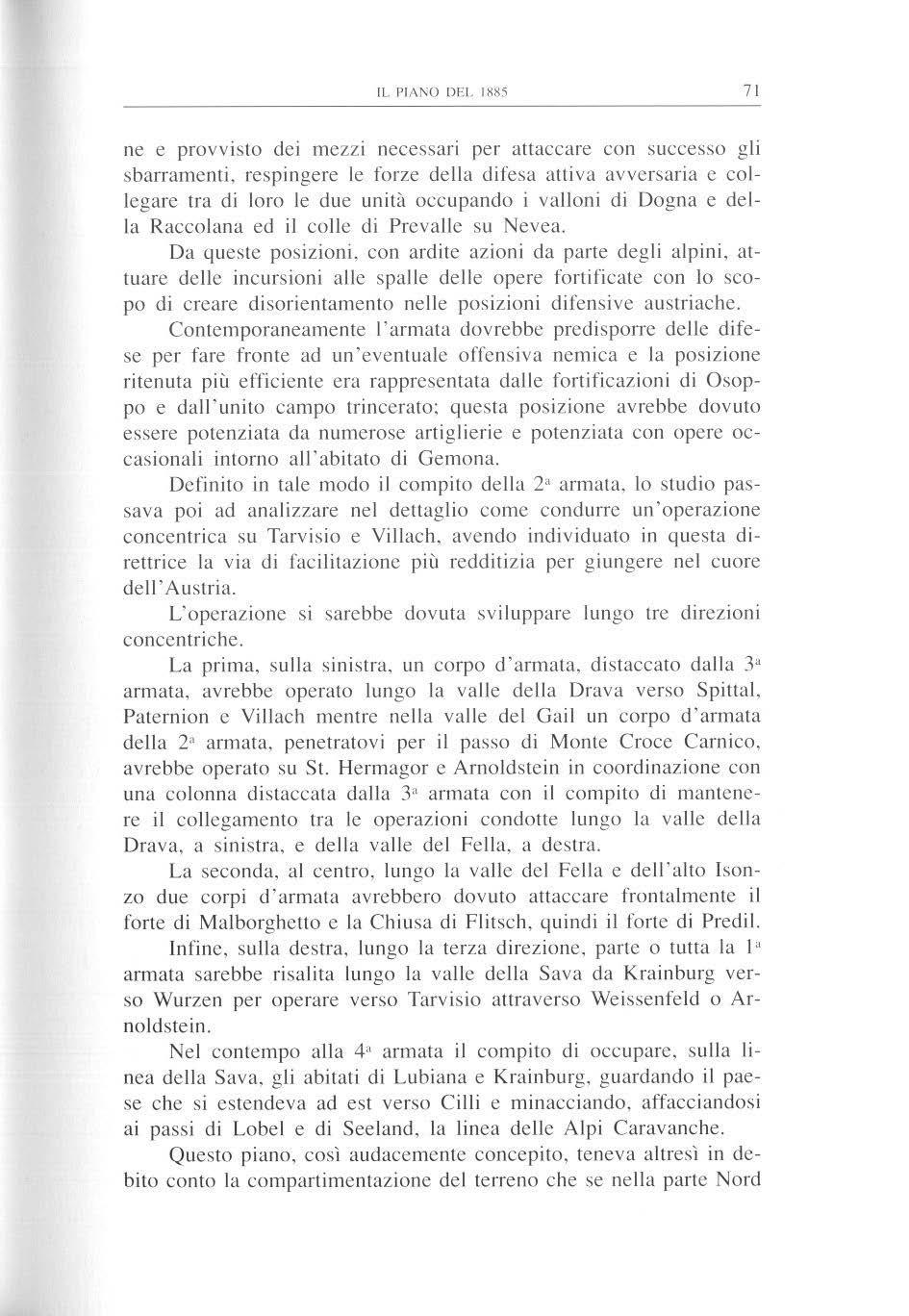
Da queste posizioni. con ardite azio ni da parte degli alpini, a ttuare delle in cursioni alle spa ll e delle ope re fortificate con lo scopo di creare disorientamento nel le posizioni difensive austriache . Contemporaneame nte l ' armata dovrebbe predisporre delle difese per fare fronte ad un 'even tuale offensiva nemica e la posizione ritenuta più effic ie nt e era rappresentata dalle fort ifi caz ion i di Osoppo e dall'unito campo trincerato; questa posizione av rebbe do v ut o esse re potenziata da numerose artig li erie e potenziata co n opere occasio na li intorno a ll' abitato di Gemona.
Definito in tale modo i I compito della 2" arma ta , lo studio passava poi ad ana li zza re nel dettaglio come condurre un'operaz ion e concent ric a s u Tarvisio e Villach. avendo individuato in questa direttrice la via di facil it az ione più redditi z ia per g iun gere nel cuore del l 'A ust ri a .
L'operazione si sarebbe dovuta svi luppar e lungo tre dire zion i concentriche
La prima, s ulla sin is tra , un corpo d'armata, distaccato dalla 3" armata, avrebbe operato lu ngo la va ll e del la Drava ve rso Spittal, Pate rnion e Villach ment re nella va ll e del Gail un corpo d'armata della 2• armata, penetratov i per il pa sso di Mont e Croce Carnico, avrebbe operato su St. H e rma gor e Arnolclstein in coo rdinazione con una co lonn a distaccata d alla 3• ar mata con il compito di mantenere il collegamento tra le operazioni co ndott e lungo la va ll e della Dra va, a s ini s tra , e de lla valle del Fella, a d es tra.
La seco nda. al centro, lun go la valle ci el Fella e dell'alto Iso nzo due corpi d 'a rmata avrebbero dovuto attaccare frontalmen te il forte di Malborghe tto e l a Chiusa di Flitsch , quindi il forte di Predii.
Infine , s ull a de s tra, lun go la te rza direzione. parte o tutta la I " armata sa rebbe ri s alita lungo la valle della Sava da Krainburg verso Wurzen per operare verso Tarvisio attraverso Weissenfeld o Arnold ste in.
Nel conte mp o alla 4" armata i I compito di occupare, s ull a linea della Sava, g li abitati di Lubiana e Krainburg, g uard ando il paese che si es ten deva ad est verso Cilli e min acc iando, affacciandosi ai passi di Lobel e di Seeland, la lin ea delle Alpi Caravanche.
Questo piano, così audacemente concepito, teneva altresì in debito conto la compartimentazione de l te rreno c he se nella part e Nord
del fronte d'attacco - valli della Drava, del Gail e del Fellapermetteva un facile travaso di forze, non altrimenti per quello Sud dove passare dalla valle del Fella a quella d e lla Sava, senza avere prima acqu1s1to il controllo della rotabile del Pre dii, avrebbe comportato un giro di ben 230 km corrispondenti a 11-12 giornate di marcia.
Tuttavia essen do l'ala de stra composta da due armate e co ns iderando che se le operazioni fossero giun te a quel punto, si poteva s upporr e che dispon essero di forze suffic ien ti pe r fronteggiare ogni situazione operativa.
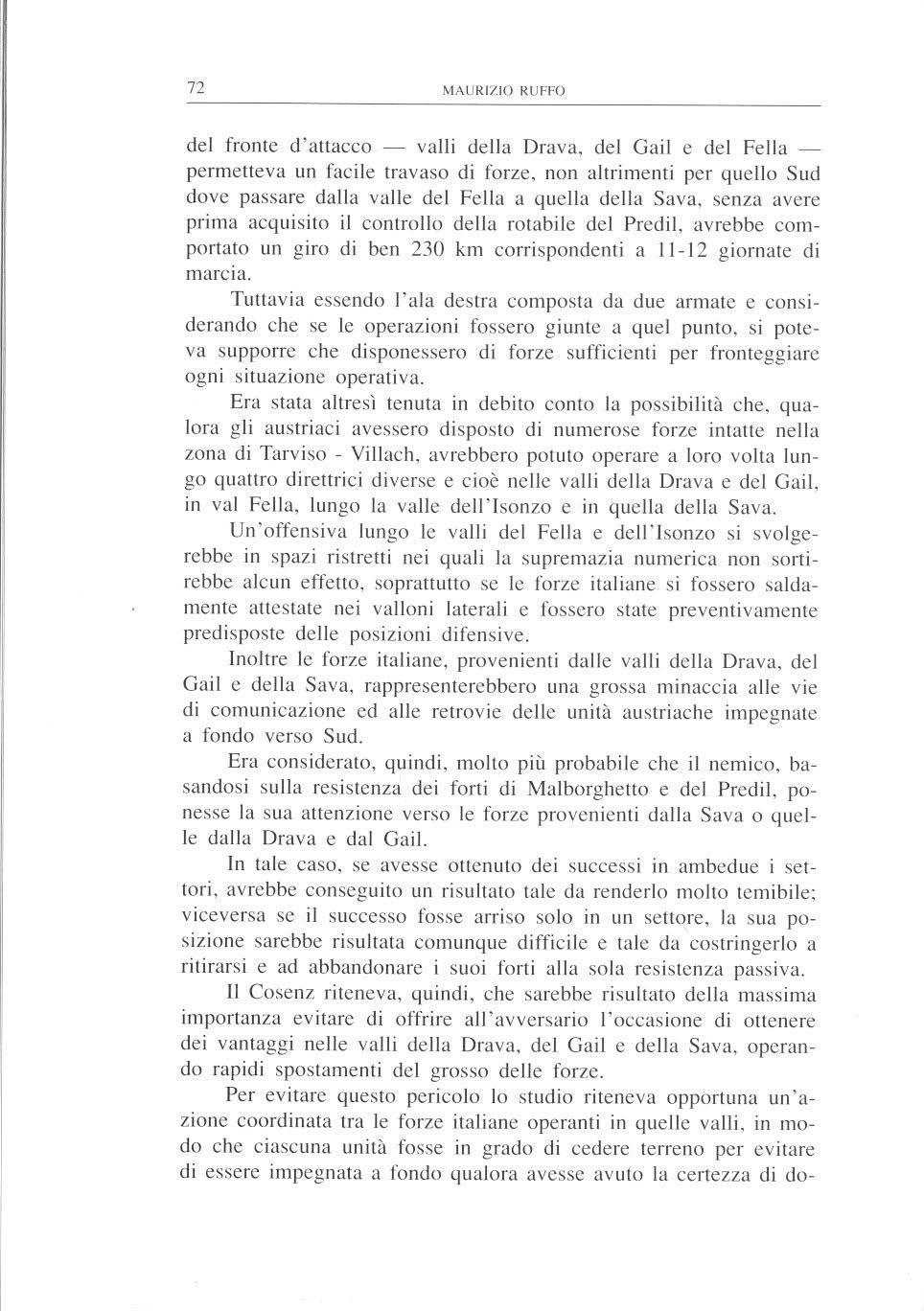
Era s tata altresì tenuta in d e bito conto la possibilità che, qualora gli austriaci avessero di spos to di numerose forze intalle nella zo na di Tarvi so - Villach, avrebbero potuto operare a loro volta lungo quattro direttrici diverse e cioè nelle valli d ella Drava e ciel Gai!, in val Fella, lungo la valle dell ' Tso nzo e in qu e lla d e lla Sava.
Un'offensiva lun go le valli del Fella e dell ' I sonzo s i svo lgerebbe in spazi ri s tretti nei quali la supremazia num e ri ca non sortirebbe alc un efferto, so prattutto se le forze italiane s i fossero saldamente attestate nei valloni laterali e fossero state preventiv ame nte predi s poste d e lle pos i zioni difensive.
Inoltre le forze italiane, provenienti dalle valli d e lla Drava , del Gail e d e lla Sava, rappre se nterebb ero una grossa minaccia alle vie di comunicazione cd alle retrovie delle unità a us triache impegnate a fondo verso Sud.
Era considerato, quindi , molto più probabile che il ne mico, basa ndosi s ulla re s i s ten z a dei forti di Malborghetto e del Predii, pone sse la s ua attenzione verso le forze provenienti dalla Sava o quelle dalla Drava e dal Gail.
In tale caso, se ave sse ottenuto dei s ucce ssi in ambedue i settori , avrebbe conseguito un ri su ltato tal e da renderlo molto te mibile; viceversa se il successo fosse arri so solo in un settore, la s ua posizione sare bbe risultata comunque difficil e e tal e da costringerlo a ritirarsi e ad abbandonare i suoi forti alla so la resistenza pass iva ll Cosenz riteneva, quindi , che sarebbe ri s ultato della massima importanza e vitare di offrire all'avversario l'occasione di ollenere dei vantaggi nelle va lli de lla Drava , del Gai! e della Sava, operando rapidi spos tamenti del grosso delle forze.
Per evitare que sto pericolo lo st udio ritene va opportuna un'azio ne coordinata tra le for ze italiane operanti in quelle valli, in modo che ciascuna unità fo sse in gra do di cede re terreno per ev itare di essere impegnata a fondo qualora avesse avuto la certezza di do -
ver affrontare forze nettamente s uperiori, tenendo si, nel contempo, in misura di riprendere l'avanzata non appena l 'avve rsario avesse cessato di premere in quella direzione e si fosse orientato, con il grosso delle sue forze, contro l'altra.
Con questo tipo di azione s i sarebbe ottenuto di attirare I 'avversario lontano dal suo centro d'azione e dal le sue lince di rifornimento e di ritirata attraverso Villach, Tarvis io e Feldkirchen, agevolando l'a z ione offensiva delle forze italiane non direttam en te impegnate.
Qualora invece gli austriaci non si fossero allontanati di troppo dalle loro basi cli partenza, que s to tipo cli operare li avrebbe rinserrati in una morsa tale dalla quale avrebbero potuto uscire so lo ritirando s i s u Klagenfurt.
Considerando poi le po ss ibilit~t operative offerte dalla valle della Sava 25 ri spetto a quelle dell e valli della Drava e d e l G ail era ipoti zzab ile che i I grosso delle forze austriache avrebbe attaccato prioritariamente le unit à di quest'ultime che a loro volta avrebbero dovuto assumere tutte le predisposizioni idonee a fronteggiare con successo la s ituazione.
Per potere operare al meglio secondo i lineamenti sopra descritti il Coscnz riteneva necessario un ottimale sistema informativo che andava dalla raccolta del le notizie , ottenuta uti Iizzando tutti i mezzi a di sposizio ne - attività cli sp ionaggio esplorazione, interro ga tori di prigionieri. disertori e ele menti della popola z ionealla valutazione, a livello s tato maggiore, eia parte degli organi dell'Ufficio militare 26 preposto alla s ucce ss iva traduzione in notizie utili per i comandanti a tutti i livelli.
L'ultima ipote s i presa in considera z ion e riguardava la possibilità che il grosso delle forze nemiche schierate sul Carso, a seguito di un rovescio subito ad opera della l '' e 4 ° armata. si fosse ritirato sugli abitati di Cil li e Marburg. In questo caso, mentre il grosso delle due armate procederebbe ali' inseguimento de ll'avv ersario,
15 La valle della Sava ira Krai nburg e Tanerburg è percorsa da due buone st rade rotabi li e dalla ferrovia; fra Tancnburg e Wur ze n per un tratto di meno di 30 km., da una rolabile e dalla ferrovia che si potrebbe utilinarc come via ord inaria.
21• Ufficio militare: era il servi z io informazioni militari che aveva il comp ilo di rac cog li ere tutte le not izie uti l i per lo svolg imen to d elle operazioni, vag liarle e tradurl e in informa7ion i che venivano diramate, ad orari pre stabiliti. ag l i ahi comandi per metterl i in grado di avere costantcmc111e un quad ro di sit ua z ione il più esalto possibi le: a livel lo armala c'erano, invece, gli Uffici "I".

verrebbe dii.taccato un contingente che, risalendo la Sava, concorrerebbe a ll a caduta dei forti di Malborghetto e del Predii.
Aperto in tal modo l'accesso alla conca di Klagenfurt. la 2 ° armata avrebbe co<,tituito i I perno di una grande conversione del grosso dell'esercito che avrebbe permesso alle forze italiane di ragg iungere il fronte della Drava tra St. Yeit e Marburg scavalcando le Alpi Caravanche.
L'ulteriore offensiva verso il bacino della Mur, e quindi verso Vienna. si sa rebb e svo lta co n modalità uguali in entrambi i casi considerati.
2. L'organizzazione de ll a mobilitazione e d e lla radunata
I piani di mobilitazione e radunata dell'esercito, in v igore n el 1885, erano la diretla conseguenza del la riforma Ricotti de l 187 1 e dei suoi successivi aggiornamenti.
Essi si basavano, principalment e, sulle esperienze maturate nella guerra franco-prus s iana del 1870, dove il sis tema cli mobilitazione e di radunata ebbe una tale influenLa sugli esiti della gue rra da giustificare l'affermazione del capo di s tato maggiore pru-, s iano. von Moltk e, che la mobili!Cl: ione è la guerra.
Su questa problematica si erano concentrate tutte le a11en1ioni degli istituti militari e civili ciel Paese e gli ordinamenti si e rano ispirati al principio c h e quanto pi1ì I' orga11i: : a:io11e d<'lle for:e armate in tempo di f)ace si 01Ticina a quello di guerra. tanto maggior sicure::a si lw di possedere 1111 esercito opera/i\'() hen organi::a to 27
L'applicazione di questi principi implicava ripercu-;sioni e.l'importanza vitale sul reclutamento. l'inquadramento ed il raggruppamento delle forze in tempo cli pace. su ll 'organizzazione delle riserve e su ll 'immediatezza della loro disponibilità.
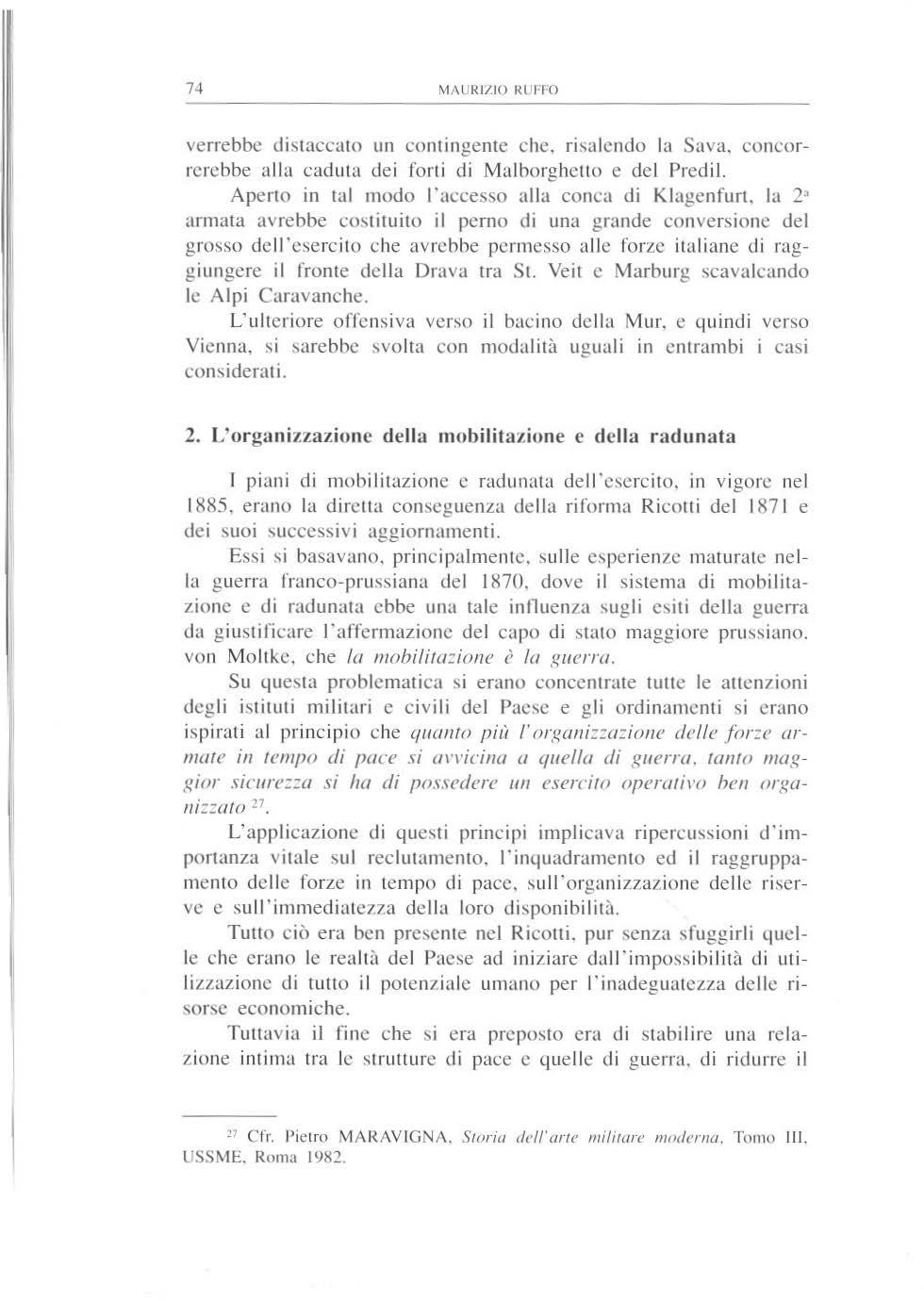
Tutto ciò era ben presente nel Ricotti, pur senza sfuggi rli quelle che erano le realtà del Paese ad iniziare dall'impossibi lit à di utiliZLazione di tutto i I potenziale umano per I· inadeguate.aa delle ri'-Orse economiche.
Tuttavia il fin e che si era preposto era di stabilire una relazione intim a tra le strutture cli pace e quelle cli guerra. di ridurre il
più possibile le inevitabili alterazioni tra le due organizzazioni all'atto della mobilitazione, cli rendere ordinato e rapido il passaggio dal!' una ali' altra fase.
L'organizzazione del Ricotti venne perfezionata e potenziata dal generale Mczzacapo nel 1877 a seguito dei provvedimenti di carattere ordinativo e di ridistribuzione delle forze sul territorio nazionale adottati in quell'anno.
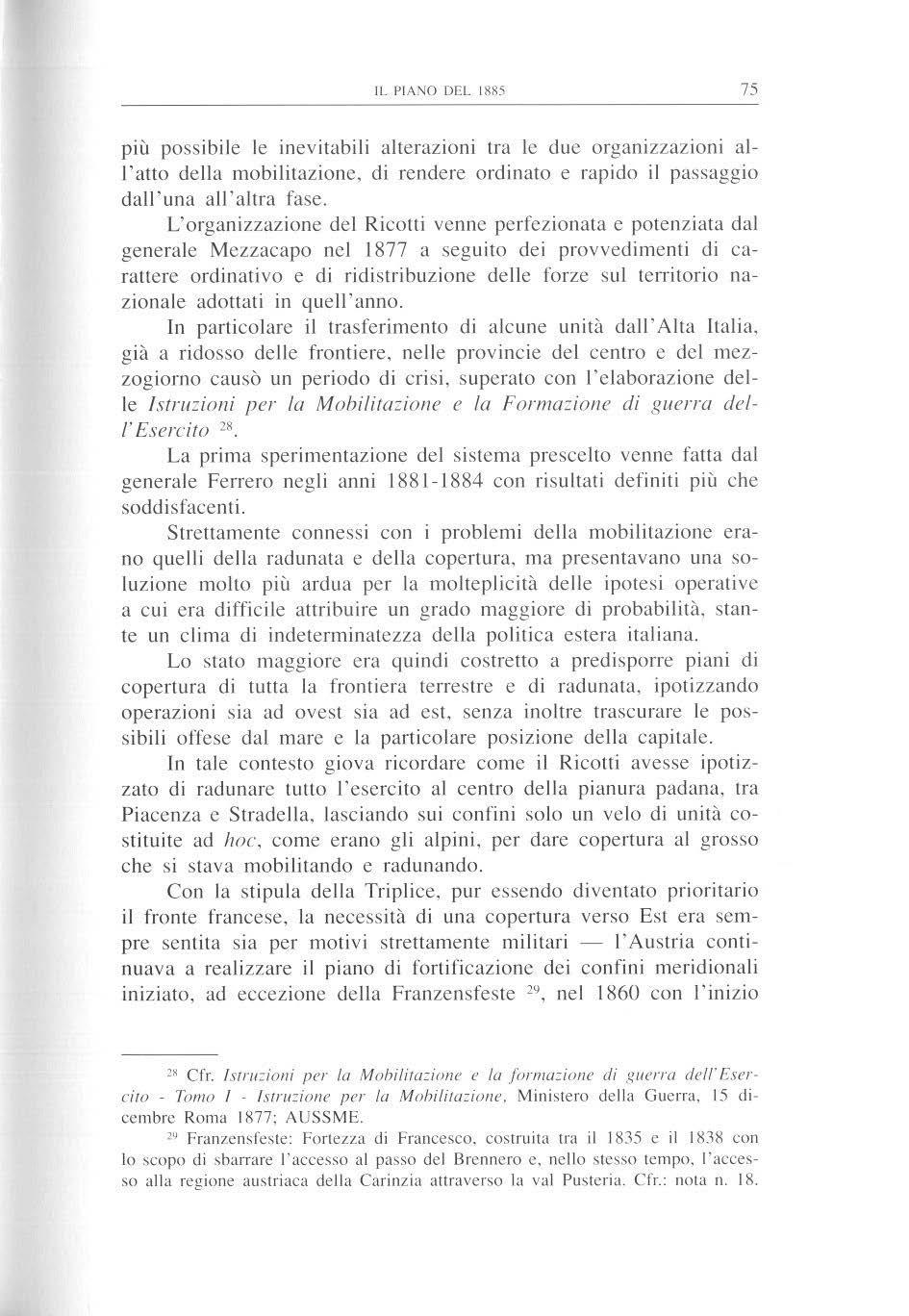
In particolare il trasferimento di a lcune unità dall'Alta ltalia, già a ridosso delle frontiere, nel le provincie del centro e ciel mezzogiorno causò un periodo di crisi, superato con l'elaborazione delle / stru::.ioni per la Mobilita:io11e e la Forma:io11e di guerra del/' Esercito 28 .
La prima sperimentazione del sistema prescelto venne fatta dal generale Ferrero negli anni 1881-1884 con risultati definiti più che soddisfacenti
Strettamente connessi con i problemi della mobilitazione erano quelli della radunata e della copertura, ma presentavano una soluzione molto più ardua per la molteplicità delle ipotesi operative a cui era difficile attribuire un grado maggiore cli probabilità, stante un clima di indeterminatezza della politica estera italiana.
Lo stato maggiore era quindi costretto a predisporre piani cli copertura di tutta la frontiera terrestre e di radunata, ipotizzando operazioni sia ad ovest sia ad est, senza inoltre trascurare le poss ibili offese dal mare e la particolare posizione della capitale.
ln tale contesto giova ricordare come il Ricotti avesse ipotizzato di radunare tutlo l'esercito al centro della pianura padana, tra Piacenza e Stradella, lasciando s ui confini so lo un velo cli unità cost ituite ad hoc, come erano gli alpini, per dare copertura al grosso che si stava mobilitando e radunando.
Con la st ipula della Triplice, pur essendo diventato prioritario il fronte francese, la necessità di una copert ura ve rso Est era sempre sen tit a sia per motivi strettamente militari - l'Austria continuava a realinare il piano di fortificazione elci confini meridionali iniziato, ad eccezione della Franzensfeste 29 , nel 1860 con l'inizio
i 9 Franzensfeste:
dei lavori per la cos tituzi one delle tagliate strada li 10 di G omagoi (strada d e llo Ste lvio). della Rocchetta (su l la s trada delln val di Non), del Bu s di Vela (a ll e porte di Trento). della spiaggia (s ul lit orale Ri va- To rb ole), di Nago (sul la s trad a c h e dal lag o di Garda porta verso Rov e reto), d e l forte Str ino (nei p ressi del pa sso de l Tona le) . del forte Am pol a (s ull a rotabile d ella va l di Ledro tra Ri va del Garda e Storo). del Bl ockhau se di D o:,, di Sponde (a fianc hegg iame nto della ta g liata so tto s tant e del Bu s di Ve la) e la ta g liata s tradale R e,·egler con le du e opere di fian chegg iamen to di L ari n o e Dan1ouno presso l" abitato di Lardaro sulla valle d el Chiese - sia per problemi di politi <.:a interna se mpre leg ati al l 'insoluto problema d e lle terre irredente.
Pertan to. p er poter d are pratica a ttu aLione al piano del Cosenz. l 'ufficio scacchiere orientale a pp ro nt ò un piano di mobilitazione e radunata s ulla fronti e ra Nord-Est c h e. te nend o con to de ll e possibilità e poten1ialità offerte da l sistema ferroviario e stradale, permettesse un o s<.: hi erame nt o di quattro armate n el minor tempo possibile.
Nel p iano ven iva data precedenza asso luta al Corpo spl'Ciale desti n ato a svo lgere una prima azione di <.:ontenimento delle avanguardie nemiche tra la linea del Tagliamento e quella del Pi ave ed a quelle unità prece ttate per il suo rafforzamento.

Negli a nn i successivi le singole fasi de ll o studio del Cosenz ve nn ero ilOtto pos te a s perim e ntazion e m ed iante le ese r<.: ita z ioni per i quadri. previste n e ll 'amb it o d eg li s tudi degli ufficiali di '> l a to maggiore.
La prima ver i fi ca venne svo lta g ià n e l marzo 1886 con un· ese r<.: ita z ione s ul tema Ritira lo del/" eserciro 110:ionale dalla linea del Pim e alla linea \ icen:a-Padorn -Mestre. nella quale si intendeva prendere in esa m e le varie s itua z ioni e pred is posi zio ni da adottare per e ffe ttu are un a manovra in riti ra ta a seguito d e l ced imento d e lla linea del fronte, in parti co lare del Piave.
TI tema pro posto era. infatti. quello cli s tud iare il dispositivo
· Tagliata strada le: con tale tcm1ine si indicavano delle opere con le quali si sbarravano del le st rad e poste a <.:aval iere delle pr incipali direttrici d'a tl acco: erano generalmcme spalleggiate da opere co\truite sui fianchi.
per l 'occupazione difensiva de ll a linea Vicenza-Padova-Mestre e le disposizioni per la ritirata in base all'ipotesi che il nemico non incalzi da vicino e supponendo compiuta la realizzazione del campo trincerato di Mestre cd attivata la linea ferroviaria che da Rovigo, attraverso Adria, porta a Chioggia.
La soluzione 31 , peraltro ben articolata nei suoi veri aspetti tattici e logis tici. coincide con l'ipotesi del Coscnz articolando, inoltre, quelle predisposizioni che sarebbero state alla base della sua attuazione in caso di bisogno.
Negli ann i s uccessivi vennero prese in considerazione le a ltre ipotesi dello studio ciel Cosenz, analizzando le settore per se ttore al duplice scopo di ver ificarne l'attendibilità e predisporre quegli strumenti operativi necessari per la loro attuazione pratica che, in un piano di portata genera le quale quello in esame, non potevano essere definiti nei minimi particolari perché bas ato, esclus ivamente , su delle ipotesi operative di carattere prettamente generale.
Sulla base dei risultati delle singole verifiche e ten endo conto dei mutamenti della politica internazionale, che comportavano lo studio cli nuovi scenari, il piano del Co se nz venne via via perfezionato fino a l 1889, quando il nuovo capo di s tato maggiore, il ten. gen. Saletta, mise mano ad una nuova stesura.
4
li Cosenz attribu iva un a fondame ntal e importanza a lla conoscenza sia de l terreno sia ciel nemi co, in tutti i loro aspetti peculiari , allo scopo di potere essere sempre in grado di adeguare I 'azione a lle varie siruaz ioni che, in un teatro di opera z ioni, si vengono man mano a creare.
Qucst.o concetto, peraltro sotto lineato nel suo studio, ven ne applicato con cos t anza tale che il primo a farne le spese fu il tenente colonnello Etto re Viganò quando, come abbiamo visto, venne incaricato dallo stesso Cosenz di stud iare , fin nei minimi particolari , possib ili scacchieri operativi contro l'Au st ria - Un g heria 32 •
L'attività si svo lg eva s u du e piani apparentemente distinti tra
11 Cfr documento n.: 6. stralcio dal docum en to del viaggio di stato magg iore: Ritirata na zionale dalla linea del Piave alla lin ea Vicen:a -Padova -Mestre 1886. Roma. AUSS ME , G 22, 29.
-'2 Cfr. Ettore VIGANÒ: op. c it. pag. 118.
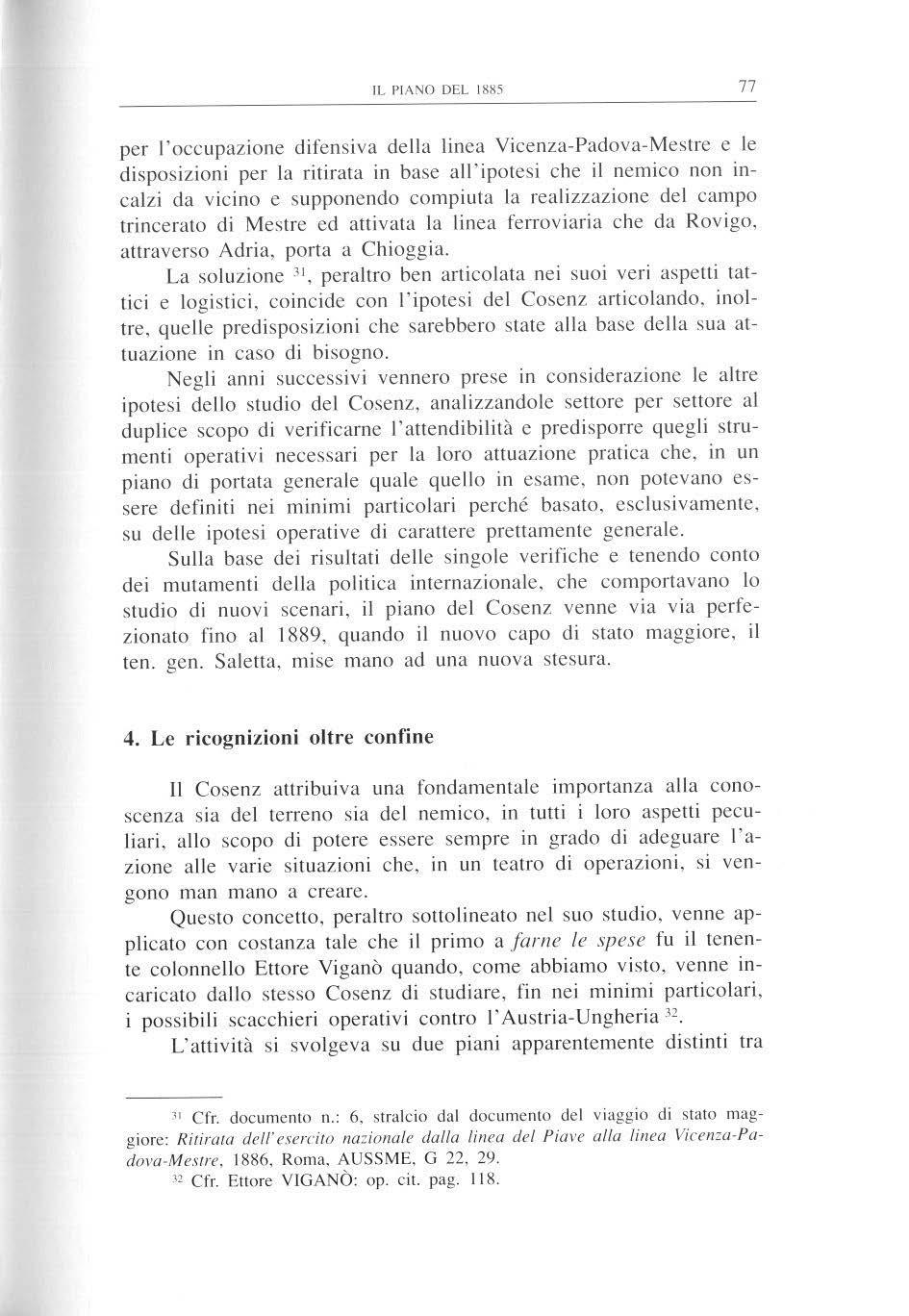
di loro, ma. in realtà, st rettam ente interconne!'.si: la ricogniLior1e del teITeno e la raccolta costante di notizie s ullo stato di preparazione del le for7e asburgiche.
Alla prima era no destina ti degli ufficiali , tratti prevalentemente da quelli dei reparti di sta nza nei pressi dei co nfini , che avevano l'incarico di svolgere d e lle ri cog ni z ioni lungo la fascia immediatamente dietro la linea di co nfin e.
I loro compiti specifici erano quelli di esa minnre il terreno nei minimi dettagli indicando la potentialità della rete stradale e di quelle ferroviaria. i lavori in corso per l'ammod e rnam e nto ed il potenziamento di entrambe. la pre<;enza cli opere fortificate di sbarramento nelle varie valli e, se possibile, rilevarne pianta, consiste nza delle opere murarie. armamento e guarnigione, e ogni altra notizia che potesse risultare utile ai fini della condotta di operazioni belliche.
Sulla relazione del capitano di s tat o maggiore Vittorio Zuppelli del settembre I 897. ad esempio, in merito alla sistemazione difens iva austriaca si leg ge: .. .credo intanw opportuno se1-:11alare alla S. \. il fat10, a mio subordinar o ai·,·iso. importanre che i lal'Ori fortifica/ori austriaci alla ji"o11tiera .fi"iula11a 11011 si limitano al solo progetlato sbarramento della strada Ci,·idale-Caporetto. come risulta dalle i11for111a::.io11i pen•enute al Comando del Corpo di Stato Maggiore, ma altre opere importanti sono a/tresì in costru:ione sia presso la chiusa di Flitsch. sia fra i forti di Predii e quello di Raihl. La rela1ione prosegue quindi: da i11Jòrma::.io11i asso/111a111e11te concordi ass11111e sul poslO mi risultò che il f!,OPerno austriaco ha f!,ÌCÌ espropriaw la chiesa di S. \'olario quale sorge sopra 1111 poggio in co11ti11ua:io11e della falda sl'ltellfrionale del M.te Mia sarà demolita e nella ,·e11111ra prima,·era si darà principio alla costru::.ione di 1m forte su q11e//"alt11ro 13 •
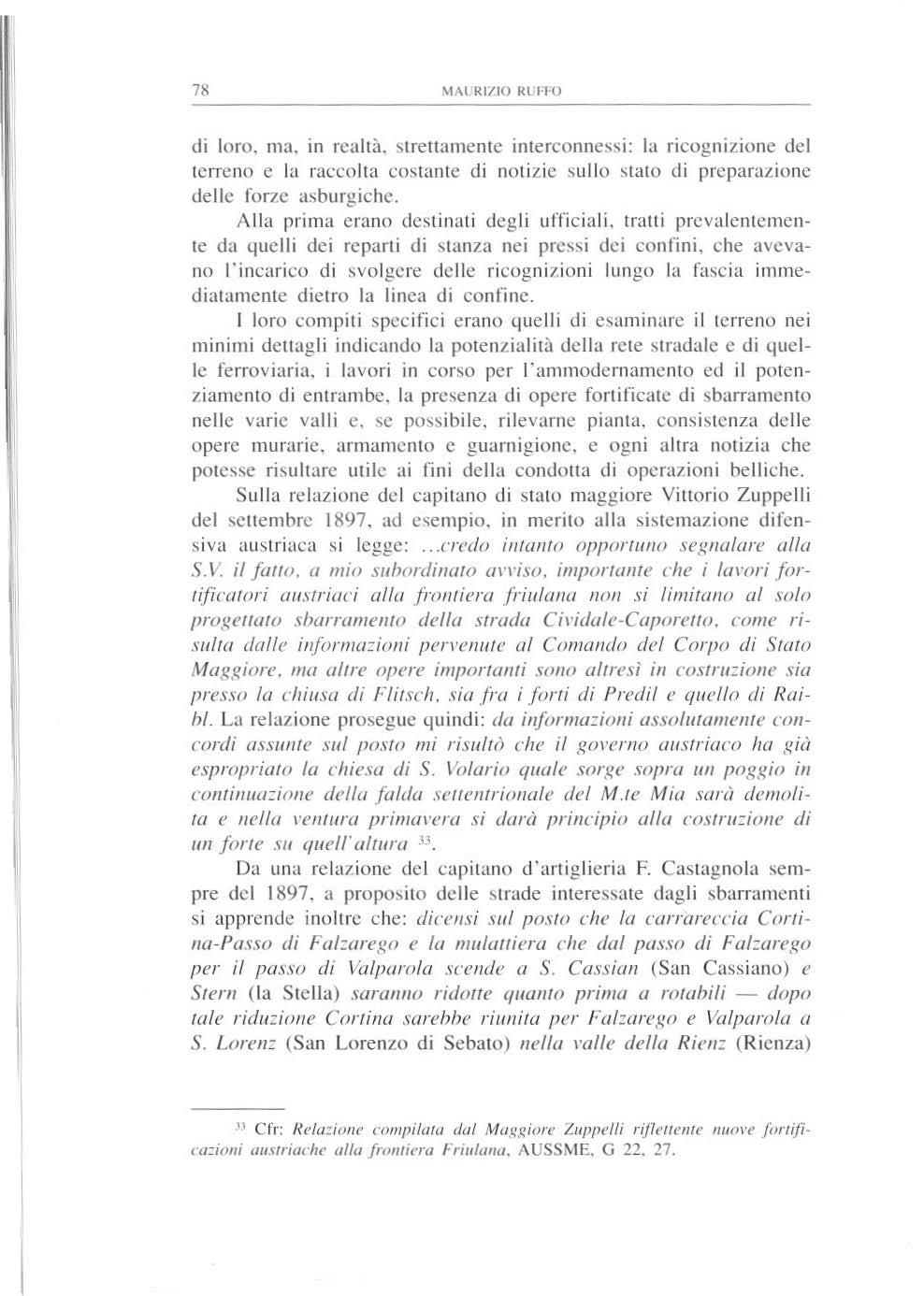
Da una relazione ciel capitano cl' artiglieria F. Castagnola sempre del 1897, a proposito delle strade interes,ate dagli sba rramenti s i apprend e inoltre c he: dice11si sul posto che la carrareccia Cortina-Passo di Fal:arego e la m11/a11iera clte dal passo di Fal:arego per il passo di Va/parola scende a S. Cassian (San Cassiano) e Stern (la Stella) saranno rido/te quanto prima a rotabili - dopo tale ridu : ione Cortina sarebbe riunita per Fal::.arego e Va/parola a S. Loren::. (San Loren zo di Sebato) nella \'alle della Ri e11: ( Ri cnza)
" Cfr: Nela : ione compilata dal Magiiore Zuppe/li rijfr1tcme 1111m•e fortijica : ioni am1riache alla frontiera l-ri11/a11a. AUSSME. G 22 '27.
mediante ro1ahile. Riustificahile quindi la cosfru:io11e di un forte nella località detta ''Jì-a i Sassi" 3-1 presso Va/parola 35
Queste ricognizioni erano però Iimitate alla conoscenza diretta del terreno e degli apprestame nti effettuati dall'avversario, necessita vano quindi cli essere integrate eia altre notizie sullo stato di preparazione delle forze provenienti da un'allro tipo di ricerca informativa.
A questa seconda attività erano devoluti, i11 primis, gli addetti militari accreditati presso il governo asburgico e quel lo tedesco, che si era ri velato una fonte estremamente attendibile di informazioni sul la preparzione militare dell'alleata, quindi una fitta rete cli in formatori .\ 6 che, utilizzando metodi talvolta poco ortodossi, raccoglievano le notizie più segrete e più importanti ai fini della completa conoscenza cicli' avve rsar io.
Questa a tti vità era diretta clall 'ufficio militare e dai singo li uffici informazioni di arma t a che provvedevano ad e lab orare le varie notizie raccolte ed a diffonderle agli organismi direttamente interessati all'attività
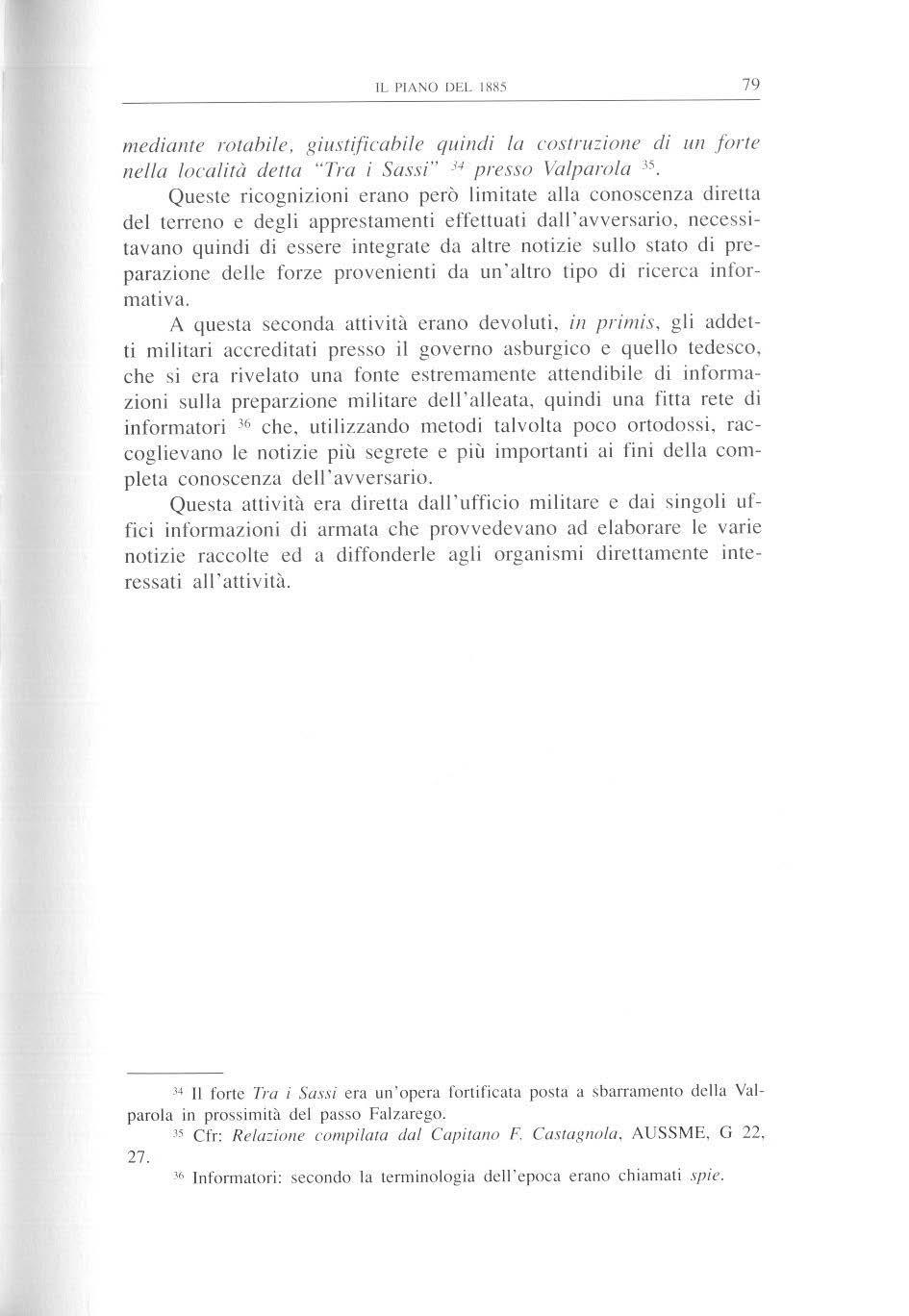
34 Il forte Tra i Sassi era u n 'opera fortificata posta a sharramen to del la Valparola in pross imità de l pas so Fa l zarego.
35 Cfr: Rela:io11e cornpi/a,a dal Capila/IO F. Castag110/a, AUSS ME , G 22, 27.
1< · Informatori : secondo la terminologia de l l'epoca era no chiamati spie.
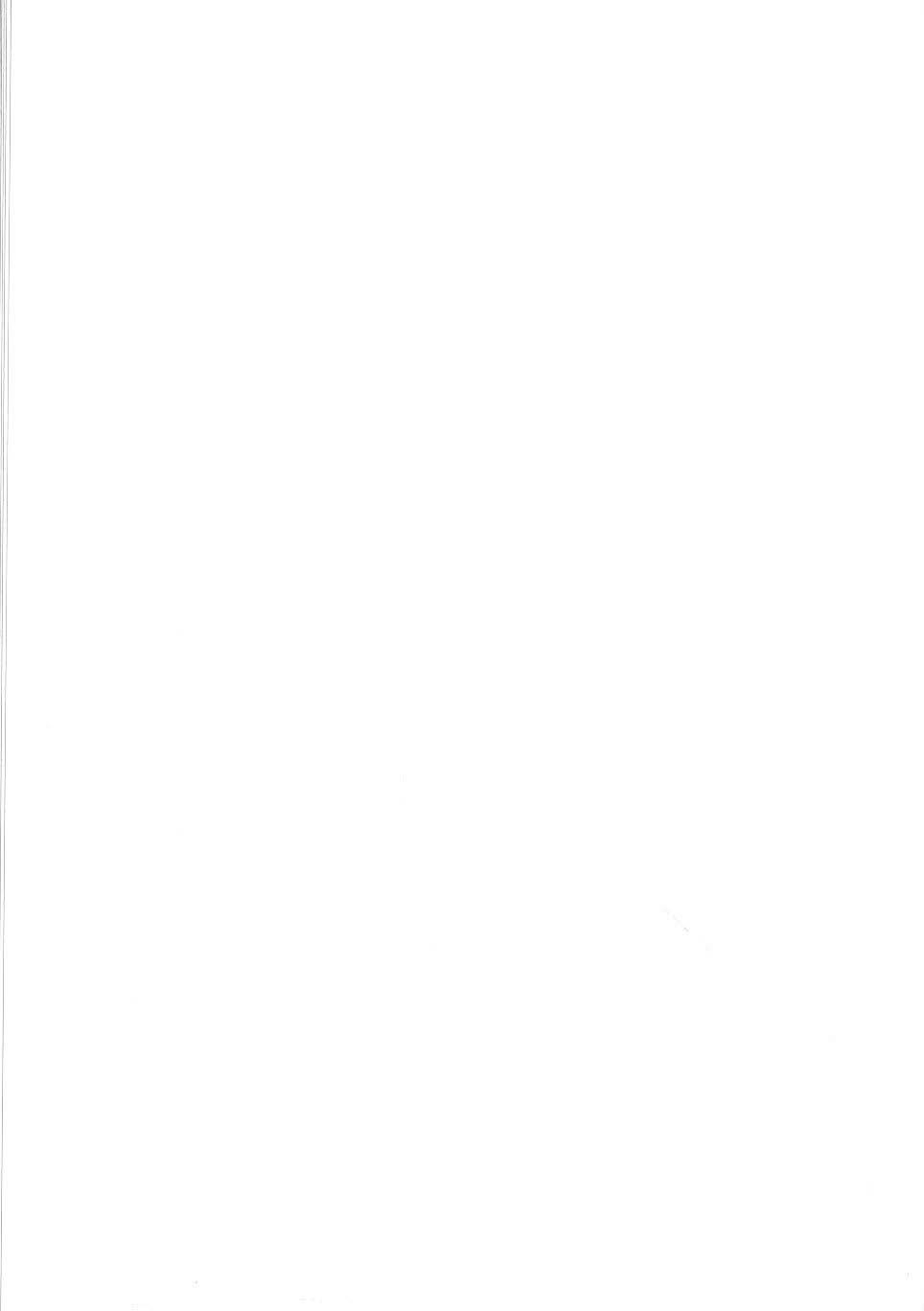
Passa ta l a bufera napoleonica , i I problema di come sa l vaguardare l'integ rità dei confini ven n e affrontato da tutti i paesi e uropei ; in particolare s i concepirono nuovi criteri per la costruzione di fortificazioni pe rm ane nti 1 • non più basati s u rocche e fortificazioni iso late o su città c inte da mura, ma su s iste mi di forti in grado di controllare intere regioni o sba rrare le principali vie di facilitazione che adducevano a ll e retrovie.
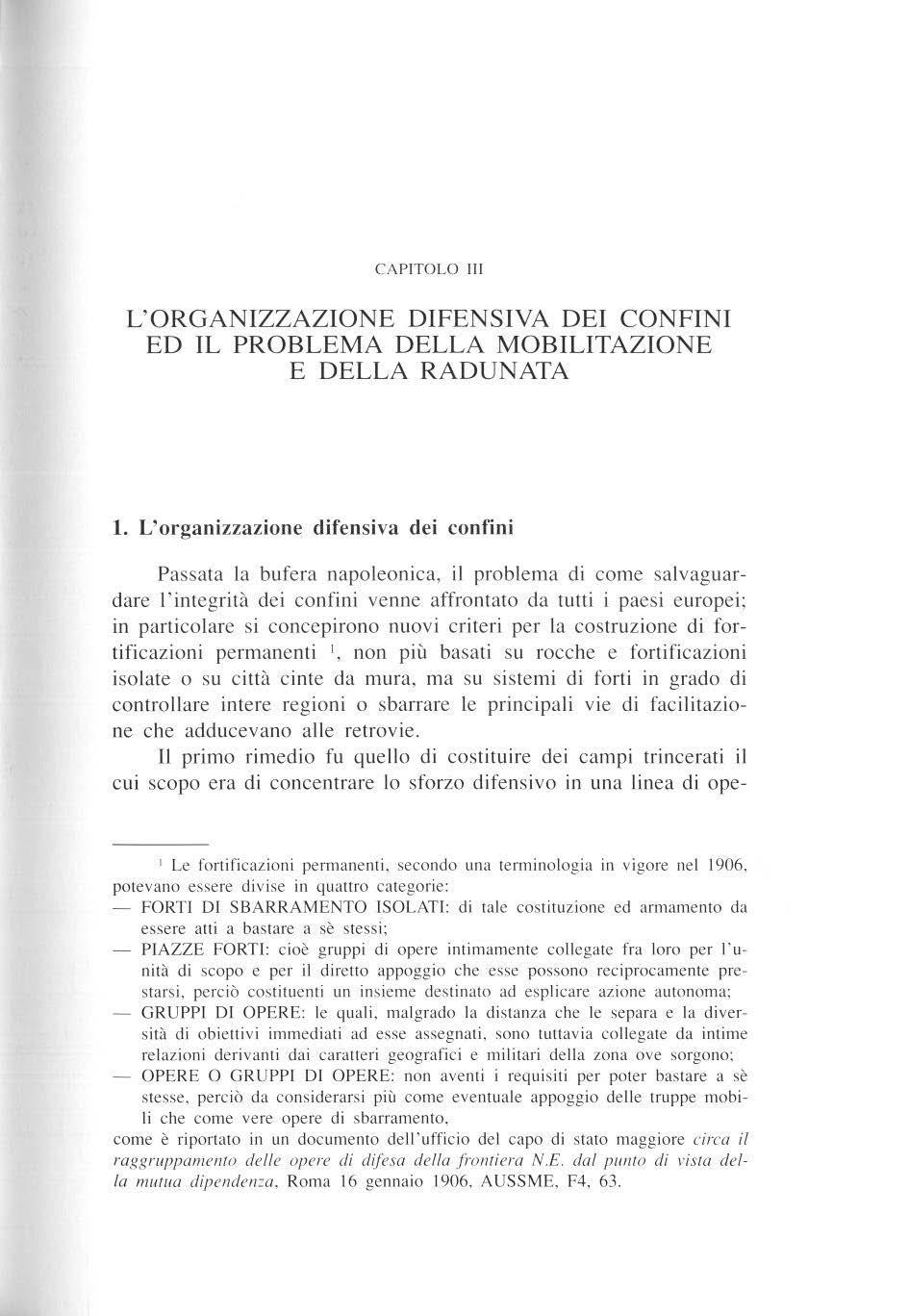
Il primo rimedio fu quello di costituire dei campi trincerati i I cui scopo era di concentrare lo sfo rzo difensivo in una linea di ope-
1 Le fortificazioni permanenti. secondo una terminologia in vigore nel 1906, potevano essere divise in quattro categorie:
FORTI DI SBARRAMENTO ISOLATI: di ta le cost itu z ione ed armame nt o da essere atti a bas tare a sè s tes s i:
PIAZZE FORTI: cioè g ruppi di opere int im amente co llega te fra loro per l 'unità di scopo e per il d iretto appoggio che esse possono rec ipr oca me nte prestarsi. pe rc iò costituenti u n in s ieme de s tinato ad esp licare az ione au tono m a:
GRUPPI D I OPERE: le qual i ma lg rado la d ista nza c he le separa e la diversità d i ob iettivi immediat i ad esse assegnati, sono tuuavia collega te da inti me re lazio ni derivam i da i cara tt eri geografici e mi li tari de lla LOna ove sorgono:
OPERE O GRUPPI DI OPERE: non avenLi i req ui siti per poter bas tare a sè stesse. perciò da co nsiderars i più come eve ntu ale appoggio delle trupp e mobili che come vere opere di sbarramento. come è rip o rt ato in un documento cie li 'uff ic io de l capo di stato maggiore circa il raggrnppamento deffe opere di difesa deffa ji·o111iera N.E. dal p111110 di rista della mut ua dipe11de11 ; a. Roma 16 gen naio 1906. AUSSME. F4, 63.
re (forti staccati), posta ad una distanza dall'obiettivo da salvaguardare da obbligare l 'avversario ad assumere un ampio dispositivo d'attacco ed a schierare le proprie batterie in una pos izio ne tale da non poter permettere che le artiglierie in esso sc hierate, riuscissero a co lpire il fronte di gola 2 dei forti di cintura diametralmente opposti ad esso, una volta conquistato un forte s taccato.
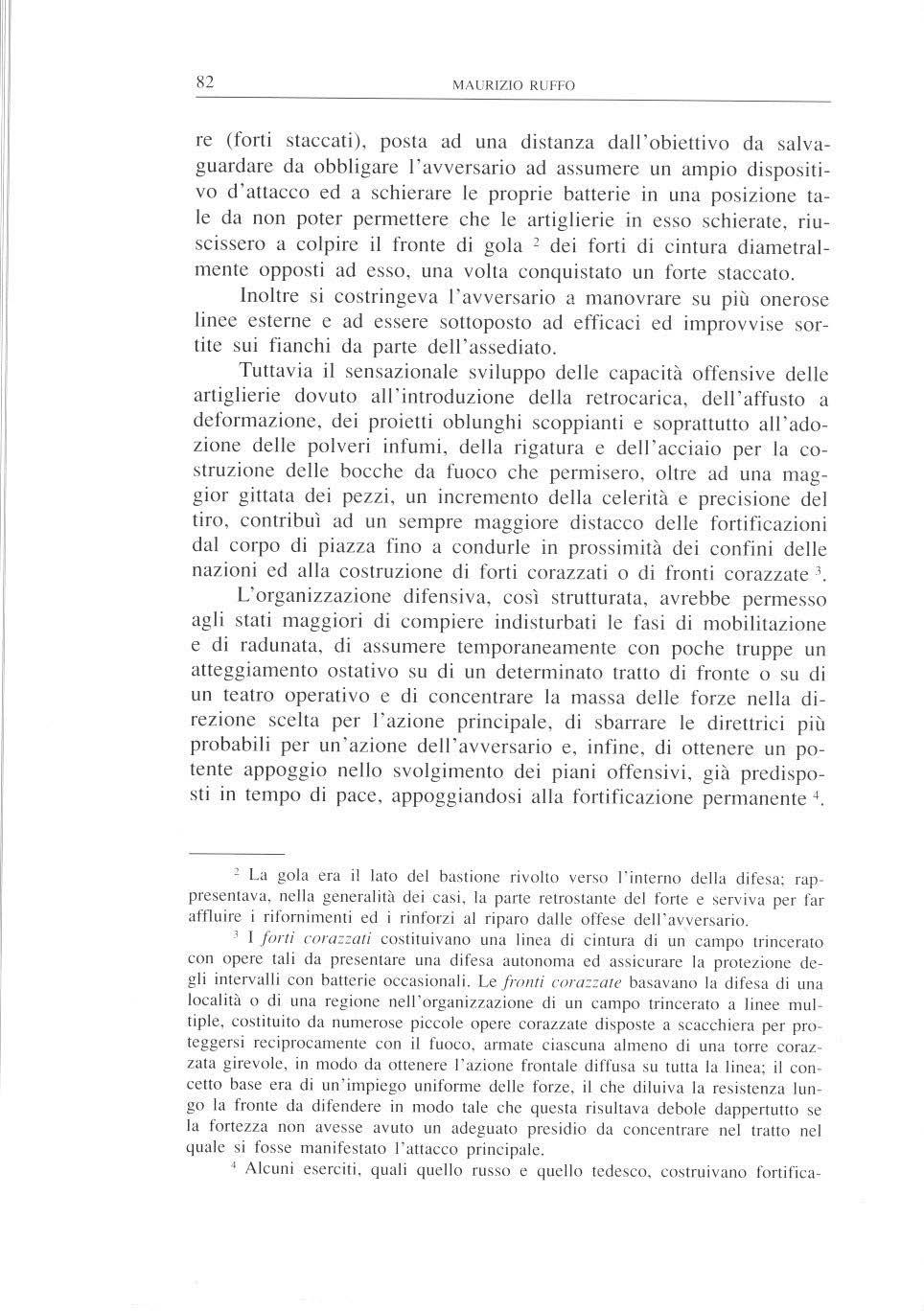
Inoltre s i costringeva l ' avversario a manovrare su più onerose lince esterne e ad essere so ttoposto ad efficaci ed improvvise sortite s ui fianchi eia parte dcli ' assediato.
Tutta via il sensazionale sviluppo delle capacità offensive delle artig li er ie dovuto a l l'introduzione della retrocarica , cieli ' affu s to a deformazione, dei proietti oblunghi scoppianti e sopra ttutto all 'adozione delle polveri infumi , della rigatura e dell'acciaio per la cos truzione delle bocche eia fuoco c he p e rmisero , oltre ad una maggior gittata dei pe zz i, un incremento d e lla celerità e precisione ciel tiro , contribuì ad un se mpre maggiore distacco d e ll e fortificazioni dal corpo di piaz za fino a condurle in pross imità dei confini delle nazioni cd a ll a costruzione di forti corazzati o di fronti corazzate\ L 'o rganizzaz io ne difen s iva , così strutturata, avrebbe permesso agli s tati maggiori cli compiere indisturbati le fasi di mobilitazione e di radunata, di assumere temporaneamente con poche truppe un atteggiam e nto ostativo su di un determinato tratto di fronte o su di un teatro operativo e di concentrare la ma ssa de lle forze nella direzione scelta per J'azione principale , di s barrare le direttrici più probabili per un 'azione dell'avv e rsario e, infine, di ottenere un potente appoggio nello svo lgimento dei p iani offensivi, g ià predisposti in tempo cli pace, appoggiandosi alla fortificazione permanente~.
2 La gola era i l l ato de l baslione rivo lt o verso l"interno de ll a difesa; rappresentava, nella genera lità d ei cas i l a pane r etrostan te de l forte e serv i va per far affluire i riforn im enti ed i rinforzi al riparo dall e offese dell 'avver sario.
3 I fo r1i cora ;:ati costiluivano una l inea di cintura di un c ampo trinc era to con opere tali da presentare una difesa auto noma c d assic urare l a pro tez ione degli interval l i co n batterie occasiona l i. Le jìm 1ti cora:: ; a1e ba savano la difesa di una località o di un a re g ione nell'organi zzaz ione di un campo trincerato a linee m ulti ple. costitu ito da numerose piccole opere corazzate disposte a scacchiera per prote ggers i rec i procamente con il fuoco. armate ciascuna alm eno di una torre co razzata gi revole , in modo da ot tenere l 'az ione fronta le diffusa su tutt a la l in ea: il concetto ba se era di un'impiego uniforme dell e forze, il che dilui va la resi stenza lungo la fron te da difendere in modo ta le che questa risu lt ava debole dappertullo se la fortezza non aves se avuto un adeguato pre sidio da concentrare ne l !ratto nel 4ualc si fosse manifestato l ' atta cco principale.
" A lcun i ese rciti, quali qu ello ru sso e 4ucllo ted esco. costruivano fortifica-
Anche il Cosenz, come abbiamo visto nel suo studio del 1885, aveva preso in seria considerazione il ruolo che le opere fortificate avrebbero assunto nella condotta delle operazioni sia difensive sia offensive.
Egli, infatti, pur tenendo presente che una guerra moderna si basava principalmente sulla continua ricerca della manovra e che la qualità degli armamenti e dei materiali, oltre che l'addestramento degli uomini, avrebbero assunto un peso sempre maggiore, riteneva che il concetto della fortificazione permanente, intesa come presidio atto a ll o sbarramento di una valle o di una via di facilitazione, era tutt'altro che superato, specialmente in terreni montuosi come quelli italiani.
Anzi, considerando il problema in chiave prettamente difensiva, la presenza di un moderno sistema cli opere, oltre che fornire una certa sicurezza da sorprese avversarie, avrebbe permesso cli muovere, utilizzando tali strutture come perni di manovra per concentrare le forze nel punto più esposto, allo scopo di riacquistare quella libertà di azione necessaria per il successivo sviluppo delle operazioni.
Ne ll e operazioni offensive , poi, la disponibilità di opere della fortificazione permanente, site nelle immediate vicinanze del settore scelto per condurre un attacco, avrebbe permesso di provvedere al concentramento ed allo schieramento delle unità preposte in un clima di sicurezza quasi totale; inoltre le artiglierie de ll e stesse nonché il personale ivi impiegato avrebbero concorso in maniera efficace al lo svo lgersi dell'azione stessa.
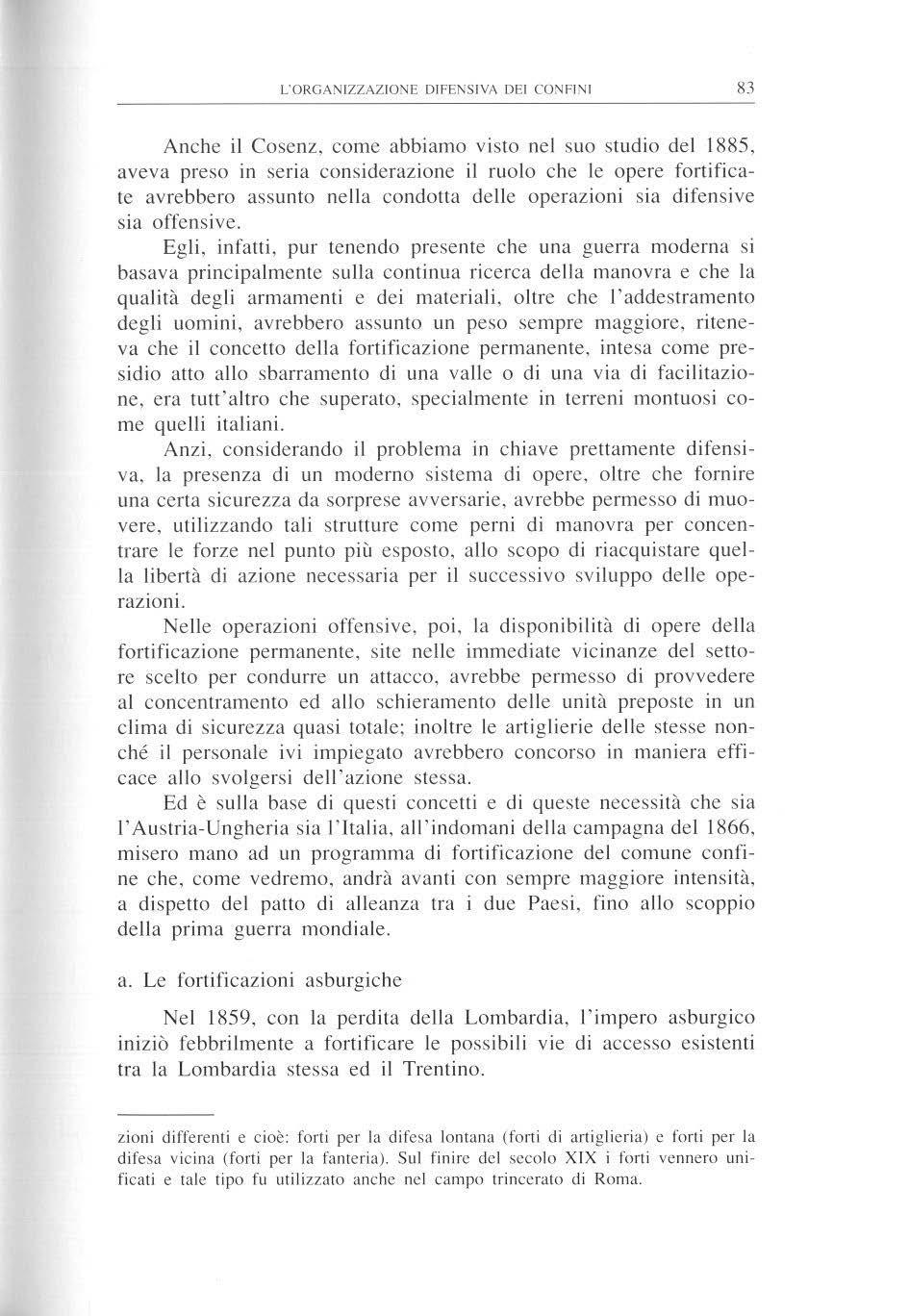
Ed è su ll a base di questi concetti e di queste necessità che sia l'Austria-Ungheria sia l'Italia, ali' indomani della campagna ciel 1866, misero mano ad un programma di fortificazione del comu ne confine che, come vedremo, andrà avanti con sempre maggiore intensità, a dispetto del patto di a ll eanza tra i due Paesi, fino allo scoppio della prima guerra mondiale.
Nel 1859, con la perdita della Lombardia, l ' impero asburgico iniziò febbrilmente a fortificare le possibili vie di accesso esistenti tra la Lombardia stessa ed il Trent ino.
zioni d ifferenti e cioè: forti per la difesa lon ta na (fort i di artig li er ia) e forti per la dife s a vicina (forti per la fanter ia). Sul fini re del secolo XIX i fo rti ven nero unificati e tal e tipo fu uti lizza to a nc he ne l campo 1rinccralo di Roma.
Allo scopo costituì una di rezione genio, la K. 11. K. Geniedirection i11 Trie11t \ a ll o speci fi co compito di provvedere a ll a costruzione delle nuove opere che. già progettare. dovevano essere ed ificate con la massima sollecitudine 6 • Dopo la ca m pagna d e l 1866 che co m po rt ò la cessio ne al l'll a li a ciel Veneto, della zona di Mantova e parte del Friuli. la D ircLione diede vita all'approntamento di nuove fortificazioni ne lla zona orienta le de l Tren ti no . in pa rt ico lare si pose mano a ll o sbarramento della Va lsugana i n co rr ispondenza del la stretla naturale di Civezzano. Nel pe r iodo tra il 1869 cd il 1885 la ciui1 di Trento venne trasforma ta in una piazzafo rt e prote lt a, a giro cl'orizzonce, da forti di cintura. d a fort i intermed i. da ba tt e r ie permanent i. eia tag li ate stradali 7 • da casermetre difensive e da trincee protette che avevano i I compi to di chiudere gli intervalli esistenti tra le singole fortificazioni.
L a cost ru zione d i ta li opere l'o rtifi ca t o r ie non conobbe alcun rallentamento nonostante che nel 1882 fos s e stato <;tipulato il trattato che legava in alleanza difensiva l'impero danubiano, la Germania e l ' I ta li a; q ues to rafforzamento dei co nfi ni . per a lt ro. s t ava quasi a sottolineare la continua e palese diffidenza austriaca nei confronti dell' It alia.
Ne l 1886, con l'avven to de l proie lto - to r pedine, l'affidabi l ità de lle fort i ficazioni fu oggetto di una profonda riflessione, tullavia il particolare ambiente alpino e l'introduzione cli aggiornate soluzioni difensive penniscro alle nuove costruzio n i di essere in grado di svolge re il loro co m p il o.
Con l'inizio di questo secolo le autorità a u striache emanarono ulteriori disposizioni per la progettazione e l'edificalione di caposa ld i fo rti f'i cat i in m ontagna c he fosse ro ido ne i a resis te re a l fuoco de ll e artig l ierie di grosso calibro.
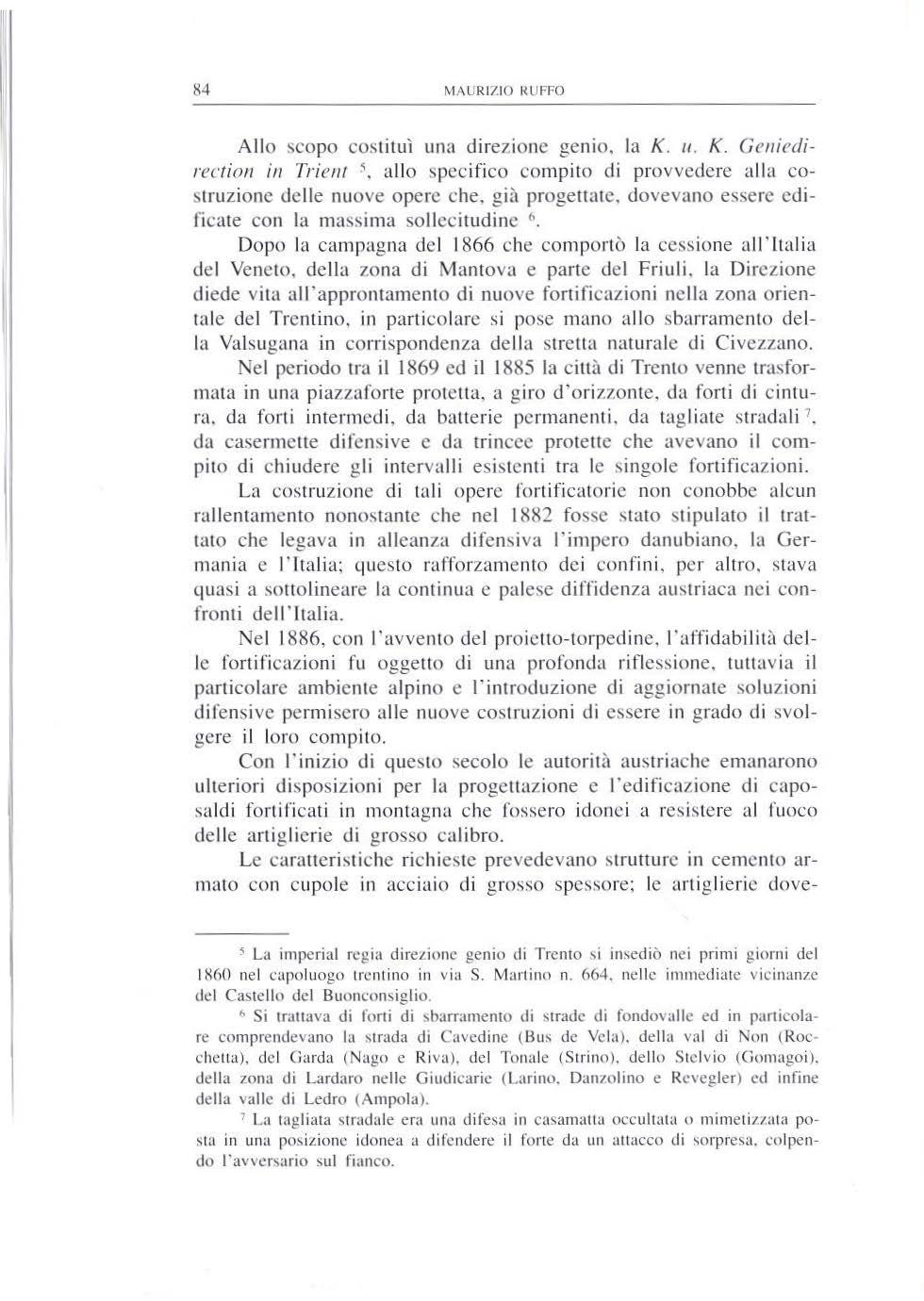
Le caraneristiche richieste p revedevano strutture in cemento armato con c up o le in acc ia io cl i grosso s p esso re; le art ig l ie ri c dove-
5 La imperial re g ia direLionc genio di Trento ,i insediò nei prim i giorni de l 1860 ne l c.ipo luogo tren t ino in via S. Martino n. 664. nelle immedia te vicinanze de l Castello de l Buonconsiglio.
6 Si trattava di forti di ~barrament o dì strade di fondovall e ed in partico lare compre ndevano la strada dì Cavedine (Bus dc Vela ) della va l di Non (Rocche ll a), de l Garda (Nago e R iva). de l Tona le (Strino). dello S telvio (Gomagoi). d e lla zona di Lardaro nelle Giudi carie ( Larino. Dan7 o lino e Rc veg ler ) cd infine d e lla valle di Lcdro ( Ampola ).
7 La tagliata ~tradale era una difesa in casamalla occultata o mime ti1.1 ata pos ta in u na pos iz ione idonea a d ife nde re il forte eia un attacco di ,orpre~a. co lpendo l'avvt:r,arìo sul fianco.
I rortifi cazio nc del Doss Trento (3 bauerie + 2 tagl iate st radali)
2. Balle ria Martignano
3. Stra~scn;,pe rre Buco di Vela (tagl iata stradale)
4. Blockha us Doss di Sponde
5. Baneria Candria i
6. Blockhaus Mando li n
7. Werk Romagnano (opera)
8. Untc r Batteri e Mattarello (batte ria infe ri ore)
9. Ob e r Bancrie M attare ll o (batter ia superiore)
I O. H auptwerk Matta rel lo (opera principa le)
11 Balleria Doss Fornas
12. Wcrk S Rocco
13. Batte rie Brusaferro
1-L Batte r ie Maranza
15. Blockhaus MaranLa
16. Ballerie Ron cogno
17. Batter ie Cimirlo
Gcw he rgallerie Serra (ga lleria ferrov iaria fortificata)
18. U ntcr St rassensperre Civezzano ( tag liata s trada le infe ri ore
19. Obcr Strassensperre Civezzano ( tagliata s tra dale su perio re)
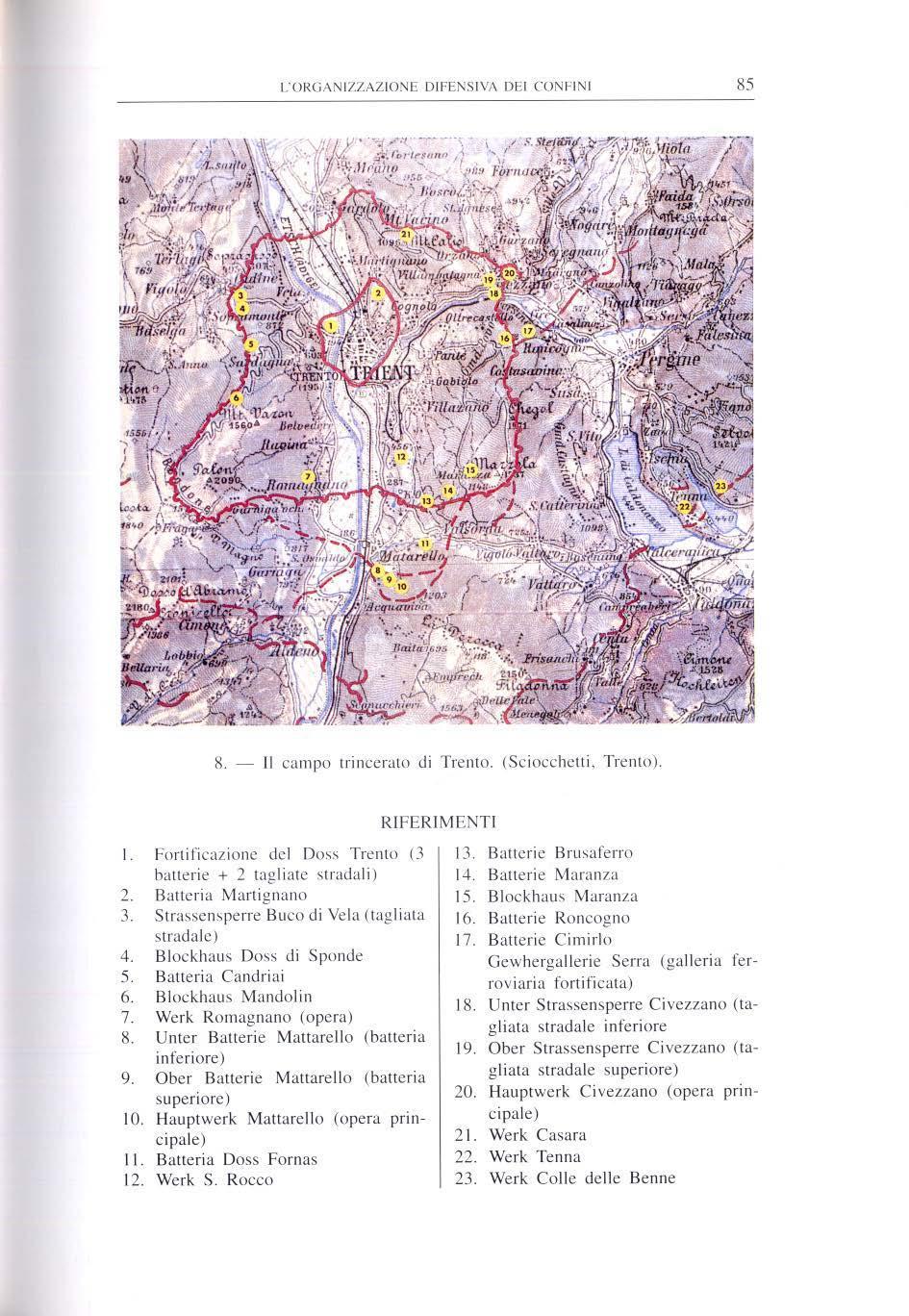
20. Hauptwcrk Civezzano (opera p rincipa le)
21. Werk Casara
22. Werk Te nna
23. We r k Colle delle Benne
9. - Altopiano di Fo lgar ia • Lal'aro nc • Ltl',erna (TN): )>[rakio d e lla ca rta a u,1riaca I:2.'i.000 del fone e dell e ope re acce,,orie ed o,taco li per I'approntamento del campo di battaglia (Nah\..ampfanlagc). Planimetria del piano di illumina1ione del campo di bauaglin con i fari e i proiettori in dolazione . I.e aree quadretJat..: rappre sc n1ano gli o\taco li pas ,i vi ( re i icola ti ). Sl' io1.:chctti. Tn:nto ).
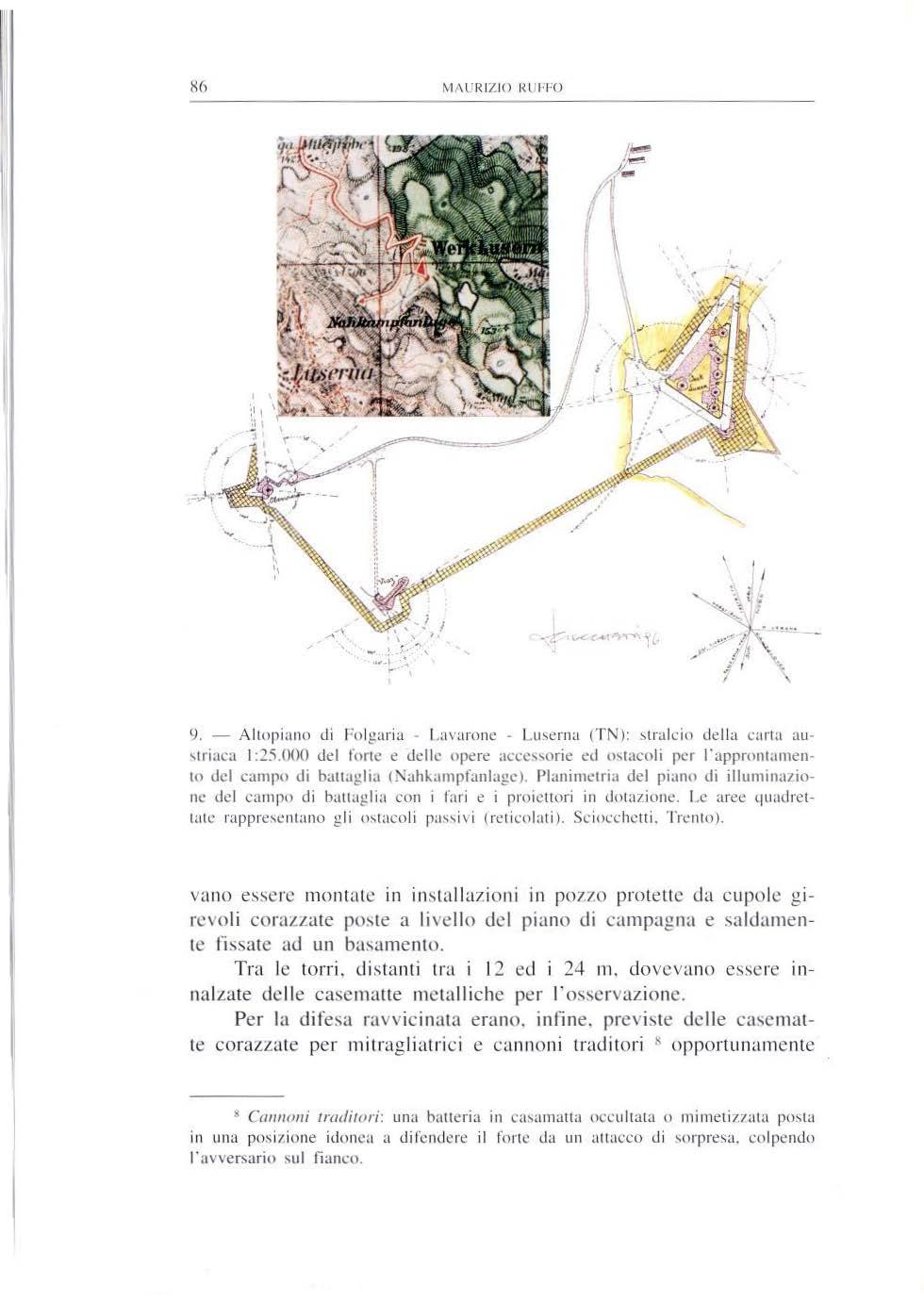
va no esse re mo nta te in in s ta lla z io ni in po 770 p ro te tt e da c upole g irevol i coraua te poste a livel lo del piano di campagna e saldamente fissate ad un basamento.
Tra le to rri. di s ta nti Ira i 12 ed i 24 111 d oveva no esse re inna lza te de ll e casema tte me t a l lic he per l 'osse rvaz ione.
Pe r la d i fesa ravvici nata erano. infi ne. previs te del le casema tte co ra zza te p e r mit rag li atri c i e ca nn o ni tra dit o ri h o pp or t un a me nt e
• Cw11w11i 1rndi1ori: una batte ria in ca~ amalla occ ult ata o mi111e ti !.7ala po~ta in un a pos iz ione idon e a a di fendere il fonc da un auacco <li ,orpresa. rnlpen <l o l'avversa rio s ul fianc o.
IO. - A ltop iano di Folgaria - Lavarone - L use rn a (TN). Forte coraaa to d i Lusern a (o d i cima Campo) vis to da lla s trada de ll e Mandric lc. Costruito a 1548 m. s. l. m tra il 19 11 ed il 19 14. aveva il compito Ji sb arrare la tes tata tlella Val d"A~, a. So ttoposto ad inten o bo mbardamento dell'artigl ieria ital iana i l s uo co mandante Eman ucl Nehesa r ordi nò d i issa re le band ie re bia nche per la resa a lle 16 del 28 maggio 19 15 C iò prov0cè> l"immediato imervento de i forti austr iaci contig ui che s pararono sul lo s tesso forte. (Sc iocchctt i Tre nto).
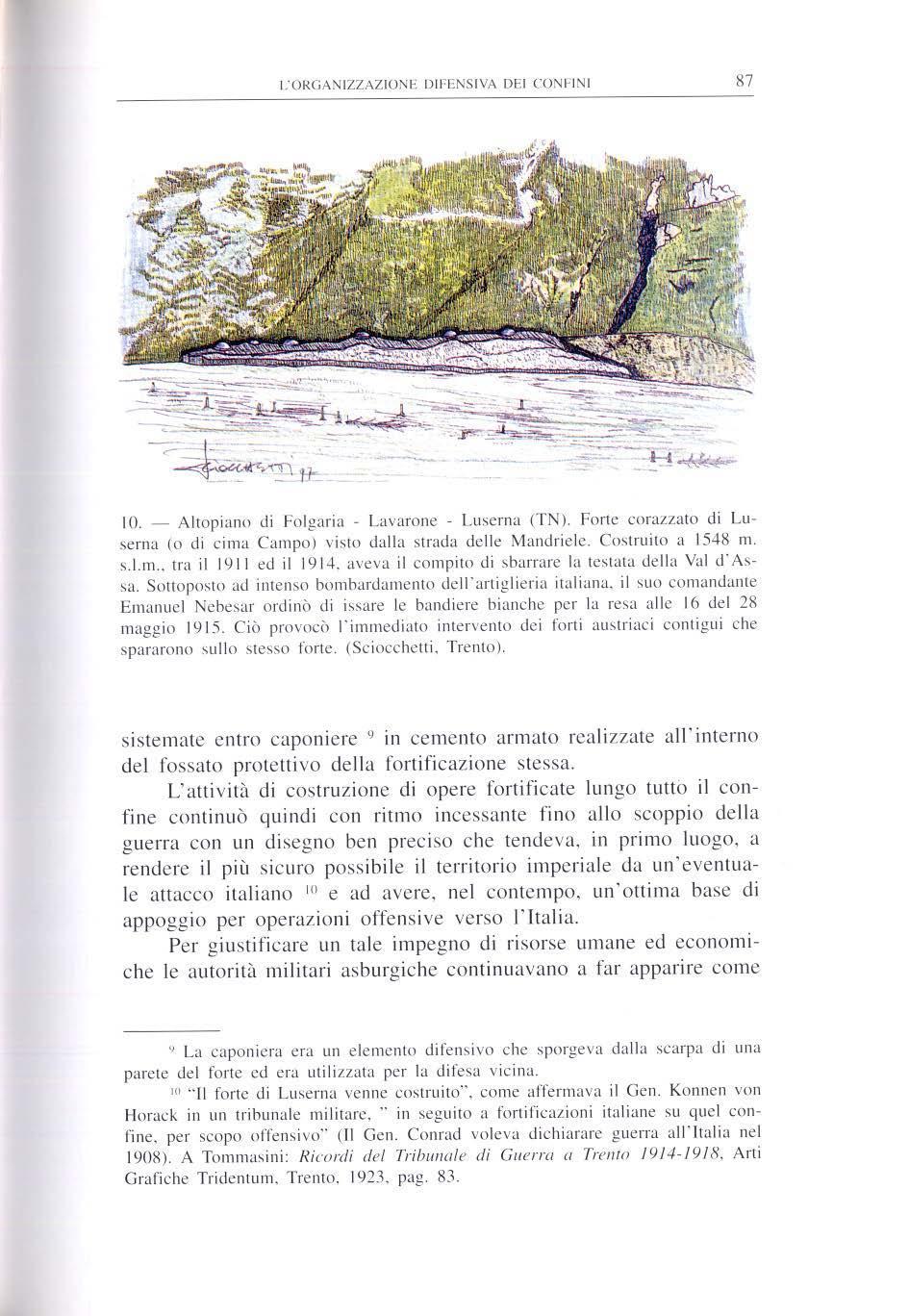
s is te ma te e ntr o capon ie re 9 in cemen to a rm ato rea li zzate a ir i nte rn o d e l fossa to protett ivo de l la for ti ficaz io ne s tessa.
L'a tti v it à d i cos tru z io ne di o pe re fo rtifi ca te l un go tu tto il co nfin e co nti n uò qu indi co n ritm o in cessa n te fin o a ll o sco ppi o de lla g ue rra co n u n d iseg no be n preciso c he te nd eva, i n primo lu ogo, a re nd e re il più s ic u ro poss ibil e il te rritorio im pe ri a le d a un 'eve ntu ale a tt acc o ita li a no 1<1 e ad ave re, ne l con te mp o, un 'o ttim a b ase d i app ogg io per ope raz io ni offe ns ive ve rso rTralia.
Pe r g iu s t ifi ca re un t a le impeg n o di ri so rse um a ne e d eco n o mic he le auto rit i1 mili tar i asb urg ic he co ntinua va n o a far ap pa ri re come
• , La caponicra e ra un elemen to difen~ ivo che sporgeva dalla scarpa di u na parctc tl el forte cd era uti lizzata per la difesa v ic in a.
1<1 '" Il forte di Lu se rn a ven ne cos truit o··. co me a ffer mava il Ge n Kon ne n vo n I lnrack in un t ri b un ale mi litare. ·· in seguito a fo r1 i ri caL io n i ita lia ne s u quel confi ne. pe r sco po offe nsivo'" ( l i Gc n. Conrad voleva dic hi arare g uerra ali" It a lia nel 1908). A Tommasini: Ri cordi del Trilm11afe di Guerra a Tre111n 1914 - 1918. A rti G rafiche Triden tum Trento 1923. pag 83.
11 - Altopiano tli r:olgaria - L:I\ arone - Lu,crna. Forte coranato tli Lu\erna cTN): , "la tlel fo,,ato anteriore e della balleria <lt:i cannoni traditori pmti ,ullo ,pigolo nord clelr opcra. Anna111c1110: 4 obici coraua 1i PI I M05 da I O cm. in cupo Il' rnranatc: M80 da 250 111m . di spc,,ore: 2 cannoni a 1iro rapiuo da 6 cm. \109: 2 1:annoni ··1rauitori·· ua feritoia I\ISchK \109 da 8 cm.: 19 mitragliatrici MG :'-107 da 8 mm. Due moderni fortini per la fa111cria (deno111111a1i Via, cd Obcrwic,el ). uowti di anig lie ri e a corta giuata e di osservatori cora11ati c he 1:omp leta\'ano 1·opera. Le strutture de l forte furono protellc tlalro,~erva,ionc a, vcr~nria a n11.:no di iuonco 111.1,1:hcramcnto a mezzo cli colore. (Sciocchelli. Trelllo).
una reale minaccia i lavori <li rafforLamento dei confini compiuti dall"Ttalia e la dislocazione, da parte di questa. di numerose unità ai co nfini ori entali. in un settore che, sulla base degli accordi politi ci. non sarebb e sta to necessario difendere con un largo spiegamento di forze.
Di tal e moti vaz ion e si rend eva interessato interprete il gc n. Conrad. che vedeva nell ' Italia un 'al l eata infida da cui guard ar..,i con part i colare artenLio nc tanto da giw,tificare anche una guerra preve nti va, e da alcuni organi di stampa au st ri aci qual e premessa al -
1' illustrazione ed all a giustificazione dei propr i l avori di rafforzamento dei confini 1 •
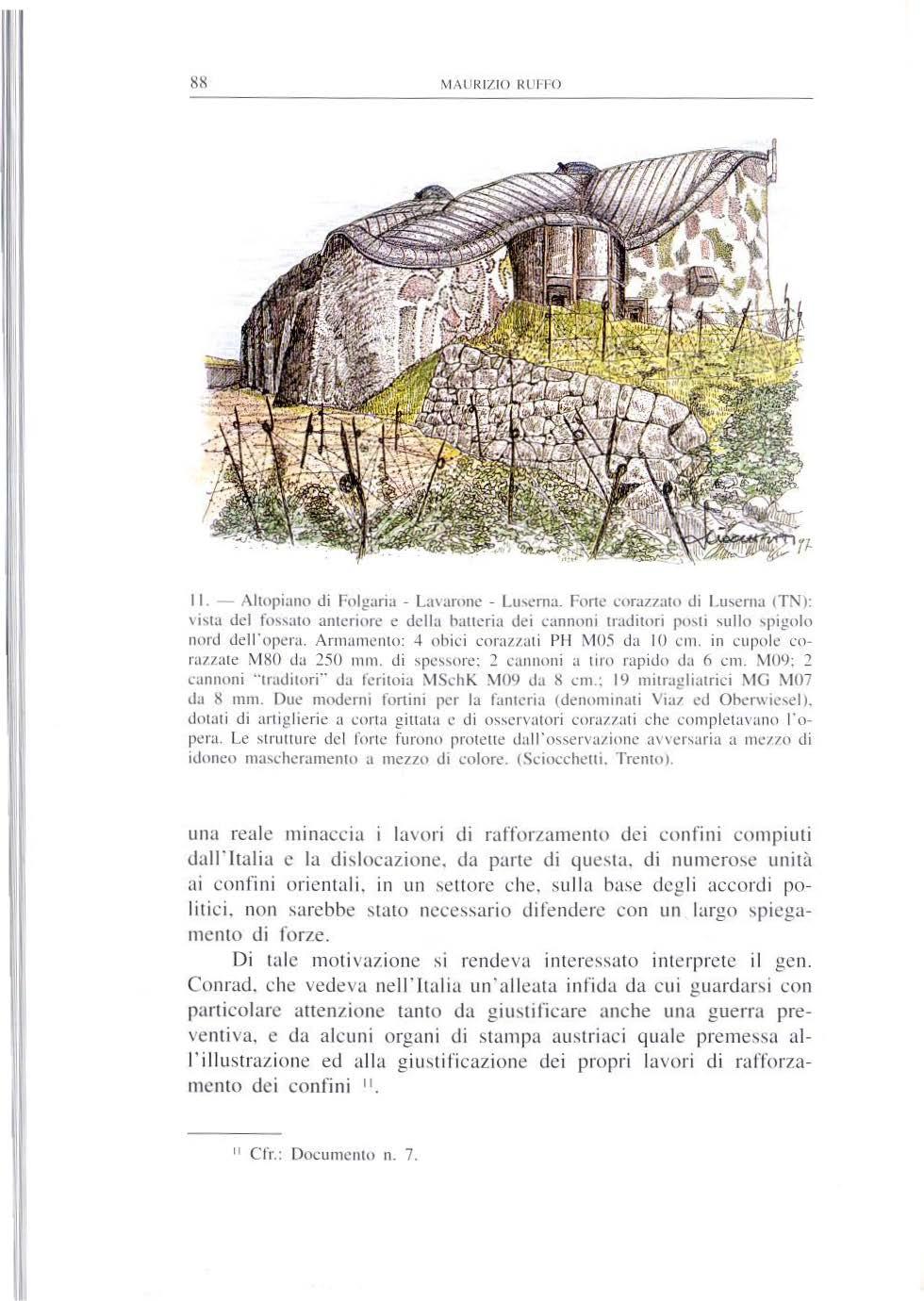
12. -Tren tu. Pone un i ficato (E in he its fon) c.Ji Mattare llo: 400 111. s. l.111 . Progettato seco ndo le direttive de l Comandante cie l Genio del X I V Corpo c.Ji lnnsbrud tenente mare~ciallo <..li campo Juliu~ Ritter von Vogl. Ultimato nel 1889. Arma111ento: -+ can noni MSchK M96 eia 12 cm. in ca nn oni era minima: 2 obici corazzati PH M99 eia 15 cm : 11 mitragliatrici MG M93 da 8 mm. (Sdocc hctli. Trento).
13. - Trento. Forte unificalO (Ein heitsfort) di Ro mag nano: 406 111. s.1.m. Progettato secon c.Jo le d irettive c.Je l Comandan te del ge nio del XIV Corpo di ln nsb ruck tenente marescial lo di campo Jul ius R itter vo n Yogl. Ult i mato ne l 1889. A rmamento: 4 can noni MSchK M96 eia 12 cm in can non iera minima: 2 obici corazza ti PH M99 da J 5 cm.: 2 can non i corazza ti PzK M 94P : I I mitraglia tr ici MG M93 da 8 mm. (Sc iocchett i . Tre nto).
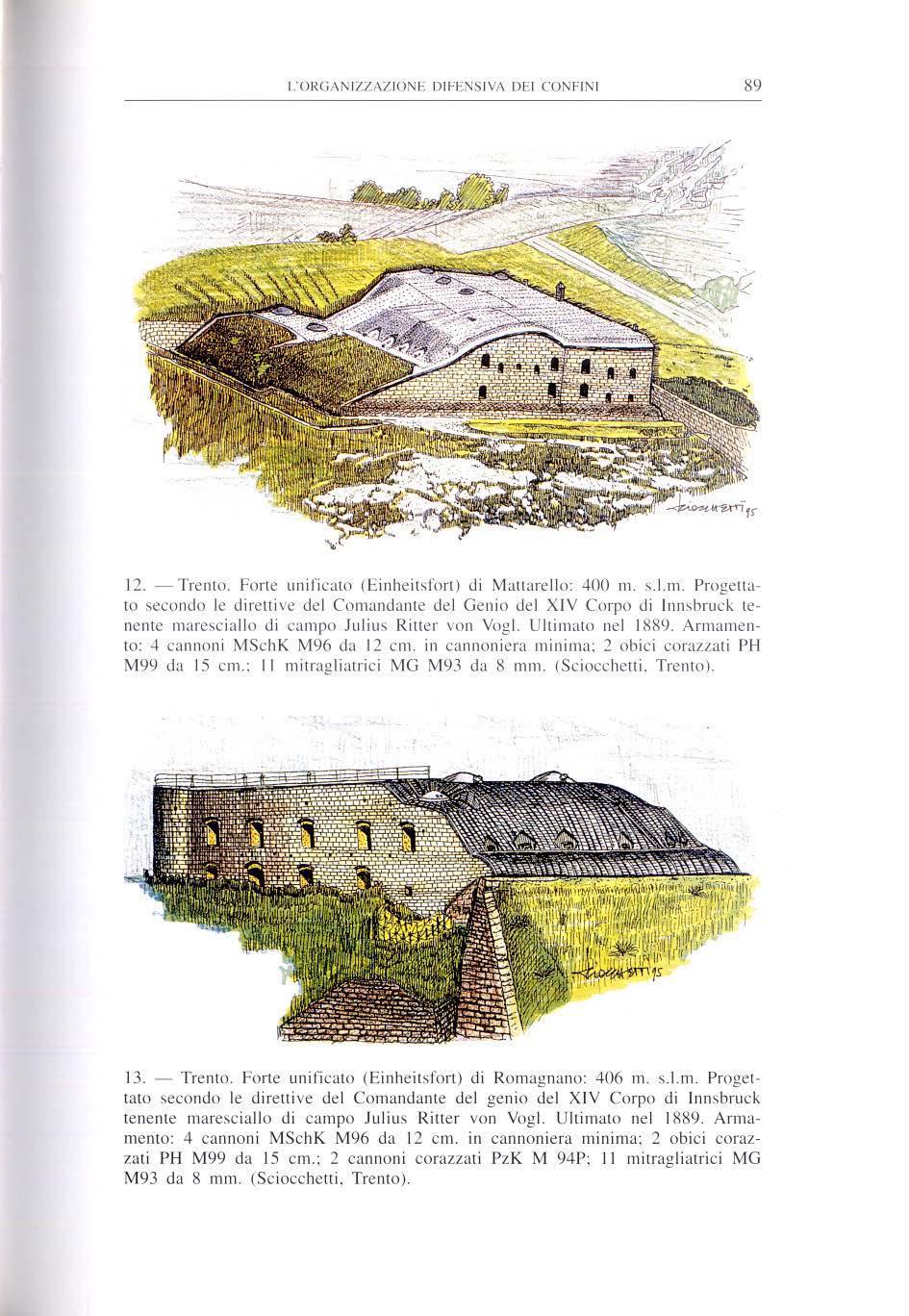
Questa attività impensieriva non poco lo stato maggiore italiano che in virtù delle ricognizioni oltre confine. svo lte con ciclica frequenza da parte di uffi ciali delle unità stanziate in località limitrofe. era in grado non so lo di aggiornare costantemente il quadro delle opere austriache in costruz io ne, ma era anche in possesso dei loro piani dettagliati. con le relative potenzialità e capacità belliche. nonché delle direzioni migliori da dove attaccarle e dei possibili sc hi eramen ti di artiglieria da dove batterle con la maggior efficacia possibile.
Ne lla memoria di una ricognizione oltre confine. operata dal capitano G. Castagnola nel 1898 nella zona cli Sesto di Pu s te ria nel1' Alto Adige orientale. in cu i s i descrivono le caratteristiche dei due forti posti a sbarrame nt o di eve ntuali penetrazioni italiane condotte da l Passo di Monte Croce Comelico in direzione della conca di San Candido (Jnnichen in tedesco) con obiettivo finale quella cli Dobbiaco. ve n gono infatti evidenziati questi aspetti.
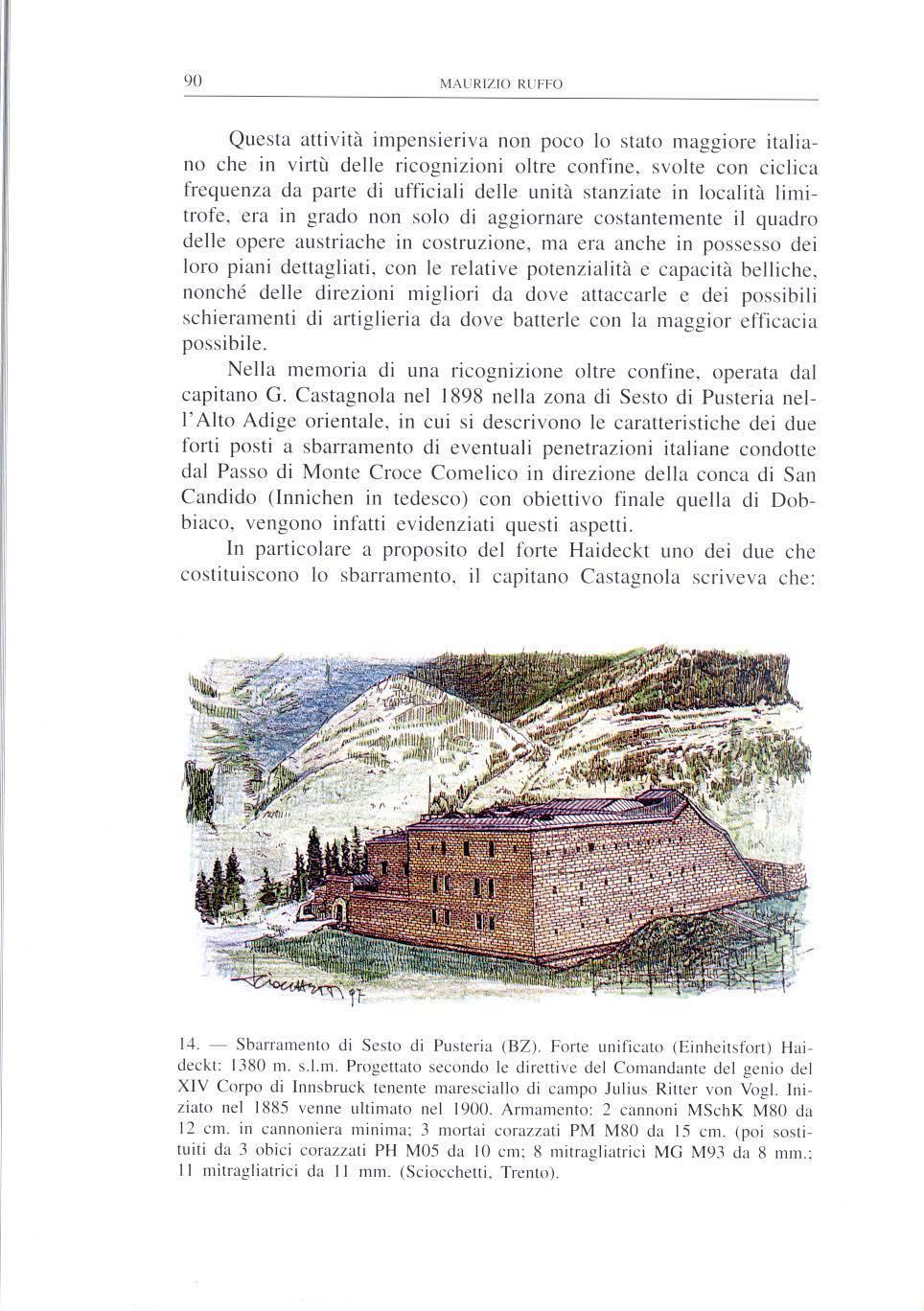
ln particolare a proposito ciel forte Haid eckt uno dei due che costi tui scono lo sbarramento. il capitano Castagnola scr iveva che:
I-+. - Sbarramento di Se sto di Pusteria (BZ). Forte un i fica l o (Einhcit sfon) Haidecld: 1380 111. s. l.111. Progettalo secondo le direttive de l Comandante del genio de l
XIV Corpo di Innsbruck tenente maresciallo di campo Julim, Riuer von Vogl. I nizia to nel 1885 venne ullimato ne l 1900. Armamento: 2 cannoni MSchK M80 da
12 cm. in cannoniera minima: 3 mortai corazzati PM M80 da 15 c m (poi sostituiti da 3 ob ic i corauati PH l'v105 da I O c m: 8 mitrag li atric i MG M93 da 8 mm : 11 mitragliatrici da 11 111111. (Sciocchelli. Trento).
... ognuno delle due rnse111c1/fe del fronte principale an::,iché essere armata cli u11 ca1111011e da c111 12 il1cm'a /cato su affusto o ca,moniero minima. è ormmo di 1 obice da c111 15 di acciaio incm·alcato parimenti s11 ajji1sro a cannoniero minima . l'cm11a111ento e/elle cannoniere all'::.iché c onsistere cli cn nnoni a tiro rapido e 111itragliere. comprende 1111Ì<Y1111e11te queste ultime: s i è pot11w al'ere certa noti ::, ia del loro numero e e/ella loro specie , si hanno cioè 4 mitragliere Maxim del calibro di 11 mm ed 1111a mitragliera Skoda del calibro di 8 m111. L 'amwmento dell'opera co n ste rebb e di 2 obici da cm J5 d 'acciaio in casematte cora::,zate. inc:01'alca ti s u (1[fì1sti a cannoniera 111i11i111a: 3 mortai da cm /5 d i bronzo in torri cora-::,::,ate Rirevoli: 4 mitragliere Maxim del calibro di 11 mm e 1 mitragliera Skocla del calibro cli mm 8. A1111almente nella parte del .fì·onte principale dell'opera corrispoll(/ente alle casematte si stanno ese -
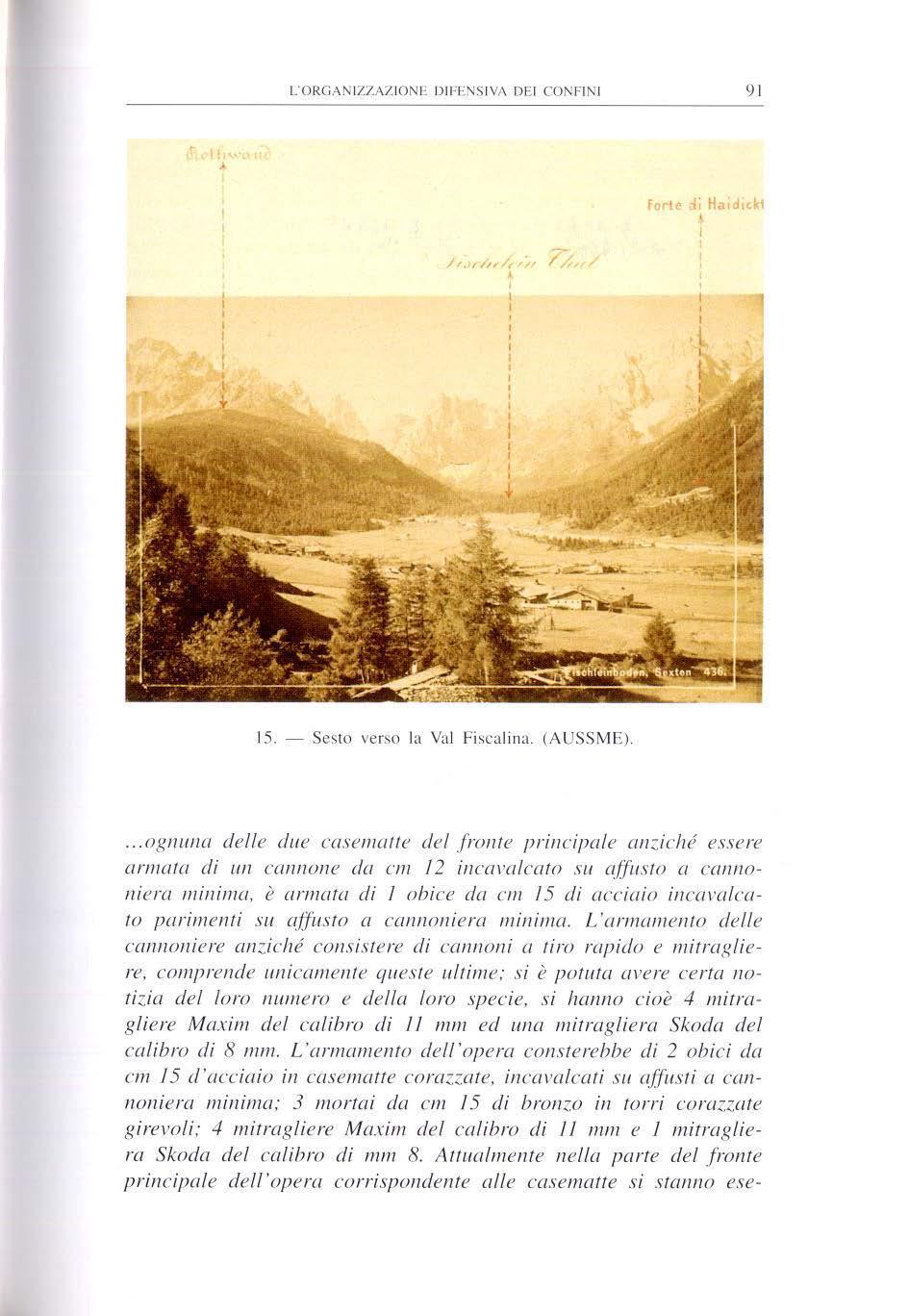
g u endo dei lal'Ori, che furono giudicati per propria ,·isione e per informa: ioni assunte, di semplice r es tauro ... 12 •
L'inte ress ante e completa rela z io ne. dopo aver precisato I· armamento dell'a ltro forte compo ne nt e lo sba rramento di Ses to, proseguiva desc rivend o quelle che, a g iudizio dell'ufficiale sarebbero s t ate le mi g liori posizioni dove sc hi e rare le batterie di artiglieria. destinate a s upport are le for7e atta cca nti. e quanti peui sa rebb e stato co ng ru o impiega rvi: .. . a Nord del d. di "Sexten Baci" , immediatamente ad Es , e nel rientrante della buona ca rrarecc ia c h e per il colle di Monte Croce ( K reu:berg) discende in 1errirorio a11s1riaco a Sexten .... il suo fi'on re permette /'impiego di 8 pe::i ... 13 •
Negli anni s uccessivi le autorità austriache portarono avanti I· attività di cos tru zione e di ammodernamento delle var ie opere con determinazione e sis te mati c ità tali da preocc upare lo s tato m agg iore italian o che, come abbiamo detto, continuava a te nersi agg iornat o s ul procede r e dei lavori m e diant e le ricognizioni o ltre confine .
Nel me r ito lo s t a to maggiore it a liano. nel 1903, aveva pubblica to una memoria s ullo stato dell e opere for ti l'i cate austriache sulla frontiera ital ian a, nelr Istria e in DalmaL.ia c he confermava I' ingen te sfo r7o sos te nuto dall'impero d a nubi ano nel particolare se tt ore 14 (c arta n. 2).
L'atti vità fortificatoria aust ri aca, a cu i s i aggiun se ro num e ro s i la vo ri occa<;ionali di approntamento di trin cera menti. baracche, caser m e e sp ianate pe r sc hieramenti di a rtigli er ia, continuò senL.a sos ta fino al maggio del 191 5 quando. lun go i principali acce ss i al se tt o re tre ntino-tiro lese e ne lla zo na di Tarvisio e Pred ii , erano o perati v i degli s barrame nti in grado di obbligare ad un tem poran eo arre s to l 'attacca nte I$ (ca rta n. 3) .
L'int ero s iste ma. in o ltre. era s tato congegnato in maniera tale da pote r gara ntire, in modo particolare ne l sa liente tre ntin o- tirolese, l 'afflu sso di forze destinate ad operare in c hia ve offe nsiva ve rso la pianura ven e ta, come poi realizzerà il ge n. Conrad nel 1916 co n la Strafexpedi1io11 16• e sos te n e rn e lo sfo rzo lo gis ti co .
12 Cfr.: Rela:ione d<'I capiwno G. Castagnola. AUSSY!E. G22. 27
n Cfr.: Ibidem.
1
• Cfr.: Memorie riguardanti le fortifi ca:ioni austriac he sulla fro111iera italiana, e Dalma zia 1903 , AUSSME
15 Cfr.: Comando del V 0 co rpo d'armata. Apprestamenti militari austria ci alla fro111iera italiana dal Garda al Passo di Mo111e Croce Comeli co, maggio I 915 .
AUSSME
16 Strafoxped ition: nel merito è da so tto lineare co me n ess un documento austriaco parli di strafexpedi tion anche se questo nome era sulla bocca di tanti . An-
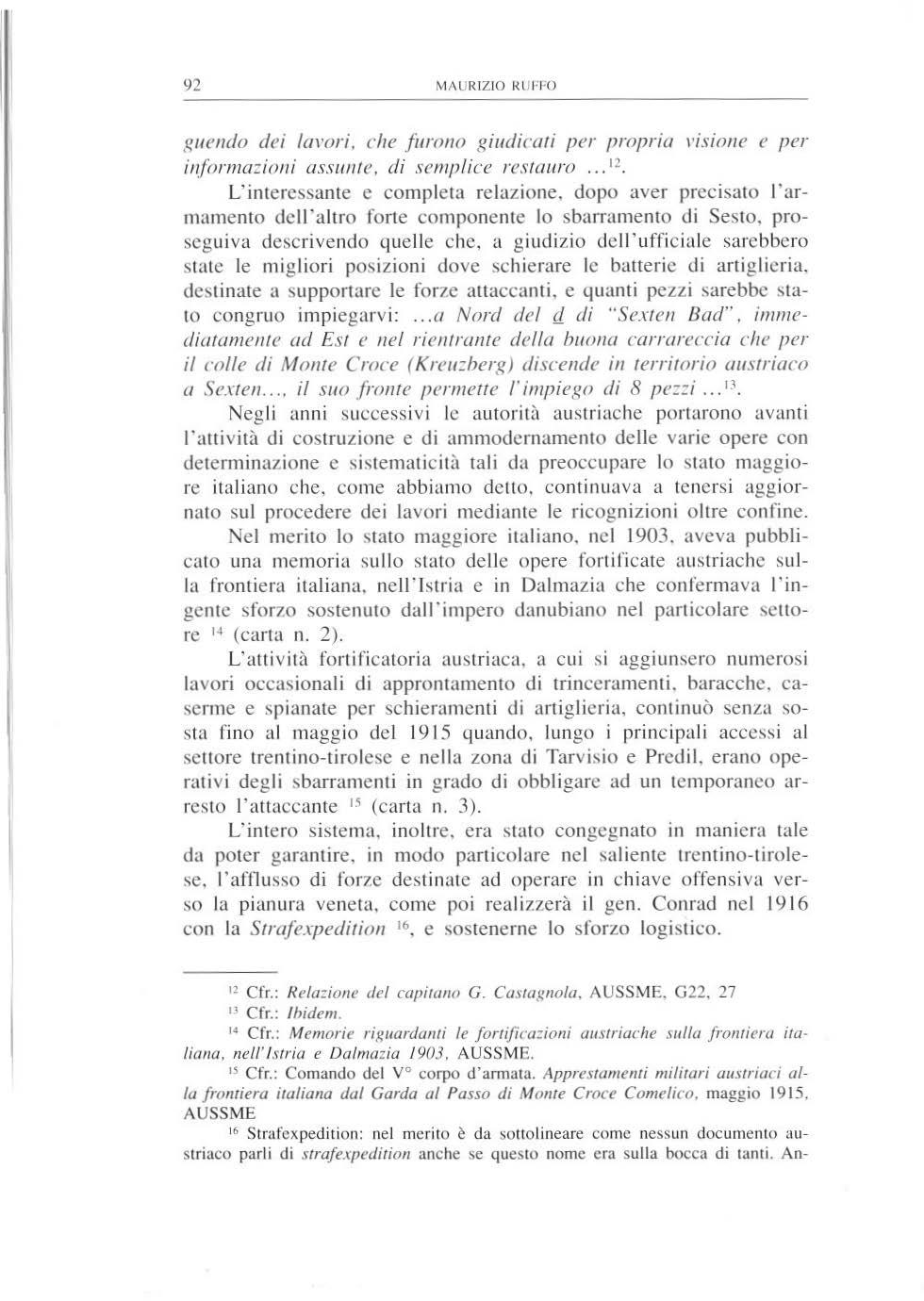
Una cura particolare venne pos ta dalle autorità austriache alla viabilità sia ferroviaria s ia ordinaria con lo scopo di agevolare il più possibi le la radunata dei reparti e d il loro schieramento lungo i l confine.
Lo sforzo princ ipale fu fatto lungo la frontiera friulana organizzando un eccellente rer.e ferroviaria che pcrmett.eva alle forze austriache di raggiungere celermente la linea d e ll ' I sonzo.
Anche il saliente trentino - tiro lese non fu trascurato provvedendovi con la costruzione di due I inee ferroviarie a sca rtamento ridotto 17 •
La prima, partendo da Trento portava a Malè, vicino al passo del Tonale, con una diramazione fino al passo del la Mendola dove , mediante una funicolare si collegava con Caldaro e, quindi, alle ferrovie meridionali austriache presso la stazione di Bolzano.
L ' altra univa la zona cli Rovereto Sud con Mori, Arco e Riv a, s ul lago di Garda, per poi proseguire per le Giudicarie da dov e, me diant e una s trada militare attraverso il passo cli Carlo Magno, si poteva agevolmente raggiungere il passo del Tonale attraverso Pinzolo oppure la conca cli Tionc attraverso il Ble gg io ed il passo del D urone.
A que s te lince , guerra durante, si aggiunsero quelle de ll a val di Fiemme, della val Gardena e la Dobbiaco-Co rtina per la cui cos tru zio n e gli imperiali fecero ampio ricorso ai prigionieri di guerra.
La s ituaz ione difensiva italiana sulla frontiera Nord - Est era cond izionata da vari fatto r i c he traevano origine da ll a rapida espansione dello s tato verso oriente determinata nei pochi anni precedenti , dalle diffico lt à economiche in cui si t rovava il nuovo regno e dal-
che nell'i mmed i ato dopoguerr a gli au tori it al iani non fecero mai ricor so a 1ale denominazio ne che ven ne usato solo dopo gli anni venti.
17 Le fer r ov ie austri ache a scarta mento normale r ientra vano nel le competenze del le au1ori tà central i dell'impero per evide nti motivi strategici, mentre quelle a sca rtamen to ridouo r ien travano nei programmi delle au tori tà pro vinc i al i (Lander). Per al tro va eletto che il programma ferroviario nel Sucltirol fu semp re avve r sato dall e au torità cen trali p er motivi economici (veri o presunti). La rete d i ele1rm·ie - così chiamate dal podestà cli Trento - non ven ne mai facil i tata g iungendo a forme cl i gr osso co ntrasto co n la parte tedesca del T irolo Me ri dionale pe r i l tracciato della l inea della val d i Fi emme. che i tedeschi volevano collegare a Bol zano e non a Tren to. Anc he la stessa linea della Vals ugana f u sem pre invisa e quando venne ina ugurata ( 1896) non era i n grado cli sopportare un t raffico pesan te o avere le cara tteris tich e - annan1ento - idonee ad un traffico interna z iona le.
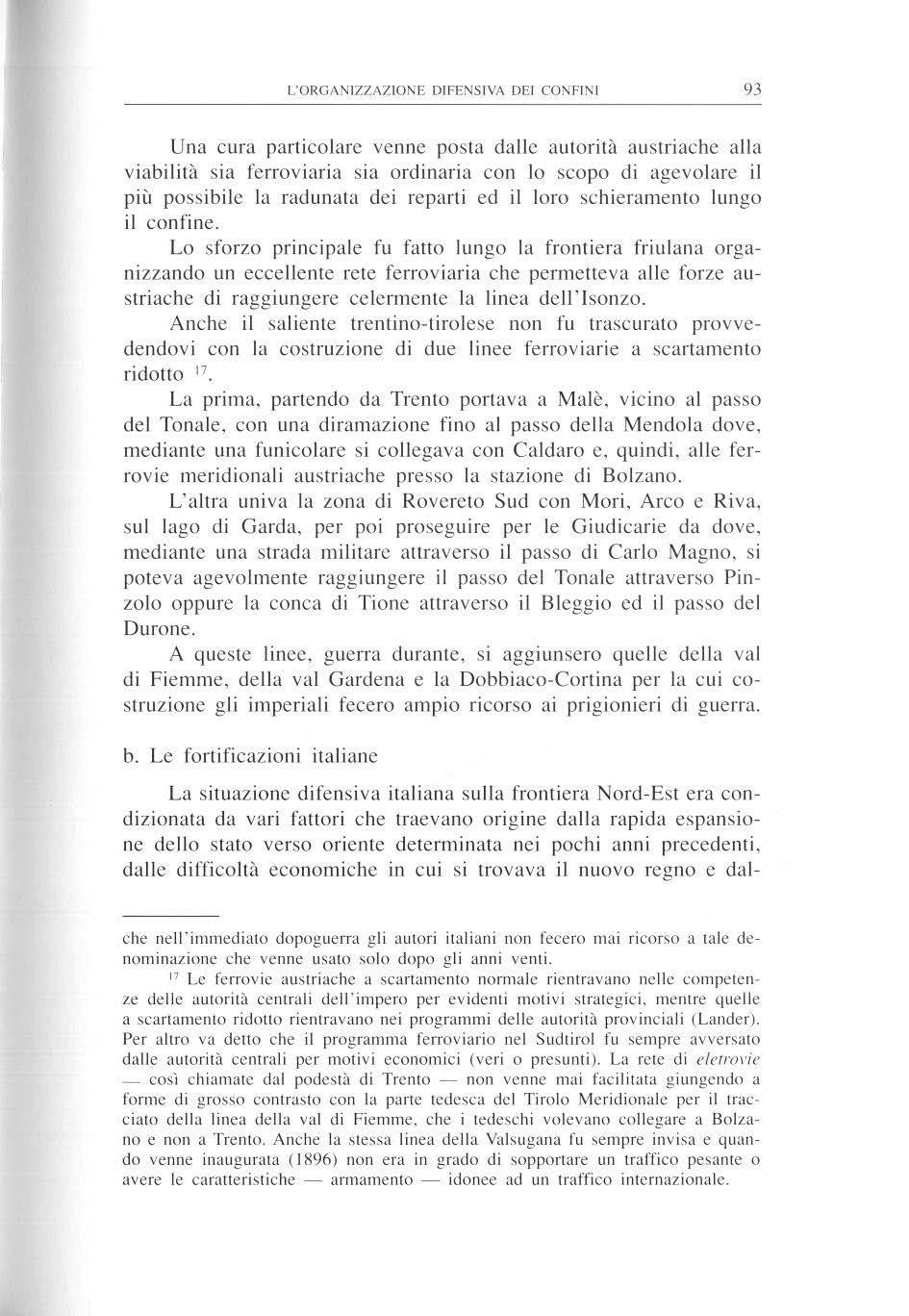
la neces~ità di rivedere l' intero quadro strategico nel cui ambito 1"1talia cercava di assumere una caratura di pote111a europea se non mondiale.
L. espansione ad E st aveva comportato J' acquisizione delle vecchie fortezze asburgiche del quadrilatero - Verona, Peschiera. Mantova e Legnago. della piazzaforte di Venezia e della città fortiricala di Palmano va.
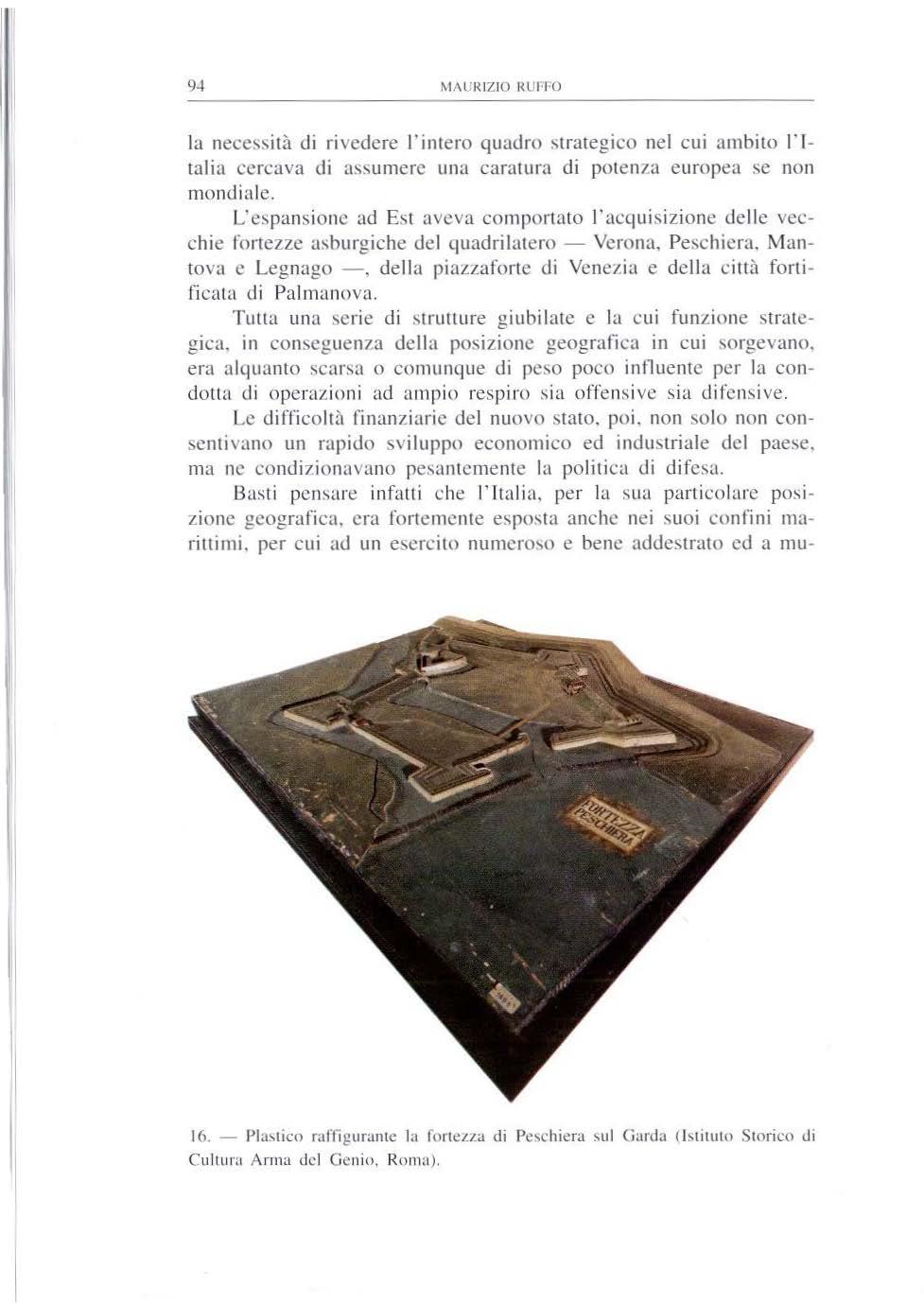
Tull a una ',Crie di strutture giubilate e la cui funLione strategica, in con egue111a della posizione geografica in cui '>Orgevano. era alquanto scarsa o comunque di peso poco influente per la condotta di operazioni ad ampio re spiro sia offensive sia <lifcnsi ve .
Le difficoltà finanziarie del nuovo stato. poi. non solo non concntivano un rapido \'iluppo economico ed industriale del paese, ma ne condizionavano pesantemente la politica <li difesa.
Basti pensare infatti che l' Italia. per la sua particolare posizione geografica. era fortemente espo"ta anche nei suoi confini marittimi, per cui ad un esercito numerO'>O e bene addestrato cd a mu -
nite piazzeforti terrestri per la difesa dei confini alpini doveva associare una marina altrettanto numerosa ed agguerrita e, comunque, in grado di svolgere un ruo lo d i difesa attivo in stretta cooperazione con le artig li erie cost iere e le forze terrestri destinate al la protezione dei litorali.
li quadro strategico, strettamente legato agli obiettivi di politica internazionale elci paese, non permetteva del resto ai vertici militari di pianificare e quindi organizzme lo strumento in una direzione piulloslo che in un 'a ltra.
Né d'altra parte l'adesione alla Triplice. seppur dando un orientamento apparentemente chiaro, era sufficiente a delineare coerenti obiettivi strategici per le forze armate in conseguenza s ia dei continui ondeggiamenti di politica interna z ionale da parte italiana, sia per gli atteggiamenti velatamente ostili degli austriaci che, in più di un'occasione , avevano lasciato perplesse le autorità politiche italiane, suscitando non pochi sos petti e dubbi sulla lealtà dell'alleato asburgico.
Per l'ftalia si presentava quindi la nece ss ità di assumere un determinato schieramento delle proprie forze in virtù degli orientamenti politici generali che la vedevano principalmente in contrapposizione , al fianco degli imperi centra li , con la Francia senza, tuttavia, potere trala sc iare di predisporre un adeguato sistema difensivo ad Est.
li problema della difesa verso la frontiera orientale era stato affrontato sin dal 1880 quando il generale Ricotti Magnani, alla commissione per lo st udio de ll a sistemazione a difesa del teatro della guerra Nord-Est ix, presentò una serie cli propos te tendenti ad organizzare la radunata e lo schieramento ini z iale dell'esercito in caso di un a guerra contro l'Au stria -Ungheria.
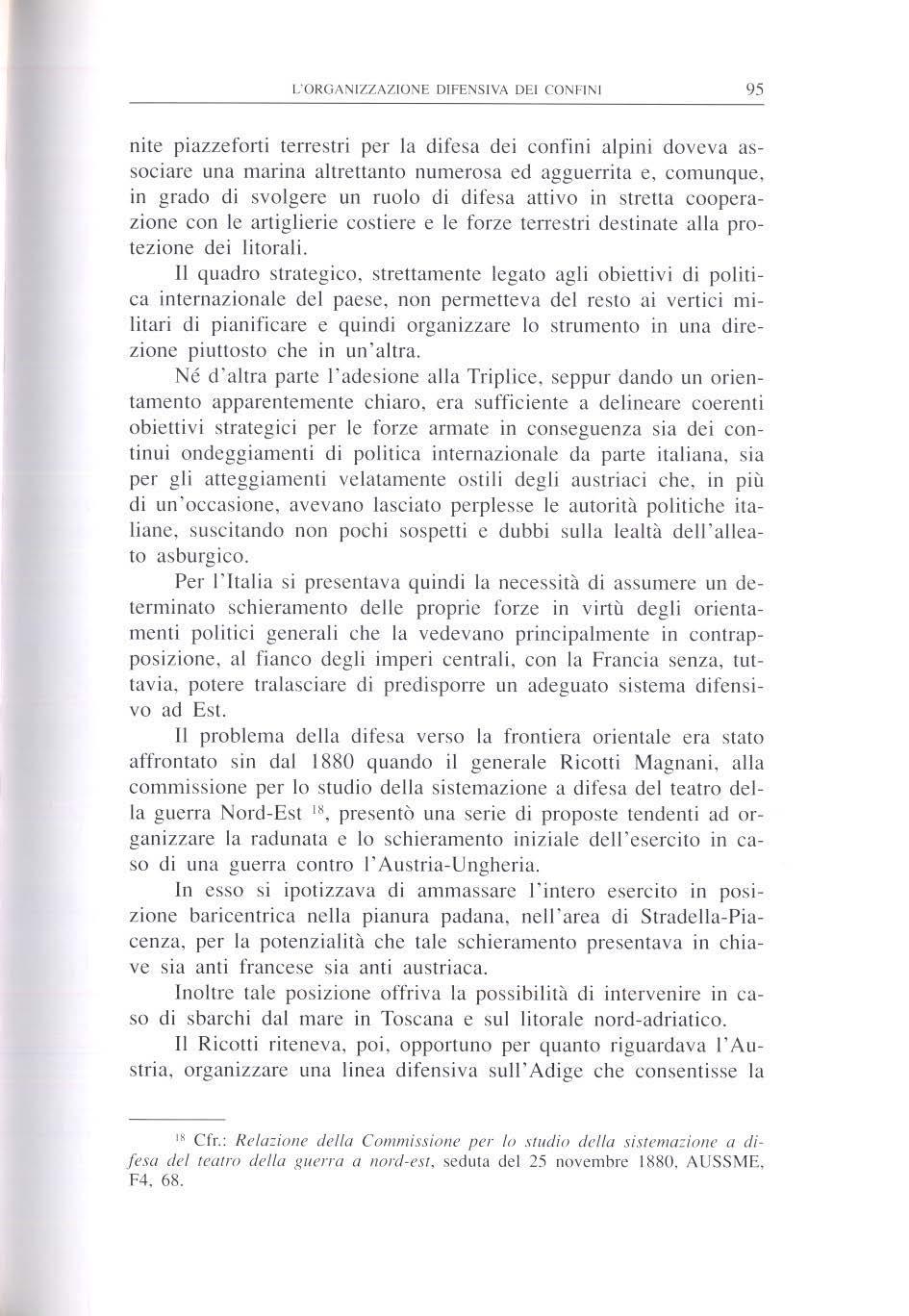
ln esso s i ipotizzava di ammassare l'intero esercito in posizione baricentrica ne ll a pianura padana. nell ·arca di Stradella-Piacenza, per la potenzialità che tale sc hieramento presentava in chiave sia an ti francese s ia anti austriaca.
Inoltre tale posizione offriva la po ssibilit à di intervenire in caso di sbarchi dal mare in Toscana e s ul litorale nord-adriatico.
Il Ricotti riteneva, poi. opportuno per quanto riguardava l'Austr ia, organizzare un a lin ea difensiva s ull'Adig e che consentisse la
1 ~ Cfr.: Rela:ione della Commis~io ne per lo s111dio della sistema:ione a difesa del teatro della guerra a nord-est, se duia de l 25 novembr e 1880. AUSSME, F4. 68.
manovra per lince interne delle forze e sulla quale potersi appoggiare in caso di controffens iva al di là di esso o, in ultima ana lisi, utili zza rla come copertura in caso di ritirata.
Tuttavia il Ricotti osservava che: non si nasconde rhe un fiume come l'Adige a1·e11te una media larghe::a di soli 100 metri e numerose strade d'accesso, diffi"cilmente potrehhe essere a lungo difeso e qualora alfaccato da for:e SO\'\'erchiant i su tutto il suo ampio fronte potrehhe in qualche tratto essere forwto ed in una sola giornata artraversato da for:e considerevo li tali da potersi mantenere sulla riva opposta.
Per queste ragioni parrebbe meno opportuno /' impianto sul/' Adige di 1·ere piazze di 1° ordine quali sa rebhem necessarie ad assicurarci una lunga difesa. ma si reputerehh ero suffi"cie11ti delle forte::e di 2° ordine su lle comun ica:ion i principali che attra1 ersano il fiume. colle quali fortezze si avrehhe fondata spe ran :a di rallentare l'inseguimemo del nemico e romere l'accordo .fi"a le sue g randi masse.
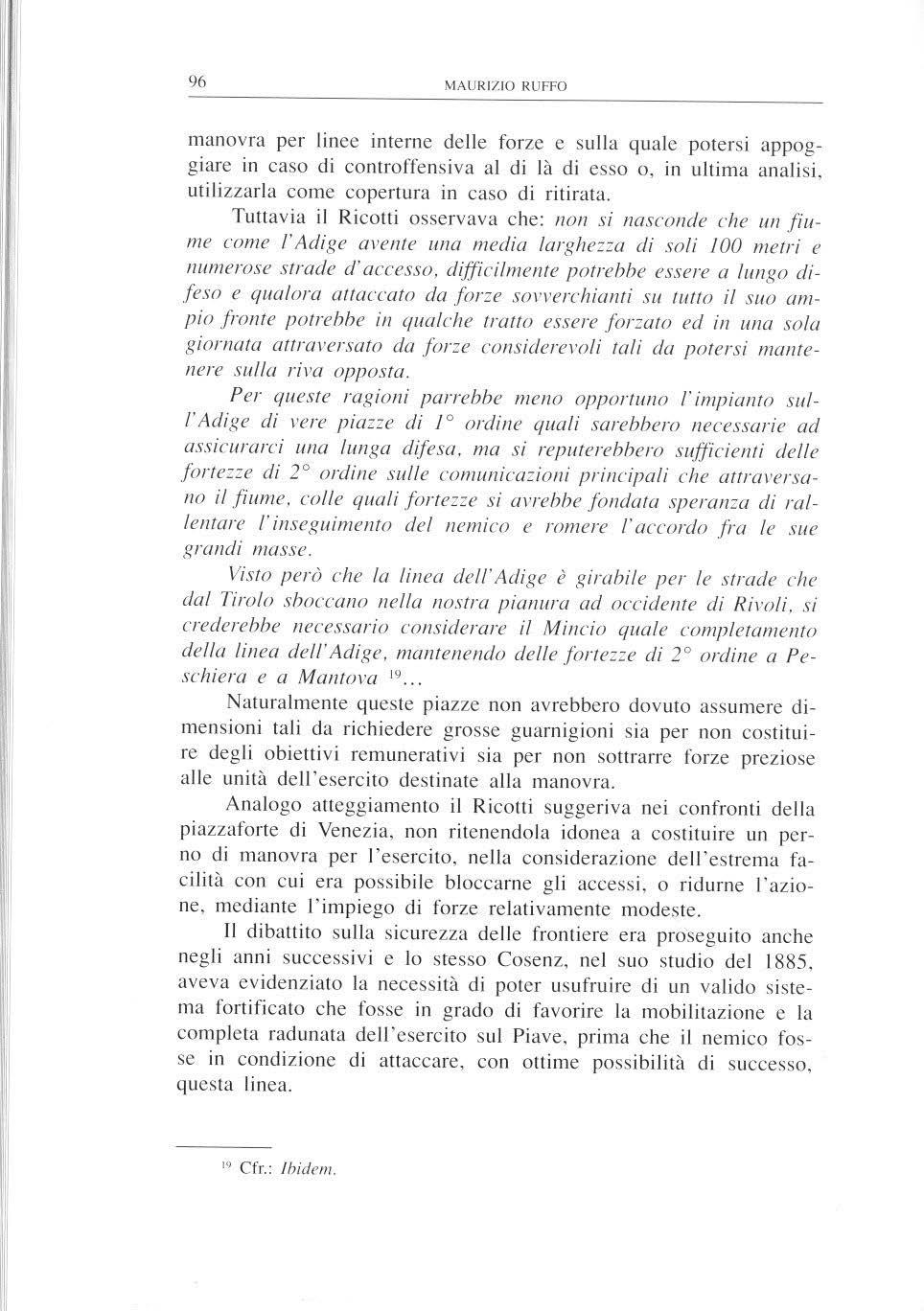
Visto però che fa lin ea dell'Adige è gi r ab ile per le strade che dal Tirolo shocca no nella nostra pianura ad occidente di Rirnfi , si crede rebbe nec essario co n siderare il Mincio quale com pl eta mento della linea del/' Adige, mantenen do delle flme::e di 2 ° o rdin e a Peschiera e a Mantova 19 •••
Naturalme nt e qu es te piaz ze non avrebbero dovuto assumere dim e nsio ni tali d a ri c hi e d ere grosse g ua rni gio n i sia per non costituire degli ob iett ivi r e mun e rat i vi s ia per non so ttrarre fo r ze pre z iose a ll e unità d ell'ese r c ito d es tinate a ll a ma novra.
Analogo attegg iam en to il Ri cotti s ugger iva nei co nfr on ti della pia zz aforte di Venezia, non ri tene ndola ido nea a cos t ituir e un perno di manovra per l 'esercito, nell a co n s id eraz ione dell'e s tre ma facilità con c ui era possibile bloccarne g li accessi, o ridurne l 'azione, me di a nt e l ' impiego di forze relativamente mode s te.
TI dibattito s ulla s icurezza de l le fron ti e re e ra proseg uito anche ne g li anni success ivi e lo s tesso Cosen z, nel s uo studi o d e l 1885, aveva ev id enzia to la necessità di pote r us ufr u ir e di un va lid o s istema fortificato c he fosse in gra do di favorire la mobilita z io ne e la compl e ta ra dunata dell'ese rcito s ul Pia ve, prima che il nemico fosse in co ndi z ione cli attaccare, con o ttim e possi bilità d i s uccesso, qu es ta lin ea.
Si era infatti presa coscienza della necessità di rafforzare la zona montana, corrispondente al teatro cli operazioni del Veneto, nella considerazione che tale scacchiere è avvolto dalla frontiera su tre lati: Est, Nord ed Ovest.
Questa esposizione dei confini presentava uno stato cli insicurezza per le operazioni di radunata delle forze italiane, salvo che non fosse stata predisposta una robusta cintura di fortificazioni in grado cli dare quella cornice di sicurezza necessaria ad un ordinato svolgersi delle operazioni della radunata stessa.
Le unità schierate nella pianura veneta, infatti, non avrebbero potuto procedere verso il Friuli senza esporre il tergo a forze austriache provenienti dal Trentino, né avanzare verso quest'ultimo senza scoprire il fianco verso quelle radunate sull'Isonzo.
Ciò comportava una ridefinizione dell'intero assello clifensivo clel1a frontiera nord -es t, problematica che, nel 1889. veniva affrontata in maniera approfondita e concreta clal1a Commissione speciale, nominata dal ministro della guerra, con il dispaccio 17 marzo 1899 - n. 1770, e presieduta da Sua Altezza reale i I principe di Napoli 20 Intervenendo in essa il tenente generale Saletta, nuovo capo di stato maggiore dell'esercito, rammentava i criteri che, sulla base delle deliberazioni emanate circa un ventennio prima dal comit.ato di stato maggiore, avrebbero dovuto servire come base dell'assetto difen sivo della frontiera Nord -Es t.
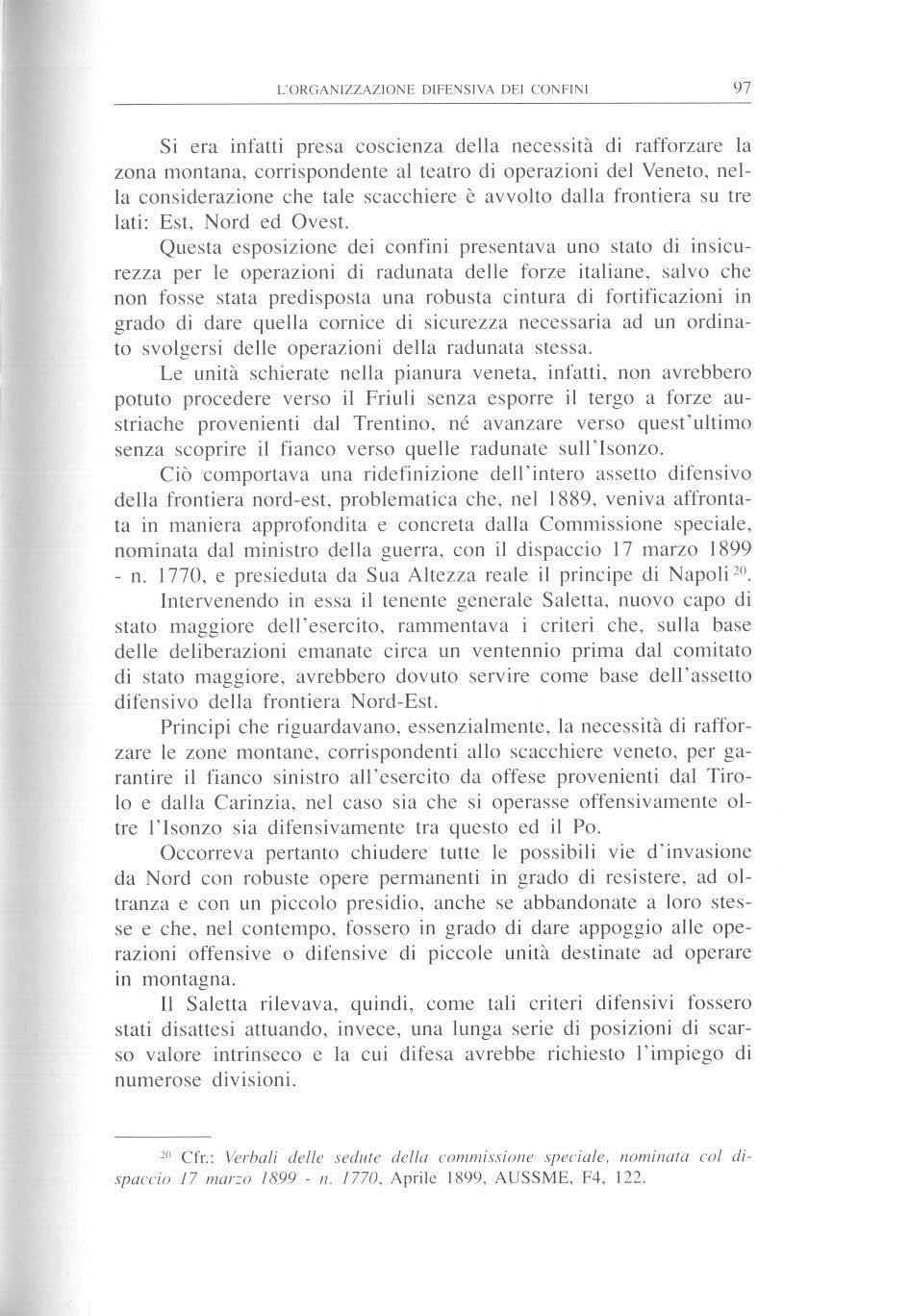
Principi che riguardavano, essenzialmente, la necessità di rafforzare le zone montane, corrispondenti allo scacchiere venero , per garantire il fianco sinistro ali 'esercito da offese provenienti dal Tirolo e dalla Carinzia, nel caso sia che si operasse offensivamente oltre l'(sonzo sia difensivamente tra questo ed il Po.
Occorreva pertanto chiudere tulle le possibili vie d'invasione da Nord con robuste opere permanenti in grado cli resistere. ad oltranza e con un piccolo presidio, anche se abbandonate a loro stesse e che, nel contempo, fossero in grado di dare appoggio alle operazioni offensive o difensive di piccole unità destinate ad operare
li Saletta rilevava, quindi, come tali criteri difensivi fossero stati clisaltesi attuando, invece, una lunga serie di posizioni di scarso valore intrinseco e la cui difesa avrebbe richiesto l'impiego di numerose divisioni.
Il capo di stato maggiore richiamava, pertanto, la necessità di rispettare i principi a suo tempo assunti; tuttavia notava anche che, con l 'aumento della potenza delle artiglierie, che venivano adottate in quegli anni, costruire delle opere che fossero in grado di resistere ad attacchi su tutti i lati avrebbe comportato il ricorso a costruzioni troppo costose; era quindi preferibile concentrare la massima potenza nella sola fronte d'a11acco.
I lavori della commissione proseguirono anche l'anno successivo con lo scopo di approfondire gli aspetti non ancora analizzati e, sulla base delle esigenze individuate, definire la priorità delle opere da realizzare sia nel campo fort ifi catorio che in quello viario che costituiva l'altro grosso problema nell'ipotesi di una guerra a nord- est. per l'assoluta insufficienza della rete ferroviaria esistente nel Veneto.
Come con lo studio del Cosenz anche lo sviluppo dato al rafforzamento dei confini era costantemente oggetto di revisione da parte del comando del corpo di stato maggiore che, periodicamente, organizzava delle esercitazioni per i quadri, chiamate viaggi di stato maggiore, al fine di verificarne la validità alla luce delle possibili azioni avversarie.
In quello effettuato nel 1904 il capo di stato maggiore pro tempore metteva a confronto le condizioni difensive austriache con quelle italiane in base alle diverse ipotesi operative. e cioè: attacco austriaco dal Tr entino, dalla conca di Dobbiaco o dal! 'Isonzo; attacco italiano rispettivamente in Tren tino , a Dobbiaco o sull '[sonzo 2 1• Ognuna di queste ipotesi evidenziava la necessità di poter disporre di un robusto sistema difensivo e, dal confronto con le opere già re alizzate o in via di realizzazione austriache e italiane, il quadro appariva nettamente a favore delle prime.
In merito il Saccoman, nella sua opera s ul genera le Paolo Spingardi mini stro del la guerra 22 , osserva come dal 1880, nonostante la riconosciuta necessità di sba rrare la frontiera aperta friulana. si era con tinuato ad elucubrare nel campo degli studi mentre gli austriaci avevano, sin dal 1897, iniziato i lavori di potenziamento delle fortificazioni nel Trentino 2-1
21 Cfr.: Rela:ir111 e del riaggio di SlalO Maggiore rle l/'w111 0 190.:/ - Frontiera Nord-Es, · AUSSME, F4. 60.
22 Cfr.: Andrea SACCOMAN. Il generale Paolo Spin g ardi minis tro della guerra (1909 - 19/4). USSME, Roma 1915.
2 ' In questo periodo si po se mano al riordino delle vecchi e fortifica7io ni mentre le nuove vennero costruite Ira il 1907 e 1·iniz io dell e o stilità. Solo dopo
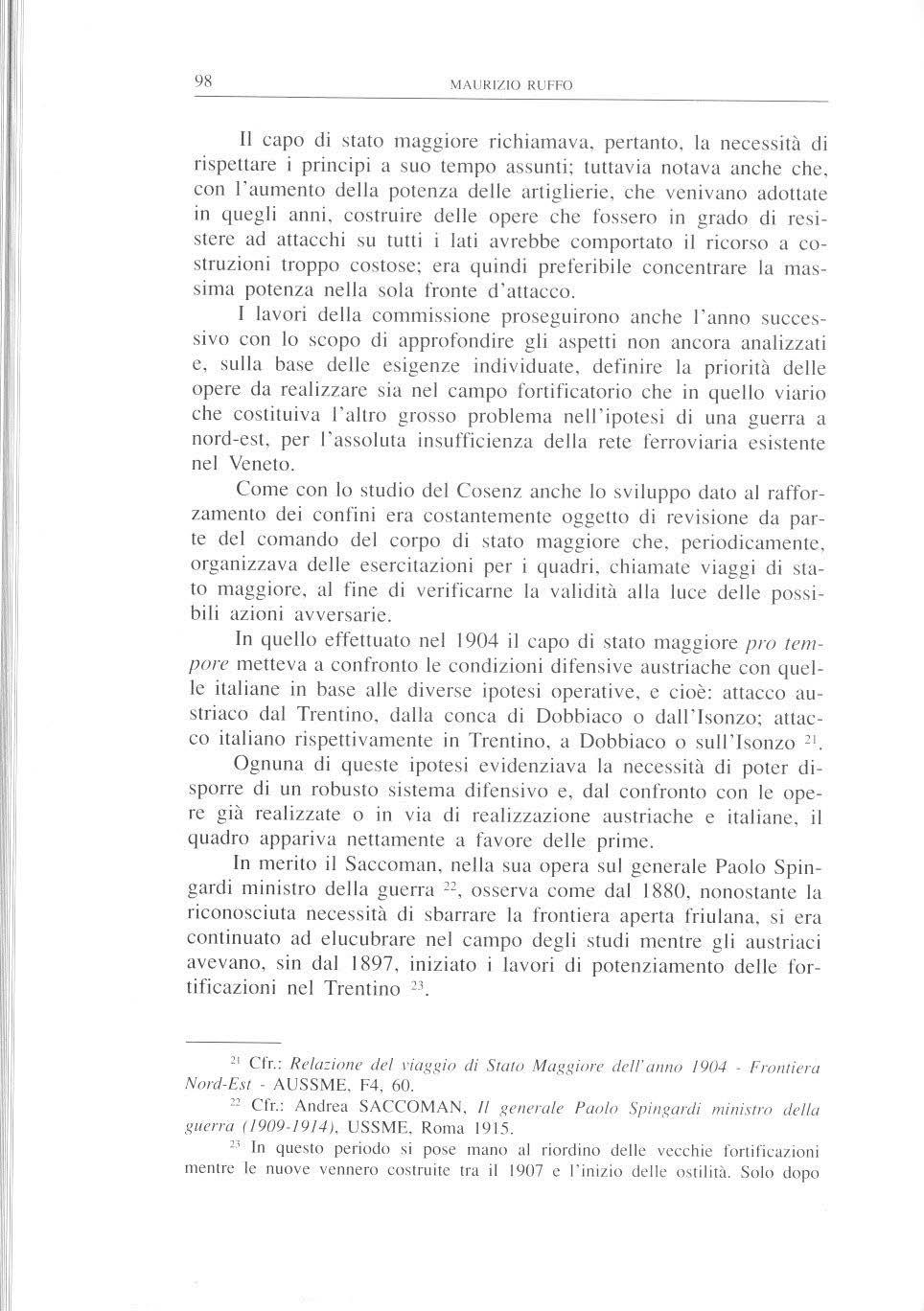
La relazione finale del viaggio di stato maggiore, nel ribadire il concetto che: le fortijica:ioni da costruire dehho110 co11se11rirci di arres{(Jre r invasore sulle principali linee di marcia che arrra1 •ersww fa jì-ontiera per una dura{(J 11011 inferiore ai 20-25 giorni. che occorrono alle nostre truppe per radunarsi e completarsi ... 24 evidenziava quelle che, pur limitate al minimo indispe nsabile per le ristrettezze finanziarie del paese, andavano comunque costruite per soddisfare ai requi s iti richiesti.
In particolare dovevano essere ubicate ed avere una struttura solida tale da essere in grado di resistere. per il tempo richiesto anche se isolate ed impossibilitate a ricevere rinforzi, ad una serie di atlacchi portati da forze più numerose appoggiate da batterie cli artiglieria cli medio calibro: dovevano. inoltre, avere in dotazione tutti gli elementi necessari per potere, sin dall'inizio delle ostilità, essere operative al massimo livello.
Nello studio venivano quindi esaminati, nel dettaglio, tulli gli sbarramenti esistenti con i lavori già condotti e, per alcuni. propost i quelli ritenuti più necessari.
L'opportunità di questi lavori venne, peraltro, ribadita sia dalla commissione suprema mista per la difesa dello stato che aveva definito un programma specifico s ulla base delle indicazioni fornite dal la commissione d'inchiesta del I 907, sia dal generale Saletta in un memoriale 2 ~ indirizzato al mini st ro della guerra nel maggio del I 908.
In esso si ribadiva la validità della scelta della linea del Piave per la radunata dell'esercito effettuala a seguito delle conclusioni ciel comitato di stato maggiore del 1880 e delle due successive commissioni speciali del 1899 e 1900.
In esso si sottolineava come più che mai era valida la scelta del Piave in quanto se si fosse adottata la soluzione di radunare l 'esercito dietro il fiume Adige, come sos tenevano alcuni, si sarebbero provocati danni enormi all'intero apparato sia per i soldi investi ti nelle opere fortificator ie, in via di realizzazione lu ngo il confine trentino-tirolese e lungo il Tagliamento, e nella costruzione di ferrovie e di strade che sarebbero così tornate utili al! 'avversario,
l a fine del seco lo vennero e~eg uiti i forti deg l i A lti p iani. di Lavarone, di Luserna e Folgaria, il forte Por a Lardaro, il forte Prc sanclla al Tonale ed i l forte Garda a Riva.
1° Cfr.: lhidem. pag. 109.
15 Cfr.: Memoria!<' a S. F.. il ministro della guerra circa la difesa della ji-011tiera Nord-F:st. AUSSME, G22, ?.7.
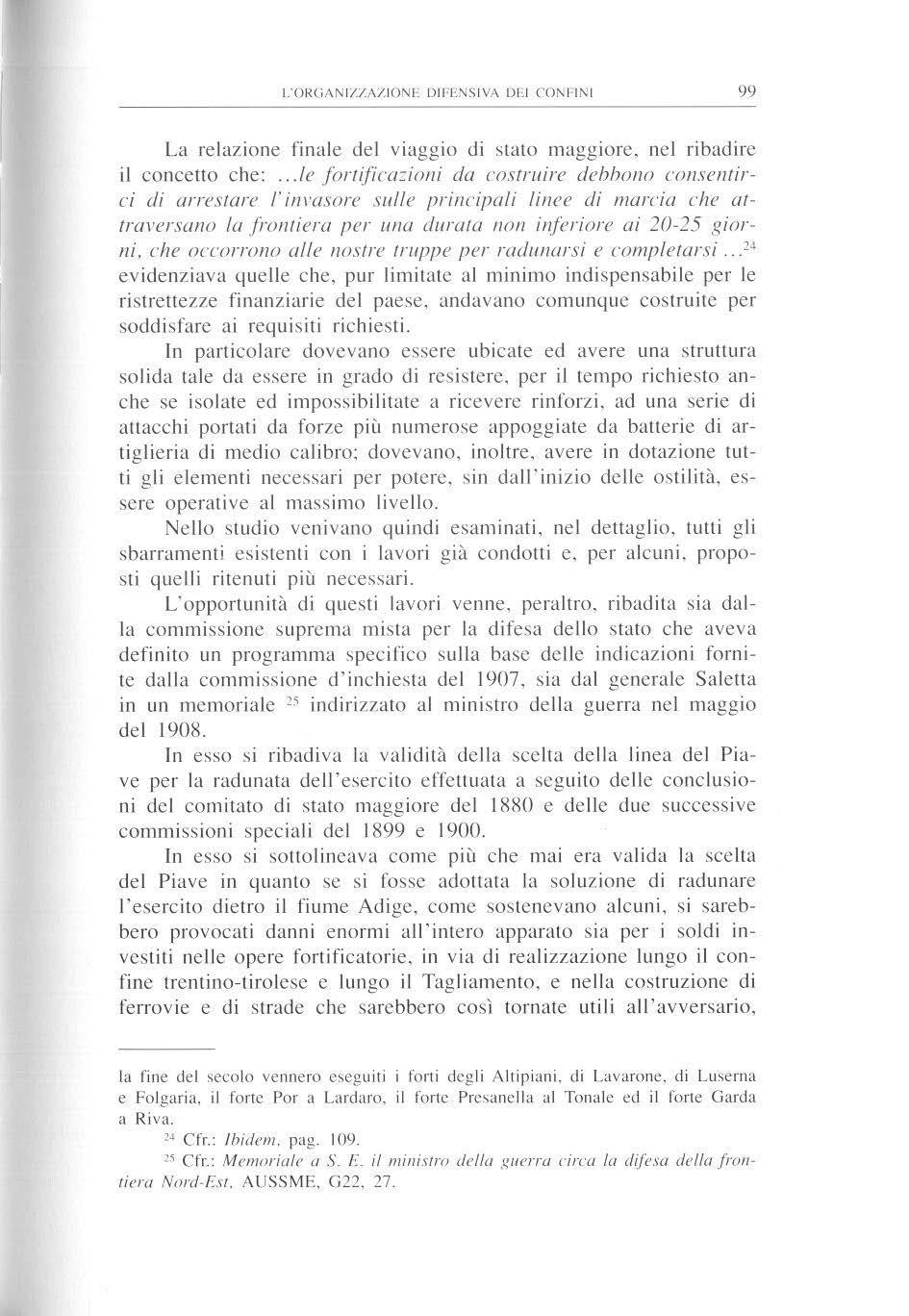
17. - Forte Ceraino. Dopo i lavori di rimodernamento , il s uo armamento. come la btr bas sa del la Tagliata d'ln canal, era interametnc in casamatta. ( C.do fTASE, Verona). sia per le ripercussioni morali che l'abbandono della pianura veneta avrebbe provocato nella nazione.
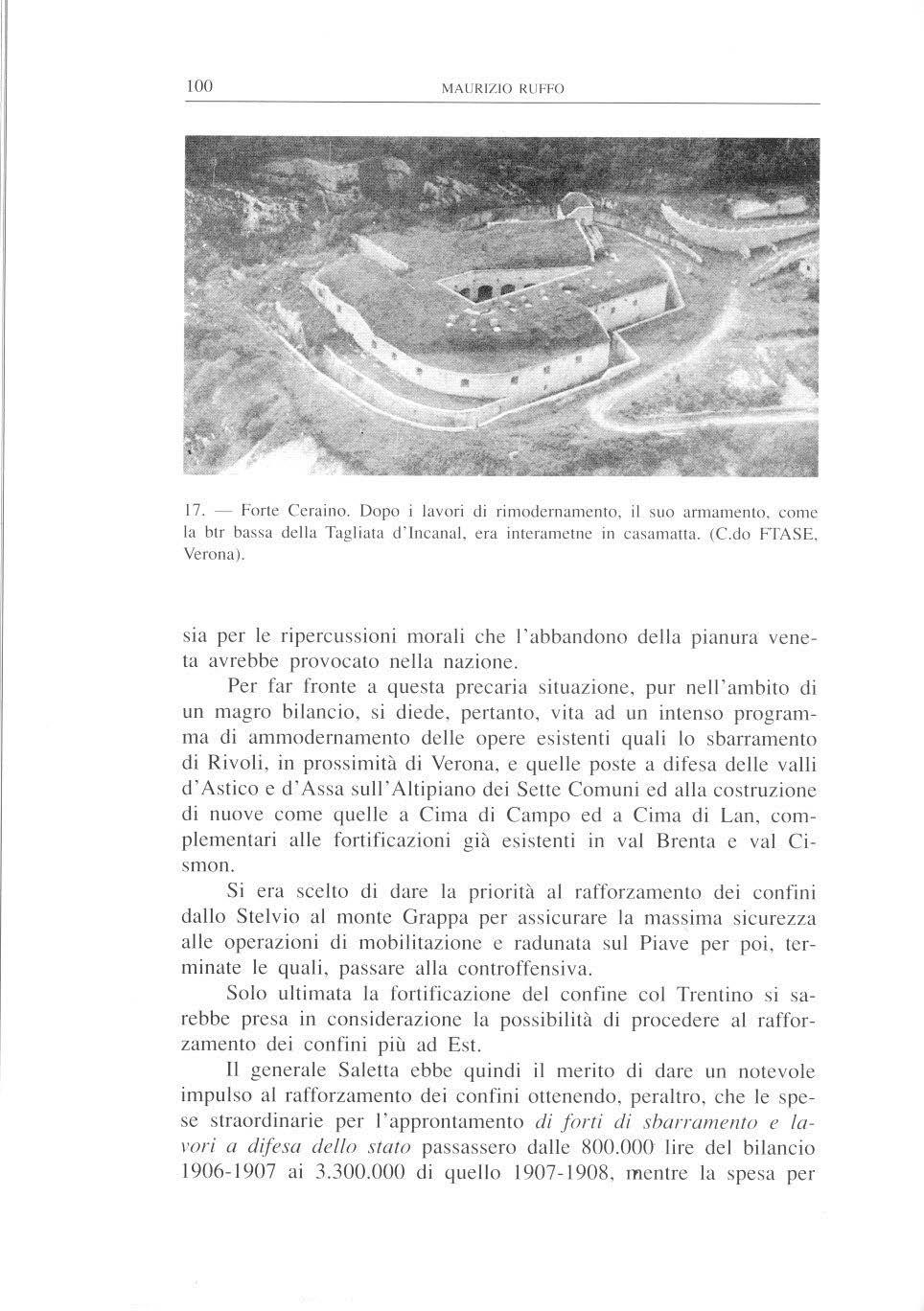
Per far fronte a questa precaria situazione, pur nel! 'ambito cli un magro bilancio, si diede, pertanto, vita ad un intenso programma cli ammodernamento delle opere esistenti quali lo sbarramento di Rivoli, in prossimità di Verona, e quelle poste a difesa delle valli d 'Astico e d 'Assa sul!' Altipiano dei Sette Comuni ed alla costruzione cli nuove come quelle a Cima di Campo ed a Cima cli Lan, complementari alle fortificazioni già esistenti in val Brenta e val Cismon.
Si era scelto cli dare la priorità al rafforzamento dei confini dallo Stelvio al monte Grappa per assicurare la massima sicurezza alle operazioni di mobilitazione e radunata sul Piave per poi, terminate le quali, passare alla controffensiva.
Solo ultimata la fortificazione del confine col Trentino si sarebbe presa in considerazione la possibilità cli procedere al rafforzamento dei confini più ad Est.
li generale Saletta ebbe quindi il merito di dare un notevole impulso al rafforzamento dei confini ottenendo, peraltro, che le spese straordinarie per l'approntamento di forti di sbarramento e la1·ori a difesa dello stato passassero dalle 800.000 lire del bilancio
1906 - 1907 ai 3.300.000 cli quello 1907-1908, mentre la spesa per
18. - Forte Rivoli. La fotografia a s1n1stra riproduce il fronte principale dell 'opera ali 'inizio degli anni 1860. Sulla sua som mit à s i possono intravedere le bocche da fuoco s ist emate in barbena (!): l ' in gresso (B), di c ui si intravede la s trada di accesso, era nella parte posteriore de ll'opera. L'immagine a destra rappresenta i l forte dopo le modifi c he apportate dagli Italiani negli anni 1880- 85. Notare la btr. casama tta (A) ed il camb iamento di ingresso ( B) dovuto all'i nvers ione del fronte principa le.
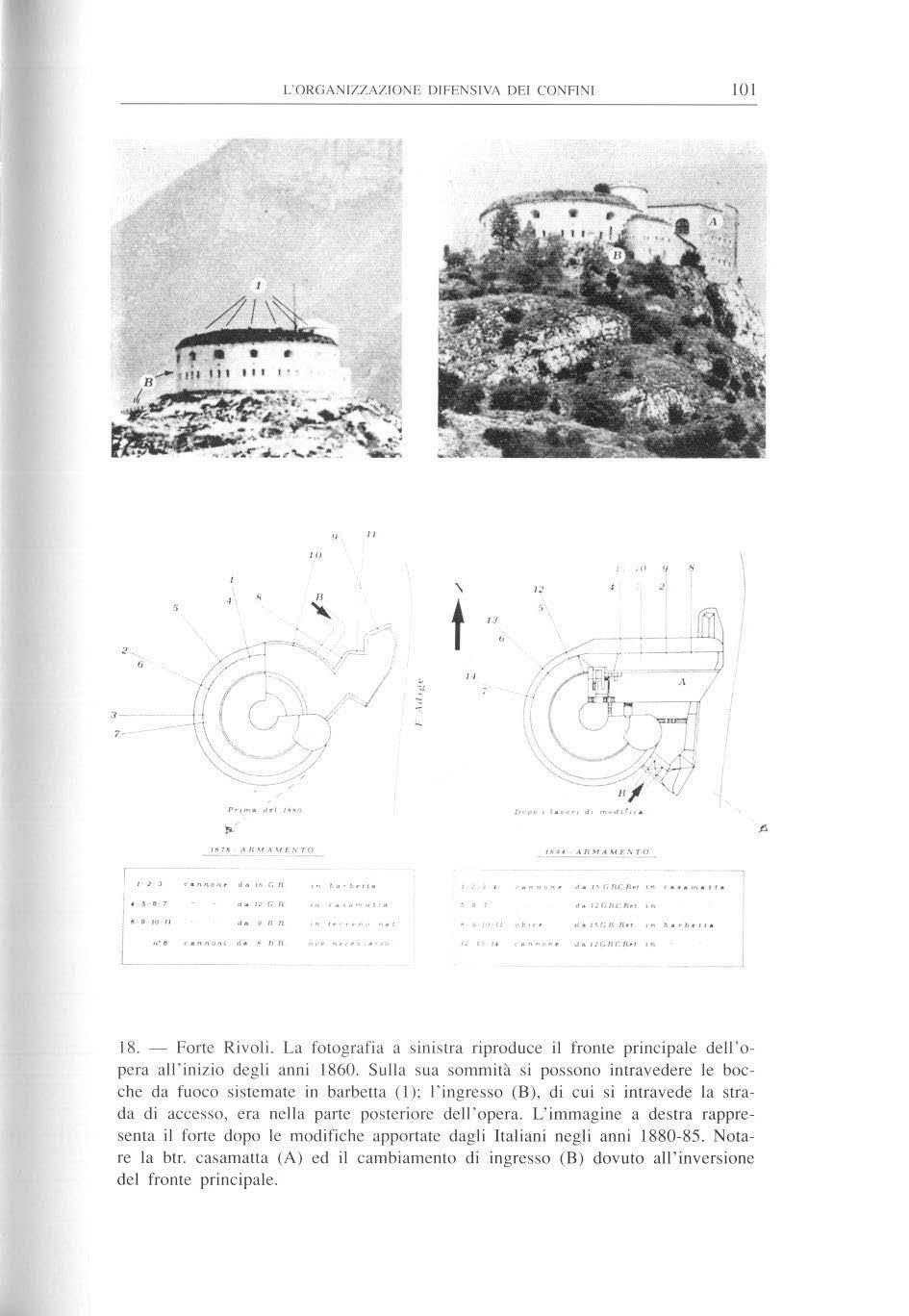
l'armamento delle fortificazio n i passava . nello stesso periodo. da 2.000.000 a 3.700.000 di lire 26
ln ques t a sua opera il ca po d i stato magg iore trovò nel ministro della guerra, il genera le Paolo S pi ngardi assu r to a tale carica nel febbraio 1909, un prezioso alleato che non solo sostenne inpPa rl a m e nto l ' in d ispe n sab il it à d i n uov i stanz ia m e n t i , ma cos t ituì u n pungolo continuo per l"accelerazione dei lavori emanando, con una circolare del 7 luglio 1909, apposite direttive nelle qual i sottolineava la necess ità d i u n' intens i ficazione dei lavo ri stess i .
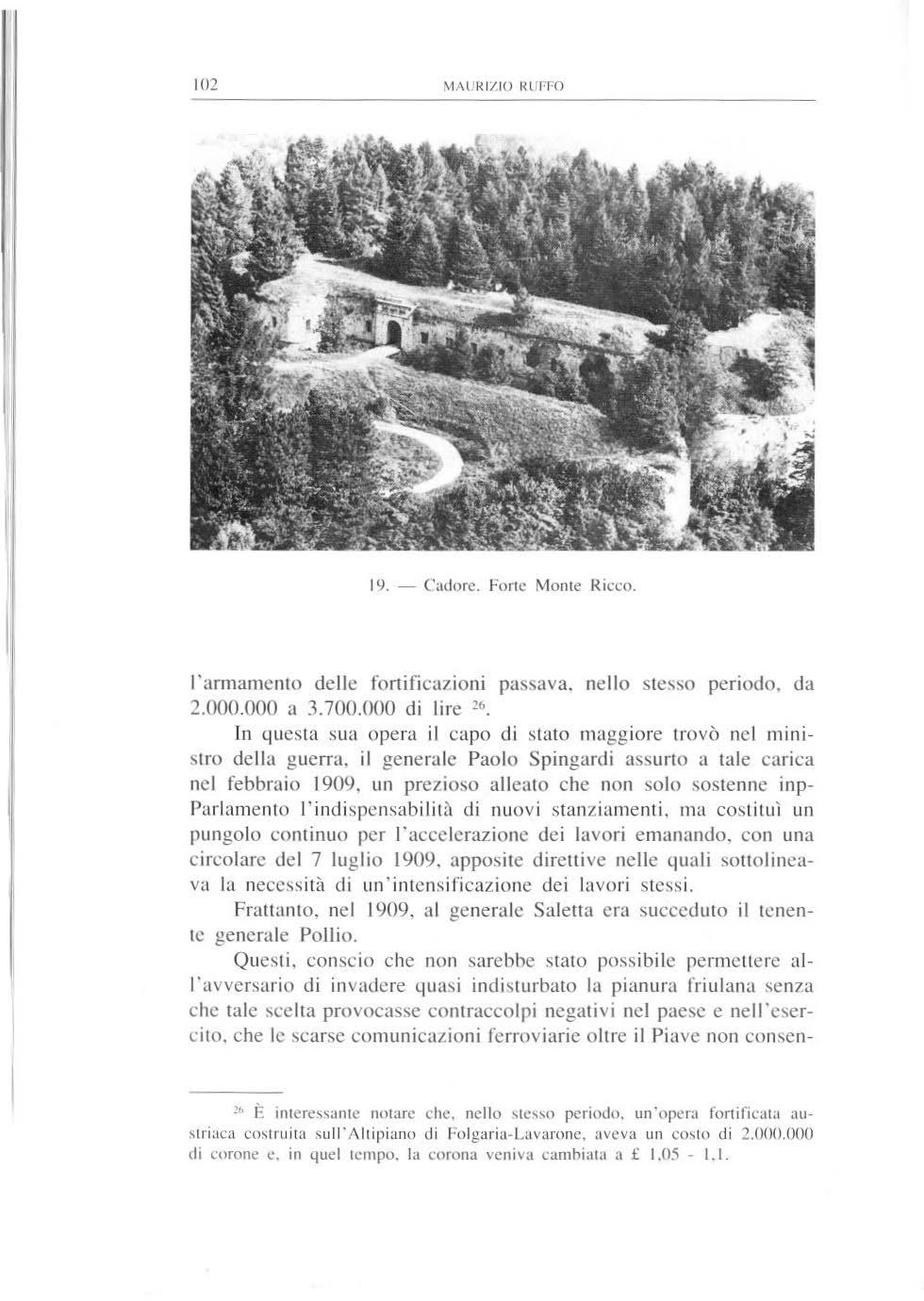
Frattanto. nel 1909, a l ge nera le Saletta era succeduto il tenente generale Pollio.
Q uesti. conscio che non sarebbe stato possibile perme tt ere ali 'avversario d i invadere quasi indi~turbato In pianura friulana senza che tale scelta provocasse contraccolpi negativi nel paese e nell'esercito, che le scarse comunicaLioni ferroviarie oltre il Piave non con!>en-
~" È 111tere~sante notare che. nello ,tcs,o periodo. un ·opera fortifa:aw austriaca costru it a sull'Altipiano d i 1--olgaria -Lavaronc, aveva un co,to d i 2.000.000 di coron e c. in quel tempo. la corona veni, a cambiata a f: 1.05 - 1.1.
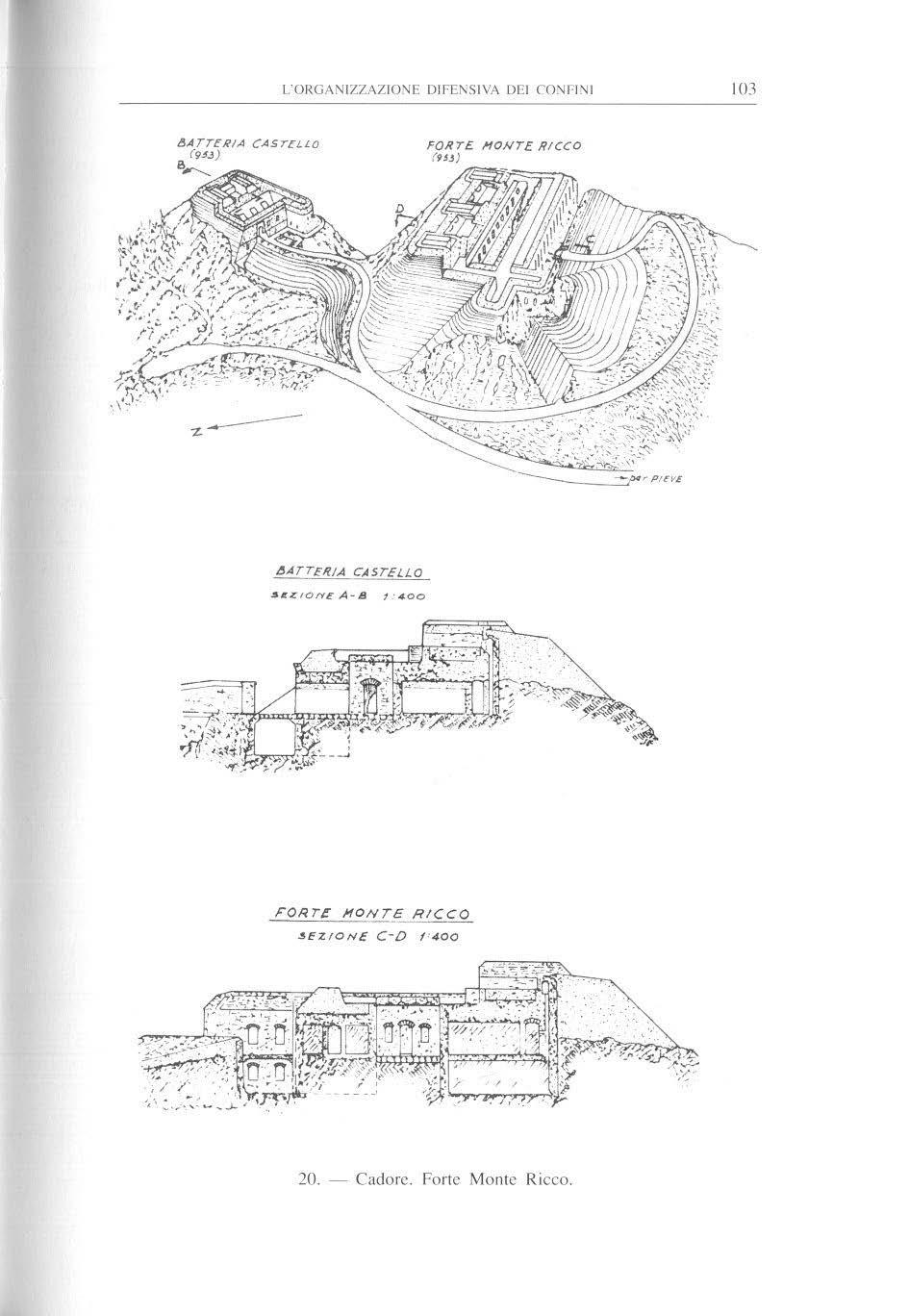

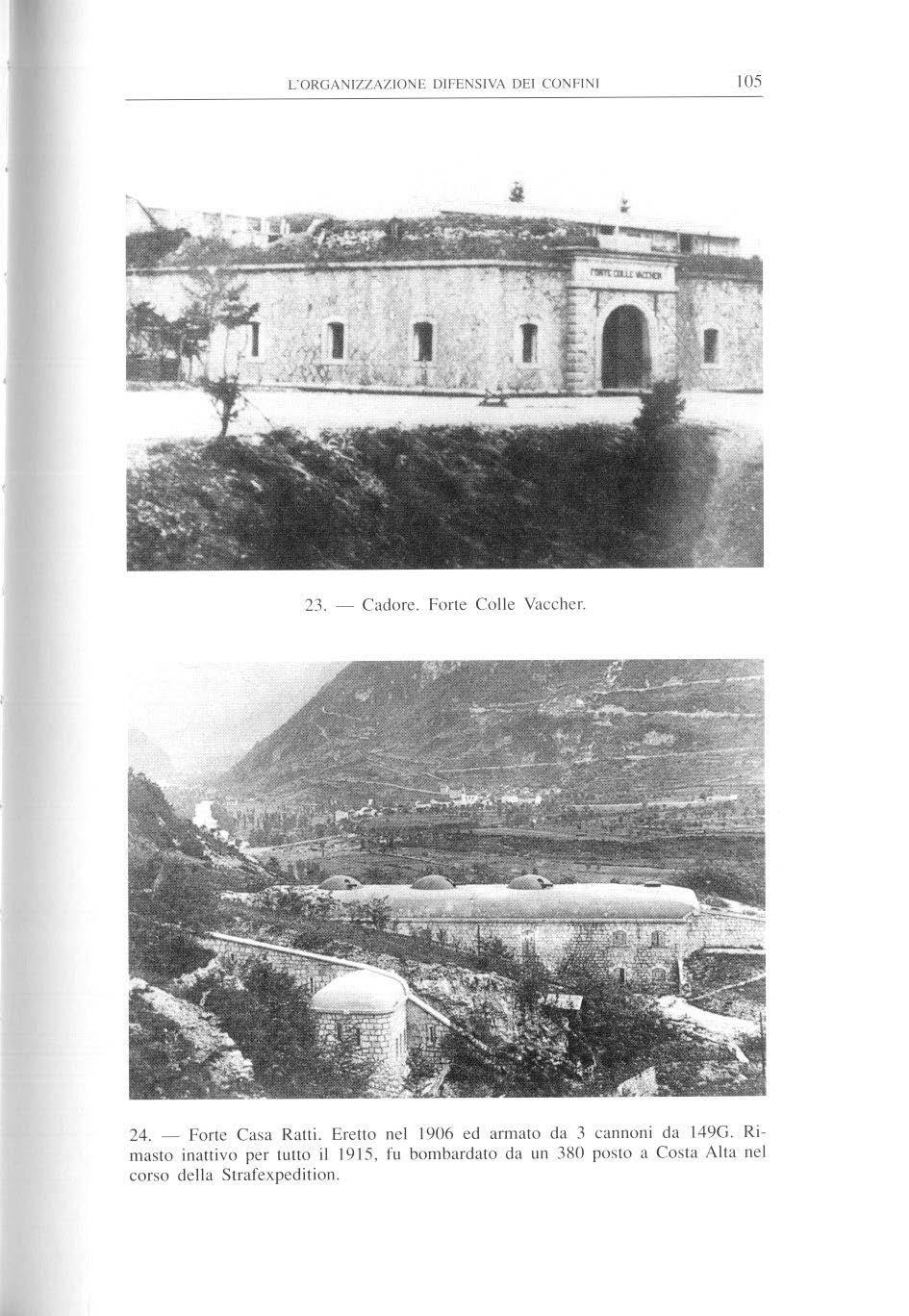
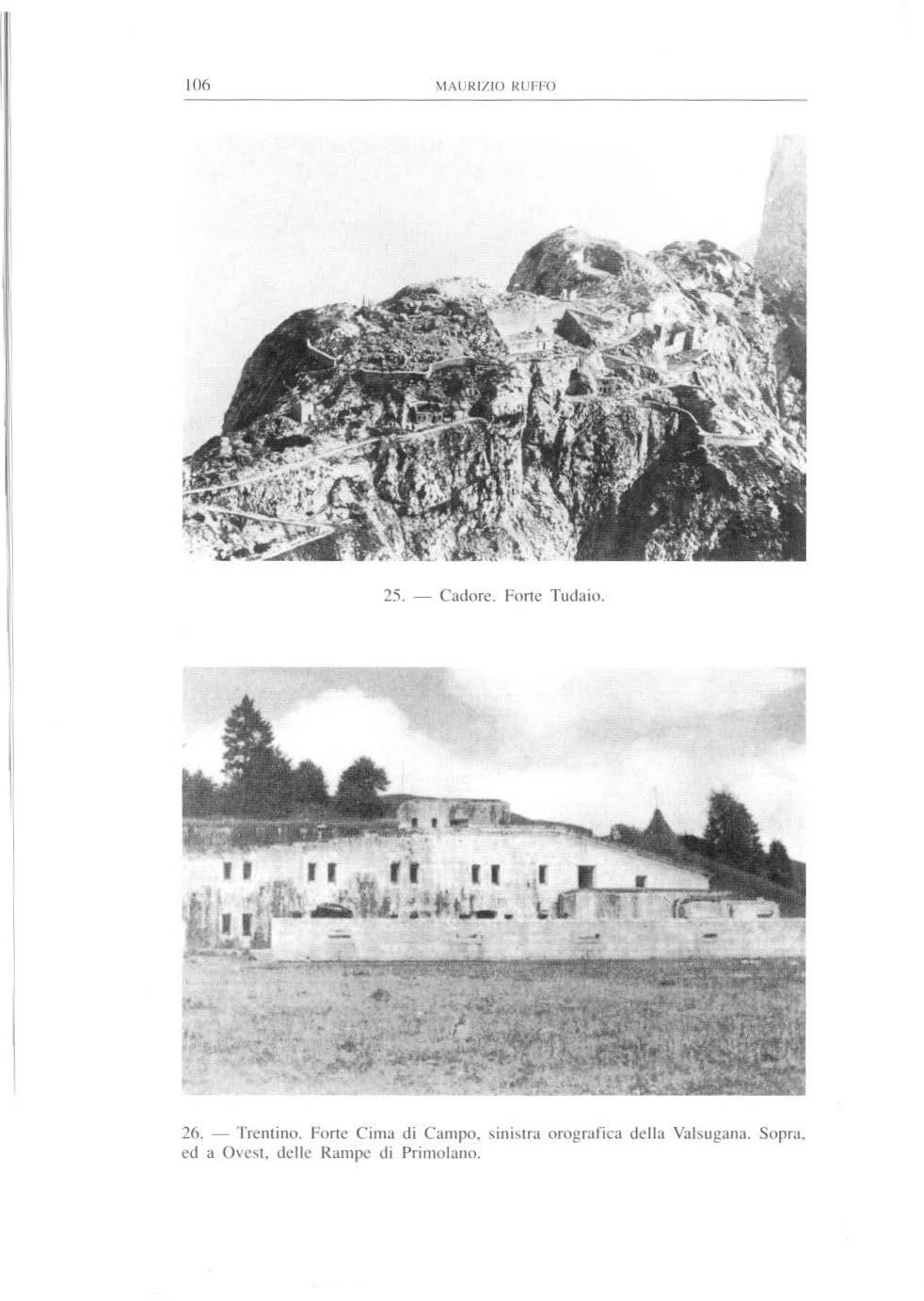

tisscro la radu n a t a sul Tagliamento cd infine che questo fiume non rappresentasse un ostacolo alla pro g re ss ione ne mi ca, pe nsò di attuare una difesa basata su truppe mobili c he ag isse ro in strclta correlazione con le fortificazioni permanenti per dare modo al grosso dell'esercito, radunatosi sul Piave, di schierarsi su l T agl iamento.
Questa nuova concez ion e strategica implica va un 'es pan s io ne ve rso Est del programma di fortificazioni appena concordato con il ministro Spingardi e finanziato dal parlamento.
Tutta v ia lo s tat o maggiore rit eneva di poter aggirare l'ostacolo burocratico risparmiando nei la vo ri per le opere s ul confi ne trentino per utili zzare quelle risorse in Friuli , anche se tale decisione avrebbe, inevitabilmente, ca usa to il sorgere di sospett i su ll 'efficacia dell e opere in via di rea li zzazio ne 27 su l marg ine ciel sa i iente trentin o- tirole se.
27 Nel merito è da ril eva re che l e voci circo lanti ancora oggi, tra l e popola1ioni lrentine e v icentine. asseriscono che i forti italiani non erano sia1i co~truiti con le dovu1e cara11eristiche tecniche previste per le co~ tru11 on i in ce men1 0 armato. 111 altre parol e si sos ti ene che gli itali ,111i avessero dosato gli impasti di co ng lomerati con meno cemento di quello do, uto.
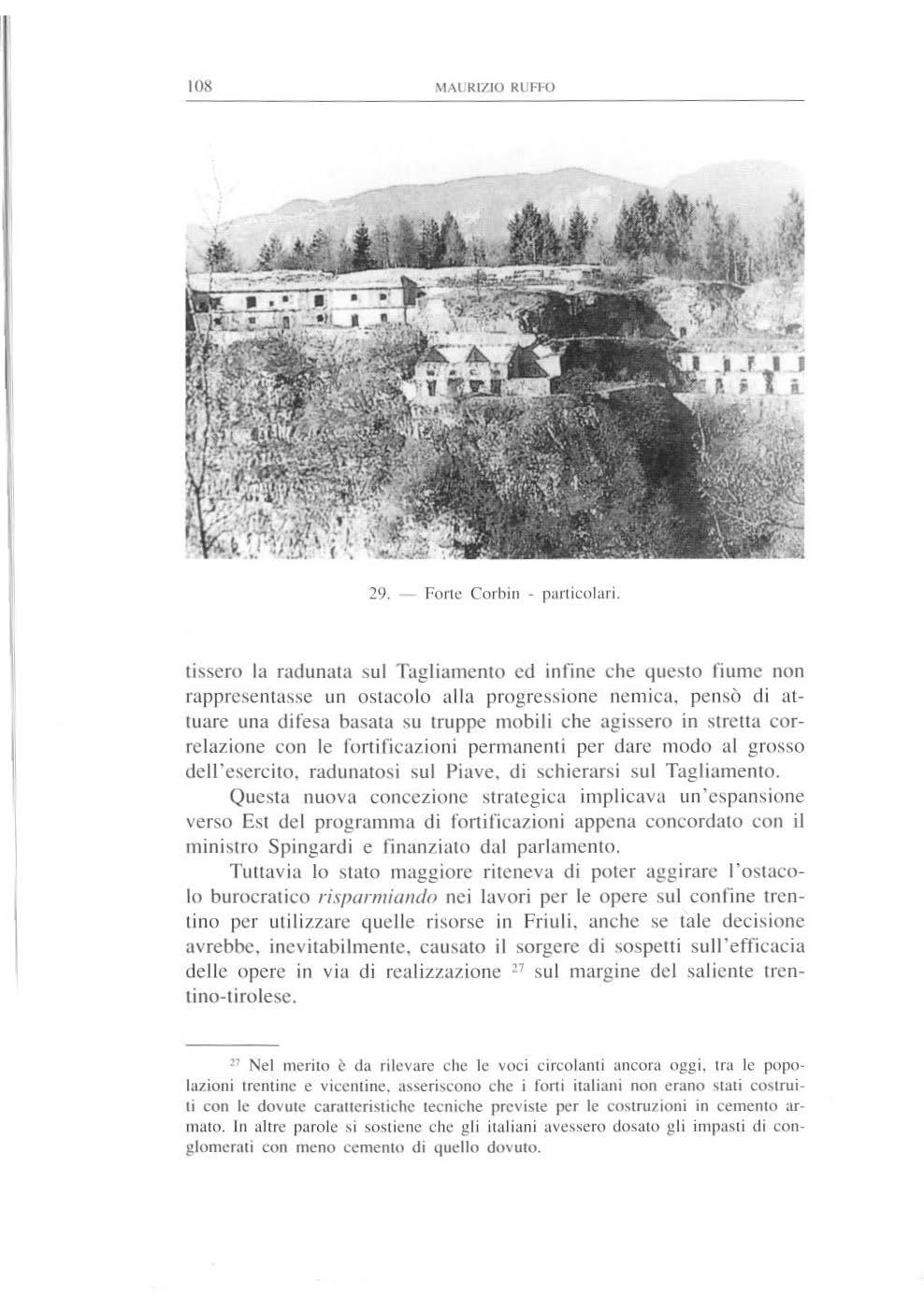
Di questi dubbi si era fatta interprete la commissione d'inchiesta del 1909 28 , presieduta dal gen. Rinaldo Taverna, che, in occasione di una visita ai forti in val Sabbia ed in val Brenta. non solo aveva preso coscienza di queste economie, ma il s uo presidente aveva ritenuto opportuno dichiararsi preoccupato della pretesa dello stato maggiore di far molto con poco. di lesinare e lasciare incomplete le difese Nord per farne delle altre altrelfanto incomplete sul ji-ol/{e Est ... perché ciò avrebbe condotto ... inevitabilme!lle ad a\'ere tutto impe1fetto e per conseguen::a inferiore allo scopo pel quo/e ,·enne idearo 29
Per risolvere il problema il ministro Spingardi, conscio della necessità di fortificare il basso Friuli e, nel contempo, s tretto dalle esigenze finanziarie. pensò di ottenere i fondi necessari operando econom ie sui lavori alla frontiera occidentale e quindi f accnclo sue, ritenendole ancora valide, le idee s trategiche del Pollio.
Le costruzioni iniziarono nel l'estate del 191 O. dopo la sospensione dei lavori per l'avversa stagione invernale, con un ritmo soste nuto e sotto i I diretto controllo del ministro della guerra che il 15 luglio, per rendersi conto di persona elci procedere elci lavori, aveva iniziato una minuziosa ispezione alle opere cli confine che si protrasse per ben due settimane.
Un elemento di perturbativa al procedere dell'attività fu il netto miglioramento delle relazioni tra l'Austria-Ungheria e la Svizzera, tanto eia far temere la stipula di un 'alleanza anti italiana. e che provocarono un momentaneo dissenso, a livello di concezioni s trategiche, t ra il ministro del la guerra ed i I capo di stato maggiore. peraltro subito rientrato, sull'opportunità di procedere con il programma fortificatorio intrapreso.
L a diversità di opinioni fu subito composta ed i lavori sulla frontiera orientale continuarono quindi con ritmo sempre più sostenuto.
L a guerra libica non comportò un rallentamento ciel le costruzioni previste, anzi il ministro Spingardi sposava tutte le tesi del Pollio, anche quella di destinare so lo una parte dei 30 milioni con -
2K I.a commiss ione incar icata di inda ga re sui serviLi dipendenti da l ministero della g uerra fu in sediata a seguito de l disegno di legge. presentato dal preside nte de l consig lio dei ministri al Senato il 24 maggio 1907. relatore Bava-Becca ri s, AUSSME. F4, 6
, 9 Cfr.: And rea Saccornan. Il generale Paolo Spingardi mi11is1ro delta guerra /1909-1914 ) USSME. Roma 1995.
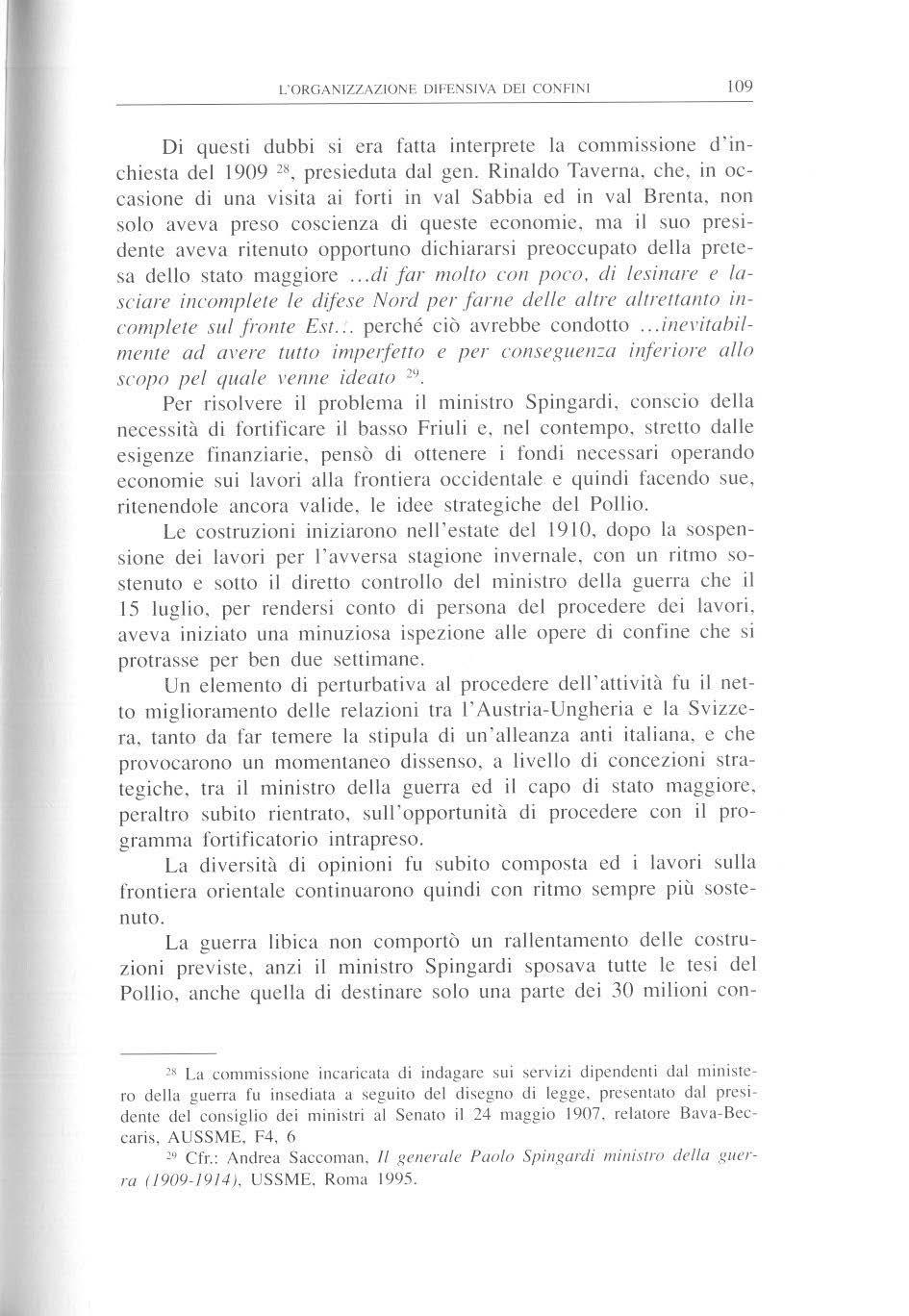
cessi dal parlamento per le opere sulla frontiera svizzera a tale confine. mentre la parte maggiore veniva riservata a quelle verso l'Austria anche .,e non sarebbero state sufficienti per raggiungere gli scopi prefis..,i.
Per il ministro era necessario fare ogni sfor10 per portare a compimen to l'assell o di quelle opere che avrebbero dovuto coslituire i caposa ldi della difese delle frontiere. Spingardi. quindi. sosteneva completamente il concetto strategico del capo di stato maggiore. eia questi illustrato in un'istruzione riservatissima dell'aprile del 1912 ai comandanti designati della 2• e della 3 ·1 armata ' 0 nella quale si sosteneva la neces.,itì1 di operare in maniera difensiva e c;ontroffensiva appoggiandosi alla fortificaLione permanente già coqruita o in via di completamento.
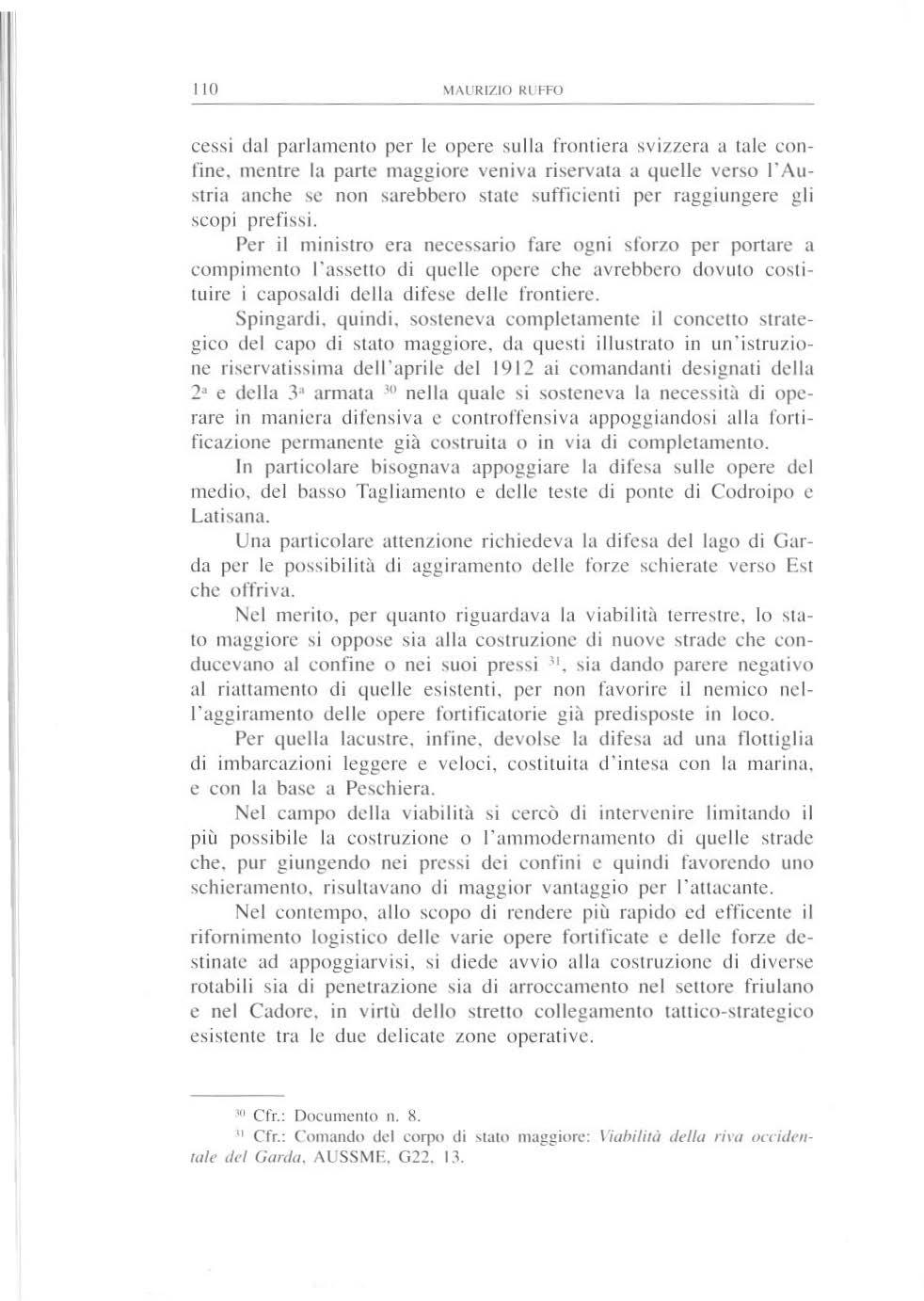
In particolare bisognava appoggiare la difesa sulle opere del medio. del basso Tagliamen10 e delle te ste di ponte di Codro ip o e Latisana.
Una pari icolare attenLione richiedeva la difesa del lago di Garda per le po-.sibilitù cli aggiramento delle forze sch ierate verso E-.t che offriva.
Nel merito, per quanto riguardava la viab ilitfa terrestre. lo stato maggiore si oppose sia alla costruzione di nuove strade che conducevano al confine o nei suoi pre-.si \I sia dando parere negativo al riattamento di quelle esistenti, per non favorire il n em ico n e ll'aggiramento delle opere fortificatorie già predbposte in loco.
Per quella lacustre. infine. devolse la difesa ad una flottiglia di imbarcazioni leg ge re e veloci, cos tituita d"intesa con la marina. e con la base a P e ... chiera.
Nel campo della viabilità !>i cercò di intervenire limitando il piì:1 possibile la costruzione o l'ammod ernamen to di qu e l le strade che. pur giungendo nei pre-.si dei confini e quindi favorendo uno schieramento. risultavano di maggior vantaggio per l'attaca ntc.
Nel contempo. allo scopo di ren dere più rapido cd efficc nte il rifornimento logistico delle varie ope re fortificate e delle forze destinate ad nppoggiarvisi, si diede avvio alla costruzione di diverse rotabili sia di pcnetra1ione -.ia di arroccamento nel settore friulano e nel Cadore. in vi rtù dello stre tt o collegamento tallico-strategico esistente tra le due delicate zone operative.
"' Cfr.: Documento n. 8.
" Cfr.: Comando del corpo di \lalo maggiore : I iabihta della ,fra 0 CC' id1'111ale di'/ Garda. AuSSME. 022. 13.
Lo s tudio del generale Cosenz era stato, come abbiamo già accennato. sottoposto ad immediata verifica attraverso le esercitazioni per i quadri.
rn esse la sua va lidit à generale era stata confermala, tuttavia l'evolversi della situaz ion e internazionale. in specia l modo per quanto riguardava le relazioni con la Francia. aveva consigliato se non una revisione almeno un aggiornamento del piano stesso.
Questa necessità derivava dalla considerazione c h e la conformazione geografica dell'Ttal ia è tale che i suoi confini terrestri si presentano molto forti. specia lm ente verso occidente, grazie alla barriera naturale rappresentata dalla catena alpina. ma estremamente vulnerabili nel loro sviluppo costiero, tanto da esporla a possibili sbarchi dal mare che avessero il chiaro intento di isolare l'es ercito dalle sue naturali fonti di rifornimento sit ual e lungo tutta la peniso la ed in particolare nel centro- sud 12
Si rendeva perciò necessario riesaminare l'intera problematica della difesa dello stato sia da l punto di v ista operativo sia per quanto riguardava le predisposi.lioni per la mobi I itazione e la radunata.
In tale contesto, ferme restando le predisposizioni ado !l ate nei confronti della frontiera Nord -O vest e la possibilitit di rendere disponibili delle forze da inviare sul Reno a l fianco delle forze tedesche. si ritenne nec essario di poter avere a disposizione un 'unità - a li ve llo divisione - in Sicilia per garantire l 'Ttalia meridionale da even tu a li sbarchi dal mare .
Tuttavia non potendo. per motivi di cara!l ere prettamente economico, costituire nuo ve unità dopo il riordinamento opera to dal Ricotti si co nsiderò più opportuno. per avere la disponibilità di questa grande unità, rivedere la radunata su lla fronte Nord-Est ed in particolare il co mpito assegnato al Corpo speciale che, secondo i I Cosenz, avrebbe dovuto svolge re un ·azione di frenaggio tra il Tagli amento ed il Piave, destinando alle funzioni di cope rtura tr e divisioni di cavaller ia dislocate s ulla s ini s tra del Tagliamento.
-'' Il fucile mod. 9 1. c he cos t it uì l'armame nto ind i v idua le del'eserci10. ven iva prodouo in g ran parie presso la fabbr ica cli Terni e le polveri erano preparate principalmente presso il laborator io pirotecnico di Capua: come riportato ne ll' opera di Gianrodolfo Rotasso e Mauri7io Ruffo: L' ar111w11e111U i11dirid11al<' del/' esercito italian o dal /861 al /943. USSME. Roma 1995.
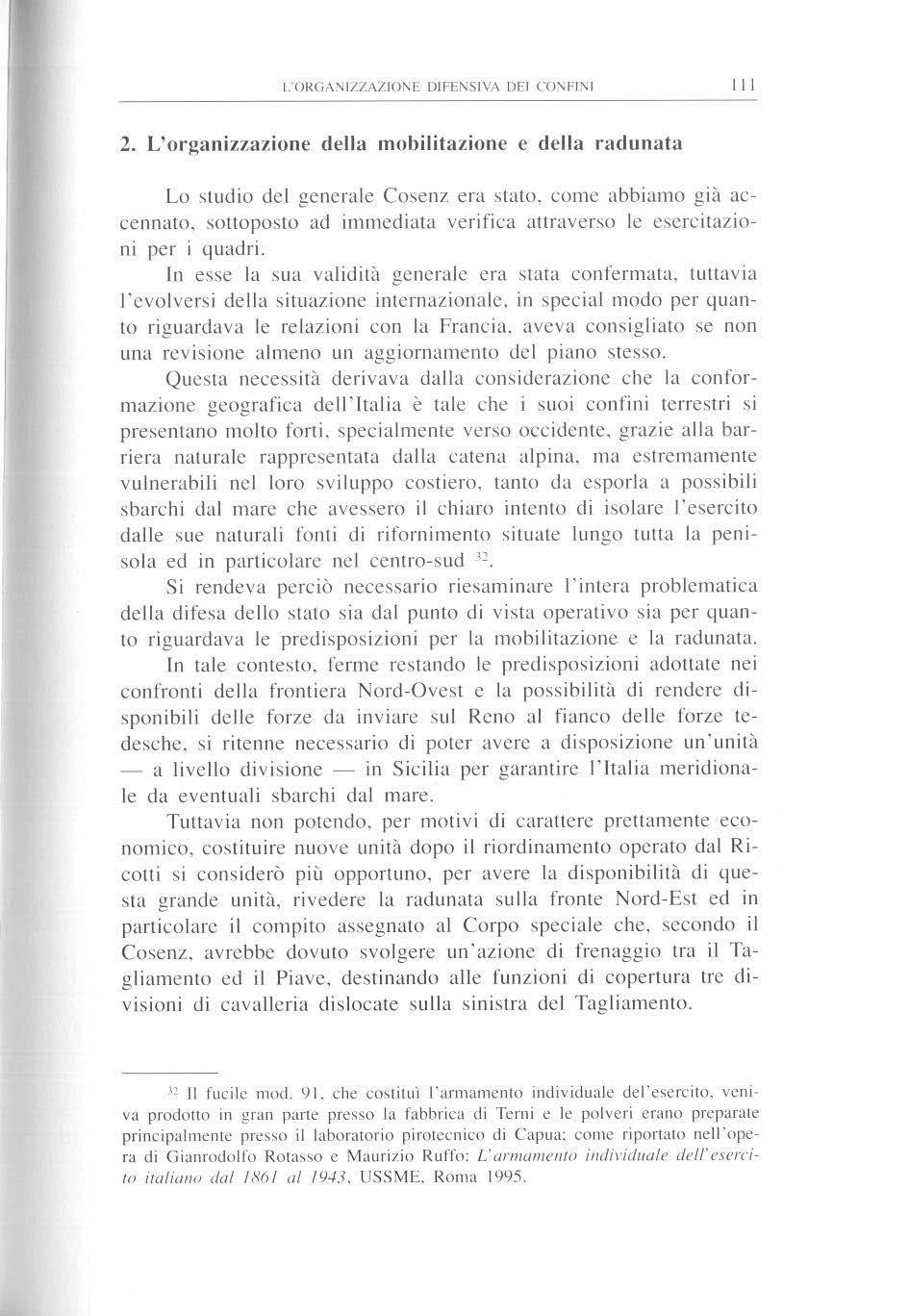
Ciò comportava una ridisegnazione dei piani di mobilitazione e di radunata. già pred isposti. c h e tenesse in debito conto non '>Olo la necessità di accelerare i tempi neccs<,ari all'afflusso delle varie unità dell' eserci to sulla lin ea del Pia ve, ma di avere già un valido presidio alle frontiere in grado di ritardare ravani;ata nemica di quel tanto n ecessar io per effett uar e le o pe razioni cli radunata previste.
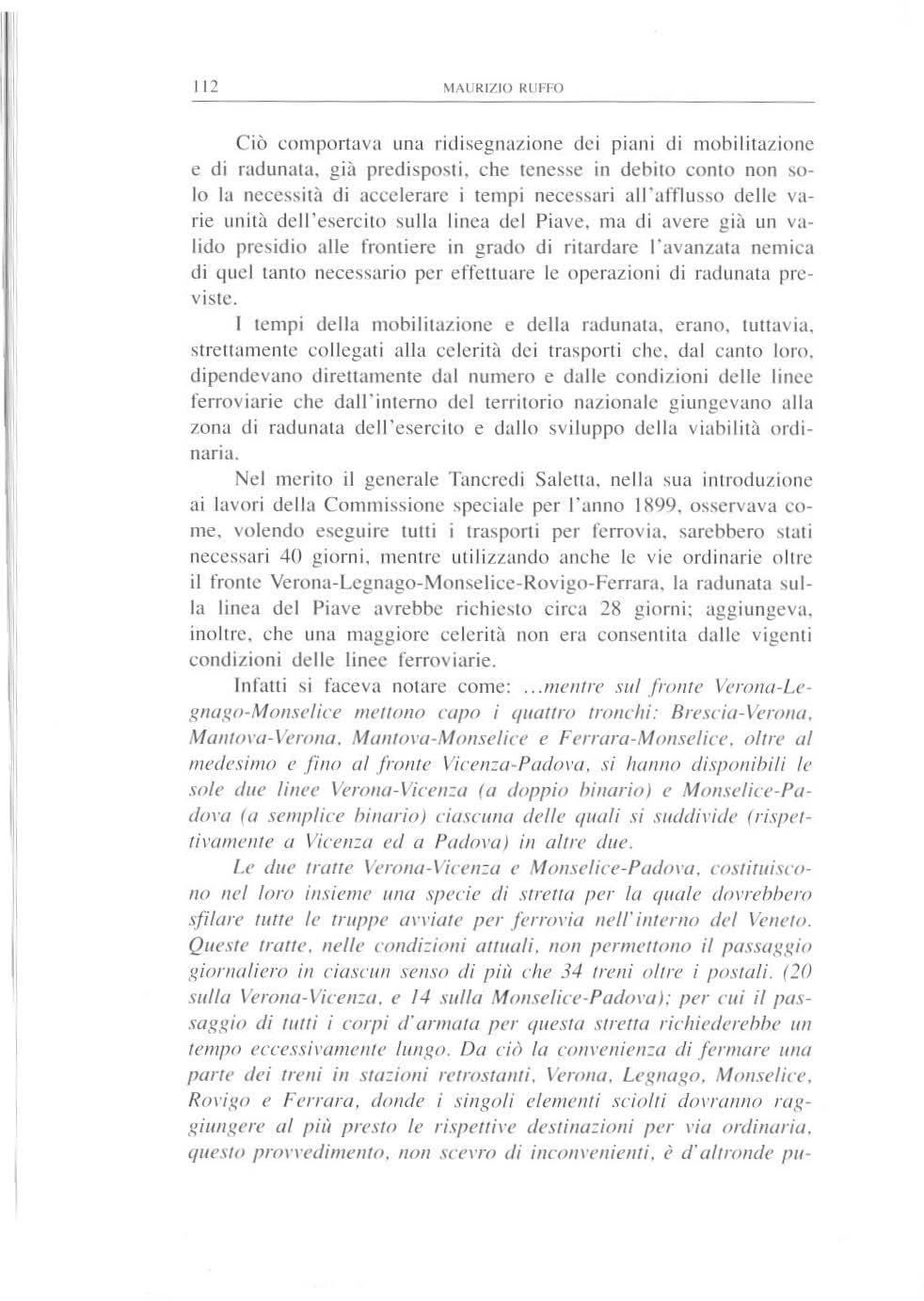
I tempi della mobilita;,ionc e della radunata, erano, tuttavia, s trettament e co lle ga ti alla ce lerità elci trasporti che. dal can to loro. dipendevano direttamente dal numero e dalle condi?ion i delle lince ferroviarie che dall'interno del territorio rnuionalc giungevano a lla zona di radunata dell'esercito e d a llo sviluppo della viabi lit à ordinaria.
Nel merito il generale Tancr ed i Saletta, nella sua introduzione ai lav ori della Commissione '>peciale per l'anno 1899. osservava come. volendo esegu ire tutti i trasporti per ferrovia, sarebbero '>lati ne cessa ri 40 g iorni , mentr e utili zzando anche le vie ordinarie oltre il fronte Verona-Legnago-Monselice-Rovigo-Ferrara, la raduna t a sulla linea del Piave avrebbe richiesto circa 28 giorn i; aggiu n geva, inoltre, che una maggiore celer ità non era co n senti ta dalle vigenti concliLioni delle linee fe rr oviarie.
Infatti si faceva notare co m e: .. .me11tre su l .fi'o11te \lerona-Legnago-Mo11selice mellono capo i quattro tro11c/ii: Brescia-\lero11a. Ma11wrn -\ 'ero11a. Ma111om-Mo11selice e Ferrara -Monselice. oltre al medesimo e fi no al .fim11e ViC'e11:a - Pado\'CI, s i ha11110 disponibili le sole due linee \ 'em11a-Vice11:a (a doppio hinario) e Monselice-Padorn (a semplice hinario) ciascuna delle quali si .rnddiride (rispetti1·wne11te a \licen::a cd a Pado va) in altre due.
Le due trai/e \em11a-\ 'ice11:a e Mon.H•lice-Poclorn. cmtiflli'ìCo110 nel loro insieme 1111a specie di stretta per la quale chJ\' rehbero sfilare lllfte le truppe a1Tiote per fe,.,-01·il1 netr interno del \ 'e11e10. Queste tratte, nelle co11di::io11i al/110/i, 11011 permettono il passaggio giorna li ero i11 ciusct111 se ns o di pilÌ e/te 34 treni oltre i postali. (20 ml/a \ ero110-\' ice11::o, e /.I sulla Mo11selice - Pac/ol'(I): per cui il passaggio di 11111i i corpi d'armata per ques/a stretla ricltiederehhe 1111 1e111po eccess i1 om e111e lun go. Da cià la com·e11ie11:o di fermare una porte dei 1re11i i11 slll::ioni retrostanti. \ 'em11a, Legnago, Monselice. Rm igo e Ferrara, donde i singoli elementi sciolti dm ·ra11110 raggiungere al pilÌ presto le rispe11i1·e desti11a::io11i per rio ordinaria. quesw pro1'l'edime1110. 11011 scc1To di i11co111·enie111i. è c1· al1m11de pu-
re reclamato dalla insufficienza dei me zz i di scarico delle sta z ioni situate nella zona di radunata oltre il fì'onte Verona -Monselice 33
Sul la base di queste osservazioni il generale Saleua riteneva che per accelerare la radunata dell 'esercito verso la frontiera NordEst. sarebbe stato assolutamente nece ssa rio raddoppiare la Monselice-Padova , impiantare il sistema di blocco su questa linea e s ull a Verona - Vicenza, impiantare un analogo s iste ma s ulla Padova-Mest r e, procedere al raddoppio del binario nella tratta tra Mestre e Treviso ed infine amp li are ed aumentare i mezzi di scarico e di manovra dei treni nelle stazioni di Bassano, Cornuda, Feltre, B e lluno , Castelfranco, Treviso, S. Donà di Piave e Conegliano.
Qualora venissero portati a compimento tutti questi lavori i te mpi per la radunata di tutto l'esercito sulla linea ciel Piave si sarebbero potuti st imare in circa ven tidue g iorni , ponendo l'esercito italian o in una posizione cli vantaggio tempora le, nei confront i cli quello avversario, tale da permettergli di avere l ' ini z iativa delle operazioni.
Questa possibilità era anche una conseguenza diretta di uno studio compiuto s ulla mobilitazione austriaca dal quale sa rebbe risultato che, pur utilizzando al massimo tulla la potenzialità della propria rete ferrov iari a, l'esercito imperiale sarebbe s tato in grado di concentrarsi con nove divisioni nel Trentino , sette nella val Pusteria, nov e nelle conche di Villach e cli Tarvisio e diciotto fra il basso Isonzo e la conca di Lubiana.
Tuttavia s i notava anche che il vent iduesimo g iorno, quando l 'ese rcito italiano avrebbe completa to la propria mobilita z ione , I' Austria - Ungheria non avrebbe avuto modo cli intraprendere un 'az ione offensiva nella pianura friulana se non con sole undici divisioni. disponendo, nel contempo, di cinque divisioni s ul Pulfero e s ul Fella, un a verso l 'a lt o Piav e, tr e nei pressi cli Cismon Cordevo le, una in val Bren ta , tre in val d 'Assa e in val d'A st ico ed infine due s ulla zo na di Pian delle Fugazze.
Ne ll ' aprile del 1902 lo sta t o maggiore dell 'eserci to emanava un nuovo s tudi o s ulla mobilitazione e radunata verso la frontiera Nord - Est 34
.ll Cfr.: Verbali delle sed111e della commissione speciale 11omi11ata co l dispacc io 17 mar:o 1999 - n. 1 770 Aprile 1899. pag. 4 -5 , AUSSME, F4 , 122.
3• Cfr.: Rela: ione imorno al proget to di mohilita:ione e radunata verso la ji'ontiera N. F. Apr i le 1902. A U SSME, F4. 11.

Esso prendeva spunto da una comparazione tra la radunata verso la frontiera orientale e quella verso la frontiera occidentale, sulla base s ia della dislocazione iniziale dell'esercito e s ia della condizione della rete ferroviaria verso i due confini.
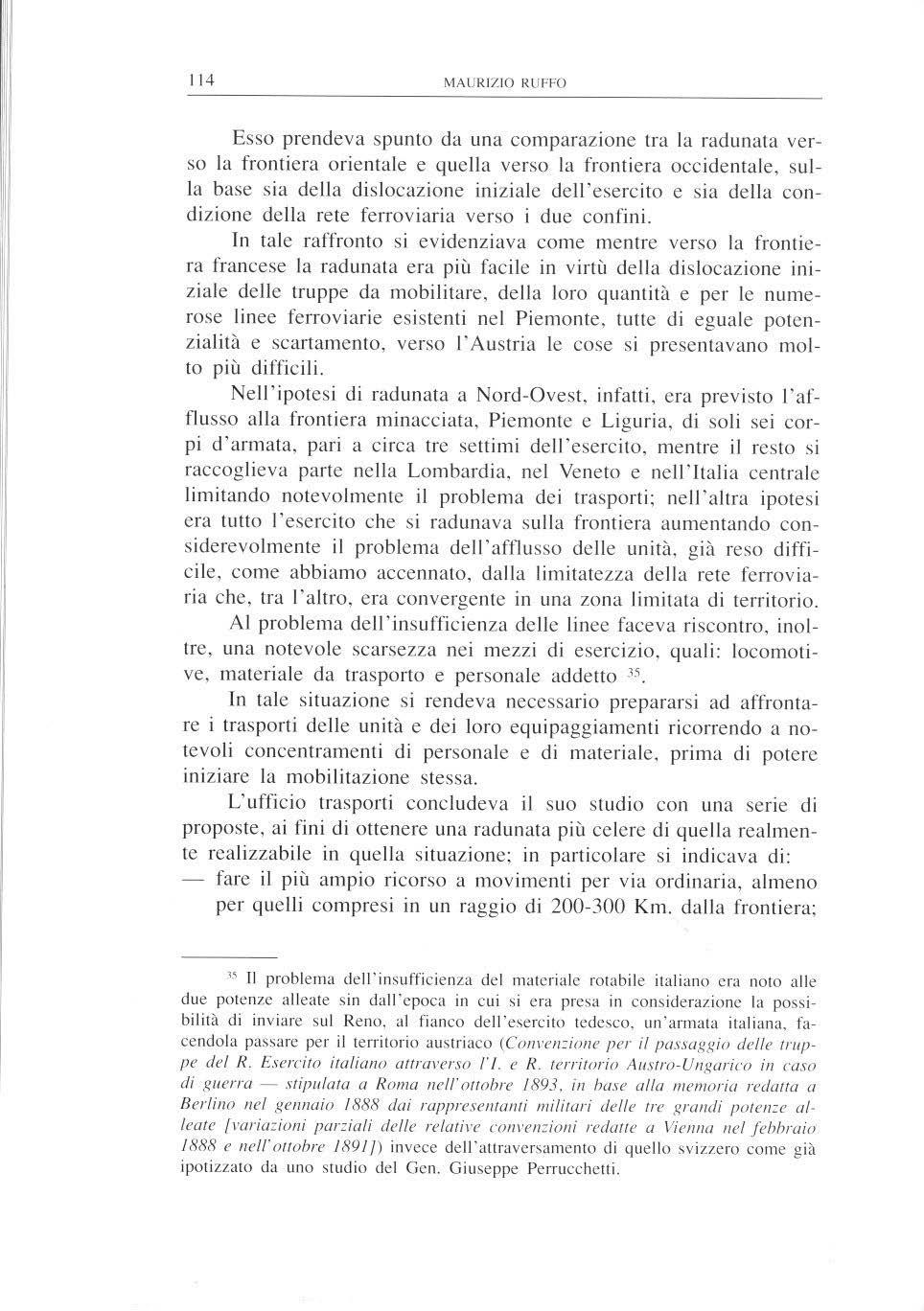
Tn tale raffronto si evidenziava come mentre verso la frontiera francese la radunata era più facile in virtù della dislocazione inizia le delle truppe da mobilitare. della loro quantità e per le numerose linee ferroviar ie esistenti nel Piemonte , tutte cli eguale potenzialità e scartamento, verso l'Austria le cose si presentavano molto più difficili.
Nell'ipotesi cli radunata a Nord-Ovest. infatti, era previ s to l'afflusso alla frontiera minacciata, Piemonte e Li guria, di so li sei corpi d'armata, pari a c ir ca tre settimi dell'esercito, mentre il resto si raccoglieva parte nella Lombardia, nel Veneto e nell'Italia centrale limitando notevolmente il problema elci trasporti; nell'altra ipotesi era tutto l'esercito che s i radunava sulla frontiera aumentando considerevo lm ente il problema dell'afflu sso delle unità , già reso diffici le, come abbiamo accennato, dalla lim itatezza della rete ferroviaria che, tra l'altro, era convergente in una zona limitata di territorio.
Al problema del!' insufficien za delle linee faceva riscontro, inoltre, una notevole scarsezza nei mezzi di esercizio, quali: locomotive, materiale da trasporto e personale addetto 35 •
In tale situazione si rendeva necessario prepararsi ad affrontare i trasporti delle unità e dei loro equipaggiamenti ricorrendo a notevoli co nc entramenti di perso nale e di materiale, prima di potere iniziare la mobilitazione stessa .
L'ufficio trasporti concludeva il suo studio con una se rie di proposte, ai fini cli ottenere una radunata più celere di quella realmente realizzabile in quel la situazione; in particolare si indicava di: fare il più ampio ricorso a movimenti per via ordinaria, almeno per quelli compresi in un raggio di 200- 300 Km. dalla fron ti era:
1 -' [I problema de ll ' in sufficienza del materia le rotabile ita l iano era noto alle due potenze al leate si n dall"epoca in cui si era presa in cons iderazione la possibilità di inviare su l Reno, al fian co dell'esercito tedesco. un'armata ita l iana. facendo l a passare per il territorio austriaco (Co111·e11:io11e per il passaggio delle /ruppe del R. csercilo i1aliano attra,·crso /' I . e H.. terrilorio A11s1ro-Ungarico in caso di guerra - slipulata a Roma netro11obre 1893. in base alla 111emoria redatla a Berlin o nel gennaio I 8R8 dai rappresen1a111i mi/ilari delle rre grandi poren:e alleale {varia ; ioni par:ia/i delle relaril ·e co111·en:io11i redai/e a Vienna nel febbraio /888 e 11etr o11obre /89/}) invece dell'auravcrsa mento di quello svizzero come già ipotiZLalO da uno studio del Gen. Giuseppe Perruccheiti.
di ant1c1pare la radunata, rispetto all'ordine di mobilitazione, di quel le truppe destinate al l'occupazione avanzata;
di portare a compimento quei lavori di miglioramento della rete ferroviaria già iniziati e quelli che, pur essendo stati ritenuti necessari, erano stati rimandati a dopo il 1906 per mancanza di fondi;
di mettere in atto tutte le predispoizioni per gittare un ponte sul fiume Sile tra San Michele e Roncade, al momento della mobilitazione, per favorire il concentramento della 2" annata;
di prevedere l 'invio di una compagnia ferrovieri a Castelfranco in sussidio ciel personale della rete ferroviaria del la Società Veneta;
di utilizzare anche il trasporto fluviale approfittando della pres en z a di numerosi canali in tutta la pianura veneto - friulana 36 Tutte queste proposte erano. peraltro, condivise clall 'ufficio ciel capo di stato maggiore anche se mancava, da parte degli organi centrali, non solo una vera e propria presa di coscienza della gravità del problema, ma anche una decisa volontà di risolverla.
Ciò trovava la s ua giustificazione nella necessità, di carattere prettamente diplomatico. di non allarmare l'alleata danubiana in un momento in cui si stava trattando il terzo rinnovo dell'alleanza e la situazione politica europea stava attraversando un periodo di forti tensioni.
Lo spunto per affrontare decisamente il problema fu offerto al capo di stato maggiore, il generale Saletta, dalle risultanze del viaggio di stato maggiore del 1904, nel quale vennero, per la prima volta ed in maniera g lobal e, analizzati tutti gli aspelli cli un conflitto con tro l'Austria-Ungheria.
Questi aspetti si tradussero in una se ri e di "studi special i", tra i quali quello riguardante il problema della mobitazione ~ 7 e quello del le ferrovie 38 , annessi alla relazione finale cieli' esercitaz ion e stessa.
L 'analisi partiva dalla descrizione del sistema in v igo re e dalle motivazioni che ne erano alla base: sfruttare i11rensamen1e la poten:ialità de/le ferrol'ie fino dal primo giorno di mohilita:ione, eseguendo con1emporaneamen1e e prorniscuamell!e le due operazio-
11 • Cfr.: Rela :ione into rno al prog etto di mo/Jilita:ione e rad1111aw 1erso la fimlliera N. E Aprile I 902. pag. 23 e seg AUSSME. F4 11.
17 Cfr.: Documento n. 9.
3 ~ Cfr.: Documento n. IO.

ni della mobilita:ion e e della r ad un ata ... ·19 , per g iungere, attraverso un o s tudi o a pprofondito del problema. ad enunciare quei provve dim e nti c he av rebbero pem1esso cli se mplificare e di accelera re le operazioni di mobilita z ion e e quelli neces s ari per a ument a re la produttività delle fe rrovie e dare il via al la rea lizza7ione di ess i.
Per ottenere la se mplifi caz io ne delle operaz ion i, attuando un a radun a t a più rego lare ed e l astica, s i s uggeriva cl i aumen tare il contingent e annuo per accrescere la forza in co n ge do disponibile, quindi di c reare d e ll e zone di co mpl eta m e nt o reggimentali per perm e ttere ai reparti cli fanteria cli co mpletars i con elementi tratti in loco.
Alt ri pro vve dim e nti presi in esa me era no quello di abolire o ridurre i di s tr e tti di co mpl e tament o, cli camb iar e i c rit e ri cli a sseg nazione dell e reclut e s ulla base d e i bisogni di guerra e n on cli uniformità cli co ntingent e nell'ambito del rep a rto, di predisporre c he ogni ce ntro di mobilitazione di cava ll eria trov asse s u l posto g li uom ini ed i quadrupedi necessari per il suo comp letam ento ricorrendo, se n ecessa ri o, ad un a nuova ridislo caz ione delle unit à di cav alleria.
Bisognava poi ri orga ni zza re i se r v izi ed il tr e no militare ed. infine. adottare la chia mata per ca rt o lina co me già a t tuato con la milizia mobile e qu e ll a te rrit o riale.
l suggerime nti con tenut i nella rel az ion e furon o. s u diretta so llecitazione del ca po di s tat o mag gio re dell"esercito, s ubit o trad o tti in proposte concre te a l mini s te ro della g ue rra con il foglio d e ll'u fficio de l capo di s tato ma ggio re dell'esercito n. 32 de l 27 ge nnai o 1905 40 •
In ess o , dopo avere evidenziato c he in man canza di una modifica. da parte d e l min is te ro. della ci rcosc rizion e territ oriale per c reare le zone di re c lut amento r eggi m en t a li , ta nt o va leva mantenere il s istema v ige nt e di ac copp iam e nto d ei d e pos iti e d e l co mpl etament o per briga t a, e dopo aver so1t o lineato le gra,·i ri.rnlwn:e della 11w11m'l"a s,·ol tasi du ra111 e il viag1:io di stat o ma1:giore, s i formula va no ra cco lt e e sv ilupp ate in tr e fascico li anness i. de ll e proposte co nc re te c he , pur ten endo co1110 dei cos ti e delle le gg i in vig ore, e rano in g rado cli porta re all'elim ina z ion e d eg li in co nv e ni e nti regis tra ti.
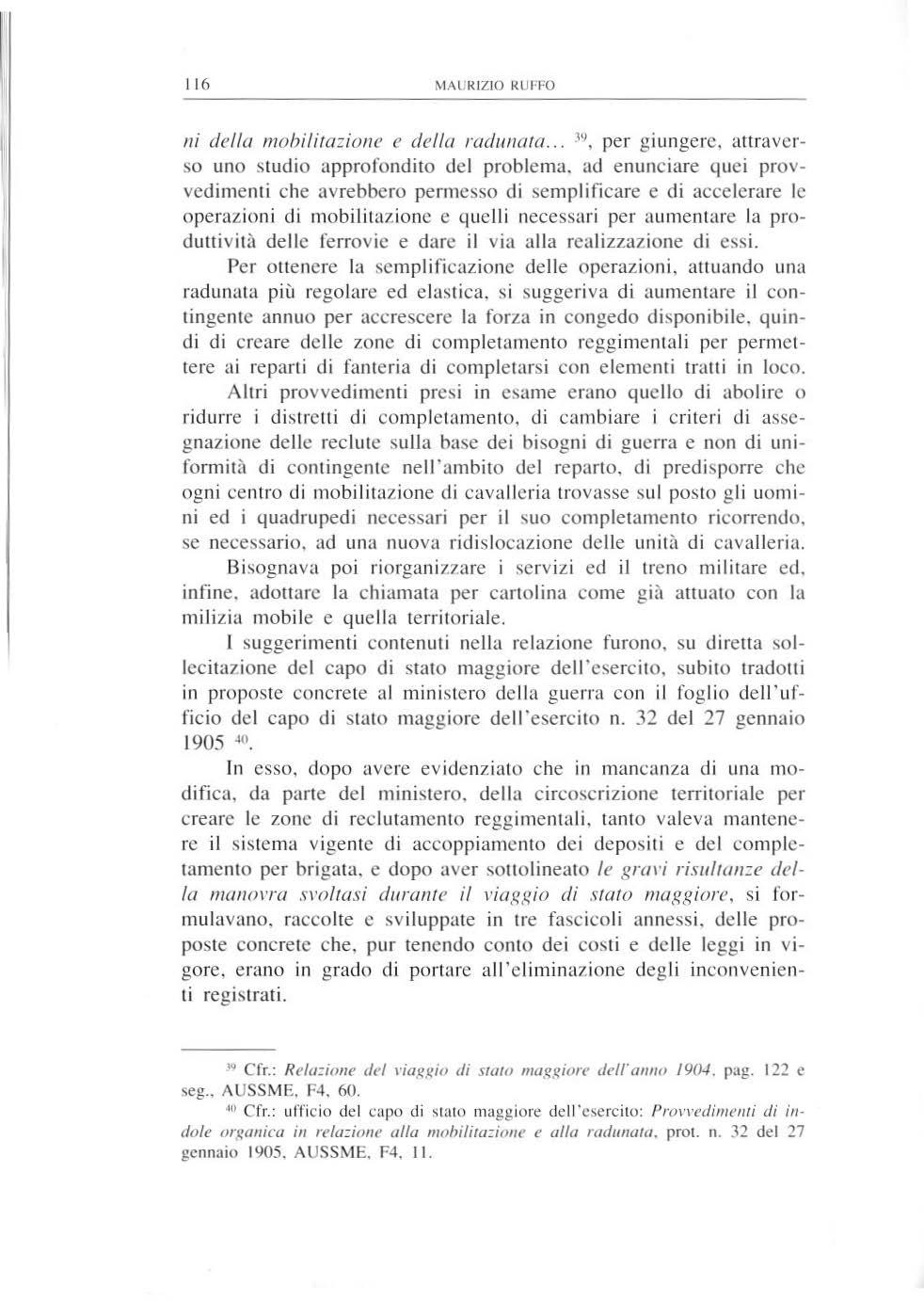
'" Cfr.: Rela:ione dl'I l'iaggio di sw10 maggiore del/' a111w 19().I. pag. 122 e seg AUSSME. F4. 60.
•° Cfr.: u ff ic io de l capo di sia to maggiore del I ·esercito: P rov1wlim e111i di indole organica in rela : ione alla mohiliw:ionc e alla raduna/a. prot. n. 32 del 27 gennaio 1905. AUSSME. F-4, 11.
I primi due fascico li contenevano delle proposte di cara tt ere genera le che avevano lo scopo di perfezionare tutto il s istema di mob ilit azione, a prescindere dall'ipotesi di radunata.
li te r zo comprendeva alcu ni s uggerimenti particolar i che avevano lo scopo di r im ediare a ll e lacune d e lla radunata s ull a fronte Nord-Est e c he era no stat e preve ntivam en te vagliate anche dal l 'Ufficio trasporti pe r le impli cazioni che ne sareb bero de ri vate ai fini di un a co rretta e se mpre più celere radunata dell ' intero eserc it o nel Friu l i.
Il Saletta, da uomo concreto qu al'era, auspicava un ' immediata approvazio ne de l le proposte pe r potere pa ssa re s ubito alla fase esecutiva c he s i sa reb be potuta comp letare e ntro la primavera del 1906 co n il rinnovo completo del piano dei tra spo rti.
L ' intero problema de l la radunata s ulla fronte Nord -Es t venne pertanto affrontato ed ott imi zzato, con quelle che erano le poss ibi1it à finanziari e del mom en to , con vera determinazione e concre tezza dal capo cli s tato maggiore, ottenendo che, con l ' invio dei corpi cl· armata cl ell ' esercito permanente in primo scag lion e nella zona di radunata mentre le divisioni di milizia territorial e segu ivano in secondo scag lion e, l'int era ra dun a ta s i effe ttuas se nell ' arco di ve nticinque giorni .
Dal 1906, pur aggio rn a ndo con un a certa costanza i piani rel ativi ai trasporti, strettame nt e legati a llo svilu ppo de lla rete fe rrov iar ia nel particolare se ttore, non s ub e ntrarono a ltre g rosse modific he fino al al 1908.
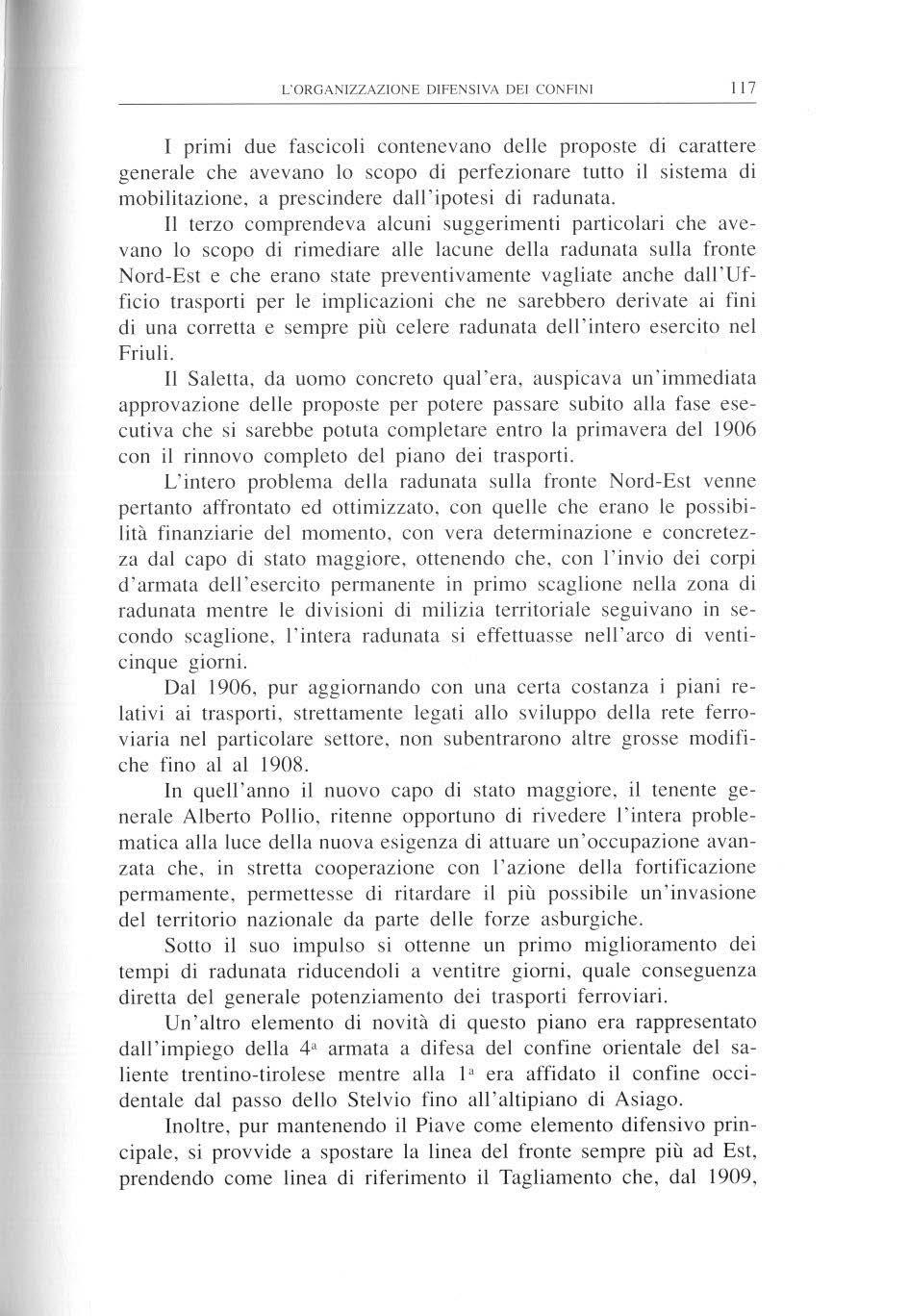
In qu e ll 'a nno il nuovo capo d i s tat o ma gg iore , il tenen te gen erale Alberto Pa llio , rit en ne opport un o di rivedere l'intera problematica alla lu ce de lla nuo va esige n za di att uare un'occupa z io ne avanzata c he, in s tretta coo p eraz ione con l ' azione de lla fortifica z ione permamente , permettesse di ritardar e il più poss ibil e un ' in vasione d e l te rrit or io nazionale da parte del le forze asburgich e.
Sotto il s u o impulso s i otte nn e un primo miglioramento dei tempi d i radunata riducendo I i a ve nti tre g iorni , quale co ns eguenza diretta del ge nera le potenziam e nto de i trasporti ferrov iari.
Un 'a ltr o e le m e nt o di novità di q uesto piano e ra rapprese ntato dall'impiego de ll a 4 a a r mata a d ifesa del co nfin e o ri entale del sali e n te tre ntin o -t irolese mentre alla 1" era affidato il confine occide nt a le dal pass o dello Stelvio fino all'altipiano di Asiago.
Inoltre , pur mante ne ndo il Pi ave come ele mento d ifensivo pri ncipale, s i provvide a spos tare la lin ea d el fronte se mpre più ad E st, prenden do co me linea di riferim e nt o il Ta g li amento che, dal 1909,
ini7iò ad essere attrenato come prima linea difensiva e, mediante le due teste di ponte fortifica te di Codroipo e Latisana, assunse anche la funlione di base di partenza per un'inedita strategia offensiva. Si veniva così a creare sul Tagliamento una tenaglia difensivacontroffensiva che comprendeva, ne lla s ua part e sinistra. anche le fortificazioni della zona di San Daniele sul medio corso del fiume.
Su questo progetto, tra il 1911 ed il 191 2, se ne venne delineando un nuovo.
Infatti, in un rapporto tenuto dal Palli o ai comandanti di armata, nel 1911, il capo di s tillo ma gg iore informava che ancora per quelJ"anno. malgrado tutti gli sfarl i dell"ufficio trasporti. non sarebbe stato possibi le attuare c he una parte dei provvedimenti riguardanti l'occupa7ione avanzata, pur introducendo le varianti organiche che erano state apportate all'ordinamento quali la CO!->tituzione di nuovi reparti alpini e batterie di artiglieria da montagna, nuove formazioni di artiglieria da forteaa e nuovi reggimenti di cavalleria assegnati, in aggiunta temporan ea. alla divisioni 41 •
li nuovo p rogetto di radunata fu quindi pronto per il marLo del 1912 ed in esso erano state introdotte tutt e le modifiche organiche. le nuove disposizioni per l'occupazione avanzata e quelle relative alla prima destinazione del le unità.
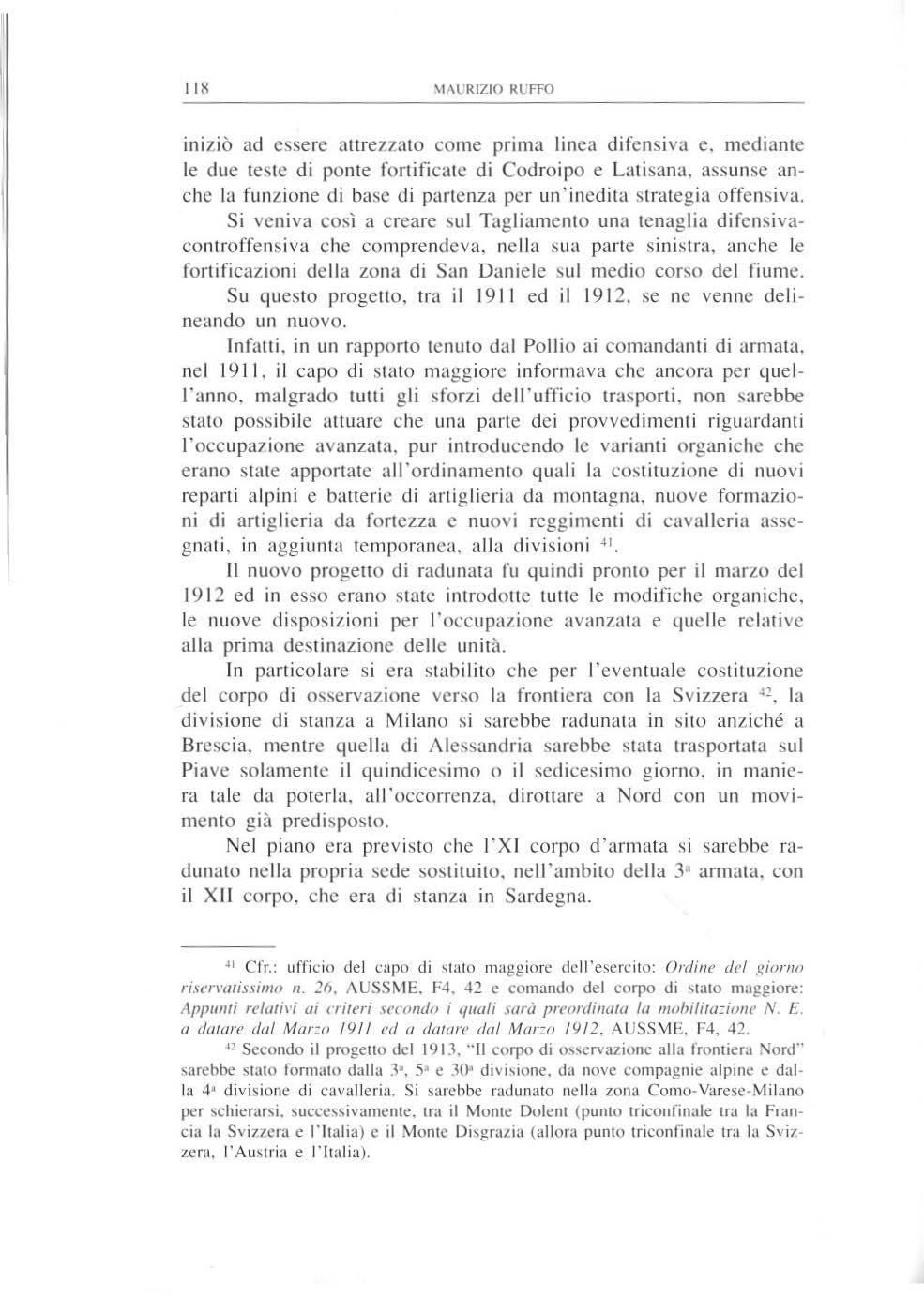
In particolare si era stabi lito che per l 'even tual e cos titu zione del corpo di osserva1,ione verso la frontiera con la Svizzera 42 , la divisione di s tanla a Milano si sarebbe radunata in s ito anziché a Brescia. mentre quella di Alessandria sarebbe stata trasportata sul Pi ave solamente il quindicesimo o il sedicesimo giorno, in maniera tale da poterla, all'occorrenza. dirottare a Nord con un movimento già predisposto.
Nel piano era prev is to che !"Xl corpo d'armata si sa rebbe radunato nella propria sede sostituito. nel! 'ambito della 3·' armata, con il XII corpo, che era di s tan la in Sardegna.
Cf'r.: ufficio del capo di ,tato ma!!giore dell'esercito: Ordine del g iorno ri.1e1Ta1issi1110 11. 26. AUSSME. F4. 42 e comando del corpo di ,rato maggiore: App11111i relatii-i ai criteri H'co 11do i quali wrà preordinata la 1110/Jiliw::ione N. E. a datare dal Mar:o 191/ ed a datarl' dal Mar:o 1912. AUSSME, F4. 42.
,,
IJ Secondo il progetto del 1913. "'Il corpo di O'>'ervazione alla frontiera 'lord"' sarebbe stato formato dalla 3 • , 5• e 30' divi,ione. da nove co mpagnie alpin e e dalla 4 11 divisione di cava lleria. Si sarebbe radunato nel la zona Como- Varese -Milano per schierar,i. succe\\ivameme, tra il Monte Dolent (p unto triconfinale tra la Francia la Svi77cra e l"Italia) e il Monte Disgralia (allora punto trieonfinale tra la Svizzera. I"Austria e l 'Italia).
P er il trasporto di questo corpo al Nord s i sarebbe ricorso ai trasporti marittimi fino a La Spezia cd a Genova e quindi instradato per ferrovia verso il Piave.
Infin e s i era stabil ito c he all'X l fosse affida to il compito di proteggere le coste Sud della penisola da even tuali sbarchi del nemico e cos tituire, nel contempo, una minaccia verso la parte meridionale del s u o territorio.
A tale scopo era previsto che fosse sbarcato s ulla costa orientale cicli' Adriatico, co nfid ando in una sic ura alleanza con la Serbia ed una possibile con il Montenegro.
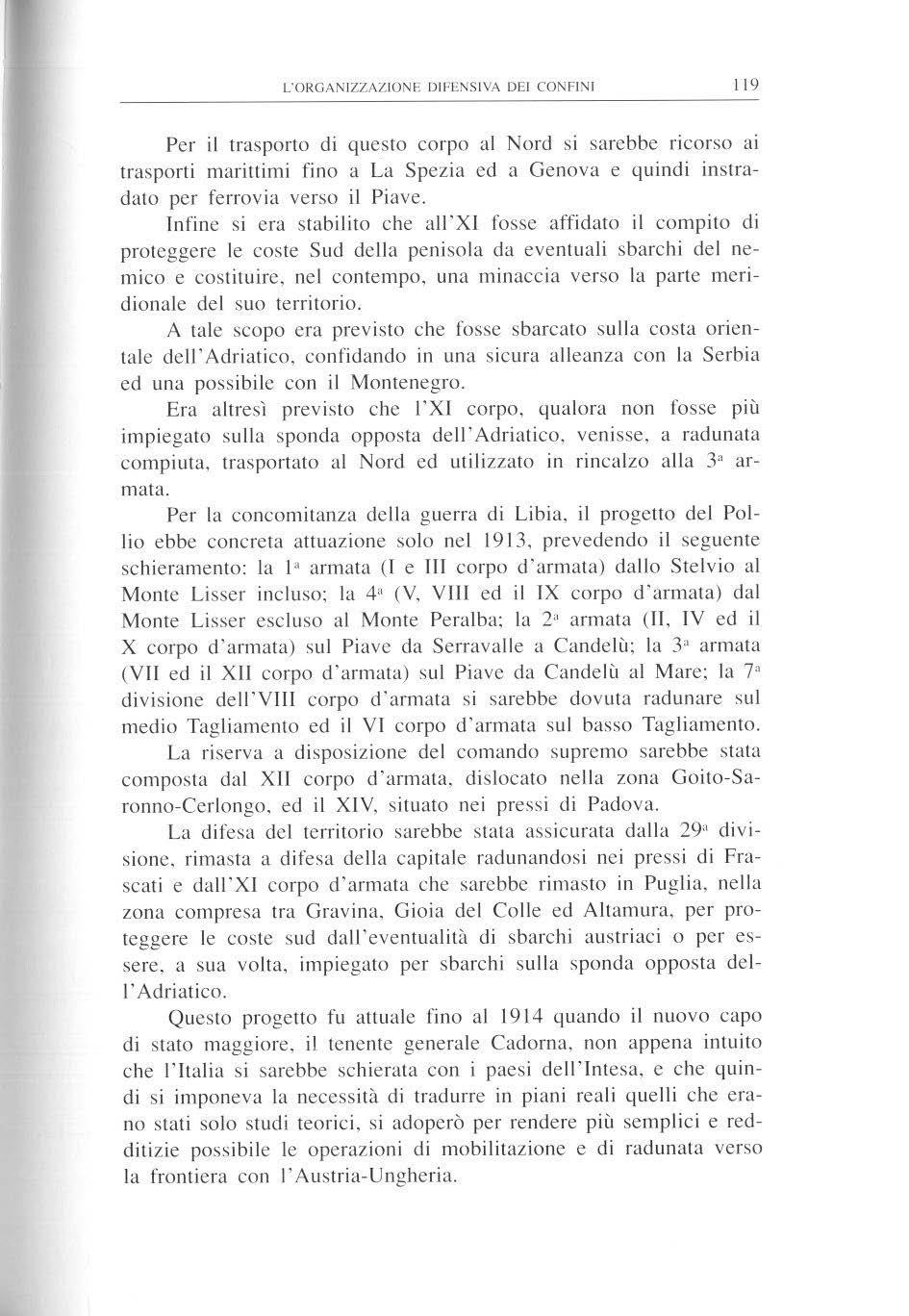
Era altresì previsto che l'XI corpo, qualora non fosse pitt impi egato su ll a sponda opposta del!' Adriatico, venisse, a radunata compiu t a, trasportato al Nord ed utilizzato in rincalzo alla 3• armata.
Per la concomitanza della guerra di Libi a, il progetto del Pollio ebbe concreta att ua z ion e solo nel l 913, prevedendo il seguente schieramento: la 1a armata ( T e III corpo d'armata) dallo Stelvio al Monte Lisser incluso; la 4" (V, Vlll ed il IX corpo d'armata) dal Monte Lisser escluso al Monte Peralba: la 2" armata ( Il , IV ed il X corpo d'armata) sul Pi ave da Serravalle a Candelù; la 3• armata (V IT ed il XII corpo d'armata) su l Piave eia Candelù al Mare; la 7" divisione dell'VIII corpo d'armata si sarebbe dovuta radunare sul medio Tagliamento ed il VI corpo d'armata sul basso Ta gliamento.
La riserva a disposizione del comando supremo sarebbe sta ta composta dal Xll corpo d'armata, dislocato nella zona Goito-Saronno-Cerlongo. ed il Xl V, situato nei pressi di Padova.
La difesa del territorio sarebbe s tata assicurata dalla 29" divis ion e, rimasta a d ifesa della capitale radunandosi nei pressi di Frascati e dall'XI corpo d'armata che sarebbe rimasto in Pu glia, nella zona compresa tra Gravi na, Gioia del Colle ed Altamura, per proteggere le coste sud dall'eventualità di sbarchi austriaci o per esse re, a s ua vo lt a, impiegato per sbarch i su lla sponda opposta dell'Adriatico.
Questo progetto fu attuale fino al l 9 14 quando il nuo vo capo di sta to maggiore, il tenente genera le Caclorna, non appena intuito che l ' It alia si sarebbe sc hi erata con i paes i dell'Intesa, e che quindi si imponeva la necessità di tradurre in piani reali quelli che erano sta ti so lo studi teorici, si adoperò per rendere più semplici e redditizie possibile le operazio ni di mobilitazione e di radun a t a verso la frontiera con l 'Aust ria -Ungheria.
Nello sv iluppo dei progetti di m ob ilita z ion e dal 2 agosto del J914 intervennero tuttavia alcune circostanze di natura politica c he ne condizionarono una co rreua revisione.
li governo, infatti, nel dichiarare la neutralit à italiana non aveva escluso un a partecipazione a l conflitto e. per evitare il rischio di esse re coi n vo lt o anzitempo, si era dimostraro inte r essa to non ranto all'eventualità di una m obi lit azione quanto ad un semplice atto di preparazione militare dire tto a fronteg g iare tutt e le eve ntu a lit à.
In tale situaz ion e tra il 2 ed il 7 agosto si limitò ad autorizza re la prece tta z ion e di 20.000 quadrupedi e di parte dei veico li re4uisibili, diede altresì l'autorizzazione alla chiamata di alcune classi.
Questi primi provvedimenti avevano l o scopo di permettere alr esercito di rinsanguare su l posto le proprie unità e di cos tituirsi una ri serva di uomini istruiti. idonei al trattenimento in servizio al momento in cui si sa rebbe proceduto al rinvio del co ngedamen to delle c lassi richiamate e di quella an1iana.
Alla fine di a gos to le autorità governative s i vennero grad ualmente convi ncendo della necessità di dover pervenire alla mobilitazione generale in sosti tu z ion e di quella parziale precedentemente auto ri uata.
Tutta v ia questa evoluzione s i svi lupp ò attraverso tre successivi progetti c he il ge nera le Cadorna, appena gl i furono co muni ca ti. non esi tò a giudicare come tecnicamente inattuabili perché estremamente pericolosi.
Con il primo s i pensava di predisporre il paese ad uscire dalla ne utralit à cos titu e ndo in Val Padan a. in una posizione cen tral e quindi, una massa di 200-300.000 uomini mobilitando so lo i dodici corpi d'armata permanenti.
1el secondo s i era presa in consideraz ione la necessità di dover richiamare a lle a rmi alcune c lassi di milizia mobile, pu r ci rcoscrivendo il loro impiego presso l'esercito m ob ilitato ai soli elementi rit en uti indispensabili a lla costituzion e degli organi più vitali.
li terw prevedeva di radunare l'intero ese rc ito a l centro della Val P adana. in una posizione arretrata, per evi tare di dare l'impressione di esse rsi sc hi a rati da una parte o d a ll 'a lt ra d e i contendenti.
Scartati tulli e tre dopo l'energico interve nto del capo di stat o ma gg ior e, il gove rno si decise dell'assoluta necessità di a ttu are la m ob ilita zio n e e la radunata secondo i piani g ià predisposti nel tempo di pace.
All'atto della mobilitazione le annate, con i ri s pettivi co rpi d'armata avrebbero assunto la fisionomia e lo sc hieram en to decisi con il documento d e l generale P o lli o de l 1912.
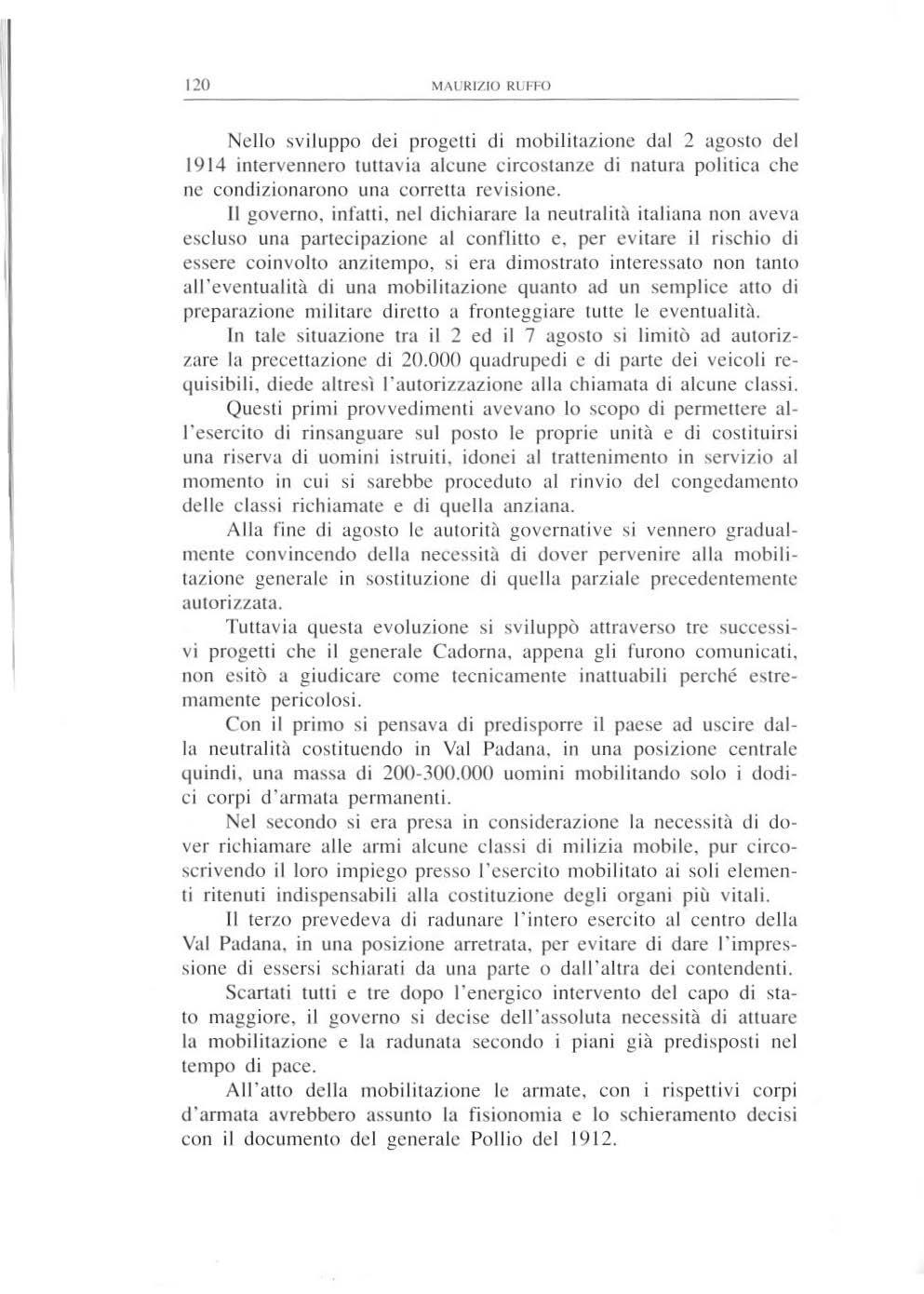
La protezione di queste attività era devoluta, lungo tutta la zona montana dallo Stelvio a l mare, a ll e unità in occupazione avanzata, scaglionate in profondità su due linee ~ .,_
Era inoltre previsto che non appena la situazione politico- internazionale l'avesse consigliato, e comunque prima dell'ordine di mobilitazione, tulle le truppe eia montagna s i spostassero dalle loro sed i sta nzia l i s ull a frontiera minacciata, dove sa rebbero state raggiunte da i reparti assegnati a li ' occupazione avanzata, dalle truppe destinate alla difesa delle fortezze e da quattro div isioni di fanteria; a loro vo lt a tutte le unità che si fossero trovate lontano dalle proprie sed i ab itu a li, v i avrebbe ro dovuto fare immediatamente rientro.
Nel documento s i precisava poi che la radunata dei corpi d'armata permanenti sarebbe avvenuta con lo sfilamento cli cinque di essi sulla lin ea ferroviaria Torino-Verona e sei s u quella Monselice- Conegliano.
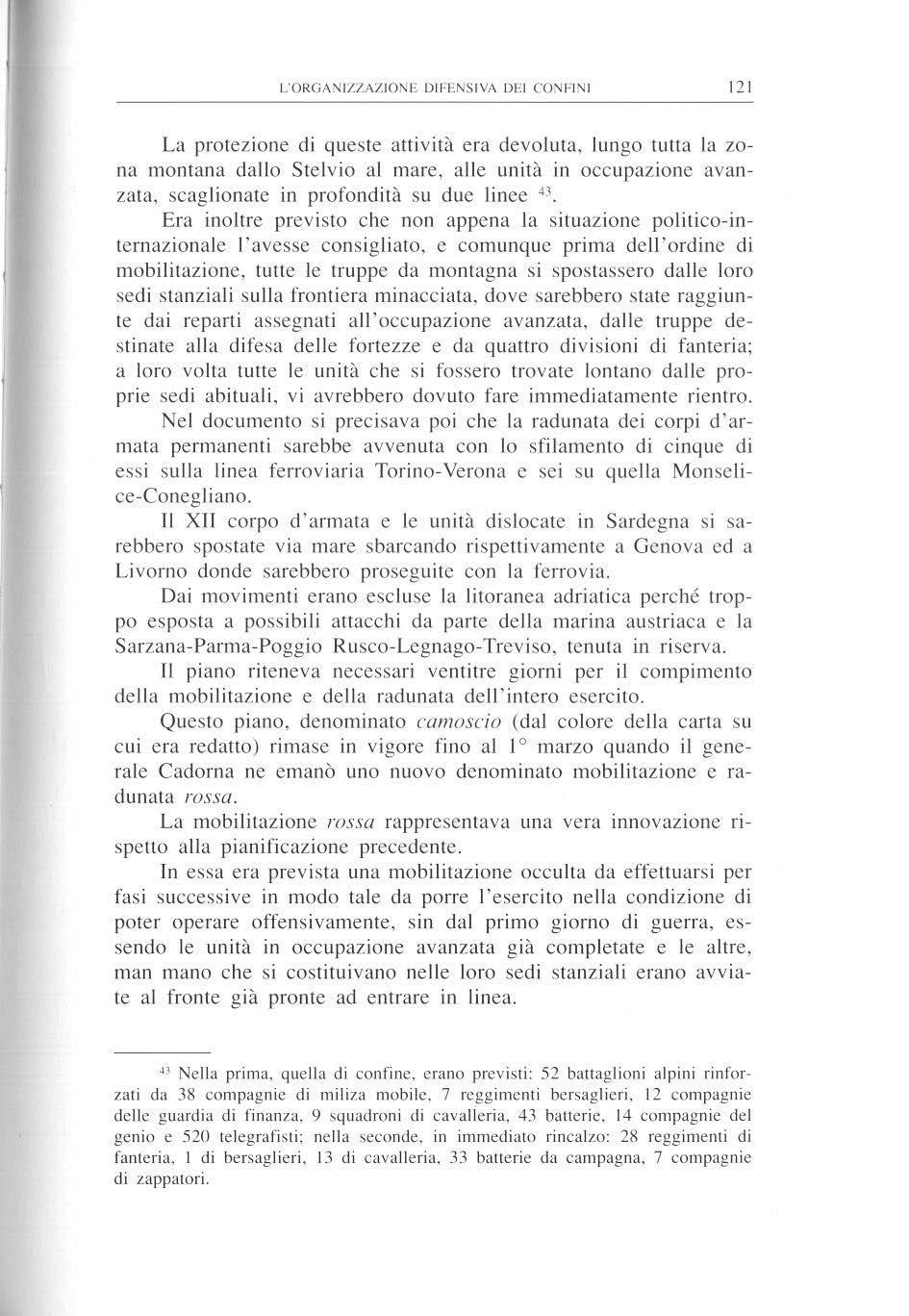
Il XII corpo d'armata e le unità dislocate in Sardegna s i sarebbero spostate via mare sbarcando rispettivamente a Genova ccl a Livorno donde sarebbero proseguite con la ferrovia.
Dai movimenti erano escluse la litoranea adriatica perché troppo esposta a possibili attacchi da parte della marina austriaca e la Sarzana-Parma-Poggio Rusco-Legnago-Treviso, tenuta in riserva.
Il piano riteneva necessari ventitre giorni per il compimento de ll a mobilitazione e della radunata dell'intero esercito.
Q uesto piano, denominato camoscio (dal colore della carta s u cui era redatto) rimase in vigore fino a l l O marzo quando il generale Cadorna ne emanò uno nuovo denominato mobi lit azione e radun a ta rossa.
La mobilitazione rossa rappresen tava una vera innovazione rispetlo a ll a pianificazione preceden te .
I n essa era prevista un a m ob ilita z io ne occu lta da effett uar si per fasi success iv e in modo tale d a porre l 'ese rcito nella condizione di poter operare offe ns iva m e nt e, sin dal prim o g io rno cli gue rra , esse ndo le uni tà in occupazione ava nzata g ià co mpl e t a te e le alt re, man mano c he s i costituivano ne ll e loro sed i sta nziali erano avviate a l fronte già pronte ad entrare in linea.
" 3 Nella pr im a. quella d i confi ne, erano previsti : 52 batta gl ioni alpini r in forzat i da 38 compag ni e di m il iza mob il e, 7 regg im en ti bersa gl ieri, 12 compag ni e delle gua rd ia di f in a nza, 9 sq uad ro ni di cava ll e ri a 43 batte ri e, 14 compag ni e del genio e 520 te legrafisti; nella seco nd e, in immediato rinc a lzo: 28 reggimenti di fa nt e r ia, I di bersag l ie ri , I 3 d i cava ll e ri a. 33 ba u er ie da cam pag na. 7 compag ni e di zappatori.
TI nuovo s istema, inoltre presentava il van taggio di chiamare gradualmente alle armi le varie classi in congedo. alleviando le diffi co lt a di alloggiamento dei repati cd i disagi conness i con un prolungato periodo tra scorso in tenda nella LOna di radunata.
TI governo poi manteneva fino all'ultimo la poss ibilità di sceg li ere il momento di dichiarare la gue rr a. mentre il comandante aveva la facoltà, potendo regolare l'afflusso delle truppe, non solo di m od ificare nel tempo la radunata de ll' ese rcit o. ma anche di assegnare alle amrnte, subito all'i ni zio delle operazioni, gli obiettivi la cui preve ntiva co nqui s ta fosse premessa per l ' ulterior e azione da compiersi non appena riunite le forze necessarie.
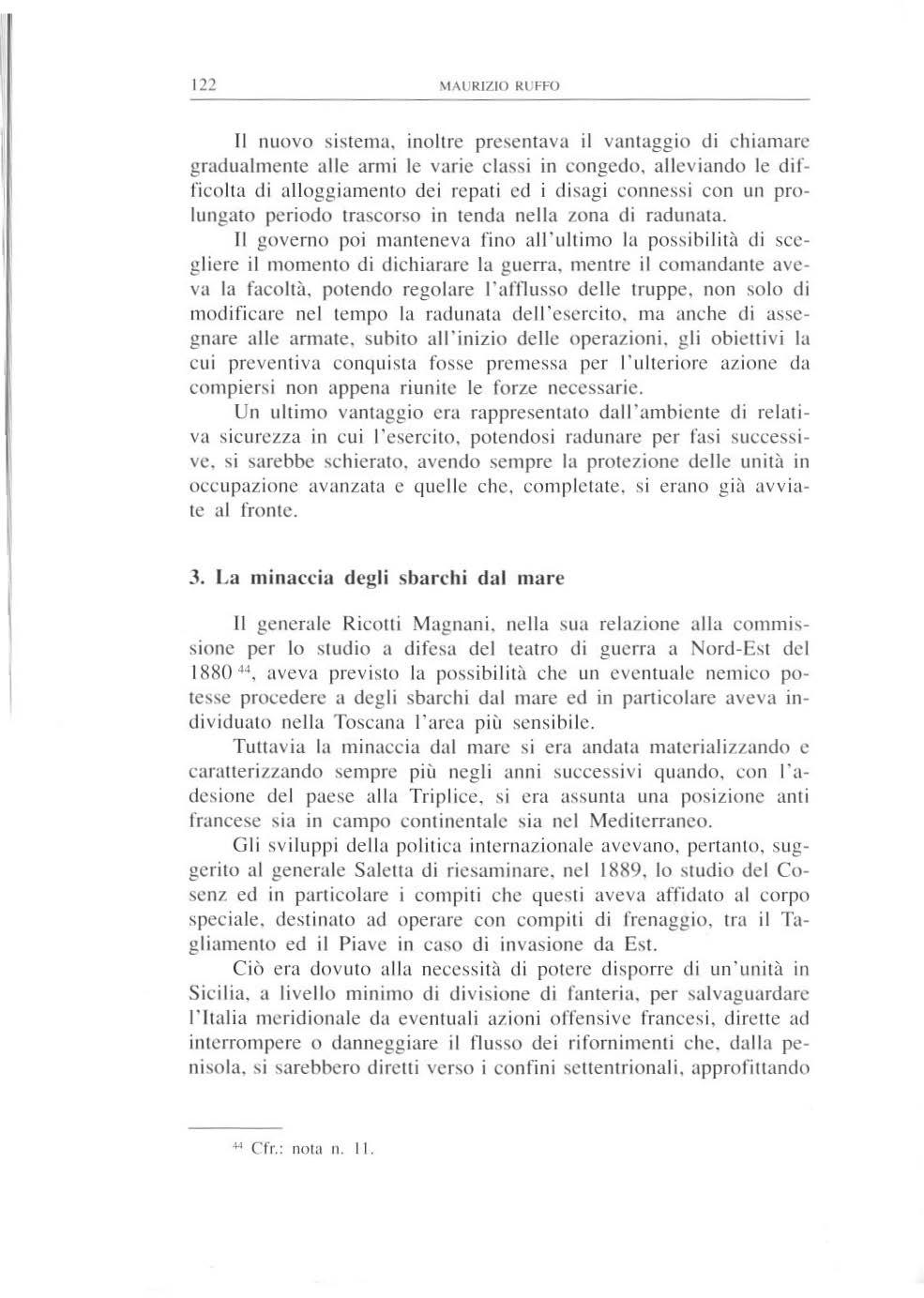
Un ultimo va nta ggio era rappresentato dall'ambiente di relativa s icurezza in cu i l' eserc it o. potendosi radunare per fasi successive, si sarebbe schierato. avendo sempre la prote7ione delle unità in occ upazi o ne avanzata e qu e ll e che, completate. s i era no già avv iate al fronte.
3. La min accia degli s barc hi d a l mare
11 generale Ric otti Magnani. nella 'lUa rela1ione alla commissione per lo s tudi o a difesa del teatro di guerra a ord-Es t del 1880 4 ~ aveva previsto la possibilità che un eve ntuale nemico potesse procedere a degli sbarchi dal m a re ed in particolare aveva individuato nella Toscana l 'arca più se n sibi le.
Tuttavia la minaccia dal mare si era andata materiali7lando e caratteri, La nd o sempre più negli anni successivi quando, co n l'adesione del paese alla Tripli ce. si era assunta una posizione anti francese sia in ca mp o contine nt ale sia nel Mediterraneo.
Gli sv iluppi della politi ca interna z ional e avevano, pertanto. suggerito a l genera le Saletta di riesaminare. nel 1889, lo studio de l Coscnz ed in particolare i compiti che qu es ti aveva affidato al co rp o specia le destinato ad operare con compi ti di frenaggio, tra il T agliamento ed il Pi ave in caso di invasione da Est.
Ciò e r a dovuto alla n ecess it à di potere disporre cli un'unità in Sicilia. a livello minimo di divisione di fanteria, per ,alvaguardarc l' It al ia meridionale da eve ntu a li azioni offensive fran ces i, direrte ad interrompe re o danneggiare il flusso dei rifornimenti che dalla peni sola, si s arebbero diretti verso i confini scllentriona li , approfittando
dell'estensione e della quasi totale mancanza cli protezione del le nostre coste.
Un altro provvedimento, adottato dal Saletta , era stato quello di sc hierare un corpo d'armata in Pu glia cd una divisione a Roma.
Infatti , fatta eccez ione per alcune opere fortificate lungo la costa, come i forti di Reg g io Calabria e Messi na , non esistevano oper e per la difesa delle coste, ma solo presidi per la difesa di obietti v i particolari come la stessa capitale e la piazza di Napoli, salvagua rdata , peraltro, so lo da 6 battaglioni di milizia territoriale.
TI problema della difesa delle coste era quindi stato affrontato anche dal le due commissioni del 1899 e 1900 nella quali, oltre ad auspicare un intervento diretto della marina e delle unità navali dell a regia guard ia di finanza, si erano s tudiati alcuni provvedimenti cli carattere fort ificatorio lun go le coste dove era previsto l 'impiego di repar ti cli milizia mobile e di alcu ne batterie di artiglieria da campag n a.
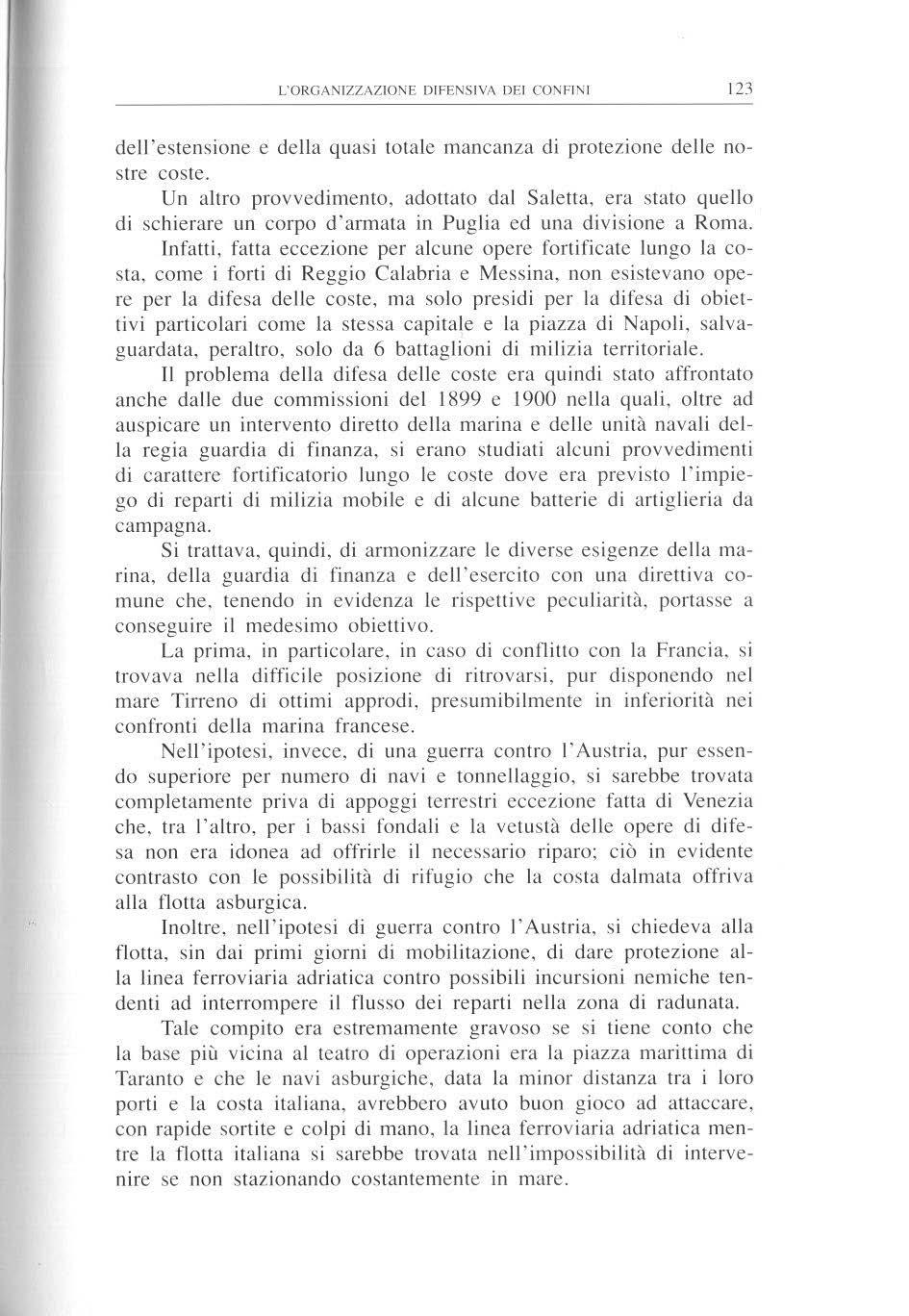
Si traltava, quindi, di armonizzare le diverse esigenze della marina, della guard ia di finan za e clcll 'esercito con una direttiva comune che, tenendo in ev id enza le ri spettive peculiarità, portasse a conseguire il medes imo obiettivo.
La prima, in particolare, in caso di confli tt o con la Francia , si trovava nella difficile posizione di ritrovarsi, pur disponendo ne l mare Tirreno cli ott imi approdi, presumibilmente in inferiorità nei confronti della marina francese.
Nell'ipotesi, invece, di una gue rra contro l 'Austr ia, pur essendo s uperiore per numero cli navi e tonne ll aggio, si sa rebb e trovata co mpletam e nt e priva cli appoggi terrestri eccezione fatta di Venezia c he, tra l 'a ltro, per i bassi fondali e la vet us tà delle opere di difesa non era idon ea ad offrirle il necessario riparo; ciò in evide nt e con tra sto con le possibilità di rifugio c he la costa dalmata offriva alla flotta as burgica .
Inoltre, ne ll 'ipo tesi di guerra co ntro l 'A u s tria , s i c hi e d eva alla fl o tta, sin dai primi giorni di mobilitazione, di dare protez ion e all a linea ferroviaria adriatica contro possibili in cursioni nemiche tendenti ad interro mp ere il flu sso dei r e parti ne lla zona di radunata.
T ale compito era est re m a me nte gravoso se s i tiene con t o che la base più vicina al teatro cli operazio ni era la piazza marittima cli Taran to e che le navi asb urgiche, data l a minor distanza tra i loro porti e la cos ta italiana, av reb bero avu to buon gioco ad attaccare, con rapide sort ite e co lpi cli mano, la linea ferroviaria adr i at ica mentre la flotta italiana si sa re bbe trovata nell'impossibilità di intervenire se non stazio nando cos tant e mente in mare.
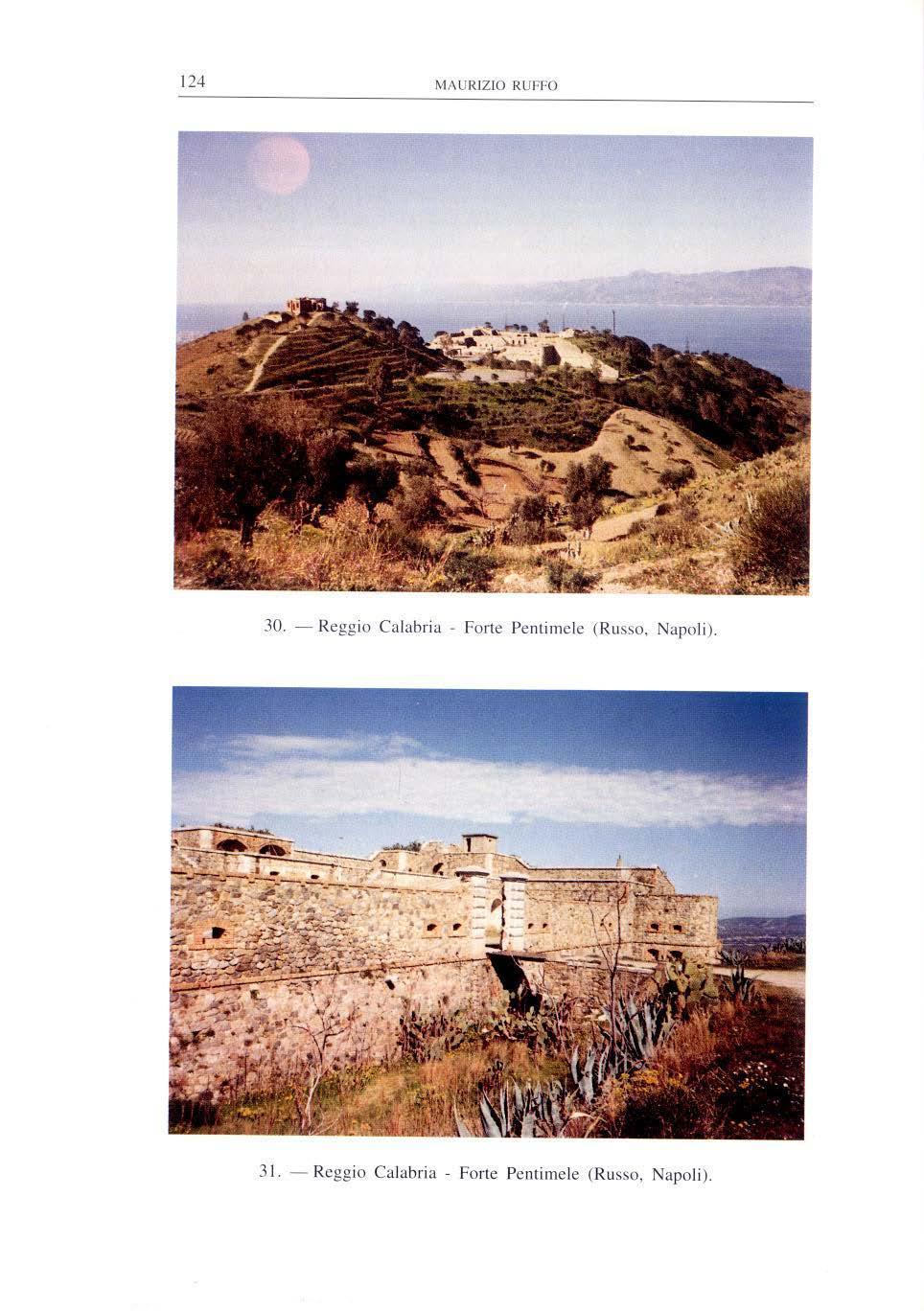
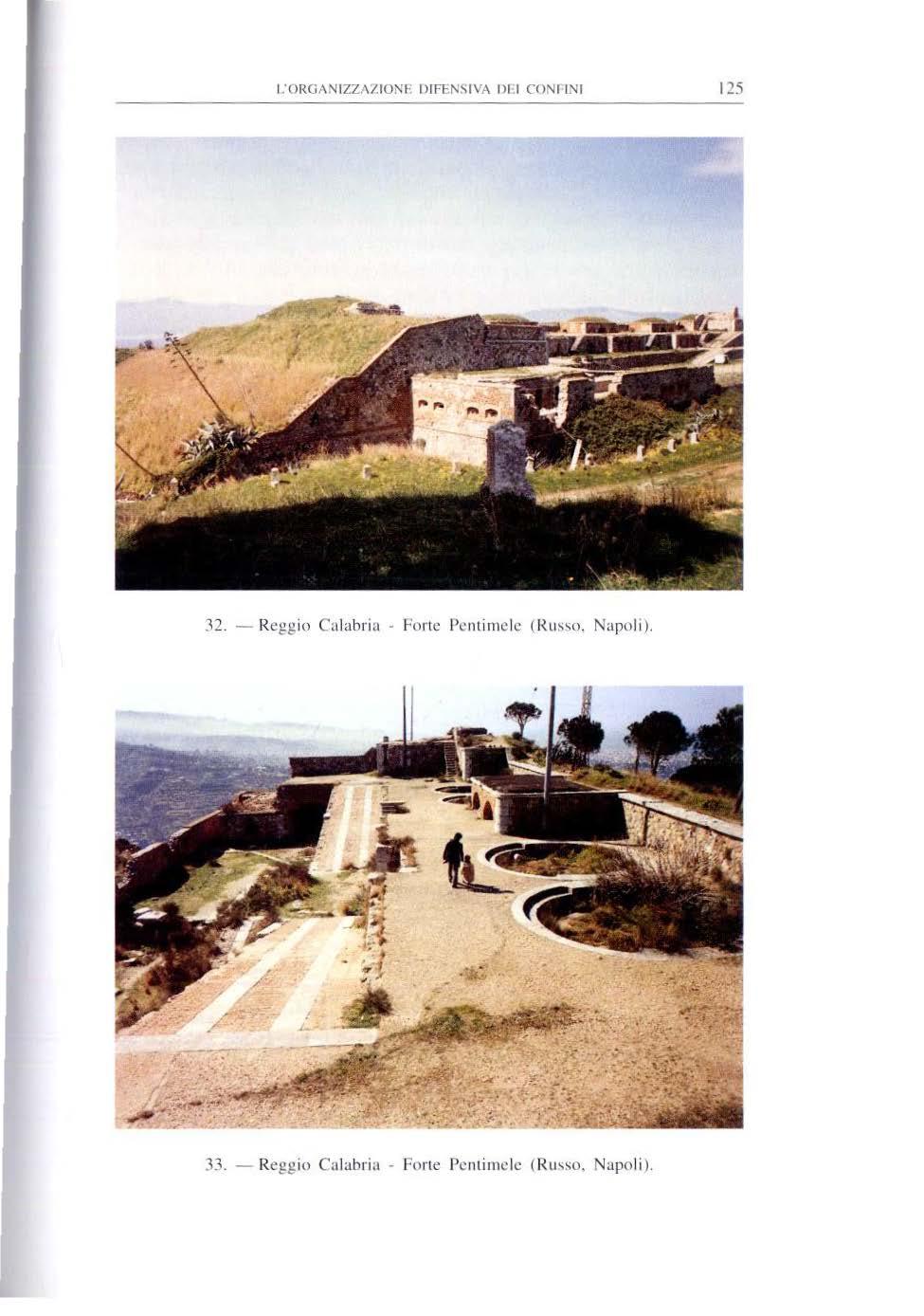
Di quest o s tato d i cose s i era fatto int e rprete il mini s tro d e lla marina c h e in una lettera indirizzata il 24 maggio de l 1905 al capo di stato m aggiore d e ll 'ese r cito con ogge tt o la pro tez io n e della flotta alla mobilit az ion e dell' ese rcito n e l caso di radunata Nord-Est 45, so tt o lin eava le diffi co lt à c h e la marina avrebbe dovuto a ffrontare e s up era re per asso lvere nel migliore dei modi al co mpit o richi es tog li: tuttavia il mini s tro ribadiva che: .. .cotes t o compito di p roteggere la mohilita:ione del/· esercito nel percorso ferrm·iario litoraneo sarà ten uw prese m e, per l'alto suo i•a/ore, i11 quelle istru:::ioni che sarehbero emana t e rerijica11dosi il caso che qui si considera 46 .. .; so tt oli n eando in tal e modo la totale dedi1:ione della marina.

Le is tru z ioni ausp icate dal ministro d e lla marina trovarono rap idame nte conc re t a rea li zzaz ione: non solo. esse furono ogge tt o di co ntinu o aggioname nt o, in maniera congiu nta da parte ciel mini stero d e l la guerra e di que ll o della marina, fino al marzo 1915 quando i ministri Zuppelli, per il dica s tero della g uerra, e Viale. per quello d e lla marina. a pprovarono l'ultima s tes ura , prima della g uerra, del/" /stm : ione per la difesa delle coste e per la prote:io11e delle Jerrtffie in guerra.
L'istruzione H s i divid eva in du e parti: la prima tratlava d e lla difesa delle cos te . mentre la seconda si occu pa va della pro te7i one delle ferrovie.
In essa venivano s tabiliti i vari tipi di inte rv e nto, chi li d oveva a ttu a re e le vari e responsabilità di comando al fine di svolgere un·azione g ià coo rdinata preve ntivam e nt e s in dal te mpo di pace ed in g rado di esse re attua ta. co n la d ovu ta ce le rità e s incroni a, al m omento delrord in e di mobilita1:ione.
Il manuale, infine , si co nclud ev a co n una tab e lla .ix c he d efiniva. sc h e mati ca ment e, ma n e l contempo c hiaram e nt e . i tra tti di litorale da difendere ed i coma ndi a c ui e ra devoluto il compi to.
Per quanto atten e va al l ' o rdinam c nto d e ll a difesa costi e ra il ge-
4 ' C'fr.: Ml ISTERO DELLA MARI I\. ufficio di srnto maggiore: Prme:to· 11e della Flo11a alla 111ohitiw:io11e de/feser<"iw 11ef caso di racl,maw NE pro1. n. 1224 RR del 24 ma ggio 1905. A USS ME F4, 11.
• 1 • Cfr.: Ibidem.
J ' Cfr.: l :i1ru:io11e per fa difi•.w delle cMI<' e per fa pm1e:io11e delle Jerm1·ie i11 guerra. minislcro della guerra e mini ~tc ro del la marin a. Rom a 1915. AUSSME. F-1. 2.
" Cfr.: D ocumento n. 11.
nerale Saletta, e,tremame nt e atten to a l problema, non lesinava gl i sfarti per giungere ad un potenziamento del delicato se1tore.
In tal e quadro. n e l dicembre d e l 1905 . in una riuni o ne con g li ispet1ori delle costruzioni del genio e d'artiglieria circa I'asselto difens ivo d e lla lin ea d e ll e Giudi c ari e e delle val li dell'Assa e cieli' Astico, si era affrontato il prob lema di potenziare I 'a rmam ento di alcune batterie cos ti ere nella piazza di T aranto e di Venezia '"
Per quest'ultima, in particolare. s i trall ava di intallare d e i cannoni da 254 B fomiti dalla marina. nella zona del Cavallino. ad E s t cli Venezia. per poter contrastare le na vi nemic.:he a n c.:he a ll e lunghe distanze ,o.
li Po lli o, a s u a vo lt a , s i era mostrato particolarm en te sensibile a l prob le ma d e lla difesa cos ti era, ev id en7. iand o, n e ll a riunione d e l 23 dicembre 190 8 51 , l'importanza che, in tale contesto. avrebbe assun to la piazza di Brindi si .
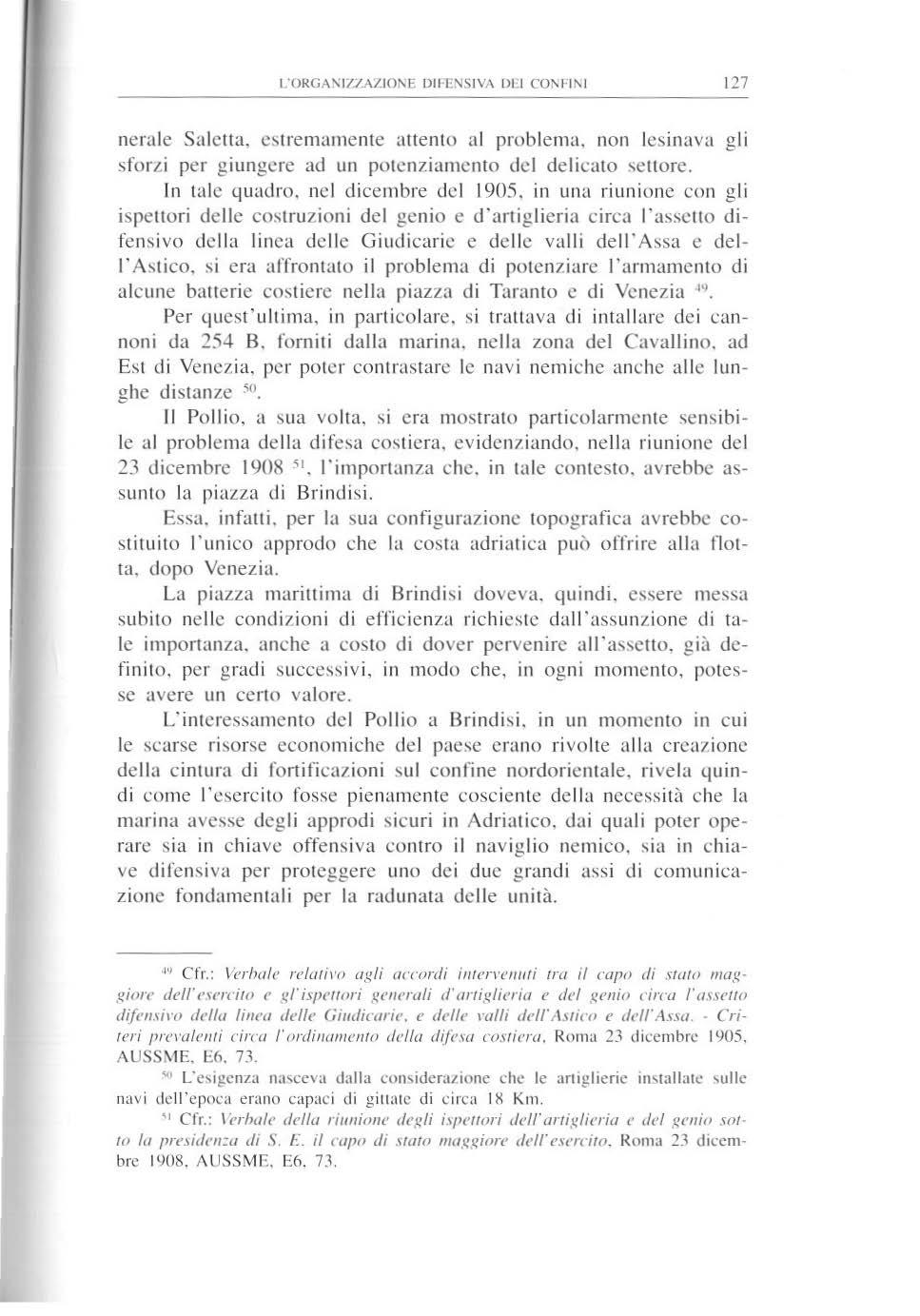
E ssa. infalli. per la s ua co nfigurazion e topo grafica avrebbe cos tituito l ' unico a pprod o c h e la cosra adriatica può offrire alla flotta. dopo Venezia
La piazza marittima di Brindisi dov eva quindi, esse r e messa subito n e ll e condi z ioni di eff ic ie n z a richieste dall 'ass un zio n e di tale importanza. anc.:he a costo di do ve r per ve nire all'assetto. g ià d efinito. pe r g radi s ucc ess iv i, in mod o c h e, in ogni momento, potesse ave re un certo valore.
L'interessame nto del Polli o a Brindisi. in un mom e nto in cui le sc.:a r se risor se eco n om ic h e del paese era no riv o lt e a lla creazione d e ll a cin t ura di fortifica1io ni !-i UI co nfine nordorientale, ri ve la quindi c.:o me I·es ercito fosse pienamente wsciente d e l la necess ità c h e la marina avesse d eg li approdi s ic uri in Adriatico, dai quali pote r operar e s ia in c hia ve offensiva c.:o ntro il naviglio n e mico, sia in c hi ave difensiva per prote gge re uno dei due g randi ass i di co muni cazion e fondamentali pe r la radunata de ll e unità .
Cfr.: I 'erho/e relaril ·o agli accord i i111e 1T c11 111 i tra il capo di sta ro maggiori • del/' e11•rci10 , r.:fispetwri ge111'rali ,rarriglieria e del ~e11io circa /' arse//o diji•11 ,irn della linea delle G111dicam• e delle rnlli clel/' , h1irn e 1il'lrA.1.1a - Cri1ai prc\'(l/e111i cirrn /' ordi11a111c11 10 dello diji•,a cos riera, Roma 23 dicembre 1905, AUSS'v1E. E6. 73.
,,,
"' L·e\lgenza na,cc\'a dalla con~idcra1.ione che le artiglierie i1htalla1c \Ulle nav i de ll' epoca erano ca pac i di g i11 a1c di c irc a 18 Km.
'
' Cfr.: \ 'erhafr e/ella ri1111io11c degli i.1pe1rori del/' artiglieria 1• del ge11io SOi · lo la pre:,id,•11:a d, S. E. il c apo di ,\/tifo maggiore delr est'rd/0 R oma ~3 dicembre 1908. /\ USS ME . E6. 73 .

Verificate, con varie eserci ta zioni per i quadri , le diverse ipotesi operative prese in cons id erazione dallo studio del generale Cosenz, già dal 1889 si era se nt ita la necess it à di provvedere ad un aggiornamento dello studio s t esso.
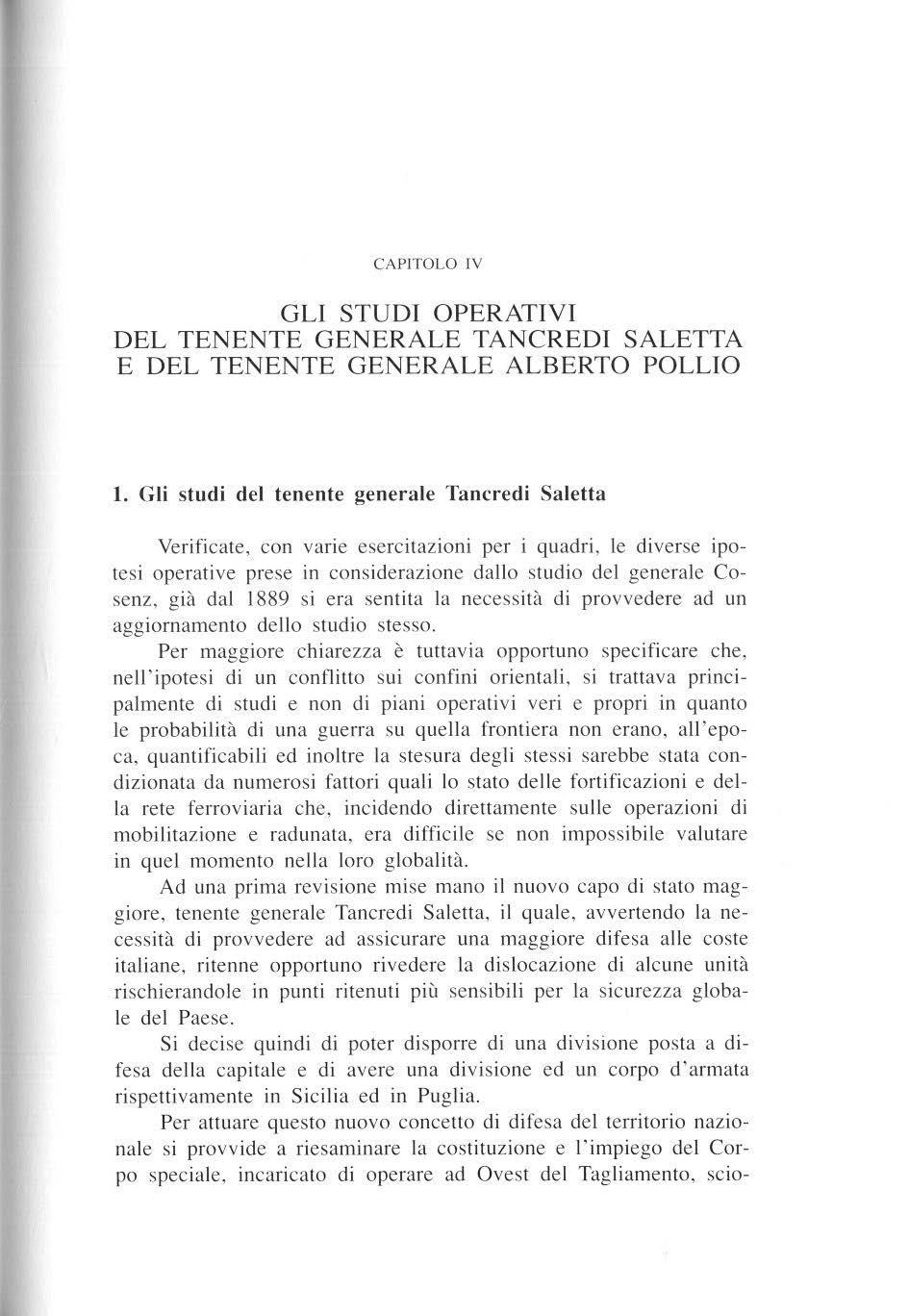
P e r maggiore ch i arezza è tuttavia opportuno spec ifi ca re che, nell'ipotesi di un conflitto sui confini orientali, si trattava principalmente di stud i e non di piani opera ti vi veri e propri in quanto le probabilità di un a g uerra su qu e lla frontiera non erano, all 'epoca , quantificabili ed inoltre la s te s ura degli s tess i sa re bbe s ta ta condizionata da num erosi fattori qu a li lo s tato delle fortificazioni e della re te ferroviaria c he, in cidend o di re tt ame nte su ll e operazioni di mobilitazione e radunata, era diffi cile se non impossibile va lut are in quel momento nella lor o g lob a lit à
Ad una prima revisione mi se man o il nuo vo capo di s tato maggio re, tenente genera le Tancredi Sal e tta , il quale , avve rt e ndo la necessità di prov vede r e ad assicurare un a maggiore dife sa alle coste itali ane, ritenne opportuno riv e d e r e la di s loca zione di alcune unità rischierandole in punti ritenuti più se nsibi li per la sicurezza globale ci e l Paese
Si decise quindi di poter disporre di una divisione posta a difesa della capitale e cli avere una di v isione ed un co rpo d'armata rispettivamente in Sici lia e d in Pu g lia.
Per a ttuare questo nuovo concetto di difesa ciel terr itorio na zional e si prov vid e a riesaminare la costituzione e l'impiego de l Corpo s pec ial e, in ca ri ca to di operare ad Oves t del Tag liamento , sc io -
gliendolo e des tinando a svo lgere le s ue funzioni di copertura tr e divi s ioni cli cavalleria dis locate sulla si ni s tra di quel corso d 'acqua.
La 1a e la 2" armata destinate a sc hierar si s ul Piav e, dovevano , inoltre , spi nge r e tr e corpi d'armata fra il Piave ed il Ta g liamento ed un altro nella zo na di Belluno.
L ' armata di ri se rva, poi , venne di s locata più a Nord, ne lla zona di Padova-Rovigo - Leg nago.
Tutti que st i provvedimenti furono quindi adottati per re c uperare qu e ll e forze necessarie per l'attua zione del progetto di difesa delle coste.
Questo studio, tuttavia, se conseguiva l 'ob iettivo prefissato di dare una certa s icurezza anche ai confini costieri, avrebbe comportato, come abbiamo detto la revi sione dei piani di mobilitazione e radunata e la nece ss ità di rafforzare i confini montani con poderose ope r e fortificate.
Il dibattito sulla sicurezza verso Nord-Est veniva, quindi , assumendo se mpre maggiore importanza e s ia lo stato mag g iore sia i comandi periferici si adoperarono, neg li anni successivi, pe r affrontare e dare una risposta credibile ali' ipotes i di una g uena co ntro l'Austria-Unghe ria.
A questo sforzo dello s tato mag g iore s i era no affiancate le riso luzioni d e lla comm issione per la dife sa dello sta to che, ne ll e s ue sed ut e del 1899 e ciel 1900, aveva so ttolineato l 'asso luta necessità cli provvedere alla difesa de i confini Nord -Ori e ntali e, in partico lare, della fron ti e ra friulana mediante la creazione di una robusta fascia fo rtifi cata lungo le principali vie di facilitazione in montagna, pe r impedire g li aggiramenti eia Nord, e la contemporanea realizzaz ione di una moderna rete ferroviaria nella pianura fino a l Pia ve.
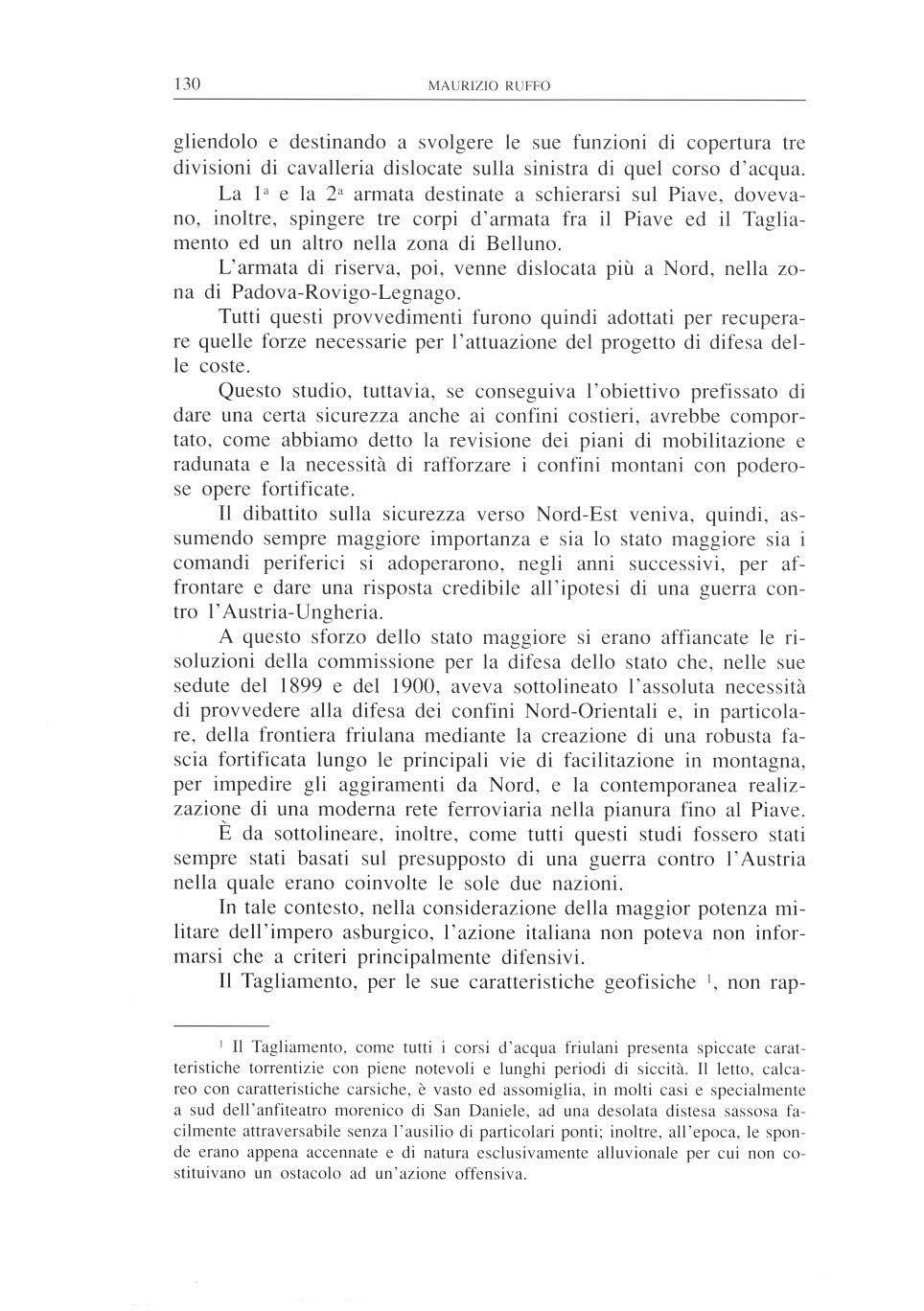
È da sottolineare, inoltre, come tutti que s ti s tudi fossero s tati sempre stati bas ati s ul presupposto di una gue rra contro l 'A ustria nella quale e rano coinvolte le so le due na z ioni.
In tale contes to. nella considera z ione della maggior poten za militare dell'impero asburgico, l 'azione italiana non poteva non informars i che a criteri prin cipalmente difen s ivi.
TI Tagliamento , per le sue caratteristiche geofisiche 1 , non rap-
1 Il Tagl iame nto , come tutti i corsi d'acq ua friu lani presen ta spiccate caratteris ti c he torrent iz ie con pie ne notevoli e lu nghi periodi di sicc ità Il le llo calcareo co n caratte ri s ti che carsic he, è vasto ed assomiglia. in mo lti cas i e specia lmente a sud d el l'anfit ea tro more nico di Sa n Dani ele. ad una d esolata di stes a sassosa faci lm ente attra versa bil e senza l'ausi lio di parti colari ponti ; inoltre. a li 'epoca, le s ponde era no appe na accennate e di natura escl usiva me nt e alluviona le per c ui non cost it uivano un ostacolo ad un'a z ion e offe nsiva.

DELL'ESER CITO ALLA FRONTIERA
NELLO STUDIO D EL 1889
123 ()JV/S ION/i A PAURMO /
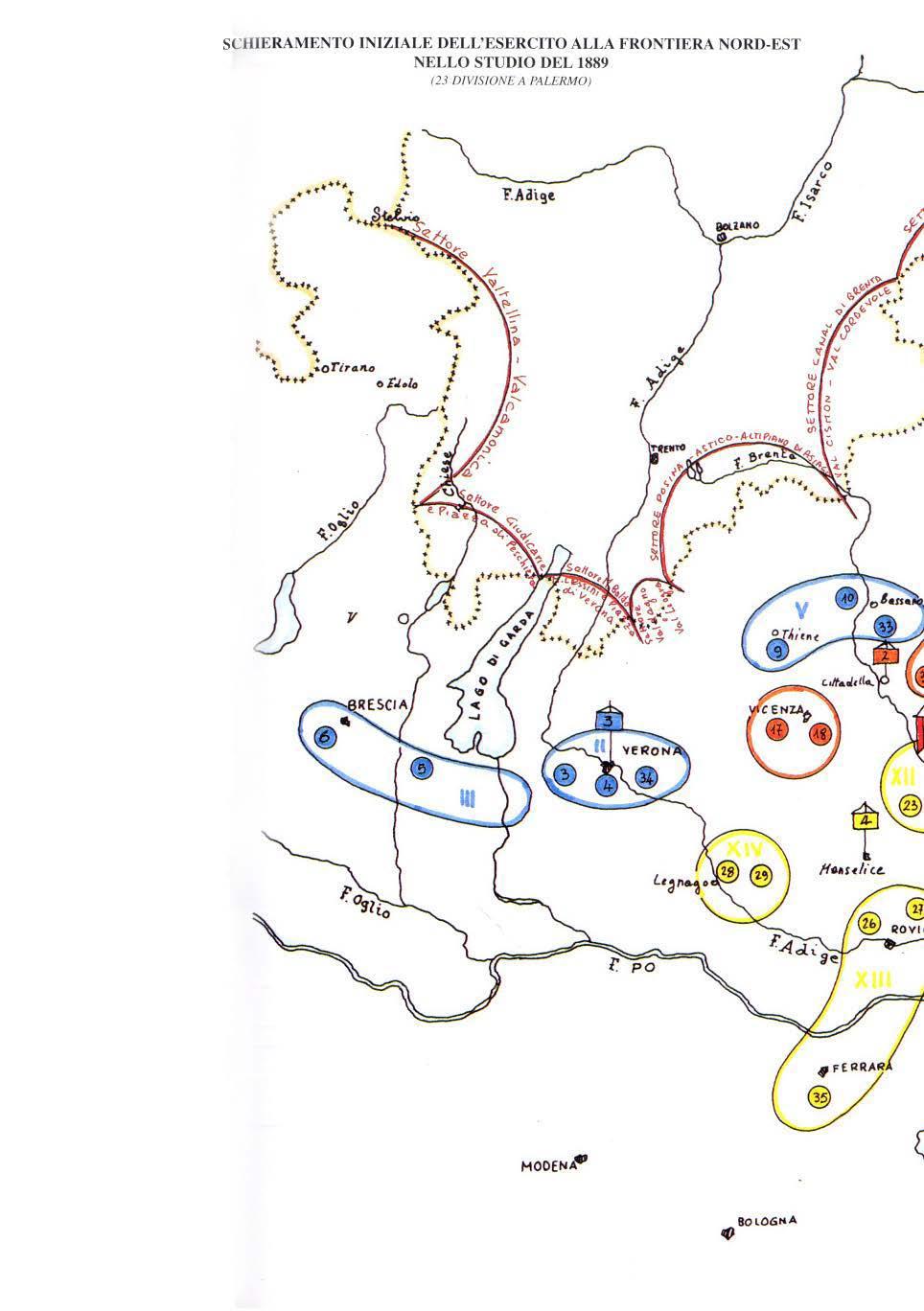

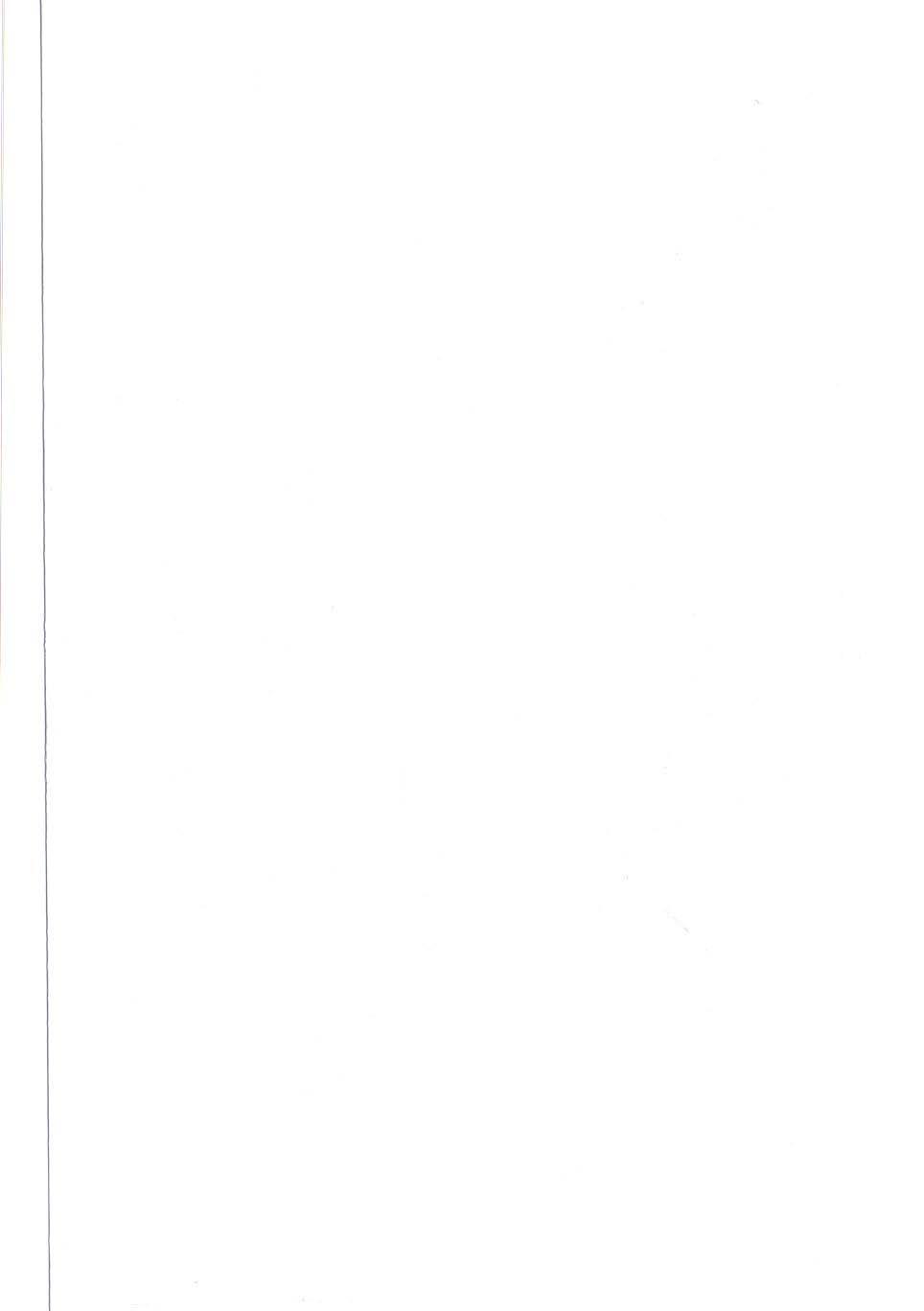
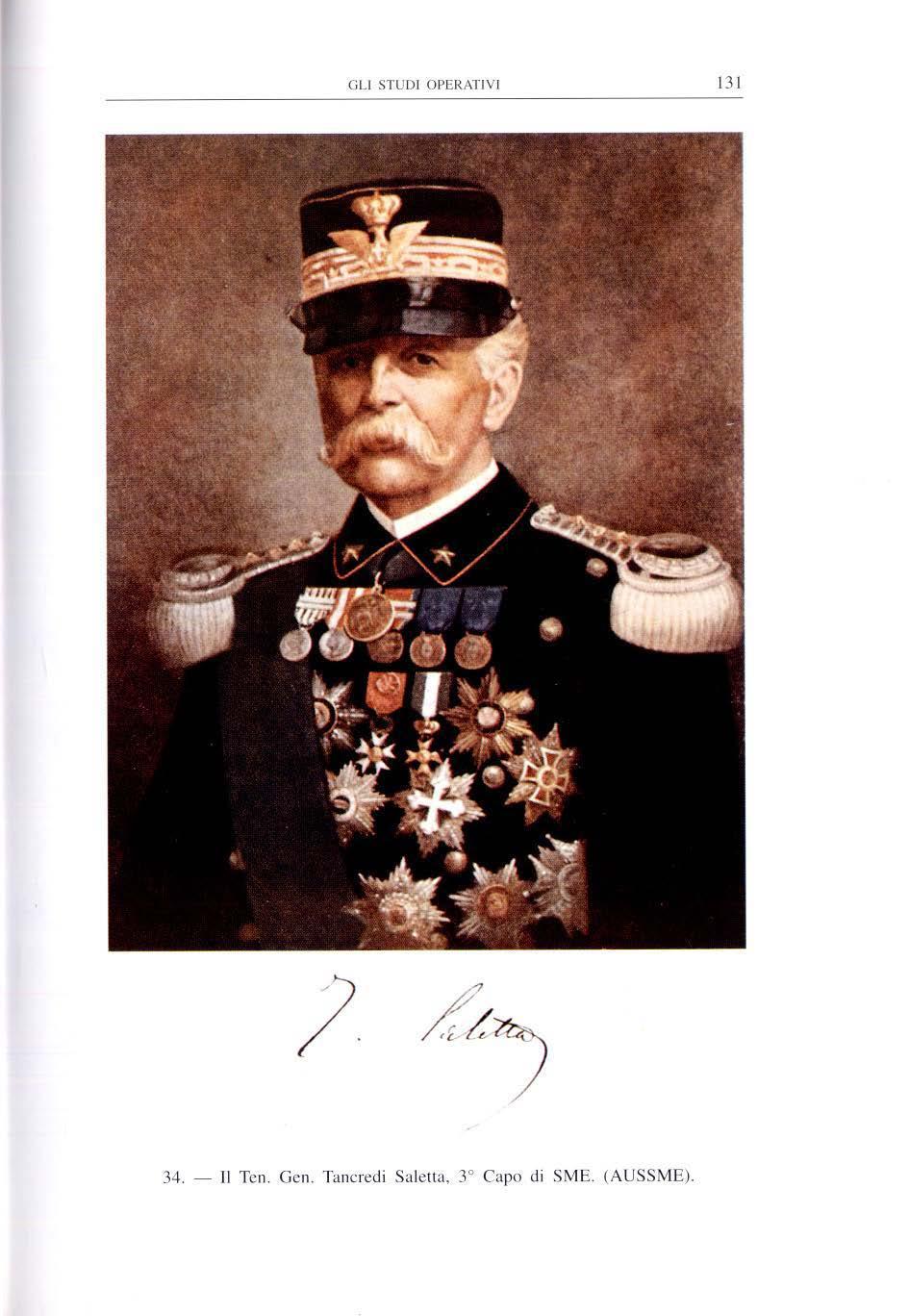
presentava di per sè un ostacolo rilevante e si trovava ad una certa distanza dai terminali ferroviari italiani creando, di conseguenza, grosse difficoltà, sia temporali sia logistiche, per le operazioni della radunata, mentre era sufficientemente vicino all ' Tsonzo, considerato la base di partenza delle unità austriache che potevano usufruire, invece, di un 'o ttima rete ferroviaria per effettuare il loro concentramento.
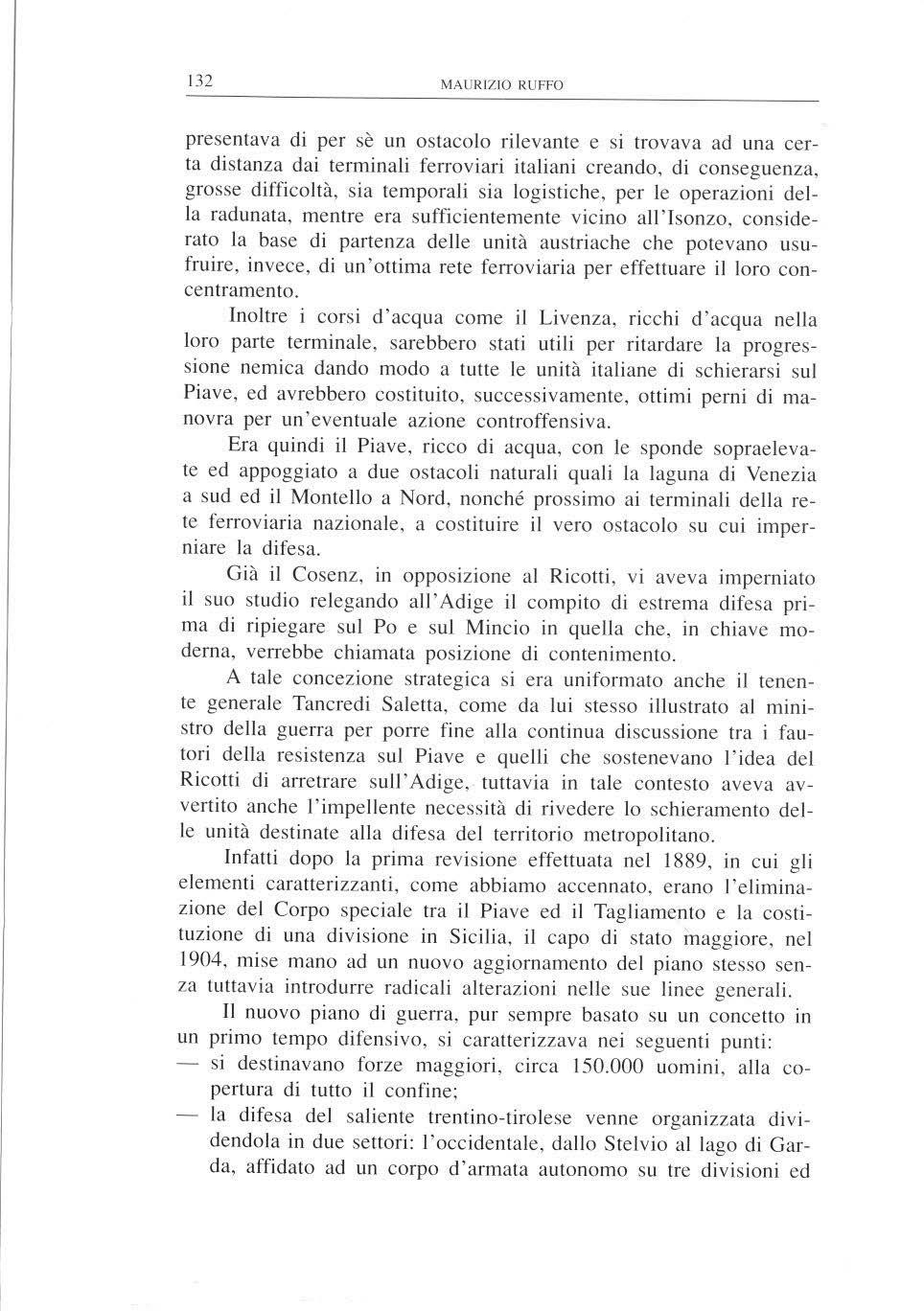
Inoltre i corsi d'acqua come il Livenza, ricchi d 'acq ua nella loro parte terminale , sarebbero stati utili per ritardare la progressione nemica dando modo a tutte le unità italiane di schierarsi sul Piave, ed avrebbero costituito, successivamente, ottimi perni di manovra per un 'e ventuale azione controffensiva.
Era quindi il Piave, ricco di acqua, con le sponde sopraelevate ed appoggiato a due ostacoli naturali quali la laguna di Venezia a sud ed il Montello a Nord, nonché prossimo ai terminali della rete ferroviaria nazionale, a costituire i I vero ostacolo s u cui imperniare la difesa.
Già il Cosenz, in opposlZ!one al Ricotti , vi aveva imperniato il suo studio relegando alJ' Adige i I compito di estrema difesa prima di ripiegare s ul Po e sul Mincio in quel1a che, in chiave moderna , verrebbe chiamata posizione di contenimento.
A tal e concezione strategica s i era uniformato anche il tenente generale Tancredi Saletta, come da lui stesso illustrato al minist ro della guerra per porre fine alla continua discus sio ne tra i fautori della resistenza s ul Piave e quelli che sostenevano l'idea del Ricotti di arretrare s ull'Adige, tuttavia in tale contesto aveva avvertito anche l'impellente necess ità di rivedere lo sc hieramento delle unità destinate alla difesa del territorio metropolitano.
Infatti dopo la prima revisione effettuata nel l 889, in cui gli elementi caratterizzanti, come abbiamo accennato , erano l'eliminazione del Corpo speciale tra il Piave ed il Tagliamento e la costituzione di una divisione in Sicilia , il capo di stato maggiore, nel 1904, mise mano ad un nuovo aggiornamento del piano stesso senza tuttavia introdurre radicali alterazioni nelle sue linee generali.
Il nuovo piano di guerra, pur sempre basato su un concetto in un primo tempo difensivo , si caratterizzava nei seguenti punti:
si destinavano forze maggiori, circa 150.000 uomini , alla copertura cli tutto il confine;
la difesa del saliente trentino-tirolese venne organizzata dividendola in due se ttori: l 'occidentale , dallo Stelvio al lago di Garda, affidato ad un corpo d'armata autonomo su tre divisioni ed

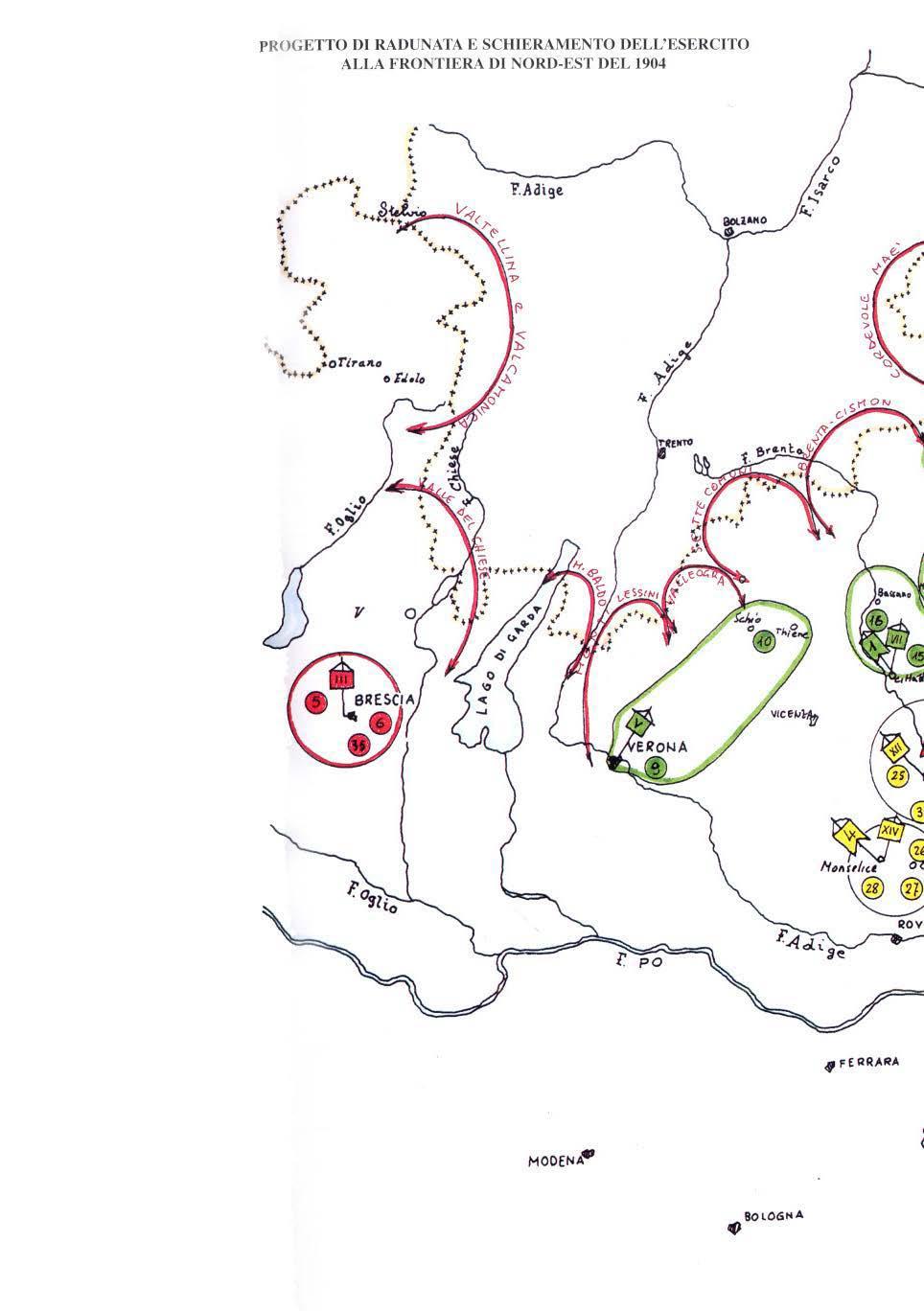
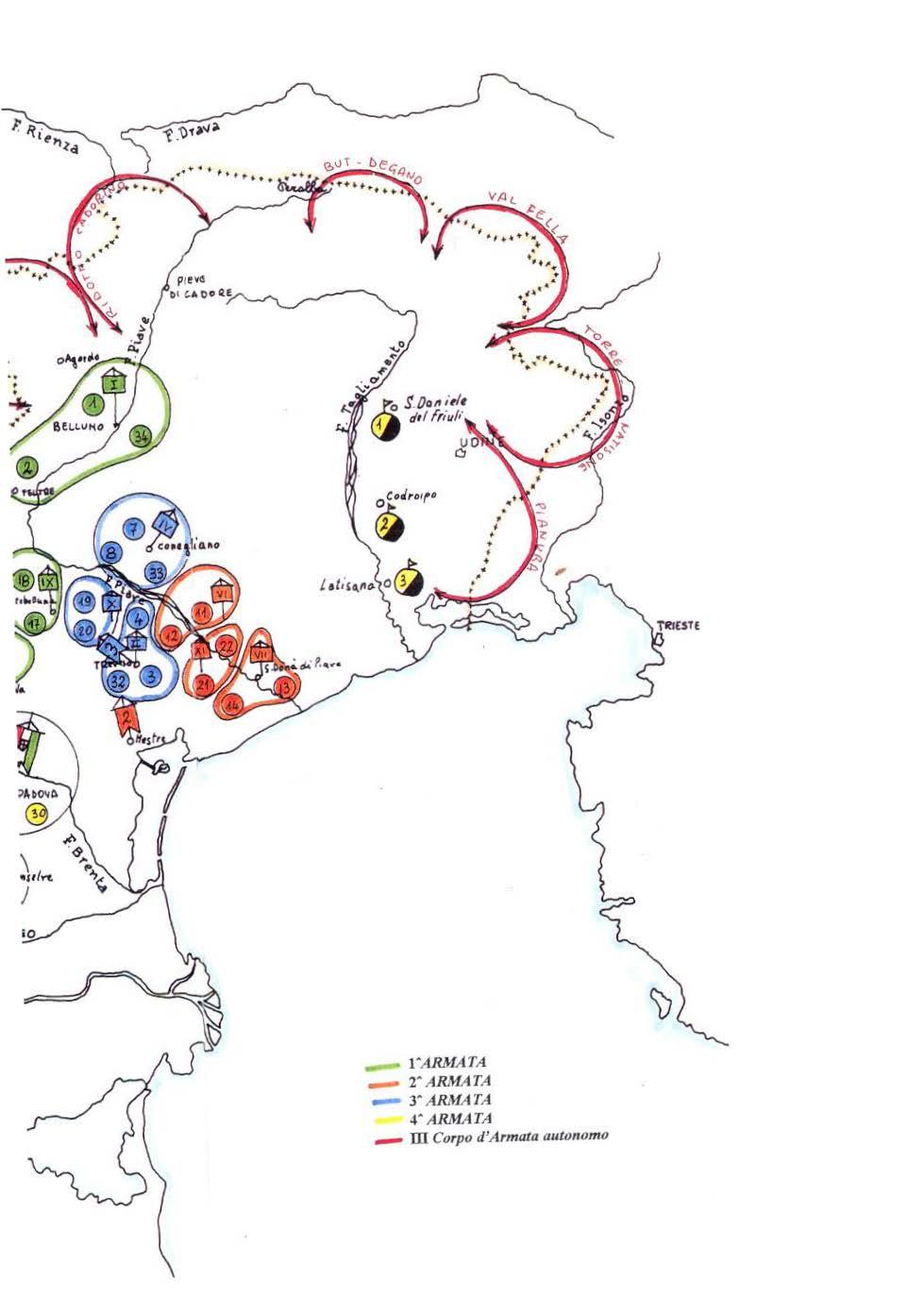
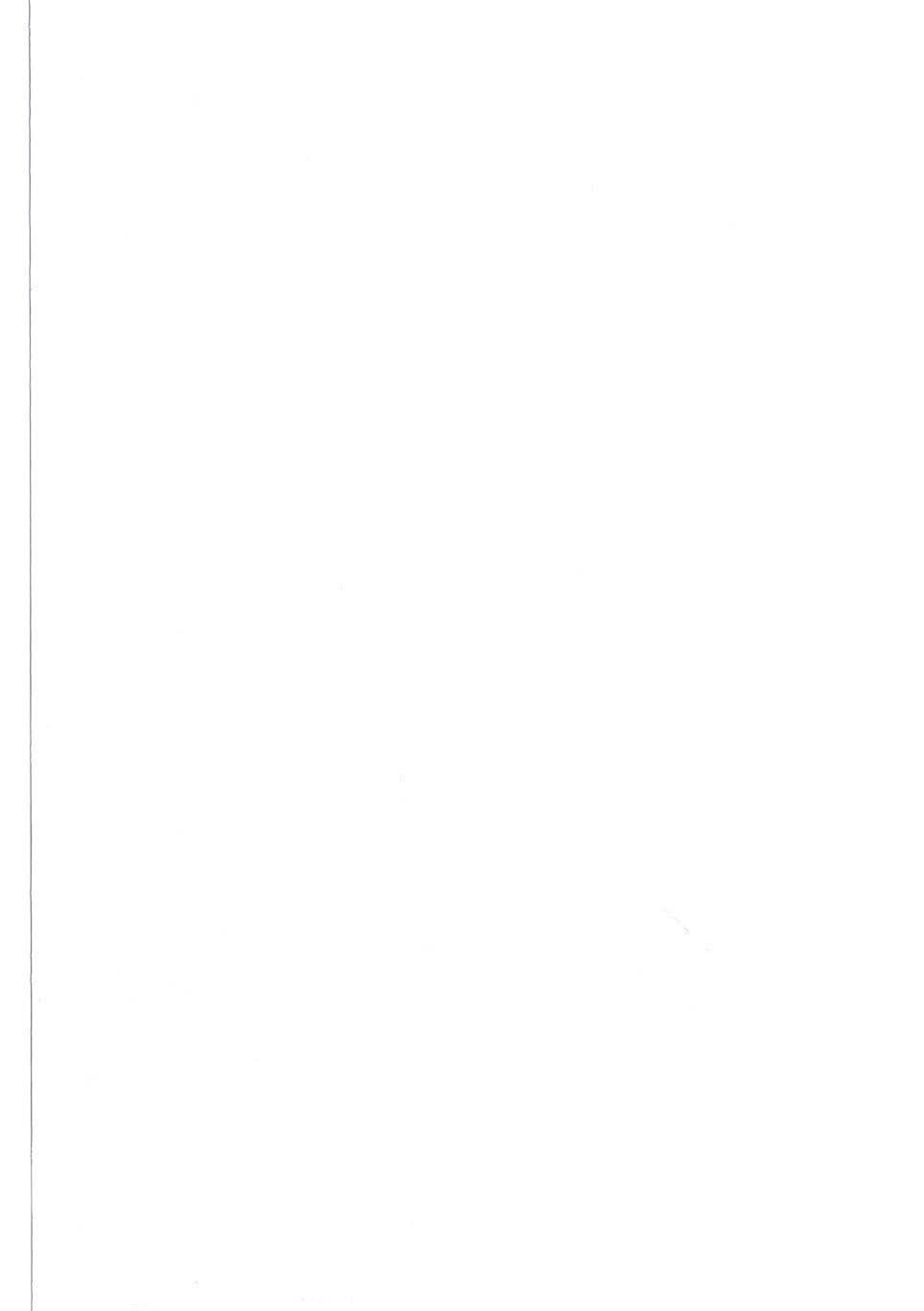
un ·aliquota di truppe alpine; l'orientale al la P armata. cosrituita da quattro corpi d'armata, la 4 a armata, di riserva, veniva com;entrata tra Monselice e Padova;
per garantire la difesa del teritorio contro i poss ibili sbarchi dal mare s i lasciava un corpo d'armata in Pu g lia ed una divisione a R oma;
rimaneva inalterata sul Piave la dislocazione delle due armate, la 2 " e la 3 ". e s ulla sinistra d e l Tagliamento quella delle divisioni di cavalleria.
Questo piano era stato quindi definito in tutti i minimi particolari con la redazione e la diramazio n e di tutti i documenti relativi alla mobilitazione d e ll e unità , ai trasporti delle s tes se per la radunata cd infine al loro schieramento.
E sso costi tui va il primo , vero e completo progetto di mobilitazione e radunata nord -es t.
D 'a lt ra parte il timor e cli attacchi dal mare, peraltro vivamente sen tit o dal Saletta, n on ri g uardava so lo la poss ibilità di attacchi lungo la costa adriatica con lo sco po di sco nvolgere le comunicaz ioni ferroviarie e s tradali italiane o mina cciare la capitale del regno, ma anche di sbarchi a breve di s tanza dal fronte con il chiaro scopo di aggirare a breve raggio le forze impeg nat e nella difesa d e lla p o rta aperta del Friuli.
Questa ra g ionevole paura trovò un a s ua esemplificazione allo r quando lo stato ma gg iore dell 'ese rcito i oppo e alla rich ies ta del comune di M arano La g unare soste nut a per a ltro da llo s tato maggiore marina , di i crivere il proprio porto fra quelli cli 1" catego ri a, al fine di sv ilupp are le attività economic he del Friuli attraverso la rea li zzaz io n e di un approdo che avrebbe dovuto essere il più grande e d importante del la regione.
La laguna. infatti, era ritenuta dallo · tato maggiore dell'esercito un va lid o ostacolo a poss ibili sba rc hi e la costruzio n e cli un porto e numerosi cana l i, c he eia esso s i s arebbero diramati in varie direzioni tra cu i Venezia, avrebbe potuto rapprese ntar e un pericolo ma gg iore d e i vantaggi ottenibi li 2 in termini lo g is ti ci e militari dalla poss ibilità cli far affluire via mare ed in breve tempo de ll e forze not evo li.
Tuttavia , come abbiamo visto. la situazione ci e l la ret e ferro-
2 Cfr.: comando del co rp o di s1a10 maggiore: Approdo di Morano La g unare. AUSSME. G 22, 13.
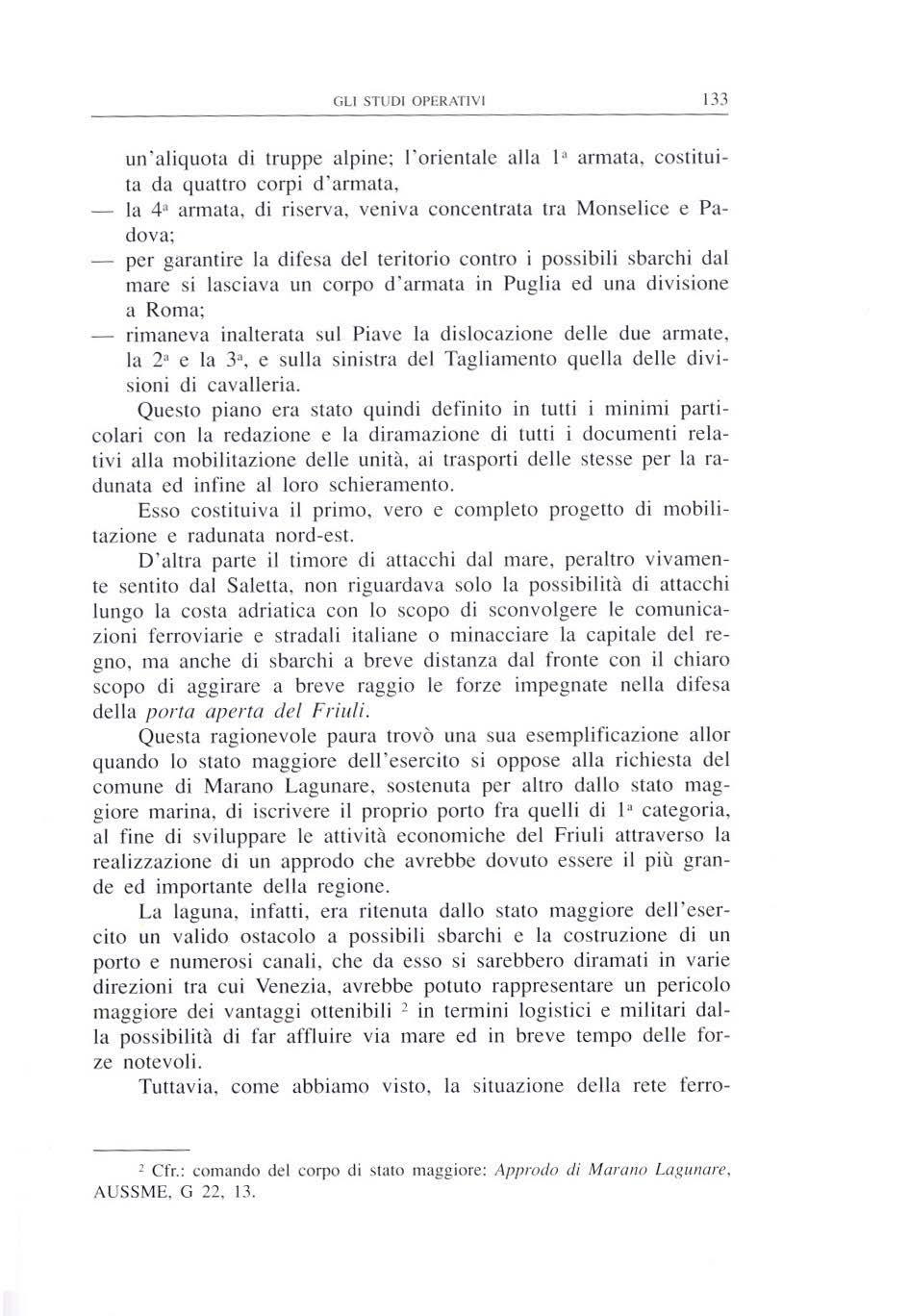
viaria e la penuria dei mezzi di trasporto imponevano per la compl e ta radunata l ' utili zzo di be n ventisei gio rni e ciò spiega il rileva nt e num ero di forze destinate a lla cope rtura de i co nfini , la preocc up az ione di r e nd ere più efficace la di fesa del sal ien te tre ntin o - tirole se e lo sc hi eramento d e l g ro sso dell'ese rc ito, mante nut o anco ra a rre tr ato s ull a lin ea de l Pi ave.
P er ovv ia re al proble ma dei te mpi richie s ti dalla mobilit az ione e da ll a radunata, so tto la direzione d e llo s te sso ge nerale Saletta , ven iva no avv iati deg li s tudi per ce rcare di ren de re più celere il completamento della c ope rtura e d e ll 'effettua zione de ll ' intera rad un ata.
Ques t a necess it à e ra magg iormente sen tita nell a co ns id erazione dei provve dim e nti che l 'A us tria aveva adottato e c he ve n ivano a confe rirg li ancora m aggiori vantaggi di ve locit à nel le o pe ra z ioni di rnobi Iitaz ione e radunata.
Si s tabilì , quindi , che fossero in via ti ne ll a zona di radu na ta in primo scag lion e i corpi d'annata dell'ese rc ito permanente ed in seco ndo scag li one seguissero le divisioni de ll a milizia te rritori ale.
Con l'adozione di que s to prov ved imento si riu sc ì a gua da gnare un g iorn o, portando a venticinq ue g iorni il tempo comp lessivo per attuare tutte le operaz ioni di mobilitazion e e raduna ta.
P e r ultim o s i s tabilì che una d e ll e due armate di s lo ca te s ul Pi ave, dov esse s ubito fare avanzare s ul Tag liamanto un co rpo d'armata a sos teg no de ll e tre divisioni di cavaller ia c he l à operavano.
Qu es t 'u ltimo piano re s tò, tutta via, nelle s ue linee ge nera li quello de l 1904 , tanto che si può dire che esso cos titu ì più una varian te di qu e llo ciel 1904 che non uno nuovo .
2. G li s tudi d e l te n e nte ge n e ra l e A lb erto Po lli o
Nella primav e ra del 1909 a l Sal e tta s ucce sse ne ll a car ica di capo di s tato magg io re il te nent e gen era le Alberto P o llio il qu a le . a pprofittando dei mi gliorame nti ragg iunti dall 'o rga niz zaz ione de ll 'ese rc ito e d a lla ret e fenov ia ri a. avve rtì s ubit o la po ss ibilit à di m e ttere mano ad un ulteriore aggio rnam e nt o delle di s pos iz ioni impartite ne l 1904 dal s uo predecess ore .
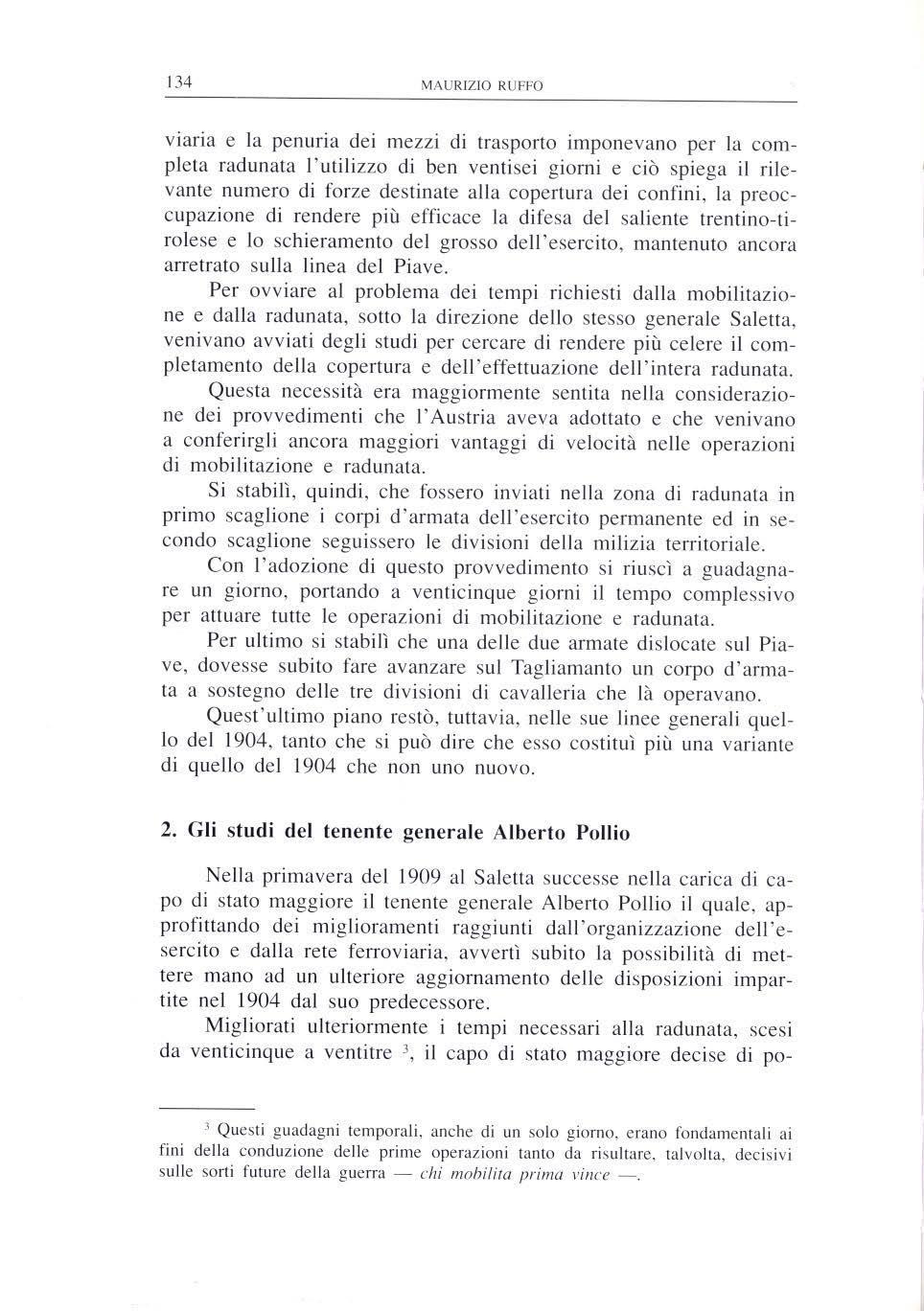
Mi g liorati ult e riorm e nte i te mpi necessari a ll a r aduna ta, sces i da venticinq ue a vent itre 3 , il capo di s tat o mag g iore deci se cli po -
3 Q uesti gu adagni tempora l i, anche di un solo giorno erano fo ndamental i ai fini d el la conduz ione dell e prime operazioni tan to da risultare. talvo l ta, decisivi su lle sorti future della guena - chi mohilira prima 1i11 ce -

tenziare la difesa del pericoloso sai iente trentino-tirolese schierando la la armata dalle Giudicarie all'altopiano dei Sette Comuni e la 4a dalla valle del Brenta a tutta queJla del Piave.
Non vennero variati i compiti della 2• e della 3• armata destinate ad operare nella pianura veneto - friulana e la riserva fu costituita da due corpi d'armata , dislocati tra Padova e Monselice.
Per la difesa del territorio la divisione esistente in Sicilia venne rinforzata ed elevata a rango di corpo d'armata , mentre rimase inalterata la divisione destinata alla difesa della capitale.
Tuttavia il concetto fo ndamentale era semp re il medesimo: difensiva iniziale sul Piave in attesa di eventi 4 che permettessero il passaggio alla controffensiva.
Le crescenti tensioni intemazional i e le difficoltà di dialogo con l'Austria, dove le tesi sostenute dal generale Conrad di una guerra preventiva contro l'Italia, seppur tenute a freno dall'imperatore Francesco Giuseppe e dal ministro degli esteri Aehrental, acquistavano sempre più credito sia neJla casta militare sia tra la stessa famiglia imperiale con l'aperto sostegno dell'erede al trono , l'arciduca Francesco Ferdinando , spingevano il PolJio ad aumentare, in questo val id amente e fermamente soste nut o dal ministro della guerra generale Spingardi, le misure cli v igi lan za aJle frontiere NordOrientali.
Né, d ' altra parte, le pressioni tedesche , concretizzate dall'attivismo del capo di stato maggiore von Moltke, verso l 'Ttalia e l 'Austria-Ungheria per un maggior affiatamento nell'ambito della Triplice 5 , né le conti nu e affermaz ioni di fedeltà ed assoluto rispetto dell'alleanza servirono a dissipare i dubbi sulle reciproche intenzioni ed il Conrad non solo non faceva nulla per fugare tali timori , ma tornava ad invocare l a g uerra contro l ' Italia approfi ttando dell'impegno italiano in Libia, presentato dal capo di stato maggiore asb urg ico come un pericoloso rafforzamento politico-militare dell ' Italia nel concerto europeo in generale ed in quello dell'alleanza in particolare.
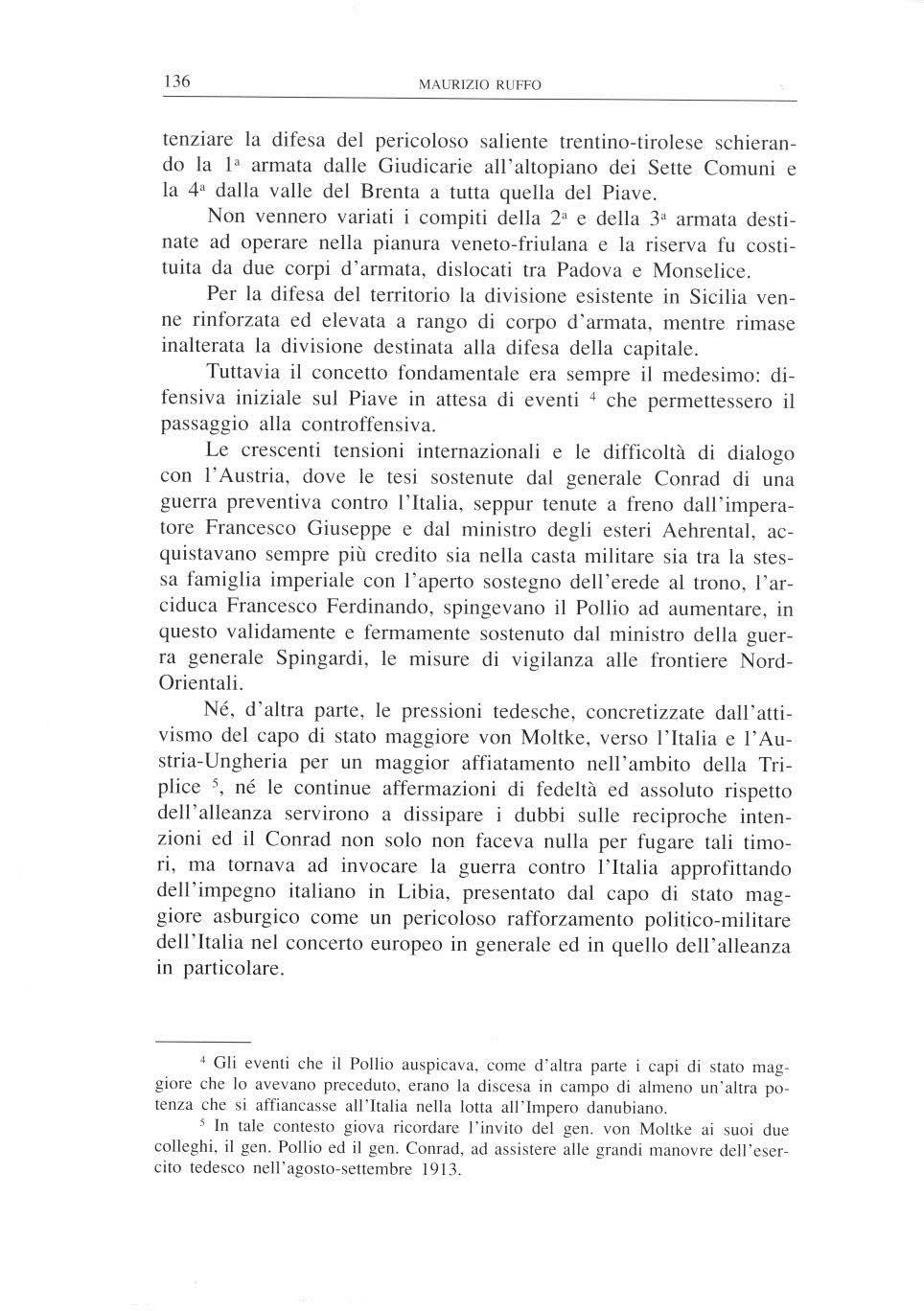
4 Gli eventi c he il Poll io auspicava, come d'a ltra parte i capi di stato maggio re c he lo avevano preceduto , erano la d iscesa in campo di a lm eno un'altra potenza che si affiancasse ali 'I talia nella lotta ali' Impero danubiano.
5 In tal e contest0 g iova ricordare l'in vito de l gen. von Moltke ai suoi d ue colleghi, il gc n . Pollio ed il ge n. Conrad, ad assistere alle g randi manovre de l! 'esercito tedesco ne ll'agosto-seuembre 1913.

ALLA FRONT I ERA NORD-EST DEL LUGLIO 1909
(FUORI 7.0NA Xli Cdli.,, 29 /J/V/SIONJ;/
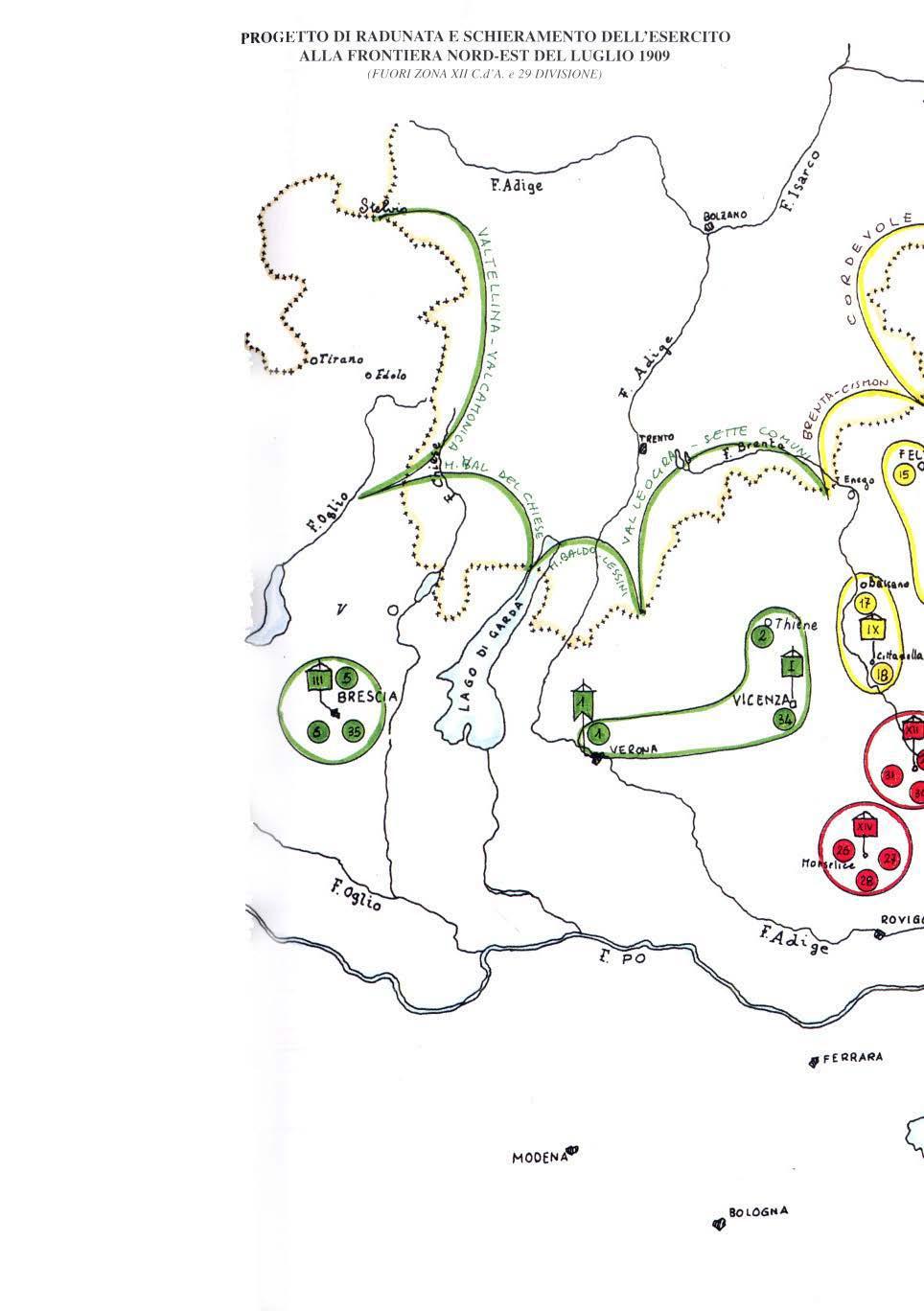
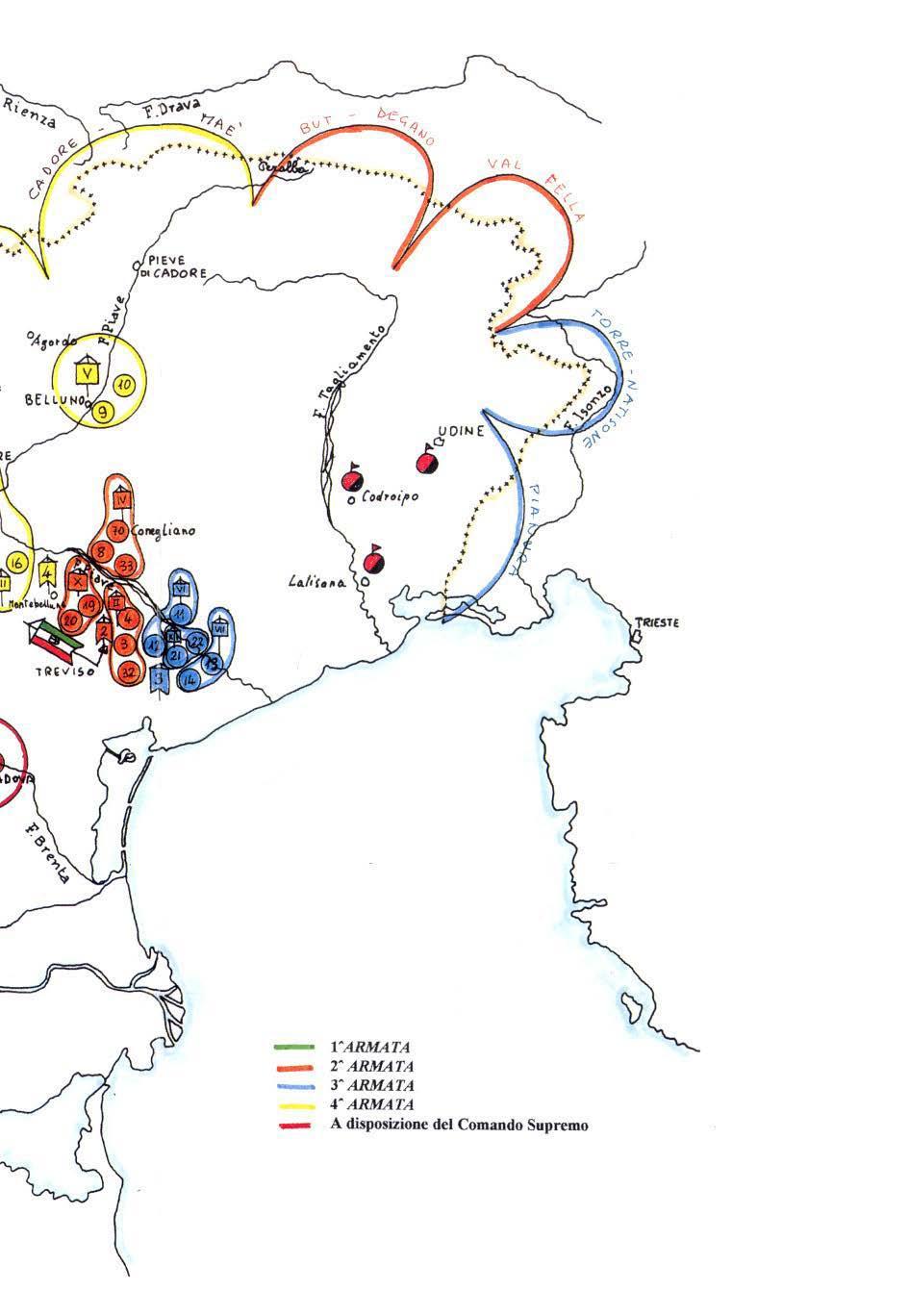
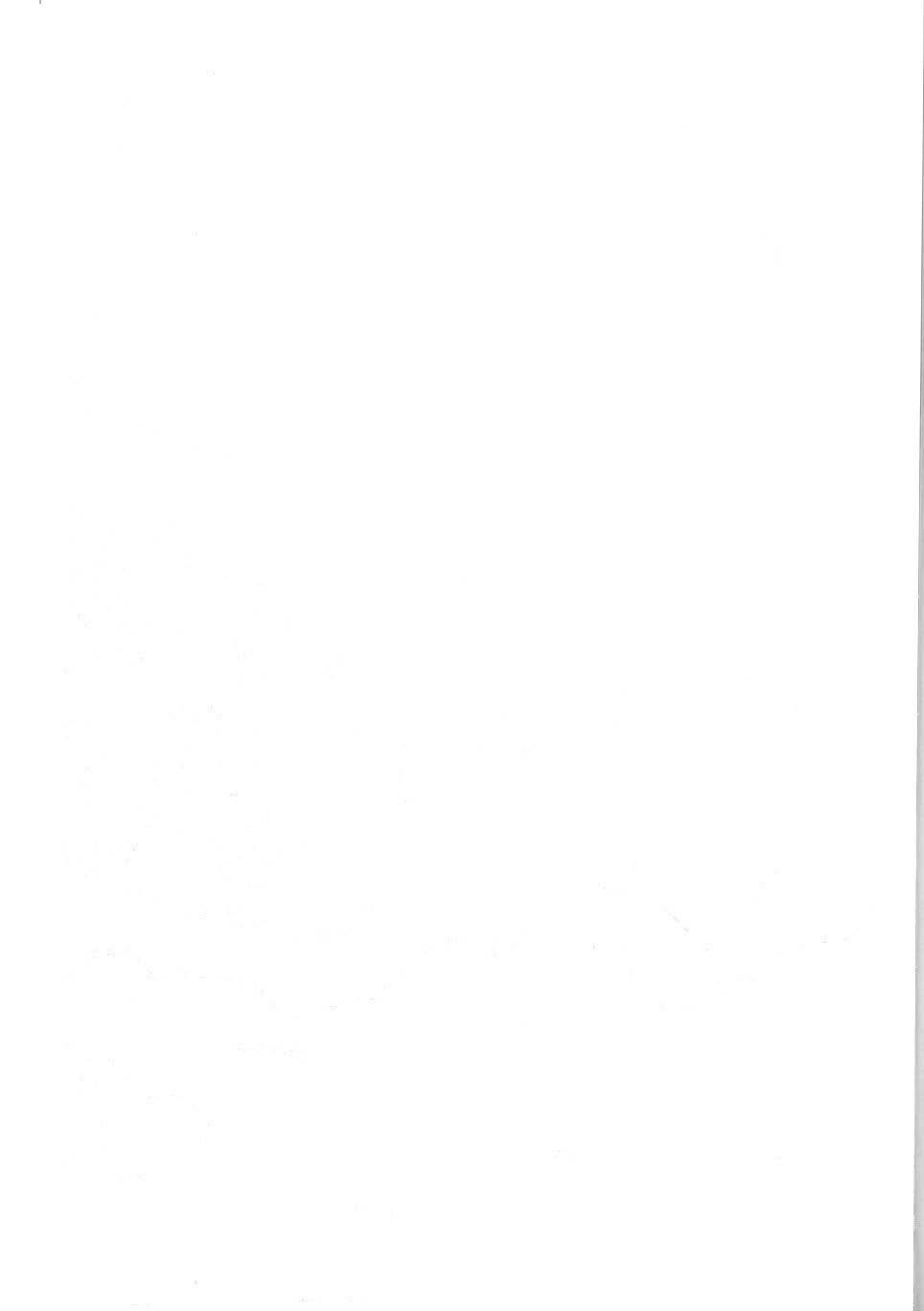
L'attenzione dell'intero Paese verso i problemi della difesa delle frontiere anelava quindi sempre più imponendosi ed in tale contesto il Pollio decise di rivedere il concetto strategico posto a base delle operazioni verso Est: non bisognava più aspettare il nemico su l Piave , eventualmente rallentandone la progressione con azioni di frenaggio, ma, utilizzando le nuove fortificazioni erette sul medio e basso Tagliamento, prevedere una difesa basata, inizialmente, sull'occupazione avanzata senza per altro disdegnare la possibilità cli condurre arditi colpi di mano in territorio nemico.
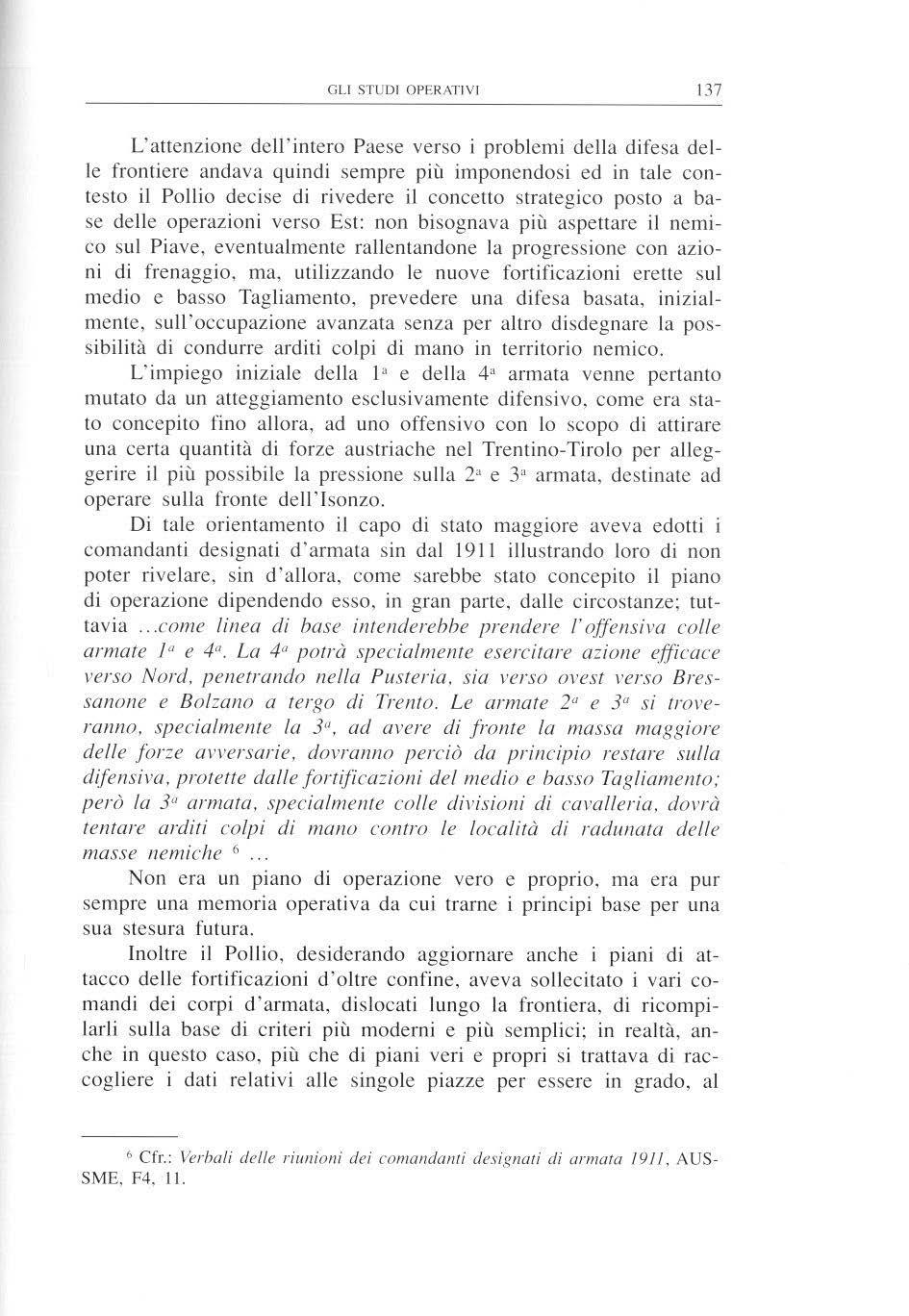
L'impiego iniziale della ta e della 4" armata venne pertanto mutato da un atteggiamento esclusivamente difensivo, come era s tato concepito fino allora, ad uno offensivo con lo scopo di attirare una certa quantità di forze austriache nel Trentino -Tirolo per alleggerire il più possibile la press ione sulla 2• e 3" armata, destinate ad operare s ulla fronte cieli ' I sonzo.
Di tale orientamento il capo di stato maggiore aveva edotti i comandanti designati d ' armata sin dal 1911 illus trando loro di non poter rivelare, sin d'allora, come sarebbe stato concepito il piano di operazione dipendendo esso, in gran parte , dalle circostanze; tuttavia .. .rame linea di base intenderebbe prendere l'offensiva colle armate Ja e 4 ° . La 4" potrà specialmente esercitare a zione efficace ve rso Nord, penetrando nella Pusteria, sia 11er:m ovest verso Bre ssall(me e Bol zano a t ergo di Trento. Le armate 2 " e J a si troveranno, specialme111e la 3 °, ad avere di fi·onre la massa maggiore delle for ze av,•ersarie. dovranno perciò da principio restare sulla d~fensim. protette dalle fortifica:ioni del medio e basso Tagliamento; però la J a armata. specialmente colle divisioni di ravalleria, dovrà tentare arditi co lpi di mano contro le località di radunala delle masse nemiche 6
Non era un piano di operazione vero e proprio, ma era pur sempre una memoria operativa da cui trarne i principi base per una sua s tes ura futura.
Inoltre i I Poi I io, desiderando aggiornare anche i piani di attacco delle fortificazioni cl' oltre confine, aveva sollecitato i vari comandi dei corpi d'armata, dis locati lun go la frontiera, cli ricompilarli su ll a base di c rit e ri più moderni e più semp li ci; in realtà, a nche in questo caso, più che di piani veri e propri s i trattava di raccoglie re i dati relativi alle singole piazze per essere in grado, al
momento ciel bisogno , cli formulare dei veri e propri piani sulla stregua delle condizioni reali del momento.
Sulla base di questa concezione offensiva si ipotizzò anche di realizzare arditi colpi di mano e si incaricarono i reparti dislocati in alcuni specifici settori della frontiera di dare vita ad un'intensa attività ricognitoria in territorio nemico con l'intento di pianificare delle azioni di sabotaggio che ritardassero ed ostacolassero il più possibile la radunata dell'avversario.
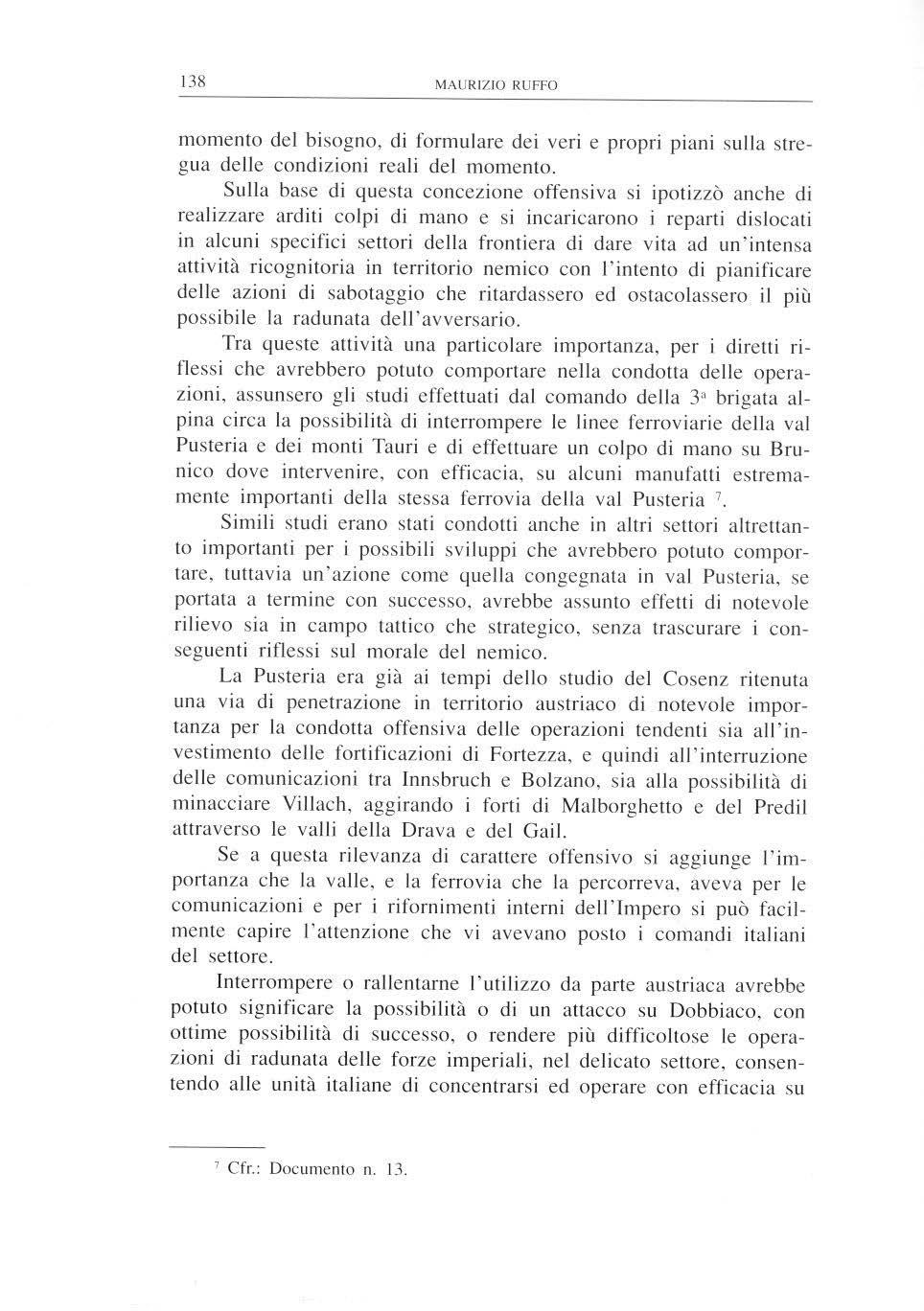
Tra queste attività una particolare importanza, per i diretti riflessi che avrebbero potuto comportare nella condotta delle operazioni, assunsero gli studi effettuati dal comando del la 3a brigata alpina circa la possibilità di interrompere le linee ferroviarie della val Pusteria e dei monti Tauri e di effettuare un colpo di mano su Brunico dove intervenire, con efficacia, su alcuni manufatti estremamente importanti del la stessa ferrovia della val Pusteria 7 •
Simili studi erano stati conclolli anche in altri settori altrettanto importanti per i possibili sviluppi che avrebbero potuto comportare, tuttavia un'azione come quella congegnata in val Pusteria, s e portata a termine con successo, avrebbe assunto effetti di notevole rii ievo s ia in campo tattico che strategico, senza trascurare i conseguenti riflessi sul morale del nemico.
La Pusteria era già ai tempi dello studio ciel Cosenz ritenuta una via cli penetrazione in territorio austriaco cli notevole importanza per la condotta offensiva delle operazioni tendenti sia all'investimento delle fortificazioni di Fortezza, e quindi all'interruzione delle comunicazioni tra Innsbruch e Bolzano, sia alla possibilità cli minacc iare Villach, aggirando i forti di Malborghetto e ciel Predii attraverso le val li della Drava e del Gai I.
Se a questa rilevanza cli carattere offensivo si aggiunge l 'importanza che Ja valle. e la ferrovia che la percorreva , aveva per le comunicazioni e per i rifornimenti interni dell'Impero si può facilmente capire l'allenzione che vi avevano posto i comandi italiani ciel settore.
Interrompere o rallentarne l 'utilizzo eia parte austriaca avrebbe potuto sig nific are la possibilità o di un attacco s u Dobbiaco, con ottime possibilità di successo, o rendere più difficoltose le operazioni cli radunata delle forze imperiali, nel delicato seteore, consentendo alle unità italiane di conce ntrar si ed operare con efficacia su
un altra area ritenuta, al momento, più remunerativa senza timor e di essere sopraffatte o aggirate nel Cadore.
Come si è eletto alla definizione di questi studi, ed in particolare per quanto riguardava la difesa avanzata, contribuirono, quindi, in maniera particolarmente attiva sia i comandanti d'armata che i comandanti in sottordine.
In tale contesto, assume un aspetto s ignificativo anche lo studio del maggior generale Francesco Stazza, comandante della brigata Pistoia , che, incaricato dal comando della divisione cli Bologna di s tudiare la frontiera friulana so tto il punto cli vista della difesa avanzata, redigeva nel febbraio del I 911 un'interessant e monografia 8 s ull 'argomento .
In essa il generale Stazza analizzava i I terreno compreso fra monte Maggiore, punto più orientale delle prealpi ca rniche, ed il mare al fine cli individuare le operazioni che, a cavaliere della linea di confine, potevano. essere svo lte, all'inizio delle ostilità, dalle truppe in occupazione avanzata.
Il compito principale di tali forze, necessariamente limitate , sarebbe sta to quel lo di proteggere l 'afnusso del grosso dell'esercito, la s ua radunata e lo schieramento dei reparti e degli organi logistici.
Queste unità inoltre sarebbero tornate utili , presentandosene l'opportunità, per intraprendere delle azioni offensive, naturalmente commisurate all'entità ed alle capacità operative delle forze stesse, tendenti all'occupazione di posizioni migliori sia per fornire una maggior protezione della radunata s ia per disturbare quella avversaria ed infine per ottenere s ucces si anche di piccola entitit, ma che, all'inizio delle ostilità, avrebbero prese ntato sempre positivi riflessi sul morale del Paese e delle truppe.
Più interessante e, per intuibili motivi dato il livello, piì:1 completo era lo studio che il tenente generale Cesare Ponza di San Martino, comandante de s igna t o della 3" armata, aveva inviato nel luglio ciel 1911 al capo cli stato maggiore in merito sia al l 'assetto difensivo del la front iera or ientale sia alle proposte per condurre l 'occupazione avanzata della grande unità alle sue dipendenze 9
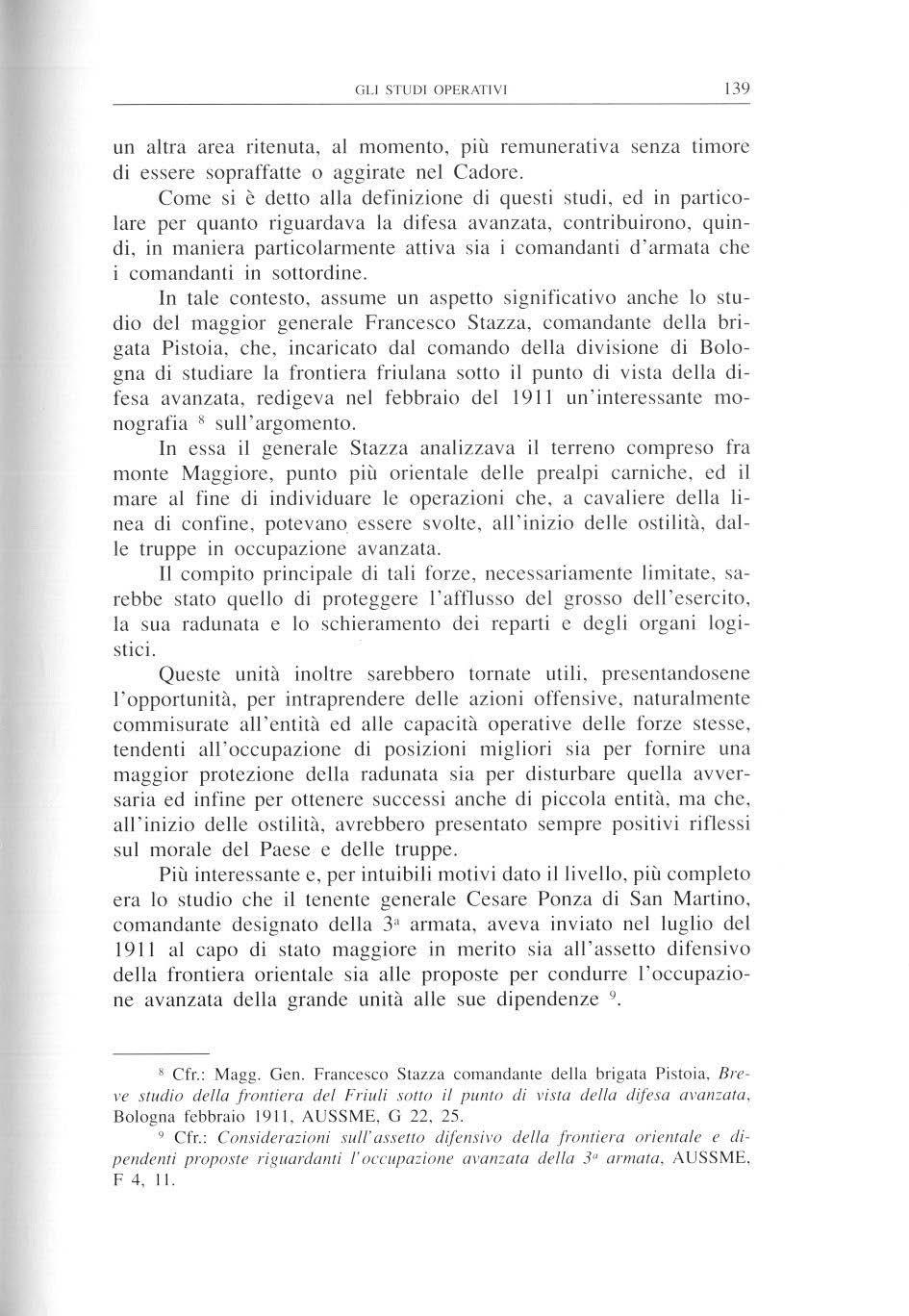
s Cfr.: Magg. Gen. Francesco Stazza comandante della brigata Pis to ia, Breve s /l1dio della ji'ontiera del Friuli sono il punto di vista della difesa al'an:ara. Bolog na febbra io 19 11 , AUSSME, G 22. 25.
9 Cfr.: Considera:ioni su/I' assetto dife11si1·0 della ji'ontiera o rienrale e dipendenri proposte riguardanti /' ocrnpazione ava nzma della 3" armata, r\USSME. F 4. 11
Come riporta nella premessa alla sua memoria, il di San Martino aveva personalmente compiuto una ricognizione ne l tratto di frontiera fra monte Mag g iore ed il torrente Judrio. nella zona morenica del medio Tagliamento ed in quella della riva s ini stra del basso Tagliamento. dove erano in costruzione le opere di fortificazione previste per la frontiera orientale, ed infine aveva visitato il tratto di lit ora le ritenuto più esposto a qualche tentativo di sbarco da parte austriaca.
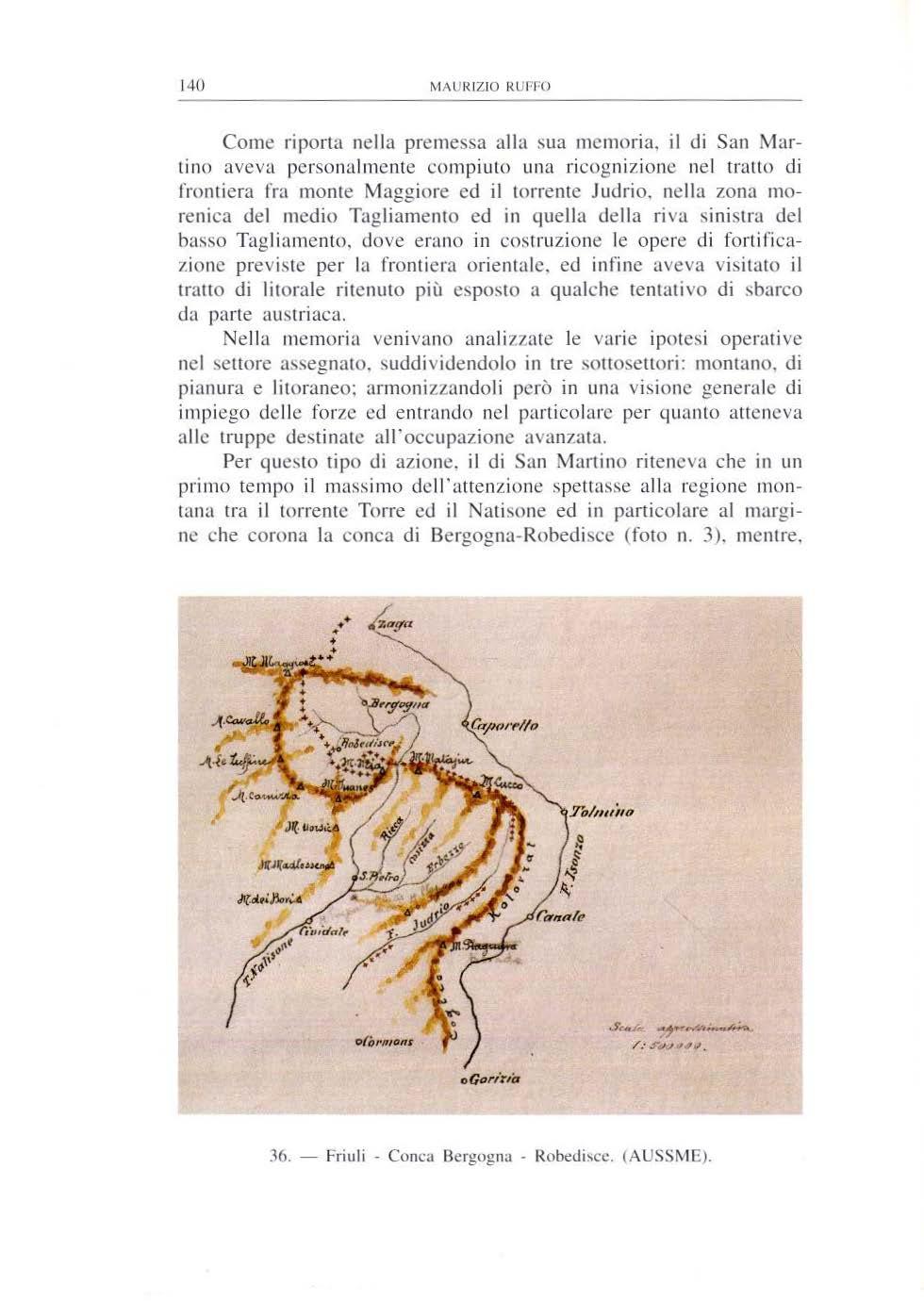
Nella memoria venivano analiz7ate le varie ipotesi operative nel settore assegnato. suddividendolo in tre sottosettori: montano, di pianura e lit ora ne o; armoniu.andoli però in una visione ge nerale cli impiego del le forze cd entrando nel partico lare per quanto atteneva al le truppe destinate atr occupazione avanzata.
Per questo tipo di azione. il di San Martino riteneva che in un primo tempo il ma ss imo dell'attenzione spettasse alla regione montana tra il torrente Torre cd il atisone ed in particolare al margine che corona la conca di Bergogna-Robediscc (foto n. 3 ) . mentre,
in un secondo tempo, grazie all'azione di grosse masse di truppe, una funzione fondamentale sarebbe stata esplicata dalla cintura fortificata di Latisana-Codroipo-margine morenico ciel Tagliamento; la zona costiera, per le sue particolari caratteristiche topografiche. non avrebbe rappresentato un grosso problema.
Fissate le lince guida, i I comandante designato della 3" armata passava ad illustrare nei dettagli le varie moda! ità esecutive delle azioni offensive da condurre, suddividendole in tre atti principali.
li primo era rappresentato da attacchi alle linee ferroviarie oltre confine che l'avversario avrebbe utilizzato per l'afflusso delle proprie unità nella zona di Cormons, Gorizia. Gradisca. Monfalcone e Cervignano.
Il secondo atto riguardava la possibilità di discendere dal margine montano della conca di Bergogna- Robedisce verso l'imbocco della ste s sa per la sua conquista ed essere in grado. succe s sivamente e con forze adeguat e , di procedere con decisione vers o l'abitato di Capo retto.
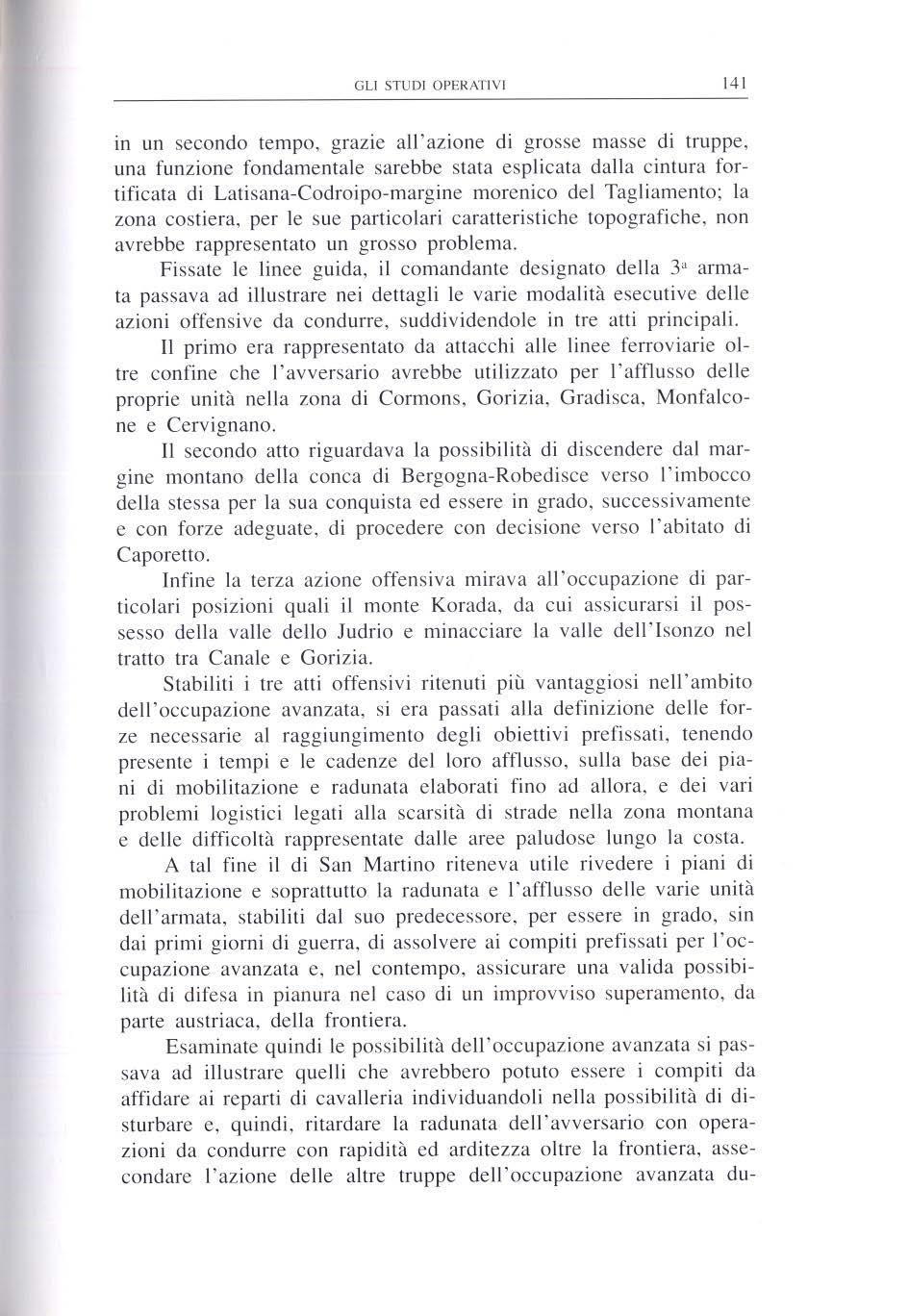
Infine la terza a z ione offensiva mirava all'occupazione cli particolari posizioni quali il monte Koracla, da cui assicurarsi il possesso della valle dello Judrio e minacciare la valle dell 'lsonzo nel tratto tra Canale e Gori z ia.
Stabiliti i tre atti offensivi ritenuti più vantaggiosi nell'ambito dell ' occupazione avanzata. si era passati alla definizione delle forze necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefis sati , tenendo presente i tempi e le cadenze del loro afflusso, sulla base dei piani di mobilitazione e radunata elaborati fino ad allora. e dei vari problemi logistici legati alla s carsità di strade nella zona montana e delle difficoltà rappresentate dal le aree paludose lungo la costa.
A tal fine il di San Martino riteneva utile rivedere i piani di mobilitazione e soprattutto la radunata e l'afflusso delle varie unità dell ' armata. stabiliti dal suo predecessore, per essere in grado. s in dai primi giorni cli guerra, di assolvere ai compiti prefissati per l'occupazione avanzata e, nel contempo, assicurare una valida pos sibilità di difesa in pianura nel caso di un improvviso superamento , da parte austriaca , della frontiera.
Esaminate quindi le possibilità dell'occupazione avanzata s i pass ava ad illustrare quel li che avrebbero potuto essere i compiti da affidare ai reparti di cavalleria individuandoli nella possibilità di disturbare e, quindi, ritardare la radunata cieli' avversario con operazioni da condurre con rapidità ed arditezza oltre la frontiera, assecondare l'azione de lle altre truppe dell'occupazione avanzata du-
rante lo sviluppo di eve ntuali azioni offe n sive nella regione collinosa tra lo Judrio e l'Isonzo, impedire eventuali incurs ioni della cavalleria avversaria verso la zona di radunata delle truppe amiche cd infine ostacolare e ritardare, per quanto possibile, l'avanzata delle colonne nemiche che fossero riuscit e a sfociare nella pianura e ad invadere il terr itorio metropolitano.
La difesa della costa da barchi a breve raggio. tendenti a dist urbare la radunata non era ritenuta un probl ema rilev an te dati gl i scars i approdi e. sopratt utto , le caratteristiche di scarsa percorrib ilit à del terreno lungo l'intera fascia costiera. in gran parte paludoso, co n s trad e ricav a te su argini e con andamento Sud-Nord, fatta eccezione della rotabile Porto g ruaro -La tisana -$. Giorgio di NogaroCervignano. che avrebbero pesantemente cond izionato l'operare di even tuali unità nemiche ivi sbarcate, per altro di en tit à forzatamente riclolla ed alla cui n e utra I izzaz ione sa re bbero s tat e sufficienti poc he forze.
Per ultimo il generale di San Martino si soffe rm ava sull'efficienza operativa dell e opere fortificate e rette tra il m edio cd il basso Ta gliamento rilevando come. mentre le prime disponevano di un ecce ll en te campo di tiro, quelle dislocate tra Codro ip o e Latisana, per il parti co lare tipo di vegetazione 10 che le c ircondava, si tr ovavano nella quasi impo ssi bilit i, di operare efficacemente non solo alle grandi, ma anche alle medie ed alle piccole distanze.
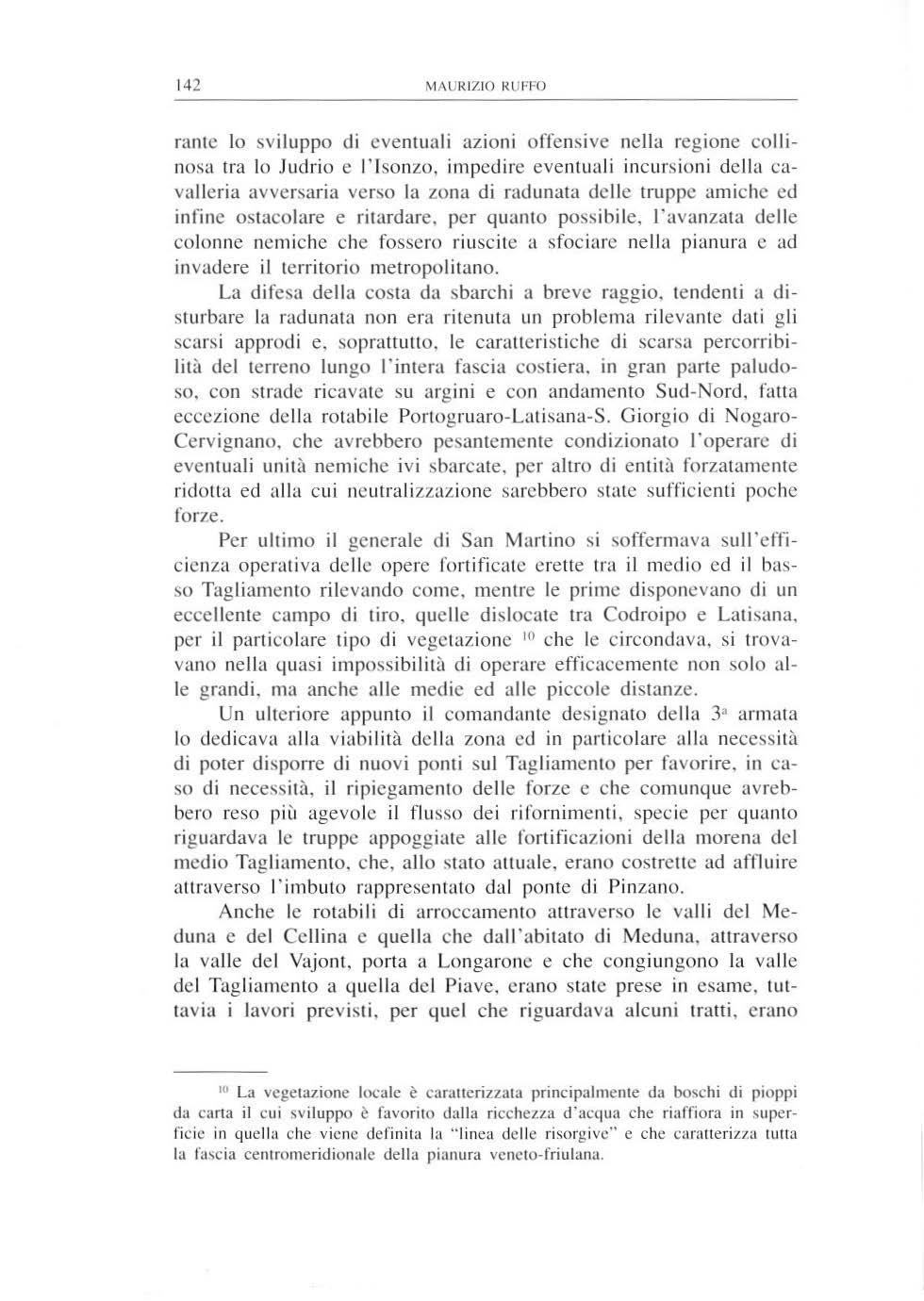
Un ulteriore appunto il co mandante designato della J a armata lo d e dicava a lla viabilità della zona cd in particolare alla nec ess it à di poter disporre di nuovi ponti su l Tagliamento per favorire. in caso di necessità, il ripi egamento dell e forze e che comunque avrebbe ro reso più agevo le il flu sso dei rifornim e nt i, specie per quanto riguardava le truppe appoggiate alle fortificazioni della morena del medio Tagliamento. che, allo s tato a11uale, erano costrette ad affluire attraverso l ' imb u to rappresentato da l po nte di Pinzano.
Anche le rotabili di arroccamento attraverso le valli del Meduna e del Cellina e quella che dall'abitato di M ed una , allraverso la valle del Vajont, porta a Longarone e che co ngiun go no la va ll e de l Tag l iamento a quella del Piave. era no s tat e prese in esame, tuttavia i lavori previsti, per quel che ri g uarda va alcuni tratti , erano
io La vegetazione locale è carauerizzata principalmente da boschi di pioppi da carta il cui sv iluppo è favorito dalla ri ccheaa d"acqua che riaffiora in superf'i c ic in quel l a che vie ne definita la "l in ea d el le risorgive" e che cara tterizza tulta la fa~cia cen tromeridionate della pianura veneto-friulana.
in grave ritardo tanto da farle ritenere non atte a svo lgere le mansion i richieste ad una strada militare di grande rendimento.
La memoria operativa del di San Martino terminava con l'indicazione della necessità di determinare, per quanto riguardava la difesa avanzata, una più stretta correlazione con la 2" armata nella zona in cui le due armate venivano a co ntatto , corrispondente all 'a rea della va ll e di Resia e del passo di Tanamea 11 , per il pericoloso saliente che avrebbe potuto rappresentare se sfruttato in modo adeguato dal nemico.
Nello svi lupp o del dibattito concernente la difesa ai confini Nord-Est, so ll ecitato come abbiamo visto dal capo di stato maggiore e che, è opportuno sotto lin earlo ulteriormente, non diede mai vita ad un vero e proprio piano di operazione, ma so lo ad un costante aggiornamento delle dispo siz ioni sulla mobilitazione , prese parte attiva anche il comandante designato della 2" annata, il tenente generale Luigi Cadorna.
li contributo cli pen s iero ciel Cadorna, d'altra parte , viene ad assumere una notevole importanza nella preparazione dei piani se si tiene conto che il Caclorna s te s so , chiamato nell'estate del 1914 12 , a conflitto iniziato, a succedere a l generale Pollio improvvisamente scomparso 1\ si trovò a dover gestire inizialmente lo status di non belligeranza e successivamente, con l'adesione all'alleanza contro gli Imperi centrali, la necess ità di dare concretezza, in pochi ssimo tempo, a tesi operative fino ad a ll ora solo ipotizzate.
Dunque l'analisi partico lareggiata del la concezione strategica ciel Pollio, per quanto ri g uardava lo specifico settore di competenza della 2° armata , venne condotta dal Cadorna scindendo la due fasi operative teorizzate: l 'occupazione avan zata della linea di confine e la difesa di seconda linea s ul Piave.
11 Il passo di Ta namea. secon do l a diz ione dell'epoca, era chiamaw anche di Tanameje.
12 Come riportato sull a re l azione Ufficial e ita l iana su lla 1" guerra mondial e il Cadorna assunse la ca rica di Capo di stato maggiore il 27 lu gl io 1914.
13 In merito al la data della scomparsa de l tenente ge nerale Pollio c·è da rilevar e che n el l a Relazione Ufficiale ita l ia na sull a Grande Guerra al vo lume l , pag. 67. si riporta il 1° lugl io, m ent re al cune fonti b ibli ografiche come Le origini della guerra del 1914 di L. A l bertini. vo lume l!I , pa g. 298. si ind ica come il 28 giugno la data della scomparsa del capo di stato mag giore. Nel l ibro di Rocca sul g enerale Cadorna si ev idenzia che i l Pollio apprese la notizia dell'eccidio di Saraj evo, il g iorno dopo , a Torino dove si era recato per assis tere alle prove delle n uove artigl ierie pre sso i l po l igono d i Venaria Rea le; durante tal i prove si se ntì male e mori due g iorni dopo: nell a notte tra i l I O ed il 2 lug l io.
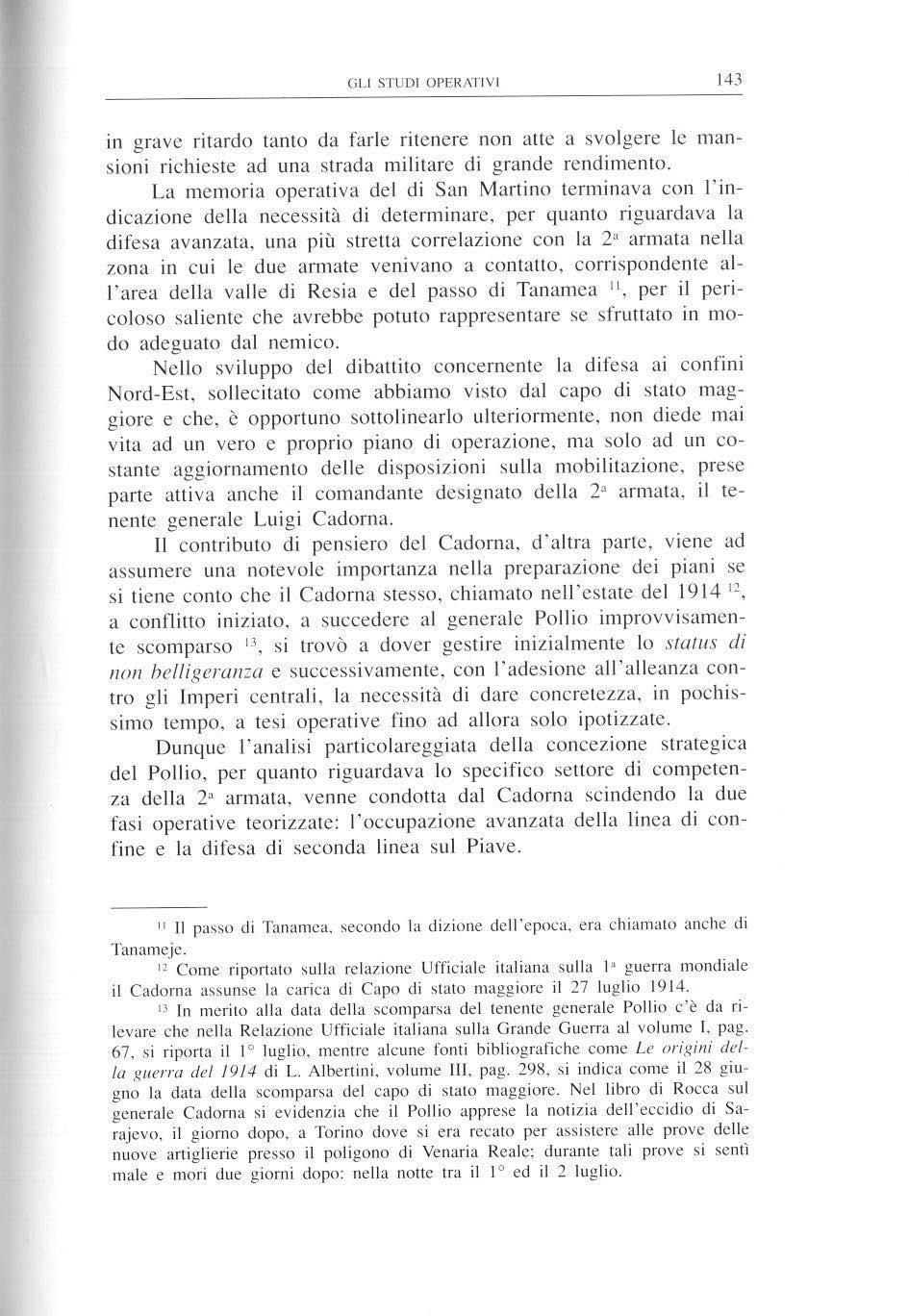
La prima ip otes i: l'occupazione avanzata della linea di confine nella Carnia e nella valle del Fella, venne studiata basandosi inizialmente s ul presupposto che l 'A ustria attaccasse con tutt e o gran parte delle s ue forze, in un secondo tempo suppone ndo che I'Impero danubiano fosse imp egnato, in con temporanea, su altri fronti.
Nel primo caso, tenendo co nto del l' es iguità delle forze a disposizione rapportato alla notevole es tension e di terreno montano da presidiare, che va dal monte Peralba al monte Maggiore, nonché della capillare rete s tradale che adduce al confine. si riteneva che un vigoroso a tt acco austriaco per le valli del But e del Chiarsò avrebbe travolto le forze presenti in zona e c he le otto co mpagnie a lpine di stanza a To lm ezzo, quali riserva orientata verso il settore But-Degano, non sarebbero state in grado di intervenire con efficacia.
ln questa ipotesi il Cadorna riteneva più redditizio abbandonare tutto il terreno a ll a sinistra dell'alto Tagliamento, lasciandovi solo poche forze di copertura con il compito di ritardare il più possibile la progressione nemica ed attuare le interruzioni stradali previste, e imposta re la difesa su lla sponda destra del fiume tra monte Resta ccl il gruppo del Verzegnis.
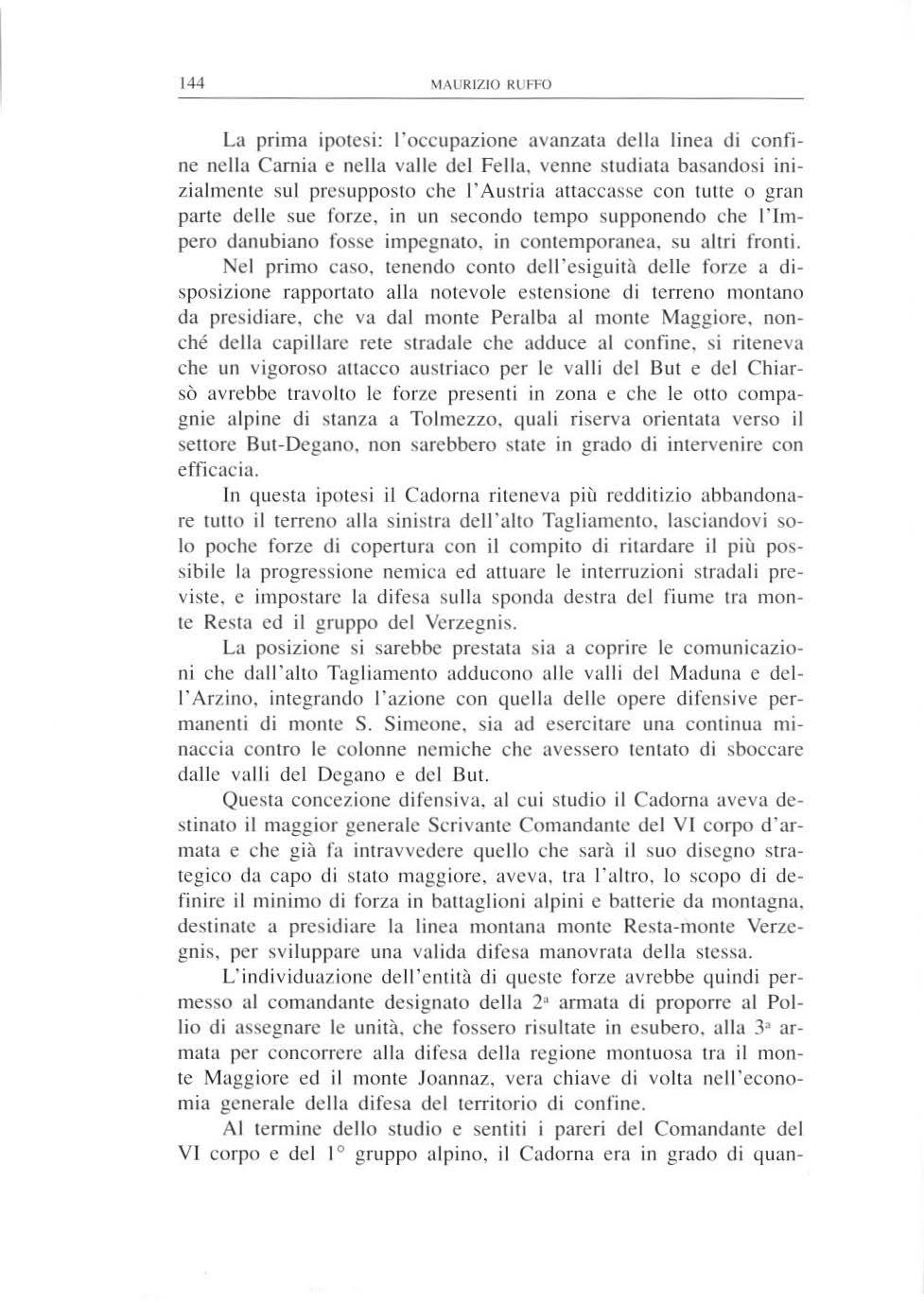
La posizione si sarebbe prestata sia a copr ire le comunicazioni che clall'alto Tagliamento adducono alle valli ciel Maduna e cieli ' Arzino, integrando l 'azione con quel la delle opere difensive permanenti di monte S. Simeone. sia ad esercitare una continua minaccia contro le colonne nemiche che avessero tentato di sboccare dalle val I i del D ega no e del But.
Questa concezione difensiva . al cu i studio i I Cadorna aveva destinato il maggior generale Scrivanie Comandante del VI corpo d'armata e che già fa intravvedere quello che sarà i I s uo disegno strategico da capo di s tato ma gg iore , av eva, tra l'altro , lo scopo di definire il minimo di forza in battaglioni a lpini e batterie da montagna. destinate a presidiare la linea montana monte Resta -monte Verzegnis, per svi luppare una valida difesa manovrata della stessa.
L ' individuazione dell 'en tità di queste forze avrebbe quindi permesso al comandante designato della 2" armata di proporre al P allio di assegnare le unità. che fossero risultate in esubero. alla 3• armata per co ncorrere alla di resa della regione montuosa tra il monte Ma gg iore ed il monte Joannaz, vera chiave di volta ne ll'economia genera le della difesa del territorio cli confine.
Al termine dello s tudi o e sentiti i pareri del Comandante del VI co rpo e del I O g ruppo alpino, i I Cadorna era in grado di quan -
tizzare in dieci battaglioni alpini e quattro batterie da montagna la forza necessaria alla difesa della destra del Tagliamento, rendendo così disponibili se i battaglioni alpini eia mandare in rinforzo ai due reggimenti bersaglieri ed al battaglione Cividale, destinati alla difesa avanzata tra monte Maggiore ed il monte Joannaz 14 • Nel prendere successivamente in considerazione il secondo caso della prima ipotesi, venne analizzata la poss ibi lità che le truppe in occupazione avanzata sfruttassero il momento favorevole, offerto da l contemporaneo e forte impegno delle forze austriache su altri fronti, per sviluppare un'energica azione offensiva in territorio nemico all'arr ivo dei grossi dell'armata.
l n tale eventua li tà l 'avanza t a si sarebbe dovuta sv iluppare lungo le p ri cipali linee di com uni caz io ne che convergono a Tarvi sio (alto I sonzo e Fella) e quelle che dalla Carnia scendono nella valle del Gail.
L e forze dell'occupazione avanzata pertanto si sarebbero spinte verso i valichi cli frontiera o avrebbero occupato stabilmente delle posizioni prossime alla linea di confine per costituire delle basi di partenza per l'attacco a ll a linea stessa; l 'obiettivo era p er tanto costit ui to dai passi di Monte Croce Carn ico, cli Pramosio, di Meleclis e del Caso n d i L anzo; costituivano un ob ie tti vo importante anc he il passo d i Volaja, per la possibilità che offr iva d i far cadere il passo di Monte Croce Carnico se for temente occupato da ll e forze nemic he, e quello di Nassfeld, partendo da P on tebba (Carta n. 6)
Le modalità della conquista della valle del Gail per puntare s ull 'abitato di Vill ac h , prim a, e su q uello di Kl age nfurt , poi, costitui va no, per come erano state congegnate dal Cadorna, un ' impo rtante va ri a nt e al vecchio studio del Cosenz.
In esso infatti s i ip ot izzava c he la co nqui s ta della conca d i Vill ach sarebbe avvenu ta ad opera della 2° a rmata per T a r vis io, dopo il forzamento dei fo rti di Malborg hetto e de l Predii , con il sosteg no di alcune forze che, procedendo dalla va ll e de lla Dra va e dall'alta va ll e del Gai!, avrebbero concorso a ll a caduta dei du e s ba rramenti a us triaci per man ovra.
O ra, invece , era la 2a ~u-m a ta c h e da so la avrebbe conquistato la va ll e del Gail ed av reb be reca to aiuto alla 4• impegnata nel Cadore e rallentata dalla resistenza delle fo rti ficazioni poste a s barra -
14 Cfr.: Ufficio del coma ndan te des ignato d'anna t a in Genova, Prot. n. 234 R. , Genova 24 marzo 1912, Occupa:irme avanzata nella Carnia e nella valle del Fella, AUSSME, H5, 12 R. , busta 9.
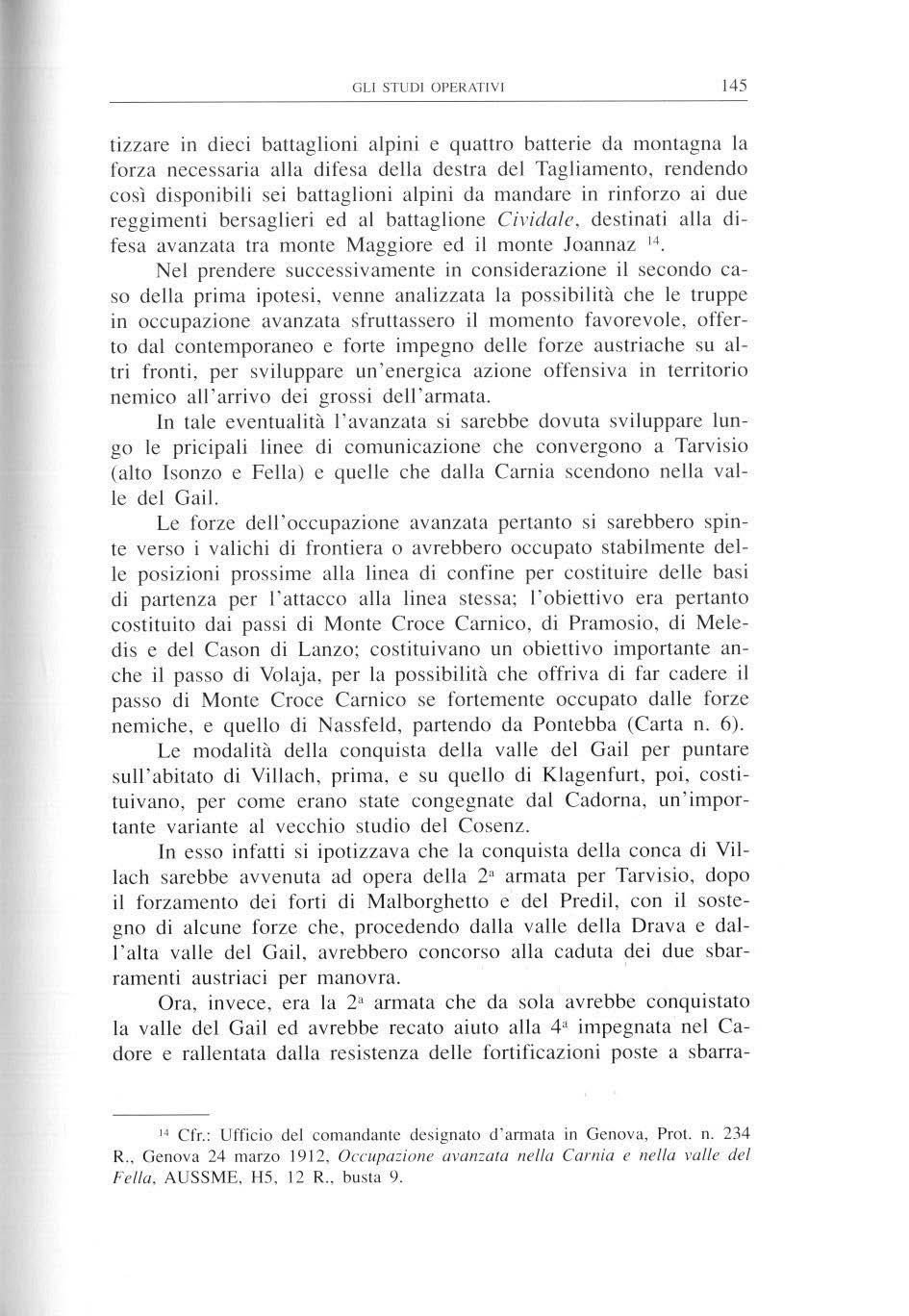
mento della strada di Alemagna 15 - forti di Landro e di Plat zw iese (Pratopiazza) - e di quella del passo di Monte Croce Comelico 16 - forte Haideckt e forte Mittelberg -.
L'altra ipotesi operativa: la difesa di seconda linea sul Pia ve e le sue adiacenze, vedeva sorgere un notevo le contrasto tra le concezioni s trategiche d e l Pollio e quelle del Cadorna.
L'anali si d e l comandante design a to della 2" armata prende va lo s punto dalle conclusioni della R e lazione s ulle difese di seconda linea da apprestarsi s ul Piave ed agli sbocchi di Vittorio Veneto e del Can s iglio , approntata da una commissione, pres ie duta dal tenente generale Ragni , incaricata di st udi are il particolare problema.
Nel merito il Cadorna riteneva che s i fo sse ro raggiunti tutti gli obiettivi indicati dalla direttiva n. 966 R. del 24 aprile 191 l dell'ufficio d ifesa de llo s tato , fatta eccezione per quanto prev isto al punto b) della s tessa.
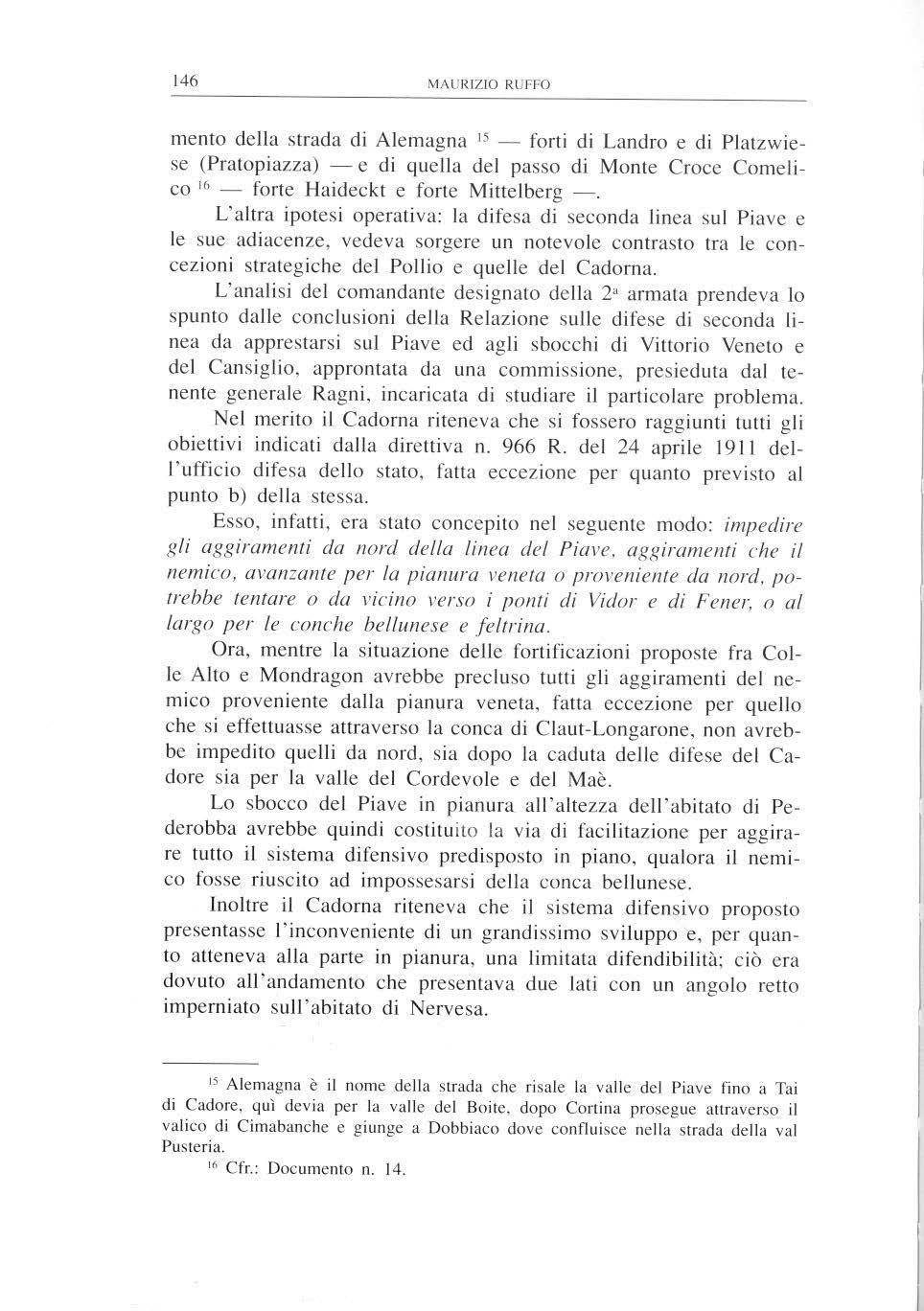
Ess o , infatti , era s tato concepito nel seg uente modo: imp edire gli agi iramenti da n o rd della lin ea del Pia ve . ag[!,iramemi che il nemico, avanzante per la pianura veneta o proveniente da nord. potrebbe tentare o da vic ino i·erso i p on ti di \lidor e di Fene,~ o al largo per le conch e bellunese e feltrina.
Ora, mentre la situazion e delle for tifi cazioni proposte fra Colle Alto e Mondragon avrebb e precluso tutti gli aggiram e nti del nemico proveniente dalla pianura veneta , fatta eccezione per quello che si effettuasse attraverso la conca di Claut-Longarone, non avrebbe impedito quelli da nord, sia dopo la caduta delle difese del Cadore s ia per la valle del Cordevole e del Maè.
Lo s bocco del Piave in pianura all'alte zza d e ll'abitato di Pederobba avrebbe quindi cos titu ito la via di faci lita z ione per aggirare tutto il s iste ma difensivo predisposto in piano , qualora il nemico fosse r iuscito ad imposses ars i della conca bellunese .
Inoltre il Caclorna riteneva che il s istema difensivo propo s to presentasse l ' inconvenien te di un gra ndis simo s viluppo e , per quanto atteneva alla parte in pianura , una limitata cl ifenclibilità; ciò era dovuto all'andamento che presentava due lati con un angolo retto imperniato su ll 'a bitato cli Nervesa.
15 Alemagna è il nome della strada che ri sale l a va lle del Piave fino a Tai di Cadore. quì devia per la valle del Boite, dopo Cortina prosegue attraverso il va l ico di Cimabanch e e giunge a Dobbiaco dove confluisce nella strada della va l Pusteria.
16 Cfr.: Documento n. 14.
li tratto Nord, p1u breve e con sviluppo da Colle Alto a Nervesa era più difendibile per la natura collinosa del terreno, per il domin io che eserc ita su ll a pianura e per la facile osservazione degli effetti ciel tiro.
TI lato in pianura , da Nervesa a San Donà cli Piave, era lungo circa 36 km ai quali bisognava aggiungere lo sviluppo delle tre tes te cli ponte 17 previste dalla Commissione al di là del fiume, per una lunghezza complessiva di circa 65 km.
Le stesse teste di ponte, eccezion fatta per quella della Priula che aveva due batterie di medio calibro, erano armate con batterie da campagna largamente intervallate e con una difficile osservazione del tiro.
Se ne deduceva che, di fronte ad un attacco condotto con energia, i salienti rappre se ntati dalle teste di ponte, facilmente avviluppabili, avrebbero offerto una scarsa re sis tenza; le truppe, inoltre , scosse nel morale perché costrette in ritirata dal Tagliamento e dopo due giorni cli marcia, non avrebbero potuto opporsi ad un nemico che, imbaldanzito dai successi fino allora conseguiti, avrebbe proceduto ad imbastire un rapido attacco per impedire il riordinamento delle unità.
Un altro aspetto che lasciava perplesso il Cadorna era la considerazione che queste teste di ponte, così vaste e che richiedevano notevoli forze per la loro difesa, non fossero in grado di fornire la stessa resistenza che sarebbe stata offerta, per la loro intrinseca robustezza, dalle fortificazioni che la componevano chiamate ad operare da sole, almeno per il tempo s tretta me nt e necessario per permettere alle unità in ritirata di attraversare i ponti sul Piave.
Il generale Cadorna non so lo esprimeva tutte le sue perpless ità in materia, ma, da uomo concreto e leale qual'era, si sentì in dovere di esporre le s ue con trari età in man iera costruttiva proponendo del le so lu z ioni alternative che, a s uo giudizio, avrebbero potuto meglio soddisfa r e alle es i genze .
In questa analisi , per meglio definire il suo pensiero , ritenne opportuno considerare i due cas i in cui ci si sarebbe potuti trovare qualora costretti al ripiegamento dalla linea del Tagliamento: nel primo si ipoti zzava la possibilità di resistere saldamente nel Cadore, lun go il Cordevole ed il Maè prolungando ult e riormant e la di -
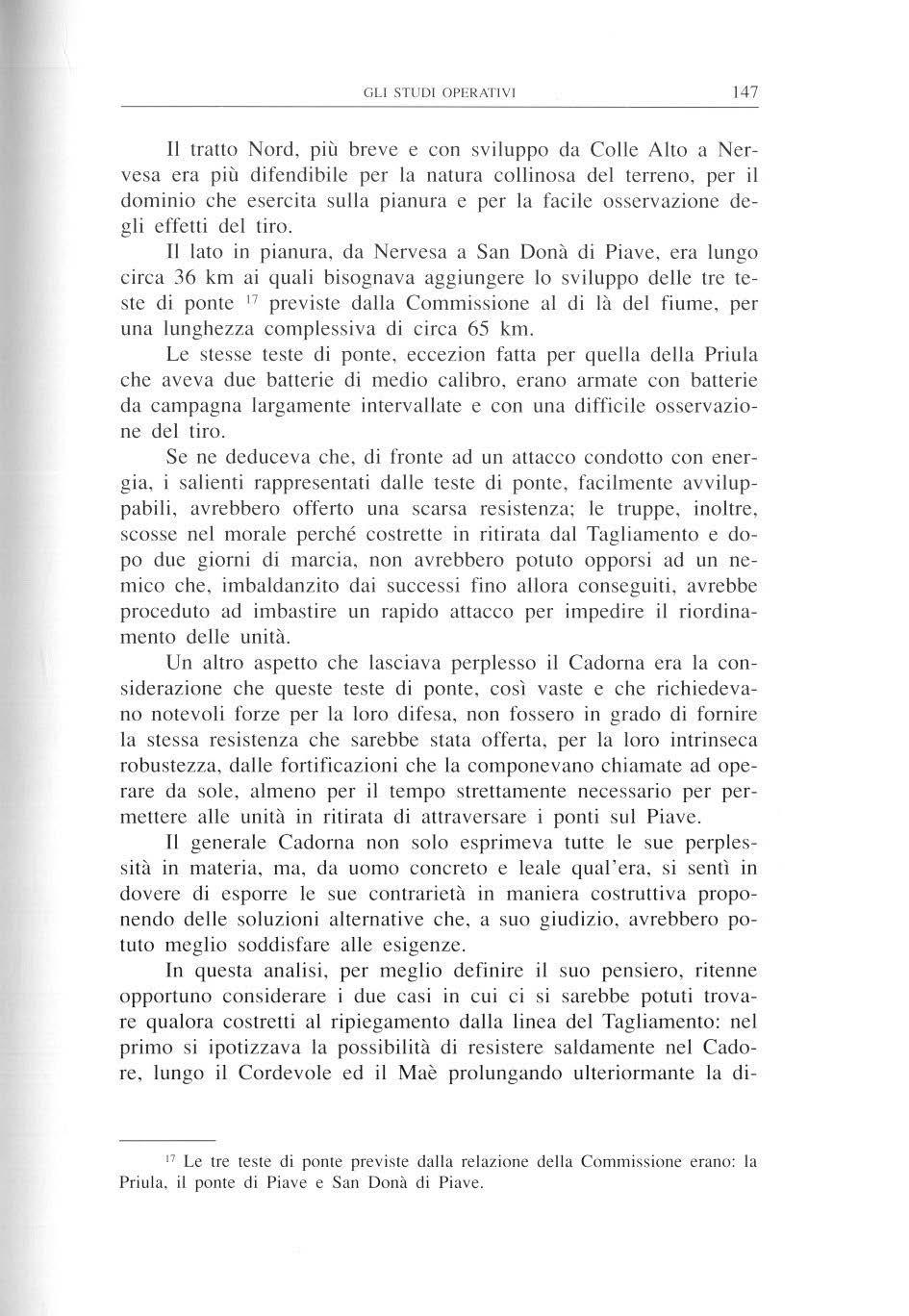
fesa, nel secondo era presa in esame la possibilità che il nemico si fosse impossessato di queste valli e stesse per penetrare nella conca di Belluno.
Scendendo nel particolare il Cadorna sosteneva che nella prima ipotesi sarebbe stato più opportuno impiantare la difesa sul fiume Livenza per le caratteristiche di questo corso d'acqua, poco largo ma inguadabile per la notevole quantità d ' acqua e per l'altezza delle sue sponde erose; inoltre la Livenza presenta un o sviluppo limitato essendo lunga meno di 30 km nel tratto da Sacile a Portogruaro dove iniziano ad estendersi le paludi litoranee.
Questa lin ea non si presta ad azioni offensive e quindi anche controffensive e sono sufficienti poche forze per il suo control lo; nella s u a parte settentriona le, invece, a monte della ferrovia Sacile-Pordenone fino allo sbocco del Cellina, la pianura si presenta cli facile percorribilità ed idonea ad azioni controffensive soste nute dal fuoco di numerose batterie che fossero approntate sulle ondulazioni che so rgono ai piedi delle pareti Sud-Orientali del gruppo montuoso cli monte Cavallo.
Il Cadorna riteneva pertanto che questa linea, pur avendo una buona poss ibilità cli condurre azioni controffensive sulla sua sinistra, fosse in grado, ott imam ente appoggiata com 'era ai monti ed a l mare, cli copr ire non solo la retrosta nte p ianura, ma anche tutte le comunicazioni che si dirigono nelle conche di Belluno e di Feltre al le spalle ciel Cadore, del Maè e del Cordevole.
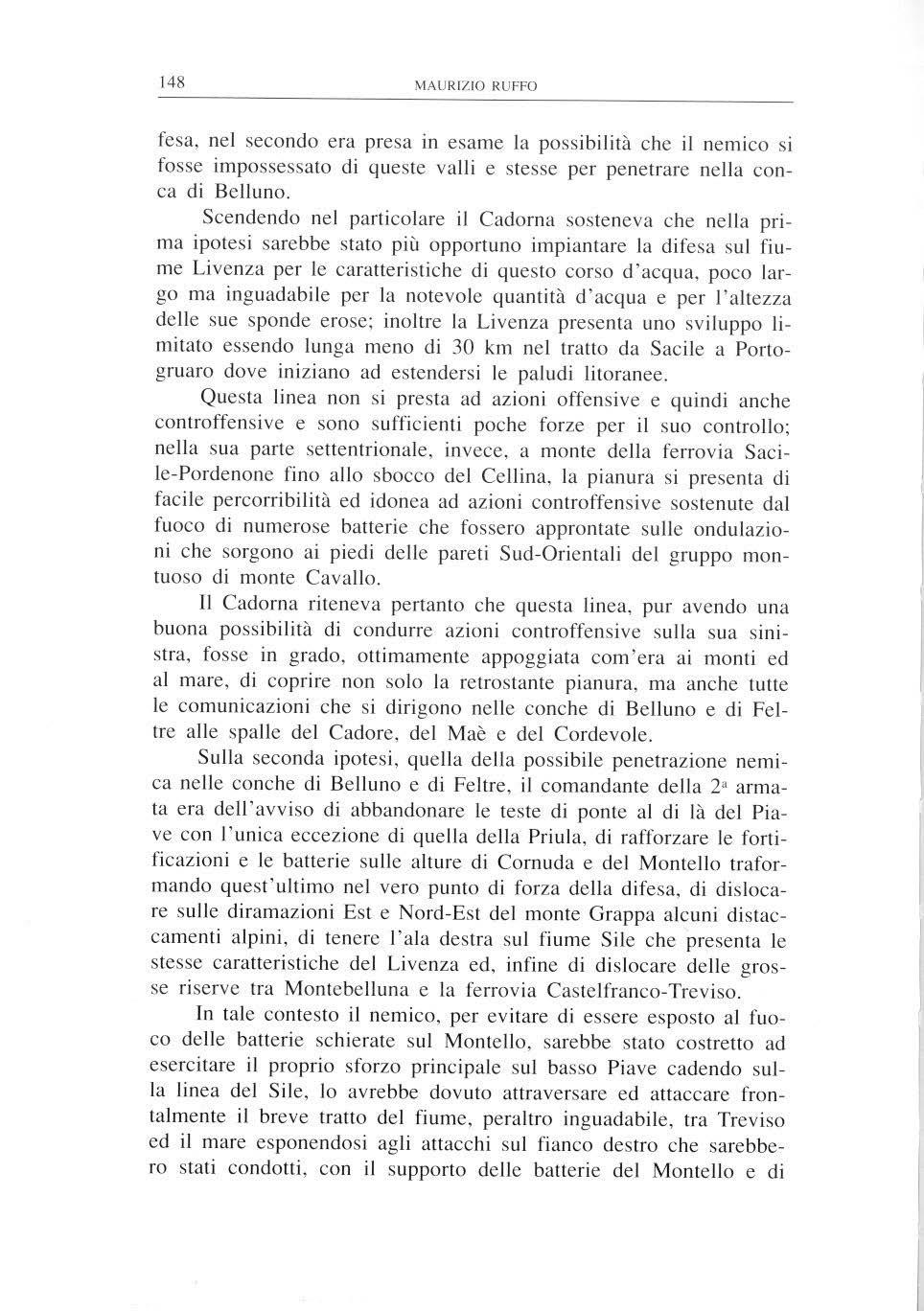
Sulla seconda ip otesi, quella delJa possibile penetrazione nemica nelle conche di B e llun o e di Feltre , il comandante de.lla 2a armata era dell'avviso cli abbandonare le teste di ponte al di là ciel Piave co n l 'unica eccezione cli quella della Priula , di rafforzare le fortificazioni e le batterie sulle alture cli Comoda e del Montello traformando quest'ultimo ne l vero punto di forza della dife sa, cli di s loc are s ull e diramazioni Est e Nord - Est del monte Grappa alcuni distacca menti alpini, di tenere l'ala destra s ul fiume Sile che presenta le stesse caratteristiche del Livenza ed, infine cli cl is locare ciel le g ro sse riserve tra Montebelluna e la ferrovia Castelfranco-Treviso.
In tale co nte sto il ne mico , per ev itare d i essere esposto a l fuoco delle batterie sc hierate s ul Montello, sarebbe stato costretto ad esercitare il proprio sforzo principale sul basso Piave cadendo sulla linea ci e l Si le, lo avrebbe dovuto attraversare e d attaccare frontalm e nte il breve tratto del fiume , peraltro in g uadabile, tra Treviso ed il mare espone ndo si ag li attacchi s ul fianco destro che sareb bero stati condotti, co n il suppo rto delle batterie del Montello e cli
quelle schierate intorno a Treviso, dalle riserve che si sa rebbero mosse dalla fronte tra Montebelluna e la ferrovia Castelfranco-Treviso in direz ion e del Piav e.
Il generale Cadorna concludeva queste sue osservazioni sui ris ultati della commissione Ra g ni evidenziando che le so lu zioni da lui espos te avrebbero presentato il vantagg io , per quella del Piave, di essere diffici I mente prevedi bi le dal nemico e quindi costituire per esso un 'aute nti ca sorpresa, mentre per quanto riguardava la linea del Livcnza le difficoltà del terreno e la relativa vicinanza con il Tagliamento non avrebbero consentito al nemico di approntare sin dal primo momento un attacco violento mentre avrebbero permesso alle forze italiane, in ritirata. di riorganizzarsi ed attuare una valida difesa 18
A simi li osservazioni il generale Pollio ritenne opportuno dare un 'ampia cd articolata risposta tendente so pratutto a ribadire quelle che erano le s ue concezioni strategiche, per altro complctamante recepite dalla commissione R agni.
Nella sua replica il capo di stato maggiore affermava, in merito alla possibilità di un aggiramento per le conche di Belluno e Feltre, di ritenerlo assai poco probabile perché sarebbe caduto sotto le difese di Senavalle e del Cansiglio, mentre per quanto riguardava le provenienze da Nord le difese del Cadore e del Cordcvole erano tali da non poter essere facilmente superabili, tenendo in debito conto anche le condizioni d el terreno che si prestano ad una tena ce e prolungata resisten:a mediante la manovrn sia da sola sia appoggiata alle fortifirazioni 19 •.•
Le un iche vie di facilitazione che potevano creare delle preoccupazioni e d in cui il giudizio del Poli io coincideva con qu e llo del Cadorna erano la va l Maè, che tuttavia era facilmente sbarrabi le o interdibi le, e la carrozzabile de lle prealpi carnic he attraverso la quale s i sarebbero potute incolonnare le forze avversarie c he tendevano al Piave.
I n tal e contes to erano già st.ati avviati degli studi su come proteggere, con la vo ri di tipo permanente , l'importante crocevia rap-
18 Cfr.: Ufficio del co ma ndant e designato d'armala in Genova, Prot. n. 57, Genova 3 febbraio 1912, Difésa di sernnc/a linea sul Piai·e e adiacen : e, A USSME, J-15, 12 R. , busta 9.
19 C fr.: Co mando del Corpo di Sta to Maggiore. Ufficio Difesa d ello Stato, Prot. n. 11 55 R.S. , Roma 4 maggio I 912, Difese di secu11da linea sul Pial'e ed adiacen:e, AUSSME. H5. 12 R., busta 9.
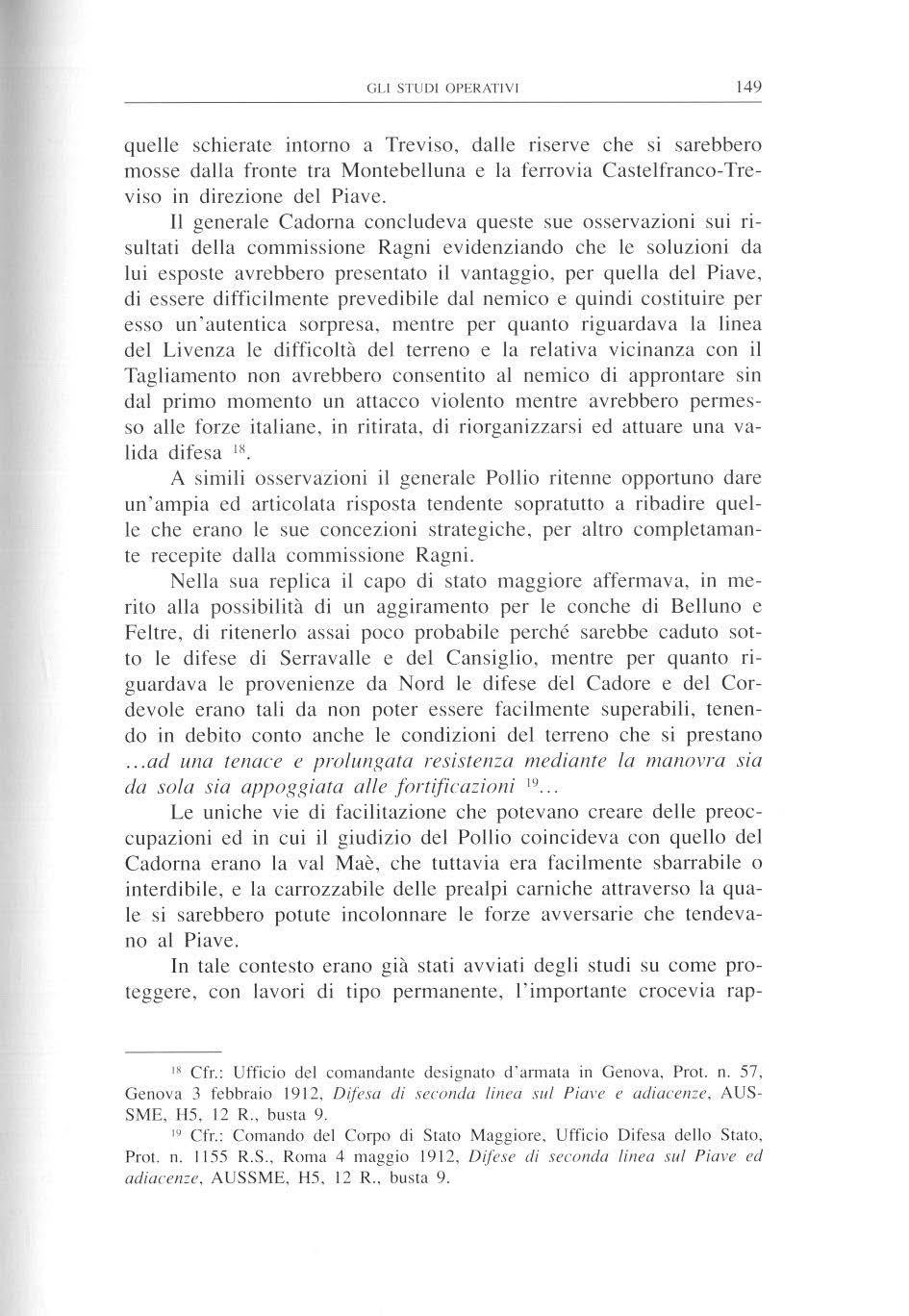
presentato dall'abitato di L o ngaro ne , assic urand o ne la difesa anche da prove n ie nz e da s ud attraverso il paese di Ponte ne ll e Alpi.
Un altro elemento di di sse nso era l'imp os t azione della difesa su l Pi ave.
Il capo di stato maggiore non c ondivideva l'idea di utiliz za re la lin ea del Livenza, pe r c hé le cara tter is ti c he di questo corso d'acqua erano m ol to s imili a quelle del P iave e la poca dis ta nza dal Tag li a m e nto e la con te mporan ea limit atezza di zo ne idonee al concentramento delle forze non la facevano preferire al la precedente per condurre un ·azione co ntroffensiva, inollre questo fiume per i s uo i appoggi a ll e ali avre bbe potuto rapp re sentare un prez ioso e lem e nt o ritardat o re.
Nea nc he que ll a del Sile era ritenuta idon ea perché prese nta va l'incovenientc di essere troppo a ridosso della piazza di Venezia il cui co invol g im e nto prematuro nell'azione difensiva ne avrebbe ridotto drasticamente quell'autonomia necessaria ad adempiere alla sua speciale fuinzione s trategi ca.
So lo sul Montell o e sulla necess it à di po tenz iarne le ca pac it à operative la concezione dei du e alti uffi cia li pre se ntava un punto cli convergenza.
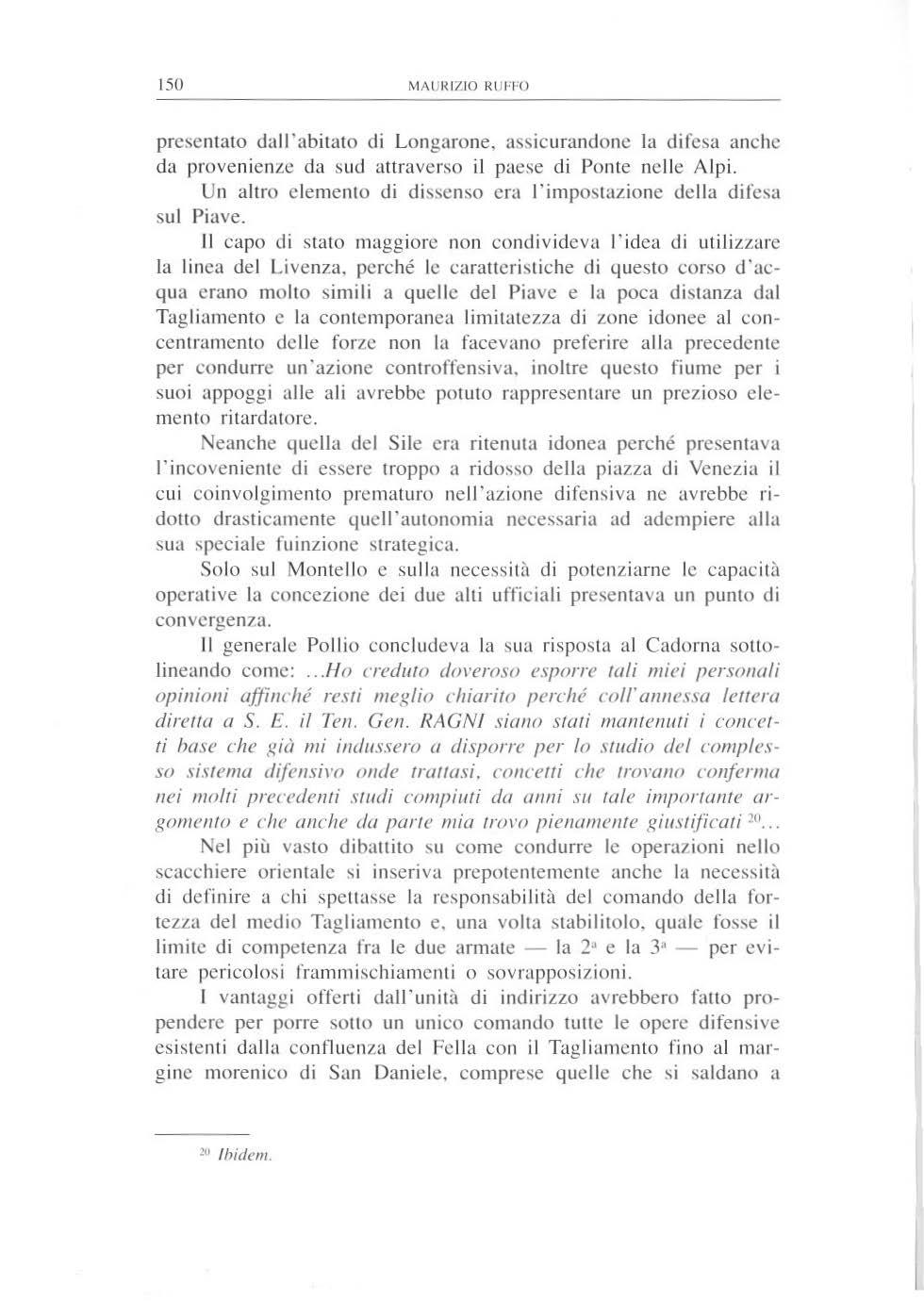
11 ge nera le Pollio co nclud eva la s ua rispo s ta al Cadorna so!lolin eando come: .Ho credwo dm·eroso esporre tali miei personali opinioni affìnché resti meglio chiarito perché col/' w1ne.ua lettera dire1ta a S. E. il Ten . Ge 11. R AGNI siano stati manle11u1i i concetti hase che già mi indussero a disporre per lo studio del comple.,·so sis1e11w difensivo onde trnltasi. concelfi che trornno conferma nei molti precedenti studi compiuti da anni s11 tale imporrante argomenro e che anche da parte mia trn1 ·0 pie11a111e11te giustificati W. ..
Nel più vas to diballito su co me co ndu rre le opera1ioni nello scacchiere oric ntale si inscriva prepotentemente anche la necessità di d e finire a c hi s pe tta sse la responsabilità del co man do della forteaa del m edio T agl iame nt o e. una volla s tabilitolo. quale fosse il limit e di competenza fra le du e armate - la 2,, e la 3,, per evitare pe ricolo s i frammischiamenti o sovra ppos izion i.
I vantaggi offe rti dall'unità d i indirizzo avrebbero fatto propendere per porre so tto un unico comando tulle le opere difensive esistenti dalla co nflu e nza del Fe lla con il Tagliam e nto fin o a l marg in e morenico di San D an ie le. co mprese quell e che si saldano a
questa linea verso Est. facendo fronte alle provenienze dall'Isonzo e dall'alto Natiso ne.
Questo sulla base concettuale che tutte queste fortificazioni avvolgono e pro teggono un unico campo di manovra o di raccolta, separando le operazion i che il nemico tentasse per il Fella e la Carnia da quel le condotte lungo la pianura friulana, mentre la batteria di Chi u saforte era da considerarsi come un 'opera a se stante.
Tutt avia il vasto ccl articolato sistema difensivo della piazza ciel medio Tagliamento non permetteva ad un unic o comandante cli esercitare nella maniera più efficace la propria opera, inoltre tutto il complesso avrebbe dovuto essere posto sotto la giurisdizione di un unico comando d'armata, verosimilmente quello della 3".
Questa armata si sarebbe quindi trovata a disporre di tutto il corso del Tagliamento, dalla stretta di Ospedaletto al mare, precludendo alla 2• ogni via di rifornimento o cli ritirata attraverso il medio e basso Tagliamento, costringendola ad utilizzare esclusivamente le comunicazioni montane, cli minore potenziai ità ed esposte alle incursioni nemiche, data la loro vicinanza al confine.
TI criterio che il capo cli stato maggiore ritenne opportuno adottare era legato alle funzioni delle opere: le fortificazioni ciel margine morenico cli San Daniele avevano una funzione eminentemente strategica, avevano cioè lo scopo di spingere le forze nemiche verso la zona litoranea scarsa cli strade e di difficile percorrenza agevolando, nel contempo, l'offensiva sul fianco de ll e colonne avversarie; le altre opere avevano, invece, il compito di sbarramento e di interdizione di singole va ll i ed arterie stradali.
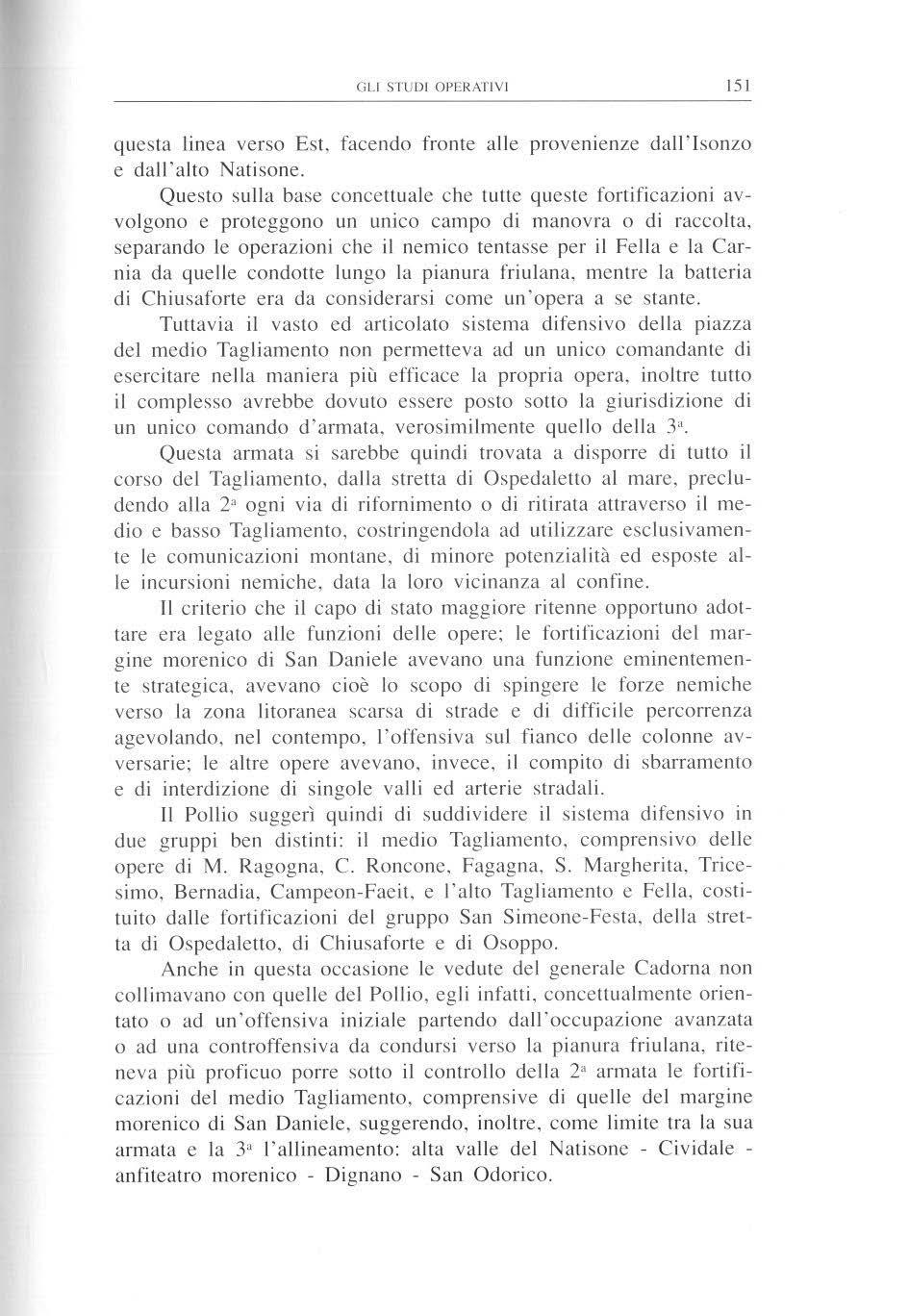
Il Pollio suggerì quindi di suddividere il sistema difensivo in due gruppi ben distinti: il medio Tagliamento, comprensivo delle opere cli M. Ragogna, C. Roncone. Fagagna, S. Margherita, Tricesimo, Bernadia, Campeon - Faeit, e l 'a lto Tagliamento e Fella, costituito dalle fortificazioni del gruppo San Simeone-Fes ta, della stretta cli Ospedaletto, di Chiusaforte e di Osoppo.
Anche in questa occasione le vedute del generale Cadorna non collimavano con quelle del Pollio, egli infatti, concettualmente orientato o ad un 'offensiva iniziale partendo dall'occupazione avanzata o ad una controffensiva da condursi verso la pianura friulana, riteneva più proficuo porre sotto il controllo della 2• armata le fortificazioni del medio Ta gliamento, comprensive di quelle del margine morenico di San D aniele, s uggere ndo , inoltre, come limite tra la sua armata e la 3" l'allineamento: alta valle del Na t isone - Cividaleanfiteatro morenico - Dignano - San Odorico.
La questione, che non era di seco ndaria imp or tan za per le implicalioni che avrebbe comportat o nei riguardi della definilione delle nuove direttiv e s ulla radunata e su i tra s porti, venne portata a solu zione nell'aprile del I 9 12 quando il generale Po Ilio. ribadite le motiva z ioni c he lo avevano indotto a prendere in esame la poss ibilità di ripartire la responsabilità della zona di frontiera fra le due armate 21 , stab ilì c he: ...
a) il Mont emaggiore costitusce il limite ji-a le armate 2" e 3 11 sulla linea di fro11tiera. Però spetta alla 3 ,, armata la difesa di Ml di Mu si immediatarneme a nord di Montema ggiore e quindi anche dal passo di Tanameje;
h) la 2° armala ha alla sua dipenden:a la pia::a Allo 'làgliamento-Fella. comprendente le opere: monte San Simeone-Festa. 111011te Ercole-Co111ielli. Chi11safor1e col ridolfo di Osoppo. La Ja armata ha alla s ua dipe11den:a lo pia::a Medio Tagliamento. compre 11de111e le opere: Col Colai, Ragogna. Col Ro11co 11e, Fagagna. Sc1111a Margherita. 1ìfresimo. Bemadia, FaeitCampeon. Buja;
r) la riparti:ione della :ona di rad1111ata .fra le due armate 2" e 3 11 è .fatta s ulla hase dei criteri an:idetti e quindi la linea di deli111ita:io11e si s,·olge approssimamente dal Mo11te111aggiore per passo Tanam eje, monte Musi. so rgenti del Torre. monte C hiamp on. Gemona. fiume Ledra, rio a destra del Tagliame1110, P in:ano, Spilimherio, P ordeno n e 12 .•.
Inoltre, in attesa che venissero cos truiti altri ponti s ul Tagliament o a monte di quello di Pin zano, la 2• armata era a utori uata ad avva lersi di quest'ultimo viadotto e d e lla strada Ra gog na-San Danie le -Osoppo, nonostante che cadessero so tto la zo n a di rcsponabilità, della 3" armata.
Nonostante la c hiar eaa e la risoluteua de ll e disposizioni del ca p o di s tato maggiore il ge nera le Cadorna, pur aderendovi con vero se nso di disciplina, non so lo era rimas to delle sue opinioni, ma aveva anche sen tito il dovere di esternare a ncora una vo lt a, i suoi convincimenti al ge neral e Pon za di San Mart ino. co mandante desig nat o del la 3• armata.
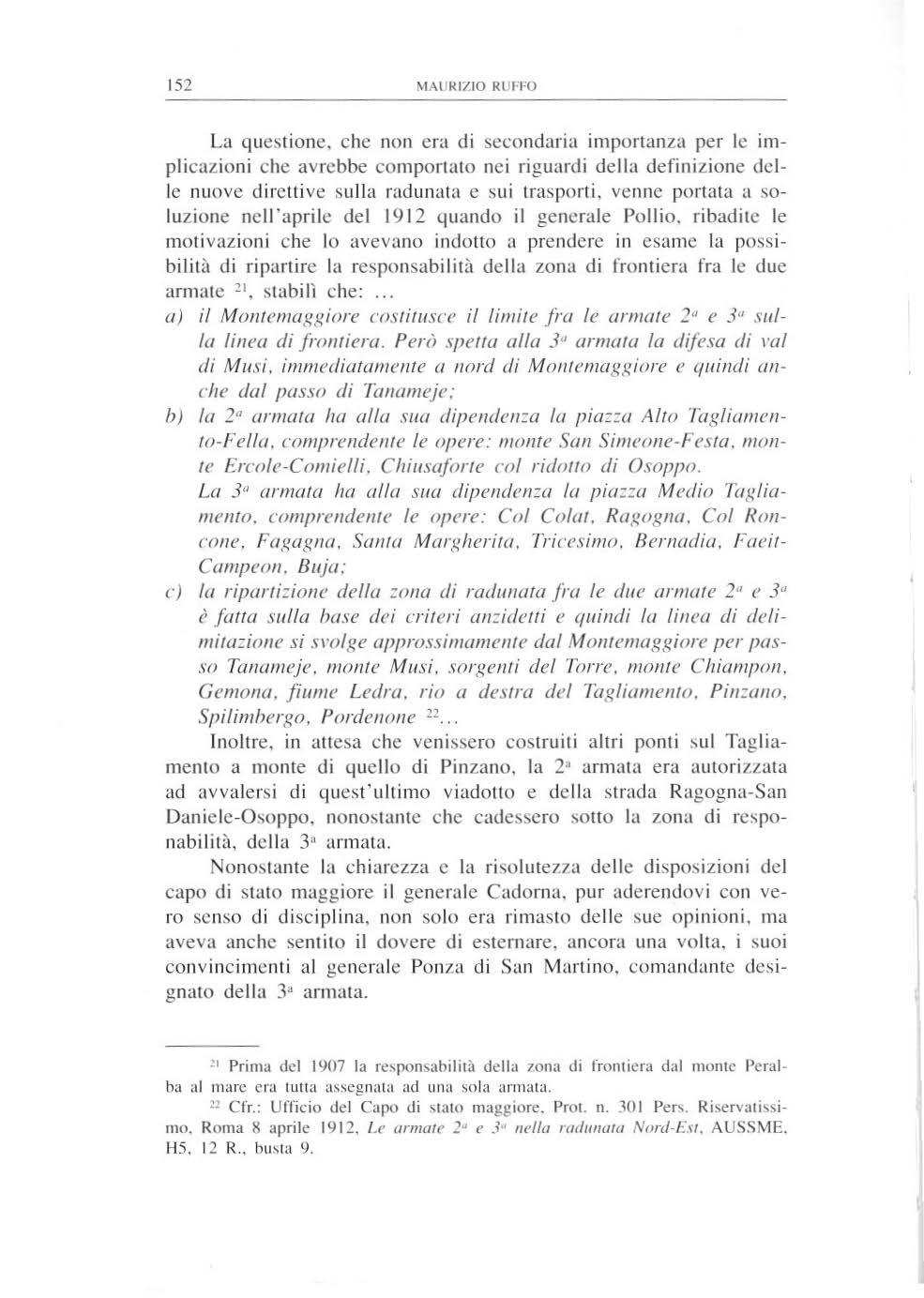
1 P rima del 1907 la re~ponsabilità della rona di frontiera dal monte Pera lba al mare era tutta assegnata ad una sola armata.
)l Cfr.: Uffic io de l Capo di ~tato maggiore. Prot. n. 301 Per, Ri~ervati\simo. Roma 8 aprile 1912. L<' unnatc 2• e 3·' nelta rad1111aw Nord-Ew. AUSSME. H5, 12 R. , bw,ta 9.
Infatti nello stesso mese di apri le , con una le ttera pe r so na le 23 rib adiva che la sudd ivi s ion e delle forze tra le due grandi unità, stante l'attuale area di responsabilità, i compiti assegnati ed i tempi necessari per l 'afflusso dei grossi, era sproporz ion a ta e, soprattutto, troppo sbi lanciata a favore della 2" arma ta, mentre, in caso di un a forte pressione esercitata dal nemico s ul medio e basso Isonzo quest' unit à sarebbe necessariamente richiamata in tale settore abba ndonando l 'a lto Ta g liamento.
L a concezione strateg ica del Pollio era tutt avia legata alla sua visione e fedeltà triplicista, dove il rafforzamento del le difese ad oriente era detlato più da es igenze di s icurezza generale dei confini , per altro fortemente fortificati da parte dell'Austria. che non da un atteggiamento di ostilità verso la potenza confinante.
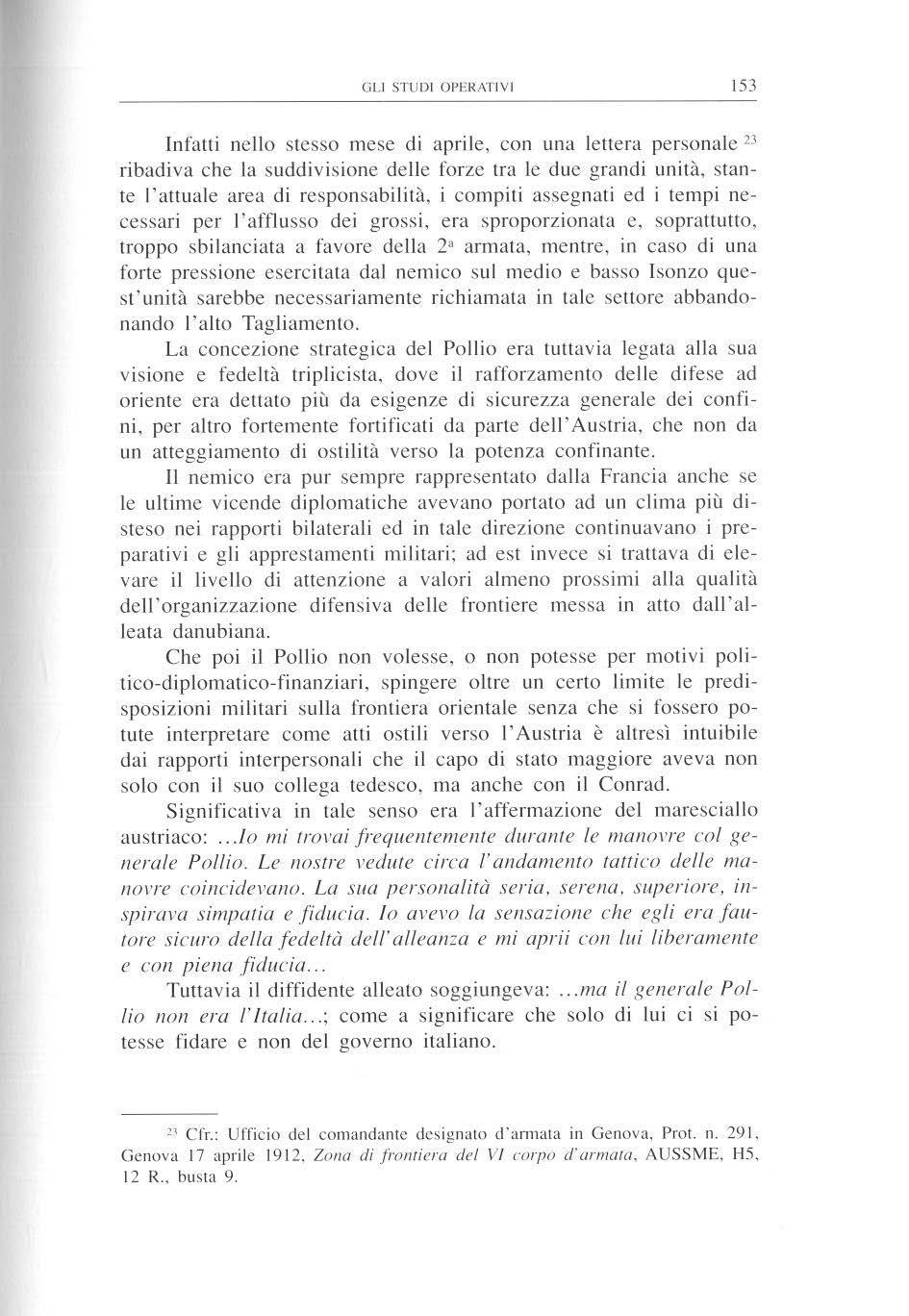
11 nemico era pur sempre rappresentato dalla Francia anche se le ultime vicende d iplomati che avevano portato ad un clima più disteso nei rapporti bilaterali ed in tale direzione contin ua vano i preparativi e gli apprestamenti militari; ad est invece si trallava di elevare il livello di attenzione a valori almeno prossimi alla qualità dell 'orga nizzazione difensiva delle frontiere messa in atto dall'alleata danubiana.
Che poi il P allio non volesse, o non potesse per motivi poi itico-diplomatico-finanziari, s pin ge re oltre un certo limite le predisposiz ioni mii itari s ulla frontiera or ientale senza che si fossero potute inte rpretare come atti osti Ii verso l'Aus tria è altresì intuibile dai rapporti interpersona li c he il capo di s tato maggiore aveva non solo con il s uo collega tedesco, ma anche con il Conrad.
Significativa in tale senso era l 'affe rmazion e del marescial lo austriaco: .. lo mi trol'ai fi'equenternente duranle le manol're col generale Poi/io. Le nostre vedute circa l'andamento tattico delle mano1·re coincidevano. La sua personalità seria, serena , superiore, inspirnva s impa1i a e fiducia. lo avevo la sensazione che eg li era fautore sicuro della fedeltà dell'alleanza e mi aprii con lui liberamente e con pieno fiducia
Tuttav ia il diffidente alleato soggiungeva: ma il generale Po/fio non ern l'Italia ... ; come a s ignificare che solo di Lui ci si potesse fidare e non del gove rno italiano.
2 ' Cfr.: Ufficio de l comandante designato e.l'a rm a ta in Genova, Prot. n. 29 1 Ge nova 17 apri l e 1912. Zona di fi'Ol1tiaa del \Il !'orpo d 'arma ta , AUSSME, H5, l 2 R., bu sta 9
Po i I
It
(Germania).
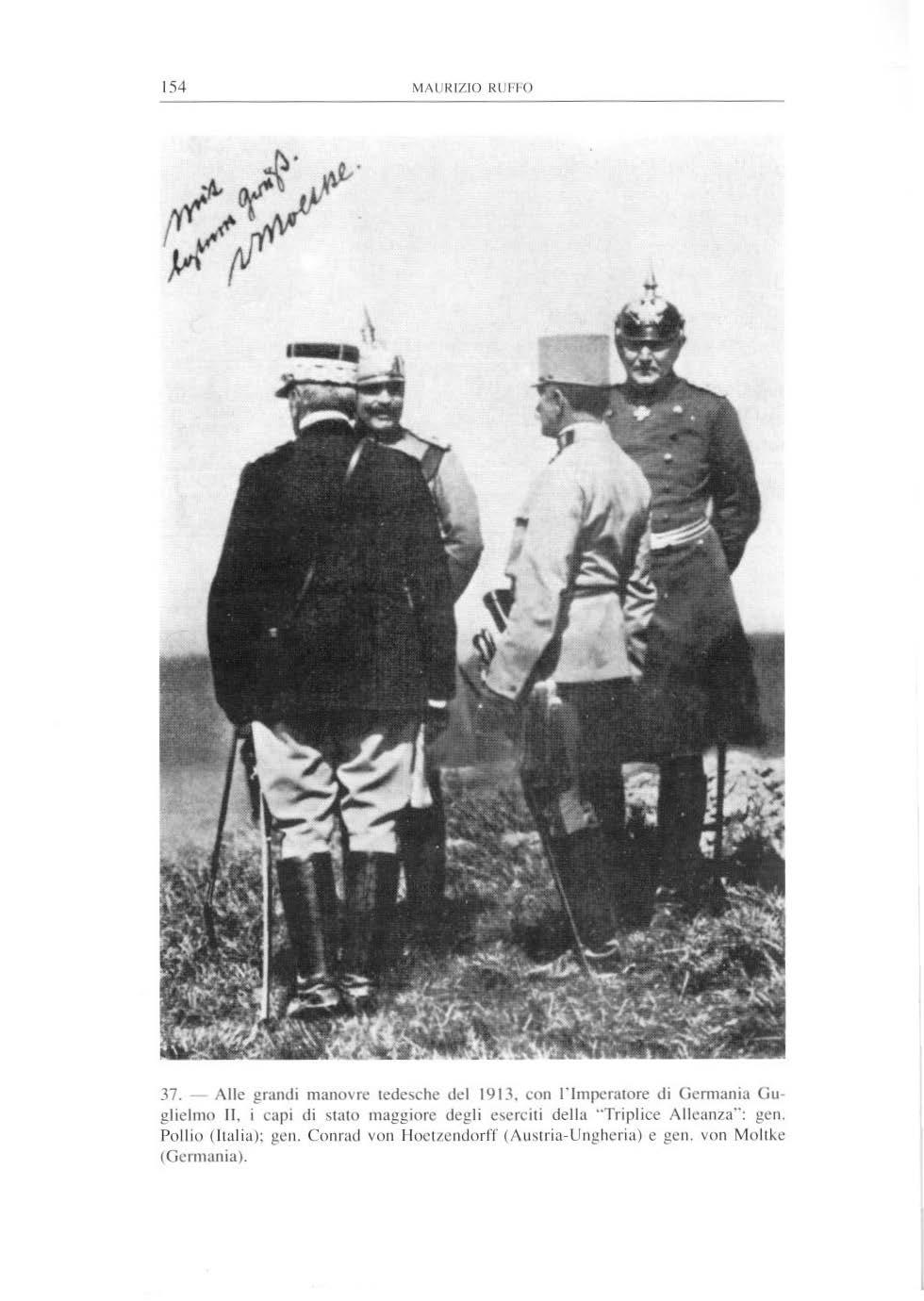
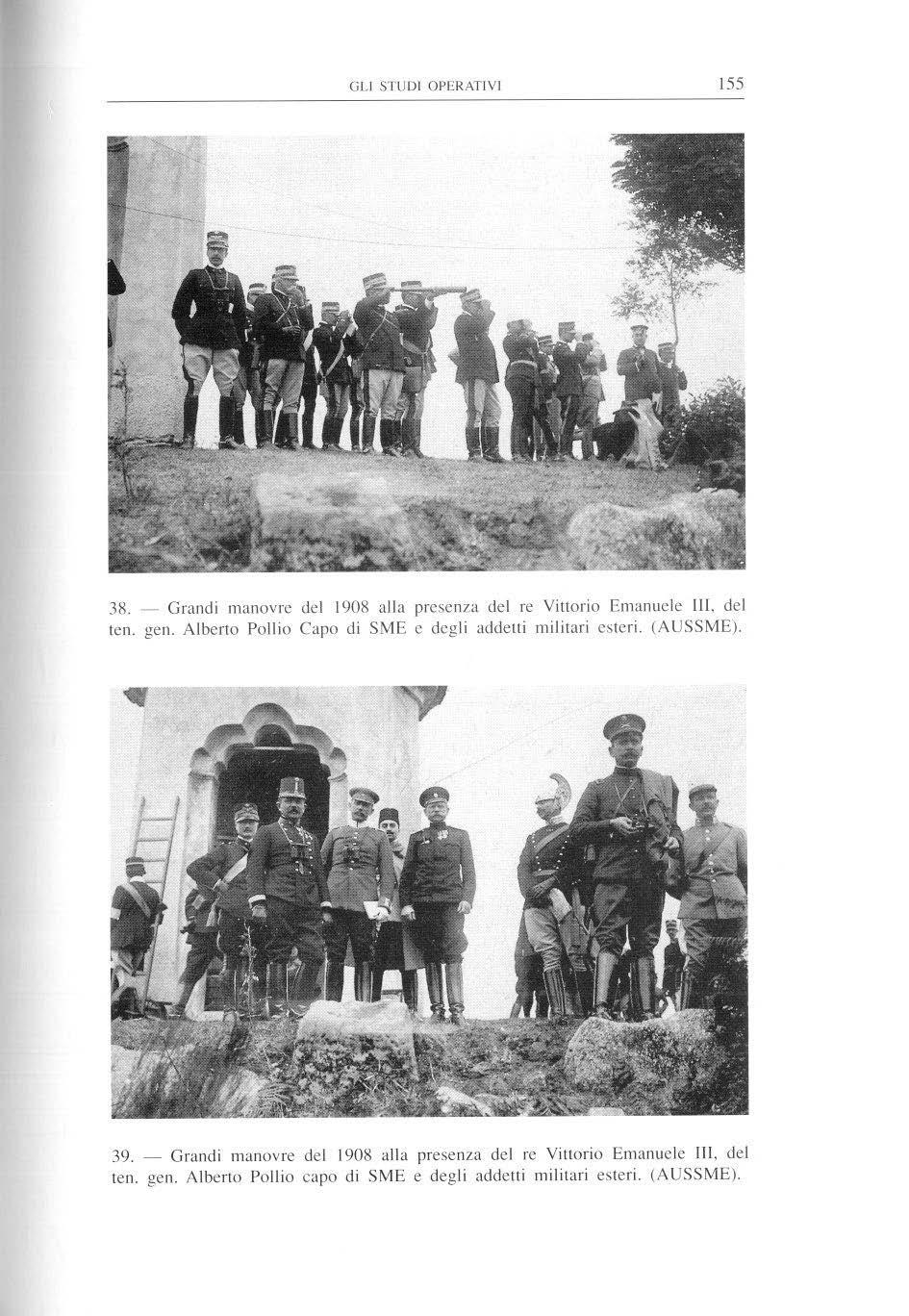
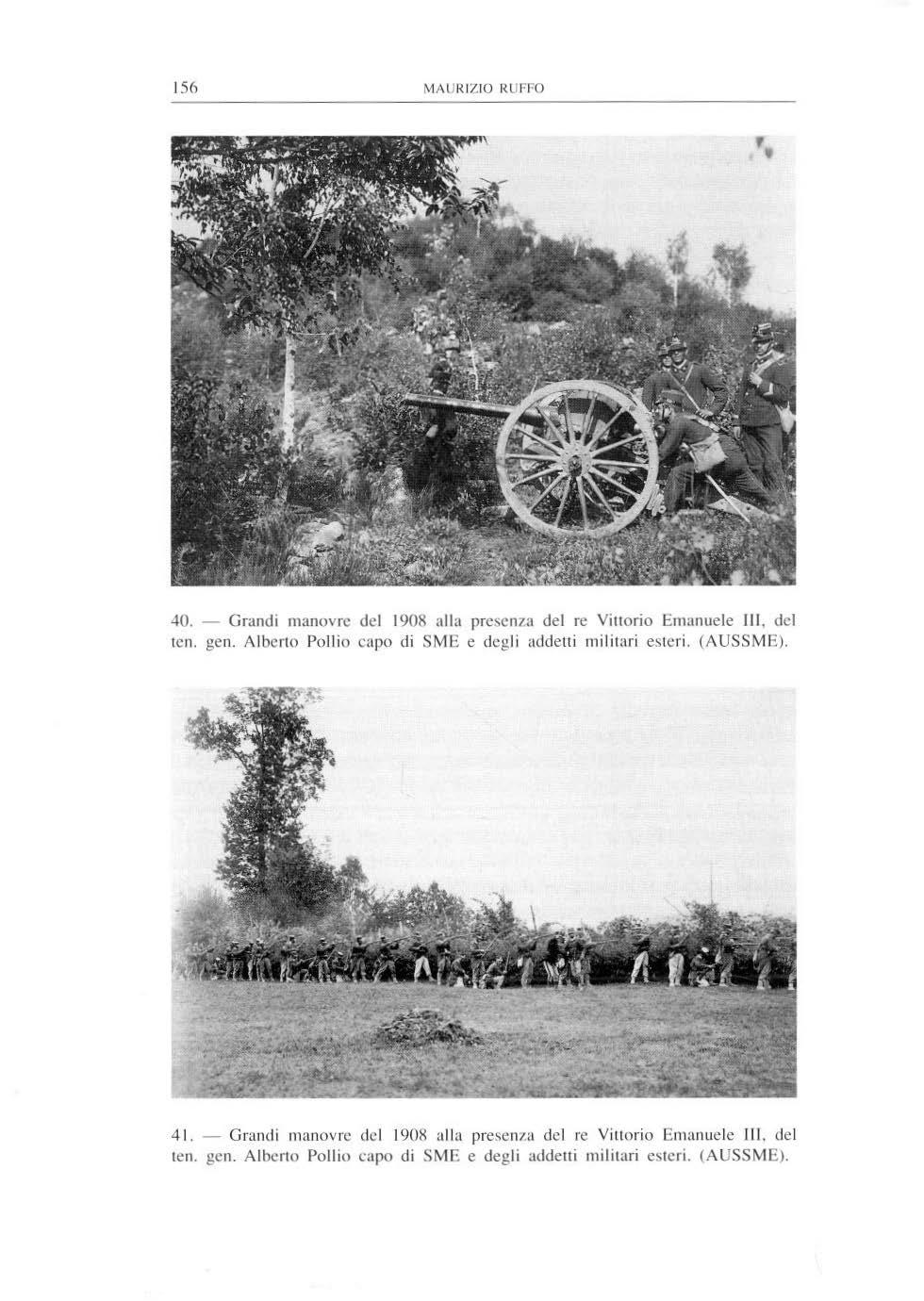

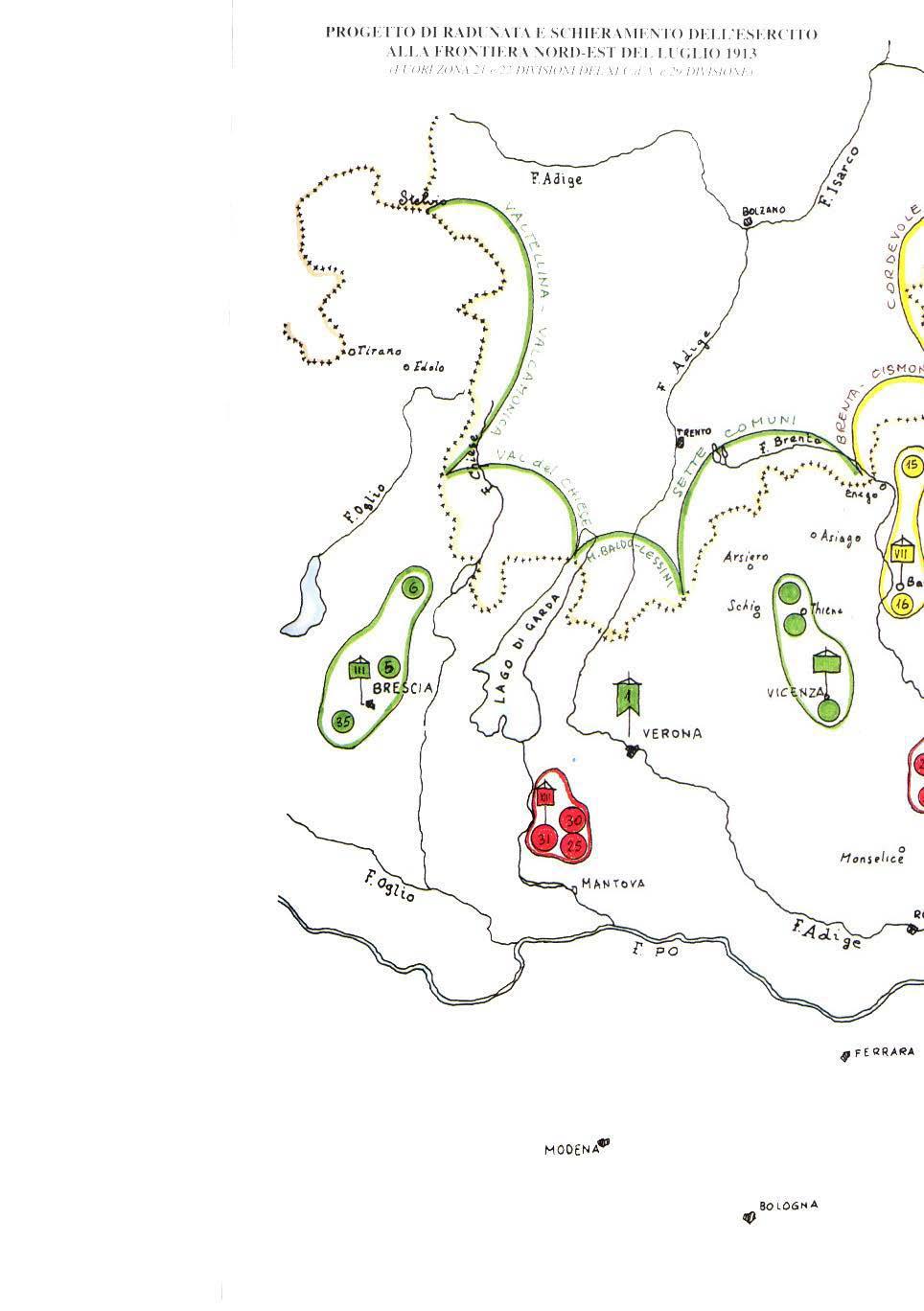
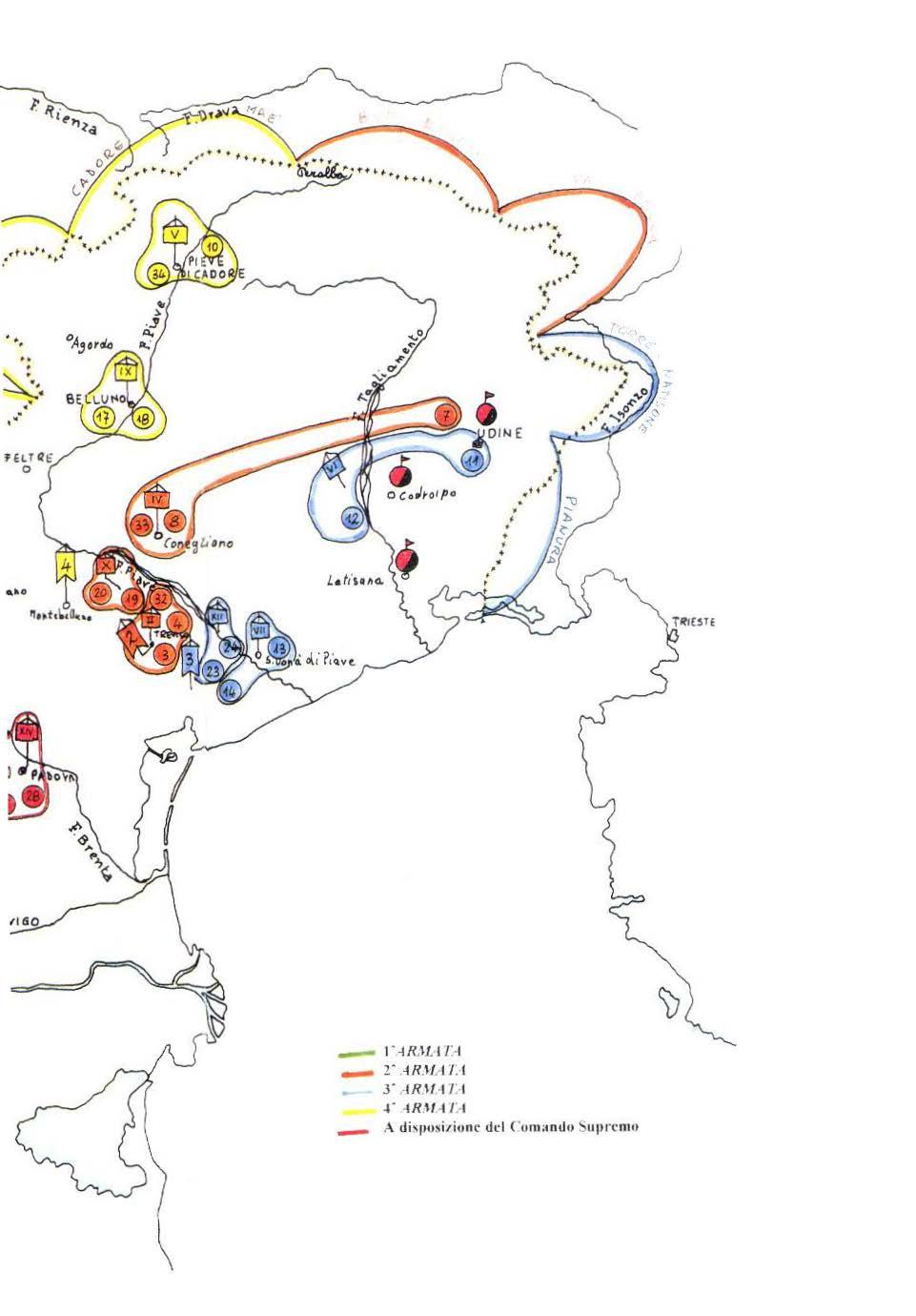

Resta il fatto che sotto il suo mandato il Pollio riuscì non solo a ricostruire un esercito che anni di pace e di scarsa atten z ione aveva ridotto in uno stato di scarsa efficienza, ma ad avviare e p6rtare a compimento il progetto di una difesa ad Oriente non solo imperniata sulle opere della fortificazione , ma anche sul l 'incisivo intervento delle unità destinate alla difesa avanzata sui confini.
Il suo progetto operativo del I 913, tenendo conto dei fauori di debolezza dell'esercito italiano rappresentati dal maggior tempo occorrente per la mobilitazione e la radunata, dallo sfavorevole rapporto di forze con l'esercito asburgico 24, dalla mentalità difensiva che aveva caratterizzato i vertici della forza armata per mezzo secolo e clall ' incerta politica estera del governo, si basava ancora , forzatamente, su un atteggiamento inizialmente difensivo.
Contenuto l'attacco nemico il Pollio ipotizzava quindi una manovra controffensiva, da condursi sulla base delle circostanze ci e l momento, con il fine di riconquistare il territorio italiano invas o ed inseguire il nemico sul suo stesso terreno.
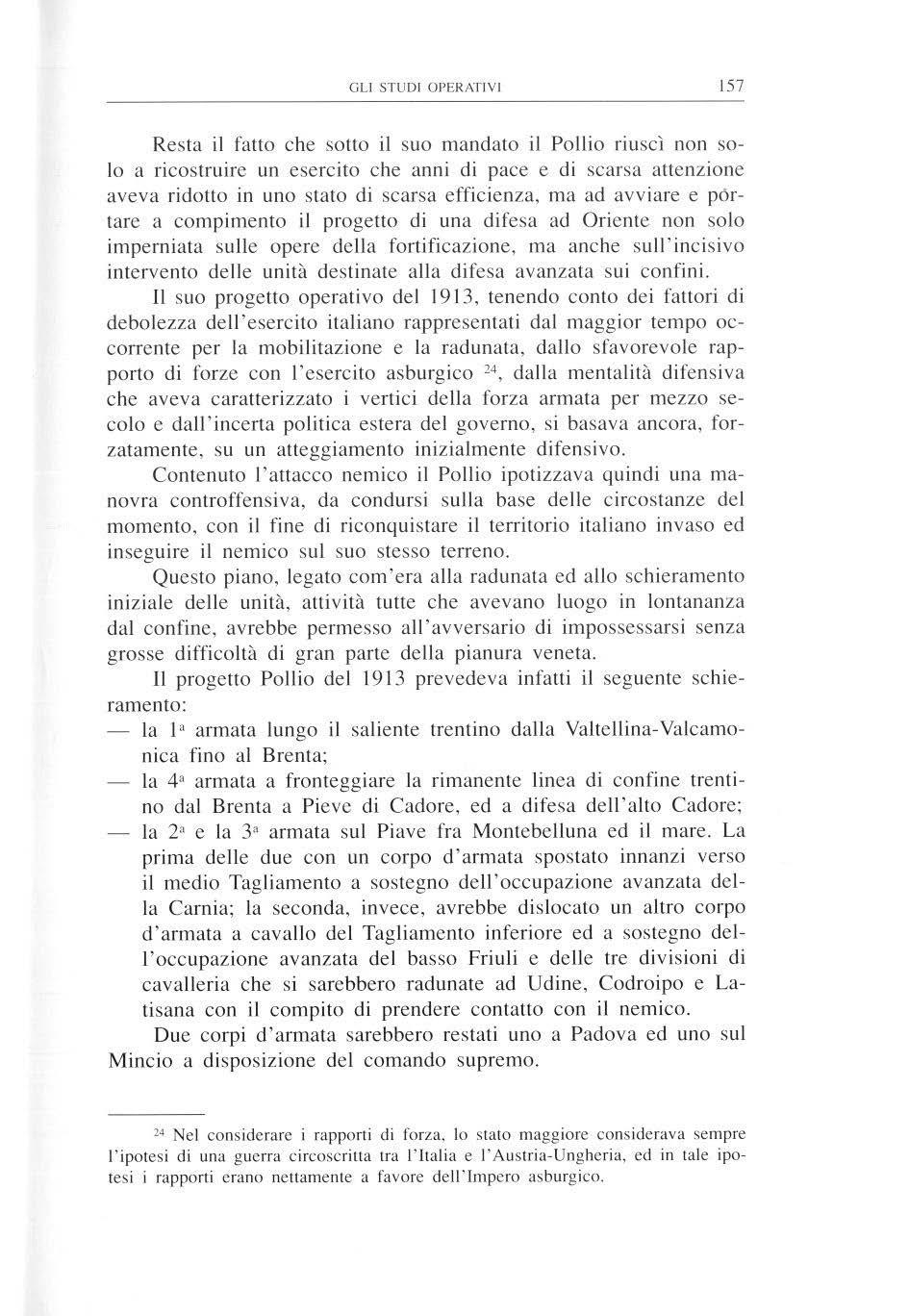
Questo piano, legato com 'era alla radunata ccl allo schieramento ini z iale delle unità, att.ività tutte che avevano luogo in lontananza dal confine, avrebbe permesso all'avversario cli impossessarsi senza grosse difficoltà cli gran parte della pianura veneta.
Il progetto Pollio del 1913 prevedeva infatti il seguente schieramento:
la Ja armata lungo i I sali ente trentino dalla Valtellina-Valcamonica fino al Brenta;
la 4 • armata a fronteggiare la rimanente linea cli confine trentino da l Brenta a Pieve di Cadore , ed a difesa dell'alto Cadore;
la 2 a e la 3• annata sul Piave fra Montebelluna ed il mare. La prima delle due con un corpo d'annata spostato innanzi verso il medio Tagliamento a sostegno dell ' occupazione avanzata della Carnia; la seconda, invece, avrebbe dislocato un altro corpo cl ' armata a cavallo del Tagliamento inferiore ed a sostegno clel1'occupazione avanzata del basso Friuli e delle tre divisioni cli cavalleria che si sarebbero radunate ad Udi ne, Codroipo e Latisana con il comp ito di prendere contatto con il nemico.
Due corpi cl' armata sarebbero restati uno a P adova ed uno sul Mincio a disposizione del comando supremo.
4 Nel cons id era re i rapporti di forza. lo stato maggiore cons id erava sempre l'ipotesi di una guer ra c ircosc rill a tra l ' Italia e l ' Au s tria-Un g heria , ed in tale ipotes i i rapporti erano ne ttamente a favore dell'Impero asburg ico.
Il Pollio prevedev a anche un co rp o d 'a rmat a e d una divisione per la difesa del te rritori o da sbarc hi dal mare e la costituzione di un corpo d 'osse rvazi o ne lun go la frontiera svizzera.
La difesa si sa rebbe, di consegue nz a, rea liz zata sulla linea montana ci e l confine con il Trentino e su l Pi ave, a meno che la resis te nza delle truppe in occupazione avana,ta e dell e forteuc del Tag li amento non avessero dato tempo e modo al g rosso delle for1e di g iung ere dal Piave al Tagliamento.
Ques to progetto, pur essendo ancora vinco lato ad una v is ion e difensivistica. introdu ceva un e lem e nto di novi tà rappresentato se non da un 'immediat a offensiva, almeno da una più rapida controffensiva.
Questa possibilità ern offerta, co m e abbiamo visto, dalle o pere fortificate. vo lut e dal capo di stato maggiore, che erano in grado di re nd e re più difficil e un 'av an za ta austriaca ne l Friuli e che. se sosten ut e d a un 'att iva e fo rt e difesa mobil e, avrebbe ro conse ntit o l 'a rriv o dei g ro ss i s ul Tag li amento prima che qu es ti cadesse in mano nemica.
In virt ù di questo progetto il ge nera le Po lli o fu in grado di compilare le Norme ge n erali per /' impi ego delle Grandi U nirà di guerra 25 del l 9 13, ispirate ad un conce tt o t a tti ca m en te o ffensivo.
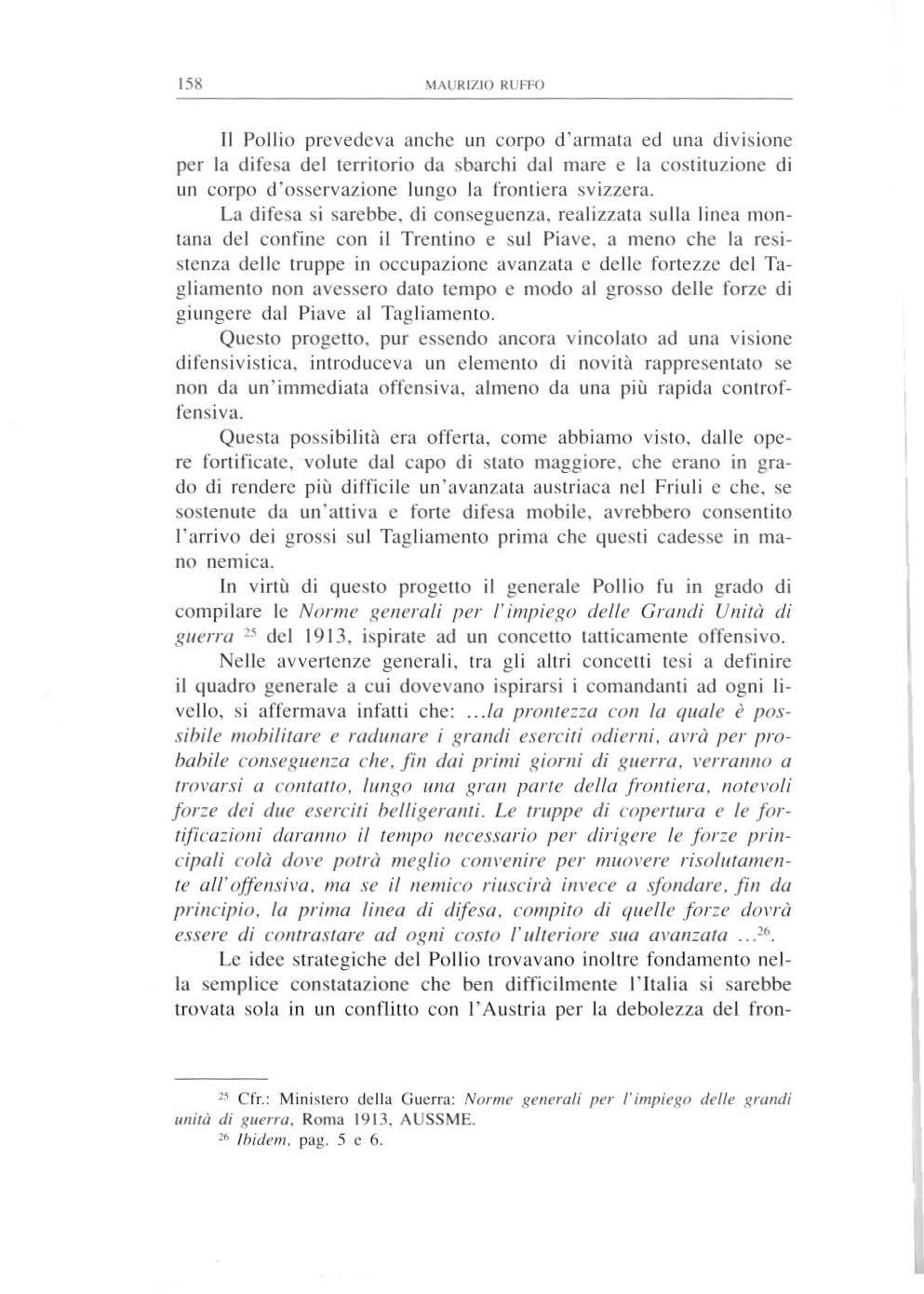
Nelle avvertenze generali. tra g li altri co n celli tesi a definire il quadro ge nera le a cu i dovevano ispirarsi i comandan ti ad og ni livello, s i affe rmava infatti che: la pro11te::a con la quale è possibile mobilitare e radunare i gra ndi eserciti odie rni , avrà p e r probabile conseP, u en:a che. fin dai primi giorni di guerra, ,·erra,1110 a trovarsi a co ntaffo, lun go una gran parte della ji-ontiera, not e ,,oli for:e dei due eserciti belligera111i. Le truppe di copertura e le forrifica z io 11i daranno il tempo n ecessa rio per diri ge re le for:e principali colà do,·e potrà 111eglio com·enire per m11m·ere risolutamente al/'ojfe 11 s iva. ma se il nemico riuscirà in1 ·ece a sfondare. fin da principio, la prima linea di difesa. co111piro di quelle for :e dmTà essere di con tra s tare ad ogni costo /' ult eriore sua a1 ·an:ara ... 2".
L e idee s trategi c he de l Pollio trovavano inoltre fondamento nella e mplice c on s tata z ion e che ben diffi c ilm e nte l ' I talia s i sa re bbe trovata s o la in un conflitto con l'Au s tria per la d e bol ezza del fron-
25 C fr.: M ini s1ero del la Gue rra: Norme ie 11 era/i per /' impiego delle grandi 1111ità di guerra, Roma 1913, AUSSME.
26 lhidem , pag. 5 e 6.
te interno cieli ' Imp ero danubiano che , oltre a confinare con sette stati diversi e per lo più ostili, doveva fare i conti con il rifiorire dei sentimenti irredentisti delle popolazioni ad esso appartenenti e che, in caso di conflitto. non avrebbero certo manifestato quell 'attaccamento alle sorti della duplice monarchia che qualcuno ipotizzava.
li dibattito sulle operazioni da co ndurre co ntro l'Austria non vide un 'attivazione. in prima persona , dei comandanti della 1" e della 4" armata per il ruolo più limitato a cui sarebbero state chiamate le due grandi unità.
Tale ruolo consisteva, sostanzialmente , nel limitarsi ad adottare un atteggiamento offensivo che permettesse di attirare, nei settori di loro competenza, più forze avversarie possibile distogliendole dal settore dell'Isonzo agevolante , in tale modo , il compito principale affidato alla 2• ed alla 3" armata.
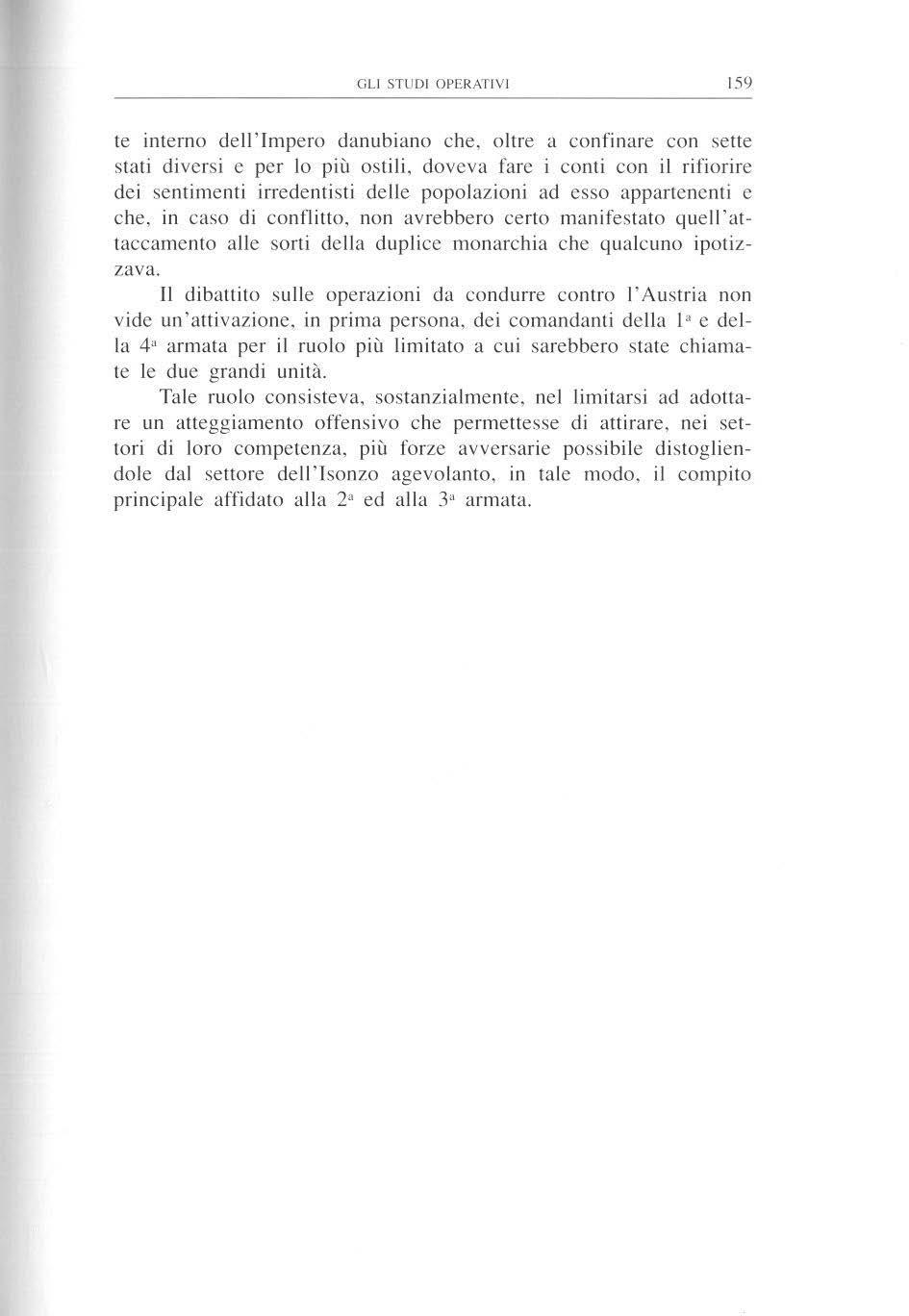
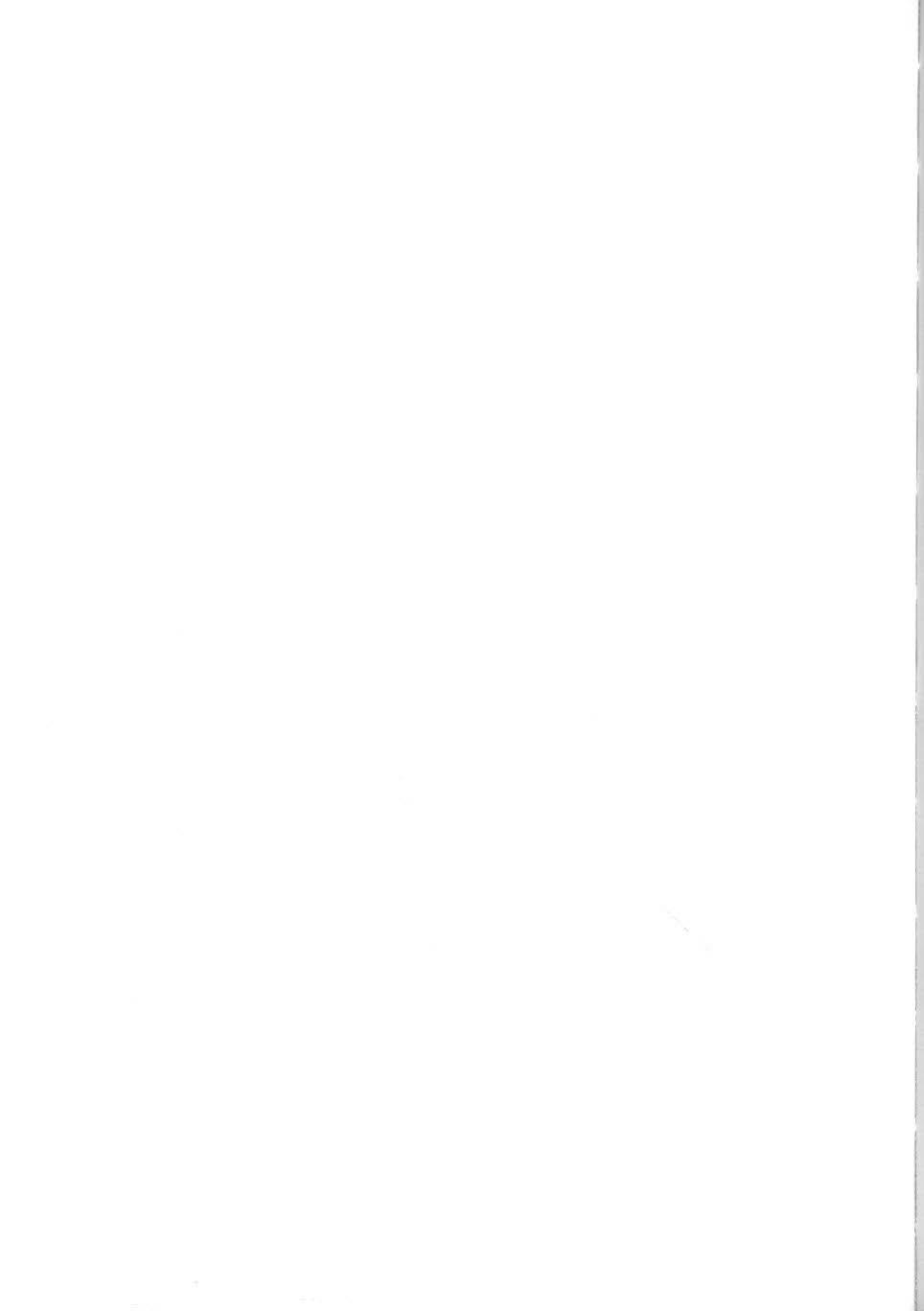
Quando il 27 luglio 1914 il tenente generale Luigi Cadorna venne chiamato ad assumere la carica cli capo cli stato maggiore, lasciata vacante dati ' improvvisa morte ciel tenente generale Pollio sopraggiunta il l O luglio , l'Austria-Ungheria gi~t aveva lanciato l 'ultimatum alla Serbia, innescando quella reazione a catena che portò alla deflagrazione della guerra.
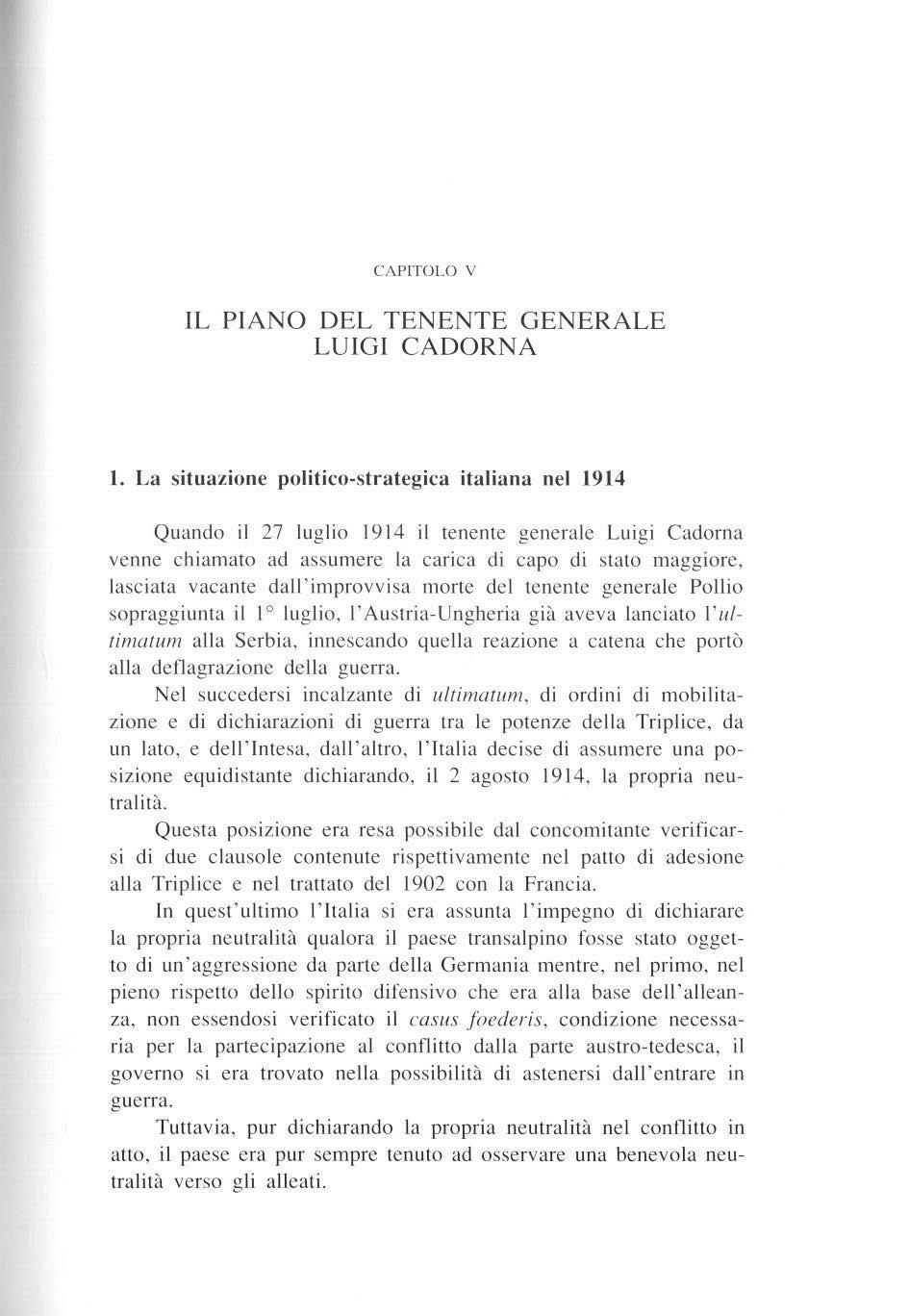
Nel succedersi incalzante di ultimarum, di ordini di mobilitazione e di dichiarazioni di gue rra tra le potenze della Triplice, da un lato, e dell'Intesa, dall ' altro, l ' Italia decise di assumere una posizione equidista nt e dichiarando, il 2 agosto J 9 I 4 , la propria neutralità.
Questa posizione era resa possibile dal concomitante verificarsi di due clausole contenute rispettivamente nel patto cli adesione alla Triplice e nel trattato ciel 1902 con la Francia.
ln quest'ultimo l'Italia si era assun ta l ' impegno di dichiarare la propria neutralità qualora il paese transalpino fosse stato oggetto di un 'aggressione eia parte della Germania mentre, nel primo, nel pieno rispetto dello spirito difensivo c he era alla base dell'alleanza, non essendosi verificato il casus foecleris , condizione necessaria per la partecipazione al conflitto dalla parte austro -tedesca, il governo si era trovato nel la possibilità di astenersi dall'entrare in g uerra.
Tuttavia, pur dichiarando la propria neutralità ne l conflitto in atto, il paese era pur sempre tenuto ad osservare una benevola neutralità verso g li alleati.
Ques ta si tuazione politica rappresentò quel periodo di grande incerte zza nella qual e s i venne a trovare lo stato ma ggio re italiano nel pred is porre tulle quel le misure, di carattere organizzativo. finanziario ed operativo, che fossero in g rado di m ette re il paese al s icuro da eve ntuali azioni militari da parte di altre potenze
È qui nece ssa rio so ttolineare come il generale Cadorna, con una lettera indirizzata al mini s tro della guerra il 29 luglio 1• avvertisse la neces s ità di segna lare i provvedimen ti più importanti d a adottare per porre l 'eserc ito nelle condizioni di fronte gg iare, nel modo migliore. l 'eve ntualità che la Francia, seppur impegnata quasi totalmente nella decisiva lotta sul Reno , attuasse dei parz iali atti di offensiva tallica , tendenti all'acqui s izio ne di alcune posizioni nel territorio italiano che riv es tivano un alto valore tattico e s trategico .
Tra qu es ti s piccano , per le conseguenze che avrebb ero potuto cornpore per la sicurezza ad E s t , l 'inizia le invio delle truppe alpine , di s locate s u ambo le fronti ere, a svolge re le escursioni est iv e verso le te s tat e d e lle valli de l confine occidentale e, in un seco ndo tempo , s u autorizzazione del mini stro della guerra, l'imme diat a attuazione dei tra s porti d e i materiali d'artiglieria dalla frontiera NordEst a qu e lla Nor d-Ovest per completare l'armam e nto d e lle fortezze di que s t ' ultima.
La s ituazione politico-st rateg ic a europea, nel fratt e mpo. era in via di profondo mutamento e la decisione italian a aveva pro voca to nelle due potenze alleate un clima di delusione e diffide nza verso l ' Italia tali c he in Austria. dove l'avv ers ione e ra più manifesta, si ipoti zzava la possibilità di prende re l'iniziativa. con una deci sa azione offensiva, contro "l'alleata infede le".
Non solo, ma il c lim a già di per se s te sso teso, s i venne sempre più deteriorando sia per le richie s te italiane di compensi inoltrate alr Austria in seg uito alla sua espansione verso oriente, come era contemplato nei trattati d e lla Triplice , s ia p e r la crescente mobilitazione interna per una guerra che portasse a compimento i sogni e le a s pirazioni irredentistiche che erano s tat e la base del Risorgimento.
In questo stato di incertez za del governo e di crescente ostiI ità da parte delle nazioni a l leate, il Cadorna si trovò ad organizzare l 'ese rcito predi s ponendo i piani operati v i, il completamento deg li uomini e dei materiali, il supporto logi s tico.
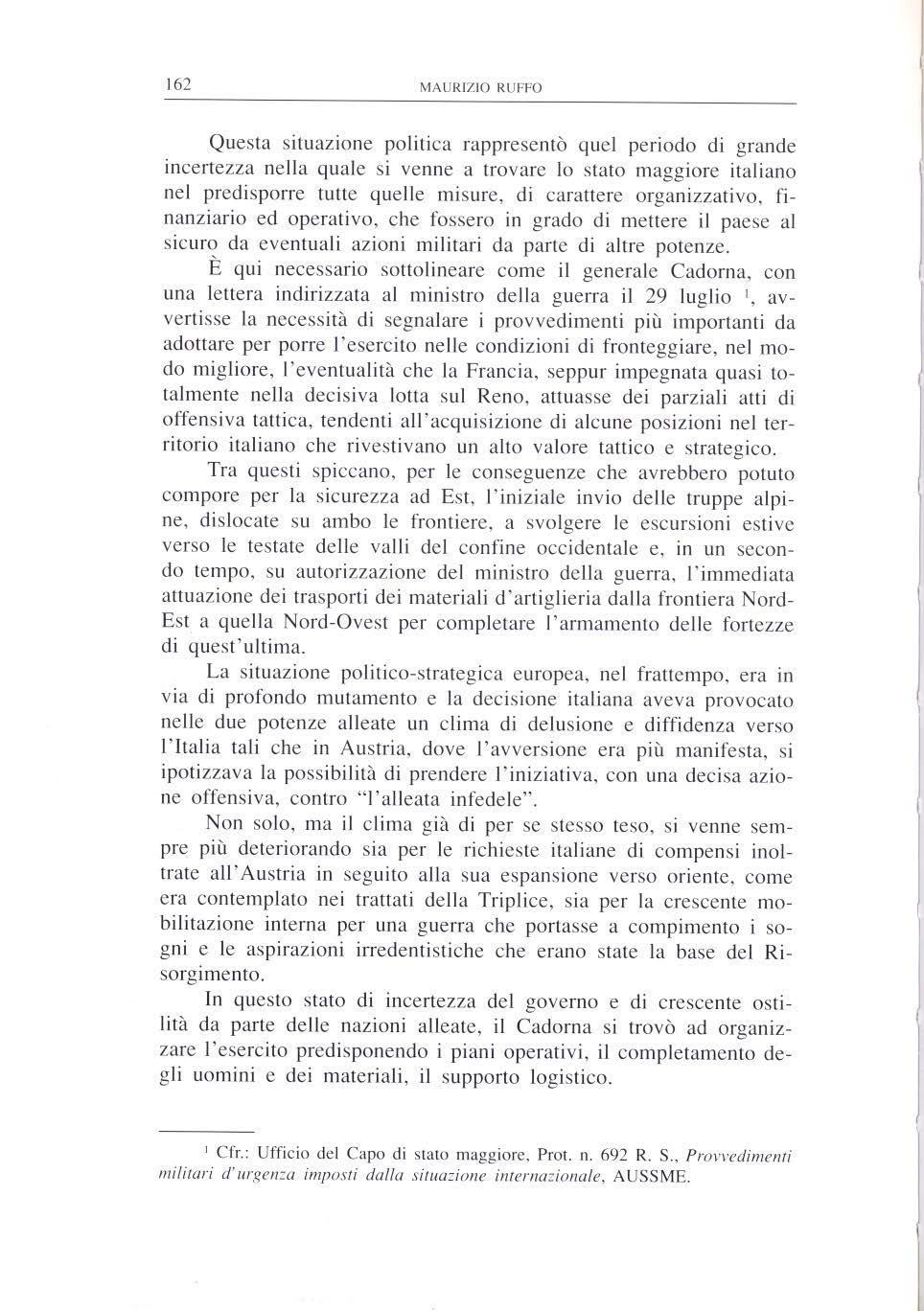
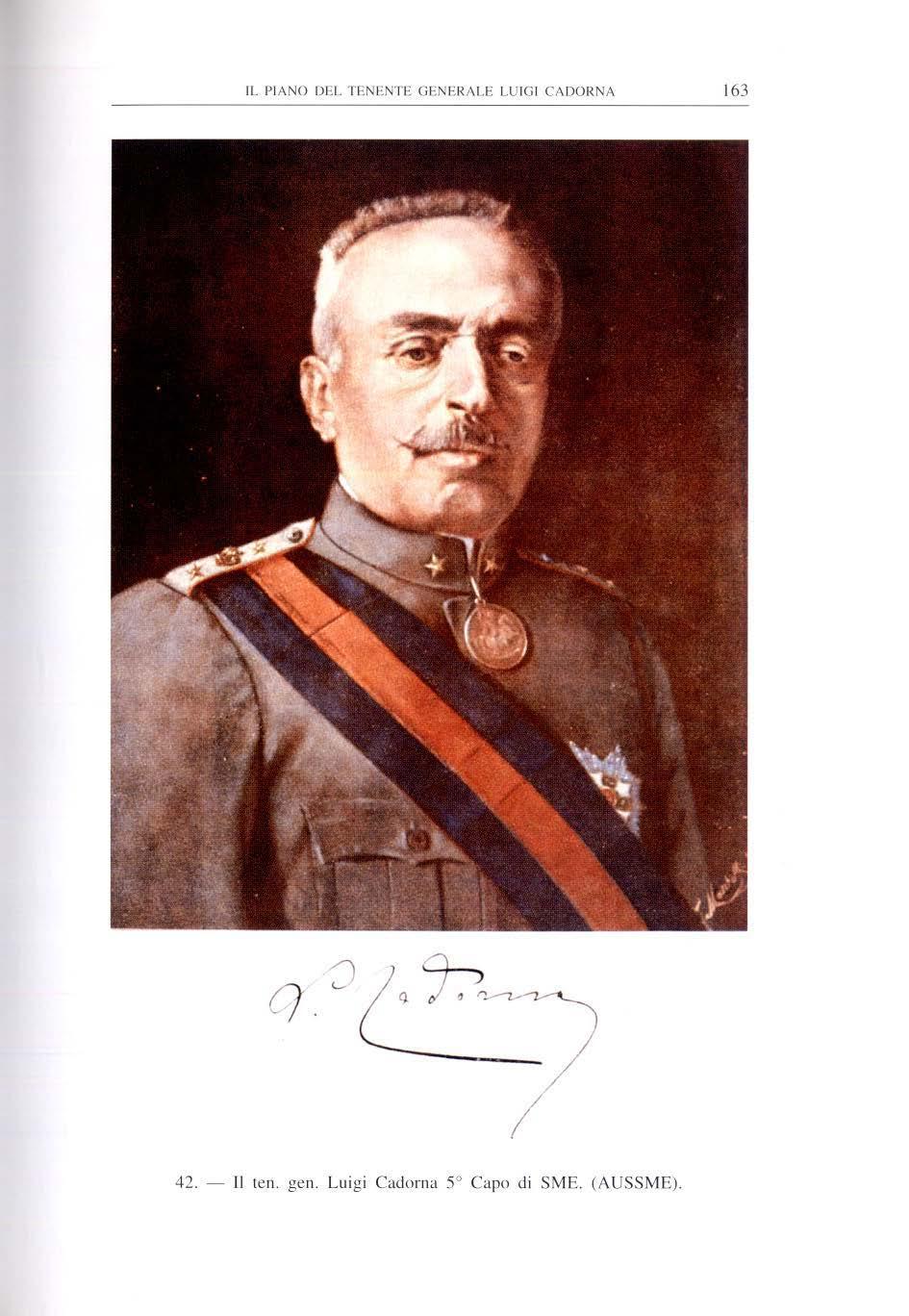
La situazione politica internazionale, che si prospettò al generale Cadorna nell'estate del 1914, era quindi mutata dopo la dichiarazione cli neutralità e la presa di coscienza che, in caso cli partecipazione al conflitto, l'avversaria eia frontegg iare sarebbe stata l'Austria-Ungheria.
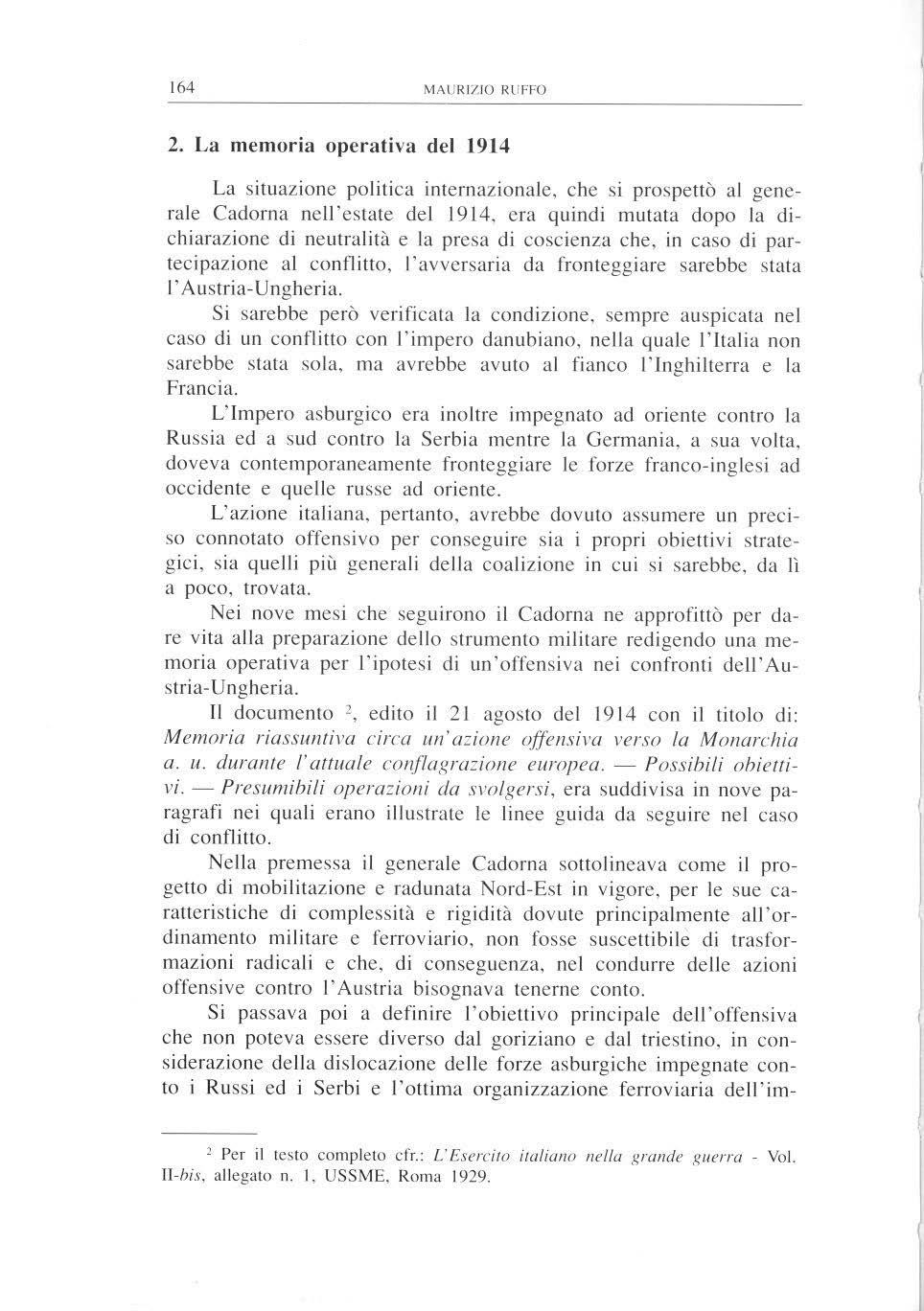
Si sarebbe però verificata la condizione, sempre auspicata nel caso cli un conflitto con l 'impero danubiano, nella quale l'Italia non sarebbe stata sola, ma avrebbe avuto al fianco l'Inghilterra e la Francia.
L'Impero asburgico era inoltre impegnato ad oriente contro la Ru ssia ed a s ud contro la Serbia mentre la Germania , a sua volta, doveva contemporaneamente fronteggiare le forze franco-inglesi ad occidente e quelle rus se ad oriente.
L'azione italiana, pertanto, avrebbe dovuto assumere un preciso connotato offensivo per conseguire sia i propri obiettivi stra tegici, sia quelli più generali della coalizione in cui si sarebbe, eia lì a poco, trovata.
Nei nove mesi che seguirono il Caclorna ne approfittò per dare vita al la preparazione del lo strumen to mi lit are redigendo una memoria operativa per l'ipotesi cli un 'offensiva nei confronti del!' Austria-Ungheria.
Il documento 2 , edito il 21 agosto del I 914 con il titolo di: Memoria riassunti1'a cirra un'a:ione offensiva verso la Monarchia a. u. durante l'attuale co,!flagrazione europea. - Possibili obiettivi. - Presumibili opera:ioni da Sl'olgersi, era s uddivi sa in nove paragrafi nei quali erano illustrate le linee guida da seguire nel caso di conflitto.
Nella premessa il generale Cadorna sottolineava come il progetto cli mobilitazione e rad un ata Nord-Est in vigore, per le sue caratteris tich e d i complessità e rigidità dovute principalmente all'ordinamento militare e fe rro via ri o, non fosse suscettibi le di trasformazio ni radicali e che, cli conseguenza , nel cond urre delle azioni offens ive contro l'Austria bisognava tenerne conto.
Si passava poi a definire l'obiettivo principale dell 'o ffensiva c he non poteva essere diverso dal goriziano e dal triestino, in cons id erazione della dis locazione delle forze asburgiche impegnate conto i Russi ed i Serbi e l'ottima o rga ni zzaz ione ferroviaria dell'im-
2 Per il testo comp leto cfr.: L" Esercito italian o nella grande f?uerra - Vo i. II -bis, allegato n. I. USSME, Rorna I 929.
pero asburgico, in grado di far affluire rapidamente il proprio esercito sulla frontiera aperta del Friuli.
Come obiettivo secondario si indicava il Trentino, subordinando l'azione all'efficienza delle difesa e, soprattutto al principio cli non disperdere forze in più obiettivi contemporanei.
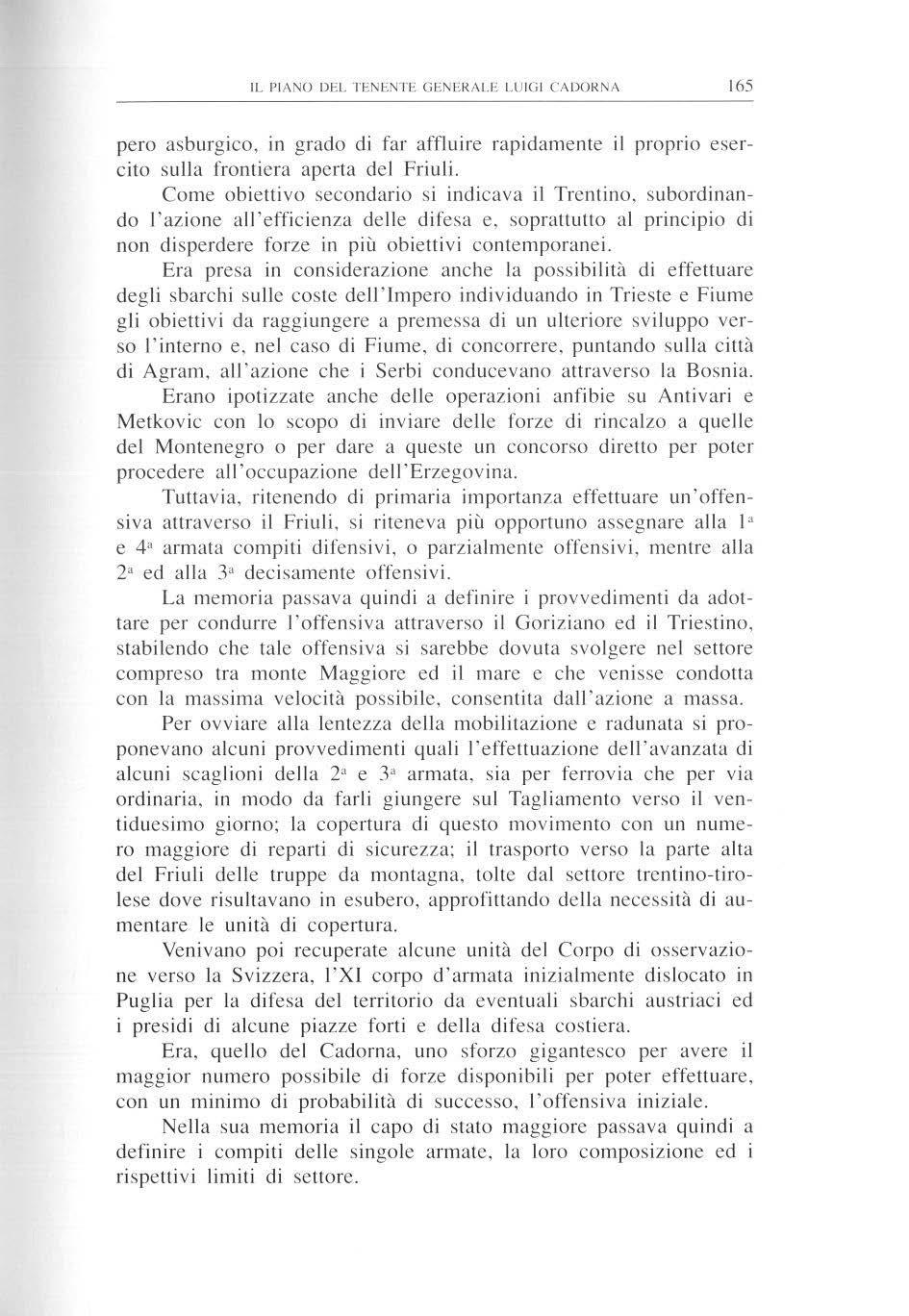
Era presa in considerazione anche la possibi lità di effettuare degli sbarchi sulle coste dell ' lmpero individuando in Trieste e Fiume gl i obiettivi da raggiungere a premessa di un ulteriore sviluppo verso l ' interno e , nel caso di Fiume, di concorre re. puntando sulla città di Agram. ali ' azione che i Serbi conducevano attraverso la Bosnia.
Erano ipotizzate anche delle operazioni anfibie s u Antivari e Metkovic con lo scopo di inviare delle forze di rincalzo a quelle del Montenegro o per dare a queste un concorso diretto per poter procedere al l'occupazione del l'Erzegovina.
Tuttavia, ritenendo di primaria importanza effettuare un'offensiva attraverso il Friuli , s i riteneva più opportuno as s egnare a ll a I " e 4" armata compiti dife nsivi, o parzialmente offen s ivi, mentre alla 2• ed alla 3" decisamente offensivi.
La memoria pass ava quindi a definire i provvedimenti da adottare per condurre l'offensiva attraverso il Goriziano ed il Triestino, stabilendo che tale offensiva si sarebbe dovuta svolgere nel settore compreso tra monte Maggiore ed il mare e che venisse condotta con la massima velocità po s sibile, consentita dall'azione a ma ss a.
Per ovvia re alla len tezza della mobilitazione e radunata si proponevano alcuni provvedimenti qu a li l 'effettuaz ion e dell'avanzata di alcuni scag li o ni della 2" e 3• armata. sia per ferrovia che per v ia ordinaria, in modo da farli g iun gere su l Ta g liam ento verso il ventiduesimo giorno ; la copertura di questo movimento con un numero maggiore cli reparti di sicurezza; il tra s porto verso la parte alta ciel Friuli de ll e truppe da montagna , tolte dal settore trentino-tiroles e dove ri s ulta va no in es ub ero, approfittando della necessità di aum enta re le unità di copertura.
Venivano poi recuperate a lcune unità del Corpo di osservaz ione verso la Svizzera, !'X l corpo d ' armata inizialmente dislocato in Pu g lia per la difesa del te rritorio da even tu al i sbarchi austriaci ed i presidi di alcune piazze forti e de ll a difesa costiera.
Era, quello del Cadorna, uno sforzo giga nt esco per avere il maggior numero possibile di forze disponibili per poter effettuare, con un minimo di probabilità di s uccesso , l'offensiva iniziale.
Nella s ua memoria il capo di s tato maggiore passava quindi a definire i compiti delle singo le armate, la lo ro composizione ed i rispettivi limiti di se tt ore.
In particolare asseg na va a lla I • armata. sc hi era t a dallo Ste lvio al mont e L isser ( in c lu so), un co mpito di ca ratt e re difensivo co n la possibilità di co ndurre piccol e azioni offensive che avessero lo scopo di mi g liorare la difesa de i co nfini; la 4 a armata. il cui sc uore andava dal mont e Lisser (esc lu so) al monte Peralba . av rebbe dovuto, qual ora le c ircos tanze lo avessero co ns igliato, ag ire offcnsivamenLe dall'alto Piav e verso la val Pus teria con il fine s ia di ta g liare le comunicazioni d e l Tirolo co n il re s to dcli' Imp ero. s ia pe r co ncorre re ad eve ntuali operazioni offe nsi ve d e ll e trupp e della Carnia ve rso Tarv bio; alla 2·' cd alla 3·1 armata, sc hierate la prima dal mont e Maggior e (esclu s o) a Prepott o (s ul torr e nte Judrio) e la seco nda da que s to al mare, era affidato il compito di condurre l'offen s iva vero il cuore dctrAustria-Ungheria; il tratto dal mont e Pe ralba al m o nte Ma ggio re era affidato ad un coman dant e dip e nd e nte dire tt a m e nte dal comando s upremo.
Il primo obie tli vo della 2" e 3• armata e ra la conq ui s ta della linea de l 1· Is onzo cd in particolare il possesso delle alture de l K olovrat e del Co g li o, qui, se occo rreva, bisognava attestarsi a difesa per res istere ad e ve ntuali ritorni offensivi nemici.
Se poi le forze co n le quali era s ta ta raggiunta la lin ea dell' Iso nzo no n fossero risultate s ufficienti per co ntinu a re l'offens iva, bisog nava sos tare su ll e posizi o ni in attesa dell'arriv o dei gross i, dopo di c he le due armate avreb bero dovuto riprend ere l'avanzata verso la Sava puntand o s ulle conc he cli Krainburg e Lubiana.
La m e moria opera ti va acce nna va a nc he alla proba bilità c he. durante lo svo lgiment o di qu es ta seconda o ffensiva i I nemico, pe r contrastare efficacemen te l 'avanza ta italiana, avrebbe potuto irrigidire la dife s a , in un primo temp o, lungo I· o rlo occidentale della frattura d e ll' Idria, quindi lungo qu e lla de l Yipacco .
li Cadoma fa ceva poi rife riment o alle opera.doni da co ndurre contro il forte cli Malborghetto e le opere di Pred ii e di Flit sc h la c ui espugnazione. come lui s tesso afferm a .. . era lll'Cessaria per impadronirsi del nodo di Ta l'l'is: il posse .\so di q11es10 nodo .wradale a,·rehbe assirurato il fianco sinistro del nostro sc ltierame111 0 s ulla Sava, e sarehhe sra10 il primo passo per m •a,rzare nella conca di \lillaclt 1. ..
Sulla base di que s ta m e moria il co mando sup re mo provvide a definire lo schieramento che l 'ese rcito mobilitato avrebb e dovuto assumer e, in partico lare ess o fu così ar ti co lato:
\ Cfr.: Luigi CADO RNA, La guerra alla fronte irafia11a, voi. I, pag. 96. Frate lli Trevc,, Editori. Milano 192 1.
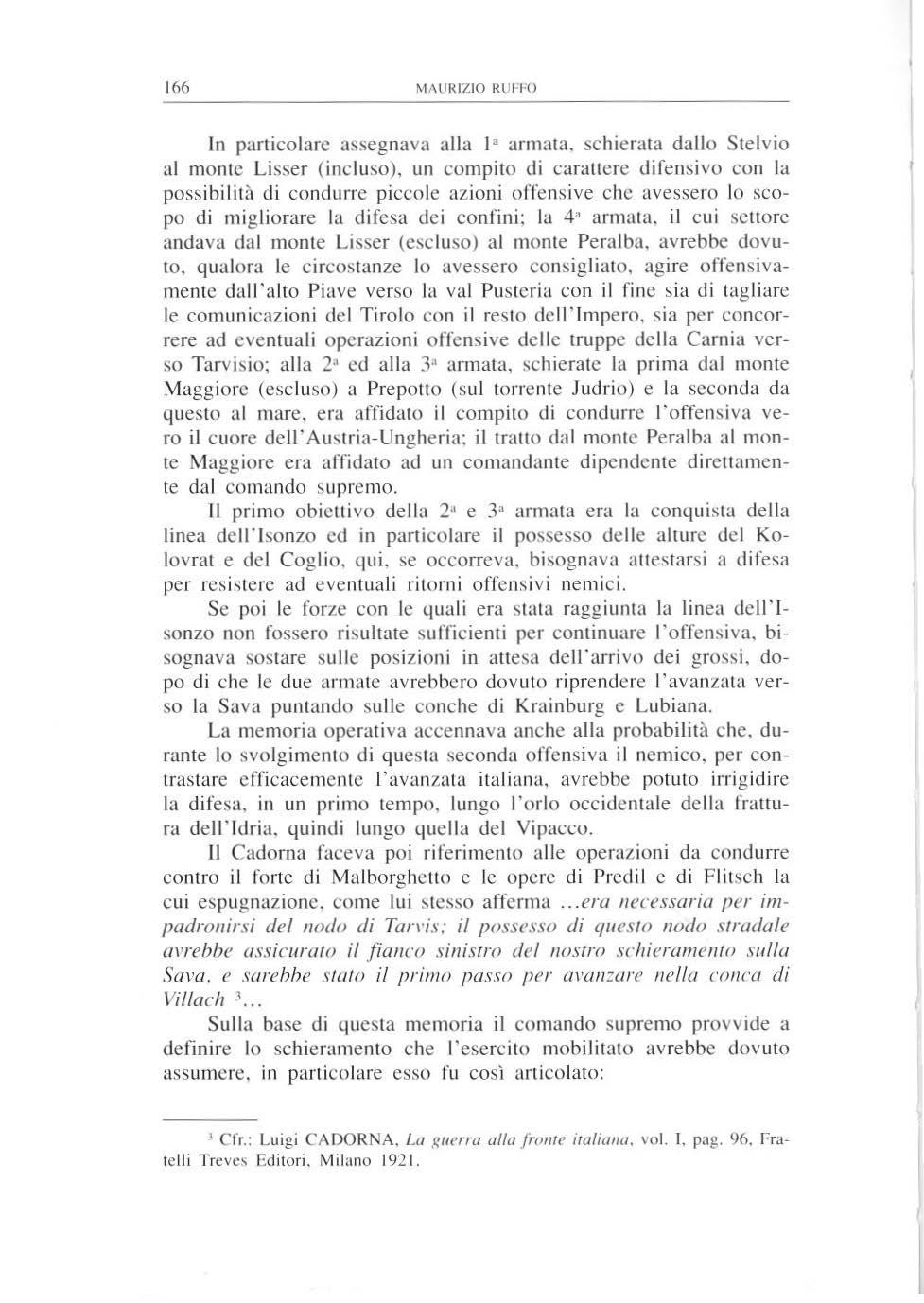
l3 armata: (due corpi d ' armata ed una divi sione) s ulla fronte tridentina dallo Stelvio a valle Cismon compresa;
4• armata: (due corpi d 'a rmata) nel Cadore; Corpo della Carnia: (un corpo d ' armata e sedici batlaglioni alpini) da l Cadore al monte Maggiore;
2• armata: (tre corpi d'armata ) dalla monte Maggior e alla strada Co rmon s-Go ri zia compresa;
3• armata: ( tre corpi d'armata) dalla destra de l la 2 • armata al mare;
riserva: (due corpi d'armata di tre divi s ioni di milizia mobile ciascuno) tra Verona e Desenza no , più una divi sione dell'esercito permanen te a Bassa no.
La m e moria operativa d e l genera le Cadorna stabiliva, quindi. di prendere s ubito e con decision e l ' iniziativa contro l 'A ustria-Ungheria, disponendo quallordici divi sio ni lungo i 500 km. di fronte dallo Stelvio alla Carnia, quattordi c i s ui 90 km. ci rca del fronte principale , rappresentato dall' I sonzo, e sette in ris e rva , orientate al concorso d e ll'offens iva principal e .
Il documento terminava con un breve accenno all ' impiego di quelle unità nav a li che fossero sta te poste a sos tegno de ll 'azione dell'e se rcito nei settori costieri di Sagrado e di Basov izza, qu est'ultimo ne l caso in cui si fosse proceduto all'occupazione di quella città.
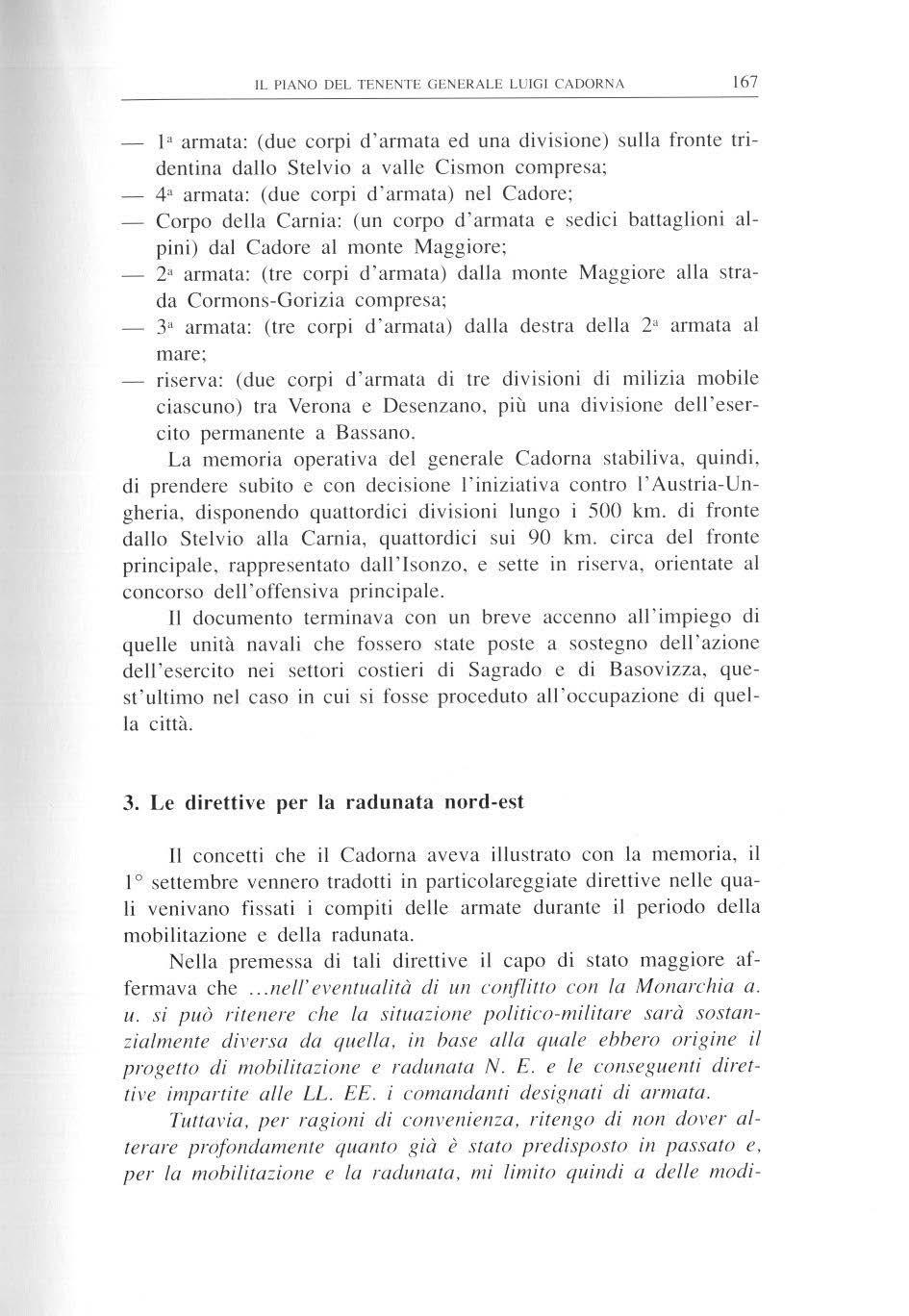
3 . L e dir e tti ve pe r la radun at a n o rd -es t
11 concetti che il Caclorna aveva il lustrato con la memoria, il I O settembre vennero tradotti in particolareggiate direttive nelle quali venivano fissat i i compiti d e lle armate durante il periodo della mob il itaz ione e della radunata.
Nella premessa di tali direttive i I capo cli s tato maggiore affermava che . nel/' evenl ualità di un conflilfo con la Monarch ia a. u. si può rit e n e r e c he la situa z ione politico -militare sarà sos tanzia lm en te diversa da quella , in hase alla quale ebbero orig in e il progeflo di mobilita zione e radunata N . E . e Le conse,quenti direttive impartite alle LL. EE. i coma ndanti des ignati di armata
1imavia, p er ra g ioni di convenien:o, ritengo di non dol'er alt era re profondament e quanto g ià è stato predispo s to in passato e, per la m ob ilita zione e la radunata, mi limit o quindi a d e ll e modi -
Il Cadorna s i e ra reso co nto che per attuare il suo concetto d'azion e e ra nece ssa rio ri vedere alcune predisposizioni per accelerare il più poss ibil e la radun a la e lo sc hieramento dell'esercito c h e, alla frontiera orientale, era anco ra pesantemente condiz ionat o dalla precaria si tua zione delle ret e fe rroviaria.
Inoltre egli ten eva conto de l fatto c he nei precedenti piani di mobilit alio ne il presupposto. posto alla base dell'estensione degli s te ssi era c he s ia l'Italia s ia l 'Aus tria -Ung heria mobilitassero contemporan e ament e
Que s to pres upp os to assicurava un ce rto peri o do di s icurezza alle unit à c he a ftlui vano ve r so la frontiera offe rt o dalle presumibili co ntemporane e opera7ioni m esse in atto dall'avversario.
La situaz ion e c he si pre se ntava in quel mom e nt o era tutt avia co mpl e tam e nt e cambiata. l'Au s tri a-U ng her ia aveva già tutto I'ese rc ito mobilit a to e si <,arebbe traltato di trasportarne una parte ne l se ttore più interessa to.
Se quindi l ' Itali a avess e fallo seguire la mobilitazion e alla dic hiara z ion e di g ue rra , l'Austri a, s fruttando l'ottim a organizzazione ferroviaria a s ua disposizione, sarebbe s t ata in g rad o di tra sportare rapidam e nre s ul confine italiano, prele vando le dai fronti russ o e se rbo, delle forze tali eia essere in grado cli prend e re l'iniziativa di c ondurre un 'azione o ffe n s iva in profondità nella pianura veneto-friulana.
P er far fronte a que s ta nuova situazione strategica il ca po di stato maggiore rit e neva necessario sia acce lerare la cos titu zione dei nuclei di co pertura. ri s petto a quanto fin o allora previs to. s ia di a um e ntare le trupp e all'uopo d es tinat e e d in tal e co n1 es10 s i co ncretiz zava l ' idea di trasferire pari e delle unità da monta g na d e lla l • e della 4 ·' armata in Friuli, eq uilibrando in tal mod o le forz e tra il sa liente tr e ntino - tir o lese e le necess ità dell'alto Friuli 5
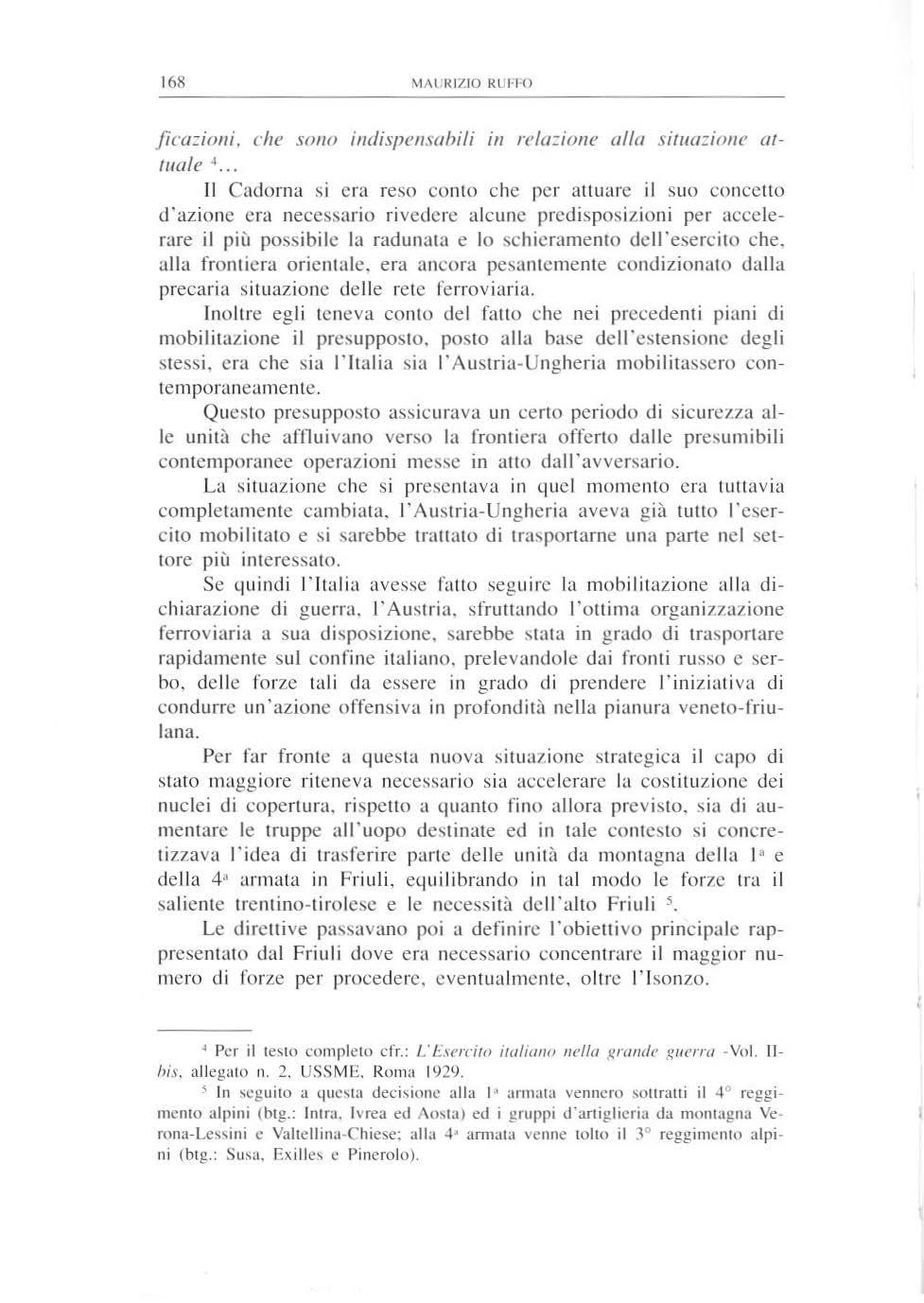
Le dire1tive pa \savan o poi a definire l'obietti vo principal e rappresentalo dal Friuli dove era necessa rio concentrare il mag g ior numero di forze per procedere, eve ntualm e nte, o ltr e l ' Iso nzo.
' Per il 1e, to co mpl eto cfr.: L'l! 1rrci10 i1afio110 nrfla grande guerra - Voi. 11hi s, allegalo n 2, USS M E. Roma 1929.
5 In seguilo a qu e, 1a deci,ione a lla I ' arma la ve nn ero so ttraili il 4 ° reggimento alpini (b1g.: lntra , Iv rea ccl J\o,rn) ed i gruppi d'art iglieria da monta gna Verona-Le,,ini e Vallellina C hi ese: alla 4• am1a1a venne 101!0 il p reggimento alpini (bt g .: Susa. Ex ill e, e Pinerolo).
Come obiettivi suss idiari si assegnavano alla 4 • armata ed alle truppe Carnia rispettivamente la conca di Dobbiaco, donde prosegu ire sia ad Ovest in direzione di Fortezza-Bressanone-Bolzano sia ad Est lungo le valli della Drava e del Gai!, cd il possesso dei forti di Malborghetto, del Predii e di Flitsch, per aprirsi la strada verso Villach e Klagenfurt.
Venivano inoltre date delle disposizioni s ul con tegno da assumere da parte delle armate e delle truppe della Carnia riguardanti la necessità di garantire, ali' inizio del le ost i I ità, l'in violabilità del confine assumendo principalmente un contegno prudente salvo condurre delle azioni offensive lo cali, contro un nemico debolmente assestatovi, in grado di migliorare le possibilità di difesa.
11 documento s i conc lud eva con gli ordini circa l'organizzazione dei co ll egamenti e delle informazioni.
Unitamente a queste disposizioni venivano emanate, con un documento a parte, le norme di co nd otta a cui doveva uniformarsi i I comandante della zona Carnia nell'ipotesi offensiva oltre l'Isonzo.
In esse si s t abiliva che, durante la mobilitazione e radunata , le truppe della zona Carnia avessero compiti di copertura nei confronti di eve ntu ali provenienze da nord, mentre a mobilitazione conclusa, a seconda degli intendimenti del comando s upr emo, esse sarebbero potute essere ch iam ate a concorrere a ll'a zione della 4" arma ta , penetrando nella valle del GaiL o a quella della 2". tendendo all'esp ugnazione del forte di Malborghetto e delle opere fortificate elci Predii e di Flitsch.
Fissato il disegno genera le di come condurre le operazioni ed e manat e le conseguenti direttive, il capo di stato ma ggio re era sempre attento ad ogni possibile variante che potesse incidere sulla co ndotta delle operazioni.
Con il prolun garsi della neutralità e l 'a rri vo della stagione invernal e iI comando s upremo avvertì l a necess ità di pren de re in seria considerazione l ' ipotesi di operazioni da co ndurre in quella s tagione.
Il 15 ottobre, il genera le Cadorna ema nava le varianti alle dirett.ive del I O sette mbr e 6 , ne ll e quali erano presi in esa m e g li adattamenti da assumere nel! 'affron t are una campagna in In verno.
In esse il capo di s tato ma gg iore ril evava come la stag ion e invernale imponesse delle limitazioni a ll e grandi operaz ion i e, in mis ura maggiore, nelle zone più e levate e più aspre , ma osservava an -
<> Pa il 1es10 comp lelo cfr.: C Eserci10 i1alia110 nella grande guerra - Vol. 11 - his, allega to n. 3. USSME. Roma 1929
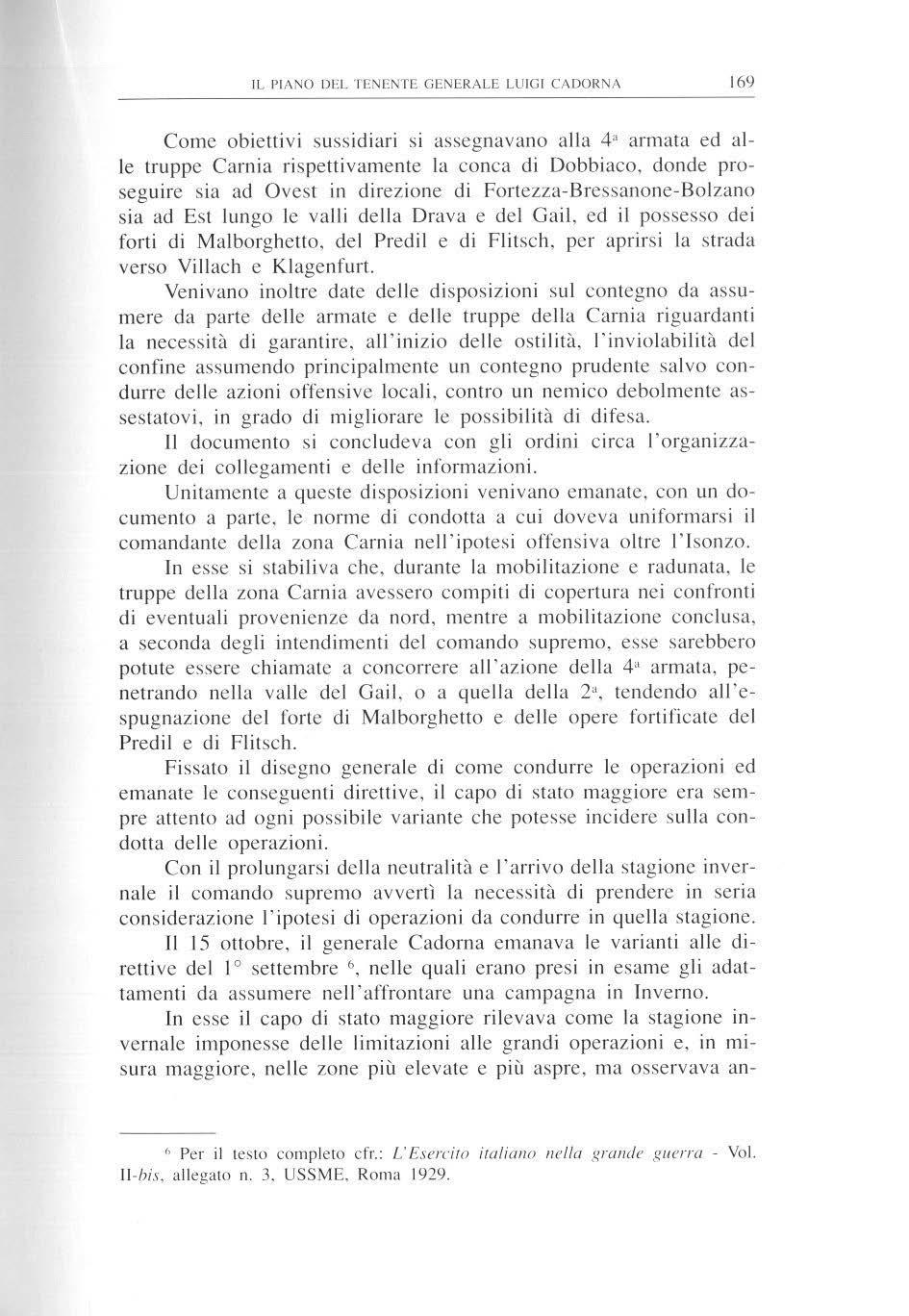
che che .. se però limita le grandi opera:ioni offensire. specie nella :ona alpina pi1ì ele,·ata. come alla base del salienre tirolese, per co ntro facilita ardite imprese parziali di truppe atte alla monragna, tanto pi1ì che, data la situa:ione politico-militare - suppos/a dalle presenti dire11i1·e - le nostre truppe da mo111ag11a od equipaggiate da mo11tag11a 11011 m'ranno di frollfe truppe ugualmente scelfe e soprattu tro prariche dei luogh i
L 'obie ttivo principale. date le sue caratteristiche topografiche. veniva qui ndi ad acquistare maggior importanza grazie alla quasi totale impraticabilità del resto della fronte. più alta cd imperrcorribile in inverno.
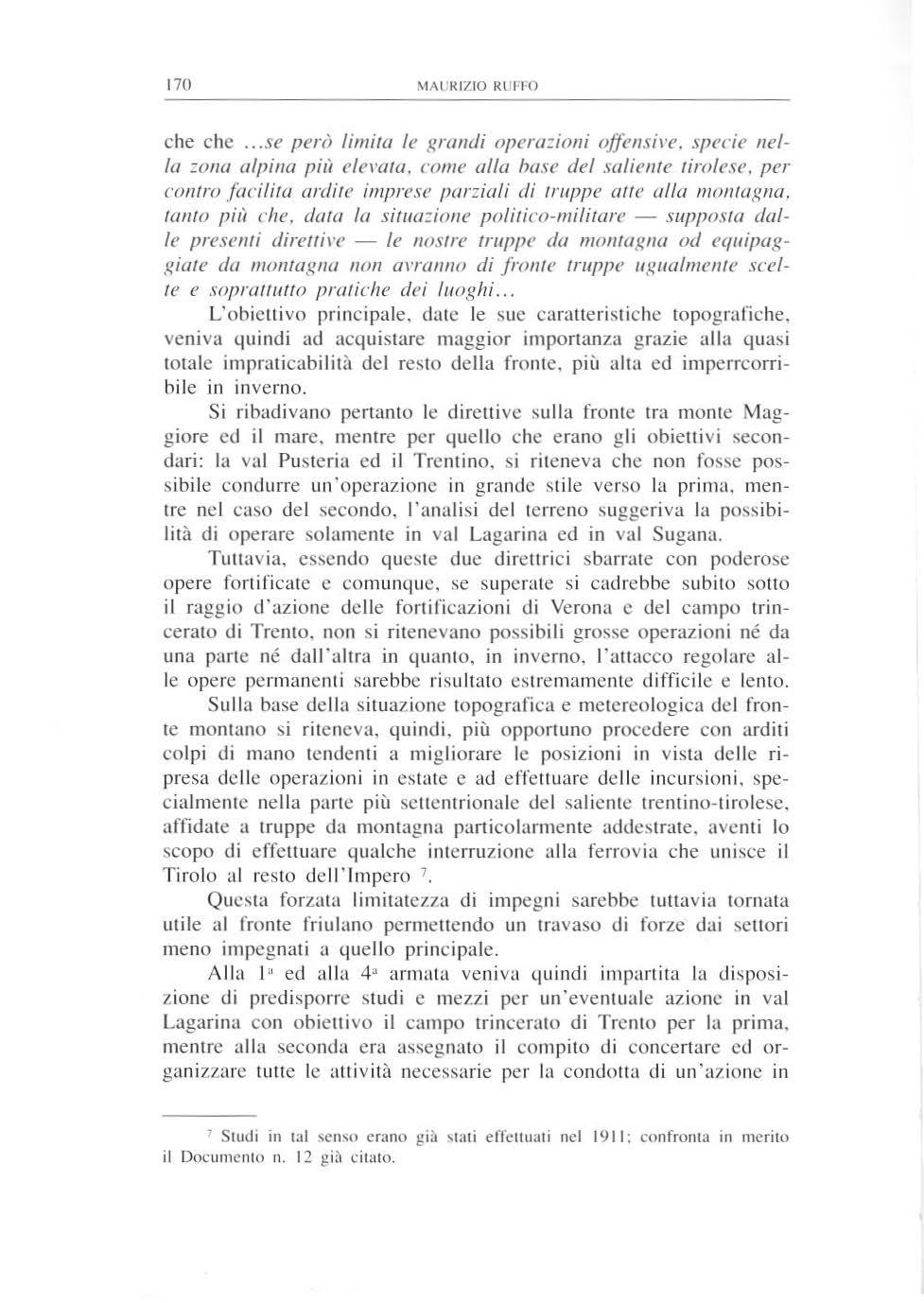
Si ribadivano pertanto le direttive su lla fronte tra monte Maggiore ed il mare. mentre per quello che erano gli obiettivi secondari: la val P usteria ed il Trentino, si riteneva che non fosse possibi le cond urre un 'ope razion e in grande s tile verso la prima, mentre nel caso d e l secondo, l'analisi del terreno suggeriva la possibilità di operare so lamente in val La garina ed in val Sugana.
Tuttavia, essendo queste due direttrici sbarrate con poderose opere for tifi cate e co mun q ue, se superate si cadrebbe s ubito so tto il raggio d'azione delle fortificazioni di Verona e del campo trincerato di Trento. non si ritenevano poss ibili grosse operazioni né da una parte né dall'altra in quanto, in inverno, l 'attacco regolare a lle opere permanenti sa rebbe risultato es tre mament e difficil e e le nto.
Sulla base della si tua z ione topografica e metercologica del fronte montano si riteneva, quindi. più opportuno procedere con arditi colpi di mano tendenti a miglio r are le posizioni in vista delle ripresa d e ll e opera.lioni in es tat e e ad effe ttuare d e ll e in c ursion i, spec ialm ente nella parte più settent ri ona le del saliente trentino-tirolese. affidate a truppe da montagna particolarmente addestrate, aven ti lo scopo di effe ttuare qualche int erruzio ne alla ferrovia che unisce il Tirolo a l resto d e ll ' l mpero 7 •
Questa forzata limitatezza di impegni sarebbe tuttavia tornata utile al fronte friulano permettendo un travaso di forze <lai settori meno impegnati a quello principale.
A ll a I " ed a ll a 4• armata veniva qu indi impart i ta la disposiz ion e di predisporre s tudi e mezzi per un ·eventuale azione in val Lagarina co n obiettivo il campo trincerato di Trento per la prima. mentre alla seconda era assegnato il com pito di conce r tare ccl orga ni zza re tutte le attiv it à necessa ri e pe r la condotta cli un 'az io ne in
- Studi in tal ~enso erano già ,tati effettuati nel 191 I: co nfronta in merito i l Docum e nto n. 12 già citato.
val Sugana e di alcune offensive parziali sia lungo la direttrice MaèCordevole, sia nel Cadore.
L e direttive per la 2a e la 3• armata, emanate il l O settembre, rimanevano invariate.
Al coma ndo zona Carnia era affidato il compito di contrastare tenacemente l 'attacco nemico lun go il tratto di fronte dal monte Peralba al monte Maggiore; inoltre doveva predisporre studi e d isposizioni per l'attacco del forte di Malborghetto e delle opere di Flitsch e del Pred ii.
D oveva a ltresì . . . predisporre per offensive parziali, intese a conquistare i ricoveri alpini costruiti dalla Monarchia oltre confine. e studiare la possibilità di ardite incursioni nella rnlle della Drava, allo scopo di i111errompere la ferrovia di comunica:ione del tiro/o col resto della Monarchia. Studiare il concorso di truppe della zona Carnia. coni•e11ie11temente aumentate. ad e1•entuali op erazioni offensive della 2" e 3" armata oltre /' lson:o, in base a direttive speciali impartite 8 •••
Mente lo stato maggiore emanava 4ueste direttive che avevano lo scopo principale di far fronte a lla si tu azione immediata, con vera lungimiranza, provvedeva a s tud iare tutti qu egli accorgimenti c he, in caso di partecipazione al co nflitt o, avrebbero permesso di evita re rischi di invasione e, nel co nt empo, aume ntat o le poss ibilità di svi luppare un'azione offensiva in territorio asburg ico.
Il 27 gen na io 1915 l'ufficio del ca po di stat o maggiore - mobilitazione -e mana va una c irco lare nella quale erano illustra ti gli eve ntuali provvedimenti da prendere per assicurare m eg lio l 'az ion e difensiva d e ll e trupp e a lla frontiera ne i primi gio rni di mobilitazione.
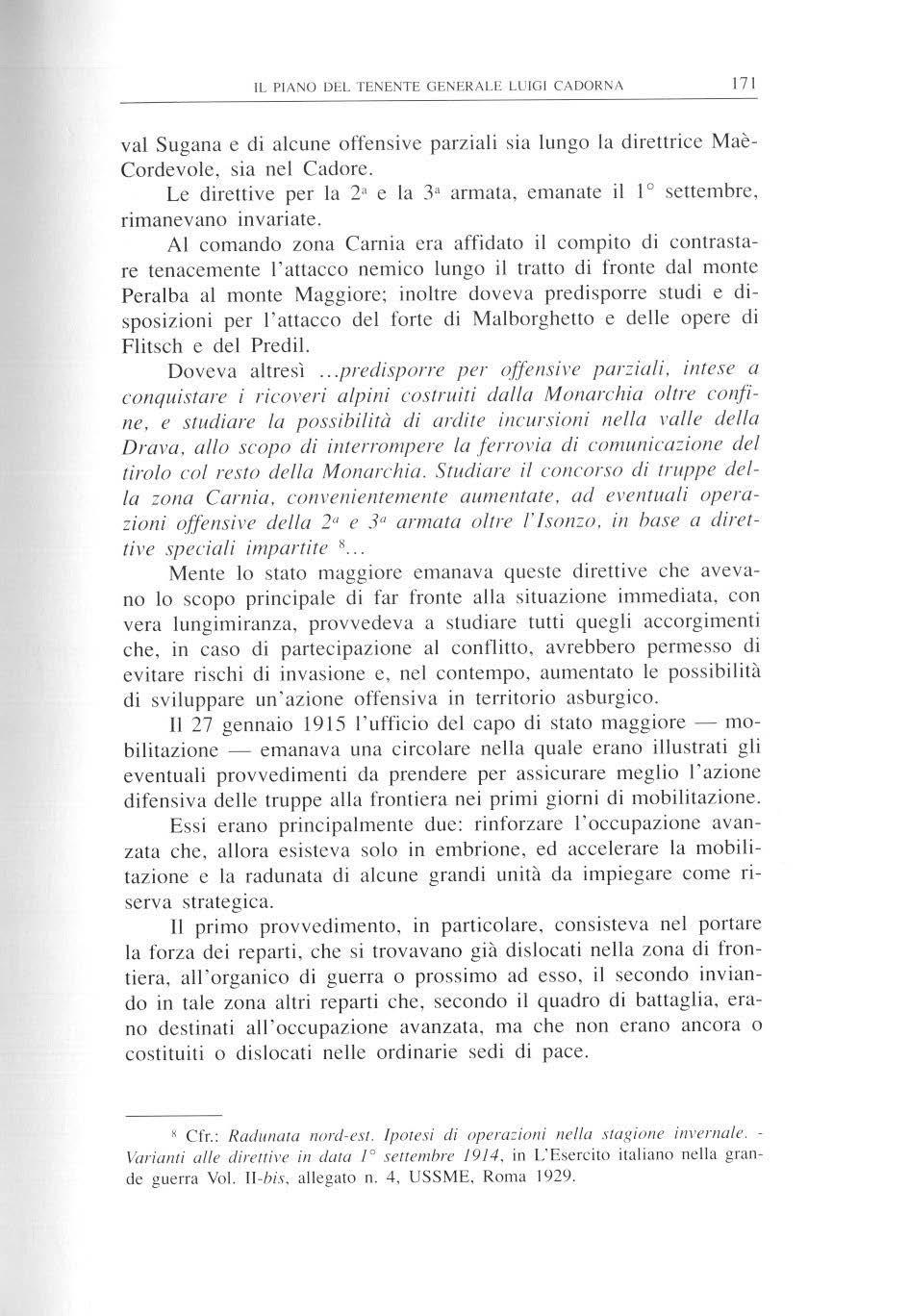
Ess i e rano principalmente due: rinforzare l'occupazione avanzata che, a llora es is teva so lo in embrio ne, ed accelerare la mob ilitazione e la rad unata di alcu ne g randi unit à da impiegare come riserva s trat eg ica .
Il primo provvedimento, in particolare. consisteva ne l portare la forza dei re parti , che si trovavano già dislocati ne ll a zo na di frontiera, all 'o rganico di g ue rra o prossimo ad esso , il secondo inviand o in tale zona altri reparti c he, seco nd o il quadro di battaglia, erano destinati all'occupazione avanzata, ma che non era no ancora o cos tituiti o dislocati nelle ordinarie sedi di pace.
x Cfr.: Rad1111a1a nord-e.1 1. !p o iesi di op era : io11i nella sta i ione i11vema/e.Variami alle d ire 11ive in da1a 1° se 11emhre /914. i n L'Ese rcito ita l ia no nel la grande gue rra Voi. 11 -his. allega to n. 4. USSME, Roma 1929.
Il secondo provvedimento era la logica conseguenza del primo in quanto. esse ndo una parte notevole dei corpi d'armata di frontiera già destinati all'occupa1ione avanzata. il loro completamento ne implicava l'accelerazione della mobilitazione e della radunata.
Il principale prob lema che si poneva ora al ge nerale Cadorna era come ottenere l'a cce lerazione della mobilitazione e della radunata. senza tullavia sconvolgere quanto già pianificato nei piani degli anni precedenti.
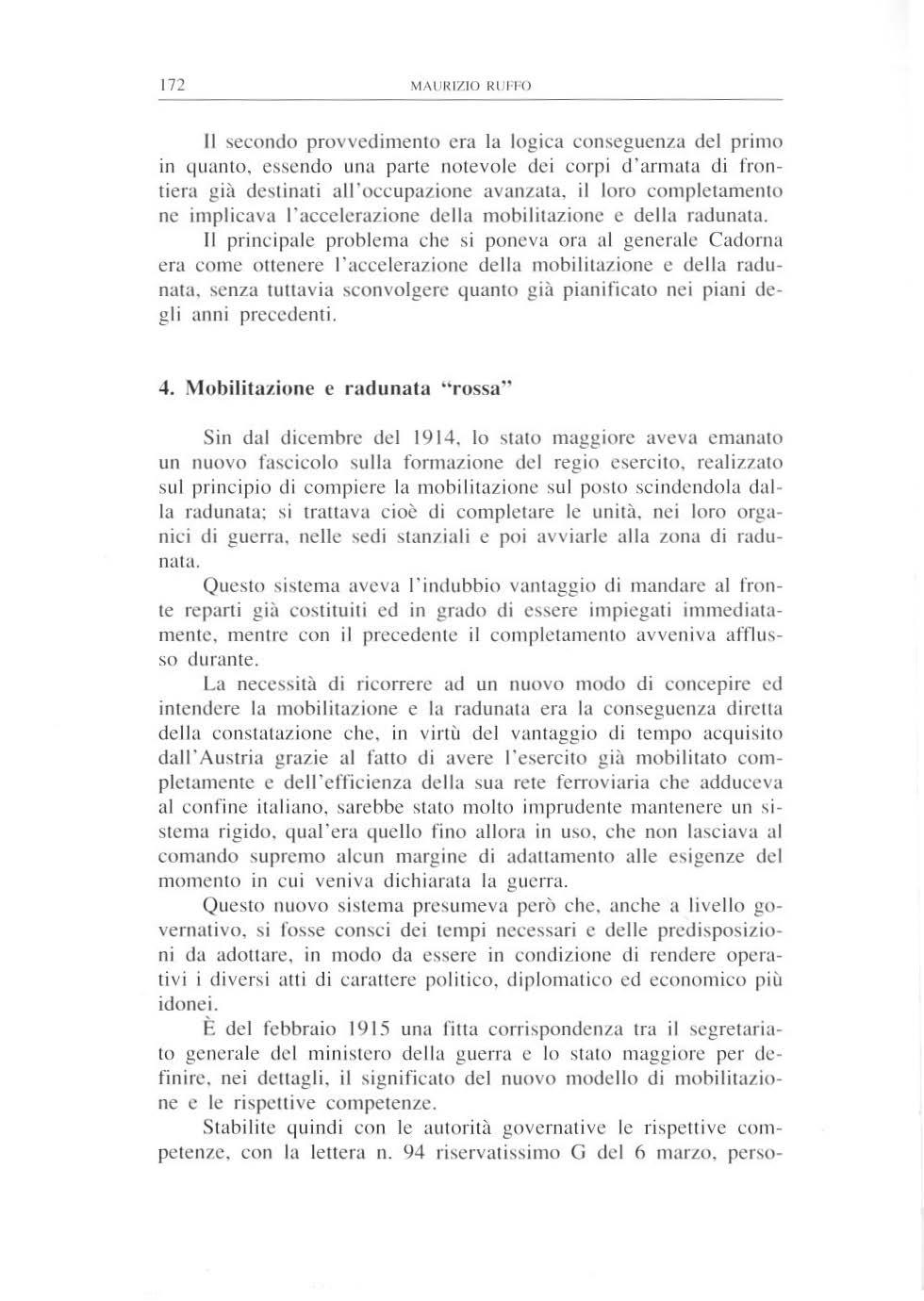
Sin dal dicembre del 19 I 4. lo stato maggiore aveva emanato un nuovo fascicolo sulla formazione del regio esercito, rcaliuato s ul principio di compiere la mobil it azione sul posto scindendo la dalla radunata: si trattava cioè di complelare le unirà. nei loro organici di guerra. nelle sedi stamiali e poi avviarle alla Lona di radunata.
Questo sistema aveva l'indubbio vantaggio cli mandare al fronte reparti già cost ituiti cd in grado di essere impiegati immediatament e, mentre con il precedente il completamento avveniva afflusso durante.
La nece s-; ità di ricorrere ad un nuovo modo di concepire cd intendere la mobilitalione e la radunata era la co nseg u enLa diretta della constatazione c h e. in virtù del vantaggio di tempo acquisito dall'Austria graz ie al fatto di avere l'esercito gii, mobilitato completamente e dell'efficienza della sua rete ferroviaria che adduceva al confine italiano. sarebbe stato molto imprud en te mantenere un s is tema rigido. qual" e ra quello fino allora in u so. che non la~ciava al comando supremo alcun margi n e di adallamento alle esige nz e del mom en to in c ui veniva dichiarata la g u e rra.
Questo nuovo s is tema prc -; umeva però che. anche a li ve llo governativo, si fosse consci dei tempi necessari e delle predisposiLioni da adottare, in modo da esse re in co ndizion e di rendere operativi i diversi atti di carattere politico, diplomatico cd economico più idonei.
È del febbraio I 9 15 una fi11a corrisponden;,a tra il '>Cgretariato generale del mini s te ro della guerra e lo s tato mag g iore per definire. nei dettagli, il sig nifi ca to del nuovo modello di mohilitaLione e le rispe11ive competenze.
Stabilite quindi co n le autori tà governative le risp e ttive comp e te n 7e. con la lettera n. 94 riservatissimo G elci 6 marL.o. perso-
nale ai comandanti d'armata ed a quello della zo na Carnia 9 , il generale Cadorna illustrava le nuove modalità della mobilitazione e della radunata chiamata "rossa", dal colore della carta su cui erano scritti i documenti, per distinguerla dalla precedente nella quale il colore distintivo era il ·'camoscio".
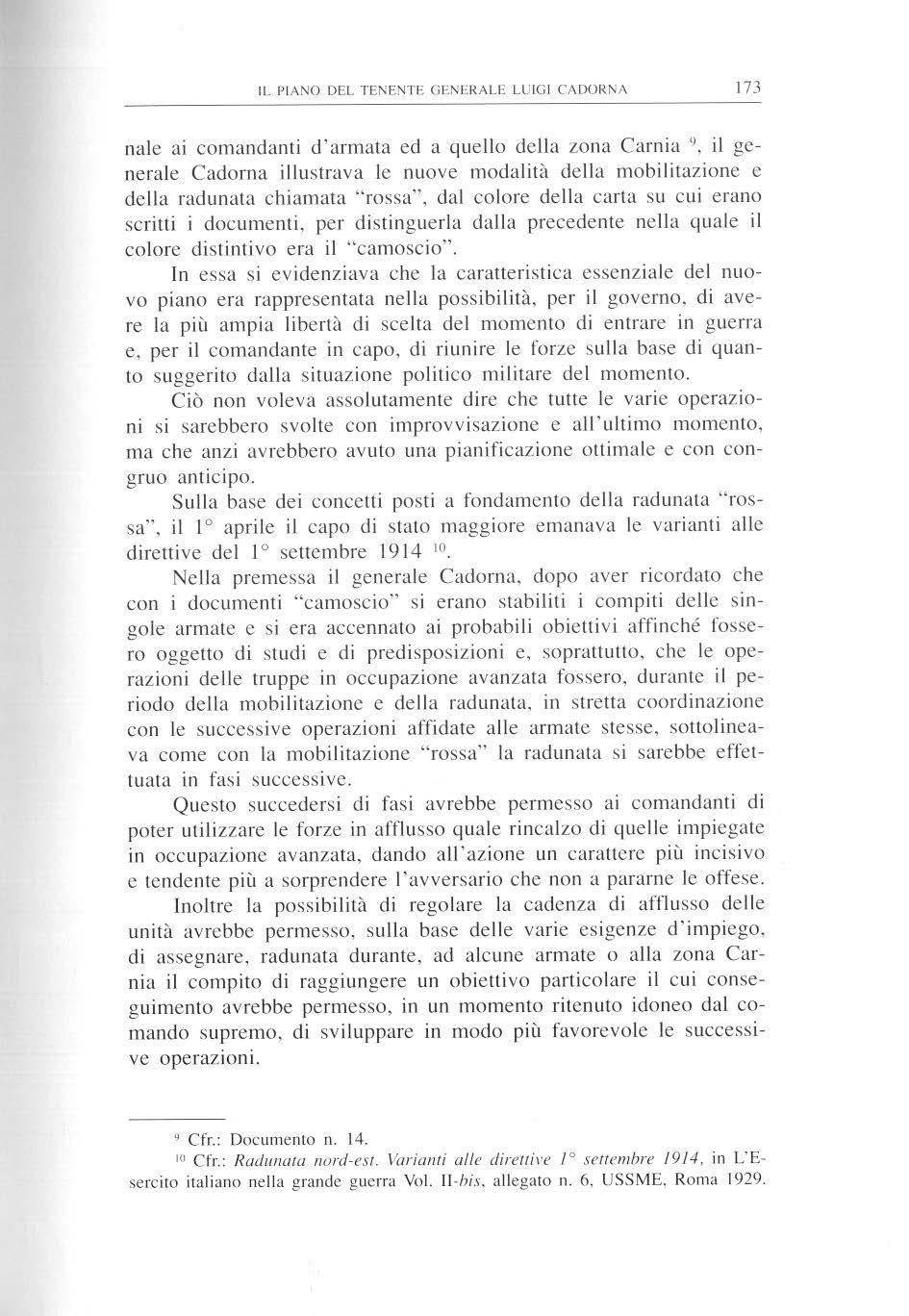
In essa si evidenziava che la caratteristica essenziale del nuovo piano era rappresentata nella possibilità, per il governo, di avere la più ampia libertà di scelta del momento di entrare in guerra e, per il comandante in capo, di riunire le forze s ulla base di quanLo suggerito dalla situazione politico militare del momento.
Ciò non voleva assolutamente dire che tutte le varie operazioni si sarebbero svolte con improvvisazione e all'ultimo mom ento, ma che anzi avrebbero avuto una pianificazione ollimale e con congruo anticipo.
Sulla base dei concetti posti a fondamento della radunata "rossa", il I O aprile il capo di s tato maggiore emanava le varianti alle diretti ve del I O settern bre I 9 I 4 10
Nella premessa il generale Cadorna, dopo aver ricordato che con i documenti "camoscio" s i erano stabiliti i compiti delle singole armate e s i era accennato ai probabili obiellivi affinché fossero oggetto di s tudi e di predispos izioni e, soprattullo, che le operazioni delle truppe in occupazione avan za ta fossero, durante i I periodo della mobilitazione e della radunata, in stretta coordinazione con le successive operazioni affidate alle armate stesse, so ttolineava come con la mobilitazione "rossa" la radunata s i sare bbe effettuata in fasi successive.
Questo succedersi cli fasi avrebbe permesso ai comandanti di poter utilizzare le forze in afflusso quale rincalzo di quel le impiegate in occupazione avanzata. dando all'azione un carattere più incisivo e tendente più a sorprendere l'avversario che non a pararne le offese. Inoltre la possibilità di regolare la cadenza di afflusso delle unit~t avrebbe permesso, sulla base delle varie esigenze d'impiego , cli assegnare, radunata durante, ad alcune armate o alla zona Carnia il compito di raggiungere un obiellivo particolare il cui consegu imento avrebbe permesso, in un momento ritenuto idoneo dal comando supremo, di svi luppare in modo più favorevole le successive operazioni.
9 Cfr.: Documento n 14.
Cfr.: Radunata
Un a ltro aspetto importante del documento era la rivalu tazione, in chiave strategica, del sa liente trentino-tirolese.
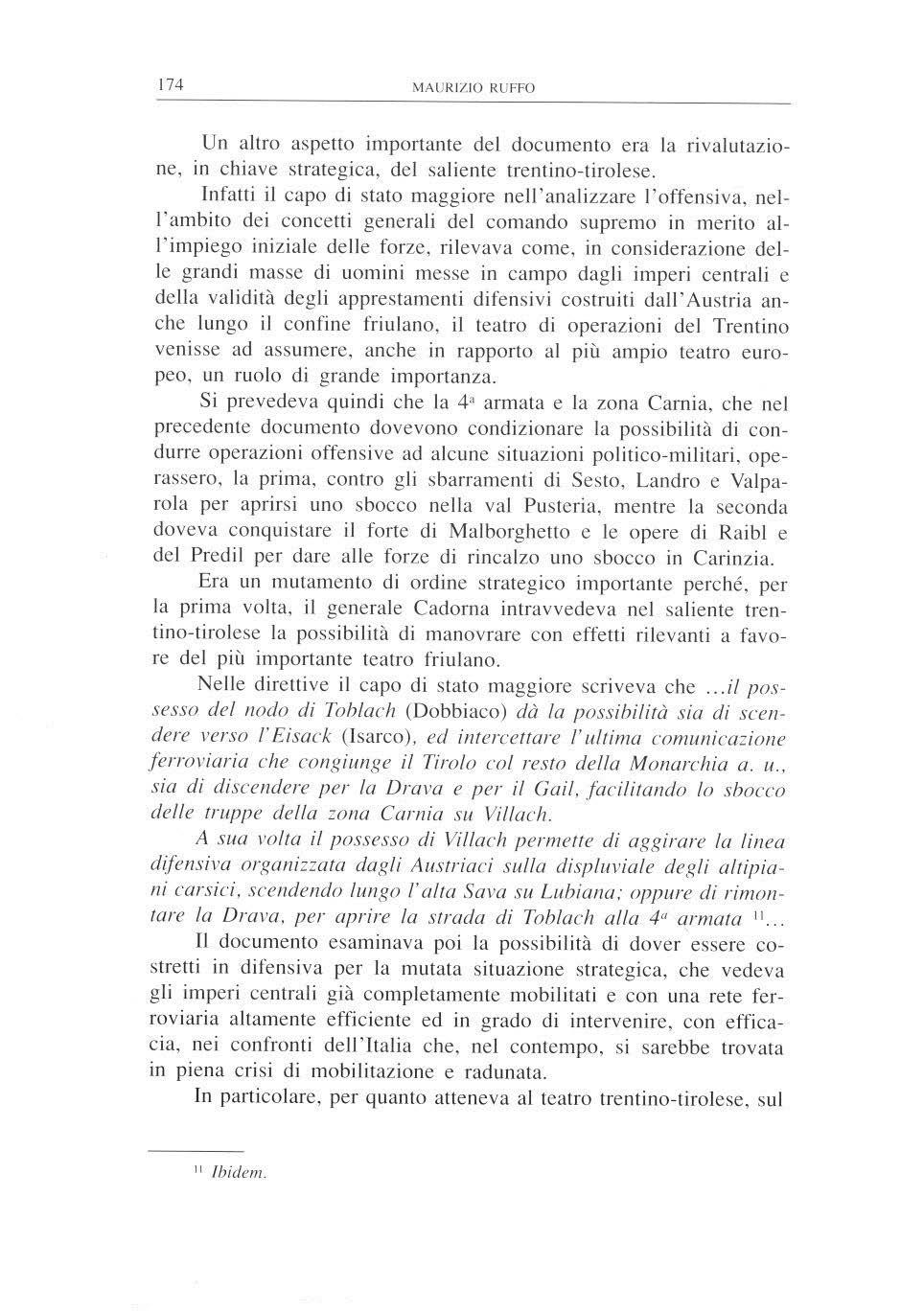
Infatti il capo di stato maggiore nell 'analizzare l 'offensiva, nell'ambito dei co ncett i generali del comando supremo in merito ali' impiego iniziale del le forze, rilevava come , in considerazione delle g randi masse di uomini messe in campo dagli imperi centrali e della validità degli apprestamenti difensivi costruiti dall'Austria anche lungo il confine friulano , il teatro di operazioni del Trentino venisse ad assumere, anche in rapporto al più ampio teatro europeo, un ruolo di grande importanza.
Si prevedeva quindi che la 4 " armata e la zona Carnia, che nel precedente documento clovevono condizionare la possibilità di condurre operazioni offensive ad alcune si tua zion i politico-militari, operassero, la prima, contro g li sbarramenti di Sesto, Landro e Valparola per aprirsi uno sbocco nella val Pus teria, mentre la seconda doveva conquistare i I forte di Mal borghetto e le opere di Raibl e del Preci il per dare alle forze cli rincalzo uno sbocco in Carinzia.
Era un mutamento di ordine strategico importante perché, per la prima volta, il generale Cadoma intravvedeva nel sa li e nt e trentino-tirolese la possibilità cli manovrare con effett i rilevanti a favore del più importante teatro friulano.
Nelle diret!ive il capo di stato maggiore scr iveva che ... i/ possesso del nodo di Tohlach (Dobbiaco) dà la possibilità sia di scendere 11erso /' Eisack ( Isarco), ed intercettare l'ultima comunica:ione ferroviaria che congiunge il Tirolo col resto della Monarchia a. u., sia di disce ndere per la Drava e per il Gai/, facilitando lo shocco delle truppe della zona Carnia s u Villach.
A sua 110/ta il possesso di Villach permette di aggirare la lin ea difensiva organizzata dagli Austriaci sulla displuviale dep,li altipiani cars ici, scendendo lungo l'alta Sava su Lubiana: oppure di rimontare la Drava. per aprire la strada di Toblach alla 4" armata 11
Il documento esaminava poi la possibi lit à di dover essere costretti in difensiva per la mutata situazione strategica, che vedeva gli imperi ce ntrali già completamente mobilitati e con una rete ferroviaria altamente efficiente ed in grado di intervenire , con efficac ia , nei confronti dell'Italia che, nel contempo, si sare bbe trovata in piena crisi di mobi I itazione e radunata.
In particolare, per quanto atteneva al teatro trentino-tirol ese, sul

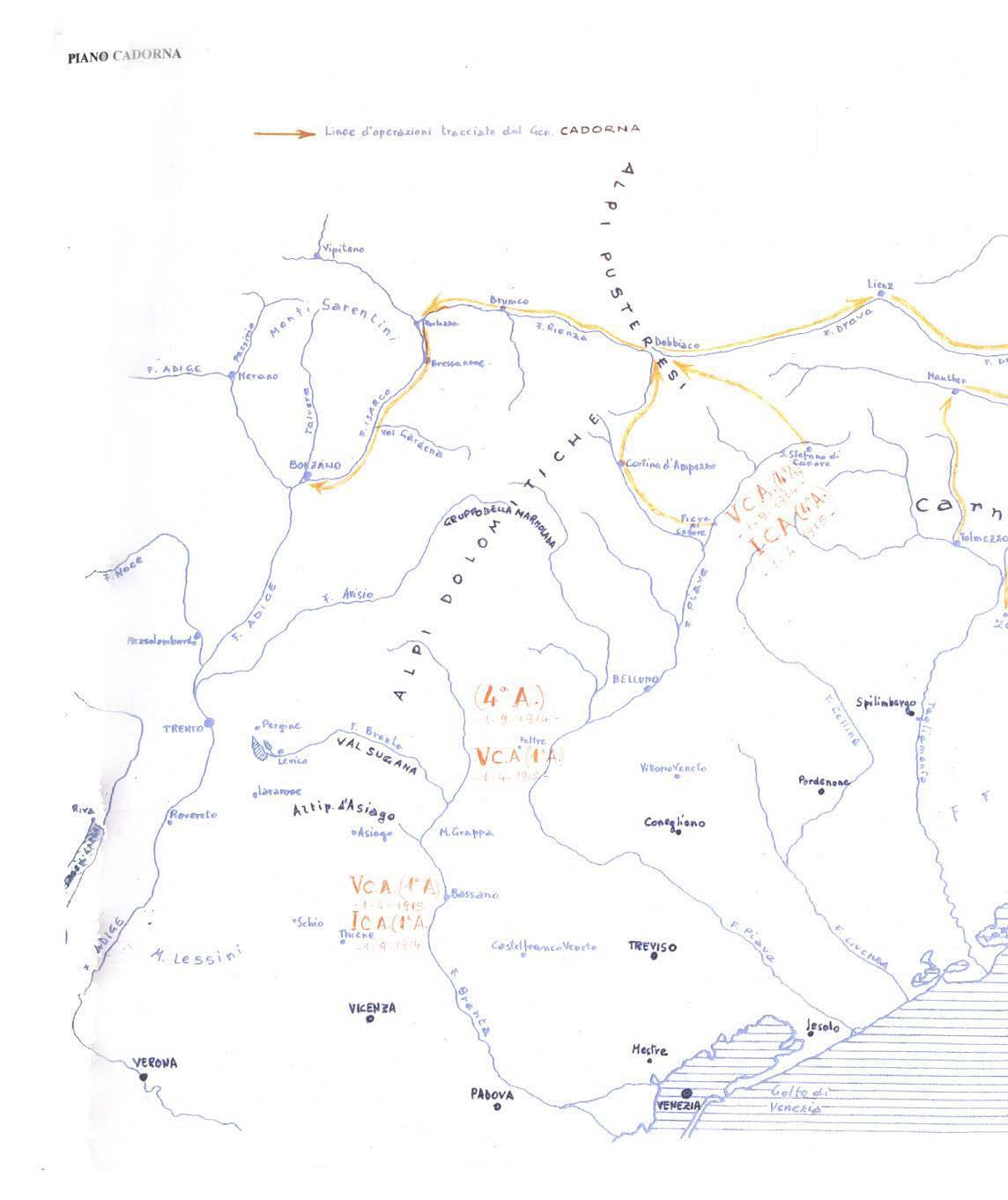
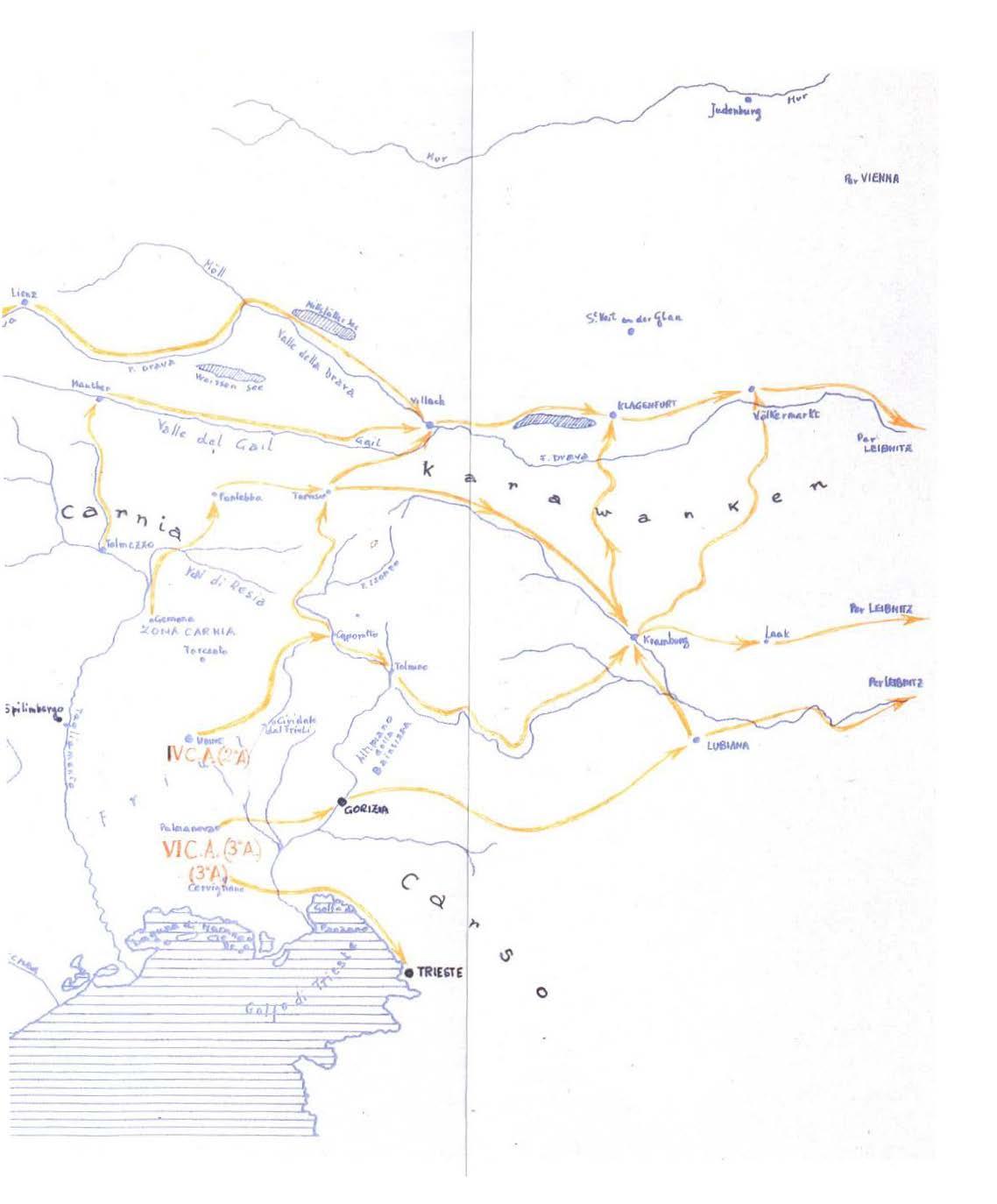

s uo lato occidentale bi sog nava re s is tere ad o lt ranza nella regione del Mortirolo e sullo sbarramento delle Giudicarie raccordando le due difese mantenendo il possesso dell'area Croce Domini-Maniva: s ul la to occidentale, dall'Adige al Pera lba, la difesa avrebbe dovuto imperniarsi su ll e regioni for tifi cate Baldo-Lessini e Ag n o -A ssa. nonch é s ulle forte zze Brenta -C is m on e Cadore-Maè. li ridotto Cadorino, per la particolare imp ortanza c h e riveste, avrebbe dovuto essere difeso ad oltranza.
Ne l teatro di ope razioni ciel Friuli la res is ten za avrebbe dovuto imperniarsi su una linea app oggia ta a ll e fortezze del medio e basso Tagliam e nto predisponendo, si n dal tempo di pace e limitatam ente ai so li ca p osa ldi. le o p e re n ecessar ie per il s uo rafforzamento.
Alla zona Carnia il compito di raccordare la difesa tra il teatro tre ntino-tirol ese e quell o friulan o dand o vita, in virtù del partico lare te rre n o, ad una difesa att iva e manovrata.
S ulla base di questi concetti veniva n o indicati gli obiettivi da co n seg uire da parte d e ll e singole armate durante il p e riod o d e lla radunata.
Alla I• era affidato il compito di att ivare un a difesa aLtiva mirant e a co n seg uire il p ossesso d e i co lli ed a svo lge re un ' impon ente azione di fuoco co ntro le fortific,llioni austriache per agevolare il compito d e lla 4a armata.
L a 4" doveva conseg uire co n la sua ala destra la co nqui sta del nodo di D obbiaco e, con quella s ini stra, il gruppo m on tuo so de l Sella p e r pot e r proseg uire, in seguito. sia verso l ' Jsa rco sia lun go la Dra va.
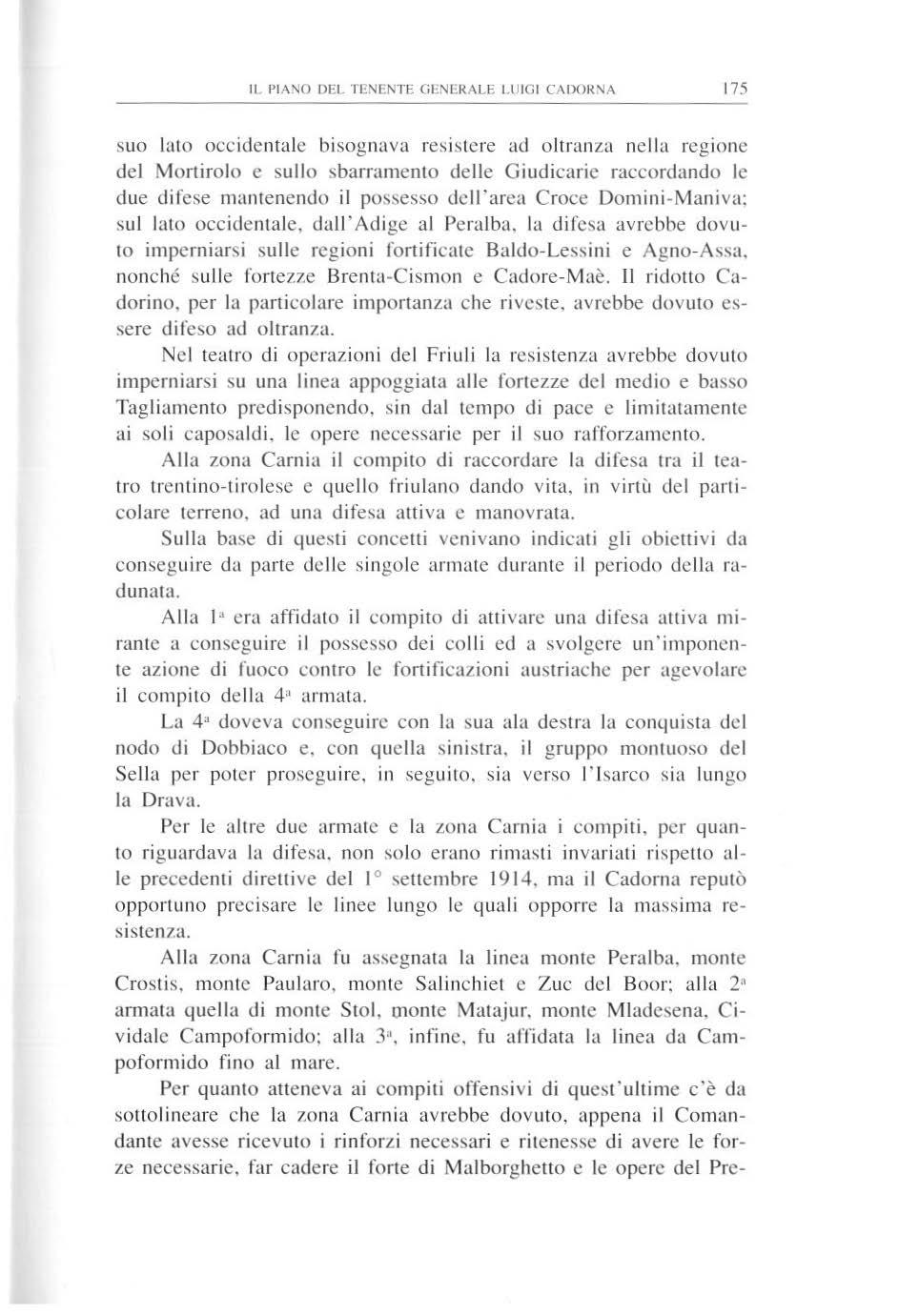
P e r le a ltre du e armate e la zona Carnia i compit i, per quanto ri g uardava la difesa . non so lo erano rimasti in va riati ri s pe llo alle precedenti di re tti ve del 1° se tt embre 1914. ma il Cadorna reputò opportuno prec is are le line e lungo le quali opporre la ma ss ima res is te n7a.
Alla zo na Carnia fu assegnata la lin ea m on te P era l ba. monte Cro s ti s, mont e Paul a ro , mont e Salinchiet e Zuc del Boor: alla 2" armata quella di mont e Stol, 01ont e Matajur. mon1 e Ml a d ese na. Cividale Campo formid o; alla 3·'. infin e. fu affidata la linea da Campoformido fin o al mare.
P e r quant o atteneva ai co mpiti offensivi di quest'ultime c'è d a so ttolin ea re che la zona Carnia avre bbe dovuto, appena il Comandante avesse ri cev ut o i rinforL. i ne cessari e ritene sse di avere le forze necessarie, far cad e re il forte cli Malborg h e tto e le opere del Pre-
dii , di R aib l e di Flit sc h 11 ; la 2• si sa rebbe dovuta impossessa re di Caporetto e. se poss ibil e, d e i monti K o lovrat e Korad a; alla 3" era affidato il co mpito di conquistare l'altura di Medea ed i p onti s ul -
1' Iso nzo tra Cervignano e Monfalcone. per assicurarsi le basi di parte n za per un attacco alle alture di Sagrado.
Sempre nell'ambito dei compiti offensivi. il capo di stato maggiore affidava alla 2• ed alla 3 , annata l'in carico di contras t are, per quanto possibile, lo scarico delle truppe austriache n eg li scal i fe rroviari di T o lm ino. Gorizia e Monfalcone. utilizzando. se possibile. anche gli a ero plani; non solo, ma la 3" annata av rebbe dovuto effeuuare un 'inc ursione su Monfalcone per distruggervi la stazione ferrov iaria e d una su Gorizia con obiettivo la dis truzi one del campo d'avia1ione, a qu es t'ultima avrebbe concorso il comando supremo co n i meai aerei a sua disposizione.
li generale Cadorna non s i limit ò ad operare so lo su l fronte terre'> tre per migliorare il più possibile l'organiaazione e la prepara,ione dell'esercito sia in ca mpo lo g istico sia tattico in vista del1'orma i pross ima entrata in gue rra dell' Italia, ma si preoccupava anche di come le forLe navali avrebbero potuto co ncorr e re alla co ndotla del le operazioni terre s tri.
All'emanazione delle direttive alle armate fece seg uito anche un accordo con il capo di stato ma gg iore ckl la marina nel quale era prevista la costituzione. a Venezia, di una sq uadra navale. composta di quauro incrociatori di tipo an tiquat o e di naviglio silurante, per condurre le operazioni verso Trieste.
Ques ta s quadra avrebbe dovuto appoggiare le operazioni del1' ala destra dell'esercito verso la ciu~, di Trieste ballendo, con le prop rie artiglierie, le pos ta z ioni austriache su ll e alture intorno a Monfalcone e su qu e lle a nord della s trada litoranea MonfalconeTri es te; inoltre avrebbe dovuto impedire alle navi avversarie svolgessero analoga azione contro la forze italiane rendendogli imp oss ibil e l 'uti li uazione di quella strada e della ferrovia. el concepire la memoria operativa e le seg uenti direttive. particolarmente quelle lega te alla mobilitazione ''rossa", il ca po di s tato maggiore, come aveva sotto lin eato nelle premesse. faceva affi-
11 Qu este d irettive ve nn ero imp a rtit e al Co mandant e delle truppe zona Carnia ~im ilment e come con quelle del 1° se u embre 1914. co n dbposi7ioni a parte in data t O aprile 1915: cfr.: Radunata nord-eJt (rossa). \ 'aria111i alle dire11ive per il r·o111a11da111e la : 0110 Carnia durante il periodo della 111nhi/i1a:io11e e rad1111ara, in L'E se rcito iialiano nella grande g uerra Vo i 11 -his. alle ga to n 7. USSME. Roma 1929.
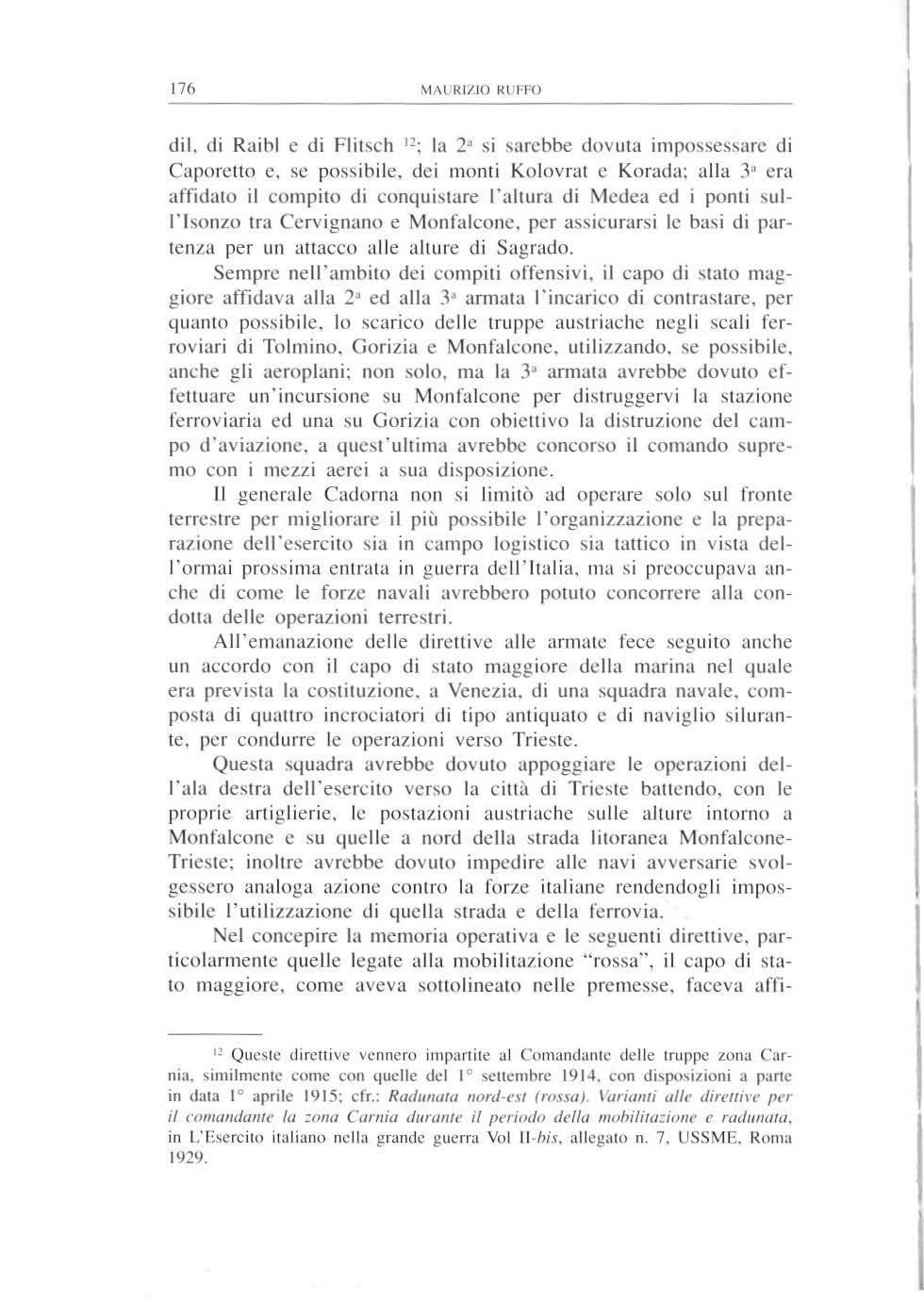
<lamento su due condizioni essenziali per la riuscita del piano: la sorpresa ed il contemporaneo impegno delle forze asburgiche sui fronti russo e serbo.
Per soddisfare alla prima condizione era stata ideata la mobilitazione occulta da raggiungersi, come si è detto, per fasi successive, nell'ambito del progetto di mobilitazione '"rossa'', al fine di far coincidere la dichiarazione di guerra con l ' inizio reale delle operazioni offensive da parte delle forze in occupazione avanzata.
Per la seconda co ndi zione era necessario uno stretto collegamento tra g li alleati e per conseguirlo il generale Cadorna si era impegnato in prima persona facendolo inserire nelle convenzioni militari legate al Patto di Londra.
Nel merito il capo di stato maggiore, in una sua lettera al pres idente del consiglio del 17 giugno, nella quale lamentava la mancanza di collaborazione da parte degli alleati, ricordava, come lui stesso afferma, che .. .io are\'O faflo inlrodurre. nelle conFen:ioni militari stipulale. chiaro e preciso il patto relativo a questa coopera:ione delle for:e. fatto che più esp/icitome11te si rilel'a nella convenzio11e con la Russia. tralfandosi di coopera:ione in 1111 teatw di opera:ioni comune. In tale com·en:ione era stato stabilito che l'esercito italia110 s' impeg11a1 •a ad entrare in campagna non più tardi del 26 maigio 19 I 5 ...... e che il suo intervento avrebbe dovuto essere agevolato dalle opera:ioni dep.fi altri tre eserciti alleati. i quali, alla loro volta do1•c1·ano. col loro energico contegno. impedire al nemico di riunire sulla nostrn frontiera forze di schiacciante superiorità ..... Colla suddetta co11 1•e n:ione l'esercito italiano e quello russo, concellfrato in Galizia. dovern110. come primo scopo da raggiungere, cercare di battere il nemico che avevano di fronte sul comune tealro austro-ungarico 11
Anche g li eserciti serbo e montenegrino avrebbero dovuto partecipare a questo grande progetto di cooperazione attuando un' offensiva, con direzione Nord-Ovest, allo scopo di congiungersi, prima possibile, all'ala destra dell'esercito itali ano e quindi proseguire insi eme verso Lubiana.
Ma tralasciando quelli che furono i problemi che l' esercito si trovò ad affrontare al momento della s ua discesa in campo, è importante sottolineare che i I documento del I O apri le rappresentò I'ultimo aggiornamento del piano di operazioni, contro la monarchia danubiana, prima dell'emanazione, da parte ciel comando supremo, dell'ordine di opera:ione n. I.

Con le direttive del I O apri le l 'ese rcito si preparava se mpr e p1u ad affrontare quella guerra che o rm a i era di ven ta ta ineluttabile. e lo faceva cercando di pas sa re, nel min or tempo possibile e senza grossi traumi , d a quella concezione difensiva che ne aveva semp r e cara tt e ri zzato l ' impo stazion e s tra tegica ad un'impostazione s piccatamente offensiva verso l 'A us tri a -U nghcria.
Con la denuncia della T ripl ice ed i l co nt emporaneo impegno preso con g li alleati de ll ' Intesa, l 'Ita li a si appre stava ad e ntrare in g ue rra e ntr o i I 26 maggio ed in tale prospettiva il 16 il ca po di stato ma gg io re e manava l 'o rdin e di operazione n. l.
Nella lettera di trasmissione il genera le Cadorna, oltre a spec ificare c he l' ordine avrebbe avuto va lidit à so lame nt e se espressamente ordina t o e sare bbe entrato in vigore nel g iorno e nell ' ora indicati telegraficamente, comunicava che, nel caso in cui le ostili tà fo sse ro ape rte dal nemico o che l'ordine di in iziare le osti lit à non fosse accompag na to da quello esplicito di attuare l'ordine di operazione n. 1, b isog nava attener s i a quanto stabi lit o co n le di rettive del 1° aprile.
Qu esta precisa zione si era re sa indis pensabile dalla necessità di da re a ll e armate, ed in particolare alla 2• , alla 3• ed alla zo na Ca rnia , delle is tru zio ni chiare che le mettessero in condizione di predisporre, a loro volta, g li o rdini necessari per ev itare s ia di essere so prese eia un 'even tu a le azione d e l nemico, sia per non indug iare ne ll ' int rapre nd ere l'azione per mancanza di ordini preci s i.
L 'o rdin e d i operaz io ne n. 1 indirizzato alla 2", alla 3• a rm ata ed a lla zona Ca rnia aveva co me oggetto il primo sba lzo offensivo per raggiungere le linee cieli' Isonzo.
Premesso che era intendime nto del comando s upremo cli avanz ar e al più pres to verso l ' Iso nzo con la 2• e la 3" armata pe r assic ura r si degli sbocc hi offe n s iv i ad Est di qu el la lin ea, il docum e nt o indi cava g li obiettivi immed iati da ra gg iun gere, rapprese nt a ti dalla conca cli Tolmino pe r la 2" ar m ata ed il basso I sonzo per la 3".
Dopo aver indi ca to i co mpiti delle s in gole arma te e la lin e a di s eparazione tra le s tes se, il documento terminava s offermando s i su lla cara tter ist ica c he avrebbe dovuto avere l 'operazione.
Essa. infatti , av rebbe dov uto assu me re il carattere di un 'e nerg ica e d improvvisa irruzion e e, per o tt e ne rl o, era necessario che fossero messe in atto tutt e le pre disp os iz ioni necessa ri e per mantenere il più s tre tto seg reto sia s ull e forze s ia s ul loro concentramen to .
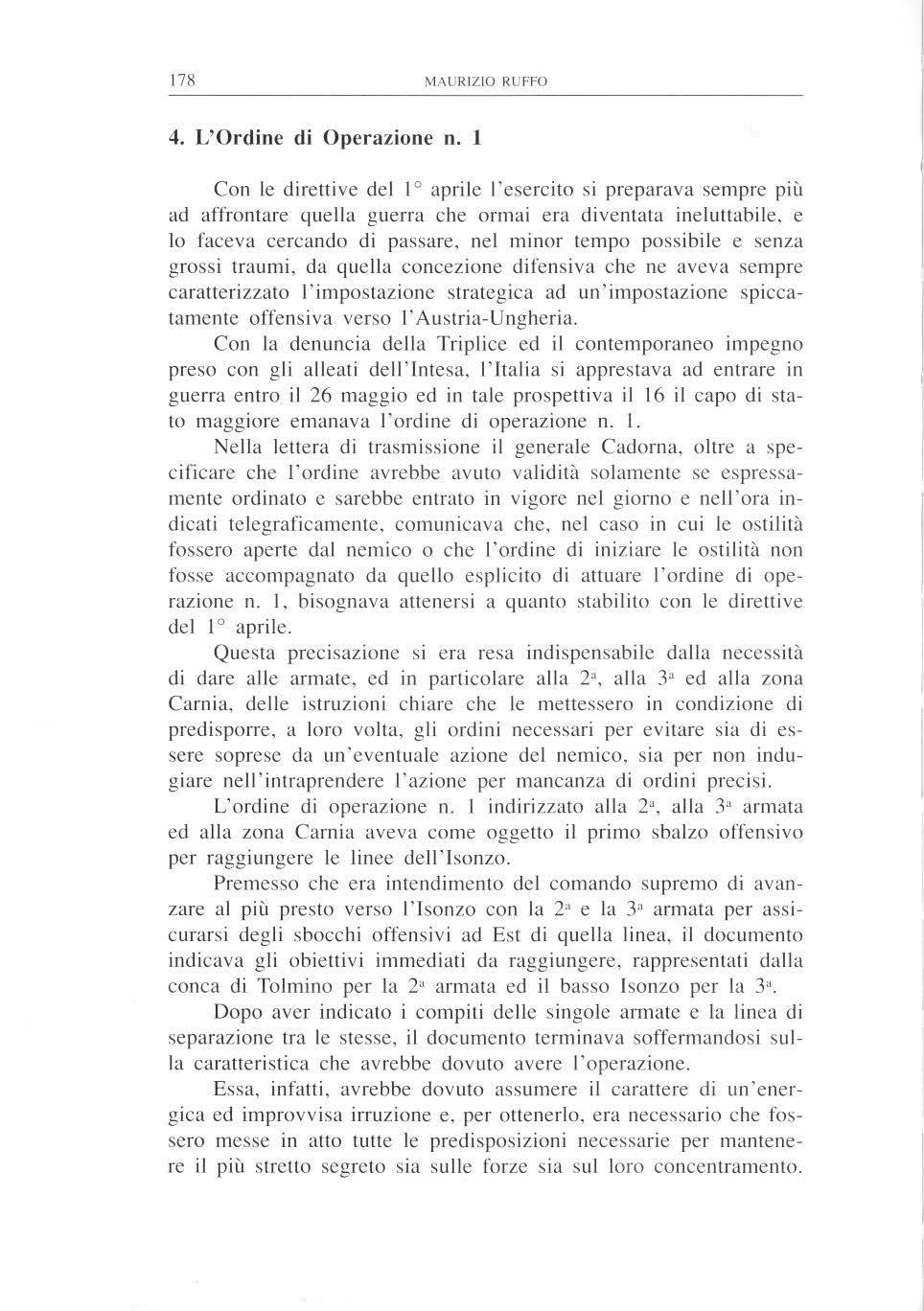
L'Ordine di Operazione n. l del 16 maggio 1915 costituì dunque l'epilogo degli studi che si n dal 1885, dietro sollecitazione del generale Coscnz, si erano succeduti per analizzare e pianificare le possibili operazioni sulla frontiera Nord-Est.
Tuttavia, per capirne appieno gli sviluppi, è fondamentale tenere sempre presente che il modo in cui lo stato maggiore italiano affrontò il problema del suo confine orientale era la risultante della politica che il governo aveva intrapreso negli anni immediatamente dopo la terza guena d'indipendenza e che lo vedeva strettamente legato alla Germania bismarkiana .
La realizzazione poi, ncll' ambito della Triplice, dell 'alleanza con l 'A ustria- U ngheria, seppur contraria alla tradizione risorgimentale, era stata ritenuta indispensabile per il rafforzamento del giovane stato che, affacciandosi nel concerto europeo, nece ssi tava di validi sostenitori per condurre una politica di sviluppo economico e sociale.
Tuttavia con la nomina del generale Cosenz a capo di stato maggiore dell'esercito, se è pur vero che si pianificavano, con viva attenzione, le possibili operazioni nei confonti della Francia , si ritenne opportuno analizzare anche la possibi lit~t di dover essere costretti ad una guerra contro l'Austria.
Eventualità che i successori del Cosenz tennero sempre in evidenza, ma quello che appare più importante è i I confronto fra quello che era lo studio di questi e la memoria operativa del generale Caclorna del I 914.
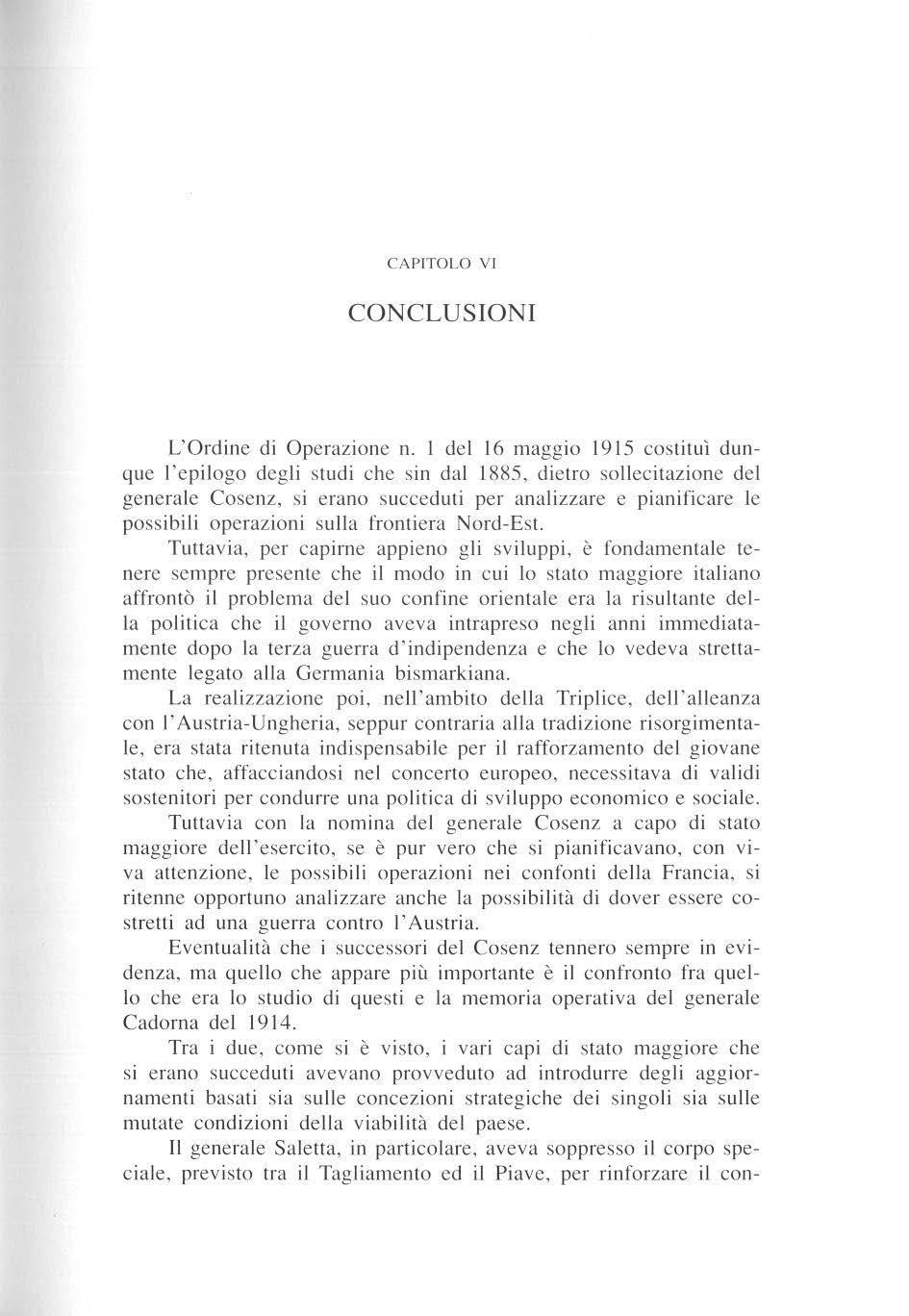
Tra i due, come si è visto, i vari capi di s tato maggiore che si erano succeduti avevano provveduto ad introdurre degli aggiornamenti basati sia sulle concezioni st rategiche dei s in gol i sia sulle mutate condizioni della viabilità del paese.
Il generale Saletta, in particolare, aveva soppresso il corpo speciale, previsto tra il Tagliamento cd il Piave, per rinforzare il con-
trollo del te rritorio metropolitano, con particolare atte nzio ne a quello peninsulare.
li ge neral e Pollio, da parte sua, aveva provvedu to a l rafforzamento dei confini con l a cost ru z io ne di numerose opere d el la fortific az ione permanente e d a veva sviluppato il co ncetto d e lla difesa ava n z ata , ma la vera svo lta, nella concezione s trat eg ica s i era av uta co n il genera le Cadorna.
TI Cosenz, ipoti zza nd o una gue rr a nella quale l'Italia sarebbe s tat a sola co ntro l 'Aust ri a aveva introdotto, quali elementi di nov it à, J' id ea di difendersi sul Piave, anziché su Il ' Adige come teorizza to fino ad al lora 1 , e, quando le circostanze lo avrebbero permesso, di passare a ll a con troffen s iv a per ri conquistare il terre no momentaneamente ceduto a li 'avversa ri o e s pin gere le ope ra z ioni in territorio nemi co .
Non solo, si rit eneva pure di po ter condurre delle operazioni offensive in profondità pe nsand o cli arrivare a sc hi e rare l'esercito sulla Mur con obiettivo Vienn a .
In ques ta ipotesi la conquista del salien te rappresentato dal Trentino era vista dal Cosenz quale premessa per co ndurre con s uccesso l e operazioni s ull ' Tsonzo.
Il possesso della co nca cli D o bbiaco acquistava, per il gene rale Cosenz, un ' importa nza quasi primaria per le possibilità c he questa offriva pe r il prosieguo delle operazioni s ia in direzione O vest, ve r so il forte di Fortezza e quindi il Bre nn e ro e Bolzano, sia verso E s t , attraverso le va lli della Drava e del Gail, per conco rr e re, con l 'arma t a impe g nata verso Ta rvi s io , alla conquista delle co nch e di Villach e Kla ge nfurt.
Per il Cadorna, costretto da g li avvenimenti a modifi care co mpletamente l 'a tt egg iamento opera tivo fino a ll ora ipotizzato d a una concezione difensiva ad un a esc lusivam e nte offensiva, i l co nilitto s i sa rebbe , inv ece, dovuto decidere s ull ' Isonzo e l'obiettivo non era rappre se ntato tanto dal la conquista della capitale nem ica quanto dal1' annien tamento delle s ue forze.
Ciò e ra otten ibil e s up e randole lungo la direttri ce Is onzo- piana di Lubi ana, procedendo a ttra ve rso il Carso e la via Tolmino-v alle dell ' lclra , previa copertura dalle pro ve nien ze d a l Nord con il possesso de lle conche di Vill ac h e di Klagenfurt.
Come si è v is to il piano era inqu adrato nel contesto di un ptu ampio quadro s trateg ico di coalizione dove e m e rgeva la necessi t à '

di conquistare la Sava per g iun gere sul fronte M a rburg -Yarasdin da do ve, in co llabora zio ne co n l 'eserc ito serbo, proseguire nel cuore d ell'impero a l fin e d i co ngi un ge rs i a Bud apest co n l'esercito russo.
I n questo amb it o il sa li e nte trentino-tirolese ven iv a, inizialmen te, a perdere di importan za, tanto da s uggerire al Caclorna di ordinare a ll a l " ed a l la 4• armata di assumere un atteggiamento esclusivamente difensivo, sa lvo qualche colpo di mano o limitate azioni lo cali che si fossero rese necessa ri e per migliorare le posiz ioni senza, per altro, rischiare il benché minimo in s uccesso, per non incorre re nei negativi contraccolpi psicologici c he ne sa rebbero derivati.
Solo con le v arianti cl e ll ' ap ril e 1915 alla sua precedente memoria operativa, il Cadorna vide ne l sali en te tr entino-ti rolese la poss ib i l ità di cond urr e o perazio ni offensive che, pur risultando complementari a llo sfo r zo principal e s ull ' Isonzo, avrebbero potuto co ndune a risultati notevoli in campo stra tegico
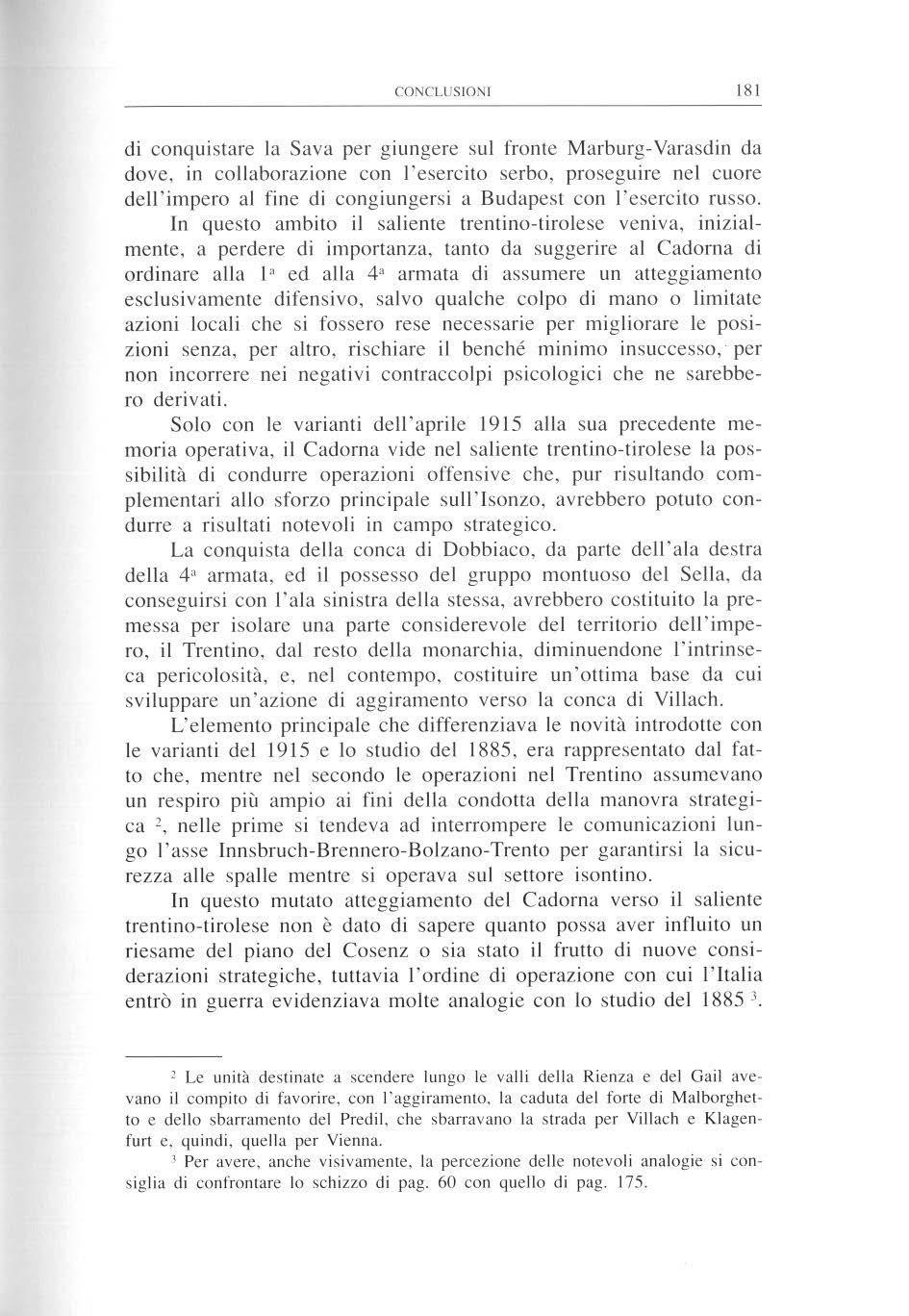
L a conquista della co nca di Dobbiaco , da parte dell'ala destra della 4" armata, ed il possesso del grup po montuoso del Sella, da conseguirsi con l'ala sini st ra della stessa, avrebbero costituito la prem essa per isola r e una parte co n side revole ciel territorio d ell ' im pero, il Tre ntino , dal resto della monarchia, diminuendone l'intrinseca pe ri co losi t à, e, nel contempo, cost ituire un 'ott ima base eia cui sv ilupp a re un 'azione cli aggirame nto ve r so la co nca cli Yillach.
L'ele m e nto principale che differenziava le novit it introdotte con le varianti de l 1915 e lo studio del 1885, e ra rappresentato dal fatto che, me ntr e nel secondo le operazioni nel Tre ntino assumevano un res piro più amp io ai fini della condo tta della manovra s trateg ica 2, ne ll e prime s i tendeva a d interrompere le comunicazioni lungo l 'asse Inns bru ch-Brennero-B olzano-Trento pe r ga rantirsi l a sicurezza a ll e s pall e m e ntre si operava su l se ttore isontino.
In qu es to mutato atteggiamento del Cadorna verso il sali ente trentino - tirol ese non è dato di sapere quanto possa aver inOuito un rie sa m e del piano de l Cosenz o s ia stato il frutto di nuov e considera z ioni s trat eg ic h e, tuttavia l 'ordine cli operazio ne con cui l ' It a lia entrò in g uerra evidenziava molt e analogie con lo s tudio del 1885 3
1 Le unità dest in ate a scendere lun go le va lli della Rienza e del Gai l aveva no il comp ito di favo rire, co n l'aggiramento, la cad uta del forte di Malbor ghelt o e de l lo sbarram ento d el Predi i. c he sbarra va no l a strad a per Villach e Klagenfurt e, quindi , quell a per Vienna.
' Per av ere anche v isiv amente, la percez ione delle notevol i analogie si co nsig l ia di confrontare lo schizzo di pag. 60 con quello di pag. 175.
È da so ttolin eare, in o ltre, che per il Cosenz l 'a na li s i di possibili operazioni verso la frontiera No rd-E st era puramente precauziona le, cioè un atto dovuto da parte di un capo di s ta to maggiore, e, comunque, per lui ed i suoi s uccesso ri s i partiva sempre eia un co nce tt o che prevedeva, almeno ini zialme nte, un atteggiamento difensivo.
Questa impostazione era pera ltro d ettata, come si è visto, dal fatto c he la potenza militare austroungarica e r a considerata nettame nte superiore a quella itali ana e non era quindi ipot izzab il e un conflitto in c ui l ' Itali a s i fosse trovata, da sola, im peg n ata co ntro l' impero d a nubiano.
I l Cadorna, invece, si era tro va to a dover fronteggiare un a s itua z ion e impre vis ta ne11a qua le a l cambio di a lle a nza s i era unita la necessità di operare esclusivame nte in c hi ave offe n s iva, senza peraltro poter disporre di un qualche cosa di co ncret amente predisposto in tempo cli pace che non fossero i piani di mobilitazione. Sin dal momento d e lla dichiarazione di neutralità eia pa rt e del gove rn o ital ia no, in fatt i , il generale Cadorna, pur intuendo una partecipazione italiana a lla gue r ra, non aveva ricevuto delle indicazioni precise co ntro quale avversario orientare l'esercito e, cosa fondamentale per un comandante , quando poter iniziare la mob ilitazion e e le operazioni 4
A ta l proposito, è s ufficiente pensare che le prime predisposizion i c he vennero adottate nel luglio 1914 ri g uardavano un aumento d ei presidi e della v igi lanza verso la Francia, ment re co ntro I' A us tri a, a l di fuori d e i piani di mobilitazione e radunata non c'era niente cli pianificato.
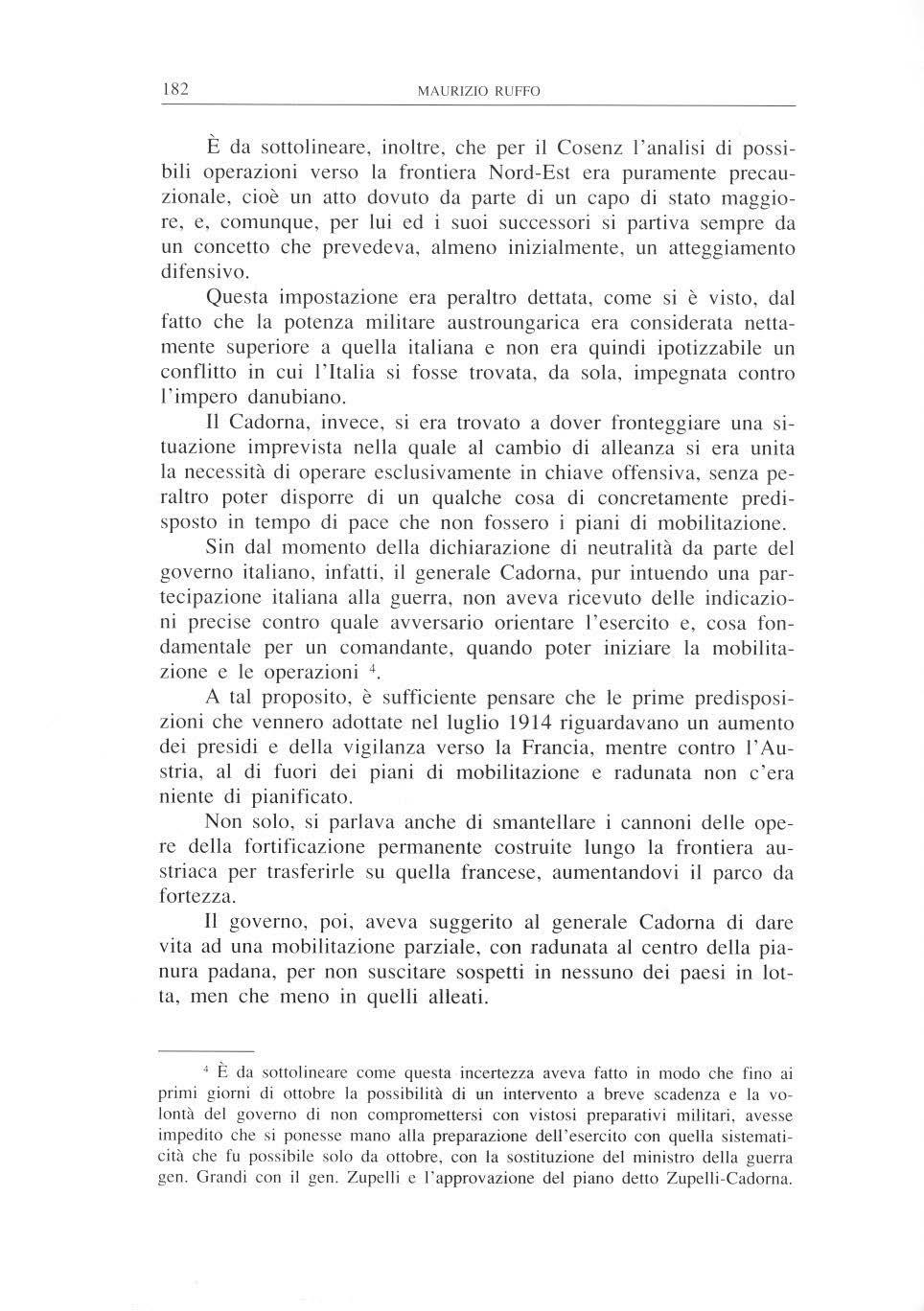
Non so lo , si parlava anc h e di s m a nt e ll are i cannoni de lle opere de lla fortificazione permanen te costruite lun go la frontiera austriaca p e r trasfer irl e s u quella franc ese, aumentandovi il parco ei a fortezza.
li gove rno , poi , aveva s u gge rito al ge ne ral e Cadorna di dare vita ad una mobilita zione parziale, con radunata al centro della pianura padana , per non suscitare sos petti in ne ss uno dei paesi in lotta , me n che meno in quelli alleati.
• È da so ttolin eare come questa incertezza aveva fatto in modo che fino ai primi giorni di ottob re la poss ibilità di un interv ento a breve scadenza e l a volontà del govern o di non co mpromettersi co n vistosi preparativi militari , avesse impedito c he si pon esse mano alla preparazione dell 'esercito co n quella sis tema tic ità che fu possi b ile solo da ottobre, con l a sos titu zio ne de l mini stro della guerra gen. Grandi co n il gen. Zupel l i e l ' approvazione del piano dello Z upel li -Cado rn a.
Un altro elemento di significativa differenza tra il piano congegnato da l Cosenz e quello del Cadorna era rappresentato dal sistema di mobilitazione e radunata adottato.
Con il primo era in vigore un sistema definito rigido, dove le d ue operazioni avvenivano contemporaneamente, con l'inconveniente che in zona di radunata arrivavano sia i reparti da completare sia i richiamati, creando problemi di organizzazione dei tra s porti, di equipaggiamento, di addestramen to e di amalgama a li ' interno d ei repa rti stessi.
Con i l secondo, si era pensato ad un sistema, chiamato mobilitazione rossa, in cui i repa rt i si completavano nelle loro sedi di pace e, quindi, venivano inviati al fronte pronti per essere impiegat i immediatamente.
Questa nuova co ncezione avrebbe presentato i vantaggi di semplificare l 'orga ni zzazione dei trasporti , con il risparmio di tempo che ne sarebbe der ivato, e di poter inviare i reparti d ire ttamente in linea di operazioni senza dover sostare, per il completamento, nella zona di radunata.
Non vanno tuttavia dimenticati gli sforzi che erano stati operati sia dal generale Sa letta sia dal generale Pollio, e che tendevano a porre rim edio, pur con tutte le limitazion i di carattere finanzia ri o e politico a c ui dovettero andare incontro, ad un a situaz io ne mili ta re della frontiera No rd - Est es tremamente carente.
Era pur vero che il Veneto e l a pianura friu l ana e ran o stat i acquisiti so lo nel 1866, m a negli anni seguenti la si tua z ione i nfrastru tt ural e, ferrovie soprattutto, era rima sta estremamente care nte.
In o ltre la s ic urezza dei nu ov i co nfini non era stata a d eguatamen te affronta t a, rim a ne ndo l 'ese rc ito legato alla vecc hi a co ncezione del Ri cotti di radunare le forze nella p i an ura padana, a Stradella, e lascia nd o lun go le vall i a lp i ne so lo delle unit ~ t terr itoriali, le compagnie a lpini cli recente cos titu z io ne, co n compiti di fre na gg io.
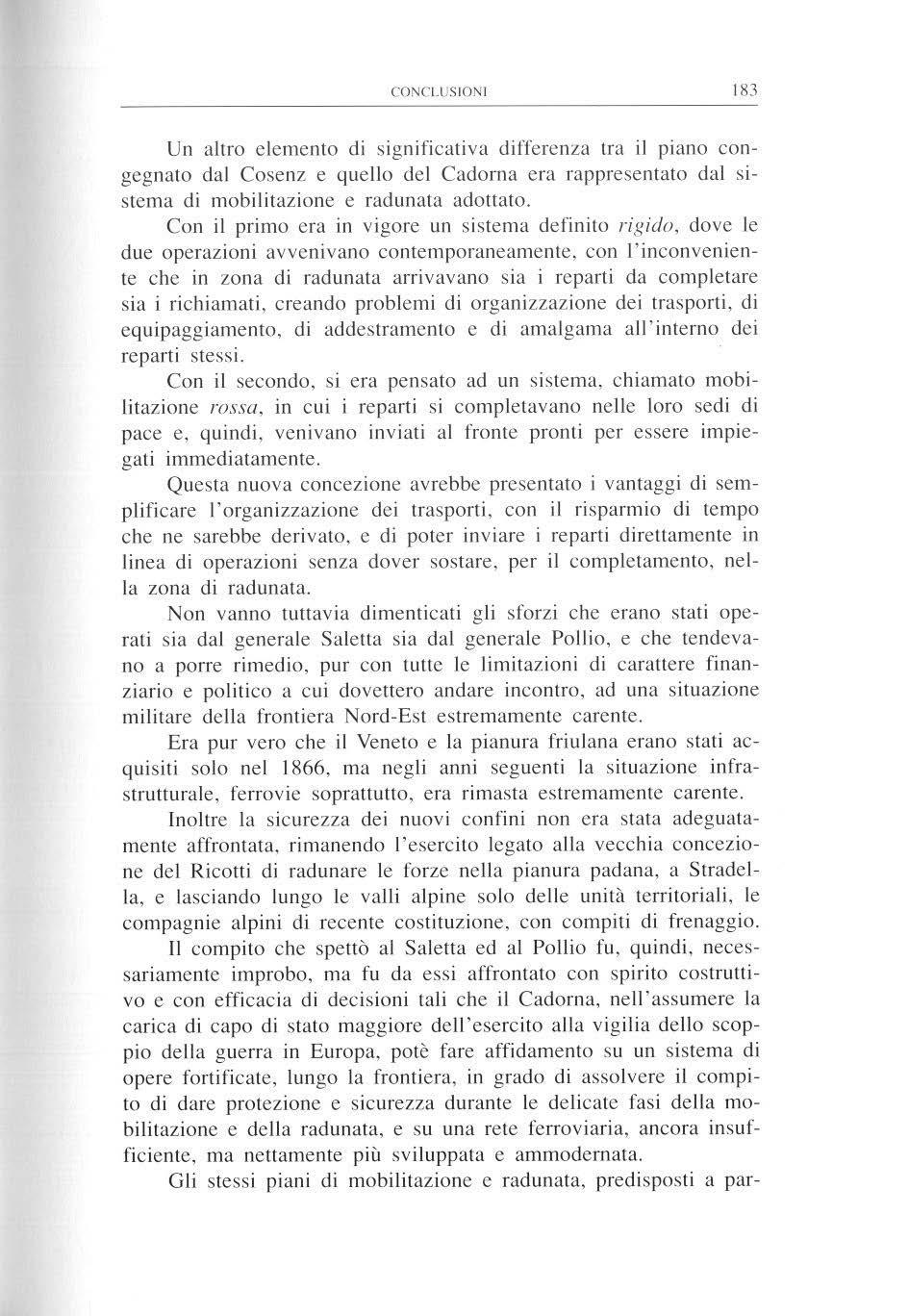
Il compito che spettò a l Saletta ed al Pollio fu , qui nd i, necessa ri amente improbo, ma fu d a ess i affron t ato con s pirito cost rutt ivo e con efficacia d i decisioni tali che il Cadorna, nell'ass umere la carica di capo di s ta to magg iore d e ll 'eserc it o al la vigilia de llo scoppio del la g ue rra in Europa , potè fare affidame nt o s u un sistema di opere fortificate, lungo la frontiera, in grado di asso lvere il comp ito di d are protez ion e e s icu re zza durant e le d e lica te fas i della mobilitazione e della radu nat a, e s u un a re te ferroviaria , a ncora in s u fficiente, ma nettamente più sv iluppata e ammodernata.
Gli s tess i pi a ni di mob il it az ion e e ra du nata, pre di s pos ti a par-
tire dal 1885, erano s t ati sempre pi ù aggiornati e perfezionati con il progredire sia della rete ferroviaria e de ll ' intero sistema de ll e comunica t ioni , s ia d e llo sviluppo delle fortificazioni e degli o rga nici d e ll' ese rcito stesso.
I noltre un n otevole contributo alla preparazione della nazione alla g ue rra era sta to dato dalla presa di coscienza, da parte dcli' opinion e pubblica, del la necess it à di provvedere a ll a dife sa de l paese sin dalla linea di confine, senza dover cedere un solo pa lm o di territorio metropolitano al nemico.
Ciò è dimostrato dal co ntinu o avvicina m e nt o dell'esercito ai confini: da Strade ll a ci si era portati ini z ialme nt e all'Adige, poi al Pia ve ed infine al Tagliamento.
Le s tesse truppe di copertura, in un primo tempo costi tuit e da picco I i reparti di milizia territoriale, erano anda te via v ia aume ntando di numero e quantità, venendo a comp rendere anche repar ti dell'e se rcito permanente oltre al personale impiegato nelle opere fortifi cate.
Si era passa ti , c io è, dal co rpo speciale, sc hi erato tra il Tagliament o ed il Piav e co n compiti di frenaggio dell'avanzata de l nemico. ad una cintura di unità impiegate in occu p az ione avanzata, che non si sa rebbero più limitate a ga r ant ire solo l 'in teg rit à del territorio metropolitano, m a, ove possibile, avrebbero a nch e assunto l'ini z ia ti va oltre il co nfin e.
È infine importante so tt olineare co m e, an c he nel pe riodo d i adesione al la Triplice, l'Italia, pur asso lve nd o al sacro dovere di predi s po rre tutte le misure id o nee alla sa lvaguardi a de lla prop ria sic urezza ed indipendenza. avesse se mpre mostrato la propria assoluta fedeltà ai trattati sot t oscritti, pur correndo anche il rischio di trovar si, impre parata, a dov er fronteggiare un 'agg ressio ne d a pa rt e di una na z ione alleata.
E la dim os tra z io ne più chia ra era data, nel pe ri odo interessato, dal la pressoché assoluta mancanza di una pian ificazio ne operati va verso l ' Au s tria- U ngh e ria , cosa che non s i ern ve rifi ca ta né ve rso il co nfine fra ncese 5 né nell'approntamento d e lle predisposizioni pe r l ' in v io di alcuni co rpi c1·armata s ul Re n o al fianco de ll 'ese rcito tedesco.
'
Cfr.: Maurizio Ruffo. L" /1alia 11e/la 1i·iplice Allea11:a midi sulle opl'ra:ioni militari alla Jro111hn1 Jra11ce.1e /913. in ~tudi storico militari 1995. USS M E. Roma 1997.
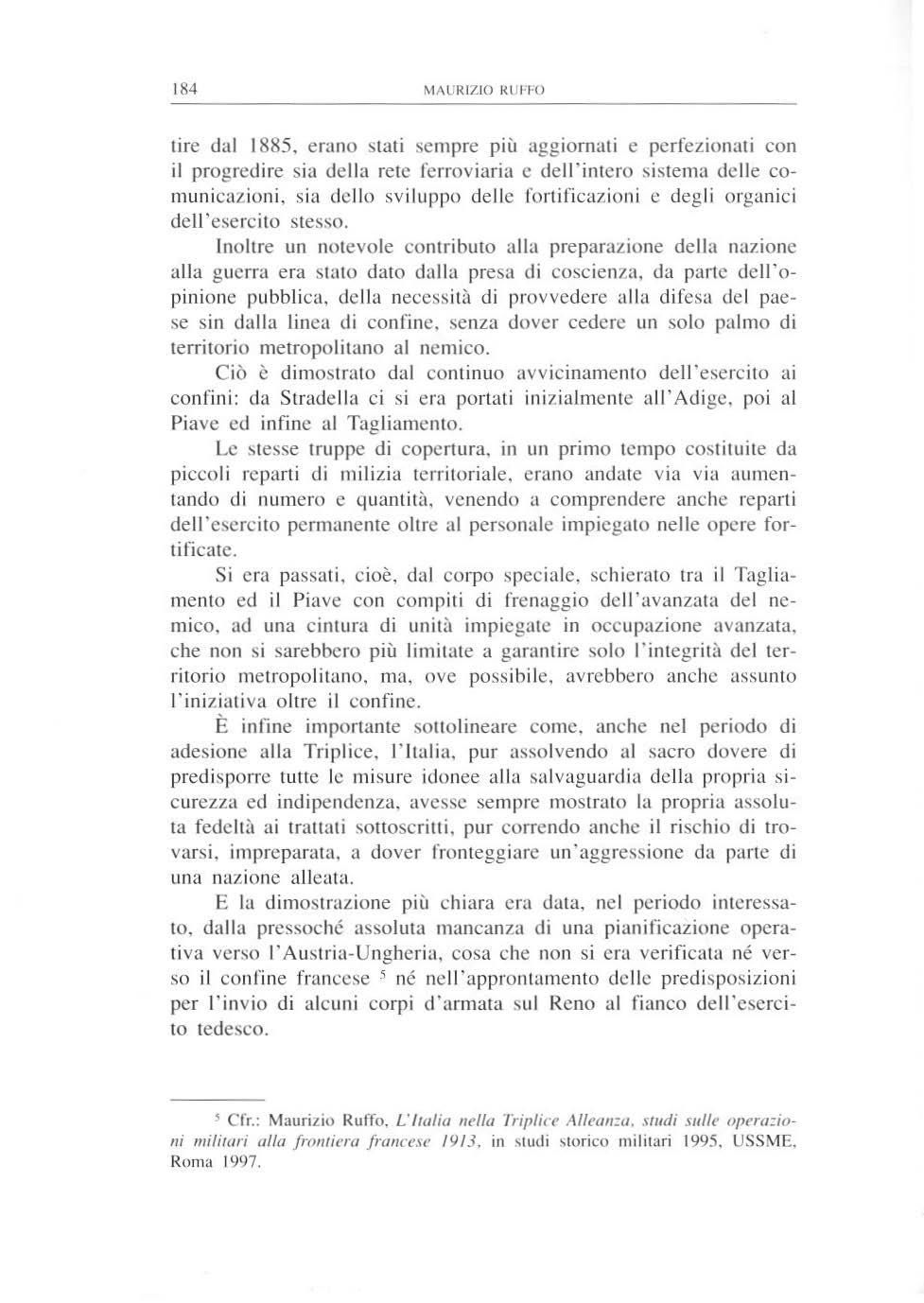
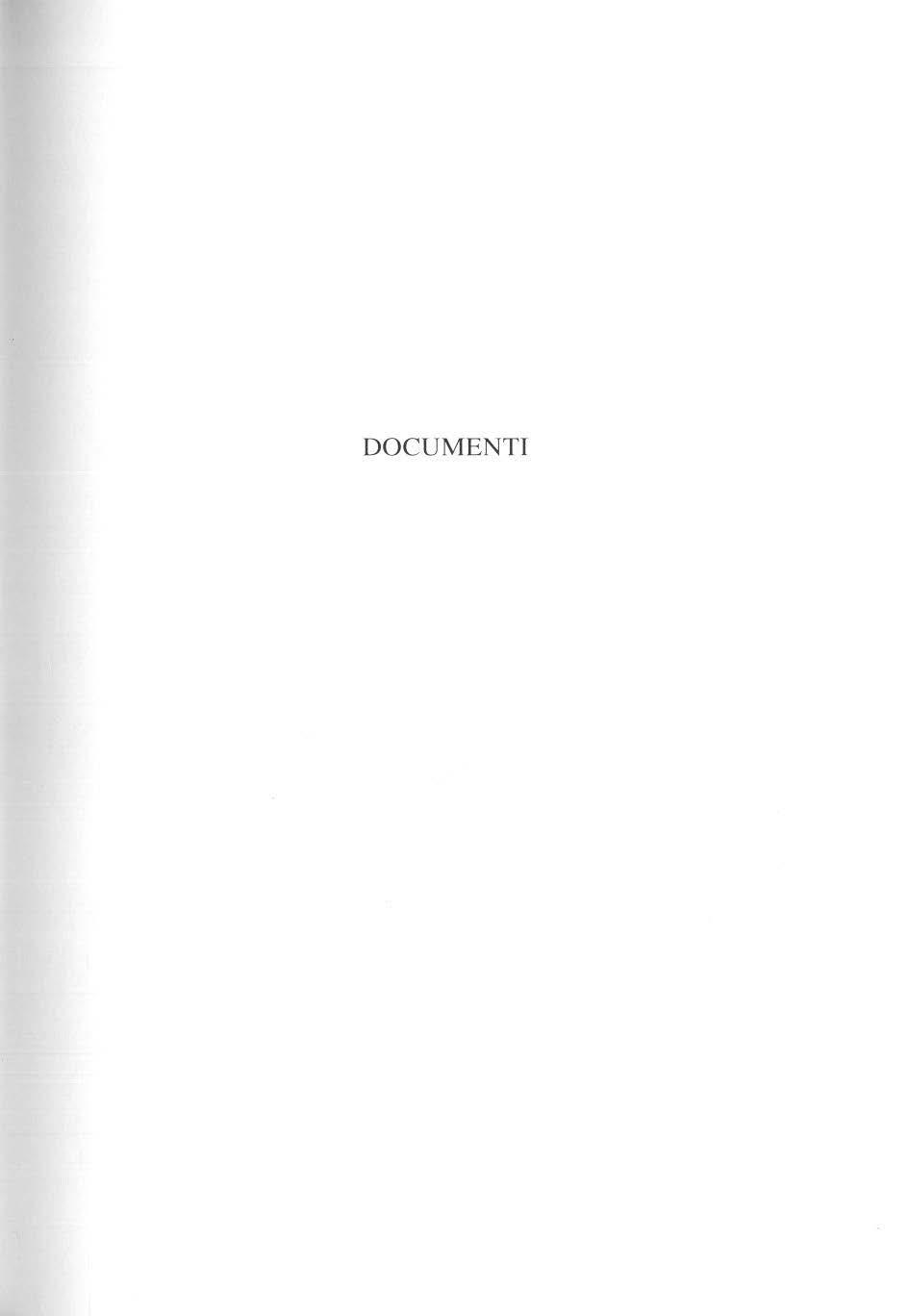

Le LL. MM. l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia etc. e Re apostolico di Ungheria, l'Imperatore di Germania, Re di Pru ssia e il Re d'Italia, animati dal desiderio di aumentare le garanzie della pace generale, di rafforzare il principio monarchico e con ciò di mantenere intatto l 'o rdine soc iale e politico nei loro rispettivi Stati , si sono trovati d 'accordo nel conchiudere un trattato che, per la sua natura essenzialmente conservatrice e difensiva, non persegue altro scopo che di premunirli contro i pericoli che potrebbero minacciare la sicurezza dei loro Stati e la tranquillità dell'Europa.
Per questo scopo le LL. MM. hanno nominato:
S. M. l'Imperatore d'Austria, Re cli Boemia etc. e Re apostolico cli Ungheria il conte Gustavo Kàlnoky, generale, suo ministro della casa imperial e e degli affari esteri;
S. M. l'Imperatore di Germania, Re cli Prussia il principe Enrico Yll di Reuss, aiutante di campo generale, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso S. M. imperiale e reale apostolica;
S. M. il Re d ' lt.alia il conte Carlo Felice Nicolis cli Robillant, tenente-generale, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso S. M. imperiale e reale apostolica , i quali, muniti di pieni poteri che sono stati trovati in buona e debita forma, hanno convenuto gli artico I i seguenti:
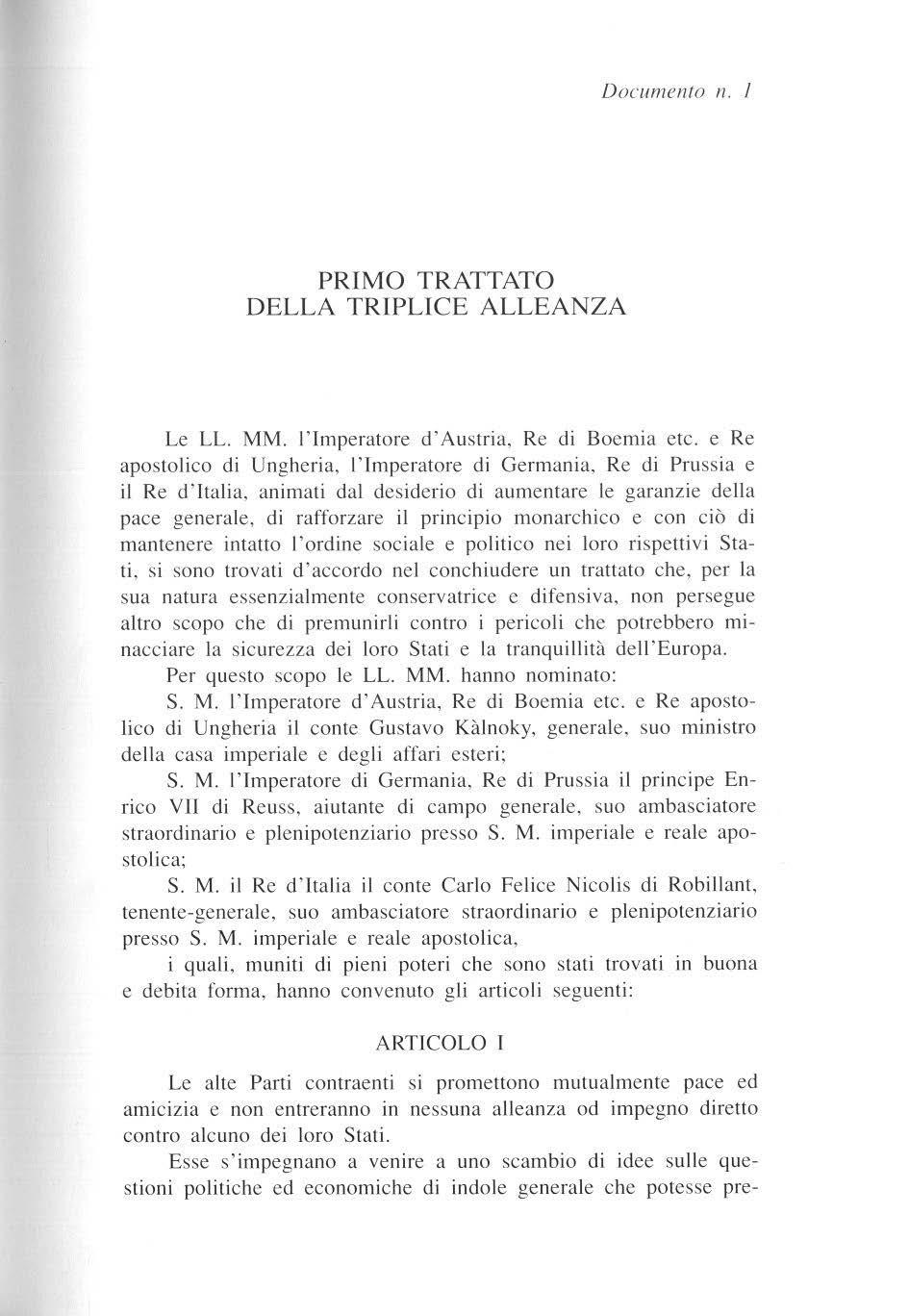
Le alte Parti contraenti s i promettono mutualmente pace ed amicizia e non entreranno in ne ss una alleanza od impegno diretto contro alcuno dei loro Stati.
Esse s'impegnano a venire a uno scambio cli idee sulle questioni politiche cd economiche di indole generale che potesse pre-
sentarsi e si promcllono in oltre il loro mutuo appoggio nel limite dei loro propri interessi.
I cl caso che l'Italia, senza provocazione dirclla da parte sua. fosse per un qualunque motivo attaccata dalla Francia, le due altre Parti contraenti saranno tenute a prestare alla parte attaccata aiuto e assistenza con tutte le loro forze.
Questo stesso obbligo incomberà all'Italia nel caso di un'aggressione, non direttamente provocata, della Fran cia contro la Germania.
Se una o due delle alte Parti con traenti , senza provocazione dirella da parte loro, venisse ad essere attaccata e a trovarsi impegnata in una guerra co n due o più g randi potenze non firmatarie del prese nte trattato, il "cas11s foederis" si presenterà simultaneamente per tutte le a lt e Parti co ntraenti.
Nel caso di una grande Potenza non firmataria del presente trattato minaccias se la sicurezza degli Stati di una delle alte Parti contraenti e la parte minacciata si vedesse perciò costretta a farle la guerra, le due altre P arti si obbligano ad osservare verso la loro alleata una neutralità benevola. In questo caso ciasc una cli esse si ri serba la facolti:1 di prendere parte al la guerra, se lo g iudi chi opportuno, per fare causa comune con il suo alleato.
Se la pace di una delle alte Parti contraenti venisse ad essere minacciata nelle circostanze previste dagli articoli precedenti, le alte Parti contraenti si concerteranno in tempo util e s ulle misure militari da prendere in vista di un'eventuale cooperazione.
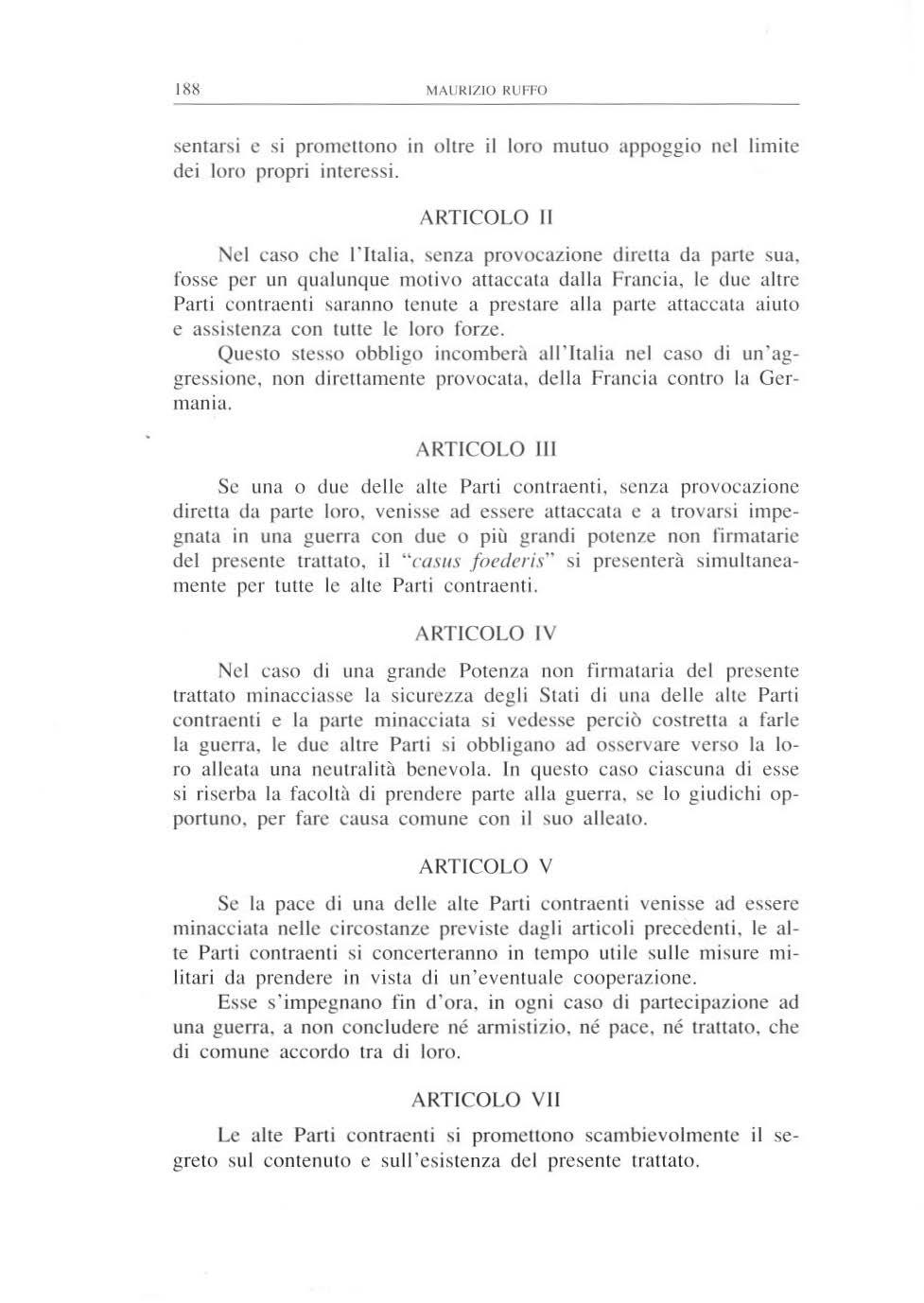
Esse s' imp egnano fin d'ora. in ogni caso di partecipazione ad una gue rra , a non concl ud ere né armisti7io, né pace, né trattaro, che di comune accordo tra di loro.
Le alte Parti contraenti si promellono scambievo lm en te il segreto s ul contenuto e sull'esistenza d e l presente rrattato.
11 presente trattato r esterà in vigo re durante cinque anni a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche.
ARTICOLO vm
L e ratifiche del presente trattato saranno scambiate a Vienna nel tempo di tre settimane, o più presto se far si può.
ln fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.
Falto a Vienna. il i·entesimo giorno del mese di maggio del/' anno mille ortocenlo ollantadue .
Kàlnoky E. V11 cli Reuss C. Robillant
NOTA: Cfr. Alfrcd Francis PRIBRAM. Die politischen Ceheirn1 •ertrage Oe srerreich-U11gams /879-/914. pag. 24 (dall'Archivio di Stam di Vienna. att i segreti VII. 75). Gli ori g in ali sono in l ingua francese.
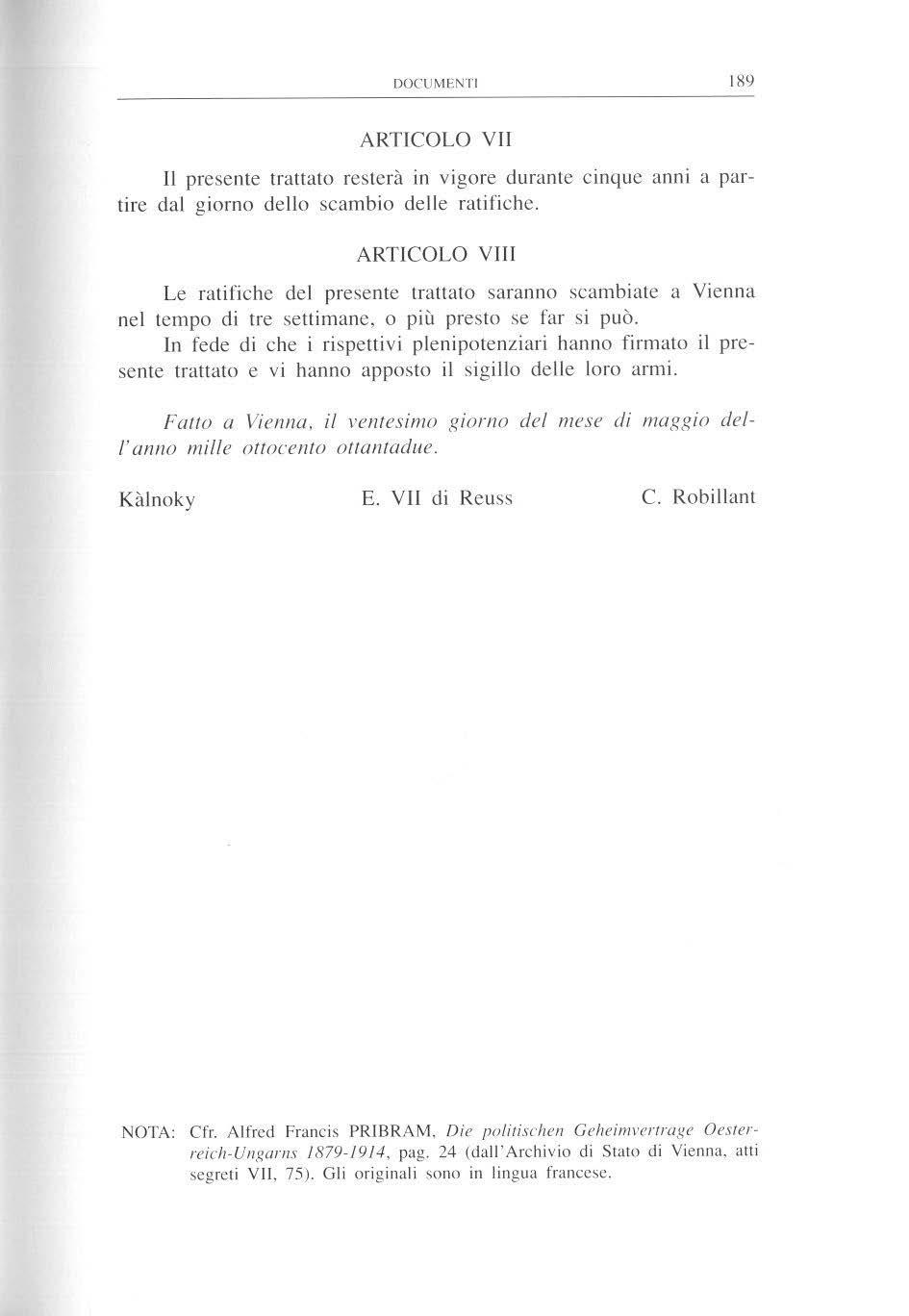

"Accordo concernente la cooperazione dell'Italia alla guerra contro le Potenze Centrali - Londra, 26 aprile 1915".
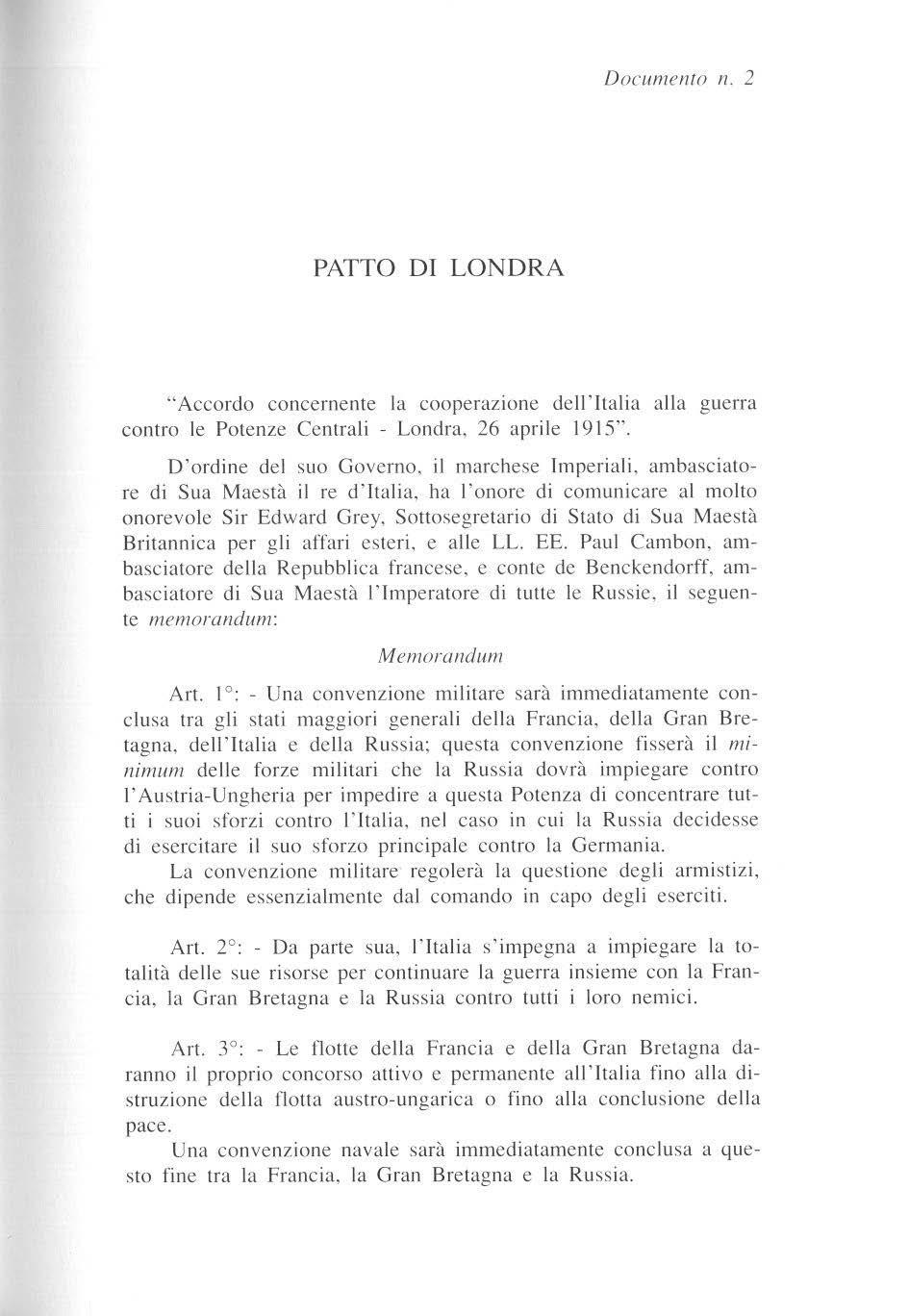
D'ordine del suo Governo, il marchese Imperiali , ambasciatore di Sua Maestà il re d'Italia, ha l 'ono re di comunicare al molto onorevole Sir Eclward Grey, Sottosegretario di Stato cli Sua Maestà Britannica per gli affari es teri, e alle LL. EE. Paul Cambon, ambasciatore del la Repubblica francese, e conte dc Benckendorff, ambasciatore di Sua Maestà l'Imperatore di tutte le Russic, il seg uente memorandum:
Memorandum
Art. I 0 : - Una convenzione militare sarà immediatamente conclusa tra gli stati maggiori generali della Francia, della Gran Bretagna , dell'Italia e della Rus sia; que s ta convenzione fisserà il minimum delle forze militari che la Russia dovrà impiegare contro l'Austria-Ungheria per impedire a questa Potenza di concentrare tutti i suoi sforzi contro l'Italia, nel caso in cui la Russia decidesse cli esercitare i I suo sfo rzo principale contro la Germania.
La convenzione militare regoler~t la questione degli armistizi, che dipende essenzialmente dal comando in capo degli eserciti
Art. 2 ° : - Da parte sua, l'Italia s'impegna a impiegare la totalità delle sue risorse per continuare la guerra insieme con la Francia, la Gran Bretagna e la Russia contro tutti i loro nemici.
Art. 3° : - Le flotte della Francia e della Gran Bretagna daranno il proprio concorso attivo e permanente all'Italia fino alla distruzione della flotta austro-ungarica o fino alla conclusione della pace.
Una convenzione navale sarà immediatamente conclusa a questo fine tra la Francia, la Gran Bretagna e la Russia.
Art. 4 ° : - Ne l trattato di pace, l'Italia otterrà il Trentino, il Tirol o cisalpino con il s uo confine geog rafico e natural e (la fronti era del Bren nero), nonché Tri es te. le contee <li Gorizia e di Gradisca, tutta ri stria fino al Quarnaro, ivi comprese Volosca e le isole istriane di C herso, Lu ss in. co me pure le iso le tt e di Plavnik , U ni e, Cani<lole. Palazzuol i, San Pi et ro cli Nembi. As in e ll o. Gruica e gli iso lotti vici ni .
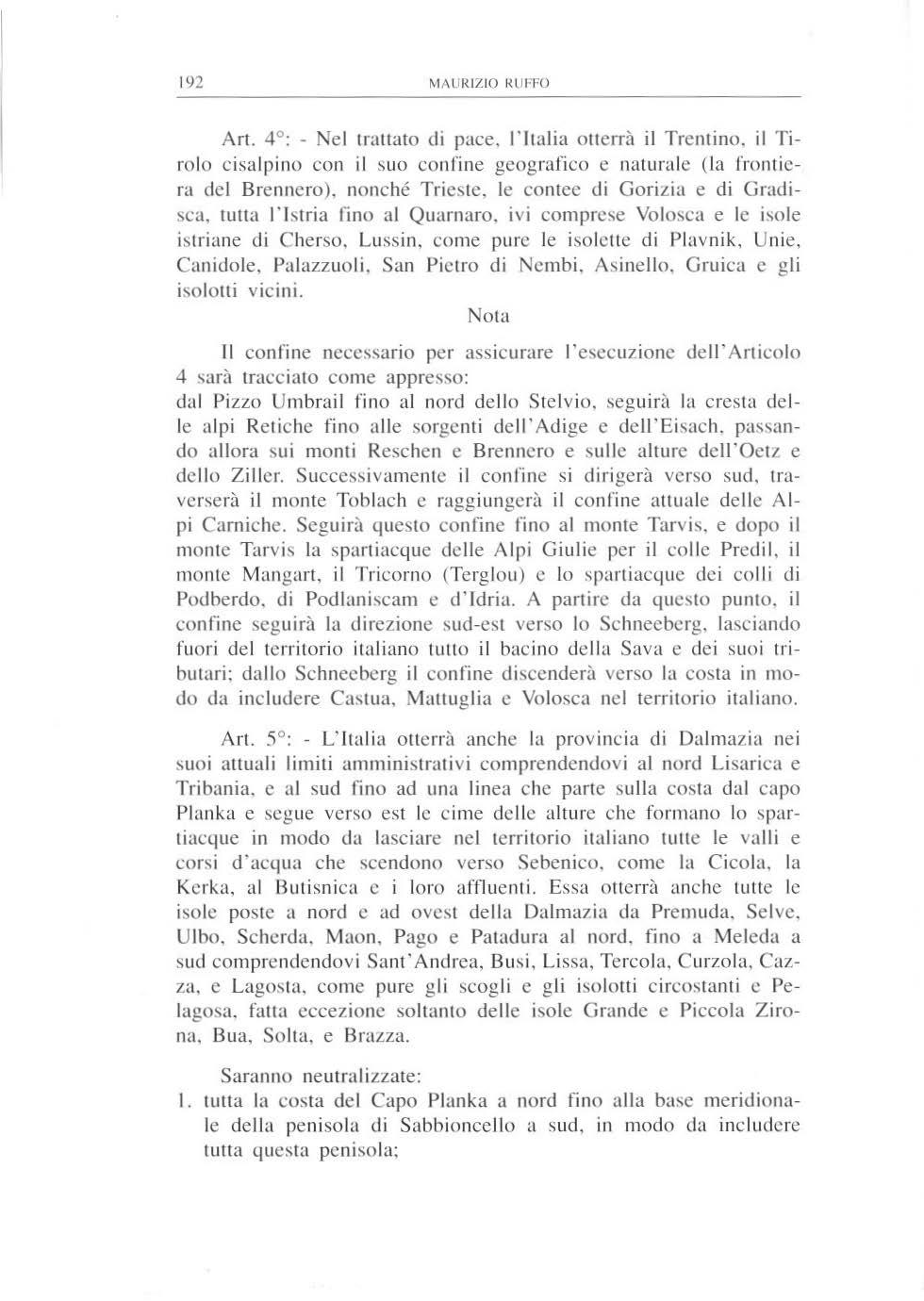
TI con fin e necessario per assicurare l 'esecuz ione dell'Articolo 4 sarà tra cc iato come a ppresso: dal Pi zzo U mbrail fino al nord d e llo Stelvio, seg uir ~1 la cres ta delle a lpi R e ti c he fino a ll e sorgen ti dell'Adige e dcll'Eisach. pas-,ando allora su i monti Reschen e Brennero e sulle alture dcll'Oet1 e dello Zillcr. Successivamente il confine s i dirigerà verso s ud , traverse rà il monte Toblach e raggiungerà il co nfine a uual e d e ll e A lpi Carniche. Seguirà q ues to confine fino al monte T arvis. e dopo il m on te Tar vi-, la s pa rti ac qu e delle Alpi Giulie per il co ll e Predi i, i l m o nt e Man ga rt, il Tricorn o (Te rgl o u ) e lo spar tiacqu e dei colli di Podberdo. di P o dl aniscam e d'Idria. A partire da questo punto. il confine seguirà la direzione sud -est verso lo Sc hn ecbcrg, lasciando fu o ri del te rritorio it a liano tutto il bac ino d e lla Sava e elci s uoi tributari; dallo Schnecbcrg il con fin e d isce nd erà ve rso la cos ta in modo da includere Castua, Mauuglia e Volosca nel territo ri o italiano.
Art. 5° : - L ' I talia olle rr à anc he la pro vinc ia cli Dalmazia nei suoi a uuali limit i a mmini s trati vi co mprendendovi al nord Lisarica e Trib a nia , e al s ud fino ad una lin ea c he parte s ulla cos t a dal capo Planka e seg ue verso est le c ime d e ll e altur e c he formano lo spa rti acque in modo da lasc iare nel territorio italiano tutte le valli e corsi d'acqua c he scend o no ve rso Seben ico, come la Cicola, la Kc rka, al Butisnica e i loro afflu e nti. Ess a o tterrà anche tulle le isole poste a nord e ad oves t dell a Dalma z ia d a Premu d a. Se lve, Ul b o, S cherda. M ao n , Pa go e Pata dura al nord. fino a Me leda a s ud c ompre nd e ndovi Sant' Andre a, Bu s i , Lissa, Te rcola , C urzola , C a zza. e La gos ta, come pure g li scog li e g li iso lo tti cin.:ostanti e Pelagosa, fatta eccez io ne so lt a nt o delle isole Grande e Pi ccola Z ir ona, Bu a, Solta, e Braaa.
Sarann o neutrali zz ate:
1. tutta la cos ta del Capo Planka a nord fino alla base meridionale della pe ni so la di Sabbioncello a s ud , in modo da includ e re tutt a questa peni so la;
2. la parte del litorale che com incia a nord in un punto sit uato I O c hil ometri a sud della punta di Ragusa Vecchia sce ndendo a sud fino al fi um e Voiussa, in modo da in cludere il go l fo e i porti di Cattaro , Antivari, Dulcigno, San Giovanni di Medua , Dura zzo, se n za preg iu dizio dei diritti del Montenegro risult.ati dalle dichiarazioni scambiate tra le Potenze in aprile e maggio 1909. Poiché questi diritti non s'applicano che all ' attuale territorio montenegrino non potranno essere estesi ai terri tori o porti che potessero venire attribuiti al Montene gro . Quindi , ness una parte delle coste attualmente appartenenti a l Mont e neg ro potrà esse r e ne utraliz za ta. L e re s trizioni riguardanti il porto di Antivari alle quali lo stesso Mon tenegro ha a de rito ne l 1909 rimarranno in vigore;
3. e, infine , tutte le isole che non sono attribuite aJJ ·Italia.
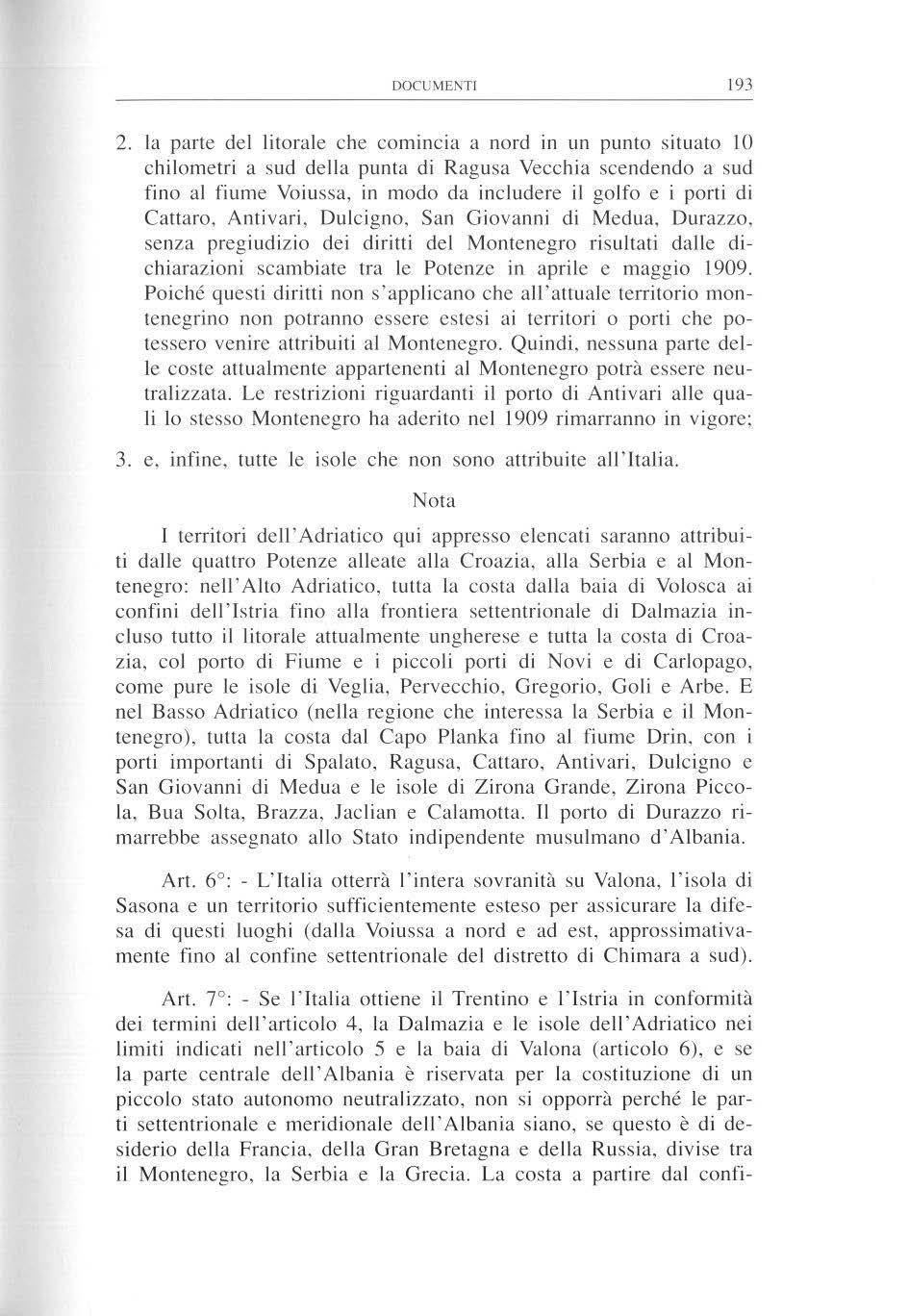
l territori dell ' Adriatico qui appresso elencati saranno attribuiti dalle qu a ttro Pote nze alleate alla Croazia, alla Serbia e al Montene gro: nell 'A lto Ad ri at ico, tutta la costa da ll a baia di Vo losca ai confini dell ' Istria fino a lla frontiera settent ri ona le d i Dalmazia incluso tutto i I Iitorale attualmente un g he rese e tutta la costa di Croazia, col porto di Fiume e i piccoli porti di Nov i e di Carlopago, come pure le isole di Veg li a , Pervecc h io , Gregorio, Goli e Arbe. E nel B asso Adriatico (nella regione che interessa la Serbia e il Monte negro) , tutta la costa dal Capo Planka fino a l fiume Drin , con i porti importanti d i Spalato , R agusa , Cattaro. Antivari , Dulcigno e San Giovanni di Medua e le iso le di Zirona Grande, Zirona Piccola , Bua Solta, Brazza, Jaclian e Cala motta. Il porto di Dura zzo rimarrebbe asseg nat o allo Stato in d ip ende nt e musulmano d'Albania.
A rt. 6° : - L ' Itali a otterrà l ' inte ra sovra nit à s u Valona, l ' isola di Sasona e un territorio s uffi c ie nt e me nt e esteso per a ss ic ura re la difesa di questi luo g hi ( dalla Voiu ss a a no rd e ad est, approssimativamente fino a l co n fi ne se tt e ntrion a le del di s trett o di Chimara a s ud ) .
A rt. 7 ° : - Se l ' Italia ott iene il Tre ntino e l ' Ist ria in conformità dei termini dell'articolo 4, la Dalmaz ia e le isole dell'Adriatico nei limiti indicati nel l 'artico lo 5 e la baia di Valona (artico lo 6), e s e la parte ce ntr a le dell 'A lb an ia è ri servata per la cos titu z ion e di un piccolo stato a utonom o ne utra! izz ato, non s i opporrà perc hé le parti se ttentrionale e m e ridional e del l 'A lbania s iano , se questo è di desiderio della Fra nc ia, d e ll a Gran Bretag na e della Ru ss ia, divise tra il Montenegro , l a Serbia e la Grecia. La costa a partire dal confi -
ne meridionale del possesso italia n o di Valona (ved. l'articolo 6) fino a l Capo Stylos sa r à neutralizzata.
L' It a li a sa rà inca ri cata di rapp rese nt are lo S ta to d'A lbania ne lle s ue relaz ioni con l 'estero.
o·a1tro canto, l" It alia accetta di lasciare in ogni caso atrest dell'Albania un territorio sufficiente per garantire l'esistenza di una fr o n t iera com u ne a l la G rec ia e a ll a Serbia a ll 'oves t d e l lago d'Oc hri d a.
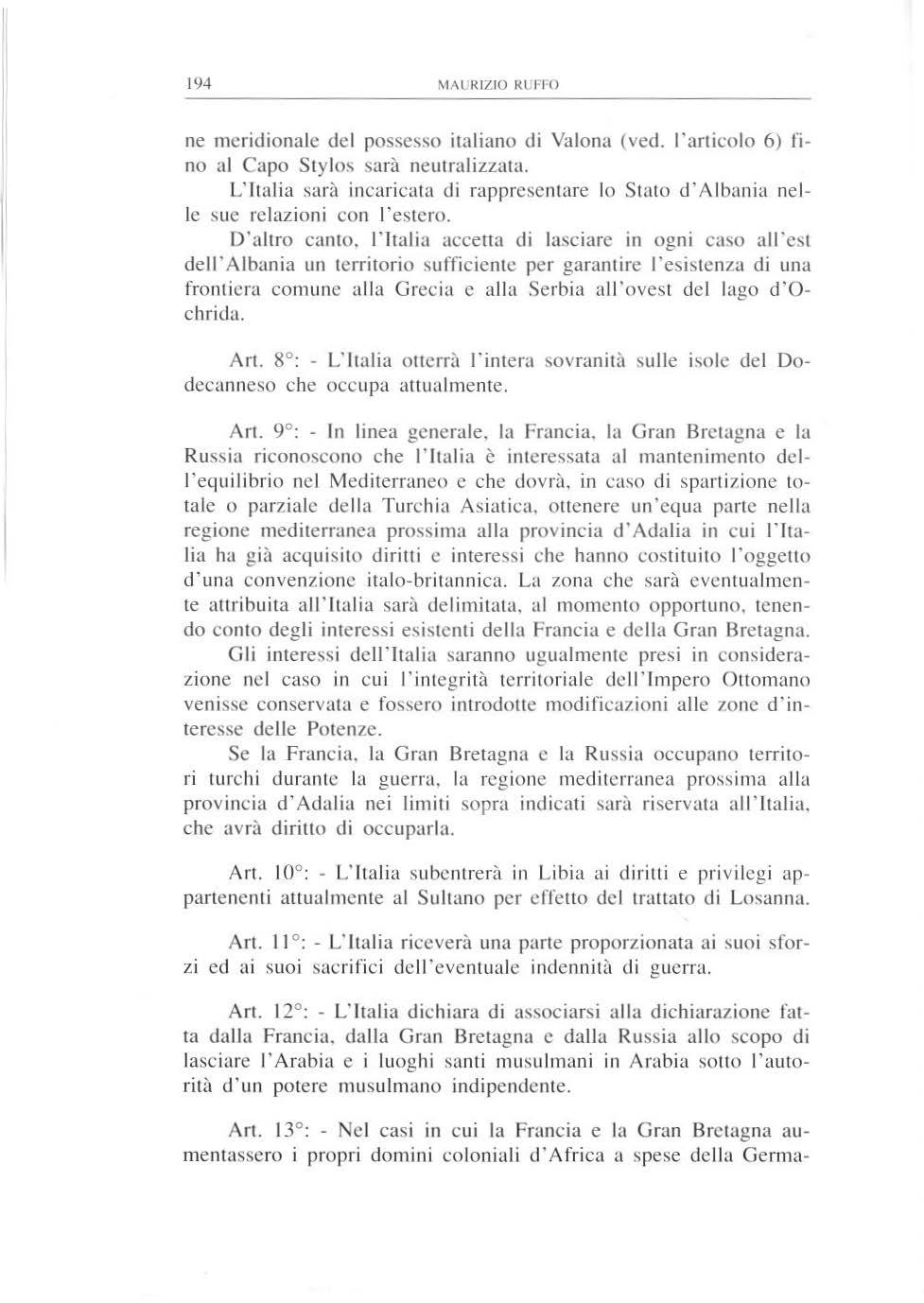
Art. 8°: - L' Italia otterrà I" intera sovranità sulle isole del Dod ecan neso che occupa a tt ua lme n te.
Art. 9 ° : - In l inea generale, la Francia. la Gran Bretagna e la R ussia riconoscono che l'Italia è interessata al mantenimento del!'eq u ili b ri o nel Med iterraneo e c h e dovrà, in caso cli s pa r t iz ione totale o parziale de ll a Tu rc h ia As iatica. ottenere un 'eq u a par te nella regione mediterranea prossima alla provincia d ·Adalia in cui ri talia ha già acquisito di r itti e interessi che hanno costituito l'oggetto d ' un a co n ve n zio ne it a lo-br it a nni ca. La zo na c he sarà event u a l mente attr ib uit a a ll ' It a l ia sarà delimi tata. a l momento opportuno, tenendo conto deg l i interessi esistenti della Francia e della Gran B retagna.
Gli inte ressi dell'Italia saranno ugualmente presi in consideraz io ne ne l caso in c ui l 'i n tegr it à terr it o ri a le cicl i ' Im pero Otto m ano venis'ic co n servata e fossero introdotte modificazioni a ll e zone d' interesse delle Potenze.
Se la Francia, la Gran Bretagna e la R ussia occupano territori tur c hi dura nt e la g uerra, la reg io ne m e d i terranea prossi m a a ll a p rovincia d'Ada lia nei limiti sopra indicati sarà riservata a ll ' It alia. che avrà d irillo di occuparla.
A rt. 10° : - L' It a lia s u be ntre r à in L ib ia ai d ir ill i e p r iv il eg i appart e nen ti a tt ua lme n te al Su lt a no per effe tt o de l t ra t tato di Losanna.
A r t. 1 1° : - L" It a lia riceve rà una parte proporzionata ai suoi sforzi e d ai s uoi sac rifi c i d e ll'eve ntual e in de nnit ~ l di gue rra.
Art. 12 ° : - L' It a lia dichiara di associa r si alla dic h iarazio ne fatta dalla Francia, da l la G r an B retagna e da ll a R ussia allo scopo di lasc ia re l ' Ara b ia e i luo g hi sa nti mu s ulm a ni in Ara bia so tt o l ' aut orit à d ' un po te re mu s ulm a no indip e nden te.
A rt . 13 ° : - Ne l cas i in c ui la Fra ncia e la Gra n Bre tag na a um e ntasse ro i pro pri dom i ni co lo ni a li d ' Afri ca a s pese d e ll a Ge rm a-
n ia, le due Potenze riconoscono in I inea di principio che l'Italia potrebbe reclamare qualche equo compenso specialmente nel regolamento in suo favore delle questioni riguardanti le frontiere delle colonie de li 'Eritrea, del la Somalia e della Libia e de lle vicine colonie della Francia e della Gran Bretag na.
Art. 14°: - La Gran Bretagna s'impegna a facilitare la conclusion e immediata, a eque condizioni, d'un prestito di almeno 50.000.000 di s terline da emettersi s ul mercato di Londra.
Art. 15 ° : - La Francia, la Gran Bretagna e la Russia sosterranno l 'oppos izione che l'Italia farà ad ogni proposta mirant e a introdurre un rappresentante della Santa Sede in tutti i negoziati per la pace e per il regolamento dei problemi creati dalla presente g uerra.
Art. 16° : - La presente intesa sarà tenuta seg reta . La sola adesione cieli' Italia al la dichiaraiione ciel 5 sc ll emb re 1914 sa rà resa pubblica subito dopo la dichiarazione cli guerra da parte o contro l'Italia.
Dopo aver preso atto di questo memorandum, i rappresentanti della Francia, della Gran Bretagna e della Rus s ia, debitamente autorizzati a que s to fine, hanno concluso col rappre sen tante cicli ' I talia , ugualment e autorizzato dal suo Governo, il seg uente accorcio: la Francia, la Gran Bretagna e la Ru ssia danno il loro pieno assenso al memorandum prese ntato dal Governo Italiano. Con riferimento agli articoli I , 2 e 3 del memorandum. che prevedono la cooperazione militare e navale delle quattro Potenze, l' Italia dichiara che entrerà in campo al più presto possibile e in un per iodo di tempo che non potrà oltrepassare un mese dalla firma de lle presenti.
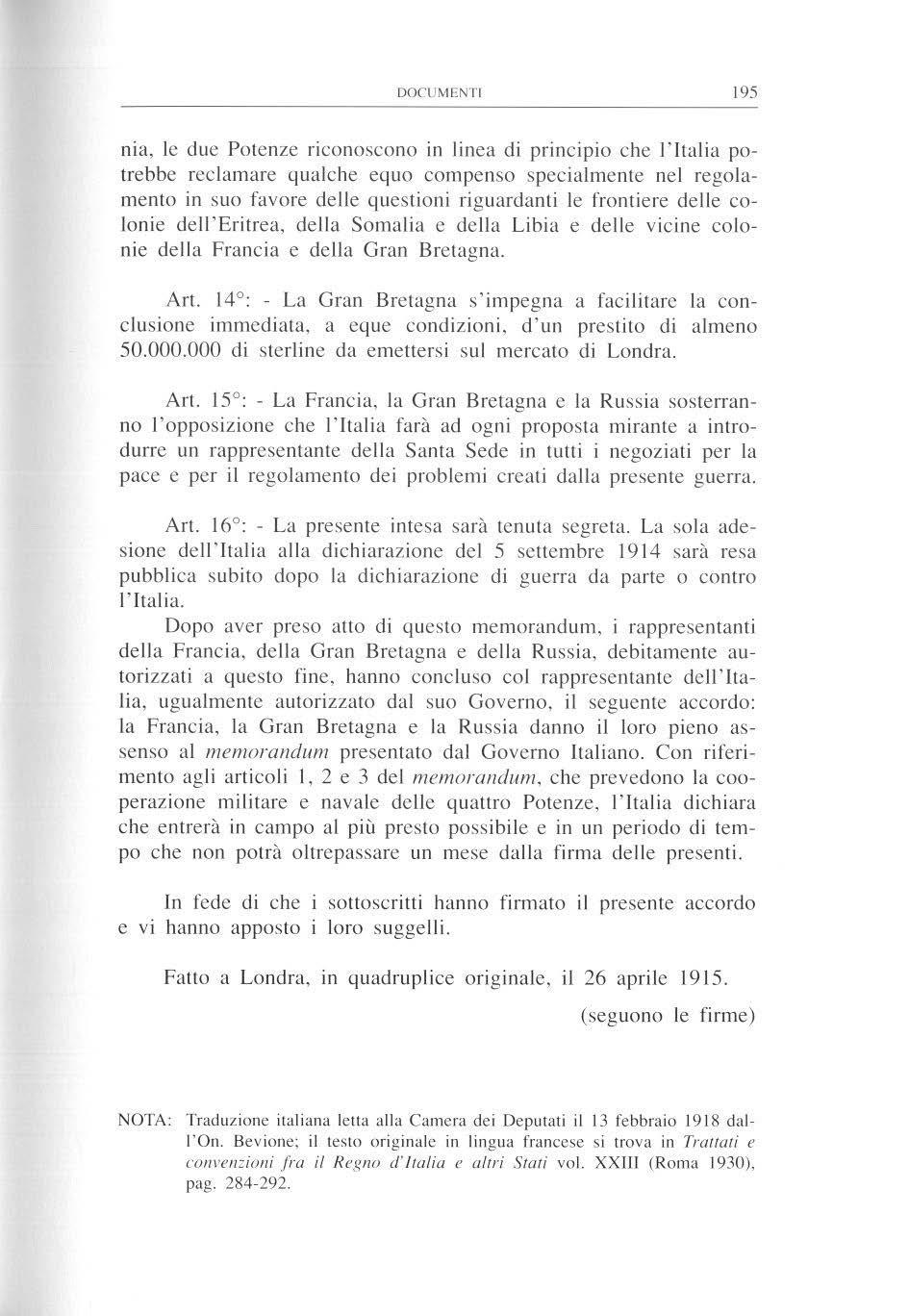
ln fede cli che sottoscritti hanno firmato i I presente accordo e vi hanno appos to loro s uggelli.
Fatto a Lo ndra, in quadrup l ice originale , il 26 aprile 1915.
(seguono le firme)
NOTA: Traduz ione it al iana letta alla Camera dei Dep utati il 13 febbraio 19 18 dall'On. Bevione ; il testo origina le in l ing ua franc ese s i tro va in Tra/lati e co11,•en:io11i fi'a il Regno d ' Italia e altri Stati vo i. XXIIl (Roma 1930) , pag. 284-292

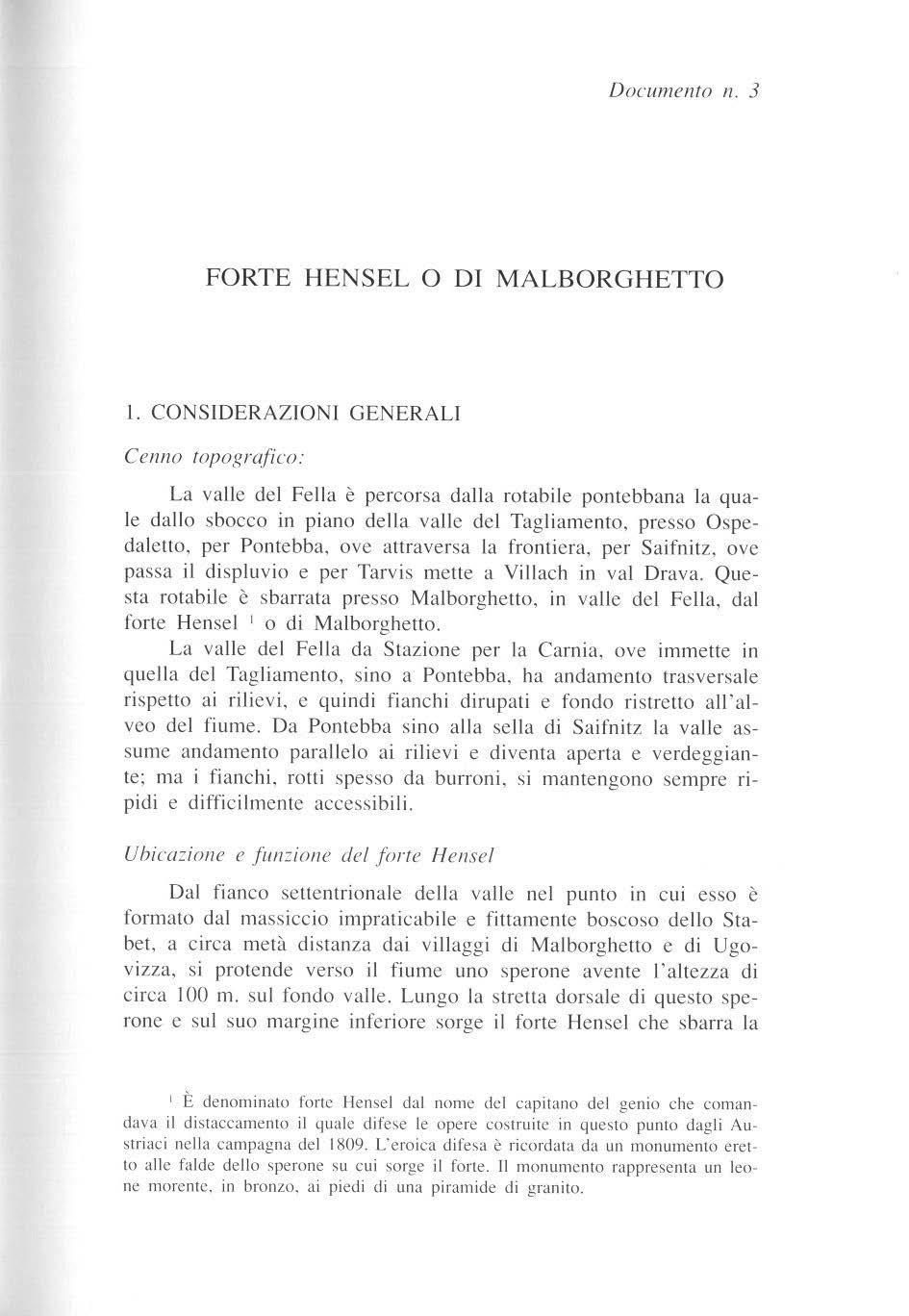
Cenno Topog rafi co :
La valle de l Fella è pe rcorsa dalla rotabil e pontebbana la quale dallo s bocco in piano della valle de l Tagliamento , presso Ospedal e tt o, pe r Pontebba, ove attraversa la frontiera, per Saifnitz, ove passa il di sp lu vio e per Tarv is m e tt e a Vi ll ach in val Drava . Questa rotabile è s barrata presso Malborg he tto, in va ll e del Fella, dal forte H ense l I o di Malborghetto.
La va ll e del Fella d a Stazione pe r la Carnia, ove immette in quella d e l Ta g liamento , si no a Ponte bba, ha andame nto trasversal e ri s petto ai rilievi. e quindi fianchi dirupati e fondo ristretto all'a lveo del fiume. Da Pontebba sino all a sella di Saifnitz la va lle assume anda m e nto para ll e lo ai r ili ev i e d ive nta ape rta e verdeggiante; ma i fianchi. rotti s pe sso da burroni, si mantengono semp re ripidi e difficilmente accessibili.
Uhica:ione e ji111:io 11 e del forte H ensel
Dal fianco se tt e ntrionale de ll a va ll e ne l punto in cui esso è formato dal ma ssiccio impraticabi le e fittamente boscoso del lo Stabet, a circa m età distanza dai vi ll agg i di Ma lborghetto e di Ugovizza, s i protende ve rso il fiume uno .sperone avente l'altezza cli circa I 00 m. sul fondo va ll e Lun go la s tretta dorsale di qu esto sperone e s ul .s uo m a rgine infer iore s orge il forre Hen sel c he s barra la
1 È denom in ato fo r te Hensel dal nome del cap itano de l genio che co mandava i l distaccamenlO il quale difese l e opere costruite in ques to pun to dag l i A ustri aci nella cam pagna de l 1809. L 'e roi ca dife~a è ri corda ta da un monumento ere tto all e falde dello sperone su cui sorge il forte. li mo nu men to rappresenta u n leone m orente. in bronzo. ai pie di d i una piramide di granito
rotabile pontebbana ed interessa così le nostre o peraz ioni militari avenri svil uppo pe r la va ll e del Fe ll a.
Il for te H ense l fu cost ruito neg li a nni 1880 - 83; venne poi s uccessivamente ampliato e mig liorat o ed oggi co nsta:
a) d e ll'op e ra , principal e, bassa;
b) del!' opera alta;
e) di una batteria e di una c upola inte rm ed ie;
cl) di opere accessorie e com u nicazioni
a) Opera p r incipale bassa. È costruita su di un ripiano ricavato a ll' est re mit à Sud del dosso dello spero ne. Con s t a di un fabbricato a quattro piani che com pre nd e una fronte principale cd un fianco. Ne ll a fronte principale vi so no:
l) una batte ri a corazzata, tipo Gruson, per 4 pe7,zi 2 ;
2) du e torri corazzate , tipo Gruson, c i ascu na per 2 pezzi \ Nel fianco, che forma l' estremità Sud dell'opera, v i so no diversi ma gazz ini , camcro ni , corpo di g uardia ecc.
li primo ed i I secondo piano so no so tt erra ne i e scavati in gran parte ne ll a roccia; al ter zo piano, che è al li ve llo del co rtile interno , s i trov a la batter ia corazzata e l'ingresso a l forte; ne l quarto piano sono impostate le du e torri corazzate. La stru ttura della batteria corazzata e delle torri è in calcestruzzo.
Lungo la fronte princip a le ci e li 'opera è scava to un fosso che gira a nche attorno al lato Nord d ell'opera stessa.
TI fosso è fiancheggiato da una ga ll er ia di con tro sca rpa s ituat a ali 'es tremità Nord del fosso stesso.
Un a capponiera è rica va t a verso il mezzo d e l fianco Sud per fianche gg iare tal e fianco nel quale sono ape rte d e ll e feritoie; un a m ezza capponiera ricavata ali 'estremità orientale d e llo s tesso fi a nco, fiancheggia il fronte di gola ne l qual e vi sono anche dell e feritoie.
b) Op era alta . Si trova ne lla parte più e leva ta d e l forte e co n s ta di 4 torri corazzate g irevo li ( Panze rturm e) in ciascuna delle quali è installato un mortaio di b ro n zo del ca libro cli cm. 15.
2 Pare che lo spes sore delle piastre sia di m. O, 42. ' Pare c he lo spessore delle piastre sia di 111. O. 53 p resso l e cannoniere e di m. O, 45 negli al tri punti.
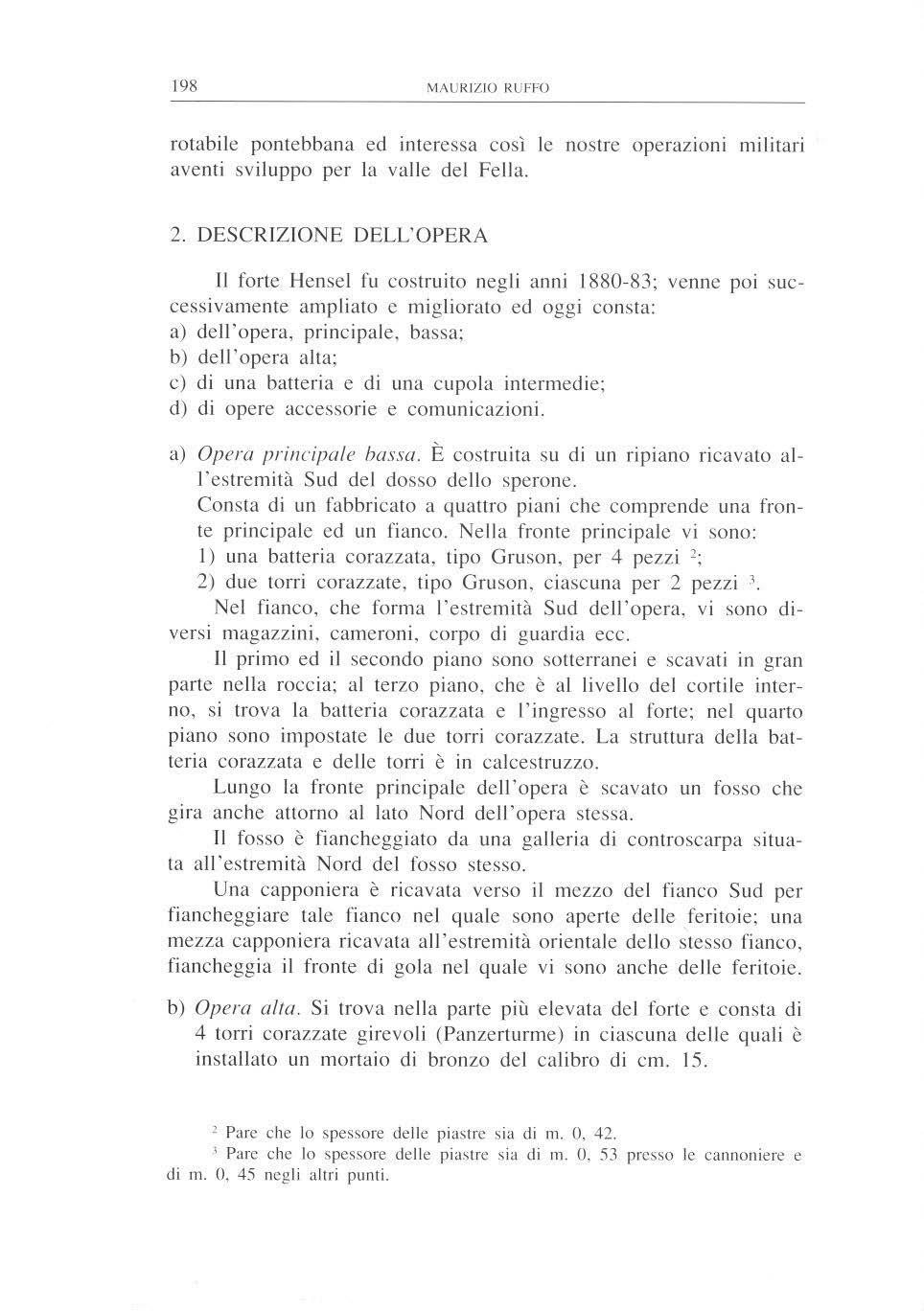
c) Batteria e rnpola intermedie. Sul dosso dello sperone, fra le due opere bassa ed alta, si trovano una batteria ed una cupola girevole. La batteria è in barbetta per due pezzi; la cupola girevole è identica alle 4 cupole che formano l'opera alta e si trova poco sotto della batteria.
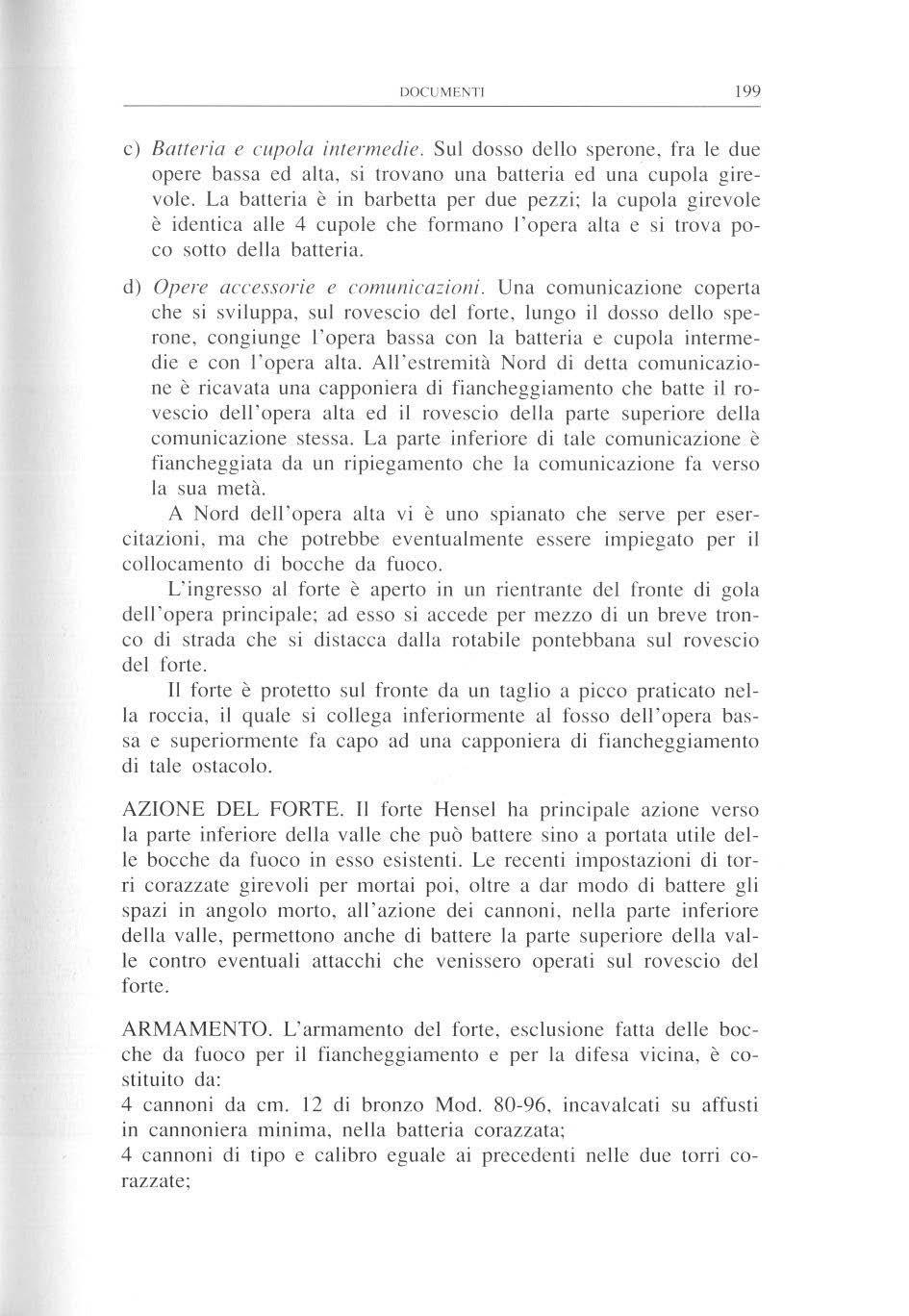
d) Opere accessorie e comunica:ioni. Una comunicazione coperta che si sviluppa, sul rovescio del forte, lungo il dosso dello sperone, congiunge l'opera bassa con la batteria e cupola intermedie e con l'opera alta. All 'estremiti1 Nord di detta comunicazione è ricavata una capponiera di fiancheggiamento che batte il rovescio dell'opera alta ed il rovescio della parte superiore della comunicazione stessa. La parte inferiore di tale comunicazione è fiancheggiata da un ripiegamento che la comunicazione fa verso la sua metà.
A Nord dell'opera alta vi è uno spianato che serve per esercitazioni, ma che potrebbe eventualmente essere impiegato per il collocamento di bocche da fuoco.
L'ingresso al forte è aperto in un rientrante del fronte di gola dell'opera principale; ad esso si accede per mezzo di un breve tronco di strada che si distacca dalla rotabile pontebbana sul rovescio del forte.
TI forte è protetto sul fronte da un taglio a picco praticato nella roccia, il quale si collega inferiormente al fosso dell'opera bassa e superiormente fa capo ad una capponiera di fiancheggiamento di tale ostacolo.
AZIONE DEL FORTE. Il forte Hensel ha principale azione verso la parte inferiore della valle che può battere sino a portata utile delle bocche da fuoco in esso esistenti. Le recenti impostazioni di torri corazzate girevoli per mortai poi, oltre a dar modo di battere gli spazi in angolo morto, all'azione dei cannoni, nella parte inferiore della valle, permettono anche di battere la parte superiore della valle contro eventuali attacchi che venissero operati sul rovescio del forte.
ARMAMENTO. L'armamento del forte, esclusione fatta delle bocche da fuoco per il fiancheggiamento e per la difesa vicina, è costituito da:
4 cannoni da cm. 12 di bronzo Mod. 80-96, incavalcati su affusti in cannoniera minima, nella batteria corazzata;
4 cannoni di tipo e calibro eguale ai precedenti nelle due torri corazzate;
5 mortai di bronzo del calibro di cm. 15 nelle 5 torri corazzate g irevoli;
2 pezzi, presumibilmente dei calibri di cm. 12 o 15 , nella batteria in barbetta.
In complesso l'armamento principale consta di una venr.ina di bocche da fuoco, tenuto conto anche di quelle che potrebbero essere collocate su llo spianato che si trova nella parte più elevata del forte.
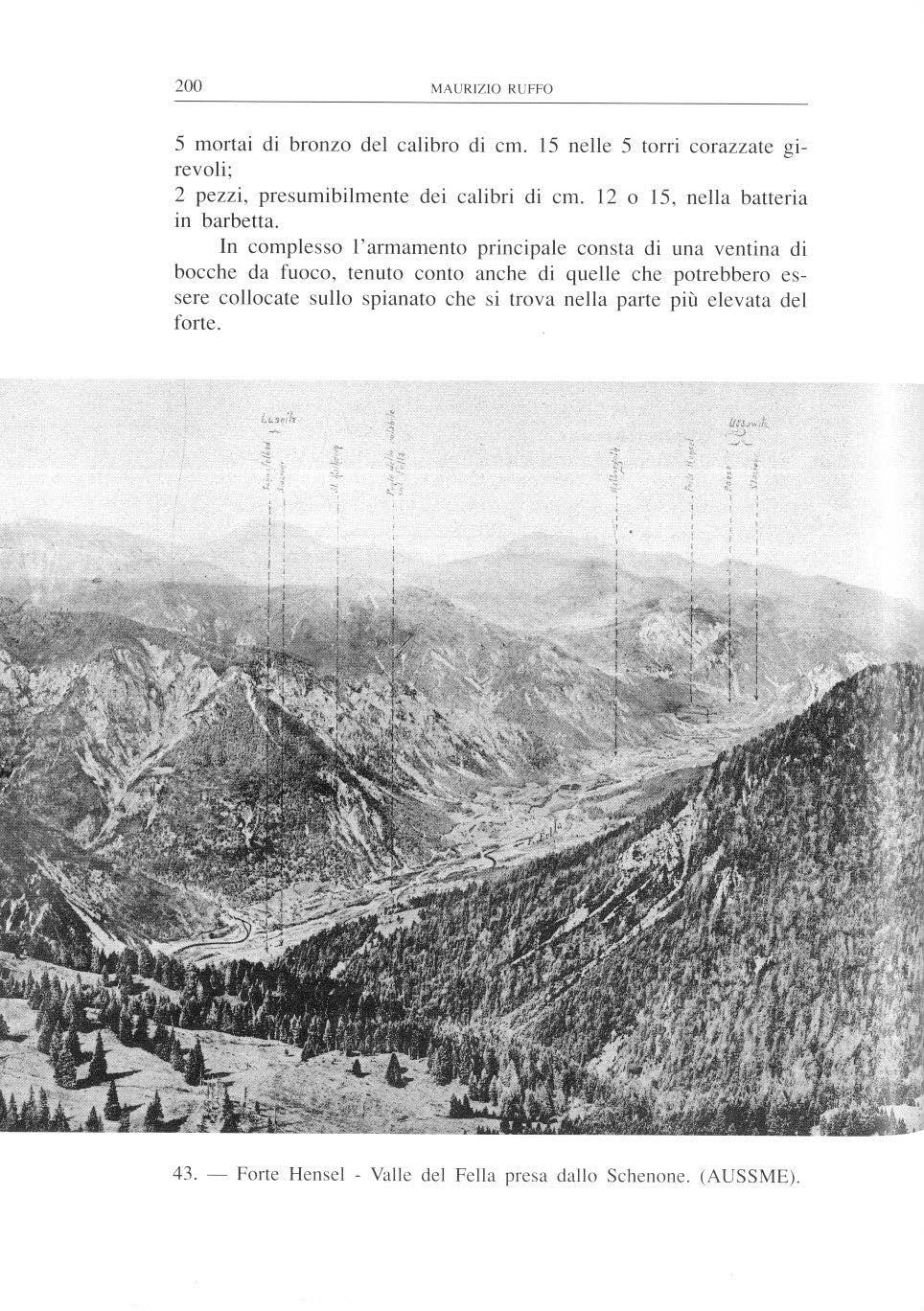
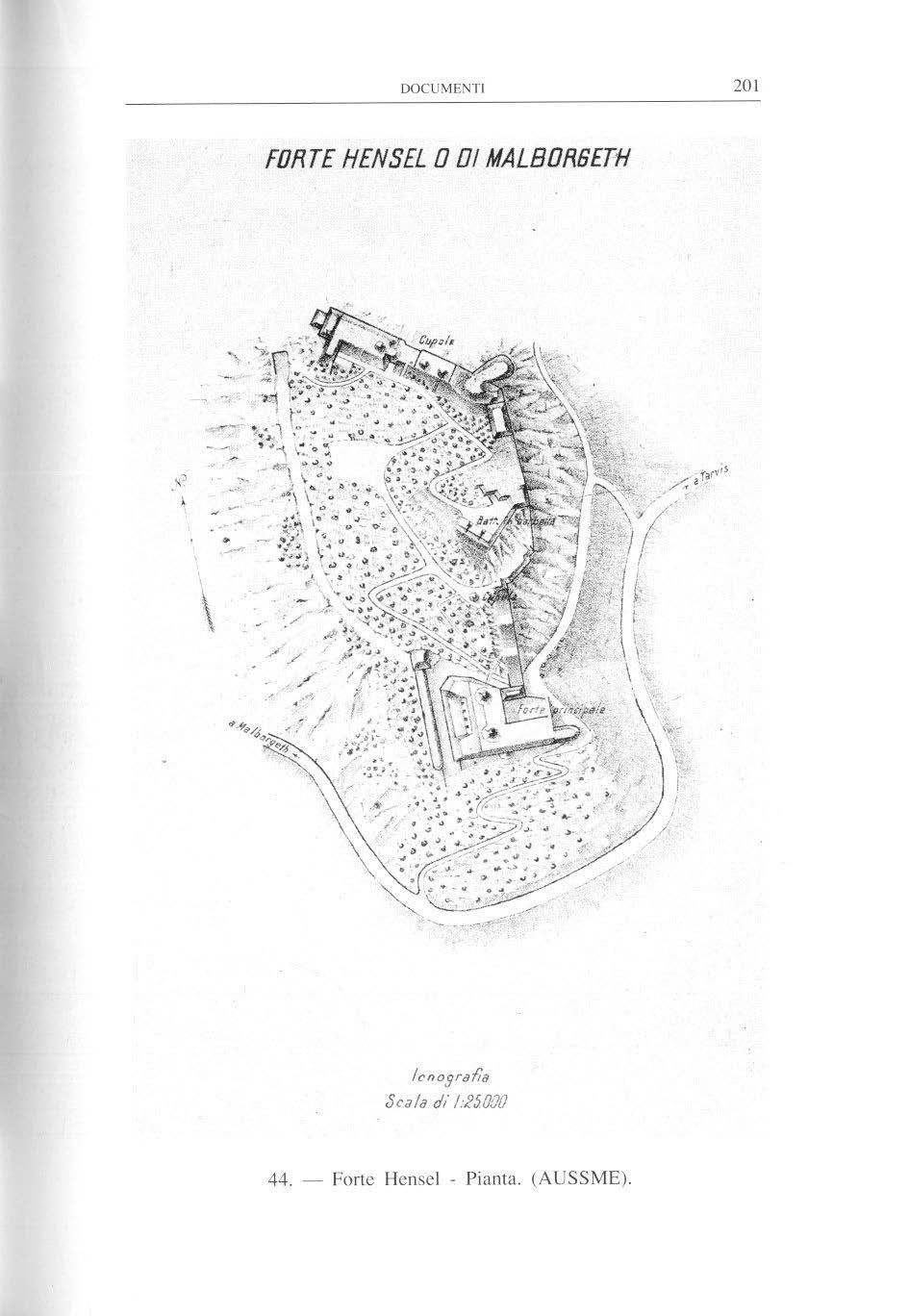
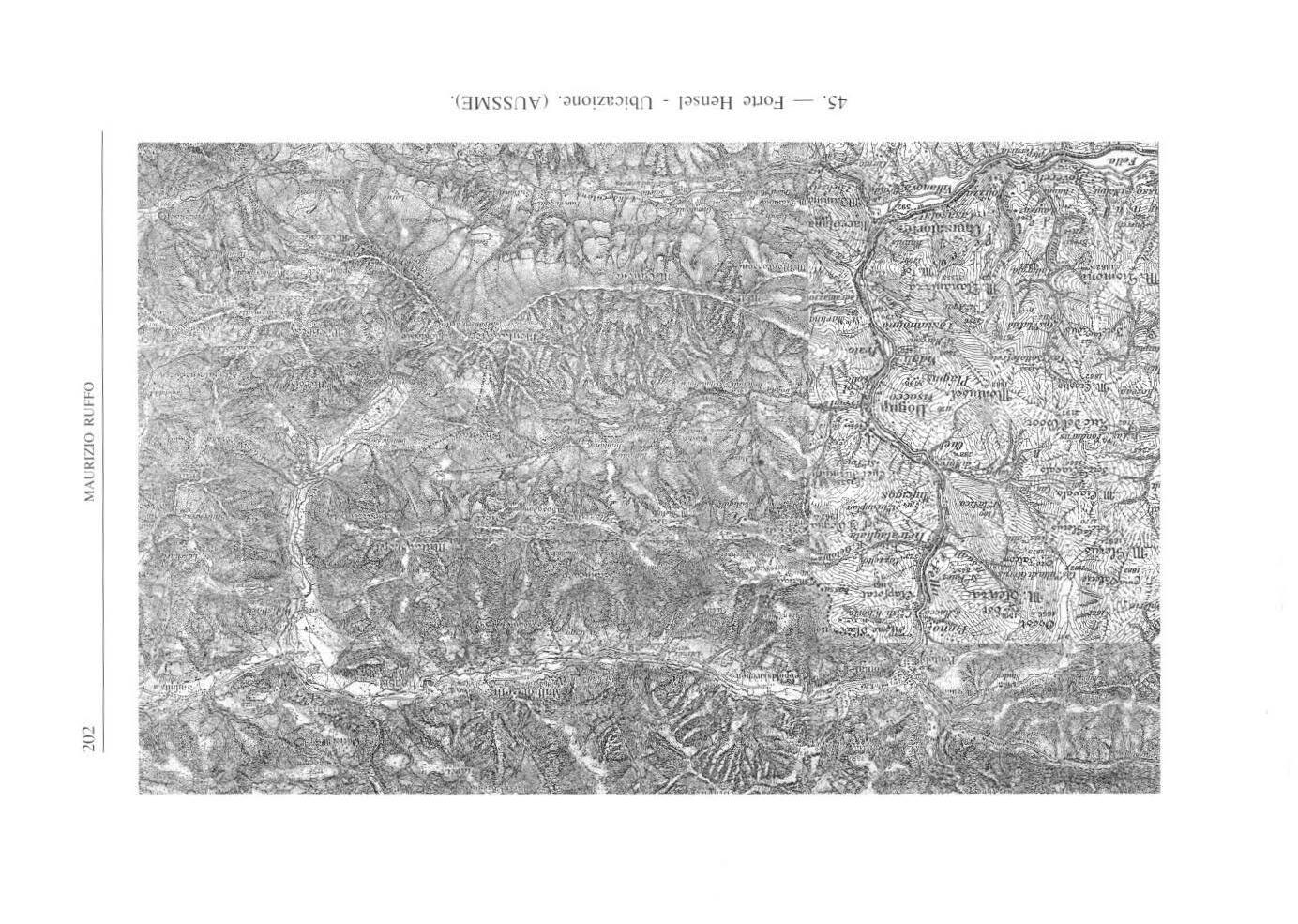
Cenno topografico.
li torrente Koritnica, affluente di destra dell ' Isonzo, ha ong1ne in alcuni burroni che solcano profondamente il versante meridionale del M. Mangart. Nel suo tratto superiore scorre in selvaggio vallone sino alla conca di Mittelbreth su cui scendono ripidi e fittamente boscosi i versanti che la limitano. Nella conca di Mittelbreth sbocca nella Koritnica il torrente Predilca che ha le sue origini al passo del Predii.
Dopo la conca del Mittelbreth la valle si restringe nuovamente tra pendici boscose sulla destra, aspre, rocciose e rotte da numerose frane sulla sinistra, sino alla confluenza del rio Mogenza. Quindi la valle va sempre più rinserrandosi tra i fianchi rocciosi ciel Rombon e del Karnica, che in alcuni punti cadono quasi a picco sul torrente eia un'altezza di oltre 100 metri e formano la così detta Chiusa di Flitsch.
Oltrepassata la chiusa, la valle si a llar ga progressivamente in una conca a versanti dolcemente inclinati, in basso coltivati e praticabili, che da Flitsch prende nome e dove ha luogo la congiunzione della Koritnica coll'Isonzo.
La rotabile che da Tarvis per il passo del Predii, Flitsch , Caporetto e Tolmino mette a Gorizia, percorre dal Predii a Flitsch le va lli del Predilca e della Koritnica e da Flitsch a Gorizia la va ll e dell'Isonzo. A Caporetto si distacca da tale rotabile quella del Pul fero.
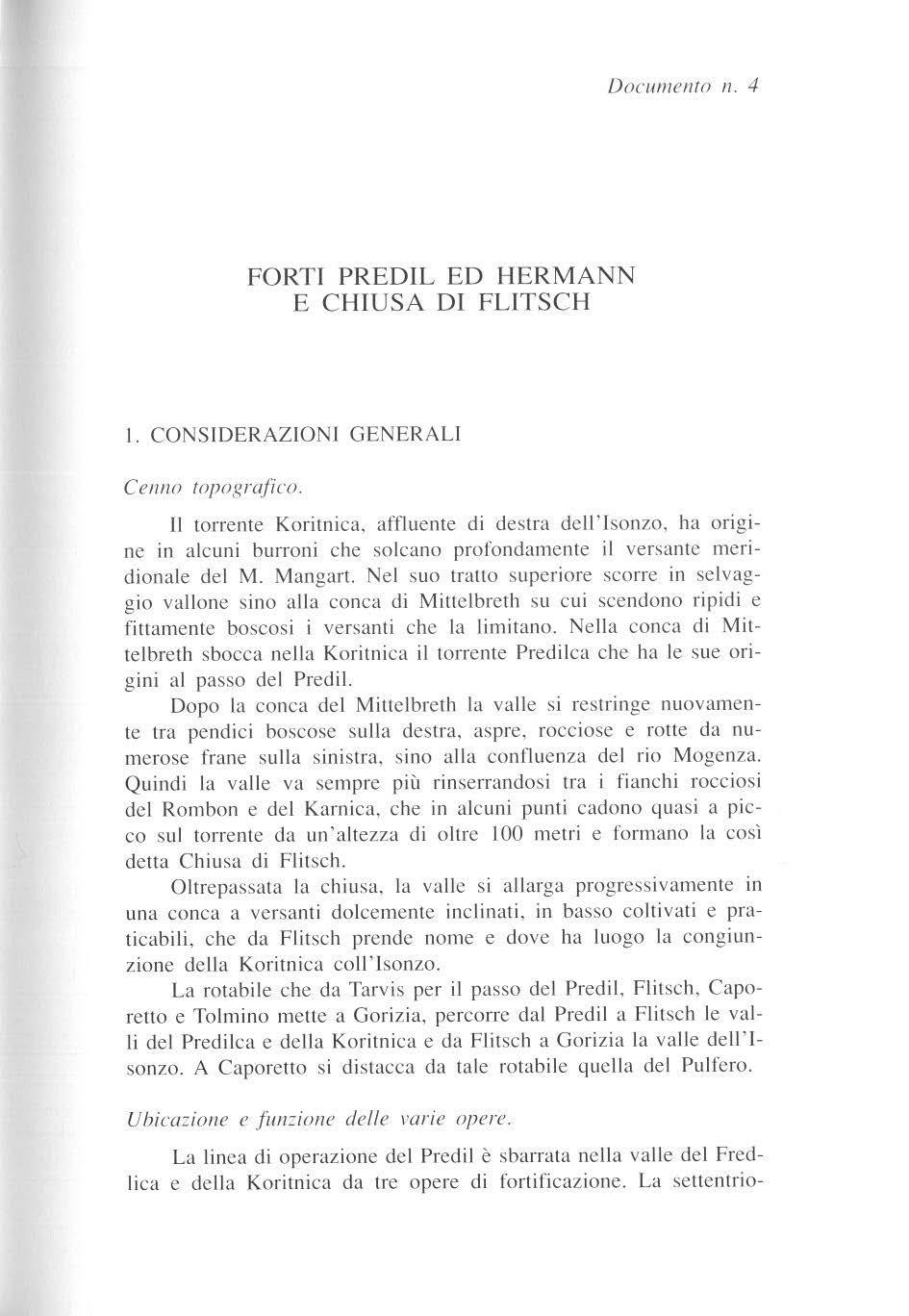
Ubica : ione e jineione delle varie opere.
La linea di operazione del Predii è sbarra ta nella valle del Fredlica e della Koritnica da tre opere di fortificazione. La sellentri o-
nale di tali opere , il forte Predi I, sorge ad oriente ed in vicinanza dell'omonimo passo; le altre due opere: forte H erma nn e Chiusa di F litsch, trova nsi alla Chiusa di Flitsch, nel punto più ristretto della valle.
Scopo di tutte queste opere è quello di opporsi all'avanzata di truppe che rimontando le valli dell'Isonzo, della Koritni ca e del Predilca tendano al passo del Pred ii e quindi a Tarvis.
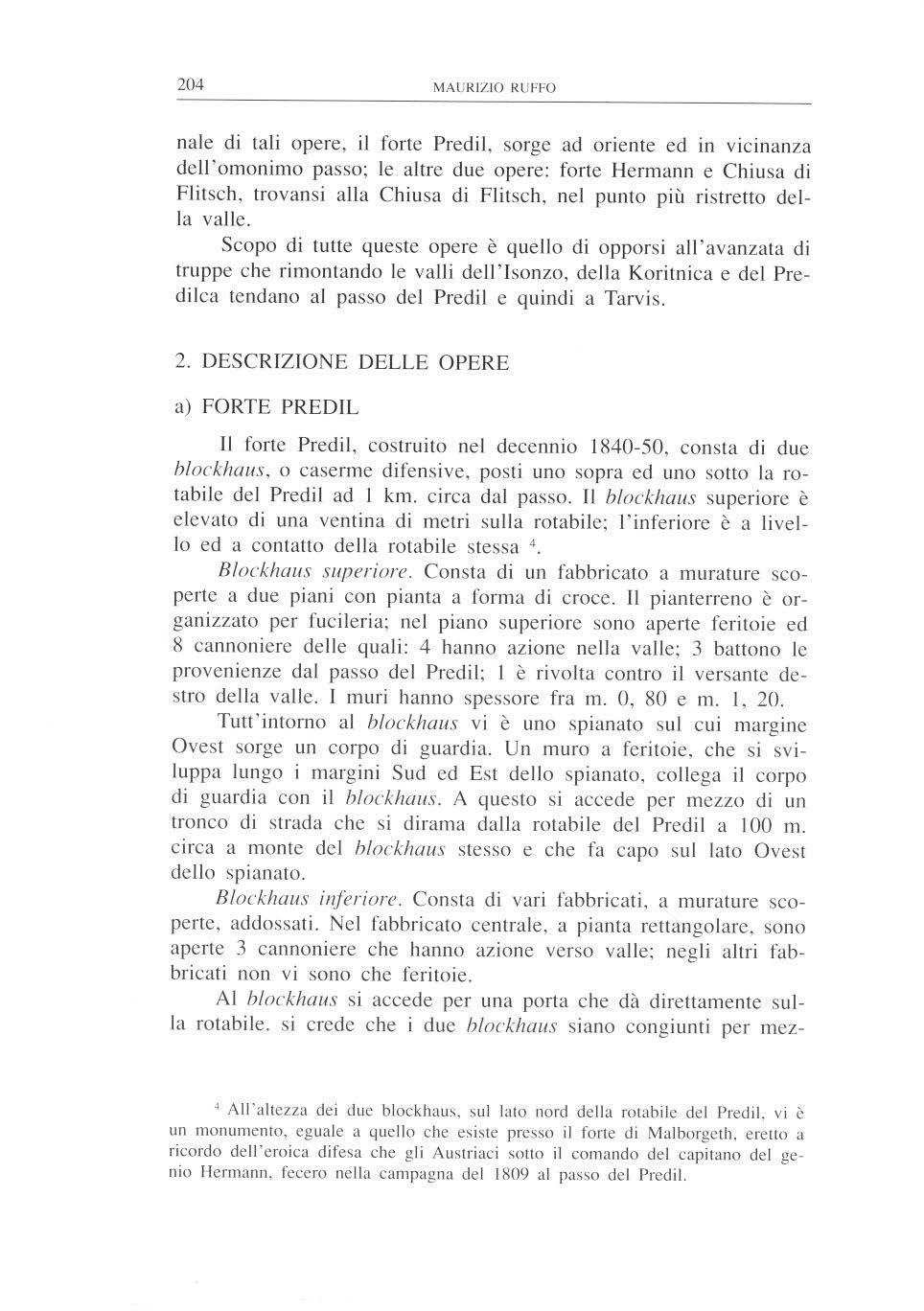
TI forte Predii, cos truito n el decennio 1840-50, consta di due hlockhaus, o caserme difensive , posti uno sopra ed uno sotto la rotabile del Predii ad l km. circa dal passo. Il blockhaus superiore è elevato di una ventina cli metri sulla rotabile; l'inferiore è a livello ed a contatto della rotabi le stessa 4 •
8/ockhaus superiore. Consta di un fabbricato a murature scoperte a due piani con pianta a forma di croce. li pianterreno è organizzato per fucileria; nel piano superiore sono aperte feritoie ed 8 cannoniere delle quali: 4 hanno azione nella valle; 3 battono le provenienze dal passo del Predii; I è rivolta contro i I versante destro del la valle. I muri hanno spessore fra m. O, 80 e m. 1, 20.
Tutt 'i ntorno al blockhaus vi è uno spianato s ul cui margine Ovest sorge un corpo di guardia. Un muro a feritoie, che si sviluppa lungo i margini Sud cd Est dello s pianato, collega il corpo di guardia con il hlockhaus. A questo s i accede per mezzo di un tronco di strada che si dirama dalla rotabile ciel Predii a 100 rn. circa a monte ciel hlockhaus stesso e che fa capo sul lato Ovest dello spianato.
8/ockhaus inferiore. Consta di vari fabbricati , a murature scoperte, addossati. Nel fabbricato centrale, a pianta rettangolare , so no aper te 3 cannoniere che hanno azione verso va ll e; negli altri fabbricati non vi sono che feritoie.
Al blockhaus si accede per una porta che dà direttamente s ulla rotabile. s i crede che i due blockhaus s iano congiunti per mez -
0 All"altezza dei ùuc blockhau~. su l lato nord della rotabile del Predii, v i è un monumento, egua le a quello che esis 1e presso il forte di Malborgeth, eretto a ri cordo dell'eroica difesa c he gli Austriaci so llo i l co mando del capitano del genio I lermann. fecero nella campag na del I 809 al passo del Predii.
zo di una comunicazione sotterranea, e che un 'altra comunicazione sotterranea, larga m. I ed alta m. 2, collega il forte Predii con la batteria del passo del Predi!.
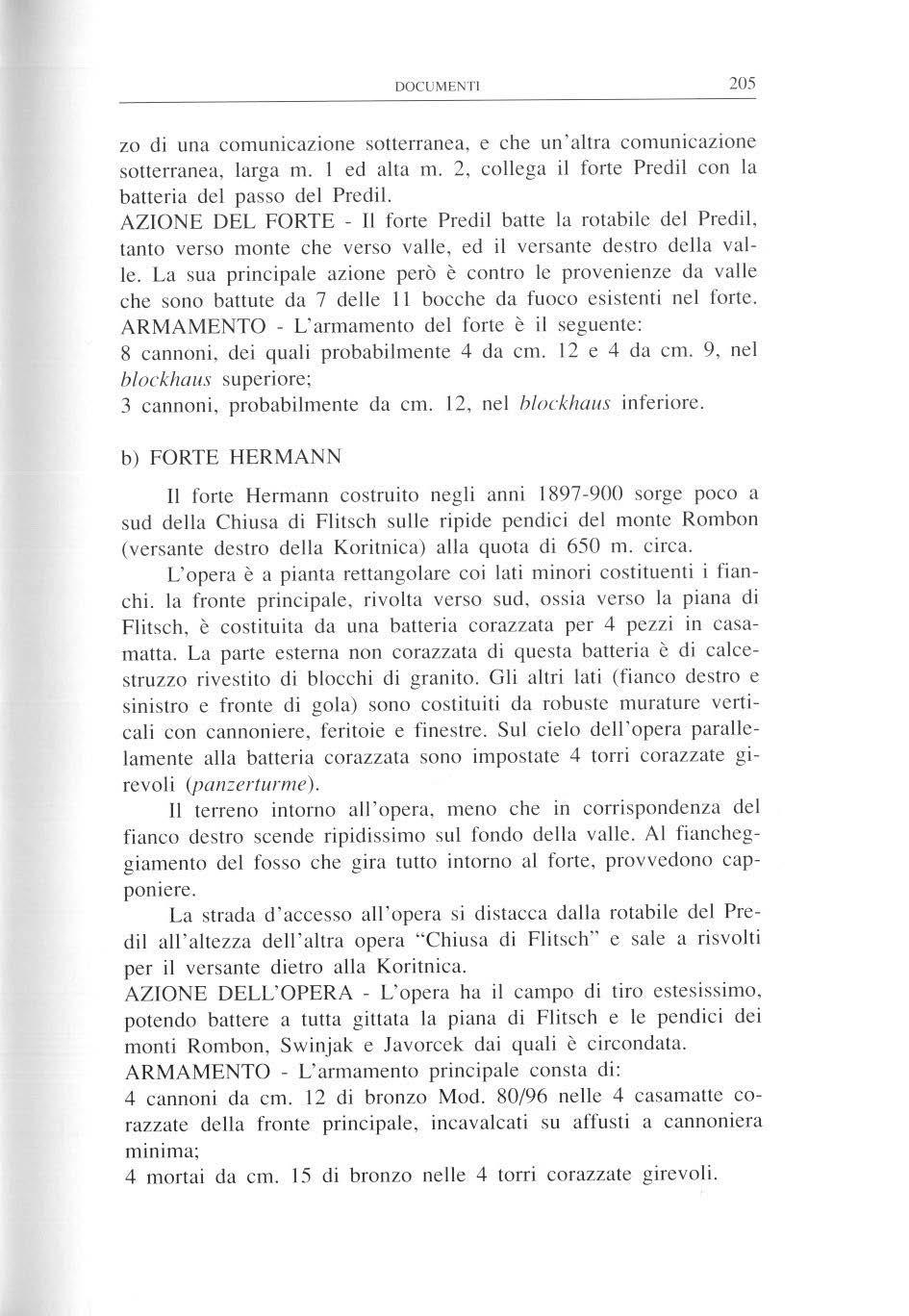
AZ IONE DEL FORTE - Il forte P redi! batte la rotabile del Predii, tanto verso monte che verso valle, ed il versante destro della valle. La sua principale azione però è contro le provenienze da valle che sono battute da 7 de ll e I I bocche da fuoco esistenti nel forte.
ARMAMENTO - L'armamento del forte è il seguente:
8 cannoni, dei quali probabilmente 4 da cm. I 2 e 4 da cm. 9, nel blockhaus superiore;
3 cannoni, probabilmente da cm. 12, nel h/ockhaus inferiore.
li forte Hermann costruito negli anni 1897 - 900 sorge poco a sud del la Chiusa di Flitsch sulle ripide pendici del monte Rombon (versante destro della Koritnica) alla quota di 650 m. circa.
L'opera è a pianta rettangolare coi lati minori costituenti i fianchi. la fronte principale , rivolta verso sud, ossia verso la piana di Flitsch, è costituita da una batteria corazzata per 4 pezzi in ca s amatta. La parte esterna non corazzata di questa batteria è di calcestruzzo rivestito di blocchi di granito. Gli altri lati (fianco destro e sinistro e fronte di gola) sono costituiti da robuste murature verticali con cannoniere, feritoie e finestre. Sul cielo dell'opera parallelamente alla batteria corazzata sono impostate 4 torri corazzate girevo l i (panzerturme).
11 terreno intorno a ll 'opera, meno che in corrispondenza de l fianco destro scende ripidissimo sul fondo della valle. Al fiancheggiamento del fosso c he gira tuuo intorno al forte, provvedono capponiere.
La strada d'accesso ali' opera si distacca dalla rotabile del Pred il all'altezza de ll 'a lt ra opera "Chiusa di Flitsch" e sa le a risvolti per i l versante dietro alla Kor itn ica
AZIONE DELL'OPERA - L'opera ha il campo di tiro estesissimo, potendo battere a tutta g iu ata la p ia na cli Flitsch e le pendici dei monti Rombon, Swinjak e Javorcek dai quali è circondata.
A R MAMENTO - L 'armamento principa le consta di:
4 cannoni da cm. 12 di bronzo Mod. 80/96 ne ll e 4 casamatte corazzate della fronte principa le, incavalcati s u affusti a cannoniera mi n ima;
4 mortai da cm. 15 di bronzo ne ll e 4 torri corazzate girevo l i.
Quesf opera a murature scoperte, venne cost ruita negli anni 188 J -82 s ull e rovine dell'antica rocca omo nim a. Essa trovasi a 5 km. a nord del paese di Flitsch immediatamente a valle del ponte per cui la rotabile dalla sponda sin istra passa sulla destra della Koritnica.
Consta essenLialm en te di un fabbricato con tracciato a dente. con due fronti rivolte rispettivamente a sud e ad est. La fronte sud, che guarda le provenienze da Flitsch, presenta 3 cannoniere ad apertura minima, protetle da scudo metallico, e delle feritoie; delle 3 cannoniere 2 sono a l piano superiore ed I a l piano inferiore. La fronte est, rivolta al versante sinistro della valle, presenta verso tale versante delle feritoie, ed alla sua estremità nord ha 2 cannoniere che bat1ono verso monte.
Nei due piani del fabbricato oltre le casamaltc vi sono cliversi locali per uso alloggio e magazzini.
Innanzi ai lati sud cd ovest dell'opera gira un fosso che è battuto nel lato sud da una cappo ni era cos trutta al sa li e nte ciel dente, e nel lato ovest da un corpo di guardia che trovasi sul rovescio del fabbricato.
li corpo di guardia è collegato alle due cstremitl1 del fabbrica to per mezzo cli due muri a ferit oie che racchiudono un co rtil e. cl muro a feritoie rivolto a nord trovasi l'ingresso dell'opera al quale si accede per meao di un breve tronco di strada. che si distacca dalla rotabile del Predii su l rovescio dell'opera s tessa presso i l ponte della Koritni ca.
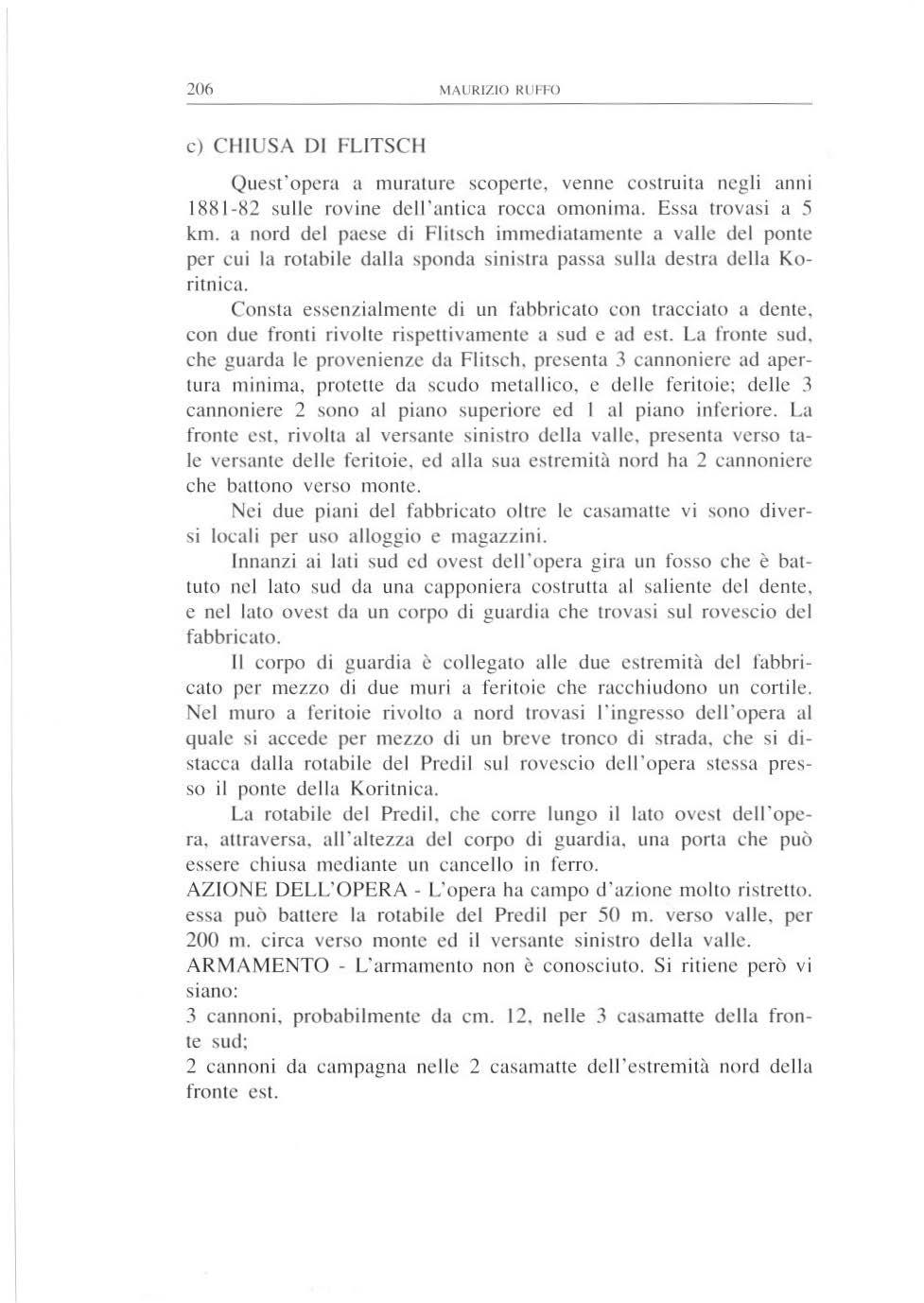
La rotabile del Predii. che corre lungo il lato ovest dell'opera. atlraversa, all'altezza del corpo di guardia, una porta che può essere chi usa mediante un cance llo in ferro.
AZIONE DELL'O PERA - L'opera ha campo d'azione molto ristretto. essa può baltcrc la rotabile del Predi i per 50 m. verso valle. per 200 m. circa verso monte cd il versante sinistro della va ll e.
ARMAMENTO - L 'a rmam e nto non è co nosciuto. Si riti ene però vi siano:
3 cannoni, probabilmente da cm. 12, nelle 3 casamatte della fronte sud;
2 cannoni da campagna n e ll e 2 casamatte dell'estremità nord della fronte es t.
Cenno topografico.
Fra le s trett e di Mezzaselva ( Isa r co), cli Rio di Pusteria (Rienza) e di Bressanone (Isarco), si apre la conca di Bressanone, in mezzo a ll a quale si eleva una zona collinosa che prende il nome cli altip ian o di Sciaves.
Questo a ltipi ano è fortemente ondulato, in parte coltivato e in parte boscoso, e ricco di abi tali; esso si eleva di circa 300 m. su l fondo di due valli laterali. in terpo nendosi fra le stesse a gu isa cli cuneo.
La co nca di Bressanone è circondata da un a corona di monti, a lti da 2500 a 3000 m., che scendono ve rso il fondo cli essa con fianchi ripidi, in gran parte a prati o coperti di boschi.
L e rotabili e le ferrov ie de l Bren nero e della Pusteria en trano nella co nca , da nord, per i varc hi c he !'Isa rco e la Rienza si aprono attrave rso queste montagne, a F ortezza ed a Rio cli Pusteria.
L a rotabile e la ferrovia ci e l Brennero corrono, nella co nca, semp re sulla destra de ll ' Isa rco; qu e ll e della Pu ster ia , a Rio di Puster ia , sono inv ece cost rette ad a bband o n are il corso della Ricnza a causa della ripid ezza el ci versa nt i e de ll'angustia della va ll e, e lambendo a nord l 'alt ipian o cli Sciaves, passano ne lla valle dell' l sa rco e vanno a riunirsi a Fortezza a quelle del Bre nn ero . D alla rotabile d e lla Pu s rer i a, si distacca a nord cli Sciaves, un tronco di strada rota bile che, costegg iand o ad oves t l'altipiano va a congiungersi direttam e nt e a lla rotabi le del Bre nn e ro , a monte di Bressa none.
La co nca cli Bressa no ne è pertanto il punto di confluenza delle più imp ortanti comunicazion i rotabili e f eITovia rie fra la valle de ll 'A di ge- I sa rco, clell' l nn e de ll a Drava, e da ciò ripete l ' importan za militare.
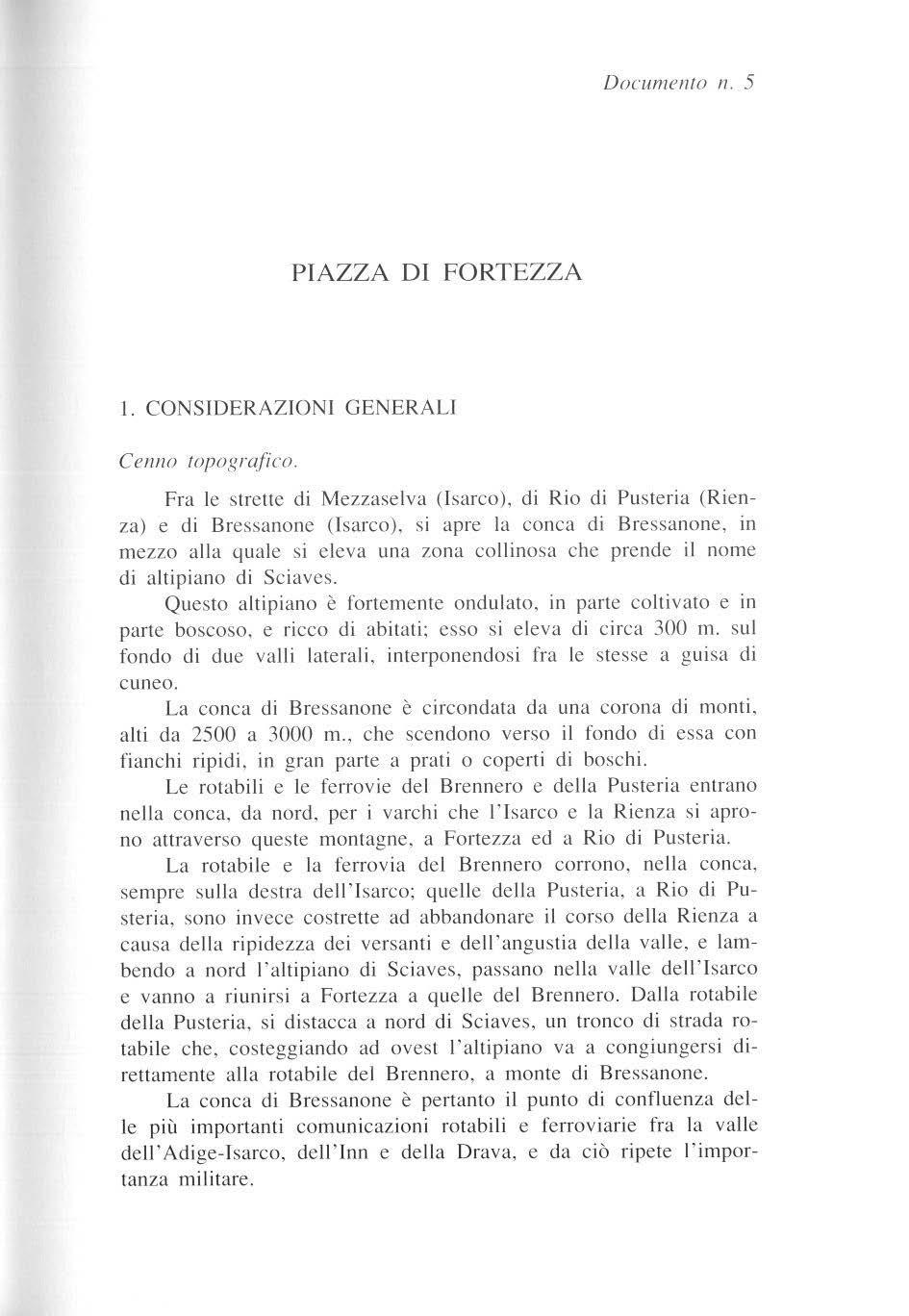
La piazza di Fortezza, costruita negli anni 1837-38. sorge nel punto dove la rotabile del Brennero sbocca nella conca di Bressanone; consta di un corpo di piazzo costruito sopra un poggio roccioso di poca elevazione, fra la strada e l'alveo dell 'Tsarco, e di un corpo staccato, costruito più in alto, sul versante destro della valle.
La piazza di Fortezza sbarra la strada del Brennero e della Pusteria al loro punto di congiunzione. Questo sbarramento può però essere evitato, per chi provenga dalla Pusteria, per mezzo del le s trade dell'altipiano di Sciaves, che deve perciò, in questo caso, essere occupato dal difensore.
Sorge sopra un poggio roccioso (alla quota di 765 m.) sulla destra dcll'lsarco, ed è costituito da un enorme ammasso di costruzioni in muratura , interamente scoperte, disposte in due cinte.
La CINTA ESTERNA è composta cli cinque fronli, cli tracciato assai irregolare per adattarsi al terreno, non munite in gran parte di fosso.
Le batterie cli queste fronti sono quasi tutte in casamatte. e ad un piano quelle volte da est cd a sud, a due quelle volte ad ovest e nord-ovest.
Sono organizzati per fucileria, casamatte e grossi muri staccati.
L'insieme delle cinque ji-011/i costituisce un poligono irregolare, che permette di portare fuochi in tutti i sensi (tiro a puntamento diretto ed indiretto).
Il law sud è formato da due fronti approssimativamente bastionate: consta cioè del bastione A, del bastione B, D , E, e di quello G, tra loro riuniti dalle cortine B ed F.
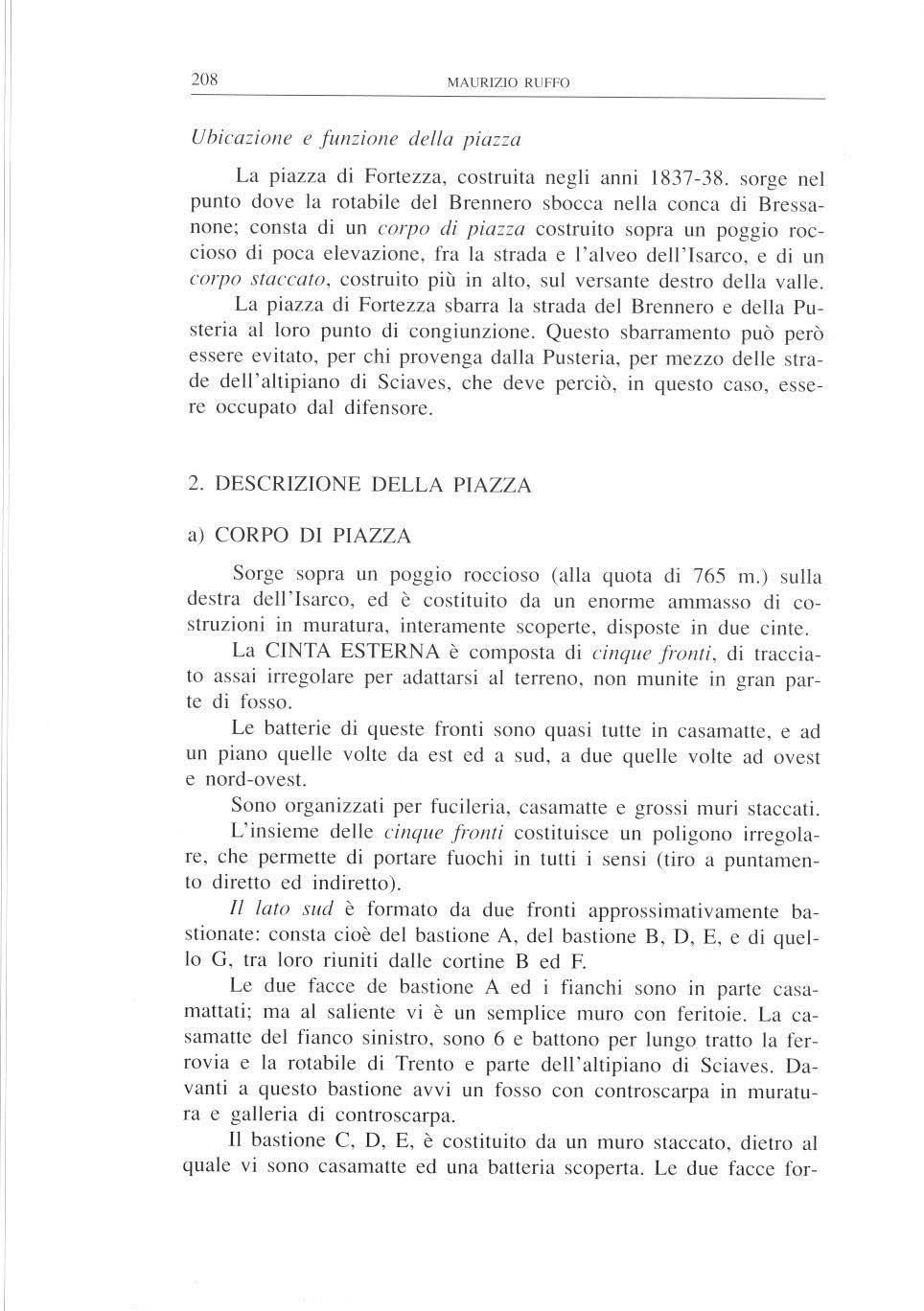
Le due facce de bastione A ed i fianchi sono in parte casamattati; ma al saliente vi è un semplice muro con feritoie. La casamatte del fianco sinistro, sono 6 e battono per lungo tratto la ferrovia e la rotabile di Trento e parte dell'altipiano cli Sciaves. Davanti a questo bastione avvi un fosso con controscarpa in muratura e galleria di controscarpa.
Il bastione C , D, E, è costituito da un muro staccato, dietro al quale vi sono casamatte ed una batteria scoperta. Le due facce for-
mano angolo molto ottuso fra di loro, ed i d ue fianchi sono corri. Ali ' angolo s ud-ovest vi ha una casamatta C per due pezzi, e quindi una batteria D in terra per cinq ue pezzi , corrispondenti alla faccia s ini s tra ed al fianco sinis tro havvi una grande casamatta con quattro can noni ere e tre fuc iliere nella faccia, e due ca nn on ie re nel fian co.
li terzo bastione del la to sud (G) è formato eia un a grande casamatta per otto pezzi , dei quali c inqu e hanno azione a sud e tre ad est. In questo bastione il salien te è fortemente arrotondato.
I tre bastioni sono collegati fra di loro dal le due co rtin e B e d F c he sono formate eia robusti muri, co n num e rose feritoie. Ne ll a cortina B , s pezzata ad a ngo lo, s i a prono due passaggi, l'uno per l ' ingresso a lla fortezza , l'altro alquanto più eleva t o, per la ferrov ia. La co rtin a F in vece è rett ili nea; davanti ad essa esiste un fosso scavato nella roccia il qua le è ricoperto con una tettoia e sembra dover se r v ire per deposito cl i materiali.
Il lato orientale è fo rm a to da una fron te tanagliata , ai due sa1ie nti vi so no le due grandi casamatte G ed M. Della prima fu g ià de tt o . La seconda con tracciato curvilineo raccorda la fronte es t a lla fronte nord; è munita di c inqu e ca nn oniere con azio ne verso le alture cli Aica e ve rso l 'a ltipiano di Sciaves. L' angolo ri en trante dell a te na g li a è formato d a muri e feritoie, attraverso ad uno dei quali è aperto un passaggio per la ferrov i a. Davanti a ll 'a ngo lo rientrante o ra eletto, e d a lqu an to più alta d elle due cos tru z ion i casamattat e v i è un a mezza torre scoperta H , forata co n cinque cannoni e re e diverse feritoie, la quale batte più direttamente il pon te d ella ferrov i a, e fiancheggia i due lati della te na g lia.
Più in basso e so tto la fe rrovia v i è un 'altra mezza torre scoperta L , munita di un ordine di fe ritoi e; essa infila i l ponte in leg no della rotabil e della Pu s ter i a e batte le a di ace nze di qu es to e d e l ponte d e lla fe rr ov ia.
Oltre !'Isarco, n e ll 'a ngo lo n ord formato da qu es to fium e e d alla ferrov i a tro vas i una cos tru z ion e casamattata 1 c he è un a s pec ie di corpo di g ua rdia , fogg ia to a tanagl ia ed ord inato per fanteria. Batte la rotabi le della Pu s te ri a e buon tratto del le tto del! ' Isa rco .
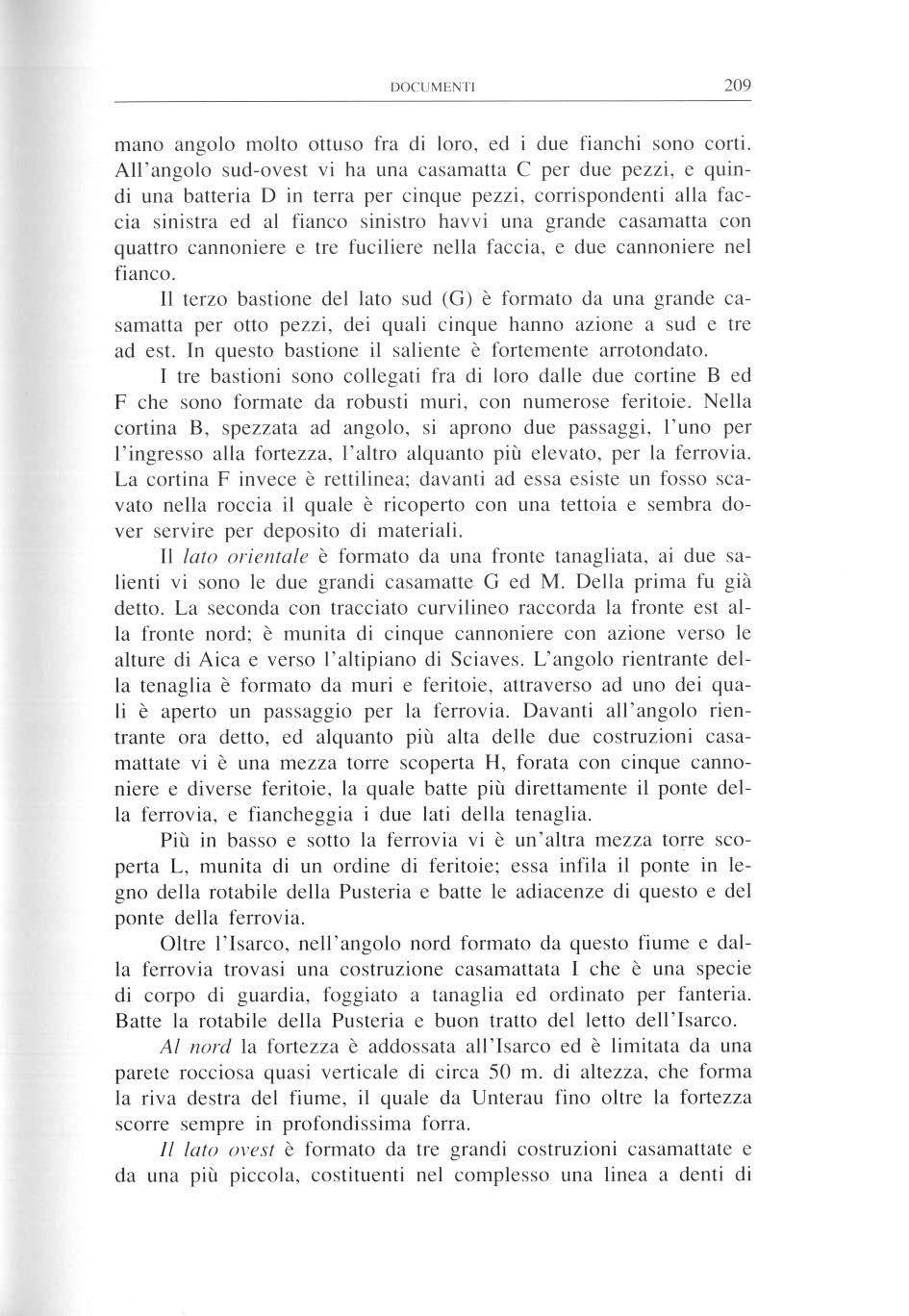
Al nord la fortezza è addossata a ll ' Isarco ed è limit ata da una pa re te roccio sa qua si vertica le di circa 50 m. di altezza, che forma la r iva destra del fiume , il qu ale da Unt era u fino oltre La fortezza sco rre se mpre in pro fo ndi ss ima forra .
i I lato m·est è formato da t re gra ndi costruzioni cas am a ttat e e d a un a più picco la, cos titu e nti ne l co mpl esso un a lin ea a denti d i
sega con facce s uccessivamente ritirate e collocate più in basso man mano che si procede da s ud a nord , dalla ferrovia cioè al fiume. Tali casamatte , per artiglieria, hanno azione verso ovest e nord-ovest; sono a due ordini di fuochi ciascuna e provviste di sette cannoniere per ogni piano quella A e quella X, e di cinque quella Z. Al saliente del bastione A vi ha inoltre una cannoniera volta ad ovest , la quale batte solo la s trada e la ferrovia.
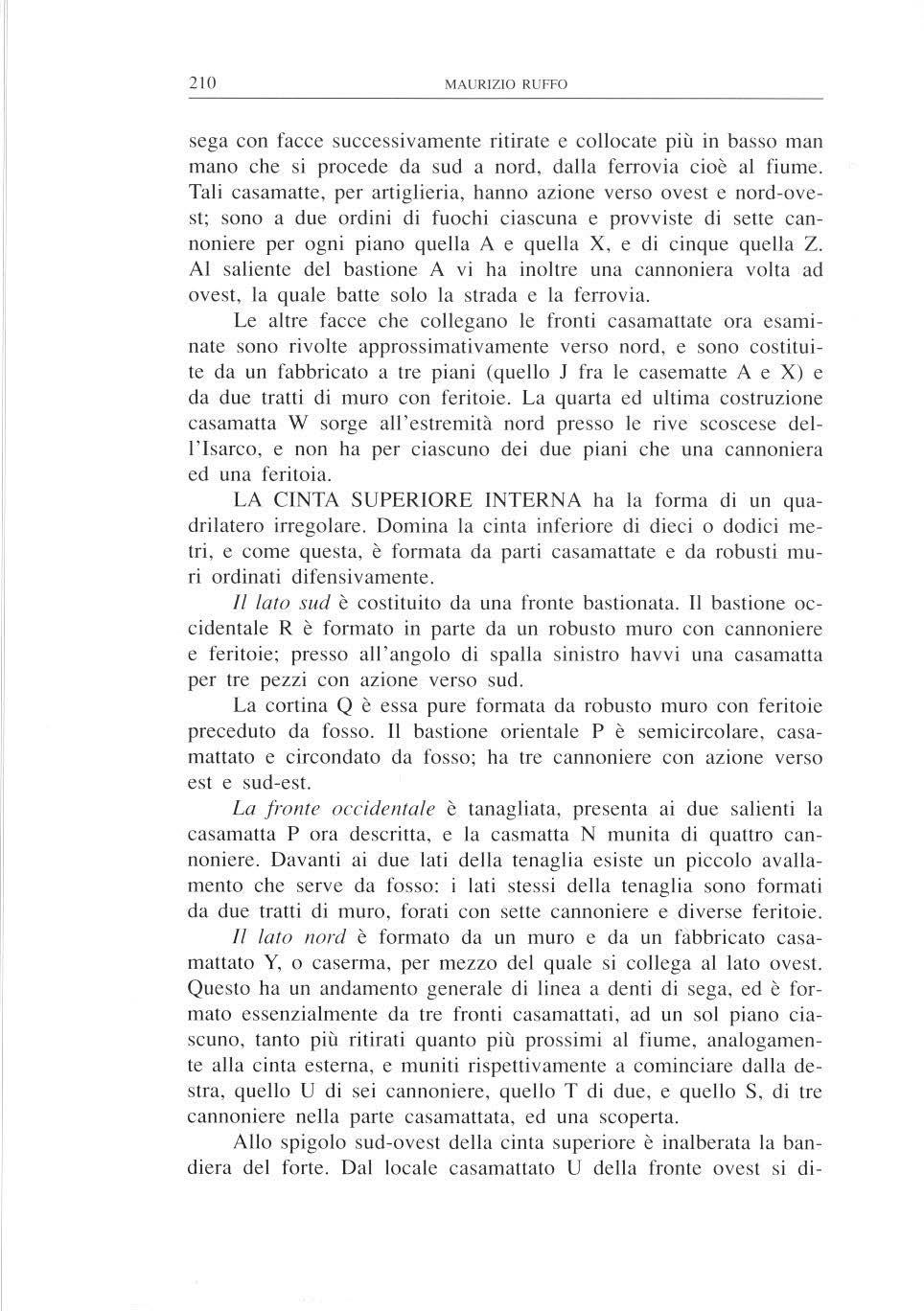
Le altre facce che collegano le fronti casamattatc ora esam inate sono rivolte approssimativamente verso nord , e so no costituite da un fabbricato a tre piani (quello J fra le casematte A e X) e da due tratti cli muro con feritoie. La quarta ed ultima costruzione casamatta W sorge all'estremità nord presso le rive scoscese cieli' Isarco , e non ha per ciascuno dei due piani che una cannoniera ed una feritoia.
LA CINTA SUPERIORE INTERNA ha la forma di un quadrilatero irregolare. Domina la cinta inferiore di dieci o dodici metri , e come questa, è formata da parti casamattate e da robusti muri ordinati difensivamente.
li lato sud è costituito da una fronte bas tionata. Il bastione occidentale R è formato in parte eia un robusto muro con cannoniere e feritoie; presso all'angolo di spalla sinis tro havvi una casamatta per tre pezzi con azione verso sud.
La cortina Q è essa pure formata da robusto muro con feritoie preceduto da fosso. li bastione orientale P è se micircolare , casamattato e circondato da fosso; ha tre cannoniere con azione verso est e sud-est.
La fi'onte occidentale è tanagliata , presenta ai due salienti la casamatta P ora descritta, e la casmatta N munita di quattro cannoniere. Davanti ai due lati della tenag l ia esiste un piccolo avallamemo che serve eia fosso: i lati s tessi della tenaglia sono formati da due tratti cli muro, forati con sette ca nnoniere e diverse feritoie.
Il lato nord è formato da un muro e da un fabbricato casamattato Y, o caserma, per mezzo del quale si collega al lato ovest. Qu es to ha un andamento generale di linea a denti di sega, ed è formato essenzialmente da tre fronti casamattati, ad un sol piano ciasc uno , tanto più ritirati quanto più prossi mi al fiume , analogamente alla cinta esterna, e muniti rispett i vamente a cominciare dalla des tra, quello U di sei cannoniere, quello T di due , e quello S, di tre cannoniere nella parte casamattata, ed una scoperta.
Allo s pigo lo sud-ovest d e l la cinta superiore è inalberata la bandiera del forte. Dal locale casamattato U della fronte ovest s i di -
parte un muro a feritoie, il quale va a raggiungere la co rtin a B ; questo muro ha la fronte a d ovest, e se rv e a coprire da quel lato l a comunicazione fra la cinta este rna della fortezza e la cinta inte rna.

Entro la cinta interna vi sono poi diversi fabbricati a d uso case rma .
Il corpo di piazza comunica co l c orpo s ta ccato med iante una rotabil e e per una via so tt e rranea c he pres umibilmente s i dipartir e bbe presso la porta d'ingresso della cortina B , passando ne ll ' inte rno di una spec ie di magazzino che rimane sotto a ferrovia.
ARMAMENTO - Non s i s a preci sa re bene il numero dei pezzi che costituiscono l 'a rmamento del co rpo di piazza: si sa però che l 'armamento è costituito da pezzi a retrocarica di recen te mod e llo. In complesso vi sono circa 50 cannon iere le quali hann o az io ne ve rso ovest e nord-ovest; e circa 56 rivolte verso es t e sud -es t.
b) CORPO STACCATO li co rpo s taccato s ituato 111 riva destra del! 'Isarco su di un ripiano alto da I 00-150 m. s ul fondo d ella valle, è separato d al corpo di piaz za pe r me zzo della ferrovia del Brennero . E sso è formato d a una serie di costruzioni in muratura disposte s u di un tracciato a forma irrego lare ed a ma gg io e r azione verso monte che verso valle.
Il lato est di questo tracciato è formar.o da un muro alquanto ritirato nella parte centrale C ove è praticata la porta d'ingresso. Può paragonarsi ne l complesso ad una front e bastionata; il ba s tione s ud è costituito da un g ran fabbricato K casamattato a du e piani, arrotondato in corrispondenza del sai iente, ove so rg e s ul dinanzi una capponiera se micirco lare b.
La faccia a pros p e tta quasi verso est, e s i compone di du e parti di differente l iv e llo (di cui la più bassa qu e lla a nord), e d aventi ciascuna du e cannoniere al piano inferiore , e una fila di feritoie al s up e riore.
I l fianco d è cos tituito da due ordini di feritoie su l fianco del fabbricato k; e di un tratto di muro c h e collega questo colla cortina e ne l quale s ono praticate du e can noni ere e alcune fe ritoi e .
La cortina e il bas tione nord son o costituite cli ma ss ima parte da muro con feritoie; oltre a ciò ne l bastione e so no praticate c inque cannoniere per una batte ria scoperta, avente azione verso est e s ud-e s t.
Lungo il fronte nord e per metà circa della lunghez za di questo, prosegue il muro rettilineo; nel primo tratto f sono praticate tre cannoniere per batteria sco perta, e negli intervalli tra l'una e l'altra delle feritoie; sul di dietro vi ha la caserma h.
Il tratto successivo del muro è più basso, munito di so le feritoie, ed insieme al gomito I (specie di capponiera con feritoie e una cannoniera) viene a funzionare da muro staccato rispetto alla retrostante batteria in terra g, ove si s uppon e possano essere collocati da quattro a sei pezzi. Ques ta batteria ha alle spalle la caserma i.
Procedendo verso m·est fa seguito una costruzione casamattata m; nel piano superiore sono praticate sei cannoniere; nell'inferiore del le feritoie, e al centro è collocata una capponiera II semicircolare. Finalmente all'angolo ovest su ha un ' altra capponiera p, in parte circolare, ove potranno forse essere collocate pure delle artiglierie, essendo in essa praticate 3 o 4 cannoniere.
Non si sa indicare precisamente come sia formato il lato sud.
Ne ll'interno del forte vi sono vari fabbricati per caserme e magazzini i quali s uperano alquanto in altezza i muri e le costruzioni esterne. Per le comunicazioni col corpo cli piazza vedi la descrizione di que s to.
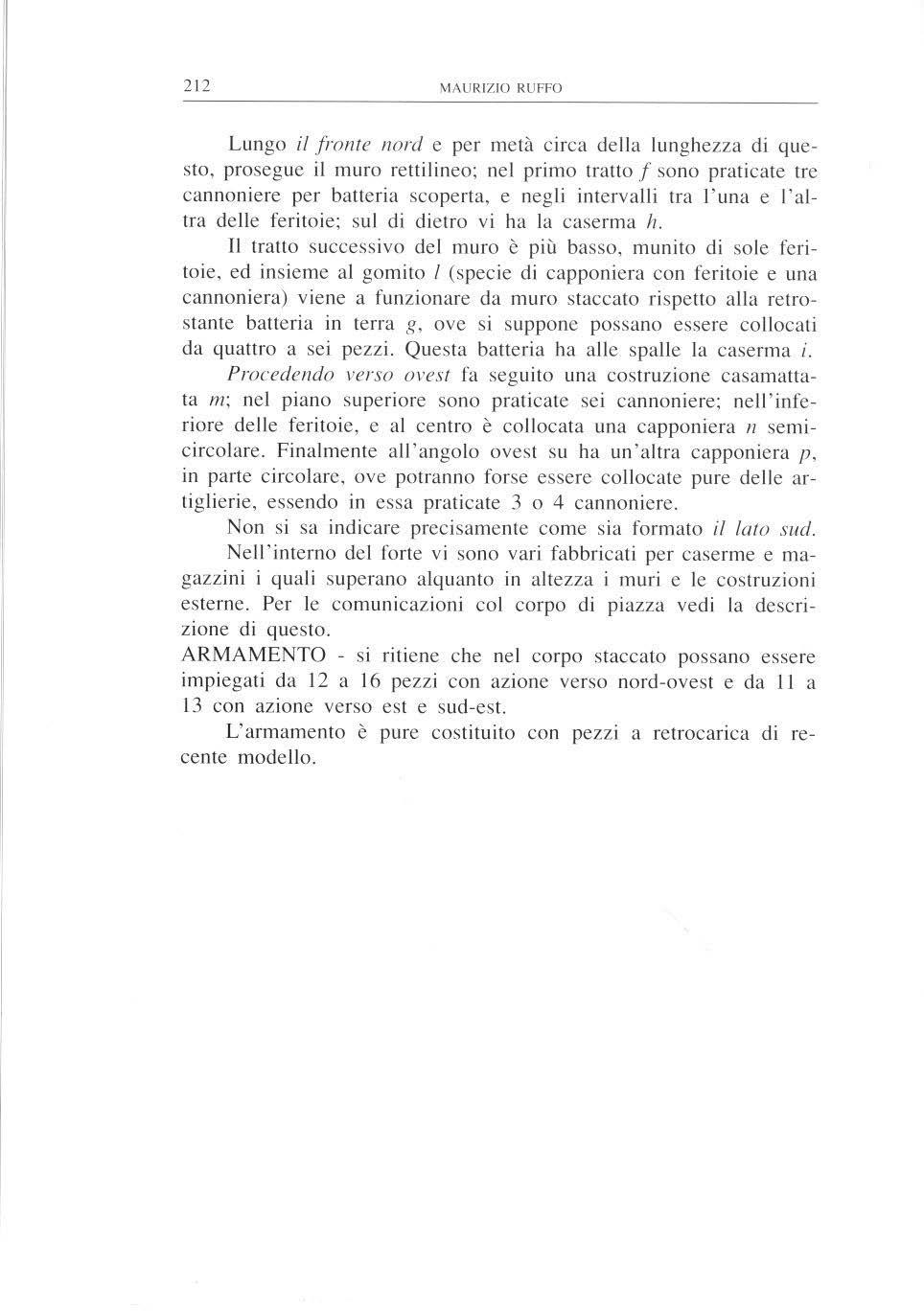
ARMAMENTO - si ritiene che nel corpo staccato possano essere impiegati da 12 a 16 pezzi con azione verso nord -oves t e da 11 a 13 con azione verso est e sud- est.
L 'armamento è pure costituito con pez z i a retrocarica di recente modello.
Leggonda 1&,.,,,W. ""#""""'//"/; B f'<>,/, ..•,, ,,;;.;,,..,,~ e H

Y,sf;; <fil $ Vd-nt
lJ .9,fft!/':'tl ~l'if'".'.; ){' e.i,., , ,,., /,. ..:.:.~,,..,.,V H ; i ,!,1'!',:',<"U#JfH/" '<'
I CO'"/·'•' i/-J'.,.,,,./,,, ,.,,.,,.,,.,.~.,,d,.., d l ,f.,.,.,.,._.,~"-'""""",:,,.,-,.
I' ,/ ; f ,U,,..,,.,, •· ,,p,tn4'
!/
b/,t,••N ·1 ///f/"N '!"vhP,,; h
l- r C.,,o·'!•t: 1 o e,,,,,.~
f1arld •/ /)r.JJS11>1~h 1·,t
s~d!tVl:40fJP
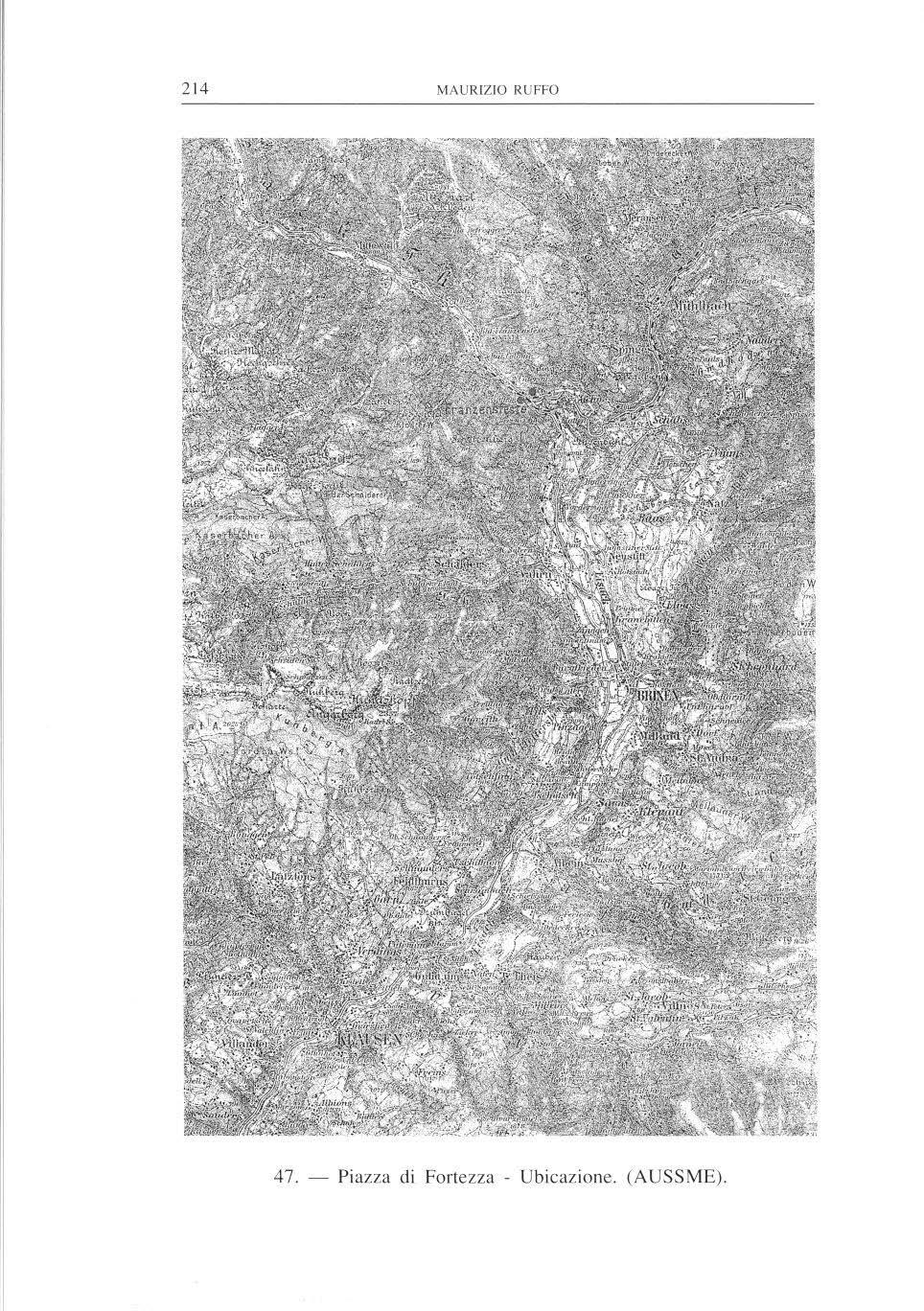
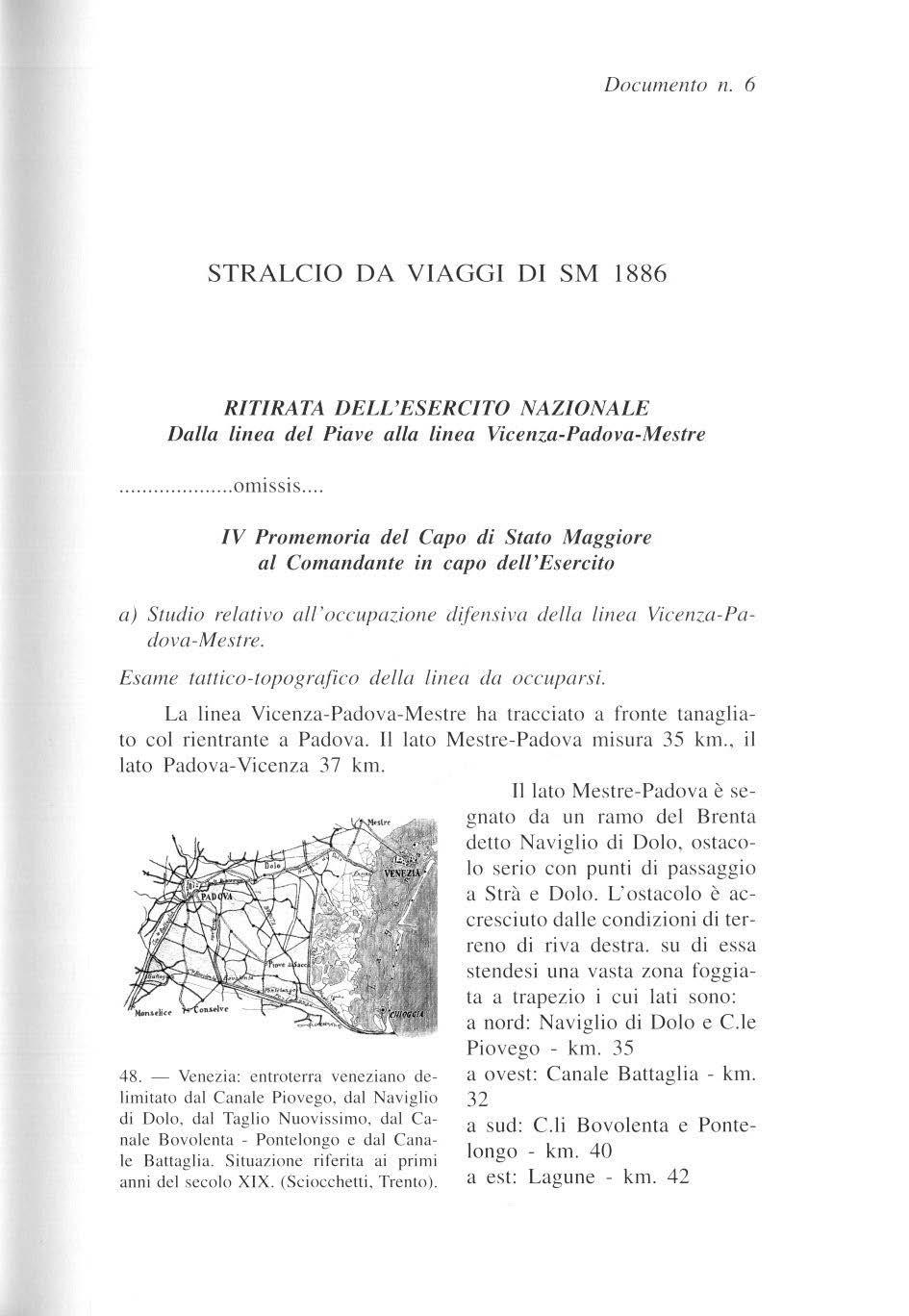
Dalla linea del Piave alla linea Vicenza-Padova-Mestre
omissis
IV Prom emoria del Capo di Stato Maggiore al Coman dante in capo dell'Esercito
a) Studio relativo all'occupazione difensiva della linea Vicenza-Padova -Mestre.
Esame tattico-topogrc;fico della linea da occuparsi.
La li nea Vicenza-Padova- Mestre ha tracciato a fronte tanagliato co l rientrante a Padova. li lato M estre-Padova misura 35 km., il lat.o Padova-Vicenza 37 km.
Il lato Mestre - Padova è seg nato da un ramo del Brenta detto Naviglio di Dolo, ostacolo serio co n punti ùi passaggio a Strà e Dolo. L'ostacolo è accresciuto dalle condizioni di terreno di riva destra. su ùi essa stendesi una vasta zo na foggiata a trapezio i cui lati sono:
a nord: Navig li o di Dolo e C.le
Piovego - km. 35
48. - Venezia: en trot erra veneziano delimitato dal Canale Piovego. dal Nav igli o di Dolo. da l Taglio Nuoviss i mo. dal Canale Bov ol cnta - Pontelongo e dal Canale Battag l ia. Situaz ione rifer ita ai p rimi an ni del secolo X I X. (Sc ioceheu i . Trento).
a ovest: Canale B attaglia - km. 32
a s ud: C.li Bovolenta e Pontelongo - km. 40
a est: Lagune - km. 42
L ' interno del trap ez io è solcato da numero s i e profondi ca nali , altezza media I , 50 m., larghezza da IO a 40 m., essi so no c hiusi fra argini co s tituenti qui le sole vie di comunicaz ione. La chiaviche idrauliche di Strà, Dolo , Battaglia e Brondolo pennettono di aumentare il corpo d 'acqua dei cana li ed inond are il terreno interposto. Con questa inonda z ione si da a questa zona di terreno il carattere di un se rio ostacolo alle operazioni in qualunque senso dirette , di so lido lega me fra il lato Vicenza-Padova e le lagune, e s i limita l'occupazione della linea ai due punti di Padova e Me s tre. da ambedue que s ti punti si può co n forze conside revo li sbocca re contro un n em ico che tentasse forzare il lato inferiore della tanag lia o minacciarne il fianco s inis tro e le spa ll e qualora il tentativ o fosse diretto contro il lat o s up er ior e Pado va ha p erò caratteri co ntroffen s ivi maggiori di M es tre. Pado va in fa tti , al centro d e l vasto rettan go lo formato dal Brenta, dalla Bre ntella, dallo Scaricatore e dal c anal e di Pioveg o, punto inte rmedio dei fronti intermedi s tabili s ul Bre nta da Vaccarino a Dolo , nodo delle strade dall'alto Veneto all'Italia centrale, può considera r s i come un vasto campo trince rato na tural e , pe rno della dife sa attiva fra Pia ve e Brenta. Me s tre ha pure ca ratteri controffensivi assai s piccati, m a nell e s ue attuali condizioni di distacco dal res to del co ntin en te no n s i presenta come punto favorevole al concentrame nto di forze molto numero se (massi mo 4 Corpi d 'A rmat a) .
TI lato s up e riore d e lla tana g lia è seg n a to dal corso del Bacc higlione eia Vicenza a Padova. Il fiume presenta ottime condizioni difensive , le quali so no aumentate dai gr uppi di colline c h e sorgono sulle s ue rive (Co lli Be rici e d Euganei s ulla riva destra, Al t.ure di Montegalda s ulla riva sin istra ). Ques ti grup pi formano nel loro ins ieme una region e co llinosa, che sa ldata ai Lessini dalla Stretta di Vic e nza , alla La g una dal bas so Brenta , coperta sul fronte ciel Bacchiglione, cost itui sce un ' insieme di pos izioni tatti c h e atte a spalleggiare la no s tra controffensiva s boccante eia Padova e da M es tre.
Cr iteri per l' occ upa z ione difensiva della lin ea
1 criteri per l'oc c upa zion e della linea s i ria ss umono nei seg uenti:
1. Concen trare la massa delle forz e s ul lato P adova- M es tre ripartendole co n giusta proporzione in du e nuclei a Padova e Mestre e predi s pone ndo inonda zio ne del terreno di riva de st ra del Brenta . Da questi due punti operare offensivamente contro le ma sse ne miche s bo ccan ti nel pi ano fra Piave e Brenta.
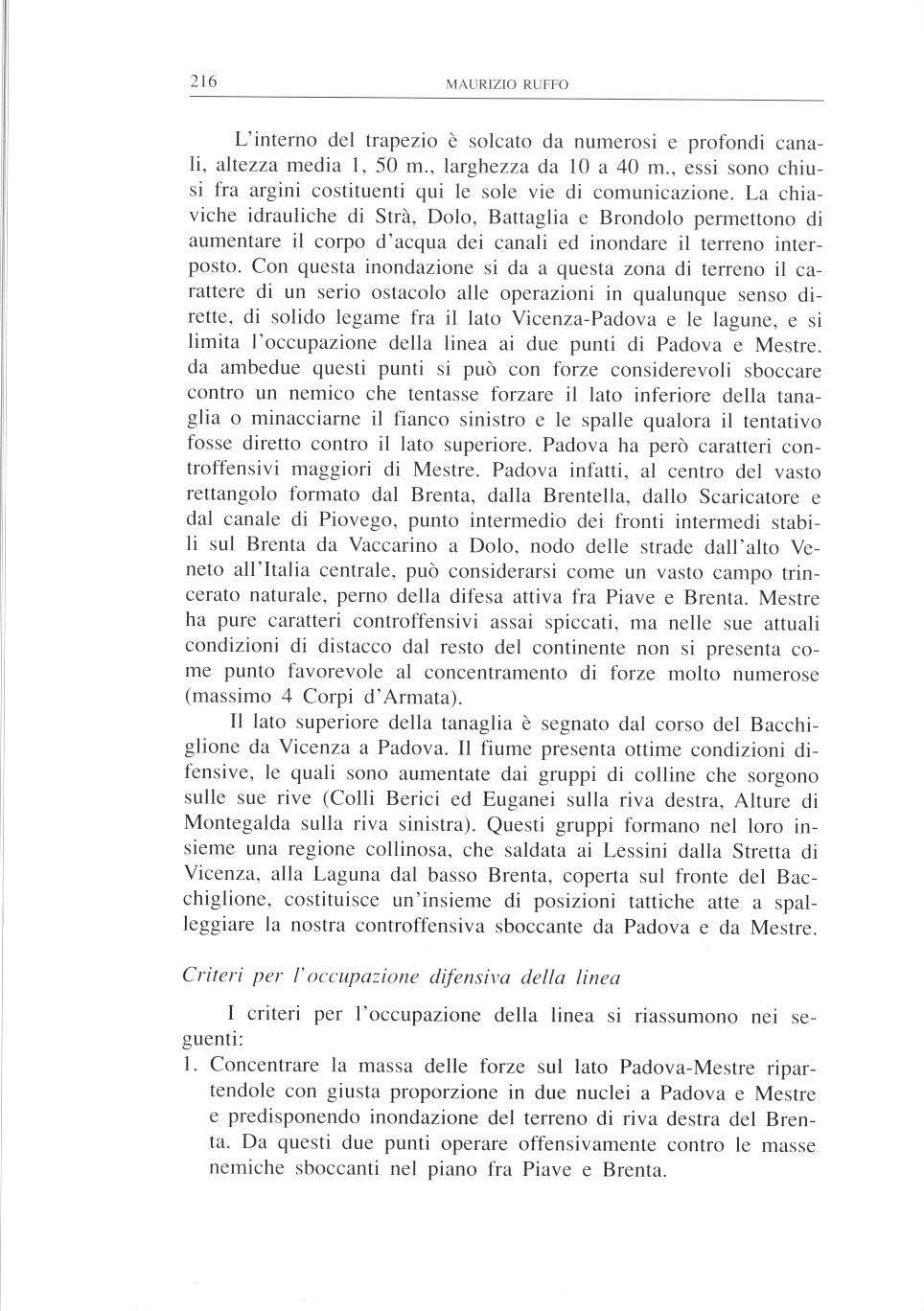
2. Occupare difensivamente i punti principali del lato Vicenza-Padova allo scopo d'intercettare la nemico la marcia verso est e di spalleggiare la mossa offensiva ora descritta.
In base a questi criteri i movimenti da eseguirsi possono così riassumersi:
1. Ritirata del le truppe dalla lin ea del Piave sui punti Mestre e Padova e s ul trailo Padova-Vicenza.
2. Avanzata dell'Armata di riserva su Padova.
3. Ripiegamento del X ° Corpo su Vicenza. Que s to Corpo terrà distaccamen ti a Bassano e a Thiene a sostegno delle truppe di difesa cli Primolano e di Settecomuni, sgombrerà l'alto Piave abbandonando a se stesse le truppe di difesa del ridotto cadorino.
La seguente tabella indica la dislocazione dell'esercito nazionale dopo l'effettuazione dell'occupazione della linea Vicenza- Padova-Mestre.

Disloca:ione per f' occ11pa:io11e difensil'a della linea Vicen:a-Pado1 •a-Mes tre
Armate Corp i Di slocazion i Sta bil imen ti Li nea di rif. to Ann otazioni av. Li
1• l'avaro I inea ferrov iari a:
11 • nord di Me stre Rovi go -Adria -
J a m· Mestre Rov igo Loreo -Ch ioggia Si collega no a
1v0 Ze llari no e via acquea: Noale: co ll a
J• D. Cav. sul fronte Chioggi a-M estre destra
1/2-2• D. Cav. Marcon -Noalc dell a J• D.
v • Vigon ,a Pcl v•. v1 ° e v11 °
v 1° Villa nova Corpo li nea ferrov iaria :
2 a v 11° Cam po d'Arsego 1.eg nago-~1onse Iice-
v 111 ° Montegalda Legnano Padova. Pel VIIl° e 1/2
112 - ix• Longure ix• via ord inaria:
5• D. Cav. Caste lfranco Lcg nago -:>lovcnta
x• Vicen za Li ne a ferrov iari a: Di ,taccam ent i
3" x 1° S. Bonifacio Mantova Mantova- Verona a Bassa no
xu• Ve rona-Lonaw Verona -Lonato e Tiene
Xlll 0 Padova Li nea ferrov iaria:
4 a x i v• Padova Fe rrara Ferrara-Padova
xv • /\bano
Coman d o in capo Padova
h) Studio relativo al movimento in ritirata ossia al passaggio dalla linea del Piave a quella Vicenza-Padova-Mestre.
Esame sommario fallico-topografico della zona da attrai·ersarsi.
Questa zona è compresa fra la linea del Piave, quella Vicenza-Padova-Mestre, il fronte Ponte Priula-Mo ntebelluna-Bassano -V icenza e la laguna veneta.
Profondità della zona nel senso della marcia (in linea retta): minima da Ponte Piave a Mestre 30 km.
mass ima da Ponte Priula a Vicenza 62 km.
La zona è generalmente piana, fertile ed offre ottime condizioni d'accampamento per numerosa truppa di qualsiasi arma.
La rete stradale è assai ricca in tutti i sensi, il suo andamento generale presenta tuttavia la carati.eristica di convergenza dalla linea del Piave a Treviso e d'irradiamento da questo punto sul fronte Vicenza-Padova- Mestre.
Gli ostacoli tattici che questa zona presenta non hanno grande valore. Orientandoli rispetto alle due presumi bi I i direttrici cieli' offensiva nemica possono così raggruppar si:
I. Direttiva procedente dal Piave verso est o s ud -es t:
Sile eia considerarsi pel solo tratto Treviso-Porte Grandi. Lunghezza 20 km. , larghezza media 30 m. , profondità 2, 4. Treviso, città murata, costituisce un buon appoggio a sinistra ed è il punto più importante della linea;
Musone torrente a fronte concava verso est. Valore tattico piccolo, aumentato nella parte bassa ciel suo corso eia altri torrenti che corrono paralleli ad esso;
Brenta eia considerarsi pel tratto Bassano-Dolo, ove s i salda alla linea Padova-Me s tre. Lunghez za 60 km., larghe zza media 70 m., profondità 1, 5 m.
Queste tre linee possono offrire un ostacolo momentaneo al1'avanzata del nemico e si presentano come linee atte alla sosta delle truppe in movimento dal Piave al Fronte Vicenza-Padova- Mestre.
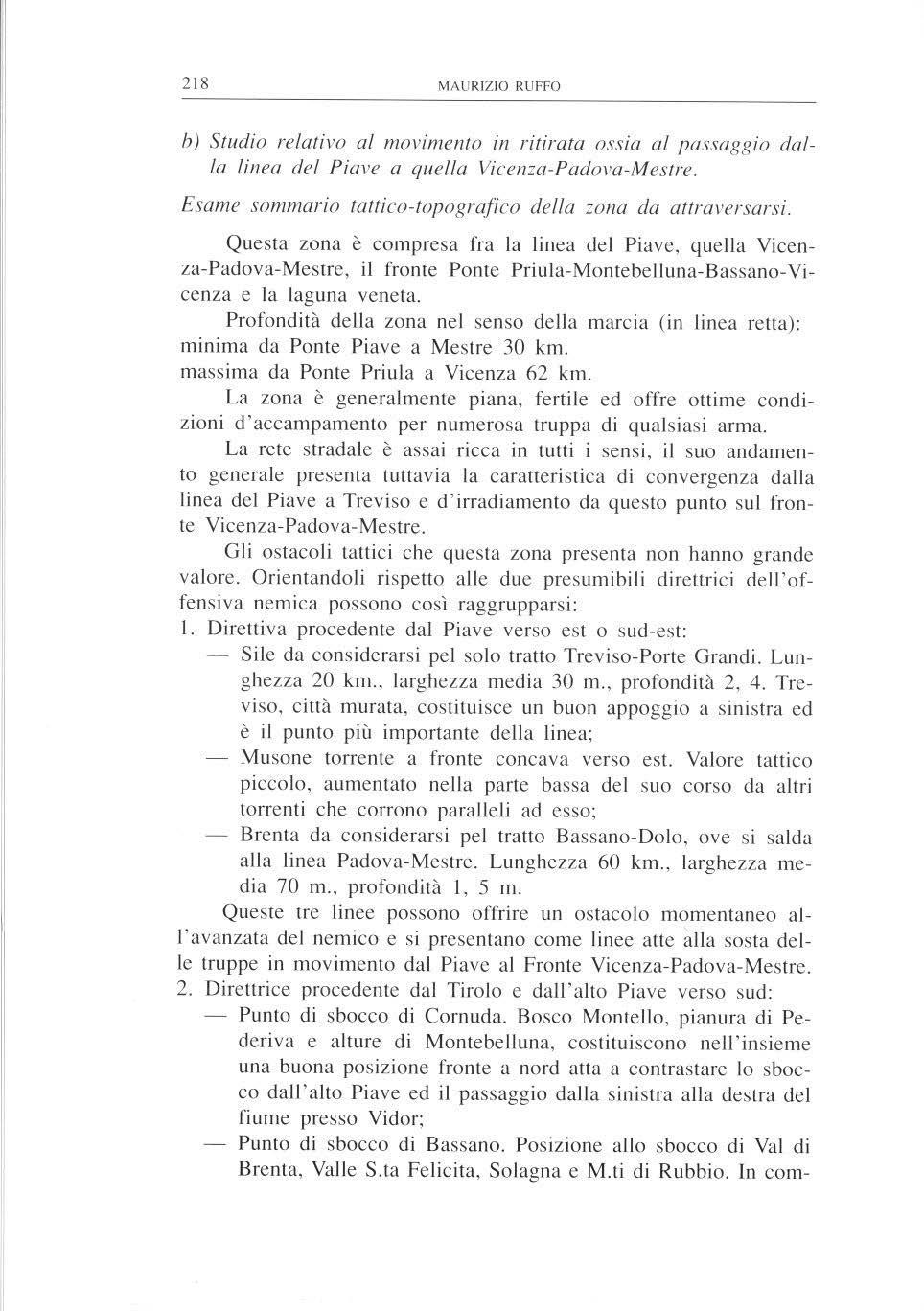
2. Direttrice procedente dal Tirolo e dall'alto Piave verso sud:
Punto di sbocco cli Cornuda. Bosco Montello, pianura di Pecleriva e alture cli Montebelluna, costituiscono nell'insieme una buona posizione fronte a nord atta a contrastare lo sbocco da!J 'a lto Piave ed il passaggio dalla sinistra alla destra del fiume presso Vidor;
Punto di sbocco cli Bassano. Po sizione allo sbocco di Val di Brenta, Valle S.ta Felicita, Solagna e M.ti di Rubbio. In com-
plesso ottima posizione contro attacchi frontali, richiede forze numerose per la s icure zza delle ali non validamente appoggiate. Ques te due posizioni si presentano come convenienti per la protezione dell'ala sin is tra del le truppe in ritirata e potranno essere efficacemente occupate da un distaccamento avente la mi ssione anzidetta.
Criteri per I' esecu : ione del movimento i11 ritirata
I criteri ai quali può informarsi il movimento in ritirata dalla linea del Piave a quella Vicenza- Padova-Mestre s i ria ss umono nei seguenti:
I. Passagg io immediato di tutte le trupp e sulla destra del Piav e . Dis tru zione dei ponti e irradiamento della cavalleria lungo la riva des tra allo scopo di inte rromp ere l'immediato contatto con il nemico.
2. Ritirata delle truppe sosta ndo s uccessivamen te sulle lince:
Site: Tr eviso -Porte Grandi;
Muson e e corsi d'acqua paralleli: Asolo-Castefranco-NoaleMestre;
Brenta: Bassa no-Dolo-M estre.
3. Occupazione temporan ea per parte di un distac camento a protezione dell 'ala s ini s tra dei punti di sbocco di Mont ebelluna e Bassa no.
In base a qu es ti criteri l ' effettuazione ci el movimento potrebbe aver luogo nel segue nte modo e g iusta le norme seg uenti:
I. Ini zio ciel movimento ne lle ore antimeridiane ciel giorno x.
2. Compimento in cinque g iorni raggiungendo:
la sera del giorno x la linea del Silc;
la sera del giorno x+l la linea del Musone;
la sera del giorno x+2 la linea del Brenta;
la sera ciel giorno x+4 la linea Vicenza - Padova-Me s tre.
3. La rete s tradale può essere così ripartita:
I • Armata: dalla Strada P.te di Piave-Treviso-Mogl iano-Marte llago-Mirano, inclu sa, a sud;
2• Armata: dalla predetta strada, esclusa, a nord, lasc iando libera la strada Bassano -Vicenza al X ° Corpo.
4. La prote z ione del l 'ala sinistra durante il movimento di ritirata può affidars i:
a llo sbocco di Cornuda: all 'VI11 ° e 1, 5 IX° Corpo; allo s bocco di Ba ssa no: al X ° Corpo. Questo dovrà perciò avanza -
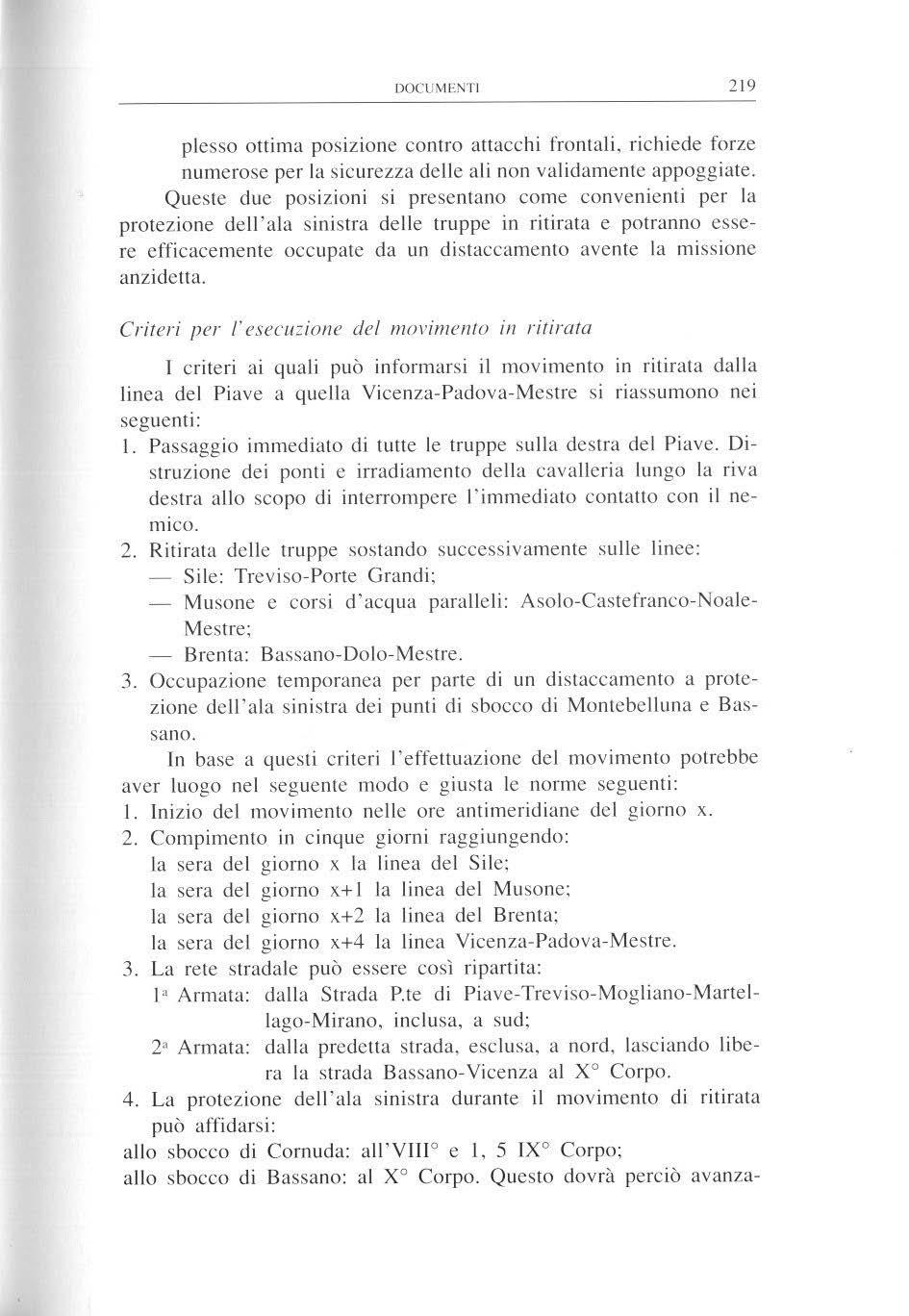
re circa una divi~ione a Bassano pe r la se ra del giorno x e tenerve la fino a movimento compiuto, quindi ri t irar la s u Yicen7a lasciando un distaccamento a sostegno delle truppe di Primolano.
La segue nt e tabella da le possib ili dislocazioni dei Corpi durante il mov imento.
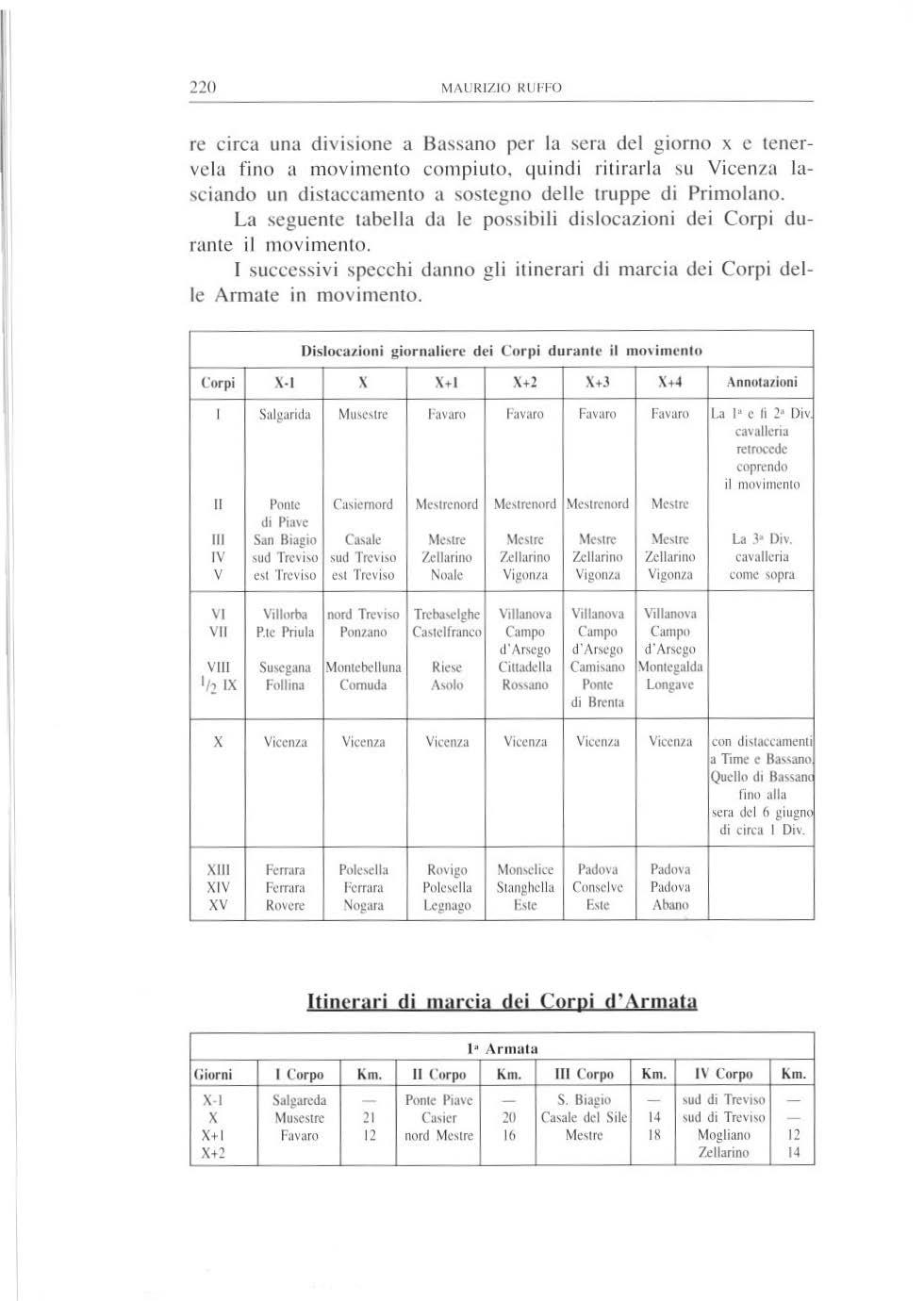
I s u ccess ivi specc hi danno g li itinerari di marci a dei Corpi delle Arma te in movimento.
O isloca1.ioni giornaliere dei Corpi durante il mo,imcnto
Corpi X- I X X+I X+2 X+3 X+~ Annota1ioni
I Su lguri, la Mu ,c,1rc Fiwaro bva ro Fuv aro Favaro La I' e li 2" Div ca1.11icria re1rocedc coprendo il mov ime nto
Il Po111c (a'1cmord Me,trcnord Me,trcnord Mc,trcnord Me,trc d1 Pia,e
lii San Biagio Ca,ak Mc,1re \lc ,1re \l e,1re ~k,1re La , D1v
IV wd Trcv i,o ,ud Tre, i,o Zellar ino 7.cllarino Zc ll arino Zc ll anno cavalleria
V e,t Trev iso est Trev iso Noalc Vigo 111a Vigo111a Vigon,a come ,opra
\'I Villorba nord Tremo Treb,N:lghe \ '1llanou \'illanO\a VillanO\a
VII P.tc Pnula Pon1,1110 Ca,tclfranco Campo Cumpo Campo d"A rscgo d·/\rscgo d"Ar,cgo
VIII Su,cgana Montere iIuna Ric,e Ciuatlclla C'anu,ano \fon tegalda
112 IX Follina Comuda /\,olo R0\\,1110 Pomc Long.i,c di Brenta
X Viccn,a Vicc n7 a Vicenza Viccn,a Vic\!nta Vkcn,a co n di,t,1ccamen1i a Time e Ba,-ano Quello eh Ba,sanc fino alla ,era del 6 giugno di ci rca I Di,·.
Xlii Ferrara Polc,clla Ro1igo Mon..clice Pado1a Padova
XIV Ferrara Ferrara J>o lc,cl la Swng hc ll a Conse lve Padova
xv Ro,ere \J oga ra Lc~nago l:\IC E,1c /\bano
Itinerari di marcia dei Corpi cl ' Armata
l 'Ar m a t a
Giorni I Co rpo Km. Il Corpo Km. lll Corpo Km. I\' Corpo Km.
Xl Salgareda - Pome P1a,c - s. BiJ)!IO - ,ud di Trevl\O -
X Mu,cs1rc 21 Casier 20 (a,ale del Silc 14 ,ud di Treviso -
X+ l F.iva ro 12 no rd Mestre 16 Me,1rc 18 Mogliano 12
X+2
Zellarino 14
2• Armala
Giorni V Corpo Km. VI Corpo Km. VII Corpo Km. VIII Co rpo Km. f/ 2 IX Corp< Km.
X- I cs1 Treviso - Vi ll orh a - Pont e Pri ul a Susegana - Follina -
X es1 Treviso - nord Treviso IO Ponzano 16 Mo111ebellun a 20 Cornud a 26
X+ I Noale 22 Trcba , d ghc 24 C,h lclfranco 28 Rie,~ 1'2 Aso lo 9
X+ 2 Vigonza 18 Villanova 20 Ca mpo 22 C' in adella IS Ross ano 18 d'Ar,ego
X+3 Cami:>ana 20 Ponie Brema 12
X+-1 Mon tega ld a 10 Longu re '26
4" Armala
Giorni XIII Co rpo Km. XI V Corpo Km. XV Corpo Km.
X- 1 Ferrara - Ferrara - Rc,•crc
X Polesella 22 Ferrara - Nogara 18
X+l Rovigo 12 Pobell a 22 Legnago 24
X+'2 Monse li ce 20 S1ang hell a 20 Es te 30
X+3 Padova '2 1 Consclw 18 Este
X+4 Padova 20 Aba no 26
e) Enumera zione e riassunto degl i o rdini e disposi:ioni da emanars i per I' effe rtua :ione del progettato mm·imento.
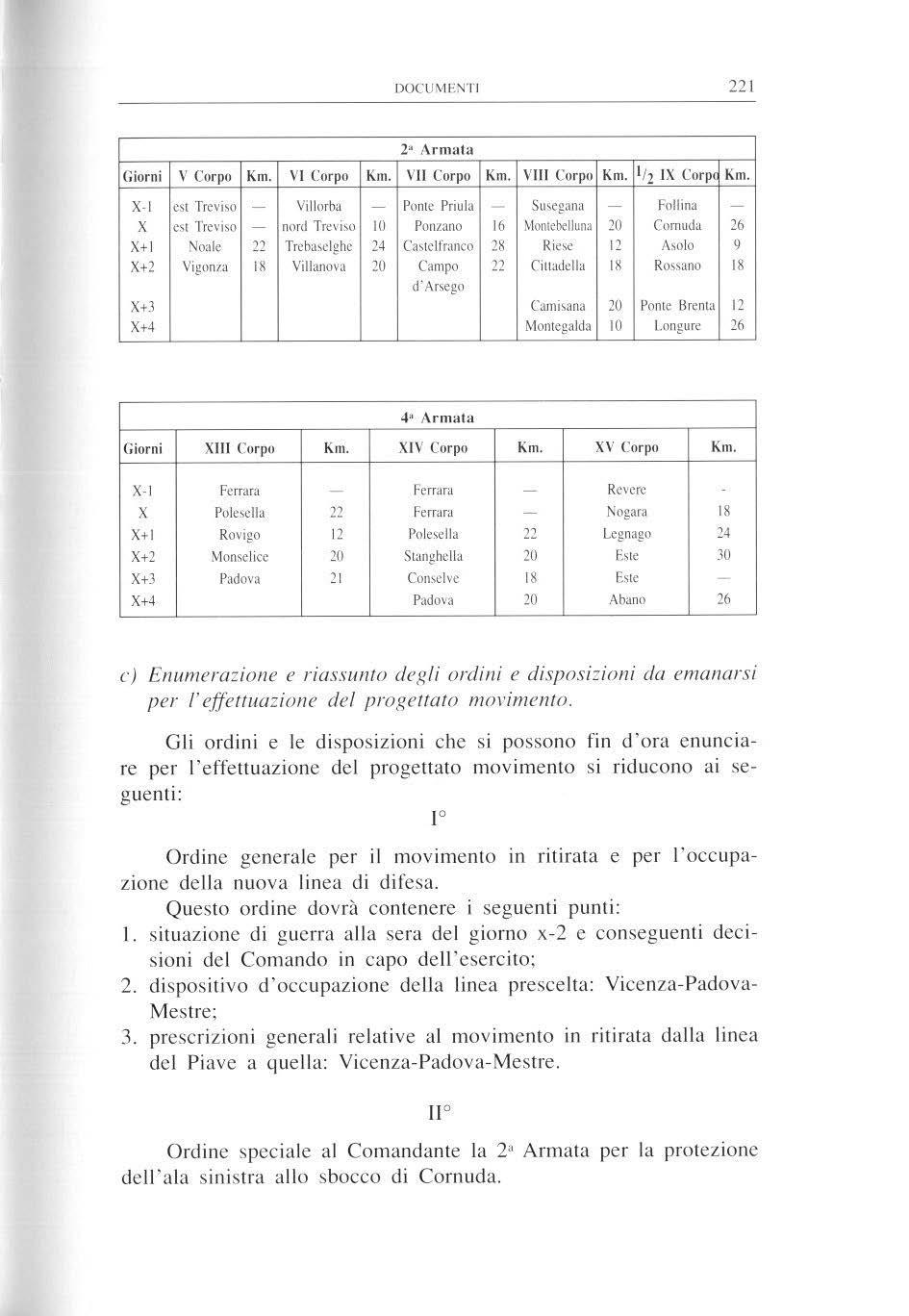
Gli ordini e le di s pos iz ioni che s i po sso no fin d 'ora e nunci ar e per l'effettuazione d e l progettato movim e nto s i ridu co no ai seguen ti:
10
Ordine ge nerale per il movimento m ritirata e per l 'occupaz ion e d e ll a nuova lin ea di difes a.
Que s to ordine dovrà contenere i seg ue nti punti:
I. s ituazione di g uerra alla se ra del g iorno x -2 e conseguenti d ec is ioni del Comando in capo de ll 'ese r ci to ;
2. di spos itivo d 'oc c upazion e de lla linea presce lta: Vi ce nza -PadovaMe s tr e;
3 presc ri zion i ge nerali relativ e al movim en to in ritirat a d a lla lin ea del Piave a quella: Vi ce nz a-Padova-Me st re.
11 °
Ordine spec ial e a l Comandante la 2 " Armata per la protez ione d e ll 'a la s inistra allo s bocco cli Cornuda .
Ordine speciale al Comandante il X ° Corpo d'Armata per la protezione dell'ala sinistra allo sbocco di Bassano.
Ordine speciale al Comandante la piazza di Venezia per la predisposizione del!' inondazione del terreno di riva destra del Brenta e per la preparazione di materia le nautico da trasporto per i rifornimenti della l" Armata, in base alle richieste dell'Intenden z a della stessa.
Lettera al Comandante le truppe del ridotto del Cadore contenente le informazioni relative alla situazione a lui creata con l ' effettuazione del progettato movimento in ritirata .

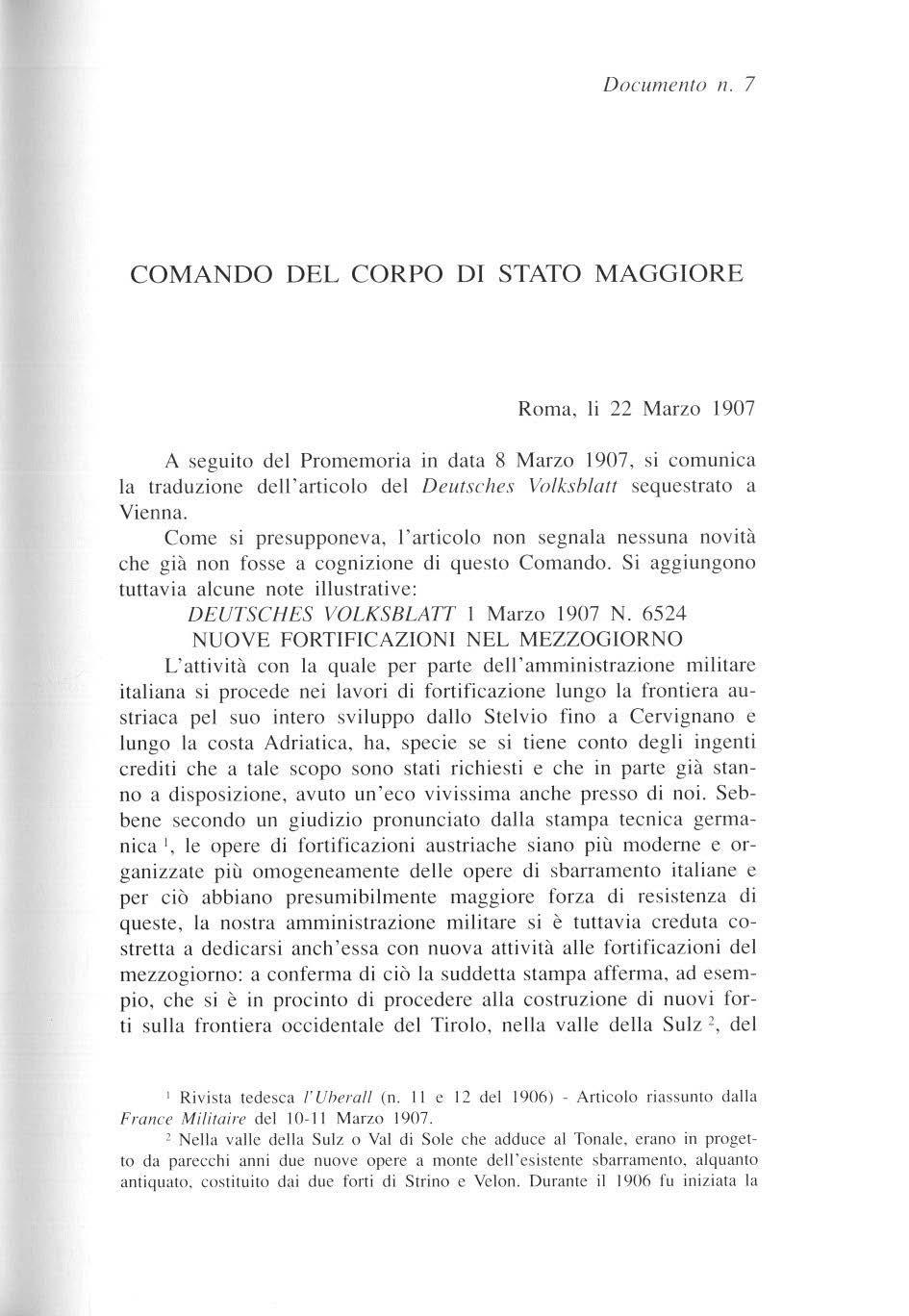
Roma , li 22 Marzo 1907
A seg uito del Promemori a in data 8 Marzo 1907, si comunica la traduzione dell'articolo del Deutsches Vo/ksblatt sequestrato a Vienna.
Come s i presupponeva , 1' artico lo non seg nala n ess un a novità c h e già non fosse a cognizione di qu es to Comando. Si aggiungono tuttavia alcune note illus trativ e :
DEUTSCH ES VOLKSBLATT I Marzo 1907 N. 6524
NU OVE FORTIFICAZIONI NEL MEZZOGIORNO
L 'a ttività con la quale per parte dell'amministrazione militare italiana s i procede nei lavori di fortificazione lun go la frontiera austriaca pel suo intero sviluppo dallo Stelvio fino a Cervignano e lun go la costa Adriatica, ha, s pec ie se si tiene conto degli ingenti crediti che a tal e scopo sono s tati richie s ti e che in parte già sta nno a di sposizio ne , avuto un 'eco vivissima anche presso di noi. Sebbene seco ndo un giudizio pronunciato d alla s tampa tecnica ge rmanica 1 , le opere di fortificazioni austriache s iano più mod erne e organizzate più omogeneamente delle opere di sbanamento italiane e p e r c iò abbiano pres umibilmente ma gg iore forza di re s is tenz a cli que s te, la no s tra amministrazione militare s i è tuttavia c r e duta costretta a dedicarsi anch'essa con nuova attività alle fortificazioni del m ezzogio rno: a c onferma di ciò la suddetta stampa afferma, ad esempio, che s i è in procinto di proce dere alla cost.ruzione di nuovi forti sulla fronti e ra occidentale ciel Tirolo, nella valle d e lla Sulz 2 , del
1 Rivista tede sca /' Ul>era/1 ( n. 11 e 12 del I 906) - Articolo riassun to dalla France Mifitaire del 10-11 Marzo 1907
2 Nell a val l e d ella Sulz o Val di So le che add uce al To nale. erano in proge tto da parecchi anni due nuove opere a monte dell'esiste nte sbarram ento, alq uanto antiquato, costituito dai due fort i di Strino e Velon. Durante il 1906 fu ini ziata la
Sarca 3 e del D aone 4 • Senza entrare in particolari vietat i dalla legge sulla stampa, accennerò so lt anto c he formano oggetto di tale accresciuta attività fortifica toria da un a parte l 'opportunità di provvedere ad una maggiore s icurezza ciel Tirolo meridio nale di fro nt e alle zone di radunata ita l iane Ars iero-Asiago e Primolano-Fastro - L amon , come pure la nece ss ità di difendere più eff icacemente l'importan te va l Pusteria e d'altra parte il completamento deg li sba rramenti della Carinzia nonché delle s trade e ferrovie provenient i da Gorizia. Lungo la costa si s tan no completando le fort ificazioni di Pola e Cattaro e s i p rocede alle nuove fortificazioni d i Sebenico e Ra gusa e di alcune isole 5 In seg uit o a li ' istituzione di un comancostruzio ne di un tronco di strada mi l itare che dal fondo valle. nei pressi de l forte Velon. deve condu rre ad una pos izione in locali tà Pozzi /\ l ti ove, dicesi. nel corrente anno sarà in i ziato un nuovo forte con obiettivo i l passo e le proven ienze dal Tonale. (V. Fogl io Bormi o u. Passo de l Tonale della Carta Ausl riaca I :75 000 e Bollettino dello Scacchiere Orien tale N. 25 del 10 novembre 1906).
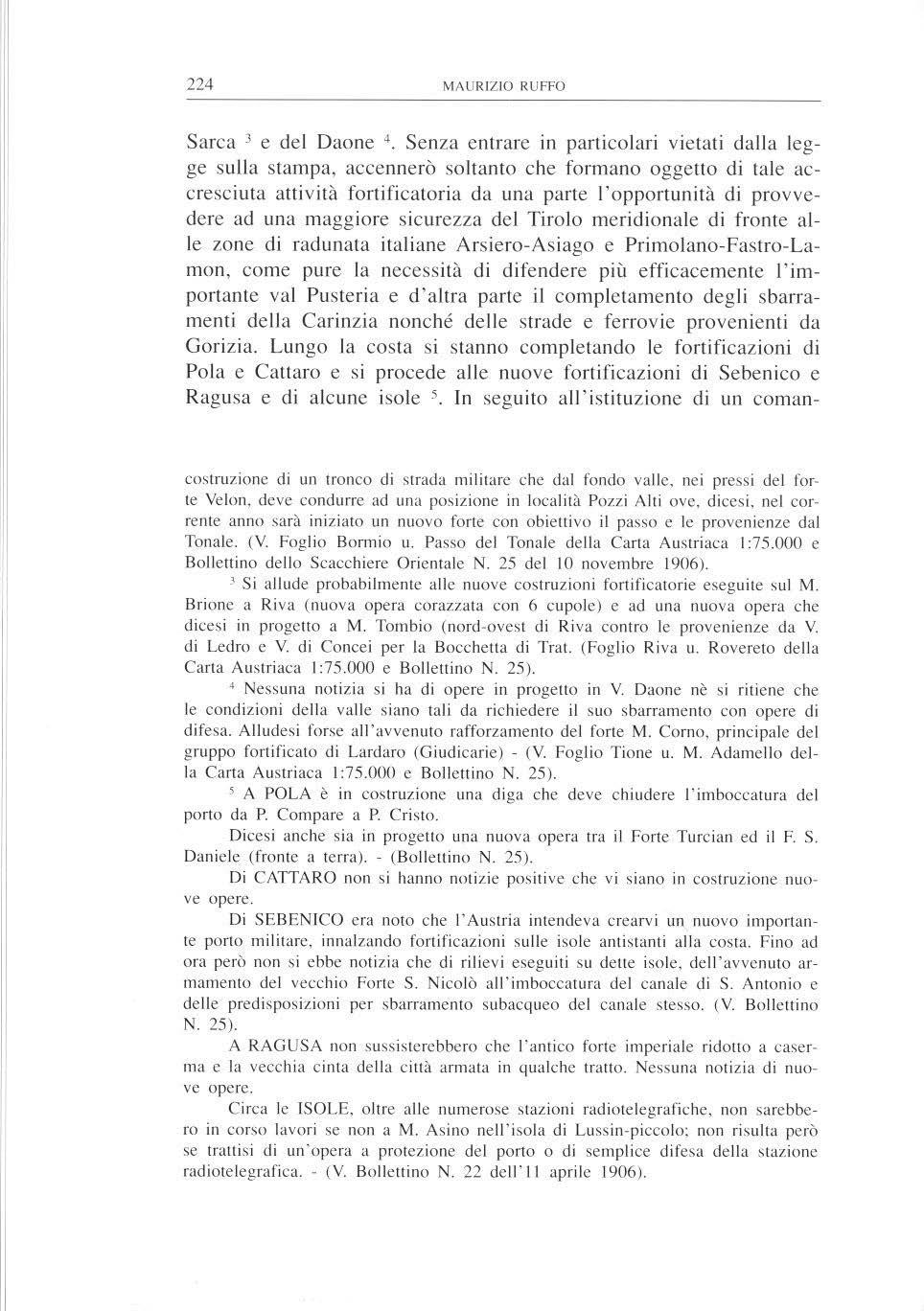
3 Si allude probab i lmente alle nuove costruz ioni fortificarorie eseguite sul M Brion c a Riva (n uo va opera corazzata co n 6 cupo le) e ad una nuova ope r a che d icesi in progetto a M Tombio (nord -ovest di Riva con tro l e provenienze da V. di Ledro e V. d i Concei per la Bocchella di T r at. (Fog li o R i va u. Rovereto della Carta Aust ri aca I :75.000 e Bollettino N. 25).
• Ness una no ti z ia si ha di opere in progetto in V. Daone nè si ritiene che le cond iz ioni della valle sia no tal i da richiedere il suo sbarr ame nto con opere di difesa. Alludesi forse all 'avvcnu to rafforzamento del forte M. Corno, principal e del gruppo fort i fica to d i Lardare (G i udicarie) - (V. Fogl io T ione u M. Adamello dell a Carta Au striaca I :75.000 e Bollett ino N. 25).
> A POLA è in costruz ione u na d iga che deve chiudere l'imbocca tur a cie l porto da P. Compare a P. C ri sto.
Diccsi anche sia in progello una n uova opera tra il Forte Turc i an ed i l F. S. Danie le ( fr onte a terra ). - (Bo ll ettino N. 25).
Di CATTARO non si han no notizie posit i ve che vi sia no in co struzione n uove opere
Di SEBEN ICO era noro che l ' A ustr ia in tendeva cr ear v i un nuovo importante po r to mi l itare. in na lza ndo fortificaz ioni sulle iso le an tis tanti alla costa. Fi no ad ora per ò non si ebbe not i zia che di ril ievi esegu it i su dette isole. dell'avvenuto armamen to de l vecc hio Fo rt e S. Nico lò all'imboccatura ciel cana le di S. J\ ntonio e delle pred isposizio ni per sbarramento subacqueo del cana le stesso. (V. Bollettino N. 25).
A RAGUSA non sussisterebbero che l'ant ico forte imperiale ridotto a caserma e la vecchia cin ta della c i llà ar mata in qualche tratto. Nessu na notizia cli nuove opere.
C irca le ISOLE, oltre alle numero se staz ioni radio telegra fich e, non sarebbero in co rso lavori se non a M. Asino nell'isola di L uss in -p icco lo; non r isulla però se tralli si di un opc r a a p ro tez ione de l porto o di semplice difesa della st azione radiote legrafica. - (V. Bolle ttino N. 22 dcli' Il apri le I 906).
do di sbarramenti a Riva 6 e dell'aumento dell'artiglieria eia fortezza sembra che i provvedimenti nel T ir o lo meridionale s ia n o ormai di dominio pubblico. Quello che è asso lut amente sintomatico è lo stato de ll e direzioni ciel genio lungo la frontiera che si trovano in pretta contraddizione con l a situazione numerica prescritta e prevista dal B il ancio preventivo per l'anno 1907. L a s itua zione normale per Tr e nt o sarebbe cli l ufficiale superiore e di 4 ufficiali inferiori , mentre presentemente quella direzione conta I ufficiale superiore e I O ufficiali in fer iori; Brixen che nel lo stato normale dovrebbe avere I ufficiale s uperiore e I inferiore, ha ora due ufficiali inferiori in più; così pure K lagenfurt. L a direzione del genio di Pola ha due ufficiali super iori e 10 infer iori, mentre norma lm ente dovrebbe averne rispettivamente I e 5; la direzione di Cattaro ha oltrepassato di 8 ufficiali inferiori il suo organico normale che è di I ufficiale superiore e 5 ufficia li inferiori. A tutto CIO si aggiunga ancora un aumento di personale nell'organico dei ragionier i e dei sorveglianti alle costruzioni militari.
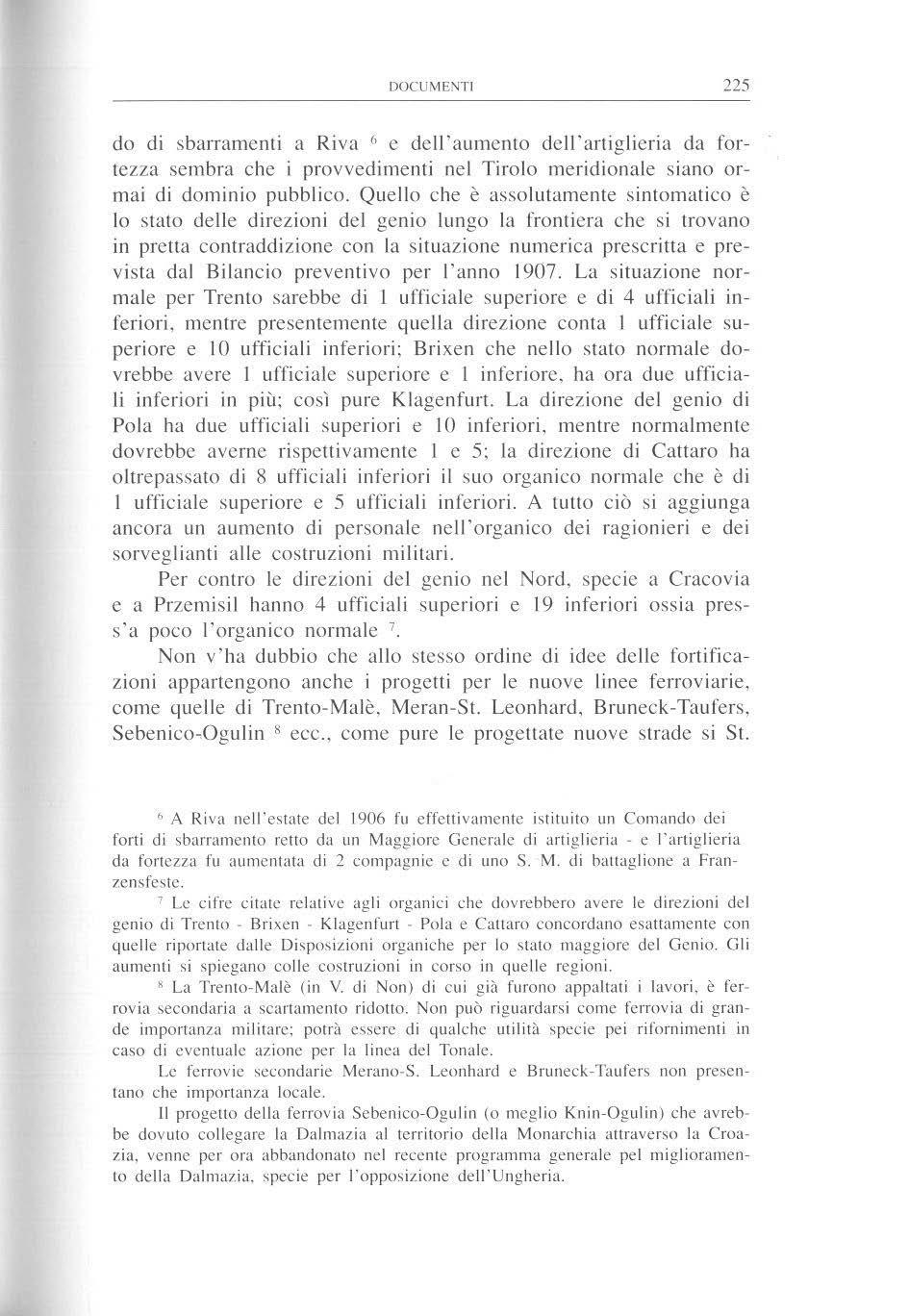
Per contro le direzioni del genio nel Nord, specie a Cracovia e a Pr zemis il hanno 4 ufficiali superiori e 19 inferiori ossia press 'a poco l'organico normale 7 •
Non v'ha dubbio che allo stesso ordine di idee delle fortificazioni appartengono anche i progetti per le nuove Iinee fer r oviarie, come quelle di Trento - Malè, Meran -St. L eonhard, Bruneck -T aufers, Sebenico - Ogulin 8 ecc., come pure le progetta te nuove s trade si St.
0 A Riva nell'estate de l 1906 fu effettivame nte ist i tuito un Coma ndo dei forti di sba rramento retto da un Magg iore Generale di art ig l ie ri a - e I ·artiglieria da fortezza fu aum entata d i 2 compag nie e di uno S. M. di hallag li one a rranzcnsfcs te.
7 Le ci fre c i ta te re lat i ve ag l i or ga ni c i c he dovrehbero avere le direzioni del genio d i T renlo - Br i xen - Klagenfun • Po la e Cattaro concordano esattame nte co n quel le riporta te dalle Dispos iLioni organiche per lo st ato magg iore del Genio. G l i aument i si spiegano colle costr uzio ni in corso i n quelle region i.
" La T r emo-Malè (in V. di Non) di cui giil furono appaltati i lavori , è fe rrovia 1,econdaria a scartame nto ridotto. Non può ri guarda rsi come ferrov i a d i grande importanza mi l itare: potr /1 essere di qualc he ut i l ità specie pe i rifornim en ti in caso di eventuale az ione per la l inea de l To nale.
Le ferrovie secondarie Merano-S. Leonhard e Bruneck-Taufer~ non presentano che importanza l ocale.
li progetto della ferrovia Sebenico-Ogu l in (o meg l io Knin-Ogu l in) c he av rebbe dovuto collegare la Dalmazia al ter rit ori o de ll a Monarchia attraverso l a Croazia, venne per ora abbandonato nel recente prog ramm a general e pel migl ioramento del la Dalmaz ia, specie per l'opposiLione dell'Ung heria.
Leonhard-Jaufenpass-Sterzing, Krimml-Kasern, Cortina -Colle di Falzarego, Arabba-Pordoi, Primiero-passo di Bricon -Castel Tesino 9 ecc., le quali tutre come pure gli ampliamenti di talune stazioni ferrov iarie progettati nel programma d'investizione della Sudhahn non tendono solamen te ad aumentare il traffico e ad agevo lare l'affluenza dei forestieri, ma rispondono anche ad esigenze strategiche 10 • Di guisa che al di qua e al di là della nostra frontiera meridionale regna una febbrile attività mi li tare a ll o scopo di mantenere fra i due stati un'inalterata pace armata, la quale dopo le mancanze di tatto ufficiali di Udine, lascia, come si afferma eia fonte non ufficiale, molto a desiderare.
9 La strada de l lo Jaufenpass è in corso di co.struL ione da parecch io lempo: stabi lirà una diretta comu ni cazione dal Brennero a Merano, faci l itando gli accessi e la ritirala dalla l inea de l la Vintschgan.
La proge ttata strada del Kri111 n1l er Taucrn (da Krimml nell'a lta valle della Salzaeh a Kasern in V. dell" /\hrn) metterft i n comunicazione il Pinzgau co l Pusterthal facendo capo a Bruneck.
La Cortina-Pas so di Falzarego. g ià da lu ngo lempo carrareccia costituisce un lronco de l la grande l inea rotabile di arroccamento delta delle Dolomi1i; che unisce il Pusterlhal al medio Adige. Anche 1ale tronco sarà ridotto a buona rotabile nel co rren te anno.
La Arabba-Po rdo i pa~s (dal Bueh en stein alla V. di Fassa) è da 3 anni co mpiuta ed ape r ta al lraffico.
La Primiero - Passo de l Brocon-Ca stel Tesino da parecchi anni in progetto non fu per ora costruita che nel tratto Imc r-Cana l S Bovo. Cost ituirà un arroccamento in prossimi tì1 della frontiera fra la l inea del Cismon e la Va l Sugana.
1n rurono seg nalati lavori d i ampliamento a scopo spec ialmente militare in numerose staz ioni lu ngo la linea Ams tetten-Pon tafe l.
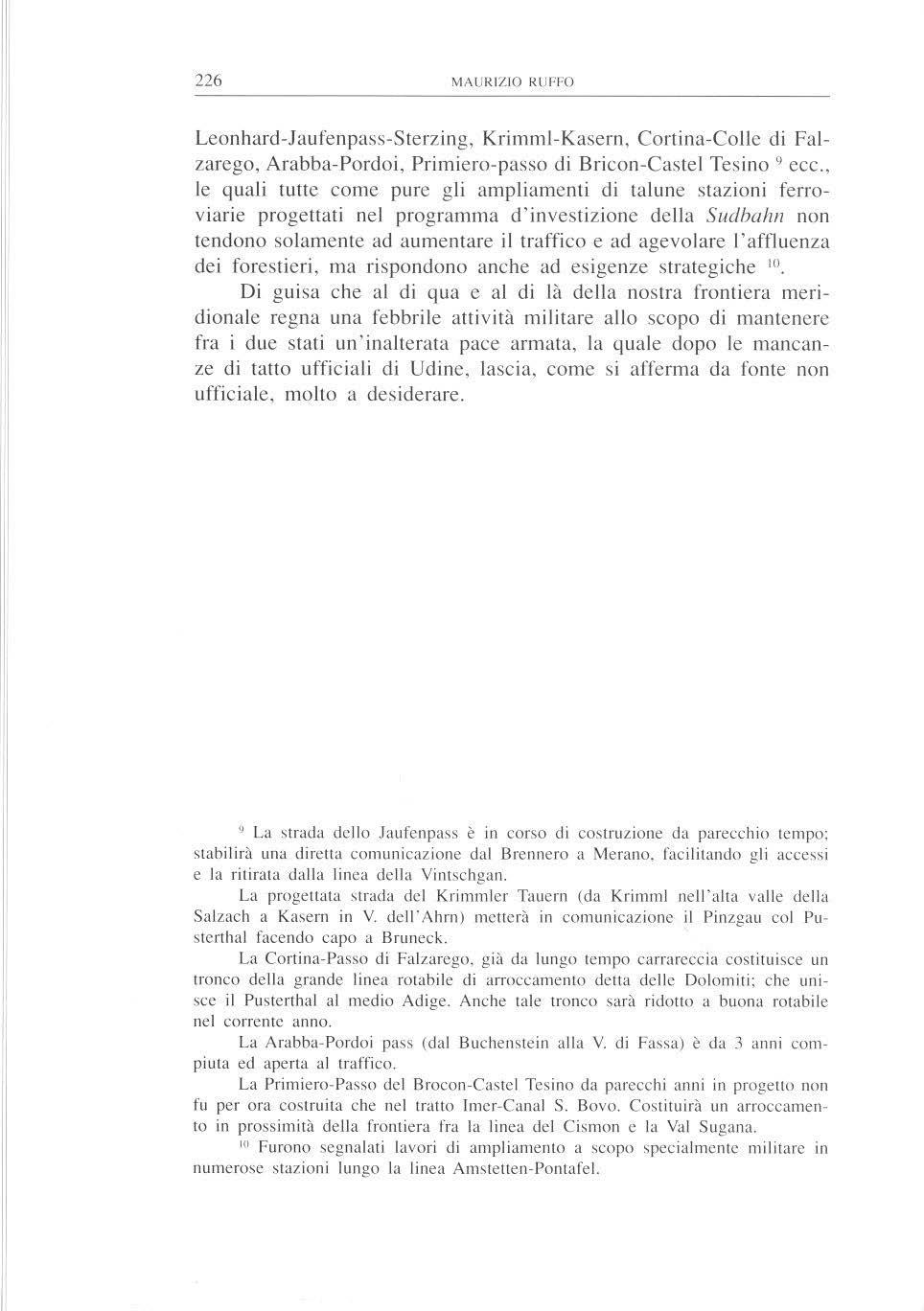
N. 30 l di prot. Pers Riservatissimo
Roma, addì 8 Aprile 1912
OGGETTO: Le Armate 2• e } • nella radunata Nord-Est.
Dal carteggio svoltosi in questi ultimi tempi coi Comandanti de s ignati della 2a e 3" annata, è apparsa l'opportunità cli definire , fino da ora, alcune questioni che si riferiscono alla dislocazione delle truppe ed alla ripartizione dell e zone di radunata N. E. fra le armate stesse, in connessione anche al raggruppamento delle opere di difesa permanente stabilite dal confluente del Fella nel Tagliamento al margine morenico di S. Daniele.
La definizione di cui trattasi sa rà sancita nelle DIRETTIVE e nel FASCICOLO DI RADUNATA N. E., che saranno diramati in sostituzione di quelli vigenti, ed in relazione al rifacimento già in corso del progetto generale dei trasporti. de s tinato ad entrare in vigore nel 1913.
Ad ogni modo credo bene comunicare quanto segue ai comandanti predetti per fissare s ubito alcuni punti principali che hanno formato oggetto di particolare di s cussione ed esame.
Ragioni meritevoli di molta considerazione sono state addotte sia ne l se nso di portare all'a lta valle del Natisone i l limite fra le due Armate ponendo sotto un unico comando alla dipendenza della 2• armata tutto il sistema difen s ivo del medio Tag liamento, sia
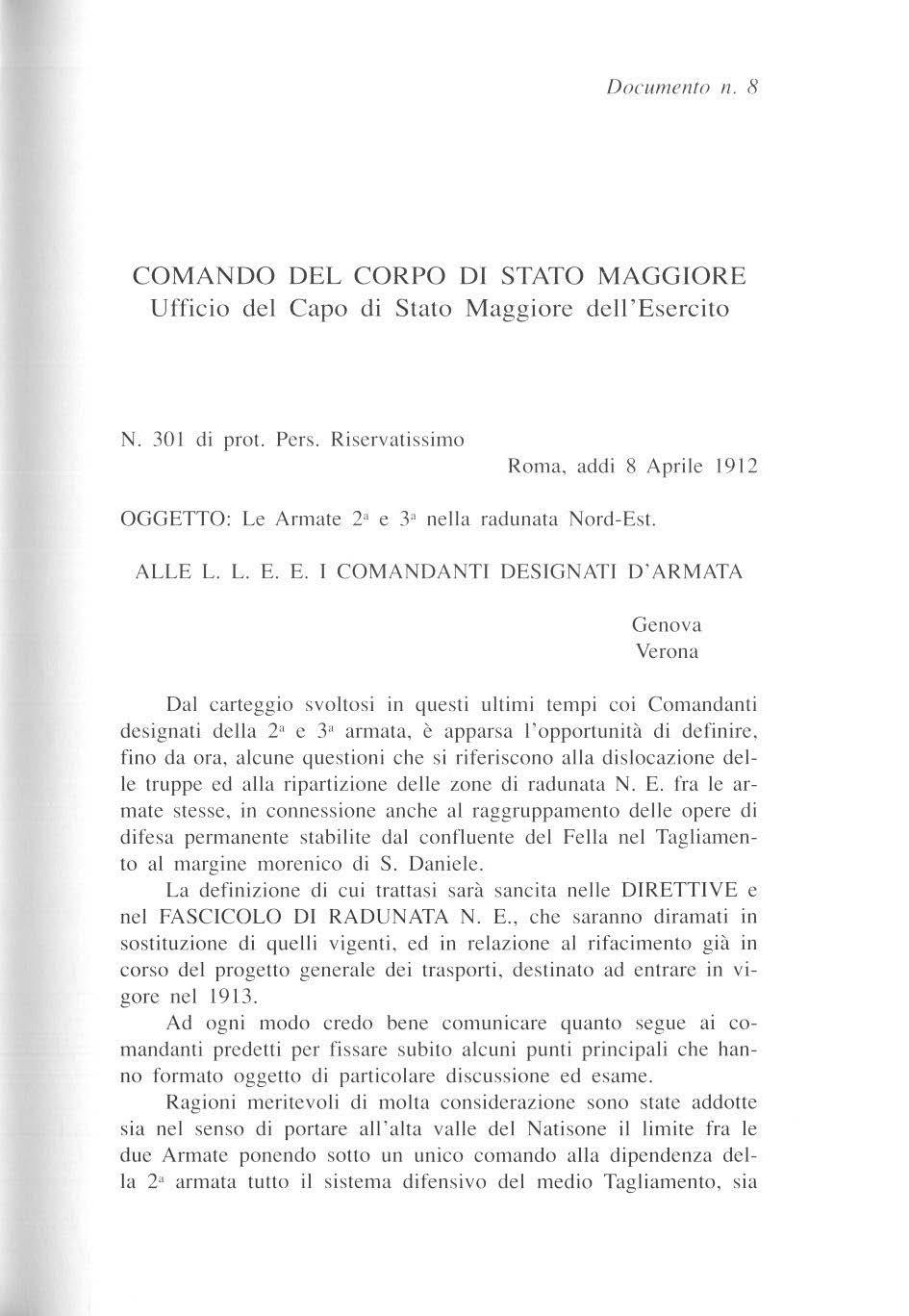
nel senso di lasciare l'attuale limite fra le armate e porre tutto questo sistema difensivo alla dipendenza della 3" aramata.
Però, tutto ben ponderato; ritengo che, mentre nulla hanno perduto del loro valore i motivi che consigliarono ad addivenire alla ripartizione fra le due armate, con limite al Montemaggiore, delta zona di frontiera dal Peralba al mare, (zona che prima del 1907 era tutta assegnata ad una so la armata), sia pure conveniente, per le ragioni che ho già avuto occasione cli esporre, la scissione ciel sistema difensivo (ora ragruppato sotto l 'u nica denominazione di Medio Tagliamento) in due gruppi distinti; Alro Tagliamento - Fella alla dipendenza della 2" armata e Medio Tagliamento alla dipendenza della 3'• armata.
La determinazione non può naturalmente basarsi sul piano d'operazione che si seguirà, perché que s t'ultimo è funzione del modo con cui si farà effettivamente la radunata, del tempo che avremo avuto a disposizione per la preparazione occulta, dei movimenti iniziali .......e, sopratutto, di ciò che farà il nemico.
Ad ogni modo, anche per un'eventuale azione della 2" armata con obiettivo Tarvis, non ritengo necessario che siano assegnate al1'armata stessa tutte e due le rotabili che convergono su Tarvis e che sia quindi esteso fino alla valle ci e l Natisone il limite meridionale di tale azione, perché, come ebbi già ad accennare in altra circostanza, la 2" armata dovrebbe essenzialmente seguire la strada Pontebbana, coll'ausilio, se sarà possibile , di quella di valle Raccolana, quest'ultima da ridurre carreggiabile al momento del bisogno sulla base cli studi e di predisposizioni prese fin dal tempo di pace.
E ritengo che non convenga neppure abbandonare senz'a ltro tutto il territorio sulla sinistra cieli 'alto Tagliamento per la preoccupazione che un attacco vigoroso del nemico possa travolgere le nostre forze dislocate nelle va lli del But e del Chiarsò.
Come ebbi giit a dire in altra circostanza analoga, anche l 'avversario ha bisogno cli tempo per mobilitarsi ed ha bisogno cli mezzi per vivere in forza a distanza dai suoi centri, né è eia escludere che possano , da un momento all'altro, intervenire elementi nuovi che facciano cambiare notevolmente la situazione a nostro vantaggio. Non vi sarebbe quindi ragione di cedere senz'altro ciò che forse si potrà conservare, pure arrischiando parziali scontri con s uccesso non buono e pur dovendo prevedere la eventualità di essere costretti a ripiegare poi sulle posizioni meglio difendibili delle prealpi carniche.
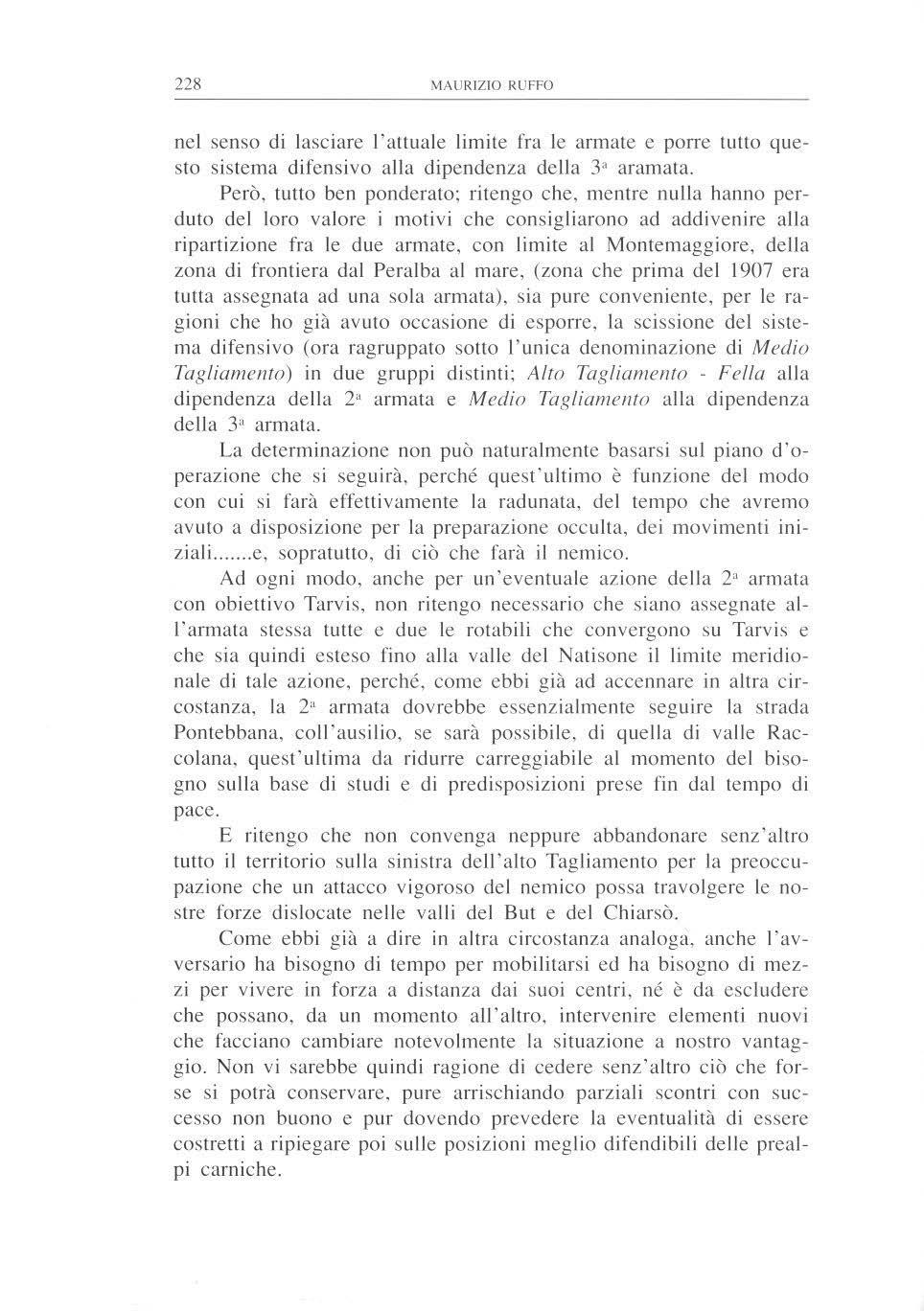
In sostanza, l'azione principale della 2" armata dovrà sempre svolgersi come è previsto dalle attuali Direttive, nelle alte valli del Fella e del Tagliamento, mentre l'azione verso sud dal lato settentrionale della tanaglia difensiva del Friuli ed il mantenimento del possesso della regione fortificata del medio Tagliamento formeranno i compili principali della 3• armata.
Rimane, in conclusione, stabilito:
a) il Montemaggiore costituisce il limite fra le armate 2" e 3" sulla linea cli frontiera. Però spetta alla 3" armata la difesa di v. di Musi, immediatamente a N. di Montemaggiore e quindi anche dal passo di Tanameje;
b) la 2" armata ha alla sua dipendenza la piazza Alto Tagliamento - Fel/a, comprendente le opere: M. S. Simeone-Festa, M. Ercole-Comielli, Chiusaforte col ridotto di Osoppo.
La 3" armata ha alla sua dipendenza la piazza del Medio Tagliamento, comprendente le opere: Col Colai, Ragogna, Col Roncone, Fagagna, S. Margherita, Tricesimo, Bernadia, Faeit-Campeon, Buja.
c) La ripartizione della zona di radunata fra le due armate 2a e 3• è fatta sulla base dei criteri anzidetti e quindi la linea di delimitazione si svolge approssimativamente dal Montemaggiore per P. Tanameje, M. Musi, sorgenti del Torre, M. Chiampon, Gemona, F. Ledra, rio a destra del Tagliamento, Pinzano, Spilimbergo, Pordenone.
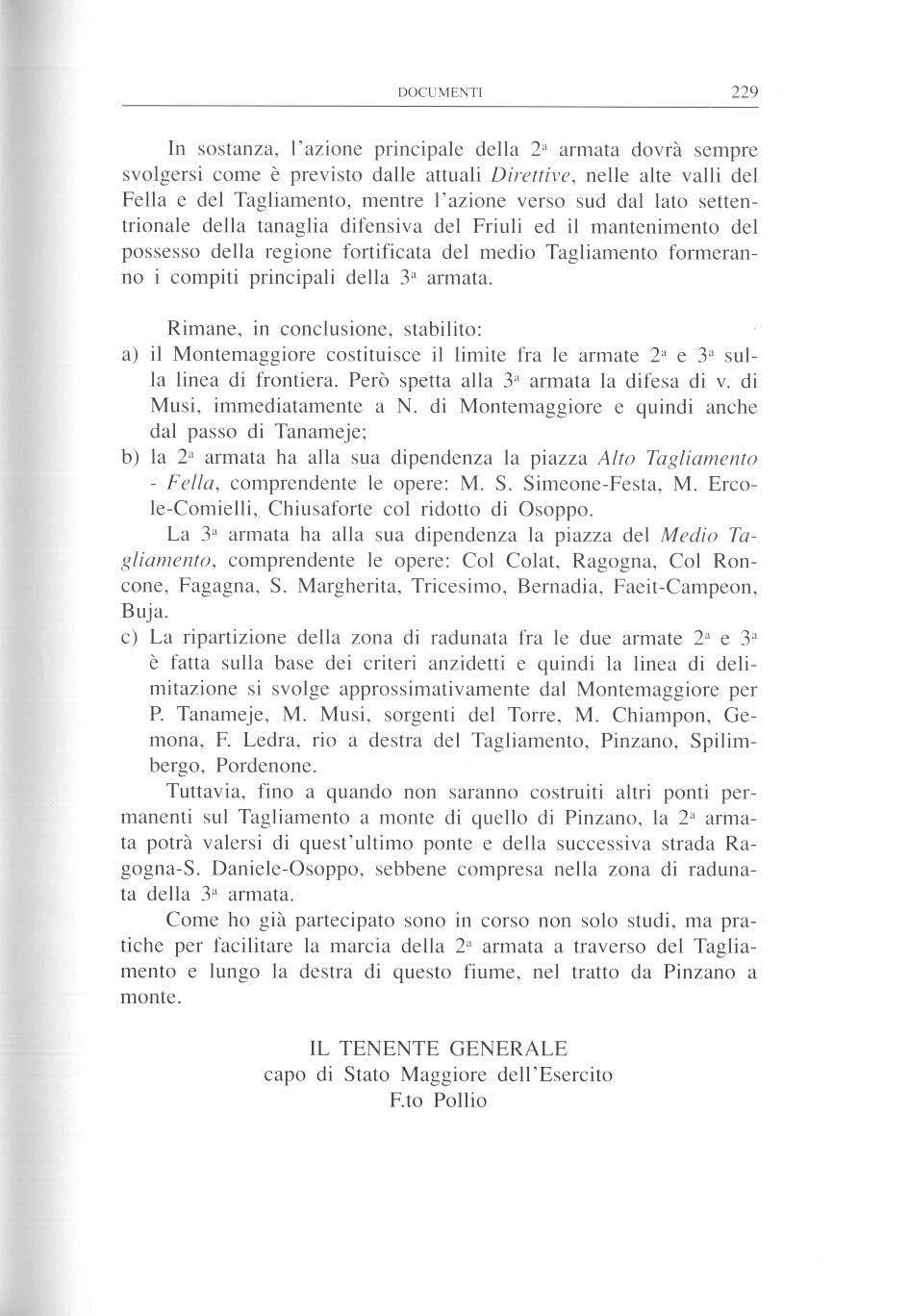
Tuttavia, fino a quando non saranno costruiti altri ponti permanenti sul Tagliamento a monte di quello di Pinzano, la 2" armata potrà valersi di quest'ultimo ponte e della successiva strada Ragogna-S. Daniele-Osoppo, sebbene compresa nella zona di radunata della 3" armata.
Come ho già partecipato sono in corso non solo studi, ma pratiche per facilitare la marcia del la 2a armata a traverso del Tagliamento e I ungo la destra di questo fiume, nel tratto da Pinzano a monte.

CONS IDERAZIO N I su ll e proposte contenute nella relazione intorno al progetto di mobilitazione e radunata ve r so la frontiera N. E.
I. Propos te di modifica:ioni al .fascicolo di radunata.
a) CONVENIENZA DI AVV IAR E AL CONFINE ED A I FORTI DI SBARRAMENTO ALCUNI REPARTI DI TRUPPA PRIMA DELL ' ORDINE Dl MOBILITAZIONE.
Non solo pare dcbbasi riconoscere tale co nven ienza per analogia con quanto si fa con la radu nata N. O. ma i l provvedimento sembra ancora molto più urge nt e e da adottarsi in più larga misura in caso di radunata No rd -Est dove si ha una frontiera apreta lungo la qual e no n si dispone che di 6 compagnie di fanter i a e di 4 s quadroni di cavaller ia, mentre a Ud ine, per esempio, si h an no d epositati circa 20 .000 fra fuci li e moschetti e dota zion i vestiario, v iveri di riserva ecc. ecc . in quantità corr ispo nd e nti.
Inoltre occorre compe nsa re quella mancanza di pred is pos izioni a ll a radunata che esis tono lun go la frontiera Nord - Ovest.
Si potrebbe studiare d' accordo coli' Ufficio trasporti se ed in qual mi s ura e quali reparti co nvenga mandare prima della m ob ilitazione in mod o da rin forza re i principali presidi d i frontiera e dei forti e di rimuovere contemporaneamente le maggiori diffi coltà di trasporto dei p rimi tre giorn i d i mob ilitazione.
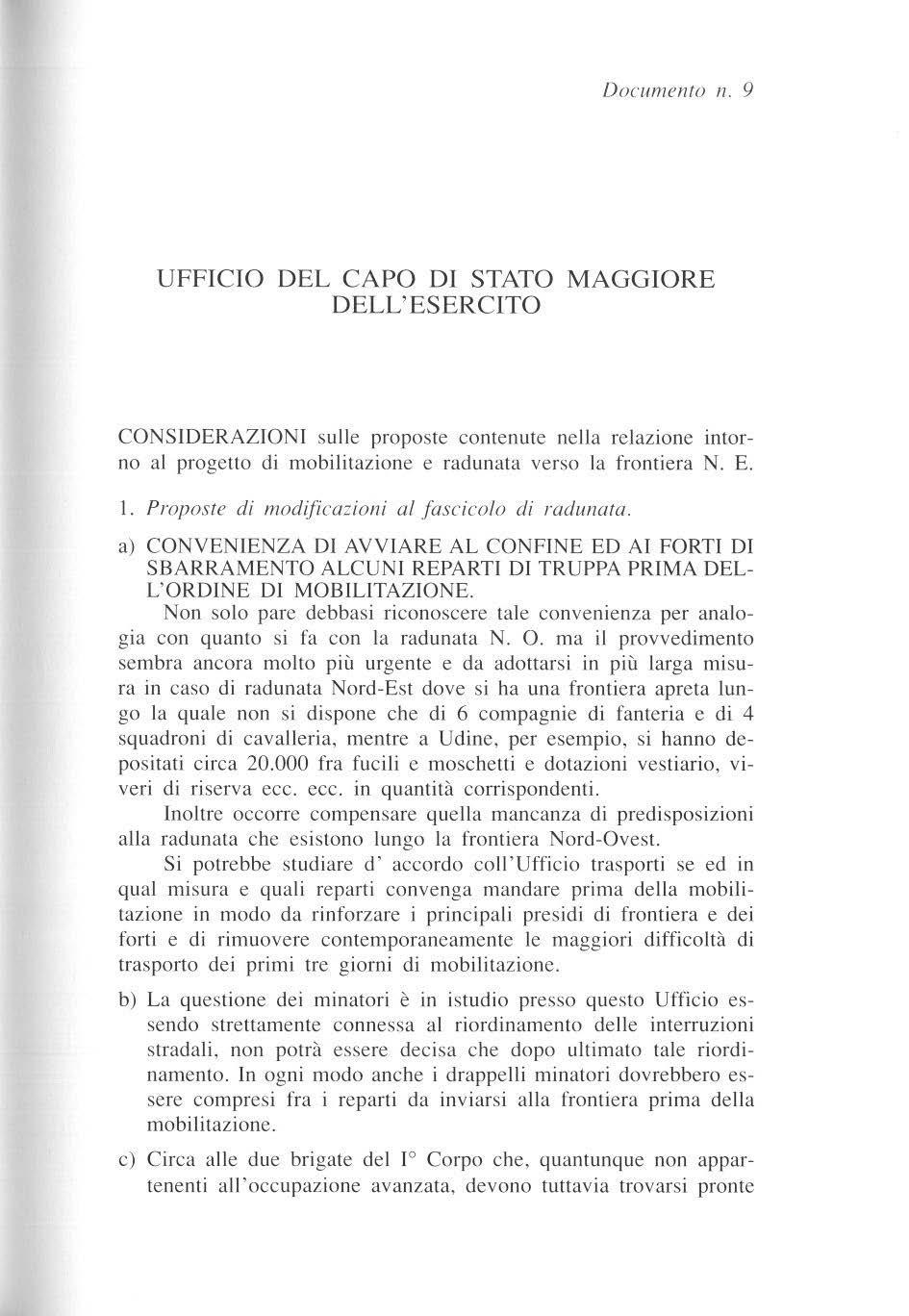
b) La qu est ion e d ei minatori è in istudio presso questo Ufficio esse nd o s tr ettame nt e co nn essa al riordinamento delle interruzioni stradali, non potrà essere decisa che dopo ultim a to tale riordinamen to. In og ni modo a nc he i drappelli min atori dovrebbero essere compresi fra i repa rti da in viars i a lla frontiera prima della mobilitazione.
c) Circa all e du e brigate del I° Corpo c he , quantunque no n apparte nenti a ll 'occ upazion e avanzata, devo no tuttavia trovarsi pronte
a muovere a rincalzo di questa, non pare opportuno accennare a ciò nel Fascicolo, essendo state, dette due brigate, tolte dallo specchio delle truppe in occupazione avanzata per ordine di S. E. il Capo di stato Maggiore, affinché non venissero fin dai primi momenti impiegate a spizzico lungo la frontiera. Con ordine interno venne invece dispo s to che l'Ufficio Traspo rti le facesse affluire alla frontiera fin dai primi giorni di mobilitaz ione. È così certo che esse non saranno impiegate che in caso di assoluta necessità.
d) Circa al reggimento di Udine , che si fraziona fin dai primi momenti per andare in occupazione avanzata provvisoria e così pure per quello di Belluno; pare che la que st ione possa notevolmente allargarsi , sorgendo il dubbio se convenga destinare i reggimenti bersaglieri all'occupazione avanzata anche quando siano di stanza in regioni molto lontane dalla frontiera o se non s ia meglio de s tinarvi i reggimenti di fanteria che sono giit sul posto.
I reggimenti bersaglieri hanno i 1 vantaggio di non essere truppe inquadrate nelle divi s ioni, le quali perciò possono completarsi coi loro quattro reggiemnti di fanteria; ma impiegando i bersaglieri , si è costretti ad inviare fino al loro arrivo truppe di fanteria in occupazione provvisoria: ciò viene a complicare notevolmente i movimenti dei riparti di fanteria s ul piede di pace e dei loro complementi che debbono essere inviati in siti diversi secondo i g iorni in cui partono, ovvero non possono raggiungere il reggimento che quando esso si sarà ritirato dal! 'occ upaz ione avanzata e sarà anelato nel s uo sito cli radunata.
Se si sos tituissero , in molti casi, i reggimenti cli fanteria a quelli bersaglieri nel! 'occupazione avanzata, si verrebbe ad alleggerire notevolmente i 1 movimento dei primi giorni: buona parte dei complementi potrebbero essere avviati ai reggimenti in occupazione avanzata per via ordinaria o colle tramvi e, vi sa re bbe maggior prontezza di completamento e si avrebbero in occupazione avanzata molti elementi locali utilissimi per la dife sa
Qualora poi venisse introdotto nella legge di reclutamento la chiamata per precetto personale anche per l 'E. P., come si è proposto, questi reggimenti fanteria potrebbero, durante la preparaz ione diplomatica della campagna, venir man mano rinforzati rendendo così solida e pronta l 'occupazione avanzata fino dai primi momenti senza incontrare difficoltà cli trasporto.
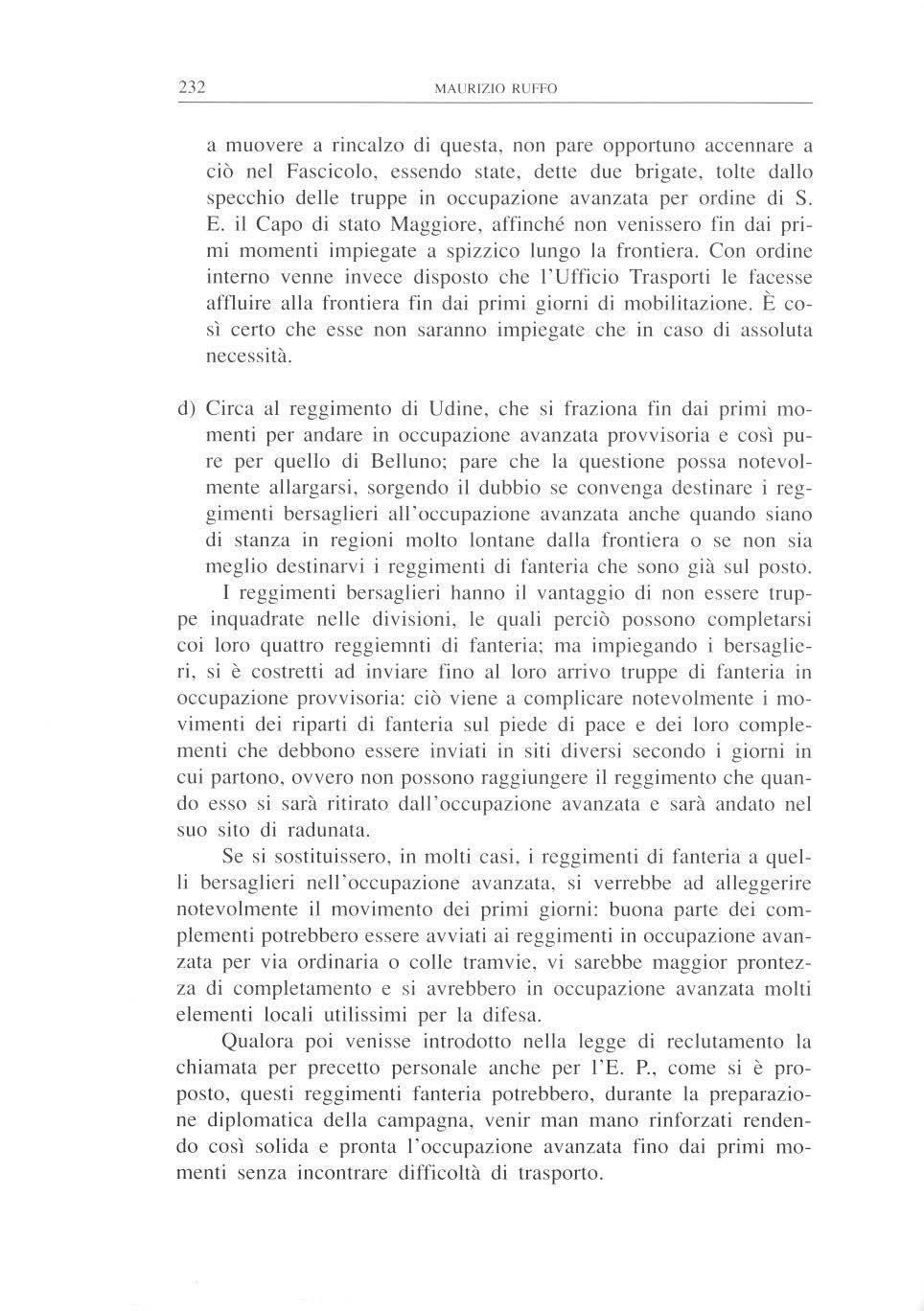
Pare pertanto che la questione della sostituzione dei reggimenti bersaglieri con reggimenti di fa nte ria dislocati in prossimità della frontiera , meriti di essere st udiata e convenga pure insistere presso il Ministero per l'accennata modificazione della legge, e ciò tanto più c he a ltri studi hanno messo in evidenza che l'ese rcito avversario con tro il quale s i comp irebbe la radunata N. E .. ha in pieno vigo re il s istema di com pletamen to occ ult o anche in tempo di pace.
e) Circa alla sez ione panettieri di Bari la proposta pare opporturnss1ma e nessuna difficoltà vi sareb be a fare la var iante al fascicolo.
f) S. E. il Capo di Stato Maggiore ha già approvato il proposto camb io di assegnazione de ll a brigata granatieri; non si può però introdurre la variante nel fascico lo che dopo avvenuto il preannunci ato cambio di g uarnigione, dovendo il fascico lo basarsi sempre su llo stato di fatto e non s u situazioni prennunciate so ltanto.
g) Per quanto riguarda i distretti di comp lemento si è già compiuto altro s tudio c he dimostra la pos s ibilità di so pprimerne gran parte ed in avvenire forse anche tutti meno talu ni del genio.
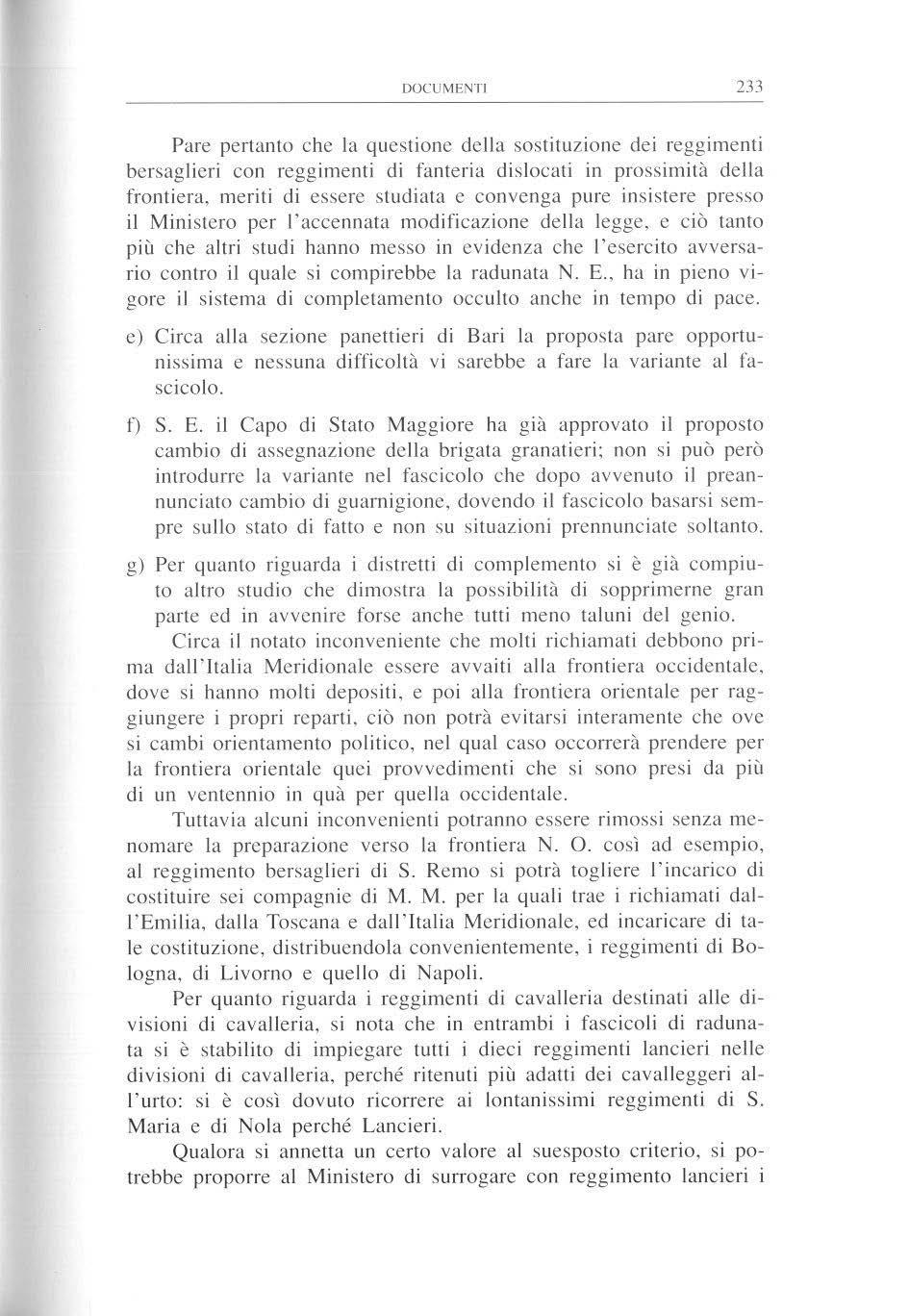
Circa i I notato inconveniente che molti richiamati debbono prima dall' It alia Meridionale essere avvaiti a lla frontiera occidentale, dove s i hanno molti deposit i, e poi alla frontiera orientale per ra ggiu nge re i propri reparti, ciò non potrà ev it arsi interamente che ove si cambi or ientamento politico, ne l qual caso occorrerà prendere per la frontiera orientale quei provvedimenti che si so no presi da più cli un ventennio in quà per quella occidentale.
Tuttavia a lcuni inconvenienti potranno essere rimossi senza menom are la preparaz ione verso la frontiera N. O. così ad esempio, al reggimento bersaglieri di S. Remo si potrà tog li ere l 'i nc a ri co cli cos tituir e se i compagnie di M. M. per la quali trae i richiamati dall ' Emilia, dalla Toscana e dall'Italia Merid ionale, ed in ca ri ca re cli tale costituzione, clis tribu enclola convenie nt e me nt e, i reggimenti di Bolo gna, di Livorno e qu el lo di Napoli.
Pe r quanto riguarda i reggimenti di cava ll e ria d es tin ati alle divisioni cli cavalle ria , s i nota che in e ntrambi i fascico li di radunata s i è s tabilito cli imp iegare tutti i dieci regg ime nti l anc ier i nelle di vi sioni di cavalleria, perché rite nuti più a d a tti dei cavalleg ge ri all ' urto: s i è così dovuto ri corre re a i lontanissimi regg imen ti cli S.
Maria e di No la perché Lancieri.
Qualora si annetta un certo va lore al suesposto c rit erio, si potrebbe proporre al Minis te ro cli s urro gare con reggimento lanci e ri i
cavalleggeri nelle guarnigioni di Verona ed Udine od in quelle di Faenza e Bologna togliendo i lancieri da Nola e S. Maria.
Vi sarebbe anche maggior facilità di reclutamento dei lanceri nel Veneto e nel l'Emilia che nell'Italia Meridionale , dove scarseggiano le alte stature.
Per quanto riguarda l'assegnazione alla prima linea di due corpi d'armata a tre divisioni (1 ° e IV 0 ) che non possono essere pronti a muovere e ad operare che al 20° o 21 ° giorno per i numerosi e pesanti serv izi, pare potrebbero essere sostituiti da altri due a due divisioni: occorrerebbe però studiare quali sarebbero i due da designarsi per ragioni di opportunità di trasporti.
Non v'è eia pensare a togliere ai due corpi 1° e 1V 0 le terze divisioni di M. M. perché ciò turberebbe tutta l ' assegnazione dei servizi che sono appunto formati dal tipo per tre divisioni presso determinati reggimenti d 'a rtiglieria.
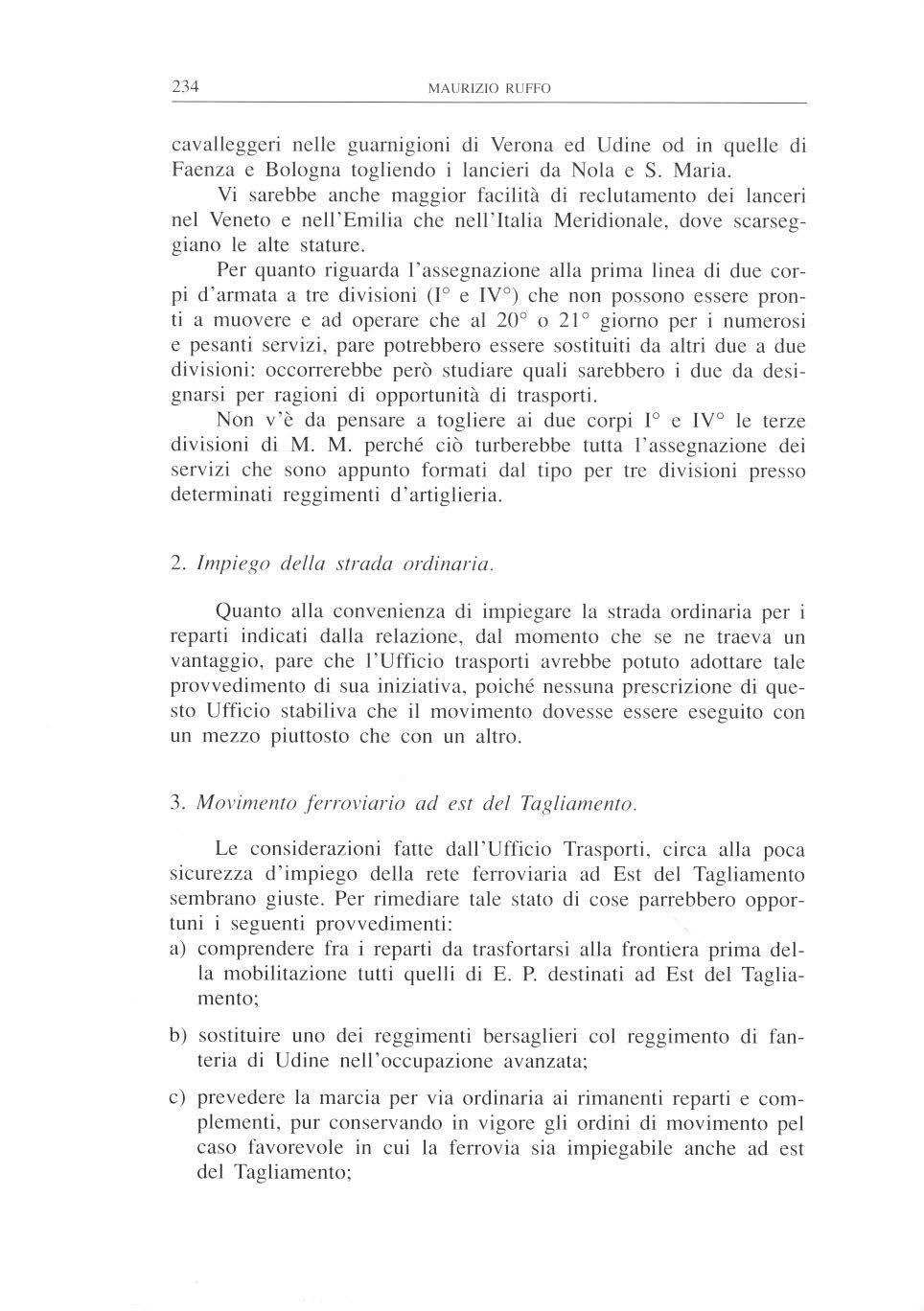
2. Impie go della strada ordinaria.
Quanto alla convenienza di impiegare la strada ordinaria per i reparti indicati dalla rela zio ne, dal momento che se ne traeva un vantaggio, pare che l'Ufficio trasporti avrebbe potuto adottare tale provvedimento di sua iniziativa, poiché nessuna presc rizione di questo Ufficio stabiliva che il movimento dovesse essere eseguito con un mezzo piuttos to che con un altro.
3. Mm ·irnenlo .ferrO\'iario ad esr del Tagliamento.
Le considerazioni fatte dall'Ufficio Trasporti, circa alla poca sicurezza d'impiego della rete ferroviaria ad Est del Tagliamento sembrano giuste. Per rimediare tale stato di cose parrebbero opportuni i seguenti provvedimenti:
a) comprendere fra i reparti da trasfortarsi alla frontiera prima della mobilitazione tutti quelli di E. P. destinati ad Est del Tagliamento;
b) sostituire uno dei reggimenti bersaglieri col reggimento di fanteria di Udine nell'occupazione avanzata;
c) prevedere la marcia per via ordinaria ai riman en ti reparti e complementi, pur conservando in vigore gli ordini cli movimento pel caso favorevole in cui la ferrovia sia impiegabile anche ad est ciel Tagliamento;
d) organizzare un serv1z10 di protezione delle ferrovie che impedisca la possibilità della loro distruzione per parte cli piccoli drappelli di cavalleria.
4. Ostacolo fi·apposto dal Site al co11cen1rame11to della 2 a armata.
Pare opportuna la proposta di organizzare un mezzo di passaggio sul Sile fra Roncade e S. Michele del Quarto.
Senza togliere i mezzi di passaggio assegnati alle grandi unità od altri materiali disponibili, che nella radunata Nord-Est hanno la massima importanza, si potrebbe costruire facilmente un ponte provvisorio di circostanza con legname che si trova in grandissima abbondanza in Treviso.
Non volendo ricorrere a materiai i di circostanza, si avrebbero disponibili a Piacenza due sezion i da ponte.
Dalla monografia ciel Silc pare che i punti più adatti a tale passaggio sono a Cenclon ed a S. Elena dove esistono già passi a barca e vi so no già strade e le rampe di accesso al fiume che è largo so lo 35 a 40 m. in condizioni normali.
5. Mm·imento ferroviario nei primi 3 giorn i di mobilita : ione.
In merito alle varie proposte fatte per ovviare agi i inconvenienti previsti dal movimento dei primi tre giorni di mobilitazione pare:
accettabile, anche perché necessario compenso alla mancanza di preparazione verso la frontiera orientale e per togliere altri inconvenienti già notati, il provvedimento di portare alla frontiera truppe de st inate all'occupazione avanzata prima clell 'ordi ne di mobilitazione; me no opportuni gli altri provvedimenti che porterebbero ritardo nella radunata;
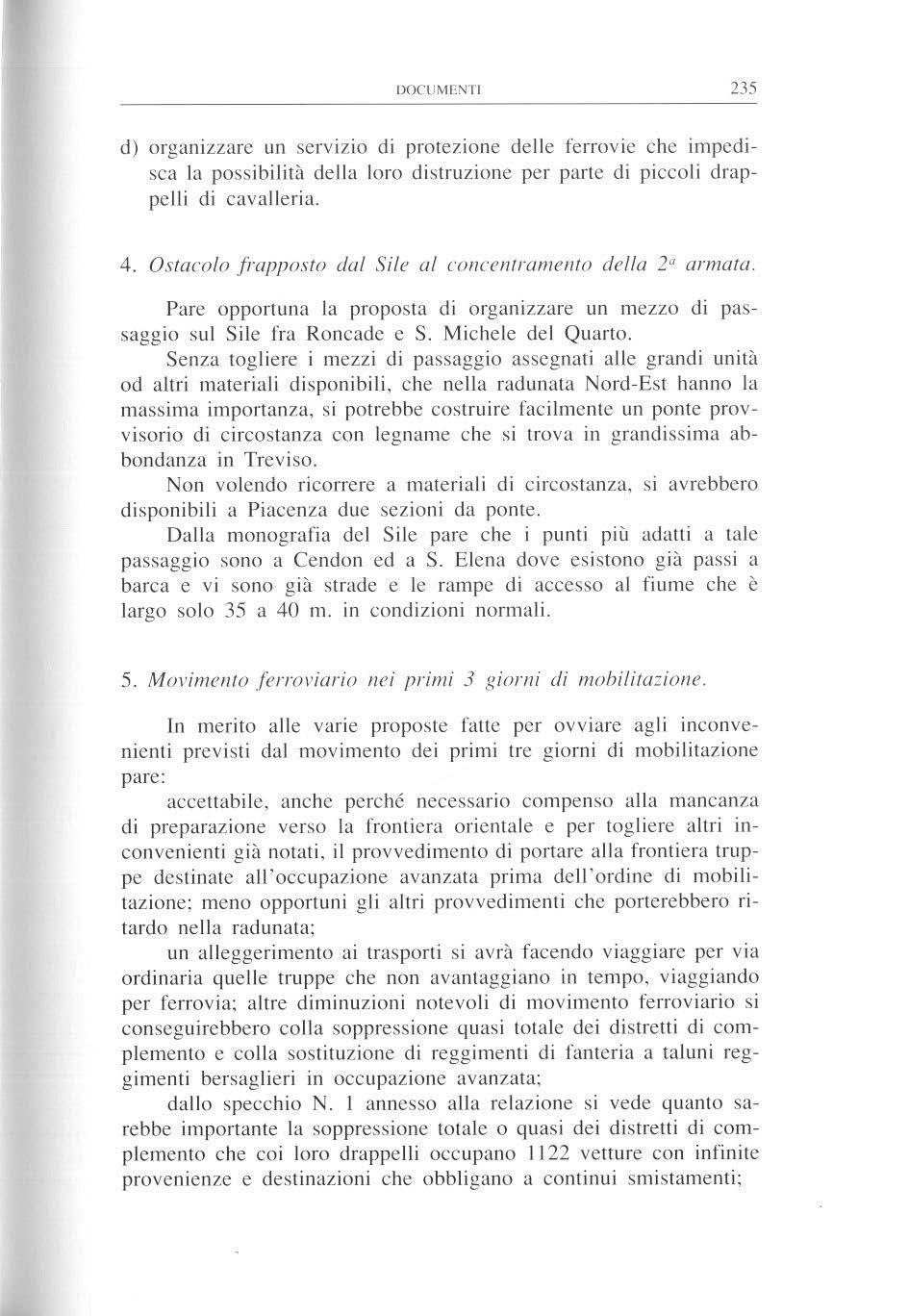
un al leggeri mento ai tra s porti si avrà facendo viaggiare per via ordinaria quelle truppe che non avantaggiano in tempo, viaggiando per ferrovia; altre diminuzioni notevoli di movimento ferroviario si conseguirebbero colla so ppressione quasi totale dei distretti di complemento e colla sostituzione di reggimenti di fanteria a taluni reggimenti bersaglieri in occupazione avanzata;
dal lo specchio N. 1 annesso alla relazione si vede quanto sarebbe importante la soppressione totale o quasi dei distretti di complemento che coi loro drappelli occupano 1122 vetture con infinite provenienze e destinazioni che obbligano a continui smistamenti;
p,uTebbe pertanto che con le ora accennate riduzioni di trasporti il movimento potrebbe acquistare sufficiente elasticità.
6. lm·ori ferroFiari.
I grafici di intensità del movimento lungo le I inee mettono in evidenza, in modo parlante, la necessità dei raddoppi cli PadovaMonselice e Mestre -Treviso.
7. Deficienza di me:.::.i della Società Veneta.
Pare utilissimo il provvedimento di inviare , a rinforzo del lo scarso personale della Società Veneta, una compagnia ferrovieri di esercizio a Castelfranco cd a fare eseguire ricognizioni preventive agli ufficiali e so ttufficiali della compagnia destinata.
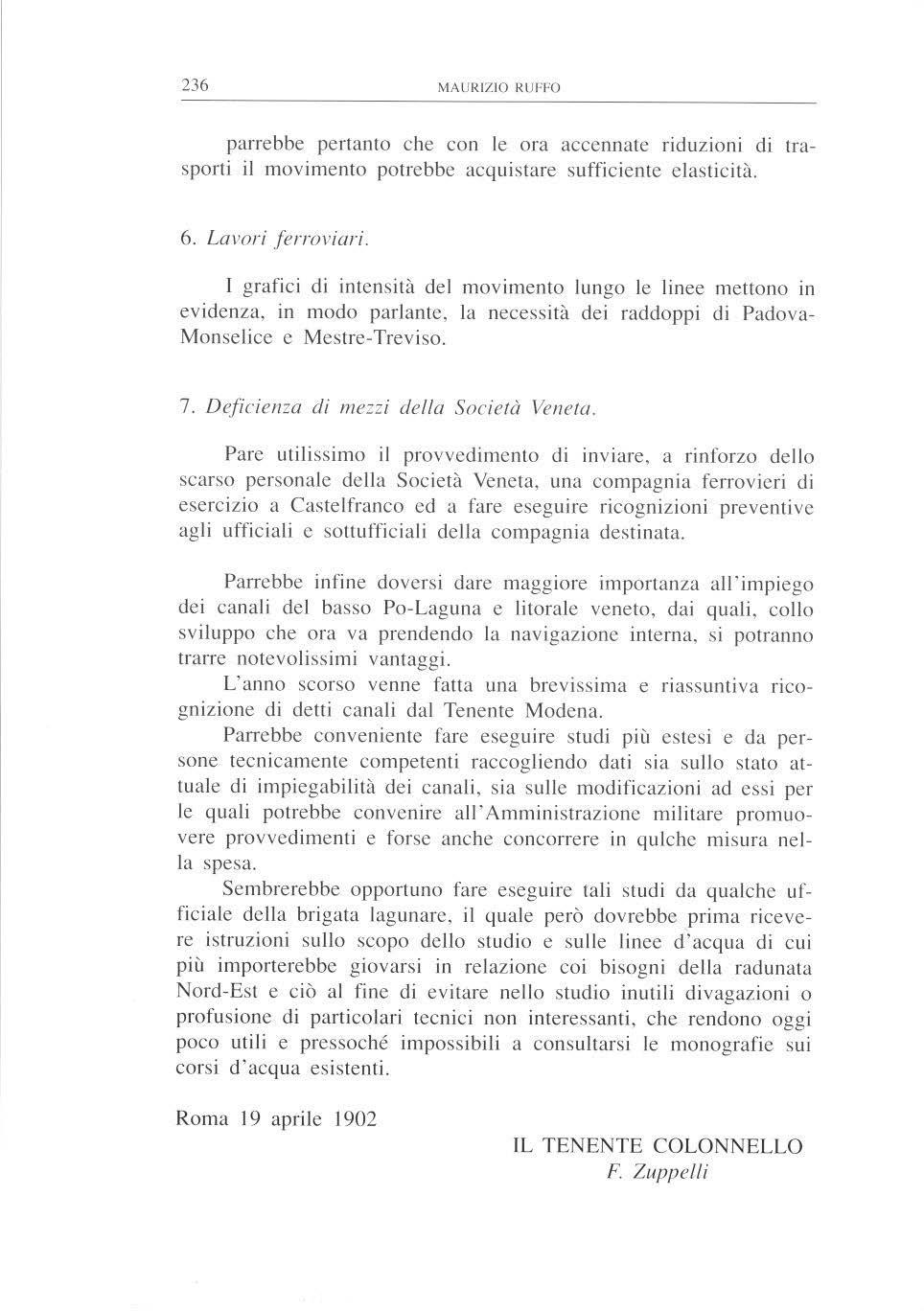
Parrebbe infine doversi dare maggiore importanza ali' impiego dei canali del ba sso Po -Lag una e litorale veneto, dai quali, collo sviluppo che ora va prendendo la naviga zione int e rna , s i potranno trarre notevolissimi vantaggi.
L'anno scorso venne fatta una brevissima e riassuntiva ricognizione di detti canali dal Tenente Modena.
Parrebbe conveniente fare eseguire s tudi più estesi e da perso ne tecnicament e competenti raccogliendo dati sia sullo s tato attuale di impiegabilità dei canali, sia sulle modificazioni ad essi per le quali potrebbe convenire ali' Amministrazione militare promuovere provvedimenti e forse anche concorrere in qulchc misura nella spesa.
Sembrerebbe opportuno fare eseguire tali studi da qualche ufficiale della brigata lagunare, il quale però dovrebb e prima ricev ere istruzioni sullo scopo dello studio e sulle linee d'acqua di cui più importerebbe giovarsi in relazione coi bisogni della radunata Nord-Est e ciò al fine di evitare nello s tudio inutili divagazioni o profusione di particolari tecnici non interessanti , che rendono oggi poco utili e pressoché impossibili a consultarsi le monografie sui corsi d'acqua esistenti.
Roma 19 aprile 1902
I L TENENTE COLONNELLO F. Zuppe/li
11 sis tema di mobilitazione e radunata, da noi seg uito , è basato sul cr iter io di sji·11ttare inten samen te la poten :ia fità delle ferro1•ie ft110 da primo giomo di mohilita zione, eseguendo contempora11eame11te e promiscuamente le due opera:ioni della mohilitazio11e e della radunata.
Ques to s is tema co ndu ce bensì al ri su lt a to , cer to importante, di radunare l'esercito nel pii~ breve tempo possibile, ma rende la radunata es t remamente rigida e di complicata esecuz ione.
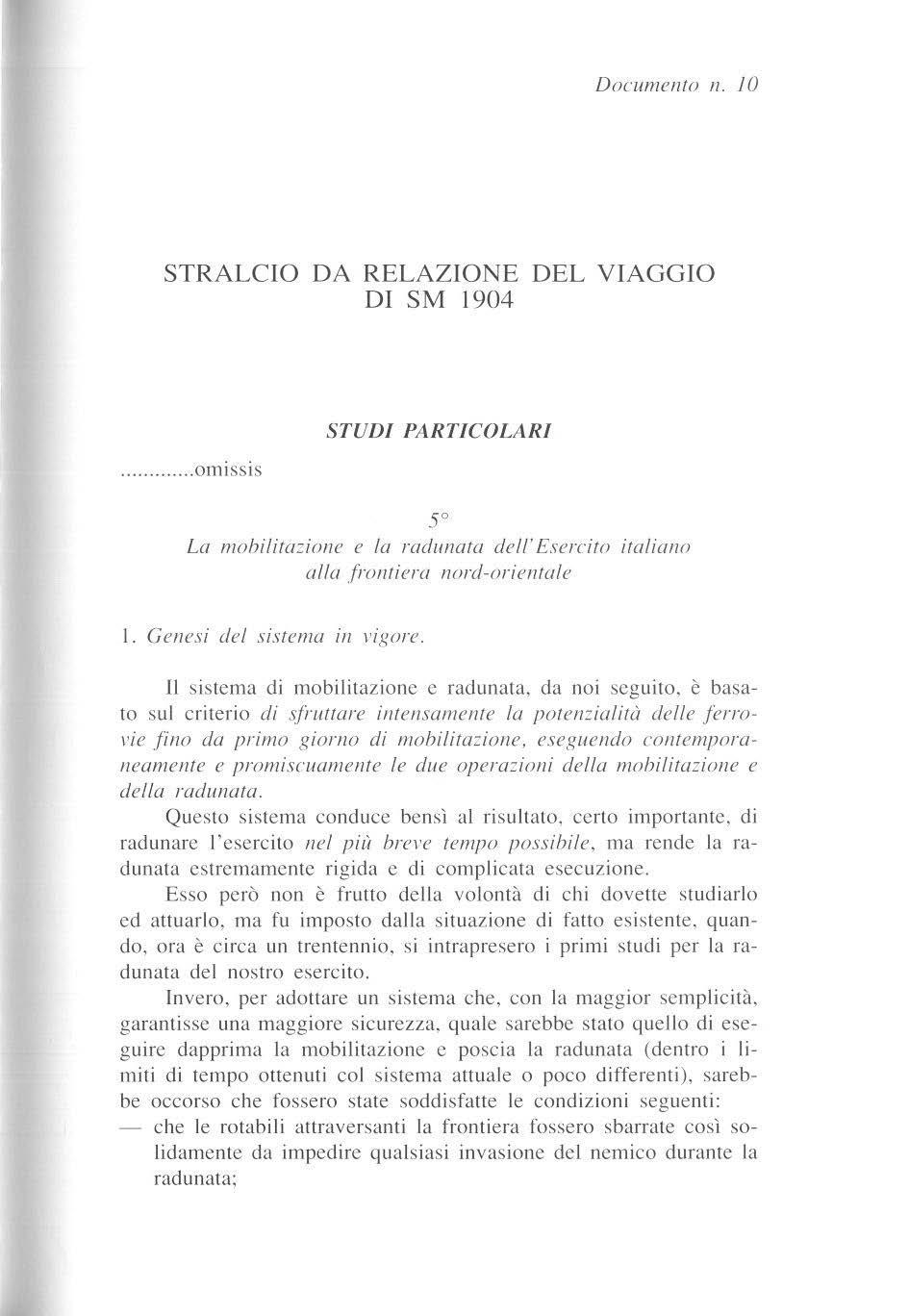
Esso però non è frutto d ella vo lon tà di ch i dovette s tudiarlo ed attuar lo , m a fu impos to dall a sit uaz ione di fatto esis te nt e, quando , ora è c irca un trentennio, s i intrapresero i primi studi per la radunata del no stro ese rcito.
In vero, per adottare un siste ma che, con l a maggior semplicità, garan ti sse una maggiore s icurezza, quale sarebbe stato quello di esegu ire dapprima la mobilitazione e poscia la radunata (dentro i Iimiti di tempo ottenuti col s iste ma att ual e o poco differenti), sa rebbe occorso che fossero s tate sod di sfa tt e le condizioni segue nti: che le rotabi Ii attraversanti la frontier a fossero sbarrat e così solidamen te da impedire qualsiasi invasione ci el nemico du rante la radunata;
che i corpi trovassero nelle loro vicinanze tutti gli elementi necessari al loro completamento, per poter mobilitarsi nel più breve tempo che fosse possibile; che la rete ferroviaria avesse produllività s ufficiente per assicurare il celere ed ordinato trasporto dei corpi d'armata mobilitati e dei servizi dell'esercito.
Ora queste condizioni non si verificavano allora, e, ad onta dei miglioramenti introdotti , non si verificano neppure oggidì, se non in modo impari al bisogno, specia lmente per la frontiera nord-est dove. oltre il danno della mancanza di fortificazioni, si risente quello della scarsità dei presidi locali.
Perciò , volendo soddisfare a l criterio di avere radunato I'esercito nel più breve tempo possibile, non si può a meno di s fruttare subito ed intensamente tutta la potenzialità delle ferrovie e di frammischiare la mobilitazione alla radunata.
L'essere, infatti , la frontiera nord-est male difesa, anzi 111 alcuni tratti ancora aperta, e scarsamente presidiata. obbliga ad avviare alla frontiera medesima, al più presto, sul piede di pace , e frazionati in molteplici destinazioni, i numero si riparti di truppa destinati alla occupazione avanzata; ed inoltre le divisioni di cavalleria, che urge avere s ul T agliamento, per opporsi alle incurs ioni della preponderante cavalleria avversaria.
Per la grande estensione cli detta frontiera, tal i riparti ascendono alla ingente quantità cli 130 mila uomini circa (compresi i presidi provvisori dei forti). i quali rimangono sottraili per la massima parte da l grosso dell'esercito: e di essi, 92 mila circa, debbono va lersi delle ferrovie, che rimangono così impegnate in un movimento intenso fino dal primo giorno di mobilitazione.
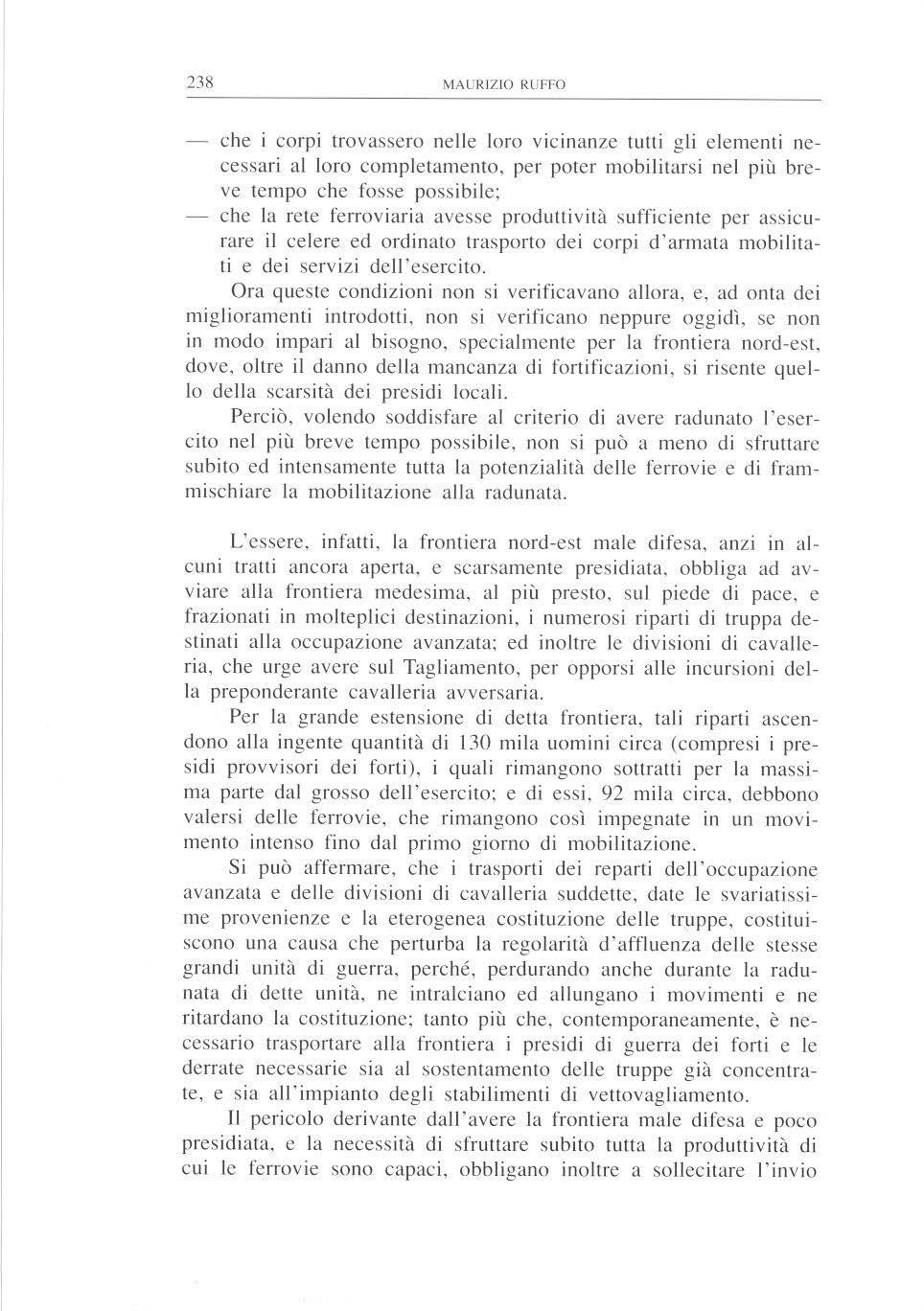
Si può affermare , che i trasporti dei reparti cieli ' occupazione avanzata e delle divisioni di cavalleria suddette, date le svaria t issime provenienze e la eterogenea costituzione delle truppe, costituiscono una causa che perturba la regolar it à d 'affluenza delle stesse grandi unità di guerra, perché, perdurando anche durant e la radunata di dette unità, ne intralciano ed allungano i movimenti e ne ritardano la costituzione; tanto più che, contemporaneamente, è necessario trasportare alla frontiera i presid i di guerra dei forti e le derrate nece ssar ie sia al sostent.amenro delle truppe già concentrate, e sia all'impianto degli s tabilimenti di vettovag li amento.
TJ pericolo derivante dall'avere la frontiera male difesa e poco presidiata, e la neces s ità di sfruttare subito tutta la produttività di cui le ferrovie sono capaci, obbligano inoltre a sollecitare l'invio
sul la zona di radunata di alcune delle grandi unità. prima che siano mobilitate; e ciò accresce il numero delle truppe partenti sul piede cli pace. e rende inevitabile uno strascico prolungato di complementi di uomini, cavalli e carri.
Questi inconvenienti potrebbero essere minori, se le ferrovie avessero una produttività adeguata ai tra spo rti da eseguire e se i corpi e le grandi unità trova ssero nelle vicinanze gli elementi necessari per una pronta loro mobilitazione. Ma ciò non è.
Infatti:
I 0 ) la potenzialit~t delle ferrovie è impari ai bisogni delle mobilitazione, come risulta dallo s tudio 2 °, specialmen te in prossimità della zona di radunata, dove il numero delle linee indipendenti, anziché aumentare, va diminuendo a mano a mano che i trasporti convergono e si addensano verso la zona stessa; 2° ) i sistemi di mobilitazione, essendo conseguenza dei sistemi seguito nel reclutamento, nell'ordinamento e nella dislocazione dell'e se rcito , non possono a meno di subire la influenza delle cause che hanno impedito , ed impediscono tuttora. di avere l 'ese rcito reclutato , ordinato e di s locato seco ndo le esigenze della mobilita z ione, anziché, talvolta, secondo esigenze affatto estranee.
Per tali cause, che dipendono dalle leggi in vigore o dalle condizioni oltre che geografiche anche economiche e politiche d e llo stato, dalle quali i governi fino ad ora succedutesi hanno creduto di non poter sottrarsi, le principali sono:
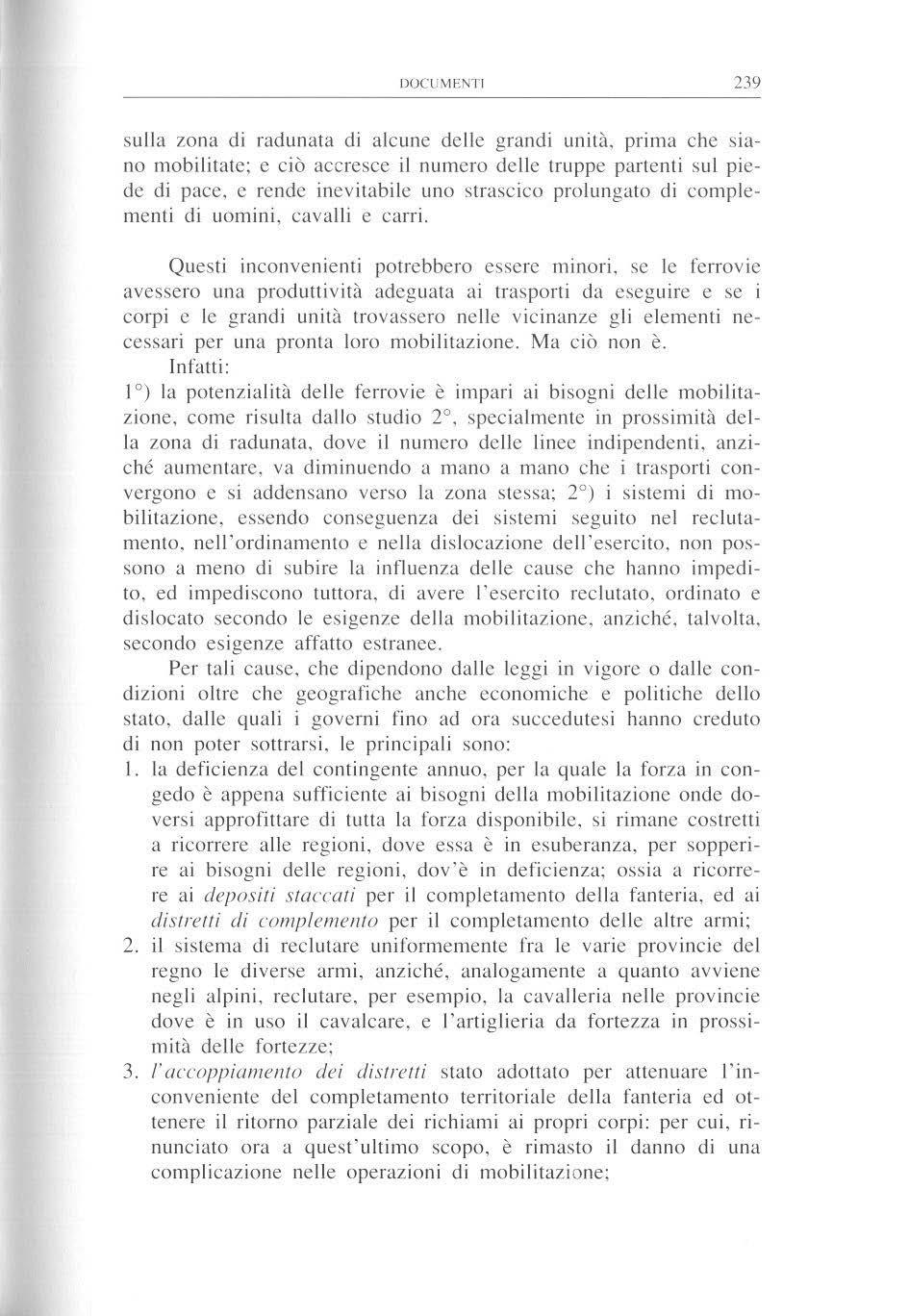
I . la deficienza del contingente annuo , per la quale la forza in congedo è appena sufficiente ai bisogni della mobilitazione onde doversi approfittare di tutta la forza di sponibile. s i rimane costretti a ricorrere alle regioni, dove essa è in esuberanza, per sopperire ai bisogni delle regioni, dov'è in deficienza; ossia a ricorrere ai depositi s10ccati per il comp letamento de lla fanteria, ed ai distretti di comp/eme11to per il completamento delle altre armi;
2. il s istema di reclutare uniformemente fra le varie provincie del regno le diverse a r mi, anziché, analogamente a quanto avviene negli alpini, reclutare, per esempio, la cavalleria ne lle provincie dove è in uso i l cava lcare, e l'artiglieria da fortezza in pross imità delle fortezze;
3. /"accoppiamrnto dei distrelfi stato adottato per attenuare l'inconveniente del completamento territoria le della fan teria ed ottenere il ritorno parziale dei rich iami ai propri corpi: per c u i. rinunciato ora a quest'ultimo scopo, è r imasto il danno di una compl icazione nelle operazioni di mobil itazi o ne:
4. una distribuzione delle guarnigioni nello stato, che risponde alle esigenze di accarezzamento, di sicurezza pubblica o cli interessi locali, ma non sempre ai bisogni della mobilitazione, e, conseguentemente, una distribuzione dei centri di mobi lit azione, specialmente del le armi a cavallo, non sempre in relazione a tali bisogni:
5. l'avere il treno legato all'artiglieria, ciò che rende gravosissime le operazioni cli mobilitazione dei reggimenti di artiglieria, e concorre a rendere più lenta e complicata la costituzione dei servizi:
6. la molteplicità elci centri cli mobilitazione cui si deve ricorrere , per causa della distribuzione esistente dei materiali e della forza, nella costituzione dei quartieri generali e dei servizi vari dell'esercito, nonché della costituzione delle unità di milizia mobile:
7. infine, la dislocazione dei corpi dell'esercito, dei depositi di materiali e degli enti cli mobilitazione, rispondente ora qua s i esclusivamente alla ipotesi di radunata verso la frontiera nord-ove st.
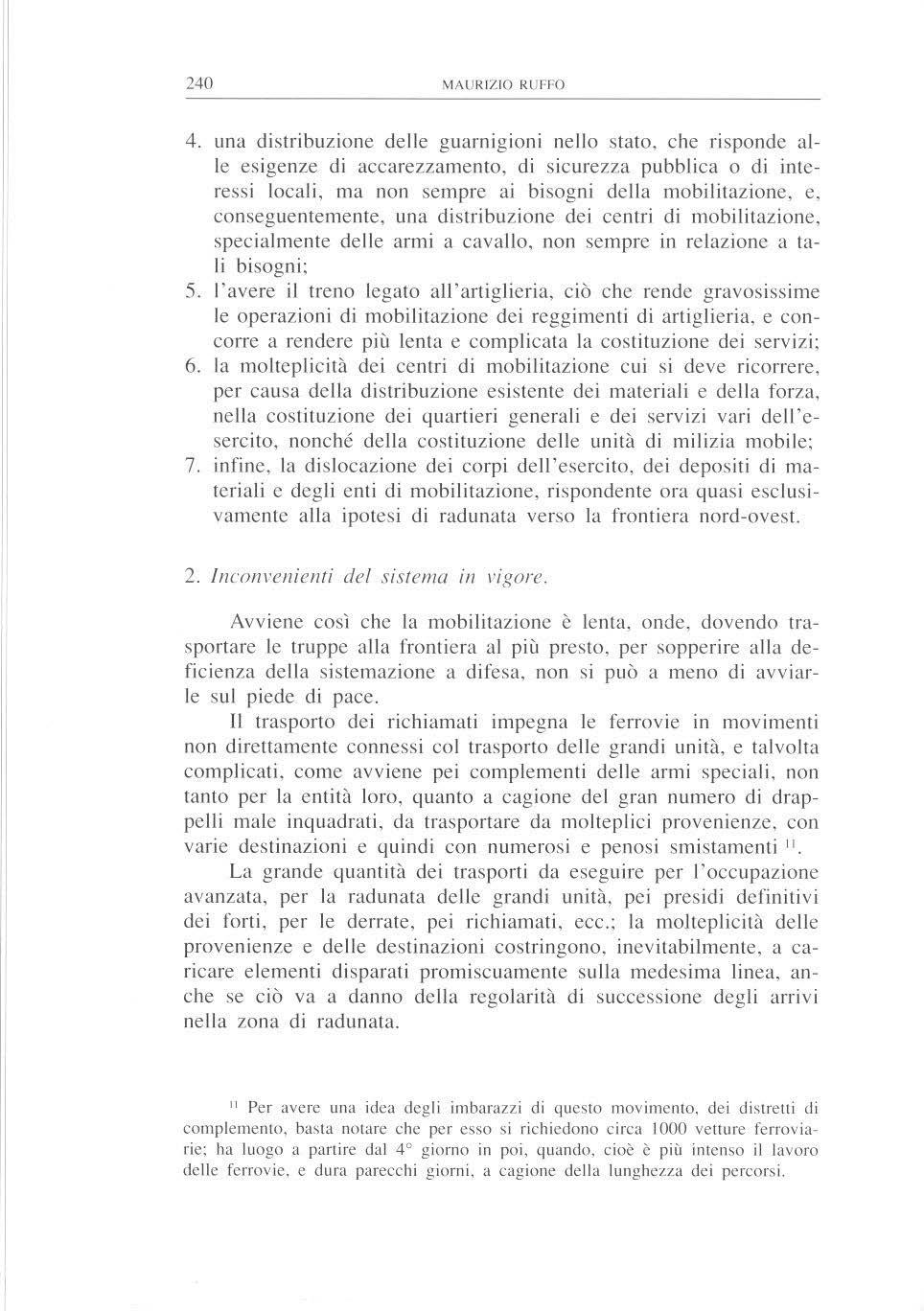
2. Inco11ve11ie11ti del sistema in rigore.
Avviene così che la mobilitazione è lenta. onde, dovendo trasportare le truppe alla frontiera al più presto, per sopperire alla deficienza della sistemazione a difesa. non si può a meno di avviarle s ul piede di pace.
li trasporto dei richiamati impegna le ferrovie in movimenti non direttamente connessi col trasporto delle grandi unità, e talvolta complicati. come avviene pei complementi delle armi speciali, non tanto per la entità loro, quanto a cagione del gran numero di drappelli male inquadrati, da trasportare da molteplici provenien ze, con varie destinazioni e quindi con numerosi e penosi smistamenti 11 •
La grande quantità dei trasporti da eseguire per l'occupazione avanzata, per la radunata delle grandi unità, pci presidi definitivi dei forti, per le derrate, pei richiamati, ecc.; la molteplicità delle provenienze e del le destinazioni costringono, inevitabilmente. a caricare elementi disparati promiscuamente sulla medesima linea, anche se ciò va a danno della regolarità cli successione degli arrivi nella zona cli radunata.
11 Per avere una idea degli imbarazzi di questo movimento, dei distreui di complemento. basta notare che per esso si r ichiedono circa 1000 vetture ferroviarie: ha luogo a partire dal 4° giorno in po i quando, cioè è più intenso il la voro de l le ferrovie, e dura parecchi g iorn i a cagione della l unghezza dei percorsi.
Lo specch io seg ue nt e dà un a idea cli tutti i trasporti 12 occo rrenti pe r radunare l 'esercito alla frontiera nord - est:
X l corpo d'ar m ata (2 d iv. ) s ul piede di g ue rr a
X lii corpo d'arma ta (3 div.) s ul p iede di g uerra
XIV corpo d'a nn ata (3 div. ) s ul piede di guerra l
d ·a rm a ta
,_ occupaz ione avan z ata
-
s porti d i cop le menti e di elemen ti va r i occorren ti per mobi litare preventivamente serviL i di corpi d'a rma ta , d'armata e per il G.Q.G . 308 derra te 32 1 ) 1547

richiamati da i dis tretti di comple m e nt o
p residi d i g uerra dei fort i e de ll e piazze forti
var i (29 • divis ione - Roma. grupp i campa li di M.T.. rea li carabinier i)
TOTALE 2 943
,_
12 Co l nome di trasporto s i vuo le intendere ogni eleme nto ( truppe o se rvizi) c he ha una provenienza ed una d es tinazio ne deter m inata s ia c he pe r e sso s i ric hi eda l'imp iego di un int ero treno. s ia anche di poc hi v e ico li. Un treno può quindi co mpren d e re u no o più tra s pon i.
Ques ta denomina z ione di trasponi, a nzic hé di tre ni , dipende appun to dalle ragio ni indicate ne ll ' a linea precedente.
1., Col no m e di tras por to si vuole in te ndere o g ni e lemento ( truppe o serv iz i) c he ha una provenie nza ed un a dest in az ione determinata. s ia c he per esso si rich ieda l'im pi eg o di u n in te ro treno , sia anc he di pochi ve icol i. Un t reno può quindi comp re ndere uno o più tra sporti.
Esso dimostra che di tutti i tra sporti occorrenti pe r mobilitare e radunare l 'intero esercito, so lo la metà circa sono direttamente connessi col movime nto cli radunata del le gra ndi unità di g uerra e dei relativi se rvi z i , e ciò dà la mi s ura d e ll ' influenza esercitata, s ullo s volgim e nto de lla radunata , da ll e cause accennate più so pra . ln co nclu s ione i l s is tema in vigore, pur presentando, co me s i è de tto , il vantaggio di radunar e l 'ese rcito alla front iera ne l più breve t em po possibi le, presenta diversi gravi inconvenienti, che potrebbero sconvo lgere le operazioni della preparazione imm e diata alla guerra. È nec essa rio , p e rtanto , indicare i provve dim en ti occorrenti per eliminare o quanto meno per diminuire, tali inconvenienti .
3. Pro1•vedimenti per migliorare il sis1ema in 1·igore.
Il primo e d il più urgen te è quello di raffèH:are la .fron1iera, in modo da anes tare l'in vaso re s ull e principali linee di mar c ia per una durata non inferiore a 20-25 g iorni, seco ndo le prop os te indicate nello studio 4 ° .
Infat ti, la necessità di do ver avviare alla frontiera notevo li forze, al più presto, per compensare le difese ins uffici e nti e manch evoli , dà origine o rende più se ntiti g li inconvenienti sopra accennati. Pertanto , rafforzare la fronti era, equivale a to g li e r e il male maggiore , ed a re nd e re di s ponibili buona parte d e ll e truppe mobili, de s tinat e ora all'occupazione avanzata.
Gli altri inconvenie nti sono:
A) aumentare le trupp e di presidio nel Veneto;
B
) semplificare e d accelerare le operazioni di mobilita zione;
C) accresc e r e la potenzialità de ll e ferrovie.
A) L'aumento delle truppe di presidio nel Veneto è un a mi s ura così st rettame nte collega ta alle ragioni politiche, che non s i posso no formulare propos te concrete al riguardo , se n za prima determinare fino a qual limite dev es i te ne r conto di tali ragioni.
Non considerando c he le so le esigenze militar i, s i può dire , che otterrebbe un buon ri s ultato, se s i attestasse al la fronti era orientale un secondo co rp o cl ' arma ta , con tutte le s ue trupp e a portata , aumentando conte mporan ea men te la cava lleria e le trupp e da montagna e tra sfe re ndo nel Ve ne to qualche riparto di minatori 14
14 Attualmente un so lo corp o d'amiata. i l V. cd una part e del lii si auestano al l a fronti era orienta le, la quale ha pur sv i l uppo circa doppio di quel l a occ iden tale, dove, invece, si attestano tre co rpi d ' armata. D ei sette reg gi ment i alpini
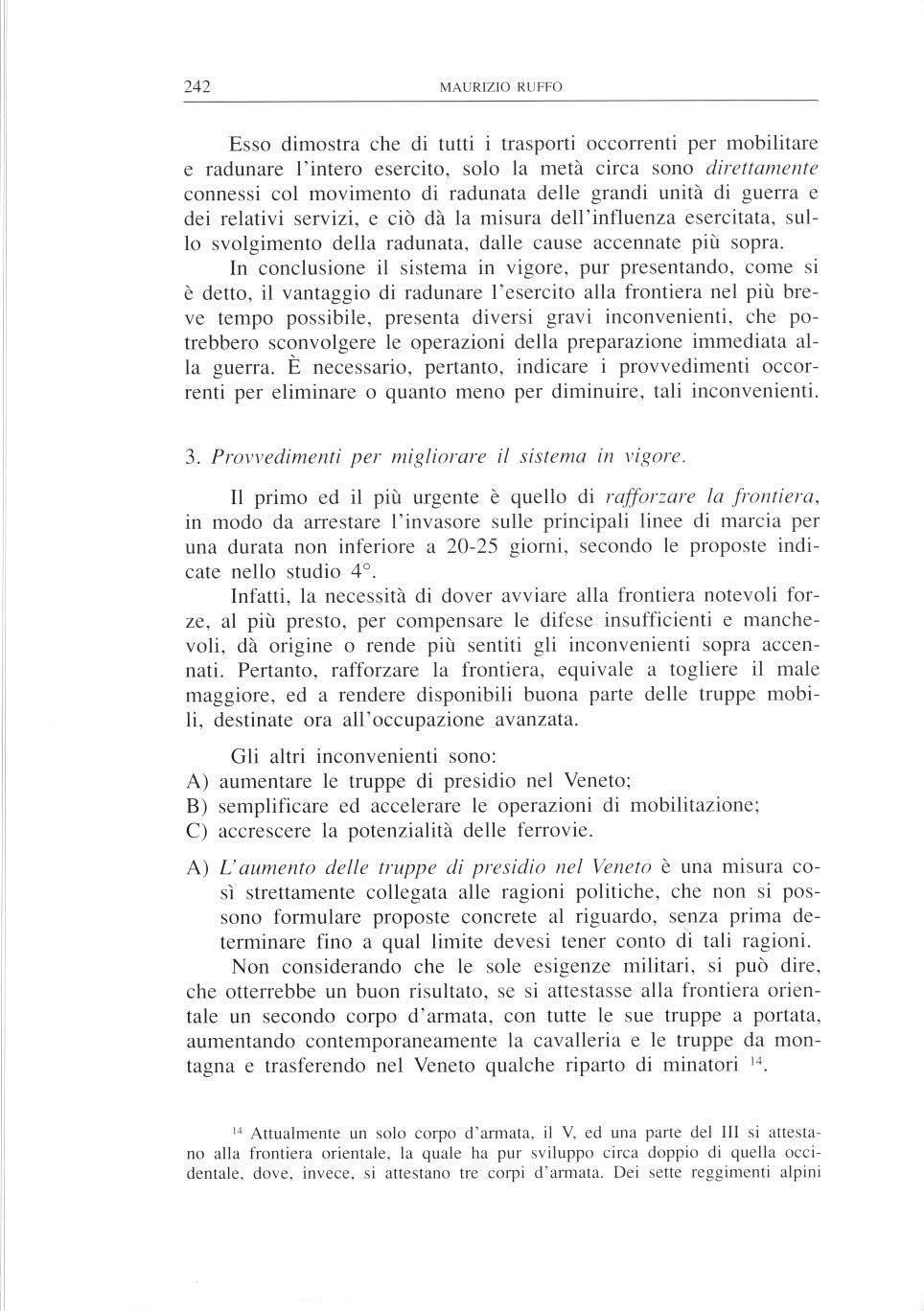
Ma ciò condurrebbe ad un rimaneggiamento dei presidi e de lle circoscrizioni attua li. No n pote ndo affrontare f in d'ora q uesta misura, co n verrebbe a lmeno adottare le proposte seg uenti:
a) rinforzare le g ua rn igioni di fanteria di Udine e P a lma nova;
b) dis loca re a P a lmanova un reggimento di cava ll eria. trasferendo a lt rove il deposito allevamento cava ll i, o ra troppo esposto;
c) sol lecitare l'invio sul Tagliamento de ll e truppe necessarie ad ass icurare la difesa di tale linea, adottando i provvedimenti indicati a pag. 100.
B ) I pro1·1·edimenti che pennetterehhero di semplificare e di accelerare le operazioni di mohilita:ione sono molto importanti, in quanto che darebbero modo ai corpi di completarsi colle risorse disponibili sul pos to, e quindi permetterebbero di accostarsi al conce tt o di eseguire la mobilira:ione dei corpi stessi, prima di dar principio ai trasporti della loro radunata; il quale concetto sarebbe veramente il più efficace per giungere ad una radunata più rego lare e p i ù e lastica.
Ta l i provvedimenti sono i seguenti i:;:
I 0 ) aumento del contingente annuo , onde accrescere la forza in congedo disponibile;
2°) creazione dei circoli cli reclutamento od almeno delle zone cli completamento reggimentali, per dar modo a lla fanteria cli com -
Lre sol i sono stabil i t i l ungo l a frontiera orienta le. e di essi un so lo ba1tagl ione, i l battaglione Gemona, sul lun go tratto dall'alto Tagl iamento al mare. Ness uno dei reggiment i de l Veneto è rinforzaio. nessun ri parto minatori trovasi sul po sto. ment re sono numerose le in ter ruz ioni cui converrebbe p rovvedere, a cagio ne specialmente della insuffic iente difesa. Infi ne, me nt re la g rande qua ntitft di cava lleria di cui dispo ne l'Austria. rich i ederebbe che buon numero dei nost ri reggimen ti d i cava l leria fossero a portata della pian ura fr iul ana, non ne esiswno in Veneto che 4uatlro, cioè que l l i di Udine. Padova, Vicenza e Verona.
•~ I provved im enti c he seguono formarono oggetto di proposte concrete presentate al M inistero co n le lettere: 9 giugno 1902 N. 182; 22 novembre 1902 N. 425; 2 9 novembre 1903 N. 387; 2 1 gennaio 1904 N. 2: 15 ge nnaio 1904 N . 9.
Nel loro complesso essi costitu iscono u n prog ramma vasto, la cui auuazione comporterebbe provved i menti di natura finanzia r ia e legis lativa. e richiederebbe del tempo.
Si potrebbe però ugua lmen te dare i n iz io al prog ramma medes i mo, coll'adottare quella pa r te dei suddetti provved i rnemi che è co nsemita dalle legg i attual i non ri chieda spese eccess i ve e, nello stes so tempo, non ponga os tacolo ad u no svo lg irnenw avvenire dell'in tero programma
Questi ultimi provved i men ti forma no oggetto di proposte spec ial i prese ntate a parte al Ministero della guerra.

pletarsi con elementi tratti sul posto a somiglianza di quanto praticano le altre armi;
3 ° ) abo l izione o a lmeno riduzione dei distretti di complemento;
4 ° ) mutamento dei criteri di assegnazione delle reclute, in relazione ai bisogni della guerra, anziché seguendo il criterio dell'uniformità di riparto de l contingente fra tulle le provincie del regno, e ciò per trarre miglior partito dalle risorse locali;
5° ) rimaneggiamento dei centri e.li mobilitazione delle armi a cavallo, in maniera che ogni centro di mobilitazione trovi sul posto quasi tutti gli uomini ed i cavalli necessari per la mobilitazione; e quindi se possibile , modificazione della dislocazione di alcuni reggimenti de lle truppe a cavallo 16 ;
6° ) riorganizzazione dei servizi e del treno militare;
7 ° ) adozione della chiamala per cartolina, coll'estendere ed applicare s u larga scala all 'E.P. la chiamata personale. che la legge oggi ammette per la M.M. e la M.T.
Questa ultima proposta avrebbe speciale importanza perché permetterebbe di rinforzare gradualmente, in caso di bisogno i riparti di frontiera e dare un primo adeguato presidio ai forti di s barramento ed alle piazze marittime, senza bisogno di ricorrere ad ingenti trasporti di truppa dalle altre parti del regno.
Oggidì invece se, in previsione di una rottura delle ostilità, si volessero rinforzare, per misura di prudenza, la guarnigioni di frontiera, si dovrebbe ricorrere a trasporti di truppe ed a chiamata di classi, sollevando così sos petti , e ciò senza guadagnare tempo , poiché, per la necessità di rispettare i turni prestabiliti del materiale ferroviario mobile , si sarebbe costretti a far correre poi a vuoto gran parte dei treni. già destinati pel trasporto de lle truppe avviate preventivamente alla frontiera.
C) I provvedimenti occorrenti per aumentare la produlfil'ità delle .ferrol'ie sono indicate nello studio 2 ° , pag. 94. È uti le però avvertire che tali provvedimanti non soddisferebbero che in parte al loro scopo. ove contemporaneamente non si
16 Se, ad esempio, un regg imento di cavalleria cd uno d·arliglieria da campagna si dislocassero nel 1crritorio del Xl corpo, che ne è 1ota l rnente sprovvisto, si se mplifich erebbero di molto le operazioni di mobilitazione. senza tener con to degl i altri vantaggi nella ist ruzione delle varie armi di detto corpo. Ba sta infalti pensare. che nel territorio dell'XI corpo si ha un numero di caval li idonei per l'esercito. ugua le ad una volta e mezzo c irca a quelli d el X corpo. dove invece sono dislocati 5 r eggi menti di cavalleria e 3 di art ig l ier ia da campag na.
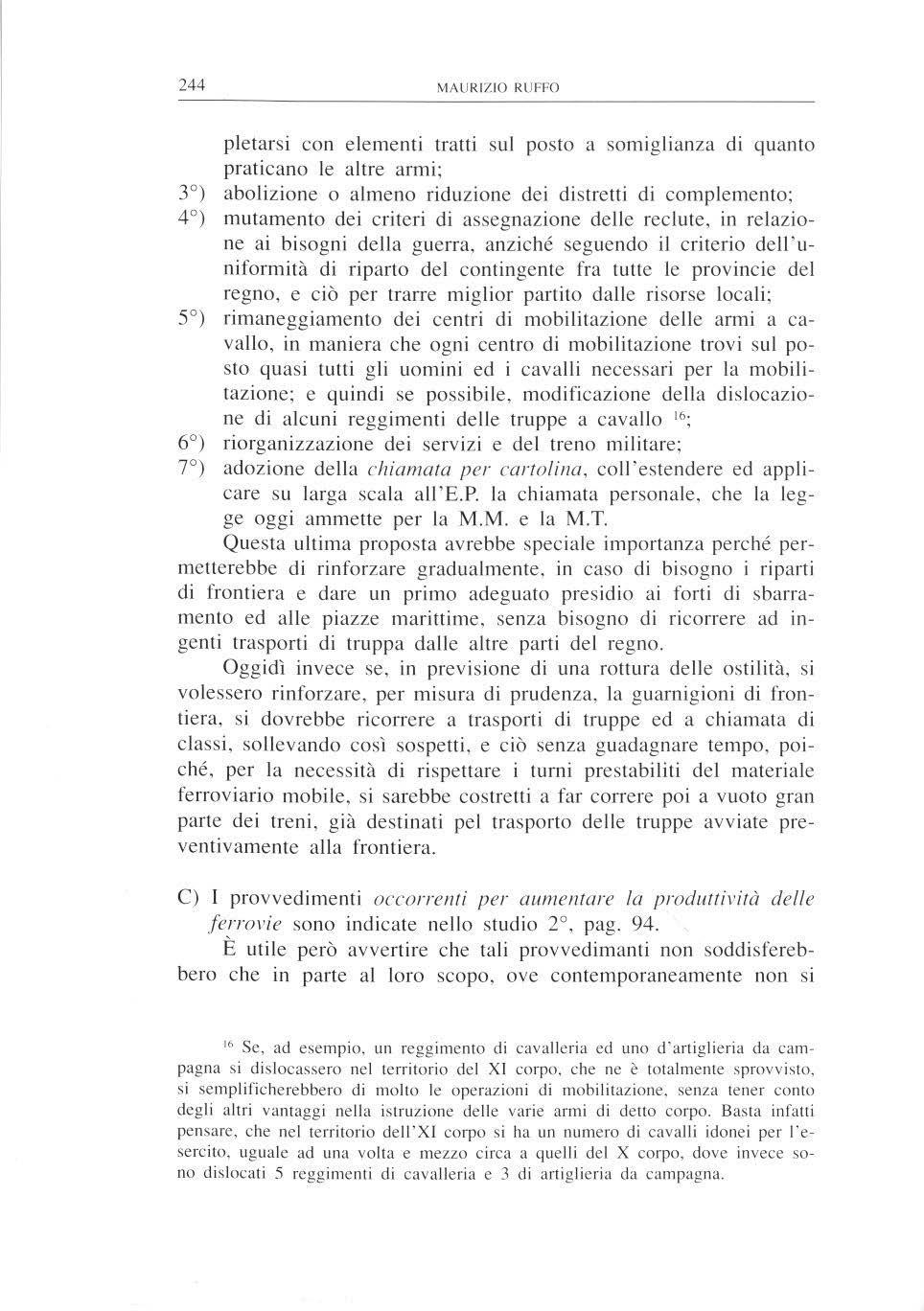
adottassero quelli per migliorare l'asse tto difensivo della frontiera e per semplificare ed accelerare la mobilitazione.
Invero, a poco varrebbe di avere una ricca rete di ferrovie a disposizione, quando la zona di radunata continuasse ad essere facilmente esposta alle offese del nemico, e le ferrovie ad altro non servissero che a trasportare alla frontiera scheletri di battaglioni, batterie in formazione ridotta e servizi incompleti, come ora si è cost retti a fare. TI lungo strascico dei trasporti di complemento delle truppe e dei servizi, che occorrono alle grandi unità perché sia no in grado cli combattere, anullerebbe in parte il vantaggio della maggior celerità, che le ferrovie permetterebbero di conseguire.
In conclusione, la prima necessità cui conviene provvedere, per migliorare le condizioni della nostra radunata alla frontiera nordest, è quella di rafforzare la frontiera.
Senza di ciò, permarrebbe la necessità di avviare alla frontiera le truppe s ul piede di pace, e sa rebbe tolta ogni efficacia ai provvedimenti intesi a semplificare e ad accelerare le operazioni cli mobilitazione cli queste truppe e ad accrescere la potenziai ità delle ferrovie .
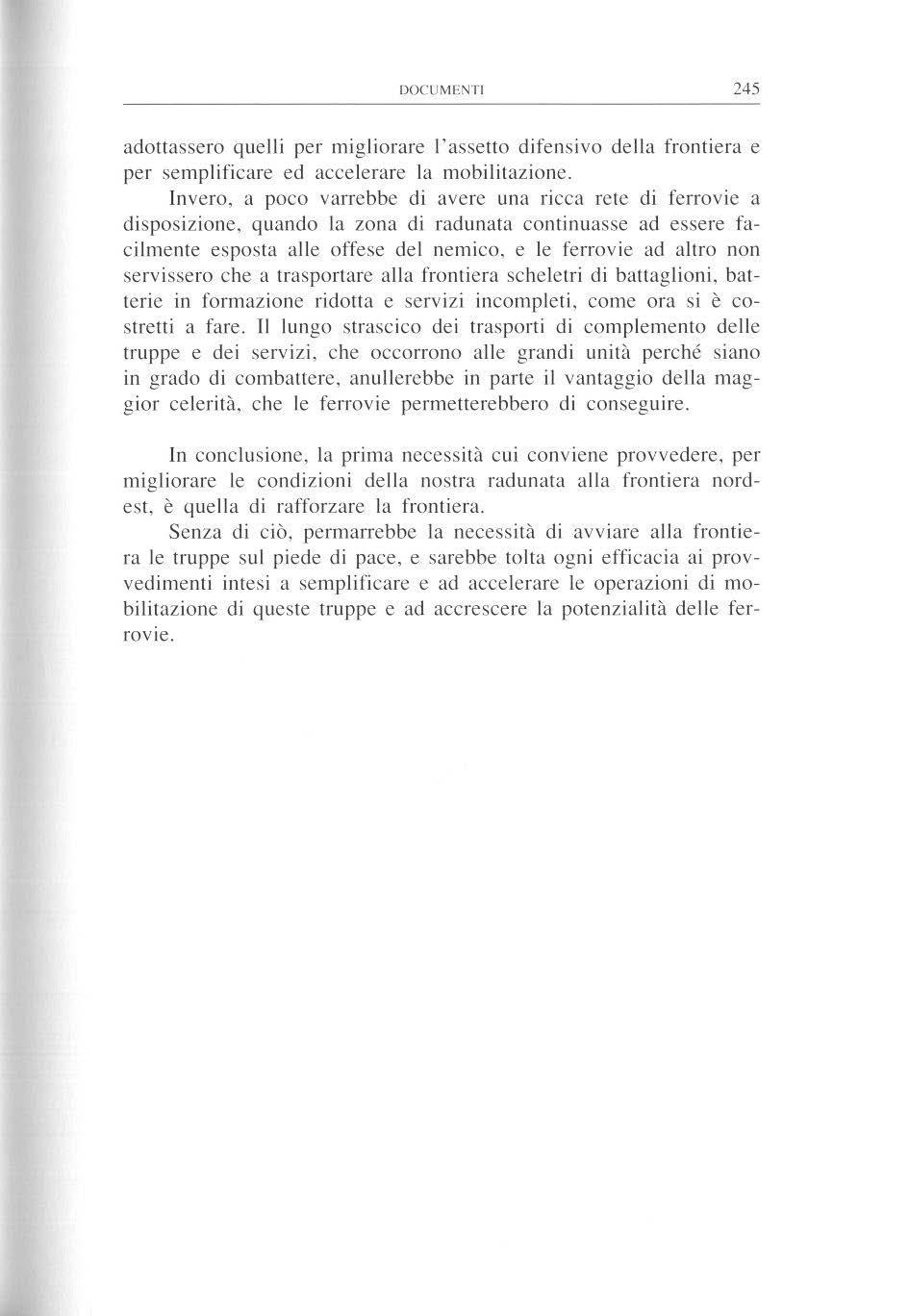

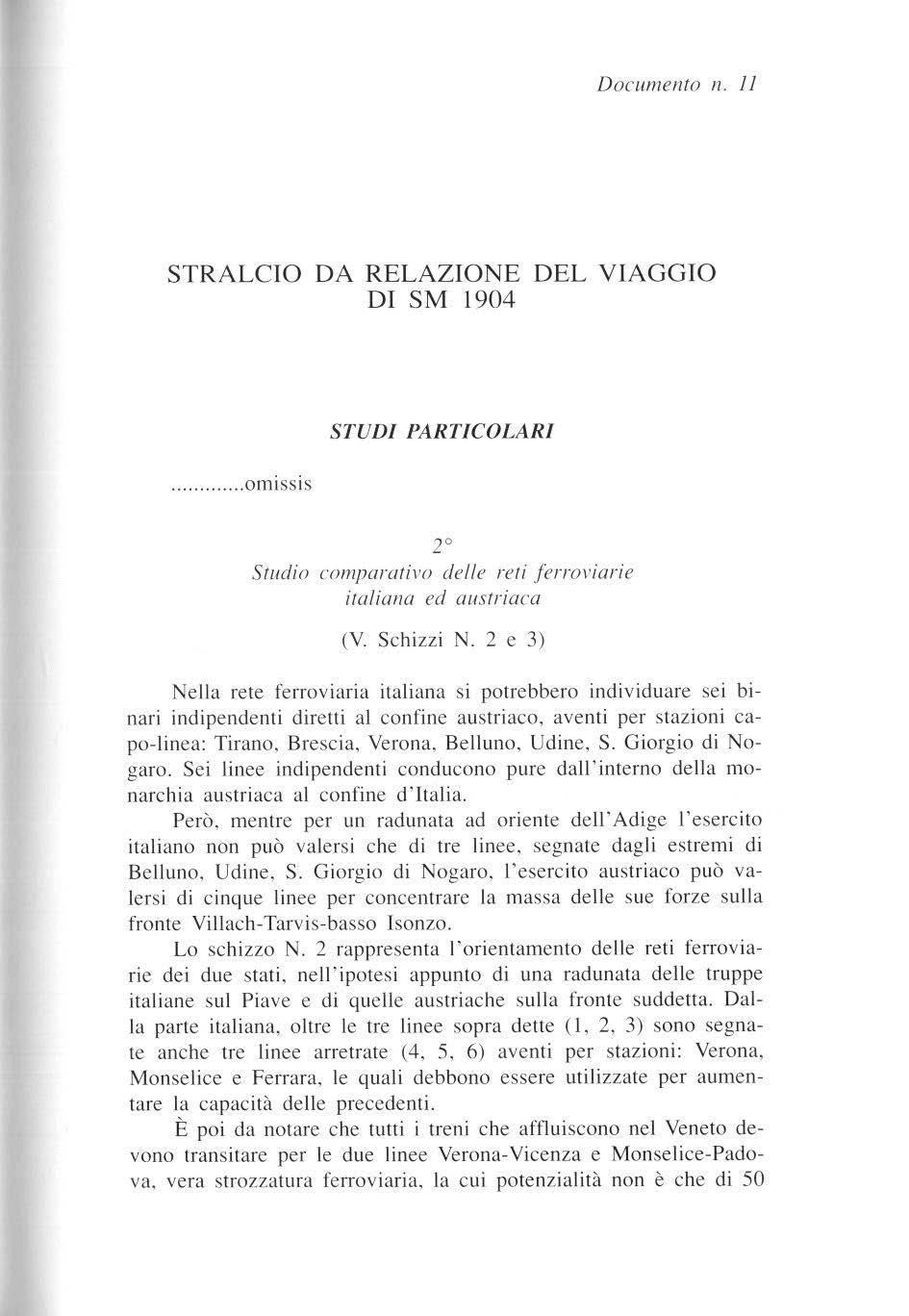
Studio comparativo delle reti ferro 1•iarie Ì/a/iana ed austriaca
(V. Schizzi N. 2 e 3)
Ne ll a rete ferroviaria italia na s i potrebbero individuare sei binari indip e nd e nti diretti a l confine a us tri aco, ave nti pe r s ta z ioni capo - lin ea : Tirano , Brescia, Verona, Belluno. Udin e, S. Giorgio di Nogaro. S ei linee indipendenti c onducono pure dall ' inte rno della monarchia austriaca al confine d ' Italia .
Pe rò , m e ntr e per un rad un ata ad oriente cieli' Adi ge l'esercito itali a no non può va lers i che di tre lin ee, segna te dagli estremi di B ellu no, Udine , S. Giorgio di Nogaro, l'esercito austriaco può valers i di cinque lin ee pe r co ncen trare la ma ssa dell e s ue forze s ulla fronte Villach-Tarvis-basso I sonzo.
Lo sc hi zzo N . 2 rapprese nta l' orientamento de lle reti ferroviari e dei due s tati , nell ' ipotes i appunto cli una radunata d e lle truppe italiane sul Piave e di qu elle austriache s ulla front e s uddetta. Dalla parte italiana , oltre le tre linee so pra d e tt e ( 1, 2, 3) so no seg nate anche tre linee arretrate (4, 5, 6) aven t i per s taz ioni: Verona, Mon se lice e Ferrara, le qua li debbono essere utiliz zate pe r aument a re la capacità dell e precedenti.
È poi d a notare c h e tutti i treni che affluiscono nel Veneto devono tran s it are per le due linee Vero na-Vic enza e Mon se lice- Padova, ve ra s tro zzat ura fe rro via ri a, la cui potenz ia lità non è che di 50
treni g ionali eri (escl u s i i postali). Olt re il fro nt e Vicenza-Padova, e fino a l Piav e, tale potenzialità s i ridu ce a 42 tr e ni al giorno; e dal Pi ave a l Tag liamento a so li 28 .
L'Austria, p e r co ntro , può utili zza re, per una rad unata verso il Friuli, le lin ce 2, 3, 4, 5, 6, l a c ui potenzialità compless iva, data s pec ialm e nte l'amp iezza di ta lu ne s taz ioni, può essere fonda tam ente ri ten ut a di c irca 62 tr e ni g io nali eri per trasporto di truppe.
È quindi asso lut ame nte da esc lu dere che l 'ese r c it o italiano possa, in tempo opportuno , rad un ars i su l T agliamento; m a a nc he limit a nd os i alla linea del Pi ave, si è costretti, per diminuire il tempo de ll a radunata, a co nce ntrar e qualcuna delle g r a ndi unità più indietro della s tro zza tura so pra indicata. e ad utili zzare, anche per la radun ata d e ll e altre g r andi unit à, le lin ee più a rre tra te, scaricando le trupp e, segnata me nt e le arm i a cava ll o ed i servizi, a Verona, Monsel ice, Ferrara, e facendole po i procedere per via ordinaria.
Adoperando tali ripieghi, si può rite n e re che la radu na ta del1'ese r cito italiano sul Piave. potrebbe essere co mpiut a nel 26° g iorno , pe rò colle trupp e scaglionate a 3, 6, 8 tappe da l co nfin e irali ano .
Da parte a ustr i aca . nel le ipotesi che la ma ssa maggiore de l le forze, - c irca 27 divisioni fanteria e 8 di caval leria -s i a conce ntrat a a ll a frontiera del Friuli ed i I rim anente nella Pus te ri a e nel Tirolo, s i può r itene re c he la rad un a ta potrebbe essere co mpiut a nel 35° -36° g iorno.
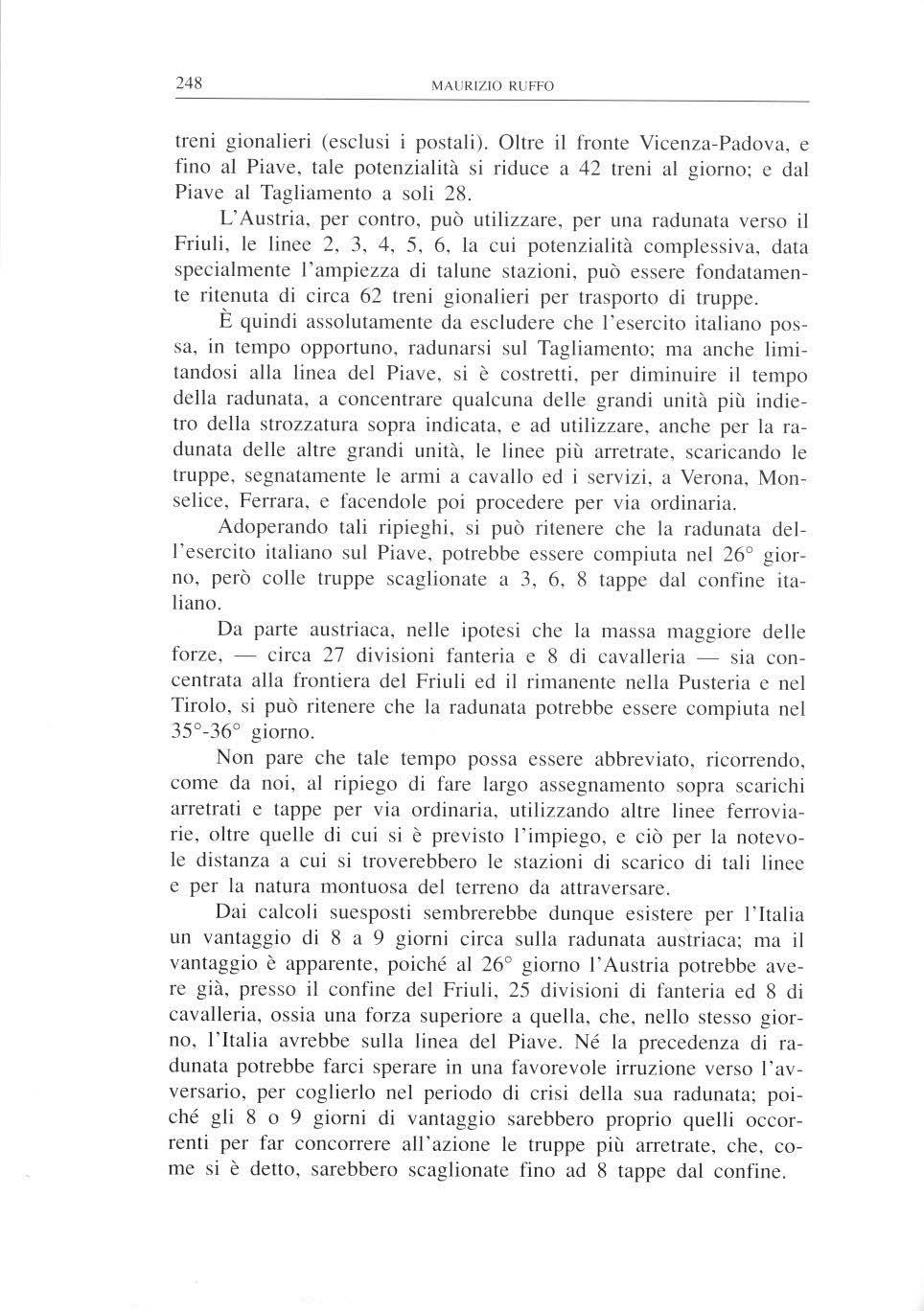
Non pare c he tale tempo possa essere ab breviato, ricorrendo, co me da noi, al ripiego di fare largo assegname nto sop ra sca ri c hi arr e trati e tap p e per vi a ordinaria, utili zzando a ltre lin ee ferrov iarie, oltre que ll e cli c ui s i è previsto l 'i mpie go, e c iò per la notevole di s tan za a c ui s i troverebbero le s tazioni di scarico di tali linee e per la natu ra montuosa del terreno da attraversare.
Da i calcoli s uespos ti se mbrere bbe dunque esistere per l' Ital ia un vanta gg io di 8 a 9 g iorni circa s ull a radunata austriaca: ma il vantaggio è appare nt e, poic hé al 26° g iorno l 'A ustria potrebbe avere già, presso il confine d el Friuli , 25 divisioni di fanteria ed 8 di c avalleria , o ssia una forza supe rior e a quel la, che, ne llo s tesso g iorno , l'I talia avrebbe sulla lin ea del Pi ave. Né la precedenza di raduna ta potrebbe farci spe rare in una favorevole irru zione ve r so l 'avversario, p e r cog li erlo nel periodo di crisi d e lla sua radunata; poic hé gli 8 o 9 g iorni di va ntagg io sa rebbero propr io quelli occorre nti per far c onc orrere a li ' azione le truppe più arretra te, che , come s i è detto , sare bbe ro scaglio nat e fino ad 8 tappe d a l co nfin e.
Questo stato di cose, diventerà ancora più grave, quando I' Austria avrà attuato i I vasto progetto di ampliamento feIToviario con la costruzione delle linee del Tauern , dei Karavanken e dei Wochein 17 •
Allora, come appare dallo schizzo N. 3, ben 7 lince 18 indipendenti condurranno al confine italiano , delle quali 6, colla potenzialità di circa 73 treni gionalieri, potrebbero essere utilizzati per una radunata sulla fronte Villach-Tarvi s -basso I so nzo.
Nelle nuove condizioni, adunque, l'Au stria potrebbe accelerare il movimento di radunata delle 27 divisioni fanteria ed 8 di cavalleria, su lla frontiera del Friuli, cli 4-5 giorni; ed in tal caso non rimarrebbero all'Italia che 4-5 giorni cli precedenza s ulla radunata austriaca, i quali sarebbero interamente perduti, per effetto dello scaglionamento delle forze in profondità, già accennato.
Inoltre , le nuove linee concederanno all'Austria maggior libertà, che non pel pa ssato. n e lla ripartizione delle forze nei due schaccieri del Friuli e del Tirolo-Pusteria, pur lasciando invariata l a durata del pariodo di radunata.
Così, utili zzan do le linee I, 2, 3, (quest'ultima prolungata fino a Villach) l'Austria potrebbe concentrare nel Trentino ed in Pusteria, nei limiti di tempo di 31 a 32 giorni, la ma ssa di 21 divisioni di fanteria; ed invece, utilizzando le line e 2, 3, 2, 5, 6, 7 per un concentramento di forze sulla linea Villach-Tarvis-baso Iso nzo, l'Austria potrebbe, pure in 3 I a 32 giorni, portarvi 36 divisioni cli fanteria ed 8 di cavalleria.
Cosicché, la costruzione delle nuove linee, mentre darà ali' Austria il vantaggio di poter variare la forza nei due scacchieri del Tirolo- Pusteria e del Friuli, le assicurerà sopra tutto l'iniziativa del le operazioni nel basso Friu li, con una massa di forze assa i superiore a quelle che l' Italia potrebbe contrappor le.
E per contro per noi sarà resa più grande l'incognita della distribuz ione del le forze avversarie, e s pecialmente aumentata la gravità della minaccia s u l fianco o su l tergo delle nostre forze, radunate eventualmente sulla linea del Piave.

17 I lavori già alacremente iniziati , debbono essere compiuti ne l I 908; però previsioni di g uerra potrebb ero renderne più solleci to il termine.
is Il tratto di Bischofshofen -S c hwar zach, comune alla I • e 2• linea, è a semp l ic e binario: ma , trattandos i d i un breve percorso ( 14 km.), con pe ndenze moderate , s i può ammettere che con opportuni p rovvedimenti possa no tran s itarvi i treni di due linee. Ed è molto probabi le che. ultimata la linea dei Tauern , l'Austria provveda s ubito alla costruzione del doppio binario in quel breve trailo.
La rete ferroviaria italiana non so lo presenta minore potenzialità di quella austriaca; ma è anche assa i più espos ta , che non questa, alle offese dell'avversario.
Infatti la linea Brescia-Verona-Vicenza, sul la quale si svolgerebbe un movimento assai intenso, è soggetta alle offese provenienti dal Garda e dalle strade mal difese del saliente tirolese; e la linea costiera adriatica, che, data la sca rs ità de ll a no stra rete ferroviaria, dovrebbe di certo essere utilizzata , è minacciata da offese provenienti dal mare 19 •
Per contro la rete austriaca presenta pochi punti vulnerabili, e cioè Oberdrauburg, sulla linea della Pus teria; Fiume , ed il tratto Monfalcone-Nebresina s ull a lin ea costiera; inoltre, quando sarà completata la linea del Wochein, S. Lucia, presso J'l sonzo.
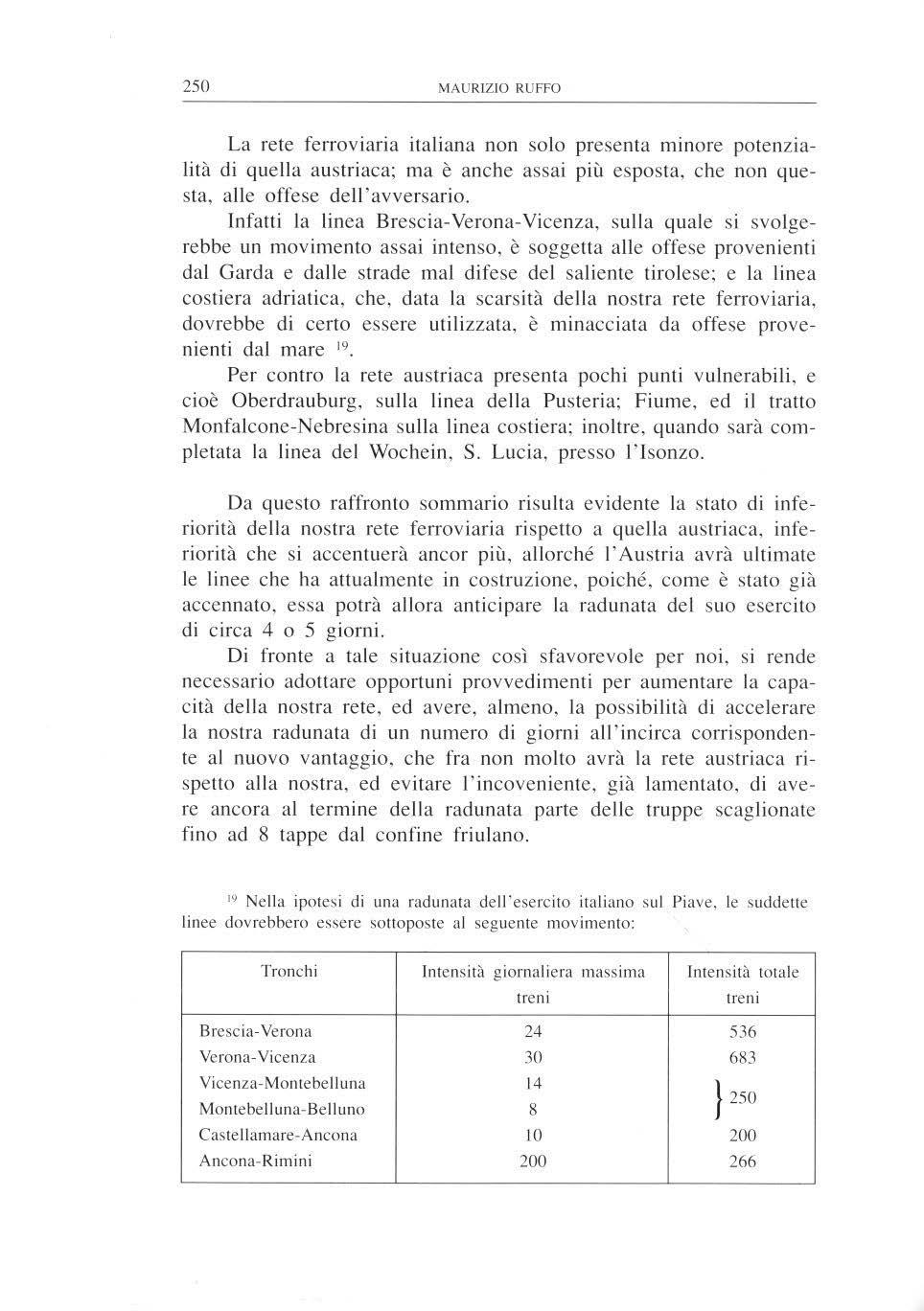
Da questo raffronto so mmario risulta ev id ente la sta to di inferiorità della nostra rete ferroviaria rispetto a quella austriaca, inferiorit à che si accentuerà ancor più, allorché l'Austria avrà ultimate le linee che ha attualmente in cos tru zione, poiché, come è stato già accennato, essa potrà allora anticipare la radunata del suo esercito di circa 4 o 5 g iorni.
Di fronte a tale situazione così sfavorevole per noi, si rende necessario adottare opportuni provvedimenti per aumentare la capaci tà della no stra rete, ed avere, a lmeno, la possibilità di accelerare la nostra radunata di un numero di giorni ali ' incirca corrispondente al nuovo vantaggio, che fra non molto avrà la rete austriaca rispe tto alla no stra, ed evitare l'incoveniente, già lamentato, di avere ancora al termine della radunata parte delle truppe scaglionate fino ad 8 tappe dal confine friulano.
Tronchi Intensità g iornal iera mas sima Intensità to tale treni treni
Tali provvedimanti sarebbero:
I raddoppio dei binari sui tronchi: Manto va -Mo selice, Ferrara-Monselice, Vicenza-Treviso, e Mestre-Treviso;
2. impianto di un altro binario indipend e nt e fra Mons e li ce e M es tre;
3. ampliam e nto di s tazioni e nuove provviste di materiale rotabile, segnatamente di locomoti ve.
Spesa occorren re 94 milioni c irca .
Adottando tutti qu es ti provvedimenti, rimaITebbe assicurata la possibilità di radunare l 'esercito su l Piave circa 6 g iorni prima di quello che oggi avverrebbe, se nza che alcun corpo fosse cos tretto a radunarsi più indiet ro di qu es to fiume.
Per ottenere so ltanto il ri s ultato di radunare l 'ese rcito su I Piave, d e ntro i li miti di tempo consentiti oggidì. ma senza che alc un corpo fosse costretto radunarsi più indietro di questo fiume, basterebbe in vece adottare i provvedi manti seg uenti:
1. doppi binari s ui tronchi: Fe rrara - Mon se li ce, Vicenza-Treviso e Me s tre -Treviso;
2. ampliamento di staz.ioni (Fe rrara , Verona, Vicenza, ecc.) ccl aumento del material e rotabile, specialmente cli locomotive.
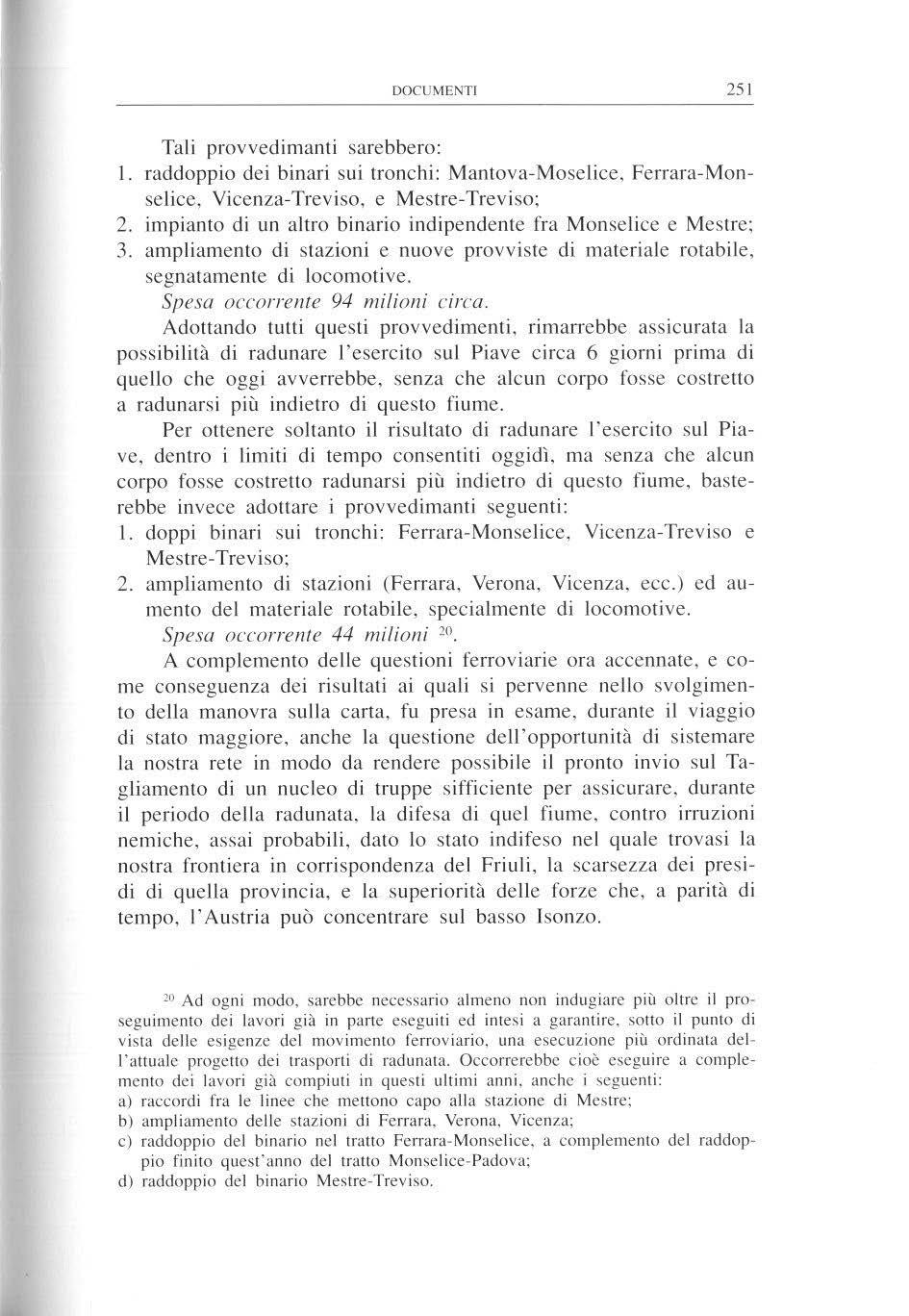
Spesa occorrente 44 milioni 20
A comp lem e nto delle questioni ferroviarie ora accennate, e come conseguenza d e i ri s ultati ai quali si pervenn e nello svo lg imento de lla manovra s ulla carta, fu presa in esa m e, durante il viaggio di s tato mag g iore, anche la qu es tion e d e ll 'o ppo r tunità di sis temare la no st ra ret e in m o do da rendere possibile il pronto invio s ul T ag liamen to di un nucleo di truppe s ifficiente pe r assicurare, durante il periodo della radunata , la difesa di quel fiume, contro irru z ioni nemiche, assai probabili, dato lo stato indifeso nel qual e trova si l a nostra frontiera in corrispondenza del Friuli, la scarsezza dei pres idi cli quella provincia , e la superiorità delle forze che, a parità di tempo , l 'Austria può concentrare sul basso Iso nzo .
20 Ad ogni modo. sarebbe necessari o almeno non indug iare più oltre il proseg uimento dei lavori g ià in parte esegu iti ed in tes i a gara ntire. sotto il punto di vista delle esigenze del mo v i menlO ferrov i ari o. una esecuzione p i ù o rdin ata de ll'attua le p r ogetto dei tra sporti di radunata. Occorrerebbe cioè eseguire a complemento dei l avori già compiuti in questi ultimi anni anche i segue nti :
a) ra ccord i fra le l inee che mettono ca po alla stazione di M estre;
b) am pl iamen to delle stazioni di Ferra ra Vero na, Vicenza;
e) raddoppio del binario nel tratto Ferrara - Monselice. a comp lemento del raddoppio fi nito quest'anno d el tratto Monselice- Padova;
d) raddoppio del binario Mestre-Treviso.
Ritenute sufficienti per tale scopo le seguenti truppe 21:
2 divisioni del VI corpo d'armata:
3 divis ioni di cavai leria , per poterle tra s portare prontamen te sul Tagliamento, occorrerebbe aumentare al produltivtà complessiva delle ferrovie comprese fra la fronte Vicenza-Padova e quel fiume (che ora è, come è già stato detto, di 42 treni fra la fronte Vicenza-Padova e il Piave , e di 28 treni fra Piave e Tagliamento) fino al limite di 50 treni , pari cioè alla produttività delle fe1Tovie che adducono alla fronte Vicenza-Padova. E pertanto occorrerebbe adottare i seguenti provvedimenti:
I. raddoppiamento dei binari sulle linee: Vicenza-Treviso, TrevisoCasarsa, Mestre-Treviso;
2. prolungamento della Treviso-Motta fino a S. Vito al Tagliamento;
3. raccordamenti. attorno alle stazioni di Mestre e Treviso, delle linee che fanno capo a talòi stazioni:
4. aumento di fili telegrafici;
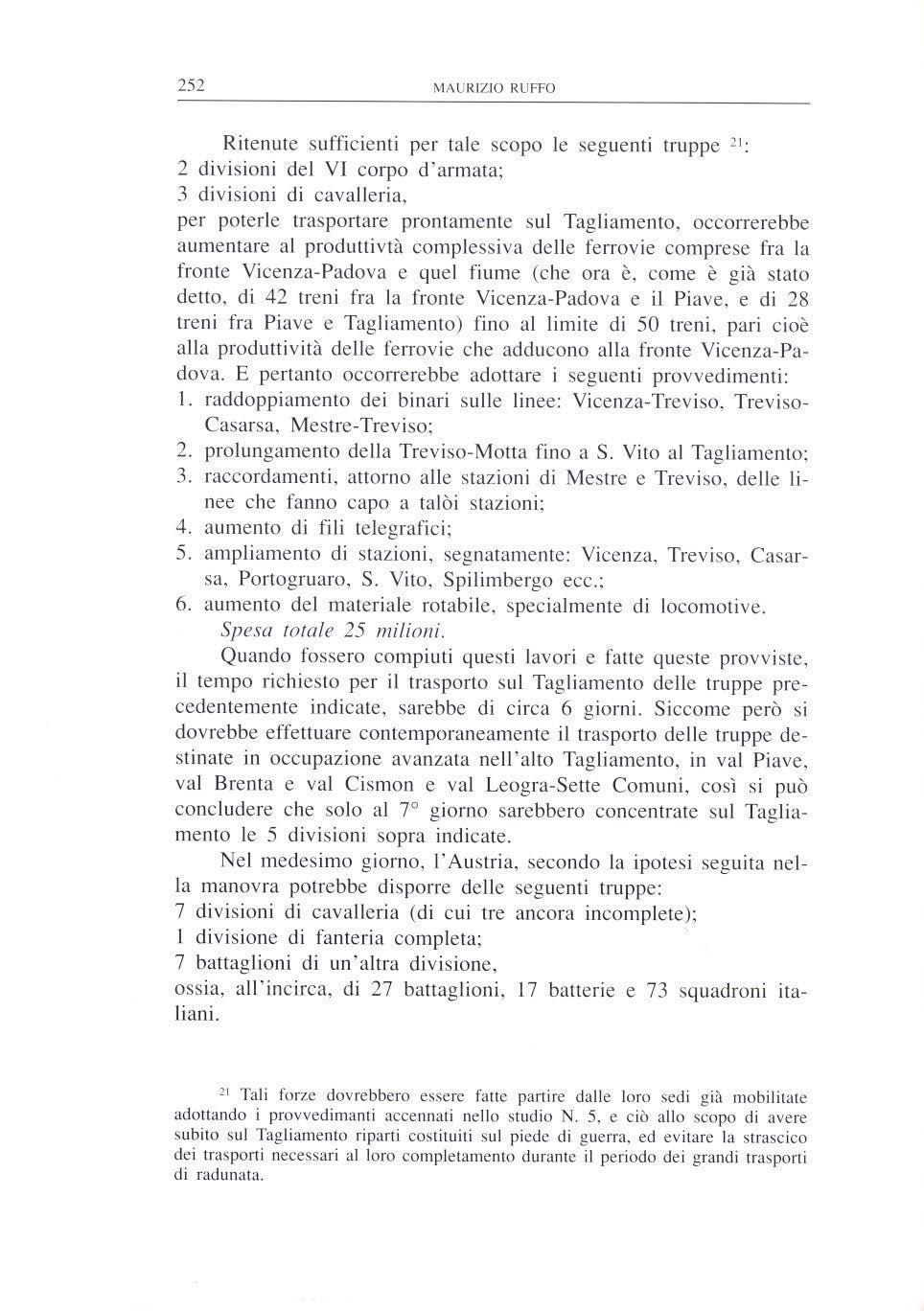
5. ampliamento di stazioni, segnatamente: Vicenza, Trevi so, Casarsa, Portogruaro, S. Vito, Spilimbergo ecc.;
6. aumento del materiale rotabile. specialmente di locomotive. Spesa totale 25 milioni.
Quando fossero compiuti questi lavori e falle queste provviste, il tempo richiesto per il tra s porto sul Tagliamento delle truppe precedentemente indicate, sarebbe di circa 6 giorni. Siccome però si dovrebbe effettuare contemporaneamente il trasporto del le truppe destinate in occupazione avanzata nell'alto Tagliamento, in val Piave , val Brenta e val Cismon e val Leogra-Sette Comuni, così si può concludere che solo al 7 ° giorno sarebbero concentrate sul Tagliamento le 5 divisioni sopra indicate.
Nel medesimo g iorno, l'Austria, secondo la ipotesi seguita nella manovra potrebbe disporre delle seguenti truppe:
7 divisioni di cavalleria (di cui tre ancora incomp lete):
1 divisione d i fanteria completa;
7 battaglioni di un 'a ltra divisione, ossia, all'incirca, di 27 battaglioni, 17 batterie e 73 s quadroni italiani.
21 Tali forze dovrebbero essere fatte partire dalle loro sed i già mobilitate adottando i provvedimanti accennali nello stud io N. 5, e ciò allo s copo di avere subito sul Tagl iamento riparti costituiti sul p iede di g uerra, ed evitare la strascico dei tra sporti nece ssa ri al loro comp letamento dura nte il periodo dei grand i tra s poni di radunata.
Si può dunque ritenere che nel la ipotesi suddetta, e piu ancora in un ipotesi più favorevole per l'Italia. il provvedimanto sarebbe da ritenersi sufficiente. a condizione però che anche le truppe italiane. come si è accennato. siano s ul piede di guerra. al pari di quelle austriache.
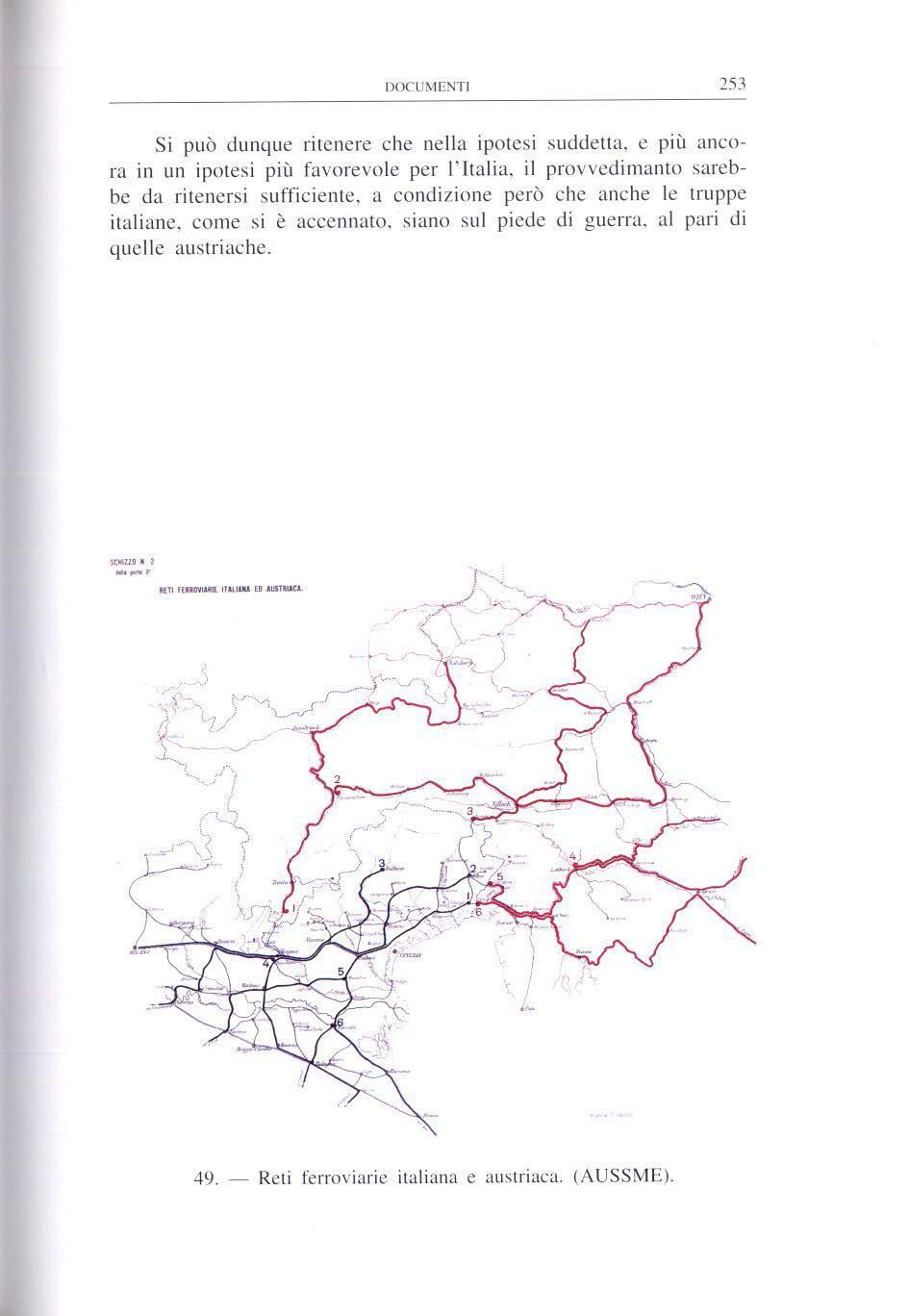
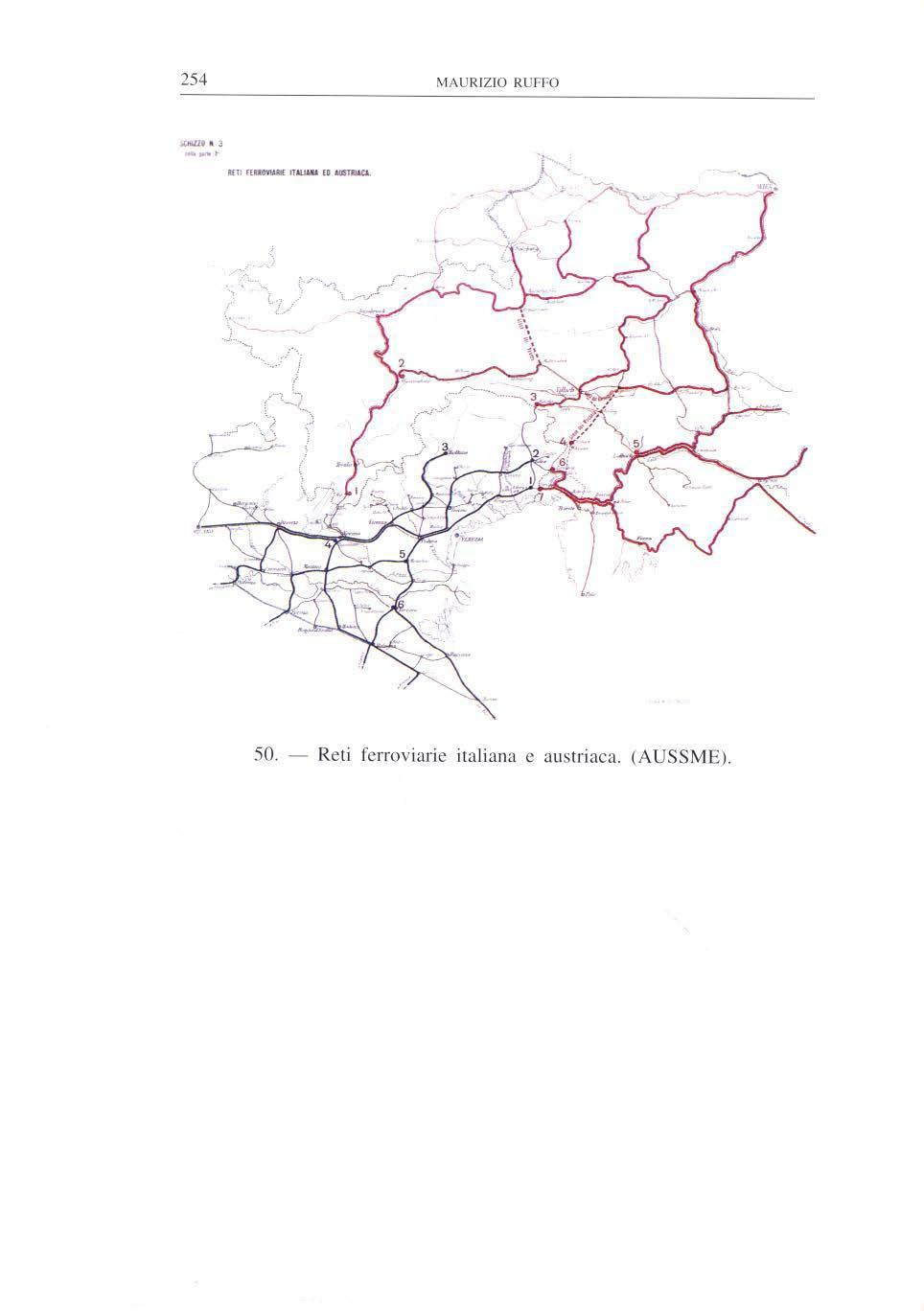
Rip a r t iz io n e d e l li to r a le p er l a difesa cos ti era
AUTOR IT.~ )ULITARI )I ARITIIME
TRATTI At;TORITA Comandi in capo Zone Gruppi di posti DEL MLLITARI di dipartim ento se maforiche se maforici
I.ITORAI.E TERRESTI marittimo o e sede e uffici cap ilinea comando militare dell'ufficio funzionant i in caso marittimo capo wna di mobilitazi one Dal confine francese al- IV corpo d'a m1a1a la foce de l torrente Dei- (Ge nova) ,a. esclusa la zona: da lla foce del Cora ll o a que ll a de l Sansob bia (forteua cos ti era di Altare Vado)
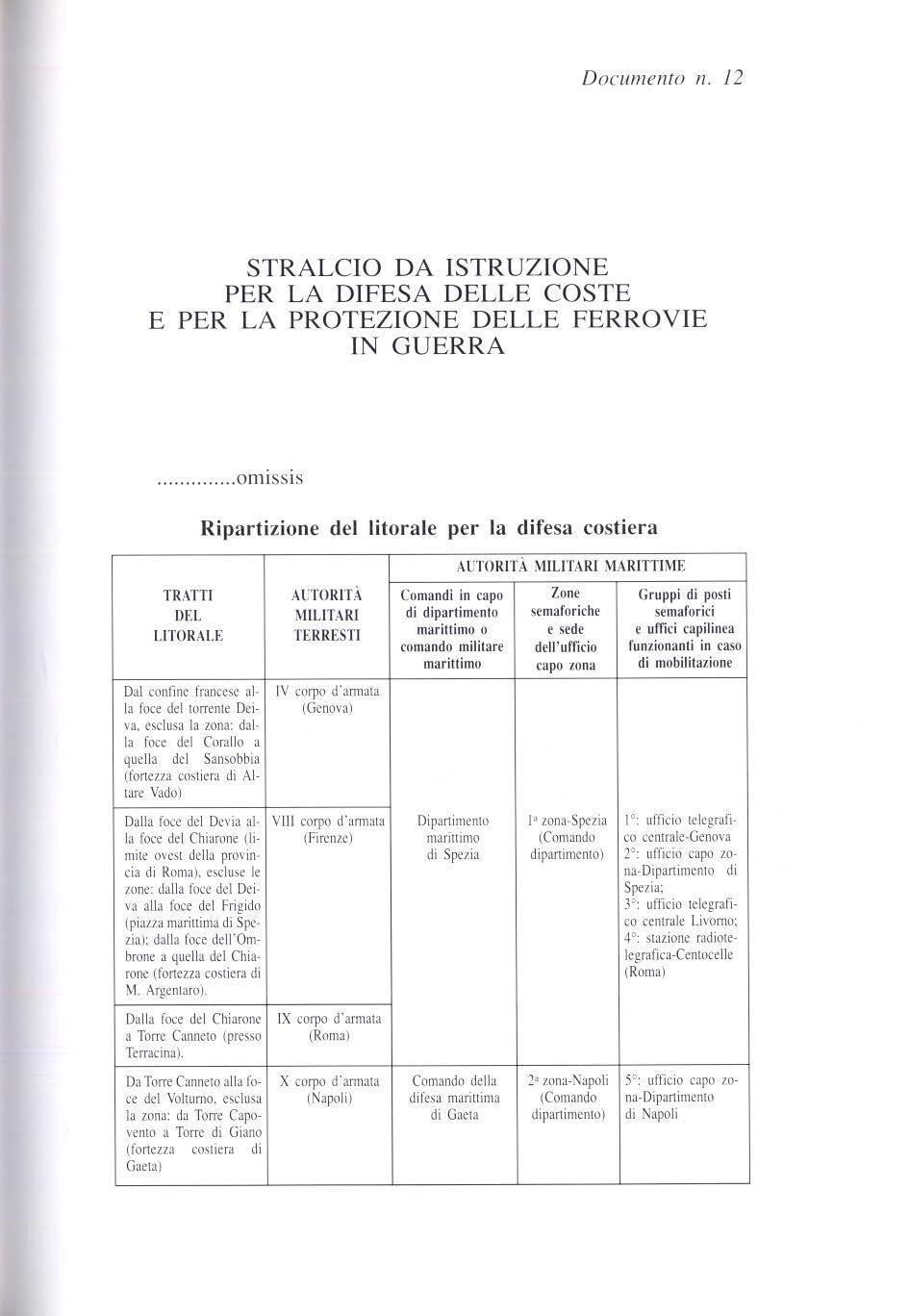
Dall a foce de l De via al VIli co rpo d':,rnrnta Dip ar1i mento l" zona -Spezia 1°: uffici ,, telegrafila foce de l Chiaw ne (li - ( Firenze) ma rimmo (Coma ndo co centrale-Ge nova mite ov ~st della prol'in- di Spe1. ia dipa rtimento) 2°: ufficio capo zo. eia di Roma). esc luse le na-Dipanimen to di ,o ne: dall a foce del Dei- Spez ia: va all a foce de l Frh! id o J>: ufficio teleg rafi(p ia, 1.a ma riuima di Spe- co centrale Livorno: zia): da lla foce deJl'Om- ~·: st azione rad iote· brune a quella del Ch ia- leerafic a·Centord le ron~ (fonezza cost iera di (Roma ) M. Arge ntaro).
Da lla foce deI Chiarone IX corpo d'armata a Torre Canneto (prc,so (Roma) Terraci na)
Da Torre Canneto all a fo X corpo d'armata Comando della 2• ,ona- Kapoli 5' : ufficio capo zoce del Voltumo. esclusa (Na poli) difes a marill ima (Comando na-D ipar1 imento la zona: cta To rre Capo - di Gaet a di panimen to) di Napoli vento a Torre di Gi ano (fo rtezza cost iera di Gaeta )
Dalla l<x-c del \'ohumo alla f1..:c del Cas1roc:ucco.
Dalla foce del (a,lro cucrn J quella del Mesima
Tuue le .-o,te della Sici lia (cd 1,olc minori) ecoste della Calahria 1 • dal la foce del ~!esima a quella uclL\"i e-.:lu...: lt /Olk' - 111 S1e1ha: dalla foce dell' l1 afo a quella del Mela (Fon. co,1kra d, ~lc,,ina -Re2 2iol: - m (J!Jbna: daÌli fo ce del \'allonc <klla ((l•ala alla foce del fium e Va ll an idi ( Fori. co,1iera di ~1e"ina -Regg iol
Dalla fo,e de!r,.\," a qudla del Trigno :. e,cluse le LOnc: dalla foce del Paterni,colo all o ,bocco del (anale Onona (pi,ll
ZJ man111ma di Taran101. dalla ,1a11olk' di , edeua di ea,a 1.·Aba1e alla ,ta11one di 1cde11a di Tor· re Vac:110 (piana maritlima d1 Brindi,i I.
Xl corpo cr arma ta (Baril
Xli corpo d. arm,ua (Pa lcm1 0)
Dipan1mtOIO manmmo di Napoli Comando della difesa mariuirna di Mes, ina '
.l• ,ona ·t.k"ma (Comando difesa maruumal
(\'· ufficio capo ,ona ~k»in:1
7': ulfi cio tcleeralico ,cntrale-Pàlcrmo
Xl corpo d'am1a1a (Banl
Dipan11ncnh1 man111mo di Tar,uuo :
J• zona Taramo : 1C'omJndo di pammcnlo)
S ullì.:m capo ZO· na-Taramo
9 : uI licio 1elegra fico ccn1ralc- Ban
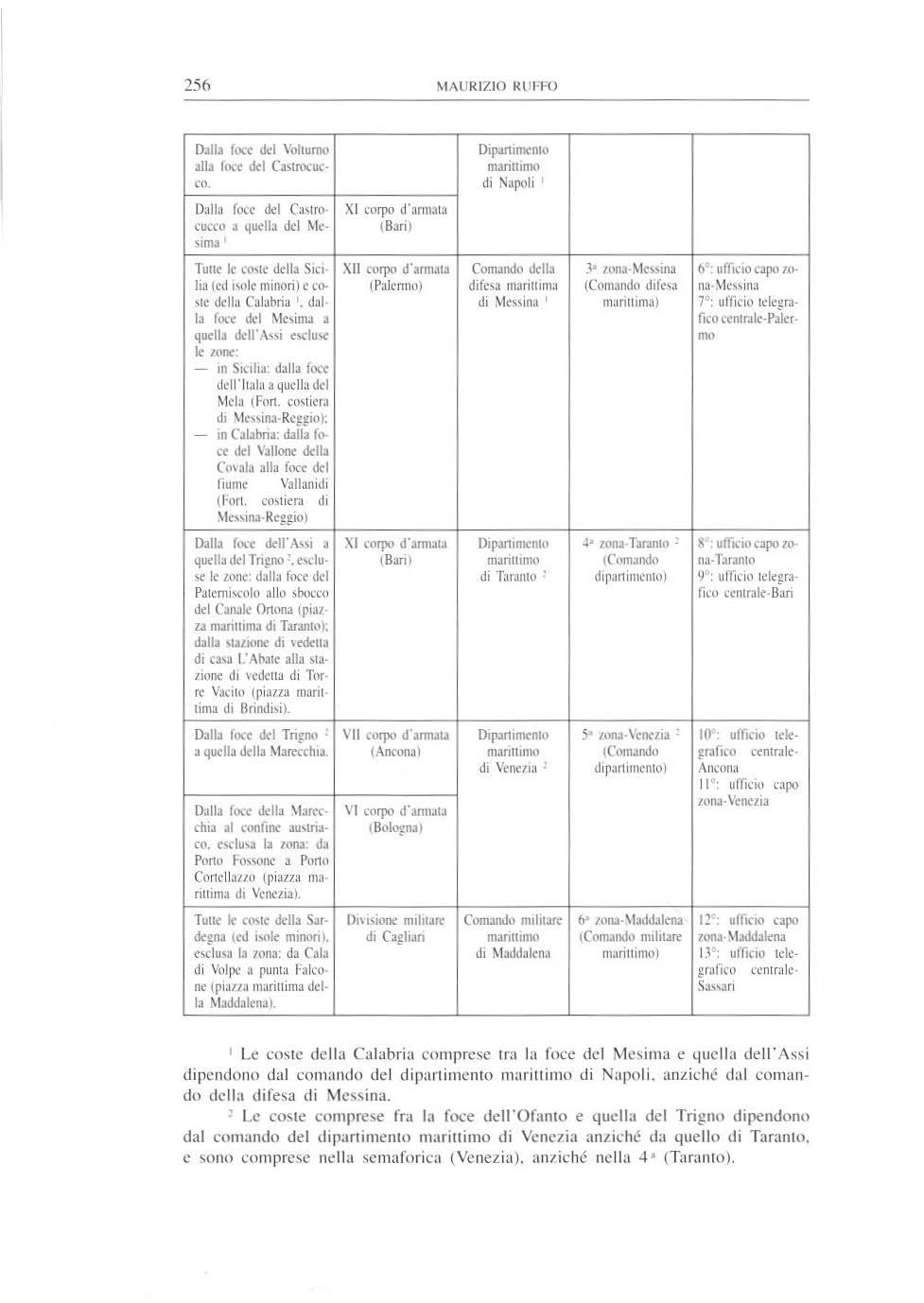
Dana f0<·c dd Trigno • VII corpo d'anna1a a quella della Marecch,a (Ancona)
Dalla foce della \ !aree ch,a al c:ontinc au,1naco. e,du,a la 1ona· da Pono fo,,onc a Porto (o r1cl la110 (p iazza ma riuima d1 Venezia).
Tune k co,1c della Sardegna tcd i,ole mmorn. c,l'lu,a la 1011a: da (ala di Volp~ a pu nta falco ne (p ia11a marill ima della Maddalcnal.
\'( rnrpo d'annala !Bologna ) D1\J,iOlk' m,hwc di (aglian
Dipammcn10 mar,1111110 d1 Vene/la
5 "'"a·\cnezia : 1Coma11do dip artimcn1oj
IO ufficio 1elegrati,o centrak
An cnna
11": ufficio capo ,om1-\'eoczia
Comando 1111!11arc 6• lona-\laddalcna 12 ufficio capo man1111no \Comando n11li1are lOnJ-~ laddalena di Maddalena manuimol l.ì : uflìcio 1dccraflco ce ntral e Sa"ari
1 Le cos te della Cal abria co mpre se tra l a foce elci Me~ima e quel la dell'As\i dipendono dal comando de l d i par<irnento 111arit1imo di Napol i . anzic hé dal coma ndo della dife~a di M es,ina.
' I.e coste comp r ese fra la foce dell'Ofanto e quella del Trign o dipendono dal comando del dipanimento mariuimo di Yene7ia a1uiché da quello di Taranto, e sono co mprese nella semafori ca (Ve nez ia). an7ic hé ne l la 4 " (Taranto).

Studio per interruzioni della linea ferro11iaria del Pusterthal
costituito da:
A - UNA RELAZIONE GENERALE alla quale sono allegati:
I O - Un itinerario grafico , rettificato, alla scala I: I 00.000
2 ° - Una raccolta del le illustrazioni alla ferrovia del Tauern
B - UNA RELAZIONE per un colpo di mano su BRUNECK, con allegati:
a) Un itinerario grafico, rettificato, alla scala 1: 100.000
Verona, Aprile 1911
Il Maggior Generale Comandante la 3" Brigata Alpina
f.to Oro
PER RISOLVERE IN MODO CONCRETO IL PROBLEMA DELLA INTERR UZ IO NE DT UNA FERROVIA I N UN PAESE ES TERO C REDO SIA NECESSARIO:
1. RICONOSCERE LA LINEA FERROVIARIA ALLO SCOPO DI DETERMINARE I P UN TI C HE SI PRESTANO ALLA INTERRUZIONE ;
2. STABILIRE LE MODALITÀ PER LA ESECUZIONE DELLE INTERRUZIONI RITENUTE UTILI.
1. RICOGNIZIONE DELLA LINEA DEL PUS TERTHAL.
Nei g iorn i dal I O al 14, mi son portato a li 'es tero ed ho percorso due volte la lin ea del Pusterthal (val Pu ster ia ) prima nel se n-
so Franzensfeste- Yil lach e poi nel senso oppos to. In e ntrambe le g ite ho cons ta ta to in modo ge nera le come la linea è armata con lo s tesso mater ia le delle gra ndi linee ad ia ce nti , per c ui g li stess i t reni dire tti e dire tti ss imi che percorrono la lin ea del l 'Adige e quella della Carinzia e Vienna percoITono pure quella del Pusterthal.
Tu tt e le s t az io ni sono in murat ura cope rte co n tego le piane e so lo presen tano poche parti del so laio superiore in leg narn e.
Sono in legnarne i magazzini delle merci, i gabi netti di dece nza ed alcuni resta u ran t sebbe ne no n in teramente.
Le s ta z ioni principali Brun eck ( Bruni co), Toblach (Dobbiaco), Innichen (Sa n Candido), Lienz, Spillai so no munite di amp i piani car icato ri , num e ro si e lun ghi binari di sca mbi o, piattaforme girevo1i. ri forni tori d'acqua. ecc. Tutte le accennate s ta z ion i sono forni te di mezz i in abbondanza e costrutte con larghi intendimenti in modo da sodd isfare ad ogni es ige n za.
L a staz ion e di Spittal si fa specia lmente notare pe r vastità e mezz i e fa capo ad essa la nuova fe rr ov ia del Tauern.
Anche le s tazio ni secondarie hanno binari d i scambio e piani car i catori di modo c he si può affermare che a tutto fu provveduto senza economia e con larg hezza di vedute.
In quasi tutte le stazion i si trova molta q ua n t it à di legname. Ciò premesso accenno a quanto ho potuto osservare lungo la lin ea.
La Pu ste ria (Pusterthal) va da Franzensfeste (Fortezza) a Yillach ed è percorsa da due corsi d'acqua in senso opposto cioè dalla Ri enz e dalla Drava che versano rispettivamente le acque nel1'Adige e nel D a nub io e perc iò nel m ar Adriatico e ne l mar Ne ro.
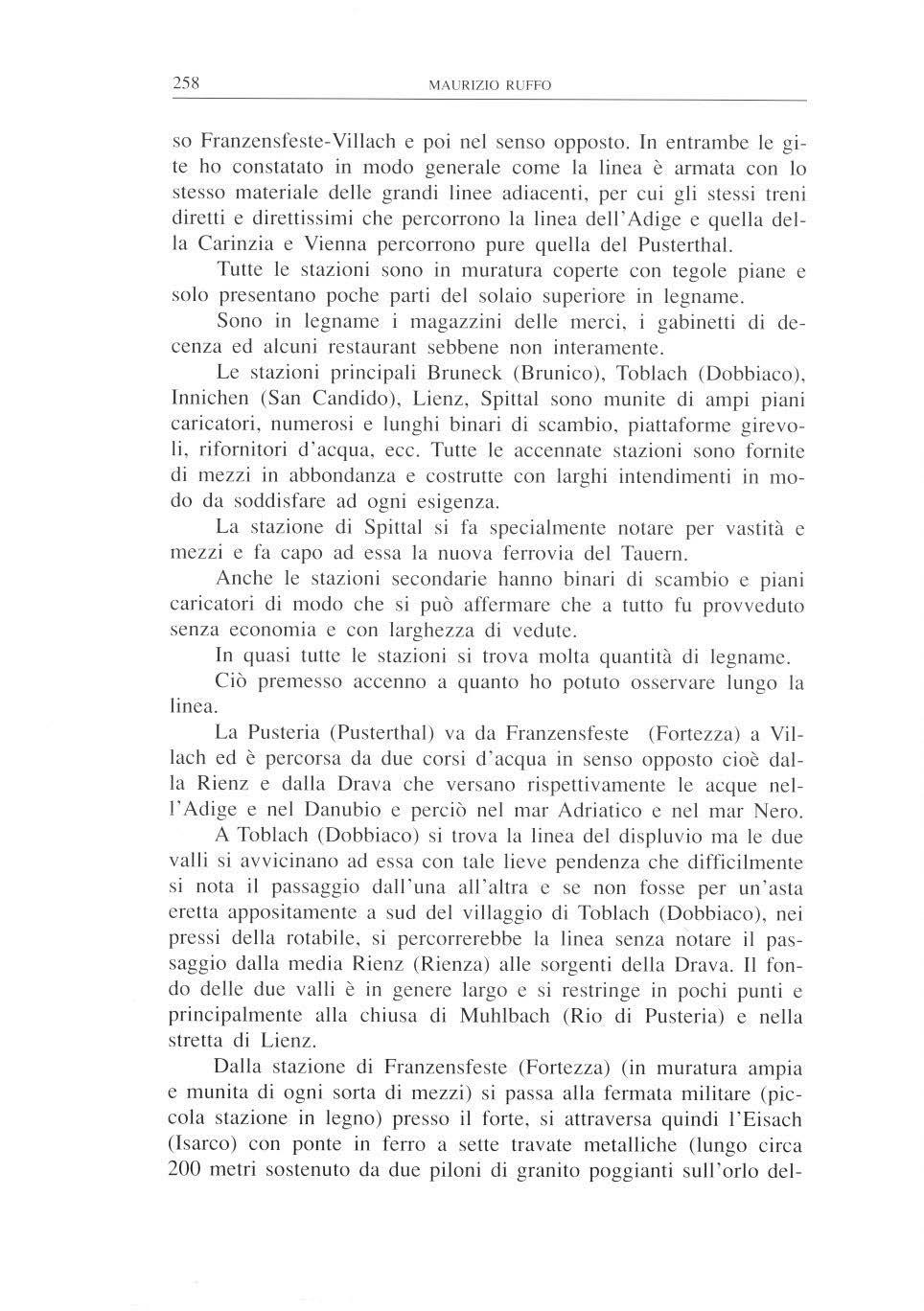
A Tob la c h ( Dob b iaco) s i trova la lin ea del displuvio ma le due va lli si avv ic inano ad essa con tale lieve pendenza c he difficilmente si nota il passaggio d a ll ' un a all'a lt ra e se non fosse per un'asta e r elta appositamente a s ud d e l vi ll agg io di Tob l ac h ( Dobbi aco), nei pressi della rotabile, si percorrerebbe la linea senza notare il passaggio dalla me dia Ri enz ( Ri e nza) a ll e so rge nti dell a Drava. Il fondo delle due va lli è in genere l argo e s i rest rin ge in pochi punti e principa lmente a ll a chiusa di Muhlba ch ( Rio cli Pus te ria) e nella s tr e tta di Lie n z .
D alla stazione di Franze nsfeste (Fo rtezza) ( in muratura a m pia e munita di ogni sor ta di mezz i) s i passa a lla fermata militare ( pi ccola s tazione in legno) presso il forte, s i attraversa quindi l 'Eisach (Isarco ) c on ponte in ferro a se tt e travat e metalliche (l u ngo circa 200 me tri s oste nuto da du e piloni cli granito poggianti s ull ' orlo ci e l-
la Forra dell'Eisach (Isarco) profonda 48 m.) e si entra nell'altipiano di Spinges (Spinga). Si passa quindi per un tunnel lungo 257 metri raggiungendo la stazione di Schabs (Sciaves).
La ferrovia prosegue in trincea profonda per lungo tratto sino al ponte in ferro sul Valser (lungo 60 metri alto 20) e raggiunge la stazione di Mulbach (Rio di Pusteria). La valle va facendosi stretta e boscosa (stretta di Mulbach Rio di Pusteria) dopo di che si allarga e con frequenti svolte arriva a Vinti (Vandoies). Successivamente si passa sulla sinistra della Rienz ( Ri enza) con ponte in ferro di 50 metri circa raggiungendo la stazione di Ehremburg (Caste ldarne), dopo di che la valle molto angusta va al largandosi fino alla bella conca di S. Lorenz (San Lorenzo di Sebato) - Bruneck (Brunico).
Passata la stazione di Bruneck (Brunico) la ferrovia sale girando intorno alla città ripassa sulla destra della Rienz (Rienza) con ponte metallico (25 m. circa) e s'interna in un tunnel che chiameremo di Lamprecht lungo più di 300 m. È il più esteso di tutta la linea e passa sotto le rovine del castello di Lamprecht. Segue una breve trincea ed una grande svolta sino al bel ponte in ferro sulla Rienz (Rienza) detto di Percha (Perca) (due travate metalliche lunghe in totale 50 metri ed alto 30 sul pelo d'acqua; le travate sono sostenute da un pilastro in muratura). Si attraversano quindi due gallerie (una di 50 metri e l 'a ltra oltre i 150 metri) e si raggiunge la stazione di Olang (Valdaora) fra i due rii de l lo stesso nome che si superano con due piccoli ponti in ferro.
La ferrovia prosegue arrivando quasi a I ivello del torrente, passa un tunnel di 140 metri ed arriva a Welsberg (Monguelfo). Prosegue poscia su ponte metallico di 10 metri circa per passare il torrente Prags ( Brai es) e raggiunge la stazione di Niederdorf (Villabassa); da questa stazione continua a levante in leggera salita, passa la Ri enz ( Rienz a) su ponte metallico di 20 metri circa e raggiunge la stazione di Toblach (Dobbiaco).
N ulla di notevole nel tratto successivo fino a Sillian. La ferrovia scende dolcemente in val di Drava (Drauthal), larga e facile fin da principio, mantenendosi dapprima sulla sinistra del rio e raggiunge la stazione d'lnnichen (Sa n Candido). Prosegue a levante, raggiunge Ober Vierschach (Versciaco) e passa s ulla destra del fiume mediante ponte in ferro ad una travata di 22 metri.
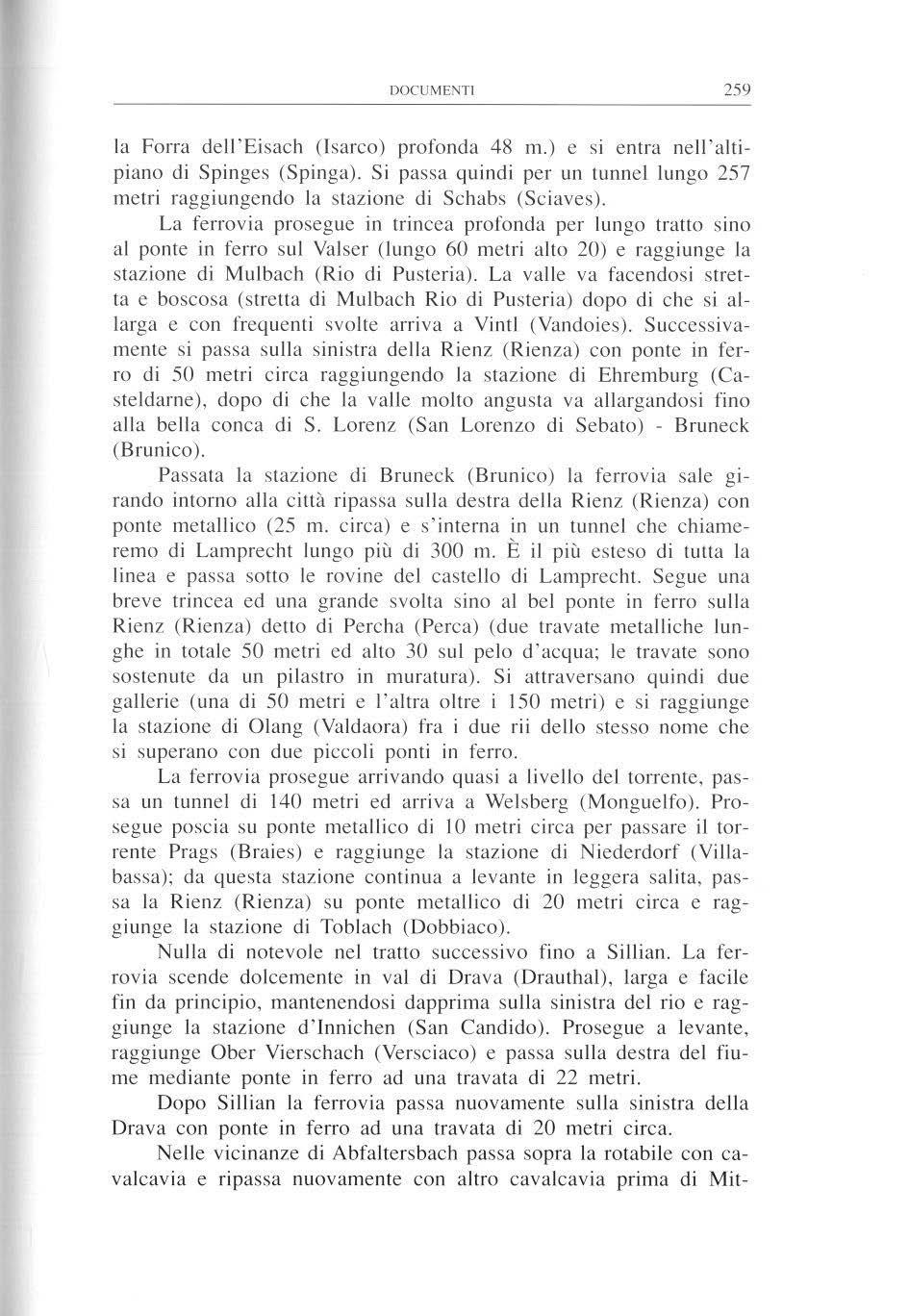
Dopo Si ll ian la ferrovia passa nuovamente s ulla sinistra della Drava con ponte in ferro ad una travata di 20 metri circa.
Nelle vicina nze di Abfaltersbach passa sopra la rotabile con cavalcavia e ripassa nuovamente con altro cavalcavia prima di Mit-
tewald dopo di che raggiunge la stazione di Thai. dopo questa s tazione la ferrovia e la rotabile procedono ravvicinate e seguendo una gran curva percorrono la stretta di Li enz. In questo tratto imboscato che dura fino a Burgfre iclen per 4 chilometri e mezzo. seguono in spazio ristretto la Drava la rotabile e subito ad essa adiacente la ferrovia. Entrambe le comunicazioni sono in rialzo inclinate a scarpa natural e, tranne nella parte che segue immediatamente la stazione di Thai ove si riscontra qualche breve tratto s ostenuto da muro. Lungo la s tretta una intenuzione sarebbe efficace e si potre bbe con una sola operaz ione distruggere contemporaneamente rotabile e ferrovia.
I punti più indicati sarebbero due: uno subito dopo la stazione cli Tahl ove la rotabile passa so tto la ferrovia e l'altro ad una d e lle due curve prima della uscita orientale della stretta.
Dopo Lienz , stazion e e punto importante di comu ni caz ioni specialmente montane, si trovano i due ponti di Ober Drauburg e quindi si prosegue per Spittal al1' infuori dei limiti ciel presente studio.
Dall 'esa me ora fatto della linea ri su lta che vi sono punti d'interr uzione da classificarsi in tre categorie , cioè: ponti, ga ll erie e cavalcavie.
Dei primi la maggior parte sono di poca importan za, di lung he zza limitata e cl i poca altezza su l pelo dell'acqua, per cui la loro distruzione sa rebbe poco efficace e poco consigliabile. Forse sarebb e preferibile di st ru ggere lunghi tratti di binario ottenendo ma ggiori risultati e con maggiore facilità, bastando il collocamento di cartucce di ge latina ai punti di congiunzione d elle rotaie e facendole bri Ilare; operazioni alla portata di tutt.i.
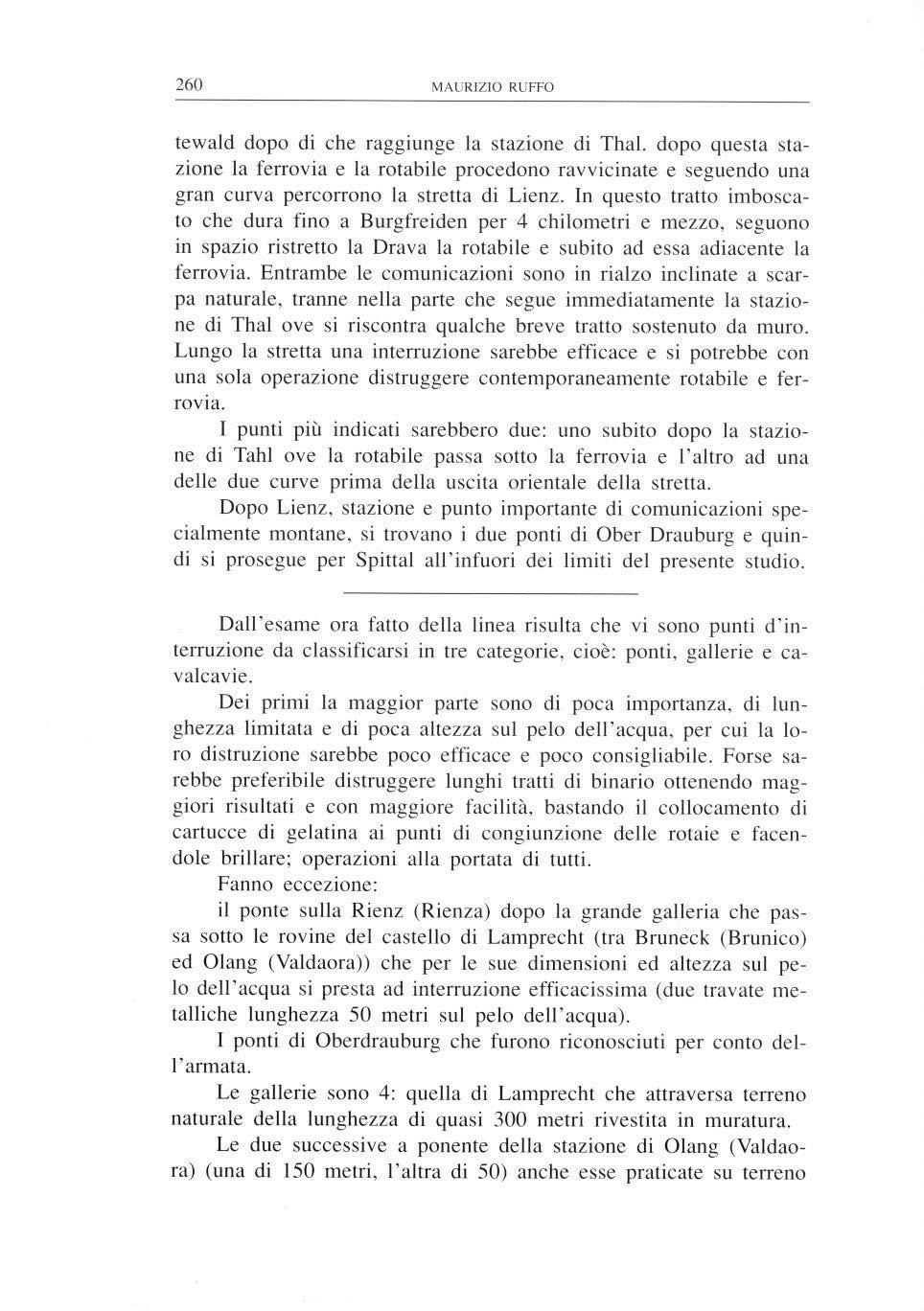
Fanno eccezion e:
il ponte sulla R ienz (Rienza) dopo la grande gal Ieri a che pa ss a sotto le rovine ciel castello di Lamprec ht (tra Bruneck (Brunico) ed Olang (Valdaora)) che per le s ue dimensioni ed altezza s ul pelo dell'acqua si pre sta ad interruzione efficacissima (due travate m etalliche lunghe zza 50 metri s ul pelo dell 'acqua).
I ponti di Obe rclrauburg che furono riconosciuti per conto ci eli 'a rmata.
Le gallerie so no 4: quella di L amprecht c he attraversa ten e no naturale della lunghezza cli quasi 300 metri rivestita in muratura.
L e due successive a ponente della stazione di Olang (Valdaora) (una di 150 metri, l'altra di 50) anche esse praticate su teneno
naturale ad eccezione del breve tratto dell'accesso ovest della galleria più lunga e dell'accesso est della più corta, tratti che sono in roccia.
Infin e l'ultima a ponente della stazione di Welsberg (Mongue lfo) della lunghezza cli 150 metri praticata interamente in terreno naturale e rivestita di muratura.
Tutte le accennate gallerie sono di forma ellittica senza piedritti e si prestano egregiamente per eff icaci interruzioni imperocché al la caduta dei rivestimenti aggiungono la frana del terreno soprastante. però la distruzione di queste gallerie richiede quantità di gelatina e speciali modalità di esecuzione che si indicheranno in seguito.
Per ultimo i due cavalcavia la cui distruzion e senza essere di grande entità s arebbe più efficace dei piccoli ponti menzionati.
Ri s ulta pertanto che le distruzioni più efficaci sarebbero quelle delle quattro gallerie e del ponte su ll a Rienz (Rienza) a levante della galleria di Lamprecht. Seguono poscia i ponti di Ober Drauburg ed i cavalcavia menzionati ed infine le interruzioni che si posso no fare alla s tretta di Lien z come si accennò precedentemente.
Altre distru z ioni e d altri incagli si possono produrre alle stazioni ferroviarie facendo saltare g li scam bi, danneggiando ( mediante cartucce d i dinamite) le piattaforme g irevo li , i rifornitori d 'acqua principalmente nelle stazioni di Toblach (Dobbiaco) ed lnni chen (San Candido), rendendo così difficile le relazioni ed i trasporti co i fo rti di Landro e Sexten (Sesto).
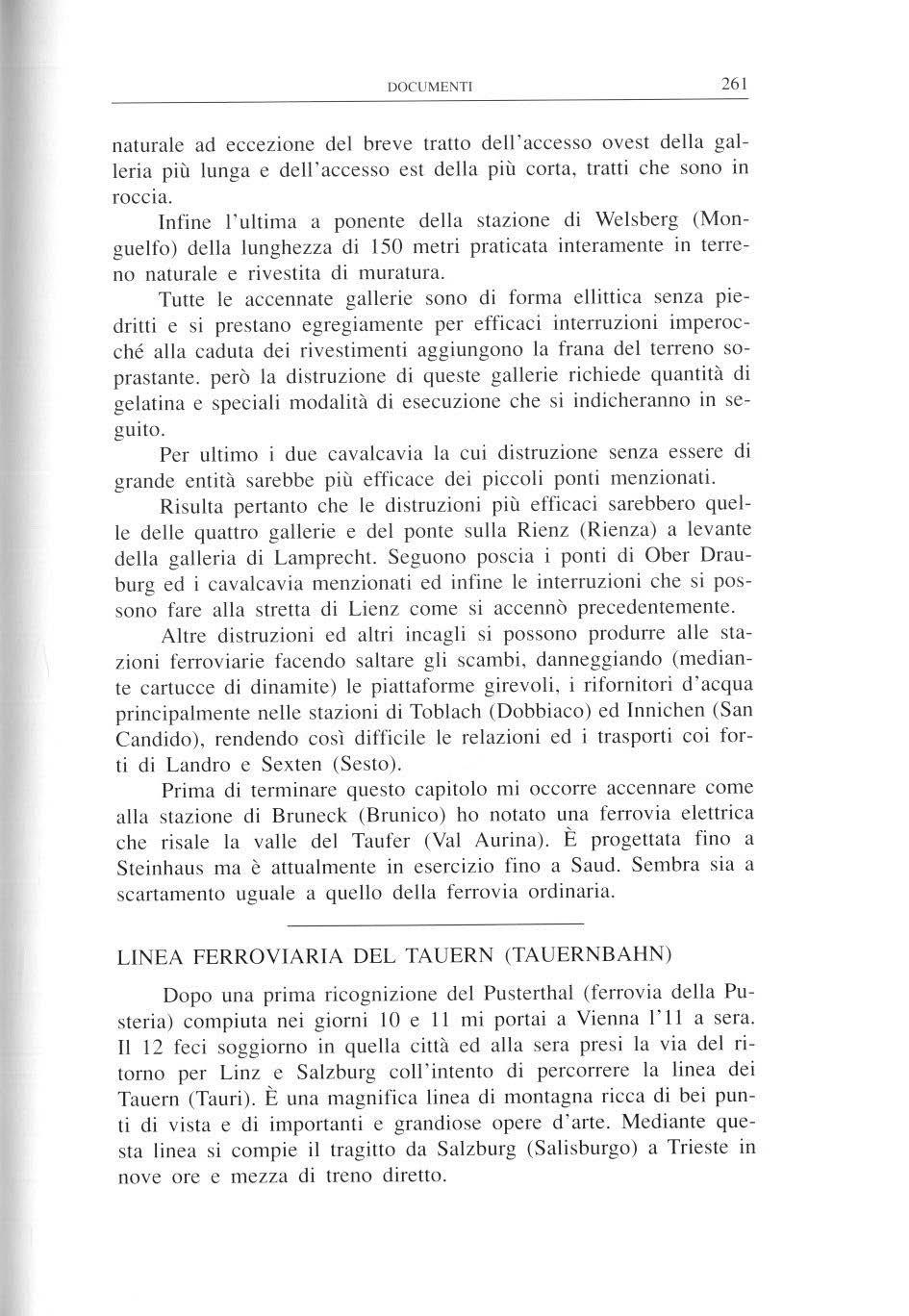
Prima di terminare questo cap itolo mi occorre accenna re come alla stazione di Bruneck ( Bruni co) ho notato una ferrov ia elettrica che risale la valle del Taufer (Val Aurina ). È progettata fino a Steinhaus ma è attualmente in eserc izio fino a Saud. Sembra sia a sca rtamento uguale a quello della ferrovia ordi na ri a.
Dopo una prima ricognizione del Pusterthal (ferrovia della Pusteria) comp iu ta nei giorni 1O e 11 mi portai a Vienna l ' 11 a se ra.
TI 12 feci soggiorno in que ll a città ed a lla sera presi la via ciel ritorno per Lin z e Salzburg co li ' intento cli percorrere la linea dei Tauern (Ta uri ). È una ma g nifi ca linea di montagna ri cca di bei punti di v is ta e di importanti e grandiose opere d'arte. M ediante qu esta lin ea si comp ie il tragitto da Salzburg (Sa li sb urgo) a Tri este in nove o re e mezza di treno diretto.
La linea ferroviaria cominc ia al la stazione di Schwarzach-SanktVi e t e corre lungo la Salzach co n la vo ri d 'a rt e numerosi, (trincee, muri di sos teg n o . di riparo, gal lerie e viadotti) fino a Labfarm. Dopo ques to punro la linea gira a sud e rimonta con forte sa l it a la valle del Gastein ove pene tra per m eao d e l tunnel di Klamn s te inpass segue una pittoresca ed imp onen te s tretta a pa reti ve rti cali di cui il punto più eleva to si tr ova presso una piccola cappella.
Ponte s ul! ' Ach e di Ga s te in e tunn e l cli 740 m e tri , poi l a fe rm a t a di Kl am ns tein La ferrovia si man ti ene poscia sempre s ull 'alto, risale il versante sinistro dell"Ache di Gastein, tocca le s t a7ioni di Dorf Gastein ed Hof Gastein, passa I ' Ache e monta faticosam e nt e fra bosc hi e prati, perco rre nd o molli viadotti. Bellissima vista sul la vale so tt os t ante e sulle lontane montagne coronate da ghiacc i. Ragg iun ge quindi la s ta7.io n e di Bad Gastcin in una posizione d e ll e più amene. li v illagg io è ri cco di belle ab itazi oni e num eros i alberghi e rinomato per le acque che in vicinanza vi scaturiscono. È una bellissima e frequentatissima stazione c limatica. La ferrov ia ripa ss a nu ova mente I ' Ach e; passa al la fe rmat a cli B ocks re in e quindi imbocca la gal leria dei T auern lunga 8500 metr i impiegando circa 10 minuti n el percorrer la. Subito dopo la galleria stazione di Mailnitz; la ferrovia di sce nd e il Mailnit z th a l c.:o n una s u cc.:essionc di tunnel e v iadotti. attraversa il Dossembach per passare nella valle di Moellthal.
Stazione di Obe r Vella c h poi qu e lla di Penck e dopo s i a trraversano n ove v iad o tti e du e tunn e l fino alla s t azione di Spittal ove la ferrovia raggiunge quella del Pm,te rthal.
Le s t azio ni so no tutt e ben costruite e provviste larga m e nt e cli m ezz i e così pure le opere d'a rte c h e o hann o il doppi o binario o n e pe rm ettono il co ll oca m ento. li grande tunn el ha gi~t il doppio binario.
Nel g iro fatto h o cercato di raccogliere quanti più dati mi fu possibile in pubblicaLioni e car to lin e ccl h o tutt o dis posto nello schizzo che fa seg uito. Fra le n o tiLi e e dati raccolti vi ha pure qu e ll a d e l la es is te n za cli un a s ta z ione elc llri ca aJlo sbocco del D ossengraben a m e t à circa de ll a distanza fra le due stazio ni di M a ilnit z ed Ober Vellach. elio sc hi uo v i è appos it a cartol in a. P robabilmente la s ta z ion e se rvir à pe r l ' impianto e le ttri co d e ll e stazioni e d e l tunnel, nonché per a lim e ntare la co rrente d"aria nel tunnel grande.
L a sera ciel 13 pernottai a Spittal e nel giorno s u ccessivo ripres i la via ciel Pu s te rthal in ferrovia fino ad Inni c h e n , quindi in ve ttura a Bruneck per osservare meglio la ferrovia. e poscia n u o-
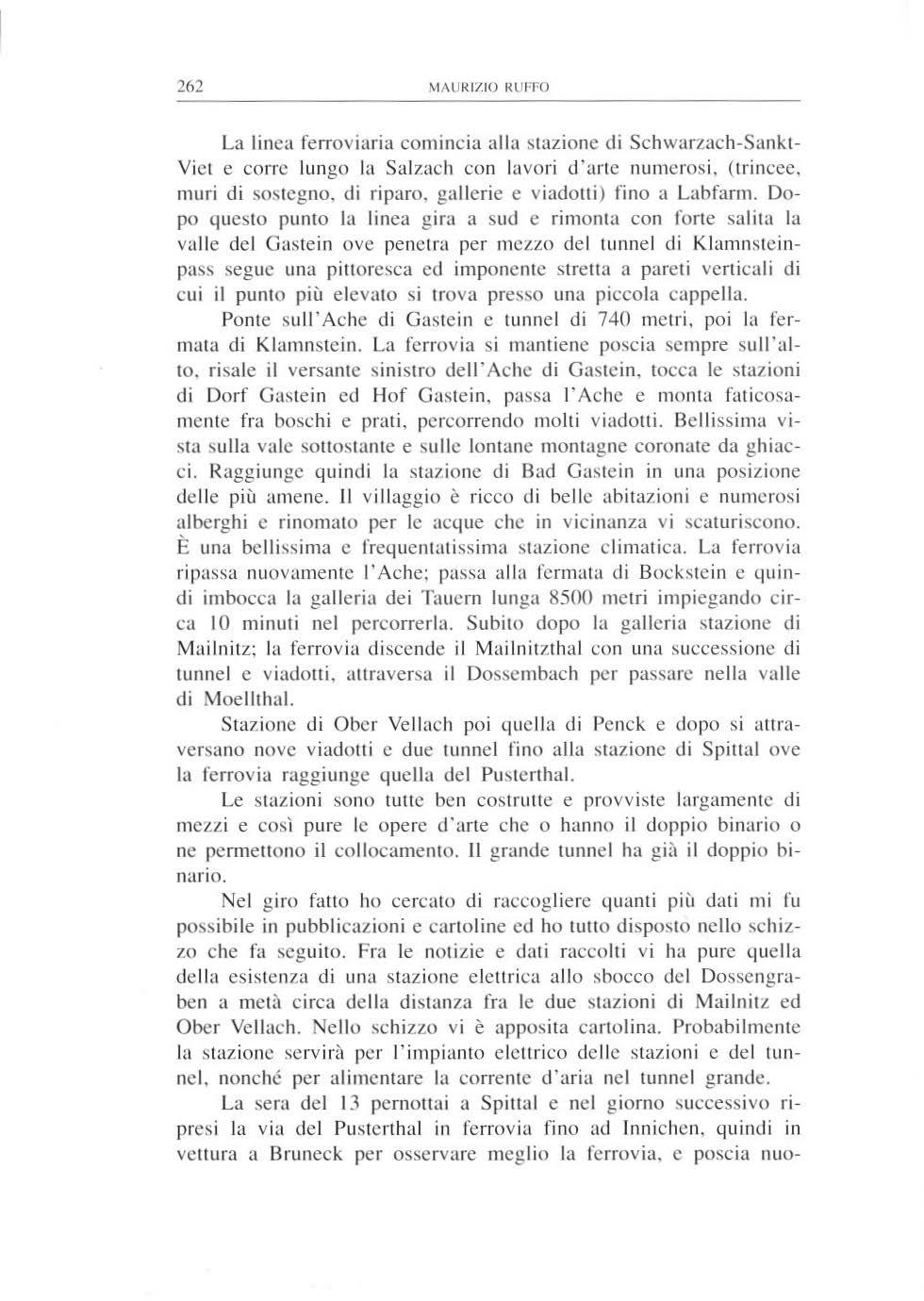
vamente in ferrovia fino a Verona ove giunsi alla sera senza incidenti di nessun genere. Per tal modo percorsi due volte la linea del Pusterthal e potei formarmene un'idea abbastanza completa.
LINEA DEL PUSTERTHAL - Come si è accennato nella ricognizione i punti che meglio si prestano a ll a interruzione sono quelli compresi tra Bruneck (Brunico) e Welsberg (Monguclfo) cioè i tunnel ccl il ponte cli Percha (Perca) su ll a Rienz (Ricnza) che si trovano a portata delle comunicazioni provenienti dalla val Cordevole per val Badia, comunicazioni che dopo S. Martino si stendono a ventaglio fra Bruneck (Brunico) ed Olang (Valdaora).
Sono certamente lunghe le vie da percorrere al di là della frontiera, ma seguendo questa zona e la comunicazione dinanzi accennata si ha il vantaggio di essere ali 'infuori dei forti ed in un paese montano ove la marcia di uomini e drappelli può agevolmente dissimularsi. D'altra parte una interruzione nei punti indicati sarebbe efficacissima e toglierebbe l'us o del la ferrovia per molto tempo, perciò i rischi e le difficoltà del l 'operazione sarebbero largamente compensati.
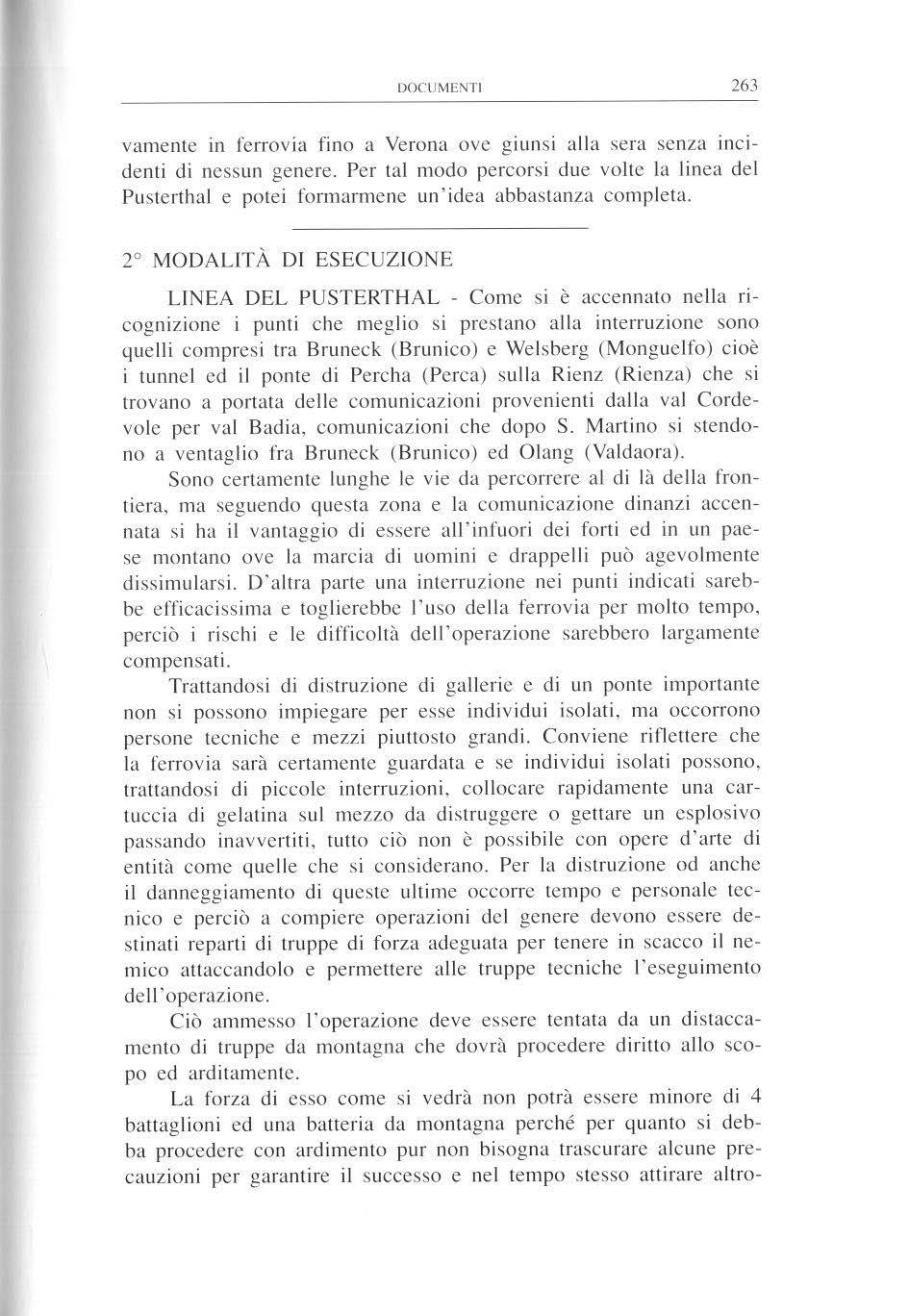
Trattandosi cli distruzione di ga ll erie e cli un ponte importante non si possono impiegare per esse individui isolati, ma occorrono persone tecniche e mezzi piuttosto grandi. Conviene riflettere che la ferrovia sarà certamente guardata e se individui isolati possono, trattandosi di piccole interruzioni , col locare rapidamente una cartuccia di gelatina sul mezzo da distruggere o gettare un esplosivo passando inavvertiti, tutto ciò non è possibile con opere d'arte di entità come quel le che si considerano. Per la distruzione od anche il danneggiamento di queste ultime occorre tempo e personale tecnico e perciò a compiere operazioni del genere devono essere destinati reparti cli truppe di forza adeguata per tenere in scacco il nemico a ll accandolo e permettere alle truppe tecniche l'eseguimento del l'operazione.
Ciò ammesso l'operazione deve essere tentata da un distaccamento di truppe da montagna che dovrà procedere diritto allo scopo ed arditamente.
La forza di esso come si vedrà non potrà essere minore di 4 battaglioni ed una batteria da montagna perché per quanto si debba procedere con a rdim ento pur non bisogna trascurare alcune precauzioni per garan tire il successo e nel tempo s tesso attirare altro -
ve l'atte nzion e del nemico. Una pa rt e adunque della forza sara indi s p ensa bil e lasciare indietro in p osizion e opportuna pe r appoggiare il movim e nto dell a co lonna ed agire seco nd o il bisogno. La colonn a operante sa r à pe r ciò ridott a a solo 3 battaglioni e l a batteria.
In apposito a ll ega to trovasi lo s tudi o di questa operazione. E sicco me per essa s i richi ede un a marcia celere e lun ga si è dovuto limitare 1' obiettivo all a distruzione d e ll a so la ga ll eria principale e del ponte cli Perc ha (Perca), tra lasc ian d o le al tre tre che s i trovano all'infuori d ella com unica z ion e diretta Corvara-Bruneck (Bruni co) e che ri c hi ede rebbero maggiori fatic h e per parte delle truppe.
P er la distruzione degli a ltri punti lun go la lin ea fino a Lienz non occonono, a pare mi o, distaccamenti e le operazioni relative possono co mpiersi da indi vidui pra ti c i ( min atori, muratori, ecc.) c he mu nit i delle cariche occorrenti tentino il colpo a momento propizio deludendo la sorveg lian za o sac rifi ca nd o qualcu no se è necessa ri o. per qu es ti uomini arditi e scalt ri non è oppo rtun o fi ssare la s trada o le s tra de che debbono te n e r e p e r raggiungere lo scopo m a anzi co n v ie ne lasc i a re loro la sce lta della via più breve ed occ ult a. Sono qu este operazioni da partigiani nelle quali deve pr eva lere l'as tu z ia a preferenza di og ni a ltra qualità, lasciamo dunqu e ad essi li bertà di azione in modo c he possano procedere rapidi e di s simulare i l più poss ibil e la lor o presenza. Anzi credo c he l 'esegu ime nto di queste mi ssioni possa meglio riuscire impiegando uomini già residenti nello stato limitrofo perché possono meg li o osservare ed agire a l mom e nto propizio.
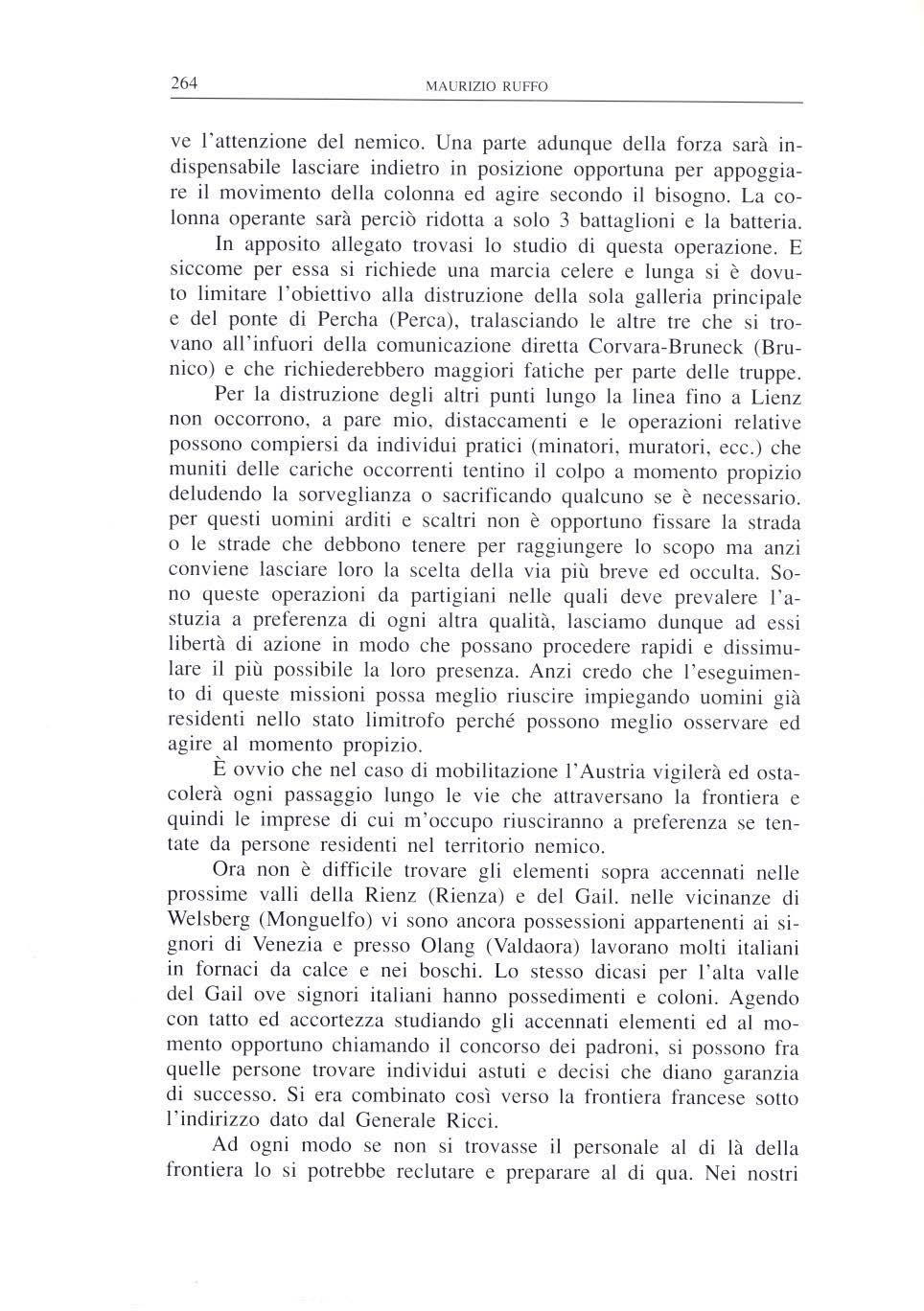
È ovv io che nel caso cli mobilita zione l'Austria vig ilerà ed ostaco le rà ogni passaggio lu ngo le vie che a ttra ve rsa no la frontiera e quindi le imprese di cui m'occupo riusciranno a preferenza se tenta te da pe r so ne resid enti n e l territorio nemico.
Ora non è difficil e trovare g li e le me nti sopra acce nn a ti nelle pro ss ime va lli de ll a Ri e n z ( Rienza) e de l Gail. ne lle v icinan ze di Wel s berg (Mo ng ue lfo ) vi so no a ncora possessioni a pparte nenti ai s ignori di Vene z ia e presso Olang (Valdaora ) la vo ran o molti italiani in fornac i da calce e ne i bosc hi. L o s tess o dica s i per l'alta va ll e del Gai! ove s igno ri italiani hanno possedimenti e co loni. Agendo con tatto ed accor tezza st udiando g li accen nati e lement i ed al momento oppo rtun o c hi aman d o il co ncorso dei padroni, si possono fra qu e ll e persone trovare individui astu ti e decisi che di a n o g ar anzia di s uc cesso Si era combinato così ve rso la frontiera francese so tto l 'indirizzo dato dal G e n era le Ri cci.
Ad ogni modo se non si trova sse i I personale a l di là della frontier a lo si potrebbe rec lut are e preparare a l di q ua. Nei nostri
paesi di confine tra i nostri alpini in congedo ed anche tra g li altri operai che vanno a lavorare a ll'estero tutti gli anni, possiamo trovare \' e lemento abile e s icuro. Anche in questi giorni ho avuto proposte da graduati in congedo di Falcade, che conosco personalmente. di cui uno principalmente abi lis simo, intelligente e capace di tutto. Sugli accennati elementi, che si trovano a nc he in Cadore. s i può fare s icuro assegnamento; basterà prescegliere quelli che si prestano, impiegarli a qualche gita per assumere informazioni senza far loro cap ire quello che sara nno destinati a fare, tenerne nota a llettarli con gratificazioni ed a l momento opportuno inviarli sul sit o - meglio se in precedenza - per fa r e il colpo. Occorre dunque pazientare per qualche mese e studiare con tatto il personale tanto fra i residenti all'estero quanto fra quelli dimoranti all'interno.
Esaurito rutto ciò che riflette il personale. stimo necessario per completare il lavoro in modo pratico, accennare al come dovrebbero praticarsi le interruzioni a ll a disposizione delle cariche ed al conseguente loro brillamento.
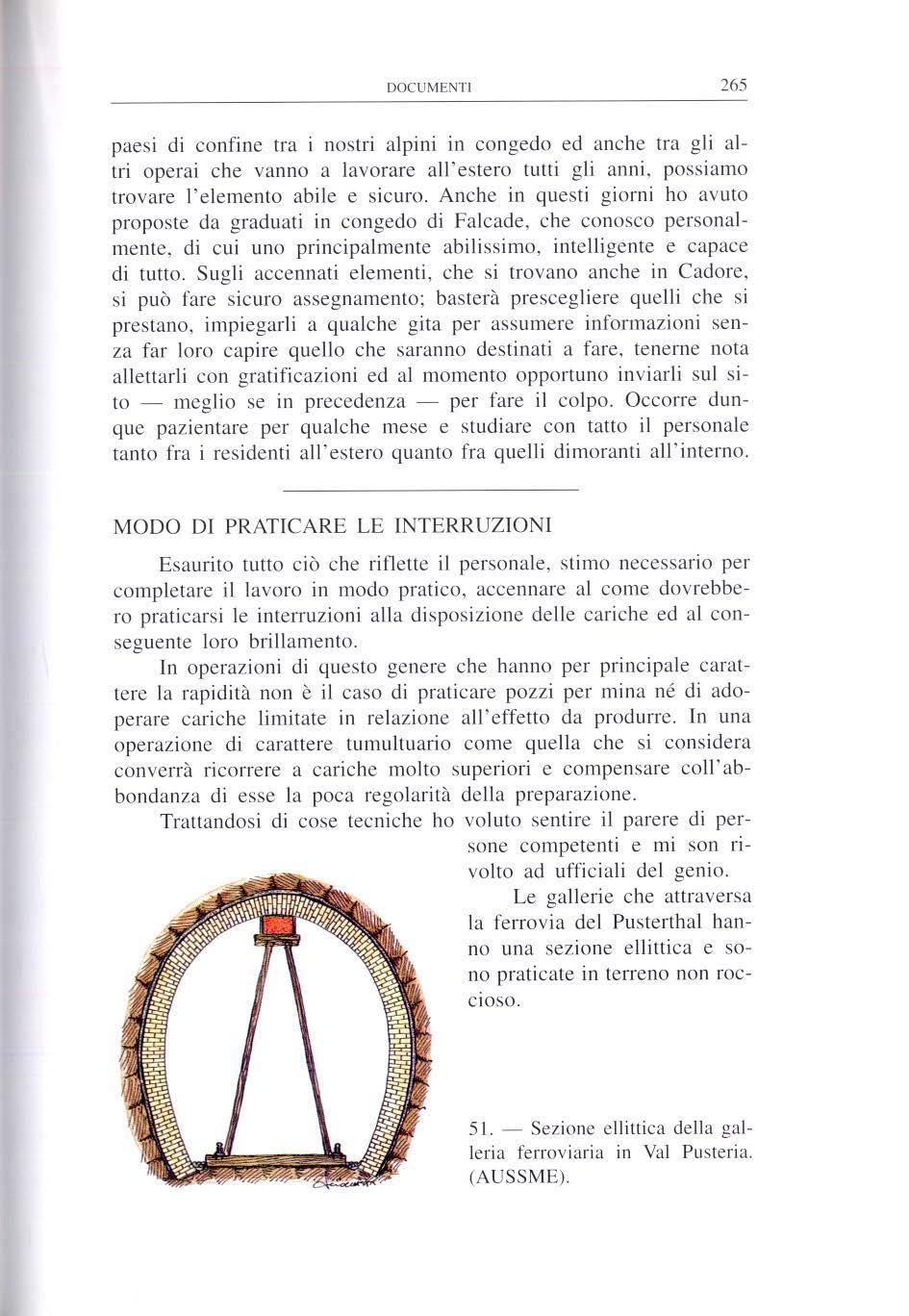
In operazioni di questo genere che hanno per principale carattere la rapidità n on è il caso di praticare pozzi per mina né di adoperare cariche limitate in relazione ali' effetto da produrre. In una operazione cli carattere tumultu ario come quella che si considera converrà ricorrere a car iche mo l to s up e ri ori e compensare coll'abbondanza di esse la poca rego larità della preparazione.
Trall andosi di cose tecniche ho voluto sentire il parere di persone competenti e mi son rivo lto ad uffi c iali del ge ni o. Le gallerie che attraversa la ferrovia del Puste rthal hanno una sez ion e e llittica e sono praticate in terreno no n roccioso.
5 l. - Sezione ell itti ca della galleria ferroviaria in Val Posteria. (AUSSME).
Un mezzo c he s i c red e att o pe r far saltare il rive tim e nto e precipitare il terreno so prastante co ns iste nel disporre co ntro il cielo della ga lleria e lun go il s uo asse a dis tan za di I O in I O metri caric he di 50 kg. og nuna di gelatina. puntellandole fortemente, come vedesi nella figurn accanto, e produrn e il brillame nto simultaneo. I punte lli s i rinvengono facilmente s tante ("abbondanza del leg name c he è s ul pos to.
Prati ca nd o intasamenti migliori gl i effetti possono essere cons id e revo li e c iò non è difficile o tt e ne re, essendo proposte per q ue lle interru z ioni truppe tec ni c he.
Per il ponte di Percha si ritiene che fin dalla sua costruLione s i s ia p e nsa to alla inte rruzion e praticand ov i po zz i da mina ccc. ccl in tal caso le truppe tecniche potranno facilmente rintracciarli e collocarvi g li es pl os iv i facendolo brillare contemporaneamente. Ma se ciò non fu fa110 bisogne rà adottare me zzi sped iti vi pe r far sal tare le due travate metalliche ed il pilone ce ntrale che le sost iene. Siccome la distruzi o ne s i s uppon e affidata a truppe tecniche s tim o inuti le scendere a eiettagli ma trattandosi di un ponte lungo e so lido non vi vorranno meno di 70 kg. cli ge latina per i trali cc i e 50 pe r il pilone cen trale. In ci fr a tonda due quintali.
La co lonna o perante non dovrebbe pe rc iò avere me no di quattro quintali di es plo s ivo per co llo ca re 4 casse tt e cli 50 kg. ognuna nella galleria come s i è accennato precedentemente.
Si intend e c he la ge latina dovrebbe essere di spos ta in precedenza in ap pos ite casse tt e per la galle ria e d in apposi ti sacchi o s alsicciotti per la ro ttura de l po nte.
Per il brillamento si multan eo sare bbe indicata raccen ione elettri ca od in mancanza la miccia detonante.
l ponti accennat i nella ri cog ni z ion e all'infuori di 4uello di Pcrc ha sono tutti in ferr o ad una so la ca mp at a ed a tra va ta retti lin ea così compos ti:
le du e travi maestre constano ciascuna cli due bri g li e principali a T compos te di piastre riunite con chiodi ribaditi e di un trali ccio le c ui s barre es te rne so no costituite da fe rri a T e le interne eia se mpli c i lamiere:
il binario che a 11 ravc rsa ogni ponte è sosten uto da traversoni in fe rro a doppio T.

Ora sentito il parere cli persone tecniche per distruggere ponti ciel genere bisogna in ognuno produrre la rottura su l mezzo della trave in fig. I " disponendo le cariche come vedesi nella figura 2 " e 3".
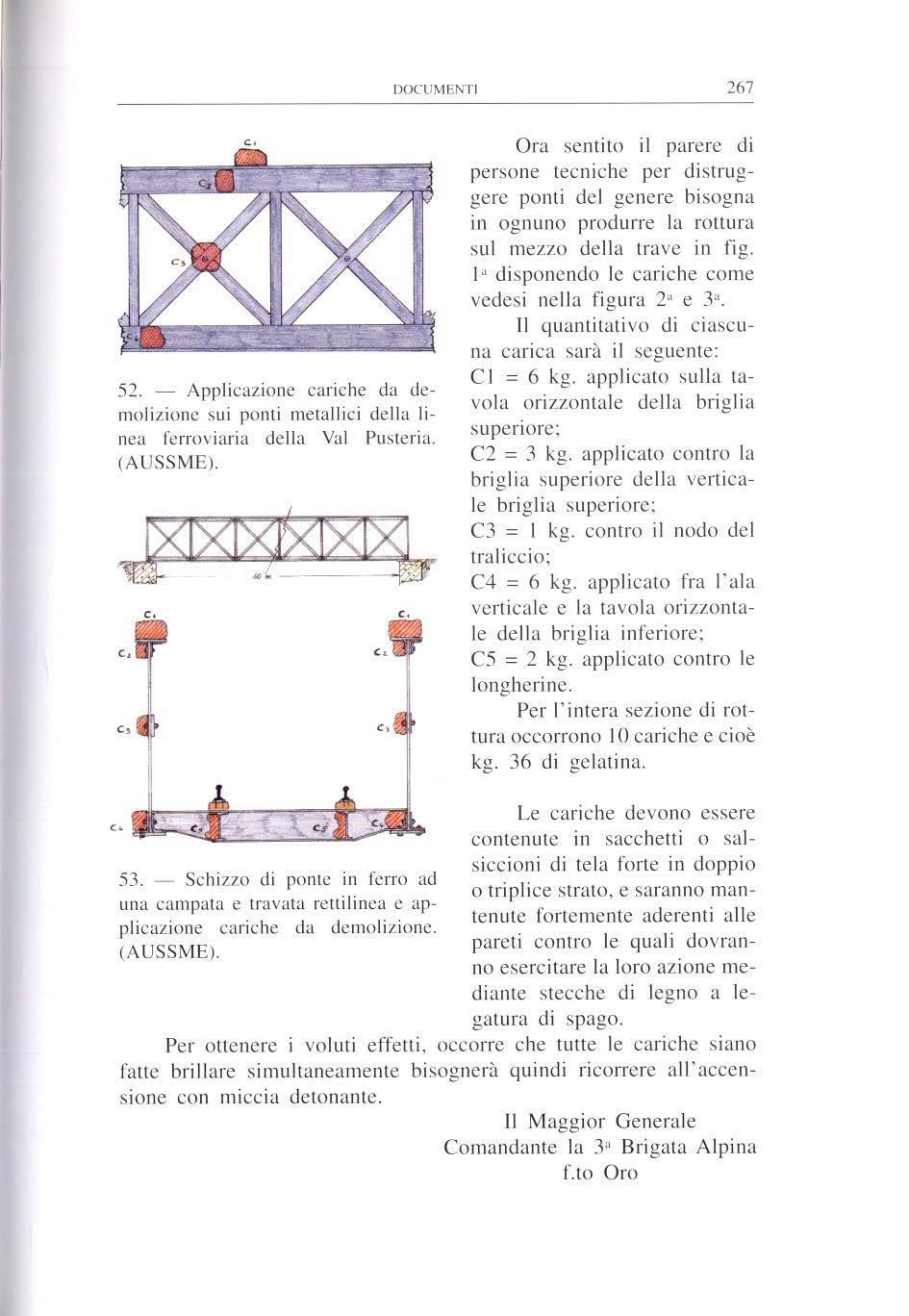
TI quantitativo cli ciascuna carica sarà il seguente:
CI = 6 kg. app lic ato sulla tavo la orizzontale della briglia superiore;
C2 = 3 kg. app li cato contro la briglia superiore del la verticale briglia superiore;
C3 = I kg. contro il nodo ciel traliccio:
C4 = 6 kg. applicato fra l'ala verticale e la tavola orizzontale della briglia inferiore:
CS = 2 kg. applicato contro le longherine. Per l'intera sezione di rottura occor rono I O cariche e cioè kg. 36 di gelatina.
Le cariche devono essere contenute in sacchett i o salsiccioni di tela forte in doppio o t ripli ce strato, e saranno manten ut e fortemente aderenti al le pareti contro le quali dovranno esercitare la loro azione mediante stecche di legno a legatura cli spago .
Per ottenere i voluti effetti, occorre che tutte le cariche s iano fatte brillare simu lt aneamente bisognerà quindi ricorrere a ll'accensione con miccia detonante.
II Maggior Generale
Comanda nt e la 3" Bri gata Alpina f.to Oro
COLPO DI MANO SU BR UNECK CON LO I NTENTO DI DISTRUGGER E T MODO EFFICACE L A FERROVIA DEL PUSTERTHAL ALLA GA LL ERIA DI LAM PR ECHT E SUCCESSIVO PONT E DI PERCHA
La operazione da compìere rìchìed c - no n vi può esse re dubbio - periz ia ed ard ìmento in sommo grado nel capo, devozi one senLa eccezione nei gregarì. È cioè una di quelle operazioni la cui riuscìta dipende esclusivamente dall'animo decisamente deliberato di tutti di vìnce re q ual unqu e ostacolo e co rrere d ritti a ll o scopo. la benché minìma ìncerrczza la farrebbe fallire e perciò occorre che la scelta del capo sia i n precedenza tabilita e che il medesìmo abbia perfe tt a conoscenza dei luoghi, conosca e sia conosciuto dal persona le che lo dovrà seg uir e. Una operazione dì questo ge nere non può ìnteramente essere improvvisata. bìsogna ìnvece sia prevista ìn ogni parti co lare dal capo che sia prepa rato a co mpierla con s icura coscienza. Ma ne ll o s tesso tempo occorre mantenere i I pìù scrupoloso segreto ed avere persone fidatissime e devote che a te mp o opportuno sapp iano dare in tempo in formazion i al riguardo della dìs locaz ione de ll e truppe avversarie e s ulla vig il anza che viene eserc it a ta sulla linea da interrompere.
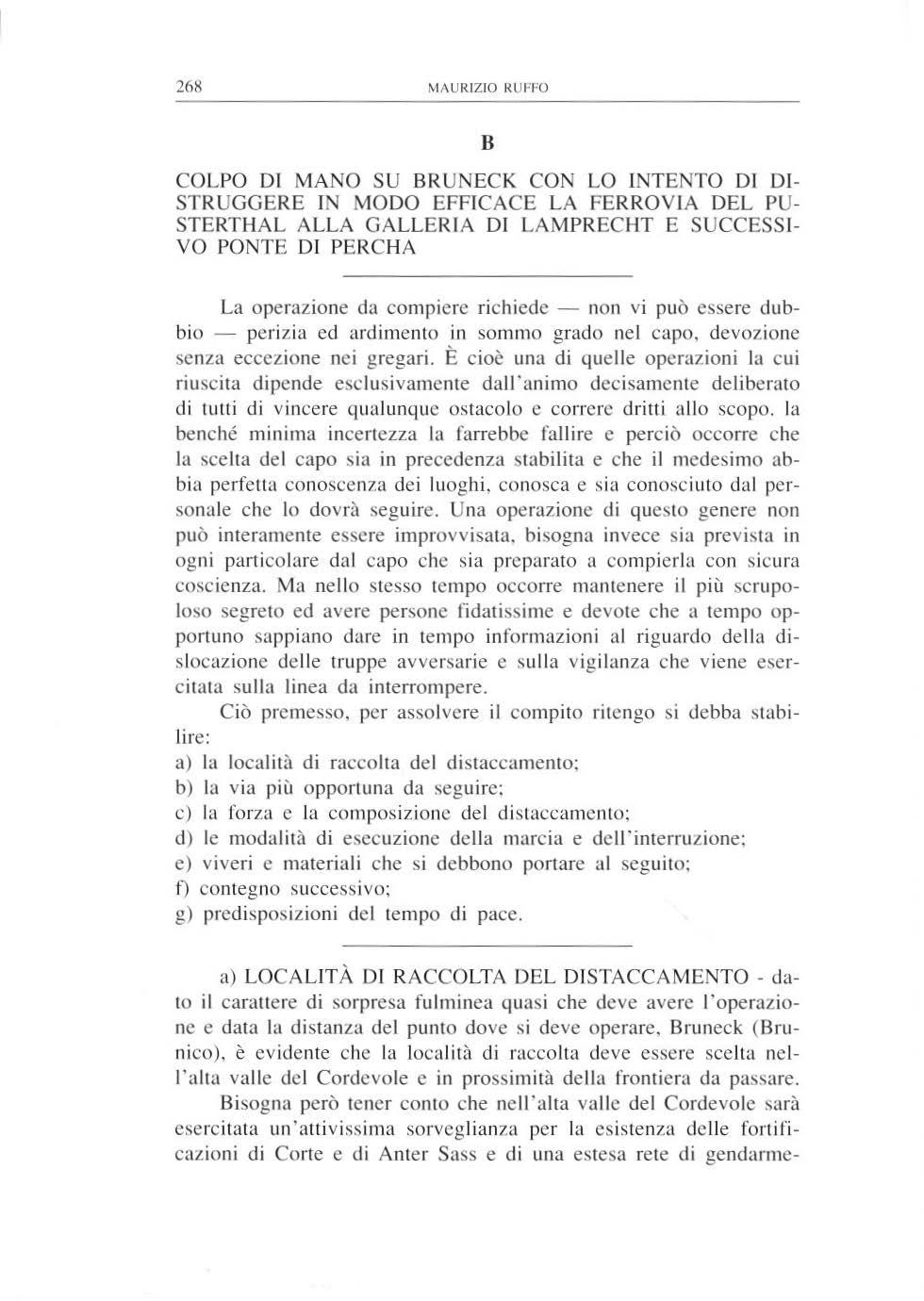
Ciò premesso, per assolvere il co mpito rìtengo si debba s tabìli re:
a) la località di raccolta del distaccamento;
b) la via più opportuna da seguire:
e) la forza e la composizio ne del d is t accame nt o;
cl) le modalità di esecuzione della marcia e dell'interrut.ione:
e) viveri e materiali che s i debbono portare al seg uit o;
f) co nt eg no s uc cessivo;
g) predisposizioni del temp o cli pace.
a) LO CA LIT À DI R ACCO LTA DEL DISTACCAMENTO - dato il carattere di so rpresa fulminea quas i che deve avere I 'operat.ìone e data la distanza del punto dove s i deve operare, Bruneck ( Bruni co), è evide nte che la località di ra ccolta d eve essere scelt a nell'alta valle del Cordevole e in pros imità della fronti era da pas~are.
Bisogna però tene r conto che nell'alta va ll e del Cordevole sarà ese rcitata un 'a tti v issima so rveg lian za pe r la es istenza de lle for tificazioni di Corte e di Anter Sass e di una estesa rete di gendarme-
ria, per cui la località che si presceglie deve essere al coperto dalle osservazioni ed altresì essere tale che consenta di pervenirvi senza destare sos petti
La regio n e denominata Malga Sotto Ciapela nell'alta va ll e Pe ttorina, affluente di destra del Cordevole, si ritiene risponda abbasta n za bene. È zo n a che giustifica la prese nza di truppe tenendo incerti s ul compito ad esse fissato perché prossima a passi di confine importanti - Padon Fedaia, Ombretta , F orca Rossa Valfredda - al coper to dalle possibili offese del forte Corte ed altresì daUa vigi l anza; infine vi si può pervenire senza che sia notato il movimento da Forno di Canale per la forcella Pi anezze.

Si aggiunga c he è una zona dove si trovano mo lti fienili atti al rifugio de ll a truppa, con che anche se il ter reno fosse coperto da neve è possibile il sogg iorno per qualche giorno.
b ) VIA DA SEGU IRE - La linea più di r e tta fra l'a lto Cordevole e Bru neck (Bru ni co), sarebbe la Sotto Ciapela, T abià sotto Quoze n , Ornella, Arabba. Campo longo e val Badia, ma la intercetta il forte d i Co rt e e d'altra parte è così in vista c he qua lsiasi movimento anche notturno, sa rebbe presto notato e segnalato a Bruneck ( Brunico) a mezzo del telegrafo e del telefono. Co nv ie ne perciò escl ud erla e agg irare la testata del Co rdevo le, scendendo in va l Bad ia a Corvara - vedasi il grafico rettifica to e quello prospetticocosa che non è difficile e per le condizio ni della strada assai buone ed altresì perché n o n si a ttra versano che d ue s ole loca lit à abitate - Ca na ze i e Plan - le quali per esse re in val di Avisio e va l Gardena possono g iovare a sviare anche meglio il sospetto dell ' avversar io , facendo ritenere il movimento - se s m ascherato - tendente all 'Av isio e all'Ad ige.
Le co ndi z ion i d e ll a strada so no ottime e l ' itinerario è tanto determin ato eia doversi escludere incertezze s ulla via da seguire, né so no ragio nevo lm e nt e prevedibili se ri os t acol i perché , al meno fino al g iorno d'oggi, non ri s ult a g li aus tri ac i abbiano por ta ta la loro attenzion e su questa s trad a c he p ur rapp resenta una ve r a minaccia sia nei riflessi di un aggiramento dello sba rram en to di Corte , s ia per un co lp o cli mano su ll a stretta di Kla'usen (Chiusa) per val Gard ena co n identico intento di distruggere la ferrov ia .
c) FORZA E COMPOSIZIONE DEL DISTA CC A MENTO - Per determinare questi elementi cli fatto bisogna cons id erare le res is te nze c he prevedibilmente posso no in con trars i. E nat uralm ente bisogna
escl ud ere che l' avversar io con mobilitazione occu lt a, abbia potuto far affluire trupp e e mezzi più di qu an ti norma lm e nte vi tiene.
Secondo le più recenti informa z io ni not e a que s to co mando , g li austriaci hann o in se d e un battag li one d c li ' E.C. con sezione di mitragliatr ic i ed una batteria da m on t ag n a fra Bruneck ( Bruni co) e S. L o rcnz ( S an Lorenzo di Se ha t o), a ltro battaglione dell'E.C. con s ezion e mitragliatrici fra Ni e derdorf ( Villabassa) e Tobl ach ( Dobbiaco). un battag li one di L ande r schu t7en co n sezione mitragliatrici ad Tnni chen (San Ca ndid o). a Fran ze n sfcstc ( Fortena) artiglieria da fortez7a.
Franzensfeste
Niederdorf
Toblach
Le di s tan ze fra Brun eck e le g ua rnigioni vicine sono le seg ue nti : da Br uneck a id . id id
l nnichen
km. 30; km. 24; km. 30; km. 35.
Qui occorre considerare du e ipotesi e cioè che il nemico possa aver se ntore della mar cia del di s ta ccame nto quando qu es t o perviene in V. Badia per non essere riu sc iti ad int e rcetta re le lin ee telegrafiche e telefoniche a mezzo di qualche emissario mandato in precedenza per tale ufficio. o pure che la marcia fino alla stretta di Month a l possa rimanere occu lt a.
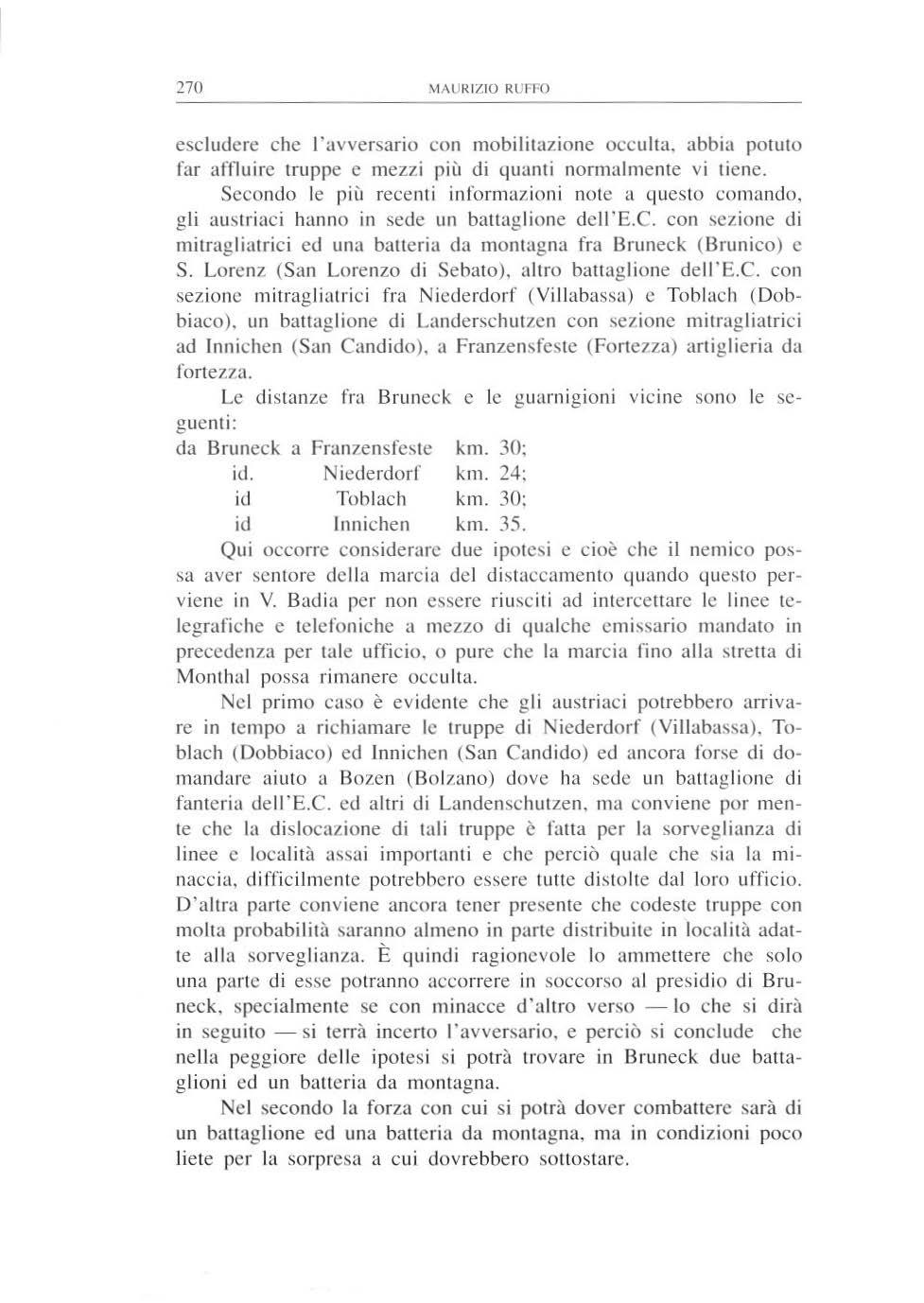
Nel primo caso è ev id e nt e che g li au st ri ac i po tr ebbero a n-i vare in tempo a richiamare le trupp e di iederdorf (Vi ll abassa). Toblach (Dobbiaco) cd lnni chen (San Candido) ed a ncora forse di domandar e aiu to a Bo zc n (Bo lza no) dove ha sed e un battag lion e di fanteria de l 1' E. C. cd altri di Landenschutzen, ma co n v ien e por mente che la dislocazione di t ali truppe è fatta per la sorveglianza di linee e loca lit à assa i imp or ta nti e c he perciò qu ale che s ia la minaccia, difficilm e nte potrebbe ro esse re tutte di s to lt e dal loro ufficio. D 'altra parte convie ne a n cora tener presente c he codeste truppe con m o lt a probabilità !-.aran no alme no in parte di stribui te in loca lit à adatte a ll a so rveglian za. È quindi ragion evo le lo a mm e ttere c he solo una pari e di esse po trann o acco rrere in socco rso a l presidi o cli Brunec k. spec ialme nt e se co n minacce d'altro ve r so - lo c he s i dirà in seg uito - s i te rr à in certo l 'avve r sario, e perciò s i co n clude che nella pegg iore d e l le ipotes i s i potrà trovare in Bruneck du e battag lioni cd un balle ria da montagna.
Nel seco ndo la forza co n c ui si potrà dov e r co mbatte re sa rà di un batt ag lione e d una batt e ria da monta g na, ma in condizioni poco liete pe r la so rpresa a cui dovrebbero s o11ostare.
Ma per determinare la forza del distaccamento queste considerazioni non so no suff ic ienti; bisogna ancora por mente alla necess ità di provvedere anche ad un a ce rt a sicu rezza del riparto che opera poiché, pur ammesso che l'operazione s ia di quelle in cu i si g iu oca con proposito fermo i I tutto per tutto, non si può a meno di occupare qu alche punto di pecu li are imp orta nza. E d'altra parte per esercitare qualche minaccia, impressionare e sgomentare le popolazioni delle va lli vicine in guisa da gettare l'allarmi in località diverse e assai distanti da q uella ove si vuol operare, conv iene avere forza a disposizione.
Tenuto conto delle possibil i resistenze nelle due eventualità esaminate ed altresì delle altre co n s ideraz ion i fatte a l riguardo, pare che il distaccamento dovreb be avere la forza di 4 battaglioni a lpini ed una batteria da montagna; una forza minore sarebbe insufficiente, una forza maggiore sove rchia, perché la marcia deve essere celer issima, la qual cosa è difficile ottenersi quando la colonna sia pesa n te .
Si tratta però di operare una distruzione con impiego di esp los iv i e perciò, pur essendovi fra le truppe alpine g li zappato ri che cli tale impi ego sono impratichiti fino dal tempo di pace, si opina c he al distaccamento dovrebbe essere aggiun t a una compag ni a cli minator i del genio
cl) MODALITÀ DI ESECUZIONE - li distacca m e nt o deve essere raccolto in precedenza nella co nca di Forno di Canale. La s ua presenza p uò esse re notata ma ciò non nuoce, poiché i vicini passi di San Pellegri no, Va ll es, Fiocobon e Mula z con obiettivo il medio Avisio possono trarre in inganno l'avversario il qu ale d 'a ltra parte no n può a meno di g iust ifi ca re la presenza di t rupp e in tale regione c he è della massima importanza anc he ne i rifl essi difensivi.
Una volta decisa in ma ss ima l 'operaz io ne, il distaccamento dov rebbe trasferirsi nella zona di Malga Sotto Ciapela passando al coperto per la forcella Pianezze , st rada che è mulatti e ra in buone condizioni in tutto il suo percorso. TI movimento dovrebbe essere fatto possibilmente all'occulto e si dovr e bbe ro pre ndere le misure necessa ri e per i mpedire le indiscrezioni. Ai riparti stessi dovrebbe essere tenuto occu lto lo scopo finale, da farsi noto so lam e nt e al momento di pa ssa re l a fro nti era
O ve si raccog l iesse il di s ta ccamen to nella conca di Caprile anziché a Forno di Cana le s i avrebbe be nsì un trasfe rim e nto assai più brev e per g iun ge re a Sotto Ciap e la, ma non è consig l iabi le farlo
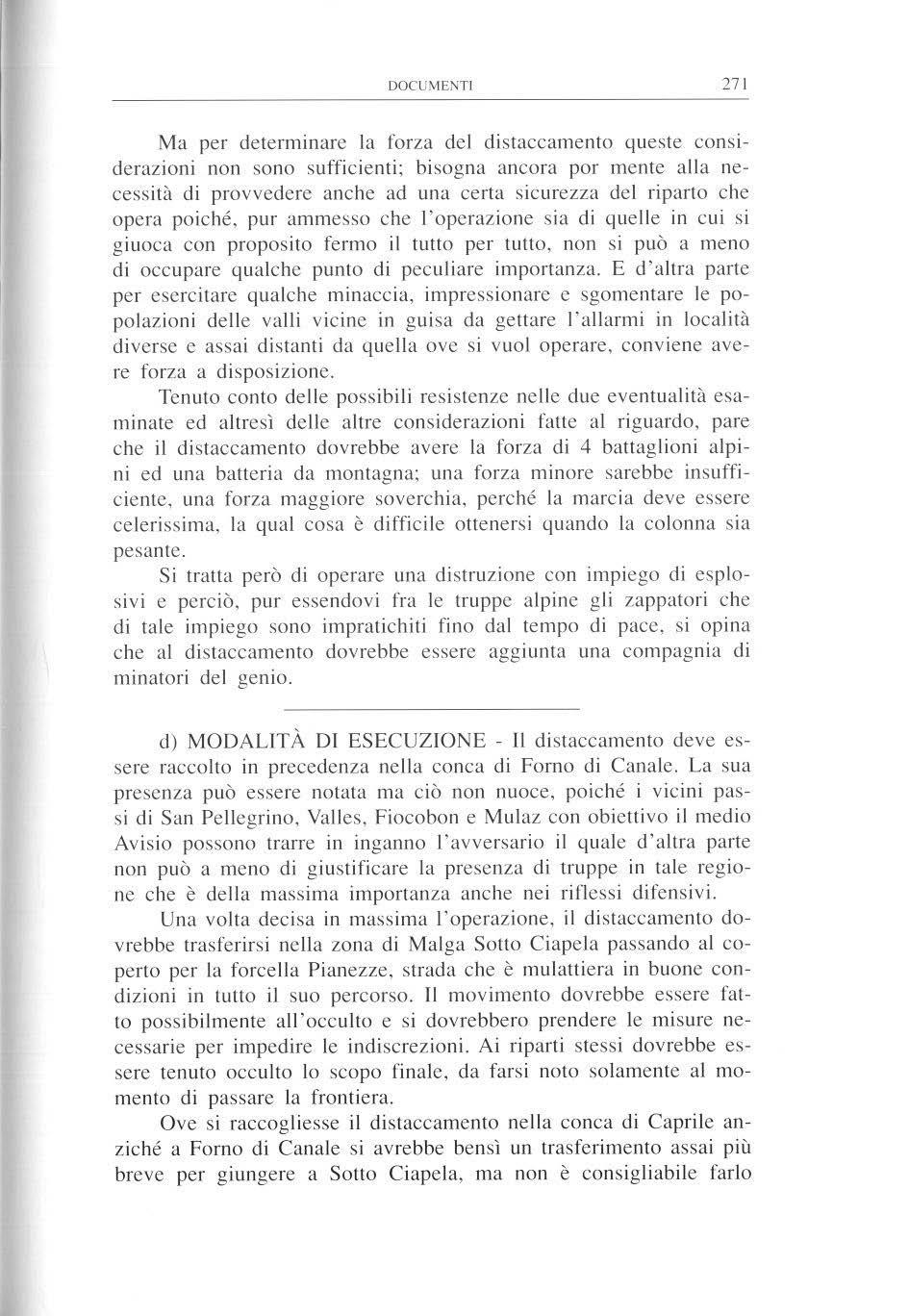
perché segnerebbe una minaccia ver o nord e provocherebbe una più attiva sorveglianza da questa parte.
A Mal ga Sotto Ciapela il distaccamento dovrebbe sostare breve te mpo in attesa dell'ordine definitivo e per provvedere ai rifornim e nti necessa ri da predisporsi fino dal tempo di pace. L a sos ta non dovrebb e prolun gar si possibi lmente oltre un giorno e sarebbe opport un o spi ngere durante questa qu alche ricognizione a Forca R ossa per sempre più co nfermar e co n dimostrazioni l'intendimento di operare verso il pa sso di S. Pellegrino.
Decisa l'operazione il distaccamento dovrebbe m ettersi in marcia ve r so sera e spingersi il più celermente possibile nella regio ne di Pian passa ndo pe l passo di Fedaia, Canazei e Sell ajoc h. 11 percorso è di ore 7,45 con andatura normale. ma è possibile percorrerlo in tempo min o re quando la truppa sia senza zaino e i quadrupedi ridotti allo s tretto necessario.
A Pi an s'impone una sos ta di un paio d'ore almeno per far ripo are la truppa e rifocillarla.
Se il distaccamento parte alle 17 da Mal ga Sotto Ciapela. alla mezzanotte può esse re a Pian ed a lle 3 del mattino riprendere la marcia per Bruneck che dista c irca 9 ore. A Stem la colonna può sdoppia r s i perché esistono due strade che procedono parallele. la vecchia buona carrareccia e la rotabil e da recente co truita.
Il percorso è lungo ma non soverchiamente faticoso perché i di livelli sono piccoli; la truppe da montagna quando s iano allenate possono percorre rlo giungendo in buone co ndizioni per operare.
E di operare vi è bisogno s ubito contro le truppe c he certamente si incontreranno e dar tempo alle truppe tecni che di comp iere la distruzione del la galleria di Lamprecht e del pont e di Pe rc ha entrambi vicinissimi a Brunec k.
La operazione è, come si vede, assai difficile ma se si prendono tutt e le misure per farla rapidamente e in modo occulto, può essere tentata. Fra le misur e da prendere si consiglia :
l. farsi precedere da individui isola ti - possono essere gli esp loratori - per ta gl iare le linee tel egrafic he e telefoniche a Canaze i, a Pian , a monte e a val le di Corvara;
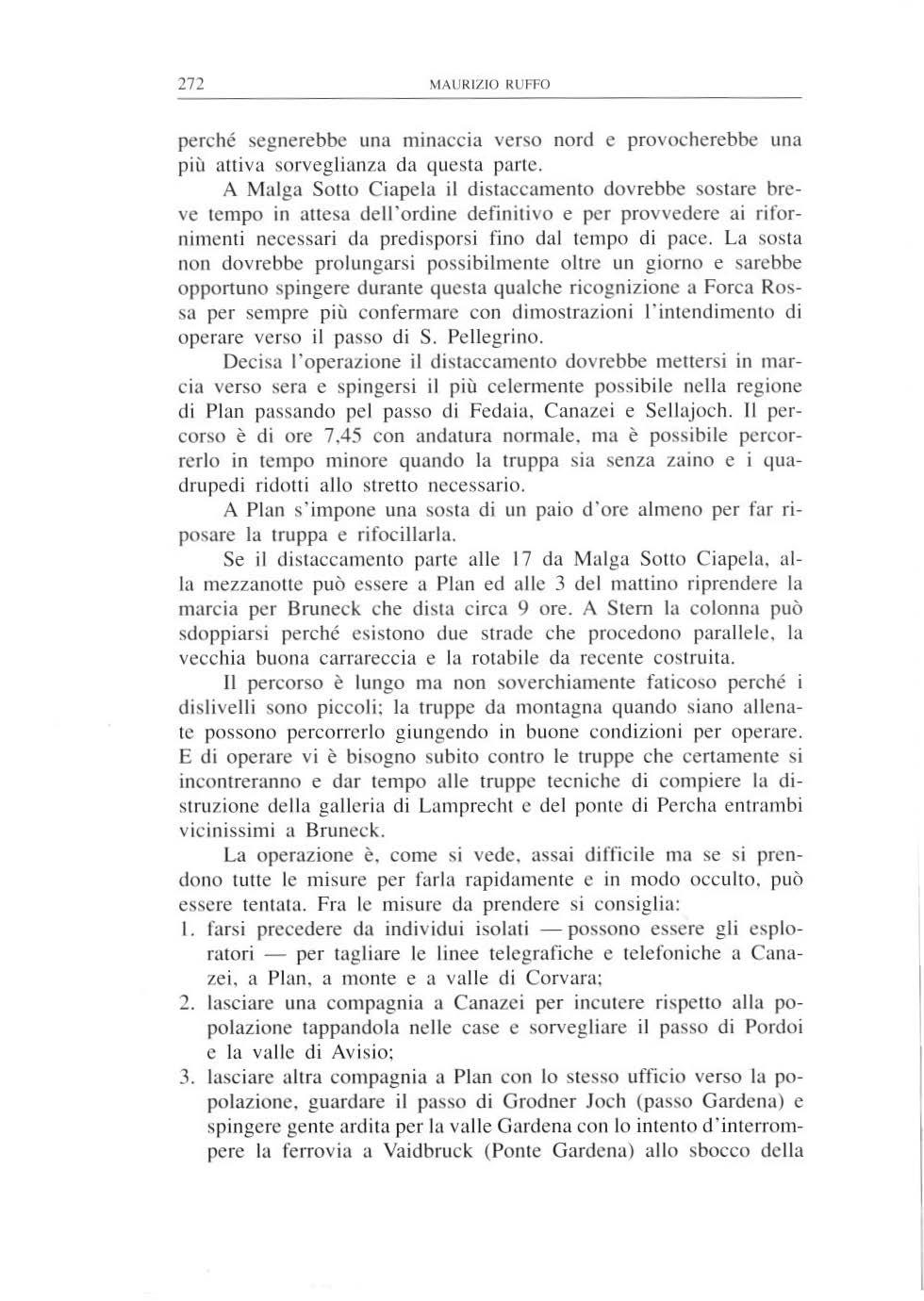
2. lasciare una compagnia a Canazei per incutere rispetto alla popolazione tappandola n e ll e case e sorvegliare il passo di Pordoi e la valle di Avi s io ;
3. lasciare altra compagnia a Pi an con lo s tesso ufficio ve r so la popolazione, guardare il passo di Grodner Jo ch (passo Gard e na ) e spingere ge nte ard ita per la va lle Gardena co n lo intento d'interrompere la ferrovia a Vaidbruck (Ponte Gard e na ) allo sbocco della
stretta di Klausen (Chiusa). Da Pian a Vaiclbruck la distanza non è che cli 22 km. cli buona rotabile e non vi è alcun presidio;
4. lasciare altra compagnia a Corvara sempre con lo eguale ufficio verso la popola zione e per guardarsi dalle provenienze di Campolongo.
Queste tre compagnie sono necessarie per garantire la via d el ritorno alla colonna ed a ltresì per richiamare l 'avversario s u altri punti.
Di peculiare importanza è specialmente la distruzione della ferrovia a Vaidbruck non solamen te pe r gli effetti materiali che s i potrebbero facilmente ottenere, ma altresì per I' allarmi che verrebbe gettato nella valle cieli' Adige al tergo del campo trincerato di Trento.
La regione di Pian , vasto campo pascolativo, è particolarmente importante per un'offensiva vigorosa, perché si ha modo dalla s te ssa di operare verso V. Badia, per V. Gardena e V. Adige e per I' Avisio ed è posizione che ha considerevole valore tattico essendo al coperto da ogni offesa anche indiretta delle fortificazioni e facilmente difendibile in caso di attacco. Per queste sue speciali condizioni si ritiene anzi che, sempre quando si coltivino obbiettivi offensivi verso il Trentino, debba que sta costituire uno dei primi obbiettivi da raggiungere.
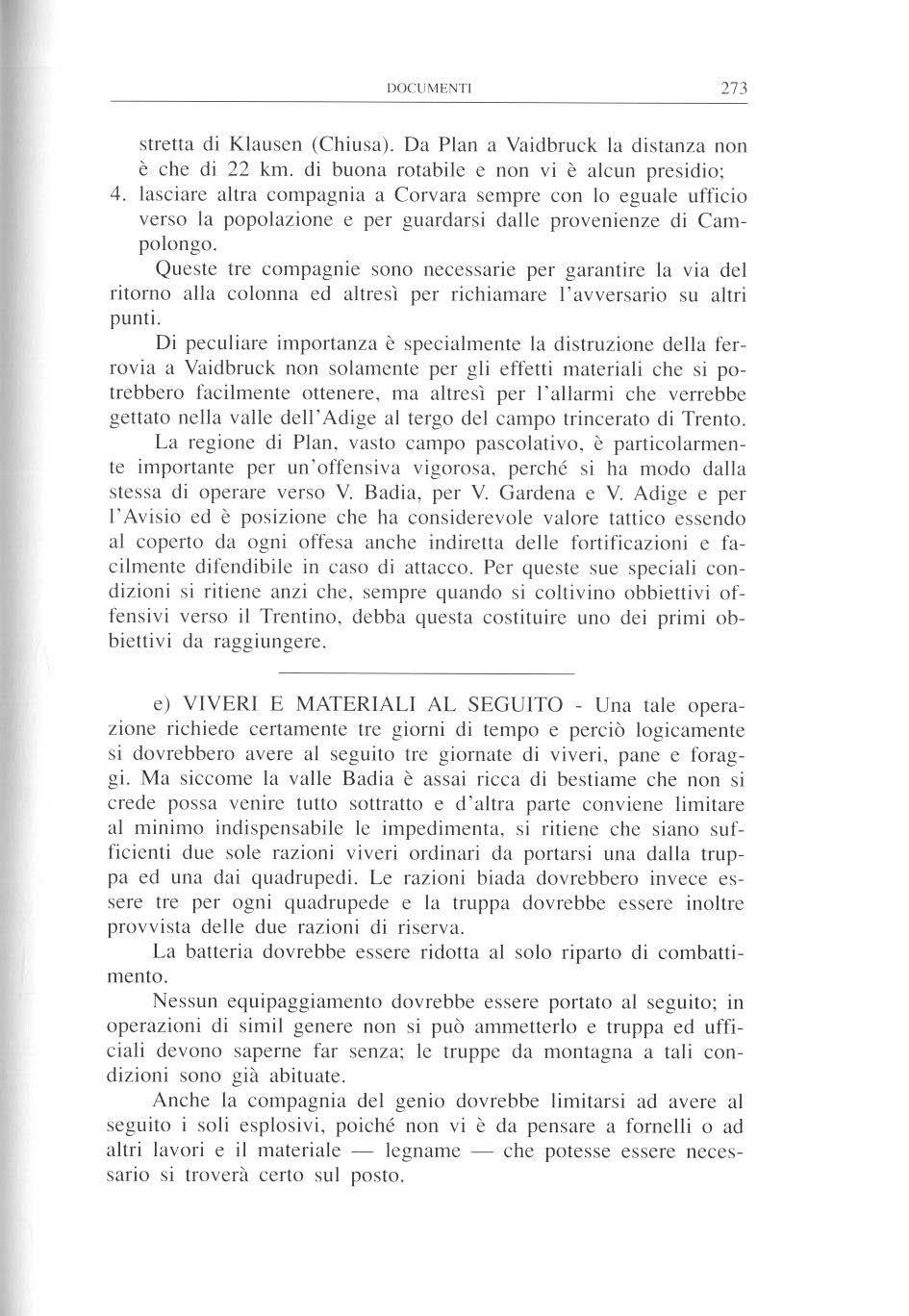
e) VIVERI E MATERIALI AL SEGUITO - Una tale operazione richiede certamente tre giorni di tempo e perciò logicamente si dovrebbero avere al segu ito tre giornate di viveri, pane e foraggi. Ma siccome la valle Badia è assai ricca di bestiame che non si crede possa venire tutto sottratto e d'altra parte conviene limitare al minimo indi spe nsa bile le impedimenta , s i ritiene che s iano sufficienti due sole razioni viveri ordinari da portarsi una da lla truppa ed una dai quadrupedi. Le razioni biada dovrebb ero invece essere tre per ogni quadrupede e la truppa dovrebbe essere inoltre provvista delle due razioni di riserva.
La batteria dovrebbe essere ridotta al solo riparto di combattimento.
Nessun equipaggiamento dovrebbe essere portato al seguito; in operazioni di simi I genere non si può ammetterlo e truppa ed ufficiali devono saperne far senza; le truppe da montagna a tali condizioni sono già abituate.
Anche la compagnia del genio dovrebbe lim itarsi ad avere al seguito i soli esplosivi, poiché non vi è da pensare a fornelli o ad altr i lavori e il materiale - legname - che potesse essere necessa rio si troverà certo sul pos to.
f) CONTEGNO DEL DISTACCAMENTO DOPO COMPIUTA
LA OPERAZIONE - È da riten ere c he la di stru z ion e d a operarsi richi e derà dalle 4 alle 5 ore, dopo di c he il di s tac ca mento dovrà s ubito ripie garsi s ulla st r e tta di Monthal che è a breve distanza da Brunec k e dov e si ha modo di resistere con poche trupp e ne l caso il ne mico vo lesse tentare qualche ritorno offensivo. Ma que s ta eve ntualità è da ritenersi poco probabile poiché trupp a sgomina ta eia una s orpresa impe tuo sa non conserva, in massima, attitudini offensive e pe rciò iI di s taccamento. pur se rbando contegno vigilante, potrà provvedere a ripo sar s i e rifocillars i. Nelle prime ore dell'alba però d ovrà riprendere la marcia e raggiungere la re g ion e di Pian che è locai ità che, come s i è g ià detto , ri s ponde eg re g iamente a minacciare e difenders i e qui , a seconda d e lle informazioni, dopo conveni e nte sos ta, potrà ripi ega r e o pe rman e re .
g) PREDISPOSIZION I DEL TEMPO DT PACE - L'esito dell ' operaz ion e dip e nde - non vi è dubbio - dalla celerità e dalla seg retezza e le disposizioni preve ntiv e pe r quanto s i tengano celate troppo o poco forniscono elemento a sospetto . M a d ' altra parte non si può a m e no di pro vve dere alla raccolta d e i mezzi e la località più adatta sem bra Ago rdo dove si può costruire un d epos ito di gelatina e dov e già esiste un deposito viveri e foraggi Da Agordo a Ma lga Sotto Ciape l a si può pervenire in una so la tappa e fare perciò il tra s porto di nottetempo se nza de s tare s o spe tti.
Sono qu es te le norme che pare dovrebbero esse r e seguite per la esec uzion e del l 'atto ardimentoso, ma r ipetes i che, data la difficoltà, occorre sia pari a l compito g rave il capo e la trupp a e c he i l massimo seg r e to s ia mantenu to s ino all'ultimo, poiché ogni più piccola indiscre z ion e potreb be mandare a vuoto l 'ope ra z ion e. Il distaccamento dev'esse re votato a l sac rifi c io, di spos to perciò a non retrocedere se non a fatto co mpiuto, ma s ic co me di predi s porre gli animi non vi è l ' opportunità, conviene la sce lt a cada su persona che goda un ascendente senza limiti e possegga perizia indiscussa.
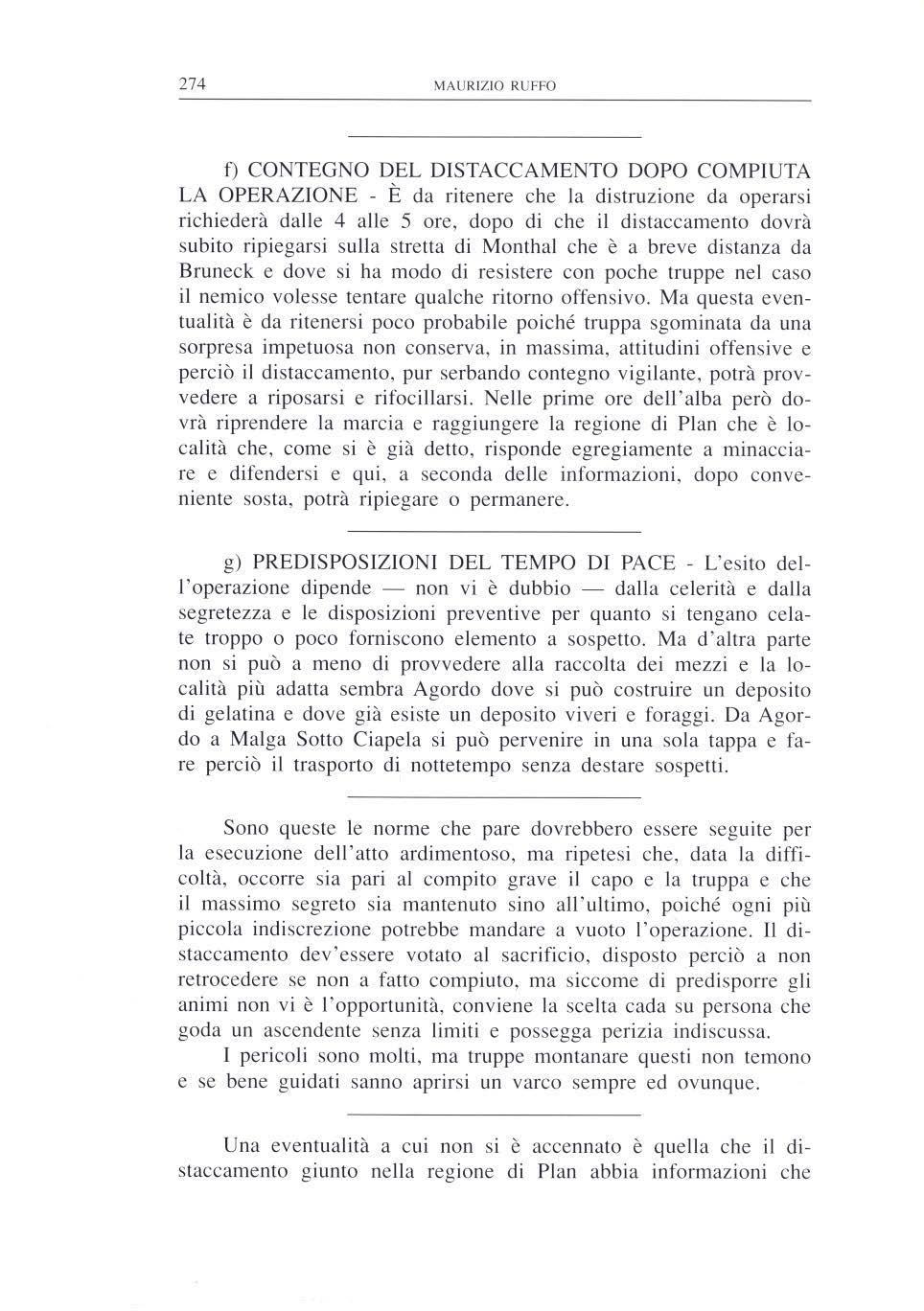
I p e ricoli s ono molti, m a trupp e montanar e que s ti non temon o e se b e ne g uidati sanno aprirsi un varco se mpre ed ovunque.
Una eve ntualità a cui non s i è accennato è qu e l la che il dis ta cca mento g iunto nella re g ion e di Pian abbia inform azion i che
sconsigliano il tentativo dell ' operazione su Bruneck. Orbene da questa regione un tentativo può e s sere fatto in que s to caso sulla ferrovia di V. cl' Adige.
Gli effetti materiali che si potranno ottenere saranno minori certamente, ma non inferiori quelli mora l i, perché una minaccia al tergo di Trento non può a meno di portare impressione s inistra su rutti coloro che s ono dis locati avanti per la difesa del campo trincerato. E non vi è a credere che le difficoltà siano meno gravi poiché la distanza - 22 km da Pian a Vaidbruch - non è grande e fino al giorno d ' oggi non s i ha notizia di pres idi dislocati nella valle Gardena.
Ciò premesso s i opina che al capo destinato alla impres a debba pure accennarsi a que s ta eventualità. lasciandolo in ogni caso libero cli agire per l'uno o l'altro verso.
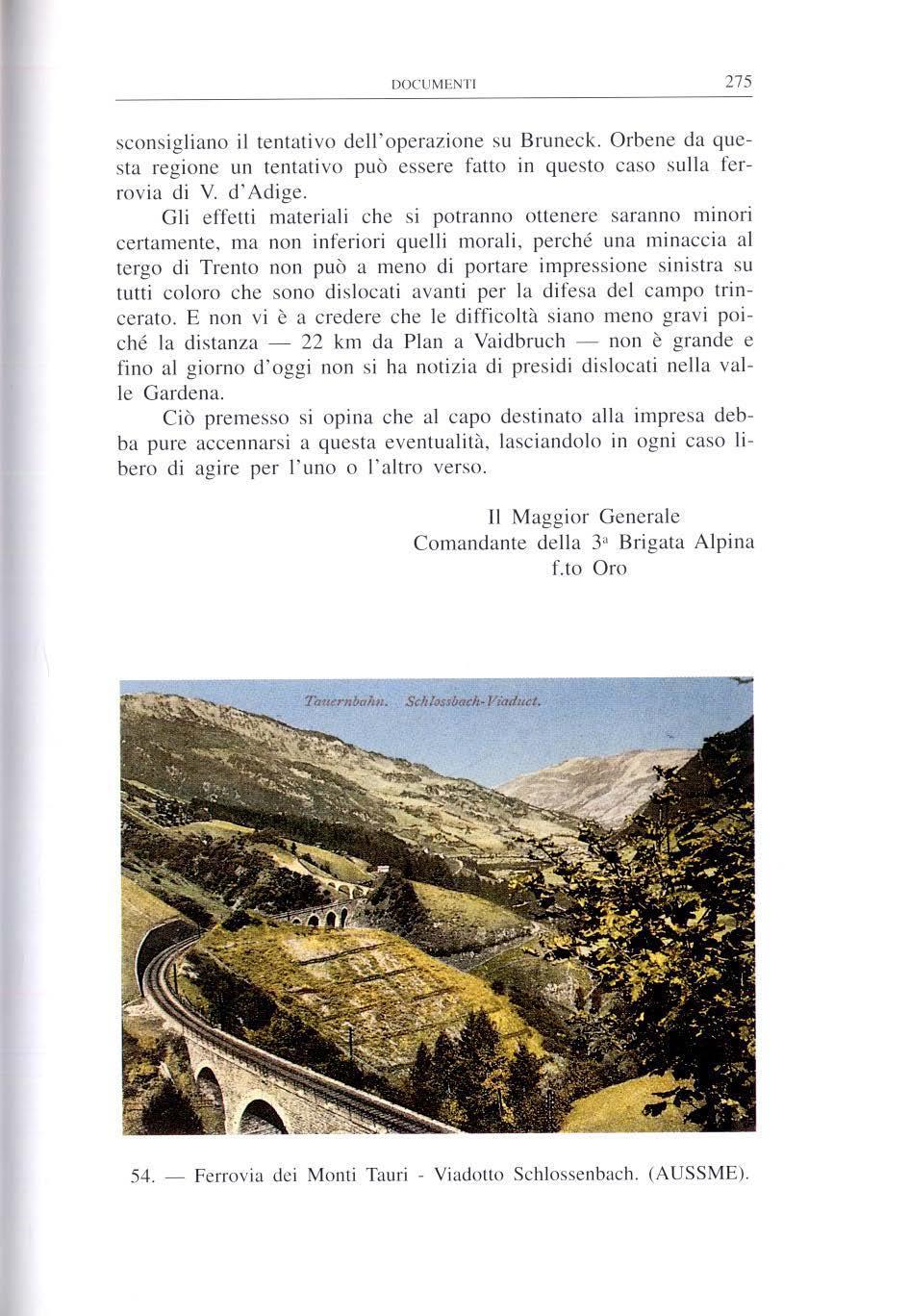
Il Maggior Generale Comandante della 3" Brigata Alpina f.to Oro
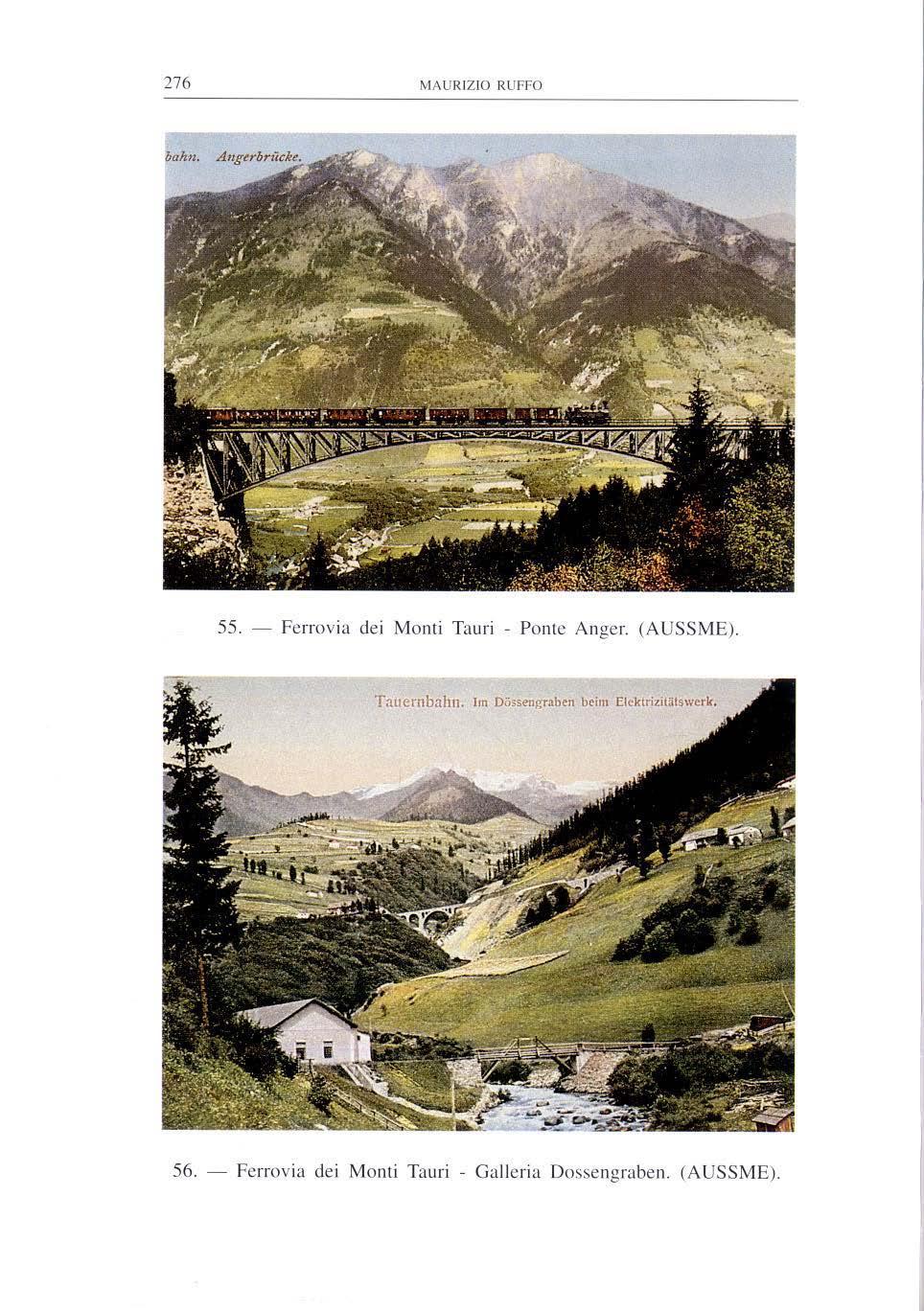
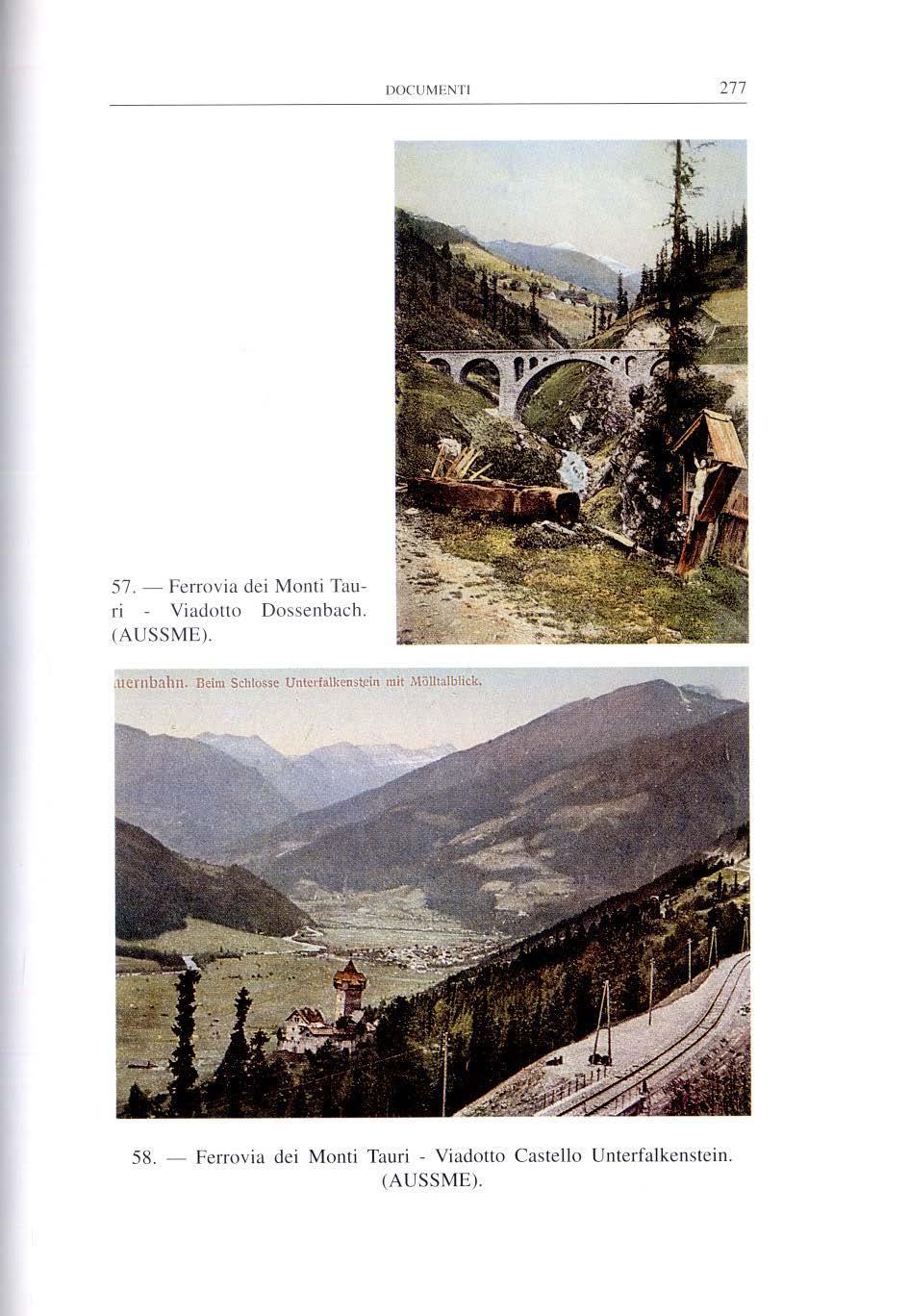
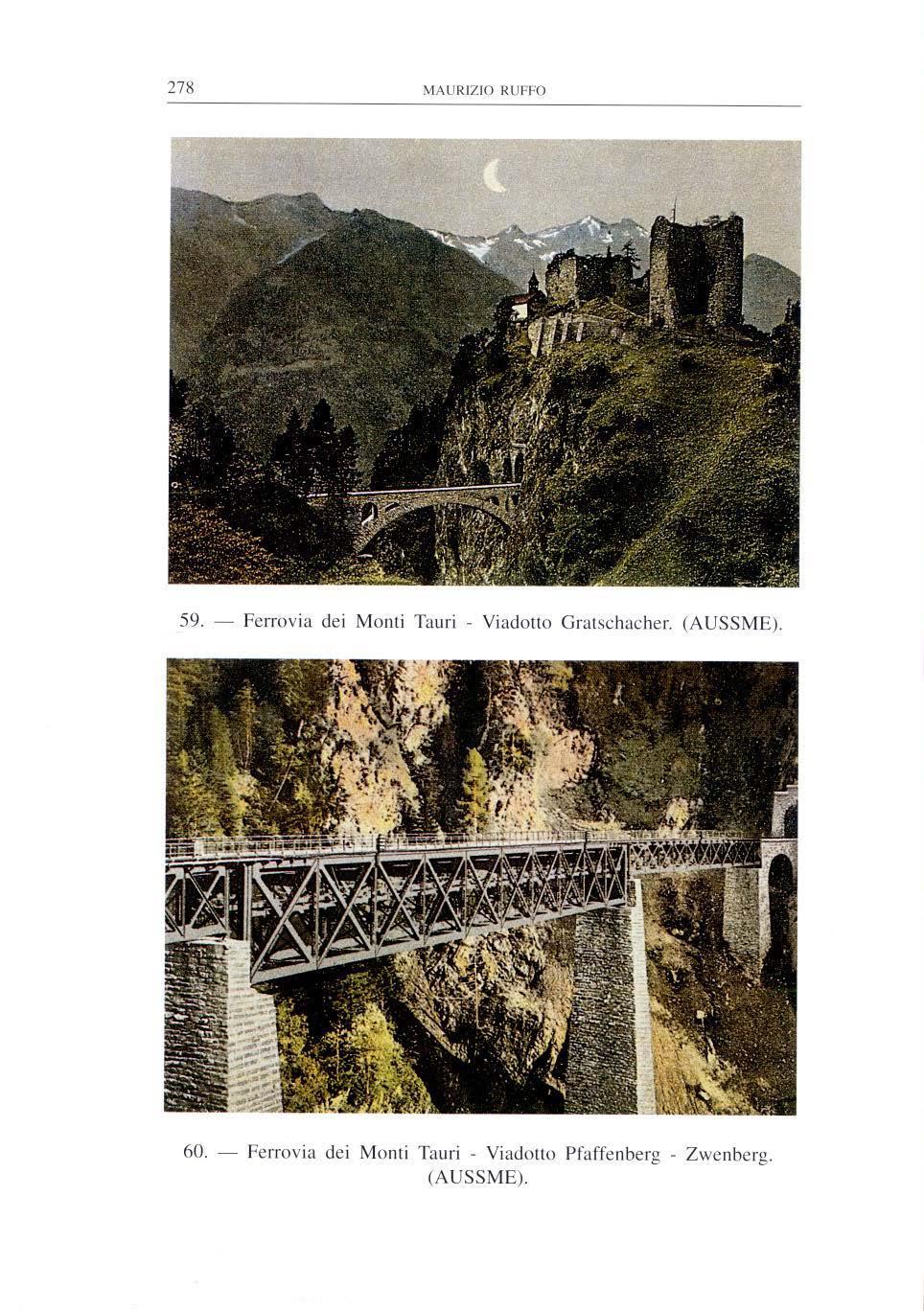
6 1 - Ferrovia dei Monti
Tauri - Viadotto Litze lsdorfcr. (AUSSME).
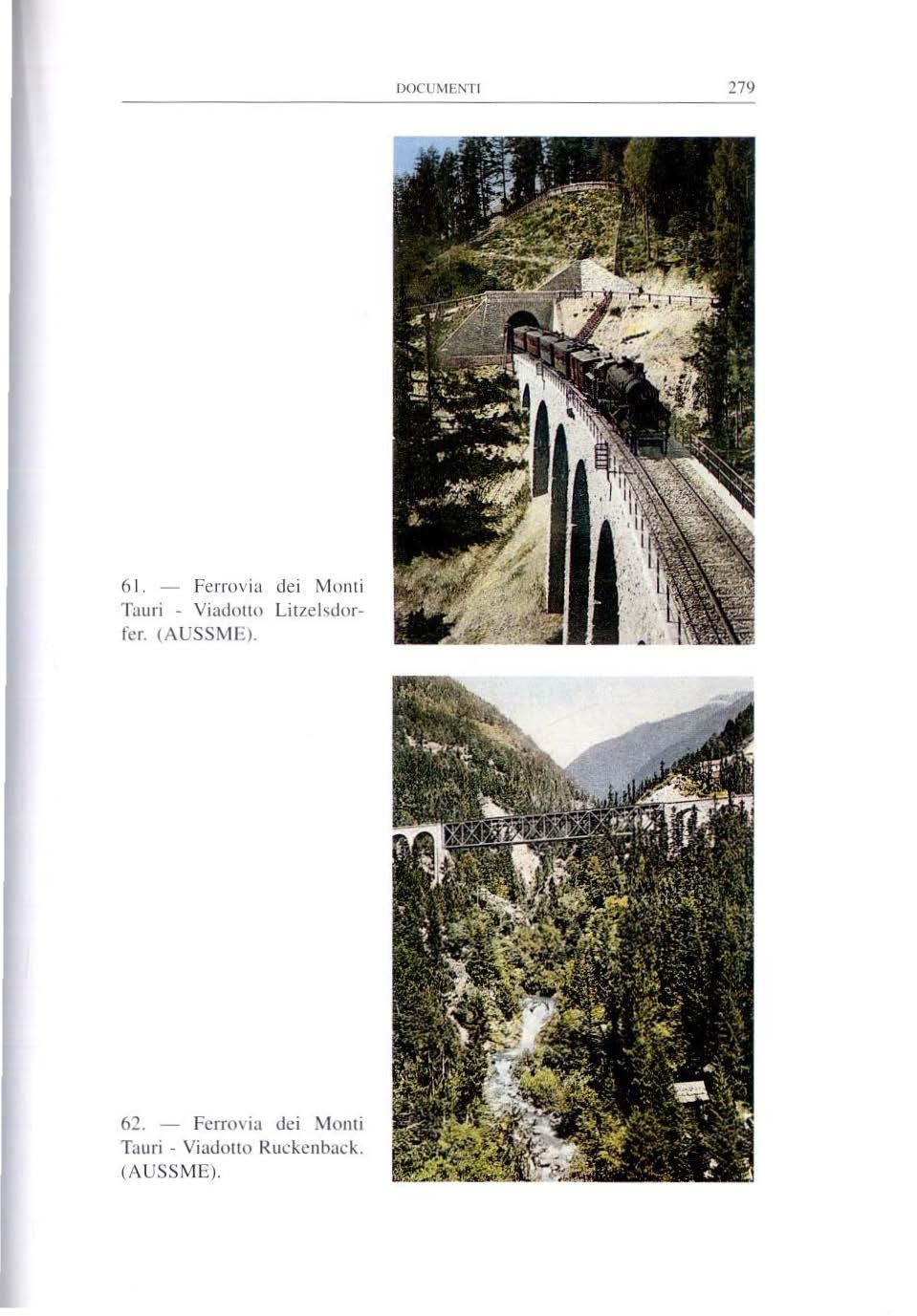
62. - F errovia dei Monti
Ta uri - Viadou o Ruckenba ck. (AUSS ME ).
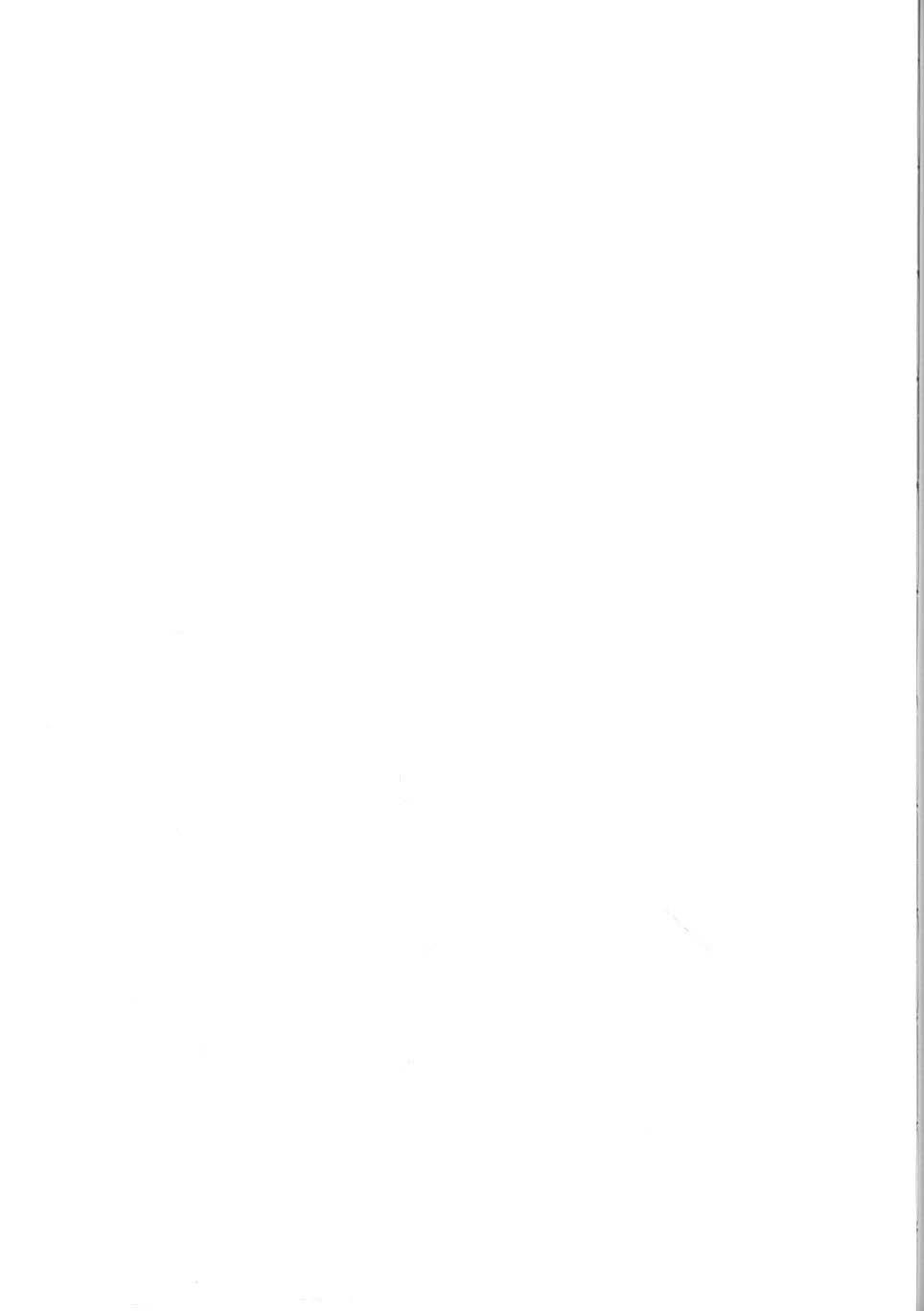
BREVE MEMORIA CIRCA UNO STUDIO PER L'OFFENS IVA della 2" ARMATA
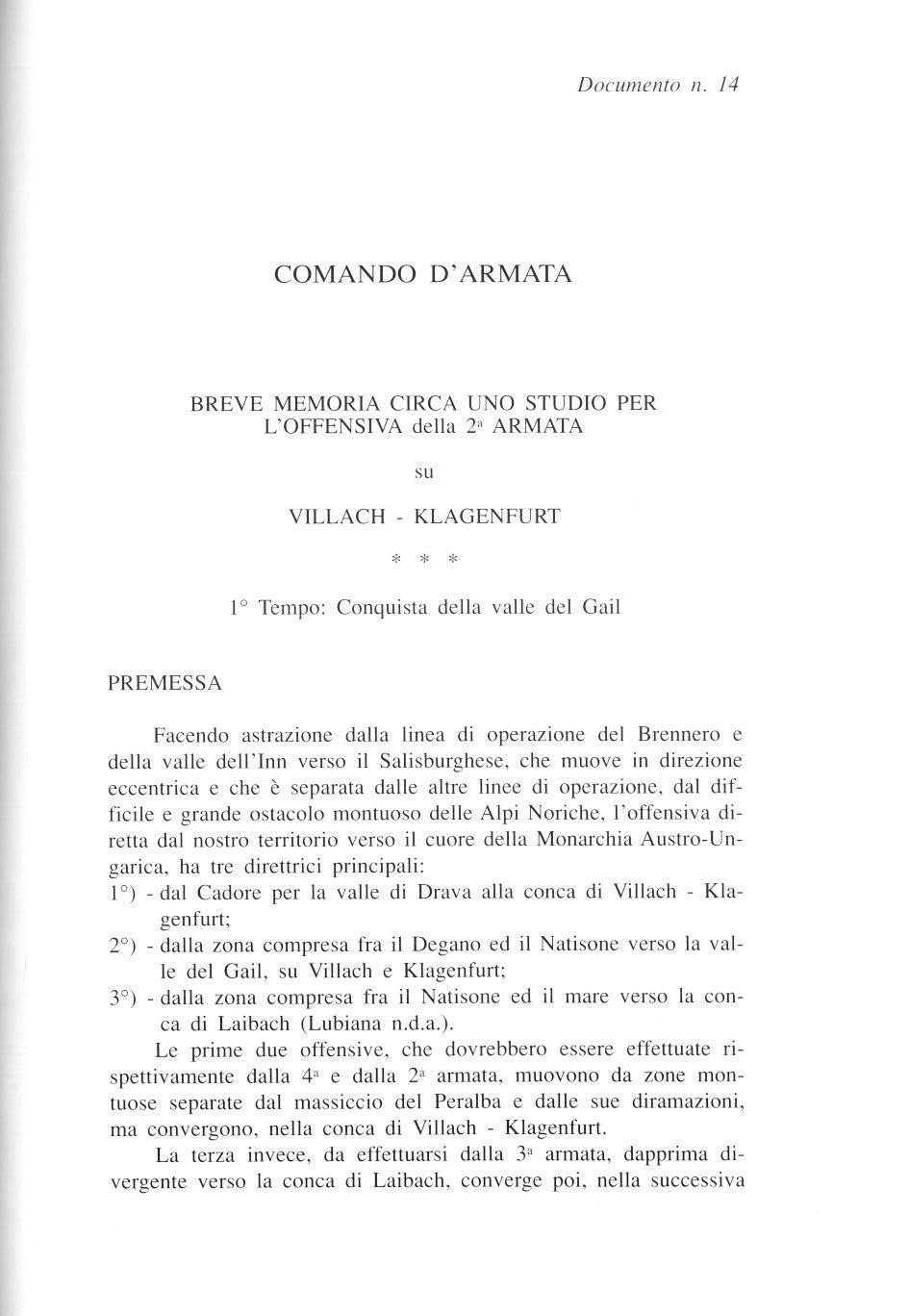
V ILL AC H - KLAG ENFURT
1° Tempo: Conq ui sta della valle del Gail
Facendo astrazione d alla linea di operazione del Brennero e d e lla valle dcll'lnn verso il Salisburghese, che muove in direzione ecce ntrica e che è separa ta dalle altre linc e d i operazione, dal diffici le e g rand e ostacolo montuoso d e ll e Alpi Noriche , l ' offensiva diretta dal nostro territorio verso il cuo re della Mon a rchia Austro-Ungarica, ha tre direttrici prin c ipali: l 0 ) - da l Cador e per la va ll e di Drav a a ll a conca di V illac h - Klage nfurt;
2 ° ) - dalla zo na compresa fr a il D ega no e d il Nat iso ne verso l a valle ci e l Gai 1, s u Vi I lach e Kl agcnfurt;
3°) - dalla zo na compresa fra i I Na ti sone ed il m are ve rso la co nca di Laibach (Lubiana n.d.a.).
L e prime due offe ns iv e, che dovrebbero esse re effett ua te ris pe ttivam e nt e dall a 4• e dalla 2• arma ta, muovono da zo ne montuo se se parate dal massicc io del Pe ralba e dalle s ue diram az ioni, ma convergono , ne lla co nca di Villach - Klage nfurt. La te rza invece , da effe ttuars i dalla 3• armata , dapprima divergente ve r so la conca di Laibae h , converge poi, nella s uccess iva
avanzata verso il finale obbiettivo di Vienna, sulle altre due, s ia direttamente pei Karavanka su Klagenfurt, sia più lontano s u Grat z per la fronte Windischgraz - Marburg.
Tralasciando di occuparmi della 3• armata, la cui marcia diverge s u Laibach , accennerò alle operazioni della 4" armata, so lo per dire che, avendo essa nella conca di Villach l 'o bbie ttivo comune con la 2" armata, le operazioni di queste du e armate debbono essere strettamente collegate.
Fino al Gai! la 2• armata ha un obbie1tivo ben definito. A raggiungere il medesimo essa potrebbe ric eve re aiuto dalla 4• armata, quando que s ta , giunta a Sillian per l'in sellatura di Tilliach , scend esse con parte delle s ue forze nell'alto Gai!. Ciò però non è facile che avvenga, dovendo la 4 • armata s uperare le fortificazioni che sba1nno la strada di Alemagna e quella di Monte Croce Comelico. M e ntre la 2• armata per penetrare dalla valle del Degano e del But in quella de l Gai! non troverebbe ostacolo di fortificazioni.
È perciò assai probabile che la 2" armata giunta al Gai! abbia da aprire la marcia con parte delle s ue forze alla 4 a armata, sboccando per Mauthen su Ober Drauburg, od anche per Tilliach su Sillian.
Comunque , non potendos i prevedere quel che accadrà dopo l'arrivo della 2• armata s ul Gail , c iò dipendendo dalle operazioni del n e mico e dalla e ntità delle re s isten ze che avrà incontrato la 4• armata, lo s tudio delle operazioni offensive dalla fronte del Natisone - D egano sarà limitato al raggiungimento del Gail.
Le s trade delle quali potrebbe di spo rre la 2" armata sare bbero le seguenti:
J 0 ) - la mediocre rotabile, ripida n e l passaggio del di s pluvio alpino, c he per l 'alto Ison zo ed il colle del Predii , per la valle della Coriten za conduce al nodo stradale di Tarvis, sussidiata dalla mulattiera che p e r valle Raccolana e la Sella Nevea si unisce alla precedente a Raib l, s barrate entrambe dalle fortificazioni di Flitsc h, cli Predii e di Raibl;
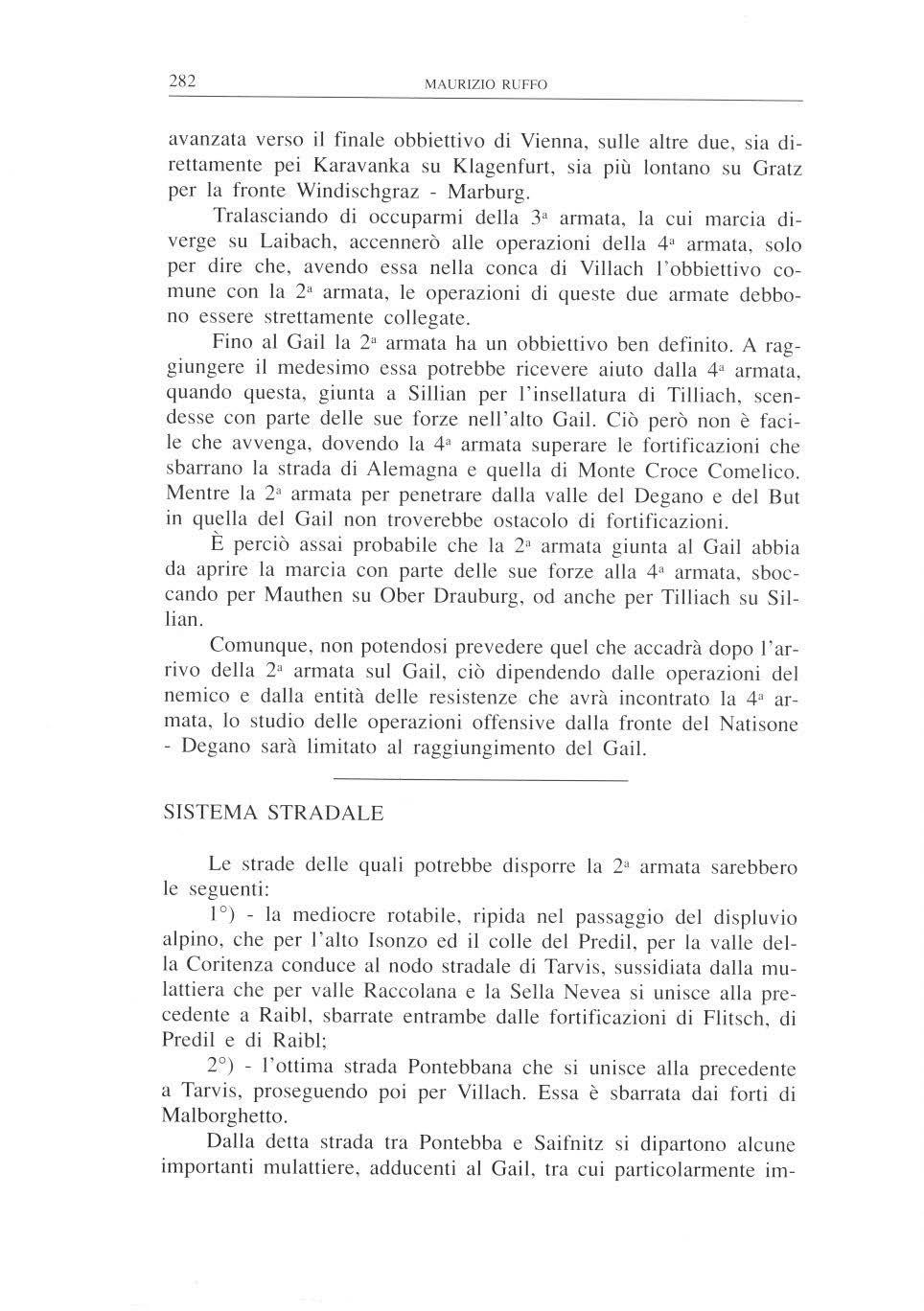
2° ) - l'ottima strada Pontebbana che s i uni sce alla precedente a Tarvis, proseguendo poi per Villach. E ss a è s barrata dai forti cli Malborghetto.
Dalla detta s trada tra Pontebba e Saifnitz s i dipartono alcune importanti mulattiere , adducenti al Gail , tra cui particolarme nte im-
portante quella che da Pontebba , prima dei forti di Malborghetto, pel passo di Nassfeld conduce a Rattendorf. A sud della Pontebbana, tra le comunicazioni sussidiarie che vengono a cadere sul tratto della Pontebbana stessa compreso tra Malborghetto e Tarvis, notiamo soltanto la strada parte mulattiera, parte sentiero facile, che da Dogna attraversa il confine presso Somdogna e, mutatasi poi in carrareccia, sbocca da Wolfsach sul rovescio dello sbarramento di Mal borghetto;
3° ) - le due rotabili che fino a Timau e Paularo rimontano le valli del But e del suo affluente Chiarsò, proseguendo poi con parecchie mulattiere e sentieri attraverso la catena alpina verso il Gai!. Fra le mulattiere hanno particolare importanza quelle che dal But conducono ai passi di M. Croce Carnico e di Pramosio (nodo importante di comunicazioni mulallierc quest'ultimo) e quelle che dal Chiarsò conducono ai passi di Pecol di Chiauli s, di Meledis e di Cason di Lanzo.
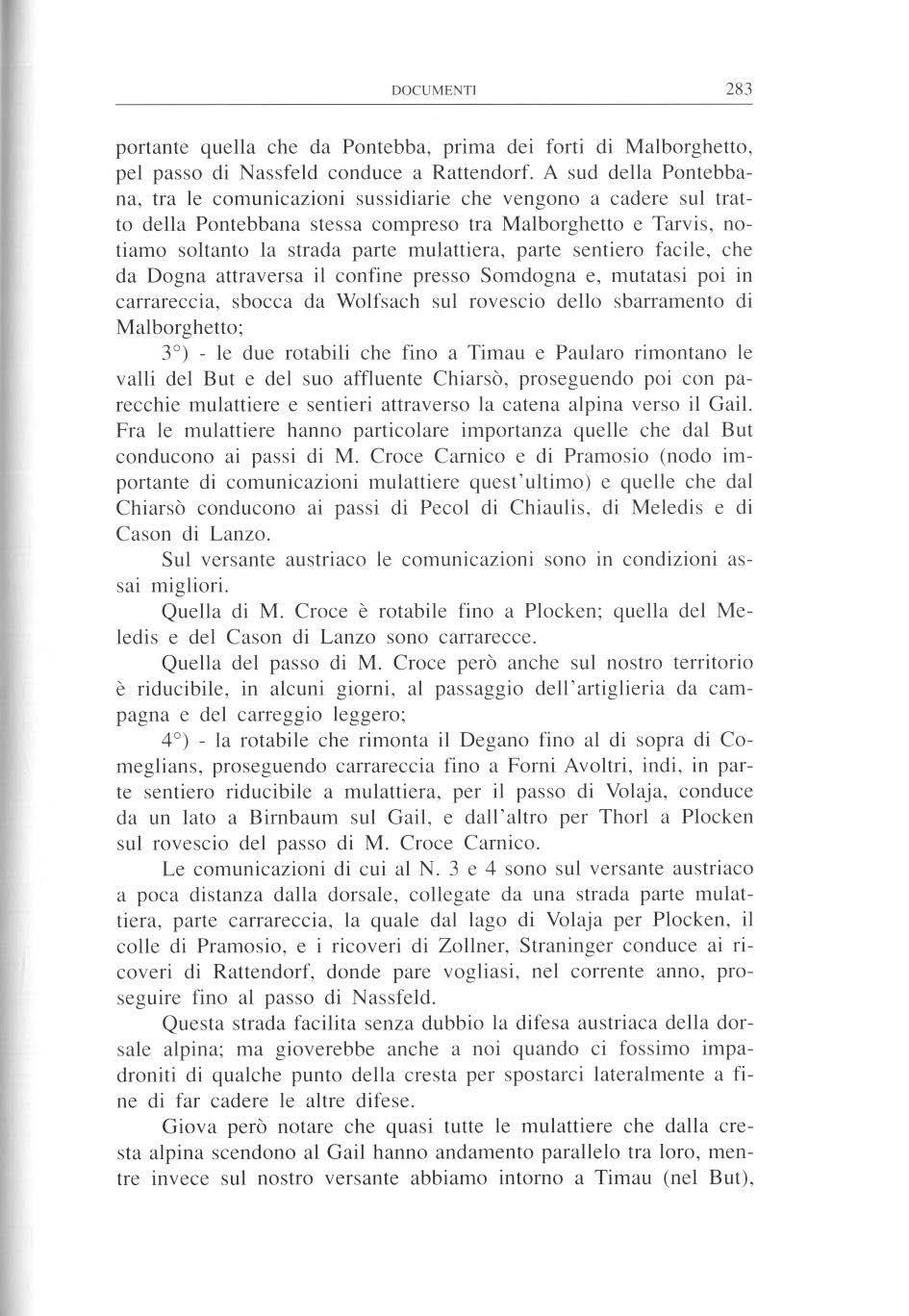
Sul versante austriaco le comunicazioni sono in condizioni assai migliori.
Quella di M. Croce è rotabile fino a Plocken; quella del Meledis e del Cason di Lanzo sono carrarecce.
Quella del passo di M. Croce però anche sul nostro territorio è riducibile, in alcuni giorni, al passaggio dell'artiglieria da campagna e ciel carreggio leggero;
4 ° ) - la rotabile che rimonta il Degano fino al cli sopra cli Comeglians, proseguendo carrareccia fino a Forni Avoltri, indi, in parte sentiero riducibile a mulattiera , per il passo di Volaja, conduce da un lato a Birnbaum su l Gai!, e dall'altro per Thorl a Plocken s ul rovescio del passo di M. Croce Carnico.
Le comunicazioni di cui al N. 3 e 4 sono su l versante austriaco a poca di s tanza dalla dorsale, collegate da una strada parte mulattiera , parte carrareccia, la quale da l lago di Volaja per Plocken , il colle di Pramosio, e i ricoveri di Zollner, Straninger conduce ai ricoveri di Rattendorf, donde pare vagliasi, nel corrente anno, proseg uire fino al passo di Nassfeld.
Ques ta s trada facilita senza dubbio la difesa austriaca della dorsa le alpina; ma gioverebbe anche a noi quando ci fossimo impadroniti di qualche punto della cresta per spostarci lateralmente a fine di far cadere le altre difese.
Giova però notare che quasi tutte le mulattiere che da l la cres ta a lpina scendono al Gail hanno andamento parallelo tra loro, mentre invece sul nostro versante abbiamo intorno a Timau (nel But),
ed alla Stua di Ra maz (nel Chiarsò), due nodi s trad ali m olto import a nti, dai qua li s i dipartono tutt e le co muni caz ioni ad ducenti a lla cres ta a lpin a, comunicazioni c he sono tra di loro collegate dalla mul a tti era che dalla S tu a di Ram az co ndu ce alla Casera cli P ramos io, sce nd e ndo poi s ul But a va ll e di Timau.

È da accen n ars i inoltre che tutt e le strade dalla 2 " alla 4 • (dalla Pontebbana a quella del pa so di M. Croce Carni co), sono collegate:
SU L NOSTRO TERRlTOR fO
dalla ottima e breve rotabile: Staz ione per la Carnia - Villa Santina , in val Tag li amento ( una ve ntina d i chi l ometri) e più a monte, dalla traversale in parte mulattiera in parte rotabile di Paularo - Paluaa - Comeglians;
dalla ottima rotabile Yillach - H ermagor - M aut hen, nella va ll e de l Gail;
La Pontebbana e la strada de l Nati s onc s ono coll eg ate:
dal la pedemon t ana: Osoppo - Tarce nt o - Udine;
IN AUSTR IA
dalla rotabile: Tarvis - passo del Predi i - Caporetto, lungo la valle de ll ' Is onzo.
A TA RV I S s i incroc ia no le comu ni cazion i tend e nti a
s ud , pel passo di Predi i a lrlsonzo per Arnolds te in , a Yi l lach ed a ll a Drava , ad est. a ll a Sa va e d a L a ib ac h. ad ovest, a P on tebba od a l FellaT agliamen to
L a zona montana a ttrav erso la quale dovrebbe procedere I' o ffen iva de ll a 2 • amrnta con primo obbiettivo la val le de l GaiJ è cos tituita dall a ca tena d e ll e A l pi Carni c he dal M. Peralba alla Se ll a di Sai fnit z . nonc hé da ll e prop agg ini montuose c he di stacca ndo i dal-
l'anzidetta Sella di Saifnitz e dalle Alpi Giulie costituiscono bacini dell'alto Isonzo e della Coritenza.
Le A lpi Carniche son divise in due traili dal passo di M. Croce Carnico - Il tratto occidentale aspro/roccioso, con alcuni nevai, costituisce la parte più a lp estre di tutta la Carnia , con media altezza di circa 2400 m. - Più tondeggiante , e per conseguenza più praticabile è il trailo orien t ale che, con una media altezza di 2000 m. s i presenta quasi in ogni punto prativo.
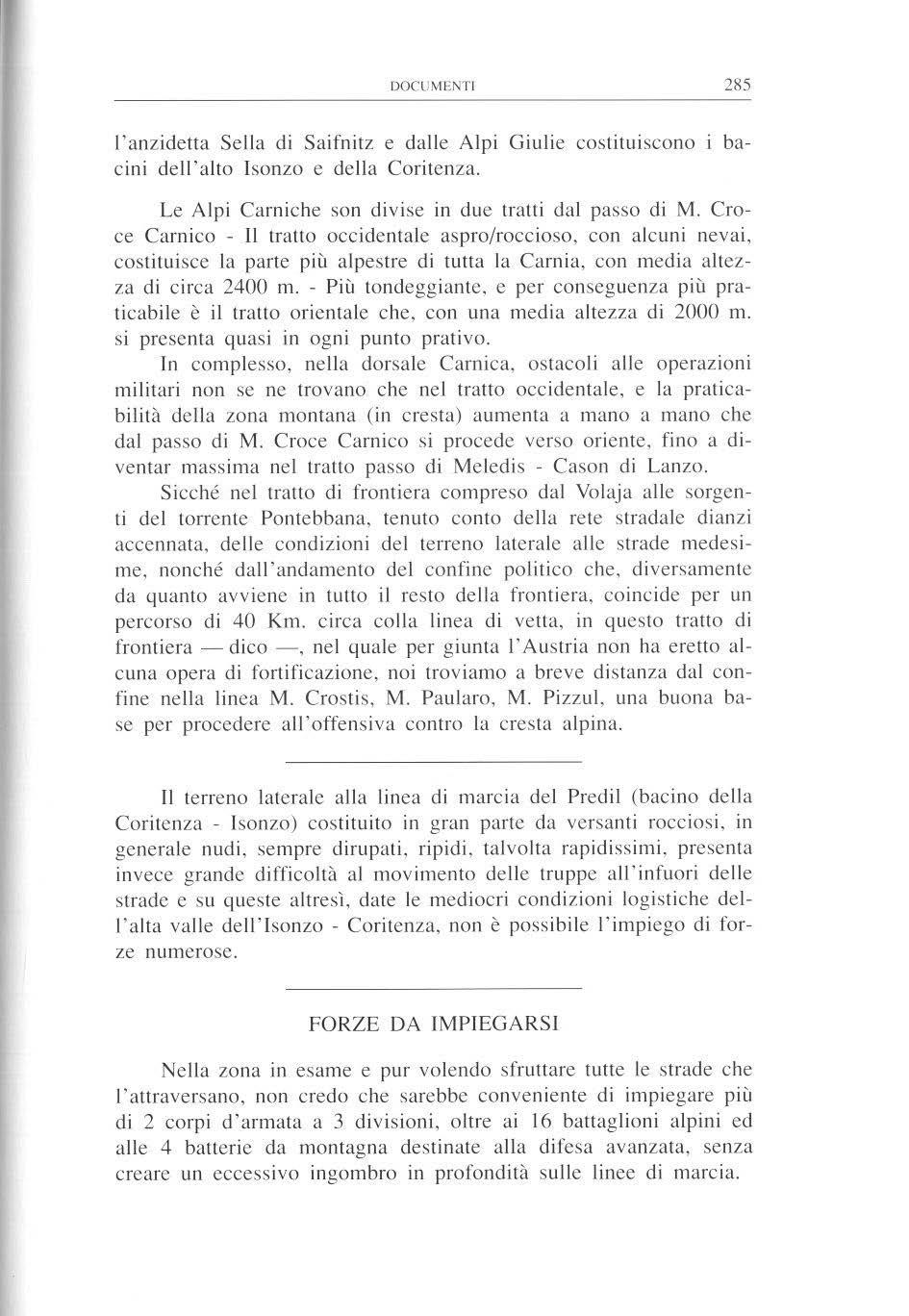
Tn complesso, ne lla dorsa le Carnica, ostacoli alle operazioni militari non se ne trovano che nel tratto occidentale, e la praticabilit à d e lla zona montana ( in cresta) aumenta a mano a mano che dal passo di M. Croce Carnico si procede verso oriente, fino a dive ntar massima nel tratto passo di Mel e di s - Caso n di Lanzo.
Sicché nel trauo di frontiera compreso dal Yolaja alle sorgenti de l torren te Ponte bbana, tenuto co nto della rete s trad ale dianzi accennata, delle condizioni d el te rreno laterale alle str ade medesime, nonché dall'andamento de l confine politico che, diversamente da quanto avvi e ne in tutto il resto della frontiera, coincide pe r un pe rcorso cli 40 Km. circa colla linea di vetta, in qu es to tratto di frontiera - dico, nel quale per g iunta l 'A us tria non ha eretto alcuna opera di fortificazion e, noi troviamo a breve distanza dal confine ne lla lin ea M. Crostis, M. Paul a ro , M. Piz z ul , un a buona base per procedere all'offensiva contro la cresta alpina.
Il terreno laterale alla linea di marcia del Pre dii (bacino de lla Coritcnza - Isonzo) costituito in gran parte da versa nti ro cc iosi , in gene ral e nudi , sempre dirupati , ripidi , talvolta rapidissimi, presen t a inv ece grande difficolt à al movimento d e ll e trupp e a ll ' infuori del le s trad e e s u que s te a ltresì, date le me dio c ri condizioni logistiche d e l1'a lta valle dell'Ison zo - Coritenza, non è possibile l 'impiego di forze num erose .
FORZE DA JMPTEGARSl
Nella zo na in esame e pur volendo sfru ttare tutte le s trade che l'attraversa no, non credo che s ar e bbe conveniente di impiega re più di 2 corpi d'armata a 3 divi s ioni , oltre ai 16 battaglioni alpini ccl alle 4 ballerie da montagna destinat e alla difesa avanzata, se nza crea re un eccess ivo ingombro in profondità s ulle linee di marcia.
A mio avviso le anzidette forze potrebbero venire ripartite nel seguente modo, coi co mpiti successiva mente per ciascuna valle indicati.
FASCIO A 1
1° corpo d'armata
7 battaglioni alpini
2 batt e ri e da montagna per le strade del Predii e della Pontebba, ripartiti nel seg uente modo:
a)
I " divisione
per il atisone e l'alto I sonzo con obbiettivo Tarvis. - Dovendo superare le fortificazioni di Flitsch, el c i Predii e di Raibl dovrebbe essere fornita del parco d'assedio speciale già stud iato per l'attacco delle anzidette fortificazioni.
b)
battaglione alpini
batteria da montagna per la valle Raccolana e la sella evea verso R aibl.
e)
2 • divisione reggimento bersaglieri
5 battaglioni alpini artiglieria della T. S.
I batteria da montagna
per la strada Pontebbana. accompagnata dal parco d'as se dio speciale pe r !"attacco dei for ti di Malborghetto.
TI reggimento bersaglieri ed i bnttaglioni alpini da Pontebba, operando per il passo di Nassfclcl e per la cres ta tra l'alto Fella ed il Gai!. coprire bbero il fianco sinistro della divisione nell'attacco di Mal borghetto.
1 La numcraLionc dei corpi d'armata e rispettiv e divisioni non corri~ponde alla ripartizio ne organica del nostro eserc ito: si è scelta la progress ione numerica naturn lc per indicare le unità di cui ,i discorre.
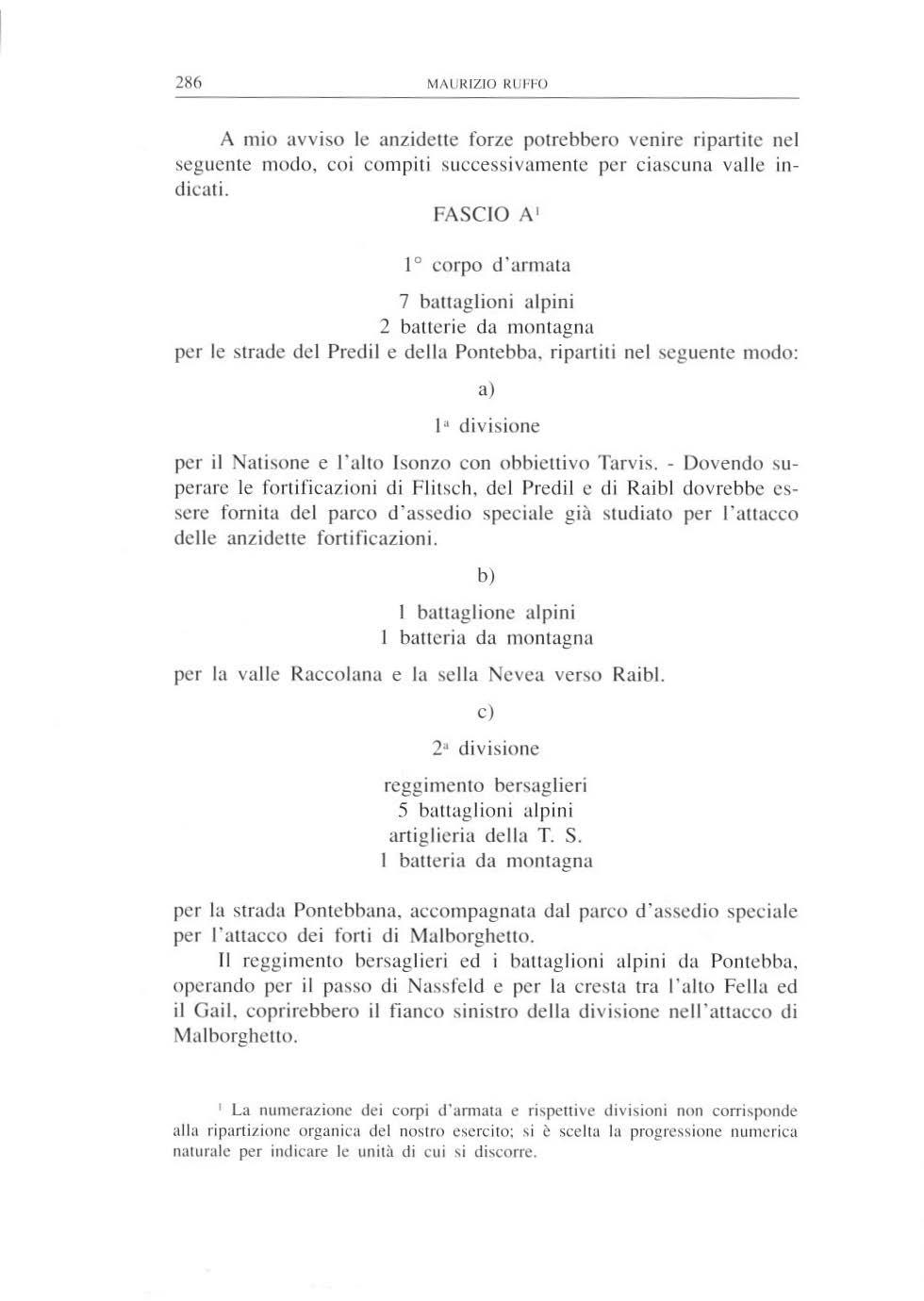
Probabilmante questa divisione, trovando su l la sua strada nelle fortificazioni di Ma lborghetto una resistenza meno lunga di quella che incontrerebbe l'altra colonna (del Predil), costretta ad attaccare successivamente tre linee di fortificazione ed a superare altresì maggiori difficoltà di terreno , s boccherebbe a Tarvis prima di quest'ultima, e però , giunta nell'anzidetta localiUt, innanzi di proseguire la sua vanzata su Vi I lach, cercherebbe di facilitare lo sbocco dell'altra colonna del la strada del Predii, att.accando di rove sc io le opere che la chiudono.
d)
1 battaglione alpini
per val Dogna con obiettivo di sboccare in val Sezera a lle spalle di Malborghetto.
e)
3a divisione
in ri se rva tra la stazione per la Carnia e Moggio Udinese.
2° corpo d'armata
9 battaglioni alpini
2 batterie da montagna
per la valle del Ch iersò, del But e del Degano, ripartiti nel seguente modo:
a)
4• divisione
3 battaglioni alpini
per la valle del Chiarsò e Paularo, donde dovrebbero impossesarsi dei passi del Meledis e del Cason di Lanzo , nonché delle teste delle valli scendenti al Ga i! tra Noeblin e Rattendorf, faci litando poi verso oriente l 'attacco del colle cli Nassfe ld e verso occidente q uello del colle del Pecol di Chiaulis e di Pramosio.
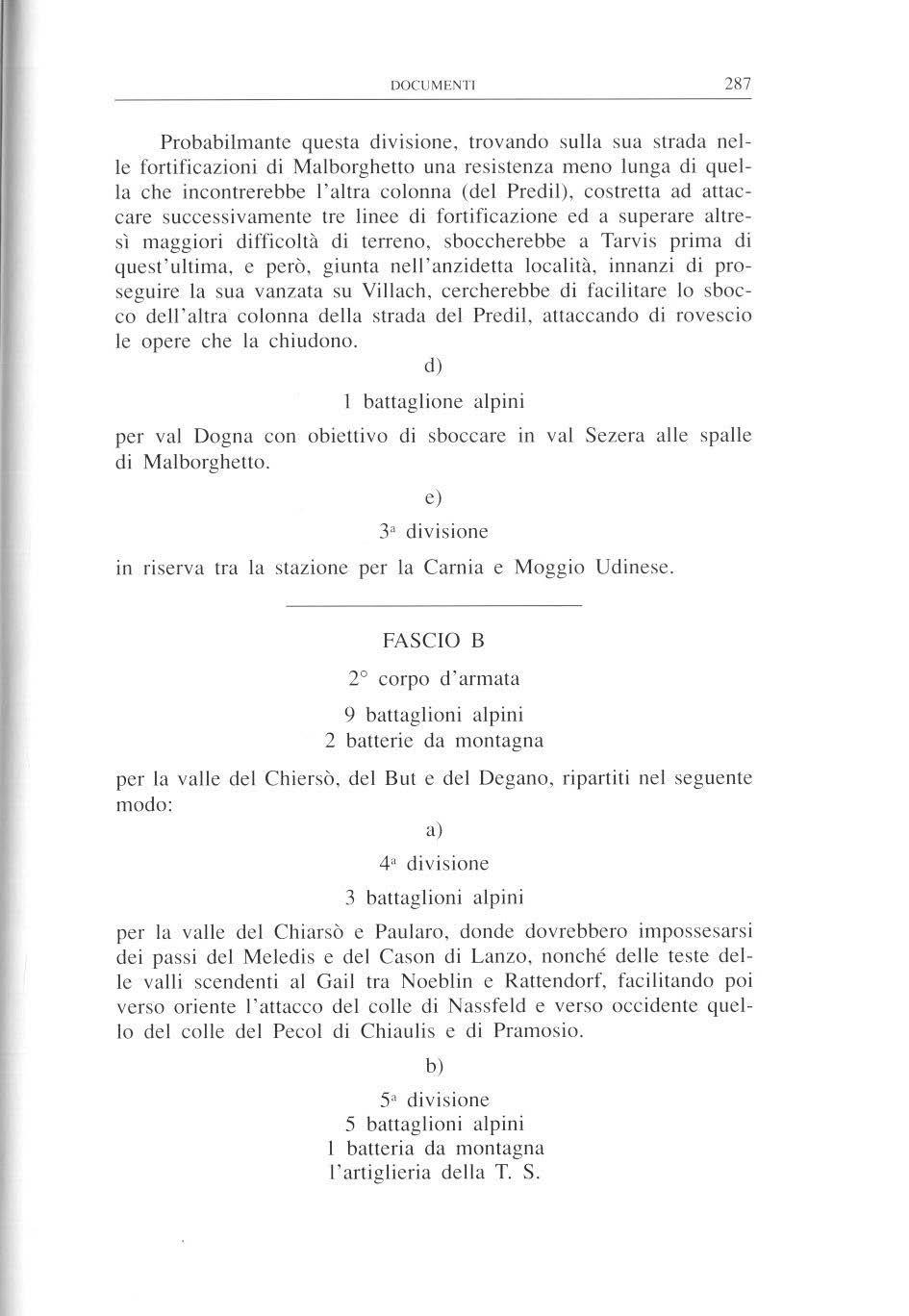
b)
s• divisione
5 battag lioni a lpini batteria da montagna
l'artiglieria della T. S.
per Timau ed il M. Paularo dovrebbero mirare all'attacco della dorsale alpina, compresa tra il passo di M. Croce Carnico ed il passo di Pecol di Chiauli, e successivamente alla conquista del contrafforte del M. Polonik , il cui possesso assicura la discesa al Gai! tra Mauthen e Dellach.
c) reggimento bersaglieri l battaglione alpino l batteria da montagna
per la valle ciel Degano a Comeglians , donde dovrebbe mirare alla conquista del passo di Volaja, per poter poi eia questo e per la strada che conduce a Plocken, concorrere a far cadere la difesa al passo di M. Croce Carnico.
d)
o" divisione in riserva fra Tolmezzo ed il piano d 'Arta.
Fino all'arrivo dei grossi de lla 2" armata i battaglioni alpini e le batterie da montagna sopra accennate, assumerebbero la dislocazione indicata dallo schizzo annesso alla memoria del Comandante del 1° gruppo alpino, relativa ali 'inizio dell'offensiva verso la valle del Gai!.
Padrone di Tarvis il 1° corpo d 'armata (linea di operazione A) cercherebbe di sboccare su Villach per Madlern e per Wurzen , mentre il 2° corpo d'armata (linea di operazione B) - in concorso con la 4" armata, che seg uirebbe la val le della Drava - vi sbocc herebbe per la strada di Notsch - Kreut ed eventualmente, per quella più occidentale cli S. Stefano -Paternion.
11 modo cli combinare l'avanzata dei due anzidetti corpi d'armata sarebbe stabilito - come già si discu sse - dopo l'occupazione di Tarvis.
Qualora fosse intenzione del Comando Supremo di inviare minor quantità di truppe per le linee prese in esame allo scopo di aumentare le forze operanti per il fascio s tradale più ricco delle Alpi Giulie, si potrebbero sottrarre dalle forze accennate le due divisioni di riserva ed in tal caso provvederebbero i comandi del le unità in ciascuna valle a costituire de lle riserve parziali, le quali, nel la
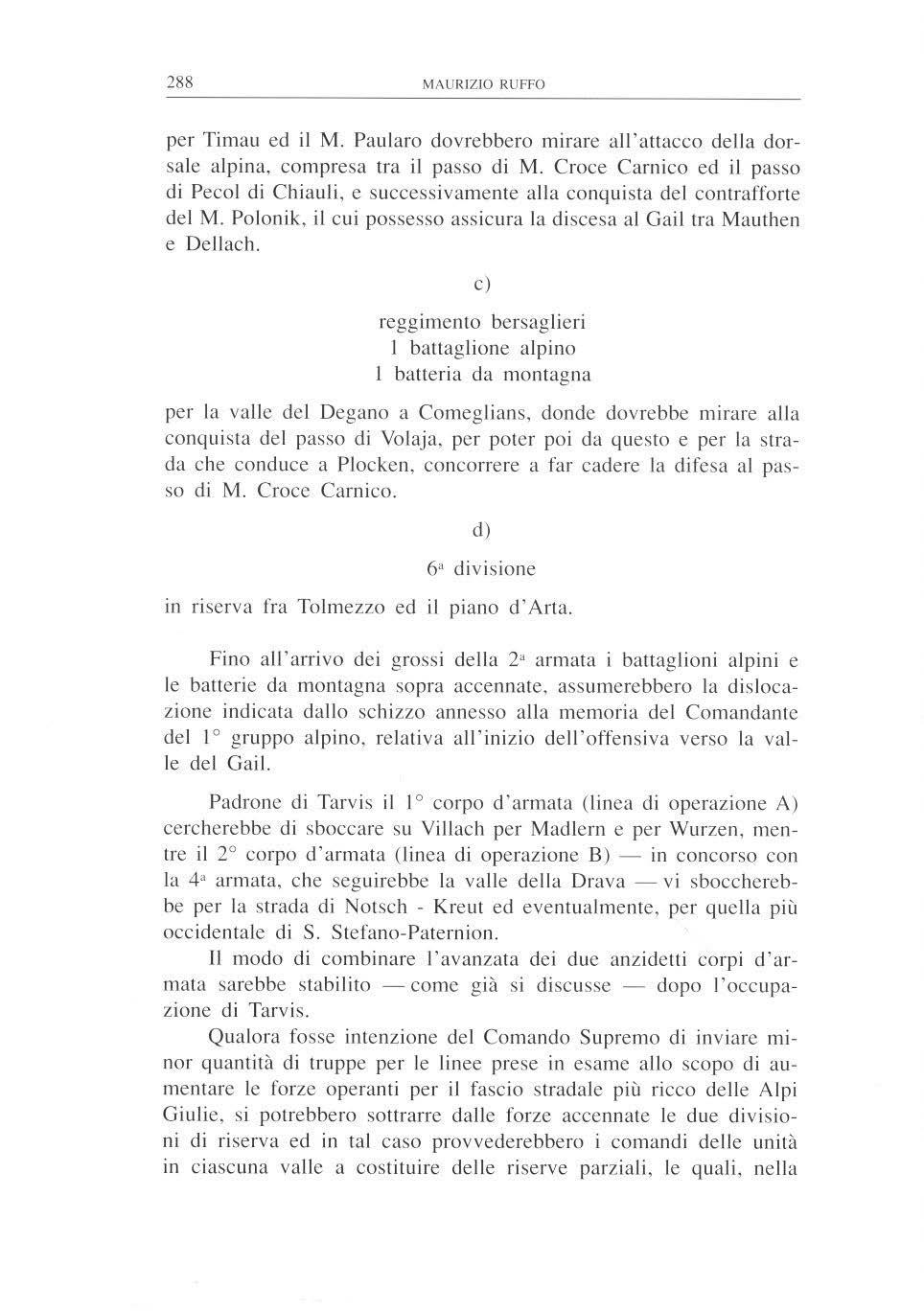
zona del 2° corpo (operante per la valle del Chiarsò, del Bui e del Degano), potrebbero essere spostate dall'una al l 'a lt ra parte delle ridette valli per la strada cli arroccamento già accennata: PaularoPaluz za - Comeglians.

Quelle parti cli carreggio non strettamente indispensabili al 2 ° corpo dovrebbero essere - a suo tempo - avviate per la strada Pontebbana a raggiungere il 2 ° corpo medesimo, nella val le del Gail.
Per il funzionamento dei servizi nella zona del 2° corpo e dopo la conquista della cresta alpina , potrebbe essere consigliato, almeno per la 4" divisione, che opera nella va ll e del Chiarsò, e per il rcggicmnto bersaglieri, J"cquipaggiamcnto da montagna. Considerando però che la s trada di M. Croce Carnico è facilmente riducibile al passagg io del carreggio leggiero e che nella valle del Chiarsò non vi sono altri tratti mulattieri che quelli che da Paularo vanno ai ricoveri di Straningcr (passo di Mclcdis) ccl ai ricoveri di Rattcndorf (passo di Cason di Lanzo), dai quali ricoveri s i proseg ue con carrareccie a Kirchbach e Rattendorf sul Gail, s arà conveniente di studiare se non si possa con slitte o con mezzi meccanici trasportare il carreggio elci corpi da Paularo agli anzidetti ricoveri, provvedendo al rifornimento con mezzi occasionali da requisirsi sia in pianura, sia nella zona momtana o mediante portatori. Mi riservo perciò di far studiare que s to importante problema dal comandante ciel genio di armata e dall'intendente d'armata.
Non si scen de naturalarncntc a maggiori particolari sullo avolgimcnto delle progettate operazioni, essendo questi di spettanza dei comandanti di corpo d'armata e di quelli delle varie colonne.
Genova, 24 marzo 19 12
L. Cadorna
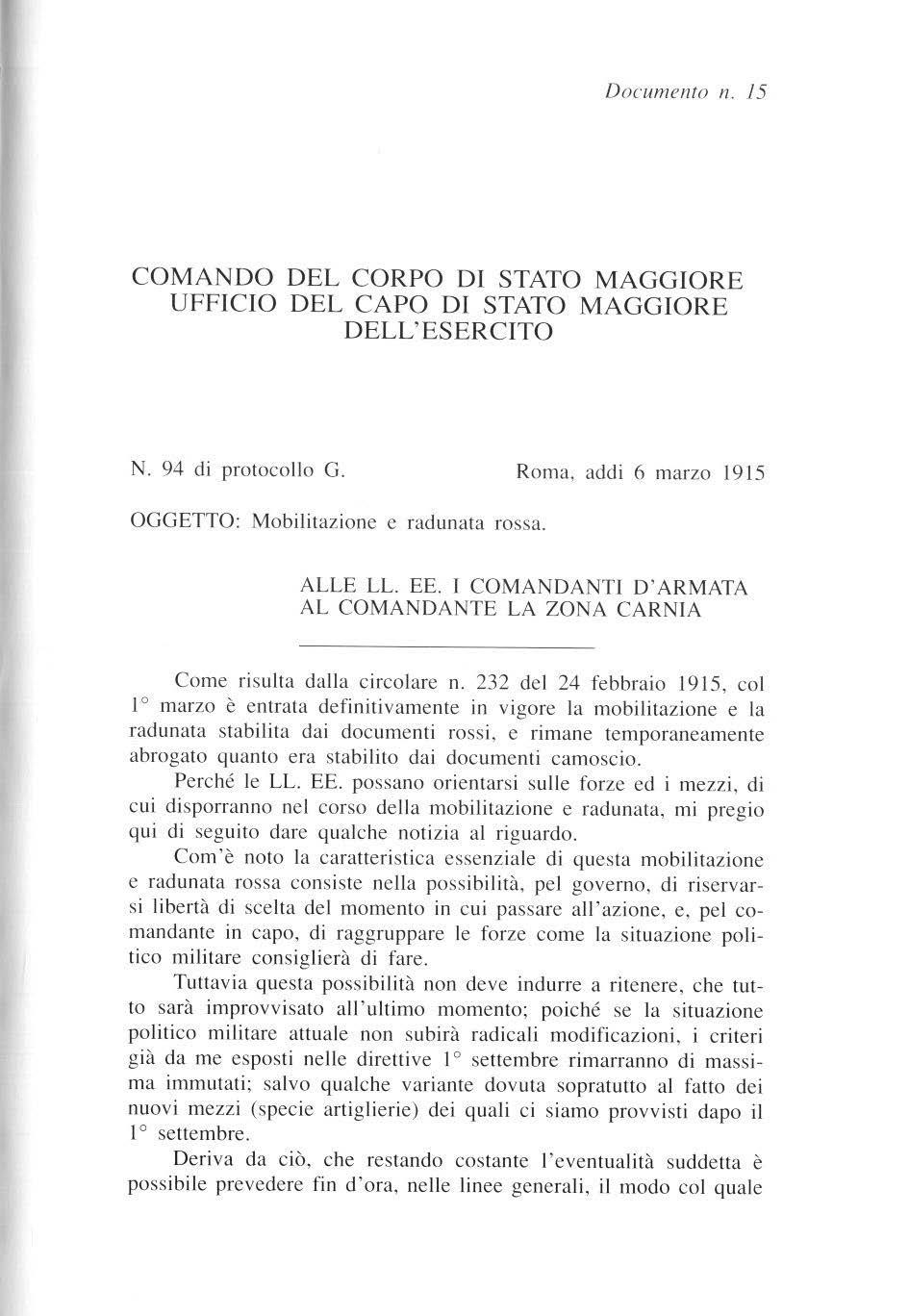
N. 94 di protocollo G. R oma, addì 6 marzo 1915
OGGETTO: Mobilitazione e radunata rossa.
Come risulta dalla circolare n. 232 del 24 febbraio 1915, col l O marzo è en trata definitivamente in vigore la mobilitazione e la radunata stabi lita dai documenti rossi, e rimane temporaneamente abrogato quanto era stabilito dai documenti camoscio.
Perché le LL. EE. possano orientarsi sulle forze ed i mez z i , di cui disporranno nel corso del la mobilitazione e radunata, mi pregio qui di seguito dare qualche noti z ia al riguardo.
Com 'è noto la caratteristica esse nziale di questa mobilita zione e radunata rossa consiste nella possibilità, pel gove rno , di riservars i libertà di sce lta del momento in c ui passare all'azione, e, pel comandante in capo, di raggruppare le forze come la s itua zione politico mili tare consiglierà di fare.
Tuttav ia questa poss i bilità non d eve indurre a ritenere, che tutto sarà improv v isa to al l 'ultimo momento; poiché se la situazione politico militare attuale non s ubirà radicali modificazioni, i criteri già da me esposti nell e dire ttive 1° se ttembre rimarranno di mas s ima immutati; salvo qualche variante dovuta sopratutto al fatto dei nuo vi mezzi (specie artig li erie) dei quali ci siamo provvisti dapo il l O settembre.
D eriva da c iò , che re s tando costante l 'eve ntualità s udd e tta è possibile prevedere fin d'ora, nelle linee genera li , il modo col quale
si svolgeranno le operazioni di mobilitazione e radunata rossa. ed è su questo argomento che mi pregio dare chiarimenti alle LL. EE.
Anzitutto per assicurare la necessaria protezione del nostro territorio, prima di compiere atti di mobilitazione pa lese o comunque capaci di provocare minacce da parte de ll 'avversario, verrà gradualmente intensificata l 'occupazione avanzata. A tale scopo per la fine del corrente mese la massima pa rt e del le truppe destinate ali 'Occ upa zio ne Avanzata = dal fascicolo di formazione e radunata r osso = dovranno ave r occupato i capisaldi della lin ea di difesa stabilita dai dispositivi. e dovranno mantenersi a portata delle rimanenti posizioni.
Non è da escludere altresì che taluni riparti. di altri corpi d'armata , vengano portati fin d'ora (sul piede di pace) nelle località di radunata per loro previste, al lo scopo di concorrere col le truppe di O. A. per fare argine ad una eventuale irruzione dell'avversario.
Circa l'intensificazione de ll 'O. A., ad all'eventua le invio di truppe a rincalzo, darò le nece ssa rie disposizioni non appena avuta l'autorizzazione mini s teriale.
Sotto la protezione delle truppe in O. A. avrà luogo la mobilit azione occulta, la quale consisterà, essenzialmente, nel movimento dei materiali, nella cos titu zione dei magazzini, nell'acquisto di materiali e derrate, nella costituzione di comandi etc.
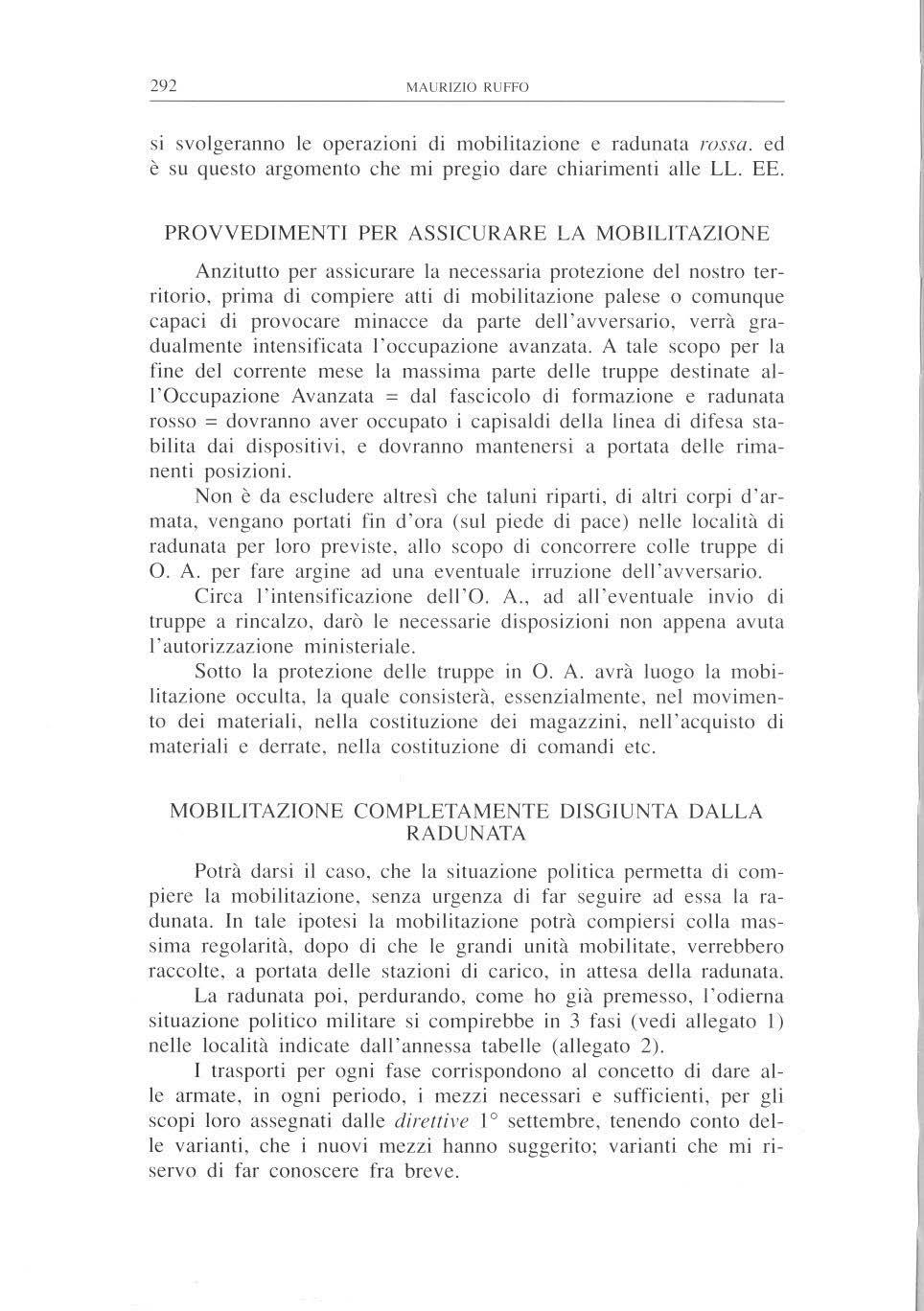
Potrà darsi il caso, che la sit ua zione poi itica permetta di compiere la mobi lit azione, senza urgenza d i far seguire ad essa la radunata. ln tale ipotesi la mobilitazione potrà compiersi col la ma ssima regolarità, dopo di che le grandi unità mobili tate, verrebbero racco lt e, a portata delle staz ioni di carico, in attesa della radunata.
La radunata poi, perdurando, come ho già premesso, l 'odierna situaz ione politico mili ta re si co mpirebbe in 3 fasi (vedi al legato 1) nelle località indicate dall'annessa tabelle (a ll egato 2).
l tra spo rti per ogni fase corrispondono a l concetto di dare alle a rm ate, in ogni periodo, i mezzi necessari e sufficie nt i, per gli scop i loro asseg nati dalle direlfi1•e l O settembre, tenendo conto delle var ianti , che i nuovi mezz i hanno suggerito; varianti che mi rise r vo di far conoscere fra breve.
Potrà darsi invece che, mentre si va compiendo la dislocazione delle truppe dell 'O. A. verso la frontiera, o durante la mobilitazione occulta, sopraggiunga la dichiarazione di gue rra.
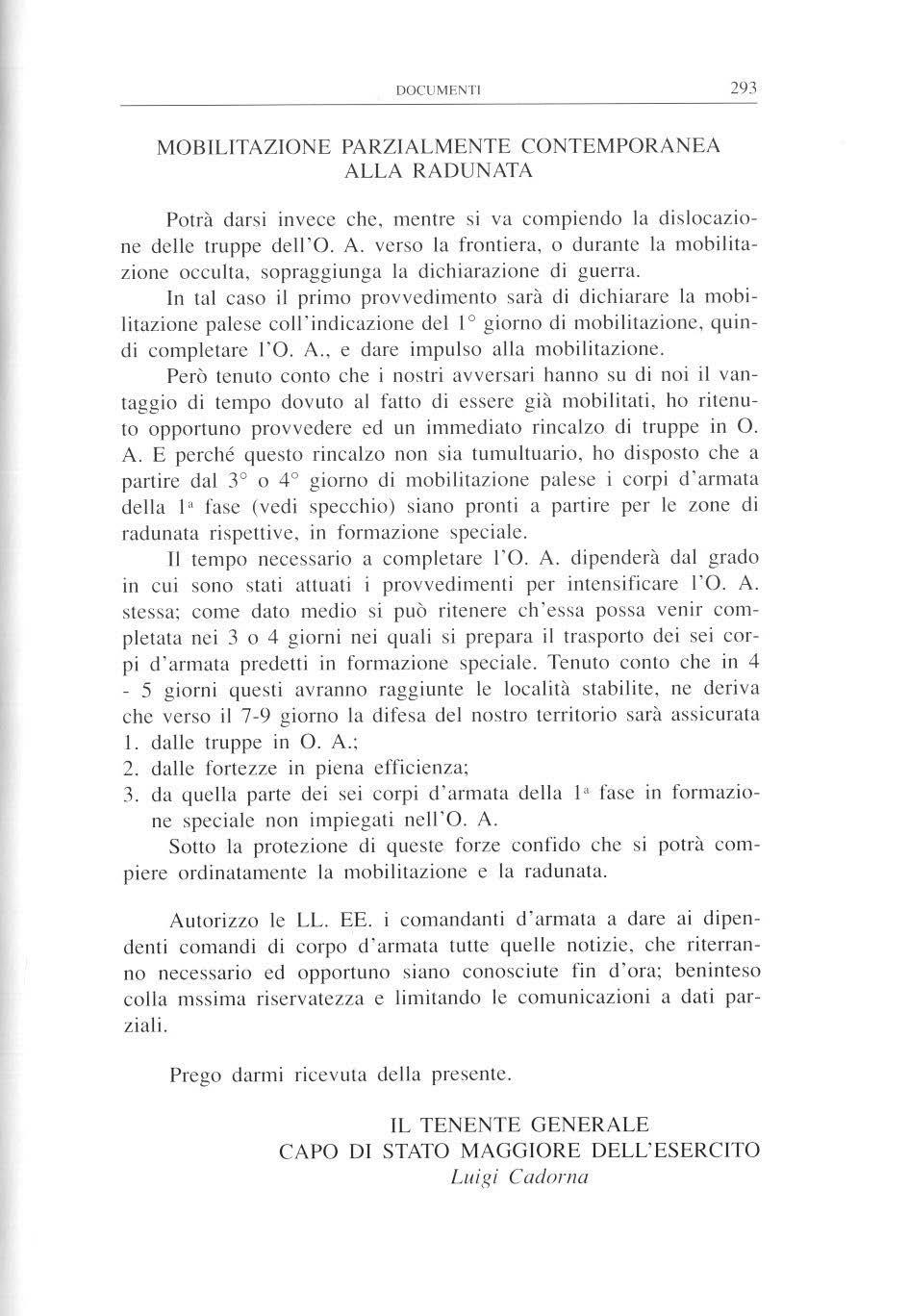
In tal caso il primo provvedimento sarà di dichiarare la mobilitazione palese coli' indicazione del 1° giorno cli mobilitazione, quind i completare J'O. A., e dare impulso alla mobilitazione.
Però tenuto conto che i nostri avversari hanno su di noi il vantaggio di tempo dovuto a l fatto di essere già mobilitati, ho ritenuto opportuno provvedere ed un immediato rincalzo cli truppe in O. A. E perché questo rincalzo non sia tumultuario, ho disposto che a partire dal 3 ° o 4 ° giorno di mobilitazione palese i corpi d'armata della l" fase (vedi specchio) siano pronti a pa11ire per le zone di radunata rispettive, in formazione speciale.
TI tempo necessario a completare I 'O. A. dipencler~1 dal grado in cui sono stati alluati i provvedimenti per intensificare I'O. A. stessa; come dato medio si può ritenere eh 'essa possa venir completata nei 3 o 4 giorni nei quali si prepara il trasporto dei sei corpi d'armata predetti in formazione speciale. Tenuto conto che in 4 -5 giorni questi avranno raggiunte le località stabilite, ne deriva che verso il 7 -9 giorno la difesa del nostro territorio sarà assicurata
1. dalle truppe in O. A.;
2. dalle fortezze in piena efficienza;
3. da quella parte dei sei corpi d'armata della l " fase in formazione speciale non impiegati nell 'O. A. Sotto la protezione di queste forze confido che si potrà compiere ordinatamente la mobilitazione e la radunata.
Autorizzo le LL. EE. i comanda nti d'armata a dare ai dipendenti comandi cli corpo d'armata tutte quelle notizie, che riterranno necessario ed opportuno siano conosciute fin d'ora; beninteso colla mssima riservatezza e limitando le comunicazioni a dati parziali.
Prego darmi ricevuta della presente.
Luigi CadornaAllega to n. I al fogl io n. 94 R.
G. del 6 marzo 1915
TRAS PORTI
1a fase (durata complessiva
9 giorn i circa)
5 reggimenti r" guardia di finanza;
6 corpi d ' armata (I, III , TV, V, VI, V TTI ) meno le divisioni di mi li zia mobile; parco d ' assed io; batteri e pesanti campa li ; divi s ion i di cavalleria; aliquote se rvizi d'armata; derrate; treni ospedale .
TR ASP ORTI
2" fa se (d urata co mpl ess iva
5 g io rni circa)
4 corp i d'armata (Il, Vll , X, XI ) m eno le divi si oni di mili z ia mobile; comando s upremo e trupp e direttament e dipendenti ; se rvi z i d'armata; derrate; tr e ni ospedale .
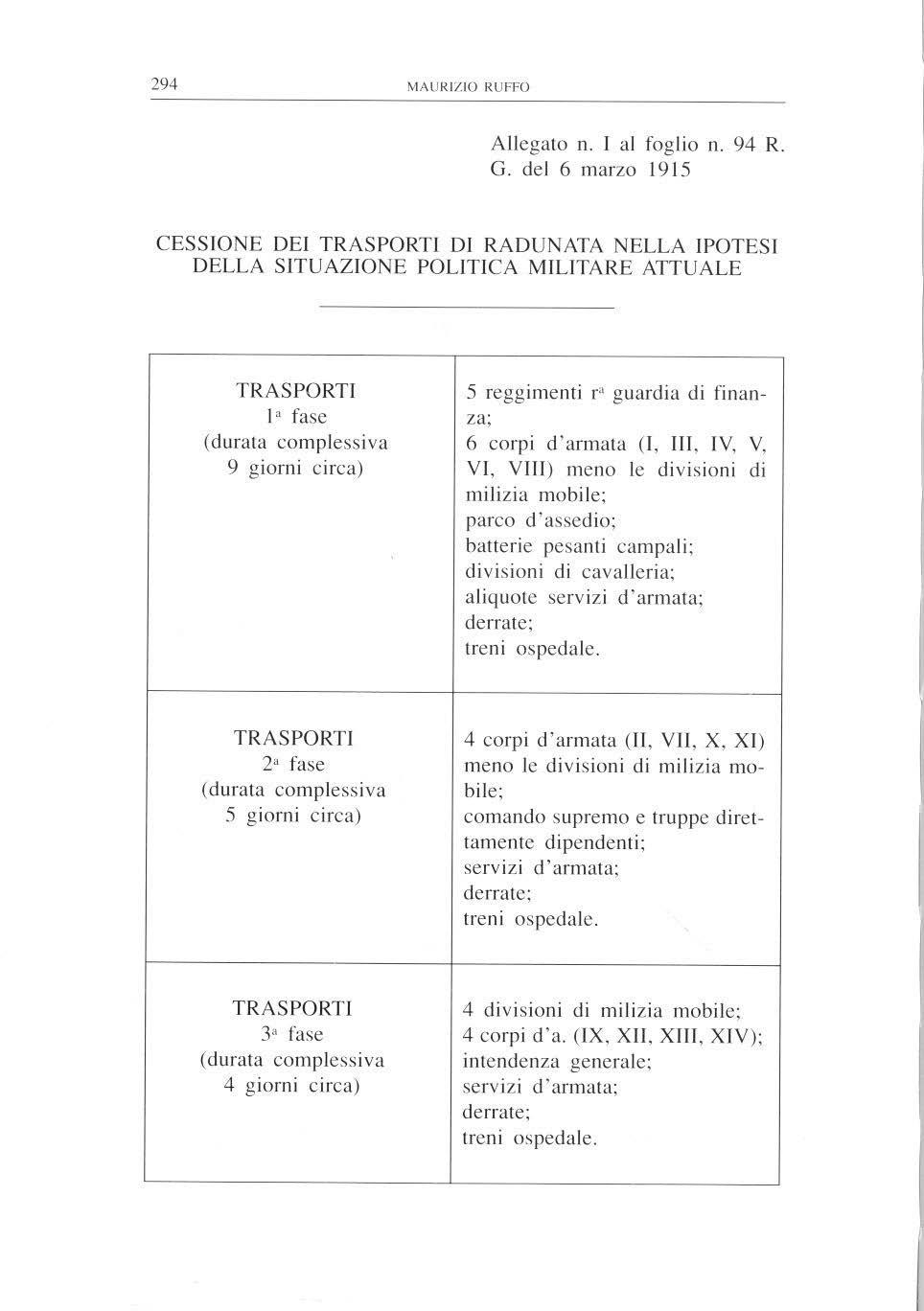
TRASPORT I
3a fase (durat a comp less iva
4 gio rni ci rca)
4 divi s ioni di mili z ia mobile; 4 co rpi d ' a. (I X, XU, XIJT, XIV ); in te nd e nza ge nera le; se r v iz i d'armata; derrate; tre ni ospedale.
Archivio Stor ico dell'USSME: Documenti Vari.
AA.VV.: ENCICLOPEDIA MILITARE, Milano 1933.
AA.VV.: I CAPI DI S.M. DELL'ESERCITO. USSME. Roma 1935.
AA.VV.: L'ESERCITO ITALIANO NELLA GRANDE (ìUERRA (1915 - 1918). USSME, Roma.
AA.VV.: STORIA D'ITALIA, UTET. Tor ino 1965.
Alberti Adriano: L'OPERA DI S. F.. IL. GENERALE POLLJO E L'ESERCITO, USSME, Roma 1923.
A lbcrlini Luigi: LE ORIG INI DELLA GUERRA DEL 1914, Bocca editori, Milano 1943.
Avarna di Gualtieri Car lo: L'ULTIMO RINNOVAMENTO DELLA TRIPLICE (5 DICEMBRE 19 12). Alpes Editore. Milano 1924.
Bcncivegna Roberto: SAGGIO CRIT ICO SULLA NOSTRA GUERRA. Tipografia Agostinia na, Roma l 930.
Biagini A ntone llo: L' ITALI/\ E LE GUERRE BALCANICHE, USSME. Roma 1990.
Brugioni Antonio: PIANI STRATEGIC I ITALIAN I ALLA V IG ILI A DELL'INTERVENTO NEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE, in Studi Storico-Militari 1984. USSME, Roma 1985.
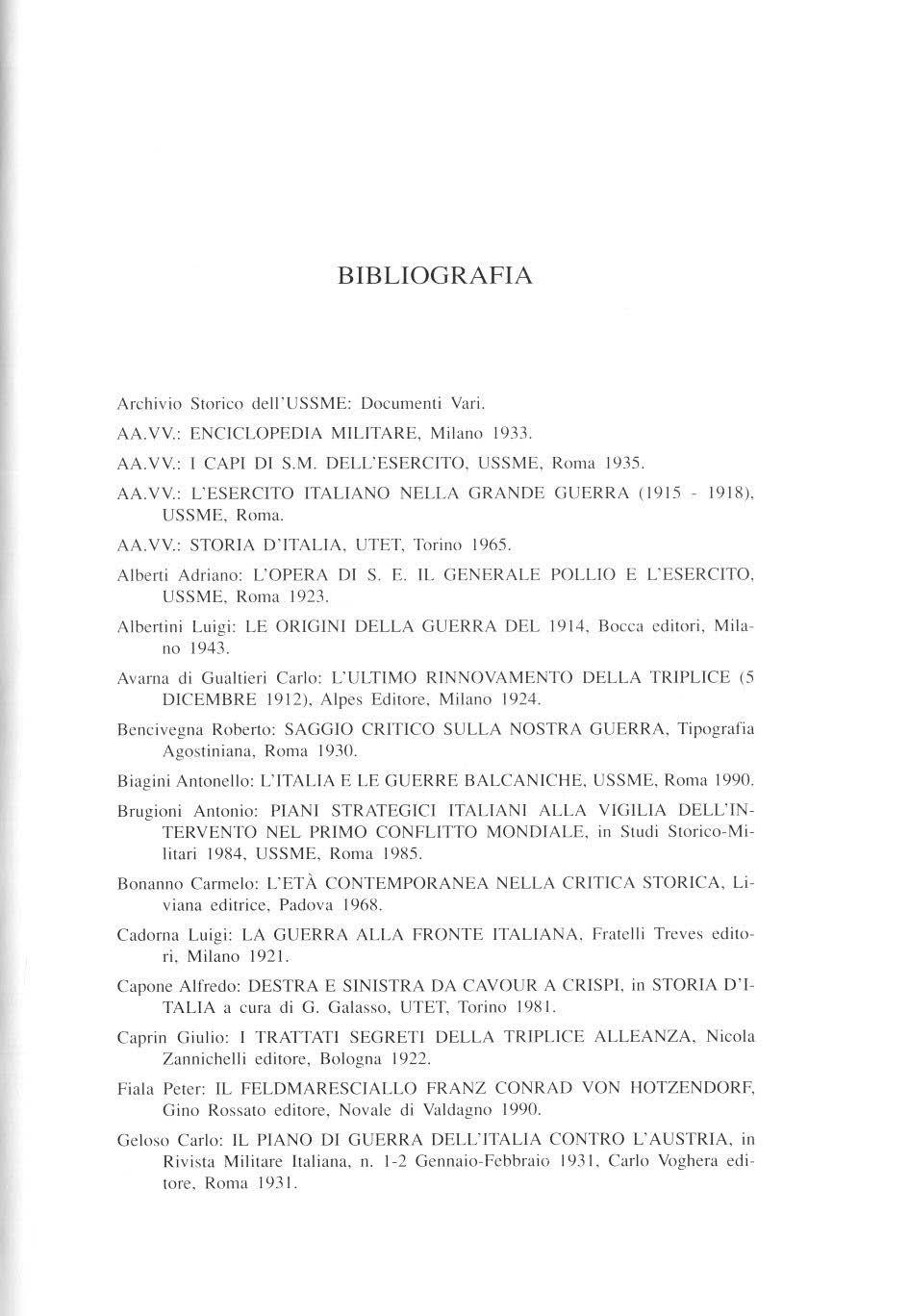
Bonan no Ca rm e lo: L'ETÀ CONTEMPORANEA NELLA CRIT ICA STORICA, Livia na ed itr ice Padova l 968
Cadorna Luigi : LA GUERRA ALLA F RONTE ITALIANA. Fratell i Treves editori. Milano I92 1.
Capone Alfredo: DESTRA E SINISTRA DA CAVOUR A C RI SPI, in STORTA D' ITALIA a c ura di G. Galasso, UTET, Torino 1981.
Capr in G iul io: I TRATTATI SEGRETI DELLA TRIPLICE ALLEANZA, Nicola Za nn ic hel Ii editore, Bologna 1922.
Fiala Peter: IL FELDMARESC IALLO FRANZ CONRAD VON IIOTZENDORF, G in o Rossato editore, Novale di Valdagno I 990.
Ge loso Carlo: IL PIANO DI GUERRA DEL.L'ITALIA CONTRO L'AUSTRIA, in Ri v ista Militare It al iana, n. 1-2 Genna io-Febbra io 1931. Ca rl o Voghera ed itore. Roma 1931.
ll er re Franz: FRANCESCO GIUSEPPE: Biblioteca Universa le Rizzo li. Milano 1982.
Mazzetti Massimo: L'ESERC ITO ITALI ANO NELLA TRIPLICE ALLEANZA. Edizioni Scientific he Italiane, Napoli I974.
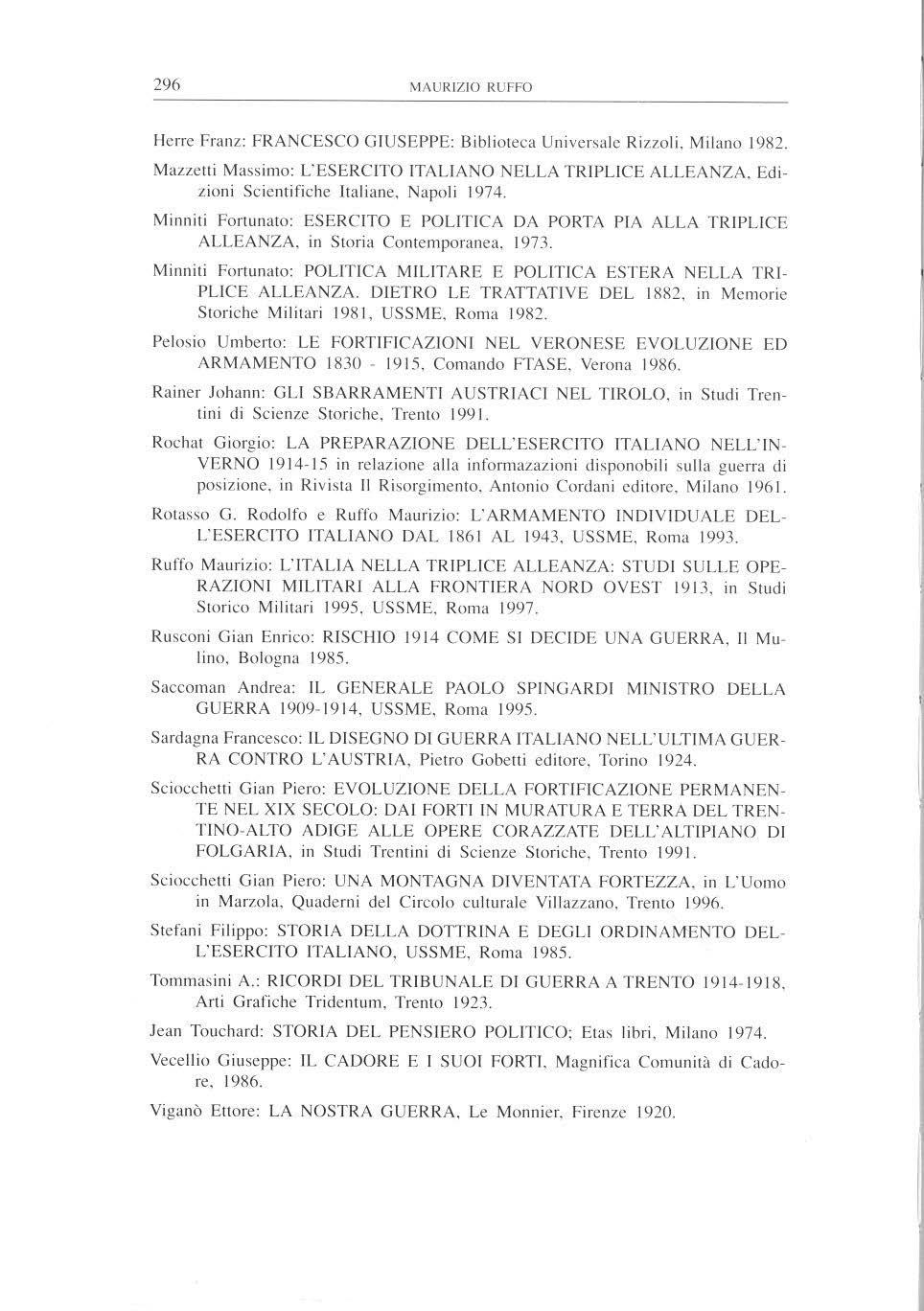
M in niti Fortu na to: ESERCITO E POLITICA DA PORTA PIA ALLA TRIPLICE ALLEANZA. in S tor ia Contemporanea. I 973.
Minniti Fo rt u nato: POLIT ICA M ILITARE E POLITICA ESTERA NELLA TRIPLICE ALLEANZA. DIETRO LE TRATTATIVE DEL 1882. in Memorie Storiche Mi l itar i 198 1, USSME. Roma 1982.
Pe losio Umberto: LE FORTIFICAZIONI NEL VERONESE EVOLUZIONE ED ARMAMENTO 1830 - 1915 , Comando FTASE, Verona 1986.
Rainer Johann: GLI SBARRAMENT I AUSTRIACI NEL TIROLO. in Studi Trent ini di Scie nze Storiche, Trento 1991.
Rochat Giorgio: LA PREPARAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO NELL'INVERNO 1914-15 in re lazione alla informazazion i disponobi li sul la guerra d i pos iz ione. in Rivista Il Ri sorgime nt o. Antonio Cordan i edito re. Milano I96 1
Rotasso G. Rodolfo e Ruffo Maurizio: L'ARMAMENTO INDIVIDUA LE DELL'ESERCITO ITALIANO DAL 186 1 AL 1943. USSME. Roma 1993.
Ruffo Mau rizio: L'ITALIA NELLA TRIPLICE ALLEANZA: STUDI SULLE OPERAZIONI MILITARI ALLA FRONTIERA NORD OVEST 1913. in Studi Swrico M il itari 1995. USSME, Roma 1997.
Ruseoni Gian Enr ico: RISCHIO 1914 COME SI DECIDE UNA GUERRA. Il Mulino. Bologna 1985.
Saccoman And rea : IL GENERALE PAOLO SPINGARD I MINISTRO DELLA GUERRA 1909- 1914, USSME. Roma 1995.
Sa rdagna Francesco: IL DISEGNO DI GUERRA ITALIANO NELL'ULT IMA GUERRA CONTRO L'AUSTRIA. Pietro Gobetti editore, Torino 1924
Sc iocchett i Gia n Piero: EVOLUZ IONE DELLA FORTIFICAZIONE PERMANENTE NEL XIX SECOLO: DAI FORTI IN MURATURA E TERRA DEL TRENTINO -ALTO AD IGE ALLE OPERE CORAZZATE DELL'ALTIPIANO DI FOLGAR IA, in St udi T re ntin i di Scienze S tor iche, Tren to 1991.
Sc iocchetti Gia n Piero: UNA MONTAGNA DIVENTATA FORTEZZA , in L'Uomo in Marzola. Quaderni del Circolo c ult u rale Vil lazza no. Trento 1996.
Stefani Fil ippo: STOR IA DELLA DOTTRINA E DEGLI ORD INAMENTO DELL'ESERCITO ITALIANO, USSME, Roma 1985.
Tommas ini A. : RICORDI DEL TR IB UNALE DI GUERRA A TRENTO 19 14 - 19 18. Arti Grafic he Trid e ntum , Trento 1923.
Jean Touc hard: STORJA DEL PENSIERO POLITICO; Etas lihr i. Mi lano 197 4.
Vecellio G iu sep pe: IL CADORE E I SUO I FORTI. Magnifica Comunità di Cadore. 1986.
Viganò E uore: LA NOSTRA GUERRA. Le Monnier, F ire nze 1920.
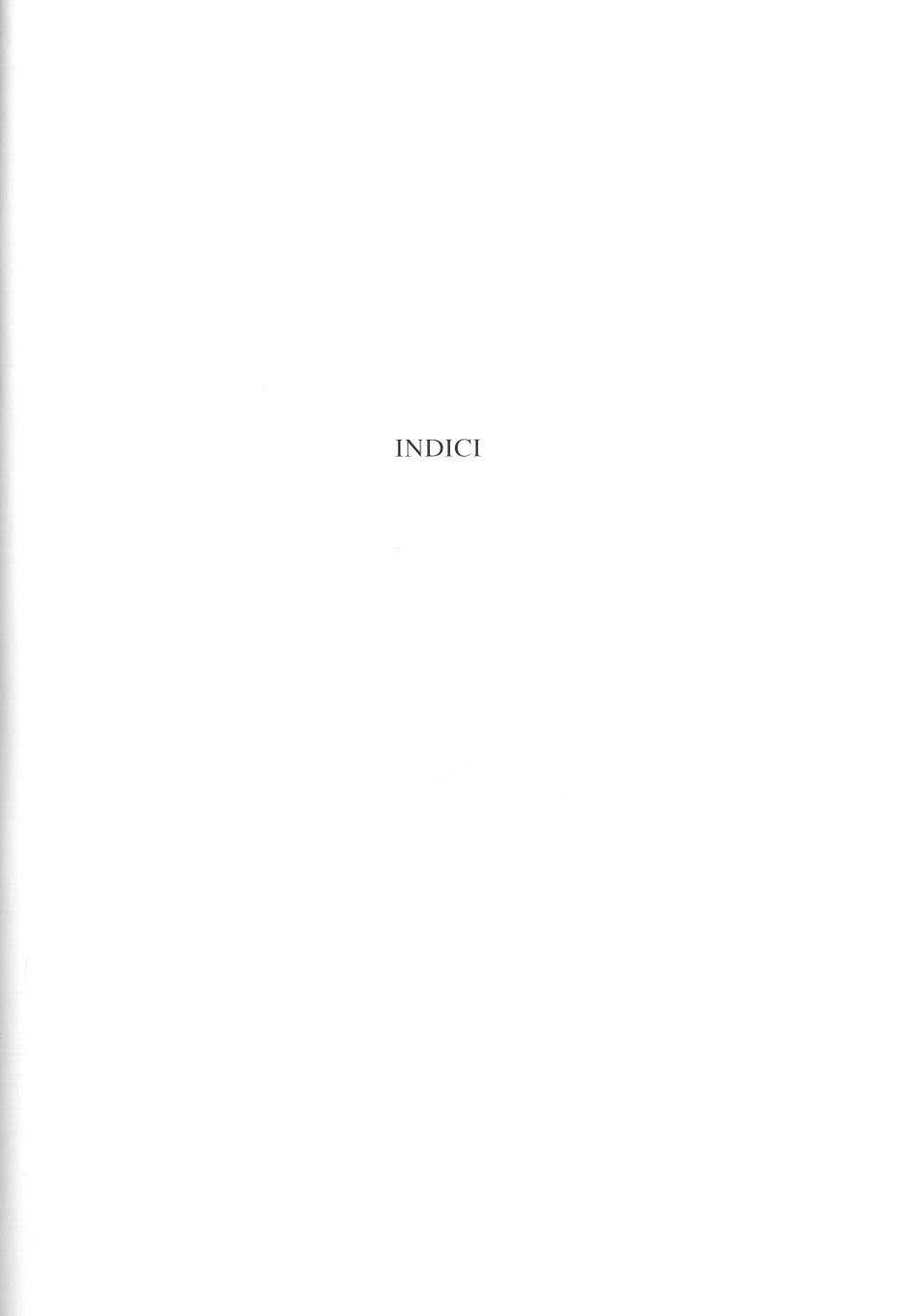

N. Ali. S intes i del co nten uto pag. Al i.
I Primo Trattato della Triplice Alleanza 187
2 Patto di Londra
3 Forre I l enscl o di Malborghello
4 Forti Predi i ed He1mann e Chiusa di F l i1sch
5 Piazza cli Fortezza
6 Stralcio da relazione del viagg io cli SM 1886 ( ritirala de l l' esercii o naziona le dal la l inea del Piave al l a l i nea Vicenza-Padova - Mes1re) 215
7 Prom emori a co ntenente la t rad uz ione dell'articolo del Deu1 sche, Vo lksb lau de l I marzo 1907 223
8 L e A rm ate 2• e 3" nella radu nala Nord-Es t 227
9 Co nsidera z ioni sull e prop os te con1enu 1c nel l a r elaz ione i ntorn o al progetto cli mobilitaz ione e radunata verso la fromiera N.E. 23 1
10 Stralc i o da relazione de l viaggio d i SM 1904
(S1 udi par!i co l ari - 5° la mob ilitazione e la radunaia de l l'eserc ito ital iano all a frontiera nord-orie ntale) 237
11 Stralc: io da relazi one de l viaggio di SM 1904
($1 udi pan icola ri - 2° studio comparativo delle reti ferrovi arie ita li ana cd austr iaca) 247
12 Stralcio da I stru zione per la difesa d elle cos te e per l a pro tez ione delle ferrovie in guerra 255
I 3 Stud io per interru zio ni della l inea fe rrovia ri a de l Pusterthal 257
14 Breve memo ria circa uno stu dio per l'offe n,i va de lla 2 " armata su V i llach - Kla ge nfurt 28 1
15 M ob i l ita zione e rad unata rossa 291
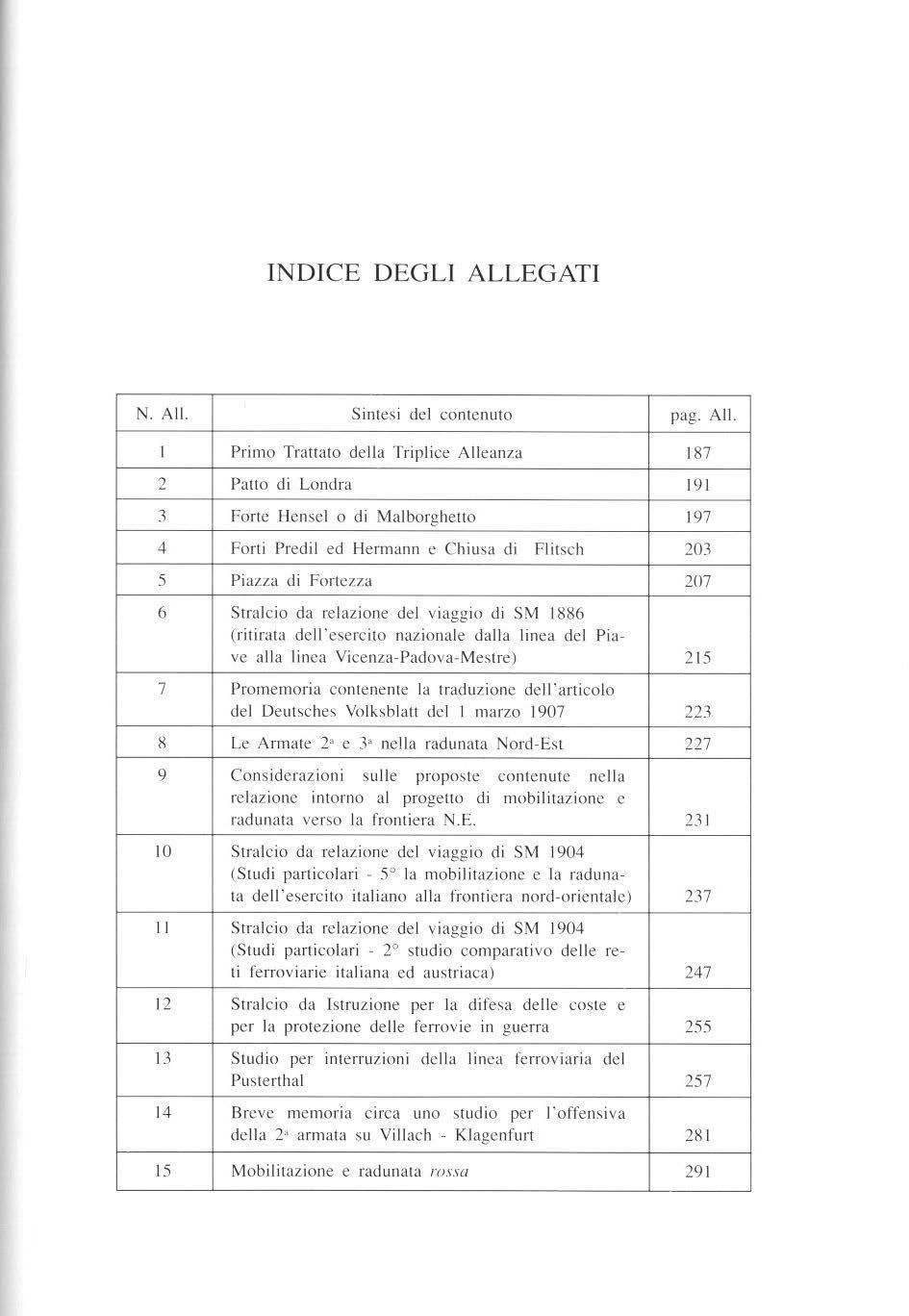

Aehrenthal (A lois Lexa von) 30. 31, 33.
A lessandro lll (Zar) 18.
Andrassy (Gyula Conte) 13 , 14 , 16.
Bava Beccaris (Gen ) 109.
Berchtold (Leopold Conte) 33, 36.
Bertolè 40, 41.
Bevione (On.) 39, 195.
Bismarck (Otto von Principe) 13 , 16, 18, 25, 27, 31.
Bi.ilow (Bernard von) 14 , 29, 36.
Cadorna (Luigi Gen.) 12, 34, 41, 43, l l9. 120, 121, 143, 144 , 145, 146, 147, 148, 149 , l50, 151, 152 , 162, 164 , 165. 166, 167, 168, 169. 172. 173, 174, l75, 176, 177 , 178, 179, 180, 181, 182. 183, 289, 293.
Casana 40.
Cas ta gno la (F. Cap.) 78, 79, 90. 92.
Conrad (Franz Gen.) 30, 31, 32, 33, 39, 87, 88, 92, 136, 153, 154.
Corti (Conte Luigi) 14 , 16 , 17.
Cose nz (Enrico Gen. ) 45, 46, 47,
48.49, 52, 55, 58, 62, 68, 72, 73, 76, 77, 83, 96, 98, 111, 122, 129 , 132 , 145. 179. 180. 181 , 182, 183.
Crispi (Francesco) 19, 26, 27.
Depretis ( Luigi ) I 9.
Disraeli (Lord Beaconsfield) 14.
Ferrero (Gen.) 40, 41, 48, 75.
Francesco Giuseppe ( Im peratore) 18, 23, 29, 30. 3 1, 32, 136.

Francesco Ferdinando 31, 136.
Gar ib ald i (Giu seppe) 16.
Giolitti (Giovanni) 32, 43.
Gorciakof 14.
Guglielmo T ( K a ise r) 18.
Guglielmo TT (Kaiser) 26, 28, 154.
Haid ec kt 90, 146.
Kalnoky (Gustav Conte) 19 , 25.
Kleist 34 .
Konnen von H orack 87.
Mcrey 35.
Mezzaca po (Gentile) 40, 75.
Mo ltk c (Hclmu t ) 30, 74, 136.
154
Monts 28.
Napoleone lii 16.
Oberda n (Gug li e lm o) 23.
Ottolenghi (Gi useppe Gen.) 42.
Pel loux (Gentile) 40.
P errucchetti (Giuse ppe Gen.) 114.
Pollio (A lb er to Gen.) 34 . 42, 43,
.
Ponza di San Martino (Cesa re Gcn.) I 39, 152.
Prati (Giovanni) 23.
Prinetti 25.
R agni ( Gen. ) 146. 149.
Reuss (Enrico VII di P rincipe)
19. 187. 189 .
Ricotti
San Giu li ano (A n tonio di M archese) 33, 36.
Sigray di S. Marzan o (Vittor io Cap.) 32.
Schlieffen (Alfred von Gen.) 27.
Scrivante (Ge n. ) 144.
Si lva ( Pie tro ) 18
Sonnino (Sidney B arone) 36 . 37, 38, 39.
Spingardi ( P ao lo Gen.) 40, 4 1, 42.43.98, 102.108.109.110, 136.
Stazza (Francesco Ge n. ) 139.
Tancredi Saletta (Gen.): vds. Sale tta
Ta verna ( Rin aldo Gen. ) I 09.
Tccchio (Sebastiano) 23.
Tittoni 30.
Umberto I (Re) 21.
Viale 40, 4 1, 126 .
Viganò (Ettore Ten. Col.) 46. 77.
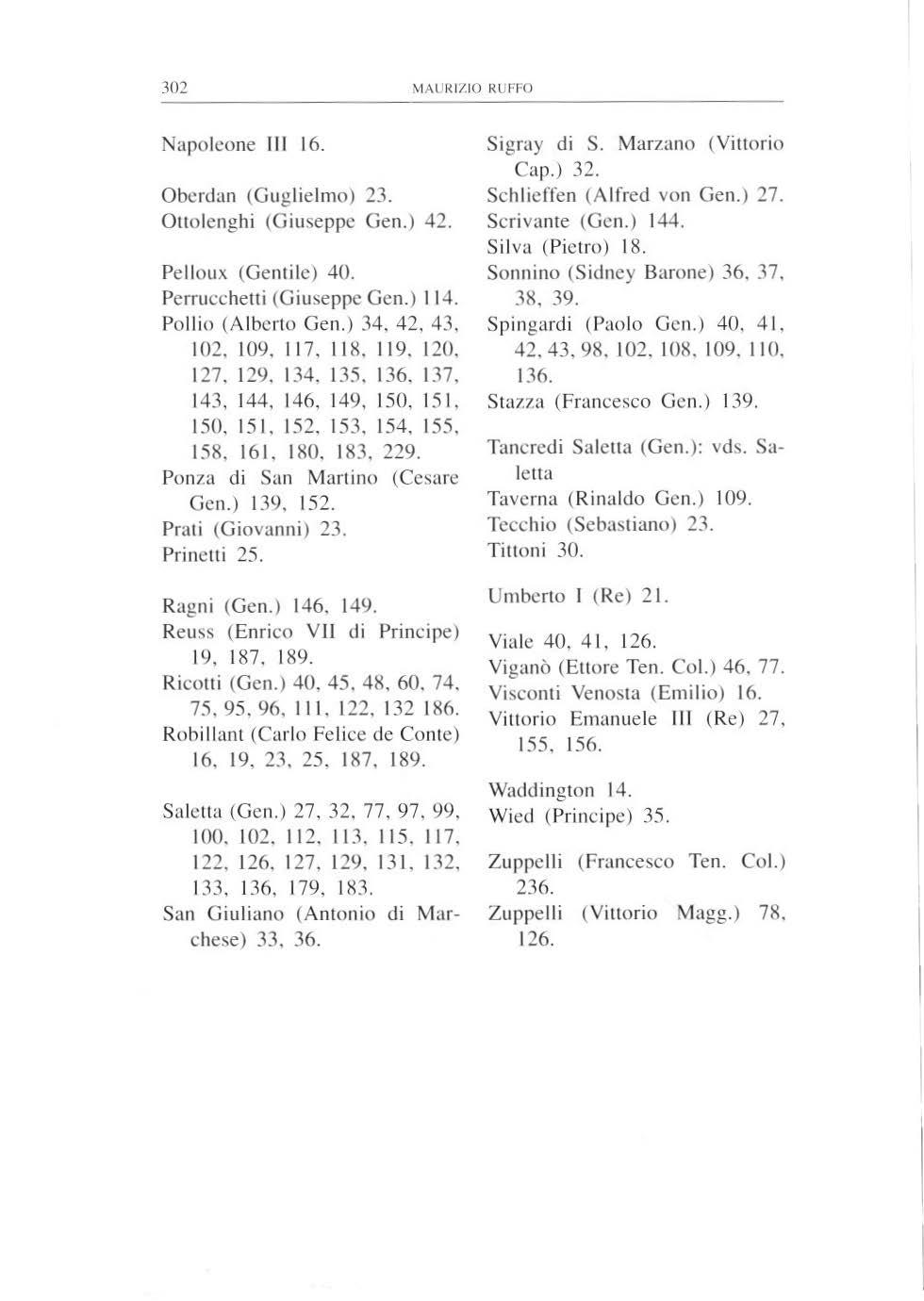
Visconti Venosta (E milio ) 16.
Vittorio Emanuele 111 ( R e) 27, 155. 156.
Waddington 14.
Wi ecl ( Prin c ip e) 35.
Zuppelli (Francesco Ten. Col.) 236.
Zuppelli (Vittorio Magg.) 78. 126.
Adelsberg 51.
Adige 59, 60, 61, 95, 96. 99, 132 , 139, 180, 184, 192, 207, 226, 247, 258, 269 .
Adige (va l) 57, 58, 273, 275.
Adria 77, 217.
Adriatico 23, 31, 33, 39, 119, 127, 193, 258 .
Africa 16. 25, 28, 31, 33, 41, 194.
Agno 175.
Agram 165.
Albania 33, 35, 193, 194.
Albaredo 60.
Alcssandretta 13.
Alessandria 118.
Algcciras 28.
Alpi 37, 65, 66, 67, 70. 71, 74, 150, 192, 28 I , 284, 285, 288.
A lsazia 28, 45.
Altamura 119.
A lt ipiano dei Sette Comuni l 00.
A lto Adige 50, 90.
Ampezzano 51.
Ancona 50, 250, 256.
Antivari 38, 165 , 193.
Armenia 13.
Arnoldstein 71, 284.
Arzino (valle) 144.
Asiago 54, 117, 224.
Assa (va l) 54, 68 , 87, 100, I I 3, 127, 175.
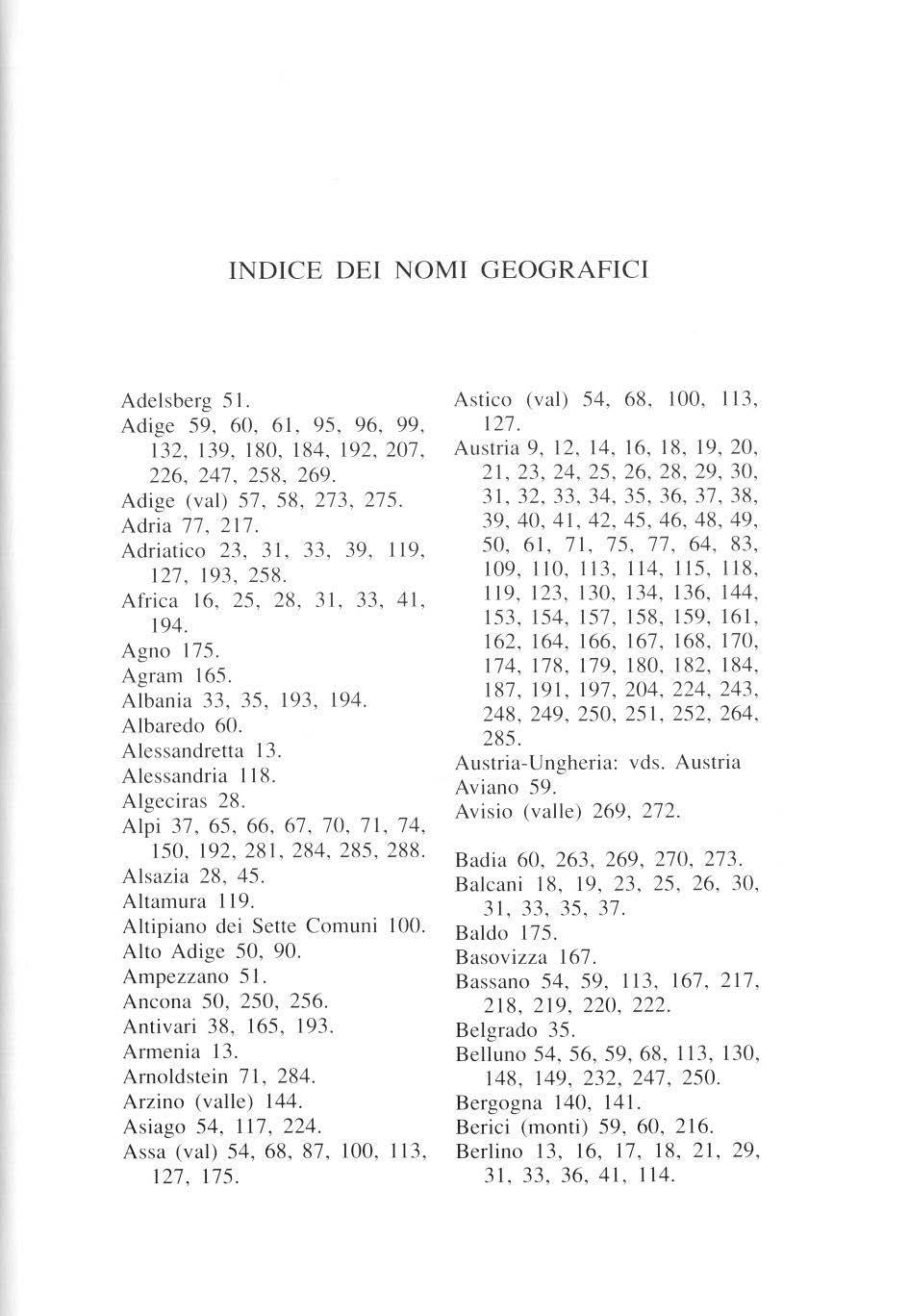
Astico (va l) 54, 68, I 00 , 113 , 127.
Austria 9 , 12. 14, 16, 18, 19, 20, 21. 23, 24, 25,26,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40,4 1,42,45,46, 48, 49, 50, 61, 71, 75, 77, 64, 83, l 09, I I O, I I 3, 114, 115, 118, 119 , 123, 130, 134, 136. 144. 153, 154 , 157, 158 , 159 , 161, 162, 164, 166 , 167, 168, 170, 174 , 178 , 179 , 180, 182 , 184, 187, 191, 197 ,204, 224, 243, 248,249,250,251,252,264, 285.
Austria-Ungheria: vds. Austria
Aviano 59.
Avisio (valle) 269, 272.
Badia 60, 263, 269, 270, 273.
Balcani 18, 19 , 23, 25, 26, 30, 31, 33, 35, 37.
Baldo 175.
Basovizza 167.
Bassano 54, 59, 113 , 167, 2 17, 2J 8, 219, 220, 222.
Belgrado 35.
Belluno 54, 56, 59, 68, 113 , 130, 148 , 149, 232, 247, 250.
Bergogna 140 , 141.
Bcrici (monti) 59, 60 , 216.
Berlino 13 , 16, 17, I 8, 21, 29, 31, 33, 36, 41, 114.
Bernadia 151, I 52, 229.
Boara 60.
Boite (valle) 68, 146.
Bologna 139 , 233, 234, 256.
Bolzano 37, 50, 64, 93, 137 , 138, 169. 180, 181 , 270.
Bosforo 16.
Bosnia -Erzegovina I 3, 14, 16, 28, 30, 41.
Bozen: vds. Bolzano Brennero
Brenta (va l) 54, I 00, 109, 113, 136, 15 7, 2 18 , 252
Brescia 54, 55, 11 2, 11 8, 247, 250.
Bressa none 137, 169, 207, 208.
Bruck 67.
Brunico 138. 258, 259, 260, 261, 263, 264, 268, 269, 270.
Budapest I 81.
Buja I 52, 229.
Bulgaria 13, 14.
Bus de Vela 84.
But (va ll e) 144, 228, 282. 283, 284, 287, 289.
Cadore
Cagli
Calchi 35.
Calino 35.
Campeon-Faeit 151.
Campoformido 175.
Canale 141.
Cana le di Sicilia 17.
Candelù 119 .
Cansiglio 146, 149.
Caporetto 69, 70, 78, 141, 176, 203, 284.
Capua 111.
Caravanche (A lpi ) 65, 66, 67, 71, 74.
Carinzia 75, 97, 174, 224, 258.
Carnia 144, 145, 151, 157, 166, 16 7, 169, 17 1, 173, 174. 175, 176, 178, 197, 284, 285, 287, 291.
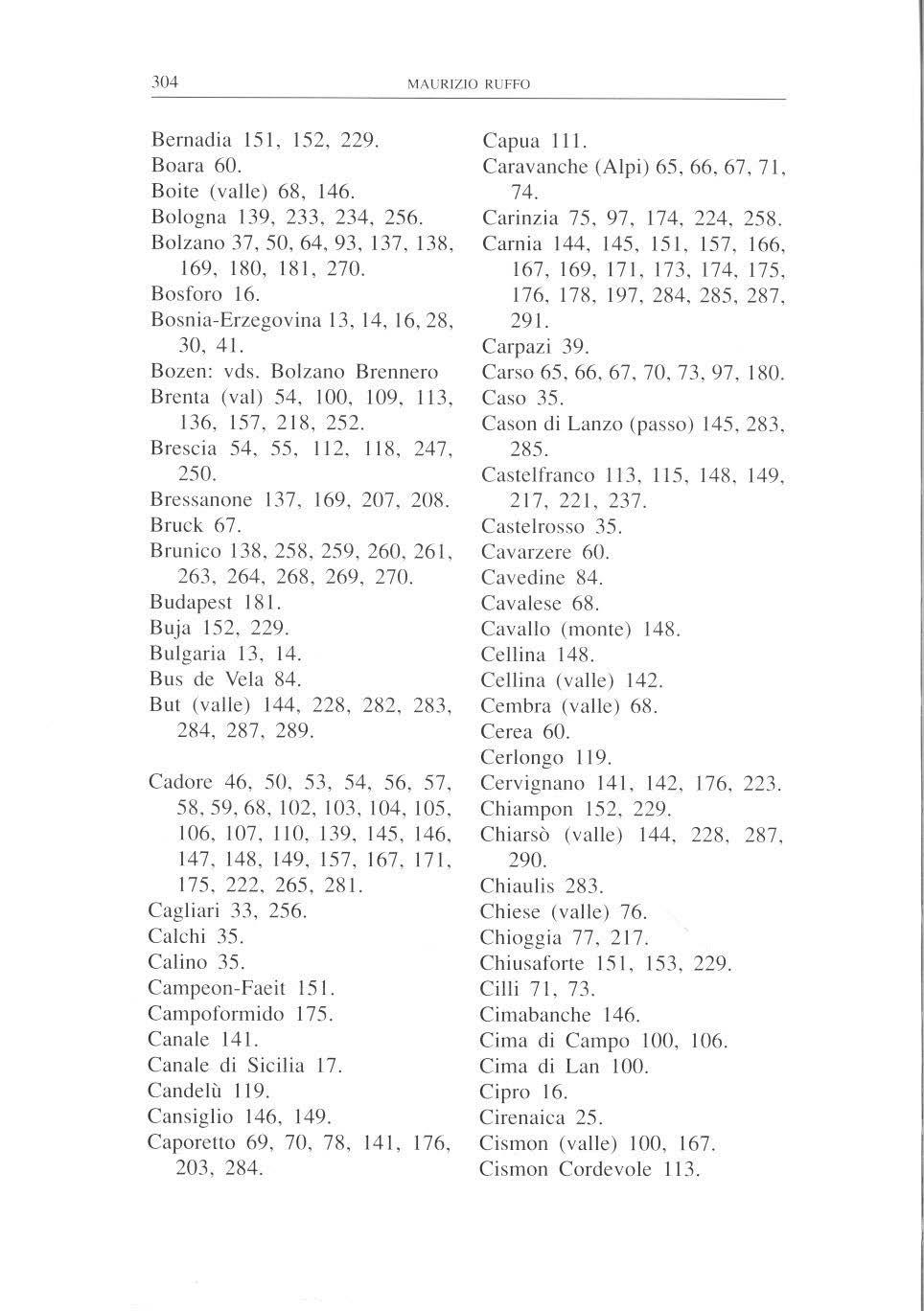
Carpazi 39.
Carso 65. 66, 67, 70. 73, 97, 180.
Caso 35.
Cason di Lanzo (passo) 145, 283, 285 .
Castelfranco 113, 115, 148, 149, 217, 221, 237.
Caste lro sso 35.
Cavarzere 60.
Cavedine 84 .
Cava lese 68 .
Cava ll o (monte) 148.
Cell ina 148.
Cellina (val le) 142.
Cembra (valle) 68.
Cerea 60.
Cerlo ngo 119.
Cervignano 141, 142,176,223.
Chiampon 152, 229.
Chiarsò (va ll e) 144, 228. 287, 290 .
Chiaulis 283.
Ch iese (valle) 76.
Chioggia 77, 217.
Chiusaforte 151, 153, 229.
Cilli 71, 73.
Cimabanche 146.
Cima di Campo 100 , J 06.
Cima di Lan 100.
Cipro 16.
Cirenaica 25 .
Cismon (val le) 100, 167.
Cismon Cordevole I I 3.
Cittadella 55, 59, 221.
Civezzano 84, 85.
Cividale 69, 78, 145, 151, 175.
Claut 146.
Codroipo 110 , 118 , 141. 142 , 157.
Coglio 166.
Col Colat 152 , 229.
Col Ronconc 15 2, 229.
Colle Alto 146. 147.
Comiell i 152, 229.
Como 118.
Conegliano 56, 112 , 120.
Coo 35.
Cordcvole 68, 146 , 147, 148 , 149 , 171 , 263, 268, 269.
Cormons 141. 167.
Cornuda 54, 113, 148, 218, 219, 221.
Cortina 51, 78, 93, 146. 226.
Costantinopoli 13.
Cremona 54, 55.
Croce Domini 175.
Crocetta 60.
Crostis (monte) 175 , 285.
Dalmazia 92, 192, 193, 225.
Danzouno 76.
Dardanelli 16.
Degano (valle) 144, 282, 287, 288, 289.
Desenzano 167.
Dignano 151.
Di sgrazia (mo nt e) 11 8.
Dobbiaco 46, 50, 58, 64, 65, 68, 90, 93. 98. I 38, 146, 169, 174, 175, 180, 181, 258, 259, 261, 270.
Doclccaneso 35.
Dogna (va llone) 71, 287.
Dolent (monte) 118.
Dolo (ca na le) 59 , 215, 216.
Dolomiti 42. 226 .
Do s di Sponde 76.
Do ssob uono 55.
Drava 67, 74, 258 .
Drava (valle) 50, 56, 66, 69, 71, 72, 73. 138, 145, 169 , 171 , 174, 175, 180 , 197,207,259, 260, 281, 284, 288.
Egeo 13, 23.
Egitto 28.
Eisack 174.
Ercole (monte) 152, 229.
Eritrea 21, 46.
Euganei ( monti) 59, 60, 216.
Europa 9, 17, 18, 20, 24, 183, 187.
Faeit-Campeon: vds CampeonFaei t
Fagagna 151, 152. 229.
Falzarego (passo) 78, 79, 226.
Fassa (valle) 68, 226.
Felclkirchcn 67, 73.
Fella (va ll e) 65, 66, 67, 70, 71, 72, 144, 145 , 197, 198, 200, 229.
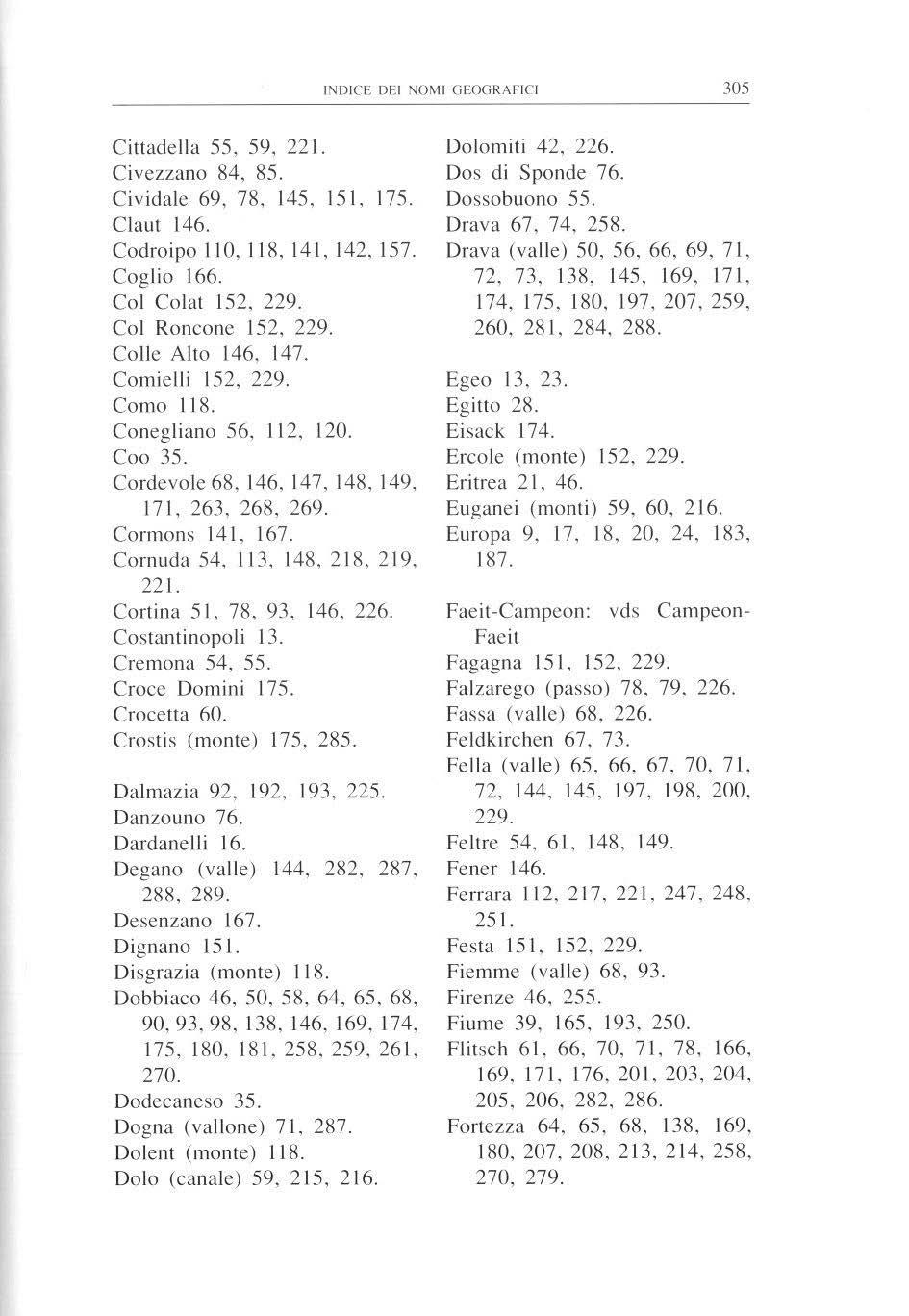
Fe ltre 54, 61, 148, 149.
Fener 146.
Ferrara I 12. 217, 221, 247, 248, 25 1.
Festa 15 1, 152 , 229.
Fiemme (valle) 68, 93.
Firenze 46, 255.
Fiume 39, 165, 193, 250.
Flitsch 61, 66, 70, 71, 78, J66, 169. 171,176,201,203,204, 205, 206, 282, 286.
Fortezza 64, 65, 68. 138, 169 , 180, 207, 208. 213, 214, 258, 270, 279.
Francia 11, 14, 16 , 17, 18, 19.
20, 21, 23, 24, 25, 26 , 27, 28,
29, 31, 32, 33, 34, 37, 39,40,
45, 95, 1 11 , 11 8, 123 , 153, 161, 162, 164, 179, 182, 188,
19 l , 19 3, 194, 19 5.
Frascati 11 9.
Friuli 46, 49, 52, 66, 67, 84, 97 , 108,109,117,133,139 ,140, 157, 158, 165, 168, 175 , 229, 248, 249, 251.
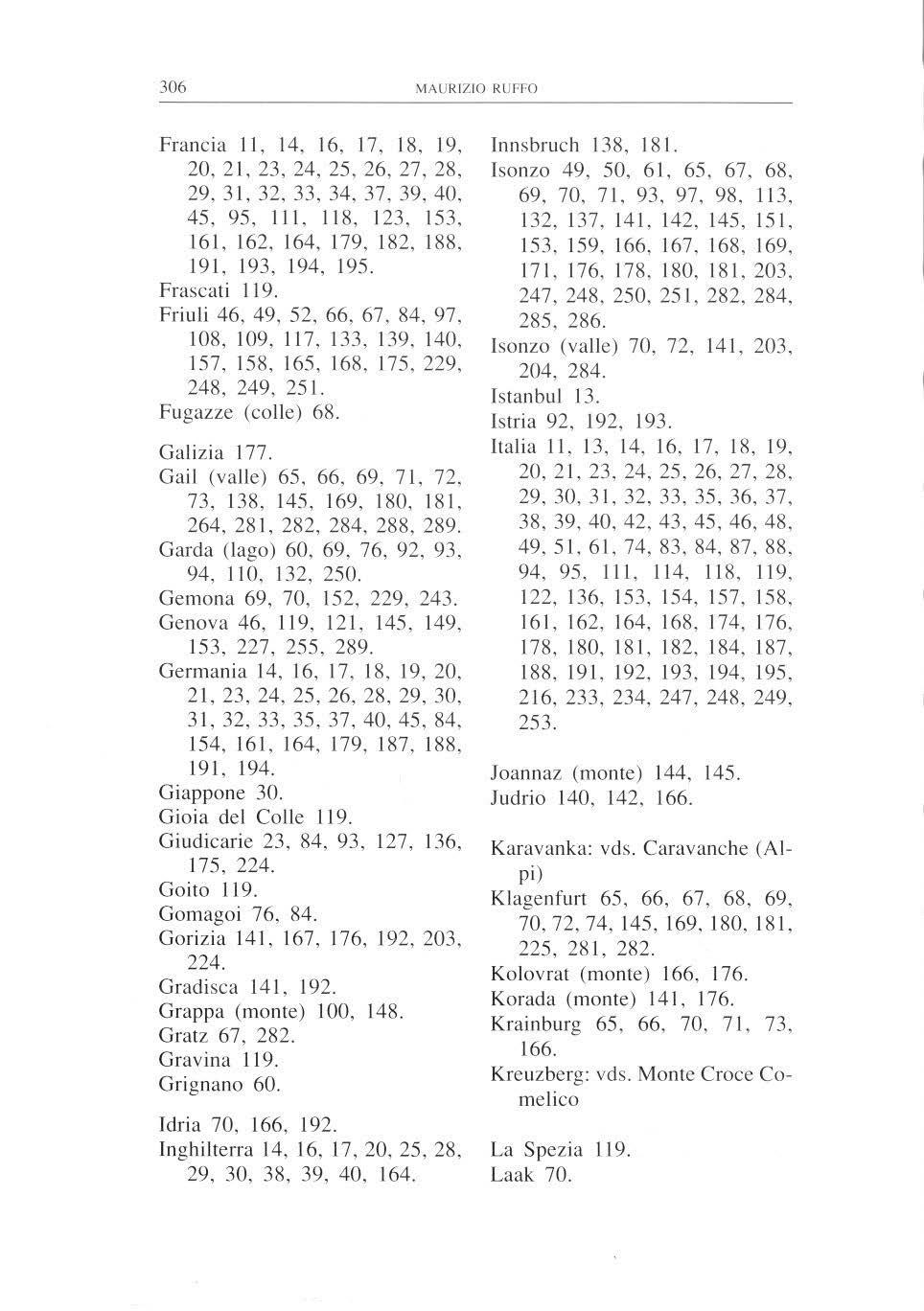
Fugazze (co ll e) 68.
Galizia 177.
Gail (valle) 65, 66, 69, 71, 72, 73, 138 , 145, 169, 180, 181 , 264, 281, 282, 284, 288 , 289.
Garda (lago) 60, 69, 76, 92, 93, 94, 11 O, 132, 250.
Gemona 69, 70, 152, 229, 243 .
Genova 46, 119 , 121, 145, 149 , 153, 227, 255, 289.
Germa ni a 14, 16 , 17 , 18, 19, 20,
21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30,
31, 32 , 33, 35, 37, 40,45, 84,
154, 161, 164, 179, 187 , 188 , 191, 194.
Giappone 30.
Gioia del Colle 119.
Giudicarie 23, 84. 93, 127, 136, 175, 224.
Goito 119.
Gomagoi 76, 84
Gorizia 141 , 167, 176, 192 , 203, 224.
Gradisca 141, 192.
Grappa ( m o nte) 100 , 148.
Gratz 67, 282.
Gravina 119.
Grignano 60.
Idria 70 , 166 , 192.
In g hilte rr a 14, 16, 17, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 164.
Tnn sbruch I 38, I 8 1.
I so nzo 49, 50, 61, 65 , 67, 68, 69, 70, 71, 93, 97, 98, 113, 132, 137, 141 , 142, 145, 151, 153 , 159 , 166 , 167, 168 , 169, 171 , 176 , 178. 180 , 181 ,203, 247,248 , 250,251,282,284, 285, 286 .
Isonzo (va ll e) 70, 72, 141, 203, 204, 284.
Istanbul I 3.
Istria 92, 192, 193.
Italia 11, 13 , 14 , 16, 17 , 18, 19, 20,21, 23, 24,25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42,43, 45, 46,48, 49, 51, 61, 74, 83 , 84, 87, 88, 94, 95, l 11 , 114, 1 18 , 119 , 122, 136, 153, 154, 157 , 158 , 16 1, 162, 164, 168, 174 , 176, 178, 180, 181,182 , 184 , 187, 188, 191 , 192, 193, 194, 195, 216,233,234,247,248,249, 253.
Joannaz (monte) 144, 145.
Judrio 140 , 142, 166.
K aravanka: vds . Caravanche (A lpi)
Klagenfurt 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 145, 169, 180 , 181 , 225, 281, 282.
Kol ovra t (mo nte) 16 6, 176.
K orada (monte) 141, 176 .
Krainburg 65 , 66, 70, 71, 73, 166 .
K rc uz berg: vds. Monte Croce Comelico
La Spezia I 19.
Laak 70.
Lagarina (valle) 54, 68 , 170.
Laibach: vds. Lubian a
Landro 68, 146 , 174, 261.
Lard aro 76, 84, 99 , 224.
Larino 76 , 84
Lati sana 110, 118, 141, 142 , 157.
La varo ne (a ltipiano ) 58 , 64, 68 , 87, 88 , 99, 102.
Lavis 68.
Ledra 152 , 229.
Ledro 76, 84 , 224 .
Legnago 54, 55, 60 , 94, 112, 121 , 130, 217, 220, 221.
Leibnit z 67.
Lendinara 60.
Leogra (valle) 54, 58 , 252.
Lero 35 .
Less ini ( monti ) 54, 68, 168, 175 , 216 .
Libia 31, 43, 119, 136, 194 , 195 .
Li g uria 114.
Li sser ( mo nt e) 11 9, 166.
Lisso 35.
Livenza51 , 53,56,59 , 13 2, 148, 149, 150.
Li vinallongo 51, 68.
Loeb e l (passo) 67.
Loben 67.
Lombardia 83, 114.
Lonato 54, 217.
Londra 38, 39, 177, 191 , 195.
Longare 54, 55.
Longarone 142 , 146, 150.
Lorena 28.
Lubiana 51 , 65, 66, 67 , 70 , 113 , 166, 174, 177 , 180, 281.
Maduna (va ll e) 144.
Maè 147 , 148, 171 , 175.
Maè (valle) 146 , 149.
Ma gg iore (monte) 139, 140 , 144 , 145, 165, 166 , 167, 170 , 171.
Ma lborgh e tto 61, 62, 63 , 65 , 66, 67, 70, 71 , 72, 74, 138, 145 , 166 , 169 , 171 , 174, 175, 181 , 197 , 282, 283 , 286, 287.
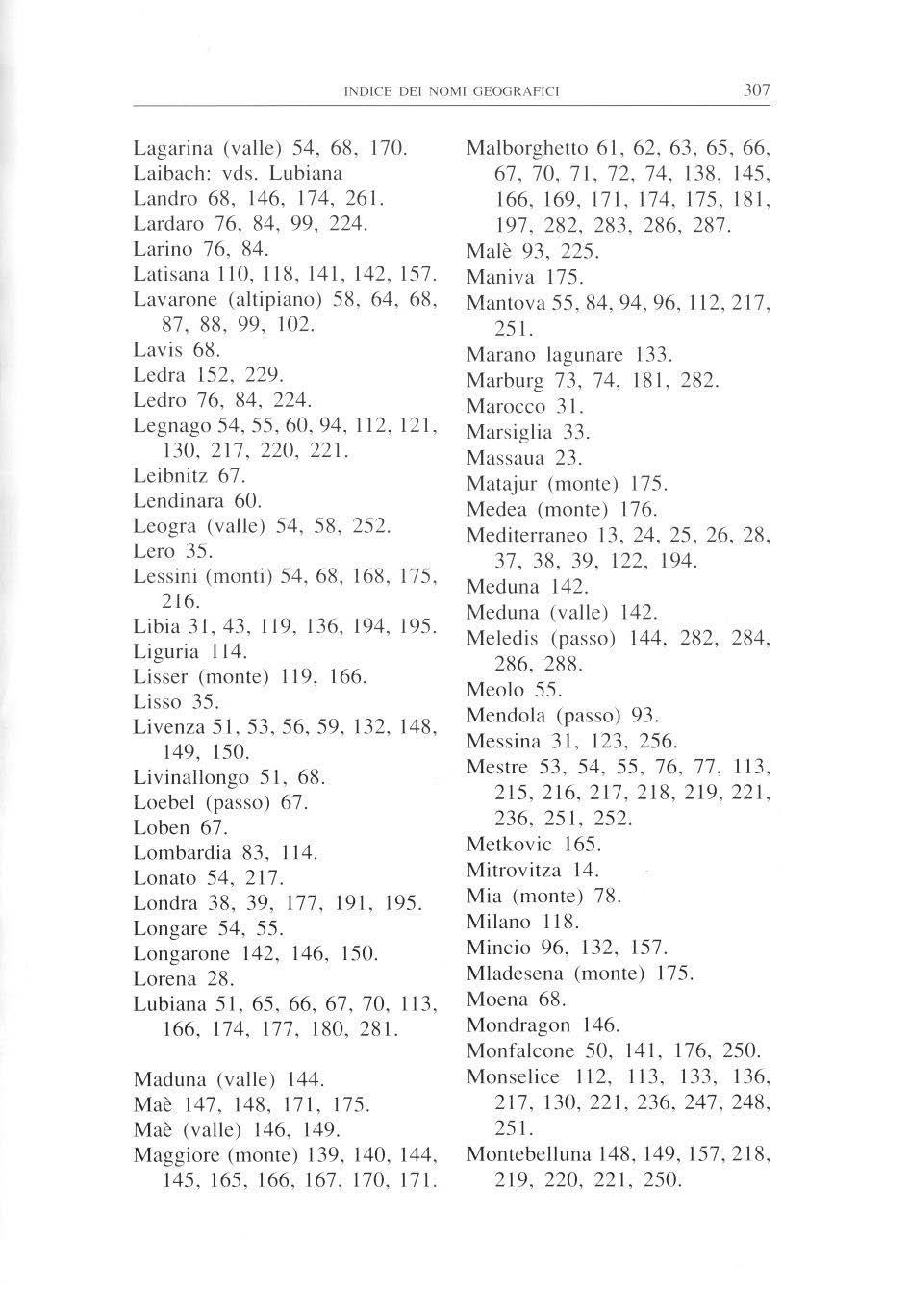
Malè 93, 225.
Maniva 175.
Mantova 55, 84, 94, 96. 11 2,2 17 , 251.
Marano la g unare 133.
Marburg 73, 74, 18 I , 282.
Marocco 3 1
Mars ig li a 33 .
Massaua 23 .
Matajur (mon te) 175.
Medea (monte) 176.
Mediterraneo 13, 24, 25. 26, 28, 37. 38, 39, 122 , 194.
Meduna 142.
Meduna (valle) 142.
Meledis (passo) 144. 282, 284, 286, 288.
Meolo 55.
Mendola (passo) 93.
Mess ina 3 1, 123 , 256 .
Mes tre 53, 54 , 55 , 76, 77, 11 3, 215,216,217, 2 18,219,221, 236, 251, 252.
Metkovic I 65.
Mitrovitza 14 .
Mia ( monte) 78.
Milano 11 8.
Mincio 96, 132 , 157.
Mlad esena (monte) 175.
Moena 68.
Mondragon 146
Monfalcone 50, 141 , 176, 250 .
Monselice 112, 113 , 133, 136, 217,130,22 1,236,247,248, 251.
Mont ebell un a 148,149,157,2 18 , 219, 220 , 22 l , 250.
Montemaggiore: vds. Mag g iore (monte)
Monte Croce Carnico (passo) 7 L 145.
Monte Croce Comelico (passo) 90, 92, 146.
Montello 56, 132 , 148, 150 , 218.
Montenegro 14, 118, 165 , 193.
Mortirolo 175.
Mur 67, 74, 180.
Musi (va lle ) 152 , 229.
Nabresina 51.
Nago 76, 84.
Napoli 9, 97 , 123, 124, 125, 233, 255, 256
Nassfeld (passo) 145 , 283, 286.
Natisone 140 ,15 1,227 . 228, 281, 282, 284, 286.
Nervesa 146 , 147.
Nevea 71, 282, 286.
Nisino 35.
Non (va ll e) 76, 84, 225.
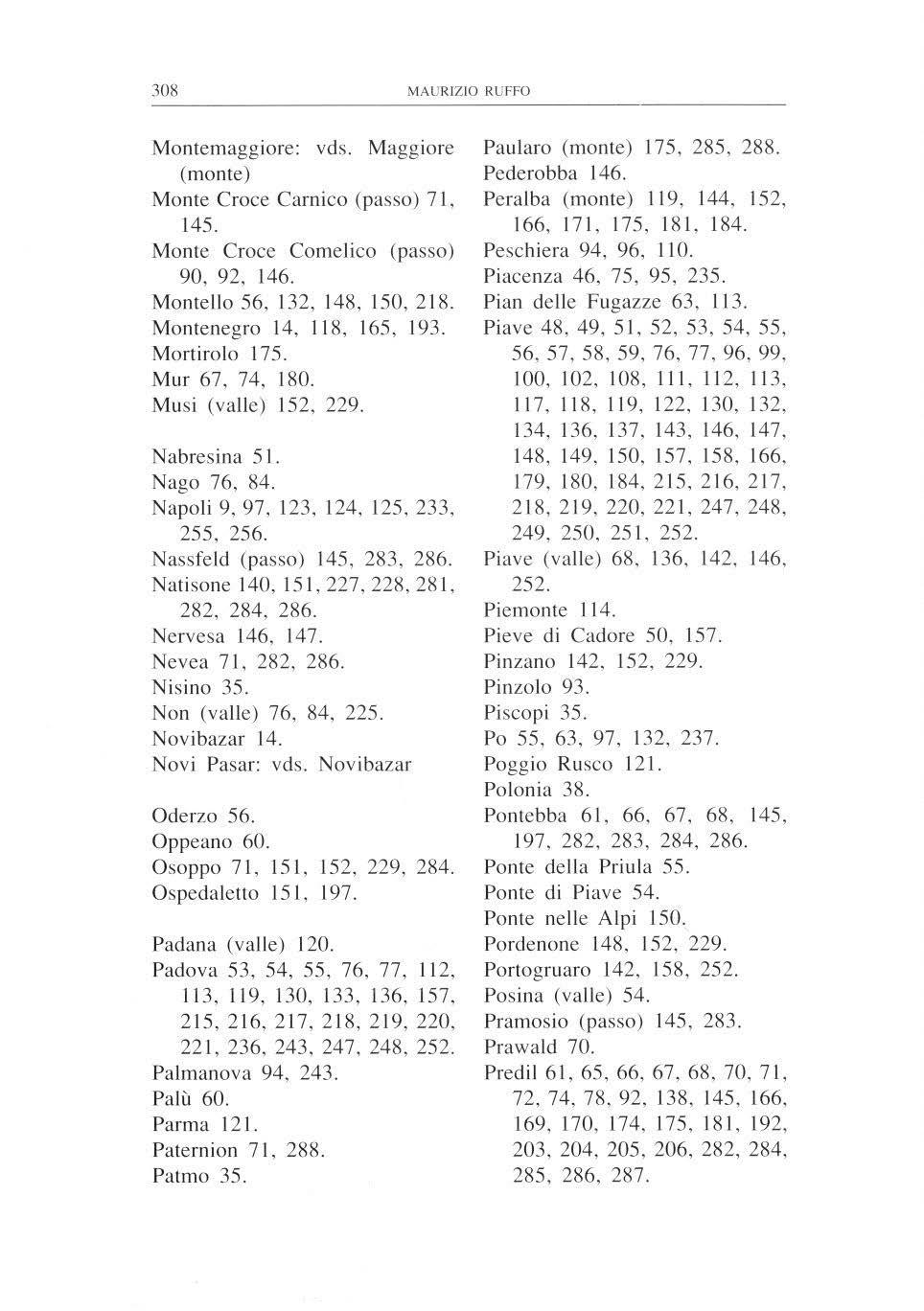
Novibazar 14.
Novi Pasar: vds. Nov iba za r
Oderzo 56.
Oppeano 60.
Os oppo 71, 151 , 152 , 229, 284 .
Os pedal e tto 151 , 197.
Padana (valle) 120.
Padova 53, 54, 55, 76, 77, 112, 113. 119 ,130,133, 136, 157, 215, 216,217,218, 2 19 , 220, 221,236,243,247 ,248,252.
Palmanova 94, 243.
Palù 60.
Parma 121.
Paternion 71. 288.
Palmo 35.
Paularo (monte) 175 , 285, 288.
Pederobba 146.
Peralba (mo nte ) 11 9, 144, 15 2, 166 , 171 , 175, 181 , 184.
Pe s chiera 94, 96, 110.
Piace nza 46, 75, 95 , 235 .
Pian d e ll e Fugazze 63 , 113.
Piav e 48 , 49 , 51 , 52, 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 58 , 59, 76, 77, 96 , 99 , 100 , 102 , 108,111,112 , 113, 117 , 118, 119 , 122 , 130, 132 , 134, 136, 137, 143 , 146 , 147, 148 , 149 , 150 , 157, 158, 166 , 179, 180 , 184, 2 15, 2 16 , 217, 218 , 219 , 220, 221, 247, 248, 249 , 250, 251, 252
Piav e ( valle) 68, 136 , 142 , 146, 252.
Piemonte 11 4.
Pi eve di Cadore 50, 157.
Pinzano 142 , 15 2, 229.
Pinzolo 93.
Piscopi 35.
Po 55, 63, 97, 132, 237.
Po gg io Rus co 121.
Polonia 38.
Ponte bb a 61, 66 , 67, 68 , 145 , 197 , 282, 283 , 284, 286.
Ponte dell a Priula 55.
Ponte di Piave 54.
Ponte ne ll e Alpi 150.
Pord e non e 148, 15 2, 229 .
Portog ruaro 142 , 158 , 252.
Po s ina (valle) 54.
Pramosio (passo) 145 , 283.
Prawald 70.
Predii 61, 65, 66, 67 , 68, 70, 71, 72, 74, 78, 92, 138 , 145, 166 , 169 , 170 , 174 , 175, 181 , 192, 203,204,205 , 206,282,284, 285 , 286, 287.
Prepotto 166.
Primiero (valle) 68.
Priula I 47, 148.
Puglia 119 , 123, 129, 133, 165.
Pulfero 113 , 203.
Pu s teria (valle) 58, 75, 113, 138, 146 , 166 , 170, 174 , 224, 257. 265
Raccolana (valle) 71, 228, 282, 286.
Raibl 78, 174 , 176, 282, 286.
Reggio Calabria 123 , 124, 125.
Ragogna (monte) 151.
Remanzacco 69.
Reno 27, 34, 111, 114 , 162 , 184.
Resia (valle) 143.
R ienz: vds. Rienza (valle)
Riva 76, 84, 93, 99, 224, 225
Resto (monte) 144.
Ri voli 60 , 63 , 96 , 100, 101.
Robedi sce 140, 141.
Rocca d'Anfo 63.
Rocchetta 76, 84.
Rodi 35.
Roma 9, li, 16, 21, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 83 , I I 4. 123. 133 , 223,227. 236,241, 255, 291.
Roncade 55 , 115, 235.
Ronchi 23.
Ro vereto 68, 76, 93 , 224.
Rovigo 55, 60 , 77, 11 2, 130,2 17, 220, 22 1.
Rumelia Orientale 14.
Ru ss ia 13, 14 , 16. 18, 19, 21 , 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 38, 40, 164 , 177 , 191. 193 , 194 , 195.
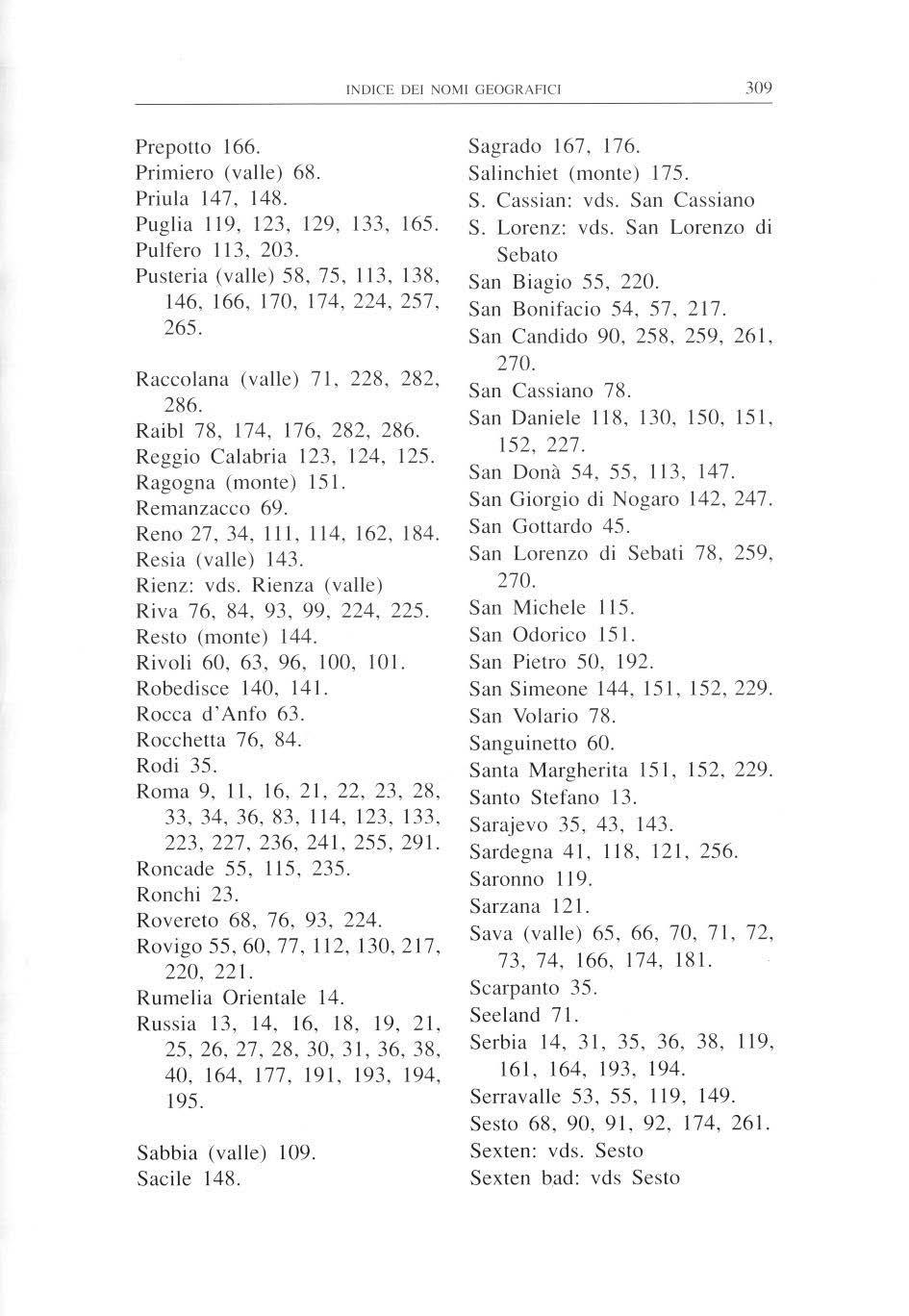
Sabbia (va ll e) 109.
Sacile 148.
Sagrado 167, 176.
Salinchiet ( mont e) 175.
S. Cassian: vds. San Cassiano
S. Loren z: vds. San Lore nzo di Sebato
San Biagio 55, 220.
San Bonifacio 54, 57, 217.
San Candido 90 , 258, 259, 261, 270.
San Cassiano 78.
San Daniele 118,130,150,151 , 152 , 227.
San Donà 54 , 55 , 113, 147.
San Giorgio cli Nogaro 142, 247.
San Gottardo 45.
San Lorenzo di Sebati 78, 259, 270.
San Michel e 1J5.
San Odori co 15 I.
San Pie tro 50, 192.
San Simeo ne 144, 151 , 152 ,229 .
San Volario 78.
Sang uin e tto 60.
Santa Marg herita 15 1, 152 , 229.
Santo Stefano 13.
Sarajevo 35, 43, 14 3
Sardegna 41, 118, 121 , 256.
Saronno 119.
$arzana 121.
Sava (v alle) 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74 , l66, 174, 181.
Scarpanto 35.
Seeland 7 1.
Serbia 14, 3 1, 35, 36, 38, 119, 161 , 164, 193 , 194.
Serravallc 53 , 55, 11 9, 149.
Sesto 68, 90, 91 , 92, 174, 261.
Sexten: vds. Sesto
Sexten bad: vds Sesto
Sicilia 17 , 111 , 122, 129, 132 , 136 , 256.
Sile 114 , 148,150,218 ,2 19, 220, 235.
Simi 35.
Spilimbergo 15 2, 229, 252.
Spittal 71 , 258, 260, 262.
Stampalia 35.
St. Hermagor 71.
St. Veit 67 , 74.
Stella 78.
Stelvio (passo) 69, 100, 117 , 119 , 121, 132, 166 , 167 , 192 ,223 .
Stero 78, 272.
Stol (monte) 175.
Storo 76.
Stradella 46, 48, 75, 95, 183 , 184.
Stramentizzo 68.
Stretti 26.
Strino 76 , 84, 223.
Svizze ra 45, 109 , J 18 , 165.
Tagliamento
Ta i ài Cadore 146.
T anamea ( pass o ) 143.
T ana m eje: vds. Tanamea (passo)
Tanerburg 73.
Taranto 123 , 127 , 256.
Tarnova (selva) 70 .
Tarvi s: vds. Tarvisio
Tarv
Tauri ( monti) 138 , 275, 276, 277, 278, 279.
Terni J 11.
Thiene 54, 2 15.
Tirolo 36, 46 , 50 , 51, 58 , 62, 64 , 66, 67, 68, 93, 96, 97, 137, 166 , 170, 171 , 174, 192 , 218, 223, 224, 225, 248, 249.
Tirre no 123 .
Toblach: vds Dobbi aco
Tolmezzo 144, 288.
Tolmino 65, 70, 176, 178 , 180 , 203.
Tonale (pa sso) 57. 76. 93, 99, 104, 223, 224.
Torbole 76.
Torino 23, 34, 120 , 143.
Torr e 140, 15 2, 229, 255 , 256.
Toscana 95 , 122 , 233 .
Tradate 46.
Trecenta 60.
Tre ntino 16 , 19, 28, 36, 37, 49, so , 55 , 57, 61, 66, 67, 68 , 83, 84 , 97, 98, 100 , 113, 104 , 106 , 137, 158 , 165 , 170, 174 , 180 , 18 I, 192 , 193 , 249 , 273.
Trento 9, 37, 5 I , 58 , 64, 69, 76 , 84 , 85, 87, 89, 93, 137, 170 ,
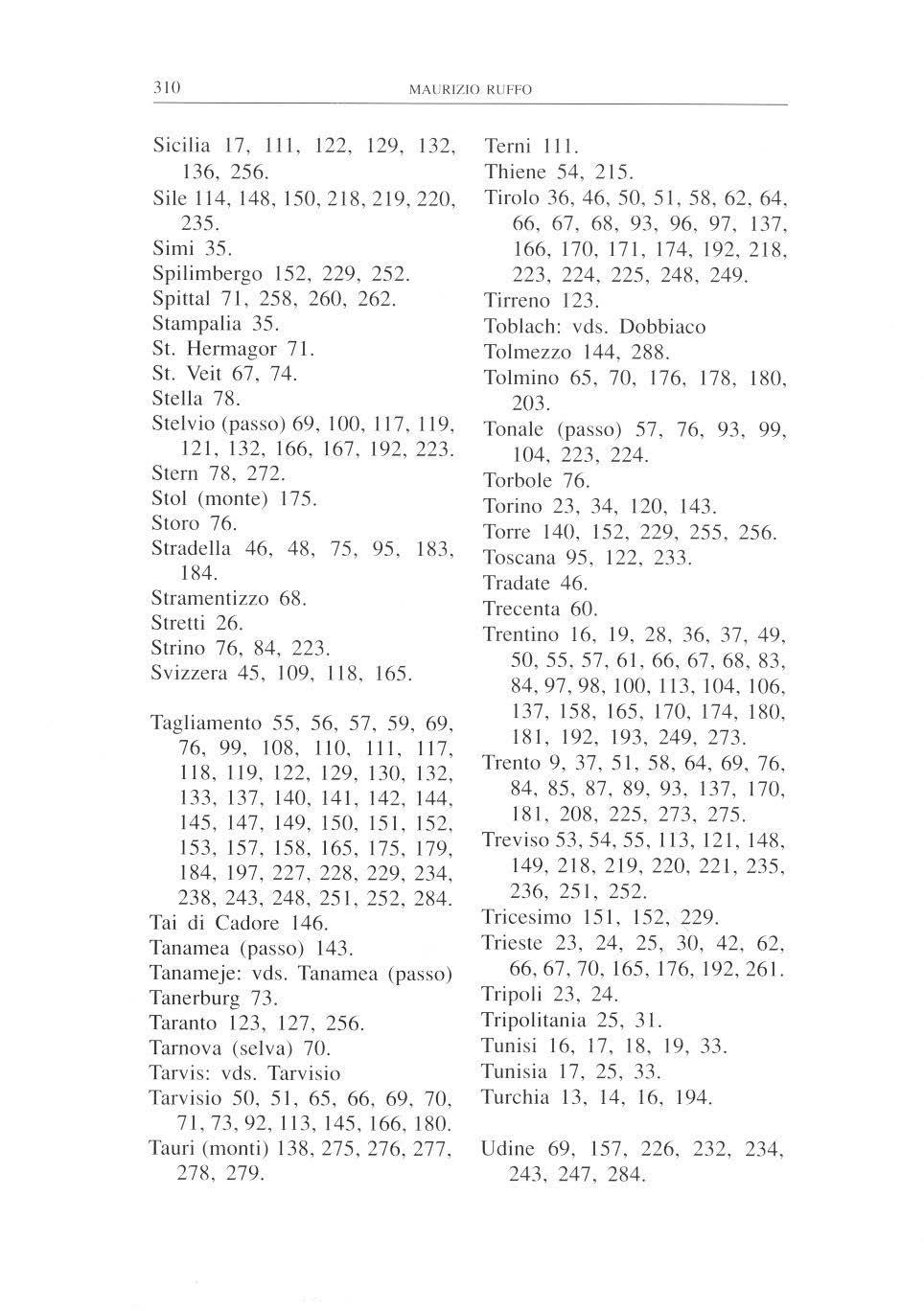
18 1, 208, 225, 273, 275.
Treviso 53, 54 , 55 , 113 , 121 , 148, 149 , 218, 219, 220, 221, 235. 236, 25 1, 252.
Trices imo I 51, 152, 229.
Tries te 23, 24, 25, 30, 42, 62, 66 , 67 , 70 , 165, 176,192,261.
Tripoli 23 , 24 .
Tripolitania 25 , 31.
Tun isi 16, 17 , 18, 19 , 33.
Tuni s ia 17, 25, 33 .
Turchia 13. 14, 16, 194.
Udine 69 , 157, 226, 232, 234, 243, 247, 284.
Vajont (valle) 142.
Valcamonica (valle) 54, 57, 61, 64, 157.
Valdobbiadene 54.
Valparola (passo) 78.
Valsabbia (valle) 54, 57, 61, 64.
Vals ugana (valle) 37, 57, 58, 59, 63, 68, 84, 93, 106.
Vallellina (valle) 57, 61 64, 157 , 168.
Varasdin 181.
Varese 118.
Verzegnis (monte) 144.
Veneto 51, 52, 84, 97, 98, 112, 114, 183, 216, 234, 242, 243, 247.
Venezia 59, 60, 94, 96, 123, 137 ,
132, 133, 150, 176, 215, 222, 256, 264.
Venezia Giulia 19.
Verona 54, 55, 60, 94, 100, 11 2, 113, 121, 167 , 168,170,217, 227,234,243,247,248,250, 251, 257, 263.
Vestone 68.
Vicenza 54, 55, 57, 76, 77, 112, 113, 215, 216, 217,218,219,
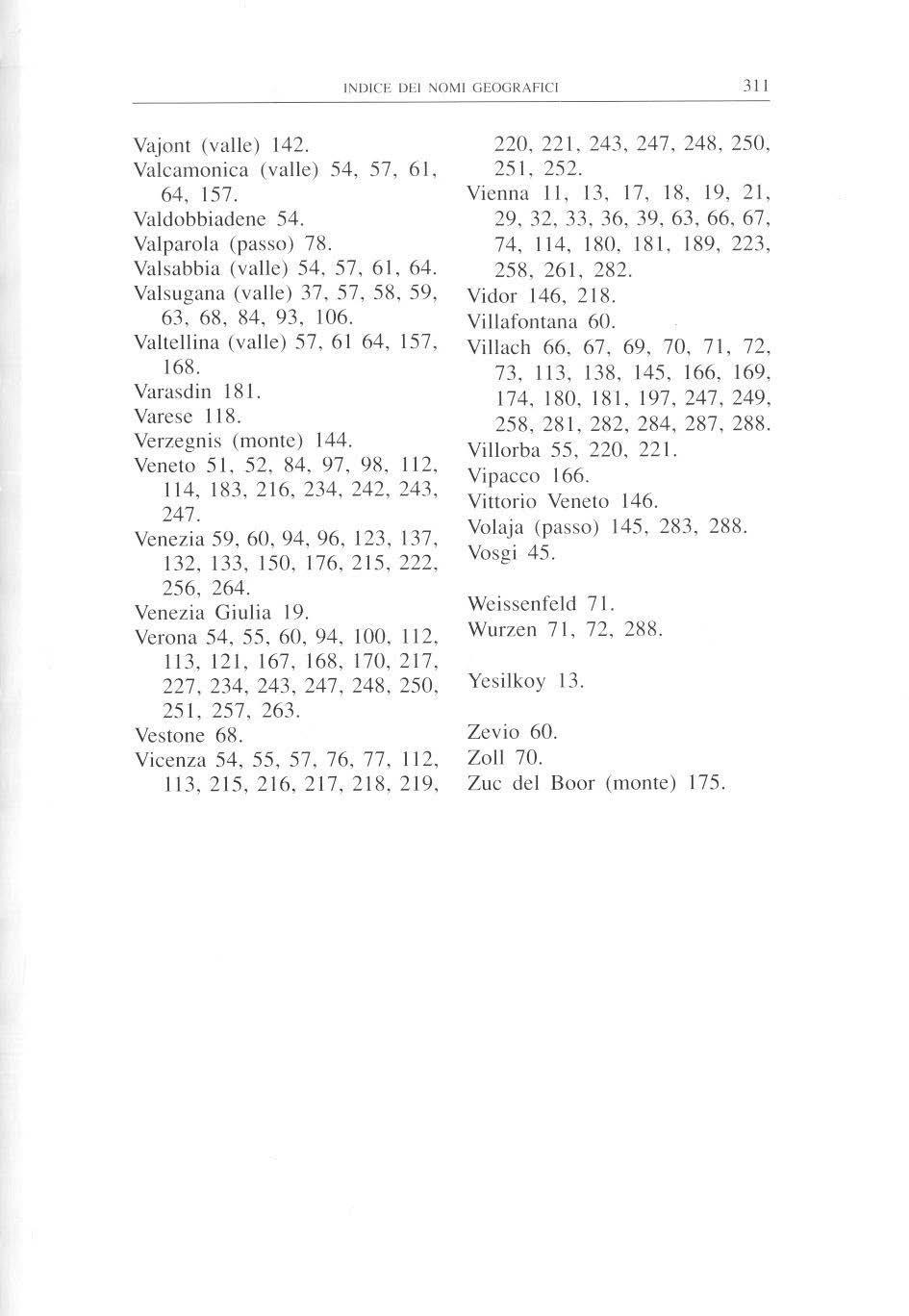
220,221,243,247,248,250, 251, 252 .
Vienna 11. 13, 17, 18, 19, 21, 29, 32, 33 , 36, 39, 63, 66, 67, 74, 114, 180, 181, 189, 223, 258, 261, 282.
Viclor 146, 218.
Villafontana 60.
Villach 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 113, 138, 145, 166 , 169, 174, 180, 181 , 197, 247, 249, 258, 281, 282, 284, 287, 288.
Villorba 55, 220, 221.
Vipacco 166.
Vittorio Veneto 146.
Volaja (passo) 145, 283, 288.
Vosgi 45.
Weissenfeld 7 1.
Wurzen 71, 72, 288.
Ycsilkoy I 3.
Zevio 60.
Zoll 70.
Zuc del Boor (monte) 175.

Presenta:ione Ringraziament i Prem essa Capitolo I
LA TRIPLICE ALLEANZA
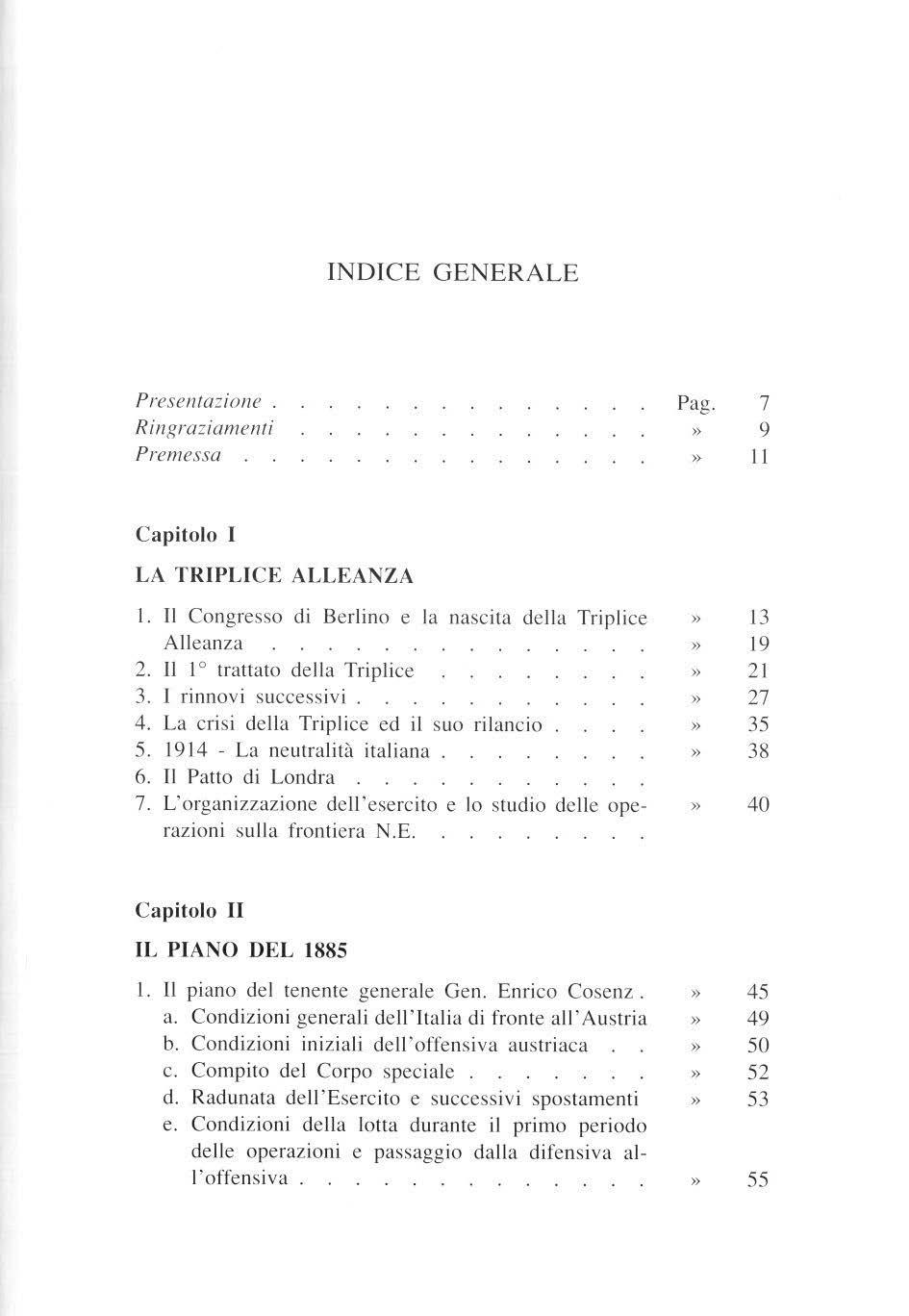
I. Il Congresso di B e rlino e la n ascita d e lla Triplice Alleanza
2 . li I O trattato della Triplice
3. I rinnovi s uccess ivi .
4. La cris i della Tripli ce ed il s uo rilancio
5. 1914 - La neu tra li fa italiana
6 . Il Patto di Lo ndra .
7. L 'orga ni zzazione dell' ese rc ito e lo s tudio d e ll e operazioni s ull a fronti e ra N .E .
IL PIANO DEL 1885
I. 11 pi a no del tenente generale Gen. En r ico Cosenz .
a Condizioni ge ner ali clell ' Italia di fro nt e a li ' Austria
b. Condizioni ini z ial i dell 'offe ns iva a us tria ca
c. Compito ciel Co rp o s peciale
d. R a dun ata de ll ' E se rc it o e s uccessiv i spos ta me nti
e. Condizioni de lla lotta durante il primo periodo de ll e operazioni e passaggio dalla dife nsiva ali 'offe nsiva
f. Ritirata dell'esercito in caso di rovescio s ul Piave g Svolgimento dell'offensiva italiana verso est
2 L'organizzazione de ll a mobilitazione e della radunata
3. Gli s tudi cli fa11ibilit~1
4. L e ricognizioni olt re confi n e .
Capitolo III
L'ORGANIZZAZIONE DIFE NS IVA DEI CONFINI ED IL PROBLEMA DELLA MOBILITAZIONE E DELLA RADUNATA
1. L'organizzazione d ifen siva dei confini.
a . Le fortificazioni asburgiche
b. Le fortificaz ioni italiane
2. L'organizzazione della m ob ilitazio n e e de ll a radunata
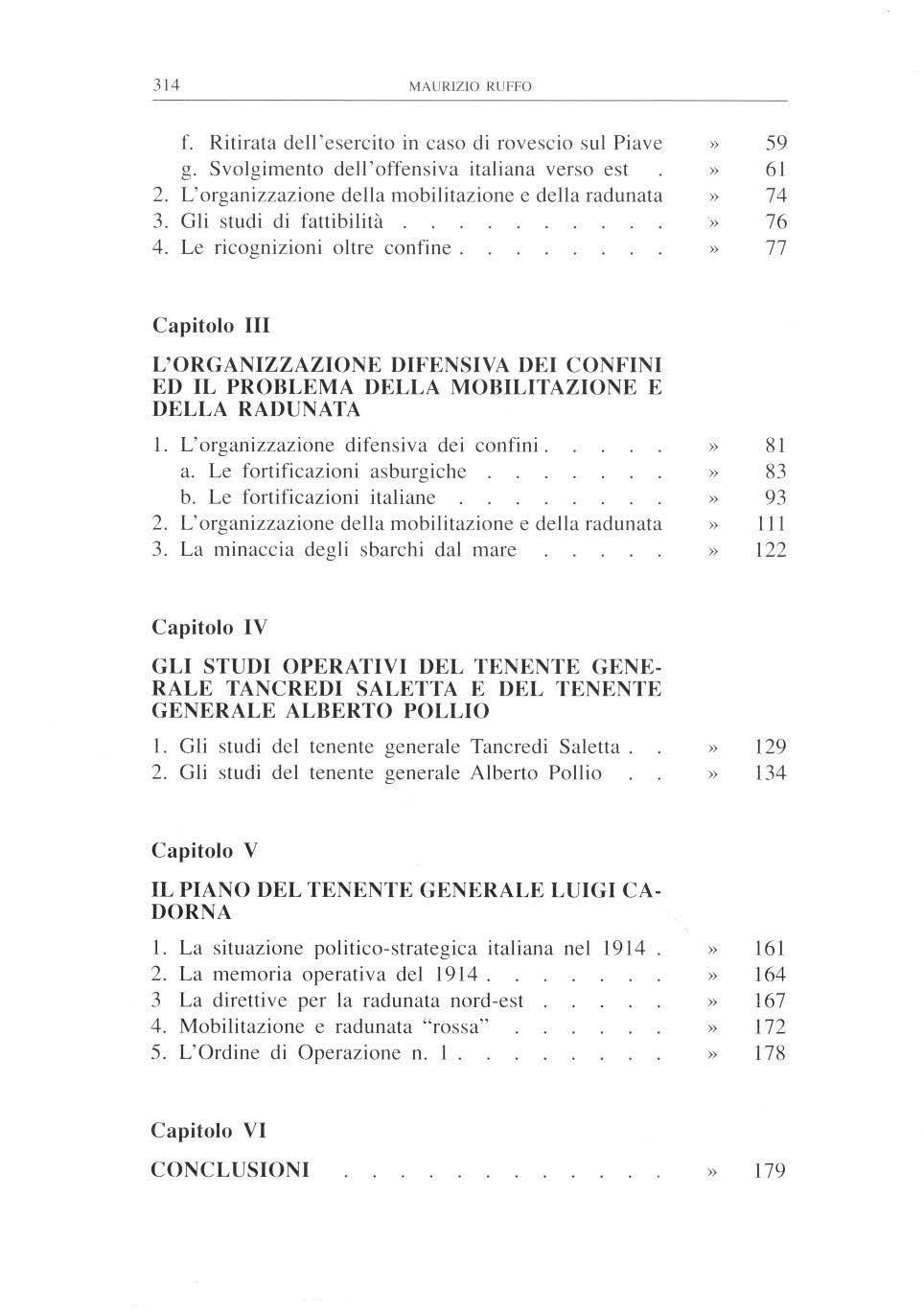
3 . L a minacc ia degli sba rchi dal mare
Capitolo IV
GLI STUDI OPERATIVI D EL TENENTE GENERALE TANCREDI SALETTA E DEL TENENTE GENERALE ALBERTO POLLIO
I. Gli studi ciel tenente ge n era le Tan c redi Saletta .
2 . Gli st udi del tene nte ge nerale Alberto P o llio
Capitolo V
IL PIANO DEL TENENTE GENERALE LUIGI CADORNA
1. L a s itu az ion e politico-strategica italian a nel 191 4 .
2 . La m e moria ope rat iva d el 1914.
3 La direttive per la radunata nord -es t
4 . Mobilit az ion e e radunata "rossa"
5. L 'O rdin e d i Operazio ne n. l