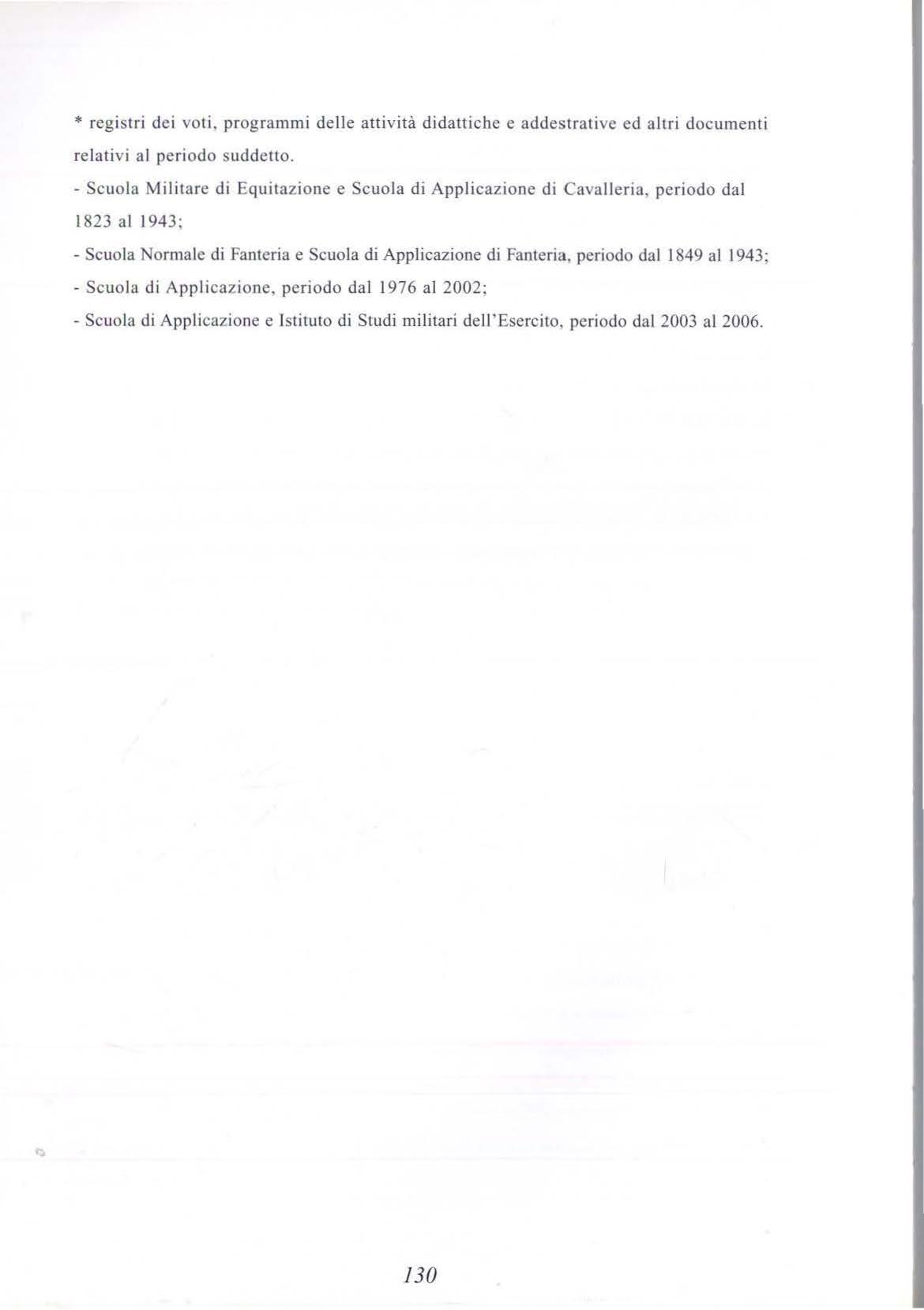Da Arsenale militare a fucina di uomini
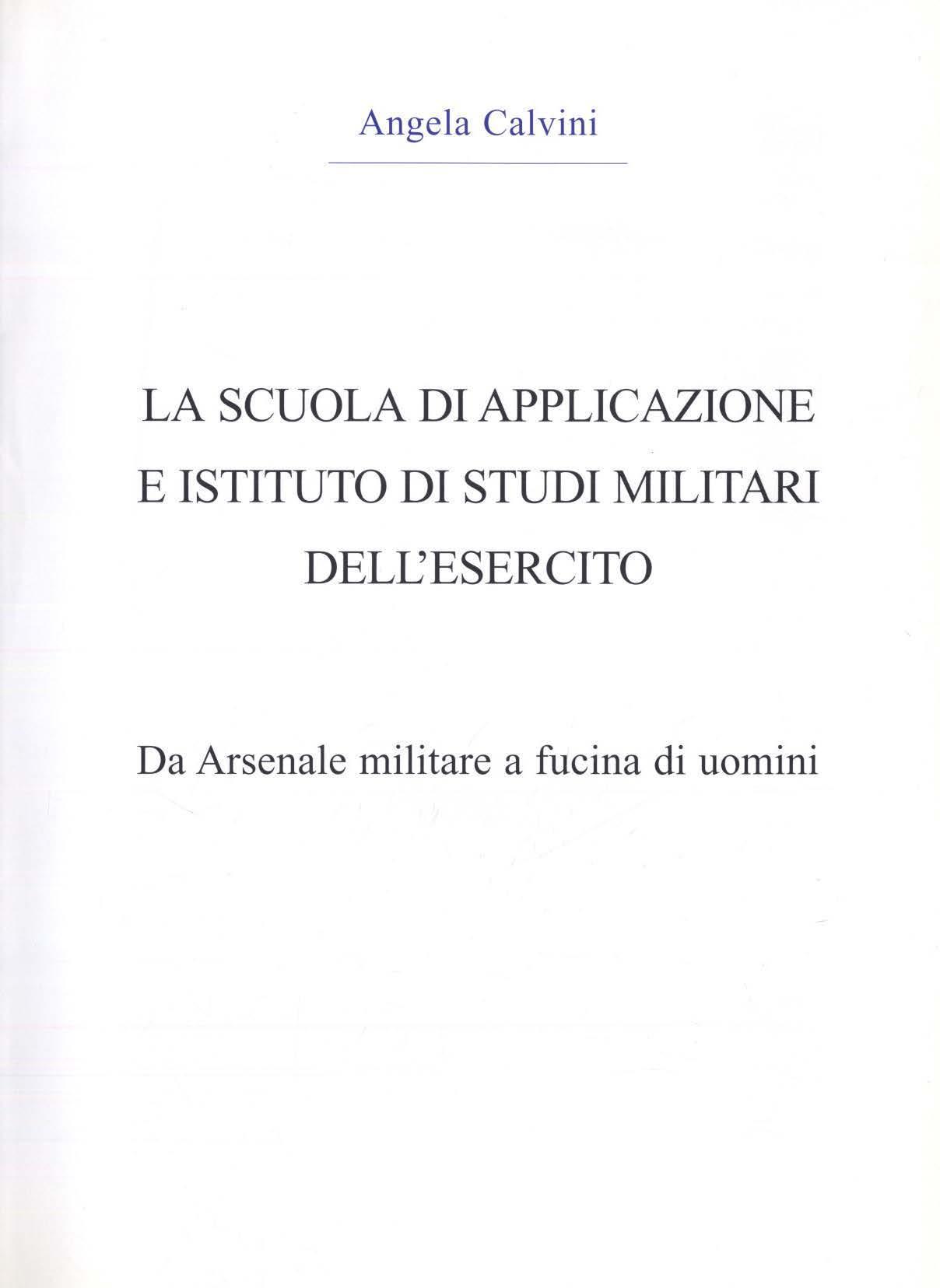
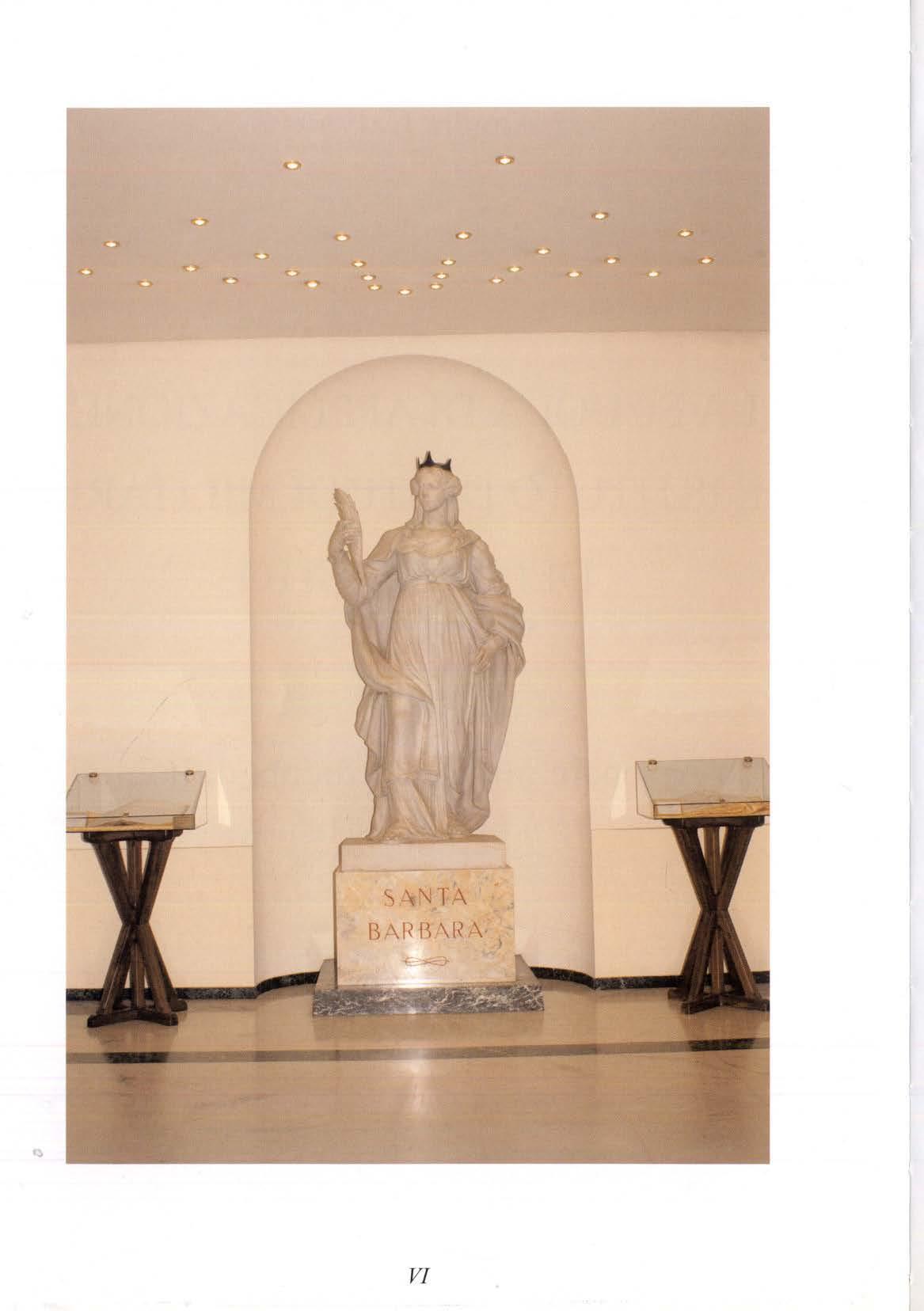
Non si può guardare al futuro senza aver presente con chiarezza il nostro passato, specie in un 'era di eccezionali mutamenti come quella attuale, sospesa tra un millennio e l 'altro. E ciò che siamo diventati oggi, grazie alla nostra storia e alla nostra vocazione alla modernità, lo vogliamo far conoscere a più persone possibili. Queste riflessioni stanno alla base della mia iniziativa di pubblicare un nuovo volume dedicato alla Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito di cui ho l'onore di essere stato il Comandante. In questi anni alla guida del più alto Istituto di Formazione dell'Esercito Italiano, ho vissuto con tutto il personale, il corpo docente e gli Ufficiali frequentatori, la rapida evoluzione della nostra Forza Armata ed il suo sfo rzo per adeguarsi ai mutati scenari internazionali. Dall'apertura al personale femminile alla fine della leva, dall ' impegno dell'Italia nelle missioni ali 'estero agli studi sempre più specializzati nel peacekeeping, il nostro Istituto ha saputo prontamente rispondere in modo propositivo alle esigenze dei tempi. E, più di tutto, la Scuola ha recepito la volontà della Forza Armata di aprirsi maggiormente verso il mondo civile e farsi meglio conoscere a!l'esterno. Già da alcuni anni i nostri corsi di Laurea in Scienze Strategiche sono frequentati anche da studenti civili, mentre i saloni del Palazzo di via Arsenale ospitano spesso convegni, cerimonie pubbliche e conferenze di alto livello. Personalmente ho inoltre voluto l 'apertura alle visite gujdate della splendida s trurtma realizzata dall'architetto De Vincenti, su un primo progetto dello Juvarra, per inserire Palazzo Arsenale nel percorso tmistico museale torinese. Dispiace infatti constatare che una realtà così importante per la città di Torino, con cui ha vissuto in simbiosi per oltre due secoli, e per il nostro stesso Paese, sia ancora poco conosciuta. Fortunatamente, però, da più parti arrivano forti e frequenti segnali di un rinnovato interesse per un reciproco scambio.
A questo punto era necessario proporre un volume aggiornato che potesse, con linguaggio scorrevole e accessibile ai più, raccontare la storia della nostra scuola, sottolineare la sua importanza nella crescita della società civile, industriale e culturale della Torino sabauda prima e dell ' Italia Unita poi, descrivendo anche in modo affascinante la sua architettura e le storie degli uomini che di qui sono passati. Lo scopo è stato raggiunto con la presente pubblicazione che, oltre a un'avvincente excursus nella storia e nella tradizione, getta anche un ampio sguardo sull'attualità dei corsi proposti dalla Scuola, Istituto ali 'avanguardia per le sue stmtture e le discipline atte alla formazione degli Ufficiali dell'Esercito Italiano e dei civili impegnati nelle operazioni di pace nelle aree di crisì.
Per questo ringrazio la dottoressa Angela Calvini, giorna l ista e Capitano della Riserva

Selezionata , cui ho affidato la stesura del presente volume. Aggiungo i miei ringraziamenti ai Tesponsabili della Biblioteca ed a tutti i miei collaboratori.
C opera è dedicata a tutte le generazioni di Ufficiali che qui si sono formate nella cultura e nello spirito , per poi contribuire con il proprio operato ed anche con la propria vita al bene della Patria.
Il mio augurio personale è che questo libro possa essere un valido strumento di conoscenza del nostro Istituto, ma anche un motivo di orgoglio per il corpo docente, i frequentatori, Ufficiali e civili, e per lo stesso Esercito Italiano.
Geu. C.A A rm a ndo N ovelli
65° Co m a n da nte d ella S cu ola d i A pp lic az io n e e I s tituto di S tu di M ilita ri del/'Esercito
l -A pagina V!, la statua di Santa Barbara, protettrice delle Armate.
2 -S opra, il Generale C. A. Armando Novelli, Comandante fino al dicembre 2006 della Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari del! 'Esercito di Torino.
3 - A pagina IX, la Bandiera d'Istituto all'interno della Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito di via Arsenale 22 , a Torino.



Torino è una città dal fascino mistetioso e austero, la cui bellezza per troppi anni è stata appannata dalle sue primarie esigenze industriali. Ma oggi con orgoglio la città rialza la testa, scuote di dosso la sua polvere grigia e si impegna a far risplendere i tàsti del passato, puntando sulle proprie ricchezze di arte, storia e cultura. Una straordinaria coincidenza ha voluto che contemporaneamente anche l 'Esercito Italiano, in fase di profondo rinnovamento , cercasse la strada di un nuovo dialogo con il mondo civile attraverso la valorizzazione delle proprie risorse. Una di queste è , apptmto, la Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito di Torino, un luogo di formazione unico nel panorama italiano, sia per l'eccellenza dei corsi, sia per l'importanza della sua storia e della sua sede.
E' stato il Generale C .A. Armando Novelli, Comandante della Scuola, ad avere la bella intuizione e la ferma volontà di far meglio conoscere al pubblico le attività dell'Istituto e le meraviglie artistiche nascoste di Palazzo Arsenale, aprendolo per la prima volta alle visite guidate e promuovendo un volume aggiornato su di esso. Devo quindi ringraziare il Generale Novelli per avermi affidato l'incarico di scrivere il libro ufficiale della Scuola, allo scopo d i redigere l'opera completa che ne descrivesse gli eventi dalla sua fondazione ai giorni nostri. Lavoro che ho svolto con passione personale, avendo avuto la fortuna di frequentare nel 2004 in questa sede il lV Corso per gli Ufficiali della Riserva Selezionata.
Mi sono così avventurata, col determinante supporto dei responsabili della Biblioteca dell'istituto, in un viaggio esaltante attraverso la storia sabauda e italiana, riscoprendo il ruolo centrale della Scuola, sia dal punto di vista militare, che da quello industriale e intellettuale. Un altro capitolo importante de l libro riguarda la descrizione dell'architettura di Palazzo Arsenale e la catalogazione delle sue opere d'arte, sala per sala. Ma la Scuola oggi è proiettata verso il futuro del peacekeeping internazionale. Non poteva quindi mancare una parte descrittiva dei corsi (aperti anche a studenti civili) che formano i nuovi Comandanti dell'Esercito Italiano, attraverso lezioni supportate dalle tecnologie e dagli studi più avanzati nel campo del mantenimento della pace. li mio tentativo è stato quello di disegnare un panorama il più aggiornato possibile, mettendo la mia esperienza di giornalista al servizio di un testo scorrevole e accessibile a tutti.
Un mio ringraziamento particolare va anche a Vasco Vi chi e Domenico Zambrano, autori deU 'interessantissimo volume "La Scuola di Applicazione: la storia e la sede", pubblicato nell993 e in ristampa nel 2002, pietra miliare tra le numerose pubblicazioni relative alla Scuola, da cui ho attinto indispensabili e approfondite informazioni per la realizzazione di questo lavoro.
Durante la lavorazione del libro dinanzi a me ho sempre avuto fermo un riferimento, la memo-

ria di mio padre, il Generale di Divisione Enrico Calvini, cui personalmente dedico questo scri tto . A lui , già frequentatore della Scuola di Applicazione di Fanteria di Parma (decorata di Medaglia d'Argento al Valor Militare per i fatti dell'8 settembre 1943) e internato militare nei lager nazisti, debbo l'amore per valori come fedeltà alla Patria, rispetto per il dovere e difesa dei diritti dei più deboli. Valori se nza tempo , nonostante i tempi tentino di dimostrare il contrario.
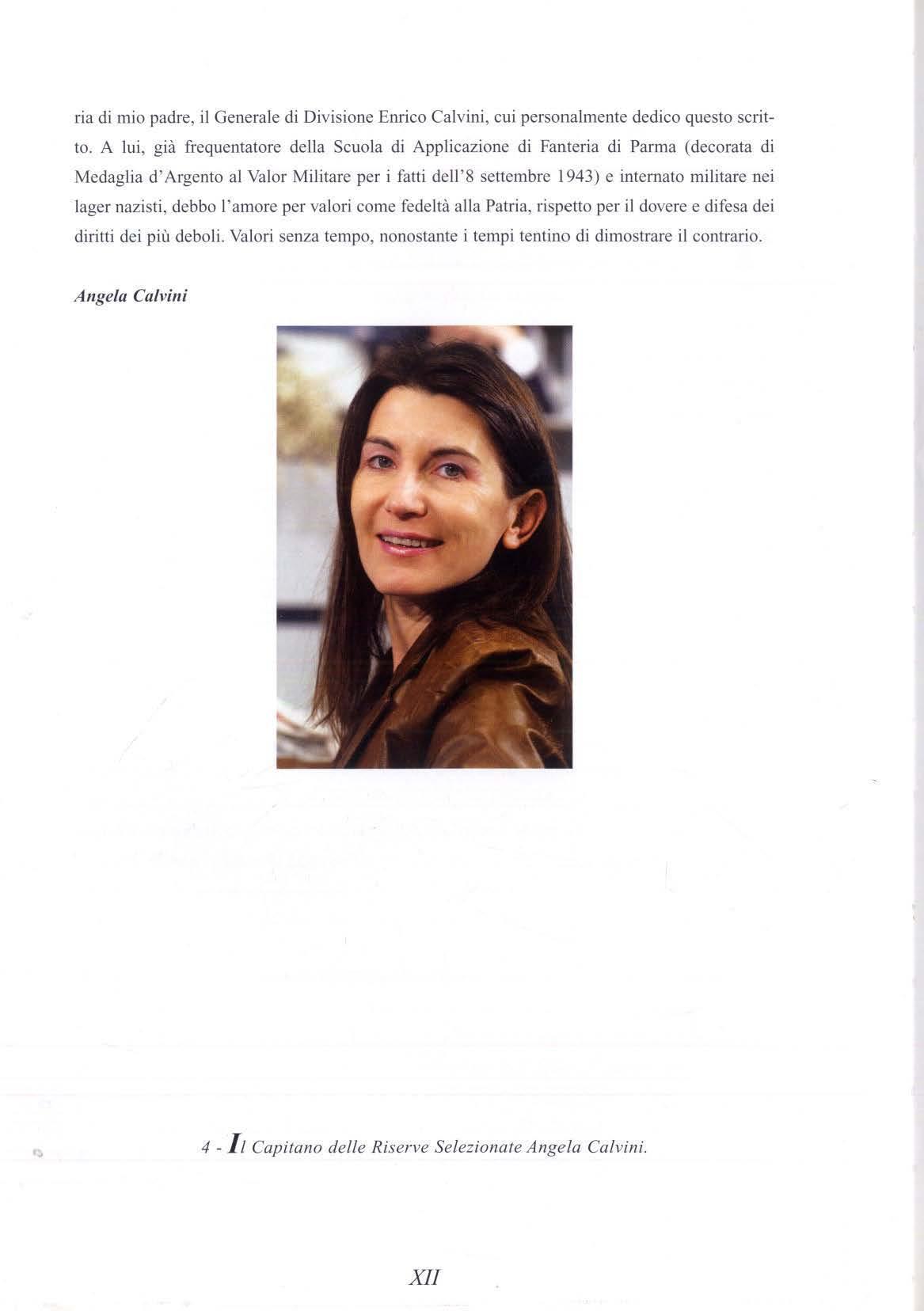 Angela Ca / vini
Angela Ca / vini
Oltre duecentocinquant'anni di storia, dalla grande tradizione sabauda alle nuove frontiere del peacekeeping internazionale. La Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell ' Esercito di Torino, oggi è l'unico Istituto di studi superiori militari della Forza Armata al quale competono la formazione e qualificazione di base e la qualificazione superiore di tutti gli Ufficiali dell'Esercito Italiano. Anche la formazione degli Ufficiali a Nomina Diretta, del Ruolo Speciale e della Riserva Selezionata, entra nelle competenze d eli 'Istituto. In tale ampiezza di offerta formativa, si pone come punto di riferimento di eccellenza accademica nel panorama nazionale e non solo. La recente rifonna delle Forze Annate italiane, in linea col mutamento degli scenari globali , ha posto come obiettivo primario la creazione di professionisti in grado di assicurare la pace nei luoghi più lontani e difficili. In questo la Scuola di Applicazione di Torino, grazie alla relazione sempre più stretta con le università e il mondo civile, da Istituto a carattere prevalentemente tecnico ha virato verso un approfondimento nel settore delle Scienze strategiche. Una serie di nuovi corsi specializzati mettono quindi a disposizione dei frequentatori le più moderne tecnologie, una visione geopolitica a largo raggio e al passo con i tempi, tenendo comunque ben presenti i valori morali , spirituali e patriottici su cui si basa lo stesso Esercito Italiano. La capacità e il prestigio dell ' Istituto affondano le loro radici in una solida tradizione ancorata alla nascita dello Stato Sabaudo e ad un rapporto di proficuo scambio con la città di Torino che trova nel Palazzo dell'Arsenale, voluto nel 1736 da Re Carlo Emanuele Ili , il suo imponente testimone: elegante opera architettonica e moderna fabbrica d ' artiglieria, scuola militare prima nel suo genere in Europa e laboratorio scientifico. Tutto nasceva dal rafforzarsi dell'indipendenza del neonato Stato Sabaudo che portava alla realizzazione di un primo arsenale nel XVl secolo e di due scuole militari: la Regia Accademia nel 1678 e le Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortificazione nel 1739. Da queste basi ebbe sviluppo il progresso scientifico e tecnico della stessa città: l'Arsenale formava in egual misura operai specializzati nella manifattura dei metalli e rampolli delle più importanti casate europee attirati dall'eccellenza degli studi. Da una parte la sua fabbrica contribuiva in modo determinante allo sviluppo dell'industria metallurgica e meccanica torinese e, di conseguenza, italiana (una parte dei suoi operai specializzati transitarono nel 1899 nella neonata FIAT). Dall'altra Je sue scuole davano alle stampe manuali scientifici adottati neg l i istituti militari russ] , francesi , prussiani e portoghesi mentre il suo corpo insegnante costituiva il nucleo fondatore della Reale Accademia delle Scienze. Tanti i nomi di spicco che hanno contribuito alla fama dell'istituzione torinese, nelle sue molteplici fasi di vita. Tra i docenti, si distinguono scienziati e intellettuali

5- L a 'Sala del Plastico ' ospita un modellino in scala dell'edificio.
come Lagrange, Saluzzo, Plana, Menabrea, Bertola, Cavalli , Burzio mentre tra i tanti allievi, ben 29 (tra cui Cavour) furono Ministri del Regno di Sardegna e altri 29 vennero nominati Ministri del Regno d ' Italia. Tra gli altri allievi de li 'Istituto figurano i grandi Generali delle due Guerre:
Lamannora, Cadorna, Diaz, Badoglio, il beato Fàa di Bruno, il pioniere dell'aeronautica forlanini e lo scrittore Perrucchetti (ideatore degli alpini).
La Grande Storia passa quindi , in un viaggio affascinante e drammatico, attraverso le splendide mura del Palazzo, nelle vicende degli uomini che qui vennero educati ad alti ideali e a un generoso spirito di sacrificio. Uomini che diedero il loro contributo personale all ' Unità d'Italia, alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale, alla Resistenza (dai valorosi fatti della Scuola di Applicazione di Parma, alla silenziosa sofferenza degli internati militari), sino alla ricostruzione dello Stato italiano nel dopoguerra e all'affermazione della credibilità delle nostre Forze in missione all'estero per sostenere la ricostruzione dei paesi ed il ritorno della pace. Sono oltre 5000 i caduti della Scuola , dalle Guerre d'Indipendenza a oggi.

Pace è la parola chiave di questi tempi tormentati, la parola che non a caso l' indimenticato Papa
Giovanni Paolo II ha usato nel benedire i giovani Ufficiali in occasione della sua visita del 1988 alla Scuola di Applicazione: "Siate convinti di svolgere un compito di pace". Un invito che oggi più che mai è realtà.



con circa 1300 Ufficiali frequentatori ogni anno, un centinaio di studenti civili, 118 professori universitari e 30 docenti militari che insegnano oltre l 00 materie universitarie e 28 materie militari di carattere tecnico-professionale, la Scuola di Applicazione c Istituto di Studi Militari de Il 'Esercito si è affermata negli ultimi anni come uno dci poli di da trici di eccellenza nel panorama italiano e come un nuovo centro culturale di prestigio per la città di Torino.
Tnnanzitutto la Scuola è l'unico Istituto al quale competono la fonnazione, la qualificazione di base e la qualificazione superiore di n1tti gli Ufficiali dell'Esercito Italiano. La formazione degli Ufficiali in servizio permanente avviene presso l'Accademia Militare di Modena per i primi due anni e, successivamente, presso la Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito. Ma, a partire dal 2000, questa ha ampliato le sue competenze c rafforzato la sua importanza nell'ambito della riforma dell'area scolastico-addestrativa della Fol7a Armata. I principali traguardi sono stati il riconoscimento del titolo di laurea, una più stretta collaborazione con gli atenei italiani, in special modo torinesi. l'apertura agli studenti civili, la nascita di nuovi corsi, il trasferimento a Torino del Corso di Stato Maggiore dalla Scuola di Guerra di Civitavecchia. Ecco in sintesi il panorama dei corsi che attualmente si svolgono alla Scuola c le loro finalità.
Come tutte le scuole militari, anche la Scuola di Applicazione è soprattutto una palestra formativa per i giovani futuri Comandanti, in cui il perseguimento delle capacità di leadership avviene attraverso i tradizionali metodi che caratterizzano da sempre la formazione di un soldato destinato ad incarichi di comando:
- fortificazione del carattere;
- insegnamento della disciplina militare;
- costruzione del senso di appartenenza all'organizzazione militare;
- condivisione dei valori posti a base del progetto.

Para ll elamente agli studi universitari e militari la Scuola persegue il non meno importante compito di "costruire" Comandanti capaci di svolgere in maniera corretta ed efficace il governo del personale e di esercitare al meglio le tre autorità componenti la leadership:
- l'autorità funzionale , intesa come prestigio derivante dal livello culturale e dalle capacità tecnico professionali acquisite ;
-l'autorità is tituzionale, intesa come competenza a s volgere l'incarico ricoperto;
- l ' autorità personale, la più importante, che deriva dall'ascendente personale o addirittura dal carisma e quindi basata sul possesso, non necessariamente innato, ma anche sviluppato con la forza di volontà, di emergenti doti di carattere.
Il programma di studi si divide in tre grandi aree formative. Qualificazione e formazion e di base. (Sottotenente e Tenente). Fonnazione culturale con il conseguimento della Laurea in Scienze Strategiche per gli Ufficiali delle Varie Anni , de1l ' Arma Trasporti e Materiali e del Corpo di Amministrazione e Comm issariato, della Laurea in Ingegneria per gli Ufficiali del Corpo degli Ingegneri dell ' Esercito. Per tutt i gli Ufficia li la qualificazione professionale con lo sviluppo della capacità di operare quale Comandante di plotone e Vice Comandante di compagnia.
Altri Corsi. Per Ufficiali del Ruolo Speciale, reclutati tra il personale proveniente dagli Ufficiali di Complemento , ora Fem1a Prefissata, dai Sottufficiali , per Ufficiali appartenenti alla Riserva Selezionata delle Forze di Completamento , reclutati tra i professionisti civili in possesso di particolari competenze assenti nella Forza Armata o disponib ili in misura insufficiente rispetto alle esigenze e Ufficia li reclutati con Nomina Diretta tra i giovani laureati in Ingegneria. Qualificazione superiore (Capitano , Maggiore , Tenente Co lonnello). Preparazione per l ' impiego nell ' ambito degli Stati Maggiori dei Comandi terrestri naziona.li e internazionali attraverso il Master di III ive ll o in Scienze Strategiche. Tre Ufficia li l'anno sono ammessi alla frequenza del Dottorato di ricerca multidisciplinare in Scienze Strategiche.

1 corsi tmiversitari sono regolati da convenzioni stip ul ate tra la Scuola di Applicazione e istituto di Studi Militari dell'Esercito, l'Accademia Militare di Modena e l'Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l 'Universit à degli Studi di Modena e Reggio Emilia e sono aperti alla frequenza di st11denti civili. L'iter formativo p revede il conseguimento della Laurea al termine del terzo anno e la Laurea Magistra le al termine del quinto anno. 11 Corso di Laurea in
Scienze Strategiche coinvolge quindi non solo varie università, ma anche diverse facoltà: Scienze Matematiche, Fisiche e Natural i, Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche e I ngegneria. Completano l'offerta formativa il Master di II livello in Scienze Strategiche e il Dottoraro multidisciplinare in Scienze Strategiche. [n media gli iscritti al Corso di Laurea in Scienze Strategiche sono 600 Ufficiali e 150 civili mentre annualmente gli studenti che conseguono la

laurea sono circa 200. Il Mastcr è frequentato da 300 tra Ufficiali e studenti civili mentre il Dottorato di ricerca, attivato annualmente, vede 7 frequentatori (3 Ufficiali de signati dallo Stato Maggiore dell'Esercito c, tramite concorso, 4 concorrenti estemj) di cui 2 con borsa di studio offerta da lla Farla Armata.
La urea in Scie nze Strategic he. Il nuovo corso di studi, avviato nell'anno accademico 1999/2000, intende conferire agli Ufficiali dell'E sercito una preparazione univers itaria ed una specifica formazione professionale che tenga conto dei nuovi scena ri internazionali e delle moderne esigenze di impiego delle Forze Armate. Si tende a formare quindi professionisti militari capaci di operare nei reparti di impiego in ambito nazionale e interna7.ionalc, con incarichi di comando e giuridico amministrativi.
Laurea Tre sono i percorsi didattici per quanto r iguarda il triennio de l corso: politico organizzativo (riservato agli Ufficiali di Fanteria. Cavalleria, Artiglieria) che fornisce le conoscenze relative alle grandi organi7.zazioni complesse; tecnico (riservato agli Ufficiali delle armi Genio, Trasmissioni, Trasporti c Materiali) focalizzato sulle nuove tecnologie; amministrativo (per gli Ufficiali del corpo di Amministrazione e Commi ssariato) che forma Ufficiali esperti nel diritto e nelle procedure amministrative.
Laurea Ma gistra le. Il ciclo che si conclude al quinto anno prevede cinque differenti lauree in Scienze Strategiche Politico Organizzative. dei Sistemi lnfrastrutturali, delle Telecomunicazioni.
Logistiche, Economico Amministrative.
Durante il corso viene data primaria importan7a all'insegnamento della lingua inglese e di una seconda lingua a scelta tra francese, tedesco. spagnolo, portoghese. A integrazione del percorso di studj viene effettuato un corso intensivo lingui stico (complessivamente di 500 ore) che può prevedere una fase all'estero, un corso tecnico applicativo, momenti di addestramento presso aree addestrative della penisola e un tirocinio pratico presso le unità operative. Mas te r di ll li ve llo in Scienze Stra tegiche. Durala un anno. Si tratta di uno dci più elevati livelli di specializzazìonc nell'ambito dell'Esercito, diretto a formare Ufficiali già esperti e si articola in due corsi.

C ors o di Sta to Magg io r e. Obbligatorio per tutli i Capitani. A carattere tecnico-professionale prepara il personale ad operare nell'ambito degli Stati Maggiori delle Grandi Unità Elementari o Forze multinazionali di livello Brigata in operazioni di guerra o di mantenimento della pace, nonché a conseguire le capacità professionali necessarie a coordinare l'impiego delle risorse o ad utilizzare strumenti comunicativi e tecniche di /eadership.
C orso pluritcmati co Aperto, su base volontaria, agli Ufficiali laureati che hanno frequentato il Corso di Stato Maggiore e ai civili. A carattere prevalentemente universitario, intende far acquisire ai frequentatori la capacità di valutare gli influssi delle situazioni socio-economiche sulla pianificazione c la condotta delle operazioni militari, la preparazione per operare nell'ambito
degli organi di vertice della Forza Armata, nazionali e multinazionali e la formazione necessaria all'insegnamento e al coordinamento didattico presso gli Istituti militari di formazione. li corso si sviluppa intorno a 5 aree di insegnamento (Gestione strategica delle risorse, Strategia operativa, Geografia antropolog ica, economica e politica, Strategia politica e Strategia economica), ha carattere universitario e si avvale prevalentemente di docenti dell'Ateneo torinese e di Ufficiali già Comandanti di contingenti multinazionali in missioni di pace.
Dottorato di ri cerca multidi sciplin are in S cienze Strat eg ic h e. A partire dali 'anno accademico 2003-2004 è stato attivato, sempre in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, un corso triennale di Dottorato di Ricerca. Lo scopo è quello di formare ricercatori in grado di condmre studi e approfo ndimenti sulle linee di tendenza nel campo strategico-mi lita re.

C o r so per Ufficiali a No mina Diretta Corsi per Ufficiali del Corpo Ingegneri reclutati tra personale civile già in possesso di laurea magistrale. Tali corsi della durata di circa 9 mesi si prefig-
gono lo scopo di conferire un'adeguata preparazione professionale come Ufficiali in Servizio Permanente.
C ors o pe r U fficiali d e l Ruol o S pecia l e. Durata 16 settimane , delle quali 8 svolte in Torino e le rimanenti presso le Scuole d'Arma e di Specialità. Lo frequentano coloro che, già in servizio in qualità di Sottufficiali o provenienti dal mondo civile perché Ufficiali di Complemento, ora Ferma Prefissata, in congedo, risultano vincitori di uno specifico concorso. L'obiettivo è far acquisire conoscenze sulle procedure operative in diversi scenari di impiego e di saper gestire le problematiche logistico-amministrative a livello reparto.
C orso p er Uffi ciali d eUa Ri se r va S el ezionata Durata l mese. Corso nato nel 2003 allo scopo di fornire la formazione di base teorica e pratica per il personale deile Forze di Completamento della Riserva Selezionata, volontari laureati prove1ùenti dal mondo del professionismo (medici, architetti, giornalisti, ingegneri , ar·cheologi, informatici, interpreti, etc.) che possono non aver mai prestato servizio militare.
TJ mutamento degli scenari internazionali degli ultimi anni ha portato ad una sempre maggiore collaborazione all'interno delle strutture militari stesse e fra queste e il mondo civile. In particolare sono nate alcune nuove specializzazioni di altissimo profilo nel settore delle operazioni di ricostruzione e di supporto alla pace nelle aree di crisi che vedono protagonista la Scuola di Applicazione e istituto di Studi Militari dell'Esercito di Torino. Questa è uno dei tre soggetti che costituiscono il cosiddetto Polo di Eccellenza per le post-conflict operations, una struttura che opera in sinergia nel settore dello studio e della ricerca per ciò che riguarda la ricostruzione nelle zone devastate dalla guerra e in quello della specializzazione del personale militare e civile destinato a operare sul campo. Il Polo di Eccellenza è costituito dal Centro Studi per le "Post Conflict Operations" dj Torino , il ClMIC Group South di Motta di Livenza, V icenza (destinato allo sviluppo delle capacità nell'ambito del la cooperazione civile- militare) ed il Cent ro di Addestramento alle "Crisis Response Operations" (CRO) di Cesano, Roma (che ha il compito di uniforn1are l'addestramento e perfezionare la dottrina).
n Centro Studi " Post Conflict Operations" (CS P C O) ha sede a Pa lazzo Simoni itJ corso Matteotti 18. 11 Cenh·o, o ltre a svo lgere il ruolo di coordinamento culturale degli altri Enti che costituiscono il Polo , è responsabile della ricerca e del la formazione nell'ambito del post-conflict. Quindi il suo ruolo è fondamentale nello sviluppo della dottrina ne l settore della ricostruzione e le sue analisi offrono un contributo essenziale al miglioramento della formazione del personale e delle capacità del la Forza Annata, fornendo ino ltre indirizzi preziosi per la p ianificazione della Difesa. 11 Centro Studi svolge anche un 'attività didattica specializzata tramite corsi rivo! -

l 2 - C onclusione del Corso di Post Conjlict Rebuilding Management.
l 3 - I ngresso del Palazzo Simoni in Corso Matteofli 18, a Torino

14- A ula 'Lì Gobbi': ospita 300 frequentatori e dispone di impianti multimediali.
15 - L a Palestra, per le atti1·ità di poten;;iamento muscolare.
16 - A nche le lingue straniere fanno parte della formazione degli Ufficiali; a lato. l 'Au la Lingue attrezzata per impartire lezioni con supporti audiovisivi.

ti a dirigenti civili e militari, italiani e stranieri , al fine di migliorare le capacità operative dei singo li e la conoscenza reciproca delle rispettive competenze operative. Difatti il Centro mantiene collegamenti con gli altri centri simili operanti in ambito Nato e non, con altre Forze Armate, con Università nazionali ed estere, nonché dipartimenti, uffici e agenzie delle Nazioni Unite. Nel 2005 è stato svolto il primo Corso in "Post Conjlict Rebuilding Management" indirizzato ad Alti UITiciali e dirigenti civili, appartenenti al Ministero della Difesa, al Ministero degli Affari Esteri, al Ministero delle Attività produttive, ad Organizzazioni internazionali quali ONU, NATO, OSCE e alle ONG nazionali e straniere, compresi i Paesi delle aree strategiche del Mediterraneo. Lo scopo è quello di completare la preparazione tecnico / professionale legata alle operazioni di stabilizzazione e ricostruzion e nelle aree di crisi (dal ripristino delle normali condizioni di vita, alla sa lvaguardia dei diritti umani) e sviluppare la c ultura della cooperazione tra diversi soggetti pubblici e privati, militari e c ivili. L'altissimo livello degli studi è garantito dai docenti che provengono da atenei quali l 'Università degli Studi di Torino, l'Università "La Sapienza" di Roma, l'Università "Roma tre", l'Università di Cassino, e dalle organizzazioni internazionali quali I' ONU, l 'UNIONE EUROPEA, la NATO, l'OCSE In oltre il corso si avvale dell'apporto di insegnanti militari, perlopiù Comandanti di contingenti multinazionali che hanno operato fuori area.
L'incremento dei compiti ha comportato per l'Istituto l'acquisizione e la ristrutturazione di nuovi complessi. Attualmente la Scuola di Applicazione può usufruire di ben 5 diverse infrastrutture dove svolgere le proprie funzioni didattiche e addestrative, passando dagli studi universitari all'utilizzo delle tecnologie più avanzate e allo sport.

La struttura principale è il Pala zzo dell'Arsenale, sede storica dell'Istituto e opera architettonica di notevole pregio edificata a paJtire dal 1739 nel rione S. Barbara della "città nuova". TI palazzo ospita, oltre al Comando, anc he le principali strutture didattiche ovc si svo lgono le le zio ni unive rsi tarie e tecnico-professionali per i corsi di formazione. Le aule e i laboratori sono 49, realizzati secondo i più moderni criteri di funzionalità, tra cui un'Aula Magna da 400 posti. Le aule sono dedicate agli allievi della Scuola caduti nel compimen to del loro dovere. Tra i vari laboratori spiccano quello di chimica c tecno logia dei materia li , quello dj fisica dei dispo s itivi elettronici, l'aula Sagat (sistema di automazione dell'artiglieria terrestre), l'aula dei materiali del genio. inoltre 3 laboratori per un totale di 96 posti sono destinati all'insegnamento dell' I nformatica. Particolare attenzione viene destinata all'insegnamento delle lingu e straniere con 4 laboratori
linguistici (totale l 04 posti) e 11 aulette di conversazione (totale 16 5 posti): so no tutti locali mu ltimediali, equipaggiati con supporti informatici c con l'accesso ai cana li tv satellitari

Co mplesso infras trutturale "Città di Torino"
La seco nda area significativa del polo didattico della Scuola di Applica.òone è quella un tempo denominata "Spianata di artiglieria". Dal 2001 il complesso, sito in corso Matteotti 18, è intitolato a ll a "Città di Torino", città decorata con la Medaglia d ' Oro al Va lor Militare. A partire dal XV Il seco lo, la 7ona costituiva l 'area sgombera da ostacoli per consentire l'incrocio del tiro delle artiglierie della Cittadella. poi nel corso delle opere di urbanizzazionc previste dal piano regolatore di inizio XX secolo venne ceduta, in ca mbio delle a r ee disme sse, dal Comune alla Amm inistrazione militare che awiò t:ma se ri e di lavori che portarono ali 'a ttuale complesso, che comprende una s uperficie di ci rca 22.000 mq. Delle opere edificate ali' inizio del 1900 non rimane traccia e i complessi edilizi oggi visib il i risalgono per lo più alla seconda metà del seco lo scorso: Pa lazzo Fanter ia costruito ne l 1961 , Palazzo Artiglieria ne l 196 8, Pa lazzo Servizi nc ll972 e Palazzo Simoni nel 1939. Essi sono destinati ad uffici, alloggi collettivi e ad aule didattiche, cui si aggiungono una palestra, una sala di potcnziamento mu sco lare , un padiglione di scherma. un campo di calcetto, una sala di addestra men to per la difesa personale. l: in tero co mpl esso dispone di 66 aule, prioritariamente impiegate per le attività didattiche del Master di Il livello in Scienze Strategiche e dei Corsi del Ruolo Speciale e della Riser va Selezionata. Cauta "L i Gobbi", di 303 posti, viene utilizzata per attività djdattiche a carattere uni versitario programmate a co rsi riw1iti.
Un discorso particolare merita Palazzo Simoni. Buon esempio di architettura razionale, costruito secondo i ca no ni este tici anni Trenta dell 'a rchitetto Marcello Piacentini e inau gur ato ne l 1939 è stato ini zia lm ente sede degli A lt i Comandi Militari, poi di comandi stranieri (Tedesco dal 1943 al 1945 c Alleato dal maggio del 194 5 al 1946) , in seg uito sede del l o Comando Militare Territoriale fin o al 1957 e, in segu ito, fino a l 1998 de l di sciolto Comando Regione Militare Nord Ovest. Per un breve periodo, fino a12000, an no del passaggio alla Scuola , ha ospi ta to il Comando Militare Regionale "Piemonte'·. Il palazzo è s tato intitolato al Cap. Gastone Simoni , effettivo de ll a Di visione Paracadutisti "Folgore", decorato della Medaglia d'Oro al Va lor M ilitare, caduto eroicamente ne ll ' ottobre 1942 ad El Alamein. La struttura ospita il Re parto Accademico e 42 aule destinate a l Master di Il livello in Scienze Strategiche. Nel complesso sono inoltre s tate r eali zza te 5 aule di diverse p otenzialità p er le lezioni del primo e del secondo anno del Corso di Laurea in Scienze Strategiche frequentate dagli s tudenti c ivi li. Vi è anche spazio per alcune strutture tec nologica mente ali 'avangua rdia adibite allo svo lgimento di attività add estrati ve particolarmente spec ializ7ate.
Sistema Automatizzato di Comando e Co ntrollo (SIACCON). Si tratta di un sistema informatico che consente di riprodune, su una cartografia, diversi scenari operativi e di simulare il flusso di comunicazioni tra i posti di comando e ipotetiche unità. E' utilizzato per addestrare gli Ufficiali frequentatori del Corso di Stato Maggiore. Le postazioni equipaggiate col STACCON 1° sono 64.
Sistema elettronico dj simulazione F.A.T.S. (Fire Au tomatic Training System). Consente l 'addestramento al tiro individual e. In una sala di dimensioni ridotte, tramite proiezioni di filmati s u schenna che simulano vru; ambienti operativi ed armi dotate di raggi laser, vengono addestrati fino a 5 frequentatori contemporaneamente. Le armi usate sono la pistola Beretta mod. 92 F, il fucile Beretta AR 70/ 90, l'anna controcarro a corta gittata Panzerfaust, mentre la distanza dci bersagli varia virtualmente da una distanza minima di 7 metri a una massima di 450 metri.
E' destinato alle attività sportive e si trova all'interno del più vasto comprensorio della Piazza d'Armi a Torino ed è sede del Centro Ippico Militare (CTM). Comprende un maneggio coperto, 2 maneggi scoperti, 38 box per cavalli, 6 campi da tennis, 2 campi da calcetto polifunzionali , un campo di calcio, una pista di atletica, un percorso volto ad addestrare i militru·i ad opera-

re c muovere in presen7a di ostacoli diversi (CAGSM).
Galoppatoio militare "Dardi "
Sorge sull'area dell 'ex poligono del Meisino e comprende due scude1ie con 32 cavalli. L'area è inclusa nel parco tluviale Pa-Stura, cti grande interesse naturalistico poiché è una delle poche zone in Europa dove nidificano gli aironi. In tale area, viene consentilo l'accesso a visite guidate per l'osservazione dei volati li ivi presenti.

La Scuola di Applicazione, per il prestigio della sua sede e per il suo riconosciuto va lore come Istituto di formazione, è coinvo lta durante l'anno in diverse manifestazioni a carattere culturale c sportivo, oltre ad essere teatro di importanti cerimonie istituzionali. Queste ultime sono particolarmente sentite come segno di continuazione tangibile delle gr'dfldi tradi7ioni del passato e stimolo per la coesione attorno ai valori fondamentali della Patria Si svolgono sempre alla presenza delle massime autorità militari e civili, l'inaugurazione c la chiusura dell'Anno Accademico, il giuramento degli Ufficiali frequentatori provenienti dall 'Accademia di Modena, il giuramento degli Ufficiali a Nomina Diretta c di quelli della Riserva Selezionata, la Festa dell'Arsenale c i raduni degli ex allievi. Tra le molte competizioni sportive di rilievo cui l'fstituro partecipa, segnaliamo svariati concorsi ippici nazionali, i Campionati
Esercito delle varie discipline (Sci. Ciclismo, Nuoto, Tiro d'armi d'ordinanza, Triathlon militare,

Maratona. etc.), la Gara internazionale di pattuglie militari. Gli splendidi saloni di Palazzo Arsenale fanno inoltre da elegante cornice ad incontri cultw-ali con personalità di rilievo del panorama intellettuale, politico e istituzionale italiano. In programma durante l'anno convegni, seminari di studi, cicli di conferenze, concerti e presentazioni di opere lette1-arie. L:Istituto ha inoltre ospitato incontri a livello internazionale quali quello dei Ministri della Difesa italiano e francese ill3 ° Comitato misto ItaliaSpagna e le celebrazioni del ventennale della Perestroika alla presenza di Michail Gorbaciov. Agli studenti e ai ricercatori è consentito l'accesso alla preziosa Biblioteca storica della Scuola che vanta 16mi1a volumi, tra cui alcune rare edizioni che spaziano dal XV al XIX secolo.
Visite illustri
A riconoscimento dell'importanza che la Scuola di Applica.Lione e Istituto Superiore di Studi Militari riveste nell'ambito della formazione delle forze Armate ed ora anche del personale civile impegnato nelle operazioni dipeacekeeping, l' Istituto è stato visitato di recente da due Presidenti della Repubblica

Italiana: francesco Cossiga il 28 ottobre 1989 e Carlo Azeglio Ciampi il 20 novembre 2001. Il Presidente Ciampi, in qualità anche di Capo Supremo delle Forze Armate, nell'incontro con gli studenti e con gli Alti Ufficiali ha sottolineato l'imp01tanza della fonnazione dei Quadri delle Istituzioni Militari Nazionali, anche in considerazione della crescente delicatezza dei compiti ad essi affidati dalla Costituzione e dagli impegni derivanti dal sistema di alleanze internazionali in cui il nostro Paese è inserito.
La vi sita di Giova nni Pao lo U e il Beato F r a ncesco Faà di Bruno
Un momento storico nella vita della Scuola di Applicazione è stata la visita a Pala7.m Arsenale da parte di Papa Giovanni Paolo 11 il 4 settembre 1988. La presenza de l Santo Padre ha coronato i l lungo impegno della Scuola per la crescita anche culturale e spirituale dei giovani allievi, nell'intento di formarli come uomini prima ancora che come militari. La visita di Papa Wojtyla rientrava nell'ambito di uno dei due viaggi da lui effettuati a Torino. Calto valore della visita del Pontefice è testimoniato dal suo desiderio di recarsi nel luogo dove, dall846 al 1848, il Luogotenente di Stato Maggiore Francesco Fàa di Bruno, beatificato nel 1988 a Roma, aveva frequentato il corso di specializzazione presso la Scuola di App licazio ne per le Anni do tte.
Calessandrino faà di Bruno ( 1825-1888) fu un personaggio eccezionale: figlio di un marchese, fu militare, fisico, astronomo, matematico, ingegnere civile. inventore, musicista, fondatore di varie istituzioni educative e sociali e infine sacerdote. formatosi negli istituiti militari torinesi, come Ufficiale combatté valorosamente nella Prima Guerra d'Indipendenza, si congedò nel 1853 e insegnò poi ali 'Università di Torino matematica e astronomia, inventò uno scrittoio per ciechi c nel 1868 realizzò

 21 - / 1 Ministro della Difesa On. Arturo Parisi sigla l'Albo d'Onore della Scuola.
21 - / 1 Ministro della Difesa On. Arturo Parisi sigla l'Albo d'Onore della Scuola.
 23- Vi sita del Capo di Stato Magg iore del/ 'Esercito, Generale C. A. Filiberto Cecchi
23- Vi sita del Capo di Stato Magg iore del/ 'Esercito, Generale C. A. Filiberto Cecchi

27- V isita del Sindaco di New York Rudo/ph Giuliani, accolto dal Sindaco di Torino
Sergio Chiamparino e dal Comandante della Scuola Gen. C. A. Armando Novelli.
28 - V isita del/ 'allenatore della Juventus Fabio Capello.

il campanile della chiesa di Nostra Signora del Suffmgio (o Santa Zita) a Torino, che all'epoca con i suoi 80 metri risultava il secondo edificio più alto della città dopo la Mole. Fu costantemente un uomo di fede tantoché, da militare, scrisse w1 "Manuale del soldato cristiano " Amico di don Bosco, in seguito creò una casa per mgazze madti, l ' Opera di Santa Zita, un collegio professionale, fondò la Congregazione delle Suore Minime di Nostra Signora del Suffi:agio e venne ordinato sacerdote nel 1876. Nell'occasione della sua visita il Papa ha benedetto l'altare di scuola juvarriana, recupemto fra le macetie degli edifici della Regia Accademia Militare bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale e posto nella Cappella della Scuola. Ancora oggi riecheggiano, profonde e significative, le parole tivolte da Giovanni Paolo U ai militari della Scuola: "La mia presenza in mezzo a voi vuoi essere anche un gesto di stima e di gratitudine per quanto compiete o vi preparate a fare a favore della sicurezza, della libertà e della pace. Sono valori ininunciabili , questi , che vanno inculcati negli animi dei giovani e per i quali è necessario svolgere ogni sforzo ed allenarsi interiormente con una profonda educazione spirituale e sociale che diventi un modo permanente di pensare e di agire[ ]. Le vostre Scuole, infatti, ham10 come obiettivo principale l ' educazione degli allievi, soprattutto di quelli che si troveranno ad essere responsabili di altri giovani. l programmi della Scuola di Applicazione mirano in effetti a preparare uomini capaci di comprendere i moderni sistemi preposti alla tutela della pace. Essi esigono determinazione, ma anche lucidità nel considerare i nuovi scenari della vita intemazionale. Vi auguro di inquadrare la vostra preparazione in questa ampiezza di orizzonti [.. .]. Ci sono dunque profonde esigenze morali alla base dell'educazione di responsabili della vita militare. I.: esempio del vostro collega Faà di Bruno e il richiamo della tmdizione ctistiana ancora viva in Italia vi aiutino a entrare in confronto coraggioso con queste esigenze. La novità dell ' uomo non 1isiede tanto nelle acquisizioni tecniche oggi raggiunte, quanto nella capacità di usarle con spirito nuovo. La condizione militare ha il suo fondamento morale nell'esigenza di difendere i beni spirituali e materiali della comun ità nazionale, della Patria. Questa difesa, garante del bene comune di un popolo, è un presupposto della pace e della concordia tra le nazioni [ .]. La difesa è prudenza, è diritto, è dovere che impegna gli uomini ad una continua vigilanza, interiore ed esterna, per preven ire lo scatenarsi dell'odio e della gueJTa. Siate dunque convinti di svolgere un compito di pace[ .]".

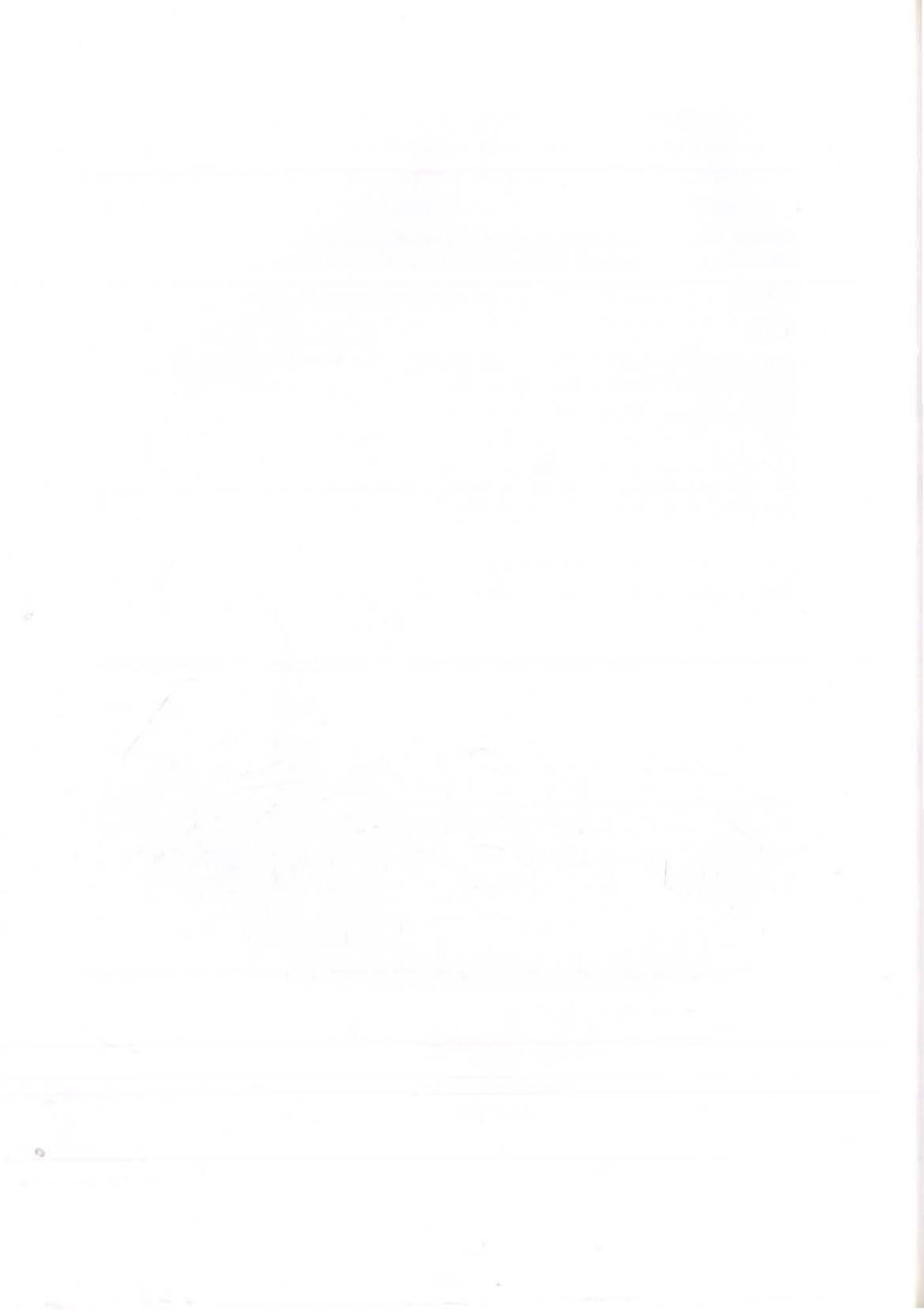

Nei secoli XVIII e XIX le Bandiere venivano concesse in dotazione esc lusivamente ai reparti di Fanteria e Cavalleria, le cosiddette "Armi di linea" e solo nel 1935 la concessione di Stendardi e Labari fu estesa ai regg1menti di Artiglieria e a quelli del Genio. Unica deroga a questa regola fu la concessione fatta dal Re Carlo Alberto nel 1840 alla Regia Accademia Militare.
Le Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortificazione quindi non hanno mai avuto una Bandiera propria. Nello stesso giorno in cui esse furono fondate, il 16 aprile 1739, però veniva-
no concesse al Battaglione de li' Artiglieria e degli ingegneri due Bandiere che vennero di conseguenza adottate anche dalle Scuole. Con le modifiche apportate da Vinorio Amedeo Ul, fu creato il Corpo Reale di Artiglieria e furono va ri ate anche le Bandiere: venne così creata la "Co lonnella 1776" c he le Scuole mantennero sino al 18 16. Successivamente, con l a Restau razione, il Corpo Reale di Artiglieria fu riordinato e ad esso fu assegnata una nuova Bandiera, la "Colonnella mod. 1816", che rimase in dotaLione delle Scuole Teoriche e Pratiche fino allo scioglimento pochi anni dopo.
Per quel che riguarda le altre Scuole di Applicazione, quella di Fanteria non ha mai avuto una sua Bandiera mentre a quella di Cava ll e ria ne l 1934 ve nn e co nc esso l 'uso dello Stendardo Nazional e. Finita la Seconda Guerra Mondiale, le Scuole militari vennero u nite mediante la riunificazion e in Mod ena di tutte le Accademia Mi l itari (c ui venne co ncessa la Bandiera Nazionale nel 1947) e, a Torino, delle Scuole d'Applicazione d 'Arma

Finalmente nel 1977, a riconoscimento dell'amalgama dei preesistcnti Istituti di formazione nell'unica Scuola di A ppli cazio ne, ve1me ad essa co nferita la B andiera. Il Tricolo re venne consegnato durante una so lenne cerimonia nel cortile d'onore del Palazzo dell'Arse na le, durante la quale la Bandiera fu anche fregiata con la Medaglia d'Argento al Valo r Militare, concessa alla Scuola di Applicazione dì Fanteria di Parma, per aver tenacemente resist i to ag l i attacchi tedeschi 1'8 settembre 1943. Madrina della cerim onia, la vedova del Generale Giuseppe Perotti, Medaglia d'Oro al Valor Milìtare, già allievo e insegnante della Scuola di Applìcazione del Genio, combattente delle due guerre mondiali, Eroe della Resistenza fucilato insieme ad altri sette patrioti il 5 aprile 1944 al Martinetto di Torino.
L'attuale Scuo la di Applicazione c Istituto Militari di Studi dell'Esercito è nata quale Scuola w1ica per tutte le Armi il primo agosto 1976. Il nuovo Stemma fu concesso ne l 1977 e modificato ne l 1987. Gli eleme nti blasonati nello scudo sono du e: la diretta discende nza della Sc uola di Applicazione dai tre preesistenti [stituti similari ( la Scuola di App li ca7ione di Fante ri a e Cavalleria, la Scuola di A ppli cazion e di Artiglieria e la Scuola di Applicazione del Genio) ed il legame co n la città di To rin o. Lo scudo è pertanto s uddi viso in quattro parti, delle quali le prime tre ri cordano le scuole e l'ultima la città.
* Il primo quarto ricorda la Scuola di Applicazio ne e di Fanteria e Cavalleria. A sua volta lo spazio è suddiv iso in quattro spazi: ne l primo quarto appare l 'Arme del Piemonte, c roce d'argento s u campo rosso caricata di un labello con tre pendenti azzurri; n el secondo l 'emblema tradizionale della Cava ll eria piemontese, l'aquila nera dal vo lo sp iegato su campo d'argento; nel terzo figurano l'Arme di Pa rm a (croce azzurra s u base d'oro ) e il s imb o lo della Fanteria, un gladio romano d'argento avvolto da un ramo d 'alloro, il tutto abbassato da un a zo na azzurra coo stella

d'argento (a ricordo della Medaglia d'Argento a l Valor Militare concessa alla scuola); nel quarto spazio, ancora ripartito, l'Arme di Pinerolo (d'argento a tre fasce di nero attraversate da un pino) e su fondo ro sso il cavallo d'argento alato, l'altro caratteristico simbolo della Cava lleria.
* li secondo quarto, invece, raiTigura lo Stemma delle Regie Scuole Teorico Pratiche di Artiglier ia e Fortificazione. Questo è partito innestato merlato d'oro (antico colore dell'arma di Artiglieria) e di rosso (antico colore del Genio) attraversato da una banda azzurra (colore dei Savoia fondatori delle Regie Scuole).

* Ana logamente il terzo quarto è dedicato alla disciolta Scuola di Applicazione del Genio. Lo Stemma è diverso da quello della Scuola di Artiglieria soltanto per l'aggiunta di una torre a tre piani.
* Nell'ultimo quarto è infine raffigurato il toro furioso d'oro su campo azzurro, Arme di Torino. Gli ornamenti esteriori dello Stemma comprendono il fregio e il motto.
11 fregio è rappresentato da una corona turrita d'oro, formata da cinque torri quadrate rettangolari con merli guelfi. Svolazzante, ai lati dello scudo, un nastro azzurro filettato d'argento.
Il motto "Doctrinas bello aptare" , che già appartenne alle Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortificazione, appare su una lista d'oro svolazzante sotto la punta dello scudo.
33 - S temma della Scuola di Applicazione di Fanteria nel l 940 (a sinistra).
34 - S temma della Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio ne/1940 (a destra).
35 - C artoncino commemorativo del primo centenario della Scuola di Cavalleria.


37- S opra, la "Campana del dovere",fusa da Simon Boucheron nel1678; oggi i suoi rintocchi si diffondono nel/ 'Istituto durante la cerimonia di apertura dell'Anno Accademico.

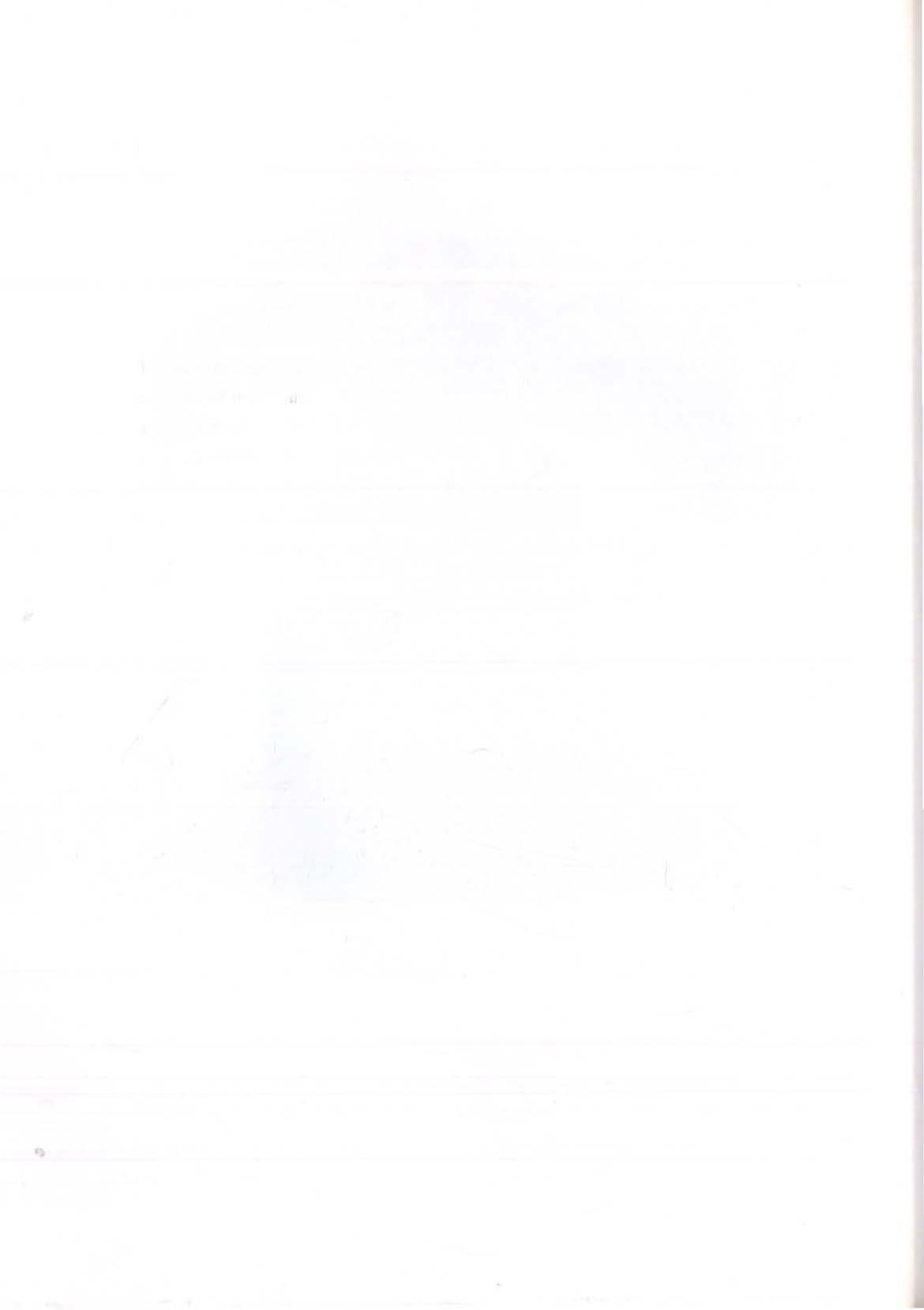
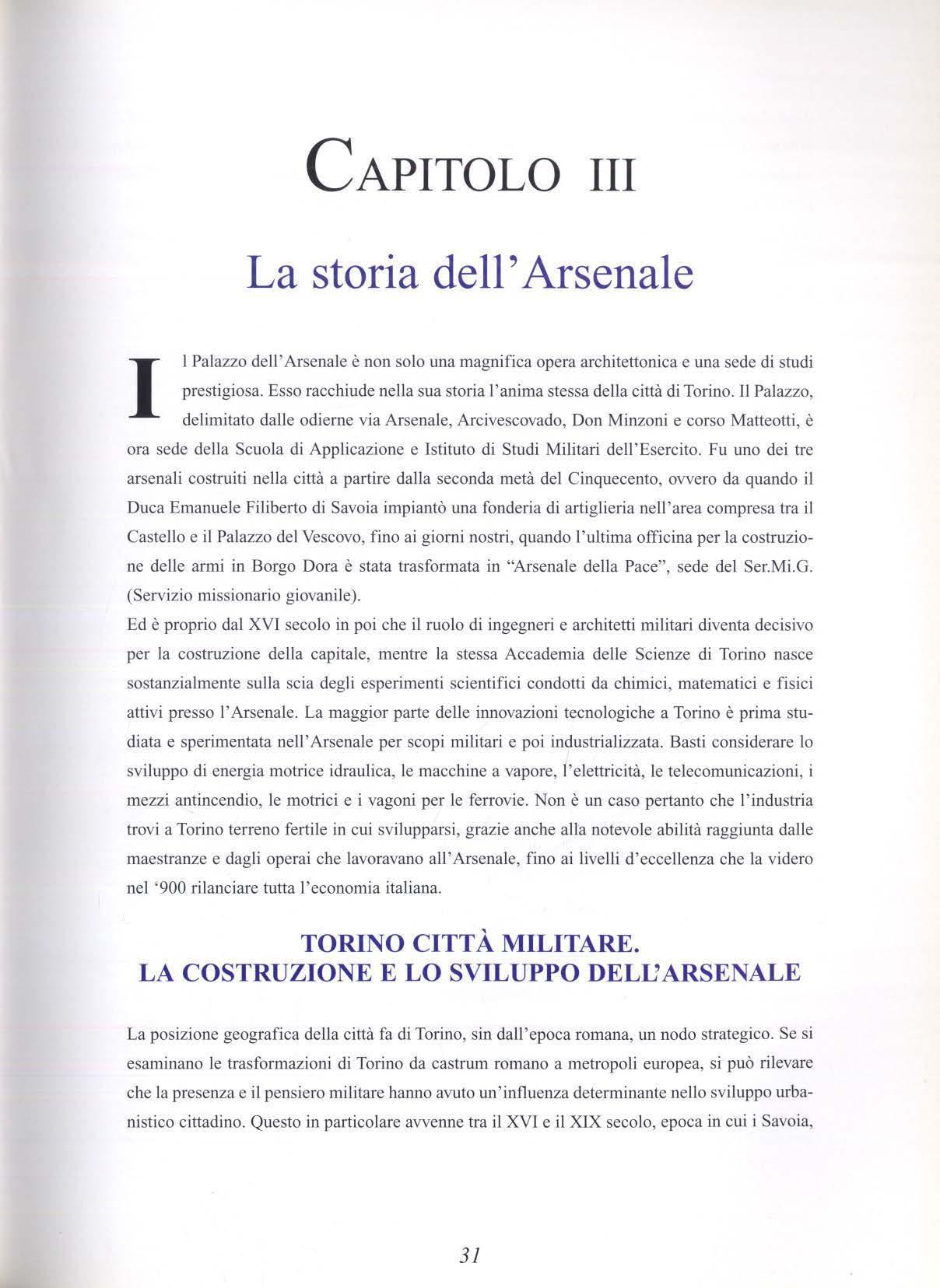
Il Palazzo dell'Arsenale è non solo una magnifica opera architettonica e una sede di studi prestigiosa. Esso racchiude nella sua storia l'anima stessa della città di Torino. li Palazzo,
delimitato dalle odierne via Arsenale, Arcivescovado, Don Minzoni e corso Matteotti, è ora sede della Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari de !l'Esercito. Fu w1o dei tre arsenali costruiti nella città a partire dalla seconda metà del Cinquecento, ovvero da quando il Duca Emanuele Filiberto di Savoia impiantò una fonderia di artiglieria nell ' area compresa tra il Castello e il Palazzo del Vescovo, fino ai giorni nostri , quando l'ultima officina per la costruzione delle armi in Borgo Dora è stata trasformata in "Arsenale della Pace", sede del Ser.Mi.G. (Servizio missionario giovanile).
Ed è proprio dal XVi secolo in poi che il ruolo di ingegneri e architetti militari diventa decisivo per la costruzione della capitale, mentre la stessa Accademia delle Scienze di Torino nasce sostanzialmente sulla scia degli esperimenti scientifici condotti da chimici, matematici e fisici attivi presso l'Arsenale. La maggior parte delle innovazioni tecnologiche a Torino è prima studiata e sperimentata nell'Arsenale per scopi militari e poi industrializzata. Basti considerare lo sviluppo di energia motrice idraulica, le macchine a vapore, l 'elettricità, le telecomunicazioni, i mezzi antincendio, le motrici e i vagoni per le ferrovie. Non è un caso pertanto che l 'industiia trovi a Torino terreno ferti le in cui svilupparsi , grazie anche alla notevole abilità raggiunta dalle maestranze e dagli operai che lavoravano all'Arsenale, fino ai livelli d'eccellenza che la videro nel '900 rilanciare tutta l'economia italiana.
La posizione geografica della città fa di Torino, sin dall'epoca romana, un nodo strategico. Se si esaminano le trasformazioni di Torino da castrum romano a metropoli europea, si può rilevare che la presenza e il pensiero militare hanno avuto un'influenza determinante nello sviluppo urbanis t ico cittadino. Questo in particolare avvenne tra il XVI e il XIX secolo, epoca in cui i Savoia,
dopo il tra sferime nt o da Chambéry alla piana piemontese, segui r ono un chiaro piano dinastico e politico vo lto allo sv iluppo della ca pitale dei domini saba udi . Ed è ali 'interno di questo scenario che nasce il Regio Arsenale di Torino, uno dei più antichi c famosi arsenali di materiale bellico, armi e artig lierie, insieme a quello d i Berlino , fatto costruire da Federico l di Pru ss ia agli iniz i d e l XVIll secolo. Per la sto ri a di Torino fu decisivo il de cennio dal 1560 al 15 70, quando il duca Ema nu ele Filiberto di Savoia, Testa di Ferro. ideò un accurato programma di ristrutturazione per la nu ova capitale, co n progetti di ampliamenti s ia s ul s is tema difensivo d ell a città, sia sulla sua
38 - L a pianta di Torino nel 1640. Nell a pianta è chiaramente individuabile il vecchio
Arsenale Filibertiano {A) nella piaz:::etta reale. La lettera (B), riportata nella città nu ova, indica il sedim e in cui verrà eretto il nuovo Arsenal e.
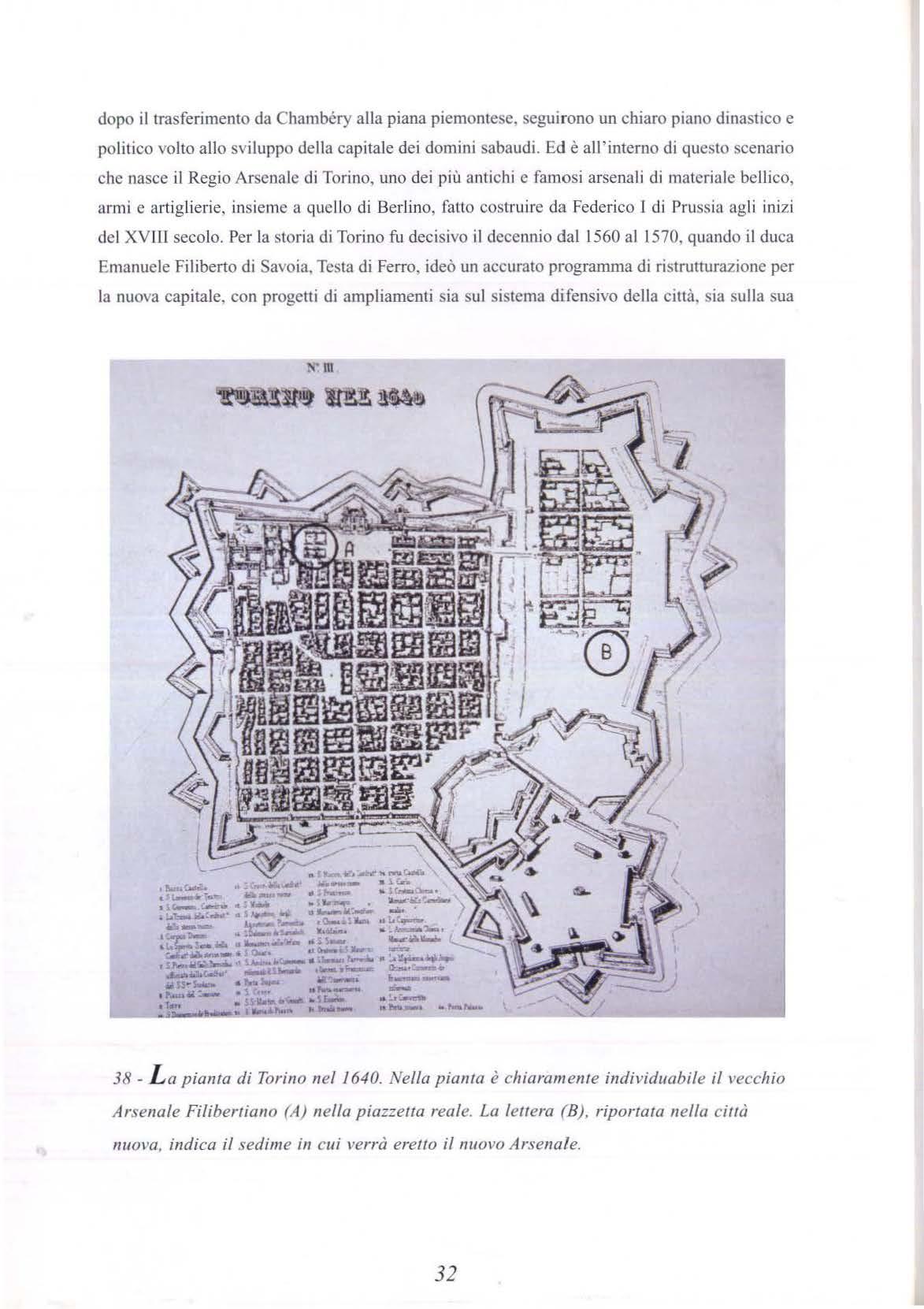
forma. Lo Stato Sabaudo, che nel 1559 aveva appena riacquisito la propria identità territoriale, era costretto a lottare per la sopravvivenza. Difatti la condotta delle operazioni belliche veniva sempre più condizionata dalla disponibilità e dalla potenza delle artiglierie e dal conseguente mutare dell'arte fortificatoria. Inoltre sui campi di battaglia le nuove tecnologie assumevano un'importanza sempre maggiore rispetto ai tradizionali metodi di combattimento. Emanuele Filiberto qtùndi dispo se la costruzione di una macchina di difesa bellica unica nel suo genere, la Cittadella, una grande fortezza pentagonale posta all'angolo sud occidentale del quadrato romano, e diede il via alla costruzione dell'arsenale. Il primo Arsenale, sorto intorno al 1570 , si trovava nella zona dell 'att uale Piazza Castello, ed era stato fortemente voluto dal duca al fine di non gravare l'erario con onerose importazioni di armi e di artiglierie dall'estero. Circa un secolo dopo, la necessità di sgomberare la piazza antistante iJ nuovo palazzo reale e quella di realizzare un arsenale di dimensioni e potenzialità tali da soddisfare le crescenti esigenze di armi e artiglierie dello Stato Sabaudo , indussero il duca Carlo Emanuele II a disporre il trasferimento dell'ormai vecchia fabbrica d'armi nella patie nuova della città, che andava ampliandosi verso meridione. L'impostazione del progetto veniva affidata dal duca all'architetto Carlo Morello il quale iniziava i relativi studi già a partire dal 1659. Per la sua costruzione, avviata intorno al 1660, poi continuata nel 1668 dagli impresari Domenico e Sebastiano Bernardi che vi lavorarono fino al 1674 e successivamente proseguita con lentezza per difficoltà di bilancio, era stata scelta un'area di fronte alla Cittadella, limitata dalla contrada deIl' Arcivescovado, da un tratto dei basti o n i e dalla cosiddetta Spianata di Artiglieria, una striscia di terreno che ve niva adibita sia al collaudo delle armi che all'addestramento del personale.
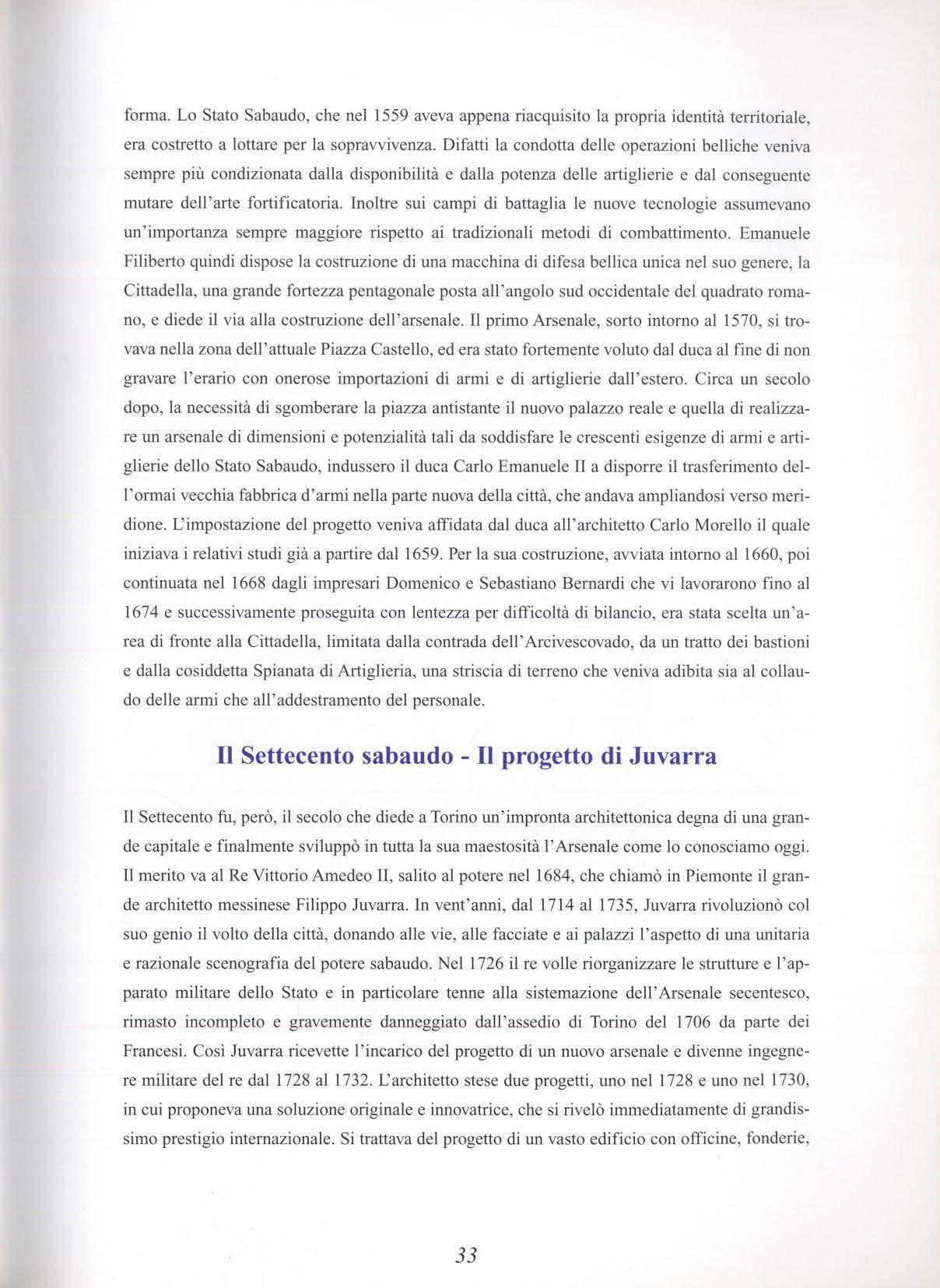
Il Settecento fu , però, il secolo che diede a Torino un 'impronta architettonica degna di una grande capitale e finalmente sviluppò in tutta la sua maestosità l'Arsenale come lo conosciamo oggi. Il merito va al Re Vittorio Amedeo li, salito al potere nel 1684, che chiamò in Piemonte il grande architetto messinese Filippo Juvarra. In vent'anni, dal 1714 al 1735 , Juvarra rivoluzionò col suo genio il volto della città, donando alle vie, alle facciate e ai palazzi l 'aspetto di una unitaria e razionale scenografia del potere sabaudo. Nel 1726 il re volle riorganizzare le strutture e l'apparato militare dello Stato e in particolare tenne alia sistemazione del! ' Arsenale secentesco, rimasto incompleto e gravemente danneggiato dall'assedio di Torino del 1706 da parte dei Francesi. Così Juvarra ricevette l 'incarico del progetto di un nuovo arsenale e divenne ingegnere militare del re dal 1728 al 1732. !.:architetto stese due progetti, uno nel 1728 e uno nel 1730, in cui proponeva una soluzione originale e innovatrice , che si rivelò u1m1ediatamente di grandissimo prestigio internazionale. Si trattava del progetto di un vasto edificio con officine, fonderie,
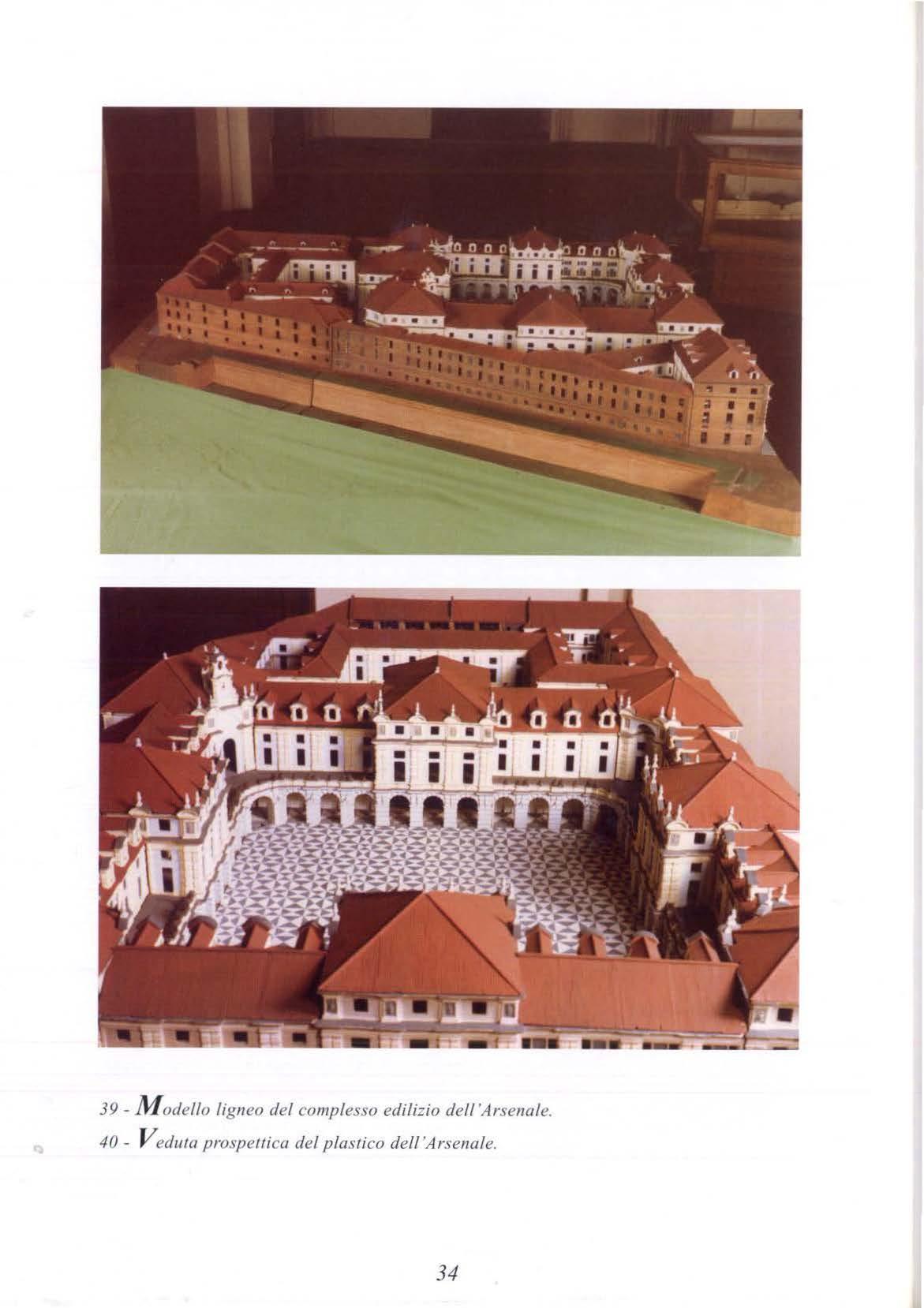 39- M odello /igneo del complesso edilizio dell'Arsenale.
39- M odello /igneo del complesso edilizio dell'Arsenale.
magazzini, locali di rappresentanza, aule per la didattica, alloggi per gli operai e per la guarnigione nùlitare che avrebbe gradualmente dovuto sostituirsi alla sede precedente , ma senza interrompere la produzione bellica. Nei suoi progetti Juvana introdusse una novità rivoluz ionaria per il suo tempo: separò la zona di produzione da quella di rappresentanza , nascose la prima dietro alla seconda e dotò quest ' ultima di uno stile moderno e vigoroso tale da riflettersi anche sulla prima. Fino ad allora , nessun altro Arsenale aveva potuto vantare geometrie così auliche ed e leganti: ampi cortili. perfettamente regolari ed essenziali , eleganti porticati , scaloni monumentali, simmetrie perfette, atmosfere luminose. La costruzione, alta due piani , prevedeva magazz ini e officine al pian terreno e le sale d'armi al secondo piano. Le idee juvaniane influenzarono in modo determinante gli ingegneri che gli succedettero alla direzione dei lavori. Juvarra, che morì nel l 736, fece in tempo a costruire solo una sala d'armi, elevata tra il 1730 e il 1732. Ques ta vem1e prima inglobata nei progetti successivi e poi demolita nel 1771.
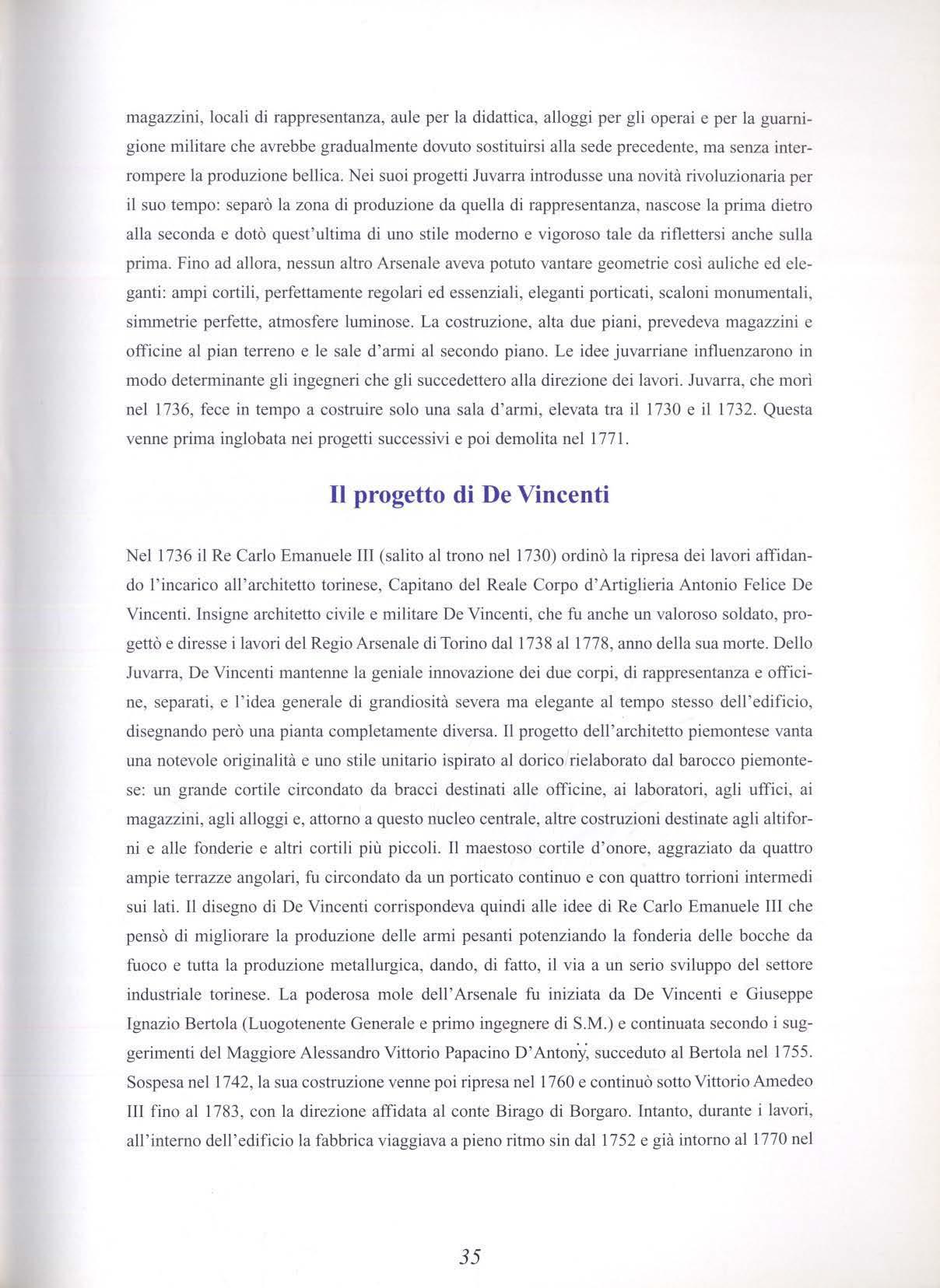
Nel 1736 il Re Carlo Emanuele Il1 (salito al trono nel 1730) ordinò la ripresa dei lavori affidando l' i11carico ali' arcmtetto torinese, Capitano del Reale Corpo d ' Artiglieria A11tonio felice De Vincenti. lnsigne arcmtetto civile e nùlitare De Vincenti , che fu anche un valoroso soldato , progettò e diresse i lavori del Regio Arsenale di Torino dal 1738 al 1778 , anno della sua morte. Dello Juvarra, D e Vincenti mantenne la geniale innovazione dei due corpi, di rappresentanza e officine, separati, e l ' idea generale di grandiosità severa ma elegante al tempo stesso dell'edificio, di segnando però una pianta completamente diversa. Il progetto dell'architetto piemontese vanta una notevole originalità c uno stile unitario ispirato al dorico rielaborato dal barocco piemontese: un grande co1tile circondato da bracci destinati alle officine, ai laborat01i , agli uffici, ai magazzini, agli alloggi e, attorno a questo nucleo centrale, altre costruzioni destinate agli altiforni e alle fonderie e altri cortili più piccoli. Il maestoso cortile d'onore , aggraziato da quattro ampie terrazze angolari, fu circondato da un porticato continuo e con quattro torrioni intennedi sui lati. ll disegno di De Vincenti corrispondeva quindi alle idee di Re Carlo Emanuele III che pensò di migl iorare la produzione delle armi pesanti potenziando la fonderia delle bocche da fuoco e h1tta la produzione metallurgica, dando , di fatto, il via a un serio sviluppo del settore industriale torinese. La poderosa mole dell'Arsenale f u iniziata da De Vincenti e Giuseppe
Ignazio Bettola (Luogotenente Generale e primo ingegnere di S.M.) e continuata secondo i suggerimenti del Maggiore Alessandro Vittorio Papacino D' Antony, succeduto al Bertola nel 1755.
Sospesa nel 1742 , la sua costTuzione venne poi ripresa ne l 1760 e continuò sotto Vittorio Amedeo lii fino al 1783 , con la direzione affidata al conte Birago di Borgaro. [ntanto, durante i lavori , ali ' interno dell'edificio la fabbrica viaggiava a pieno ri t mo sin dal 1752 e già intorno al1770 nel
nuovo Arsenale avevano sede tutte le manifatture di armi da fuoco, di legno, di cordaggio, la fonderia dei metalli, un innovativo trapano ad acqua (la tcnivella) per traforare i cannoni, il quartiere del Reggimento Reale di Artiglieria, un laboratorio di chimica e metallurgia, un gabinetto dì mineralogia, tm mu seo di modelli di fortificazioni antiche e moderne e una sala di armi antiche. Proprio in quel periodo, probabilmente fra il l 766 c il 1781, ali 'interno del Palazzo dcii' Arsenale furono trasferite le "Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artig li eria e Fortificazione", antenate dell'attuale Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Mili tari dell'Esercito.
Il periodo napoleonico, con la rinuncia al trono di Carlo Ema nuele IV e l'annessione dello Stato Sabaudo alla Francia ( 1798-1814), vide un ulteriore incremento dell'attività dcii' Arsena le. I Francesi, al posto di chiudere le officine, ne presero in mano la produzione con Ufficiali c personale d'oltralpe: grazie al governo napoleonico, infatti, ci fu una grande evoluzione dell'artiglieria piemontese, tantoché l 'attività delle fabbriche d'armi (ma la produzione includeva anche attrezzi, ruote, carri speciali, munizioni, macchine utensili) potrebbe essere considerata come il primo nucleo dell'industria metallurgica piemontese. Caduto Napoleone, nel t 814 Vittorio Emanue le l rientrò in Piemonte c il cantiere dell'Arsenale proseguì la sua espansione. Nel 1814 venne istituito un gabinetto di fisica contenente circa 600 macchine e nell822 una biblioteca che contava 4000 volumi, mentre nel 1840 i due laboratori (quello chimico-metallurgico c il gabinetto mineralogico) vantavano comp lessivamente una collezione di 3615 campioni di minerali. Col passare degli anni l'Arsenale continuava così a migliorarsi c a crescere nelle dimensioni e nella produzione, con alcuni amp li amenti voluti da Re Carlo Felice e Re Carlo Alberto. Dal 1848, infatti, Torino diventò il cuore dell'Italia e proprio in questa città fu necessario dare impulso alla costruzione degli armamenti per soste nere le guerre d'indipendenza intraprese da Vittorio Emanuele IT e realizzare il sogno di una patria unita. Torino, divenuta nel 1861 capitale d'Italia, perse ben presto il suo titolo a favore prima di Firenze c poi di Roma ( 1865). La città, privata del suo ruolo politico, in pochi anni vide un regresso nella popolazione e nelle attività, ma ebbe la forza di risollevarsi puntando sull'economia e riprendersi il ruolo di capitale. seppur non ufficiale: capitale dell'automobile, del cinema, della radio e di molto altro. In questo contribuì la svolta industriale della città che aveva il suo principale motore nella fabbrica de li' Arsena le la quale, sforna ndo ormai tutte le artiglierie per il neonato Regio Esercito Italiano, aveva contribuito allo sviluppo delle moderne tecnologie e alla formazione di maestranze specializzate.
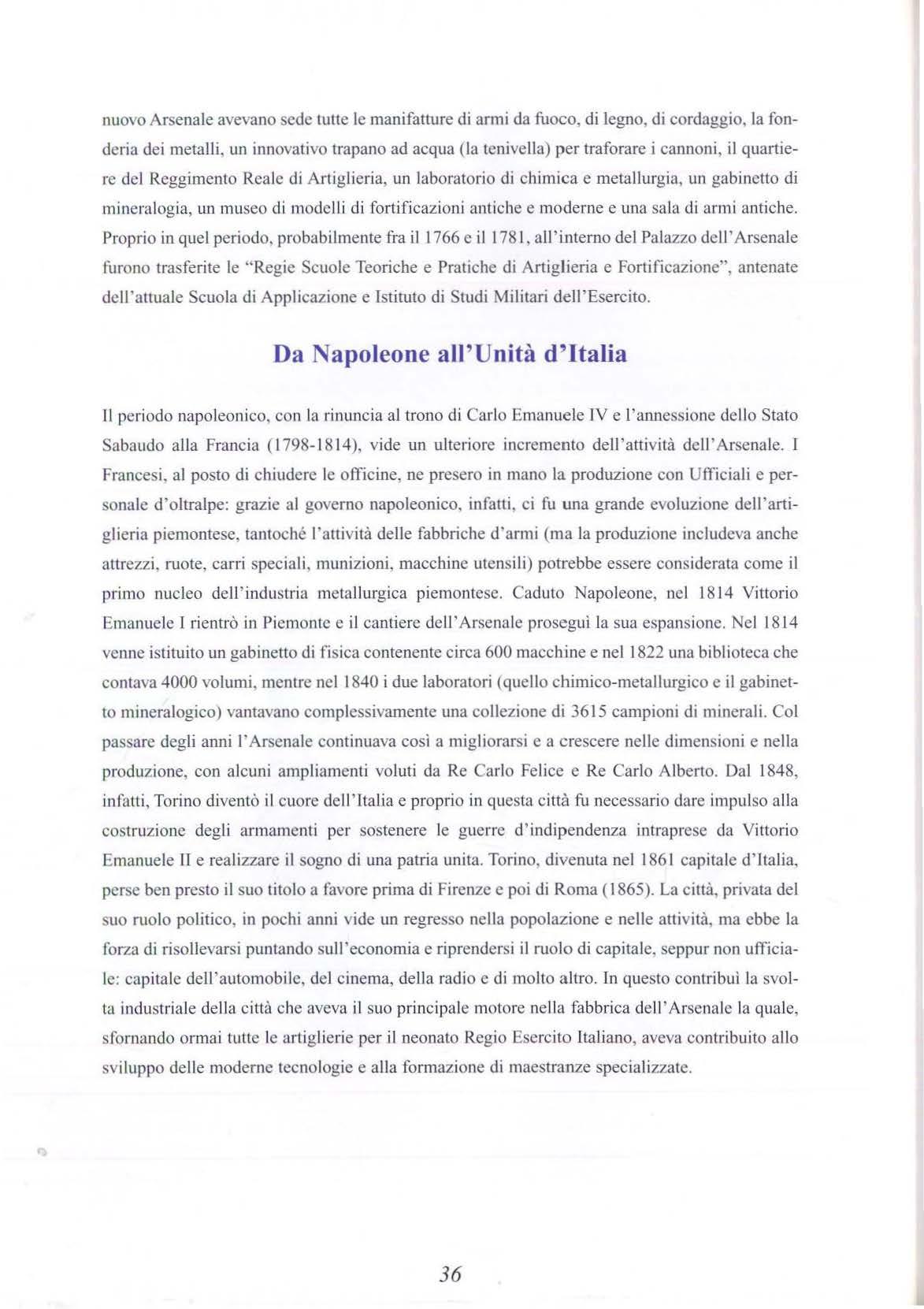
41 - C apitano Felice De Vincenti.
42- C ommendator Giuseppe Ignazio Serto/a , Conte di Exilles; Luogotenente Generale e Primo ingegnere di S. M.; Fondatore delle Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortifìca z ione da/1739 al 1755.
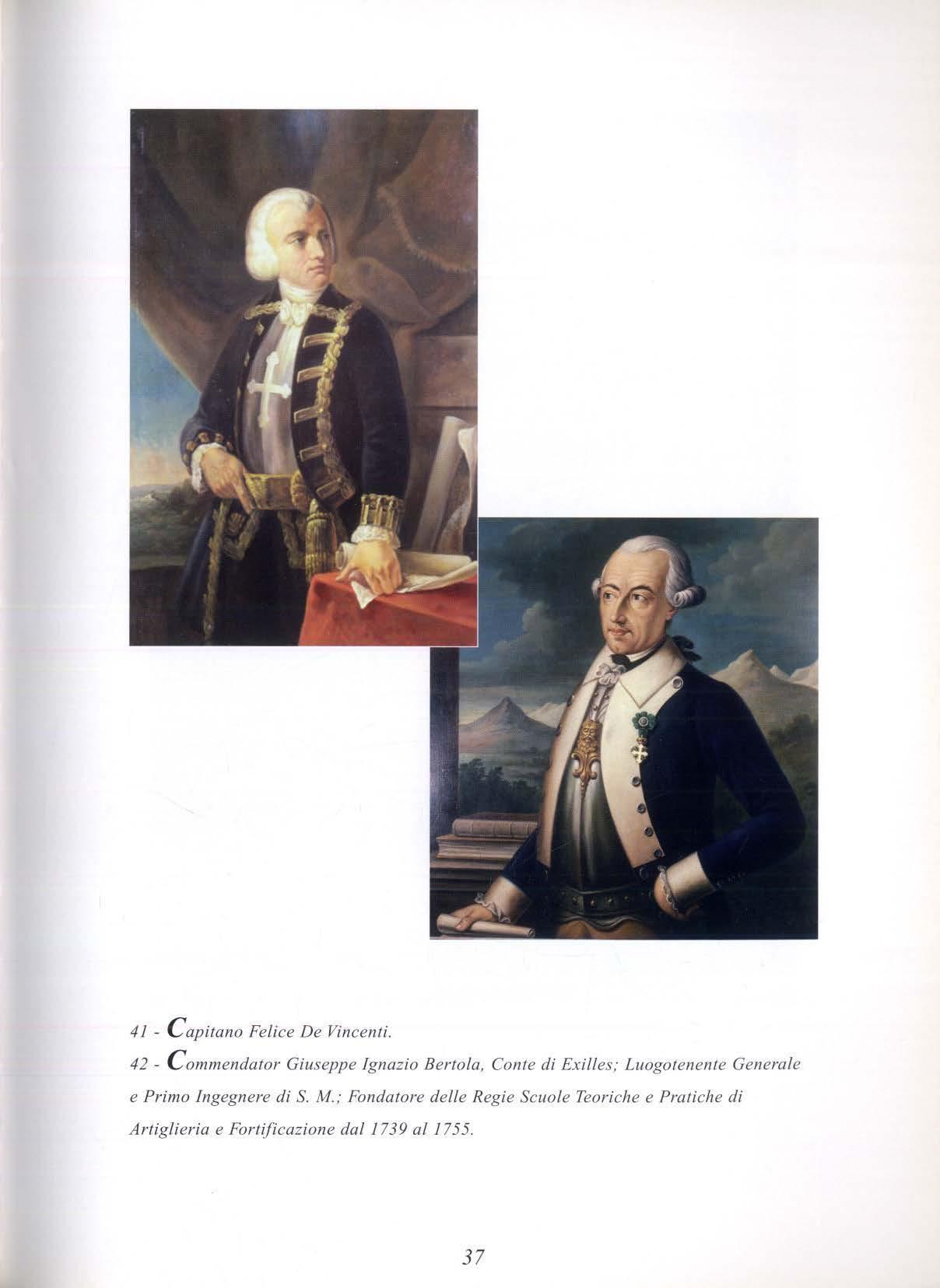
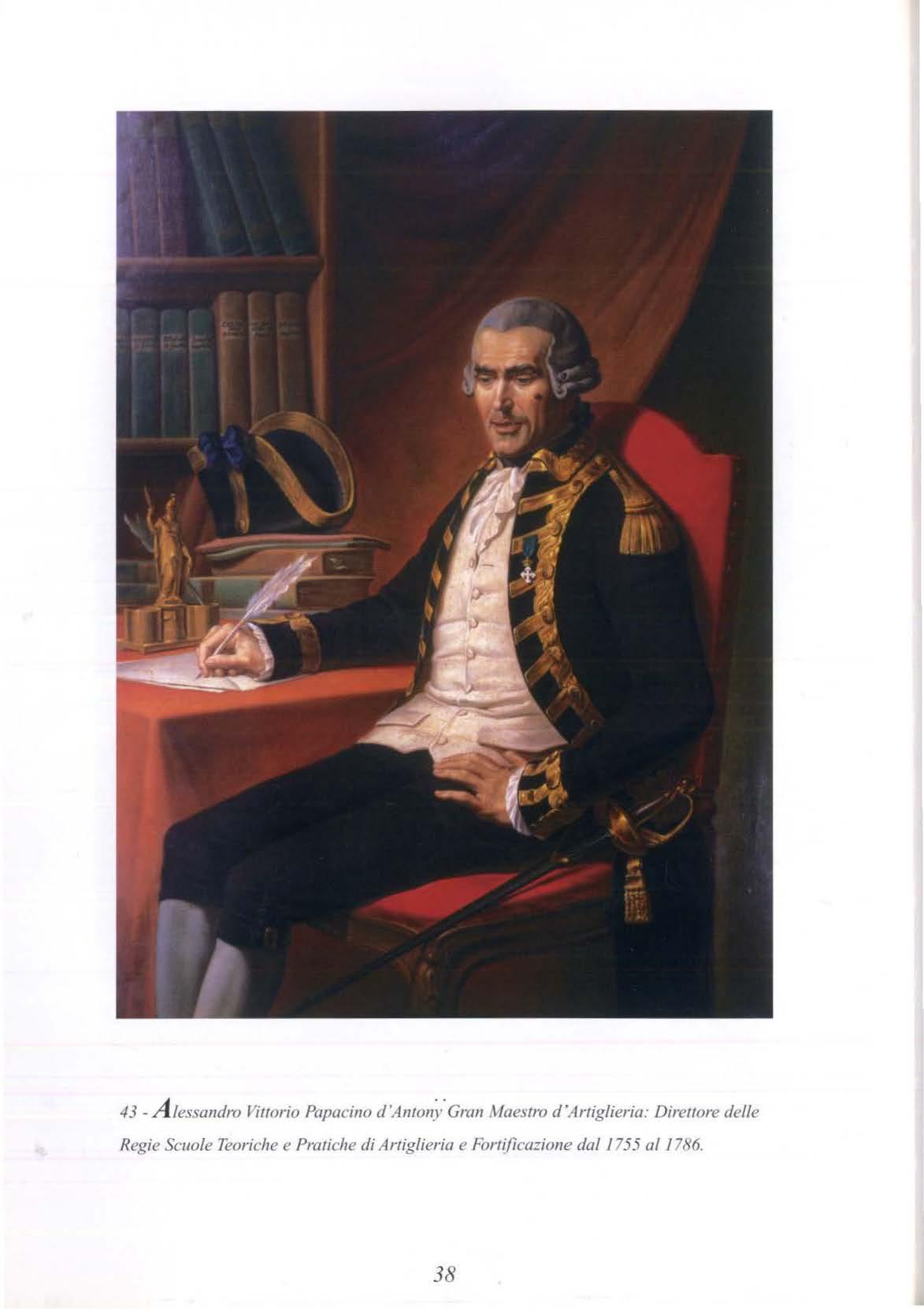
La lapide posta sul portale d'ingresso del palazzo reca la data del compimento della tàbbrica dell ' Arsenale sotto il regno di Umberto I, ill896. I numerosi fabbdcati utilizzati dalle tòndede, officine e magazzini dell 'Arsenale vennero demoliti agli inizi del Novecento, negli anni tra le due guerre mondiali , quando gli stabilimenti di produzione militare furono trasferiti all'Arsenale di Borgo Dora (la fonderia del secondo Arsenale fu ancora attiva fino al 1926) per consentire il riassetto urbano dell'area. Restò in piedi, quindi, il solo corpo principale del Palazzo, ormai totalmente votato alla formazione degli Ufficiali di artiglieria e genio. Durante i bombardamenti dcll942-43 l'Arsenale fu seriamente danneggiato (venne distrutta l'ala della Biblioteca) e venne successivamente restaurato con le fw12ioni attuali, cambiando il colore delle facciate in un rosso cupo. Solo in anni recenti vennero recuperare le tinte originali, giallo e azzurro pastello. Nel 1954 fu impiantata la fotolitografia e nel 1976 nacque l 'attuale Scuola di Applicazione con la 1iunificazione sotto un solo comando di tutte le Scuole d ' Applicazione d ' Arma preesistenti. Oggi Palazzo Arsenale è una sede prestigiosa di studi militati di visibilità anche intemazionale nonché uno dei poli culturali cittadini.
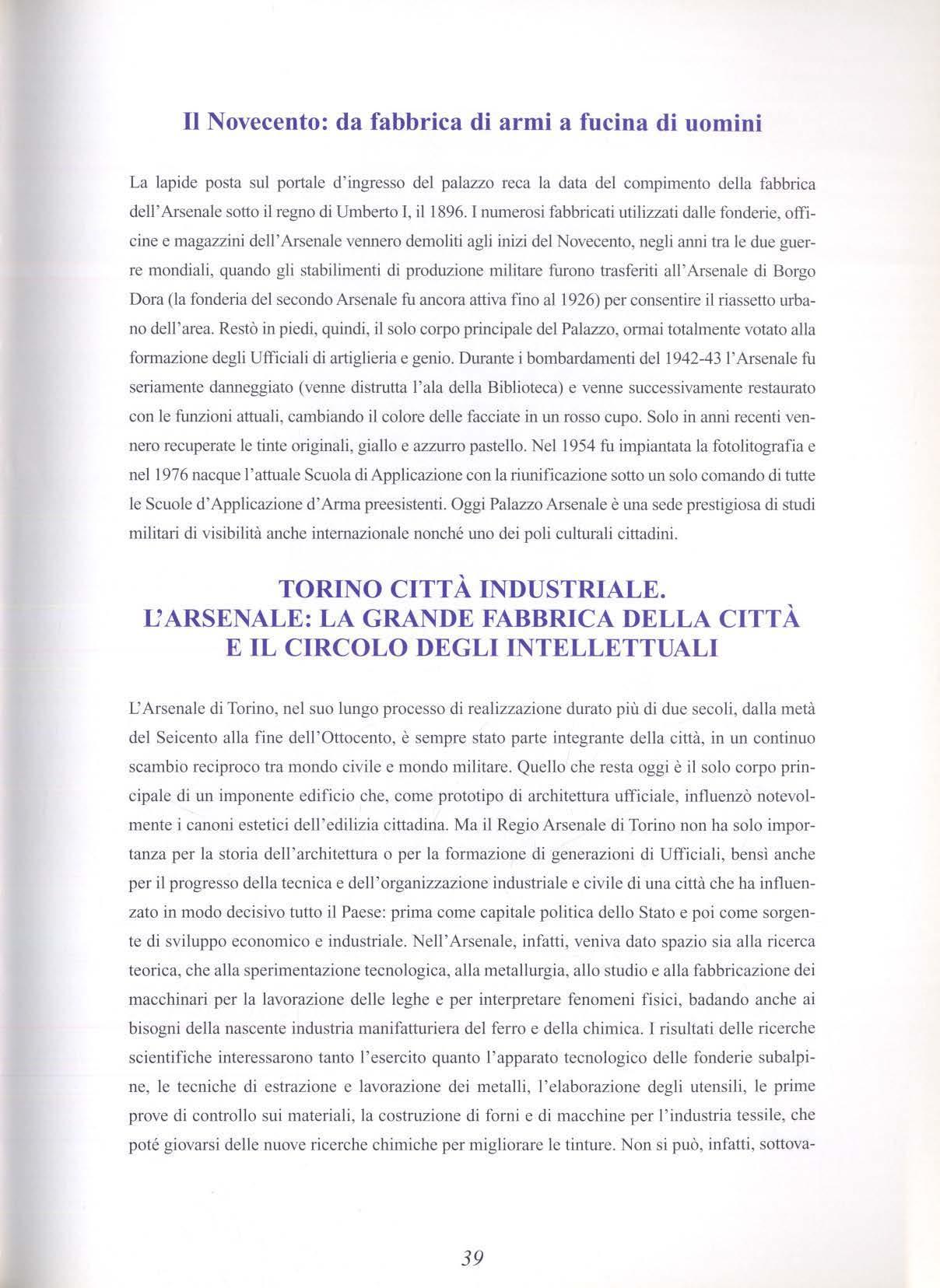
l: Arsenale di Torino, nel s uo lungo processo di realizzazione durato più di due secoli. dalla metà del Seicento alla fine de li 'Ottocento, è sempre stato parte integrante della città, in un continuo scambio reciproco tra mondo civile c mondo militare. Quello che resta oggi è il solo corpo principale di un imponente edificio che, come prototipo di architettura ufficiale, influenzò notevolmente i canoni estetici dell 'edili z ia cittadina. Ma il Regio Arsenale di Torino non ha solo importanza per la storia dell'architettura o per la formazione di generazioni di Ufficiali, bensì anche per il progresso della tecnica e de li 'organizzazione industriale e civile di una città che ha influenzato in modo decisivo tutto il Paese: pdma come capitale politica dello Stato e poi come sorgente di sviluppo economico e industriale. Nell'Arsenale, infatti, veniva dato spazio sia alla ricerca teorica , che alla sperimentazione tecnologica, alla metallurgia. allo studio e alla fabbricazione dei macchinari per la lavorazione delle leghe e per interpretare fenomeni fisici, badando anche ai bisogni della nascente industria manifatturiera del ferro e della chimica. I risultati delle ricerche scientifiche interessarono tanto l'esercito quanto l'apparato tecnologico delle fonderie subalpine , le tecniche di estrazione e lavorazione dei metalli, l 'elaborazione degli utensili, le prime prove di controllo sui materiali , la costruzione di forni e di macchine per l'industria tessile, che poté giovarsi delle nuove ricerche chimiche per migliorare le tinture. Non si può, infatti, sottova-
- J danni subiti dal palazzo a seguito di bombardamenti del! 'ultimo conflitto.
- / 1Cortile del Palazzo del/ 'Arsenale e le lavorazioni svolte.
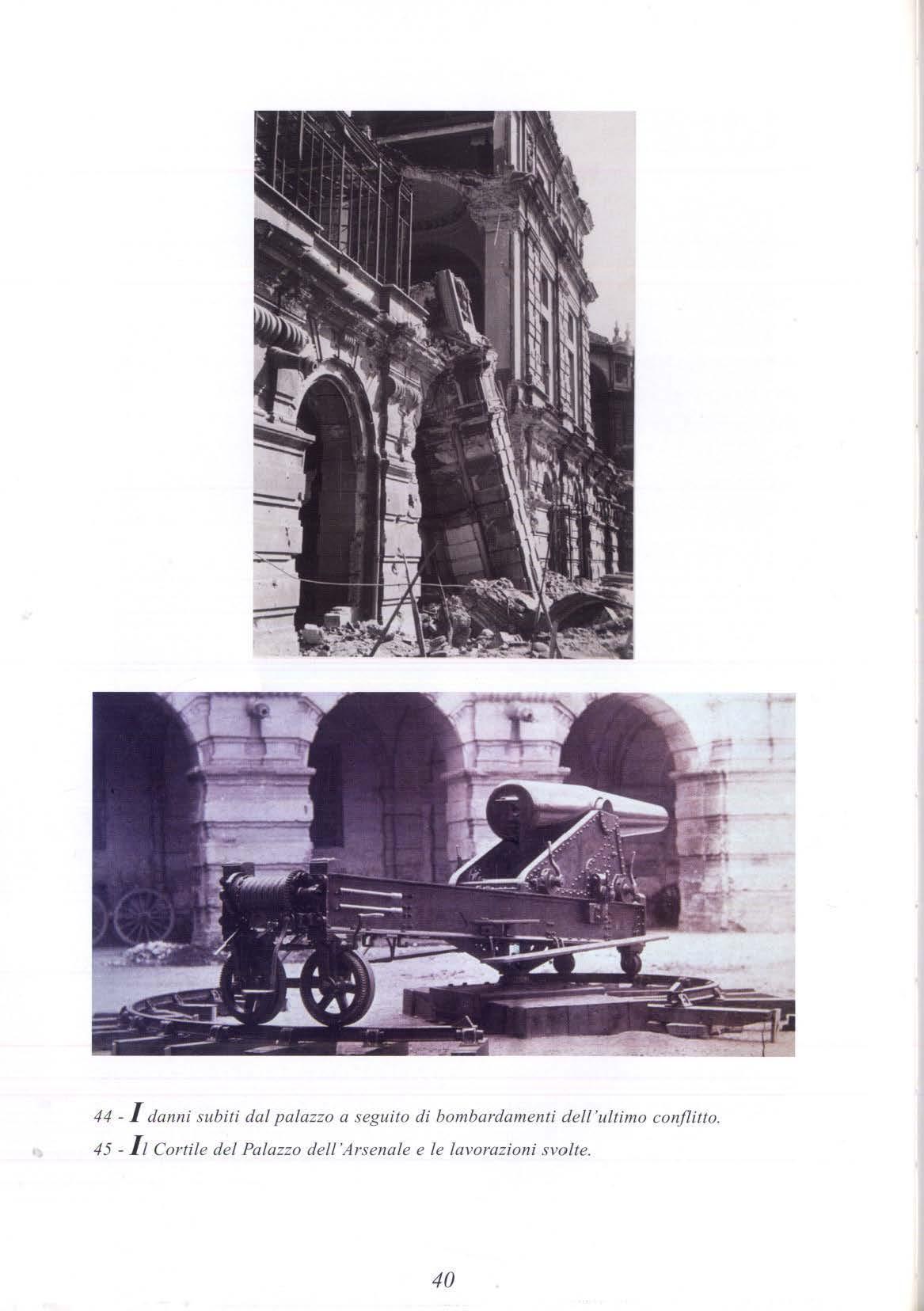
lutare il grande valore che le tecnologie degli armamenti ebbero nella fonnazione dell ' industria metallurgica piemontese e delle industrie manifatturie re.
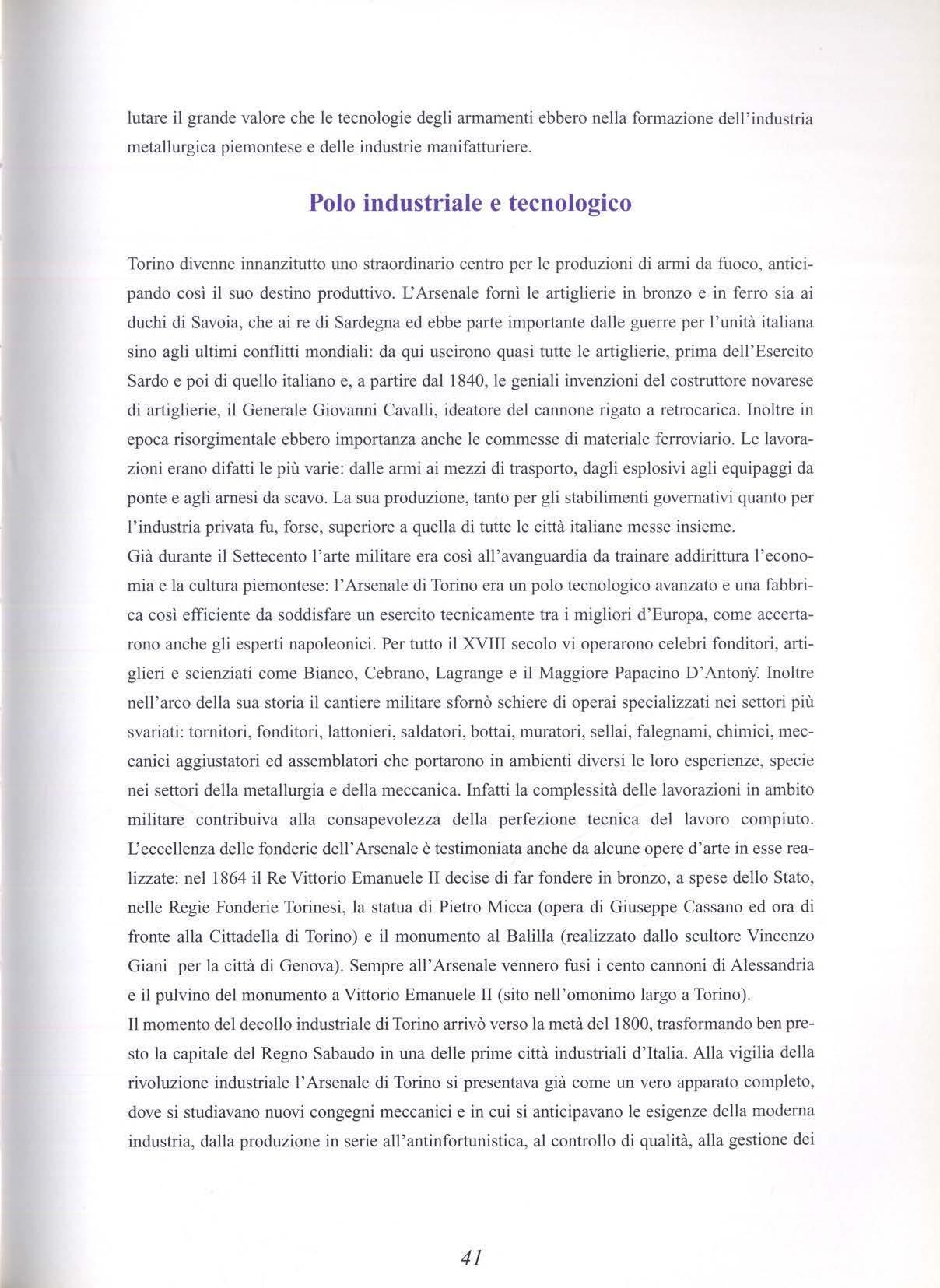
Torino divenne innanzitutto w1o s traordinario centro per le produzioni di armi da fuoco , anticipando così il suo destino produttivo. L'Arsenale fornì le artiglierie in bronzo e in ferro sia ai duchi di Savoia, che ai re di Sardegna ed ebbe parte importante dalle guerre per l'unità italiana sino agli ultimi conflitti mondiali: da qui uscirono quasi tutte le artiglierie , prima dell' E sercito Sardo e poi di quello italiano e, a partire dal 1840 , le geniali invenzioni del costn1ttore novarese di artiglierie, il Generale Giovanni Cavalli, ideatore del cannone rigato a retrocarica. Inoltre in epoca risorgimentale ebbero in1portanza anche le commesse di materiale ferroviario. Le lavorazioni erano difatti le più varie: dalle armi ai mezzi di trasporto , dagli esplosivi agli equipaggi da ponte e agli arnesi da scavo. La sua produzione , tanto per gli stabilimenti governativi quanto per l ' industria privata fu , forse , superiore a quella di tutte le città italiane mes se insieme.
Già durante il Settecento l'arte militare era cosi all'avanguardia da trainare addirittura l ' economia e la cultura piemontese: l ' Arsenale dì Torino era un polo tecnologico avanzato e una fabbrica così efficiente da soddisfare un esercito tecnicamente tra i migliori d ' Europa, come acc ertarono anche gli esperti napoleonici. Per tutto il XVIII secolo vi operarono celebri fonditori , artiglieri e scienziati come Bianco, Cebrano, Lagrange e il Maggiore Papacino D' Antony. Inoltre nell'arco della sua s toria il cantiere militare sfornò schiere di operai specializzati nei settori più svariati: tornitori , fonditori, lattonierì, saldatori, bottai, muratori, sellai , falegnami , chimici , meccanici aggiustatori ed assemblatori che portarono in ambienti diversi le loro espetienze, specie nei settori della metallurgia e della meccanica. Infatti la complessità delle lavorazioni in ambito militare contribuiva alla consapevolezza della perfezione tecnica del lavoro compiuto.
L'eccellenza delle fonderie dell'Arsenale è testimoniata anche da alcw1e opere d'arte in esse realizzate: nel 1864 il Re Vittorio Emanuele II decise di far fondere in bronzo, a spese dello Stato , nelle Regie Fonderie Torinesi , la statua di Pietro Micca (opera di Giuseppe Cassano ed ora di fronte alla Cittadella di Torino) e il monumento al Balilla (realizzato dallo scultore Vincenzo Giani per la città di Genova). Sempre ali' Arsena le vennero fusi i cento cannoni di Alessandria e il pulvino del monwnento a Vittorio Emanuele II (sito nell'omonimo largo a Torino).
Il momento del decollo industriale di Torino arrivò verso la metà del 1800, trasformando ben presto la capitale del Regno Sabaudo in una delle prime città industriali d'Italia. Alla vigilia della rivoluzione industriale l'Arsenale di Torino si presentava già come un vero apparato completo, dove si studiavano nuovi congegni meccanici e in cui si anticipavano le esigenze de ll a moderna industria, dalla produzione in serie all'antinfortunistica, al controllo di qualità, alla gestione dei
magazLini. Difatti l'industria militare all'epoca era il settore più all'avanguardia in campo produttivo: la maggior parte delle innovazioni tecnologiche a Torino venivano prima studiate c sperimentate nell'Arsenale per scopi militari e poi industrializzate. Basti riferirsi allo sviluppo delle produzioni di energia motrice idraulica, alJe macchine a vapore, all'elettricità, alle telecomuniai mezzi antincendio, alle motrici e ai vagoni per le ferrovie. Ma addirittura i progressi interessarono l'industria tessile c la chimica tintòria in relazione alla manifattura delle divise. Si può ben dire che l'Arsenale quindi fu il primo nucleo dell'industria metalmeccanica piemontese. Infatti, nel 1854, su disegno dell'ingegnere capo del Genio Sardo, il Capitano Virgilio Bordino (che era addetto all'Arsenale dove, tra il 1836, anno in cui realizzò il suo famoso "triciclo a vapore", e il 1854, costruì cinque vetture a vapore) fu realizzato nell'Arsenale un veicolo a motore che oggi possiamo ammirare al Museo dell'Automobile: si trattava di una carrozza "landau" adattata, con applicata una caldaia a motore a 2 cilindri orizzontali che poteva raggiungere una velocità di 8 km ali' ora e fu battezzata dai piemontesi '"l landò a vapor". Il 7 marzo 1859 lo stesso Bordino sperimentò sul viale dei Tigli (oggi Corso Massimo D'Azeglio) uno strano meuo che aveva battezzato "carro locomotore stradale", l'antenato dell'attuale automobile.
l:Esercito, infatti, doveva trovare il modo di effettuare un rapido trasporto di ingenti quantitativi di personale e materiali con mezzi e metodi più validi di quelli da sempre usati (cavalli, muli e carri). Le industrie meta! meccaniche in espansione a Torino, unite a quelle militari cd agli istituti e laboratori di ricerca e spcrimentazione, civili e militari, costituirono l'ambiente più adatto per un rapido sviluppo in questo settore. Nel 1862 una statistica (la prima del genere) contava nel settore ben 5.924 lavoratori. Nel 1899 alcuni addetti all'industria meccanica dell'Arsenale (dove avevano imparato a fondere i cannoni, lavorare l'acciaio e il rame, laminare rotaie per le ferrovie, etc.) costituirono parte delle maestranze di base della nascente FlAT e durante la Prima Guerra Mondiale, all'interno dell'Arsenale, venne realizzata una prima catena di montaggio. Negli armi fra le due guerre la produzione delle fonderie si spostò in altri stabilimenti c dal primo ottobre 1926 l'Arsenale ha solo il compito di formare gli Ufficiali dell'Esercito Italiano.
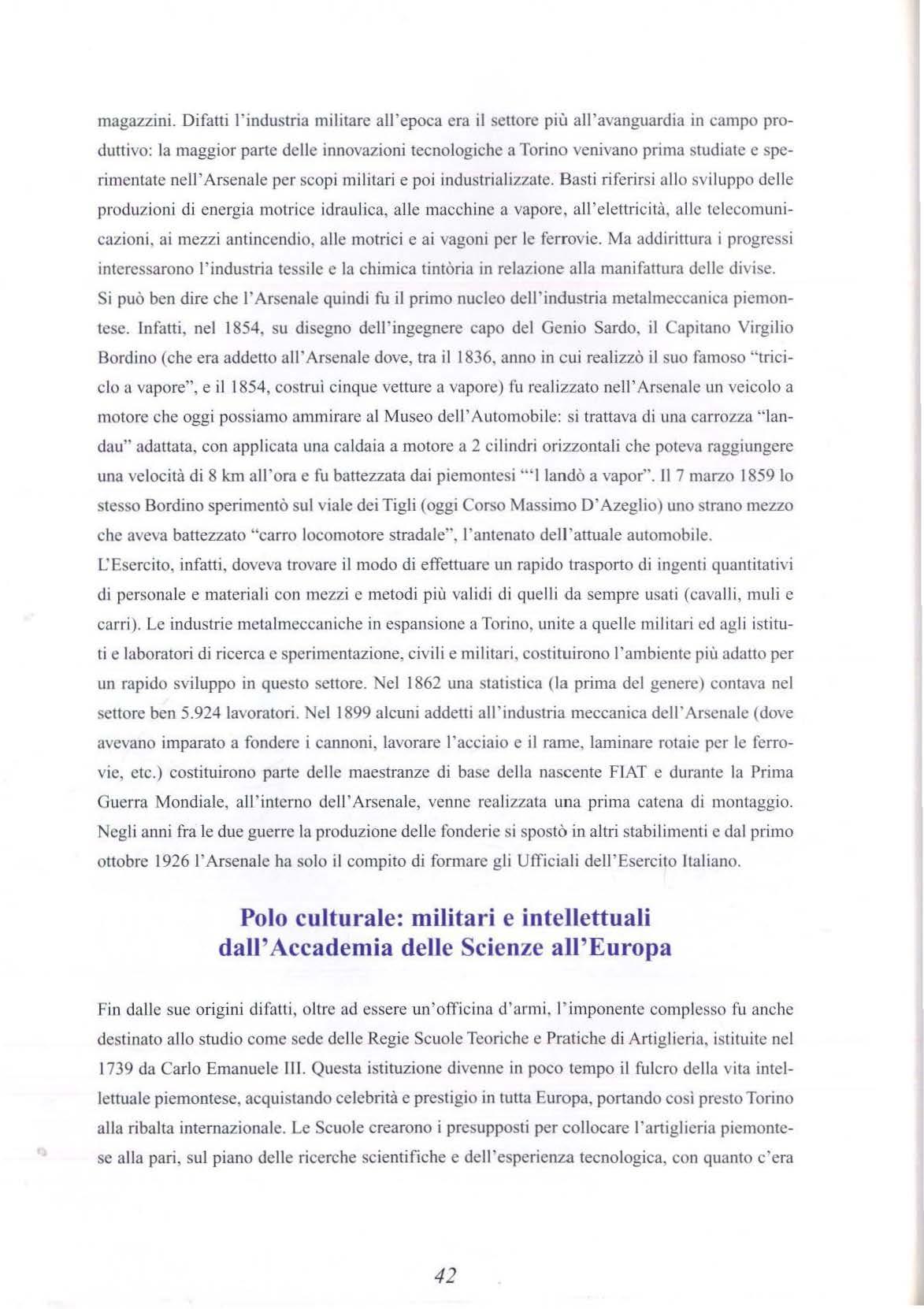
Fin dalle sue origini difatti, oltre ad essere un'officina d'armi, l'imponente complesso fu anche destinato allo studio come sede delle Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria, istituite nel 1739 da Carlo Emanuele Ili. Questa istituzione divenne in poco tempo il fulcro della vita intellettuale piemontese. acquistando celebrità e prestigio in tutta Europa, portando così presto Torino alla ribalta internazionale. Le Scuole crearono i presupposti per collocare l'artiglieria piemontese alla pari, sul piano delle ricerche scientifiche e dell'esperienza tecnologica, con quanto c'era
46 - L agrange in età matura da un 'opera di L. David.
47 - L ettera con la quale Papacino D 'Antony disponeva l'invio presso la Corte del Portogallo di libri in uso presso le R egie Scuole Militari.
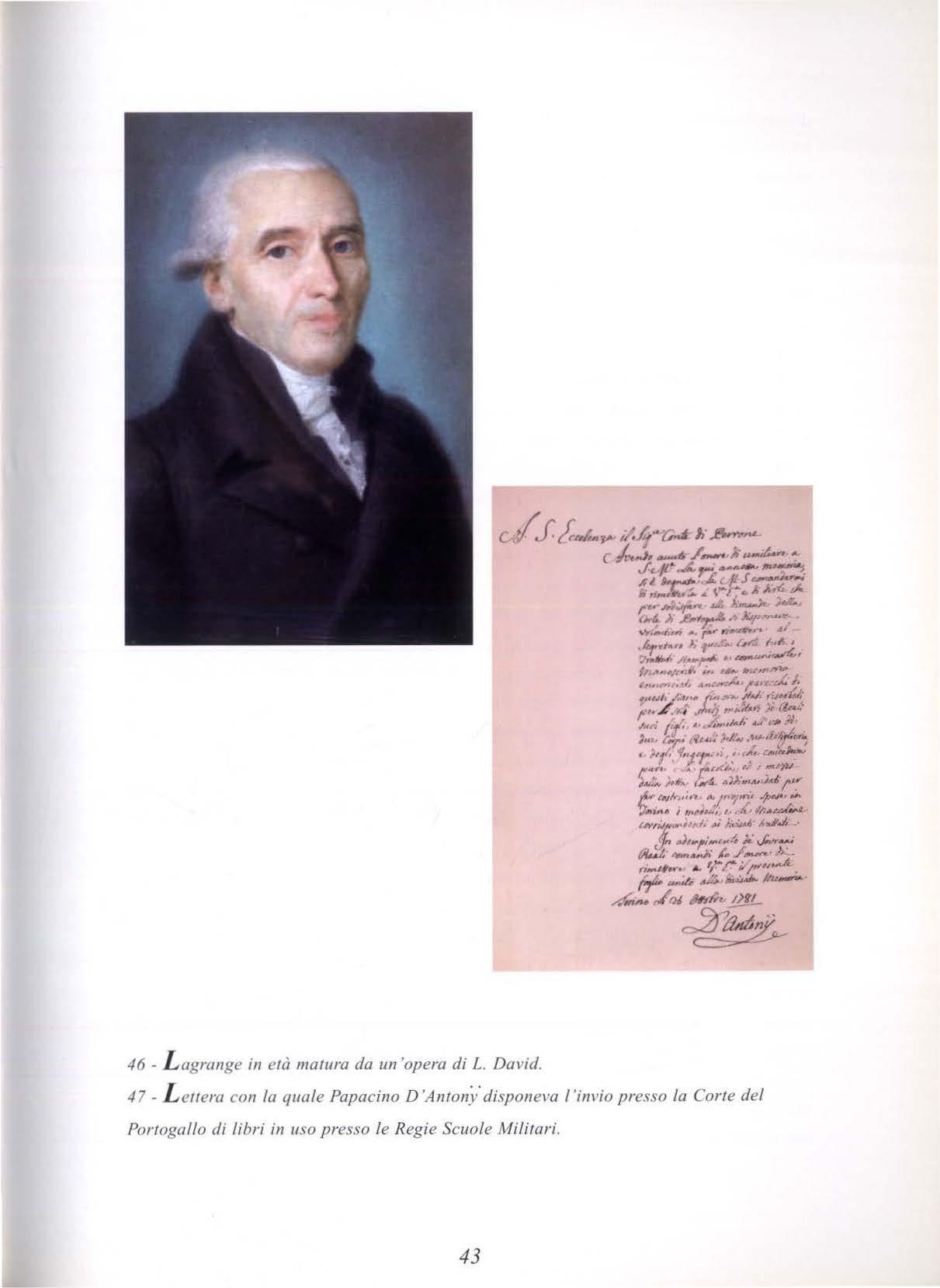
di meglio in Europa. Il rapporto degli studiosi suba lpi ni con i grandi problemi della scienza affrontati nei laboratori dell'Arsenale fu certamente all'origine di quell'atmosfera culturale che condusse nel 1783 personalità come Luigi Lagrange e Angelo Saluzzo (che insegnavano alle Scuole) alla creazione dell'Accademia delle Scienze, prcstigiosa istituzione scientifica e letteraria che porta tuttora lustro al i 'Italia nel mondo. Nel 1757, difatti, Saluzzo, Lagrangc c Cigna fondarono una Società scientifica a carattere privato che 26 anni dopo venne ufficializzata nell'Accademia, raccogliendo tra i propri soci le maggiori personalità della cultura piemontese c figure eminenti dell'Illuminismo francese come d' Alembert e Condorcet. Ed è proprio tra il 1755 e il 1766 che il giovane, e già celebre matematico, Lagrange insegnò presso le Regie Scuole di Artiglieria (l'incruico gli fu assegnato a 19 anni quando era già considerato uno dei cinque migliori matematici d'Europa) sino alla sua partenza per Berlino. Grande successo ebbe la pubb licazione dei "Principi di matematica" sublime trattato da lui redatto per gli allievi Ufficiali. I n Piemonte si formò così una profonda cultura e mentalità scientifica che influenzò anche la vita intellettuale torinese dei secoli successivi, contribuendo inoltre al progresso della scienza moderna: dagli studi di balistica c da quelli relativi alle leghe per fondere i cannoni scaturirono preziose indicazioni sia per la matematica e la meccanica razionale, sia per la tecnologia dei materiali, mentre da quegli runbienti presero avvio le scuole per ingegneri e per geometri e uscirono intelletnmli che concorsero ai primi del seco lo XlX alla rifondazione dell'Università. Tutto queso fermento vedeva coinvolte come protagoniste, accanto ali 'Università, le Regie Scuole. Alloro interno sorsero i primi laboratori di chimica delle polveri, di metallurgia e mineralogia, qui si formarono architetti militari e ingegneri esperti in fortificazioni, idraulica, balistica e scienza delle costruzioni. Le Scuole sono state considerate la fucina di una classe di tecnocrati-scienziati subalpini sin dalla loro fondazione. Il primo direttore Ignazio Bertola (ingegnere del re e autore delle principali fortificazioni piemontesi) la concepì come una scuola politecnica c militare equivalente a ll'Università. Un luogo dove formare una élite dello Stato non solo militare, ma anche amministrativa. Non a caso anche la geografia e la cartografia ebbero qui uno sviluppo fondamen tale. Uno dei primi allievi delle Scuole del Bertola fu Spirito Benedetto Nicolis de Robilant, anch'egli tra i fondatori della Società privata torinese da cui gemmerà l'Accademia delle Scienze. Mineralogista e, più tardi, capo del Corpo del Genio nell'esercito piemontese, nel 1749 su ordine di Carlo Emanuele 111 fu inviato con altri quattro cadetti delle Regie Scuole (periti durante il faticoso viaggio) a compiere un'indagin e ne ll 'Eu ropa nord-orientale intorno alle miniere e agli impianti metallurgici. Frutto di questo viaggio so no i sei volumi manoscritti dei "Vìaggi nelle miniere di Alemagna ", ricchi di disegni e mappe dettagliate.
Testimone di tanta ricchezza e innovazione culturale è ancor oggi la preziosa Biblioteca monumentale, composta da 16.400 volumi conservati a Pal azzo Arsenale, tra i quali opere dei più vari generi e testi appositamente manoscritti per gli allievi che poi ebbero una vasta diffusione in tutta

Europa. In particolare il successore di Bertola alla direzione delle Scuola, Alessandro Vittorio
Papacino D'Antony; coordinò tra il 1756 e il 1775 una serie di manoscritti in sei libri "Dell'architettura militare" e tra il 1764 e 1769 un'opera di istruzione militare, "La grande tactique ··• che ebbero grande diffusione presso le corti e le accademie di tutta Europa. Papacino D' Antony; noto a l ivello europeo tra i cultori di scienze fisiche e chimiche , era assiduo frequentatore dei migliori circoli intellettuali torinesi e istituì presso l'Arsenale il primo laboratorio chimico e metallurgico.
Molti altri sono gli esempi di questo connubio tra il mondo militare e quello culturale e scientifico, piemontese e internazionale. In particolare dopo la Restaurazione post napoleonica e la rinascita della gloriosa Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio, si rinnovò con scienziati e militari che erano anche soci dell'Accademia delle Scienze, un antico e fruttuoso connubio. A quel mondo appartengono le ricerche di prestigiosi insegnanti delle Scuole che ebbero in seguito un ruolo impo1tante nelle istituzioni del neonato Regno d'ltalia: Luigi Federico Menabrea (genio della meccanica razionale. eroe delle Guerre di Indipendenza e poi Presidente del Consiglio del Regno d'Italia nell867), Giovanni Cavalli (noto per le sue invenzioni nell'artiglieria e senatore nel Parlamento unitario), Paolo Ballada di St. Robert, Francesco Siacci (uno dei fondatoli della balistica, docente anche nelle Università di Torino e di Napoli , Senatore del Regno). Questo sodalizio proseguì anche nel '900 dove spicca la figura di Filippo Burzio: filosofo , poeta, giornalista (nell'immediato dopoguerra fu direttore del quotidiano "La Stampa") e scienziato, insegnò balistica alla Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio dal 1926 al 1943. Oggi questo tradizionale e proficuo scambio tra mondo civile e militare si rinnova e si rafforza ali 'interno della Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito cbe, grazie alla sua collaborazione con le Università italiane e con le più importanti istituzioni internazionali, si afferma sempre più come polo culturale ali 'avanguardia nel campo del peacekeeping e nella formazione di professionisti leaders nel loro settore.
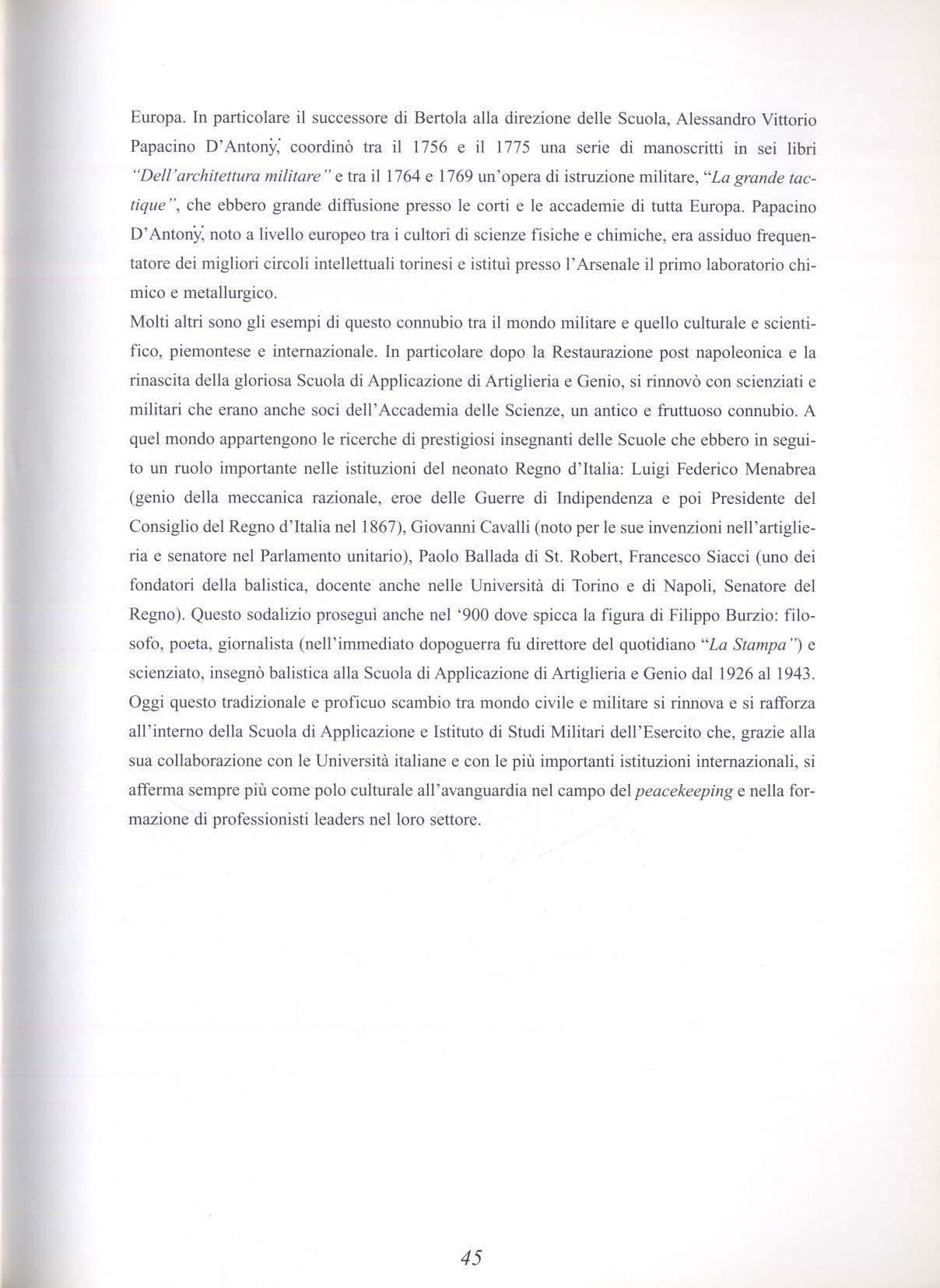
.t!J.rù Jni/d-nrc1 e a§Ù/t4AU/m
./7ra l 'archlft'H-rt,-., L.d'Jwt'JtU.
'),/ fìNÙtr ' t3,rfiL;
48- R iproduzione del frontespizio del progetto proposto da Ignazio Berta/a per la costituzione della Scuola Militare.
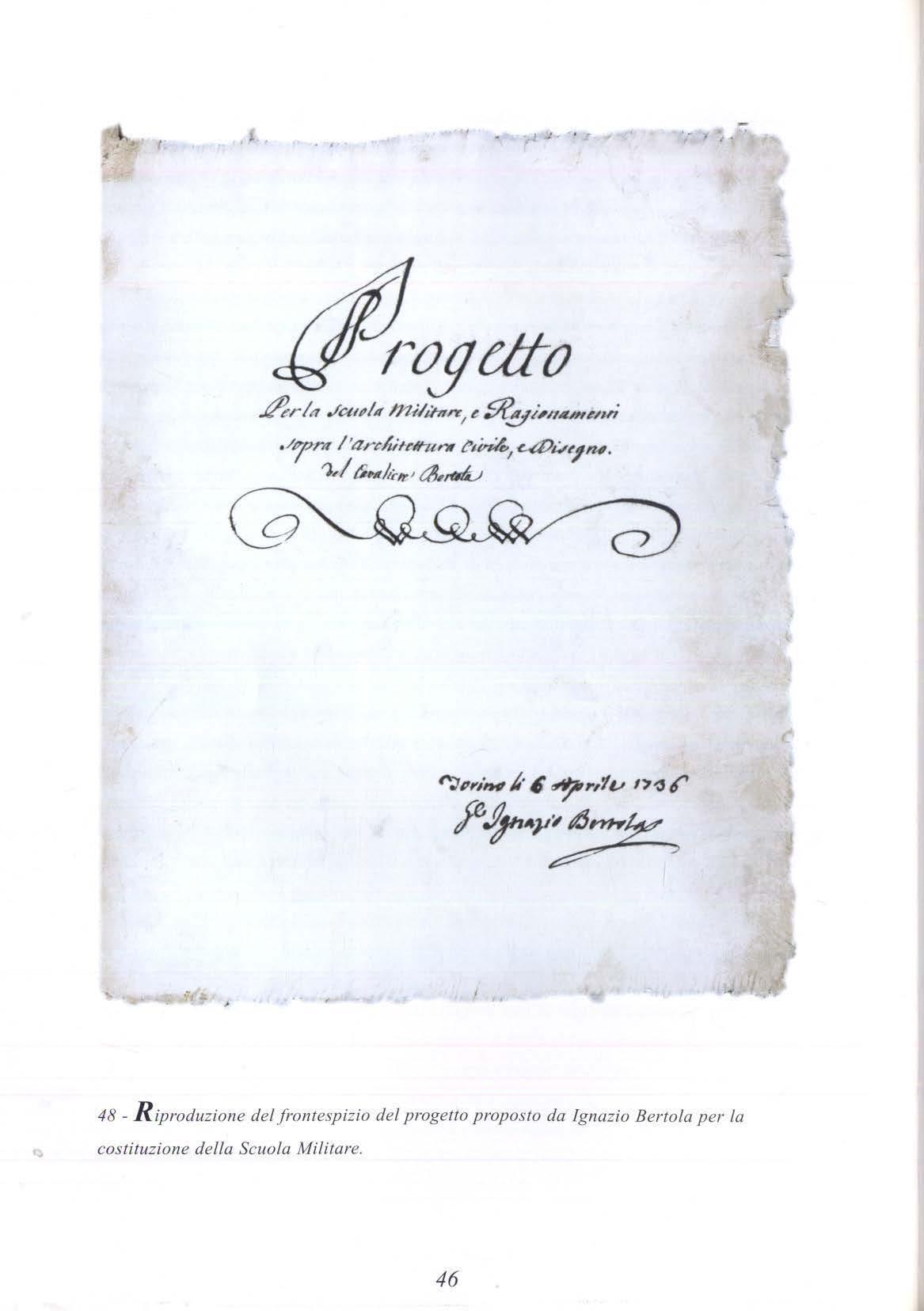
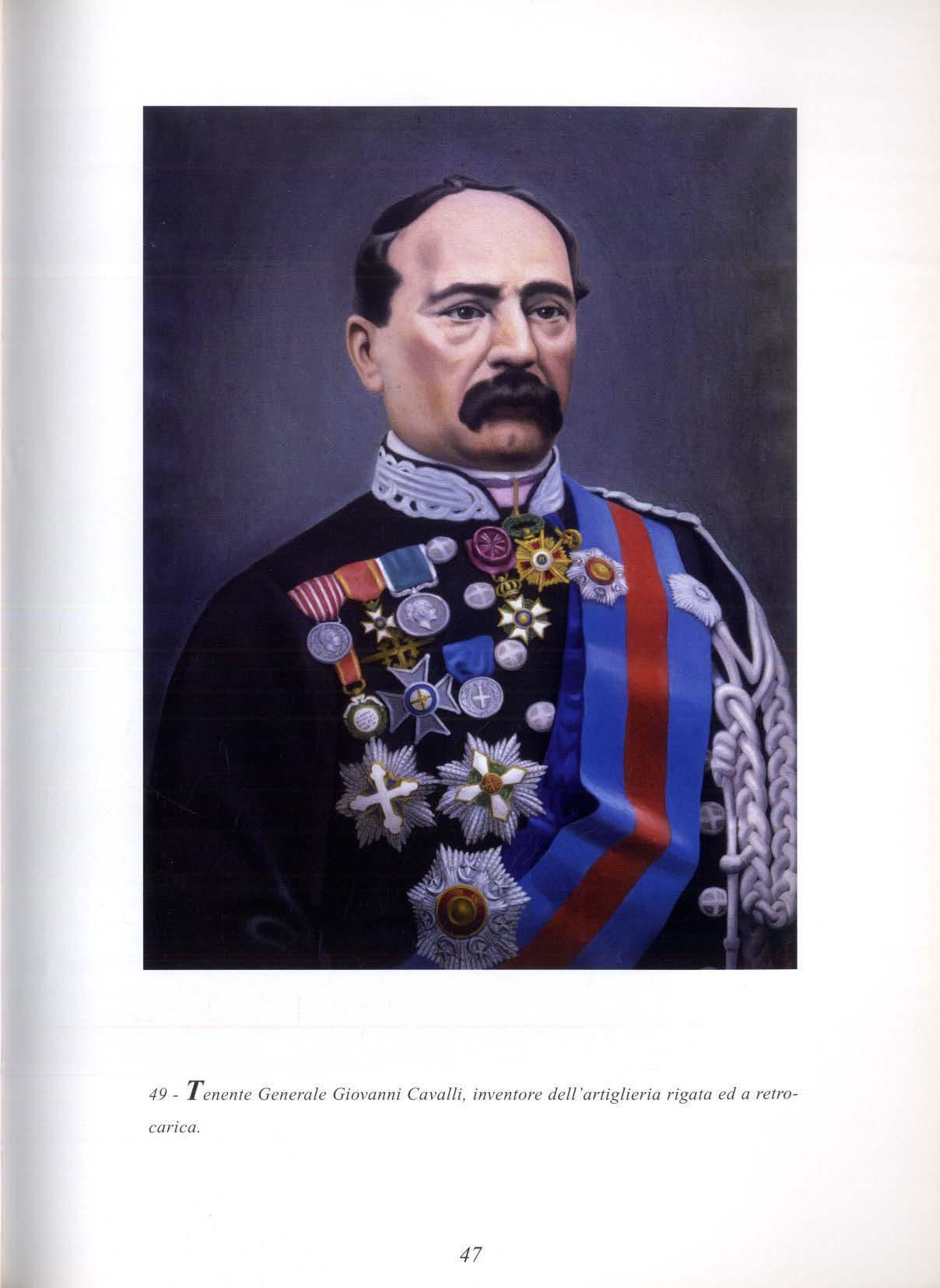
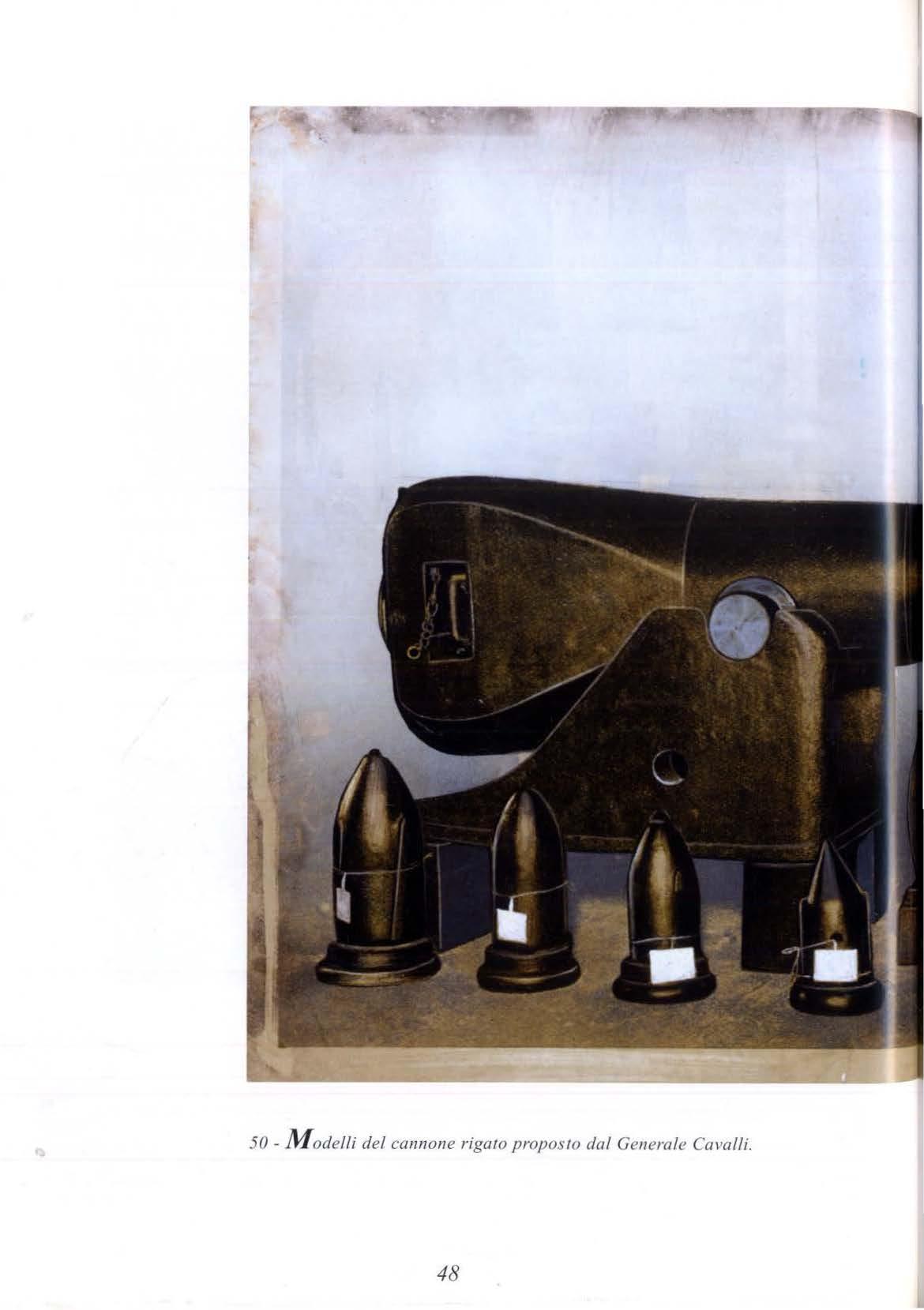
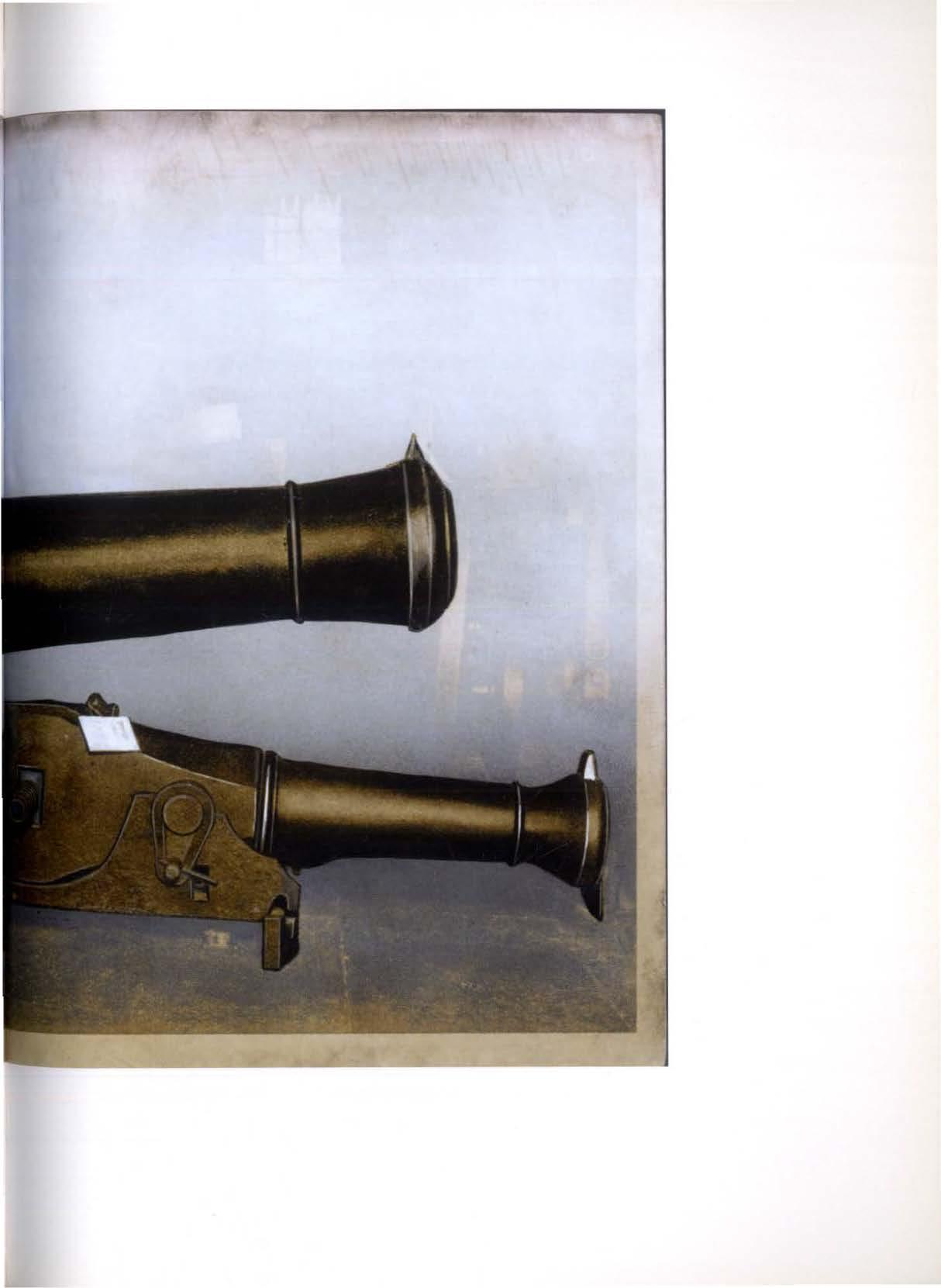
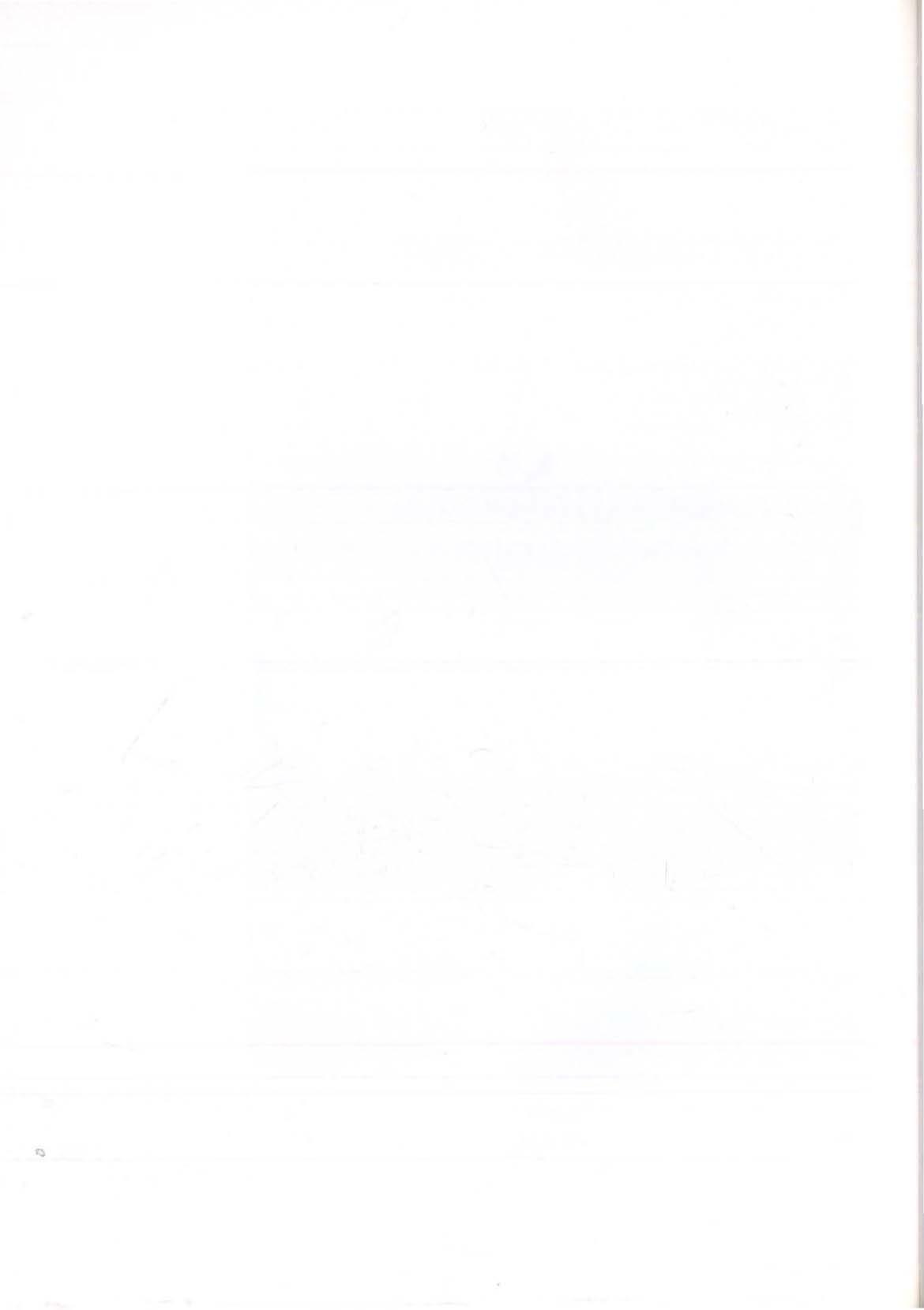
Al giorno d'oggi, del maestoso complesso dell'Arsenale non rimane che il nucleo centrale dell'opera progettata nel 1736 da Antonio Felice De Vincenti (o Devincenti), mentre i numerosi fabbricati utilizzati dalle fonderie, officine e magazzini sono stati abbattuti a Il' inizio del Novecento. I: opera, così come appariva in originale, può però essere ammirata ancor oggi in un prezioso e particolareggiato modello !igneo, accuratissimo lavoro di ebanisteria eseguito nel 1738 dagli artigiani del Regio Arsenale, esposto al primo piano del Pala zzo stesso. Vale la pena di conoscere nel dettaglio le bellezze a lungo nascoste di questo magnifico edificio torinese, che di recente ha aperto le sue porte al pubblico, con interessanti visite guidate per turisti e scolaresche.
11 progetto dell'architetto De Vincenti era tecnologicamcntc rivoluzionario. Se difatti lo schema di divisione netta tra il palazzo di rappresentanza e l'area produttiva, nascosta dal primo, veniva ereditalo dai disegni dello Juvarra (incaricato dei lavori dal 1728 al 1732), la realizzazione di un complesso funzionale, robusto ed elegante al tempo stesso, era tutta opera dell'architetto torinese. La pianta del palazzo è quadrata, 11 O metri di lato , con un Jato prolungato di 150 metri e si svi luppa su quattro padiglioni angolali sporgenti leggermente verso l 'esterno, e su due padiglioni e torrioni intermedi, uno per lato, sporgenti, sia verso l 'interno sia, in origine, verso l'esterno.
C edificio, che si sviluppa attorno ad w1 vasto cortile d'onore quadrato di 66 metri per lato, presenta una complessa elabo razione dello stile dorico reinterpretato dal barocco piemontese e notevoli accenti neoguariniani. In particolare l'Arsenale riprende un tema urbanistico tipico del primo Seicento, ca ratterizzato dall'inserimento degli androni di chiese e palazzi sullo spigolo smussato degli ed ifici. Tutti i padiglioni ed i torrioni sono a due piani.
Ciò che più colpisce della costruzione è la sua struttura ordinata e possente, che determina nella sua razionale suddivisione anche l 'aspetto estetico, maestoso e sobrio. La destinazione speciale dell'edificio, il peso degli impianti meccanici, le forti sollecitaz ioni delle macchine in movimen-

to con le conseguenti vibrazioni in tutta la fabbrica esigevano particolare robustezza ed elasticità. Questi problemi vennero risolti dal De Vincenti, con razionalità tutta militare c settecentesca, grazie ali 'applicazione di un modello logico astratto: egli trovò difatti le misure che gli permisero di raccordare con disinvoltura le varie strutture dell'edificio in tutta sicurezza. Il fabbricato appare quindi scandito, per tutto il por1icato e nei corpi aggettanti, da una rete a maglie rettangolari di circa sei metri di lato su cui si impostano volte a crociera sorrette da pilastri anch'essi rcnangolari. L'uso di queste campate, relativamente piccole rispetto allo spessore delle murature, è particolarmente efficace negli ampi sotterranei. Questa struttura a moduli contigui, evidente anche all'esterno, diventa così il tema dominante di tutta la costruzione, con le doppie lesene che determinano l'ordine gigante della facciata. Ne risulta quindi un effetto di straordinaria potenza al piano terra, mentre al piano superiore, dove le strutture sono alleggerite e il modulo di base riportato alla misura quadrata, l'atmostèra risulta più aerea ed elegante.
D'altronde la bellezza del Paiano, che noi ancor oggi ammiriamo, era soprattutto funzionale alle esigenze militari dell'epoca. l sotterranei, ben arieggiati c facilmente accessibili ai carri, erano utilizzati per contenere materie prime quali ferro, piombo e carbone, ed erano collegati alla Cittadella. Sotto il porticato, al piano terra, venivano accatastate le casse d'imballaggio ed altro legname. mentre nei locali ad esso attigui (ed oggi scomparsi) erano sistemati i mulini, le o!Ticinc dci fabbri d'arme, i laboratori di carpenteria e di falegnameria e i magazzini per la conservazione delle munizioni. 11 primo piano è ancor oggi caratterizzato da imponenti locali che all'epoca erano adibiti a sale d'armi. ovvero alla conservazione ed esposizione delle artiglierie e dei vari manufatti bellici. Altri locali dello stesso piano erano destinati ad abitaLione degli Ufficiali dei sovrintendenti e degli impiegati di maggior interesse professionale. fl secondo piano, il cui sviluppo in altezza è inferiore ai precedenti, era invece quello in cui venivano conservate le armi di riserva, le parti di ricambio, le micce, il cuoiame, le funi, i sacchi, i finimenti per i cavalli.

Le lunghissime facciate verso via d eli' Arsenale e via dell'Arcivescovado sono interrotte da avancorpi leggermente sporgenti e più elevati delle altre par1i del Palazzo e scandite da doppie lesene. Il piano terreno è delimitato superiormente da un cornicione sostenuto da mensoloni binati che conferiscono un accentuato senso di solidità ai muri. Questi mensoloni accoppiati poggiano a loro volta sopra robusti pilastri fasciati fra i quali si aprono ampi finestroni. Il piano nobile , quello di maggior altena, è limitato inferiormente da un parapetto sostenuto dal cornicione del piano terreno e superiormente da un'altra trabeazione dorica ornata da scanalature e intervallata da lesene binate e fasciate, tra le quali si trovano finestroni rettangolari sormontati da finestre quadrate. In corrispondenza di ogni avancorpo, sopra la trabeazione, si sviluppa un altro piano
con finestre inquadrate da quattro pilastri, portanti ognuno trofei d'armi plasmati in stucco.
Sopra il coronamento si sviluppano timpani curvilinei o triangolari sormontati da bombe con fiaccola, mentre altre bombe ornamentali sormontate da bandierine metalliche , in armonia con le funzioni dell ' edificio, sono poste ai vertici dei padiglioni e dei torrioni.

I.:imponente e monumentale ingresso principale del Palazzo dell'Arsenale si apre in corrispondenza di un ampio angolo smussato all'incrocio tra le vie dell'Arsenale e dell'Arcivescovado. Esso venne realizzato nel 1866 dal Maggiore del Genio, Eugenio Bella, che lo costruì ispirandosi in parte al vecchio modello del De Vincenti. Il portone ad arco, abbellito da una cornice di granito sagomata sulla cui sommità è scolpita una testa di leone , è fiancheggiato da ambo i lati da due colonne di granito fasciate che sostengono una trabeazione su cui sono collocate due statue allegoriche, opera dello scultore Musso. Quella di destra rappre se nta l 'Artiglieria, simboleggiata da una figura femminile che , seduta tra bandiere , un ariete, un cannone ed alcuni proiettili, dà fiato a una lunga tromba. La statua di sinistra, invece, riproduce il Genio sotto forma di una figura maschile che, seduta tra gabbioni, un cannone, un'aquila romana, tiene nella mano destra un fascio littorio e con la sinistra impugna tma fiaccola accesa.
Al eli sopra del portone è stata apposta una lapide che ricorda la conclusione dei lavori di costru7ione dell'Arsenale nel 1896 sotto Re Umberto l e che così recita: "Regnando Carlo Emanuele
II!- cresciuto il Piemonte in militare grandezza- sorse disegnato da Felice De Vincenti questo arsenale di g u erm e perché rimanesse di sua militare difesa presidio scuo la officina vi dié compimento l'Italia nuova regnante Umberto r. Sopra la lapide si apre un'ampia finestra arcata s u lla quale incombe, tenuto da due leoni. un grande stemma bronzeo recante le insegne della RepubbHca Jtaliana. Lo spazio antistante l 'ingresso è limitato da pesanti catene sostenute da pilas t r i di granito a rorma di proietti.
Dall'entrata principale si accede direttamente al Cortile d'onore, passando attraverso due success iv i atrii. Il primo, di pianta rettangolare, è coperto da una vo lta a vela molto bassa mentre il seco ndo , a pianta trapezoidale e coperto da una volta a crociera, è ornato da due proietti di artig lie r ia, da due bocche da fuoco in bronzo del 1629, da due mortai in bronzo del 1741 e del 1807 e da otto lapidi in marmo che riportano le motiva zio ni di a lcune importanti onorificenze tra cui q uella della Medaglia d 'Oro al Milite Ignoto. Accanto al secondo atrio è situata una Sala professori, intitolata al Generale Piergiorgio Bussolini, in cui si trovano, tra l'altro, tre lapidi con i nomi degli ex allievi delle Scuole di Artiglieria e Genio caduti nelle guerre per l'Unità d'Italia e in q uelle colonia li dal 1848 al 1918. Nel lato opposto, all'i mb occo del corridoio che si sviluppa lungo via Arsenale, è collocata la lapide commemorativa dei 200 anni deli' Istituto.
Da l lato destro dell'ingresso principale si accede allo Scalone d 'o nore. Realizzato in sti le neoclassico, si sviluppa su pianta renangolare e sale al piano nobile mediante larghe rampe in

53 - L 'at rio della Scuola (pag. 54).

54 - Una vedu ta della Cappella situata al/ 'interno della Scuola di Applicazione e Studi Militari del/ 'Esercito di Torino.
marmo bianco. Alla base dello stesso scalone è posto un cannone piemontese della metà del XVJII secolo. Sulle pareti dello scalone sono state applicate tre lapidi in bronzo riportanti le anni della Scuola di Applicazione e della Scuole di Fanteria, di Artiglieria e del Genio, quattro lapidi in marmo con la trascrizione della motivazione della Medaglia d'Oro ad Emanuele Filiberto di Savoia, gli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana c la motivazione della Medaglia d'Argento concessa ala Scuola di Applicazione di Fanteria. Nella parete della seconda rampa si trova w1 grande dipinto ottocentesco su tela raffigurante la Battaglia di San Martino del 1859 tra l'esercito sardo e quello austriaco. Accanto al dipinto campeggia l'odierno stemma della Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari del l 'Esercito.
Al piano terreno. m corrispondenza dell'incrocio dei co rridoi paralleli alle v1e dell'Arcivescovado c don Minzoni, è situata l'ampia Cappella dove s i trovano un allare di scuola juvarriana già appartenente alla Regia Accademia Militare di via Verdi, un crocifisso
dell'Ottocento e una bella Via Crucis realizzata in bronzo presso l'Arsenale di Piacenza. Abbelliscono la zona di preghiera una statua !ignea della Madonna della Consolata, opera dello scultore Vincenzo Mussncr di Ortisei , una statua in bronzo di Sant a Barbara ed alcuni quadri. L a Cap pella è stata intitolata, a ll a presenza di Papa Giovanni Paolo II il 4 settembre 1988. a l Beato Francesco faà di Bruno, soldato, scienziato e sacerdote
La parte più impressionante del complesso è senza dubbio il vasto cortile del Palazzo, che poteva esse r e usato per ammassarvi materie prime o prodotti finiti. Dal suo interno è possibile ammirare la grandiosa mole de ll ' intero complesso che ripropone g li stessi elementi architettonici osservati all'esterno, disposti però in una struttura più armoniosa e movimentata. Infatti anche internamente, nella parte centrale di ognuno dei quattro lati, sporgono degli avancorpi a due piani. Tutt'intorno al cortile, oggi chiusi da grandi finestroni, girano ampi porticati coperti da volte a crociera impostate su doppi arch i bugnati. N eli 'ordine del portico si nota un motivo deco-

56- Una suggestiva immagine scattata nel cortile della Scuola alla presenza. delle autorità durante l 'esecuzione di un concerto organizzato dai Lions.
57- L a Statua del Fante nel cortile della Scuola.

58 - L a lapide più alta porta. applicato in bronzo, lo stemma araldico della Scuola, mentre quella immediatamente sollostante reca la scritta: "A perenne memoria dei cinquemila ufficiali in servi=io permanente caduti per l'Italia e qui educati al culto del dovere - S c uola di Applicazione per le Armi Dotte Scuola di Applica zione di Fanteria
Scuola Militare di Cavalleria Scuola di Applicazione di Artiglieria e Ge nio ".
Nella ter=a lapide è scritto in incisione: "Guerre per l 'indipendenza e L'unità d 'Italia Guerre coloniali Seconda Guerra Mondiale".
E nella quarta: ''Ovunque la Patria ha chiamato il suo esercito a impegni di pace e di guerra".
rativo fonnato da un gocciolatoio a forma di cannone inserito all'incrocio dei capitelli.
Gli angoli interni del palaz7o sono caratterizzati da una geniale idea architettonica. Grandi arcate sostengono a l primo piano q uattro vaste terrazze ( un te mpo sormontate da quattro grandi nicc h ie, tre delle quali sono sta te chiuse per consentire la copertura delle verande) mentre verticalmente la costruzione s'innaln all'altezza degli avancorpi ed è fiancheggiata da gruppi di lesene so rmontate dai consueti timpani con bombe e fiaccole. Fa eccezione il padiglione diametralmen-

te opposto a quello dell'ingresso principale, sul quale si eleva un'elegante torretta barocca con orologio. Nel cortile so no stati sistemati, negli anni Ottanta, il monumento ai Caduti e la statua del Fante. n monumento ai Caduti, eretto all'interno dell'arcata centrale del porticato di ponente, è composto da due carmoni del XVIII seco lo ai lati, un braciere con fiaccola perenne e tre lapidi in marmo ve rde mare. Sotto lo stemma araldico in bronzo della Scuola la scritta è dedicata "A perenne memoria dei cinquemila ufficiali in servizio permanente caduti per l '!ta ha e qui educati al culto del dovere·· , in onore degli uomini formati in tutte le scuo le militari morti durante le Guerre per l ' Indipendenza e l 'U nità d 'Italia , le Guerre coloniali, la Seconda Guerra Mondiale e le operazioni di supporto alla pace. La statua del Fante s i trova sul lato meridionale del cortile. L'opera è stata eseguita nel 1973 dallo scultore Angelo Balzardi che aveva realizzato il primo esemplare della medesima nel 1934 per il 92° Reggimento Fanteria. Sul lato opposto campeggia dal 1993 una statua equestre in bronzo dedicata alle Batterie a Cavallo, riproduzione a grandezza naturale del ce lebre gruppo "Alle Volo ire" il cui 01iginale. opera dello scultore Malvani, si trova presso la Caserma Santa Barbara in Milano , sede del Reggimento Artig l ieria a Cavallo.
59- V eduta di un tratto dei corridoi adiacenti le vie Arsenale e Biancamano, attualmente in corso di restauro co nservativo l lavori, finanziati dalla Compagnia di San Paolo tramite gli Amici del/ 'Arte, sono attuati secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte.

!.:ingresso secondario del Palazzo è ricavato nel padiglione opposto all'ingresso principale, ovvero in corrispondenza dell'incrocio tra le vie Don Minzoni e Biancamano e nell'atrio è posto un crumone da 75/ 27 del 1911. Questo padiglione, detto della "Gran Scala", è stato realizzato nel 1778 dal Generale Ignazio Birago di Borgaro su disegno modif icato del De Vincenti cd è, se nza dubbio, una delle strutture più belle ed imponenti dell'intero edificio. La sua costruzione si sviluppa su pianta rettangolare, divisa al pianterreno in tre vani quadrati ricoperti da volte a crociera. Dai lati del primo vano scendono, a semicerchio, due rampe dì accesso ai sotterranei, mentre dal terzo vano, se mpre a semicerchio si sviluppano le rampe a doppia branca di un ampio scalone monumcntale c he conduce al g rande atrio del primo piano. Quest'ultimo è uno spazio di grande bellezza che denuncia l'inlluenza guariniana della Cappella della Santa Sindone e di Palazzo Carignano. I.:atrio, di notevole imponenza, è ricoperto da tre cupole sferiche impostale su altretlaJ1te volte a ve la, che poggiano su sei imponenti coppie di piiJastri le quali conferiscono alla costruzione una grande proie zione vertica le.

La stmttura del Palazzo dell'Arsenale manifesta tutta la sua grandiosa armonia di profili e di linee nel piano nobile, specie nei due lati limitrofi alle vie dell'Arcivescovado e Don Minzoni che hanno conservato quasi inalterata la loro conformazione originale. In questa zona è ancora possibile ammirare alcuni maestosi ed eleganti saloni, w1a volta adibiti a sale d'armi ed oggi destinati alla mensa e a Sala Convegno Ufficiali unificata. Imponente risulta l'effetto ottico di questi ambienti che ricordano le navate di alclme basiliche grazie a una serie di cupole sferiche impostate su volte a vela sostenute da una successione continua di pilastri.
All'ingresso della Sala Convegno si incontra il ptimo locale denominato Sala Cavour: oltre a vari cimeli, mobili, arredi e ad un prezioso stendardo con le armi di Casa Savoia donato da Vittorio Emanuele III, sono stati collocati una serie di busti in bronzo raffigmanti insignì studiosi e scienziati, già docenti della Scuola, celebri personalità politiche e famosi personaggi militari, fondatori, Comandanti o allievi delle varie Scuole, da cui l'istituto attuale ha tratto origine e fama. Tra questi si segnalano i busti del Generale Luigi Federico Menabrea (insegnante, scienziato e uomo politico), del Generale Giovanni Cavalli (insegnante e scienziato, inventore delle artiglierie rigate a retrocarica), del professar Filippo Burzio (insegnante, scienziato e umanista), di Alessandro Vittorio Papacino d'Antony. (scienziato, ingegnere e direttore generale delle Regie Scuole di Artiglieria e Fortificazione), di Camillo Benso conte di Cavour, del Generale e Ministro Alfonso Ferrera della Marmora. A questi si aggiungono celebri personaggi della Prima Guerra Mondiale quali i Marescialli d'italia Luigi Cadorna, Armando Diaz, Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta e il Maggiore Francesco Baracca. Fra i ritratti a olio su tela spiccano quelli dei sovrani sabaudi Carlo Emanuele III, Carlo Felice, Vittorio Emanuele H e Carlo Alberto. In una delle salette laterali sono collocati, in particolare, due dipinti ottocenteschi di proprietà dei Musei Civici cittadini, "//paesaggio con le Alpi" di G. Gamba (1849) e un paesaggio alpestre. Inoltre vi trova collocazione un trofeo con zanna d'avorio, donato di recente dal capo dell'esercito somaJo. Pwsegucndo verso l'interno della Sala Convegno, si entra nel grande Salone delle Armi, in cui si trovano quattro pregevoli lampadari dorati in ferro battuto, mobili in barocco stilizzato piemontese. alcune tele (tra cui una carica di cavalleria novecentesca) ed un dipinto di grande formato anch'esso appartenente ai Musei Torinesi, che rappresenta UJJ gradevole paesaggio di chiara fattura ottocentesca, realizzato da Francesco Petiti nell885. Interessante la serie di bozzetti in bronzo realizzati dall'Arsenale di Torino e da quello di Piacenza, soggetti in uniformi del 1843 e del 1861 riprodotti dal monumento a Carlo Alberto e da bronzi originali esistenti presso





67- / 1 Padiglione del/ 'orologio.

l'Accademia Militare di Modena ed il Reggimento " Nizza Cavalleria". Oltre il salone, si apre una sala di rappresentanza con opere grafiche di pregevole fattura. A lato del Salone delle armi si apre la sala Bar, posta in un'ampia veranda dove , con opere grafiche diverse e piccole sculture , è custodito un quadro composto da numerose incisioni all'acquaforte che rappresenta l ' albero genealogico della Casa Savoia, dalle origini fino alla Madama Reale Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours (l 700 circa). Si giunge quindi al grandioso Salone della Mensa, capace di 750 posti, dove durante l'anno scolastico trovano posto gli allievi della Scuola di Applicazione, insieme ad alcuni rappresentanti del Quadro Permanente e al Generale Comandante.
Adiacente al corridoio d ' ingresso alla Sala Convegno si trova l'ufficio del Comandante della Scuola, dove viene custodita la Bandiera della Scuola, decorata di Medaglia d'Argento al Valor Militare. ln questo ufficio sono tra l'altro sistemati un busto in marmo bianco di Emanuele

Filiberto, tmo del Cavour, un apprezzabile ritratto di Lagrange e due quadri di soggetto militare dei pittori Francesco Antoniani (sec. XVlll) e Carlo Zara (1844-1905). Poco distante si trova anche l'elegante Sala Rapporto , un locale monumentale movimentato nei volumi e abbellito da trionfi d'armi in stucco, posti in alto tra le lesene angolari di sostegno delle volte. La sala è dotata dei moderni sistemi multimediali idonei a soddisfare tutte le esigenze di collegamento e comunicazione.
Gli altri lati dello stesso piano nobile , che si sviluppano lungo le vie de li' Arsenale e Biancamano, hanno invece perduto molto del loro aspetto architettonico originario. Tuttavia alcune aree hanno mantenuto un'atmosfera suggestiva come il cosiddetto Androne del Plastico, realizzato all'interno del padiglione d ' angolo fra le due succitate vie. Qui infatti è conservato, in Lma teca, il modellino origina le l igneo, in scala l :87 del Palazzo dell'Arsenale secondo il progetto del De Vincenti, realizzato nel 1738 dagli artigiani della Compagnia delle Maestranze del Battaglione di Artig l ieria. Sempre in teche di vetro si trovano altri due modellini di strutture particolari d eli' Arsenale: il Padiglione della Grande Scala e il locale del grande trapano ad acqua per la perforazione dei cannoni (la tenivella) insieme a quello della fonderia delle rutiglierie in bronzo. Nell'androne si trovano anche una serie di statuette bronzee , copie delle statue di soldati in uniforme 1915-18 che atto m iano il monumento al Duca d'Aosta in piazza Castello , e una lapide policroma in marmo pregiato che riporta le tappe fondamentali della storia della Scuola dal la sua
68- S ala degli Stemmi.
69- S ala del plastico.



fondazione.

Da qui, due corridoi portano l'uno verso i Comandi dei corsi e la Biblioteca , l'altro verso gli uffici del Comando della Scuola. In quest'ultimo passaggio è stato collocato il busto in bronzo del Generale Giuseppe Perotti, martire della Resistenza e Medaglia d'Oro al Valor Militare.
Delle quattro terrazze originarie ricavate in corrispondenza degli angoli interni del primo piano del Palazzo , una è rimasta scoperta e tre sono state trasformate in verande coperte. Nella grande nicchia di quella scoperta sono state sistemate la stat11a di Giulio Cesare e la storica campana dell 'a ntica Accademia. Si tratta della più grande delle due campane della torre dell'orologio della Regia Accademia Militare di Via Verdi, recuperata dalle macerie di quella parte d eU' Istituto crollato in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La cosiddetta Campana del Dovere, fusa da Simon Boucberon, fonditore del Regio Arsenale, fu donata all'Accademia nel 1678, anno della sua nascita, dalla stessa fondatrice Madama Reale Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours, reggente gli Stati Sabaudi durante la minore età del figlio Vittorio Amedeo II. I.:iscrizione sul bronzo lascia intendere come l'autorità suprema volesse, tTamite il s uono della campana, ricordare ad ogni ora agli allievi l 'a ltezza dei compiti cui erano destinati ed esortarli ad una più severa applicazione allo studio. Le altre tre terrazze coperte sono note come Veranda della Sala Convegno, Veranda della Biblioteca e Veranda Santa Barbara (vi spicca infatti una grande statua in marmo della santa, riproduzione plastica del celebre quadro di Palma il Vecchio). In quest'ultima campeggiano due grandi tele rappresentanti San Giorgio, patrono della Cavalleria, e San MaJiino patrono della Fanteria, dipinto realizzato dal maestro torinese Ttalo Cremona (do nato alla Scuola degli Ufficiali frequentatoti negli anni Cinquanta del XX secolo).
Sono, questi , dei bellissimi locali ricavati al primo piano del braccio di fabbricato che si protende lungo via dell'Arsenale. La struttura interna fu impostata diversamente dalle altre pmii del Palazzo in quanto l'architetto De Vincenti, nell770, qui realizzò degli alloggi per gli Ufficiali e per il personale addetto. dei vari ambienti come li vediamo oggi risale al I 926, allorché venne qui trasferito da Palazzo Lascaris il Circolo Ufficiali del Presidio Militare di Torino. Con il passaggio del Circolo in corso Vinzaglio , in questi locali sono state sistemate, a cura del Comando delle Scuole di Applicazione d'Arma, la Sala dei Comandm1ti e l'Aula Magna.
La Sala dei Comandanti (costituita da due locali attigui) si presenta come un vasto ed elegante salone in stile neoclassico , il cui motivo decorativo più interessante è costituito dall'ampio soffitto lavorato. Sulle sue pareti e su quelle della sala contigua si trovano i ritratti dei Comandanti

dell'Accademia e delle Scuole di Applicazione dall816 ad oggi.
I.: Aula Magna, intitolata ai fratelli Alfredo e Antonio Di Dio, Medaglie d ' Oro al Valor Militare, è stata ricavata nella parte terminale dello stesso braccio dell ' edificio. Si tratta di un ampio salone rettangolare, dal soffitto piatto, la cui decora z ione di pregevoli stucchi, realizzata dopo il Secondo Conflitto Mondiale, è intonata allo stile barocco piemontese , anziché a quello neoclassico. L'aula riceve luce da quattro finestroni che guardano su via dell'Arsenale, mentre dalla parte opposta presenta una lunga balconata sostenuta da colonne e ornata da un ' artistica balaustra in ferro. Alle pareti del vasto locale sono appesi vari quadri, fra cui un ' ampia riproduzione dell ' opera ottocentesca "Scuola di cavalleria " del Cugia, eseguita dal pittore Riccardo Gontero, i ritratti del primo Direttore delle Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortifkazione , il Luogotenente Generale e primo ingegnere Giuseppe Ignazio Bertola, Conte di Exilles, del suo architetto, Cap. Felice De Vincenti e del suo secondo Direttore, Vittorio Papacino D ' Antony. Lo spazio è utilizzato sia per le cerimonie, quali il giuramento degli Ufficiali , sia per attività didattiche, seminari, concerti, conferenze e discussioni solenni delle tesi di Laurea.



In questo lato è ubicato il corridoio che collega l'Androne del Plastico con il Padiglione della Gran Scala. Quasi tutti i lo cali di questa zona mantengono inalterati i loro caratteri architettonici originari, in particolare il bel co rridoio che offre un cllètto suggestivo non solo per la sua proiezione vert icale, ma anche per la sua ampiezza. Alle sue pareti è inoltre posta una lapide commemorativa della visita del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga nel 1989, in occasione dell'inaugurazione dell'attuale Biblioteca monumentale ivi adiacente.
Le sue origini risalgono alla Biblioteca Tecnica delle "Regie Scuole Teoriche c Pratiche di Art iglieria e Fortificazione", costruita fin dall'anno della loro fondazione. Ristrutturata nel 1949, essa risulta oggi costituita dalla fusione delle Biblioteche della Scuola di Applicazione di Art iglieria e Genio, della Regia Accademia Militare e di quelle dei Presidi Militari di Torino, A lessan dria e Novara. Attualmente è suddivisa nella sezione operativa e in quella monumentale e complessivamente consta di circa 120.000 opere di carattere etico, didattico, sci enti rico, tecnico, geografico, storico, giuridico, letterario, psicologico, socio logico e militare. Le opere sono s u ddivise in 39 sezioni, di cui 16 di argomenti prettamcnte militari. La Biblioteca della Scuola è s istemata in due vasti ambienti siti a l piano nobile del corpo di fabbrica intermedio di via Biancamano. li primo ambiente, quello in cui è dislocata la Sez ione operativa, è il più ampio e il suo contenuto supera i l 00.000 volumi. Nel secondo ambiente è sistemata la Biblioteca monumentale, inaugurata il 28 ottobre l 989 alla presenza del l 'allora Capo dello Stato Francesco Cossiga. La splendida struttura architettonica della sala, dominata da cupole sferiche, è stata di recente impreziosita da un prcgiatissimo lavoro di ebanisteria e dotata di apparecchiature elettron ic he di c limatizzazione e di allarme adatte ad accogliere i suoi tesori: 16.000 fra opere rare ital ia ne c straniere, volumi di elevato valore artistico, preziose stampe e manoscritti. Tra le opere più significative qui conservate figurano ben 120 opere del 1500, perlopiù a carattere militare (a r ch itettura, fortificazione, artiglieria ma anche disciplina ed etica militare); 4 incunaboli tra cui i l "De re militari" di Valturio, del 1483, uno dei primi libri in c ui appare l'illustrazione silog raf ica (s tampata mediante tavole di legno incise); i 33 vo lumi della rara ed iz ione della "Encyclopedie " di Didero l c D ' Alembert, pubblìcata in Li vo rno tra il 1770 e i l 1779. Tra i ci mel i custod iti nella Biblioteca figurano inoltre le fotografie e g li atti di assenso e di arruolamento
a ll a Regia Accademia Militare degli allievi Luigi Cadorna ( 1865-68) e Armando Diaz ( 1879-82) e inoltre la fede di battesimo, la nomina a paggio d'onore, la votazione d·esame, i documenti di nomina a sottotenente nel Corpo Reale de l G enio dell'allievo Camillo Benso conte di Cavour,

78- L a Biblioteca della Scuola.
79 - Una veduta della Biblioteca affollata di persone durante un incontro.

nonché la domanda del Marchese di Cavour per l'ammissione del figlio Camillo alla Regia Accademia Militare. La consultazione dei testi è consentita anche a ricercatori civili, previa autoriaa.donc da parte del Coma ndante
80 - L a stru flura della Biblioteca dove sono custodile le opere più recenti.


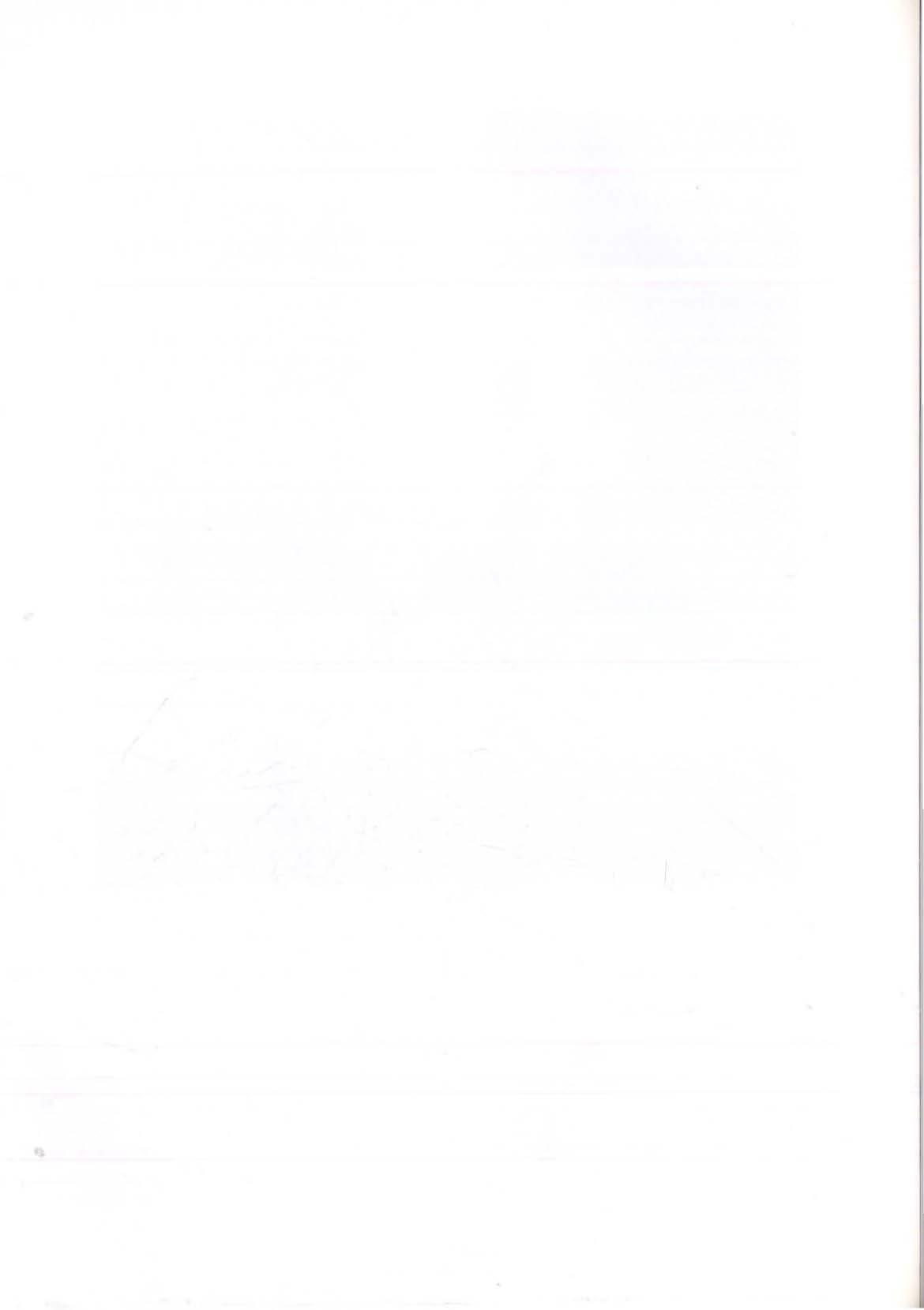

La Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito deriva dalle Scuole di Applicazione delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio che, ricostituite a Torino nel 1949 e riunite nel 1951, sono state dislocate nell'attuale Palazzo dell'Arsenale e poste sotto un unico comando con la comune denominazione di Scuole di Applicazione d'Arma. Fondate tra il XIX secolo e l'inizio del XX, traevano la loro origine da preesistenti Istituti di formazione sorti in Piemonte a partire dal XVHI secolo La Scuola attuale affonda quindi le sue radici in un passato ricco di sto ria e di cultura, si intreccia con le vicende dello Stato Sabaudo prima, e della nascente nazione italiana poi, e vanta con orgoglio l 'eredità dei grandi personaggi che l'hanno frequentata e resa celebre in tutta Ew·opa: illustri intellettuali e scienziati, da Lagrange a Cavalli e Burzio , grandi politici come Cavour e Menabrea, Generali che fecero la stmia d'Italia, da Lamarmora e Cadorna, a Diaz e Badoglio. Dalla fine del XV secolo l'introduzione delle artiglie1ie s ui campi di battaglia aveva completamente rivoluzionato il modo di intendere il combattimento e, di conseguenza, le tecniche difensive. Accanto al coraggio e al valore individuale andavano progressivamente crescendo d'importanza l'ingegno e la tecnica, cosicché il XV I secolo vide un fiorire di studi e spe rimentazione stù le nuovi armi. Dallo sviluppo e dal perfe z ionamento della tecnologia militare derivava , perciò, la necessità della formazione di nuovi militari professionisti , preparati scientificamente e tecnicamente. l moderni soldati dovevano essere in grado sia d'impiegare al meglio l e nuove armi , sia di realizzare efficaci opere di fortificazione, grazie a un ' approfondita conoscenza dei principi di balistica, topografia , metallurgia e meccanica, arte fortificatoria e tecniche di raffinazione della polvere da sparo
Ta le necessità, che porterà poi nel Settecento alla fondazione dei più importanti Istituti militari europei, fu avvertita già nella seconda metà del XVI secolo da Emanuele Filiberto di Savoia, il quale , nell'opera di 1icostruzione e rafforzamento del suo ducato divenuto indipendente nel 1559, gettò anche le basi dell'organizzazione dell'artiglieria mediante la creazione a Torino di una "schola et compagnia di bombardieri" e di un arsena le con annessa fonderia di cannoni. La riforma attuata nel 1726 dal Re Vittorio Amedeo II , in cui l'artiglieiia e gli ingegneri venivano
militarizzati, sanciva l'innovativo principio secondo il quale l 'a mmissione ai posti di co mando dell 'Artiglieria e del Genio non dovesse avvenire soltanto per concessione regia , ma fosse subordinata a provate capacità intellettuali e scientifiche. Quindi alla prima scuola militare di Torino, la Reale Accademia cost ituita nel 1678 , si agg iun sero nel 1739 le Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortificazione volute da Re Carlo Emanuele liJ di Savoia.

Istituite in Torino con regio viglictto del l 6 aprile 1739 , vennero poste sotto la vigilanza del Gran Mastro di Artiglieria e divise in Scuola di Teorica e Scuo la di Pratica. I:Istituto aveva lo scopo di garantire un alto livello qualitativo alla preparazione tecnico-scientifica di artiglieri ed ingegneri. Nella Scuola di Teorica, che pare avesse la sede in con trada dell'Accademia (oggi via Verdi), si insegnavano matematica, artiglieria e fortificazione, architettura , topografia e le va rie tecniche per adoperare l 'a rtiglieria La Scuola di Pratica, s ituata i n un poligono di artiglieria oltre il Po, prevedeva l ' insegnamento del tiro con il cannone, il getto di bombe ed altre attività pratiche. Le Scuole, in cooperaz ione con l'Arsenale che intanto era stato ampliato e potenziato con la costruzione nel l 736 del nuovo complesso, diventarono il centro propulsore intellettuale e industriale della Torino di allora. L'abate spagnolo Juan Andres, nel 1791 , riferendos i a Torino scriveva che alle Scuole di Artiglieria e Fortificazione ( nel frattempo trasferitesi all'Arsenale intorno al 1780) si devono "i meravigliosi progressi che a Torino hanno fatto le scienze naturali" e che esse sono "la cu lla della Reale Accademia delle Scienze. Per questo si vede a Torino. diversamente da qualunque altra città, essere militari la maggior part e dei membri del/ 'Accademia delle Scienze ". Le Scuole Teoriche e Pratiche costitu irono una grande novità n el panorama europeo proponendo un modello di educazione militare completa che formava nella stessa persona l'artigliere e l'ingegnere. La loro fama internazionale venne inoltre assicurata dall 'asso luto prestigio degli sc ienziati e degli intellettuali che vi insegnarono. A cominciare dal primo Direttore delle Scuole, Ignazio Bertola (figlio adottivo dell'ingegnere militare Antonio Bertola) , che si affermò quale geniale ideatore delle principali opere di difesa realizzate in Piemonte nella prima metà del XVTif secolo, oltreché come valoroso soldato in tutte le operazioni di assedio, in patiicolare quelle per la liberazione di Alessandria e Valenza.
Fra g li insegnanti di maggior prestigio della Scuola Teorica spicca la figura di Luigi Lagrange, affiancato da altri insignì studiosi come Angelo Saluzzo, fondatore insieme allo stesso Lagrange deli' Accademia delle Scienze e l'architetto idraulico Andrea Plana. Lagrange viene ricordato, oltre che come geniale studioso e teorico, anche come un grande maestro di matematica e fisica. Pur avendo ricevuto l'incarico giovanissimo, a soli 19 atmi, egli riuscì a infondere nel suo
insegnamento uno spessore scientifico e una ricchezza umana tali da attirare intorno a sé quella piccola comunità di studiosi che avrebbe dato vita nel 1783 all ' Accademia delle Scienze , che ancor oggi dà prestigio all'Italia sia nel campo letterario sia in quello scientifico. Alla morte del Bertela, avvenuta nel 1755 , venne nominato direttore della Scuola di Teo1ica il Maggiore Alessandro Vittorio Papacino D ' Antony, che s i era distinto nelle Guerre di Success ione di Polo nia ( 1733-1738) e d'Austria (1740-1748), sia come artigliere, sia come ingegnere. Già dal 1743 si era dedicato a studi particolari sulla polvere da sparo , tanto da ottenere dal Bertela l'autorizzazione a istituire presso l ' Ars enale uno "stabilimento e laboratorio chimico e metallurgico". Come Direttore della Scuola si preoccupò di riorganizzare i libri di testo e scrisse diversi trattati scientifici sull'artiglieria e la fortificazione che gli diedero in breve fama europea: tradotti in francese, inglese e tedesco, ve1mero adottati dalle Accademie dei maggiori Paesi stranieri. L'attività delle Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortificazione, durata circa ottant'anni , si concluse con la restaurazione post napoleonica. Infatti negli anni tra il 1816 ed il 1822 le loro fw1zioni erano state progressivamente devolute, parte alla Regia Accademia Militare (1816) e parte alla Scuola di Applicazione per gli Ufficiali del Corpo Reale del Genio (1819) e alla Scuola teorica di Applicazione ad uso degli Ufficiali del Corpo Reale di Artiglieria (1822).
La bufera napoleonica aveva fatto emergere la necessità di una completa riforma del! ' E sercito. Venne cos ì istituita nel 1816 da Re Vittorio Emanuele I, tornato sul trono dopo l'invasione francese, la Regia Accademia Militare che discendeva dall'Accademia Reale di Savoia, di cui ereditava la sede. Sorta nel 1678 per volontà della duchessa Maria Giovanna Battista di Nemours, quest'ultima per oltre un secolo aveva formato e addestrato i giovani appartenenti alle famiglie nobili piemontesi e straniere. Tra i suoi allievi più celebri si contano lo scrittore Vittorio Alfieri , il principe Federico Guglielmo di Brandeburgo - Shewedt, il principe ereditario Federico (poi Federico Ill) di Sassonia e suo fratello Guglielmo, il Gran Maresciallo di Svezia Conte Hans Axel de Fersen (noto per aver tentato di salvare dal patibolo la regina di Francia Maria Antonietta). La nuova accademia venne destinata alla fonnazione degli Ufficiali dell ' Armata Sarda, ma immediatamente si presentò il problema del diverso livello culturale dei militari in servizio. Difatti, dopo il 1815 , la provenienza degli Ufficiali nel ricostituito esercito sabaudo era la più disparata: accanto agli anziani già in servizio nel 1796, vi era la massa dei giovani che proveniva in maggioranza dalla disciolta armata napoleonica d'Italia e moJti di essi non possedevano una adeguata preparazione, poiché promossi solo per meriti di guerra.

82 - S corcio della celebre veduta di Torino eseguila da Gian Tommaso Borgonio tra il 1661 e i/1670. L'Arsenale nuovo sorge al termine della contrada omonima e si ajfàccia alla Spianata d'Artiglieria verso la Cilladella. (Dal "Theatrum Sabaudiae del 1862).

Manoscrilli
83 l 84 - L ihri dì tesro manoscritti. utilizzati per i Cadelfi delle Regie Scuole di Artiglieria e Fortificazione (sec. XVJIJ) e successivamente reali=zati a stampa.

Per tentare di porre rimedio a tale situazione, fu istituita nel 1819 la Scuola eli Applicazione per gli UfTiciali del Corpo Reale del Genio con lo scopo di esercitare i giovani Ufficiali ncll'applicaLione ai casi pratici derivanti dalle cognizioni teoriche apprese in Accademia. Primo Direttore di questi corsi fu il Capitano Agostino Chiodo, brillante Ufficiale del Genio e valente insegnante distintosi nelle campagne del 1848. che poi diventò anche Capo di Stato Maggiore dell'Armata Sarda, Senatore, Ministro della Guerra c Presidente del Consiglio dei Ministri. Nell'anno accademico 1826-1827, fra gli allievi vi fu anche il Luogotenente Camillo Senso Conte di Cavour, il quale fu autore di una memoria intitolata "Esposi=ione compita del/ 'origine. teoria, pratica ed e.ffètti de/tiro di rimbalzo tanto su terra quanto su acqua ". Il giovane Cavour fu anche protagonista di un curioso incidente diplomatico. Ultimato il corso ali' Accademia, il cadetto venne ammesso alla Scuola
85 - / 1Luogotenente Generale Agostino Chiodo, Direttore dei Corsi del CoJ]JO Reale del Genio (/8/9-1834) dopo l'epopea napoleonica.

 Cumtlln ;;, ,z,., dz C.u'flllr c/ .!-J 1/1/111
"'-•tri1Ji4 IIIIJIJiull "'["'t/ llrw Jl uu tW Tnwtth MI C.,. ll.uk tiJ Go.M c.-n. &-16c-,
86 - M onograjìa i11titolata ''Del tiro di rimbalzo" prese ntata dal Tenente del Cozpo
Cumtlln ;;, ,z,., dz C.u'flllr c/ .!-J 1/1/111
"'-•tri1Ji4 IIIIJIJiull "'["'t/ llrw Jl uu tW Tnwtth MI C.,. ll.uk tiJ Go.M c.-n. &-16c-,
86 - M onograjìa i11titolata ''Del tiro di rimbalzo" prese ntata dal Tenente del Cozpo
 SA R. A/IIm• th Soit"#ld J, C4nt-rro Crrut dr llmçlurrJ
87- P rincipe Carlo A/berlo di Savoia, Gran Mostro d'Artiglieria da/1820 a/1831.
SA R. A/IIm• th Soit"#ld J, C4nt-rro Crrut dr llmçlurrJ
87- P rincipe Carlo A/berlo di Savoia, Gran Mostro d'Artiglieria da/1820 a/1831.
di Applicazione del Genio. Indossando la nuova uniforme da Ufficiale, il giovane Cavour pronunciò una frase infelice: "Finalmente non indosserò più questa divisa da lacché", riferendosi alla somiglianza tra l ' uniform e indossata dagli allievi della Regia Accademia e quella dei lacché di corte. La frase venne rife rita al Re Carlo Felice il quale, non avendo molta simpatia per la famiglia Cavour che si era schierata a favore di Napoleone, pretese dal comandante della Scuola, Pilo Boy! di Putifigari. le dimissioni dell'allievo. Il comandante si presentò al Re con due richieste di cessazione di servizio, quella del Cavour e la propria, obbligando il sovrano a desistere dal suo proposito.
La Scuola Teorica di Applicazione ad Uso degli Ufficiali del Corpo Reale di Artiglieria (1822-1834)
La Scuola Teorica di Applicazione ad Uso degli Ufficiali del Corpo Reale di Artiglieria fu istituita nel 1822 da Re Carlo Felice che la pose alle dirette dipendenze del Comandante Generale del Corpo di Artiglieria, il Colonnello Conte Vittorio Casazza. L'iter di studi comprendeva una scuola di matematica e le scuole tecnico-militari. Le Scuole ebbero un ruolo di grande importanza sotto la guida del Principe Carlo Alberto di Savoia, Gran MastTo d'Artiglieria dall820 all831. Tn questo periodo proseguì l'opera di riordinamento e ammodernamento dell'Esercito, mediante l'unificazione dei calibri delle artiglierie, il perfezionamento della costruzione delle bocche da fuoco e l'adozione di criteri di addestramento che tendevano a valorizzare sempre più la personalità dei singoli combattenti. Direttori illustri furono il Maggior Generale Filibetto Appiano, Ufficiale di Artiglieria distintosi nelle campagne contro l'esercito francese, e il Colonnello Francesco Omodei, già eroico Uffic iale dell'Armata napoleonica d'Italia. Insegnante alla Regia Accademia Militare e brillante intellettuale, venne poi nominato membro della Reale Accademia delle Scienze, dove lasc iò un 'importante traccia con i s uoi trattati di artiglieria. Nel 1834, sia la Scuola Teorica di Applicazione, sia la Scuola di Applicazione del Genio cessarono di esistere e le loro funzioni vennero assolte dalla Regia Accademia Militare.
Cesigenza di migliorare e completare la specifica preparazione tecnica dei giovani Ufficiali di Artiglieria e del Genio tornò a farsi urgente e quindi il Re Carlo Alberto istituì una Scuola Complementare, comunque dipendente dalla Regia Accademia. La personalità più importante che insegnò nella scuola fu Angelo Saluzzo di Monesiglio, scrittore ed intellettuale così illustre da essere designato in giovane età seg retari o perpetuo per le classi delle Lettere nell'Accademia delle Scienze.

Ne l 1839 Carlo Alberto soppresse la Scuola Complementare sostituendola con la Scuola di Applicazione per le Armi Dotte. obbligatoria per gli allievi dei Corpi Reali di Artiglieria, Genio e Stato Maggiore usciti dalla Regia Accademia Militare, da cui la Scuola ancora dipendeva. l corsi si dividevano in materie comuni a tutti i frequentatori (mineralogia, metallurgia. topograf ia , impiego dell'artiglieria, fortificazioni, ponti militari) c materie special istiche (come fabbricuione delle polveri e balistica per Artiglieria e architettura civile c militare per il Genio). Tra g li insegnanti di maggior prestigio figurano alcuni valorosi UlTiciali che diedero poi anche un

 90- A ngelo Francesco Siacci, uno dei fondatori de/la balistica.
90- A ngelo Francesco Siacci, uno dei fondatori de/la balistica.
importante contributo alla politica nazionale. Jnnanzitutto Giovanni Cavalli, che ebbe fama internazionale per i suoi studi e le sue geniali invenzioni relative all'alleggerimento e al perfezionamento delle artiglierie da campagna, nonché per la costruzione di un innovativo cannone rigato a retrocarica. Cavalli inoltre partecipò valorosamente alle campagne contro l'Austria del 1848-1849 (in cui si distinse nella presa di Peschiera) e del 1859, arrivò sino al grado di Tenente Generale e fece parte, prima co me deputato, poi come senatore, del Parlamento Nazionale. Un'altra figura di eccezione è quella di Luigi Federico Menabrea, Ufficiale del Genio laureato in matematica, architettura c ingegneria: insegnò matematica sia presso la Scuola, sia presso rAccademia Militare, affermandosi come studioso di livello internazionale nel campo della meccanica razionale. Autore di una brillante e rapida carriera (Luogotenente Generale nel 1860), si distinse per capac ità ed eroismo nelle prime due guerre d'Indipendenza e per questo venne insignito del titolo di marchese e decorato della Medaglia d'Oro al Valor Militare. Svolse anche una importante e lunga attività politica come Deputato e Senatore fino alla nomina a Ministro in vari dicasteri e a Presidente del Consiglio dei Ministri. Appassionato studioso era invece Paolo Ballada di Saint Robert, Ufficiale di Artiglieria, insegnante di balistica e autore dj opere di notevole valore tecnico-scienti fico su meccanica, ipsometria e termodinamica.
A seguito delle esperienze della Prima Guerra d'Indipendenza e della conseguente riforma dell'esercito sabaudo, veniva nuovamente operata la separazione tra i corsi della Regia Accademia Militare e quelli teorico-applicativi. Per lo svolgime nto di questi ultimi il Re Vittorio Emanuele 11 nel 185 l sostituiva la precedente scuola con la Scuola Complementare per gu Ufficiali di Artiglieria e Genio, autonoma rispetto aU'Accademia. l direttori di questa scuola diedero un contributo importante al processo di unificazione deU' ltalia. Il Maggiore Alessandro Della Rovere comandò l'Istituto fmo al 1855, dopo aver preso parte alle campagne del 1848 e dell849.ln seguito partecipò alla Guerra di Crimea ed alle campagne del 1859 c del 1860-1861 e fu nominato Ministro della Guerra del neonato Regno italiano dal 1861 al1864. Dall 856, a capo della Scuola vi fu il Maggiore Ce&'ll'C Ricotti Magnani che partecipò alla campagna del 1848, alla Guerra di Crimea e alla Battaglia di San Martino. Venne eletto deputato in varie legislature e, dopo il 1870, nominato Ministro della Guerra. A lui si deve, in quest'ultima veste, il primo radicale processo di ristrutturazione ed ammodemamento de!J 'Esercito Ttali ano. Nel 1860 veniva realizzata l'unificazione nazionale e il 18 febbraio 1861, in Torino capitale, dinanzi al primo Parlamento italiano, il Re Vittorio Emanuele II, con Regio Decreto dcl24 gennaio 1861, sanzìo nava la trasformazione dell'Armata Sarda in Esercito Italiano. Il primo problema da risolvere era quello di completare la fusione dei vari Stati della penisola cominciando con l'amalgama dei quadri, compito che fu affidato alla Scuola Complementare che però nel 1863 fu sciolta

RMX:Or.T \ UFFJGI U.E
DELLE LEGG I, REG OLA.IIU TI E OISPOSIIIOII
Jtl1.\THf
.IL mnm tD m·IUJ\hlU!Im llliTIU
DEL IU\ISTERO IlEI. L\ GURR \.
863.
iTPOI
TORil'ìO
l'()f•HATTl r•• "'""0.,...1•, il •t.stnt
t. M...-.:••ee •t•rH• _.,, - t",.(,l""l"knl • """., JU«hlll'!l
t. ti' \•illh.,n• tp.arLe Jttrnlhu ) • • • '9•'-t •,hbn • , • • •
<4 eh --.tru.taulli ardUirtia•IC'.._ (t• t•llle
S. r-,..-,,. ,. Rlil•l•,. ,
G. FortA&catl., per.....u•l)te 41• .-,n.J ,, AH•Cit'O e ,Jtt,.. tlrll. 1''-ur: fn.rti •

fl Cuttnul.oa• J\c-ll•
Jh,rglti 1(1. ,,,u..,,,.,'lb
l..DtOXl N·
d• uf1P•I. • • •
l. hosl.'l\à • tll"fltl W uaa df mo.-i:..,.ot•
m lUI'éft'rtna • • • :\. .. t.!."! .. ,,:
• ,r fn•l• di • • : : :
";, tlv çA i:11l1 • ol'••• Pf'n'I"Ontit
d'•r\ltUtdtura • •
9 Oitf'Pl rcbhtl aJ d• 01rtnweau atrhMtloateht
t- A,·,-,w •n f.AA\41. - l/. l.dtc fA
t. çf . ·.
4 fl't.a& •Dlo '-'l JWr1e •
6. f',ec.dpi• • • • •
l. Al!pi tCaPO.n tUt arU • •
9 F•hbt\1 .adolAri del d' •
10. l"..-loe.i L .r Il • ,.,11ttri • • ••• re•
l
Dt1cpi ffJ .,p/iMu..t
t eubipMo. • 1f"'l•1 d'u. (•bbttrpJo •llitart •
l ,t•.Giun•nto • • • • • • •
1 l
93
Yd lwttJHf ,,_, fl• •Ur •ru·t' llllt •• lW,. U.
M'dia• ••·
Tur.t.L-' N" 111. l1truaitmi d, ueguir1i mi dru tUIIfi di cor10 c:rlnlt'IIIJIOTaMammU nUe lcio11i
1. q..l c'oloziòni a piedi dell'Artiglieria •
t. hlrozi()ni tnl tiro e sal bnoo goTerno delle anni
Atrardcllaraealo dell'Artiglieria •
4. blruzioni nrie cl'Artiglicria allorno al canllo
6. Scuula del condurre •
G. Sen'i1io e puotamtlnlo clelle hocche da fno.-o . •
'7 blndiOile trorica tlt•llo cvt>luziooi di baneria aUac:c.ata
8. Srualla tcutit·o- pratiea di zal't"' e eli mina .
9. Caritamen&o d aft'tu•ti e .-arri d'Artiglieria •
10 ld. dtol materiale dei Par.-bi del Geoio
n. prati.,he sulle del Genio
tt. I d praliehe geodetiche •
tS Man o pr.rc di forza cl ' acsedio
t4. Id li foru J'Clr le piaue e g li ar:M\oali
tJ Cost•uzione òi piccoli pon ' i
11 Canlleriza n. &-hrrma
Jllruaoni Ja swllc lande eli San Jlauri•in 11el l 0 anno di corm.
t . Scaola delle distanze . .
t . Scuola tli •rz•o nc e batteria allat:cata . . • . •
3 diltic Jii , nelle marcie., oc cupaxioue Ji posizioni, ac camJ'lmento drllc halt e rie, ecc •
4. pall!leggiatc a c:wallo per ahilnare gli allieTi alle marcle, alle c urt• tlei ca ,alli m mar cia c per i s truzione sul n•odo di utilizurn le po siz io ni ller Cl JM!r la difesa

6 Tiro al bersaglio t•ol moschetto e. «:olia pit'tola • • •
6 1 Id. t•olla e.arahina da h('rsa((liere • • •
• Id. l'oll e l•ocd•o da tla muro, eia campò o da •
8 E!leruzione 1lr.l tiro di hattaglia • • • • •
O. di hn•c cic ne ' le forlili l'azioni campali con le artiglierie " eon &e minn •
10 Cottrnzioe di hatteri!l e ri!"lri di t'ampagna
U. Arnt••ena. hatlc•rie d'anedio • • t J. !An·ala di piaoi topografie:; i con strumenti eJ a 'iata
19. Lrn ori .di aappa e di mina • • • • l• tru#oni da urguirsi Pia::.ze fort i J(/lb Stato IHl t" CDIJIO di cor.te .
t. \'asita 1li alnno piazze foitificate . .
t Pnmetto d'armamf'tllb 4'••• posizione d'opera nei varii periodi della dift'5Cl
S. Ilei lnori da farsi per porre una Piazza fOTte in alato di difesa
4. .leeRlilat.ioni aalle varie operuicnai pratiche oceorrenti ia n usHIO
La Scuola fu ricostituita nel 1863 a Palazzo Arsenale col nome di Scuola di Applicazione delle Armi di Artiglieria e Genio e, nel 1897, posta assieme alla Regia Accademia Militare sotto un unico comando. Il primo Comandante, il Generale Celestino Sachero che diresse l'Istituto per ben 18 anni (dal 1863 al 1881) impresse all'Istituto un indirizzo disciplinare e culturale rimasto immutato per molti anni. Tra le figure più prestigiose della Scuola di Applicazione si impose Angelo Francesco Siacci. Come Ufficiale di Artiglieria aveva partecipato alla Terza Guerra d'Indipendenza c come insegnante svolse servizio all'Istituto dal 1869 a l 1892. Le sue complesse ricerche scientifiche nel campo della balistica e le sue nuove so luzioni di calco lo ebbero una vasta eco nazionale e internazionale tanto che il Siacci venne nominato docente di Meccanica Superiore all'Università di Torino e di Meccanica R azionale a quella di Napoli. Fu poi membro delle più importanti accademie scientifiche del tempo, Deputato e Senatore del Regno.

Il 20 ottobre 1914, a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, il Ministero della Guerra decretò la sospensione dei corsi. Temlinato il conflitto, nel 1919 venne ricostituito il Comando Unificato della Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio la quale venne disciolta nel 1924 per entrare a far parte integrante dell' Accadenlia. Nel 1928 i due Istituti, pur mantenendosi sotto un w1ico comando, tornavano a separarsi. t:alto valore scientifico dei programmi venne riconosciuto ufficialmente nel 1930, quando con Regio Decreto vennero parificati a tutti g li effetti gli studi effettuati presso la Regia Accadenlia e la Scuola di Applicazione c quelli svo lti presso le Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e presso le Scuole di ingegneria.
Proseguiva quindi la tradizione, che aveva donato prestigio nazionale e internazionale ali' I stituto, di affidare a grandi maestri la formazione degli Ufficiali dell'Esercito. Nello scelto gruppo di insegnanti militari e civili cui vennero affidate le attività didattiche dell'Istituto spicca l'eclettica figura di Filippo Burzio. Scienziato ed umanista, docente di Meccanica al Politecnico di Torino, Burt:io insegnò dal 1926 al 1943 Meccanica Razionale alla Regia Accadcnlia e Balistica
Superiore alla Scuola dì Applicazione di Artiglieria e Genio. Noto in tutto il mondo per i suoi studi scientifici, si affermò anche come filosofo, poeta, letterato c giornalista. Nell'immediato
dopoguerra fu per alcuni anni direttore del quotidiano "La Stampa".
V Il giugno 1939 fu celebrato il bicentenario della Scuola, nel cortile del Palazzo dell'Arsenale, alla presenza del Re Imperatore Vittorio Emanuele 111. Dopo che nel 1940 l 'Italia entrò nella
Seconda Guerra Mondiale, la città di Torino venne sottoposta a continue incursioni aeree e la stessa Accademia fu bombardata più volte, per cui il Ministero della Guerra decretò il suo trasferimento a Lucca e il passaggio a Montecatini Terme della Scuola di Applicazione. Questa si sc iolse l '8 settembre 1943.
Si concludeva così la seconda parte della vita di un Istituto plurisecolare , reso celebre dal rigore della formazione morale e della preparazione culturale e professionale di migliaia di giovani Ufficiali dell'Armata Sarda e dell'Esercito Italiano , sia dai numerosi illustri personaggi che transitarono nelle sue aule. Tra questi , oltre a quelli già citati, ricordiamo i Generali del Risorgimento Alfonso Ferrere della Marmora e Raffaele Cadorna, alcuni dei Comandanti più noti del Primo Conflitto Mondiale, quali i Marescialli d'Italia Pietro Badoglio , Armando Diaz, Emanuele Filiberto Duca d'Aosta, nonché il Maggiore Pietro Toselli (l'eroe dell'Amba Alagi) e il Generale Antonio Cascine (l'eroe eli Monte Santo). Tra quelli che si sono affermati in altri campi, ben 29 (tra cui Cavour) furono Ministri del Regno di Sardegna e altri 29 vennero nominati Ministri del Regno d ' Italia. Erano stati allievi dell ' Istituto anche il pioniere dell'aeronautica Enrico Luciano Forlanini, il teorico della guerra Giulio Douhet, l 'es ploratore Vittorio Bottego e alcune teste coronate, come i principi reali di Francia (figli di Re Carlo X) Luigi Antonio e Carlo ferdinando di Borbone e il futuro Re Fuad l d'Egitto.
I: attuale Istituto di via Arsenale racchiude in sé anche la lunga e gloriosa tradizione delle Scuole di Applicazione delle Armi di Fanteria e Cavalleria, anch'esse fondamentali, per il loro contributo di uomini e di intelletto, alla storia d ' Italia.
Questa rinomata istituzione trae le sue origini dalla Regia Scuola Militare di Equitazione, fondata in Venaria Reale da Carlo Felice nel 1823, sia per affinare la preparazione degli uomini di Corte, sia per perfezionare l'addestramento nelle attività equestri dei giovani Ufficiali di Cavalleria. I:istituto ebbe subito un grande direttore e insegnante, il Cavaliere germanico Otto Wagner, nominato Cavallerizzo Capo e Direttore Generale dei corsi nel 1825. La sua tecnica addestrativa era basata sul cosiddetto "metodo ragionato " che consentiva allo stesso tempo di i struire il cavaliere e di ammaestrare ii cavallo. Agli innovativi insegnamenti del Wagner si debbono quindi le brillanti prestazioni degli Ufficiali di Cavalleria durante la Prima Guerra d ' Indipendenza. Nel 1848 la scuola venne disciolta al termine della campagna contro gli

Austriaci, trasferita a Pinerolo come Scuola Militare di Cavalleria e nel 1862 cambiò il nome in Scuola Normale di Cavalleria. Già dal 1856, però, era iniziato quel grande rinnovamento della tecnica equestre e dei criteri di impiego della Cavalleria che avrebbe portato in poco più di mezzo secolo a primeggiare sui migliori centri addestrativi europei. La Scuola (divenuta nel 1887 Scuola di Cavalleria) venne riorganizzata sotto il Colonnello Luigi Berta, accentuando il contenuto tecnico-tattico e tecnico-scientifico degli insegnamenti. nonché intensificando gli esercizi di equitazione con il trasferimento di parte dell ' attività a Tordi Quinto e puntando su cavalli idonei e istruttori d 'eccellenza. Fra questi il più celebre è il Capitano Federico Capri Ili che ideò un metodo rivoluzionario il cui successo rese la Scuola famosa in tutto il mondo. Il cosiddetto Nmetodo naturale di equitazione " , si basava sull'equilibrio naturale tra cavallo e cavaliere e modificava radicalmente l'impostazione dello stile tradizionale di montare a cavallo. Intanto nel 1910 L'Istituto aveva cambiato nuovamente il nome in Scuola di Applicazione di Cavalleria e i suoi successi sportivi nazionali e internazionali si moltiplicarono portando nel1927 alla creazione al suo interno di un Centro Ippico di Preparazione Giovanile (CPGI). L'8 settembre 1943 , a seguito dell'occupazione tede sca, essa venne disciolta mentre la parte relativa alla formazione degli Ufficiali in servizio pennanente venne ripresa nel 1949 nell ' ambito della Scuola di Applicazione di Fanteria e nel 1954 in quello della Scuola di Applicazione di Fanteria e Cavalleria. Cessava così l'esistenza, come ente autonomo, di lm istituto che col suo prestigio aveva trasformato il motto dell'arma "Il cuore oltre l 'osta colo" in uno stile di vita per tutti i Cavalieri, sia in battaglia sia sui campi di gara, e in lmo slogan sentito da tutto lo sport italiano. Fedeli a quel motto furono anche i suoi Comandanti e i suoi allievi più celebri. Tra i primi ricordiamo Brno Capodilista, Vittorio Ambrosia, Comandante neJJ ' ultimo conflitto della Seconda Armata nel corso dell'occupazione della Jugoslavia e in seguito Capo di Stato Maggiore del! ' Esercito e Capo di Stato Maggiore Generale, federico Ferrari Orsi, eroicamente caduto durante la Seconda Guerra Mondiale mentre era al comando di un Corpo d'Armata in Libia , Medaglia d'Oro al Valor Militare, Raffaele Cadoma, Comandante del Corpo Volontari della Libia, successivamente Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e Senatore. Tra gli ex allievi più famosi ricordiamo i grandi maestri di equitazione Federico Caprilli e Tancredj Savoi.roux, olimpionici Medaglia d'Oro Generale Beraudo di Pralormo e il Capitano Ettore Caffaratti, il poetasoldato Gabriele D ' Annunzio, eroe di guerra e scrittore che fece epoca, e Giovanni Agnelli, fondatore della FIAT e capostipite della famiglia di imprenditori torinesi. Si distinsero inoltre per valore Alessandro Bettoni, Comandante del Savoia Cavalleria , i Generali Pietro Dodi e Ugo De Carolis, Medaglie d'Oro al Valor Militare e l ' ex ambasciatore Edgardo Sogno Rata del Vallino, una delle figure più eroiche della guerra di Liberazione, decorato con la Medaglia d ' Oro al Val or Militare.

95- / 1 Capitano Federico Capri/li.
96- l Capitano Ettore Caffaratti che monta secondo il "Metodo Capri/li".

97 l 98 - E sercizi in maneggio: opere realiz=ate dal Balbo e conservate. alla Scuola di Applicazione e Studi Militari dell'Esercito di Torino.

All'indomani dello sfavorevole esito della Prima Guerra d'Indipendenza, Re Vittorio Emanuele li iniLiò una radicale riorganizzazione delle strutture militari dello Stato Sabaudo e fondò a Torino nel 1849 la Scuola Normale di Fanteria che già nel 1850 venne trasferita ad lvrea col nome di Scuola Militare di Fanteria. I suoi compiti erano di fornire ai giovani Luogotenenti le capacità di comandare in guerra dei soldati, di adottare un metodo unico di educazione e addestramento fra i diversi Corpi di Fanteria e di far completare lo studio del l'arte militare, in particolare quello della tattica e della fortificazione. Nel maggio 1859, durante la Seconda Guerra d'lndipendem::a, i trecento allievi della Scuola, sotto la guida del Colonnello ù1cisa Beccaria di Santo Stefano, presero parte alla difesa di Ivrea contro g li Austriaci che stavano avanzando. Terminata la guerra con l'annessione della Lombardia al Regno di Sardegna, il Ministro della Guerra Alfonso Ferrera della Marmora dovette provvedere all'aumento


per incorporare i soldati di leva provenienti dalle nuove province. Così venne istituito per la prima volta nel 1861, presso la Scuola di Ivrea, un corso teorico-pratico per gli Ufficiali del corpo dei volontali che desideravano entrare, come Sottotenenti, nell'esercito regolare. Nel 1862 si tornò al nome originale di Scuola di fanteria, mentre la sede fu trasferita nel 1864 prima a Colorno e poi a Parma nel Palazzo del Giardino, ex villa ducale di Ottavio Farnese. Si aggiunsero corsi per i Luogotenenti proposti per l'avanzamento e per un certo numero di militari di truppa con ferma prolungata. Negli anni successivi, la Scuola cambiò più volte denominazione: nel 1869 divenne Scuo la Centrale di Tiro , Scherma, Ginnastica e Nuoto per la Fanteria, nel 1873 Scuola Normale d i Fantelia. nel 1888 Scuola Centrale di Tiro di Fanteria (che nel 1898 aggiunse corsi di ciclismo militare). Nel 1910 non solo venne cambiato ancora una volta il nome in Scuola di Applicazione di Fanteria, ma anche il suo ordinamento interno. Gli allievi usciti dalla Scuola Militare di fanteria e Cavalleria di Modena (dal 1928 Regia Accademia Militare di Fanteria e Cavalleria) con il grado di Sottotenenti, dopo tre anni di attività nei reggimenti venivano inviati presso la Scuola di Applicazione per frequentare un corso di quattro mesi per diventare Tenente. Durante il periodo 1915-1918 la Scuola svolse un'attività molto intensa, preparando migliaia di Ufficiali per affrontare le campagne di guerra. Terminato il conflitto, tra il 1929 e il 1940 vennero ammessi anche Ufficiali frequentatori albanesi e cinesi. La Seconda Guerra Mondia le travolse pure la Scuola di Applicazione di Fanteria: questa chiuse la sua attività con una pagina eroica che le valse la Medaglia d'Argento al Valor Mili tare. 1.?8 settembre 1943, alla no t izia della firma dell'armistizio con gli angloamericani, gli Ufficiali e i frequentatori dell'istituto, al comando del Colonnello Gaetano Ricci, si asserragliarono nel Palazzo farnese dopo aver rifiutato di arrendersi alle forze tedesche della Settima Divisione SS "Ado(/' Hitler". Gli allievi e i loro insegnanti si opposero con coraggio ai ripetuti attacchi di due compagnie SS rinforzate da carli armati e cedettero il 9 settembre solo dopo la minaccia di un bombardamento aereo della città. Anche il Colonnello Ricci e il Capitano Racchi furono decorati della Medaglia d'Argento. Tra i più noti Comandanti della Scuola sono da ticordare i Co lonnelli Davide Carminati (caduto nel 1859 a San Martino e Medaglia d'Oro al Valore Militare) e Federico Menassero di Costigliole (Medaglia d'Oro per l'eroismo dimostrato nel 1866 a Monte Croce), mentre dei molti suoi ex allievi ricordiamo i Marescial l i d'Italia Gaetano Giardino (Comandante de li' Armata del Grappa), Ugo Cavallero (Capo di Stato Maggiore Generale durante il Secondo Conflitto Mondiale) ed Ettore Bastico (Comandante e storico), gli scrittori Ange lo Gatti e Giuseppe Perrucchetti (l'ideatore degli Alpini) e il ministro Paolo Spinardi.

l 04 - T iro con la mitragliatrice.
105- A dd es tramento con la sciabo la.

l 06 l l 07- S an Mauri:::io al Campo: 1890. Predisposi:::ione del bersaglio e verifica degli effetti de/tiro.

Al LA SCUOLA D'APPLICAZIONE DELL'ARMA DI FANTE,RIA
hCUlLA DI ALTI fNSECNAMENn.
CHE FORCIO' T ANTE GIOVANI GENERAZIONI DI UFFICJALI EDUCANDOLE ALLE LECC I DEL DOVERE E DEL SACRIFICIO NELLA CRITICA NOTTE DELL' ARMIS H llO. RESPI!'o'T A L'INTIMAZIONE DI RESA
AFFRONHVA UNA IMPARI LOT1A
CONTRO FORZE PIU' VOLTE SUPERIOPI COSTITUENDO UN BALUARDO
CONTRO CL QUALE URHVANO INVANO SCELTE FANTERIE AVVERSARIE
NE' LE PERDITE NE' CL SUCCESSIVO INTERVE..'ITO DI MEZZI CORAZZATI NEMICI RIUSCIVANO A FIACCARNE lA TENACE VOLONTK DI Rf.SISTfJ>;ZA
DOPO PIU' ORE DI ACCANITA LO'! T A, DESISTEVA DAL COMBATTIMEi\'TO
SOlO IN SECUlTO AD ORDINE SUPERIORE • .SUCCEUANDO CON IL SANGUE CENEROSO DEl SUOI DIFENSORI DI VALORE
AU:ONORE MILITARE P IBRE19-U.
108- P alazzo Du cale di Colorno, sede della "Scuola Normale di Fanteria" dal 1864 a/1865.

109- M edaglia d 'Argento alla Scuola d'Applicazione dell'Arma di Fanteria- 1943.
110- Vi lla Ducale di Parma, sede della "Scuola di Applicazione di Fanteria" da//865 a/1943.
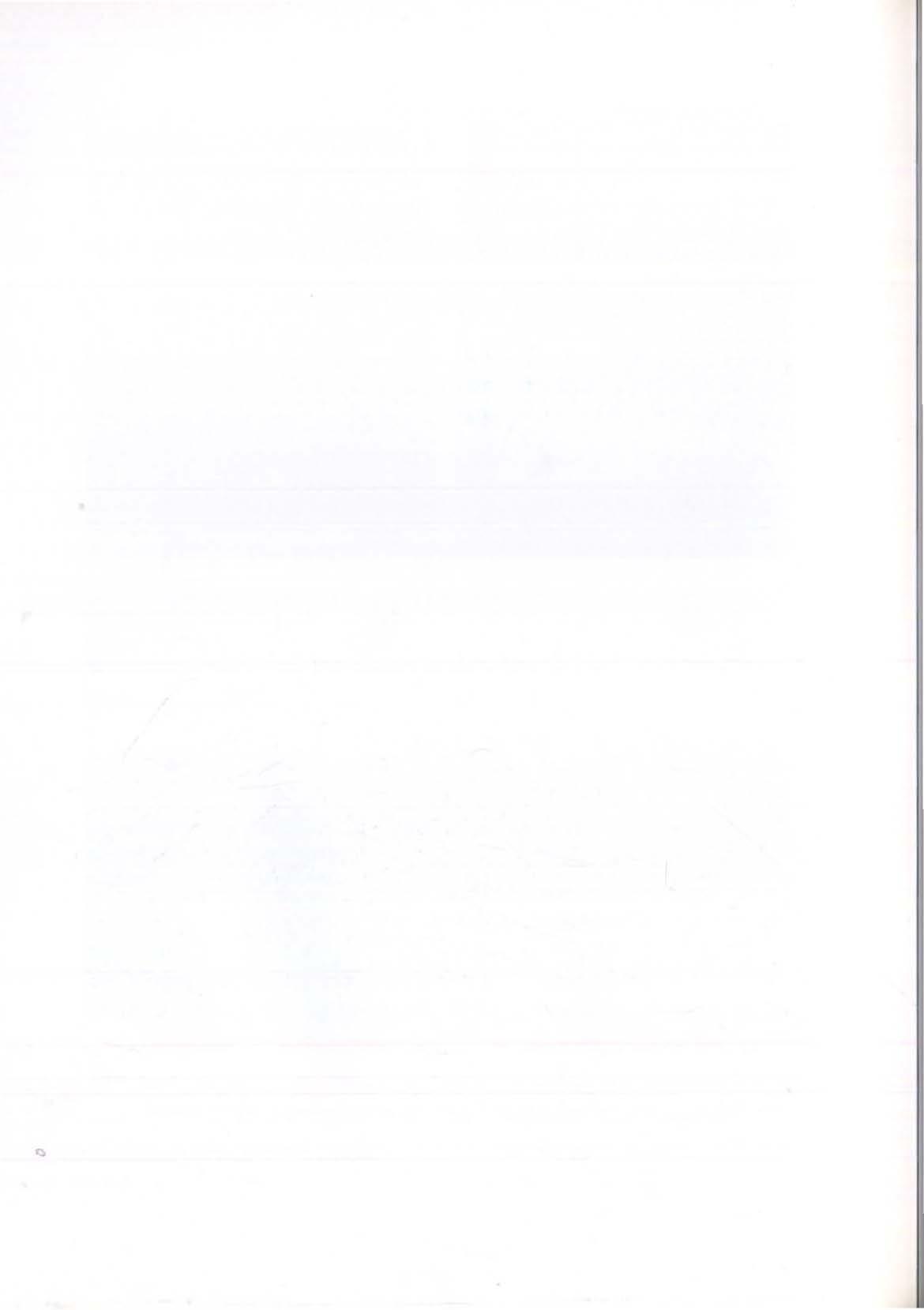

La Seconda Guerra Mondiale aveva lasciato l'Italia in una condizione di enorme difficoltà. Ovunque edifici distrutti dai bombardamenti e dagli scontri armati e profonde ferite umane e sociali. Bisognava ricostruire il Paese , non solo dal punto di vista materiale, ma anche da quello politico, economico, sociale e militare. Perciò , nonostante le enormi difficoltà dovute a una situazione critica e instabile, le autorità politiche e militari dell'epoca riuscirono a ricostruire gli Istituti principali per la formazione dei Quadri del nuovo Esercito. Il 5 aprile 1944, nella caserma "Pico'' di Lecce vennero riprese le attività accademiche del1'86 ° Corso di Fanteria e Cavalleria e de l 125° Corso di Artiglieria e Genio. l corsi vennero posti alle dipendenze del Comando Regie Accademie Militari successivamente denominato, nel 1945, Regia Accademia Militare. II 15 giugno 1946 , in seguito alla proclamazione della Repubblica , la Regia Accademia assumeva la denominazione attuale di Accademia Militare e l 'anno dopo ti entrava nella sua vecchia sede, il Palazzo Ducale di Modena, dove tuttora si trova. Nel 1949 le Scuole di Applicazione delle Armi di Fanteria , Cavalleria, Artiglieria e Genio ripresero la loro attività nella loro sede di Torino nonostante mo lte infrastrutture risultassero inagibili . Sia il Palazzo dell'Accademia di via Verdi, sia il Palazzo dell'Arsenale avevano subito pe rò notevoli daruù a causa della guerra e quindi fu necessario intraprendere una serie di onerosi lavori di ristrutturazione che durarono sino al 1950. Il Palazzo de ll 'Arsenale, difatti, a causa dello scoppio di bombe d ' aereo e spezzoni incendiari ebbe distrutta l'ala della Biblioteca e subì gravi danni ad un'ampia superficie delle copertw-e, al Salone del Circolo Ufficiali, all'ex gabinetto di architettura e agli impianti idrici ed elettrici. Gravi danni da parte dei bombardamenti subirono pure l ' ex Spianata di Artiglieria, il complesso dell'ex Accademia, il Palazzo di corso Vinzaglio e la Caserma Dabormida. Tale situazione infrastrutturale precaria era ulterionnente aggravata dal fatto che i fabbricati, abbandonati dopo 1'8 settembre 1943, erano stati occupati da Tedeschi,
fascisti e da formaLioni varie, mentre in seguito erano stati adibiti, da parte di enti locali, ad uffici pubblici e a centri di assistenza.
Nonostante le mille difficoltà, le attività della Scuola ripresero con grande slancio. La Scuola di Applicazione di Artiglieria fu ricostituita il 15 giugno 1949 in alcuni locali agibili del Palazzo dell'Arsenale e della Spianata di Artiglieria che ospitarono anche la Scuola di Applicazione del Genio, ricostituita il 23 giugno dello stesso anno. Il primo ottobre 1949 si aggiunse la Scuola di Applicazione di Fanteria (che nel 1954 cambiò il nome in Scuola di Applicazione di Fanteria e Cavalleria) prima nella sede di corso Vinzaglio e dal 1951 a Palazzo Arsenale.

La ricostruzione di un esercito moderno ed adeguato alle nuove esigenze della Repubblica italiana vedeva la necessità di Lmifonnare la formazione degli Ufficiali delle diverse Armi. Quindi lo Stato Maggiore dell'Esercito nel 1951 decise la costiluLionc del Comando Scuole di Applica7ione d'Arma, alle cui dipendenze vennero posti i tre Istituti, allo scopo di armonizzare i programmi c le materie di insegnamento e di creare una continuità più marcata con l'Accademia. Il Comando delle Scuole venne affidato al Generale Paolo Supino.
Gli anni C inquanta furono un periodo di importanti riforme sul piano della formazione e di grandi investimenti sulle strutture delle Scuole. Venne completata difatti la ristrutturuione degli edifici danneggiati dalla guerra e nel contempo vennero creati all'interno di essi nuove aule, laboratori, biblioteche, palestre oltre ad alloggi, magazzini, sale convegno, etc. Furono quindi potenziati il Ga loppatoio Militare di Sassi, la Spianata di A11ig l ieria in cui vennero realizzati, tra l 'altro, un campo di pa ll avolo c uno di pallacanestro. Nel 1954 venne impiantata una fotolitografia per un 'au tonoma produzione dei testi scolast ici e fu ro no potenziate le alt rczzaturc de ll a cattedra d i Sc ie nza de ll e Costmzion i Tutto ciò s i collegava a un'importante novità: la parificazione, a termini di legge, degli studi universitari fatti negli Istituti militari con quelli di Ingegne ria. Di conseguenza i programmi d'insegnamento, dalla fine degl i anni '50 al 1963, furono impostati su un'ampia base scientifica d'indirizzo ingegneristico, integrata da un'altrettanto ampia componente tecnico-professionale. lnoltre, le Scuola iniziarono ad aprirsi alla società civile torinese attraverso una serie di ma n ifestazioni culturali . sociali c sportive, dalle competizioni alle conferenze, in un proficuo scambio con le istituzioni e le Università locali. Alcune innovazioni furono apportate nel 1968, quando venne fortemente ridotto il numero delle materie universita r ie a favore delle ore dedicate ag l i insegnamenti professionali. I n contemporanea furono affida t i all'Istituto il reclutamento e la formazione degli UfTiciali a Nomina Diretta destinati ai servizi tecnici dell'Esercito (oggi Corpo degli Ingegneri) e vennero tenuti corsi tecn ico-app licativi per gli UfTiciali delle Varie Ar mi. Nel 1972 iniziarono i corsi integrativi annua-
li per gli Ufficiali del Servizio di Amministrazione e Commissariato provenienti dall'Accademia
Militare di Modena. Gli Anni Sessanta furono caratterizzati anche da un potenziamento delle infrastrutture della Scuola, sia con l 'acquisizione di nuove caserme e aree addestrative, sia con l'avvio di nuove costTuzioni. In particolare nell'area della Spianata di Artiglieria vennero costruiti una moderna palestra nell960, due edifici scolastici (i palazzi Fanteria e Artiglieria) nel 1961 e 1968, un padiglione per la scherma nel 1969 e un terzo edificio destinati agli alloggi di servizio collettivi (palazzo Servizi) nel 1972. Nella zona di piazza d'Armi venne inoltre realizzato nel 1971 un centro sportivo comprendente un maneggio coperto con relative scuderie e sei campi da tennis.

Dagli Anni ' 70 al nuovo Millennio:
la formazione dei professionisti del peacekeeping
Il 1975 fu l'anno di una radicale riforma dell'Esercito Italiano che coinvolgeva inevitabilmente anche gli Istitut i di formazione. Dal primo agosto 1976 na sceva un Istituto unico col nome semplificato in Scuola d'Applicazione, mentre le singole scuole si trasformarono in corsi delle diverse Armi. Dal 1978, in seguito alla costituzione a Civitavecchia dell'Ispettorato delle Scuole, l'I stituto passava dalle dirette dipendenze dello Stato Maggiore deli' Ese rci to a quello dell ' Ispettorato (oggi Comando delle Scuole dell'Esercito). Dal Comandante della Scuola continuò a dipendere, ancora per qualche tempo, l 'Accademia Militare di Modena e nel 1998 venne trasferito presso la Scuola il Corso Applicativo d eli' Arma Trasporti e Materiali. Per quanto riguarda gli studi, negli Anni '80 si iniziò ad attuare un'autentica rivoluzione che condusse la Scuola verso gli attuali livelli di eccellenza internazionale. D'altronde, lo scenario in cui andava ad operare l'Esercito Italiano diveniva sempre più complesso, con l'impegno del nostro Paese nelle prime missioni internazionali (Libano '82) e lo sviluppo di tecnologie sempre più sofisticate. 11 passo deci s ivo per la Scuola fu quello puntare al riconoscimento di una futura Laurea in Scienze Militari, rendendo i piani di studio più aderenti a quelli universitari. Vennero cosi inserite nuove materie universitarie di tipo scientifico, un1anistico e manageriale, tra cui sociologia, geografia politica ed economica, statistica. Nel 1986 il riconoscimento della necessità di professionalità specifiche, spingeva la Scuola a cambiare la s ua impostazione strettamente ingegneristica e a proporre tre indirizzi di studio differenziati: Scienze dell'Informazione , Ingegneria ed Economia e Commercio (sostituita nell '88 da Scienze Politiche). Nel 1990, con La legge 169 del21 giugno, l ' obiettivo del riconoscimento di una Laurea patificata a quella universitaria veniva raggiunto e le prime tesi vennero discusse nell'anno accademico 1992-93. Iniziava inoltre il rappo1t0 di scambio se mpre più intenso con l 'U niversità torinese, dato che gli allievi
111 l l l 2 l 113 l l l 4 - / 1
Generale Paolo Sup ino (in alto a sinistra) e i p r imi tre Comandanti delle Scuole dopo il Secondo Conflitto Mondiale, Colonnello E. Vesp ignani (in alto a destra). Colonnello G. Dragoni (in basso a sinistra) e Colonnello F. Bonelli (in basso a destra).

della Scuola di Applicazione venivano iscritti presso gli Atenei cittadini per frequentare le lezioni relative alle varie discipline mancanti al completamento del piano di studi. Inoltre, allo scopo di conferire agli Ufficiali una preparazione adeguata ai loro impieghi in ambito NATO, fin dall'inizio degli Anni '80 si migliorò l'insegnamento delle lingue, in particolare dell'inglese, grazie anche alla costruzione di moderni laboratori di lingue estere e ad un incremento delle lezioni dedicate alle lingue. Si intensificarono anche le attività culturali, come conferenze, congressi, concerti, incontri con alte personalità, culminate con le visite dei Presidenti della Repubblica Francesco Cossiga, il23 ottobre 1989, e Carlo Azeglio Ciampi, il 20 novembre 200 l; ancora prima è da ricordare quella di Papa Giovanni Paolo U, nel 1988, in occasione della beatificazione del Luogotenente di Stato Maggiore Francesco Faà di Bruno (frequentatore della Scuola tra il 1846 e i l 1848).
l l 5 - / 1 Generale Moizo. l/ Comandante della Scuola d 'Applica=ione all'attuazione del nuovo ordinamento che sanciva la scomparsa delle singole Scuole d 'Applica=ìone delle Armi, di Fanteria e Cavalleria, Artiglieria. Genio.

La svolta deci siva è avvenuta a cavallo del Millennio, con una riforma radicale che ha portato all'attuale Esercito di professionisti attraverso due tappe fondamentali: l'apertura alle donne nel 200 l e la sospensione della leva obbligatoria nel 2005. In questo ambito, pure la Scuola di Applicazione ha sub ito una sostanziale riorganizzazione a partire dal2000 che l'ha portata all'attuale situazione di unico Istituto a cui competono la fonnazionc e il perfezionamento degli UITiciali dell 'Ese rcito (anche quelli a Nomina Diretta, di Complemento e del Ruolo Speciale). ll primo grande traguardo è stato il riconoscimento agli Ufficiali dell'Esercito, a partire dall'anno accademico 1999-2000, di una Laurea specifica per la loro professione, impegnata sempre più in complessi scenari internazionali. Difatti, con la firma di una convenzione tra l'Accademia di Modena. la Scuola di Applicazione di Torino, l'Università e il Politecnico di Torino e l'Università di Modena-Reggio Emilia veniva realizzato un Corso di Laurea in Scienze Strategiche. Aperto dal 2002 anche agli studen ti civili, il Corso si divide in Laurea (i primi tre anni) e Laurea Magistrale (fino al quinto anno). La Laurea in Ingegneria invece è destinata agli Ufficiali del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito mentre per tutti è determinante l'approfondimento dell'info rm atica c delle nuove tecnologie. Dal 2003, con il trasferimento a Torino del Corso di Stato Maggiore, la denominazione è di nuovo cambiata in Scuola di Applicazione e Istitu to di Studi Militari dell'Esercito. Dinamicità e modemità sono le parole d 'ordine della Scuola di oggi che vanta una collaborazione se mpre più attiva con altre strutture militari e col mondo esterno: oggi essa conta un centinaio di docenti dvili e w1a trentina di insegnanti militari e, tra gli allievi, mille giovani Ufficiali cd oltre un centinaio di studenti civili. Torino è diventata così un polo educativo di eccellenza e a ll'avanguardia, soprattutto nella formazione di personale speciali zzato nelle operazioni di ricostruzione c supporto alla pace in aree di crisi. Di asso lut o prestigio nazionale e internazionale, fra gli altri, il Master di II livello in Scienze Strategiche, il Dottorato di ricerca nella medesima arca, i Corsi per la Riserva Selezionata e il Centro Studi "Post Conjlict Op erations ".Oggi la Scuola è più che mai proiettata verso il futuro e il mondo, forte del suo glorioso passato e ben radicata nel cuore della sua città.
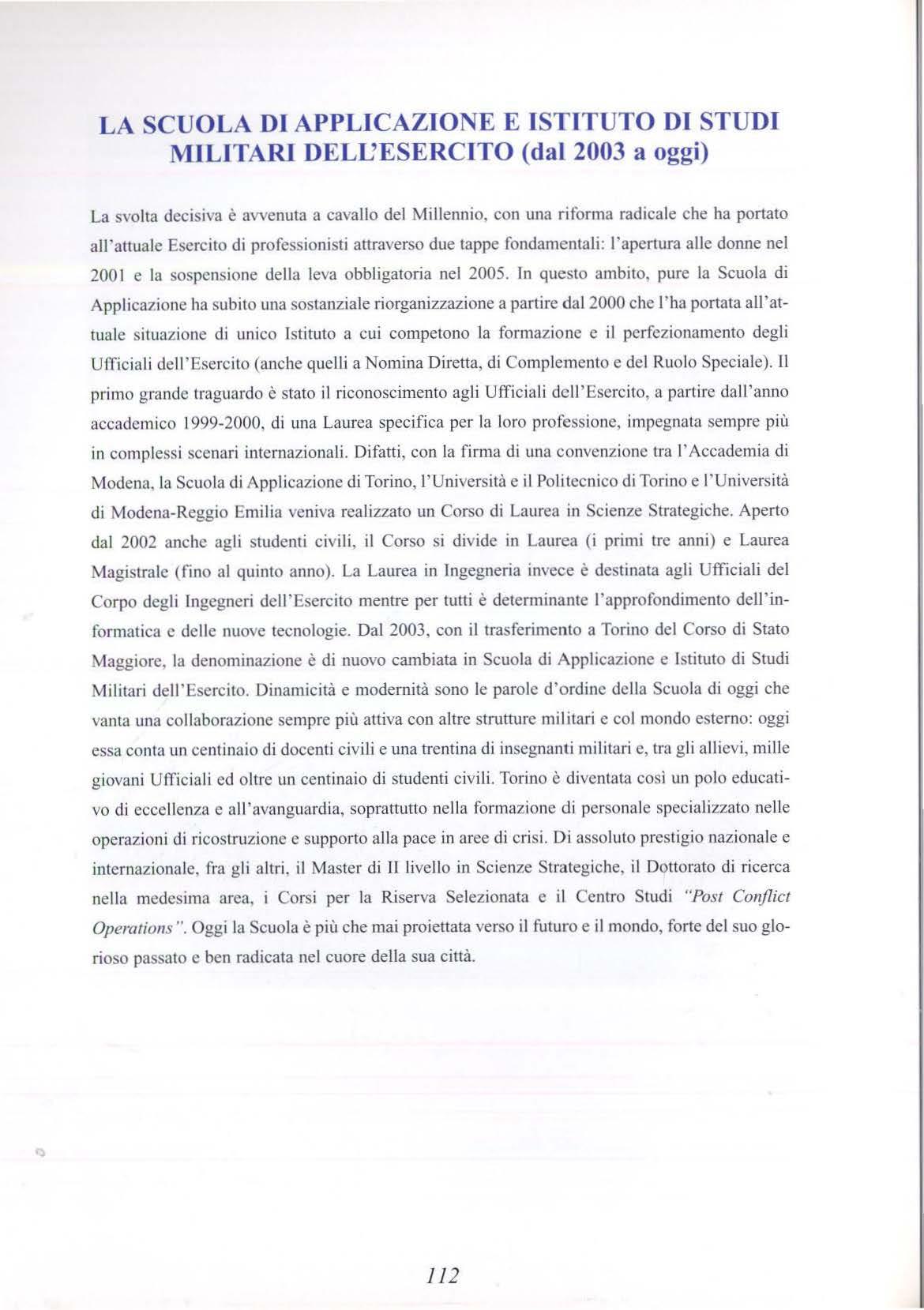
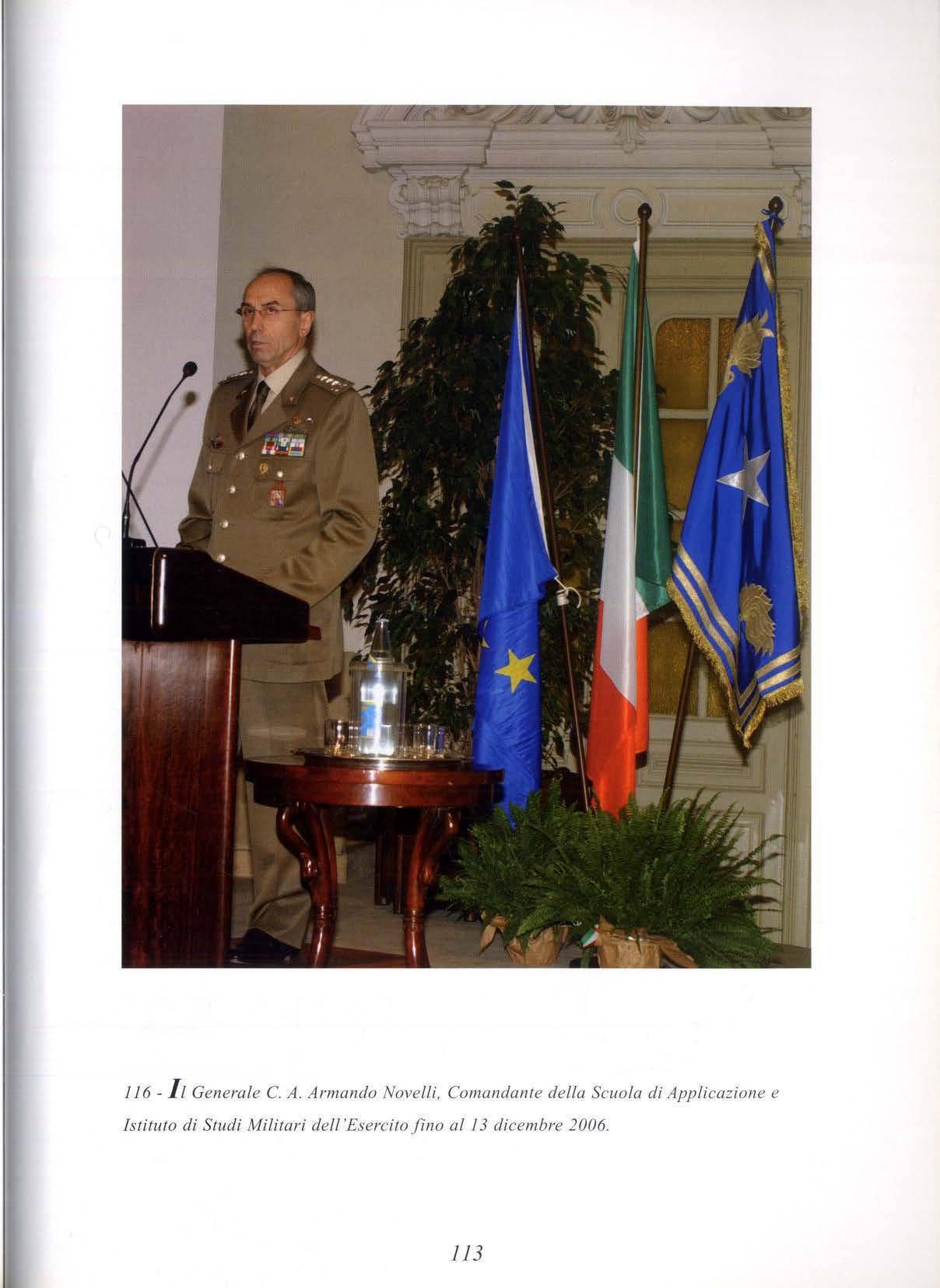
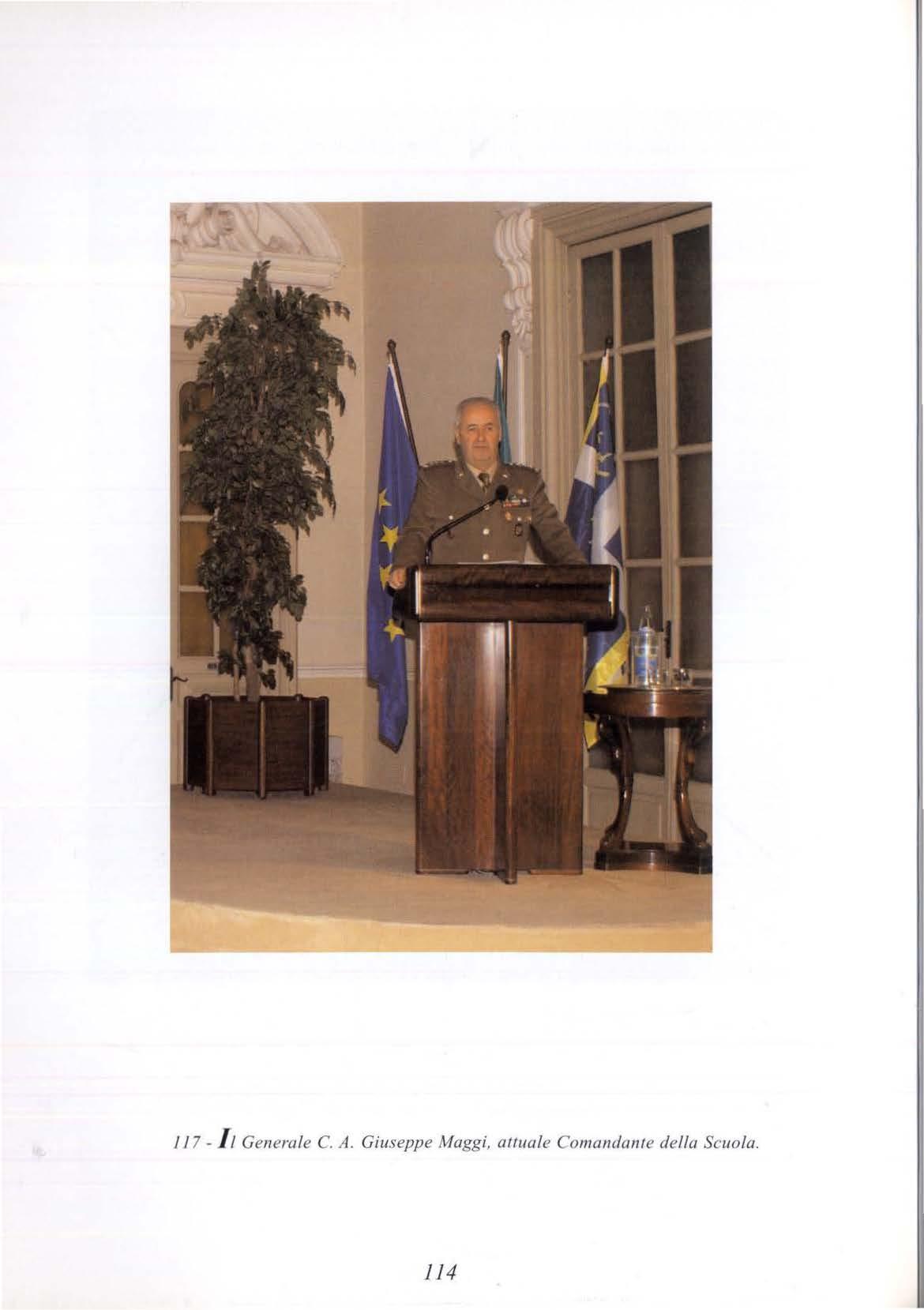 117- / t
117- / t
PREFAZIO NE OELL'A UT R1 CE
INTRODUZ IO NE
LA SCUOLA DJ APPLI CAZ ION E OGGI
La Sc uola di Applicazione co m e Sc uola dj lea d ers hip
La formazione
Qualificazione e formazione di base
Altri Corsi
Qualificazione superiore
l corsi univer sitari
Laurea in Scien7e Strategiche
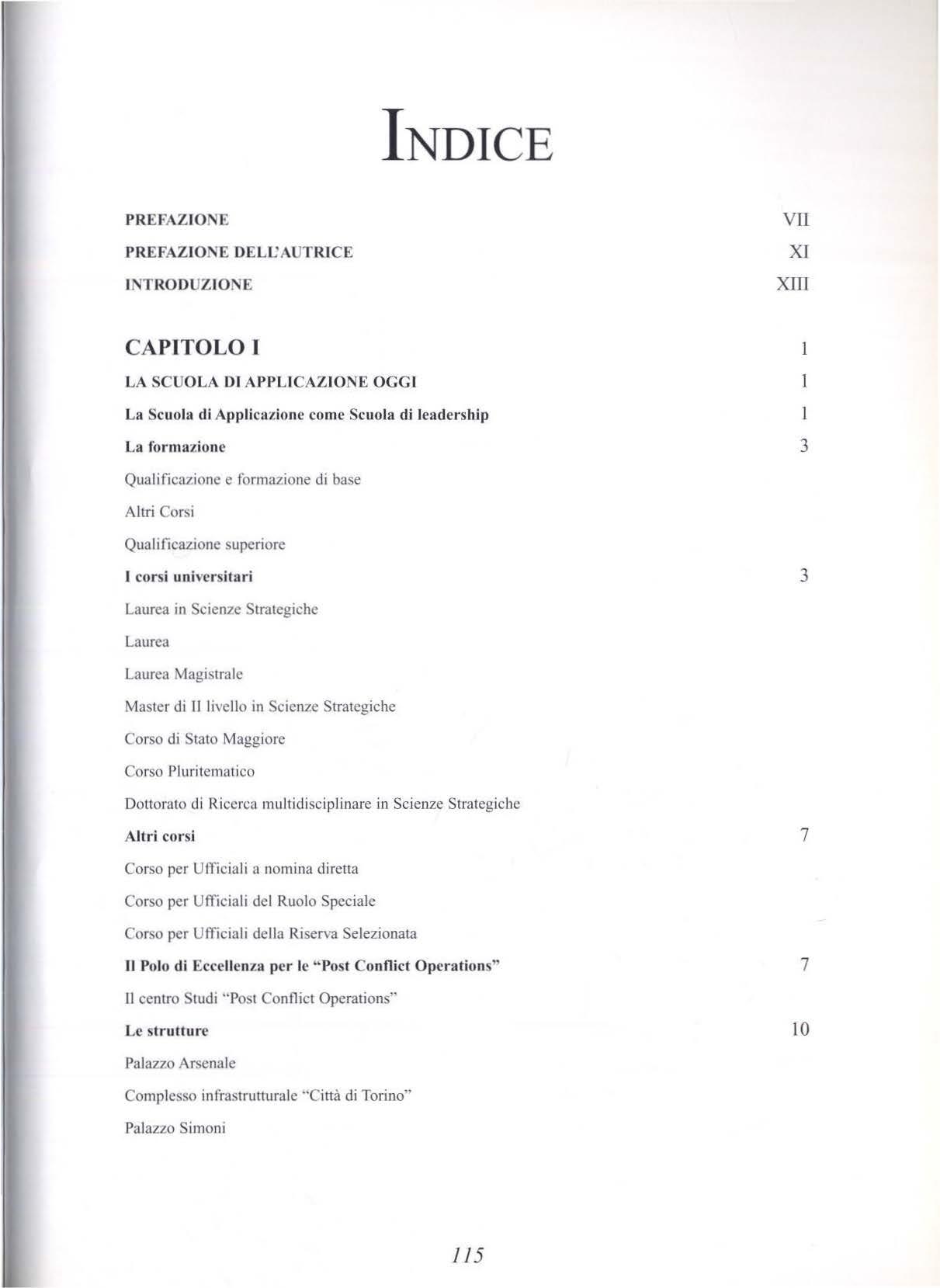
Laurea
Laurea Magistrale
Master di Il li vello in Scienze Strategiche
Corso di Stato Maggiore
Corso Pluritematico
Dottorato di Ri ce rca multidiscip linare in Scienze Strategiche
AJtri corsi
Corso per UITiciali a nomina diretta
Corso per Ufficiali del Ru olo Speciale
Corso per Ufficiali della Riserva Selezionata
n Polo di Ecce ll e n za per le " Post Co nftict Opcration s"
Il centro Studi "Post Conflict Operations""
Le strutture
Palazzo Arsenale
Complesso infrastrutturale ·'Città di Torino"
Palaao Sim oni
Sis te ma Automatinato di Comando e Co ntro ll o
Sis tema Elettronico di Simulazione
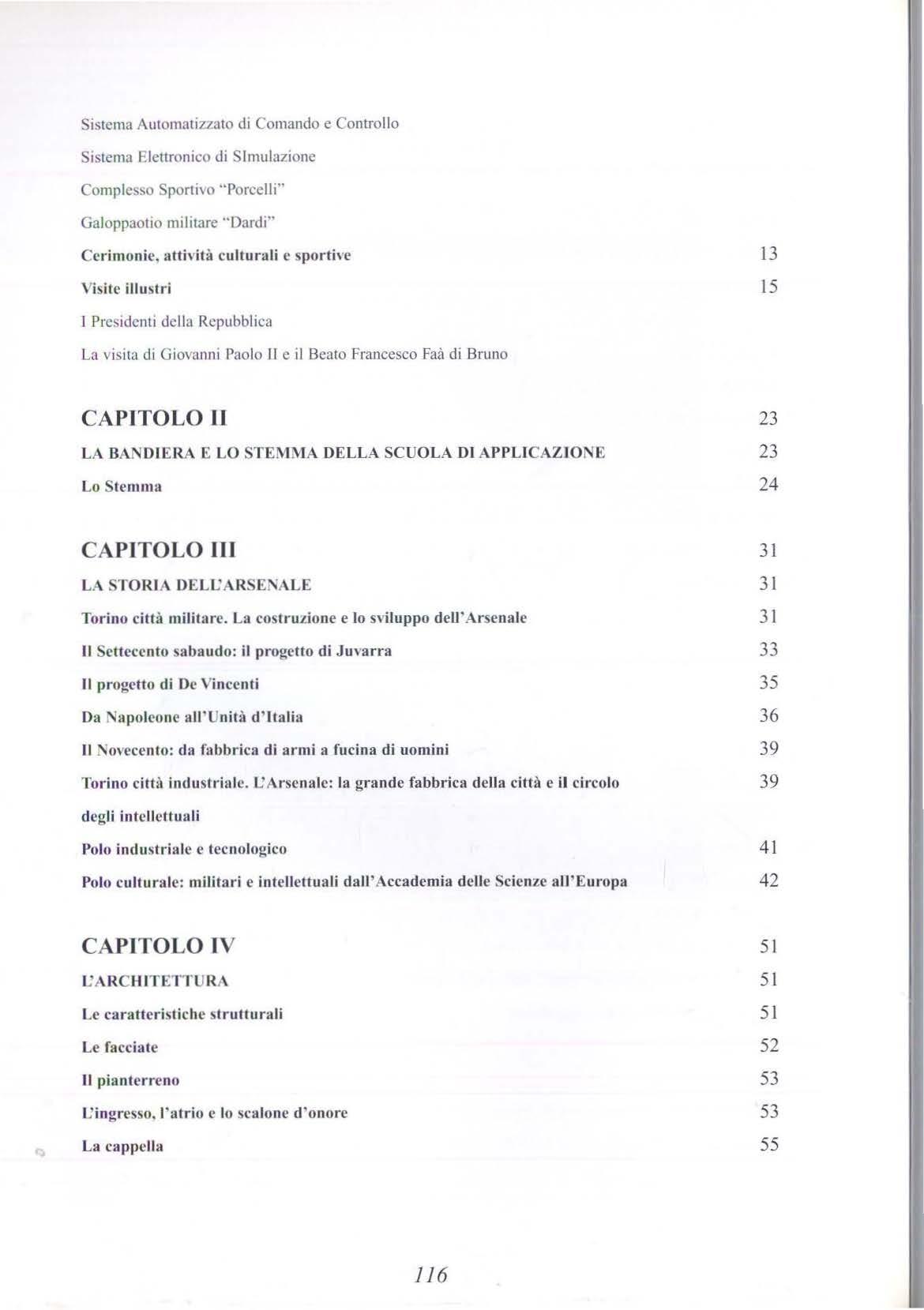
Complesso Sporti\ o ·Porcelli"
Galoppaotio milita re "Dardi''
Cer imonie, attività cultu r al i c s por tive
Visite illustri
l Pres id e nt i de ll a Rep ubb lica
La vis it a di G iova nni Pao lo Il c il Bea to Fran cesco Faà d i B r un o
LA BAl'IDlERA E LO STEMMA DELLA SCUOLA DI APPLICAZJONE
Lo Stemma CAPITOLO III
LA STOR IA DELVARSEi\ì'ALE
Torino città militare. La cos tru zio n e e lo s viluppo dell'Arsenale
Il Settecento s abaudo: il progetto di Juvarra
Il progetto di De Vincenti
Da Napo leon e all 'U nità d ' Italia
li da fabbrica di armi a fucina di uomini
To rino città industriale. L'Arsenale: la gra nd e fabbrica della città e iJ circo lo de gli int e ll ettua li
Polo indu stria le e tecnologico
Polo c ultu ra le: militari c int e ll ettu ali dall'Accademia d elle Scienze aiJ'Europa
L'ARCHITETTURA
L e strutturali
Le facc iate
Jl
TI cortile
TI padiglione della Gran Scala
Il piano nobile
La Sala Convegno e la men sa
UUfficio del Comandante della Scuola e la Sal a Rapporto
Il lato di via Arse n ale
La Terrazza e le Verande
La Sa la dei Comandanti e l'Aula Magna
Il lato di via Biancamano
La Biblioteca
LA STORIA DELLA SCUOLA - PARTE PRIMA
Le Regie Sc uole Teoric he e Pratiche di Artiglieria e Fo rtifi cazio ne (1739- l 815)
La Regia Accademia M ilitare
Il Risorgimento: daJ Regno di Sardeg na all'Unità d'Italia
La Scuola di Applicazione per gli Ufficia li d el Co rp o Reale del Genio (1819-1834)
La Sc uola Teorica di A pplicazione ad uso degli Ufficial i del Corpo Reale di Artigl ier ia (1822-1834)
La Scuola Complementa r e (1834 -1839)
La Scuola di Applicazione per le Ar mi Dotte (1839-185 1)
La Scuola Complementare per gli Ufficia li di A r t igli eria e Genio (1851-1863)
La Sc uola di Applicazione d elleArmi di Artigli eria e Genio (1863-1914)
Tra Prima e Seco nda G uerra Mondiale - La Sc uola di Applicazione di Artiglieria e Genio ( 1919-1943)
Le Sc uol e di Applicazione di Fa nte ria e Cavall e ri a La Scuola di Ap plicazion e di Cavalleria (1833-19 43 )
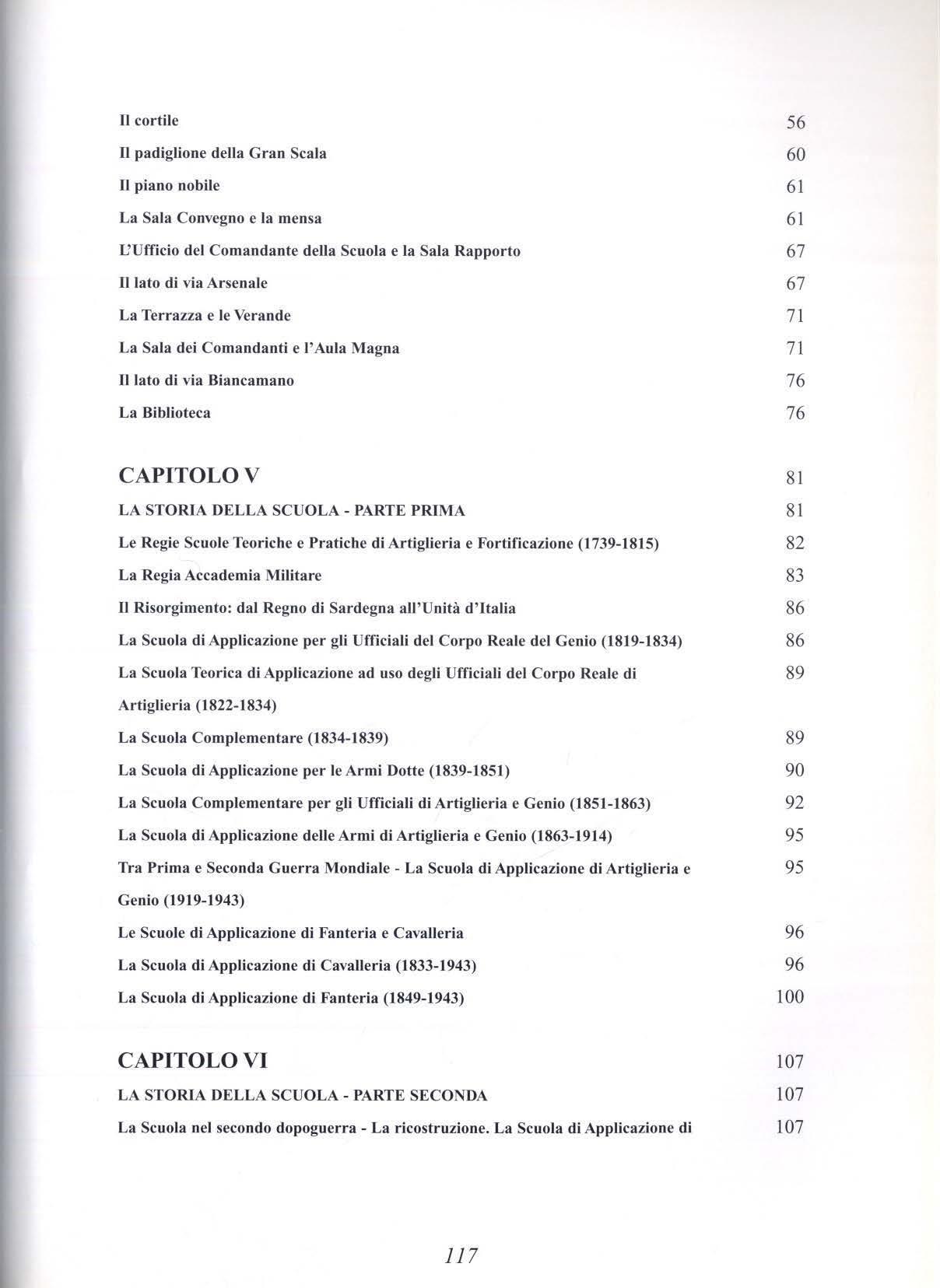
La Sc uola di Applicazione di Fa nteria (1849-1943)
LA STORIA DELLA SCUOLA - PARTE SECONDA
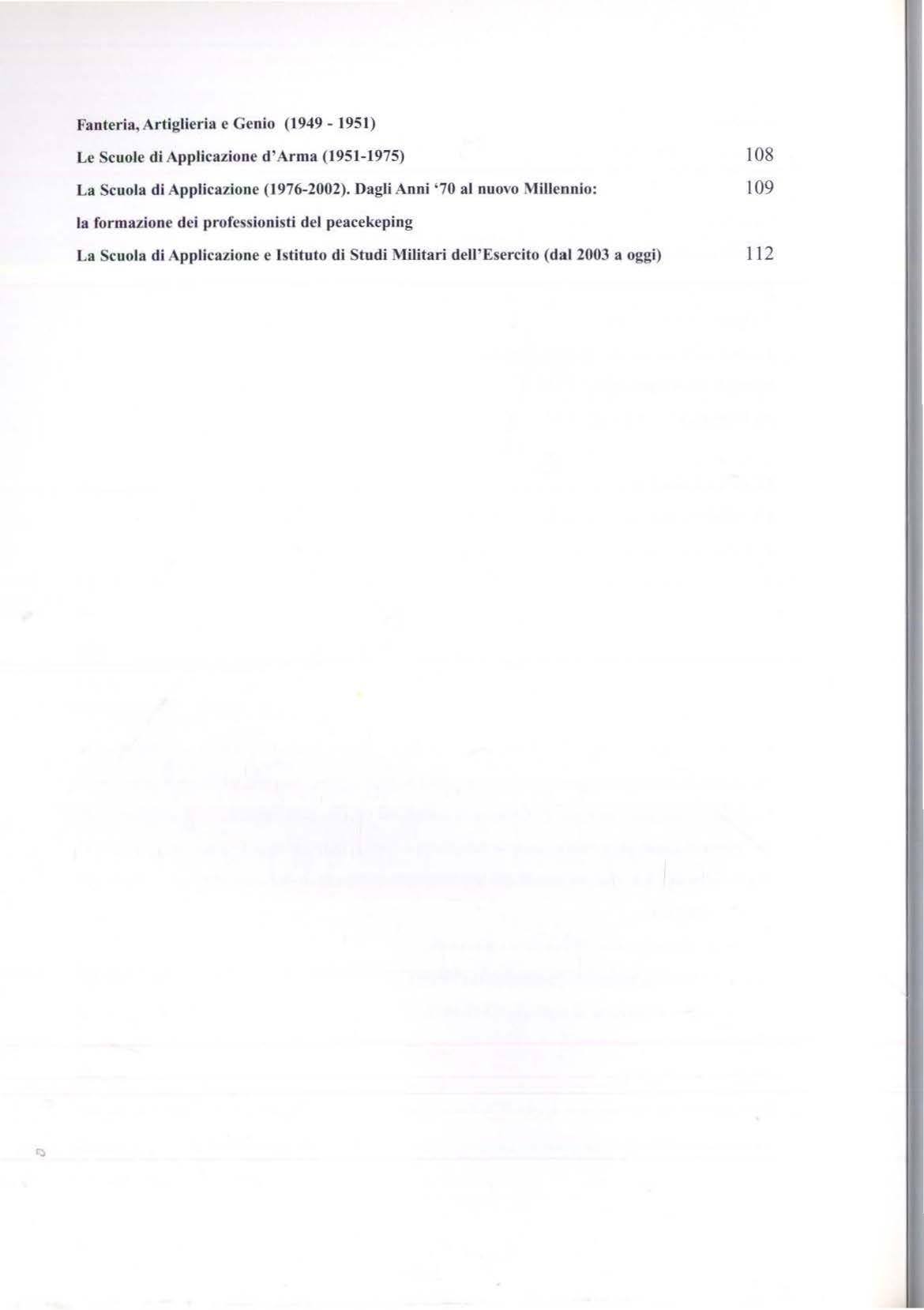
Agnelli Giovanni, Presidente c Fondatore FlAT (97)
Alfi eri Vittorio, scrittore (83)
Ambro s io Vittorio, Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale d'Armata (97)
Andres Juan, abate (82)
Antoniani Francesco, pittore (67)
Ap piano Fi lib erto, Ufficiale di Artig li e ri a (89)
Badog li o Pietro, Generale (XIV, 81, 96)
Ballada di St. R o b e rt Paolo, Ulficia le di Artiglieria (45, 92)
Balzani Angelo, pittore (59)
Baracca Francesco, Maggiore, cavaliere, aviatore (61)
Bastico Ettore, Maresciallo d'Italia, Gene rale (102)
Bella Eugenio, Maggiore del Genio (53)
Be n so Camillo, Con te di Cavour, statista (XIV, 61, 67, 76, 78. 81. 86, 89, 96)
Beraud o di Pralormo, Generale, olimpionico medaglia d'oro (97)
Bernardi Domenico, impresario (33)
Bernardi Sebastiano, impresario (33)
Ber ta Luigi, Colonnello (97)
Bertola Giuseppe Ignazio, Luogotenente Generale c primo ingegnere di S.M. (XIY, 35, 44. 45, 77, 82, 83)
Ber tola A11 tonio, lngegncre militare (82)
Bettoni Alessandro, comandante de l Savoia Cavalleria (97)
Bianco, ingegnere (4 l )
Birago di Borgaro, conte. architetto (36, 60)
Borbone Luigi Antonio (96)
Borbone Ca rl o Ferdinando (96)
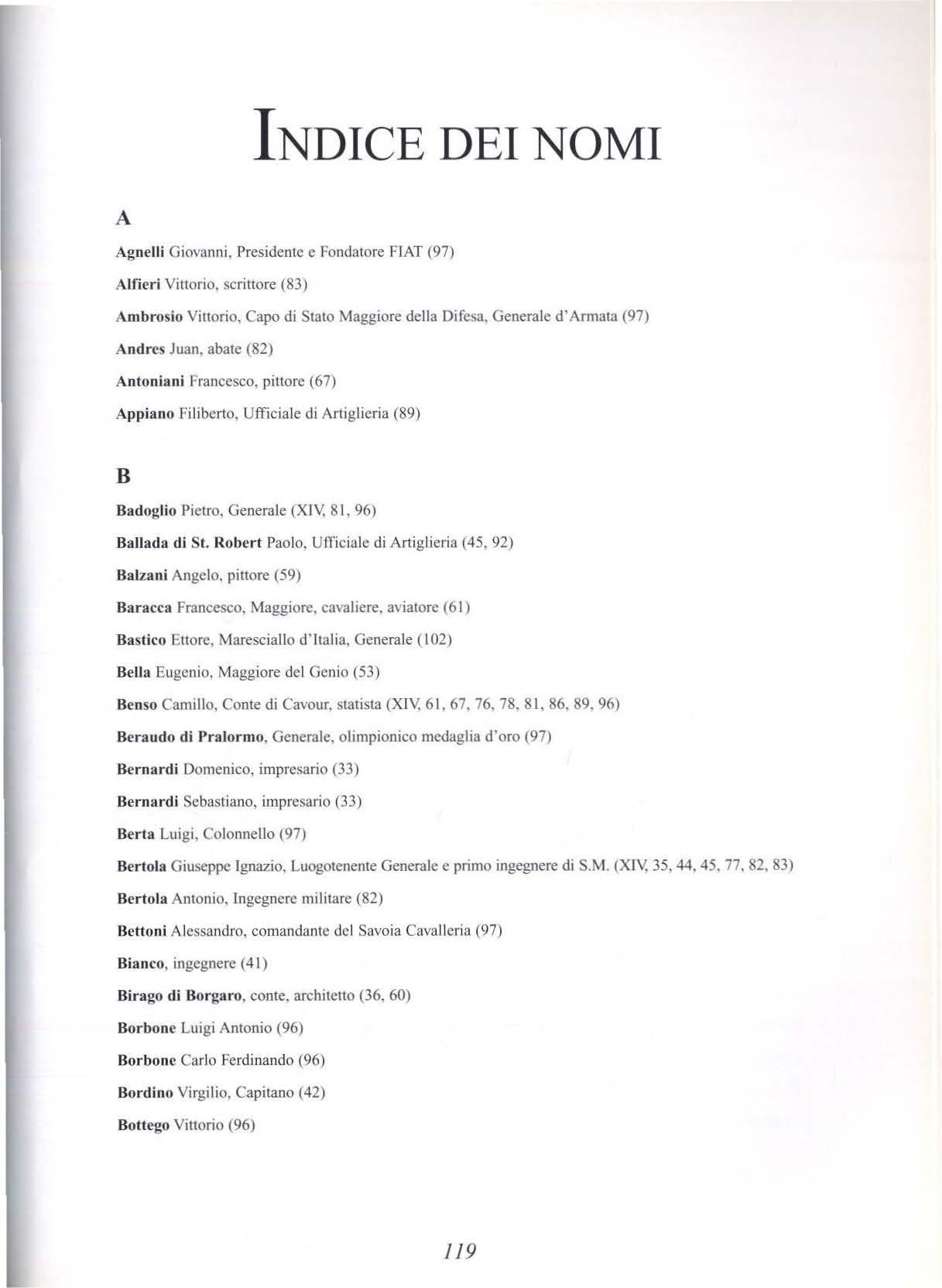
Bordino Virgi li o, Capitano (42)
Bottego Vittorio (96)
BOucheron Simon, fonditore, scu ltore (71)
Bun io Filippo, scienziato, filosofo, poeta, giornalista. direttore de La Stampa (XIV. 45, 61, 81. 95)
Busso lini Piergiorgio, Generale (54)
Ca dorna Luigi, Maresciallo d'Italia, Colonnello comandante del 10° Reggimento Bersaglieri dal 1892, figlio del Generale Raffa e le Cadorna (61, 76, 81)
Ca dorna Raffaele, Generale, Comanda nte Corpo Volontari in Libia e del Co rpo d'Armata di Torino.
senatore (X IV, 96, 97)
Caffaratti Ettore, Cap ita no (97)
Calvini Angela (X II)
Calv ini Enrico, Generale (Xl )
C ap ello Fabio. allenatore di calcio (24)
C apodi lis ta Emo, sena tore (97)
Cap rilJi Federico, Capitano (97)
Carlo X Re (96)
Ca rlo A lb e rto , Re (23, 36, 61, 67, 89)
C arlo E manu e le II , Re (33, 35)
C arlo Emanu e le JII , Re (X lii , 43, 44, 54, 61, 82)
C arlo Emanuele IV, Re (36)
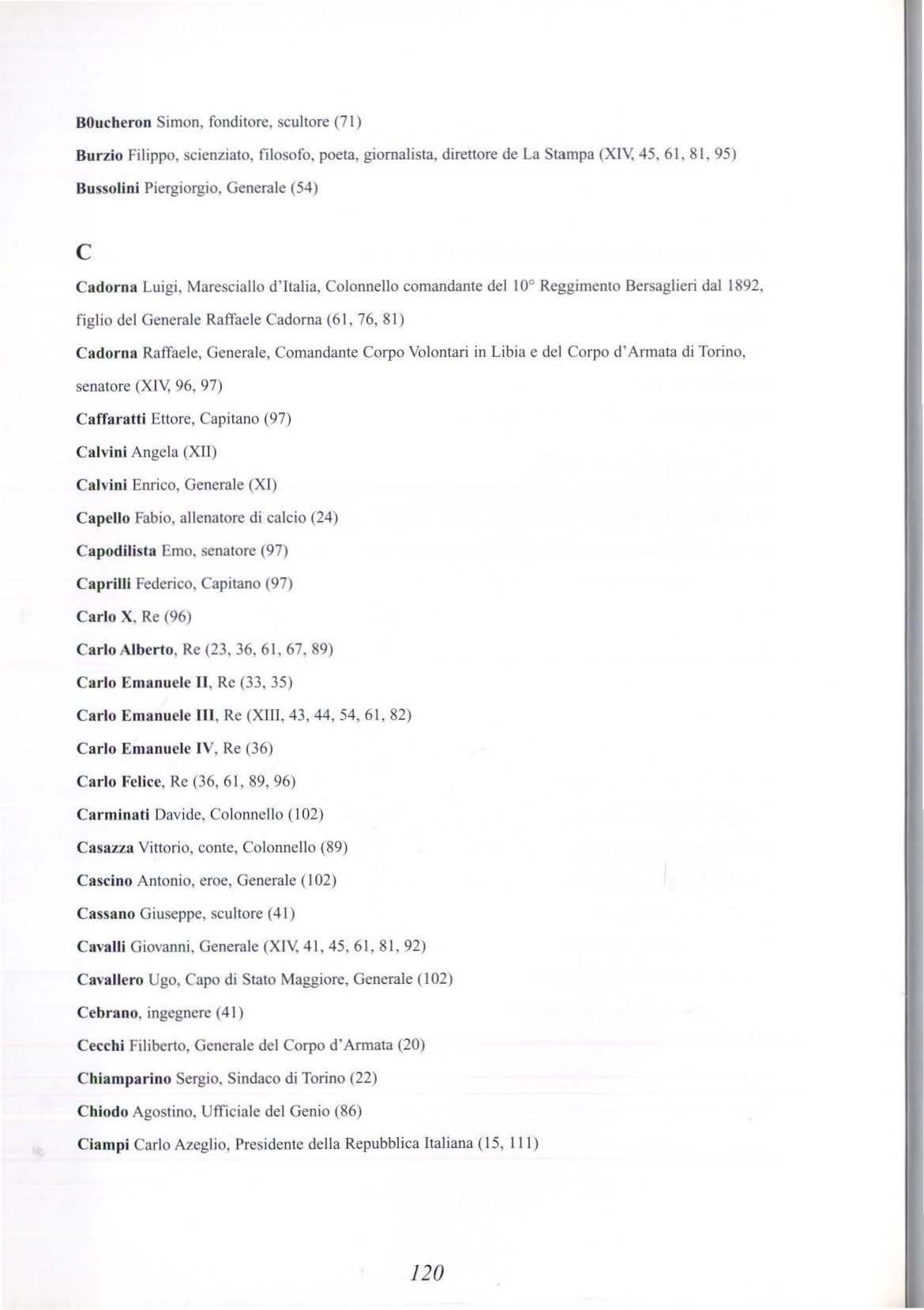
C arlo Felice, Re (36, 6 1, 89, 96)
C arminati Davide, Co lonnel lo (102)
Ca sazza Vittorio, conte, Co lonnello (89)
Casei no Antonio, eroe, Generale (l 02)
Cassano Giuseppe, scu ltore (41)
Cavalli Giovanni, Generale (X IV, 41, 45, 61. 81, 92)
Cavallero Ugo, Capo di Stato Maggiore, Generale (l 02)
Cebrano, ingegnere (41)
Cecc hi Filiberto, Generale del Corpo d'Armata (20)
C hiamparino Sergio, Sindaco di Torino (22)
Chiodo Agostino, Ufficiale del Genio (86)
Ciampi Carlo Azeglio, Presidente della Repubblica Italiana ( 15, 111)
C igna Giovanni Francesco, medico, nel 1757 tra i fondatori della Società Scientifica Torinese (44)
Condorcet, tra i primi soci dell'Accademia delle Scienze di Torino, fondata nel 1783 da Re Vittorio
Amedeo Ili (44)
Cossiga Francesco, Presidente della Repubblica Italiana ( 15 , 76, Il l)
C r e mona Italo, artista (71)
D' Alembert Jean Baptiste Le Rond, fisico . matematico c filosofo francese. tra gli autori
dell'Enciclopedia (44, 76)
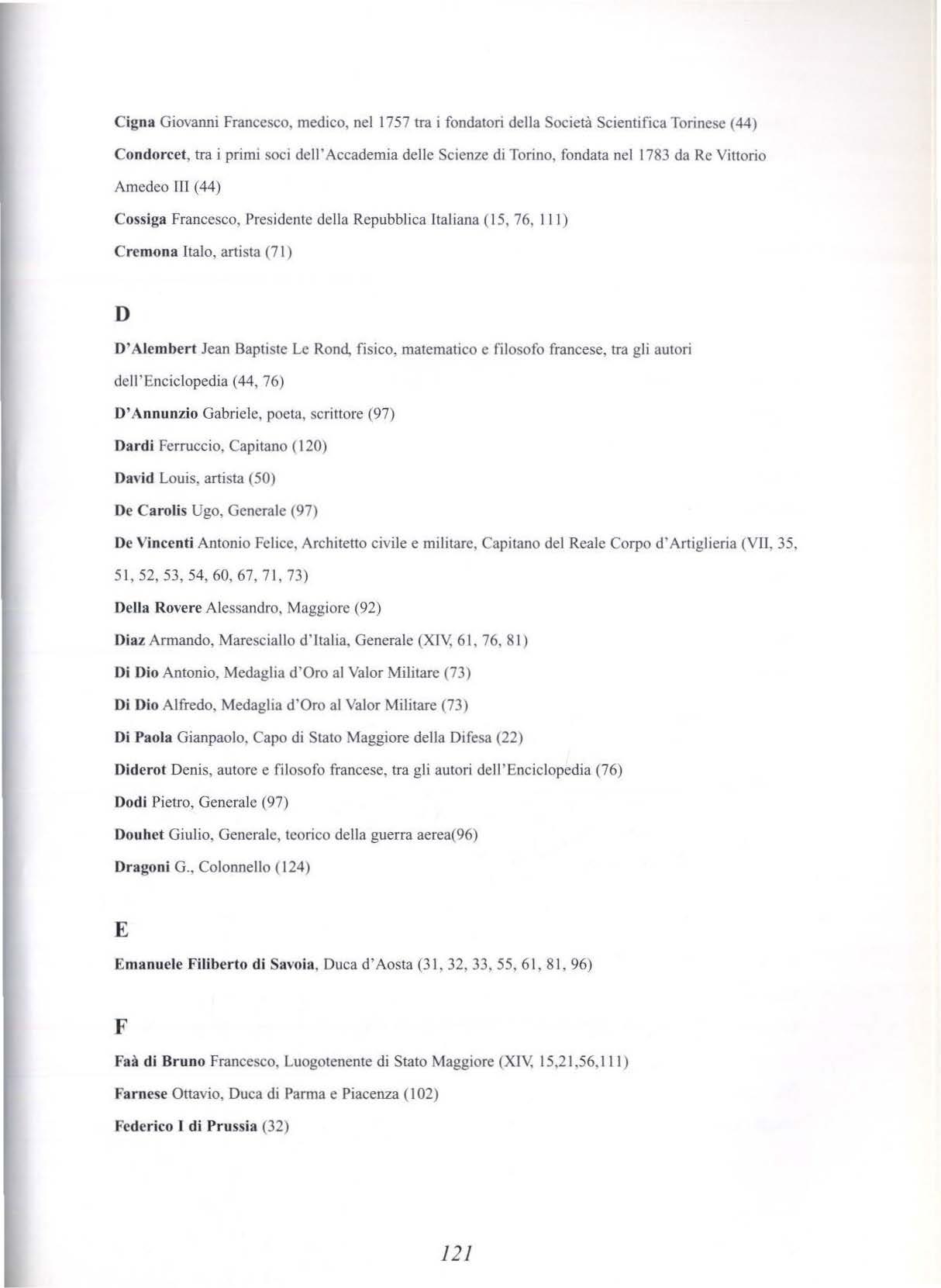
D 'A nnun zio Gabriele, poeta, scrittore (97)
Dardi Ferruccio. Capitano ( 120)
Da vid Louis, artista (50)
Dc Ca rolis Ugo, Generale (97)
Dc Vincenti Antonio Felice, Architetto civile e militare, Capitano del Reale Corpo d'Artiglieria (VII, 35, 51,52,53,54,60,67, 71, 73)
De lla Rovere Alessandro, Maggiore (92)
Di az Armando, Maresciallo d'Italia, Generale (XTV, 61, 76, 81)
Di Dio Antonio. Medaglia d'Oro al Valor Militare (73)
Di Dio Alfredo, Medaglia d'Oro al VaJor Militare (73)
Di Paola Gianpaolo, Capo di Stato Maggiore della Difesa (22)
Diderot D enis, auto re e filosofo francese, tra gli autori de li ' Enciclopedia (76)
Dodi Pie tro, Generale (97)
Douh et Giulio, Gene rale, teorico della guerra aerea(96)
Dragoni G., Colonnello ( 124)
E manu ele Filiberto di S avoia , Duca d'Aosta (31, 32, 33, 55, 61, 81, 96)
Faà di Bruno Francesco, Luogotenente di Stato Maggiore (XlV, 15,21,56,111)
Farnese Ottavio, Duca di Parma e Piacenza (l 02)
Federico l di Prussia (32)
Federico di Sassonia , Re di Prussia (83)
Ferdinando di Savoia, Principe, Duca di Genova (67)
Ferrari Orsi Federico, Generale, eroe (97)
Ferrcro d ell a Marmora Alfonso, Generale, Ministro (61, 96, 102)
Forla nini Enrico Luciano, pioniere del!' Aeronautica (XTY, 96)
Fuad I d'Eg i tto , Re (96)
Ga mb a G., pittore (61)
Gandi n Antonio, Ge ne ra le (71)
Gatti Ange lo, sc rittore ( l 02)
Gian i Vincen7o, scultore (41)
Giardino Gaetano, Maresciallo d'Italia, Duca, Comandante dell'Armata del Grappa (102)
Giulio Cesa r e Condottiero (8 1)
Gontero Riccardo, artista (73)
Gorbac iov Michail, Presidente dell'Unione Sovietica (23)
Guglielmo di Brand eburgo, Principe (83)
Guglie l mo dj Sasso nia , Re di Prussia (83)
Hans Axe l de Fersen, G ran Maresciallo di Svezia (83)
Incisa Beccarla di Santo Stefa n o , Co lonnello ( 100)
Juavarra Filippo, Architetto (33, 35)
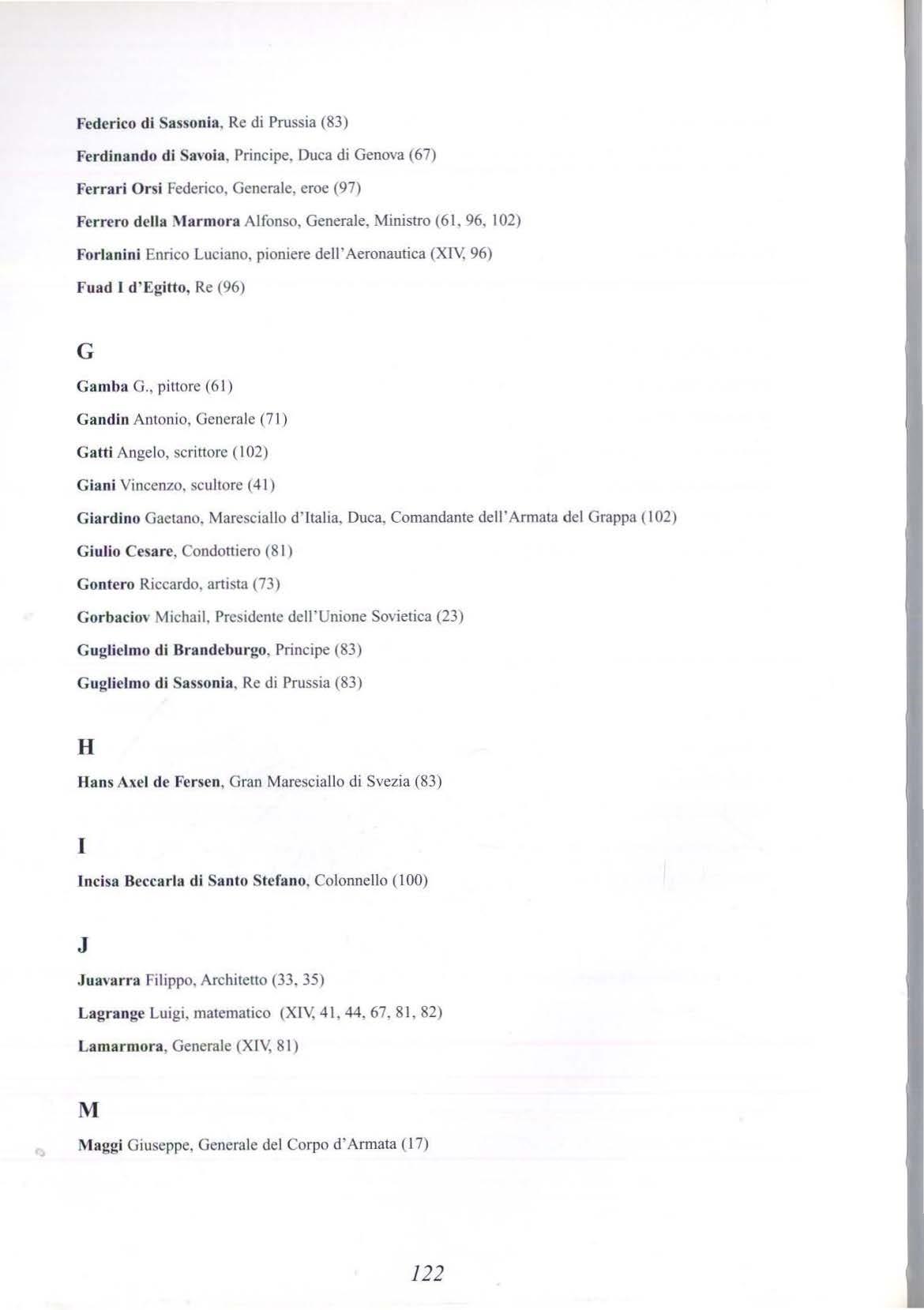
Lagrange Lu igi. matematico (XlV, 41. 44. 67, 81, 82)
Lamarmora , Gene rale (X IV, 81)
Maggi Giuseppe, Ge ne ra le d e l Corpo d'Am1ata (17)
Mal vani , scultore (59)
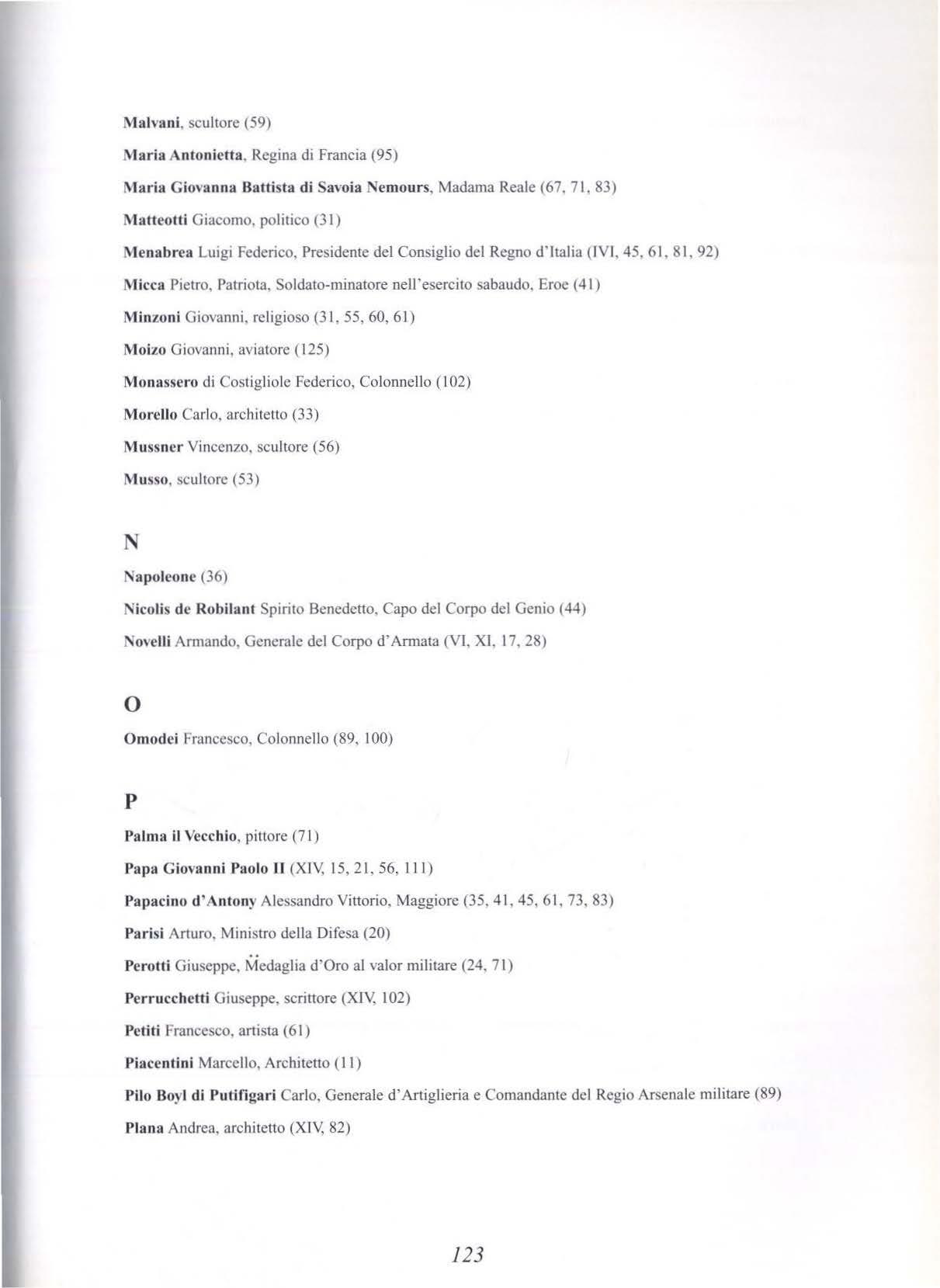
Mari a A nto ni ett a , Regina di Francia (95)
Mari a G io va nn a Ba tti sta di S a voi a Ne mours, Madama Reale (67. 71, 83)
M a tt eotti Giacomo, politico (31)
M e n a brea Luigi Federico, Presidente del Consiglio del Regno d'Italia ( l VI , 45, 61, 81, 92)
Mi cca Pietro, Patriota, Soldato-minatore nell'esercito sabaudo, Eroe (41)
Min zo ni Giovanni, religioso (31. 55, 60, 61)
Moi zo Giovanni, aviatore (125)
M o n a sse r o di Costiglio le Federico, Co lonnello (l 02)
MorcJJo Carlo, architetto (33)
Muss n c r Vinccn7.o, scultore (56)
Mu sso, scu ltore (53)
l'ia p o leo n e (36)
l'i ico li s d e R o bil a nt Spirito Benedetto, Capo del Corpo del Genio (44)
Nove lli Armando, Generale del Corpo d'Armata (VI, XI, 17, 28)
Omodc i Francesco, Colonnello (89, l 00)
Palm a il Vecc hio , pittore (71)
Papa Gi ovanni Paolo Il (XlV, 15, 21, 56. lll)
Papacino d ' Anton y Alessandro Vittorio, Maggiore (35, 41, 45, 61, 73, 83)
Pari si Arturo, Ministro della Difesa (20)
P c rotti Giuseppe, Medaglia d'Oro al val or militare (24. 71)
P e rruc ch c tti Giuseppe. scrittore (XlV, l 02)
Peti ti Francesco, artista (61 )
Pia ce nti n i Marcello, Architetto (Il)
Pilo Boy l di Putifig ari Carlo, Generale d'Artiglieria e Comandante del Regio Arsenale militare (89)
Plan a Andrea, architetto (X IV, 82)
Porcelli Nicola. Capitano ( 13)
RRi cotti Ma g nani Cesare, Maggiore (92)
Racchi Giovanni, Capitano (l 02)
Ricci Gaetano, Colonnello (l 02)
Sac h ero Ce lestino, Genera le (95)
Sa lu zzo di Mo n esig li o G i use pp e Ange lo, chimico (XIv, 44, 82, 89, 100)
aluzzo di Monesiglio Cesare, Genera le (
Sa n Giorgio (81)
San Martino (81)
Savoiroux Tancredi, Capitano, Conte (97)
S iacc i Francesco. Senatore del Regno, docen te all'Università di Torino e Napoli (45, 95)
Simo ni Gastone, Capitano (7, Il)
Sogno Rata de l Va ll ino Edgardo, conte, Medaglia d'Oro al Valor Militare, Ambasciatore (97)
Spi n ardi Paolo, Ministro (l 02)
Supin o Paolo, Generale ( 122, 124)
TTesta di Fe rr o (D uca Ema nu e le Filiber to d i Savoia (32)
Tose lli Pietro, Maggiore (96)
Umbe r to l , Re (39, 54)
Valturi o (76)
Vic h i Vasco, UITiciale c scrittore (X I)
Vittor io Amedeo II , Re (33, 41, 71, 81)
Vittorio Amedeo U, Re (2 4 , 35)
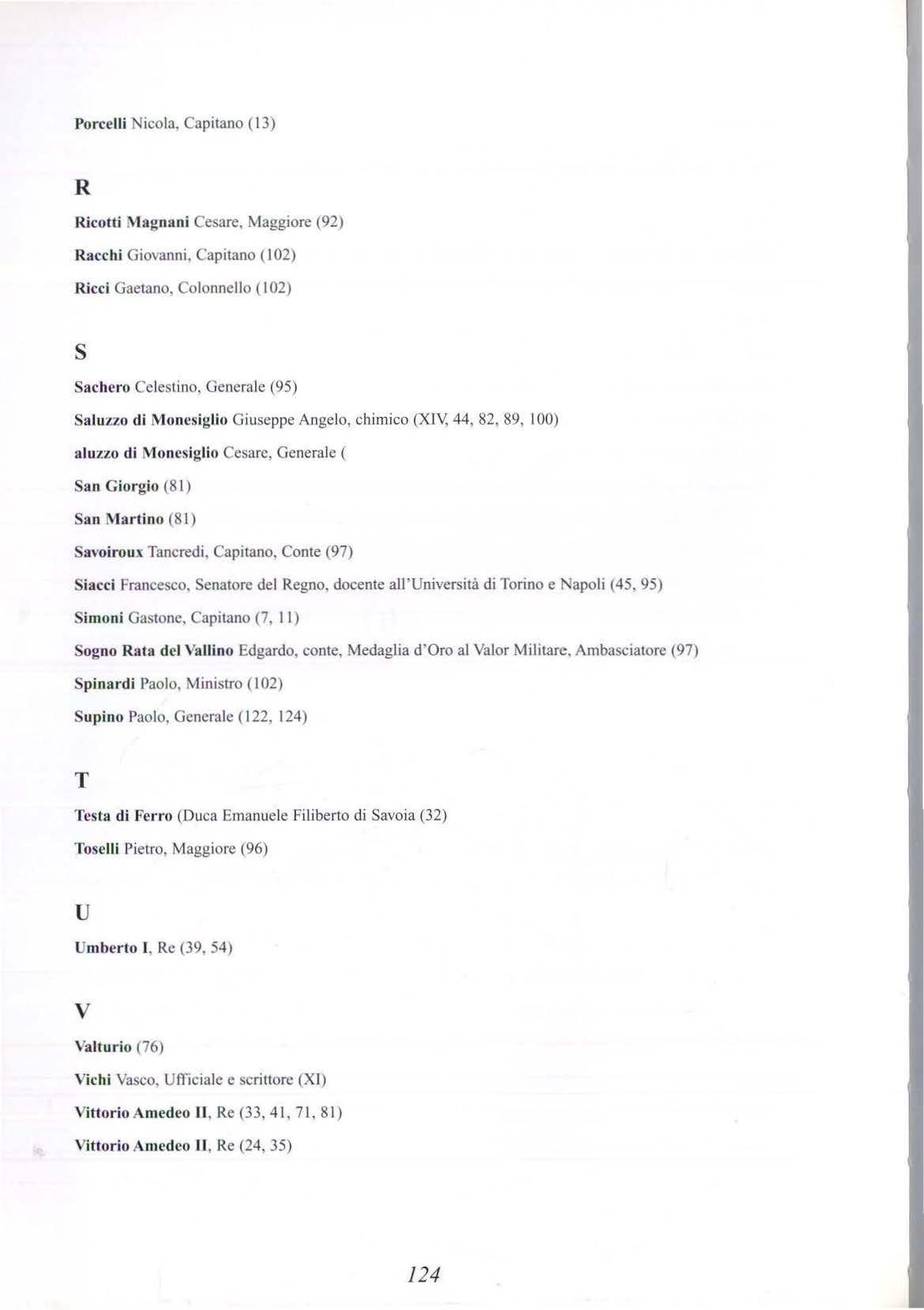
Vittorio Emanuele l , Re (36, 83)
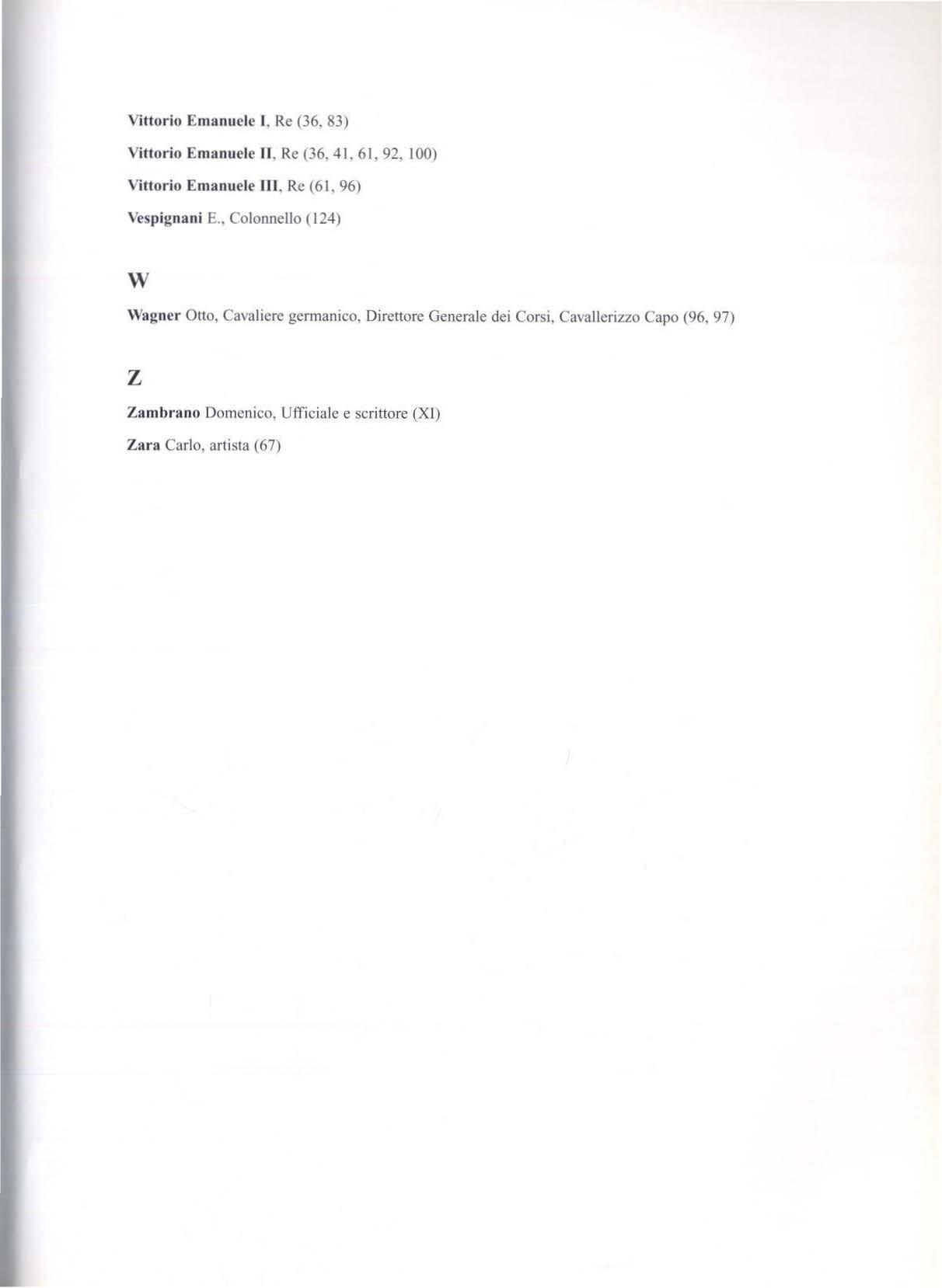
Vittorio E manu e le Il . Re (36, 41, 61, 92, 100)
Vittorio E m a nu ele III, Re (61, 96)
Vespignani E.• Colonnello ( 124)
wWagner Otlo, Cavaliere germanico. Direttore Generale dei Corsi, Cavalleriao Capo (96, 97)
Zambrano Domenico. Ufficiale e scr ittore (XI)
Zara Carlo, artista (67)
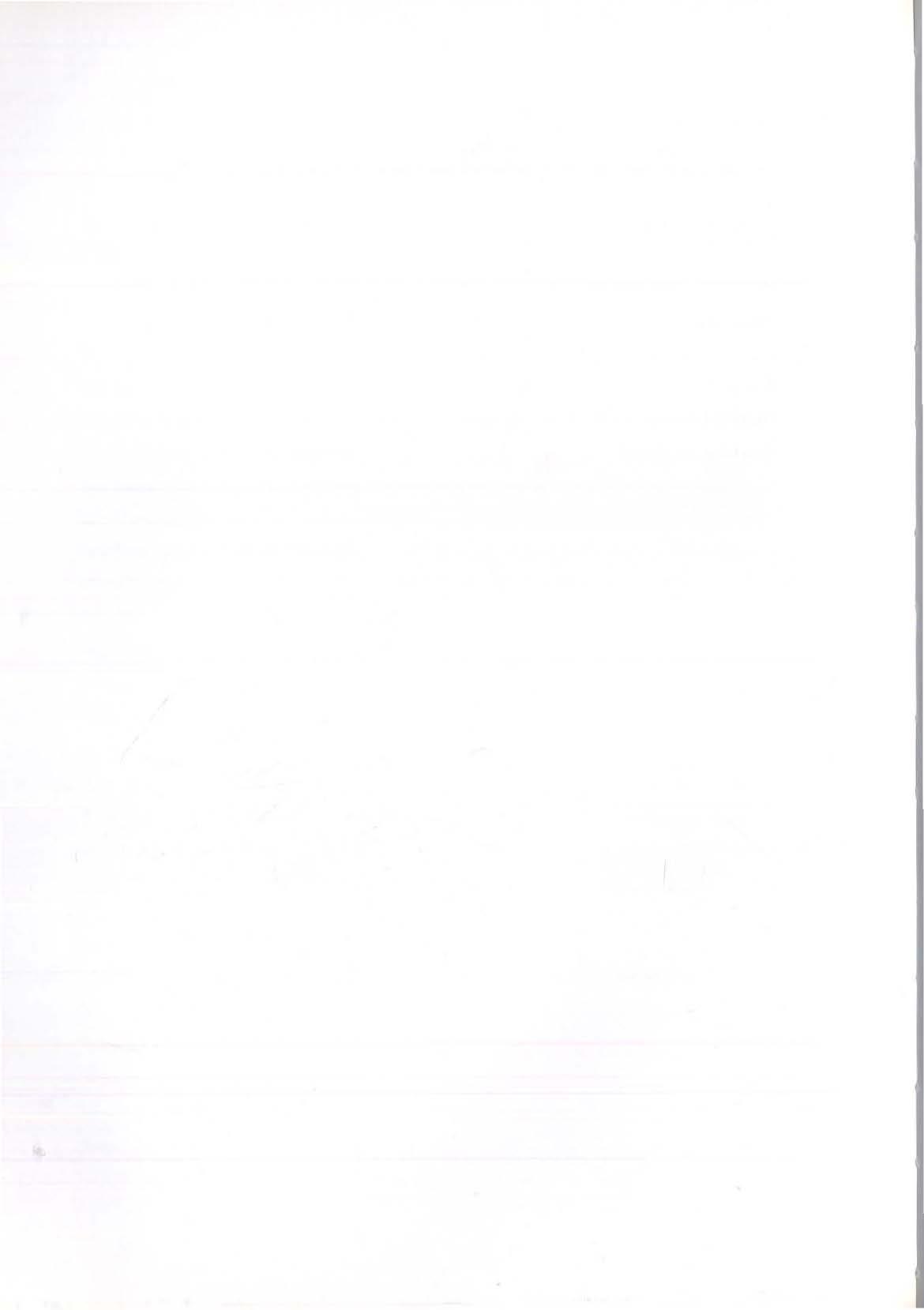
V. VICHI-D. ZAMBRA N O , La Scuo la di Applicazione, la storia e la sede, Tipolitografia della Scuola di Applicazione, Torino, 2003.
AA.VV. , L'Arsenale di Torino. 1570 - 1987 . Sede della Scuola di Applicazione, Scuola di App lica zio n e, Torino, 1987.
AA.VV ., Torino. La città, l 'a rt e e la sto ri a, G rib au d o, Torino, 1997.
M ABRATE , Torino città viva. Da capitale a metropoli: 1880-1980. Cento anni di vita cittadina. Politica , economia, società, cultura, Centro s tudi piemontes i , Torino , 1980 .
M . ABRATE , L' indu s tria side rurgica e meccanica in P iemonte dal 1831 al 1861, Museo Nazionale del R isorgimento, Torino , 1961.
ACCADEMIA DELLE SCIENZE , Do ssier, www.torinoscienza.it, 2006:

"La c himic a in Piemonte ", G. DT MODICA Le scuo le militari.
" L a geog rafia in Piemonte" , P. SERENO , Le Scuole Teoriche e Pratiche d'Artiglieria.
V. DE ALFARO , Gli st udi di fisica a Torino
" L e istituzioni della ricerca ", V. FERRONE , L'innovaz ione tecnologica e l'industria militare alla fine del Settecento
L. A DAMI , Cenni storici intorno alla Fonderia di Artiglieria di Torino, Litografia della Real Fo n deria, To rino , 1885.
S. AM BROGIO , La Scuola di Applicazione di Torino. Cenn i s t o ri ci dalle o ri gini ( 1739) ai giorni nostri, Scuola di Applicazione, Torino, 1995.
G. AMORETTI- V.BORASI , L'A rsenale di Torino nella storia e ne ll a cu ltura eu ropea.
G . AMORETTI , TI Ducato di Savoia dal J559 al 1713, Famija Turinèisa, 1988.
G. AM ORETTI , L'Arsenale di Torino 1570-198 1 Note sto ri che,Tipolitografia d e lla Scuola di Applicazion e, 1981.
ARCHIVIO DI STATO - Sezioni Riunit e, Ca rt e a nti che di artiglieria, vol. !.
G. ARPINO-A . ROBERTO , Torino altrui. Notazio ni , giudizi, ricordi di forestieri su Torino, Dani e la P iazza Edi t ore, 1990.
A.BALLO , Torino barocca , Le a, R oma, 1965.
P.L . BA SS I GNANA, Il Regio Arsenale di Torino nel '700: lavoro e tecnica, Associazione industriali metallurgici, meccanici e affini (A.M.M.A.), Torino, 1981.
M. B ERNA RDI , Piemonte eroico. Da Verrua all'Assietta. Rattero, Torino. 1940.
C. BRA JDA, L. C OLI , D SES I A, Ingegneri ed architetti del Sei e Settecento in Piemonte, in "Atti c rassegna tecnica degli ingegneri ed architetti di Torino", anno XVll, n ° 3, Torino, 1963.

J. BR UNET , Histoire générale de l'artillerie, Paris, Imprimcric militairc de GaultierLaguionie, 1842.
V BO RASI , Filippo Ju varra, ingegnere militare sabaudo, ali 'Arsenale di Torino, in
V. C OMOLI MANDRACCI , "Itinerari juvarriani", Celid, Torino, 1995.
L. C IBRA RIO , Storia del la monarchia di Savoia. Fontana, Torino, 1840.
L. C IBR A RlO , Storia di Torino , Fontana, Torino, 1846.
F. COGNASSO , Storia di Torino, Giunti Martello, Firenze , 1978
V. COMOL I MANDRACCI , Torino, Laterza, Bari. 1983.
M. DIMARTJ O , TI Museo Storico dell'Arma di Cavalleria, Torino, 1990.
A. FARA , La metropoli difesa. Architettura militare dell'800 nelle capitali d'Italia, Stato Maggiore de li 'Esercito, Ufficio Storico. Roma, 1985.
V. F E RRO NE, La nuova Atlantide e i lumi. Scienza e politica nel Pi emonte di Vittorio Amedeo 111, Mcynicr, Torino, 1988.
G. GALLEANJ D 'AGLIANO , Memorie storiche sulla guerra del Piemonte 17411747 , Stamperia Reale, Torino, 1840.
D. GARBARINO , Dal nul la il miracolo economico. Storia moderna dell'industria torinese, edizioni G. M. Torino, Torino, 1962.
E. GIANERl GEC , Storia di Torino industriale. I l miracolo della Ceronda, editrice Piemonte in bancarella, Torino, 1994.
G. GRJTELLA , Juvarra. L'architettura , Franco Cosimo Panini, Modena, 1992
A. MANNO , Sull'assedio di To rin o nel 1706, in "Miscellanea di s toria italiana", vol.XIX. Paravia, Torino, 1883
L. MA Zl , Dalle Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortificazione alla Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio,(l6 aprile 1739-16 apri le 1939 ),
Vincenzo Bomìna, Torino , 1939
r.. C . MONT U', Storia dell 'A rtiglieria italiana, R ivista di Artiglieria, Roma, 1945.
E. OLIVERO , li Regio Arsenale di Torino ed il suo architetto Antonio Felice De Vincenti, in Bollettino storico- bibliografico Subalpino, S.A.T.E.T., Torino, 1942.
M. PA SSANT I , Architettura in Piemonte da Emanuele Filiberto all'Unità d'Italia ( 1563-1870), Giorgio, Torino, 1945.
F.P I NELLI , Storia militare del Piemonte, Degiorgi s, Torino, 1854.
C. PROMIS , Biografie di ingegneri militari italiani dal XTV alla metà del XVlll, in "Miscellanea di storia italiana", Torino, 1874.

G. Q UAZZA , Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento, Soc. Tip. Modenese, Modena, 1957.
R. R ENZ I , l l Regio Arsenale di Torino: il suo contributo al progresso tecnologico di Torino e le sue macchine, in "Atti degli ingegneri ed architetti di Torino", anno XL, n °
9- l O. Torino, 1986.
F. L. ROCI E R , La Regia Accademia di Torino, Vincenzo Bona, Torino, 19 l 6.
P. SERENO , "Lì Ingegneri Topografici di Sua Maestà". La formazione del cartografo militare negli Stati sabaudi e l'istituzione dell'Ufficio di Topografia Reale , in
R.COMBA - P. SERENO , "Rappresentare uno Stato. Carte c cartografi degli Stati sabaudi dal XV I al XVIII secolo". Allemandi. Torino, 2002.
M.C . SQUECCO, li Regio Arsenale di Torino, fucina di armi e di uomini, Torino, 2001.
E.TESAURO , llistoria dell'Augusta Città di T orino, Zappata, Torino, 1679.
Theatrum Sabaudiae, 1682, edizione a cura di Luigi Firpo, Archivio Storico della Città, Torino, 1984- 1985.
A.VACCA MACCIOLINI , L e guerre nei secoli XV TTT e X TX, Sc hi oppo, Torino , 1922.
Do c umenti
-Archivio di Stato di Torino (Sez. I V: Artiglieria): documenti vari.
- Scuola di Applicaz ione, documenti relativi a:
* Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artig l ieria e Fortificazione , periodo dal 1739 al 1819 ;
*Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio, periodo dal 1819 al 1943;
* Scuole di Applicazione d'Arma:
*annuari del periodo dal 1950 al 1975:
* memorie storiche degli anni dal 1950 al 1975;
* registri dei voti. programmi delle attività didattiche e addestrative ed altri documenti r e lati vi al periodo suddetto.
- Scuola Militare di Equitazione e Scuola di Applicazione di Cavalleria, periodo dal 1823 al 1943;
- Scuola Normale di Fanteria e Scuola di Applicazione di Fanteria, periodo dal 1849 al 1943;
- Scuola di Applicazione, periodo dal 1976 al 2002;
- Scuola di Applicazione e I stituto di Studi militari dell'Esercito, periodo dal 2003 al 2006.