




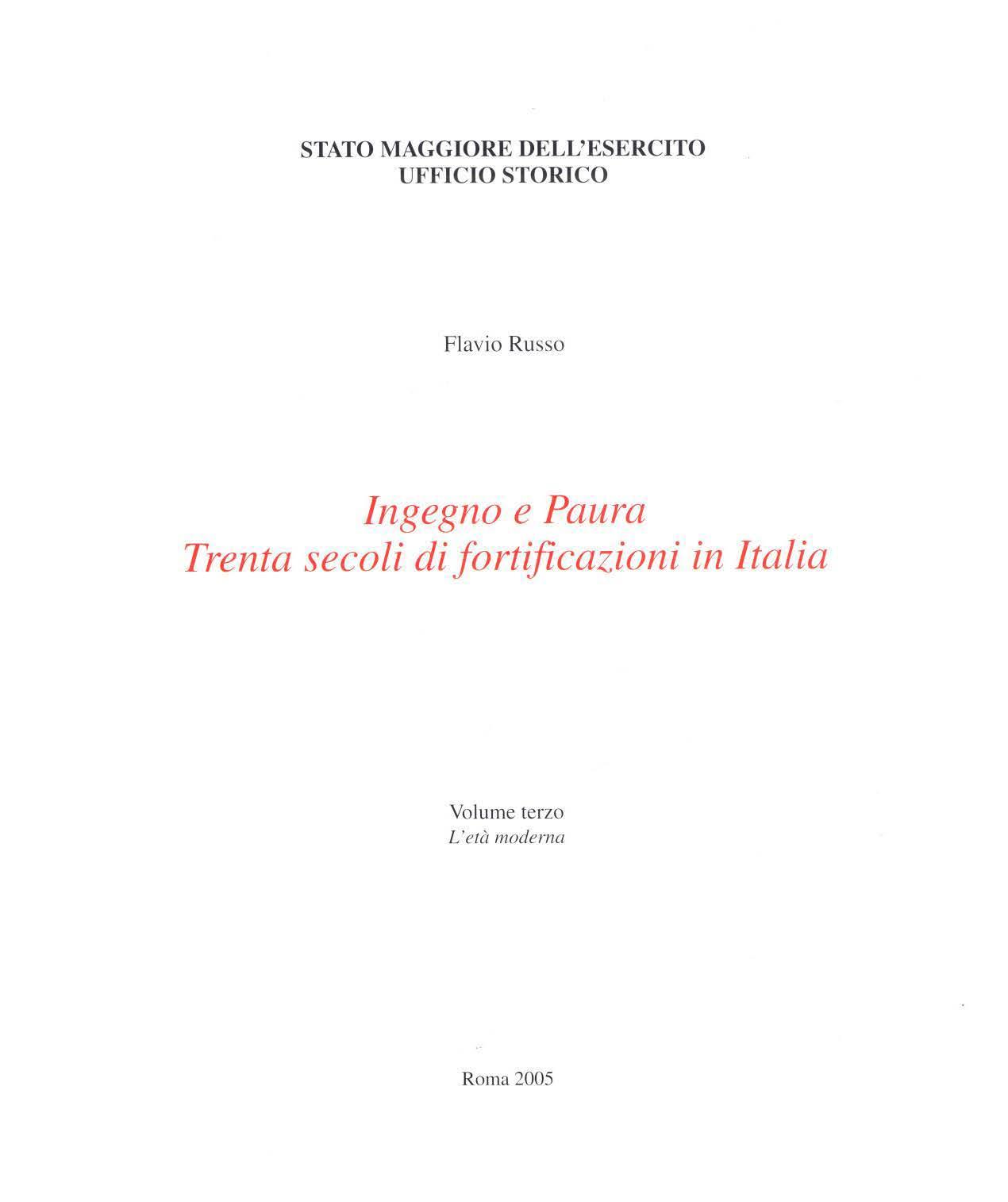
PROPRIETÀ LETfERARTA
Tutti i dir itti riservati Vietala anche la riproduzione parz iale senza auto ri zzazione
© Ufficio Storico SME - Roma 2005
Co di ce ISBN: 88 -879 40 -64-9 N. ca t. 6702
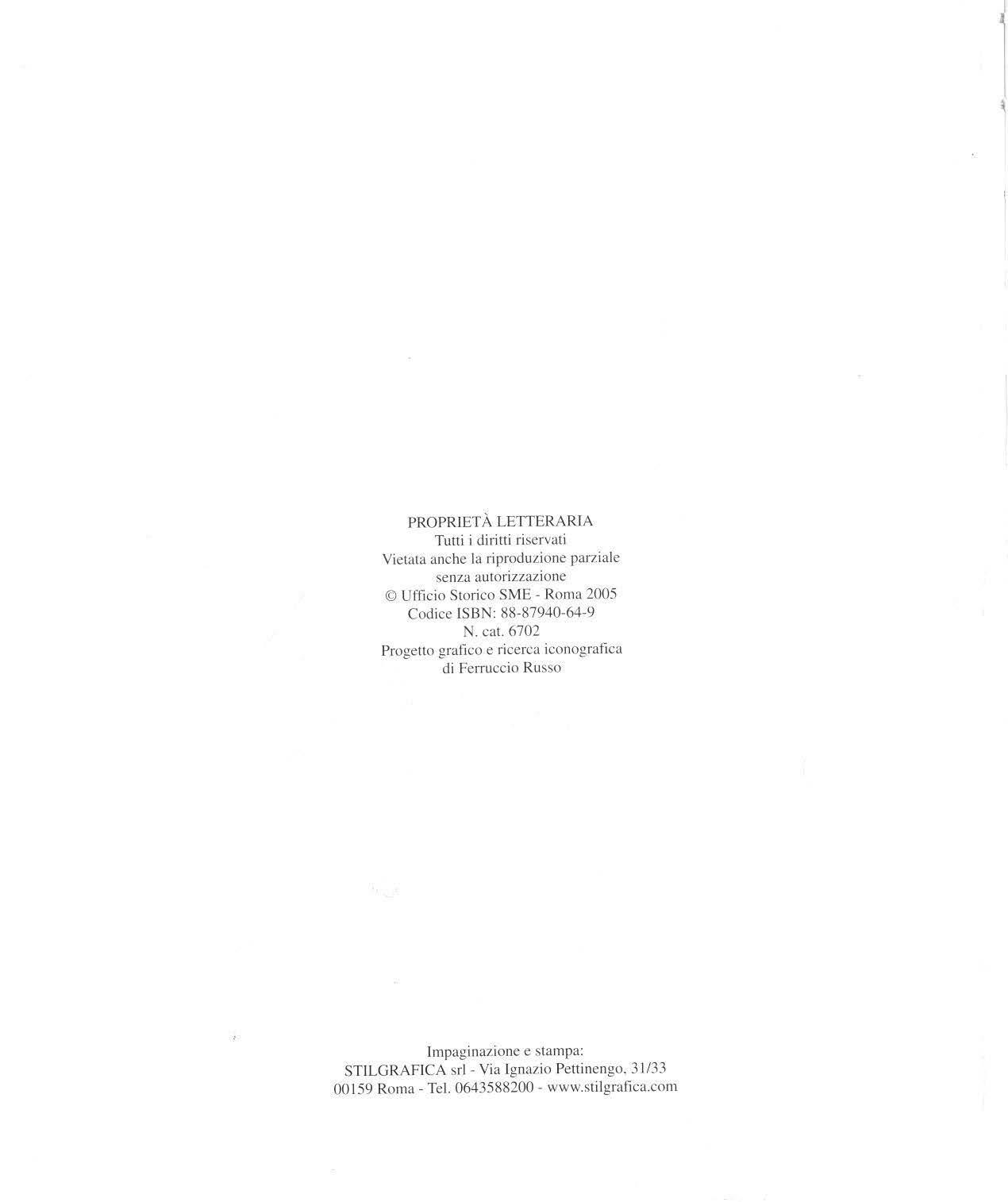
Progetto grafico e ricerca iconografica di Ferruccio Ru sso
Im paginazione e sta mp a: STILGRAFJCA srl - Via Ig n az io Pe ttin e ngo. 31/33 00159 Roma - Tcl. 0643588200 - www .st ilgrafi ca.com
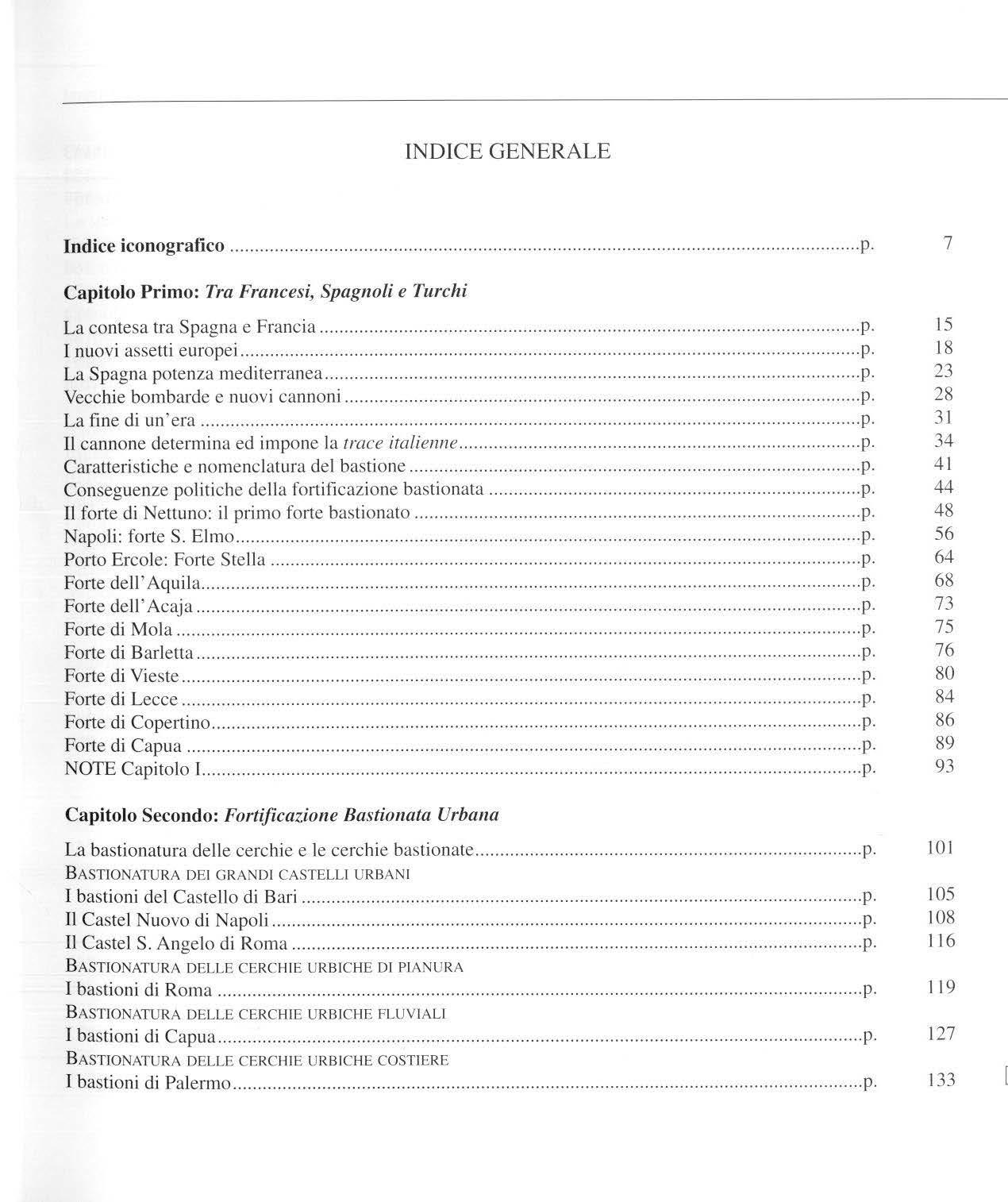
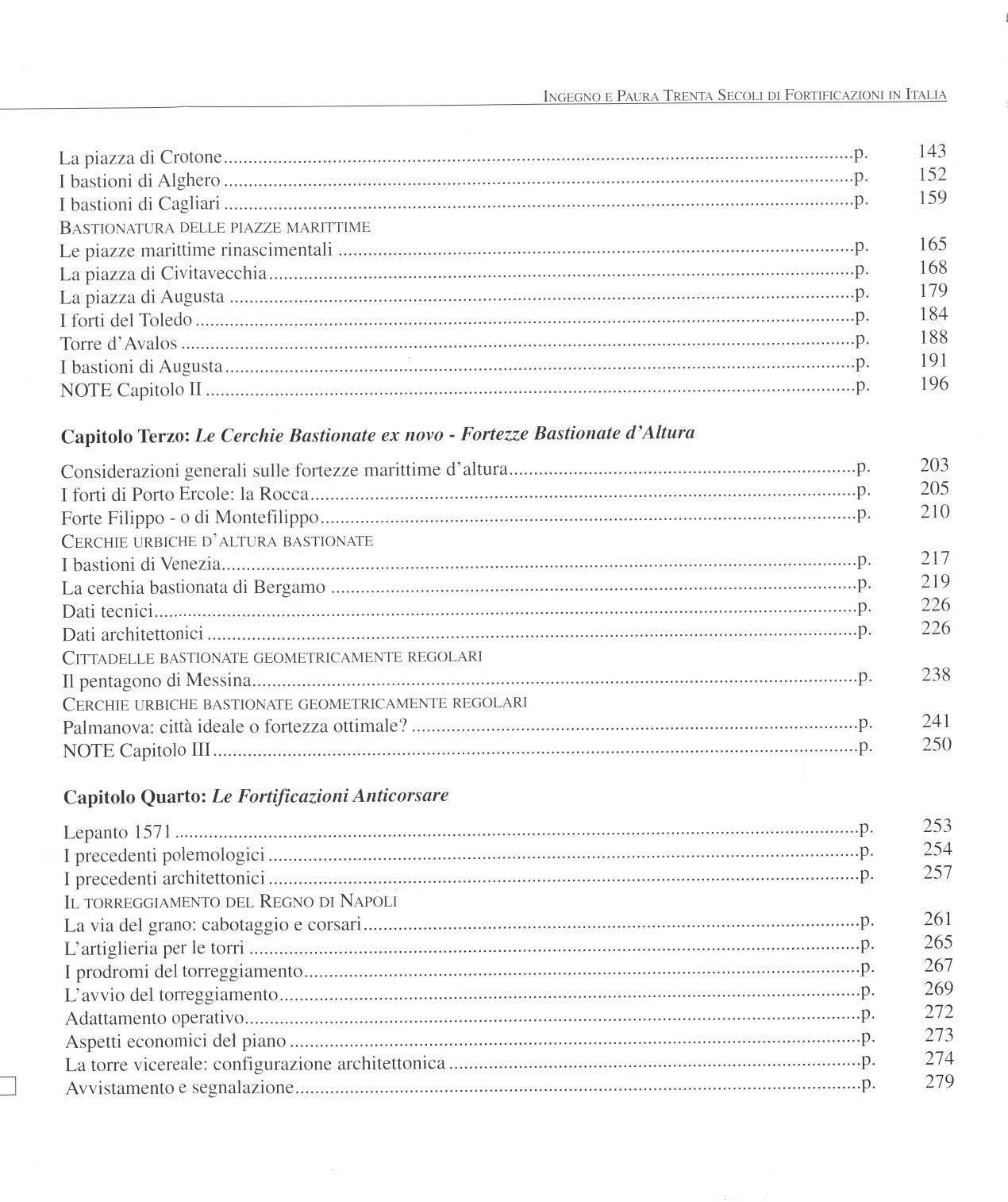
DELLO STATO PO NTIFIC IO
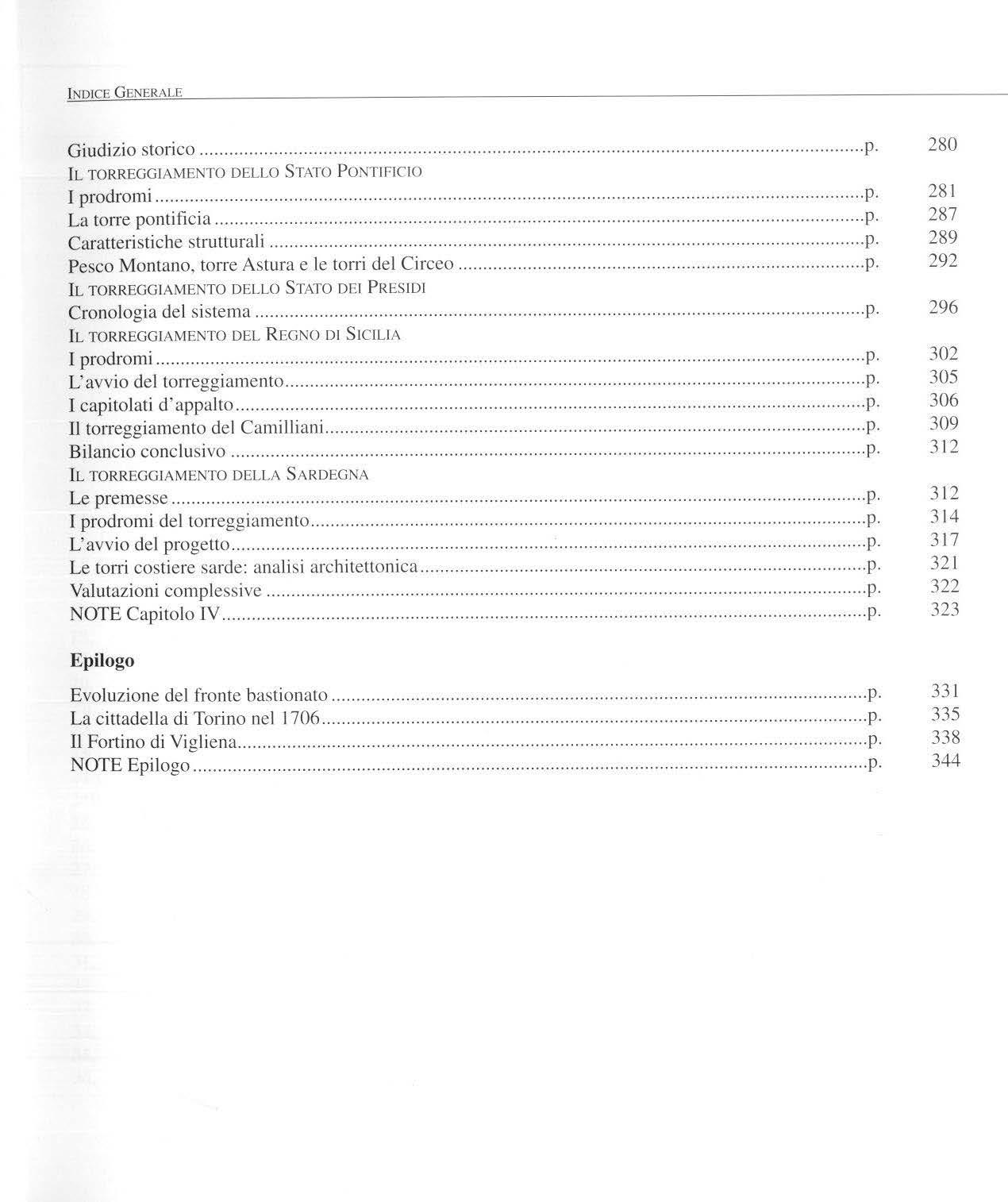
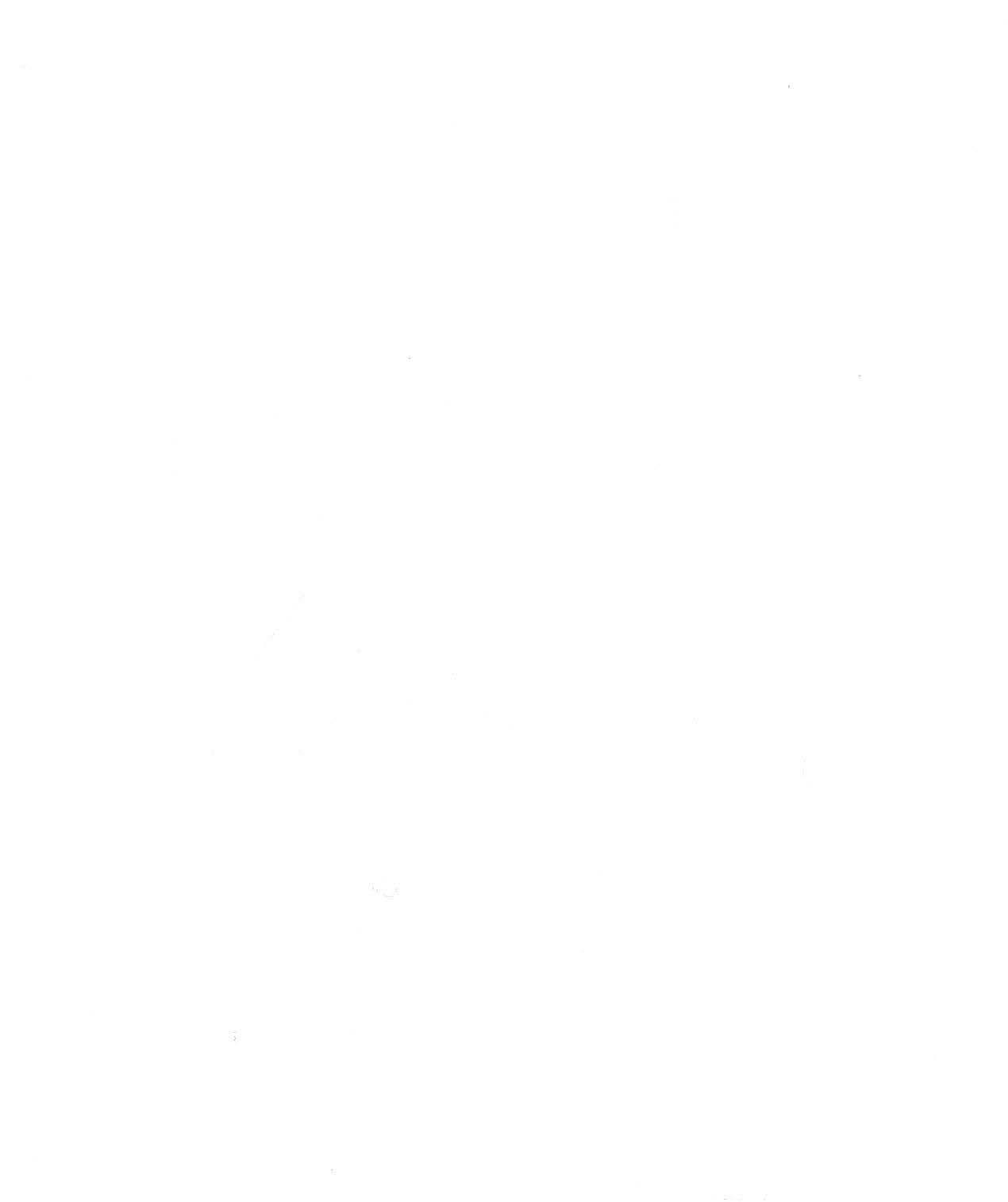
Portolano del Mediterraneo del XIV sec p.
R egno di Napoli, Atlante Manoscritto di Mario Carrara (1613) p.
Carta della Sicilia, fine sec. XV I, di Tiburio Spannocchi p.
Carta della Sardegna , 1577, di Rocco Capellino ........................................................................ p.
Carta dello Stato dei Presidi, seconda metà del XVI sec p.

Rom a, Castel Sant ' Angelo ....... ....... ... ........................................................................................ p.
Roma, Castel Sant ' Angelo, passetto .......................................................................................... p.
Tunisi stampa raffigurante l'assedio del l 574 ............................................................................ p.
Ischia scoglio di Gerone, cittadella aragonese ........................................................................... p.
Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, 48 r-a r-b, schizzi di fortificazioni .. ............................... p.
Francesco di Giorgio Martini, f. 60 tav. 257,forte zz a su poggio o su pianura .......................... p.
Schizzo del Taccola, rappresentante una fortezza fatta saltare con una mina ............................ p.
Scorcio del Castel Nuovo, Napoli ............. .. ............................................................................... p.
Grafico settori defilati . .. ...... .. .... ....................... .. .. .. .. .. .... ............................................................ p.
Caratteristiche e nomenclatura fondamentale del bastione ........................................................ p.
Schema dimostrativo della evoluzione castellologica ................................................................ p.
Veduta aerea di città bastionata: Bourtange , Olanda .................................................................. p.
Veduta aerea della città di Lu cca ................................................................................................ p.
Planim etria forte di Nettuno, B.A.Y., Chigi E III 66, 624-625 p.
Nettuno: planimetria e sezione attuali del forte . (Cenciarini-Giaccaglia) .................................. p.
Forte di Nettuno visto daJl'alto p.
Forte di Nettuno vista da terra p.
Forte di Nettuno, dettaglio spigolo rotondo del bastione p.
Marocco, Fez, il forte p.
Florida, forte Sant' Agostino, foto anni '30 p.
Scorcio fortificazione medievale di Nettuno .............................................................................. p.
Napoli, forte di Sant'Elmo, scorcio p.
Napoli, forte di Sant'Elmo, dettaglio spigolo di un puntone .. .. ...... .. ............ ..................... ... ..... p.
Napoli, corografia del forte di Sant'Elmo, fondo Konig Neapels, K.AV, Vienna ....................... p.
Napoli, forte cli Sant'Elmo, scorc io puntone .............................................................................. p.
Napoli, forte di Sant'Elmo, scorcio cannoniere basse ............................................................... p.
Napoli, forte di Sant'Elmo, KAV, Pianta piano terra ................................................................. p.
Napoli, forte di Sant ' Elmo , KAV, Pianta primo piano ............................................................... p.
Napoli, forte di Sant'Elmo, KAV, Pianta secondo piano ............................................................ p.
Napoli, forte di Sant'Elmo, KAV, Pi a nta terzo piano ................................................................. p.
Napoli , forte di Sant'Elmo, KAV, Sezìone p.
Napoli, forte di Sant'Elmo, KAV, altra Sezione .................... . .................................................... p.
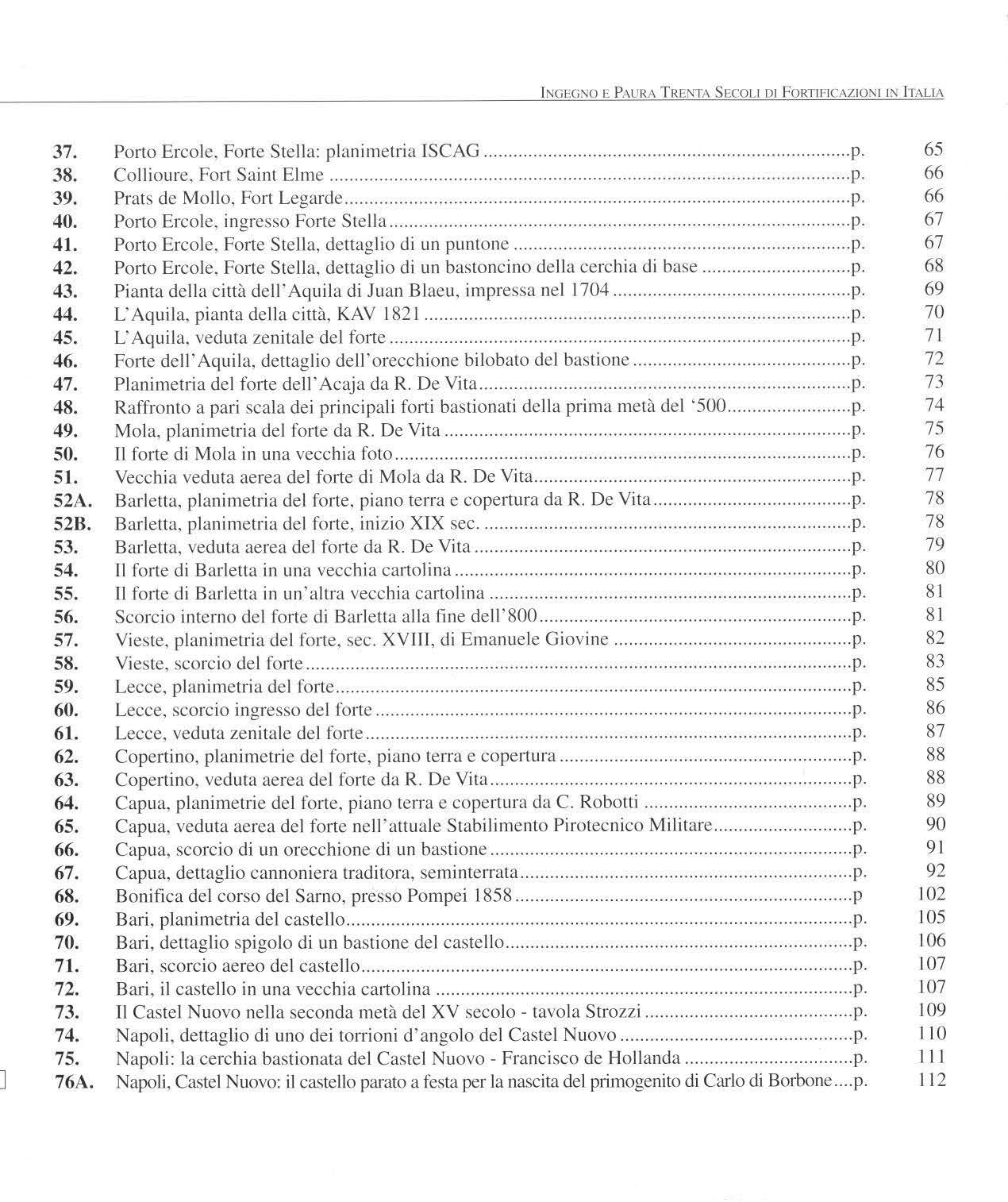
Napoli, Castel Nuovo: il castello nel I 860 ................................................................................. p.
Napoli , planimetria del Castel Nuovo con la cerchia bastionata, KAV, 1821 p.
Dettaglio planimetria cerchia Castel Nuovo, KAV p.
Dettaglio planimetria cerchia del Castel Nuovo, KAV .............................................................. p.
Dettaglio planimetria cerchia del Castel Nuovo, KAV .............................................................. p.
Dettaglio planimetria cerchia del Castel Nuovo, KAV .............................................................. p.
Molo angioino, rilievo KAV ....................................................................................................... p.
Roma , Castel S. Angelo all'interno della cerchia bastionata, in stampa di Giovan Battista Falda, 1676 ................................................................................................... p.
Roma, planimetria di Castel S. Angelo e della sua cerchia bastionata, in una stampa del 1777 ............................................................................................................... p.
Affreschi del Palazzo Vaticano: la cerchia bastionata del Vaticano e sullo sfondo
quella di Castel S. Angelo .......................................................................................................... p.
Roma, bastione del Sangallo in un'antica srampa p.
Roma, planimetria del bastione del Sangallo p.
Roma, veduta aerea del bastione del Sangallo ........................................................................... p.
Roma: dettaglio bastione presso Porta Pertusa p.
Roma, un ' antica stampa di Porta Pertusa p.
Roma, pianta delle mura gianicolensi del 1777 p.
Roma, planimetria dei bastioni nei pressi di porta S. Pancrazio: Giovan Battista Falda, 1676 p.
Capua, veduta aerea della cerchia bastionata ............................................................................. p.
Capua, rilievi planimetrici della piazza p.
Capua, rilievi planimetrici della piazza ...................................................................................... p.
Capua, rilievi planimetrici della piazza ...................................................................................... p.
Capua, rilievi planimetrici della piazza ...................................................................................... p.
Capua , il ponte di Porta Napoli .................................................................................................. p.
Capua, veduta laterale del ponte di Porta Napoli sul fossato ..................................................... p.
Capua , cannone su affusto da difesa sec. XIX ........................................................................... p.
Palermo, planimetria della cerchia bastionata. Carte Montemar, A.S.N .................................... p.
Palermo, assonometria del castello di F. Negro ......................................................................... p.
Palermo, veduta aerea di Porta Nuova ....................................................................................... p.
Palermo , scorcio di Porta Nuova ................................................................................................ p.
Palermo, scorcio di un bastione nei pressi del Palazzo Reale .................................................... p.
Palermo , Porta Felice .................. ........................ . ... . ...... ............................................................ p.
Palermo, Porta Garibaldi .................................................. .............................. . ............... ............ p.
Palermo, un bastione trasformato in civile abitazione p.
Planimetria e sezione bastione dello Spasimo ............................................................................ p.
Sezione cortine laterali al bastione dello Spasimo p.
Planimetria e sezione delle contro-mine p.
Pianta e sezione delle cannoniere p.
Crotone: una delle torri del castello p.
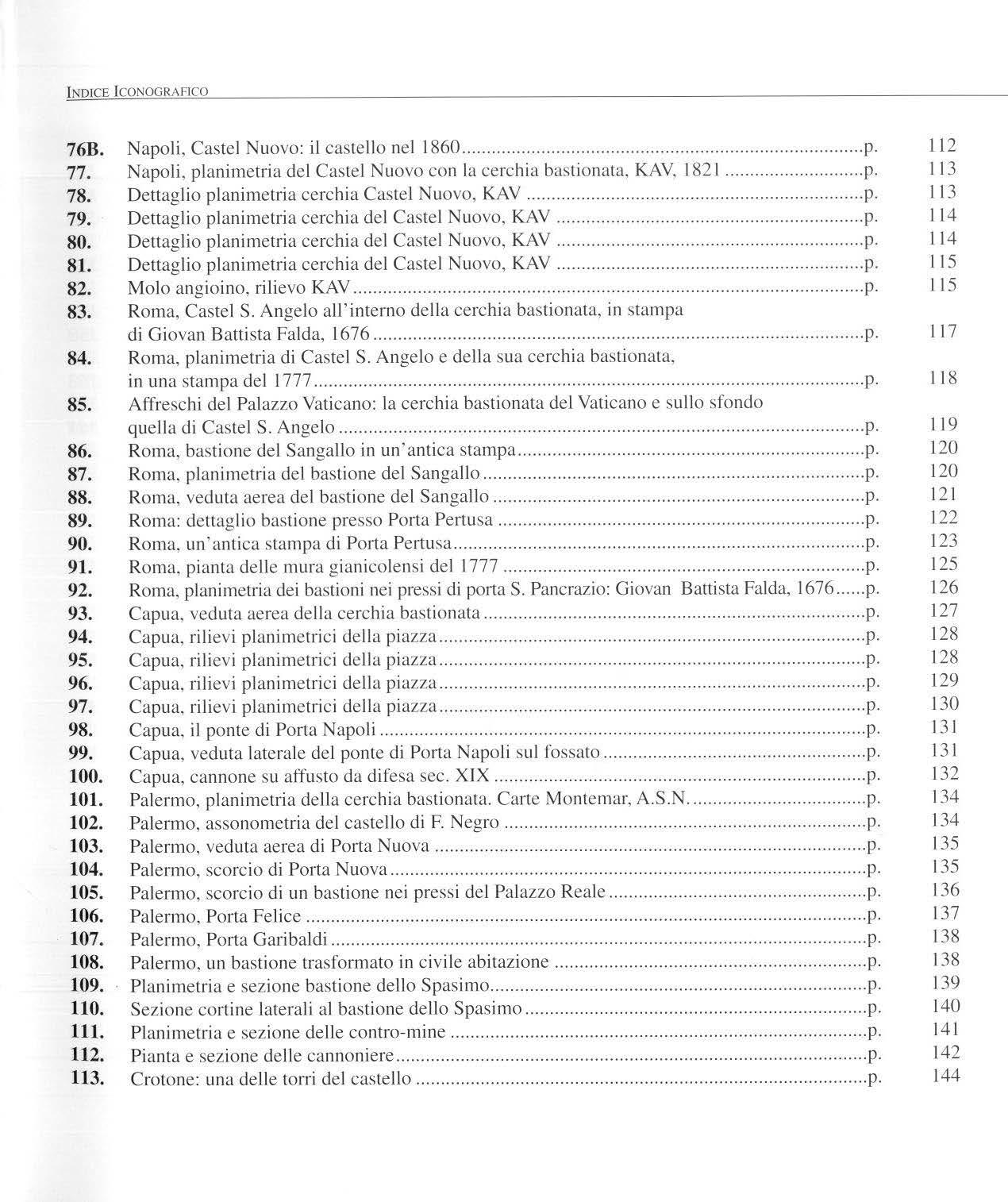
plan im etri a de ll a piazza, autore ignoto sec . XV
rilievo del 1807 della piazza
di barca corallina
torre dell'Esperò ...........................................................................................................
ved uta zen itale : nel cerchio la torre dell' Esperò
l ghero, progetti di R occo Capell in o
dettaglio delle fortificazioni del fronte a mare
dettaglio dell o sp i golo di un bastione ....
scorc io mura fronte a m are
la vertiginosa torre di S. Pancrazio
a ri, progetto di Rocco Capellino
, l 'orecc hi o ne de l bastione del L eone e l'omo nim a porta
scorcio di un bastione
i, progetto del Fratin per l' ottimizzazione delle fortificazioni bastionate
scorcio delle residue tratte della murazione medievale
Modello di galera del XV I sec . co n le vele spiegate
Modello d i galera del XVI sec. con le ve le serrate
la fo rtezza del B ramante .. .........
Civitavecchia, dettaglio torrione d'angolo della fortezza p.
Civitavecchia, scorc i o del varco della darsena p.
Civ i tavecchia, sco rc io delle antiche mura della darsena p
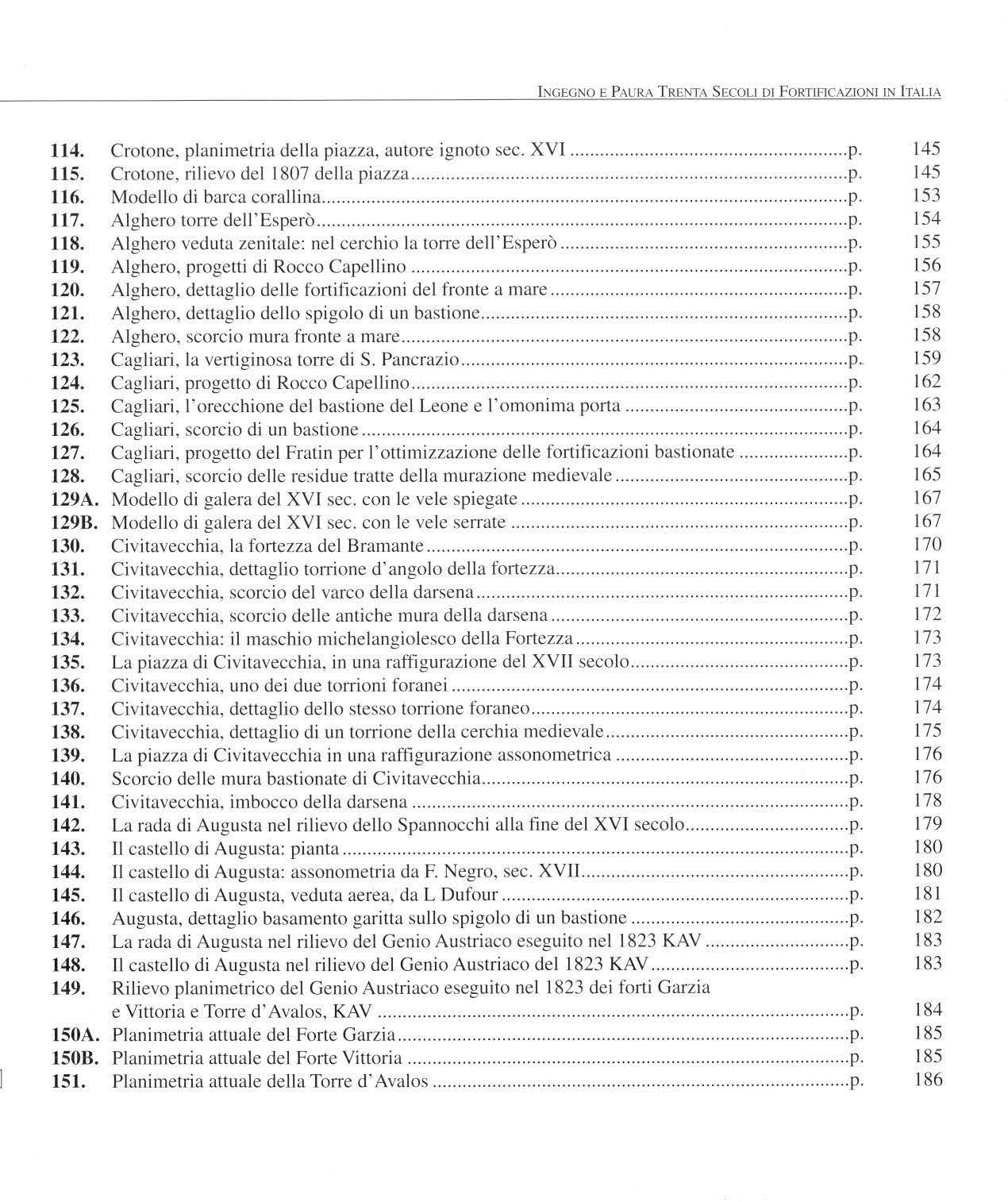
Civitavecchia: il maschio mic hela ngio lesco della Fortezza p.
L a piazza di Civitavecchia, in una raffiguraz i one del XV II secolo
Civitavecchia, uno dei d ue torrioni foranei p
Civitavecchia, dettaglio dello s tesso torrione fora neo
Civitavecchia, dettaglio di un torrione della cerch ia medieval e
L a piazza di Civitavecchia in un a raffigurazio ne assonometrica p.
Scorcio delle mura bastionate di Civitavecchia..... ... .... ....... .... .... .......
Civitavecchia, imbocco della darsena ........................................................................................ p.
La rada di A ugus ta nel rili evo dello Spannocchi a ll a fine de l XVI secolo ...................... ... ... .... .p.
Il castello di Augusta: pianta ..... . ... .... ... .. ... ......... . .... .... .... ....... .... ... .. ....... ........ ....... .. .. .... ... .......... p.
li castello di Augusta: assonometria da F. Negro, sec. XVII ............... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... ....... ...... p.
li cas tello di Augusta, ved uta aerea, da L Dufour ... .... ....... .... ....... .. ...... ..... .................... ...... .... .. p.
Augus ta, dettaglio basamento ga ritta s ullo spi go l o di un bastione .......
L a rada di Augusta nel ril ievo del Genio Austriaco eseguito nel 1823 KAV
Il castello di Augusta ne l rilievo ciel G enio Austriaco del 1823 KAV ..
Rilievo planimetrico ciel Genio Austriaco eseguito nel 1823 dei fo rt i Garzia
sotto un a lt ro angolo
d' Avalos, fronte verso il mare ape rt
ToITe di Magnisi , ved uta ae rea ..............
assonometria del 1682, stato avanzamento dei l avori

Scorcio di un bast ion e della piazza di Augusta
Il caste ll o visto dal ponte di accesso alla piazza di Augusta ............................... .. ........... .......... p.
P o rto Ercole, planimetria della Rocca, sec. XVIll , ISCAG ............... ... ................. .. ...... .. .... .. .... p.
P o rt o Ercole, l a Rocca .............. ... ... .. .. .... ... ............................. ....... .... .... ....... ......................... .. .. .p.
Port o Ercole , ord in e multiplo dei bastioni .... .. . .. ....... ................................. .................... ............ p.
P orto Ercole, la Rocca, sco rcio laterale ...................................................................................... p.
P orto Ercole , l a R occa, innesto bastioni ............................ ................. .... . .. ...... ..................... .. .. .. p .
Porto Ercole , l a Ro cca, bastioni su l mare p
P orto Ercole, l a Rocca, bas ti oni sul mare ................................................................................... p.
Porto Ercole, fo rte F il ippo, planimetria, sec. XVI II , JSCAG p.
Porto Ercole, forte Filippo, sezione sec. XVIII, ISCAG p.
Porto Ercole, forte F il ip po, panoramica p.
Po rto Ercole, forte Filippo, scorcio bastioni p.
P orto Ercole, fo rt e F ilipp o , dettaglio fianco non rientrante di un bastione .. ............................. .p.
P orto Ercole, forte Filipp o, dettaglio ponte p.
P orto Erco l e, forte Filippo , muro di controscarpa .............. ...... .. .... ..... ...................... ... ...... .. .... .. p.
P orto Erco l e , fo rt e Filippo, fossato e muro d i controscarpa...... .. .. .. .. .. ... .. .. .. ...... ................ ........ p.
B ergamo , mura venez ian e del 1561-1588 .. ...... .... .... ....... .. .. ......................... .. .... .... .... ....... ......... p.
Be rga m o, mura veneziane, disegno storico altimetr ico ....... .. .. ... .. .. .. .. . .... ............... ............... ... .. p.
B ergamo, le mura viste dal lato Sud-Ovest della città .............. ........................... ............. ......... p.
B ergamo, le mura v iste dal l ato Sud-Est della città ................. ......................... ............... ..... ..... p.
Berga mo, mu ra venez ia ne , posizione delle canno ni ere nei mura g li oni ..................................... p.
B ergamo , mura ve ne ziane , porta e cannoniera de l bastione S. L o re nzo ............ ................. ....... p.
Bergamo, corti na d e lla Fara e orecc hion e de l bastione S. Lo renzo ....... .. ... .. .. .. .. ............ ........... p .
Berga mo , mura veneziane, ca nnoni era e sortita nel bastione S. L orenzo ................. ................ . p.
Bergamo, mura ve neziane, interno della cannoniera del S. Lore nzo .. . .............. .............. .......... p.
Berg amo, ved ut a de lla ca nnoniera doppia ne lla cortina de ll a Fara ............................................ p.
B e rg amo, bastione della Fara co n inglobato l'acquedotto del 1200 .......................................... p.
Be rga mo , int e rno della can noni era doppia nella cort ina della Fara p.
B e rgamo, interno della cannoniera doppia nella cort in a della Fara .... ................. .. .. ... ............. .. p.
B e rgamo, mura venezia ne , cannoniera ne l bastione S. Agost ino ............................................... p.
B e rga m o , mura veneziane , interno della ca nn oniera d e l bast io ne S. Agostino p.
Bergamo, mura ve neziane, porta S. Agostino p
Bergamo, galleria di accesso della ca nn o ni era del bastio ne S. Mi che le p.
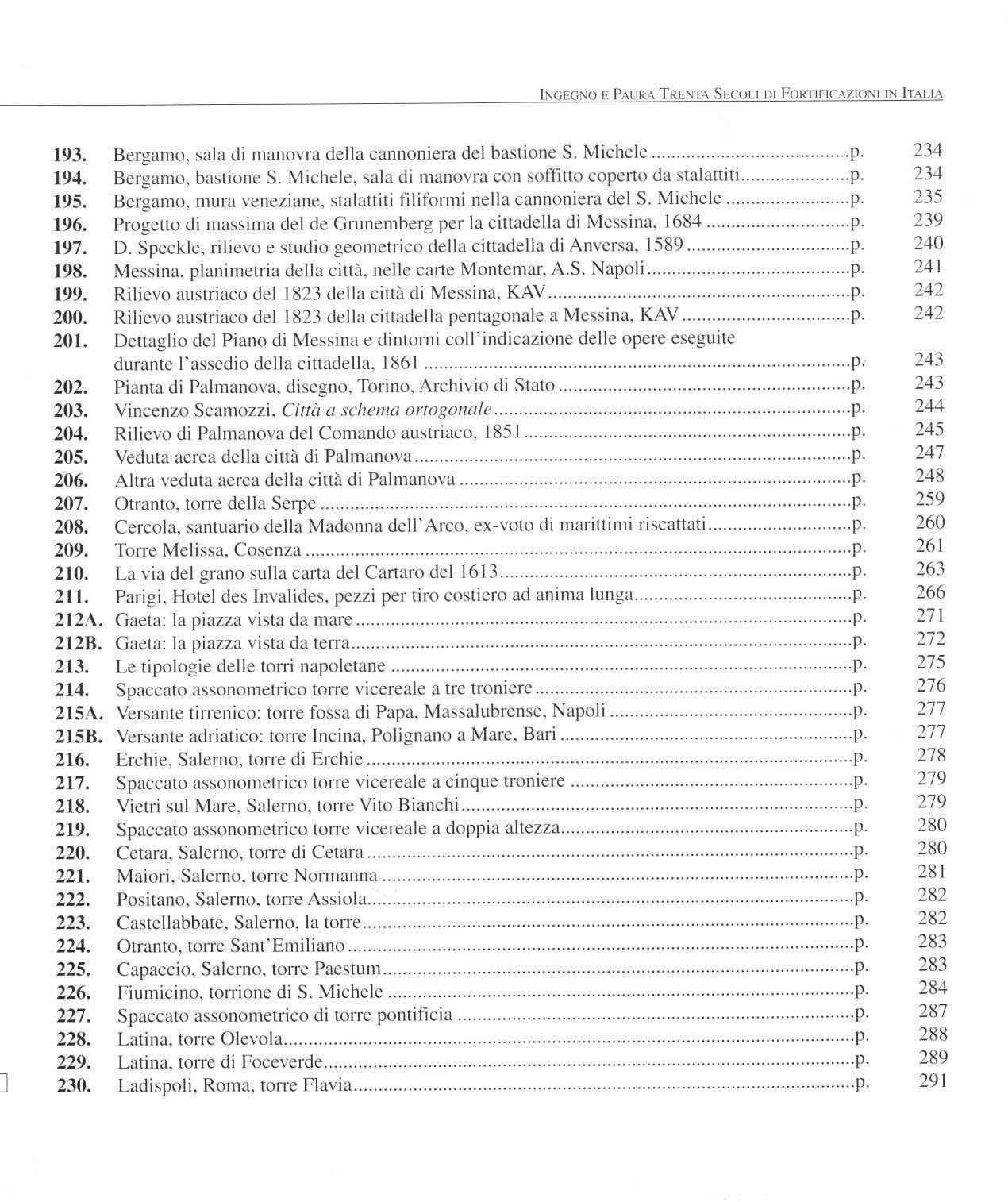
Civitavecchia , to1Te di Montalto di Castro p.
Terracina, Latina, Pesco Montano p.

Latina, to1Te Astura ..................................................................................................................... p.
Monte Argentario, torre delle Cannelle p.
To1Te dell'Avvoltoio e torre della Ciana , ISCAG, FT/18 B 1283 p.
Torre di Calapiatti, ISCAG , FT/18 A 1242 p.
Forte di Santo Stefano, JSCAG, FOl 2/8 807 p.
Porto Santo Stefano, Fortezza Spagnola o Forte di Santo Stefano ............................................. p.
Pozzallo, Agrigento, veduta aerea della to1Te di epoca normanna p.
Pozzallo, Agrigento, la torre vista da terra ................................................................................. p.
Vendicari, Siracusa, veduta aerea della torre di epoca sveva ..................................................... p.
Termini Imerese, Palermo, torre delle Mandre ........................................................................... p.
Termini Imerese, Palermo, to1Te Colonna .................................................................................. p.
Gela, torre Manfria ..................................................................................................................... p.
Palermo, t01Te Acqua dei Corsari ............................................................................................... p.
Trapani, to1Te di Ligny ............................................................................................................... p.
Ustica, torre dello Spalmatore .................................................................................................... p.
Oristano , il torrione .................................................................................................................... p.
Ton·ione di Porto Scuso .............................................................................................................. p.
Torre di Capo Malfatano ............................................................................................................ p.
Posada , ton·e di Posada p.
Capo Teulada, torre di Piscini .................................................................................................... p.
La costa di Bosa p.
Particolare della tela conservata al Museo del Risorgimento a Torino raffigurante uno dei momento decisi per la liberazione della città, 1706 p.
li ritrovamento del corpo di Pietro Micca, Luigi di Giovanni, 1884 p.
San Giovanni a Teduccio, Napoli, scorcio esterno del fortino di Vigliena p.
Planimetria del fortino di Vigliena ............................................................................................. p.
San Giovanni a Teduccio, Napoli, scorcio interno del fortino di Vigliena dopo gli scavi p.

Tra Francesi, Spagnoli e Turchi
L a calata di Carlo VIII, al di là della complessiva inutilità, aveva però mostrato , se mai ce ne fosse stata la necessità, l'intima debo l ezza difen siva di tutti gli Stati della Penisola, a parti re dal regno di Napo l i di gran lunga il più grande. In que s t'ultimo , inoltre , con l'occasione si era evidenziato il deleterio scollamento vi gente tra la dinastia e l a popolazione (I J, scissione che lo rendeva praticamente ido neo ali' acquisizione da parte di una qual s iasi potenza straniera, senza timore di alcuna sensibile resistenza. Quanto agl i altri, ad eccezione di Venezia, per la l oro evidente iITilevanza militare non potevano giocare alcun ruolo significativo e, meno ancora, determinante nella complessa co ntesa che si andava di giorno in giorno acutizzando tra la Francia e la Spagna per l'egemo ni a occidentale. Potevano, e la ritennero una lungimirante politica, barcamenarsi fra l'una e l'altra ce rcando di ritagliarsi, di vol ta in vol t a, meschini vantaggi a danno dei confinanti , altrettanto miserabil i e famelici. Il che pur margin alizzandoli dalle grandi poste del contendere, non li marginalizzava affatto dalle grandi devastazioni dell'imm ancabile corollario di scontri e gue rre, per cui anche la loro ripetutamente ostentata profess ione di n e utralit à, lun g i dal garantire una co m oda estraneità dai campi di battaglia finì per trasferirg li in casa i campi di battaglia, con le immag in abili consegue nze. A rendere il quadro ancora più sven turato e portatore di sve nture contrib uiva la c rescente pressione dell ' Impero ottomano su ll'Occid e nte ed in particolare s ulla s ua appe ndi ce più meridionale incuneata profondamente ne l Mediterraneo. Le coste al di so tto de l 42 ° di latitudine ne divennero perciò l'estrema fron ti era : c irca 2500 km ne ll a sola parte con tine nt ale, dei quali oltre i 4/5 al regno di Napo li ed il restante allo Stato della Chiesa.
Pertanto, paradossalmente, proprio dal l'i n stabi l e regno di Napoli, dall'imbelle Stato Pontificio ed, in ragione proporzionale alla loro entità demografica ed economica, dagli altri stati rivieraschi dipende va l ' inviolabilità della cristianità. E se per molti studiosi la debo l e reazione aragonese del 1480 alla conquista di Otranto (2J, effettuata da un modesto contingente turco, palesando l'insip ienza militare di una dinastia s pacciatasi per guerresca 131 , aveva incentivato l'iniziativa di Car lo VIII, la calata incontrastata di quest'ultimo doveva aver riconfermato nei Turchi la facilità di soggiogare l'intera P e ni so la con una spedizione appena più forte .
Un regno collocato al centro del Mediterraneo con oltre 2000 km di coste diveniva così l'antemurale occidenta le, baluardo che indipendentemente dal prevalere de ll a Spagna o dell a Francia avrebbe dovuto essere massicciamente difeso e strenuamente presidiato.
Da parte sua, però, avrebbe garantito al dominatore di turno un ruolo egemone nel Mediterraneo , sia dal punto di vista strategico che commerciale, potenzialmente for iero di straordinari provent i H> . Per gli intricatissimi e mo lt ep li c i intrecci genealogici dell'epoca tanto i sovrani francesi c he quelli spagno li vantavano innegabili rag ioni per aspirare alla cooptazione dell 'ambi ta preda, conco rd ando sol tanto su l ritenere ormai agonizzante la dinastia aragonese ancora sul trono di Napoli.
L e avvisaglie dell'acuirs i del quadro geostrategico non t ardaro no a manifestarsi, incentivando al di là delle A lp i ulteriori iniziative militari . Neppu re la morte di Carlo VIII , avvenuta nel 1498, mentre si acci ngeva ad intrapr e nd ere una riedizione dell 'avve ntura del '94, valse ad an ni e ntare le s uggestioni di quella conquista. Il suo s uccessore, Luigi XII, infatti, ne condivise pienamente la priorità senza la benché minima esitazione o so lu z io ne di continuità. P erta nt o, come facilmente prevedibile , nel 1499 si produsse in una sostanziale
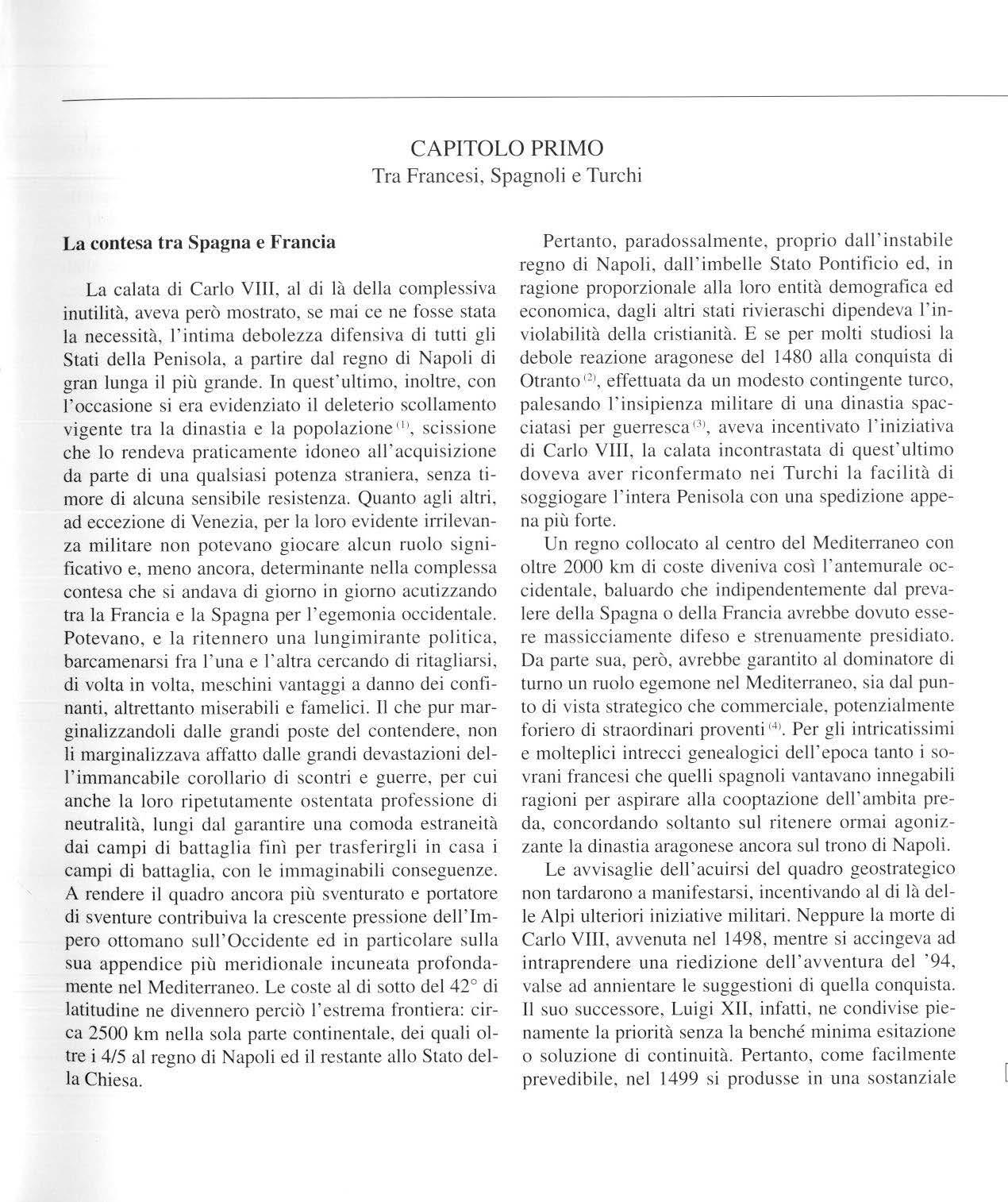
replica della celebre calata, puntando dapprima contro Milano 151 • In breve l'avanzata francese trova: ··... Saluzzo, Savoia, Monferrat o nelle stesse condizioni di semi-vassa lla gg i o e semi- imp otenza di cinque anni prima. Così che i France. i. senza colpo ferire, sono g ià alle porte del ducato di Milano .. :· 1 ~•
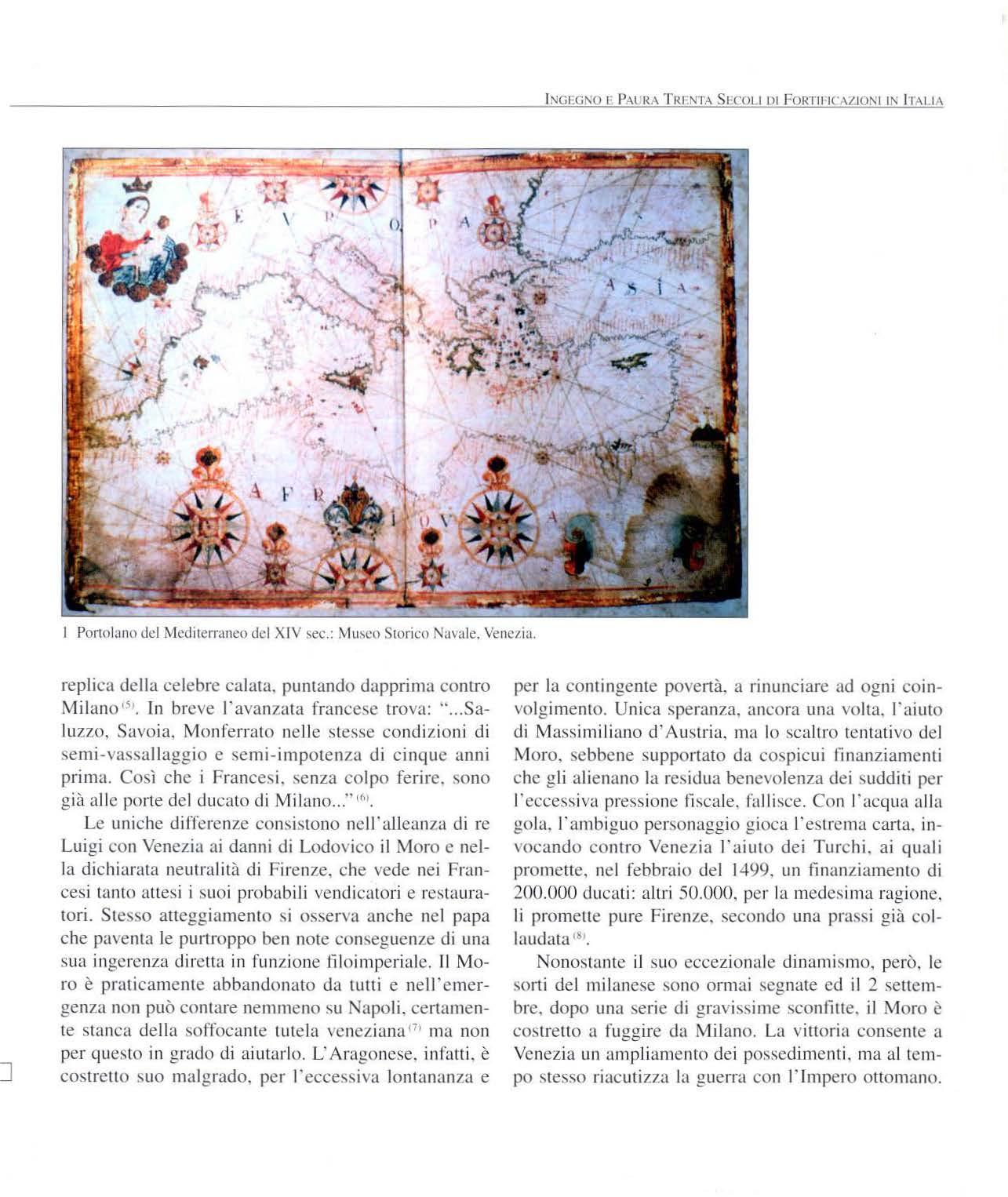
Le uniche differenze consistono nel!' a llean za di r e Lui gi con Venezia ai danni di Lodovico il Moro e nella dichiarata neutralità di Firenze, c h e vede nei Francesi ta nt o attesi i s uoi probabili vendicatori e re s tauratori. Stesso atteggiamento i osserva anc he nel papa che paventa le purtroppo ben note co n seguenze di una s ua ingerenza diretta in fun z ione filoimpe1iale. Il Moro è praticamente abbandonato da tutti e ne ll 'emergenza non può con t are nemmeno su Napoli. certamente sta n ca della offoca nte tute l a ve nez iana m ma non per qu e , to in g rad o di aiutarlo. L'A rago nese, infatti. è costre tl o suo malgrado, per l 'eccessiva l onta n anrn e
per la continge nte pove11à. a rinunciare ad ogni coinvolg imento. Unica speranza. ancora una volta raiuto di Mass imiliano d 'A u stria, ma lo scaltro tentativo del Moro, ebbene suppo rtat o da cospicui finanziamenti che g li a li enano l a re~idua benevolenza dei sudditi pe r l 'eccess iva pressione fiscale, fa lli sce. Con l' ac qu a a ll a go la. l' amb ig uo perso n agg io gioca l 'estrema carta. invocando contro Ven e Lia l'aiuto dei Turchi, ai quali promette, nel febbraio ciel 1499, un finanziamento di 20 0.000 ducati: altri 50.000. per la mede s ima ra g ion e. li promette pure FirenLe. secondo una prassi già co llaudata is, .
Nonostante il s uo eccez ion a le dinamismo, però, le sort i del rnilanese so no o rm ai s eg n ate ed i I 2 settembre, dopo una e ri e di grav issime confine. il Moro è cos tretto a fuggire da Mil ano. La vittor ia consen t e a Ve nez ia un am pliam e nto d e i possedimenti. ma al tempo s t esso riacutizza la guerra con l'Imp ero o ttom ano.
Di lì a breve, infatti, il suo ricercato intervento si materializza in una terribile scorreria penetrata fino all'Isonzo, con molte migliaia di vittime.
In breve nel giugno del 1499 i prodromi della tragedia si manifestano nel territorio di Zara, provocali dalle avanguardie dell'orda ottomana. Per quanto incredibile la reazione difensiva è trascurabile: eppure l'offensiva che si sta rapidamente materializzando 1ipropone la medesima estrinsecazione delle altre due, tristemente celebri, di appena una ventina di anni piima '91 Per l'esattezza quella del 1472 quando ben 8.000 cavalieri turchi dilagarono nel Friuli. A fronteggiarli pavidamente appena 3.000 cavalieri veneziani che peraltro consci della rimarchevole inferiorità si trincerarono presso Cervignano. A quel punto: " i nemici possono perciò penetrare indisturbati fino alle porte di Udine; ma poi subito si ritirano. Nel 1477 gl ' invasori sono sa liti a forse 10.000 cavalieri: tutta la riva destra dell'Isonzo , dal ponte di Gorizia al mare è stata ben fortificata: e due veri campi trincerati sono costruiti a Gradisca e a Lucinico. A onta di ciò, alla fine di oltobre, i Turchi riescono a passare, la notte di sorpresa, l'Isonzo sotto Gorizia; i Veneti accorrenti cadono in un agguato e nonostante la valorosa resistenza, sono in gran parte distrutti. E ora tutta la plaga fino al Tagliamento e poi fino a Sacile è campo de]]e distruzioni dei barbari che alla fine, cmichi di bottino e di prigionieri, si ritirano indisturbati. Venezia provvede adesso a guarnir meglio il confine: 6.000 cavalli e 3.000 fanti resteranno finché il pericolo non è svanito; altri 20.000 fanti ven-anno "desc,itti" per essere pure chiamati in caso di bisogno Alla fine del l478, quando i Turchi si affacciano di nuovo a ll e rive dell'Isonzo cercano invano qua e là un più facile passaggio: visto tutto ben guardato rinunziano a un'azione di viva fo rza e s i ritirano .. ."' ( I ()) Tornando al 1499 in pochi giorni l'avanzata turca diviene travolgente , mentre il Senato troppo assorto con la guerra nel milanese non r ivolge particolare attenzione alla gravissima minaccia . Dopo aver sprecato così tempo prezioso per imbastire una coerente difesa alla fi ne ai: " ... 3.000 uomini
di presidio a Gradisca si aggiunsero 1.300 cavalli, e solo all'ultin10. con l'acqua alla gola, dalroccupata Cremona s i fecero partire altri 600 cavalli e 1.000 fanti che non poterono giungere in tempo. Si contava però molto sull'opera delle cerne: ben 15.000 ceme friulane erano mobititate! Jl 18 setlembre la temp esta ottomana, da 7 a 10.000 uomini, si rovescia sul Friuli. Il provveditore veneto Andrea Zancani non osa uscire dalla ben munita Gradisca e i Turchi possono dilagare indisturbati fino alla Livenza. A Sacile però si vengono raccogliendo le truppe spedite da Cremona e alcune migliaia di cernite del Vicentino e Padovano , così che i nemici potrebbero trovarsi in situazione assai critica ... Ma i capi s pecialmente non osano impegnarsi, e i Turchi , dopo aver distrutto ben 132 villaggi e aver ucci so o fatte prigioniere 10.000 persone, possono il 5 ottobre ripassare indisturbati l'Isonzo " 1111 •
L ' efferate incursioni ottomane nel nord-est della repubblica di Venezia ribadivano , paradossalmente , la necessità di fortificare al massimo e di difendere ad oltranza il s ud-e s t del regno di Napoli. Fra quella del 1477 e quella del 1499, infatti, si collocava la già ricordata conquista turca di Otranto, con l'occu pazione della cittadina protrattasi per oltre un anno (' 21 • Senza dubbio anche in questa circostanza le vittime furono forse una decina di migliaia , fra deportati e massacrati: un bilancio perciò sostanzialmente simile a quello del Friuli. Ma l'impatto emotivo fu di gran lunga superiore, perché tutti ritennero che la fune sta vicenda rappresentava il prologo della tante volte ribadita volontà ottomana cli conquistare dopo la Roma d'Oriente anche quella d'Occidente e con essa l'intera cristianità ,u,. l n altri termini non si riguardò come una tragica scorreria analoga a quelle del Friu l i per entità degli attaccanti e delle perdite, bensì come il primo tentativo di invasione otlomana.
Il ventre molle dell'Europa, della civiltà occidentale stava perciò nell'estrema propaggine del continente nel Mediterraneo, sebbene la vulnerabilità fosse più equamente distribuita. Il che valse a trasformare, dopo
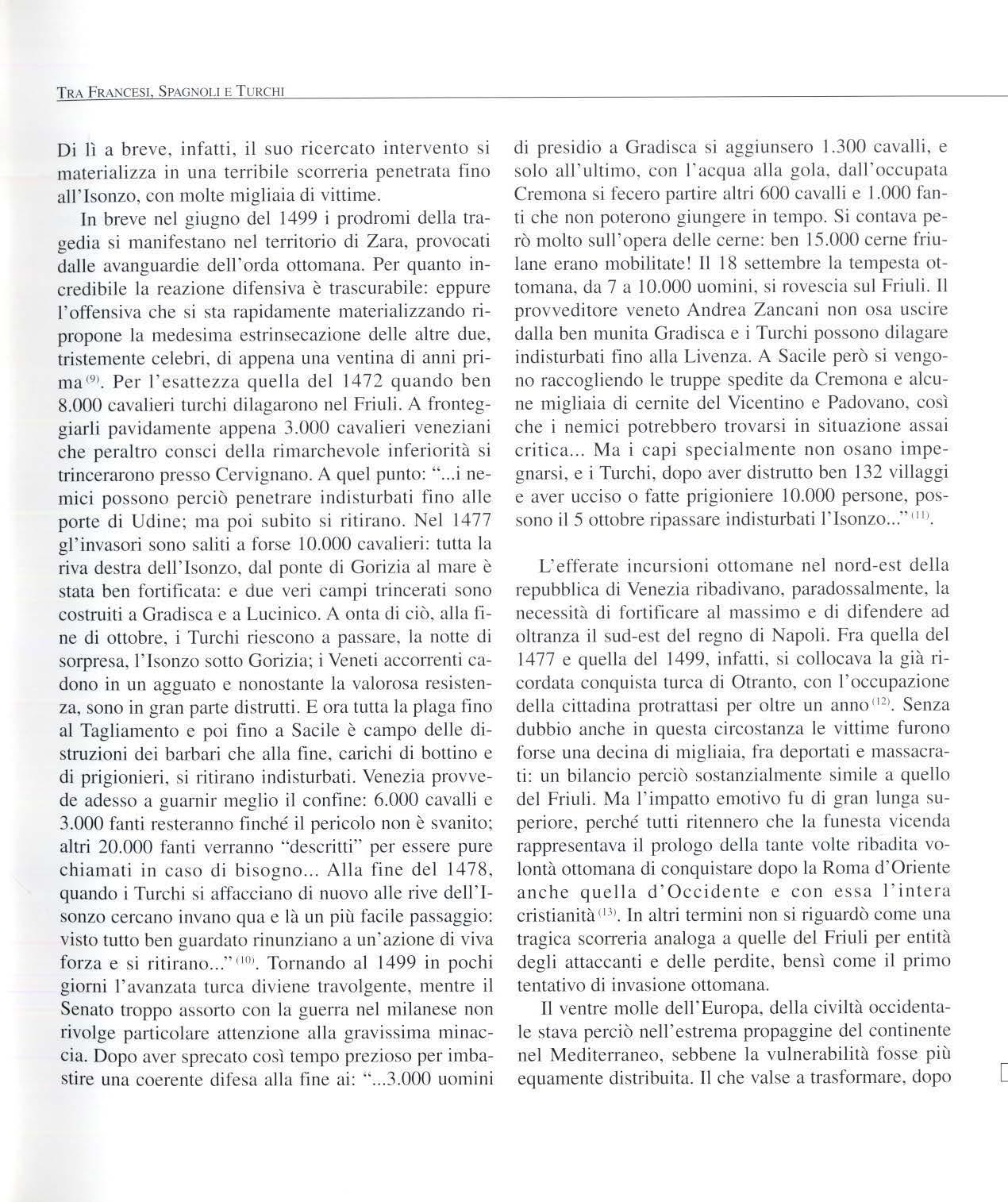
il raggiunto equilibrio fra le due superpotenze rinascimentali, le sue coste nel banco di prova per le fortificazioni più possenti e più avanzate. Ad un livello appena inferiore le difese delle tante isole della Sereni ssi ma, in quanto basi dell'unica rivale temibile sul mare dell'espansione ottomana. Appena inferiori per entità e validità le fortificazioni costiere dello Stato Pontificio, in quanto antagonista religioso dell' Islam.
Da quanto appena schematizzato potrebbe sembrare eccessivo, ed al tempo stesso riduttivo , ritenere che la fortificazione in Italia , a partire dagli inizi dell 'e tà moderna, fu soprattutto finalizzata a contrastare l 'offensiva musulmana. Ed in realtà non fu proprio cos1: ma altrettanto sic uramente le maggiori opere e le più evolute vennero schierate per frustrare tale minaccia, la più grave in assoluto. Nessuna meraviglia perciò

che una ricerca sull'evolversi della fortificazione finisca inevitabilmente per concentrarsi soprattu tto su strutture ad i bite a tale compito, protrattosi, peraltro, se nza alcuna mutazione significativa per oltre mille anni. E se la possente ed aggressiva flotta di cui dispose per lunghi secoli consentì a Venezia di contenere al massimo il ricorso alla fortificazione (14> ; se la posizione geografica alquanto se ttentrionale nel Tirreno e nell 'Ad riatico fornì una certa protezione alle coste pontificie evitando un esasperato ricorso alle fortificazioni, nulla del genere favorì quelle del regno di Napoli.
In esso lo stenninato perimetro marittimo si proponeva quale possibile via di invasione e teatro di razzie. Oltre 2000 km di coste a breve distanza, sia ad est che a sud, da nemici spietati e feroci, sempre pronti a sbarcare in forze per conquistare l 'i ntero meridione, che nel frattempo flagellavano con incessan ti incursioni e scorrerie. Solo un capillare impiego della fortificazione , antinvasiva ed anticorsara, avrebbe potuto garantire
agli abitati rivieraschi quel m in imo di sicurezza sociale indjspensabile per una normale esistenza. Ma ciò sarebb e equivalso a mantenere ad un discreto l ive ll o operativo e con struttu re frequentemente agg io rnate un 'enorme catena difensiva capace di contenere e magari di frustrare l e t err ibili ini z iati ve turch e e gli atroci insulti barbareschi. Qu als i asi regime , indip e nd e nt e m e nte dal modo con cui fosse riuscito ad impossessars i del regno, avrebbe dovuto farsi carico di ta le es igenza prioritaria , dip ende ndo dalla s u a positiva esp l etazio n e il mantenimento del po tere . Le tante dinastie ch e già si erano avvicendate al s uo governo lo avevano costantemente verificato , qu e ll a aragonese in pa11icolare. Non a caso alla stessa andava ascritta l a massiccia riqualificazione difensiva delle s ue marine disgraziatamente, come accennato, con opere d ell' ultim a transizione rivelatesi costosissime quanto di effimera durata, risultando giubilate pochi decenni dopo. Per colmo di sventura la netta percezione di tanta inad eg ua tezza coinc i se con l'altrettanto precisa constatazione dell' inc rementarsi della press io ne turco-barbaresca.
Tanto la Francia quanto la Spagna, seb be ne più o meno confusamente, sa p evano perfettamente di tale s tato di cose. E sa p eva no pure c he per pro vvedere con urgenza alla rifortificazione d ell'a mbit a con qui sta, avrebbero do vuto inevitabilmente farsene diretta me nte carico. Il reg no, infatti , era fin a n z iari ament e stremato daJl e imm e nse spese in armamenti e d in approntamenti rrulitari pro vocati dalle ottuse guerre d e ll ' u 1ti mo sovrano aragonese. L e risi ca ti ss ime disponibilità residue con se ntivano pochissimo in materia di fortificazioni avanzate p er qu anto in prece d e n za osservato, di g ran lunga più costose che nel passa lo. A d ogni buon conto prima di cimentarsi col problema pon e ndo v i in qualche maniera rimedio, occorreva rendere l'acquisizione del napoletano s tabile e d irre ve r s ibil e, costringendo anche il contendente a riconoscere quel dato di fatto.
E tale traguardo implicò un a serie es t e nuant e di batt aglie, di scontri campali e di assedi di notevole e ntità e complessit à, che so lo per larga s intes i po ssono essere nassunte.
Dunque nei primi anni del '5 00: ··.. .Ia Francia, sicura del po ssesso di Milano e Genova , dell'alleanza fiorentina e pon tifi cia, del forzato d isinteressamento di Venezia, può ritentare l ' impresa di Napoli. li re Federico s pera tuttavia che l'equilibrio italiano possa essere ancora . a lm eno in parte, mantenuto dalle gelosie di M assim ili a n o e della Spagna, anzi vi confida ta n to. da trascurare una possibile intesa col papa. Tllu sione! Il re dei R omani lo deluderà più ancora di quanto non abb ia deluso il Moro e Ferdinando il Cattolico non esiterà a tradirlo ..." 11 5> Il regno dì Napo] i assurge , allor a ufficialmente, a posta della di s puta tra le due superpotenze, e nt rambe presenti sul suo territorio con aggueniti eserciti.
Il disgraziato re di Napoli, Federico d 'Arago na , per ev itare lo sme mbram en to del regno tra quei rabbiosi an t agonisti, quale estrema ri sorsa aveva anche lui. già nel 1500, so llecitalo l'aiuto dei Turchi , ma l 'es pediente non g li era riuscito. In quella stessa estate le navi di Venezia, spasmodicamente impegnate a contrastare l'offensiva ottomana. pattugliavano ferocemente l'Adriatico e nemmeno il s ultano di Costantinopoli osava provocarle a li' interno del loro golfo .
Dop o una se rie di scaram ucce e di sco ntri di scarsa co ns i s tenza ed irrisorie conseguenze, soltanto l a piazzaforte di Tarant o 116l resisteva ancora, ultimo caposaldo aragonese inespugnato , dove il re Federico aveva s imboli camente in v ia to il primogenito, duca di Calabria , di appena 12 a nni. Alla fine gli Spagnoli , impadroniti si d'importanti ostagg i e so tto la minaccia di attentare a ll a loro incolumità, ne ottennero la capitolaz ion e il 1° m a rzo d el 1502, concludendo un assedio protrattosi per o ltre sei mesi. D a l momento del I ' ammainabandiera s ul caste llo di Taranto , gli Arago nes i uscivano dalla s tor ia del reg n o di Napo li, che: '' ... di scacciato Federico, fu partito in due pa rti e con nu ova p o li zia governato dagli ufticiali dei due re. In Napoli il re di Francia riteneva per v iceré Luigi d' Armignac duca di Nemors, il quale reggeva Terra di L avoro e l 'A bru zzo e lU tta quella parte a lui spettante In Calabria e Pu g lia , provin ce a ll a Sicilia vicine, governava il
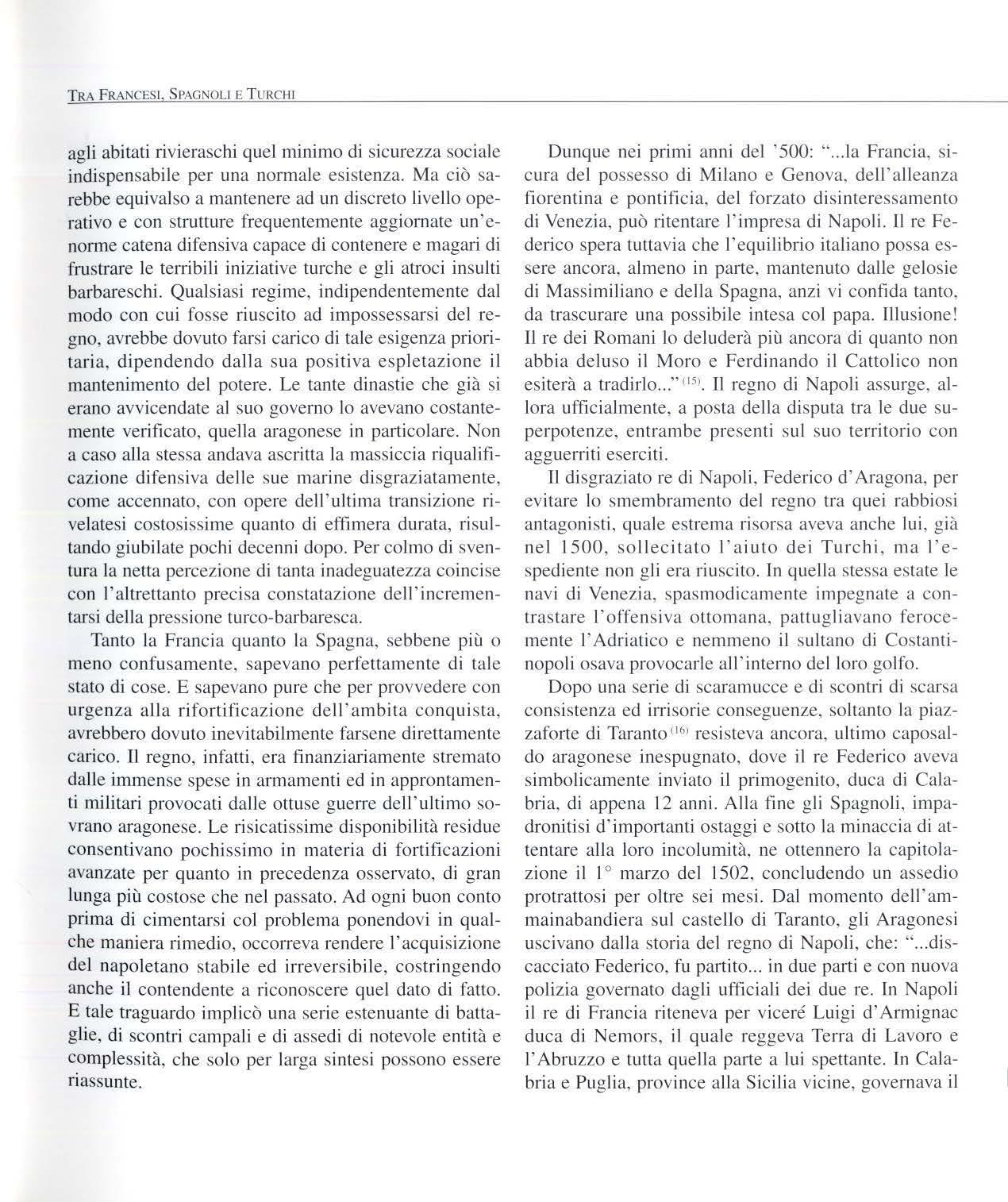
Gran Capitano, come Viceré e gran plenipotenziario di Ferdinando Re di Spagna " <17 >
Le ostili fazioni non tardarono molto a venire a diretta contesa per il possesso dell'intero Regno: a giugno dello stesso anno si ebbero i primi scontJ.i aperti. L'entità delle forze in campo, a netto svantaggio del Consalvo in ragione di 3 contro 1, gl' imposero una condotta bellica iniziale estremamente prudente, costringendolo a ritirarsi in Barletta , sotto lo spettro , per giunta, di un probabile intervento turco. Azione che in effetti ebbe un prologo nell'incursione a Castrignano vicino Otranto, ma si esaurì rapidamente al pari di tutte le consimili essendo di matrice corsara, implicita dimostrazione che il gran sultano, pur ambendo ad inserirsi nella vicenda, non si fidava ancora di nessuno dei due contendenti, con uno dei quali invece necessariamente si sarebbe dovuto alleare, e delagava a qualche corsaro barbaresco l'incombenza, vagliandone nel frattempo i riscontri.
li Consalvo aveva, tra l'altro, insediato piccole guarnigioni anche a Canosa, Manfredonia, Andria, Taranto, Crotone, Tropea, Reggio Calabria e Nocera disorientando i Francesi che vedevano così sfumare un vantaggioso e immediato confronto risolutivo in campo aperto, realizzando, invece. una logorante quanto estenuante serie di assedi. Il primo di questi, poi, condotto contro Canosa che al comando di Pietro Navarro oppose una strenua resistenza, confermò le loro più fosche previsioni. L'artiglieria francese nell'occasione non s i dimostrò affatto risolvente , obbligando i suoi detentori al deprecato combattimento ravvicinato. Logico, pertanto, da parte francese concentrare gli s forzi sulla sola Barletta. Fra il 20 agosto ed il mese di gennaio del 1503 i reiterati assalti, però, si infransero su]Je difese spagnole: vana anche la diversione a Taranto. Il tempo lavorava, ormai, a favore de l Gran Capitano che, grazie alla di s ponibilità di tante fortezze costiere, manteneva intatti i collegamenti con la madrepatria, dalla quale iniziavano a pervenire consistenti rinforzi. Fu durante questa lunga fase di stallo che si verificò l'episodio della celeberrima disfida 11 8 ) fra tredici cava-
lieri italiani ed altrettanti francesi, il 13 febbraio del I 503. A quel tempo però il grande forte, che s i continuò a chiamare, sebbene impropriamente, castello, ancora non esisteva.
Quasi a sottolineare il progres sivo avvantaggiarsi degli Spagnoli, la flotta di Luigi XII s ubì , dinanz i a B1indisi, una pesante di sfatta ad opera delle navi imperiali: da quel preciso momento Con sa lvo passò alla controffensiva. Ed il 2 I aprile, a Serrunara , un grosso contingente francese finì annientato dagli Spagnoli, determinando con la sua distru zio ne la perdita d ell'intera Calabria. Appena una settimana dopo, in Puglia, un secondo esercito spagnolo, agli ordini dello stesso Consalvo, lasciò Barletta, dirigendo verso Cerignola, per riunirsi con quello viuorioso. A loro volta i Francesi uscirono da Canosa, tentando disperatamenle di evitarne il congiungimento: su l far del tramonto le due formazioni enu·arono in contatto. La battaglia fu subito tanto violenta quanto rapida: con il so praggiungere delle tenebre , infatti, la rotta francese si confermò irreparabile <19 ) La sorte del Regno , d a quella notte , restò definitivamente stabilita: per i s ucces sivi due secoli sarebbe appartenuto alla Spagna! E con esso pure quello di Sicilia, di Sardegna e quello che di lì a breve diverrà lo Stato dei Pre s idi, oltre al ducato di Milano 1201 • Senza addentrarci ulteriormente nella vicenda, dipanatasi, comunque, fra innumerevoli scontri tra le due fazioni , va ricordato che so lo con la vittoria del Garigliano , conseguita il 28-29 dicembre dello s lesso anno, risulterà ufficialmente affermata la s upremazia spagnola. L. esito infelice sul campo, però, non sancì affatto la rinunzia di Luigi X l i alle s ue mire sull'Italia, anzi ne fomentò più che mai la cupidigia, concretizzatasi in un interminabile corollario di ostilità minori , purtroppo se mpre deva s tanti, che tuttavia non valsero a modificare l'a sse tto dinastico conseguito. E, nell 'a mbito dell'instabilità geopolitica instauratasi, tutti gli staterelli ed i potentati peninsulari vollero, a qualsiasi titolo, in se rirsi, cercando di approfittare della contesa per 1itagliarsi i massimi benefici <21 J

La battaglia di Cerignola del 28 apri le, terminata con la rotta del!' esercito francese , prelus e al dilagare delle forze spagnole nel Regno '22 J Diciotto giorni dopo Consalvo era infatti a Napoli, mentre i resti dei suoi irriducibili nemici s i rifugiavano dietro il Garig lian o ed in Gaeta , mantenendo da questa muniti ss ima piazzaforte il contatto con il Nord , in attesa di giorni migliori. Il general issimo, tuttavia, non perse tempo e consolidò la conquista, sv uotando i castelli di Napoli dalle loro residue guarnigioni. Ed ancora una volta, poderose mine fatte brillare il 12 luglio so tto Castel Nuovo m) ed il 15 sotto quello dell ' Ovo , conclusero la re si ste nza dei presi di napoletani lasciati da Luigi XII. Il 19 dello stesso me se iniziò l ' investimento della piazza di Gaeta , che capitolò so ltanto il
31 dicembre con l'evacuazione degli ultimi malandati difensori. Trani , Brindisi ed Otranto , e d anche Monopoli, a tale data erano sempre in mano ai Veneziani 124 !, per molti versi i principali beneficiari dell 'es tenuante conflitto. Non a caso è stato osservato che per la Sereni ss ima: " non vi è crisi degli a ltri stati italiani da cui non abbia ricavato vantaggi: attraverso le tri s li vicende di Napoli ha ottenuto Trani , Brindi s i, Otranto; quelle di Milano l'hanno me ssa in possesso di Cremona; la rovina del Valentino le ha permesso di divenir predominante in Rom agna. Ora poi , d'un co l po sembra aver risolto l'annoso problema della sua espa n s ione in tutta la Venezia Giulia e reso completamente un lago veneziano il M are Adriatico ... Di qui la fatale lega di Cambrai ( l O

dicembre 1508) contro Venezia, prima coalizione europ ea contro la minaccia di predominio d'una grande potenza ..." < 25 l li ridimen sionamen to di Ven ezia non tardò sotto i colpi congiunti di tanti e poderosi nerni-
ci: già nell'estate del 1509 essa restituiva alla Spagna le piaz ze marittime pugliesi per evitare ulteriori rappresaglie <26 > Le ultime presen ze militari non spagnole lasciavano così il Regno di Napoli <21 >
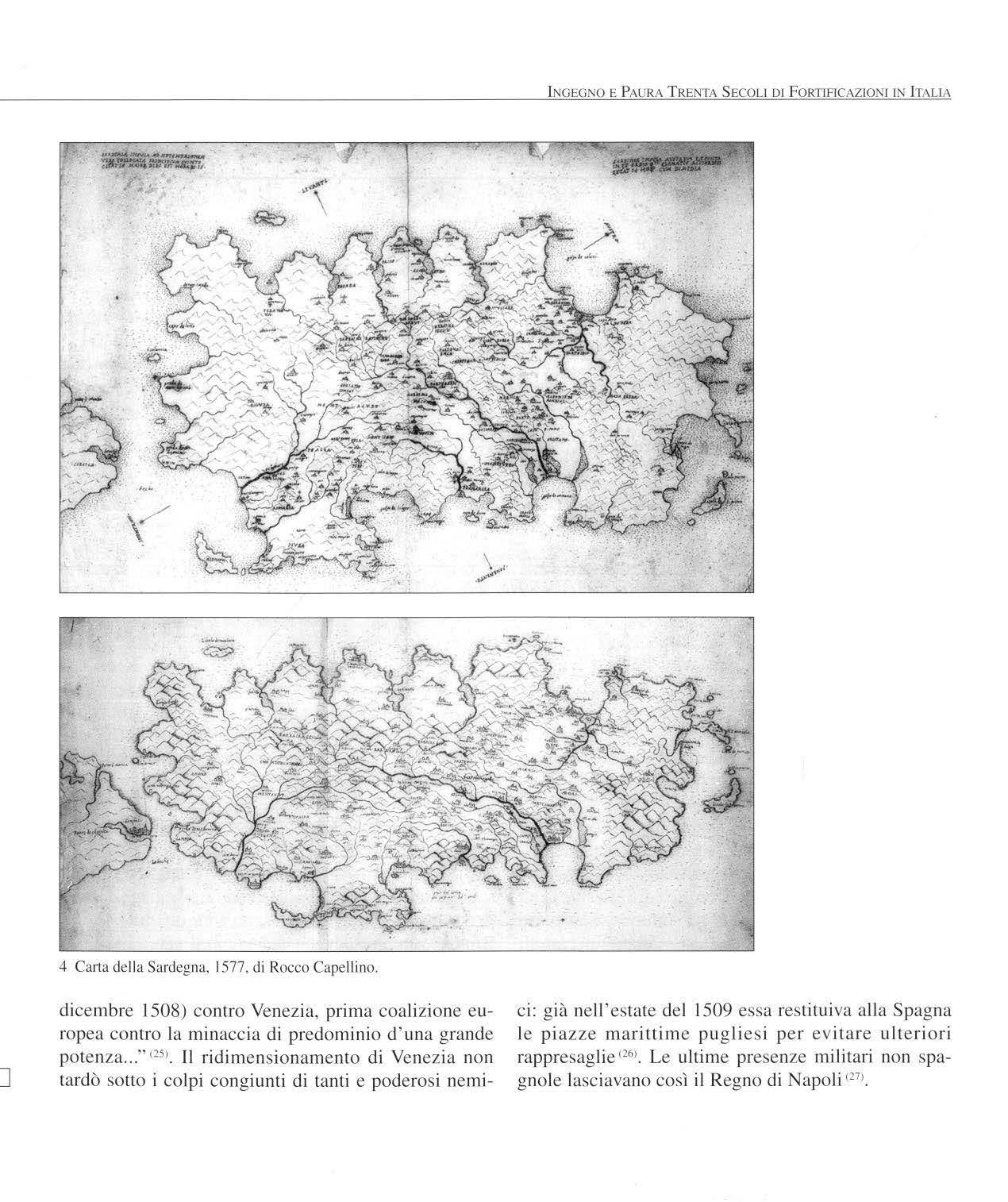
Esauritasi quella inusitata alleanza le ostilità tra Spagna e Francia ben presto riesplosero. [ primi scontri avvennero già nel 1511 , mentre contestualmente Madrid avviava in Nordafrica la politica dei presidi < 28 > , con il dichiarato intento di annientare, una volta per tutte , i covi dei corsari barbareschi di giorno in g iorno più aggressivi, s pecialmente dopo l'umilia zione di Venezia. Per gli altri Stati europei, tuttavia , tale risoluzione sem brò foriera di una progressiva sotto mi ss ione dell ' intero bacino medite1nneo occidentale e sintomo preoccupante delle mire egemoniche ed imperiali s te spagnole, peraltro già ampiamente manifestatesi con la ricordata acquisizione di buona parte della Penisola.
Il 1° gennaio del 1515, al defunto Luigi XII, successe Francesco I: la politica della Francia, però, ancora una volta non mutò minimamente, come pure la posta del contendere. In pochi mesi le tradizionali ostilità con la Spagna s i rinfocolarono nuovamente. Tuttavia la
ripresa in grande del confronto per il predominio in It alia si scatene rà nella sua cieca violenza soltanto a prutire dal 1521. Carlo V era diventato nel frattempodal 28 g iugno del 1519 - imperatore delle tante nazioni ormai aggregate sotto la dinastia asburgica.
Tra il 1521 ed il 1526 la potenza spagnola provvide a consolidare la recente sovranità sui Regni italiani scacciandone sistematicamente le residue sacche francesi. L' intera vicenda cu l minò e terminò con la battaglia di Pavia , il 24 febbraio del 15 25, risolta s i in un'enne sima, catastrofica sconfilta francese. Lo stesso Francesco I finì catturato e condotto in Spagna, dove fu costretto a sottostare alle vessatorie claus ole del ' trattato di Madrid', ratificato il 14 gennaio del 1526.
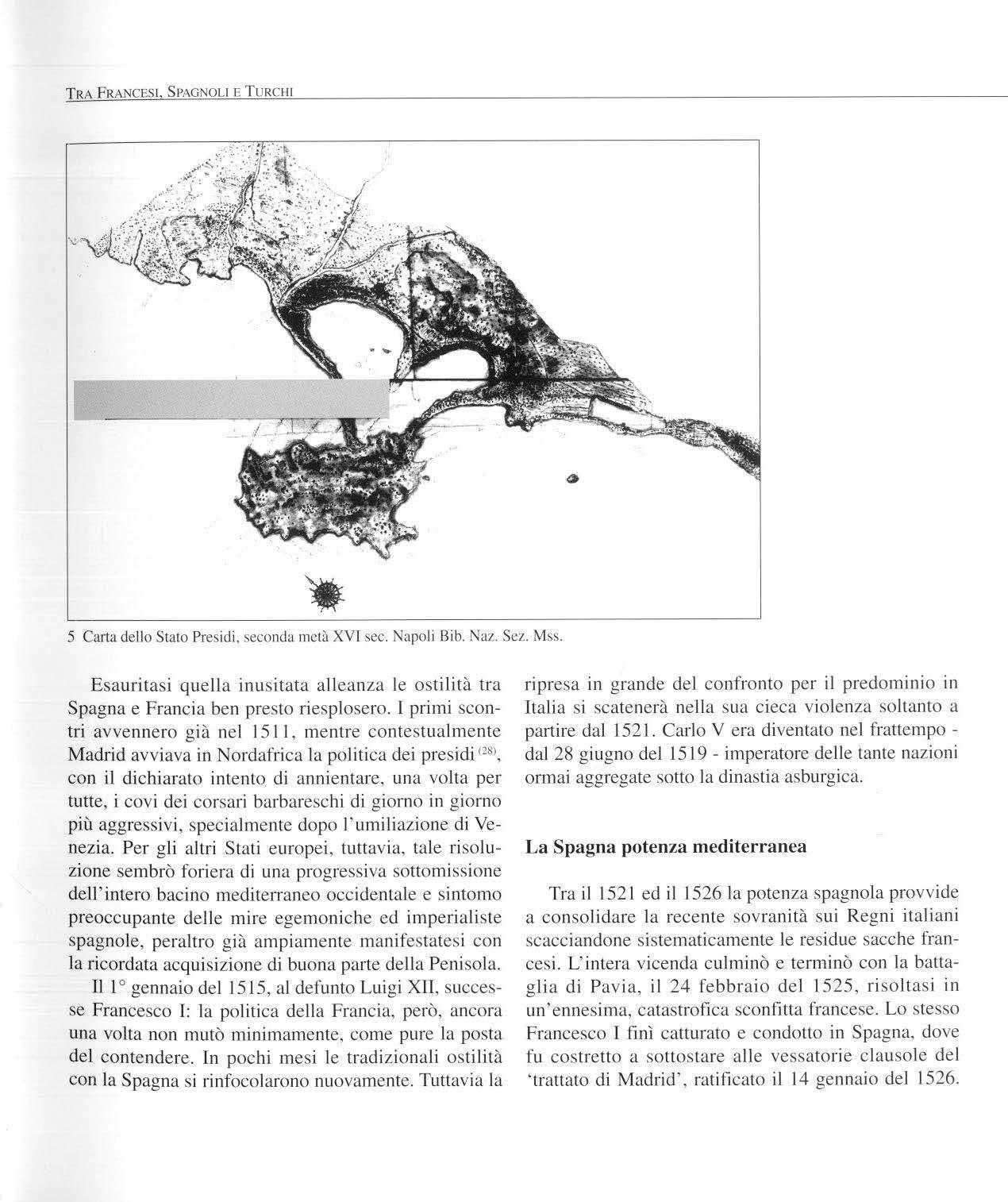
L' accordo sanciva la rinuncia da parte francese alla Lombardia , al Napoletano e d alla Borgogna nonché l ' impegno a non combattere più contro Carlo V. Ma, appena rientrato a Parigi, Francesco I dichiarò nullo il documento in quanto esto11ogli ed il 22 maggio 1526 , a Cognac. stipulò un'alleanza, ovviamente in chiave antispagnola, con il papa Ì"9 ' Venezia, Firenze, il duca di Milano e persino l ' Inghilterra, meglio nota come " Seconda Lega Santa". A spingere molti degli ex alleati di Carlo V dalla parte francese , giocò il timore prodotto dall ' abnorme accrescimento di un potere già immenso in s eguito al trattato. Tutti , infatti , paventavano di perdere ogni residua autonomia po liti ca, se non addirittura la stes sa indipendenza. Nel giugno ripresero le o s tilità.
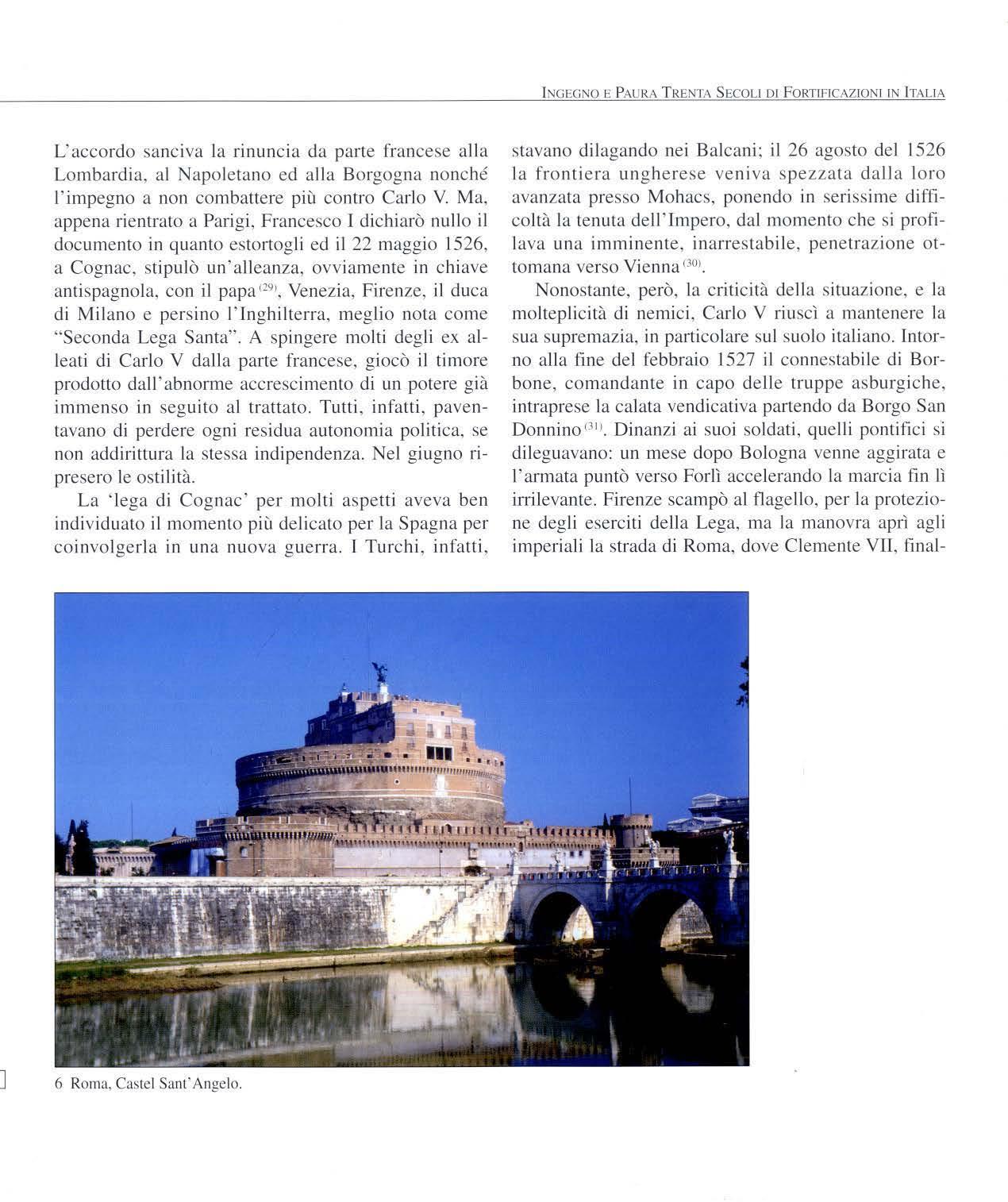
La 'lega di Cognac' per molti aspetti aveva ben individuato il momento più delicato per la Spagna per coinvo l gerla in una nuova guerra. I Turchi, infatti ,
s tavano dilagando nei Balcani ; il 26 ago s to del 1526 la fronti e ra un g here s e veniva s pe zz ata dall a loro avan z ata press o Mohacs , ponendo in s erissime difficoltà la tenuta dell ' Impero , dal momento che s i profilava una imminente , inarrestabile , penetra z ione ottomana verso Vienna 1301 •
Nonostante , però, la criticità della s ituazion e, e la molteplicità di nemici , Carlo V riu scì a mantenere la s ua supremazia. in particolare sul s uolo italiano. Intorno alla fine del febbraio 1527 il connestabile di Borbone, comandante in capo delle truppe asburgiche, intraprese la calata vendicativa partendo da Borgo San Donnino 1311 • Dinanzi ai suoi soldati, quelli pontifici s i dileg u avano: un mese dopo Bologna venne aggirata e J'armata puntò verso Forlì accelerando la marcia fin lì irrilevante . Firenze scampò al flagello, per la protezione degli eserciti della Lega, ma la manovra aprì agli imperiali la strada di Roma. dove Clemente VII, final -
mente , inizi ò a preoccuparsi. e ad occuparsi a tti vamente , de ll a difesa della città (321 • La discesa del Borbone continuò, o rm ai, indi s turb ata: i Senesi provvedevano a vettovagliare i suoi 10.000 lanzichenecchi, i 5.000 spag noli ed i 2-3.000 italiani, o l tre ad uno strasc ico dì crinlinali c he, strada facendo, s i era aggregata all e formaz ioni r ego l ari. È probabile che il totale de ll ' orda a sce ndesse a quel punto ad a lme no 15.000 uomini ; di cer to era cos ti t uit a da una ma ssa ga l va ni zzat a dal miraggio del g randioso saccheggio della Città.
Il 6 mag gio Roma è perduta: le atrocità che seguirono alla conq ui sta, tristemente celebr i come 'il sacco di R oma' 133l, determin e ranno r ennesimo cambio di sc hieram e nto del Pont e fic e e la sua u sc it a definitiva dall a L ega. Forse fidando nell'inarrestabile dilag a re ot tom ano ai confini orientali deJrEuropa , i Frances i co mpi ro n o allora u n es tr e mo te ntati vo d'in vasio n e de ll'Ita li a, so tto il comando de l Lautre c, va li cando le
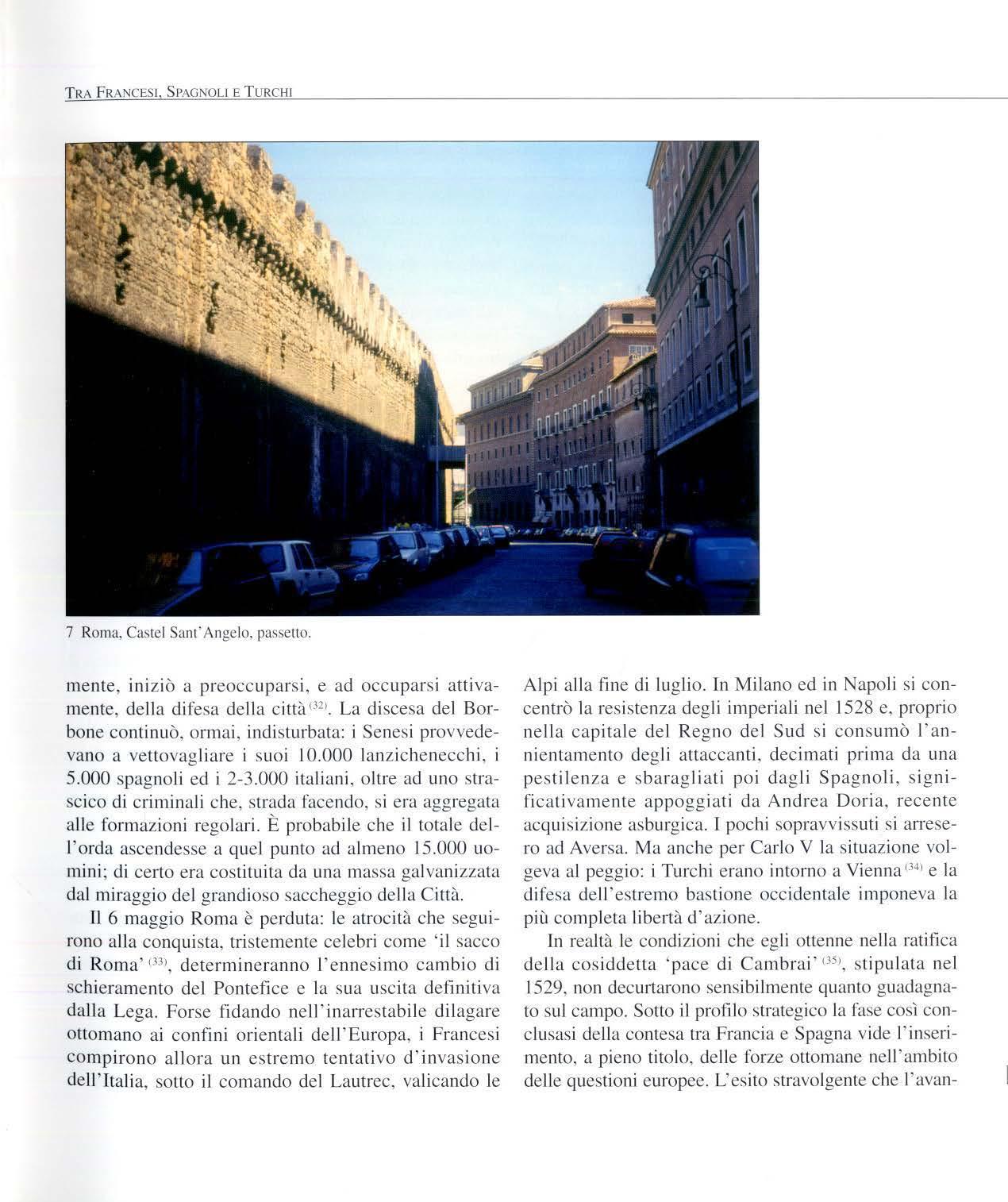
A lpi a ll a fine di luglio. In Milano ed in Napo li si concen t rò la resistenza degli imperiali nel 1528 e, proprio ne ll a capitale d e l Reg n o del Sud si cons umò l'annientam e nto degli attaccanti, decimati prima da un a pestilenza e s bara g liati poi da g li Spagnoli , sign ificativamente appoggiat i d a Andrea D oria, recente acqu is i zio ne asburgica. I pochi so pravviss uti s i a rre sero a d Aversa. Ma a nch e per Carlo V l a s itu azio ne volgeva al peggio: i Turclli era no in torno a Vienna 1341 e la difes a de ll' estremo bast ione occidentale impon eva la più comp leta lib e rtà d 'az ion e.
In real tà le co ndi z ioni che eg li ottenne nella ratifica de ll a cos id detta ' pac e di Cambrai· 135 > , s tipulat a nel I 529, non decurtarono sensibilmente quanto guadagnato s ul campo. Sotto il profilo strategico la fase così co ncl usas i de Ua contesa tra Francia e Spagna v ide l'inserime nto, a pi e no titolo , de lle forze ottomane ne ll ' ambito delle questioni europee. L'esito stravolgente che l 'ava n-
zata dei Turchi aveva prodotto sulle sortì di una guerra ormai irrimediabilmente perduta, deve aver sugge1ito al sovrano francese j vantagg i di una cooperazio ne militare con la Porta in funzione antimperiale, allea n za strisc iante che cli fatto già da tempo coordinava le ini ziative militari fra le due potenze. Fu forse quella la ge nesi dell'accordo che sarebbe passato alla stori a come 'empia alleanza' e c he per le coste italiane significò l ' avvento del più atroce dei martiri 1361•
La pace di Cambrai, non di ve rsame nt e dai precedenti trattati, non ebbe vita lunga. Carlo V, infatti , aveva perfettamente intuito la p ortata s lralegica dell'alleanza, relativamente seg reta , tra Francesco 1 ed il gran s ultano, i cui prodromi si erano dipanati nel corso del 15 33 , con una se1ie di abboccamenti ad Algeri ed a Costantinopoli. L' ascesa a comanda nt e in capo della flotta ottomana. ne l 1534, di Khair-ed -din già tristemente celebre come B a rbaro ssa m, , l asciava prefigurare una pesante offens iva na va le turco-barbaresca lungo l'intera frontiera malittima dell'Impero. ln particolare s i sarebbero moltiplicati esponenzialmente le razzie e gl i abbordagg i , az ioni in cui. il neoamm iraglio eccelleva, sia per la rilevanza numerica della navi ai s uoi o rdini sia per la propizia disponibilità delle bas i navali francesi nel Mediterraneo (38 ) A sua vo lta , certamente . Francesco I non si illudeva circa le conc rete motivazioni dell'aiuto musulmano, sempre ecomunque finalizzato al tlionfo ottomano ed ai proventi della corsa . ma riteneva c he , perseguiti a danno della Spagna, avrebbero in evi tabilmente favorito la Francia.
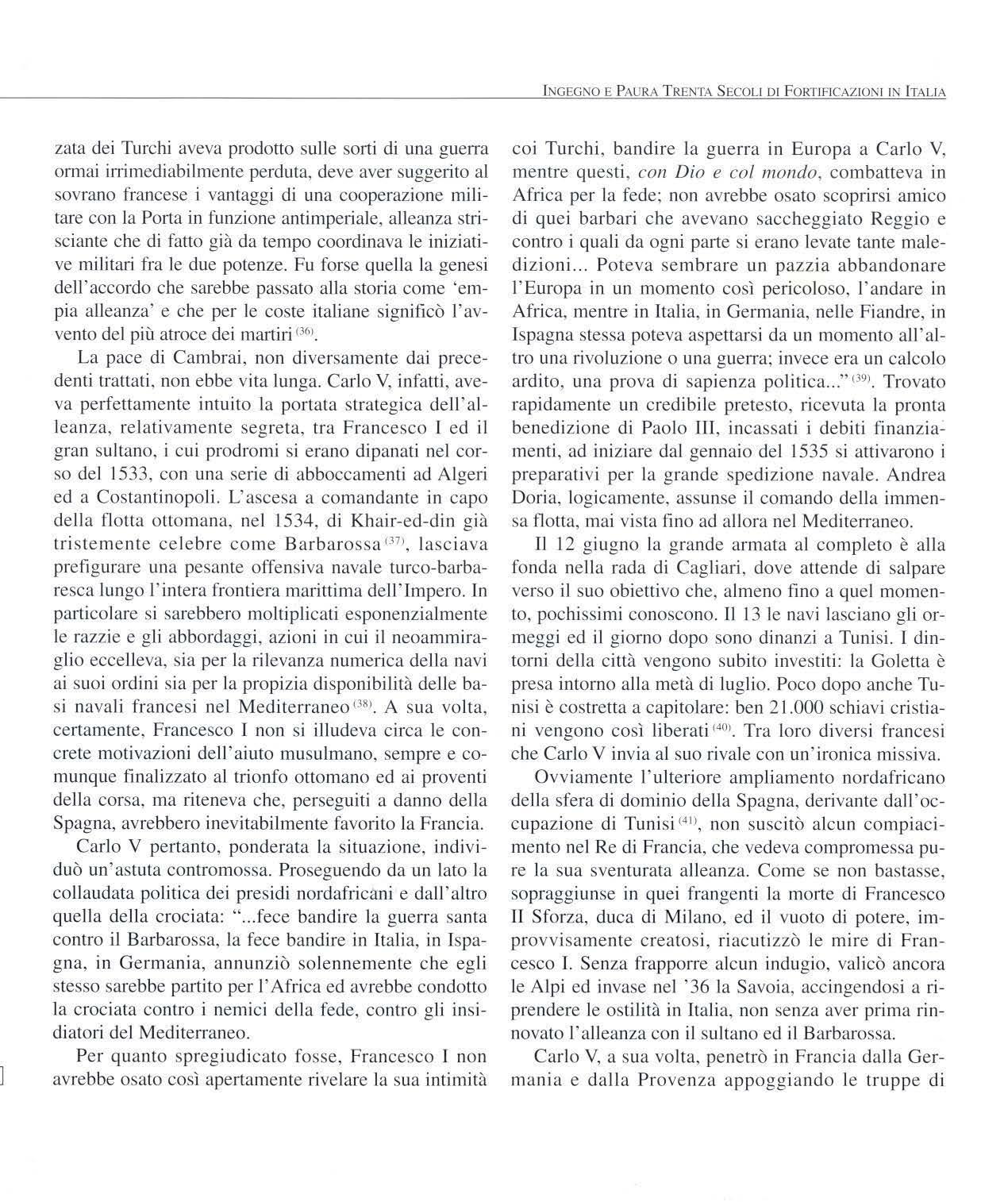
Carlo V pertanto, ponderata la s ituazion e, individuò un'astuta contromossa. Pro seguendo da un lato la collaudata politica d e i presidi nordafricani e dall'altro qu e lla d e ll a crociata: " ... fece bandire la g ue rra sa nta contro il B arbarossa . la fece bandire in It alia, in Ispagna, in Germania, annunziò so lenn eme nte che egli stesso sarebbe partjto per 1' Africa ed avrebbe condotto la crociata co ntro i ne mici della fede, contro g li insidiaro,i del Mediterraneo.
Per quanto spregiudicato fosse, Francesco I non avrebbe osato così ape1ta mente rivelare l a sua intimità
coi Tur chi, bandire la guerra in Europa a Carlo V, mentre questi , con Dio e col mondo, combatteva in Africa per la fede; non avrebbe osato scoprirsi amico di quei barbari che avevano saccheggiato R eggio e contro i quali da ogni pa11e s i erano levate tante maledizioni ... P oteva sembrare un pazzia abbandonare l'Europa in un momento così pericoloso, l ' andare in Africa, mentre in Italia, in Germania, nelle Fiandre, in lspagna s tessa poteva aspettarsi da un momento all'altro una rivoluzione o una gueITa; invece era un calco lo ardito, una prova di sapienza politica " (39 > Tro vato rap idam ente un c redib il e p retesto , ricevuta la pronta benedizione di Paolo III , incassati i debiti finanziamenti , ad ini ziare dal gennaio del 1535 si att ivaro no i preparativi per la grand e spedizione navale. Andrea Doria, l ogicamente. assunse il comando della immensa flotta, mai vista fino ad allora ne l Mediterraneo.
11 12 gi ugno la grande armata al completo è alla fonda nella rada di Cagliari, dove attende di sa lp a re verso il suo obiettivo che , almeno fino a q uel momento, pochissimi conosco no . Il 13 le navi lasciano gli ormeggi ed il giorno dopo sono dinanzi a Tunisi. I dintorni della città vengono subito investiti: la Goletta è presa intorno al la metà di luglio. Poco dopo anche Tunisi è cost retta a cap it o lare: ben 21.000 schiavi c ri stiani vengono così liberati <4 01 • Tra loro diversi francesi che Carlo V invia al s uo ri vale con un'ironica missiva.
Ovviamente l ' ult edore ampliamento nordafricano della sfera di donùnio della Spagna, derivante dall'occupazione di Tunisi <41 > , non suscitò alcu n compiacimento nel R e di Franc ia, che vedeva compromessa pure l a sua sventurata a lle anza . Come se non bastasse, sopragg iun se in quei frangenti la morte di Francesco II Sforza, duca di Milano, ed il vuoto di potere, improvvisamente creatosi, ri acutizzò l e mire di Francesco I. Senza frapporre alcun indu g io, va licò ancora le A lpi ed invase nel '36 la Savoia, accingendosi a riprendere le ostilità in It alia, non senza aver piima rinnovato l'alleanza co n il s ultan o ed il Barbarossa.
Carlo V, a sua volta, penetrò in Francia dalla Germania e dalla Provenza appoggiando le truppe di
quel secondo fronte, co nd otte dal De Leva, con la flotta capitanata da Andrea Doria. La resistenza dei Provenzali e le funeste notizie dei raid del grande co rsaro, costrinsero in breve l'ammiragli.o imperiale a desistere dalle sue azioni. Le continue trame francesi, finalizzate ad indurre Venezia a schierarsi, per paura dei Turchi, al loro fianco, si risolsero, invece, in mani era diametralmente opposta, determinando una ripresa della guerra tra la Serenissima e la Porta. L ' incerto procedere delle operazioni campali francesi in Savoia, lasciando supporre al diffidentissimo sultano, una sorta di segreto accordo tra i due contendenti europei ai suoi danni , 1o indusse a ritirare la flotta ed a stipulare un accordo con Venezia sul finire ciel 1537.
È probabile che i timori di Solimano fossero qualcosa di più che semplici sospetti poiché, grazie alla mediazione di Paolo III , Frances co J e Carlo V alla fine accettarono di incontrarsi a Nizza per appianare le divergenze e magari per addivenire ad una lega contro i Turchi. Nel maggio del '38 , infatti, l'abboccamento ebbe luo go senza generare però la benché minima reciproca fiducia tra i partecipanti: unico risultato una tregua decennale tra Spagna e Francia. L' appartenenza del Regno di Napoli alla Spagna fu definitivamente ribadita.
Da questa necessariamente s chematica ricostruzione si evince come tutte le operazioni di dife s a, di conquista e di estrema resistenza delle varie forze
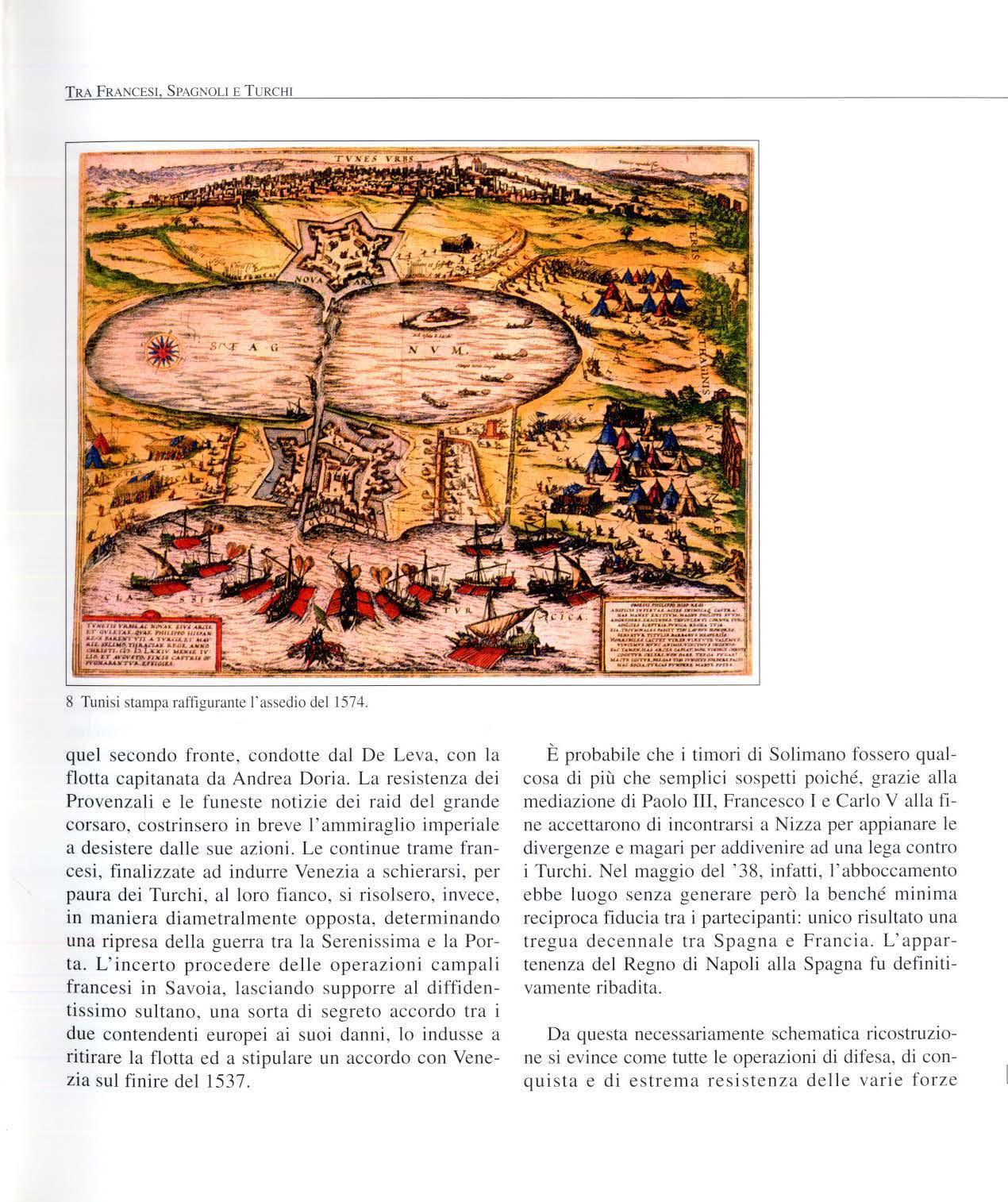
impegnate nella guerra tra Francia e Spagna, con la compartecipazione ottomana, ebbero per teatro principa le l'intera Penisola ed il suo meridione in particolare. Nel corso delle devastanti operazioni tutti i contendenti si erano avvalsi dell'appoggio delle fortificazioni esistenti. Eserciti. o formazioni armate aragonesi, francesi, spagnole e persino turche sistematicamente si batterono impiegando come basi, o investendole in quanto tali, le fortezze costiere del Regno e le sue principali piazzeforti marittime, fra le quali spiccano Taranto, Barletta e Gaeta , per non parlare delle minori, sempre d'indubbia validità.
Appare altresì evidente come purtroppo, l'alleanza franco-ottomana minacciasse proprio i tanti centri rivieraschi meridionali. È la prima conferma esplicìta che non si poteva essere sicuramente padroni del Regno senza il possesso completo di tutte quelle fortificazioni e che, soltanto la loro sistematica acquisizione. garantiva la certezza di una duratura occupazione. Come pure che l ' ingerenza turca se non debitamente neutralizzata e frustrata da una poderosa linea di fortificazioni avrebbe prima o poi avuto ragione di qualsiasi difesa, concretizzando la tanto attesa invasione.
Nessuna meraviglia, quindi, che la loro portata strategica ne uscisse così esplicitamente ribadita, come pure, e paradossalmente per lo stesso motivo, che assurgessero proprio per i Turchi a bersagli primari, altrettanti vani d'ingresso di un inespugnabile castello. La lezione venne chiaramente recepita dag l i Spagnoli, che, per tradizione militare e per recentissima esperienza , ne dedussero la priorità da accordare al potenziamento ed ali' aggiornamento delle stesse e per il completo assoggettamento del Regno e per la sua difesa contro ogni tentativo di conquista da qualunque parte provenisse. Tuttavia mentre si svolgevano le operazioni belhche ricordate, nel settore dell'architettura militare si verificò una tale serie di radicali trasformazioni <~2> , da rimettere completamente in discussione , non già i I ruolo del le piazzeforti, e più in generale di qualsiasi fortificazione ancorché dell'ultima
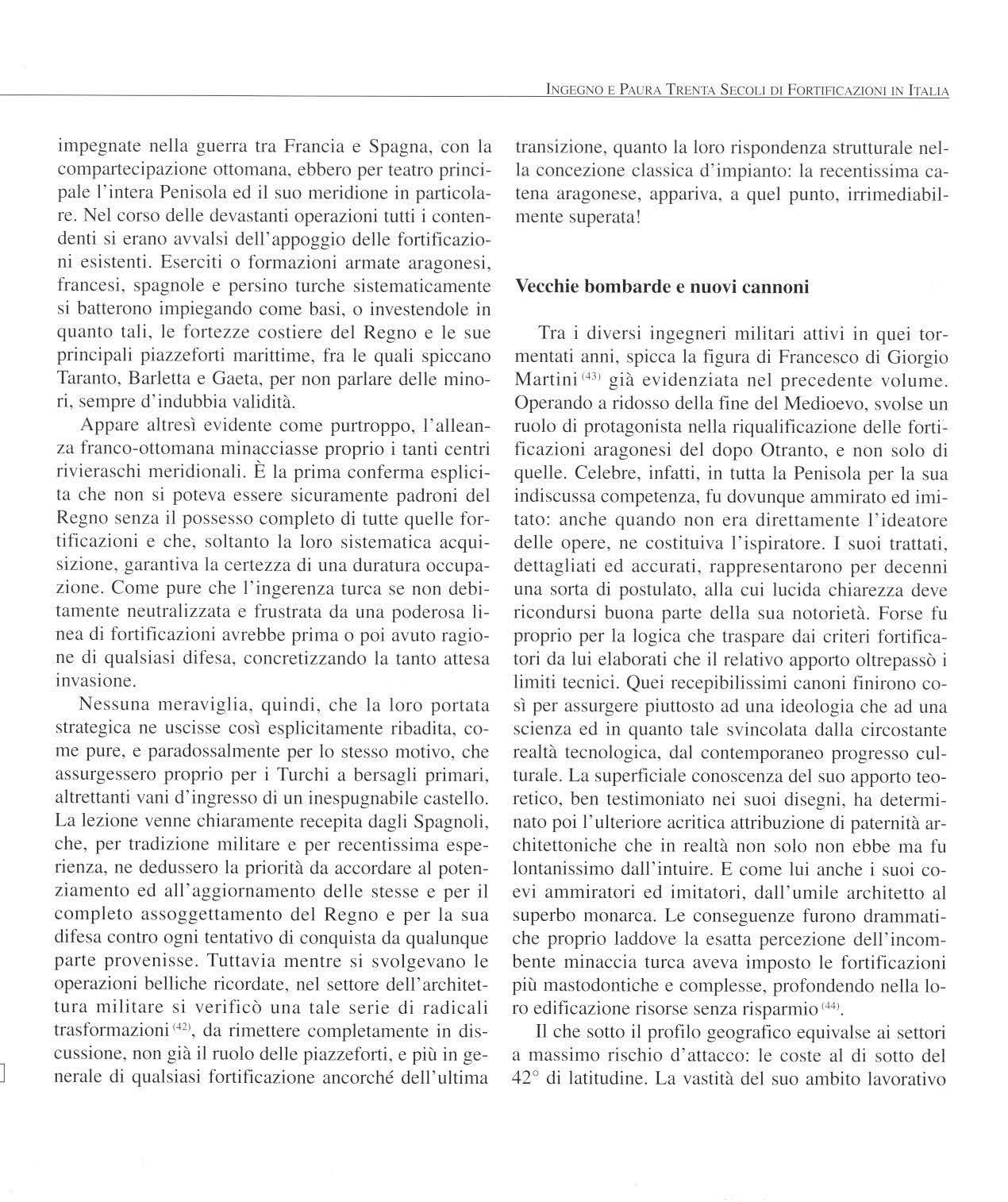
transi z ione, quanto la loro risponden z a s tmtturale nella concezione classica d'impianto: la recenti s sima catena aragonese, appariva, a quel punto , irrimediabilmente superata!
Tra i diversi ingegneri militari attivi in quei tormentati anni, spicca la figura di Francesco di Giorgio Martini (43 l già evidenziata nel precedente volume. Operando a ridosso della fine del Medioevo, svolse un ruolo di protagonista nella riqualificazione delle fortificazioni aragonesi del dopo Otranto, e non solo di quelle. Celebre , infatti, in tutta la Penisola per la sua indiscussa competenza, fu dovunque ammirato ed imitato: anche quando non era direttamente l'ideatore delle opere , ne costituiva l'ispiratore. I suoi trattati , dettagliati ed accurati, rappresentarono per decenni una sorta di postulato, alla cui lucida chiarezza deve ricondursi buona parte della sua notorietà. Forse fu proprio per la logica che traspare dai criteri fortificatori da lui elaborati che il relativo apporto oltrepassò i limiti tecnici. Quei recepibilissimi canoni finirono così per assurgere piuttosto ad una ideologia che ad una scienza ed in quanto tale svincolata dalla circostante realtà tecnologica, dal contemporaneo progresso culturale. La superficiale conoscenza del suo apporto teoretico, ben testimoniato nei suoi disegni, ha determinato poi l'ulteriore acritica attribuzione di paternità architettoniche che in realtà non s olo non ebbe ma fu lontanissimo dall'intuire. E come lui anche i suoi coevi ammiratori ed imitatori, dall ' umile architetto al superbo monarca. Le conseguenze furono drammatiche proprio laddove la esatta percezione dell ' incombente minaccia turca aveva imposto le fortificazioni più mastodontiche e complesse, profondendo nella loro edificazione risorse senza risparmio (44 i
Il che sotto il profilo geografico equivalse ai settori a massimo rischio d ' attacco: le coste al di sotto del 42 ° di latitudine. La vastità del s uo ambito lavorativo
dete rmin ò l'esigenza di avvalersi di numerosi allievi ed assistenti , alcuni dei quali meritatisi in seguito una propria autonoma e meritata reputazione, a ltr i in vece so pravvi ssuti come meri r ip etitori dei suoi superati canoni. Fra q uest i sp icca no Anto ni o Marchesi da Settignano, Baccio Po nt e lli e Ciro Ciri.
Ma al di là dell'indubbio prestigio di cui tutti quei celebri tecnici godettero a l loro tem p o, sia pure in quanti tà più o meno rilevante a seco nd a della notorietà delle rispettive costruzioni m i litari, nel complesso la loro opera, come g i à stigmatizzato <-15> , tradisce una sensibile a rr etra t ezza. D e fi c ie nza che potrebbe tra l'altro spiegare, in discreta mis ura, i tanto fulminei s ucce ssi degli eserciti francesi che invasero l'Italia negli ultimi anni del Quattroce nt o. Ed un a similare arretratezza delle boc che da fuoco, se nza dubbio ca usa piuttosto c he effetto della prima, che attinsero in quegli stess i a nni va l enze artistiche straordi n ar i e e pres ti g iose senza però subire un'equivalente evoluz ione funzionale. Le artig li erie nostrane , infatti , continu arono ad essere cost ruit e seco nd o i medesimi criteri del secolo precedente, non s ub endo un analogo proc esso rie labora ti vo di quello francese (46 > D al che non evo l ve nd osi l 'offesa no n s i evo lse neppure la dife sa : al più di venendo più grosse e fastose le bocche da fuoco divennero più grosse e fas to se anc he l e fortificazioni. Gro sse però non s ignifi ca grandi, c io è meno ro zze e d infantili. A vo l e r meg lio inda gare in mate ria di artiglieria l ' ultimo decennio del '400 in It alia costituisce uno s nodo cr itico , caratteri zza to d a du e ben di s tinte fasi.
La pr i ma può de fini r si la pura contin ua z i o ne della tradi zio n e con grande sfoggio di ornamenti e di preziosità s up e rflu e, quasi che essendosi ormai att int o l 'a pice tecnologico fosse p ossibi l e soltant o dedicarsi alla decora z ione artistica accessoria! Ed anche in que s to l e bombarde gettate dal Martini , con l e l oro rnagi stra l i ornamentazioni, squisi tam e nt e rinascimentali e la loro ass urda manovrabilità appaiono un'indubbia conferma d e l la ri co rdata arretratezza. L a seco nda fase , pertanto, dop o la brutal e presa di co -
scienza della tecnologia francese, per tanti versi alternativa, si trasforma in una spasmodica corsa a copiarne g li standard anc h e in maniera approssimata. Ovvio che gli Stati più attivi e solerti in quella onerosissima riqualificazione furono quelli più direttam ente co in volti con l a guerra contro l ' lm pe ro ottomano e più ricchi: identikit che calza a perfezione alla Serenissima e, per facile intuizione , per nulla allo Stato della Chiesa.
Emblematicamente si rintraccia nelle font i, infatti, che Venezia: " ... non procede allo svecchiamento delle proprie artiglierie pesanti prima del 1496. Il Sanuto nei suoi Diari ci informa c he in tale a nn o i veneziani fabbricano cento bombarde grosse "al costume et modo che usa no i Francesi", cioè rinnovando una buona parte dell'intero parco delle loro artiglierie d i grosso ca libro. Questi armamenti sono fabbricati in parte da fonditori di origine veneziana, che avevano appreso l'arte al servizio dei re francesi" l47 l Qu a nt o in comparabilmente diversa potesse essere la situazione in materia lo dimostra lo Stato della Chiesa. Sempre dalle fonti sappiamo , in fatti, che le malconce a rti glierie delle sue fortezze, agli inizi del ' 600 vantavano una età media di se r vizio di c ir ca un a settant i na d ' anni , per cui molti ca nn o ni so no a ncora della tipologia precedente alla calata di Carlo VIII! E non è a nc ora tutto , perché o ltre a ll a loro preoccupante vetustà quei cannoni vantavano un assortimento anarchico di ca libri , per c ui poco mancava c h e ad ognuno dovesse co rri spondere una apposita pa ll a! Il fenomeno, da un certo momento in poi man i festò in pieno tutta la s u a penalizzante conseq u e n z i alità: impossibile disporre di adeg u ato munizionamento, difficile di scernere rapidame nte i calibri, lentissime le forniture, tanto per cita re le principali deficienze. Bi sognò atte nd e re quasi la metà del XVII seco lo perché so tto Urbano VIII, che si di s tin se per l ' impul so c he impresse alla produzione di bocche da fuoco, s i te nta sse finalm e nt e di razionalizzare e ridmre i calibri. Eccone un preciso riscontro in un a nota redatta in appendice ad un inventario del maggio 1643 compi lata da V. Spada c he , l a me ntand o l a questione ,

proponeva al contempo una facile soluzione: " ...Maggior mancamento è che li 44 cannoni che sono nella fortezza ... hanno 20 calibri e quel ch'è peggio pochissimo differenti conseguentemente facili a s bagliars i l'uno dall'altro con pregiudizio grande, e rischio maggiore di chi serve al cannone, ha procurato di rimediare a quest' inconveniente il castellano con tenere le palle separate [le famose 46 piramidi n.d.a.J confanne alpeso con assai buon ordine e molta diligentia, e veramente non si poteva poner altro rimedio, ma con il tempo si potranno ticonoscer bene i pezzi e trovandosene de ricchi assai di metallo, come facilmente se trova fra i più vecchi, trivellare quelli di minor calibro et uguagliarli a maggiori più prossimi come quei di 20 a 22, di 50 a 55 e simili, ma que s ta non è cosa da ponervi le mani hora. Ma è operatione che chi ha l'autorità deve a poco a poco andarla eseguendo .. :· <48 J
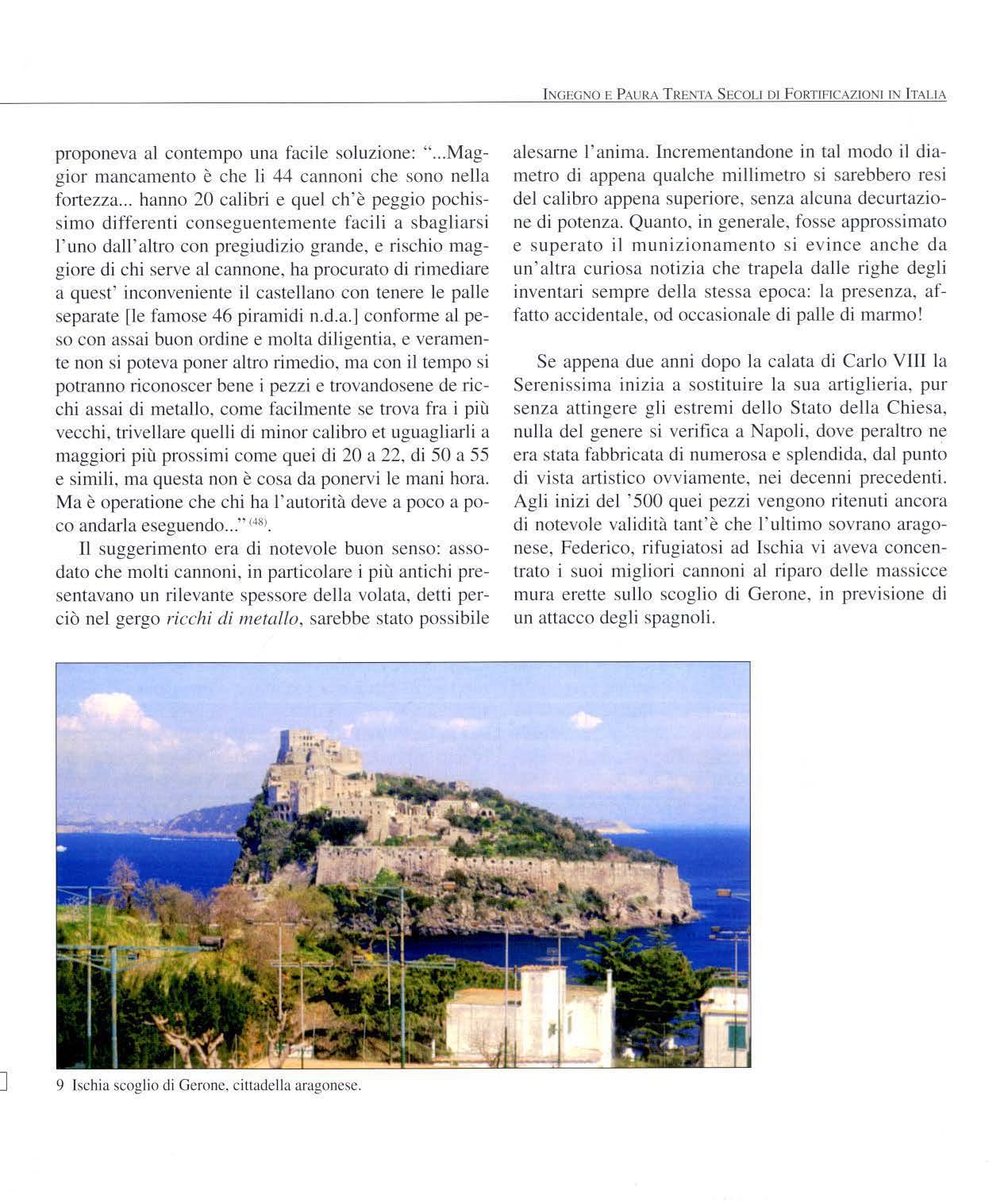
Il suggerimento era di notevole buon senso: assodato che molti cannoni, in particolare i più antichi prese ntavano un rilevante spessore della volata, detti perciò nel gergo ricchi di metallo, sare bbe stato possibile
alesarne l'anima. Incrementandone in tal modo il diametro di appena qualche millimetro si sarebbero resi del calibro appena superiore , se nza alcuna decurtazione di potenza. Quanto. in generale, fosse approssimato e s uperato il munizionamento si evince anche da un'altra curiosa notizia che trapela daile righe degli inventari sem pre della stessa epoca: la presenza, affatto accidentale, od occasionale di palle di manno!
Se appena due ann i dopo la calata di Carlo VllJ la Serenissima inizia a sostituire la sua artiglieria, pur senza attingere gli estremi de llo Stato della Chiesa, nulla del genere si verifica a Napoli, dove peraltro ne era s tata fabbricata di numerosa e splendida, dal punto di vista artistico ovviamente, nei decenni precedenti. Agli inizi del '500 quei pezzi vengono ritenuti ancora di notevole validità tant'è che l'ultimo sovrano aragonese, Federico , rifugiato s i ad Ischia vi aveva concentrato i suoi migliori cannoni al riparo delle massicce mura erette sullo scoglio di Gerone , in previsione di un attacco degli spagnoli.
Il temuto invest im ento non avvenne ma il regno fi!Ù l o stesso nelle loro mani ed il vecchio re, pur di non finire Joro prigioniero si consegnò ai Francesi trascorr e ndo es ili ato presso l a loro corte gli ultimi an ni. Quanto all e s ue eccezio n a li arti glierie finirono sve ndute , po chi mesi dopo , per meno della quarta parte del valore originario a due Capitani della squadra pontificia, c h e, caricati li sulle l oro galere, guadag n ata la foce del Tevere e risalito il fiume sino a Castel S. Angelo, ve li scrui carono . L a loro destinazione non furono le cannoniere d e ll a fortezza ma le sue sa le int erne, essendo già ritenuti un magnifico reperto museale di un 'e po ca esa uri tasi da Lempo!
Facile immaginare, a questo punto, quale po t esse essere non tanto lo stato di conservazione delle fortificazioni del reg n o di Napoli, per molte delle quali la calce era ancora fresca , ma la l oro adeguatezza ai crite ri progettuali dettati dalle nuove potenzialità offensive. Nel migliore dei cas i si trattava di strutture in grado di sostenere una discreta resistenza passiva grazie alla loro mole, se n za per questo evitare l'espugnazion e. Uni ca n ota pos iti va della v icenda che anc h e i Turchi non di sponevano ancora di artiglierie mode rn e, conced e nd o per ciò ai principali caposaldi della fronti era mru·ittima una in spera t a dilazione per rimed iare a tanta insipienza tecnica e militare.

La tesi non deve appar ire eccess iva, data l a radicalità e la rapidità delle trasformazioni de11'architettura militare manifestatesi a partire dal decennio s ucc essivo, es ito a sua vo lta dell'altrettanto stravo l gen te evoluzione d e lle bocc he da fuo co il c ui debutto era avvenuto non a caso negli arsenali frru1cesi. P er i maggiori stud iosi d e l setto re : " il vero progresso delle artiglierie da fuoco co minciò nel XV I seco lo quando, c io è, tecnici e principi cominciarono a persuadersi della necess it à di s ottopoITe la costruzio ne e l ' uso a regole detemùna-
te Ne l seco lo xvr, dopo la calata di Carlo v m, le artiglierie si modificarono ancor più: l'invenz ione degli orecchioni e la generale adozione di palle metalliche sono i due fatti p iù salienti dell'epoca , perché ad es s i si deve l ' accresciuta potenza delle bocche da fuoco le quali, diventate nel tempo stesso di minor peso, po terono e s sere incavalcate su affus ti leggeri e trainate da rapidi cavalli , anziché , come per lo innanzi , da buoi tardi e lenti. Di questo progresso devesi dare gran parte il merito ai Fra nc esi e da quanto scrissero in proposito g li storici , chiaramente risulta che il p1imato dell ' artig l ieria, da niuno contestato agli Italiani nell'intervallo dal 1350 a l 1450, passò poi a que lli " <49>
Non è pertanto affatto casua l e che nello s tes s o scorcio storico la fortificazione di matrice italiana ven i sse cooptata dovunque, essendo la più sicura ed efftcace, si tu azione c h e si 1iprop0ITà so lt anto dopo il primo decennio del XVI, quando nuovamente l ' architettura militare italiana tornerà a dettare legge in materia. Un buco. q u indi, di una vent in a d'anni corrispondent e esattamente, e logicamente, al predominio incontrastato dei cannoni francesi che decretru·ono, per quanto delineato , la scomparsa della fo11ificaz io ne di concezione antica, ancorché di canoni di tran sizione, senza però sugge1ire nulla di alterna ti vo e soprattutto senza c h e se ne potesse minimamente intuire se e come ciò sarebbe accaduto.
Qu ando i moderni cannoni, ben esemp lifi cati dalla trentina trascinatasi dietro da Carlo VIII nelle sua ca lata d e l 1494 (50 1 , comi nciarono a diffondersi, ini z iò l a rapida agonia della fortificazione di transizione. Negli a nni immediatamente s u ccess i vi quei rivoluzionari criteri costru tti vi cono bb ero ulteriori evo luzio ni fino a p ervenire alla realizzazione dei pezzi s t a ndard i c ui cano ni e co nn o t az i o ni , senza sostanzia li modifich e, o appariscenti ri e labora zio ni , troveranno adoz i one per i successivi tre secoli. Estremizz a ndo la tes i , quanto delineato sta r ebbe a dire che in pochi decenni fra le fortificazioni e l e art ig li erie si man ifes t ò un divario tecnologico di qualche mi1lennio: ce r c hi e di co n cezione romana cannoneggiat e da [
batterie napoleoniche! Lo smarrimento professionale tramandatoci negli scritti di quei tecnici di fronte alla innegabile supremaz i a ormai acquisita da11 · offesa, tradisce senza alcuna reticenza quel drammatico disso lversi di un'intera certezza architettonica, imperante da oltre tremila anni (5 1>
A co ntribuire alla s ua dissoluzione giocarono due tendenze polemologicamente antitetiche sebbene. nella fattispecie, congrue fra l oro . Da una parte infatti la potenza del tutto inedita delle nuove armi implicava la realizzazione di opere effettivamente capaci di sopportare con minor danno po ss ibile le loro offese. Allo scopo prob abi lmente la soluzione più se mplice ed intuitiva sarebbe consistita nel defilare le fortificazioni facendo le sprofo ndare nei fossati in modo da lasciarne pochissima emergenza sul terreno circostante, g iusto quanto bastava per spazzarlo con un leggero armamento. Ad una impostazione del genere sembrano ri-
farsi alcuni st udi di Leonardo 151 > ed alcuni grafic i di Francesco di Giorgio Martini , a ll orquando tentano quasi in extremis di adeguare l'ultima generazione di difese alle mutate potenzialità offensive.
La concezione tuttavia ostentava alquanti gravi inconve nienti che la resero puramente teorica: st rutture siffatte non esercitavano alcun dominio tattico su lla campagna circostante e la loro interdizion e attiva non eccedeva le poche centinaia di metri del tiro te so dei piccoli calibri. In altri termini fortificazioni del genere sarebbero ricadute sotto il tiro parabolico dei mortai. di per se scarso ma in que sto caso sufficiente a dist rugg erle, se nza poterlo controbattere. Senza contare che non disponevano di alcun espediente per sopportare impunemente g li impatti balistici, altro requisito basilare indi spe n sabi le per frustrnre l'offesa balistica. In ultima analisi si sareb be trattato piuttosto di tane che di fortezze!
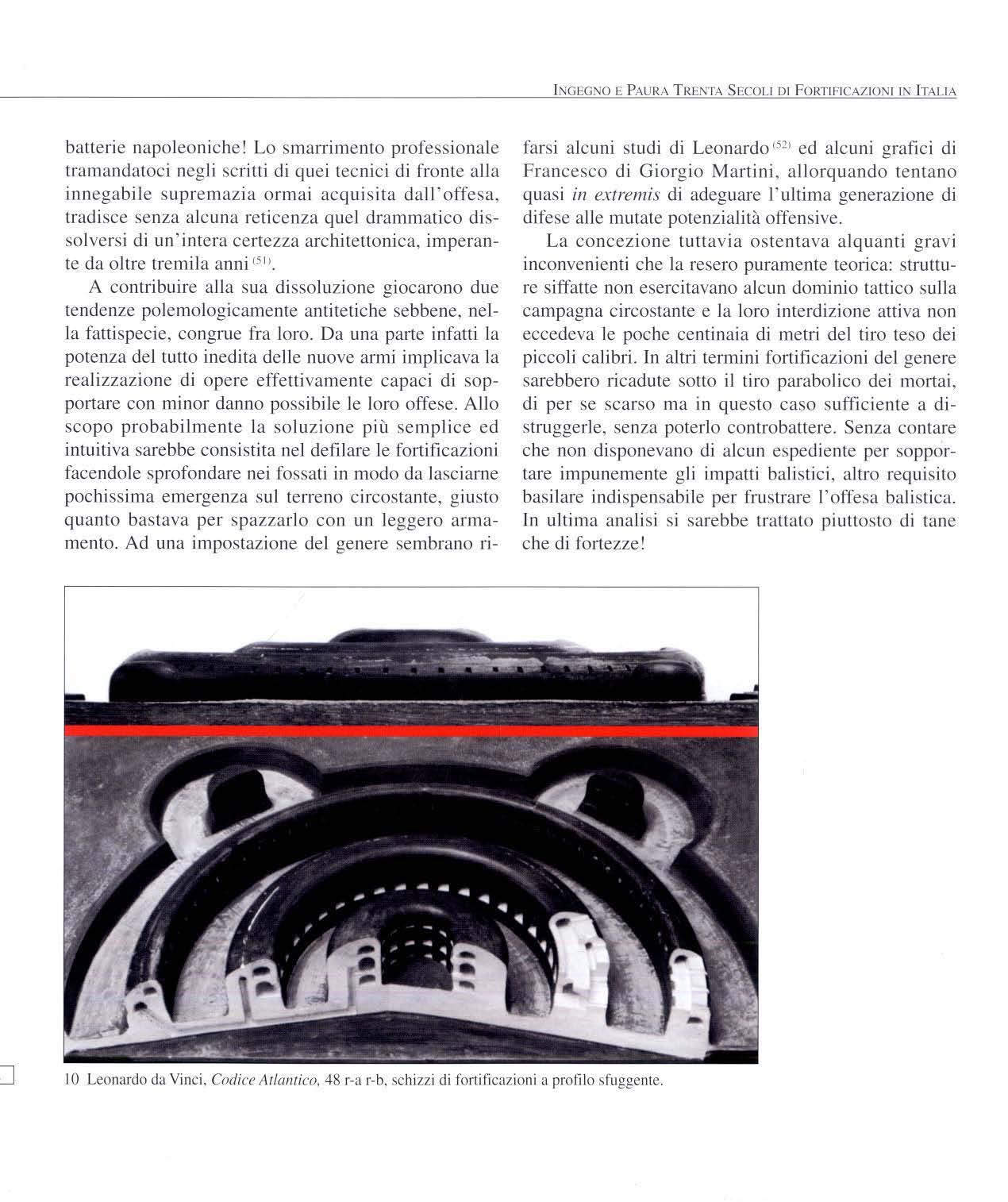 lNGEG:-lO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTI FICAZIO NI IN l TAI.IA
J
IO Leonardo da Vinci. Codice Arlan ri co. 48 r-a r-b. schizzi di fortificazioni a profilo sfuggente.
lNGEG:-lO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTI FICAZIO NI IN l TAI.IA
J
IO Leonardo da Vinci. Codice Arlan ri co. 48 r-a r-b. schizzi di fortificazioni a profilo sfuggente.
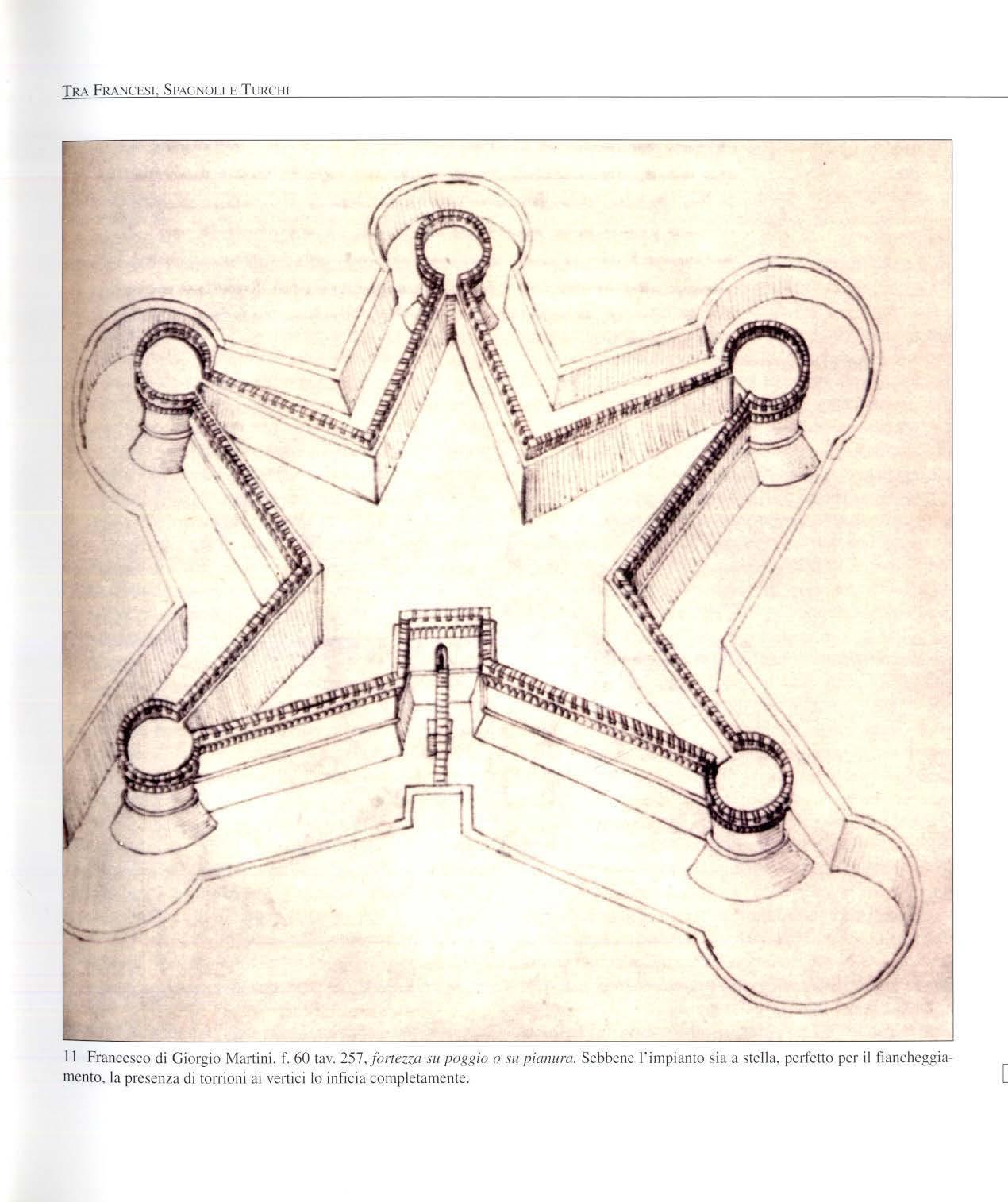
Il ca nn one deter min a ed impone la trace italienne
Il cannoneggiamento concentrato, infatti, eseguito dalle evolute artiglierie della fine del XV secolo, con le micidiali palle di ferro, sotto i cui impatti di inedita violenza scrosciavano le mura di medievale concezione, quando non anche fattura, era riuscito finalmente ad infrangere lo stallo della transizione. Anzi la predominanza dell'offesa fu talmente sproporzionata ed irreparabile che per alcuni anni si mise addirittura in discussione, in maniera lacerante, l'intrinseca validità della fortificazione permanente, paradossalmente ormai troppo vulnerabile, troppo fragile ed incapace di reazione adeguata omogenea ed isotropa. La configurazione stessa d'impianto, infatti, non consentiva di eliminare gli angoli morti che rendevano settori più o meno ampi completamente defilati al tiro di fiancheggiamento, trasformandoli perciò in altrettante vie d'attacco insidioso. In sostanza essendo la fortificazione un coacervo di espedienti strutturai i per rendere meno vulnerabili i suoi difensori ed al contempo più letale la loro reazione, a quel punto sembrava tragicamente privata di entrambe le connotazioni peraltro esiziali. ln pratica le due peculiarità precipue di ogni opera, meglio note come difesa passiva e difesa attiva erano state pressoché annientate dalle artiglieri e francesi: e senza la contestuale presenza di entrambe qualsiasi fortificazione cessava di essere la difesa per antonomasia trasformandosi in una funesta trappola, come aveva tragicamente sperimentato la guarnigione di castello di Monte S. Giovanni nel 1495. La minacciosa fortezza insediata sulla linea del Liri, fresca reduce di un violento investimento ossidionale protrattosi vanamente per ben sette anni, sembrava l'ideale per annientare la terrib i le sensazione di debolezza che la sola vista dei ca n noni francesi avevano suscitato scendendo lungo l'Italia. Napoli riponeva ancora una volta nella sua resistenza una incrollabile fiduc ia. Purtroppo però a differenza dei precedent i episodi, le inviolate mura dopo appena quattro ore di cannoneggiamento apparivano sgretolate in più punti in maniera irrepara-

bile. Dalle brecce ancora avvolte in una densa coltre di polvere gli attaccanti iITuppero al suo interno. Nel giro di un altro paio di ore quanti erano scampati al fuoco, per lo più contadini del luogo, finirono massacrati all'arma bianca. La ferale notizia dilagando per il regno confermò persino ai più ostinati che l'epoca dei castelli era a quel punto definitivamente esaurita.
E proprio sotto la pressione della necessità difensiva, in parole povere della paura , l'ingegno dei tecnici italiani, in quel brevissimo volgere di un paio di decenni, elaborò i nuovi canoni guida della fortificazione. Esattamente come i coevi cannoni quei criteri e quelle configurazioni sarebbero rimasti sostanzialmente immutati per i successivi tre secoli, capisaldi teoretici di quella che sarà dapprima la trace ìtalienne ed in seguito diverrà per tutti il fronte bastionato c53> _ Canoni senza dubbio rivoluzionari ma che , in estrema sintesi, possono per grande approssimazione ridursi a due , ovvero la terrapienatura delle opere esposte al fuoco e I' eliminazione assoluta, dei settori defilati: cioè una riformulazione della difesa passiva ed una altrettanto radicale di quella attiva.
Ovviamente essendo prioritaria la sopravvivenza la più importante delle due fu senza dubbio la prima, ovvero la capacità di rendere le nuove fortificazioni invulnerabili ai cannoni. E se per reiterate conferme la durezza dell ' estradosso delle opere, per lo più grossi conci di pietra viva, si era dimostrata inutile si provò con un espediente diametralmente opposto!
U n a prima significativa manifestazione di tale concezione è possibile coglierla durante l'assedio di Costantinopoli. Stando alla cronistoria redatta da Critobulo di Imbro < 54 J per ordine del comandante del contingente genovese Giovanni Giustiniani Longo , il 18 apri l e del 1453, minacciando un paio d i bombarde turche - il cui calibro deve ritenersi rispettivamente di circa 400 mm la più piccola e di circa 800 mm la maggiore - u na ristretta sezione delle mura della città, venne accatastato, nel corso della notte, dinanzi alla stessa un enorme cumulo di balle di lane. L'espedien -
te , tuttavia non sembra esse re riuscito pie namente, ma costituì comunque un indubbio precedente, sebbene appare credibile che già in quella tragica circosta nza dovesse va n tare più antic he app l icazioni. Non s i s pi egherebbe altrimenti come, nonostante la sua scarsa validità, fosse non so l o divulgato nei dettagli m a s ubit o recepito e riutili zzato di lì a breve anche nelle guerre europee ed in Italia in particolare . Per nulJa inverosimile che a d i ffondere l'episodio siano sta ti g li s tessi mercanti , per lo più italiani, danneggiati prima ancora che dalla vittoria turca dalla requisizione della lana . Ad ogni buon conto, comunque lo avesse appreso è certo che pe rs in o Michelangelo una se ttantin a di anni dopo ripropose quel medesimo rimedio in occasione dell'assedio di Firenze. Per l 'esattezza : " .. . il 29 ottobre 1529 fu tirato il pr im o co lpo di artiglieria sulla città, diretto contro i l campanile di San M i ni ato . Il vecchio bombardiere , dal quale dip endeva no i d ue pezzi leggeri collocati l assù, aveva tutt o il terreno davanti a sé che si stendeva come una carta geografica ed era in grado di vedere e disturbare il minimo movimento dei nemici , fino al cambio della guardia. Attrasse perciò subi to il fuoco nemico. Il primo giorno solo esso ricevette non meno di 50 p alle, molte per que ll 'e poca. Era un obiettivo so ttil e, ma co n l'intensità del bombardam e nto alcuni colpi trovarono il bersag li o, e non molti s arebb ero stati necessa ri per abbatterlo. Michelangiolo ebbe l ' idea di rin forzar l o e proteggerlo con balle di lana che ottenne dall'Arte della L a n a. Ne furono i mpie gate più di 18.000 a mmu cc hiandol e a terra per prote ggere i fondamenti e facendone pendere a ltr e dall'alto per attutire i co lpi ... " 155 l Ma a quell'epoca il criterio delle te1npienature delle fronti es po ste a l t iro nemic o, cioè della difesa ad asso rbim ento d'urto, era ormai un dato acqu i sito nelle fortificazioni che andava a d integrarsi per il medesimo risultato di ridurne la vulnerabilità co n l 'altro relat ivo a l m assi mo defilamento di tutte le strutture sprofonda ndol e ult eriorment e nel fossato, esattamente come un so ld ato in una buca o in un a trincea.
T rascurando quel significativo rimedio, relegandolo magari a espediente campale occasionale ed es temporaneo , la vera genesi tecnica della concezione soffice delle mura sembra scatmire proprio dallo stallo degli investimenti ossidionali condotti con le attiglierie . Non doveva essere sfuggi to, infatti, agli ingegneri militari più attenti, se mpre presenti nel corso degli assedi, che, superata la p1ima fase dello s mantellamento delle fortificazioni tramite i l can no neggiame nto e ridottesi que ste ad un cumulo informe ed incoerente di macerie, le palle d'artiglie1ia non riuscivano a spianarle ulteriormente. Quella so1ta di scru·patura di detriti asso rbiva passivamente i proietti senza modificare affatto il suo assetto volumetrico-spaziale e senza trasmettere alle s ue s palle alcuna sollecitazione. Da puro ingombro il mucchio di maceri e s i era trasformato in un ostacolo insormontabile per qualsiasi volume di fuoco, per quanto violento potesse essere. Ed anche di questa constatazione se ne cog li e una esplicita annotaz ione nelle pagi ne del vescovo Leonardo di Chio , sempre relative all'assedio di Costantinopoli del 1453. Precisava infatti l ' illu stre prelato che:

" hombardae, s i aderant, in co mmodirate fo ci primum lwstes offende re, ma cerie bus alveis t ec to s, non poterafl/ le bombarde, quando c'erano, per la posizione sfavorevo le i11 cui si u-ovavano. non erano in grado di offendere i nemici. che si riparavano dieu-o le macerie e nelle buche .'' '~6
L'ostacolo soffice, e l a col locazione più bas sa e defilata pertanto rappresentò la prima auspicata so luzione. Si trattava, in sostanza, di un ribaltamento radica le di concez io ne : no n più un estradosso compatto e duri ss im o, come fino al lora sc ru polosamente pe rseg uito, ma al suo posto un morbido argine di terra lievemente compattata, per consentire l ' innocuo scaricarsi d e ll 'e ne rgia c in et ica res idu a dei p ro ie tti. Per usare una terminologia contemporanea, si potrebbe ragionevo lm ente parlare, in merito al criterio informatore, di difesa a d ' assorbimento d'wto'. Ad otti mi zzru·e l'idea rendola s uscetti bile di applicazioni efficaci contrib ui va, lo gicamente, un amp i o corollario di articolazioni
accessorie , ciascuna delle quali di per sé non inedita, dettate e consentite dalle stesse armi da fuoco. Tra queste ad esempio il ricorso ali' appoggio reciproco delle sezioni di cerchia e l'abbassamento dei grossi pezzi d'interdizione verso il fondo del fossato per consentire un tiro radente e fiancheggiante: ma la rivoluzionaria novità fu la ten-apienarura. In pratica ogni opera per resistere ai tiri delle nuove artiglierie si sarebbe dovuta trasformare in una sorta cli circuito chiuso, più o meno ampio, di materiale incoerente a bassissima compattazione. Incredibilmente, almeno sotto tale profilo, la preistorica fortificazione degli aggeri di terra di riporto ricavata dallo scavo dei fossati ed ammassata sui loro cig li interni sarebbe risu ltata ideale, nonostante gli o ltre trenta secoli di evo lu zione tecnologica intercorsa! Il paradosso nella lunghissima storia della fortificazione non sarà né il primo né l'ultimo: basti pensare, ad esempio, ai rifugi antiatomici, del tutto simili a profonde caverne sotterranee, più o meno artificiali, capaci di difendere come già le remotissime abitate dai primi uomini, soltanto grazie aJla loro inviolabilità passiva.
Defilare e terrapienare le fo1tificazioni avrebbe certamente consentito di renderle estremamente resistenti, forse addùittura indistruttibili alle offese delle coeve aitiglierie. Ma ciò non avrebbe sig ni ficato automaticamente l ' inespugnabibtà delle stesse non limi tandosi mai alcun investimento al solo cannoneggiainento Ad un tradizionale assalto condotto con le ultramillenarie sca le un'opera del genere , priva cioè di una temibile e razionale difesa attiva mediante aitiglierie della stessa concezione tecnologica, sarebbe caduta in pochi minuti. Conseguita perciò una discreta invulnerabilità occoITeva però che venisse fornita a JJ e fortificazione anche una potenzialità offensiva congrua ai nuovi cannon i, capace cioè di esa ltarne al massimo le prestazione eliminando perciò la precedente inadeguatezza e, soprattutto, ogni angolo morto ed ogni settore defilato esterno a l perimetro.
In pratica essendo la difesa un'azione statica che non implicava perciò alcuno spostamento delle artiglierie , meno che mai lu nghi trasferimenti su l terreno , si sarebbero proficuamente potuti impiegare addirittu-
ra pezzi di gran lunga più potenti e pesanti di quelli d'assedio e campali, sempre però della s tessa tipologia. Per molti versi era la medesima situazione vigente alle spalle dell'armamento navale, dove movendosi le navi, ma restando fermi i cannoni la massa di quest ' ultimi non contemplava estremi tassativi o limiti di sagoma insormontabili. Libertà che consentiva, situaz ione protrattasi fino all'ultimo conflitto, dimensioni della volata e calibri assolutamente giganteschi rispetto alle coeve artiglierie ten-estri Di più, schierandosi lungo i parapetti come lungo le murate , i relativi affusti da un certo momento in poi iniziarono ad ostentare analoghe conformazioni, che divennero praticamente identiche nelle batterie destinate alla difesa costiera.
La propizia opportunità di poter avvalersi di cannoni indipendentemente dal loro peso e quindi di straordinaria potenza e gittata , rese ancora più impellente cancellare, una volta per tutte, il famigerato settore defilato, deficienza che nel frattempo aveva avuto modo di mostrare in pieno le sue nefaste potenzialità, in particolare dopo il 27 novembre del 1495. Nella circostanza a Napoli poco prima della mezzanotte il Martini, concretizzando un'idea del Taccola fece saltare in aria tramite una mina una larga sezione della cortina del Castelnuovo. L' impiego di mine 157 l nelJa storia della fortificazione si perde nella notte dei tempi , avviandosi tutte da uno scavo aperto o dietro massicci ripari o in un settore defilato. La mina del Martini in ciò non differiva dalle antenate, ma negli effetti rappresentava un'assoluta novità: fu , infatti, la prima mina esplosiva della stori a e la sua realizzazione sfuggì aJle cannonate della difesa proprio perché notevolmente fac ili tata daJla presenza, dinanzi al piede dei to1Tioni di vaste aree defilate , dove cioè i tiri di fiancheggiamento della dife s a non potevano arrivare e quelli ficcanti si potevano facilmente neutralizzare (58 l
Che la guerra sotterranea si avvalesse contemporaneamente di tecniche di approccio preistoriche e di tecniche distruttive aJl'avanguardia , non deve st upire eccessivamente per la stretta interdipendenza concettua le fra le due. Ri sapendosi che dinanzi a tutte le for-
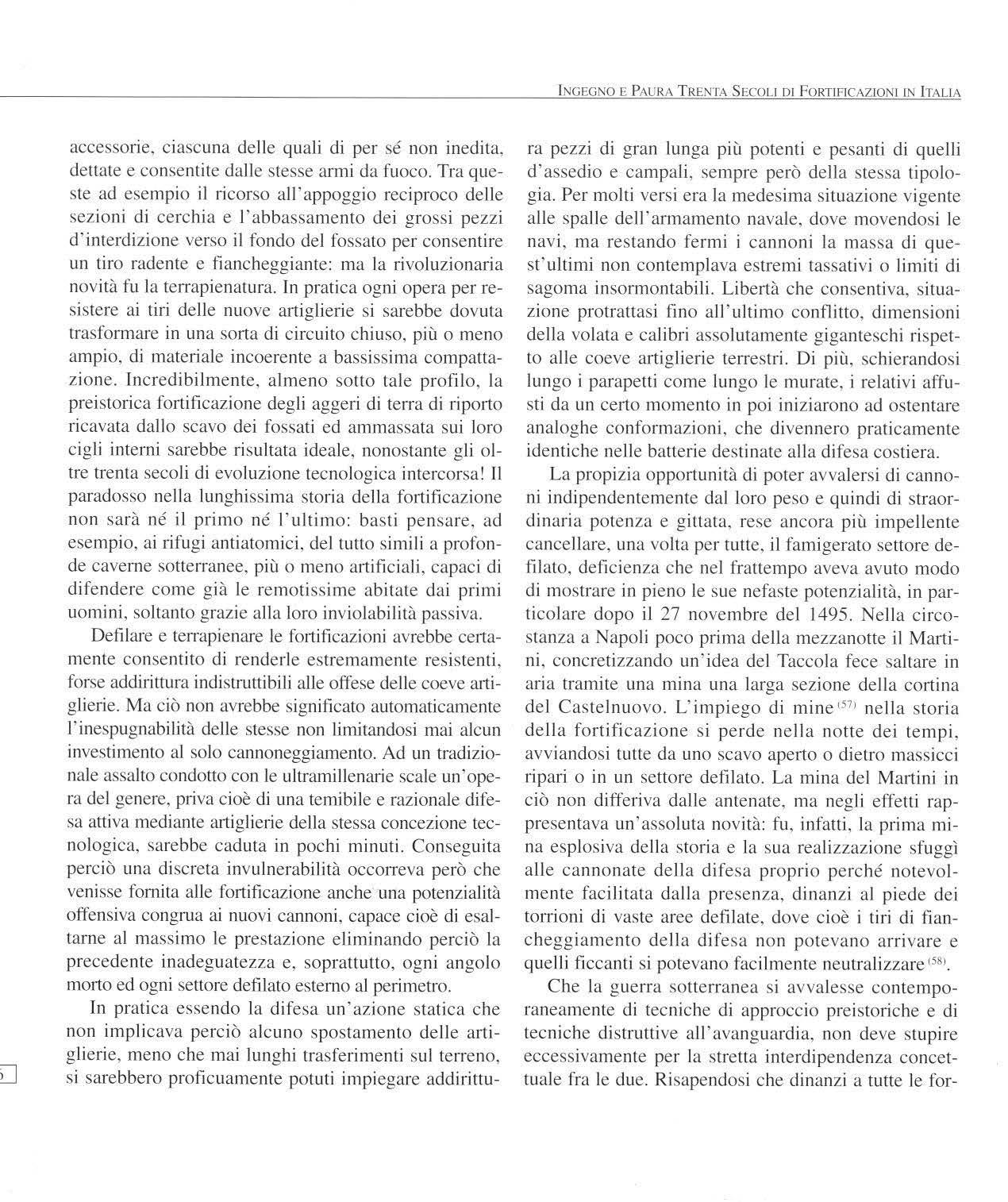
tificazioni della transizione, ed in particolare dinanzi ai loro massicci torrioni, esistevano settori non raggiungibili in alcun modo con le artiglierie di qualsiasi tipol ogia fossero sta te, fu ovvio avviare l a testa delle mine proprio da lì, portando a coincidere l'unico punto battibil e di tali gallerie con quello spazio non battibile. Avv iando lo scavo di una galleria da mina in un settore defilato , a n c h e disponendo di ca nn on i modernissimi e di grosso calibro sarebbe risultato impossibile far co nvergere le loro traiettorie sull'imbocco della galleria. D el tutto inutile il tiro ficcante, esse ndo improba la punteria, molto obliqua la traiettoria e pertanto fac i Imente n eut r a ! izzabile l'impatto con opport un e sc h ermature, q u a li gabb io ni di terra e tronchi d'albero <59l _ La vera soluzione sarebbe stata q u ella di e liminare drasticamente ogni sia pur minimo a ngo lo morto ,

ovvero elaborare inediti schemi planimetrici tanto più che i tradizionali non risultavano compatibili con la difesa ad assorbimento d'urto. Senza contare che anche l'adozione dei nuovi cannoni in fazione difensiva, implicando per gli stessi appositi appostamenti in barb et ta o in casamatta, a secondo se all'esterno sulle piazze o all'interno dietro le mura, non appariva in entrambi i casi adattabile alle tozze muraglie ed agli irrazional i perimetri dell'ultima transizione. Come se non bastasse persino sotto il profilo della mera resistenza, statica e dinamica, l'accresciuta reattività di quelle artiglierie impediva apparentemente ovvie e s brigative sostituzioni con le più antiche reimpostandole sulle coperture delle torri o sugli spalti, troppo deboli per sopportarne le sollecitazioni e troppo angusti per consentirne la manovra finendo per decurtarne le potenzialità ostative nei rari contesti di sufficiente solidità per un semplicistico avvicendamento. Il già citato vescovo, dimostrando una competenza militare assolutamente anormale per l 'e poca, osservava che persino le mura di Costantinopoli, di leggendaria solidità e grandezza non risultavano idonee alle bombarde della difesa, appena più recenti. Ricordava infatti che:
" Nam si quae magnae eremi. ne murus concuteretur 11oste1: quiescebant; imerdum in cuneos hoslium emissae, et ho111i11es et tentoria extermi11aba111 ...
I n effetti le nostre bombarde, quando era no di grosso cal i bro, dovevano tacere, perché altrimenti sconquassavano l e nostre stesse mura; ma quand o potevano sparare contro le formazioni nem iche, falciavano uomini e tende .'' ""'> .
Le bocche da fuoco di t ipo francese, senza dubbio più leggere delle vecchie bombarde a mascolo, grazie alla m aggiore resistenza delle palle di ferro impiegavano tuttavia cariche di lancio non di molto i nferiori alle precedenti determinando perciò reaz ioni appena più modeste. Ma il minore ingombro di quei pezzi co n se nt e nd o di istallarne in maggior numero mo lt iplicava le sollecitazion i divenute, pera l tro, frequentissime per l a loro eccezionale cadenza di fuoco e ben poche strut tur e della transizione risultavano in grado
di sostene r e a lun go quel tormento. Oper e inadatte quindi al nuovo armamento e, per conseguenza, inadatte ad avvantaggiarsene. Eppure proprio nell e loro prestazioni stava il rimedio al problema dei deleteri angoli morti e dei conseguenti settori defilati.

L'incremento di gittata, in particolare della s ua frazione tesa, consentiva, infatti, di battere con precis ione anche punti fino a quel momento troppo di s tanti per una sicura mira. La stessa mitrag lia, modalità di tiro con proietti frammentati - per lo più schegge di pietra o piccoli nuclei di ferro - in precedenza non attuabile per l'eccessiva dispersione della rosata provocata dall'enorme divaricazione della tromba, o cannone, delle bombarde e dalla notevole altezza del pezzo s ul terreno, diveniva ora possibile pers ino ad alcune centinaia di metri di distanza. Facile comprendere le potenzialità difensive di entrambe le pres tazioni, capaci anche con pochi tiri di spazzare il fossato da centi-
naia di metri distanza. Incrociando i tiri di ca nn oni collocati alle due est remità di una co rtina di discreta lunghezza, l ' intero spaz io antistante sarebbe stato completamente solca to dalla mortifera grandine, che, del tutto innocua per le murature s ulle quali finiva per scaricarsi , non avrebbe lasciato alle s ue spalle un filo d'erba eretto!
In dettaglio due pezzi intervallati da segmenti di cortina di un centinaio di metri tirando con angoli acuti opposti avrebbero interdetto un ' area a forma di triangolo isoscele il cui vertice poteva distare dalla cortina s tes sa persino più di 200 m ! In definitiva una coppia cannoni copriva quasi un ettaro di terreno. Con la cadenza di fuoco precipua dei nuovi pezzi le sa lve si sa rebbero potute succe dere con intervalli tanto brevi da rendere impossibile a qualsiasi temerario attaccante di percon-ere nella pausa lo spazio compreso fra il limite di gittata e d il piede del muro. Del resto anche
miracolo sa mente g uadagnatolo non vi avrebbe trovato alcuna schermatura essendo sempre nella rosata di quei cannoni. Per comprendere quanto la sc hematizzata prestazione contrastasse con quelle interdìttive precedenti è sufficiente ricordare che la medesima coppia di cannoni tirando dall'alto di un torrione avrebbe saturato un'area non superiore ad un nùgliaio di mq, riuscendo , inoltre , letal e solo nel punto d'impatto, e non già 1ungo l'intera traiettoria della rosata, esaurendosi, subito dopo, innocua nel terreno. O vvio allora percepire proprio nei tozzi torrioni. cilindrici o quadrangolari che fossero s tati , il principale ostacolo alla soluzione del problema: ma quale configurazione avrebbero dovuto attingere gli elementi preposti al fiancheggiamento destinati a sostituirli?
Dal punto di vista meramente storico tanto il problema del settore defilato quanto la s ua soluzione non costituivano neppure allo sca dere del Medioevo una eclatante novità, fatte salve le loro dimensioni. Già sedici secoli prima il celebre ingegnere militare Filon e Alessandrino ' 61 1 si era cimentato con il medesimo assillo, acuito anche allora dall'avvento di una temibile artiglieria, meccanica ovviamente, giungendo a prospettare diverse so lu zioni ottimali. In particolare s ugge,ì di tracciare il perimetro della murazionc non secondo linee rette, come di prammatica, ma secondo un andamento spezzato, a zig-zag, più propriamente definito a cremagliera o a denti di sega. Nei vertici rientrati si sarebbero praticate le feritoie per le artiglierie meccaniche, consentendo così ad ogni coppia di siffatte anni di fiancheggiare da due contigui appostamenti, rispettivamente nel rientrante destro ed in quello s inistro di ogni saliente, ciascun segmento di cortina fino al saliente stesso, incrociandogli davantj i tiri. Nessun angolo morto, ne ss un se ttore defilato: unica accortezza consisteva nell'evitare che la dimensione del singolo segmento eccedesse quella del tiro utile degli m-chi, o delle macchine da lancio , stimato prudentemente inferiore al centinaio di metri ' 62>

Sebbene ingegnosa la soluzio ne già al l'epoca trovò scarsa adozione essendo se nza dubbio efficace per
la difesa antemurale ma affetta da gravissime limitazioni per quella somrnitale, non potendosi dominare , come dalla piazza delle toni , la sommità delle cortine in caso di tentativo di scavalcamento nenùco in massa. L a bassa cadenza dì tiro delle artiglierie meccaniche non garantiva un 'efficace interdizione att iva, deficienza che relegò l'ingegnoso impianto ad impieghi a ba sso rischio.
Nei secol i s ucce ssivi, in particolare in età romana venne meno l'esigenza di fortificazioni tanto sofisticate essendo venuti a mancare nemici tanto evoluti da minacciare seriamente quelle tradizionali. La necessità, perciò, si ripropose soltanto dopo l'avvento dei cannoni di Carlo VIII, quando degli sc hemi planimetrici a cuneo cli Filone non s i era ancora persa completamente la memoria , grazie al pa ziente l avoro dei monaci amanuensi che ne avevano copiato i trattati senza comprenderne minimamente il se n so . Nessuna meraviglia pertanto che l'eliminazione del settore defilato, quand'anche meno intuiti va ed evidente della terrapienatura. si realizzò quaJche decennio prima, in pratica non appena si ebbe a disposizione un'arma capace di tirare con sufficiente precisione ad alcune centinaia di metri. Ed esattamente come delineato da Filone la soluzione consistette nel reali zzare s trutture di fiancheggiamento cuneiformi. Tuttavia la loro ottimale configurazione e la necessaria aderenza alle esigenze si di mostrarono alquanto più complesse e s uppo sero la maturazione di una piena padronanza delle peculiarità balistiche delle nuove artiglierie.
Per venire a capo della questione degli angoli morti, infatti, l 'espe rienza diretta ben poco poteva sugge rire per elaborare impianti planimetrici in grado di neutralizzarli. L' invenzione di un perimetro accortamente articolato in modo di poter battere tutta la supe rficie esterna di una fortificazione avvalendosi delle armi da fuoco, ovvero di adottare in maniera esaustiva il tiro fiancheggiant e e radente, costituiva l'ambizioso sogno di innumerevoli tecnici. Soluzione peraltro di giorno in giorno più urgente dal momento che la permanenza anche di piccoli se ttori defilati, con il diffondersi delle
mine esplosive, iniziava a farsi estremamente temibile. Forse casualmente sul terreno, forse dopo esasperan ti s tudi s ui grafici, i più accorti tecnici volendo precisa re i limiti degli aboniti settori finirono per ricavarne gli esa tti contorni geometrici.
Partendo da un recinto quadrato munito di quattro torrioni agli s pigoli, o sse rvarono che, tracciando dall'inne s to di uno di loro con la cortina la direttric e s fiorante il vertice esterno del torrione contiguo, e così via, si otteneva una figura ancora quadrata ma con agli spigoli quattro s tranissime 'punte di lancia ', quattro triangoli con il vertice verso l 'es terno , rappresentazione grafica dei tanto deprecati se ttori defilati. Allo scadere del '400 finalmente s i capì - quasi certamente ad opera del Sangallo - che quei curios i triangoli , che sfidavano l'intel l igenza di tanti ingegneri erano in pratica la soluzione del problema. Sarebbe bastato erigere i baluardi angolari non più seco ndo una pianta arbitrari a, circolare, ottagonale, quadrata, pentagonale ecc., come fino ad allora si era verificato. ma a 'punta di lancia ', a ·cuneo', per veder di sso lvers i qual siasi angolo mo,10, qualsiasi se ttore defilato.
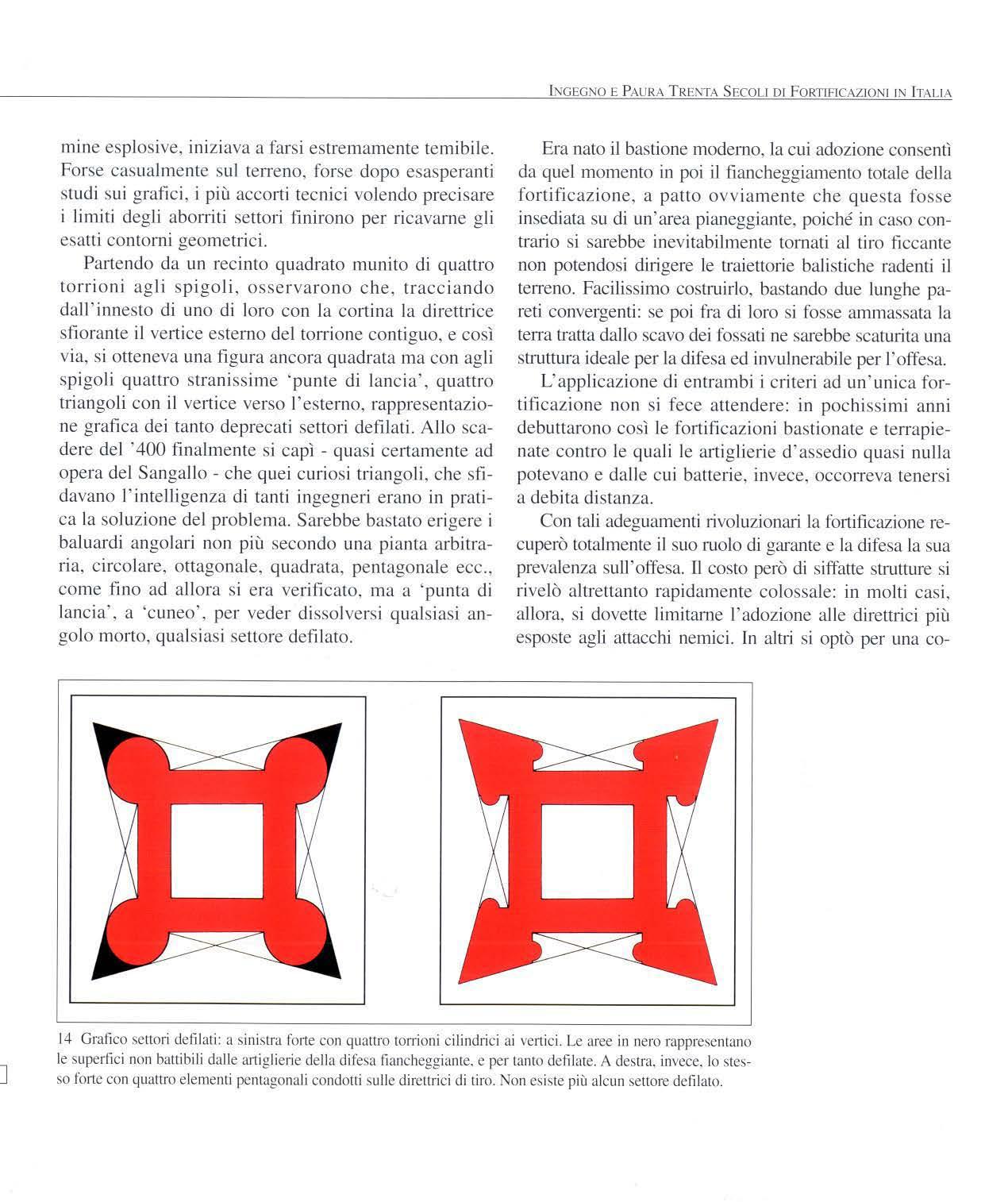
Era nato il bastione mod e rno , la cui adozione consentì da quel mom e nto in poi il fiancheggiamento totale della fortificazione, a patto ovviamente che que sta fosse in sed iata su di un 'area pianeggiante , poiché in caso contrruio s i s ru·ebbe inevitabilmente tornati al tiro ficcante non potendosi dirigere le traiettorie bai istiche radenti il terreno. Facilissimo costruirlo, bastando due lunghe pareti convergenti: se poi fra di loro si fosse ammassata la teITa tratta dallo scavo dei fo ss ati ne sarebbe scaturita una struttura ideale per la difesa ed invulnerabile per l 'offesa.
L'a pplicazione di entrambi i criteri ad un'unica fortificazione non s i fece attendere: in pochi ss imi anni debuttarono così le fortificazioni bas tionate e terrapienate contro le quali le artiglierie d. assedio quasi nulla potevano e dalle cui batterie, invece, occo1Teva tenersi a debita distan za.
Con tali adeguamenti rivoluzionari la fo11ificazionc recuperò totalmente il suo molo di garante e la difesa la s ua prevalenza s ull'offe sa. Il costo però di s iffatte strutture si rivelò altrettanto rapidamente colossale: in molti casi. allora, s i dovette limitarne l'adozion e alle direttrici più esposte agli attacchi nemici. In altri s i optò per una co-
14 Grafico se ttori defilati: a sinistra fo1te co n quattro tonioni cilindrici ai ve nici. L e aree in nero rapprescmano le superfici non battibili dalle art iglieri e della difesa fiancheggiante. e per tanto defi late. A destra. invece lo stesso fo rte con quattro elememi pentagonali condorti su lle direttrici di Liro Non es iste più alcun settore delì l aLo.
struzione progressiva di un bastione per volta, dilazionandone la realizzazione ed i relativi oneri nel tempo.
Nel corso del XIX secolo fu ampiamente dibattuta tra gli storici dell'architettura militare l'esatta collocazione cronologica e geografica di quelle nuove strutture difensive e più ancora la loro più attendibile paternità. Per molteplici osservazioni è tuttavia improponibile un ' invenzione individuale, optandosi per un affinamento accelerato e concomitante, tramite s imilari intuizioni , di diversi progettisti e fra questi, in particolare, di Antonio da Sangallo, fors e il primo ad impiegarli compiutamente (63 , Pertanto: " ... risulta acrobatico e dubbiamente utile decidere su priorità relative, su influenze determinanti. su capiscuola designati ericonosciuti confrontando tanti manoscritti e tanti tes ti che stanno nascosti , ammuffiti e polverosi Il Guglielmotti , il Promis e il Rocchi, hanno tentato ricerche di questo tipo. e il tentativo (specialmente del secondo) meriterebbe dav v ero di venire ripreso sia pure per arrivare alle idee un po ' bal z ane del teologo livornese Donato Ro ss etti, professore anche di matematica e filosofia presso la Accademia del Nobili di Torino, che auspicava un buon libro di testo 'degli ordini militari' parallelo a quello dcgl i 'ordini civili' del Vignola Una ampia indagine sistematica sull ' argomento in questione - specie se favorito da iniziali fortunati ritrovamenti e dal nuovo riordino dei dati oggi in ve1ità modesti e frammentari - s arebbe certo utile. Di queste pr e messe potrebbero fruire non soltanto la conoscenza della evoluzione e del superamento della prima costruzione bastionata italiana , ma anche lo studio delle prime lungimiranti preoccupazioni urbanistiche non riassunte soltanto con le previsioni obbligate ma intenzionali dei tracciati interni impliciti in tutte le fortezze ideali ... [deazioni tutte nelle quali la logica interdipendenza tra muro difeso, dislocamento veloce di forze dietrostanti in movimento o in attesa protetta, libertà della azione loro. facilitata affluenza cli approvvigionamenti e rinforzi , traffico simultaneo della popolazione non ostacolato e non ostacolante , possibilità di vita comune tra guarnigione e popolazione negli
angu s ti spazi s tradali e re s iden z iali allora disponibili nell e difficoltà dei lunghi periodi degli a ss edi, non ri s ultano mai dimenticate , e trovano invece armoni c i e previ s ti accomodamenti'' (64 > .
Di certo il bastione ass ume inconfondibile es pres s ione proprio allo spirare del '400 e l ' a ss um e in Italia a Nettuno , primo e s empio di quella s cuol a di fortificazione che di lì a poco sarà non a caso definit a la tra ce italienne <"5>
Assimilando con tipico criterio rinascimentale, il bas tione pentagonale alla te s ta umana - conferma indiretta deJJa sua valutazione ' capitale' nel nuovo s is t ema di elemento difen s iv o - s e ne definirono le mura convergenti verso il venice e s terno , o s aliente, 'facce ', i due lati di innesto alle cortine ·fianchi ' e l'inne s to , più s tretto ed internamente aperto, con il corpo della fortificazione 'gola ' : l e men z ionate ri e ntranze di vennero pertanto 'fianchetti ri e ntrati ' e le s porgenze murarie che le proteggev ano na s condendole ' orecchioni ' . Dal momento che le troniere celate dagli 'orecchioni ' dei ' fianchetti rientrati ' , si palesavano agli incauti attaccanti soltanto quando pervenivano nel loro c a mpo di tiro, vennero battezzate , con il tradizionale pragmatismo militare ·traditore' La curio s a definizione scaturiva dalla loro collocazione invisibile. de s tinata a colpire all ' improvviso di sbieco e mai lealment e di fronte!
In dettaglio, un bastione si articola, simmetricamente, attorno ali ' asse bisettore dell'angolo di cortina da esso protetta e che appunto per questo viene detto Capitale. Il bastione: " pentagonale ri s ulta dunque tutto un gioco di pareti inclinate ... Nel sistema bastionato definitivo , la congiungente i vertici d e i du e ... [bastioni] attigui - parallela alla cortina - determina la linea avviluppante della base ..." !661 • A sua volta la congiungente del vertice cli un bastione con lo s pigolo rientrante , foLmato dal fianco del bastione attiguo con
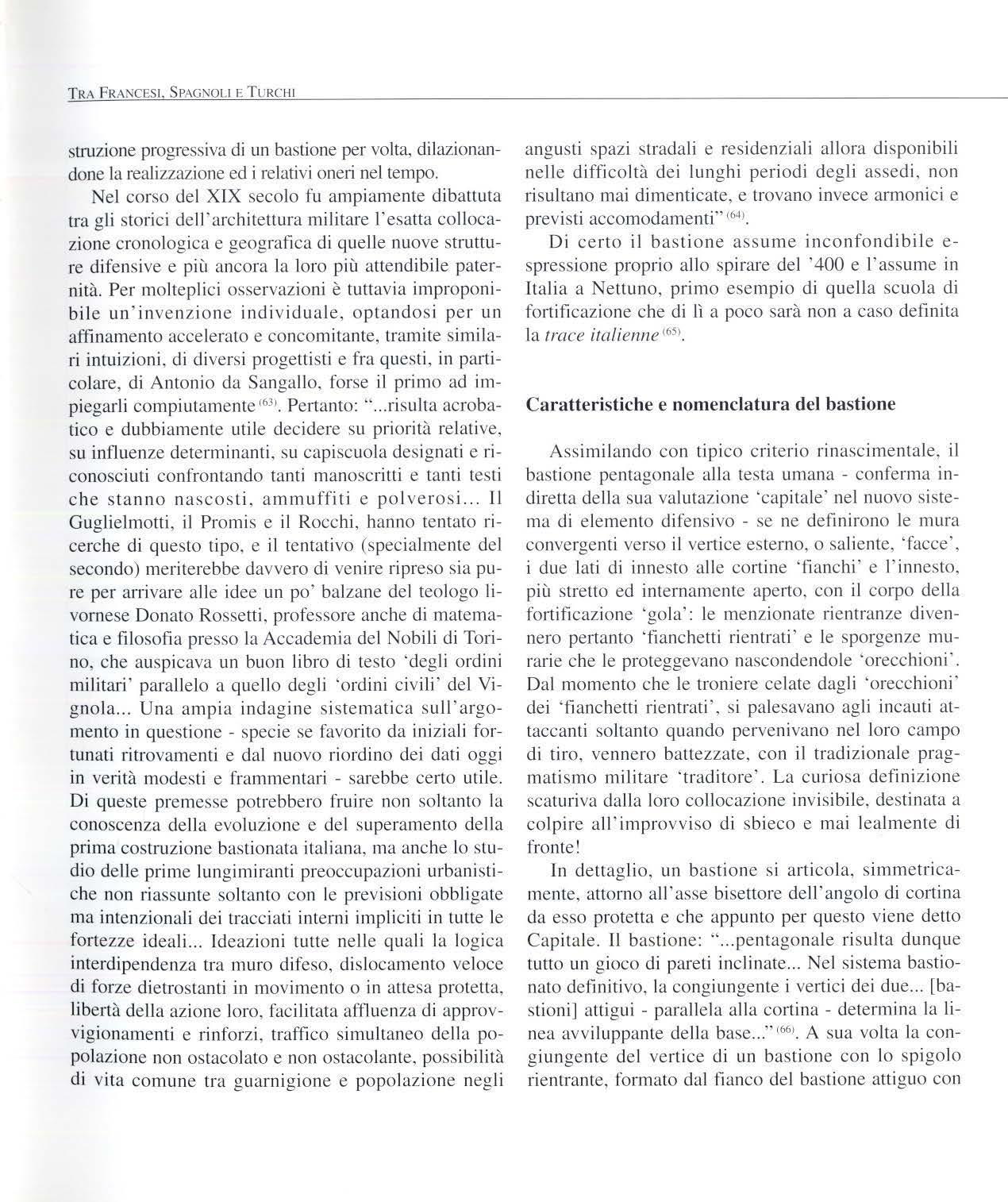
basl'= I
15 Carat!eristiche e nomenclatura fondamen tale del bast ion e
la co1tina, costituiva la linea di difesa. Nei fianchi dei bastioni s i aprirono le bocche delle troniere traditore riservare ai pe zzi destinati a spazzare, con il tiro a mitraglia incrociato , la bassa s uperficie del fossato.
E fu proprio per defilare le s uddette cannoniere che i due lati paralleli del bastione vennero arretrati, mentre il segmento che li raccordava , una s01ta di lato virtuale, per l 'esa ttezza il quinto , veniva completamente aperto verso l'interno dando origine alla cos iddetta 'go la'. Quel raccordo cos tituiva una ulteriore novità della nuova fortificazione in quanto fungeva da elemento di innesto fra il bastione e la cortina, senza dare origine come nel pass ato ad alcuna compenetrazione. Pur non mancando critiche a tale impostazione , ritenendo s i quel lato aperto eccessivamente vulnerabile in caso di distruzione del bastione stesso, e quindi una sorta di breccia appena schemrnta, la preminenza della sua fun z ione, ovvero di agevolare al massimo l'affluss o di uomini , ,u-mi e munizioni verso i gangli reattivi della s truttura , le s ue grosse e basse casematte, si confermò ne l tempo impedendone lo stravolgimento planimetrico.
La fo1tificazione bastionata esattamente come quella di transi z ione s i presentò al s uo debutto s uddivisa
verticalmente in due di sti nti livelli , dei quali il più basso sca rpate , con inclinazione più o m e no acce ntuata. Il secondo , se parato dal precedente dal tradizionale cordone torico, ri s ultava , invec e, perfettam en te a piombo. In linea di larga mas sima la parte ba sa mentale inclinata coincideva in altezza con la profondità del fossato, per cui ritenere che tale inclinazio ne fosse uti1iz za ta per attenuare la violenza degli impani balistici del nemico è scarsamente credibile, ritrovandosi per lo più de filata. Inoltre , da un certo momento in poi , che dal punto di vista attuativo con-isponde alla costruzione del Forte Carlo V di Capua, la scarpatura fu estesa all'intera altezza della costruzione, indipendentemente dalla posizione del coronamento. Il che se apparentemente sembra confermare la s uddetta s piegazione del ricorso alle s uperfici oblique, in realtà, proprio per quell'ampliarsi, è se nsa to s upporre a lcune altre spiegazioni alquanto più plausibili.
La dife sa di fiancheggiam e nto non aveva affatto eliminato quella ficcante, almeno nei momenti critici, che re s tò affidata ad alcuni pezzi detti petrieri capaci anch'essi di tirare a mitraglia con angoli di d e press ione pro ss imi alla vettìcale. Quando il fuoco di fiancheggia-

16 Schema dim ostrat ivo del la evo lu zio ne caste ll ologica. Le zo ne a pun tin i di sti nguono fossa ti asci utti: que ll e a li neette. fo ssa L i acquei. Proced e nd o dal ce ntro s i ve do no : I ) c int a co n 1interro i nte rn o e rin fo rLO agl i sp igol i - se mpl ice di fesa lineare : 2) ci nt a co n torr i add ossate. pu ntoni ai ve rti ci, torri tonde lateral i all a porta - princip io di d ifesa (ì anc hcggia ta piombante : 3) fo 1ti fi caz io ne di t ra nsito in relazione all e pri me affe m1azion i de lla artig li eria ve ri fica ta a parti re da lla seco nda metà de l Qu attrocent o co n bal uard i o bas tio n i: B) cava l ieri o pi attafor me in termedi e o rompitra tta; P) rive ll i no; R) di fesa fi ancheggia ta bassa ( rad en te) : S pal to an ti stante il fosso. Ne i se u ori contrassegnati co i nu me ri da 4) a 12), ese mpi di fortifi caz io ne mode rn a tl a l XVI seco lo i n poi : 4) d ue Li pi cl i fr onte bastiona to ital ian o Si no ti la d ifesa avanzata ne lla strada co perta de ll o spa lt o e si notino i primi accenni di piazze d . arm i che le i ntervallano; LO) fronte basso del Cohe ron - scuola olandese - con mo l tip l icaz io ne in profondi tà dell e li nee d i di fesa e pi ccole co nt rog uardie dava nti ai bas ti oni : l.3) fro nte art icolato fra ncese del Papan : l I ) e 12) fo rtifi caz io ni de l tip o Vauban (i n 12. il 20 e 30 sistema) con vasta inse rzio ne di tenagl ie e progressiva co m razionc del baluardo; 5) e 6) fo rt ifica z ioni ste llari te nagl iate co n d ifese molto av anza te a pu nta. dis poste in modo ta le da inc re menta re e ant ic ipare il tiro fi a nchegg iato (Montalamb ert) : 8) e 9) ult imi te nta tivi - insistiti fin o al l'e poca na poleonica - intes i a ra fforzare le c in te bast iona te; ri ve lli ni ai pied i dell o s pa lto, lun ette ava nzate ecc.: 7) fron te ba tio nato con rido tte e l un ette d el C hassel oup - epoc a napo leon ica. Da A nto nio Cass i Rame lli [
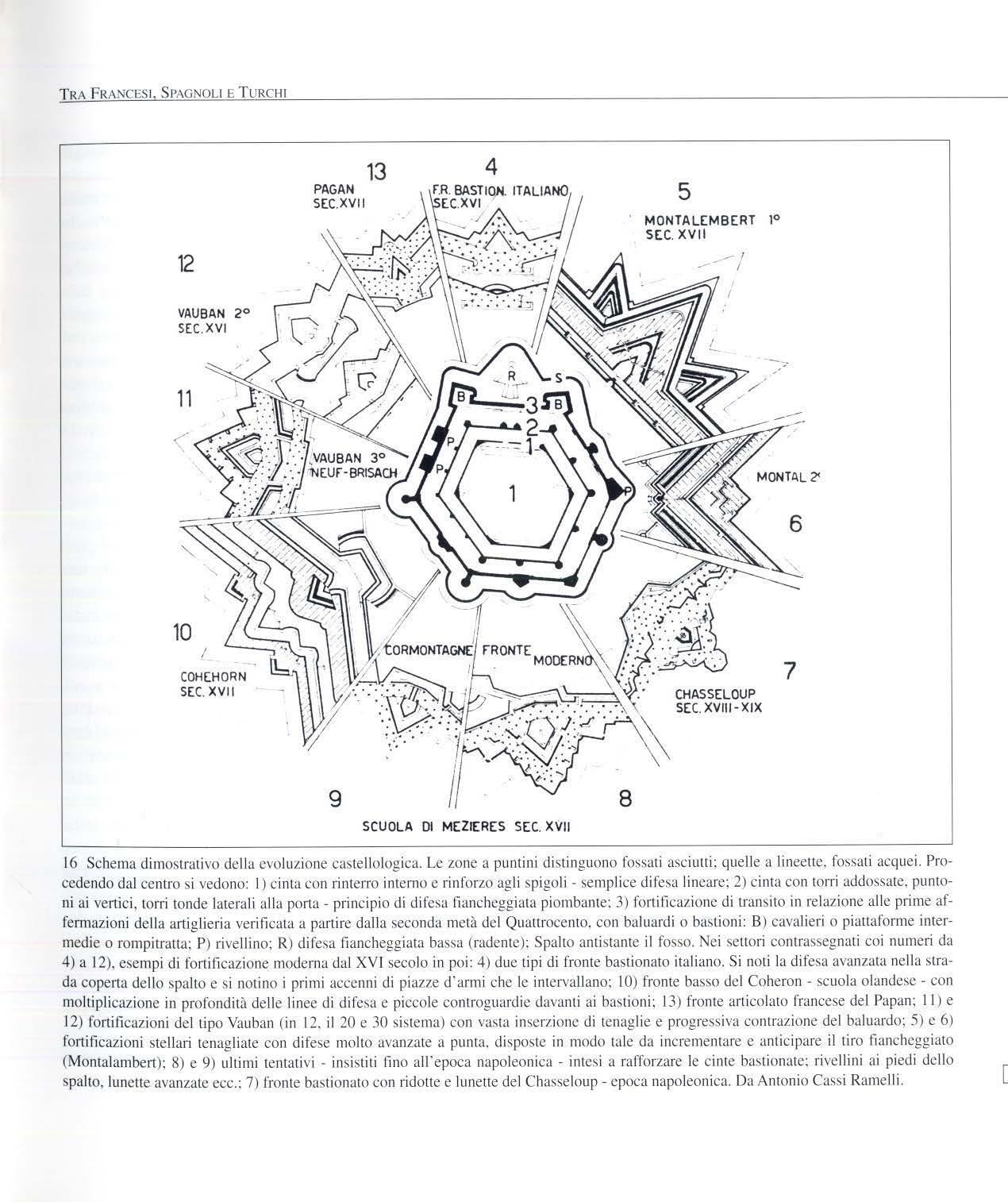
mento basso e radente non fosse riuscito ad aver ragione degli attaccanti, o i pezzi ad esso preposti fossero stati in qualsiasi maniera tacitati, il fossato avrebbe potuto ancora essere spazzato dai suddetti petrieri fatti sporgere dalle cannoniere. Per evitare però che restassero settori defilati intorno al piede delle mura lo si rese leggermente inclinato. Una seconda ragione, invece, potrebbe individuarsi proprio nel tiro a mitraglia dei pezzi traditori che per la contrapposizione dei bastioni si sarebbe inevitabilmente scaiicato sul loro estradosso: per ridurne i danni e favorirne la deviazione delle schegge si impiegò l'inclinazione delle pareti esposte portandola progressivamente sempre più su fino a farla coincidere con l ' intera altezza della fortificazione, connotazione che si ritroverà dopo il 1563 riprodotta in tutte le torri costiere anricorsare vicereali napoletane.
Nei casi in cui il bastione si articolò su più livelli si ebbe cura di raccordarli fra loro , sempre in previsione di un identico bisogno di agibilità, tramite rampe a lieve pendenza, superabili perciò anche dai pesanti cannoni affustati. Il collegamento, comunque fu predisposto per un rapido blocco in caso di intrusioni nemiche, evenienza che avrebbe trasformato così il volume interno in una serie di compartimenti stagni. Circa la compartimentazione orizzontale la si conseguì con volte solidissime, lungo il cui perimetro si aprivano le cannoniere, o le troniere, con appositi tiraggi, o sfiati, praticati sul loro 'cielo', in modo da garantire la rapidissima evacuazione dei gas di sparo. Fu quello, incredibilmente il maggior problema che aveva reso inattuabile l'ubicazione bassa dei pezzi nelle ultime realizzazioni dell'architettura di transizione, pur risapendosi perfettamente ormai dei vantaggi del tiro radente. Solo la sua perfetta soluzione tecnologica, coincidente significativamente con la comparsa del bastione, consentì di piazzai·e al I ivello del fondo del fossato i grossi calibri della difesa ravvicinata. Il che permise agli stessi di effettuare il micidiale tiro radente a mitraglia, capace di frustrare anche assalti in massa.
l calibri minori trovavano alloggiamento nei livelli intermedi del bastione, per ragioni statico-dinamiche e
per logica considerazione interdittiva , essendo gli stessi impi egati per battere il ciglio esterno del fossato ed i suoi paraggi. Sulla sommità. allo scoperto sulla terrazza di copertura, propriamente in barbetta su lla piazza d'armi, stavano i pezzi destinati a controbattere il fuoco nemico d'investimento. Le loro caratteristiche erano perciò una ragguardevole gittata, derivante dall'anima alquanto più lunga del normale , ed una considerevole violenza d'impatto a sua volta derivante dal discreto calibro del proietto. Abitualmente stava no incavalcati su affusti a quattro ruote di tipo a cassa o navale, non appena che tale tipo di supporto si rese disponi bi le , epoca generalmente fatta coincidere con la metà del XVI secolo.
Nei decenni precedenti, invece, si adottò il tradizionale affusto a due ruote. Dato che l'altezza della bocca del cannone, in entrambi gli affustamenti, comunque risultava più bassa dei parapetti, i quali per proteggere efficacemente i serve nti erano alti almeno cm 120 sul calpestio della piazza, se non 150 cm addirittura per la notevole inclinazione verso l'esterno indispensabile per deviare le palle nemiche , considerando inoltre che la loro larghezza non dì rado eccedeva il paio di metri , fu giocoforza abbassarli in alcuni punti per permettere ai pezzi di tirare. li parapetto assunse così una connotazione s imile all'antica merlatura , con elementi verticali massicci, detti appunto ' merloni ', e cannoniere intermedie fortemente strombate, lateralmente e verticalmente, sulle quali brandeggiavano le volate de l le artiglierie immediatamente prima dello sparo. Quanto al dimensionamento dei bastioni e dei segmenti di cortina interposti , non diversamente dal già vigente per le cerchie turrite nei seco l i precedenti determinato dalla gittata efficace delle armi da lancio, sarà funzione di quella delle artiglierie.
Dal punto di vista meramente ideale un perimetro chiuso essendo costituito perciò da una serie di seg-
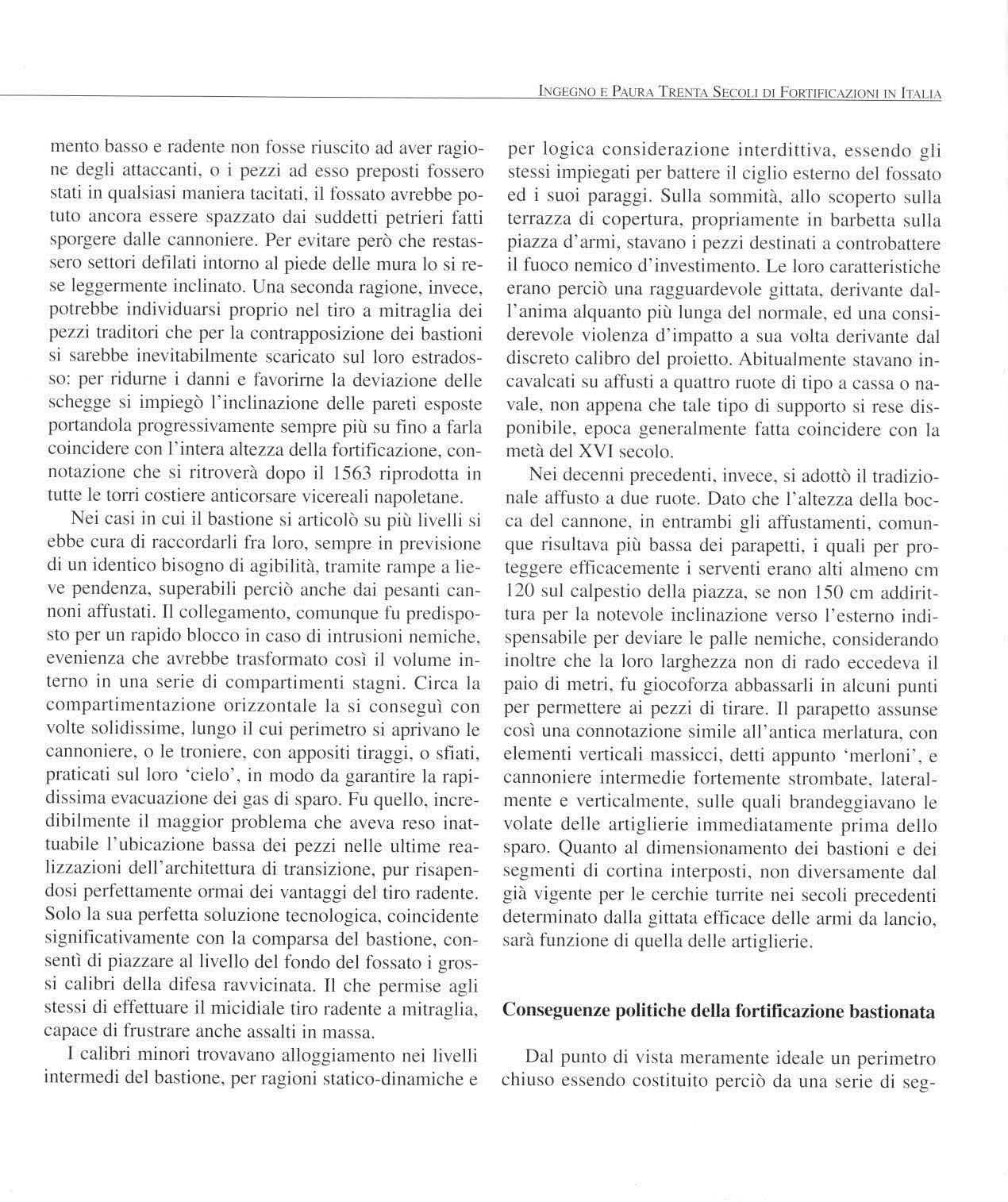 I NGEGNO E PAURA TRENTA SE COLI DI fORTIFICAZIONI IN lTALIA
Consegue nze polit ic h e de lla fortifi cazio n e bast io na ta
TRA FRAN CESI SPAGNOLI E T URCIII
I NGEGNO E PAURA TRENTA SE COLI DI fORTIFICAZIONI IN lTALIA
Consegue nze polit ic h e de lla fortifi cazio n e bast io na ta
TRA FRAN CESI SPAGNOLI E T URCIII
menti retti li nei di uguale lunghezza si trasforma in un poligono regolare. Se ai suoi vert i ci si innestano altrettanti triangoli ac uti con lo spigolo ve r so l ' esterno , l ' in sieme ass um e la connotazione di una ste ll a, qua si un gigantesco cristal l o di g hi accio: e fu appu nto quell a l a fo rm a c he ebbero le fort ifi caz i oni bastionate intorno alle città di pianura. L a presenza ambientale divenne talmente imponente d a riuscire perfettamente v i s ibil e d all'alto nella sia pur minima articolazione persino dopo quasi mezzo mill e nni o . Ovvio quindi che dopo pochi decenni dall'invenzione del bastione le: " .. . fortezze ass un sero così un carattere preponderante ne l dominio del t erri t o ri o; la dife sa in fatt i , non era più limitat a a l so lo caste ll o ma interessava in vece intere città che ven nero protette da cinte bastio na te ..." <67> .
La rilevanza delle nuove opere difensive era or m a i tale da no n poter essere asso lut a m e nte l 'esito di una volontà feudale. Qualsiasi aristocratico, pe r ri cco che fosse stato, non era orma i più in grado né di dotarsi di moderne arti gl i erie, l a cu i fabbricazio ne esulava ormai dalle capaci t à artigianali locali ed i cost i dalle potenzialità dei singoli, né di fortificazioni bastionate. L e une e le alt re per le competenze che implicavano, per gli immani oneri c he richiedevano e p e r g li imm e n si ambiti sociali che coinvo l geva no, rientravano esc lu s ivamente nelle po tenzia lit à dei maggiori monarchi e delle più ri cc he rep ubbli c he . Di conseg uenza, sotto il profilo st re ttamen te politico, l 'evo lu zione tecnologica delle artiglierie e, quindi , quella architettonica delle fortifica z ioni , favorì, quando addirittura non produsse, l'aggreg azione dei gra ndi Stati, i so li in grado di approntare e d armare adeg u atame nt e si mili opere co lo ssali, a loro volta le uni c he capaci di ga rantir e la loro indipendenza. Ed è se n za dubbio significa ti vo osservare come tutta una se rie di nuovi assetti politico t erritoriali si attuò ne ll e prima metà del XVI seco l o, qu ando dopo il seco ndo e sopra ttutto dopo il t e rzo decennio del l 500 le fortificazioni bast ion ate furono a mpiamente idon ee a fronteggiare g l i assedi, anche qu e lli con magg iore im p iego di artiglieria.
La trace italienne, nonostante i costi iperbolici che implicava , prese rapidamente piede , sorprendendo proprio per la velocità e l ' universalità dell'adozione e per la quantità di implicanze cu i dette o ri gine. Persino ne l settore squ isitamente operativo, relativo cioè agli organici degli eserc iti ed a ll a loro formazione , le conseguenze furono i mmed iate e stravo lgenti . Si richiedevano, infatti, truppe qualificate e disciplinate ben lontane dalle sparute ed anarco idi compagini tardo-medievali e dalle raccog liti cce fanterie di estrazione rura1e , approssimativamente armate e peggio equipaggiate. Non a caso con: " .. .l'apparizione della nuova fort ificaz i one permanente la tattica e la strategia furono ult e ri ormente modificate Lin partico l are quest ' ultima] fu m od ifi cata perché gli eserc iti , che penetravano offensivamente in uno stato, non potevano agg irare le grandi piazze fortificate e proseguire vers o altri ob iett ivi. In fatti dalle piazzeforti o dalle città fortificate gli eserciti che le presidiavano , se non vi erano bl occat i da un assedio, poteva no uscire e attaccare alle spa ll e l'invasore, o per lo meno tagliarne le vie di comunicazione e di rifornimento. D'altra parte pr in cipi e repubbliche non potevano m a ntene re co ntemporaneamente un ese rci to per la manovra e uno per porre gli assedi. Le forti spese per le fortificazioni permanenti imp edivano, come abbiamo già d etto, di avere eserc iti così num e ros i. Quindi era indispe nsab il e, in vadendo uno stato, porre r assedio alla piazzaforte, ne ll a quale era rin c hiu so l 'esercito nemico, per conquis tarla, e, così, riprendere lib ertà d'azione e di mov ime nto. Sol amente nei secol i d e ll e monarchie asso lut e e dei gra ndi capitani avremo ese rc iti s uffic i en ti a presidiare l e proprie fo1tezze, a porre l'assedio al le piazzeforti nemiche , a manovrar e st rat egicamente per cercare di co lpi re nella battaglia co nc lu s i va l ' ese rcito nem ico. Negli ultimi anni del Rin asci m e nto e quasi in tutto il secolo success i vo bi sogna scegliere fra l'assedio e g uerr a manovrata. Ma e ra l 'assedio che si imponeva per i mot i vi innan zi en unc ia ti ..." < 6 8l
Più prec isa me nt e, quelle: " ... for t ezze non potevano esse re prese d'a ssa lto ; se g li eserciti invaso ri l e aves-



sero ignorate semplicemente aggirandole, ciò sarebbe equivalso a porre i propri convogli di rifornimento alla mercé di sortite in forza dell e guarnigioni. Era quindi indispensabile neutralizzare questa minaccia e mascherarle, vale a dire staccare un contingente tolto dal corpo principale, indebolendolo inevitabilmente, oppure investirle con l'intero esercito; un 'ope razione che, anche se non si concludeva con un assalto generale, avrebbe richiesto molto tempo -e per gli eserciti del Cinquecento tempo significava denaro e il denaro significava avere so ld ati oppure essere costretti a rinunziarvi.
Quando si concluse il ciclo delle gueITe italiane nel 1529, le grandi linee della condotta degli assedi erano state messe a punto da esperti quali P edro Navarro e Prospero Co lonna. Per neutralizzare il fuoco della difesa, l 'asse diante ricorreva alla zappa. Per prima cosa circondava la fo11ezza con un s istema continuo di trincee poco oltre il limite superiore di gittata delle batterie della difesa ... Questo tipo di guerra di trincea monotona, sanguinosa, mortalmente malsana, sarebbe stata l'occupazione corrente del sol dato europeo per olt re duecento anni.
Tutto questo - il diffondersi dell e fortificazioni, la supe1iorità della difensiva sul campo di battaglia, l'alto costo delle truppe mercenarie e la ca ut ela professiona l e dei loro cap i - spiega perché, durante oltre cento anni, il corso delle guerre in Europa fosse tanto prolungato e senza s bocco; progrediva consumandosi a fuoco lento come legna umida, devastando le campagne come se si trattasse di una malattia cron ica che il paziente è costretto filosoficamente a sub ire con desolata rassegnaz ione: questa for m a di guerra non agiva mai come catalizzatore per un nuovo ordine politico ... Anc h e solo per sopravvivere, i mercenari dovevano opprimere l a popolazione c ivil e . Anche solo per sopravvivere i con tadini a l oro volta, privi della casa incend i ata e della fam i glia massacrata, erano costretti a farsi mercenari. Un so ld ato dell'epoca si poteva ben definire come un individuo costretto a morire per avere qualcosa per vivere " (69J
l.'lGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIANonostante ciò, mai come nella fortificazione bastionata, è riconoscibile l'avvento della razionalità sc ie ntifica e della logica matematica, espressione mas sima della rivoluzione culturale che iniziava proprio dall'artiglieria ad impo1Te la sua presenza ed il s uo apporto.

Contemplare dall 'a lto un forte bastionato cinquecentesco dà la netta sensaz ione di percepire la materializzazione di una astratta elucubrazione geometrica, assolutamente avu lsa da concreta fruibilità. Difficile presumere che quelle forme crista llin e siano il risultato positivo di precise esigenze belliche se mpre tanto caotiche da reputarsi imprevedibili per antonomasia. E una certa dose di esattezza non difetta nella sensazione: non a ll a progettualità I ib era, infatti, vanno ascritte le generatiici d'impianto, ma alle inalterabili estrinsecazioni della bai istica. Ignorare que s ta bas ilare condizione si tradu ce ne l travisamento della lettura architettonica dell 'o pera , che a sua volta, determina, non di rado, patetiche affermazioni interpr e tative , prive di qual s iasi valenza culturale.
Pur non vo lendo in alcun modo entrare nella diatriba di dove sia comparso per la prima volta il bast ione, affermazione che implicherebbe preliminarmente 1 ' esatta determinazione di cosa debba intenders i per bastione in fase iniziale, è fuor di dubbio che il primo fo11e che venne eret to con quatti·o elementi siffatt i fu quello di Nettuno. Giustamente Guglielmotti concl udendo la sua esposizione delle caratteristiche originarie del bastione ribadiva che l'insieme di quelle: " .. .invenzioni e ... progressi son tu tti del quattrocento, e tutti visibi li ne ll 'autografo de l Sangallo, e nel monumento di Nettuno ..." ooJ .
Anche in questo caso la costruzio ne, come del resto la s tra grande magg ioran za delle analoghe che s'inseguiranno nel s uccessivo mezzo secolo, fu final izzata alla difesa costiera contro la minaccia turca .
La stranezza se mai va co lta ne ll' osservare che tale
primizi a deve ascriversi alla compagine meno militarista per antonomasia dell'intero pianeta, lo Stato della Chiesa. Si tratta, se mai ve ne fosse bisogno di una perfetta dimostrazione del rimarcato parado sso di opere militari d 'ava nguardia avviate da un governo pressoché incompetente in materia , ideologicamente ostile e, per contro, abbondantemente fornito di sommi artisti-architetti.
Probabilmente intorno alla fine del XV seco lo Antonio da Sangallo il Vecchio (71 ) ricevette l'incarico professionale da Alessandro VI, compito che adempì con inusitata solerzia, tanto che in pochi me si riuscì a fornire i grafici dell 'o pera. Nonostante la rapidità, inconcepibile anche in un contesto critico quale quel tormentatissimo fine secolo, quanto elaborato dal celebre architetto non contemplava alcuna affinità con le coeve fortificazioni tutte più o meno di matrice scolastica martiniana, ancora reputata il vertice espressivo dell 'archite ttura militare. Ovv io presumere che il San gallo da tempo rimuginasse sul come usc ire dallo s tallo concettuale rappresentato dalla tran s izione ed in particolare come eliminare una volta per tutte gli angoli morti ed i se ttori defilati che accompagnavano come un 'o mbra ogni fo1tificazione. l molteplici e reiterati espedienti te s i alla s ua elìminazione s i erano fino ad allora risolti sempli cemente nella parziale decurtazione , sop rattutto perché nessun progettista aveva mai osato mettere in discussione l'adozione ste ssa dei torrioni , origine del problema, sulle cui spalle gravava l'e sperienza di quasi nove millenn i d i costante riproposizione. Nella Rocca di Ostia, in verità, si coglie, come già delineato, un primo sforzo per neutralizzare , almeno in corrispondenza del ve1tice princ ipale, il temuto settore defilato.
Il Sangallo alla fine escogitò la soluzione tanto at tesa : assumere per generatrici planimetriche delle strutture preposte al fiancheggiamento bali s tico del forte di Nettuno, le traiettor ie stesse dei tiri dei pezzi bassi, condizionate dalla presenza dei torrioni. In altre parole, partendo da un forte quadrato di 40 m di lato co n a i vertici quattro torrioni di 13 m di diametro, e
conducendo le traiettorie del tiro del fiancheggiamento in modo da farle risultare tangenti ai torrioni stessi, ricavò le dimensioni e la configurazione dei co rpi c uneiformi che occupavano con l a loro massa l'int ero se ttore defilato, e lo avrebbero perciò definitivamente e liminato. Intorno alla fortificazione ogni punto del terreno, a partire dalle mura per finire al limite della gittata balistica, risultava battibil e. Lo spazio compreso tra due bast ioni contigui poi consentiva 1' in crocio de i tiri scaturenti dalle opposte troni e re, d eterminando il mortifero sbarramento attivo meglio noto da allora come 'fuoco incrociato'.

li conseguimento teorico della nuova traccia architettonica dovrebbe ascriversi agli ultimi anni del '4 00 ma l a sua indi sc utibile adozione pr atica si materializzò soltanto con l'avvio dei lavori di Nettuno de l 1501, tanto che lo s tesso Guglielmotti ferv ido es tim atore del Martini non può astenersi dal precisare che il Sangallo: '' .intendeva riuscire molto meglio per arte e per in geg no, c he non fossero le proposte fatte a quei tempi d al celebre Francesco di Giorgio Martini, troppo tenace dei s uoi torrioni " rn,
In rea ltà la 'troppa tenaci a' del Martini, a quel punto, si era tra sfo rmata in ottusa te stardaggine e dannosa riproposi z ione di un canone fortificatorio radicalmente ed irr eve rsibilmente giubilato, che nell'arco di pochi anni non avrebbe più trovato sosten itori e, quel che è peggio, non avrebbe più fornito, qualora applicato, alcun apporto difensivo m, . Il Sangallo, quindi, decretò la fin e del protrarsi della transiz ione ed introdu sse la nuova architettura militare capace, non so lo di re s istere agli insulti delle artiglierie ma , principalmente di avvalersi in maniera ottimale del loro apporto o s tativo. Le op e re murarie , pertanto , cessavano di sos ten e re un ruolo esc lu s ivamente pass i vo per farsi carico di una funzione integrata con l e bocche d a fuoco, imponendo agli attaccanti una micidiale e vasta fascia di ri s petto.
Comunque in quel primo anno del '5 00 l 'ava n zare della costruzione tanto rivoluzionaria ed innovati va dovette sembrare per i molti sedicenti esperti di Roma [
una sor ta di cervel !oti ca elucubrazione , il parto deme nt e di una fantasia esasperata des tinata a sva nir e a l primo c imento: in poche parole denaro sp recato !
Nonostante c iò ve nn e accettata e completata, forse per la rinoma nza del progettista, forse p e r l'in s ig nificanza del luo go o forse anche p e r la volubile coerenza
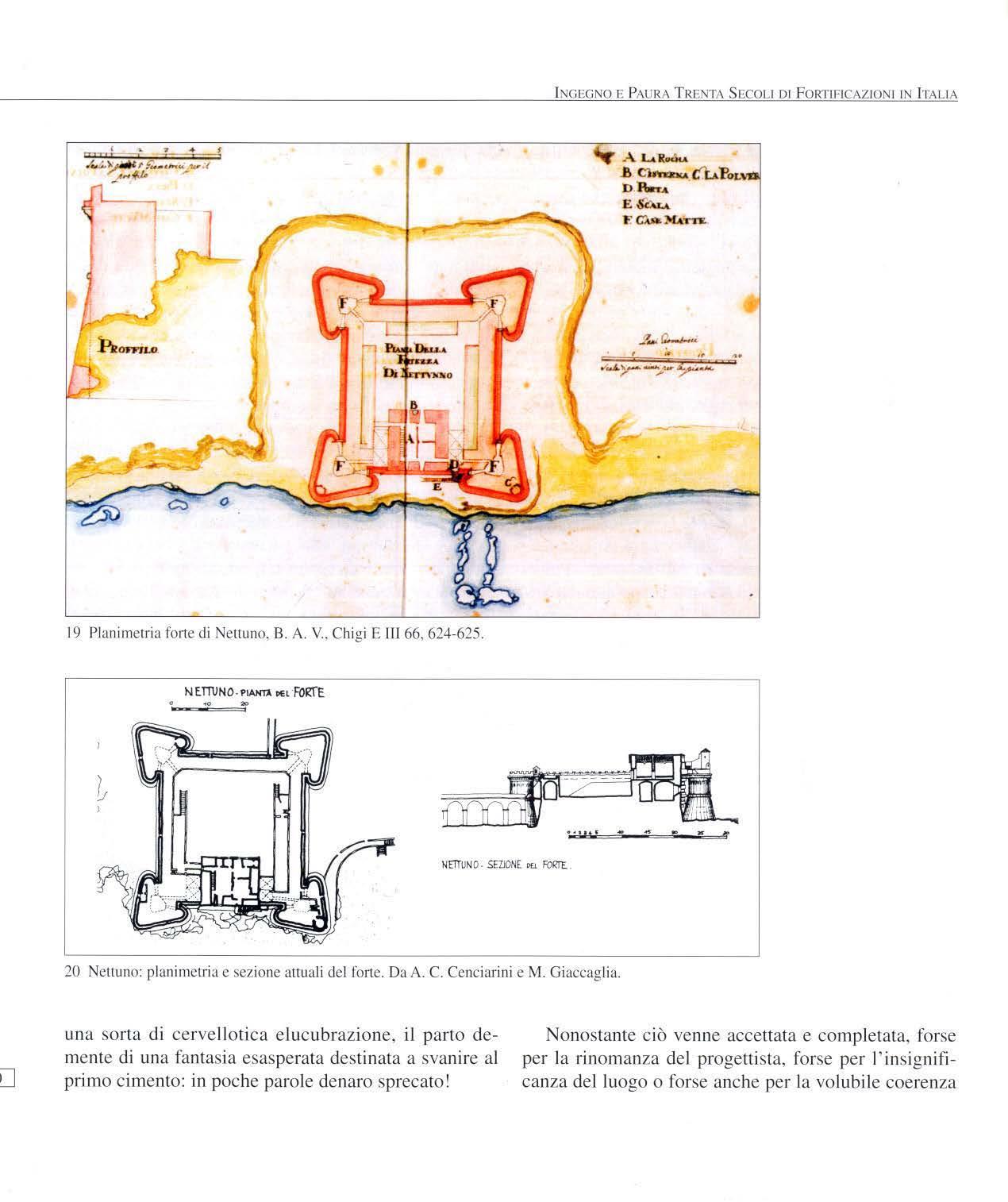
della di1igenza militare pontificia. Eppure non soltanto nel disegno d'impianto generale si coglieva l'assoluta novità della fortificazione ma persino nei suoi dettagli funzionali, quali, per esempio le troniere 'traditore'. li Sangallo, infatti, delineando i bastioni, che formalmente r icord avano vagamente il baluardo a cantoni della Rocca di Ostia, ne arretrò in corrispondenza dell'innesto con le cortine una piccola sezione verso l'interno. Ricavò, in tal modo, per ciascun bastion e una coppia di postazioni casamat t ate opposte per i pezzi bassi , destinati al fondamentale compito della difesa fiancheggiante radente il fossato. Le bocche esterne delle troniere risultavano in tal modo non so lo celate alla vista degli attaccanti ma soprattutto al loro controtiro, coperte come erano dalla massa muraria del fianco del bastione.
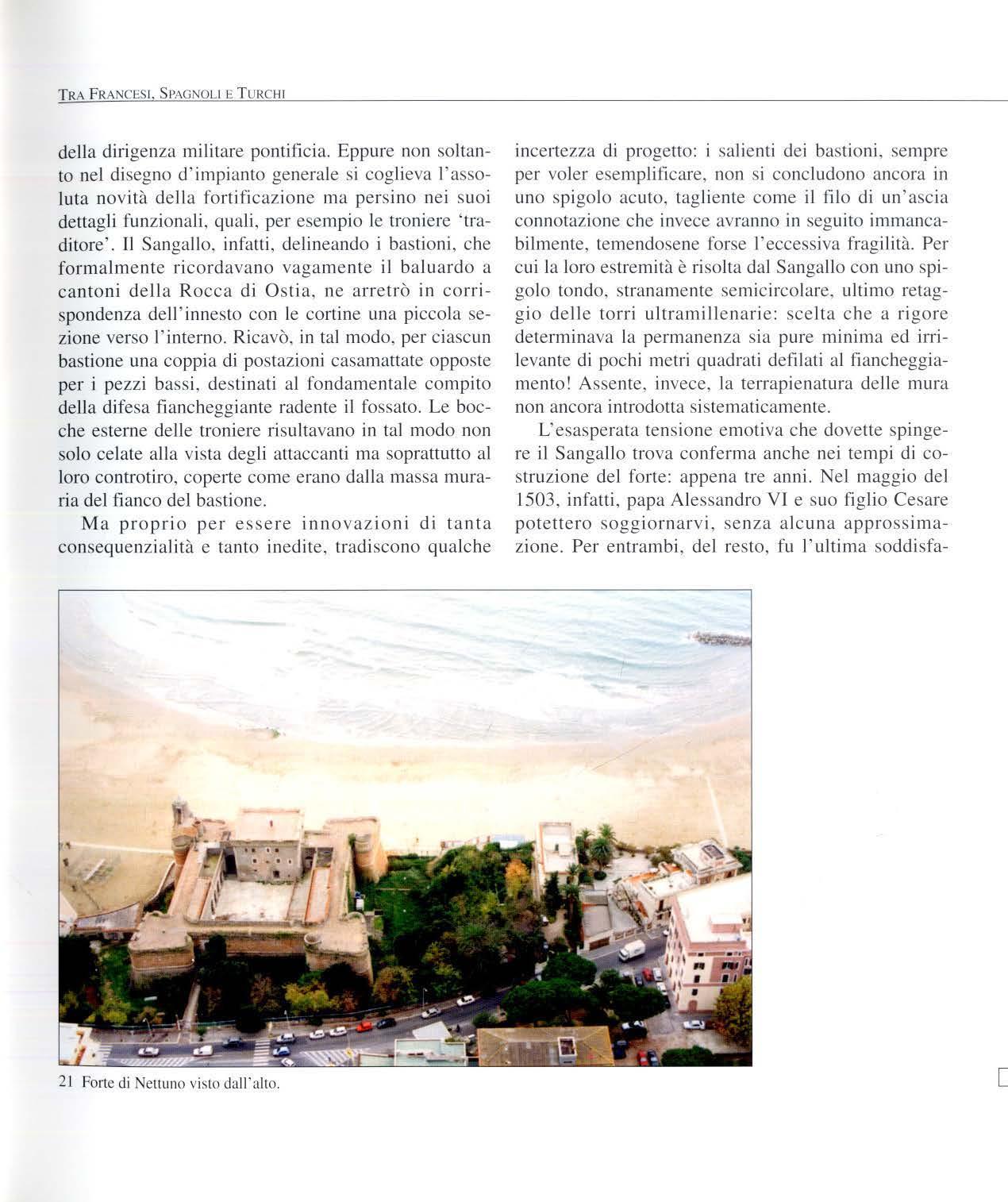
Ma proprio per essere innovazioni di tanta consequenzialità e tanto inedite, tradiscono qualche
incertezza di progetto: i sa li e nti dei bast ioni , sempre per voler esemplificare, non si concludono ancora in uno spigolo acuto, tagliente come il filo di un 'asc ia connotazione che invece avranno in seguito immancabilmente, temendosene forse l'eccessiva fragilità. Per cui la loro estremità è risolta dal Sangallo con uno sp igolo tondo, stranamente semicircolare, ultimo retaggio delle torri ultramillenarìe: scelta che a rigore determinava la permanenza sia pure minima ed inilevante di pochi metri quadrati defilati al fiancheggiamento! Assente, invece , la terrnpienatura delle mura non ancora introdotta s istematicamente.
L'esasperata tensione emotiva che dovette spingere il Sangallo trova conferma anche nei tempi di costruzione del forte: appena tre anni. Nel maggio del 1503, infatti, papa Alessandro VI e suo figlio Cesare potettero soggiornarvi, senza alcuna approssimazione. Per entrambi, del resto, fu l'ultima so ddisfa-
21 Forte di Nettuno visto clalr alto.z ione: appena tr e mesi dopo il pontefice moriv a, prob a bilm en t e avve lenato; di lì a breve anc h e il fig li o sa re bb e tra g icamente sco mpar so . Il Sanga llo , invece, esa urita l a p arentes i t ornò ai s uoi numerosi incarichi to sca ni , co n c lud e ndo la s u a g loriosa carriera nel 15 34 . ave ndo avuto così l a po ss ibilit à dì sa pe r e dovunque l odata e co ndivisa la s ua concezio n e fortificatoria, se bb e ne non ancora massicciament e riprodotta, s itu azione che s i avviò appe n a l 'anno dopo , intensificando s i rap id ame nte in quelli s ucce ss ivi. Dive rse centinaia di fo rti , sos tan z ialmente sirni Ii al s uo, d a qu el m o ment o vennero erett i per i s ucce ss iv i t re seco li in ogni part e del mond o, punteggiando a ll a fine b e n tre cont in e nti!
Circa le caratteris ti c h e principali d e l forte di Nettuno, a ncora perfe ttamente conse r vato va evidenzia to c h e s i tratta di un e dificio a pianta ret t ango l are
co n quattro bastioni a n go lari: l a lun g h ezza misurata tra ì salie nti dei ba s tioni rag giunge m 55 mentre l a l a rg hezza non eccede i 50 , minima pertanto la differenza tra l e fronti. L e co rt in e int e rpo ste a loro volta si attestano intorno a ll a tre ntina di metri L'alt ezza dal fondo d e l fosso ri s ult a di circa m I O per l a sezion e sca r pata e di circa 5 per quella ve rticale sov ras t an t e: tra l e due il t radizionale cordo ne a profilo torico cinge l ' int ero perimetro. Lo s p ess ore in diverse trat te s upera i m 5. 11 fronte a mare , uno dei lati minori , racc hiud e una sor t a di ma sc hio quadrato, dì circa m 12 di larg h ezza : uno dei s uoi l at i fuori sce di poc hi ssimo dal filo della co rtin a con se ntendo n e l!' interasse co n i l bastione l 'a ll ogg i amento dell a porta d'acce sso . U n a seco nd a porta , la principale s i apriva , preced ut a da un lungo ponte s u q uattro camp ate, di cui l'ultima le va t o ia, in asse con l a prima ma s ul fronte a terra.

Queste stando al Guglielmotti le caratteristiche distintive: '·... L'ingresso principale si apre dalla parte di te rra dove un ponte militare congiunge il greppo dai campi a ll a piazza del fortino su ll'i s te sso live ll o . Sotto cade i I fosso , di fianco la batteria nascosta. e innanzi la porta, che ancora conserva le tracce della saracinesca e dei bolzoni. Sull'architrave il più antico stemma di casa Borgia " 0 J>
Allorquando J'inc ursività turco-barbaresca intorno al 1560 a ttin se i massimi li ve lli terrifici, il fortino ritorn ato, dopo una lun ga confisca del feudo di Nettuno , nella piena proprietà dei Colonna, a cui originariamente a pp a rte neva, ricevette da Marca ntonio Colonna ulteriori c ure ed ulteriori opere difensive al suo ester -

All ' interno del forte un a vasta pi azza d'run1i. a lta s ul fossato circa m 5 con una s up e rfi c ie complessiva di quas i mq 600 , circondata lun go l'intero perimetro da una teoria di a ll ogg i ame nt i s truttur ati su di un unico piano, ad eccezione del masc hio c he ne prese nt a du e . In corrispondenza dei lati maggiori du e rampe di sca l e conducono alla piazza cli co pertura. protetta da un robus to pru·apetto continuo l egge rm e nt e aggettante s ull e cortine mediante un a fitta teo ri a di ga tt o ni. Pr es umibilmente lungo lo stesso un tempo si dovevano aprire a lqu ante can noni e re in seg uito mur a te A ll'interno di ogni bas tion e una casamatta pentagonale comunicante
con l 'es terno t ramite due troniere fra loro ortogo nali.
24A Marocco. Fèz, iI forte. [24 B Florida . forte Sant' Ago stino, foto a nni ·30_
no, che comunque non modificarono minimamente l'i mp i an to sangaU i a n o . Lo s tesso condott iero nel 1564 vo ll e c h e il piccolo abitato di Nett uno fosse protetto da una moderna cerch i a bastio n ata, parendogli le antic h e m u ra medievali n on eccessivamente re sis t enti. Partendo dal bastione ve r so la ca mp ag n a d e l fronte a te rra del fo rte fece e ri ge re la nuova cer chia perimetrale ubicandone il primo bastione al punto di innesto fra le due. Da lì una breve cor tina , pressoché perpendicolare aJla linea di cos t a, e quindi il secondo bastione i n posizione angolare , seguito a s u a vo lt a da un a ltro segmento di cortina , più esteso, ad andamento parallelo a lla marina. Un terzo ba s tion e, ancora angolare, e l 'u ltima u·atta di co rtina ortogonale alla precedente Alla co nclu s io n e d e ll a cerc hi a s ull a sp ia gg ia un quarto bast ione esa uriva il trac c iato. Du e porte sui l at i opposti, un a verso R oma ed un a verso Napoli. Il tutlo circondato dal so lito a mpio fossato.
Sebbene la modernissi m a cerchia bastionata fosse ri sultata di gi usto dimensionamento e di pod erosa co n s i s tenza il Colonna non vo ll e la demolizione d e l-
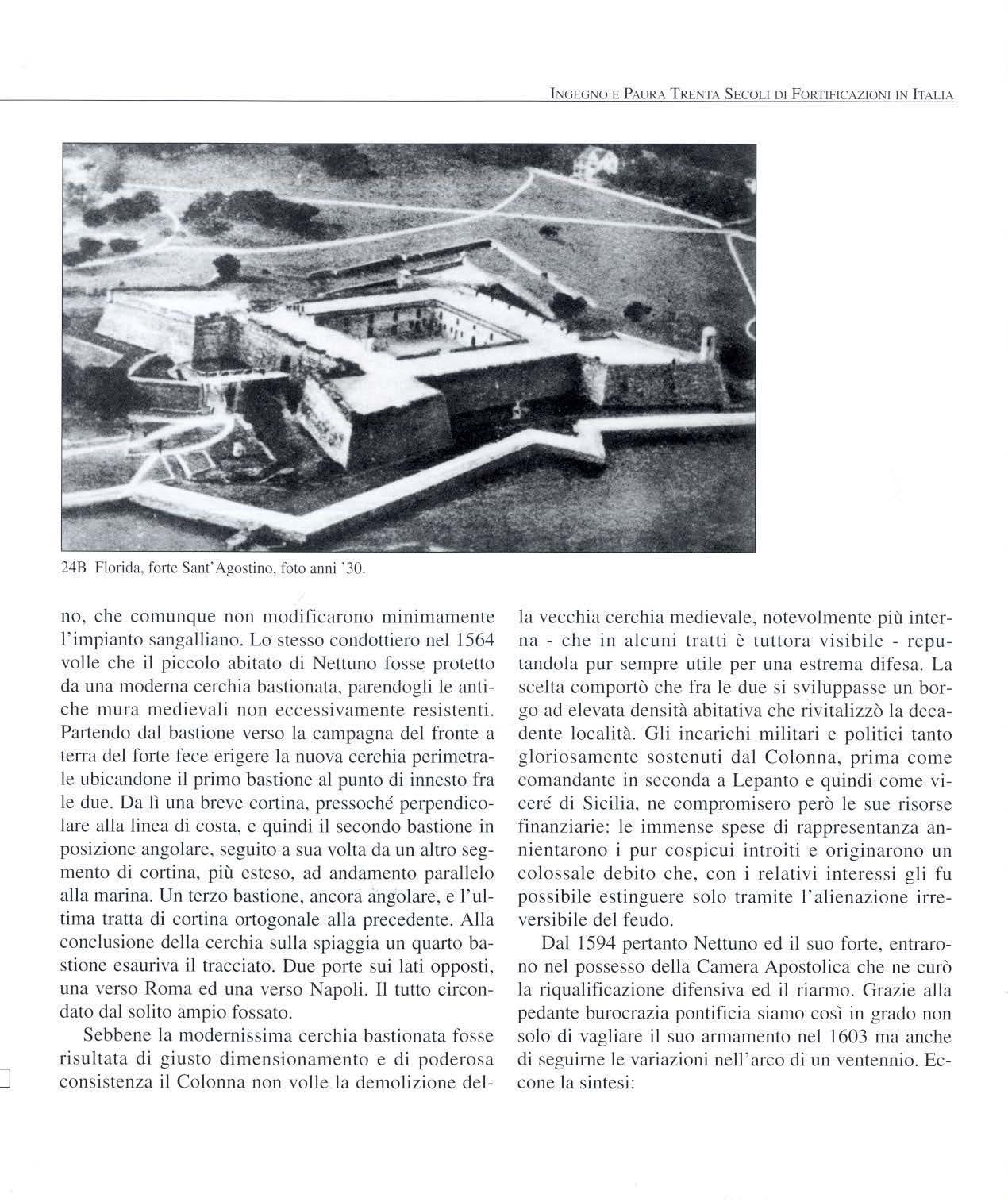
l a vecchia cerch i a medievale , notevolmente più interna - c h e in alcuni tratti è tuttora visibile - r eput a nd o l a pur sempre utile per una est r ema difesa . La s celta com p o rtò che fra l e due s i sv ilupp a ss e un borgo a d elevata densità abitativa che rivita li zzò la decadente località. Gli incarichi militari e politici tanto gloriosame n te sos t e nuti dal Colonna, prima come coma ndant e in seco nd a a L epanto e quindi co m e v iceré di Sicilia, ne com promi sero p erò le sue risorse finan ziari e: l e immense s pe se di rappresentanza anni e ntarono i pur cospic ui introiti e originarono un colossale debito che, co n i relati vi int e ress i g li. fu possibile estinguere so lo tramit e l 'a li enazione irr eve r s ibile del feudo.
Dal 1594 pertanto Nettuno ed il suo fo1te, e ntra rono nel possesso d e ll a Camera Apo sto lic a che ne curò la riqualificazione difensiva ed i l ri am10 . Gra z i e alla p eda nte bu rocraz ia pontificia s i amo così in grado no n so lo di vag li ar e il s u o a rmam e nto n el 1603 m a anche di seg uirne le variazio ni ne ll ' arco di un ventennio . Ecco n e la s intes i:
25 Scorc io fortificazione medieva le di Nettuno.
" ... a uno baluardo a mano rirw che gua rda in ve rso la marina, una colubrina di mera/lo a ca va llo
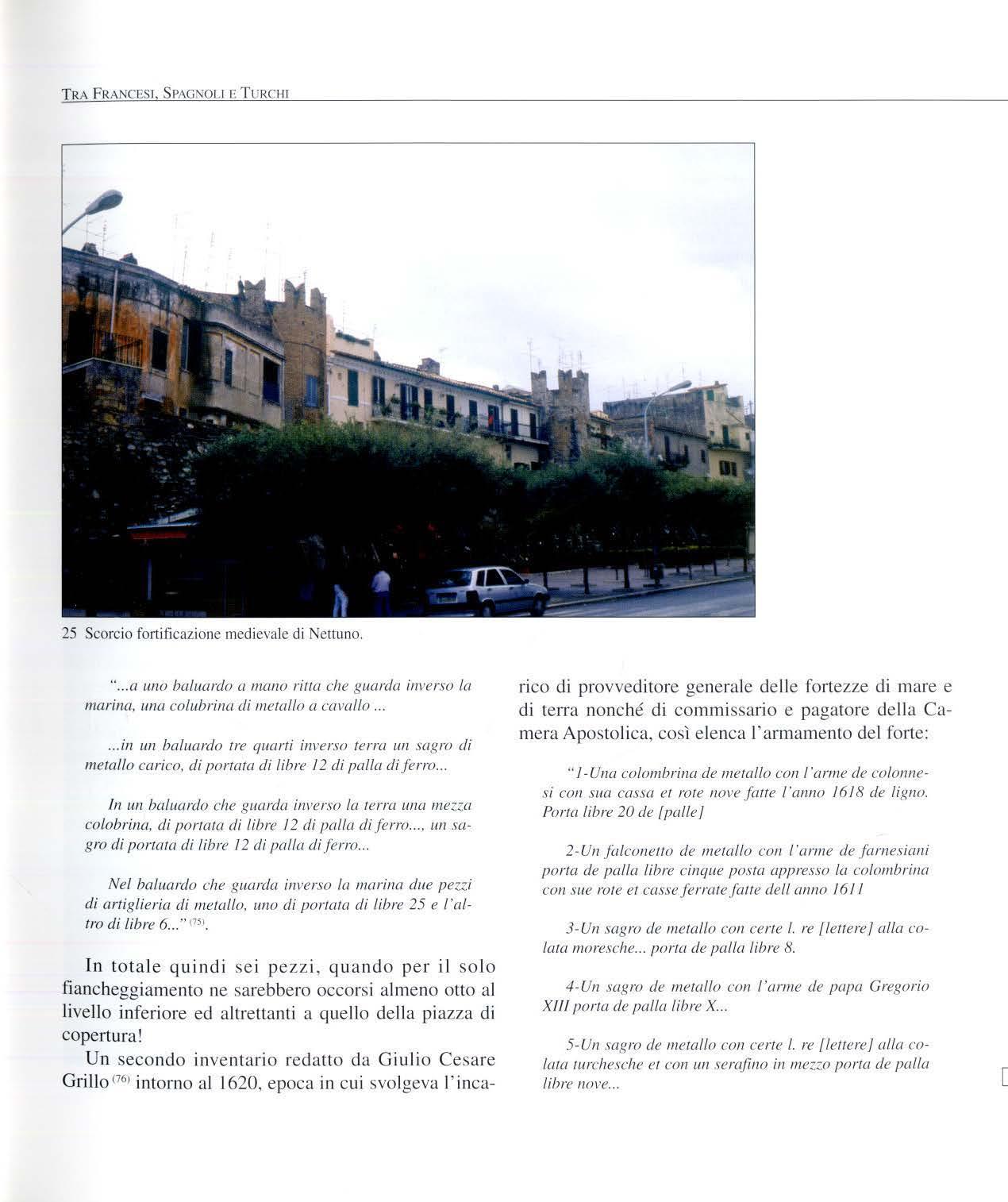
in un baluardo tre quarti Ìl1l'erso terra wz sag ro di me1a/lo carico, di p o rrara di libre 12 di palla diferro
In un baluardo che guarda inverso la terra ww me -::,z a colobrina, di porlata di libre I 2 dì palla di ferro , un sagra d i portata dì fibre 12 di palla dì ferro
Ne l baluardo che g uwda in ve rso l a marin a due p ezz i di artiglieri a di metallo, uno di portata di libre 25 e /'af1ro di libre 6 ·· <7 5 J
In t o t a l e q uind i se i pezzi, q u ando per i l so l o fianc heggi a m ento ne sarebbero occors i a lm e no o t to a l l ivel lo in feriore ed a ltretta nti a quello de ll a piazza d i co pertu ra!
U n seco ndo i nve nt ario redat to da G iul io Cesare G rìllo (76 l intorno al 1620, epoca in cui svo l geva l' in ca-
r ico di provvedito re genera le de ll e fo rtezze di mare e di te1Ta nonc hé di commissaiìo e pagatore de ll a Camera A pos to Iica , così e lenca l ' anname n to del forte:
"}-Una colombrina de m e/a llo con/ 'arme de co /0 1111 es i con su a cassa el rote nove fatte /'anno 1618 de ligno. Porta libre 20 de [palle}
2 - Un falconetto d e m eta llo con I 'arme de farnesiani pona d e palla libre cinque fJO Sta appresso la co lumbrina con s ue 1-o1e et cusseferra1e.fa11e del/ an n o 1611
3 - Un sag ra d e 111 e1allo co 11 ce r1 e I. re fl ette re 1alla colata moresc he ... porta de palla libre 8.
4-Un sag,v de rnewllo con /'arme d e papa Gregorio X lii p orta de palla fibre X.
5 - Un sagra d e metallo co n ce rte l. re [leltere} alla colaw turc hesche et con lflt se rafino in me::o porta de palla libre no ve [
6 - Una mezza colomb rù,a de metallo por/Cl de palla lihre 1·e11ti... ' ' •11 ••
Anche in qu esto in ve nl a rio i pezzi assomma no appena a se i! Ov v io reputarli l 'armamen to a bilu a le Pochi anni ancora ed una ennesima i s pezione, ne l lu g lio d e l 1623, co nd ot ta dal capitano Pomp eo Tracca g na. così ve rbali zzava in maleria:
" ... U11a colombrina longa hoch e 33 Porra di Palla li. JO in 36 bona e t ben e a cam llo
Un falcone lon go bocche 26 Porta di palla lib. 4 i11 6 bon o e t hene a cava llo
2 aspidi long/Ji bocche 24 porremo di palla lib. IO in 12 bone
Mez:a colo 111bri11a longa bocche 26 porta di palla lib 20 bona er bene a ca1•a l/o... " 17R,
Cinque modesti cannoni per un perimetro difens ivo di oltre 200 rn: logico co ncludere che la minaccia corsara non s i estrinsecasse più in s barchi e razzie a te1n ma so lt a nto con abbordaggi e catture in mare!
La deficienza infatti, che trova generalizzata e costa nt e riproposizione s ia a Nettuno che in ogni altra fortificazione costiera, d eve riteners i non so lo fisiologica, al pari d e ll 'i ns ignificante organico miliLare , ma sostanzialmente compatibile c on i compiti d e lla dife sa anticorsara esentata. per quanto ricord a to , dal do ve r sos tenere inve stimenti ossidionali propiiamente detti.

Com e in preced e nza accennato, il fiancheggiamento totale avrebbe potuto attuarsi anche senza bastioni, adottando un perimetro ad andamento spezzato, a dent e di se ga o a cremagliera. Di esempi siffatti pervenutici dall'antichità se ne rintracciano alq ua nti anche in Jt alia: tipico per tutti la sezione delle mura dell'antica Siracusa immediatamente contigua al Castello Eurialo <79) _
Una spezzata quando s i rich iud e rego larmente s u se s tessa da origine ad una figura s tellata. Un eventua-
le forle quindi, che avesse adottato tal e configurazione. sarebbe risultato pri vo di qualsiasi ango lo morto esterno e di qual s ia s i settore defilato , se nza richiedere peraltro l'edificazione di alcun bas tione, elemento difensivo dimostrato si s in dal s uo d e butto costosissimo e complesso.
Un ' opera del ge ne re , tanto lontana concettualmente d a lla fortificazione tradizionale e s olo poco meno da qu e l la recenti ssi ma bastionata , per essere concretamente edificata s upponeva una dirigenza capace di comprenderne i vantaggi ed abbastanza autorevole da imporla in un ambito s torico ancora suggestion ato dai facili c1iteri della tran s izione. Ma supponeva pure un intenso programma forr ifi catorio unica circostanza nella quaJe un impianto così a lternativo e rivolu z ionario potesse essere portato a comp im ento se nza parali zza nti crit iche. Condizioni tutte che s i verificarono a Napo li nella seconda metà degli anni '3 0 del XVI secolo, allorquando il viceré Toledo avv iò un'immen sa riqualificazione difen s iva dell'intero reg no , montando di giorno in giorno l ' in cubo de g li attacchi turco-b a rbaresc hi.
La Capitale se bbene fosse chiusa ne lle mura urbiche di recente costruzione, e di s uperal a concezione 180!, non disponeva però di un caposaldo apicale che l a proteggesse da un attacco da terra. In particolare s ulla collina di S. Manine che la s ovras tava svettava a ncora una vecch ia e mode s ti ss ima fortificazione normanna il cu i unico pregio cons i steva esclus i vamente nell'ubicazione. E fu appunto quello il sito prescelto per l' e rigenda fortezza , dopo un ' accurata indagine e dopo ponderat e a n a li si tecn i c he < 8 1' D estinala ufficialmente a proteggere Napoli, la si volle in concreto soprattutto per evitare che una s emplice batteria di cannon i piazzata s ull a so mmità d e ll 'altura dal primo nemico di turno potesse getta re, con pochi tiri, la popolazione nel panico costringendo la grande c itt à alla resa. Senza contare c h e, per ovvie considerazioni, la medesima forte zza avrebbe tenuto gli infidi abi tanti in uno s tato perenne di soggezione, tramite quegli stessi cannoni: esplicito esempio di architettura repre ss iva.
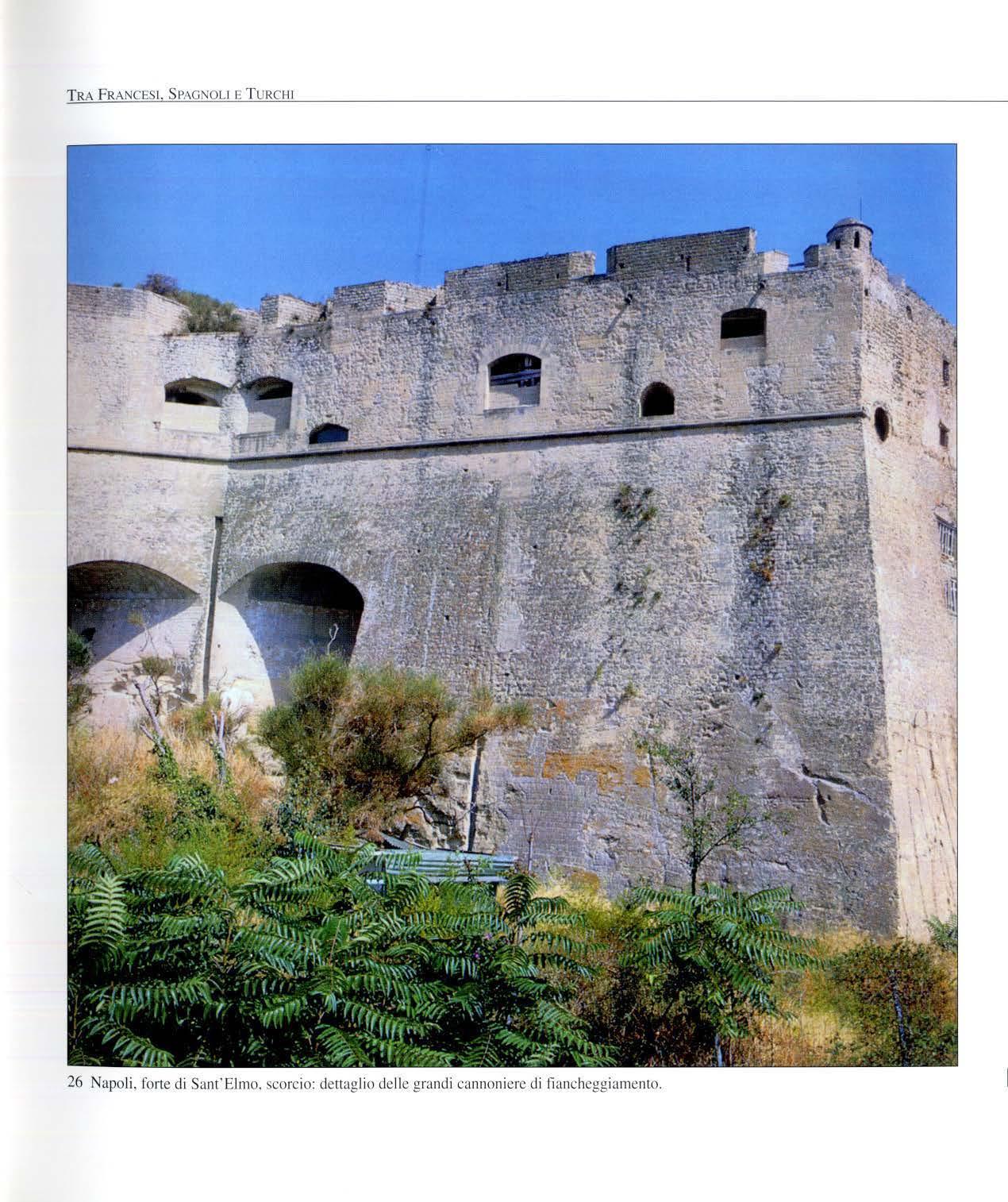
L' inc arico delJa progettazione fu dato allo spagnolo P edro Luis Escrivà !821, tecnico c he il viceré conobbe molto verosimilmente attraverso il fratello Di ego di Tol e do , priore dell'Ordine di San Giovanni di Spag na, e che ingaggiò inizi a lment e p e r la costruzione di un posse nte forte a ll ' Aquila.
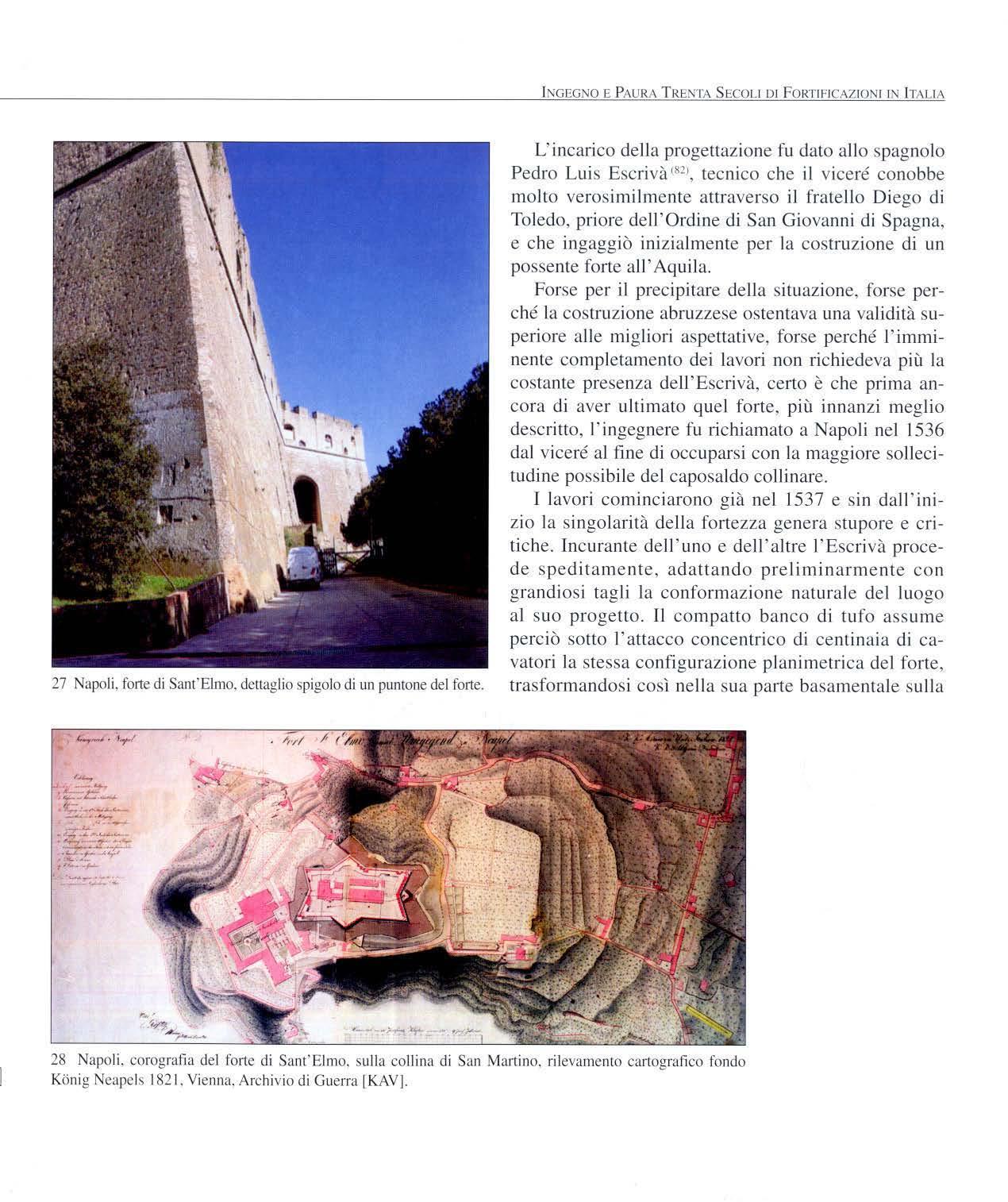
Forse per i l precipitare della s ituazione , forse p e rché la costruzione abruzzese ostentava una va lidità superiore alle mig l iori aspettative, forse perché l ' imminente completamento dei lavori non richied eva più la costante prese nza dell'Escrivà, certo è che prima ancora di aver ultimato quel forte , più innanzi meglio de sc ritto, l 'ingegnere fu richiamato a Napoli nel 1536 dal viceré al fine di occuparsi con la magg iore so llecitudine poss ibile del caposaldo collinare.
I lavori cominciarono già nel 1537 e s in dall'iniz io l a s ingolarità della fortezza genera s tupo re e critiche. Incurante dell ' uno e del] 'altre l'E sc riv à procede s p e ditamente , adattando preliminarment e con g randio si tagli la confo rmazion e natural e del luogo al s uo progetto. Il compatto banco di tufo assume perciò so t to l'attacco concentrico di ce ntinaia di cavatori la s te ssa configurazione p lanimetrica d e l forte,

q ua l e ad altezza variabi l e si inn esta la muratura. D all'alto ricorda una c urio sa ste lla a se i punte, fo rtemente a llun ga ta . A ben guardare : " ... non esistono neanc h e corti ne murarie ret tilin ee se s i eccettuano i due t ratti r e lativi alla 'co da ' del comp l esso . Ci s i trova di fronte. in prat ica, ad un ' uni ca immensa casamatta dotata di num erose postazioni per artiglieria protette e d in barbetta. Al po sto dei bastioni troviamo se i enormi puntoni in cui lo svil upp o delle facce per ciascu no di a lm eno quattro di ess i, termina dove iniz i a qu e ll o contiguo " ' 831 rJ che rappresenta. se m a i re s ta sse qualche dubbio , la tra sfo rmazione circo l are dell'impianto a deme di sega g ià de s critto da Filone Alessandrino nel Il sec. a.C .
Esattamente come per i 1 forte dell'Aqui l a i I fiancheggiamento c he l'Escrivà realizza a S. Elm o appare di ragguardevole entità, concentrandosi per l'ubicazio ne apicale lungo le due facce attigue dei puntoni. Grandi troniere a doppio appostamento so no perciò pos iz i onate in ciasc un o degli angoli rientranti del perimetro , in modo da poter s pazzare co n micidiale potenza og ni l ato della s tella e d , in particolare, q ue lli p iù 1unghi. Oltre all e troni e re per l 'a utodife sa il fo rte v iene munito di num erose cannon iere in barbetta , avvalendosi allo sco po del s uo enonne spiazzo di copertura, simi le a l carapace di una gigantesca tartaruga , da cui appunto la defi ni zi one di te stu[?gine . La di stribuzione delle stesse seg ue una logica iso tropa lun go l'intero perimetro, esp li c it a conferma che S. E lm o non è de stinato so lo a difendere la c ittà ma anche a frenarne og ni tentativo di ins urrezion e . ln quanto tale il forte napoletano sarà il capos tipite delle cittadelle spag nole , dalla duplice e d a ntitetica fina lit à che da quel momento diverranno l ' immancabile corollario di q uals iasi cerchia urbi ca bastionata.
Il fo tte, c hiam ato correntemente a nco ra con dizione spag no l a castello, nono s tante l a sua p osizio ne arroccata fu circondato da un ampio e profondo fossato, all ' este rn o del quale correva un muro di cinta di considerevo l e s pes sore. L 'entra ta venne ricavata ne ll a cortina se ttentrionale do ve il Toledo fece appo rre sul1'i mmancabile l apide comme m orat i va un 'e norm e aq uila bicipite , em bl e m a degli As burgo. Per accedere a S. Elmo sa le nd o m e no tortu osamen te dalla c itt à, s i incise ne l tufo un a appo s ita rampa che s i inerpicava lungo le ripide pendici de ll a collina. Guadagnato l'ing resso della cerchia es te rn a, s uperato il fossa to con un grande pont e l eva toio , l a rampa proseg ui va ancora al1' interno del caste ll o fino alla s ua piaz za d ' arm i, dove ve nn ero e r ett i g li alloggi per il caste llan o e per l a guarn igio ne.
A diffe re nza delle coeve fo rtezze in S. Elmo non v i era alcu n cort il e ce ntr a le, ma esattamente co m e in una nave corazzata so ltanto un ponte di coperta, s ul quale s i innal zano i suddetti edifici Al di so tto , in vece :
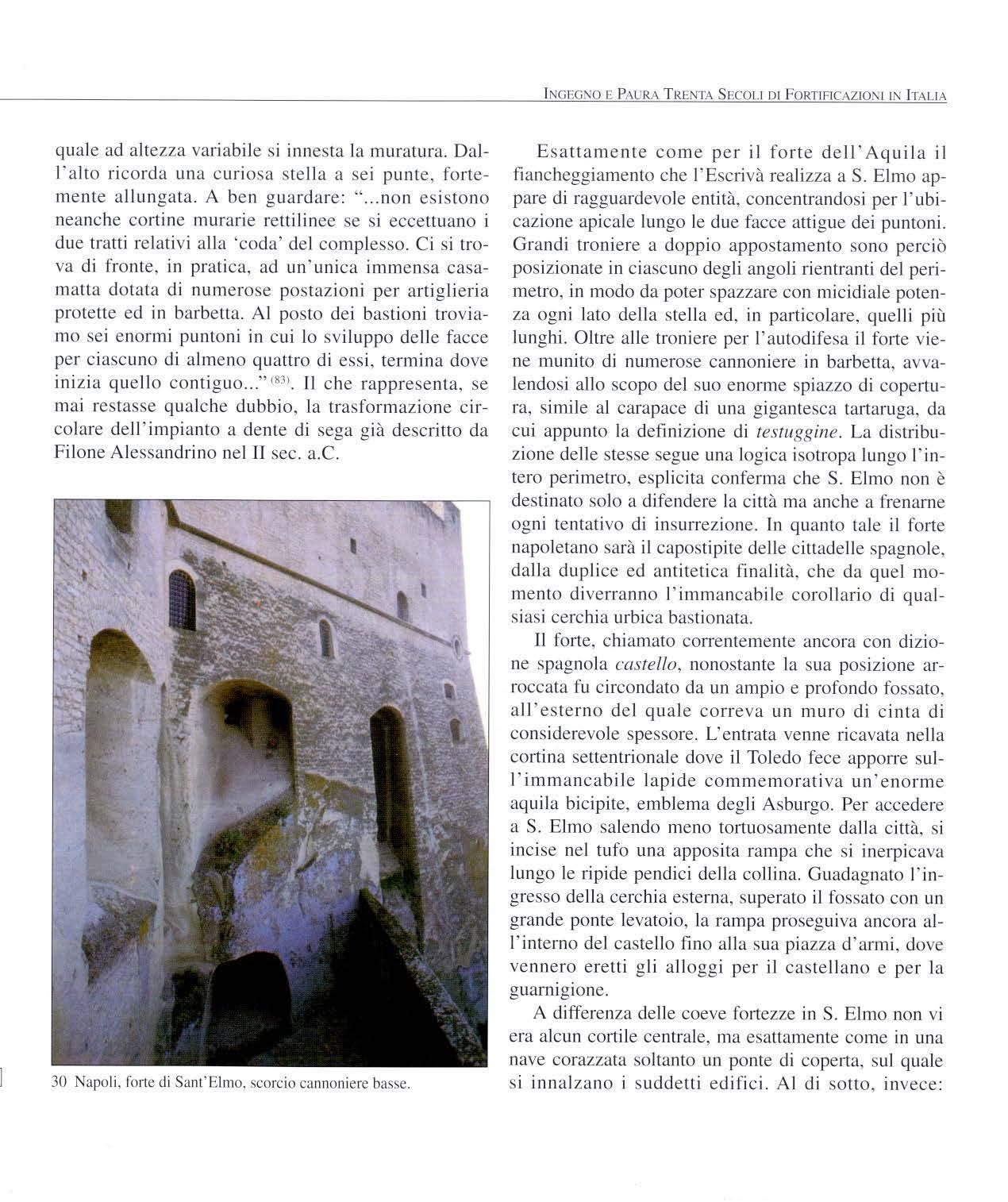 30 Napo li, fo rte di San t'Elmo. sco rci o ca nnoniere basse.
I NGEGNO E PAURA TRENTA S ECOI. I DI FORT IF!CAZION L IN ITALIA
30 Napo li, fo rte di San t'Elmo. sco rci o ca nnoniere basse.
I NGEGNO E PAURA TRENTA S ECOI. I DI FORT IF!CAZION L IN ITALIA
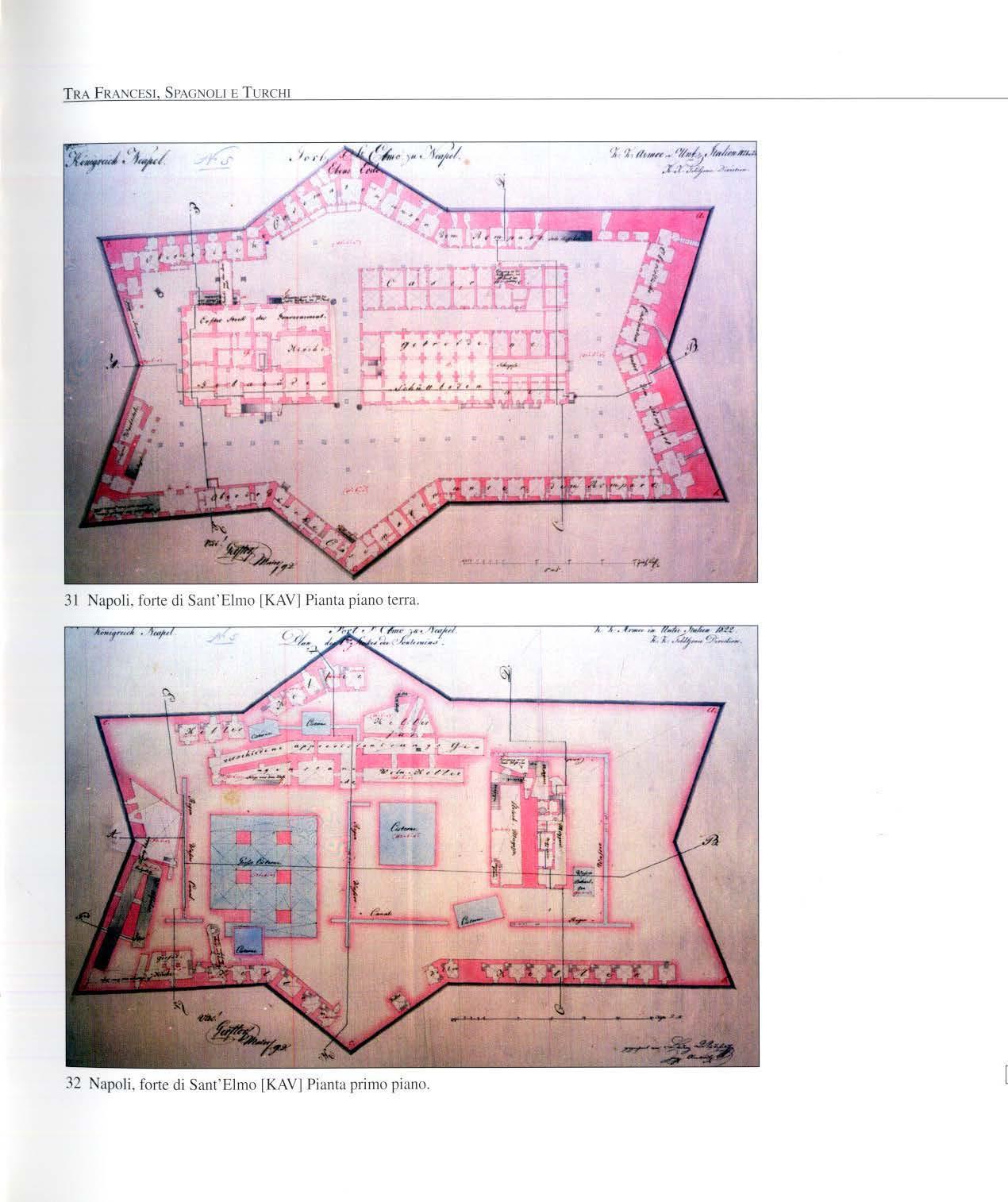
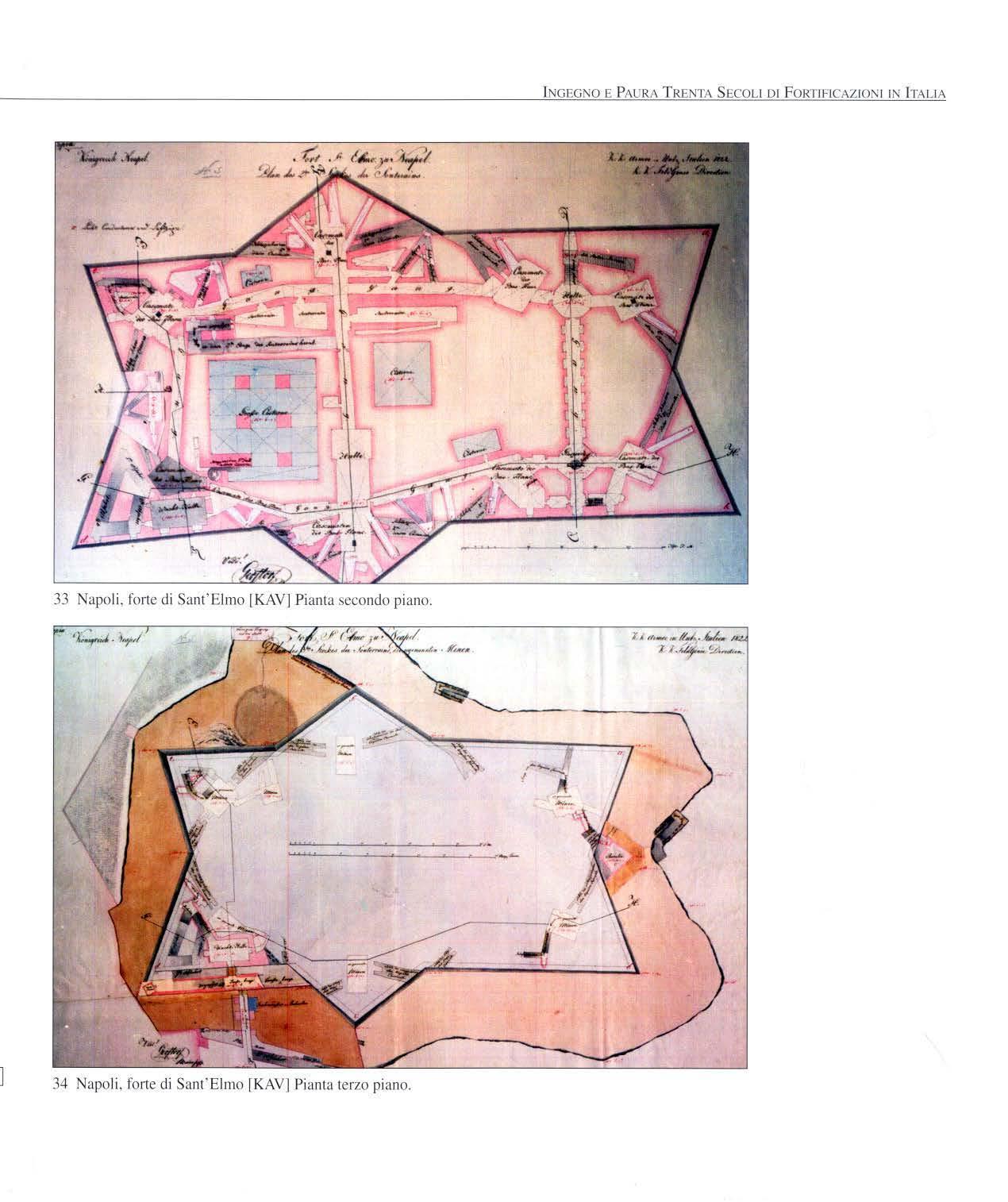

" del piazzale e lungo il contorno stellato della fortezza, furono ricavati nel1a roccia due piani di enormi locali, intercomunicanti con botole aperte nella volta, da adibire come officine, magazzini per viveri ed altri materiali, depositi di munizioni, lavatoi. forni , cucine e vasti ricoveri per truppa ..." (S4 l Sempre nel banco di tufo s i cavarono pure due enonni cisterne di cui una, in pianta di m 40x30, capace di oltre 10.000 mc d'acqua , ri se rva s ufficiente praticamente a tempo indeterminato.
L' ultimazione dei lavori non pose affatto fine alle critiche nei confronti del suo progettista, che si vide perciò costretto, evento più unico che raro nella s t01ia della fortificazione, a pubblicare un dettagliato memo1iale per esporre le sue ragioni 185 >

li tempo avrebbe dimostrato la validità dell'opera, mai espugnata nel corso della s ua plurisecolare vicenda. Nonostante ciò la s ua inconfondibile planimetria non ebbe alcuna riproposizione sign ificati va, ad eccezione del caratteristico forte Stella cli Porto Ercole, piazza cli notevole valenza strategica in quella strana entità sta tuale definita ali' epoca Stato dei Reali Pre s idi di To scana, di poco posteriore e per molti versi sim ile.
nel frattempo s i era trasformata in una soluzione canonica. L' opera in questione , battezzata dalla sua configurazione planimetrica forte Stella, progettata intorno alla metà del '500 fu impo stata però quasi ce1tamente a cavallo tra la sua fine e l ' ini zio del ' 600, nel sito di un antico fortino se ne se, come s i de s ume dai documenti innanzi citati, alla quota di m. 157 s .l.m. <86 )
La sua inconfondibile planimetria e, sopra ttutto , la discreta ripetitività d'adozione da pa1te d e i tecnici imperiali spagnoli e per contro il ,igetto da parte di quelli italiani, ne ce1tificano la datazione nello scorc io s uddetto , tanto più che almeno fino al 1646 non se ne 1intraccia alcun esplicito riferimento cartografico. Infatti , è soltanto a partire dall'assedio di Orbetello che Forte Stella compare immancabilmente in ogni mappa e sco rcio prospettico, con la definizione 01iginaria di 'Stellata'.
Alcuni decenni dopo l'ultimazione della fortezza napoletana e delle due principali di Porto Ercole, rispettivamente la Rocca e Forte Filippo, risapendosi ormai perfettamente la po s izione eccessivamente subordinata della prima a]]'altura limitrofa, si decise di stornarne ogni rischio occupandola con un ennesimo caposaldo, sia pure di modesta dimensione. La motivazione in sosta nza appare la medesima ravvisabile alle spalle del forte S. Elmo di Napoli , per cui non stupisce eccessivamente constatare che la risposta architettonica fu molto simile. Del resto la procedura di occupare con un caposaldo la sommità di ogni altura immediatamente sovrastante una piazzaforte per porl a al riparo da un potenziale cannoneggiamento nemico,
È comunque interessa nte osservare, ed al contempo emblematico per denominazione , che le sue articolazioni e dimensioni coincidono quasi esattamente con Fort Saint Elme, a Collioure s ui Piren ei Orientali, forte eretto inglobando una precedente torre di guardia nel XVI secolo, opzione questa che potrebbe anche ravvisarsi alle spalle della nostra opera. Un altro forte di identica impostazione si rintraccia, sempre sui Pirenei Orientali , presso Prats de Mollo, chiamato Fort Lagarde. ed anche in questo caso s i tratta di un'opera di montagna so rta intorno ad una preesi s t ente tone di guardia che ne diviene il nucleo centrale. E forse il dettaglio più interessante in que s to seco ndo esempio è la cerchia bastionata che la circonda, a poca distanza dalla base, trasformandola in un anacronistico maschio <s7 ) _
Tornando a Forte Stella quanto delineato induce a concludere che si ravvisano sensati motivi per ascriverne s ia il progetto che la logica stessa dell' intervento ai tecnici s pagnoli, esulando s iffatta concezione dai tradi z ionali sc hemi rinascim e ntali italiani , almeno con tanta esasperata s immetria. Intorno alla sua base, in epoca sicuramente po s teriore, venne edificato un recinto quadrilatero munito di quattro bastioni ai vertici.
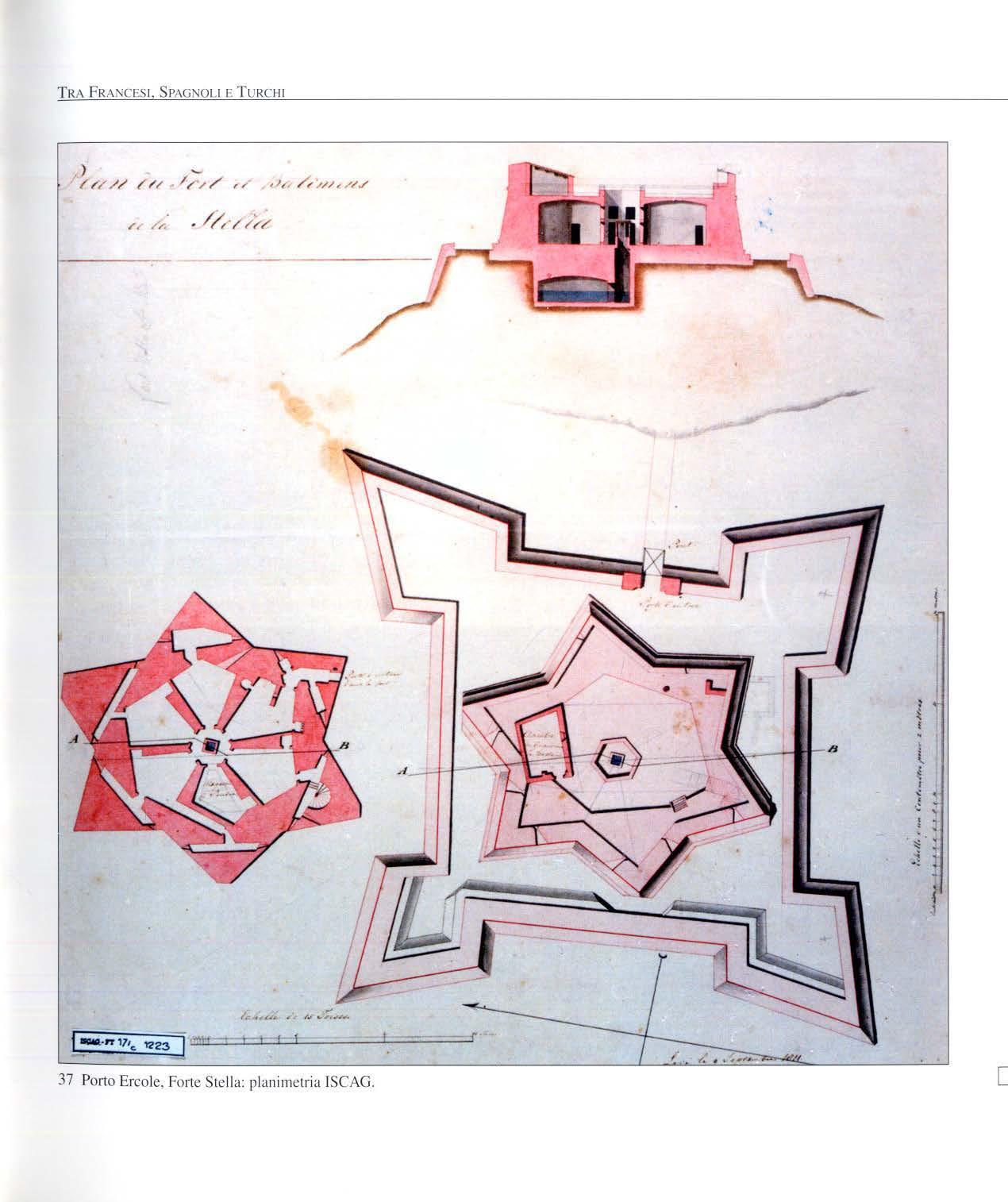
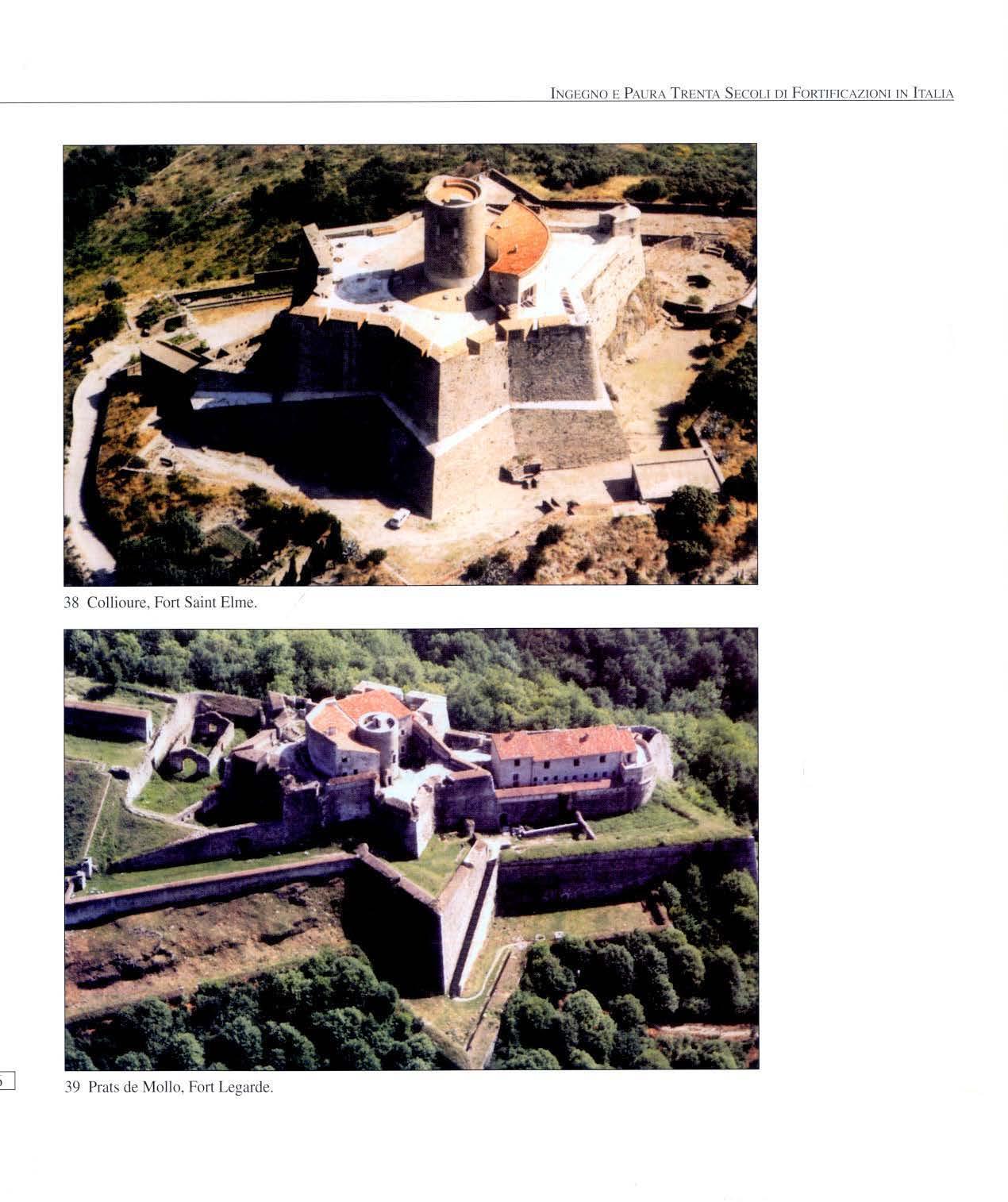
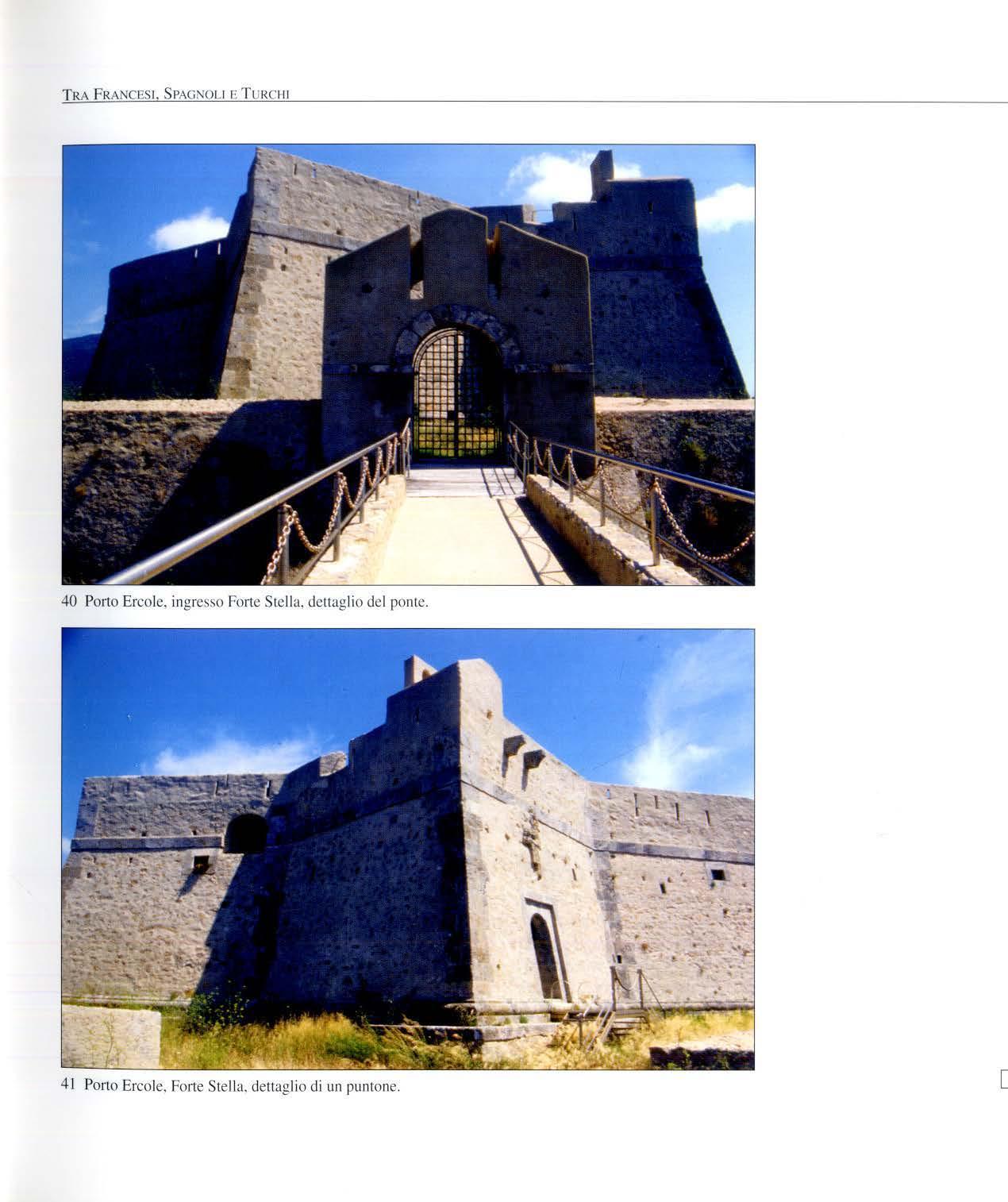
Stando ad una lapide sembrereb be che la realizzazione possa ascriversi al 1678 e d è significativo c h e ,mc be a Fort Lagarde, verso la fin e del XVIJ secolo, s i intervenne, s u progetto dell'ing. Rou sse lot per incrementarne la difesa perimetrale. Per forte Stella s i trattò di una integrazione tesa a potenziarne il fian c h eggiamento complessivo, per s to rn are la minacc i a di un eventuale perico lo so avviciname nto ossidiona le Ma prop1io pe r adattare il recinto al sito ed aJJa funzione non s i ev itò di intervenire s ull a 'stella ' s mu ssa ndo alcuni s pigo li senza b adare minjma m e nt e al 1i spetto di un a qual s ias i s imme tria tra le du e parti. I quattro b as ti o ni , poi, ri s ultan o alquanto grezz i ed approssimati, pri v i per gi unta di fianchi rie ntrati e di ssimili per d im e ns io ni . Nella cortin a orien ta le d e ll a cer chia ve nn e co lloca t a la porta d ' in g resso, preceduta daJl ' immancabil e ponte leva toio sul relativo fossato.
Jn si nt es i il: " ...forte a fo rm a di s tell a cos titui sce una vera e propria casamatta ... L 'accesso o ri g inal e era in
con-i spondenza del rivellino della porta d ' ingresso. I n seg uito fu murata e ogg i ne resta una quasi inv i sibile traccia. La porta d'accesso , la sola ag ib ile... s i trova su l lato meridionale e fu a p e11a in epoca posteriore .. . El fuerte de la Estella o de la Strellia, pur avendo ambienti in grado di accog li ere un presidio s up eriore a 50 sol dati , non e bbe che pi cco le g u a rni g io ni; poc hi u o mini in tutto, a ddirittura so lo 4 ne l 1646, aumentati a 12 ne l 1648, e spesso restava sguarnito persino di cannoni " (88 >
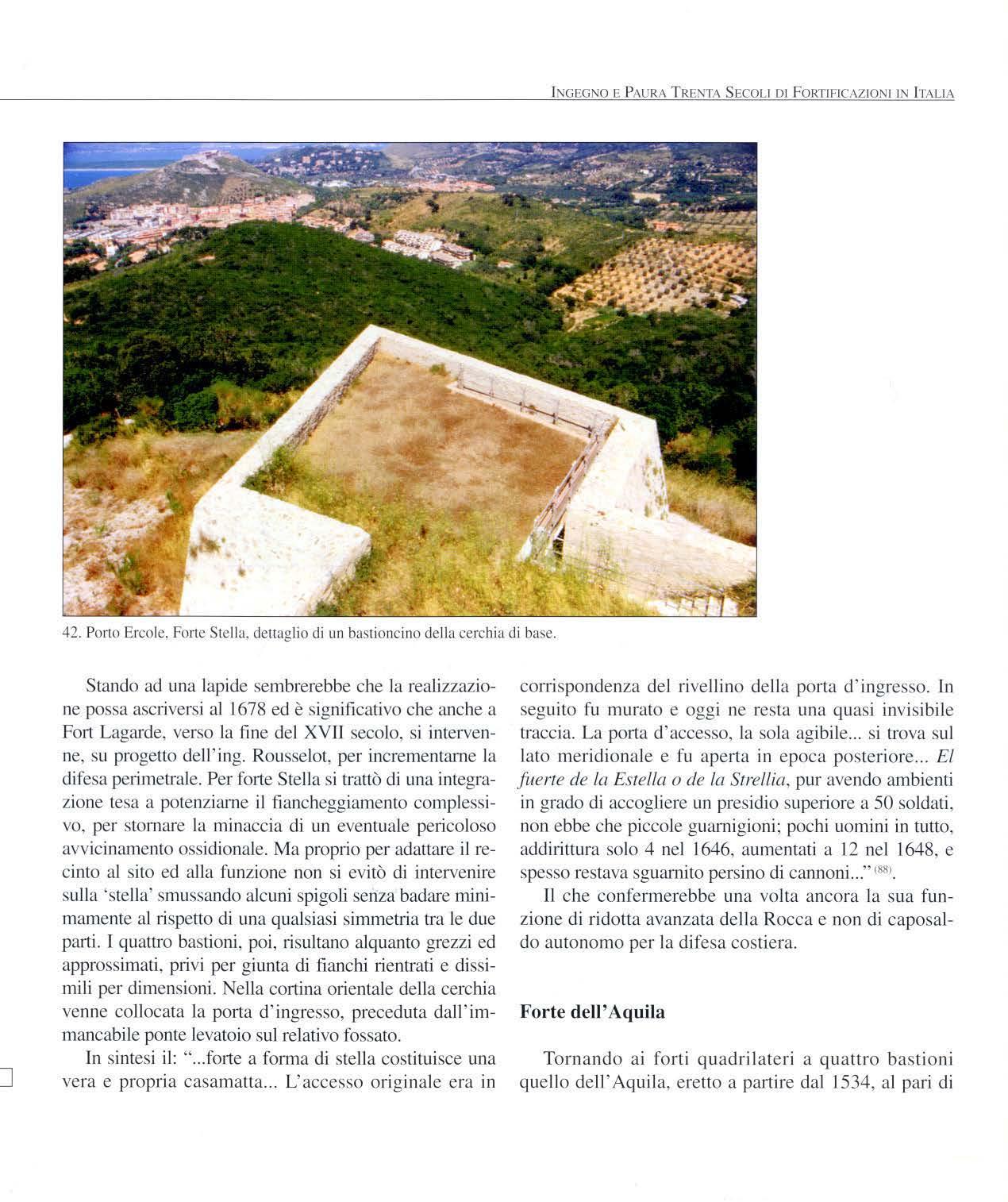
Il che conferm e rebb e una vo lta a n cora la s ua funz ione di ridotta avanzata de ll a R occa e non di caposald o a ut onomo per la difesa costiera.
Tornand o ai fo rti quadrilateri a quattro bastioni quello dell'Aquila, eretto a partire dal 1534, a l p a ri di
quelli di Acaja (Lecce 1535), di Mola ( Bari 1535 ), di B ar letta (Baii 15 37), di Vieste (Foggia 1537), di Lecce ( 1539) , di Copertino ( 1540), e di Capu a (1542) costi tui sce l 'avv io di un vasto programma di rifortificaz ione del regno di Napoli. Il r ec into più o meno quadrato con quattro bastioni ai vertici, od anche m e no in
alcuni casi di stringente condizionamento ambientale, fu il prototipo 1ite nuto più idon eo a ll o scopo. Si d i m os trava, infatti , re lativamente rapido da cos truire, abbas tan za facile da inserire in qualsiasi contesto geomorfologico, di ampia a ffid a bilità dife n si va e di sped ito accertamento finanziario al moment o dell'appalto, [
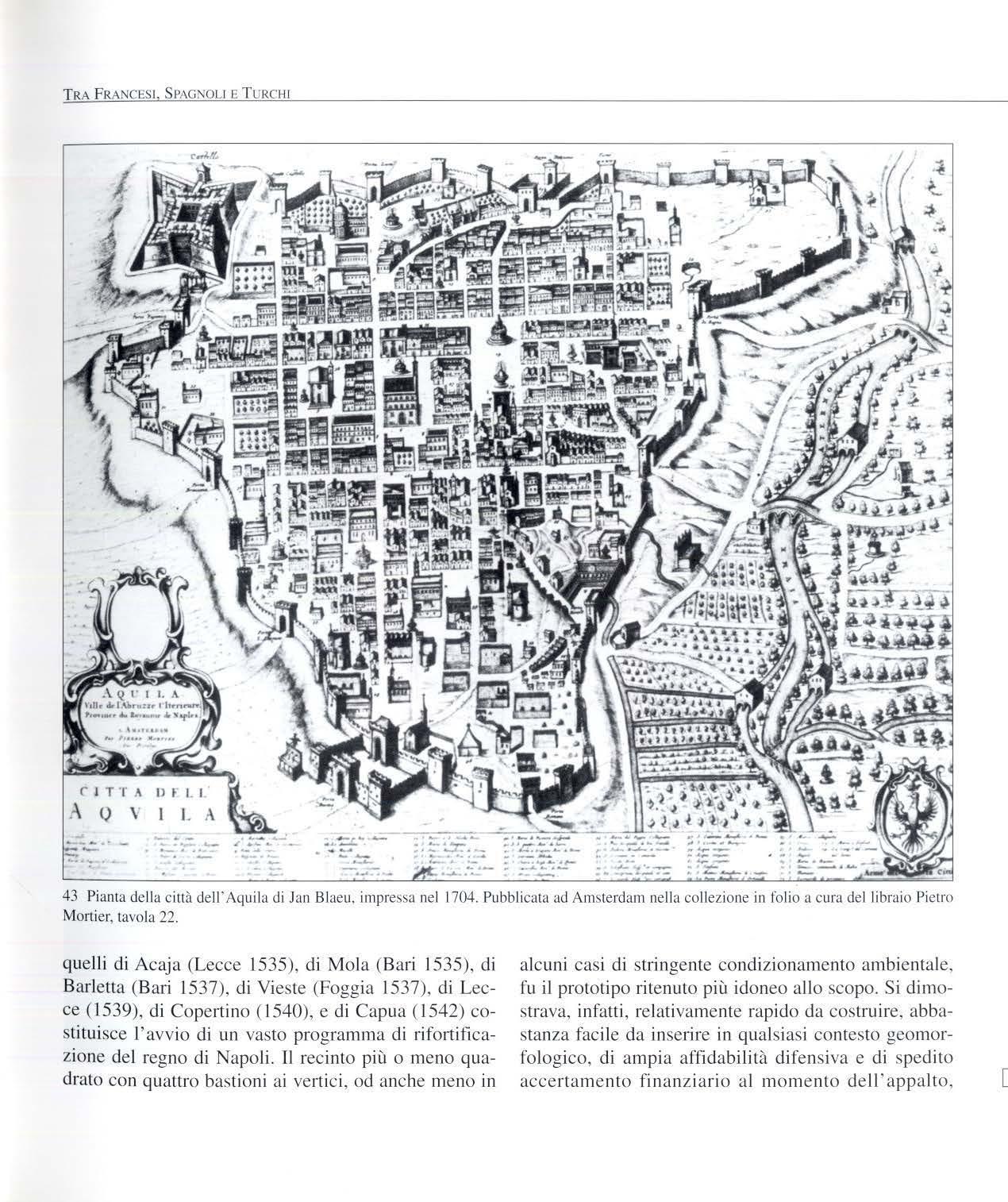
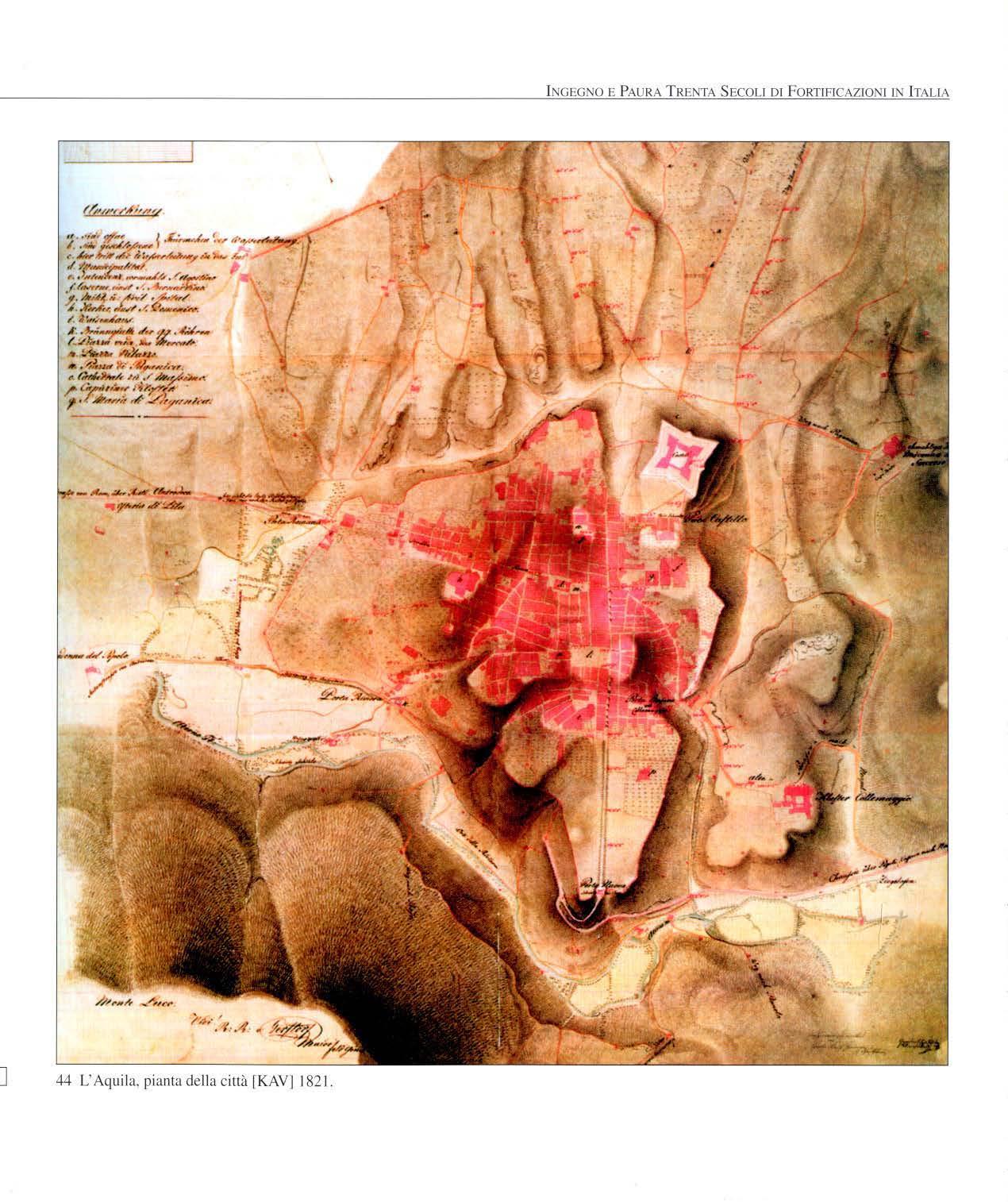
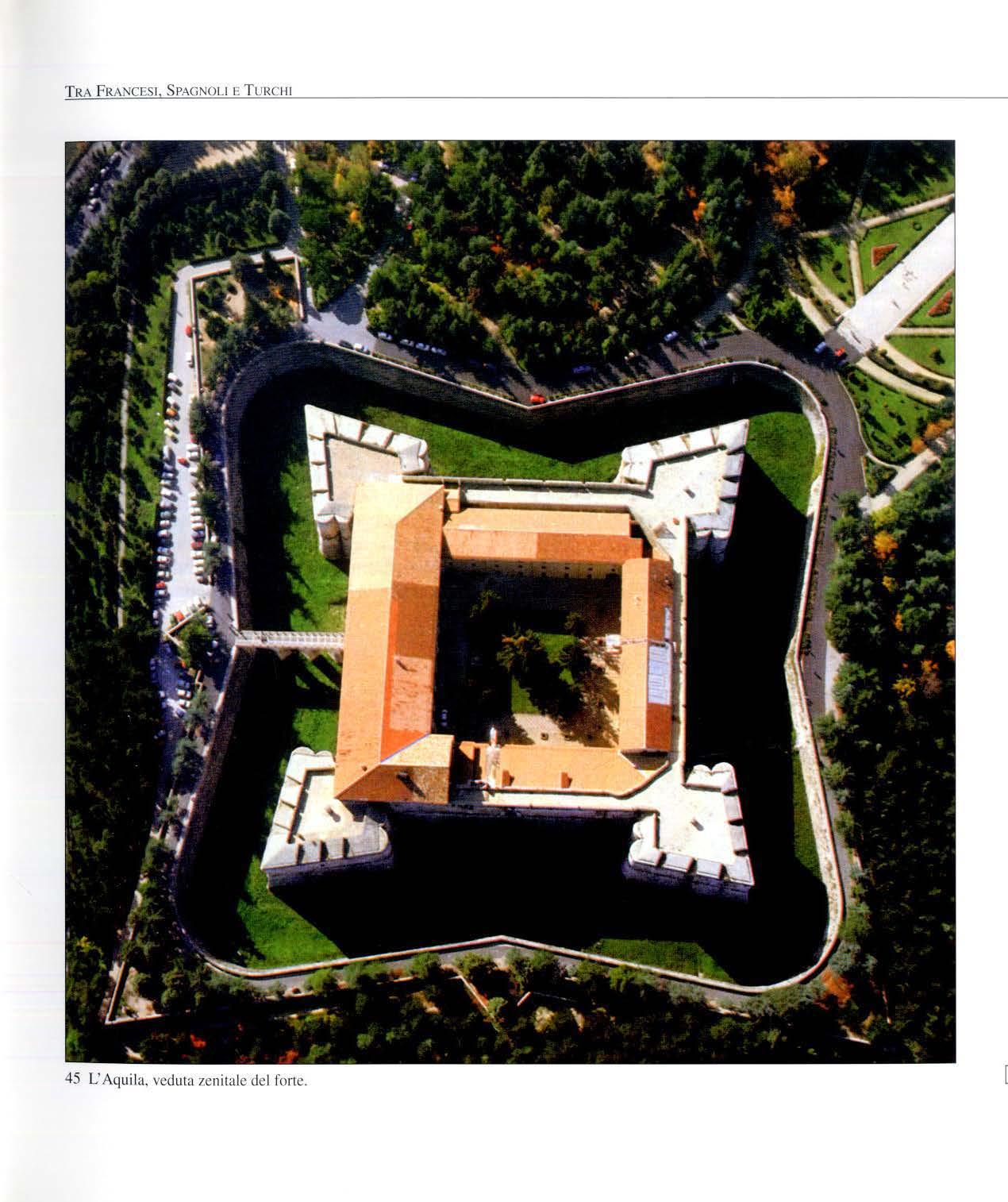
tanto per ricordare alcune delle molte s ue peculiarità incentivanti. In quasi tutti i casi rub1icati la destinazione era sempre la medesima: fronteggiare la minaccia turca frustrandone qualsiasi tentativo di sbarco. Unica eccezione il primo della serie, il forte dell'Aquila , accorta ed aggiornata riedizione di quello di Nettuno.
Significativamente lo: " schema, di cui il forte di Nettuno rappresentò il prototipo, testimonia il trapasso dal Quattrocento al Cinquecento e coincide con il passaggio dal tipo fortificato della rocca a quello del forte. Si tratta di un autentico prototipo-modello, quadrato , con quattro bastioni angolari , da] fianco ritirato che permetteva di attuare in modo quasi geometrico la radenza del le facce , fissando definitivamente la tipologia del bastione. Tutti i forti costruiti nella prima metà del cinquecento si ispirarono. chi più chi meno, all'esempio di Nettuno, al più perfezionandolo nei dettagli, ma più spesso, non riuscendo , per un moUvo o per un· altro, a ripetere con altrettanta perfezione lo schema ... J costruttori delle fortezze vicereali del Mez-
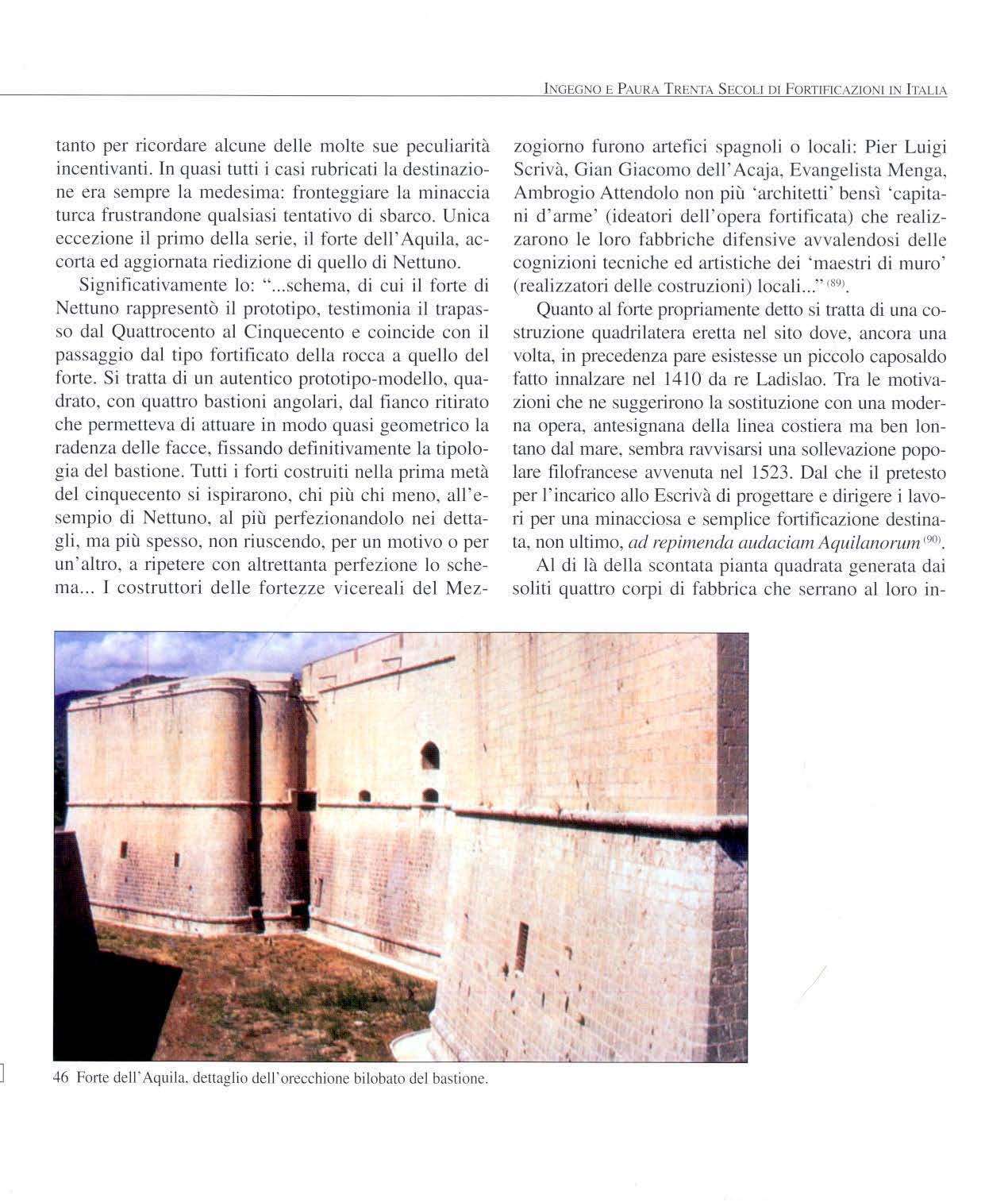
zogiorno furono artefici spagnoli o locali: Pier Luigi Scrivà, Gian Giacomo dell'Acaja, Evangeli s ta Menga, Ambrogio Attendolo non più ' arclùtetti ' bensì 'capitani d ' arme ' (ideato1i dell'opera fortificata) che realizzarono le loro fabbriche difen s ive avvalendosi de1le cognizioni tecniche ed artistiche dei ' maestri di muro' (realizzatori delle costruzioni ) locali ... " 189 l
Quanto al forte propriamente detto s i tratta di una costruzione quadrilatera eretta nel sito dove, ancora una volta , in precedenza pare esi s tesse un piccolo caposaldo fatto innalzare nel l 41 O da re Ladislao. Tra le motivazioni che ne s uggerirono la sostituzione con una moderna opera, antesignana della linea costiera ma ben lontano dal mare, sembra ravvisarsi una sollevazione popolare fi.Jofrancese avvenuta nel 1523. Dal che il pretesto per l'incarico allo Escrivà di progettm·e e dirigere i lavori per una minacciosa e semplice fo1tificazione destinata, non ultimo , ad repùnellda audaciam Aquilanorum !9nl
Al di là della s contata pianta quadrata generata daj soliti quattro corpi di fabbrica che s errano al loro in-
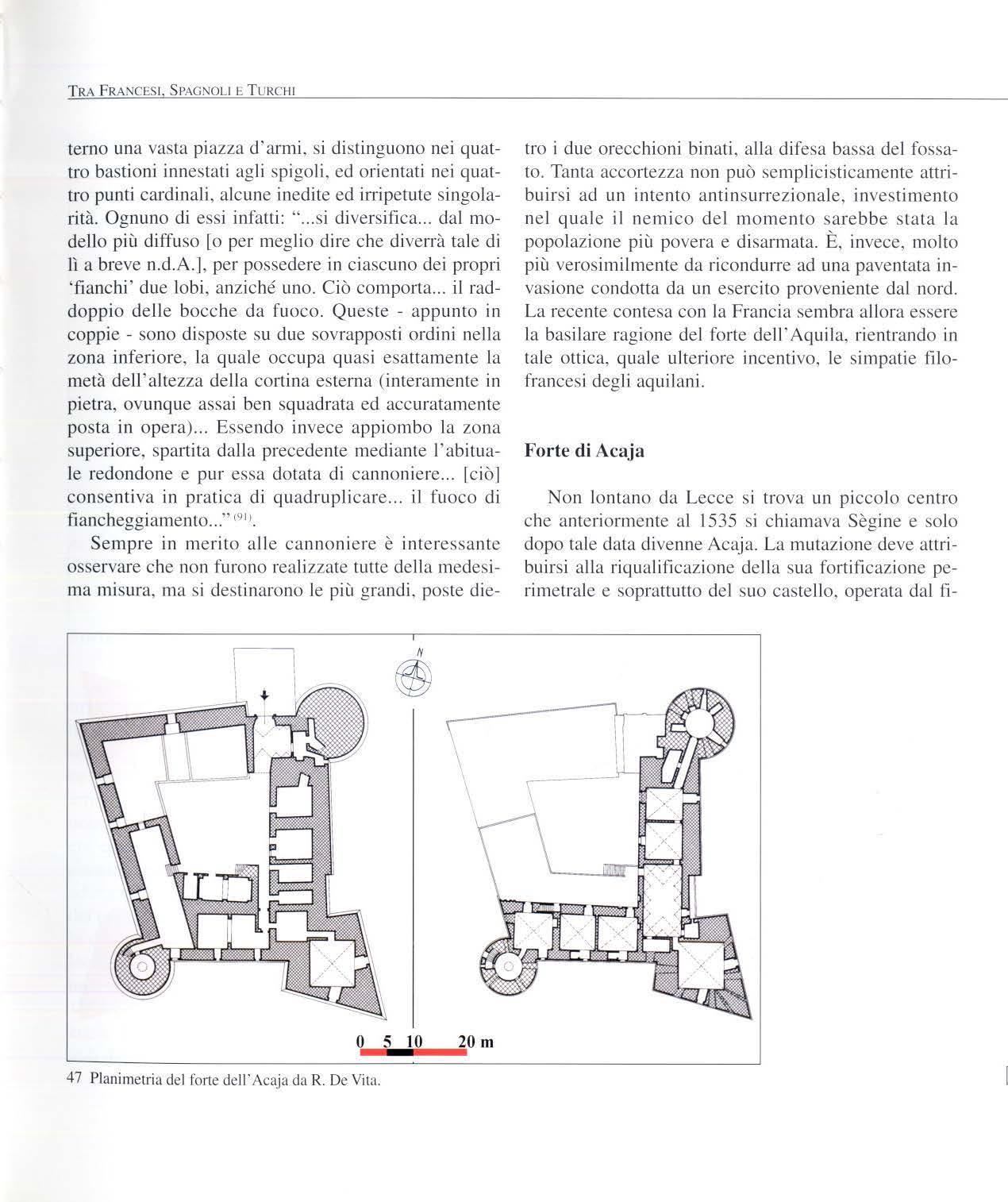
terno una vasta pia zza d' armi , s i di st inguono nei quattro bastioni innestati agli sp igo li , ed orientati nei quattr o pun ti cardina li , alcune inedite ed irripetute si ngola1ità. Ognuno di essi infatti: " s i diversifica dal modello più diffu so Lo per meglio dire che d ive rrà tal e di lì a breve n.d.A.l , pe r possedere in ciascuno dei propri 'fianchi' due Lobi, a n z iché uno. Ciò comporta il raddoppio delle boc c he d a fuoco. Queste - app unt o in coppi e - so no di spos te s u due sovrapposti ordini ne ll a zona inferiore , la quale occupa qua si esattamente La me tà dell 'a lte zza della cortina es terna ( interamente in pietra, ov un q ue assai ben squadrata e d accuratame n te po s ta in opera) ... Essendo invece appiombo la zo na s uperiore. s partita dalla preced e nte m e diante l 'a bituaJe redo nd one e pur essa dotata cli ca nn o ni ere ... fciò 1 consentiva in pratica di qu a druplic are ... il fuoco di fiancheggiamento .. .'' 19 1'
Sempre in merito alle ca nn o ni ere è int eressa nt e os ser vare che non furono rea h zzate tutte d e lla medesima mi s ura . ma s i d est inarono Je più gra ndi. poste die -
tro i du e orecchioni binati, alla difesa bassa del fossato. Tanta acco rtezza n o n può semplicisticamente attribuirsi ad u n intento anti n s wTe z ìonal e, investimento nel quale il n emico del momento sa r eb be s t a ta l a popolazione più povera e di sarmata. È, invece. m o l to più veros imilmente da ricondurre ad una paventata invasio ne condotta da un esercito pro ve ni e nte dal nord. L a recente contesa con l a Francia se mbra a l lora essere la ba silare ragione del forte d e ll'A qu il a, ri e ntrando in tale ott ica, qual e ult e riore ince n tivo, le s imp ati e filofrance s i degli aquilani.
Non lo nt ano da Lecce s i tro va un piccolo centro che anteriormente al 1535 s i chiamava Sègine e solo dopo tale data di ve nne Acaja . L a mutazione dev e attribuirs i alla riqualificazione della s ua fortificazione perim e tral e e sopratt utto del suo cas tello, operata dal fi-
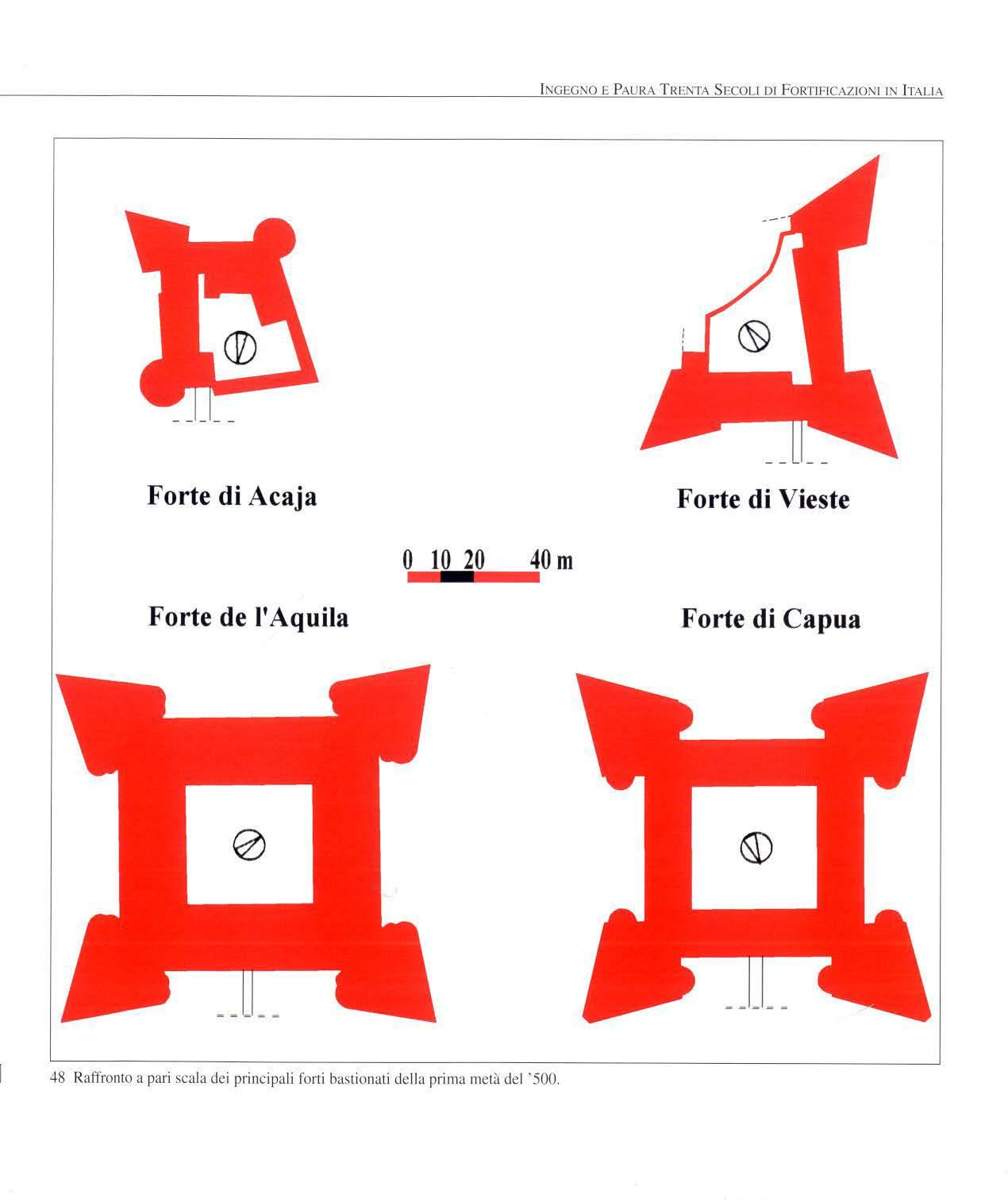
glio del feudatario Alfonso dell' Acaja , Gian Giacomo , uno dei principali ingegneri mi l itari a l se rvizio di Carlo V e d e l s uo viceré don Pedro di Toledo 1ni
La pianta de l forte, c he tale in effetti fu piuttosto che un anacronistico castello, ri se nt e di co ndizionamenti urb a ni stic i pr eesistenti e probabilmente inamovibili : la s ua co nfi g urazion e, infatti, non mostra la mede sima p erfetta regolarità dei precedenti esempi .
In dettaglio l a s ua configurazione geo me tric a: " ... è trapezia e i s uoi lati mi s urano a ll 'i nc irca m. 35. m. 44, m. 46. Ai due spigo li diametralmente o pp osti, a Nord-Est e a Sud - O vest, sorgo no due torrioni rotondi alti quanto le co rtin e ... L ' a ngolo di Sud-Est è munito di un imponente balu a rdo dallo sp igo lo molt o appunti to rivol to ver so il mare e l e zone acqu itronos e ivi es istenti ..." <93 > _ Ed è proprio qu es to s pig olo con il suo bastion e che certifica in zo na l ' avvio della ri fo rlifi caz i one voluta dal Tol edo e portata avant i spas m od icam ente prima della metà del '500
Stando a d un preciso rilievo planimetro eseg uit o sul finire del XVI seco lo dall 'ingeg nere Carlo Gambacorta, custodito in Francia , non c hé da un secon do coevo e sostanzialmente simil e conservato agli Uffizi di Firenze < 94i , intorno alla cittadina di Mola , sia pur con diverse a rticola z i oni, compaiono v is to se mura urbiche ed un notevo le forte b as tiona to. fn realtà l'abitato all ' e poca era circondato per rre lati d a l mare e riproponeva la class ic a impo st a zio ne cinta urbic a -caste llo p eriferi co, adattando le prop1ie mura alle tortuos e c irconvolu zio ni del profùo costiero ed alle asperità del te rre no. S e so tto la dinas tia angioina notevo li cure furono riservate all a località, sotto gli aragonesi s i increm e ntarono addirittura , come le superstiti strutture confe rm ereb bero . Nel 1508 però nel corso di un 'e nnes ima ostilità coi Ven eziani, Mola riportò ne ll e s ue fortificazioni considerevo}j danni , che ne d ecretarono la ricostruzione pe r opera del marche se di Polignano , Ga s pare Taraldo.
49 Mola. pl a nime rria de l fo rte. D a R D e Vita
Al rafforzamento del castello dell ' ultimo scorcio del XV seco lo . effettua to so tto la direzione dell'archilelto Giovanni Giocondo , discepolo del Mart in i, s i sommò pertanto quello dei prim:i decenni del '500, che vi de l'aggiornamento de l complesso castello-cerchia. Inoltre in età vicereale, fra il 1535 ed il 1541 , s i procedette ad ulteriori adeguamenti con la probabile esecuzione dei bastioni, so tto la supe rvi s ion e di Evan ge li sta Menga. Il sommarsi degli interventi finì col dare alla cittadina la p ec uli are connotazione che da allora non avrebbe più dismesso.
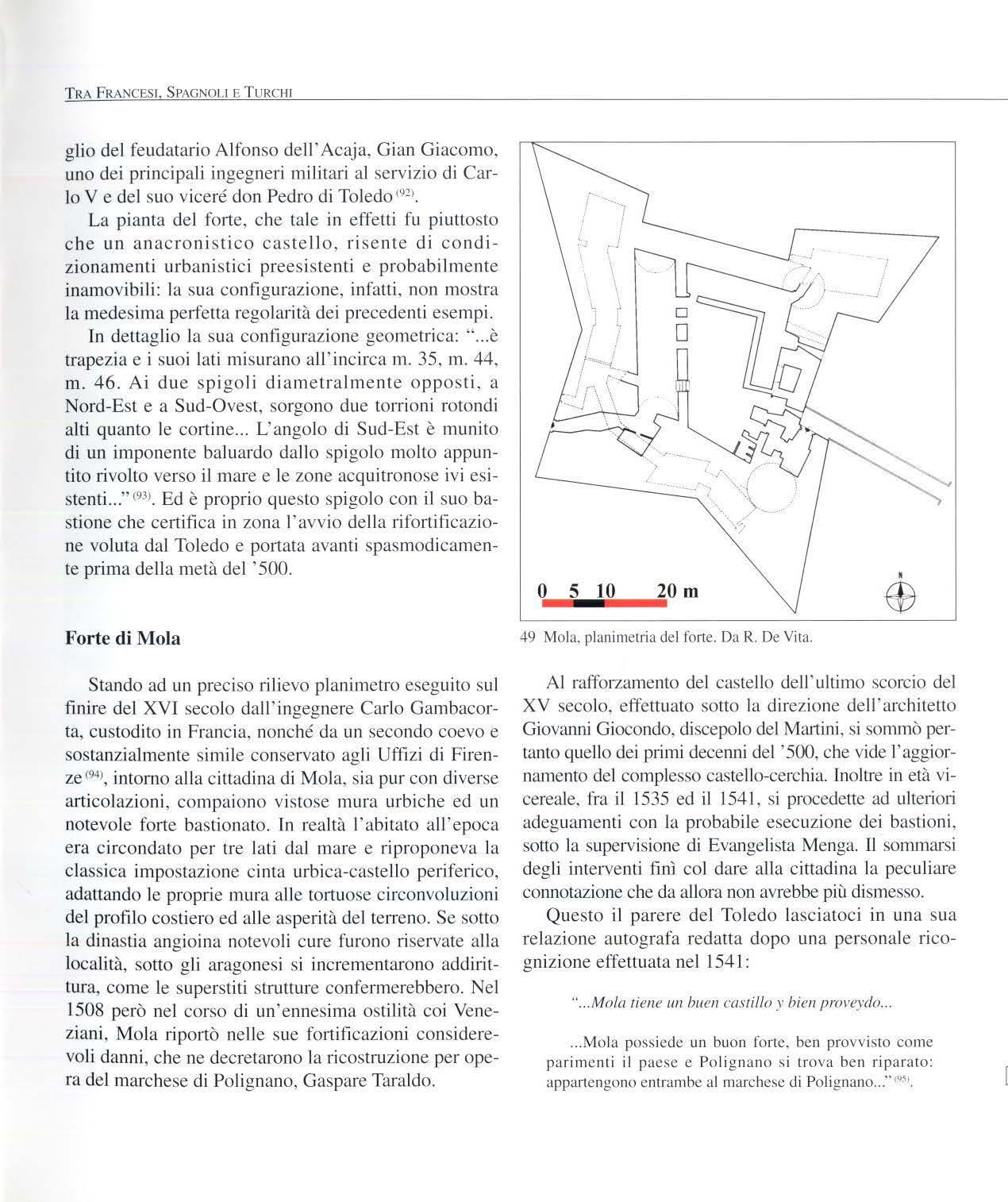
Qu es to i l parere del Tol e do lasci atoci in una sua relazione autografa redatta dopo un a personale ricognizione effettuata nel 1541:
" Mola tiene un bu en casti/lo y bien pro vey do
Mo la po s siede un buon for te ben pro v vi s to come parimenti il paese e P o l ignano ~i trova ben riparato: appartengo no e ntrambe al marchese di Polignano " c9 ; 1 •
Dal punto di vista architettonico il forte s i: " prese nta Ldi] forma quadrangolare con ag li spigoli, collegati da bre vi cortine, quattro puntoni molto s porgenti e scarpa ti. All'interno gli ambienti s i articola no intorno ad un ampio corti l e quadrangolare con i lati quasi paralleli alle cortine.
Lo s pesso re dei co rpi di fa bbrica varia dai l O ai 13 metri . Es se ndo pessime le cond izioni di conse rvazione, il castello oggi ci appare molto meno imponente di quanto fosse in origine, essendosi di s trutta qua s i in ogni lato la parte alta che si e l evava, con pareti vertical i, se p ara ta da un robu s to toro marcapia no ancora ben visibi l e, dalla murazione più bassa scarpata ... Dop o essere passat o agli Spag noli ai Veneziani e q uindi agli Spagnoli e nuovamente ai Veneziani fu da questi ceduto a Carlo V nel 1530. Ques ti fece adattare il castello alle nuov e esigenze dife n s ive ... dal! 'a rchit et to militare Evan ge li s ta Menga da Copertino.
Questi tra il 1535 e il 1540 , se n za manomettere il caste llo a ng io ino lo incapsulò con nuove mura sca rp ate se parate da quelle originarie da un o s trato di telTeno. Questo te1Tapieno interm e dio do veva servi re ad attutire l ' urto dell e cannonate ed assicurare l ' in esp ug nabilità della forte zza. L'ingre sso a l castello è collocato s ul fianco del bast ione Sud e costituito da un portale ad arco riba ssa to , traver so cui si accede al corti le" < 96 > .
All'indomani della conquista d e l R egno, per l' esa tt ezza nel 1529, s u esp li cita volontà di Carlo V, memore d e l ruolo g iocato negli episodi militari dalla fortezza di Barletta, s i procedette alla ricostru zione ex novo dell a stessa . L ' intervento costituiva la pre me ssa di un più complesso ria ssetto della cittadina in fun z ione di munita piazzaforte marittima. li vecchio castello,
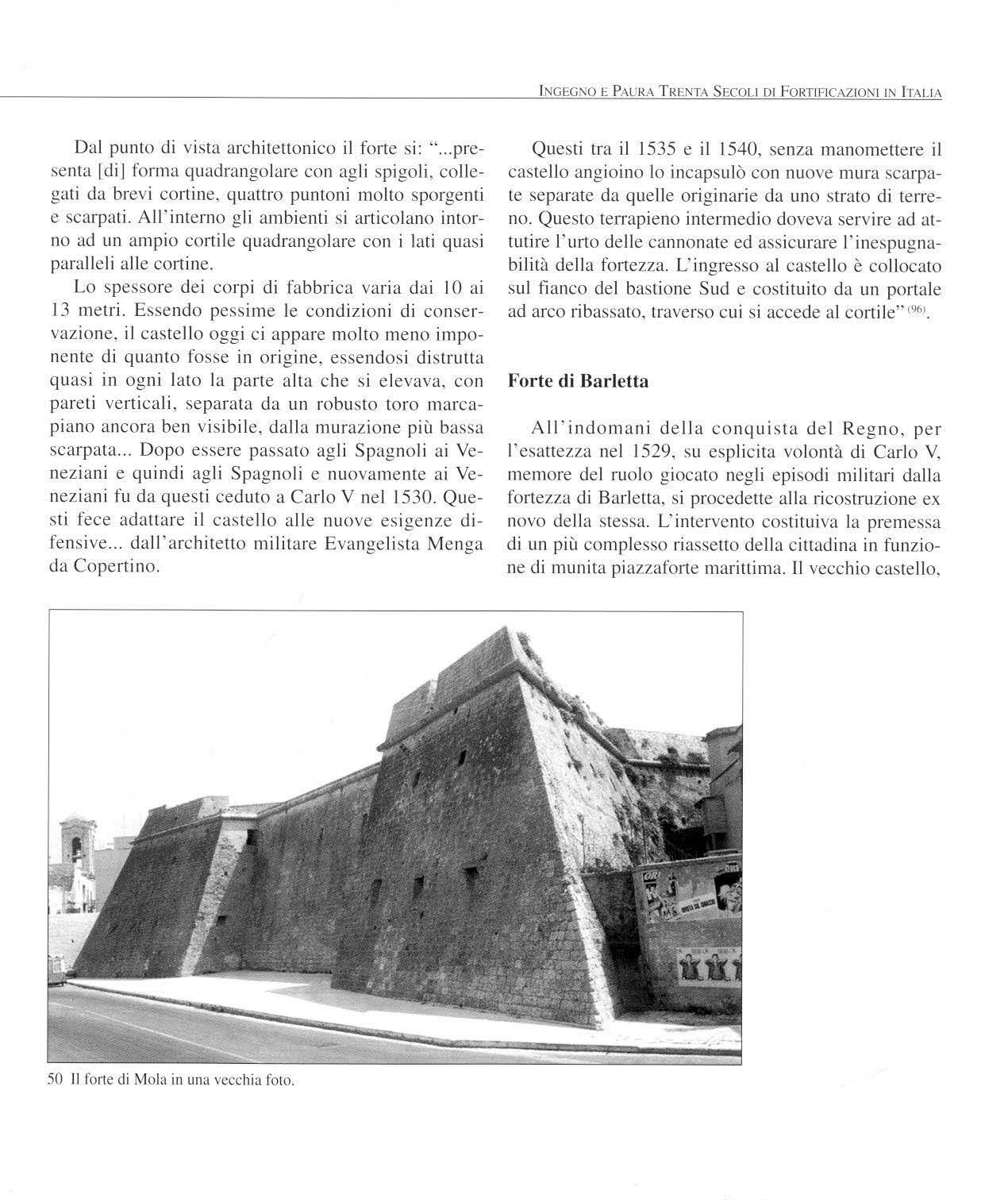 50 lJ fo rte di Mola in una vecchia foto.
ÌNGEGNO E PAURA TRENTA S ECOLI DI fORTlFICAZ!Ot\' I IN ITALIA
50 lJ fo rte di Mola in una vecchia foto.
ÌNGEGNO E PAURA TRENTA S ECOLI DI fORTlFICAZ!Ot\' I IN ITALIA
sebbene poderoso, risultava ormai anacronistico e non idoneo ad un semplice rafforzamento, in contrasto peraltro, con la visione di una moderna fortificazione integrata.
Di certo a partire dal 1532, come attestano molti documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Napo l i, si avviò la colossale opera, iniziando proprio dalla demolizione della precedente fortificazione <97> , sul cui impianto doveva erigersi l a nuova. La costruzione fu appaltata ad un certo maestro Giovan Filippo Terracciano di Cava dei Tirreni l 98 l , che ancora nel 1550 risulta operante presso lo stesso cantiere. Id eator e del progetto sembrerebbe essere stato, anche in questo caso, il famoso Evangelista Menga, architelto
militare particolarmente stimato da Carlo V, che in effetti lo incaricò di molteplici altri importanli realizzazioni difensive. Tuttavia a rendere discutibile tale paternità interviene il dettaglio, per nulla irrilevante, che no n si rintraccia , nel!' intero fascio di documenti e di quietanze relative alla suddetta opera , mai il nome del Menga né di nessun altro a lui collegato , sotto qual s iasi titolo '99 > .
È presumibile pertanto che l'architetto si limitasse ad una sorta di consulenza iniziale preventiva e che la direzione dei l avori fosse assolta dallo stesso don Ferrante De Alarcon , castel lano di Brindisi e sovrintendente delle fortificazioni pugliesi: su sua designazione fu nominato commissario alla fabbrica del castello D.

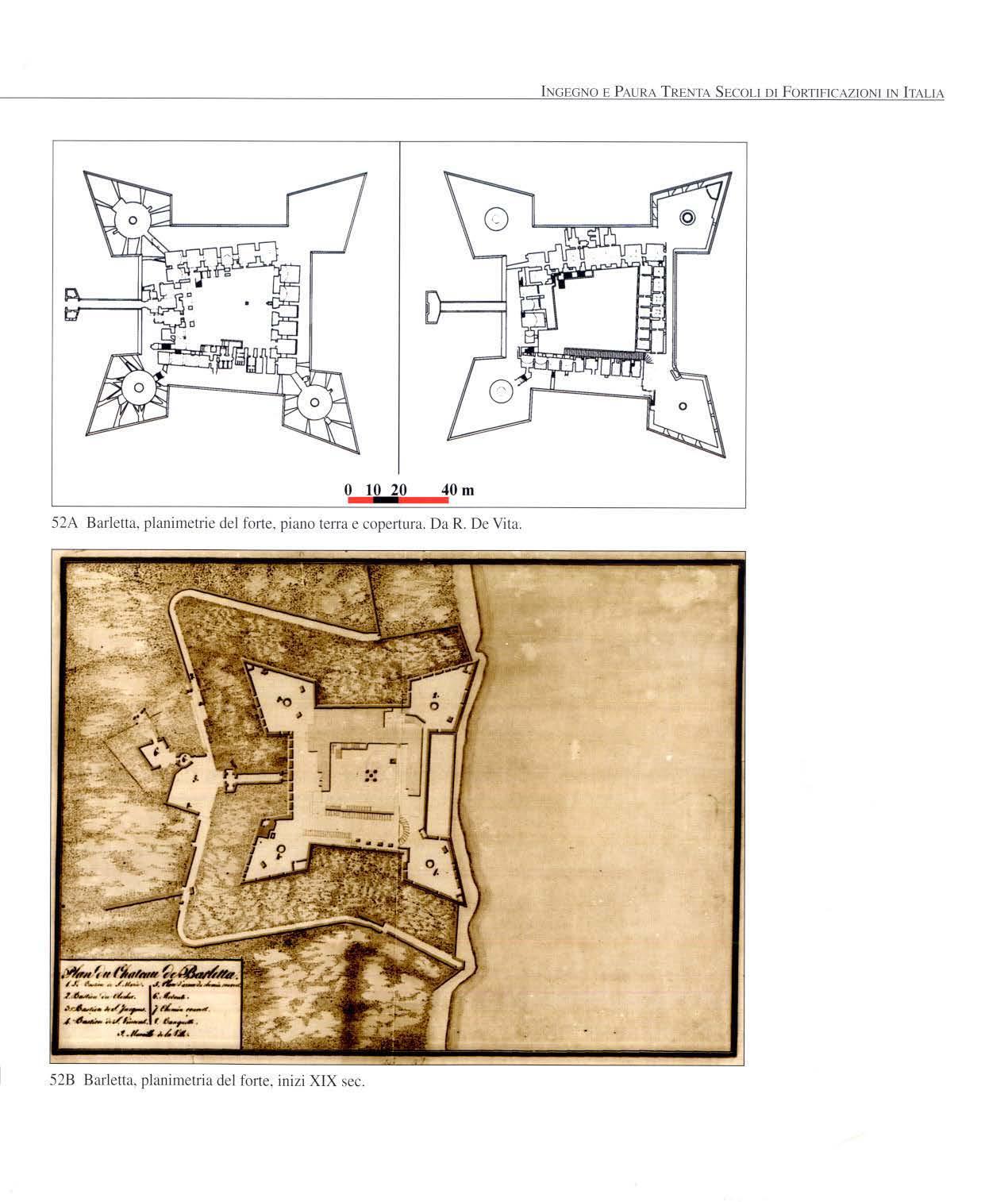
Sebastiano De Chignones, sostituito in seguito da D. Marcello Caracciolo.
La sua vicenda storica è così sintetizzata da un attento studioso: " Carlo I d'Angiò fece modificare e fortificare il castello da Pietro d ' Angicourt i100 1 fra il 1282 e il 1291. Rafforzamenti furono operati dagli Aragone s i per proteggersi dai Turchi, con lavori eseguiti in più riprese, nel 1458, nel 1465 e 148 I. Fu poi rimaneggiato con l'aggiunta di quattro bastioni tra iI 1532 ed il 1537, probabilmente s u progetto dell 'arc hitetto Evang e lista Menga da Copertino ... Al di sopra del portale d'ingresso è visibile lo ste mma di Carlo V con l'epigrafe datata 153 7. L 'o pera fu po sitivamente collaudata in occasione dell'assedio della flotta turca del Sultano Solimano il Magnifico nel 1537 ..." 00 11
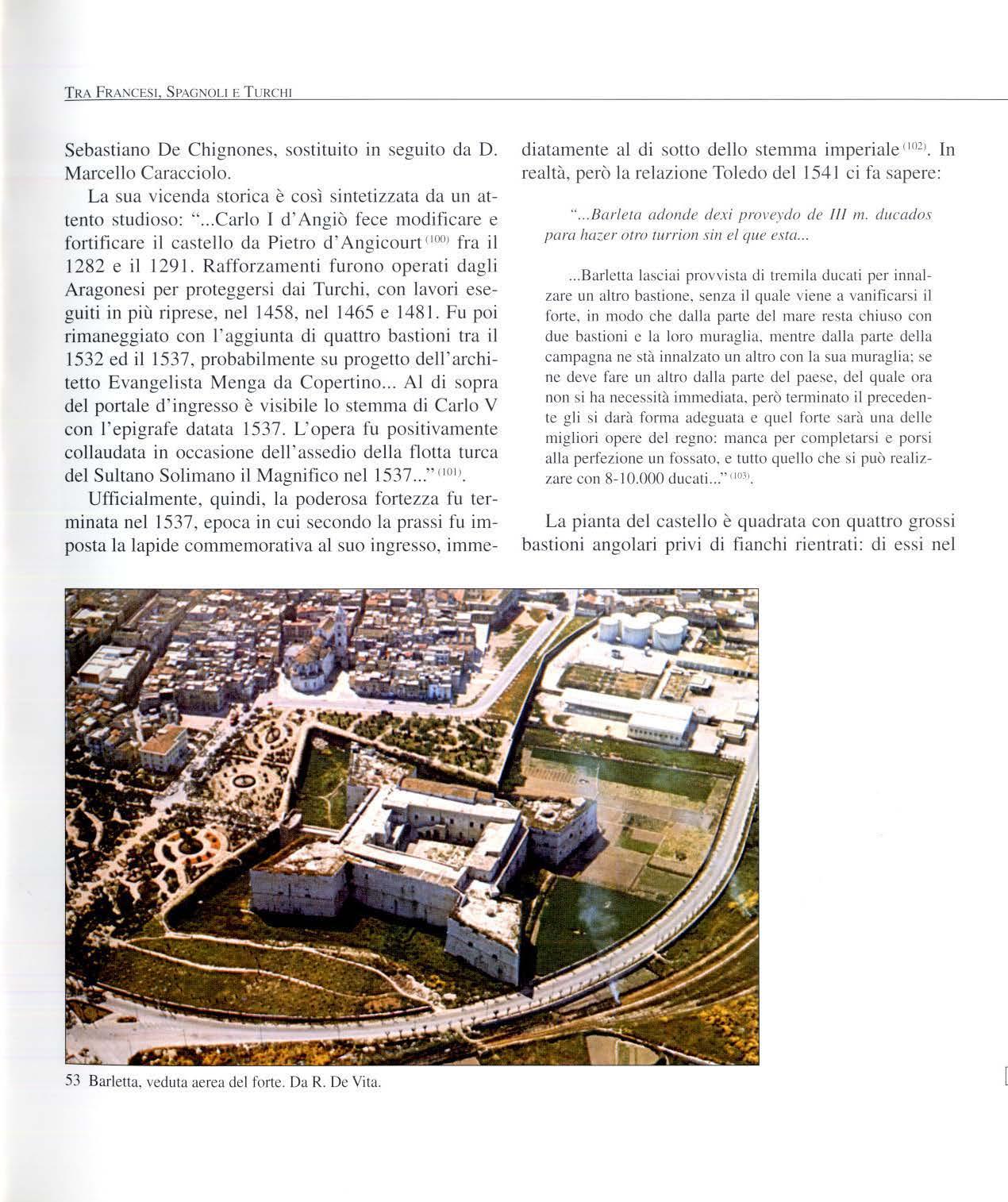
Ufficialmente , quindi , la poderosa fortezza fu terminata nel 1537 , e poca in cui secondo la prassi fu imposta la lapide commemorativa al suo ingresso, imme-
diatamente al di so tto dello stemma imperiale <1021 • In rea ltà , però la relazione Toledo del 1541 ci fa sapere :
Bar/eta adu11de d exi prm •eydo de lii m. ducados para hcr:,er otro turrion sin e/ que esta
Barletta lasciai provvista <li tremila ducati per innalzare un altro bastione, senza il quale viene a vanificarsi il forte, in modo che dalla parte del mare re<;ta chiuso con due bastioni e la loro muraglia, mentre dalla parte della campagna ne stà innalzato un altro con la sua muraglia: s e ne deve fare un altro dalla pane <lei paese, del quale ora non si ha necessità immediata. però terminato il precedente gli si darà forma adeg uat a e quel forte sarà una delle migliori opere del regno: manca per completarsi e porsi alla perfezione un fossato. e tutto quello che si può real izzare con 8 -10.000 ducati :· <1031 •
La pianta del castello è quadrat a con quattro grossi bastioni angolari privi di fianchi rientrati: di essi nel
53 Barletta, veduta aerea del forte. Da R. Dc Vita.'4 1, quello verso terra , doveva ancora essere costruito. Il lato d'iscrizione esterno del la fortificazione oscilla tra i 120 e i 130 m, di cui più della metà costituiti dai bastioni le cui facce raggiungono i 40 m, con fianchi di 14 e sa l ienti acuti di 56 <104 > . Gli ordini di fuoco erano tre sovrapposti, di cui i due inferiori casamattati ed il terzo s ulle piazze di copertura, in barbetta. Sottolineano dal di fuori la scansione ve1ticale due cornici a sezione torica, eseguite nello stesso calcare bianco dei conci delle cortine scarpate, alte circa 20 m. dal fondo del fossato. L'ingresso , logicamente, era posto verso i1 fronte a terra ed isolato mediante un lungo ponte parzialmente levatoio protetto da un piccolo ridotto all'innesto col muro di controscarpa del fossato, una sorta di e lementare rivellino
L'Università di Barletta dovette contribuire economicamente alla costruzione del forte in ragione di 14 000 ducati elargiti in rate annue di 1.000. Pur essendo in assoluto una cifra ragguardevole, specie se relazionata ad una piccola cittadina pugliese, in rap-
porto all'intero costo dell'opera rappresentarono una modestissima frazione <105 > _
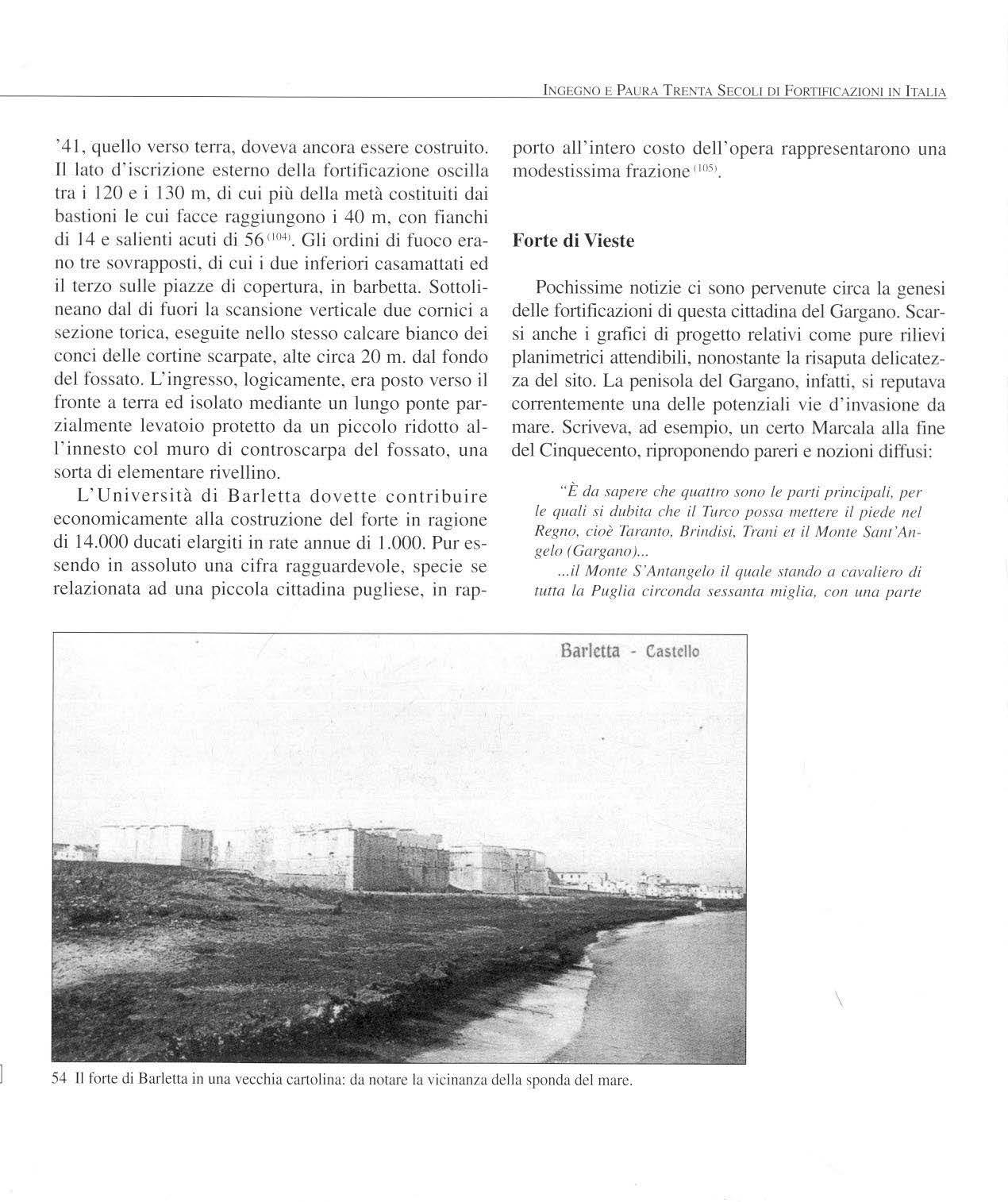
Pochissime notizie ci sono pervenute circa la genesi delle fo1tificazioni di questa cittadina del Gargano. Scarsi anche i grafici di progetto relativi come pure 1ilievi planimetrici attendibili, nonostante la ri saputa delicatezza del sito. La penisola del Gargano , infatti , si reputava correntemente una delle potenziali vie d'invasione da mare. Sctiveva, ad esempio, un certo Marcala alla fine del Cinquecento, riproponendo pareri e nozioni diffusi:
'È da sapere che quallro sono le parli principali, per le quali si du/Jita che il Turco possa mettere il piede nel Regno, cioè Taranto, Brindisi, Trani et il Monte Sant'Angelo (Ga rgano)
il Monte S'Antangelo il quale stando a cavalier<> di tutta la Puglia circonda sessanta miglia, con una parte
- CastelloBRRCcTIR - Jnterno del
 55 Il forte di Barletta in un'altra vecchia carto li na: è ancora ben conservato il suo fossato con il relativo ponte.
Castello
55 Il forte di Barletta in un'altra vecchia carto li na: è ancora ben conservato il suo fossato con il relativo ponte.
Castello
sopra il mare, di silo funissimu, abbo11da d'acqua dolce. se11za porro né ha fonezza di sorta alcuna se 11011 Vestice, e, Manfi'edonia deboli, e/ in sito di pOlersi poco migliorare, restando esposto senza per hora far a//ru rimedio, se 1w11 chi 1•olesse fortifirn rlo tucto, il che al presente 11011 è solamente difficile, ma impossibile, havendo pur troppo che fare a mantenere et migliorare li forti et fortezz.e. che sono in essere al presente sen za scoprirne de/li altri a/li nemici... " 11061 •
Il nucleo urbano originale di Vieste ri s ulta ubicato alle falde di un piccolo colle, degradante s ul mare nel quale si protendeva attraverso una stretta penisola alla cui estrenùtà si ergeva la chiesetta di S. Francesco. In po sizione apicale venne eretto il forte, da dove si dipa1tivano, divaricandosi, due lunghi sett01i muraii, il p1incipa]e a nord volto verso terra, l'altro a sud lungo la marina racchiudente il porticciolo. Entrambi poi si raccordavano con un terzo fronte anch'esso maiino volto ad 01iente ( I O?)
La configurazione ri s ultante era quindi, in prima approssimazione. triangolare, sos tanzialmente coincidente con il profilo costiero, che nella tratta orientale, per la notevole altezza, fungeva da fortificazione naturale.
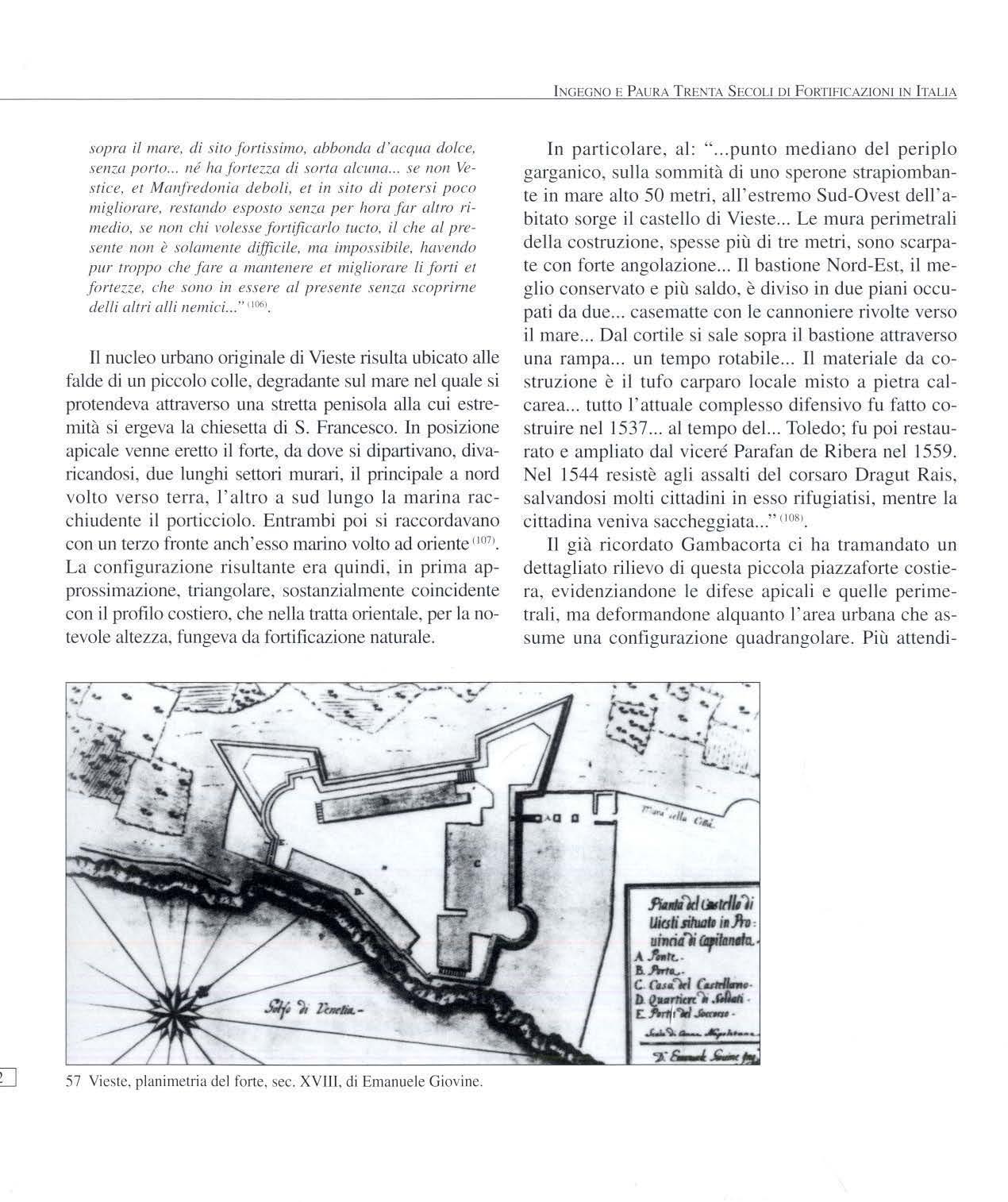
In particolare, al: " punto mediano del periplo garganico, su lla sommità di uno spero n e strapio mbante in mare alto 50 metri, all'estremo Sud- Oves t dell 'abitato sorge il castello di Vieste ... Le mura perimetrali della costruzione, spesse più di tre metri, so no sca rpate con forte angolazione... Il bastione Nord-Est, il meglio conservato e più saldo , è diviso in due piani occupati da due ... casematte con le cannoniere rivolte verso il mare ... Dal cortile si sa le sopra il bastione attraverso una rampa ... un tempo rotabile ... Il materiale da costruzione è il tufo carparo locale misto a pietra calcarea tutto l'attuale complesso difensivo fu fatto costruire nel 1537 al tempo del... Toledo; fu poi re s taurato e ampliato dal viceré Parafan de Ribera nel 1559. Nel 1544 resistè agli assalti del corsaro Dragut Rai s, salvandosi molti cittadini in esso rifugiatisi, mentre la cittadina veniva saccheggiata ..." < 1081 •
Il già ricordato Gambacorta ci ha tramandato un dettagliato rilievo di que s ta piccola piazzaforte costiera, evidenziandone le difese apicali e quelle perimetrali, ma deformandone alquanto 1' area urbana che ass ume una configurazione quadrangolare. Più attendi-
bile invece un altro grafico planimetrico conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli , sebbene posteriore al suddetto datandosi intorno alla prima metà del XVIII secolo. Mediante quest'ultimo ed una minuziosa pianta del castello eseguita nello stesso periodo da Emanuele Giovine(l 09 l, ne tenteremo un ' analisi descr ittiva e ricostruttiva.

Il castello, che costituiva e costituisce ancora oggi, iJ principale elemento caratterizzante del luogo, ha probabilmente una origine normanno-sveva, a giudicare almeno dal le permanenze strutturali che traspaiono dai grafici, nonché dal!' ubicazione arroccata tipicamente medievale. De l resto in una pergamena redatta in occasione del Concilio di Melfi, nel J059, è fatta esplicita menzione di un castello quod dicitur Besti. Parimenti risulta citato in un'inchiesta angio ina del 1285. La sua rivalutazione militare comportò la realizzazione di due bastioni asimmetrici. perfettamente rilevati dal Giovine,
01ientati vers o nord-ovest, restando l'opposto fronte a mare protetto dalla falesia garganica. Ne s suno spos tamento, quindi , del baricentro difensivo del comples so apicale , che veniva in tal modo soltanto ad acquistare nuove potenzialità di intervento balistico , sia s ul fronte a terra, che lungo il perimetro marino e nella rada.
Fu nece s sario procedere. nel medesimo contesto aggiornativo, al suo isolamento dal tessuto urbano mediante un vasto fossato scavalcato da un ponte levatoio a più campate: un ton-ione rotondo permane aggettante lungo questo lato, ultimo elemento residuo della vecchia struttura. All'interno del forte sono riportate le collocazioni degli acquartieramenti del presidio e gli alloggi del castellano con la ri s ultante piazza d ' armi triangolare. Oltre all'accesso dal ponte del lato est , vi è segnata s ul disegno una seconda porta, probabilmente d'emergenza per eventuali sortite, non a cas o detta del 'soccorso' (1101 •
Di certo dalla relazione del Toledo sap piamo che:
" la ciudad de Veste en ha;,erse un espo111on.
[D a Manfredonia provvidi che si desse una gra ndi ss ima fretta al la] c illà di Vieste nel costruirsi un bastione verso la parte del mare sulla pona principale e che s i facesse un teJTapieno e comandai agli amministratori del feudo del duca di Sessa che pagassero in quel forte per un altro bastione che corrispondesse con questo. tremila ducati ancora in modo che con questo bastione c he s i costruisce sul ro n c e con quello sulla porta e con un altro che sta nello spigolo della ci u à sopra il mare, r es ta la detta c ittà ben forti f'i ca ta c ben difesa. purché le si faccia avere qualche artig li eria.. .'. ""' .
È per noi impossibile s tabilire quanto delle sezioni moderne delle fo11ificazioni di Vieste fosse già pe1fettamente ultimato né, meno che mai, in che condizioni di conservazione s i trovassero le precedenti in quel tragico 1554 allorquando la flotta turca attaccò la città. Così la relazione del viceré s ul doloro so episodio:
" La annado torquesca pareciò e11 estos mares
... La fl olla turca apparve in questo mare di Puglia il 18 [giugnoj scorso. e sbarcò un cont in ge nte s u di un litora le del duca di Sessa che si chiama YicsLe. Le forze nemi che can nonegg iarono la città tino al 22. da mare e da terra; le fortificazioni della c ittadin a erano deboli per cui il 22 i difensori le abbando naron o e si rifu g iaro no ne l cas tell o che si arrese a sua volta il gio rno 24. A resistere un g io rn o di più. e lo av rebbero potuto fare. un raggruppamento che io g li avevo appositamente e con urgenza inviato d a Napoli cli mille fant i spagnoli e cli trecento caval ier i g li av rebbe portato i I socco rso necessario <1111 •
La tragica v icenda ebbe un 'a ll u cinante ripropo sizione nel l 566. svo ltasi quas i con le medesime modalità, fatta salva una migliore condizione della fortificazione perimetrale. Nella circostanza il dispositivo v icereale difens ivo era sta to. purtroppo , precocemente e parzialmente disattivato. La cittadina fu atrocemente sacc hegg iata e d inc e ndiata: molti abitanti deportati , l ' intera contrada devastata e desolata. La s trenua resistenza di
Mario di Abenate e d ei s uoi concittadini a s te nto rinc hiu s isi ne l forte non va lse però ad imp edire l'iiTuzione dei turchi nell'abitato. Con la be stial e efferatezza tipica delle orde mu s ulmane Vieste fu posta a sacco: " .. .a nulla era val sa la mediazione di un tal canonico Nerbis, o de Nerbis, che aveva patteggi a to la resa dietro consegna di oro e di argento .. . 7.000 i morti , molti dei qua li furono trucidati nei press i d e lla cattedrale ... " 11 131 •
Eloquentemente il di spacc io del governatore ribadi va che:
" la 111ejor perdida que ha sido es la maggio re perdita subita è quella della deportazione di più di 3 000 anime " " ' " ·
Al centro di Lecce s i e rige un grosso forte quadrangolare, dai connotati canonici: un reci nto quadrato , nella fattispecie un trapezio, con qu attro bastioni ai vertici. Come in tutti i similari finora incontrati , anche in questo si distinguono ancora i resti di una precedente fortificazione, finita fagocitata d a lla più modern a, in po s izione qua si concentrica. Dalle fonti sap piamo che il forte fu costruito su pro ge tto di Gian Giacomo dell' Acaja , già in precedenza più vo lte incontrato, tra il 1539 ed il 1549, s u pres sante s timolo di Carlo V che voleva stanziare in zona un po sse nte nucleo milita re di cavalleria al fine di fru strare qual sia s i non improbabile iniziativa turca. Per tale motivo i lavori vennero ponati avanti con eccezionale so lerzia, tant'è che appena due anni dopo il Toledo poteva scrivere, avendolo appena visitato, il seg uente rapporto:
" De Brindez vine a Leche, donde he hallado el cast illo puesto en fortijìcation ...
.. .Da Brindisi pervenni a Lecce, dove si è comp le tato il fo rte in cos Lrn zio ne e la città è così co mpl e Lata ne lla sua fortificazione e il fo rte risulta mo lto be n dotato di artig li erie. provvisJO in abbondan7.a cli gra no e di tutte le alt re munizio -
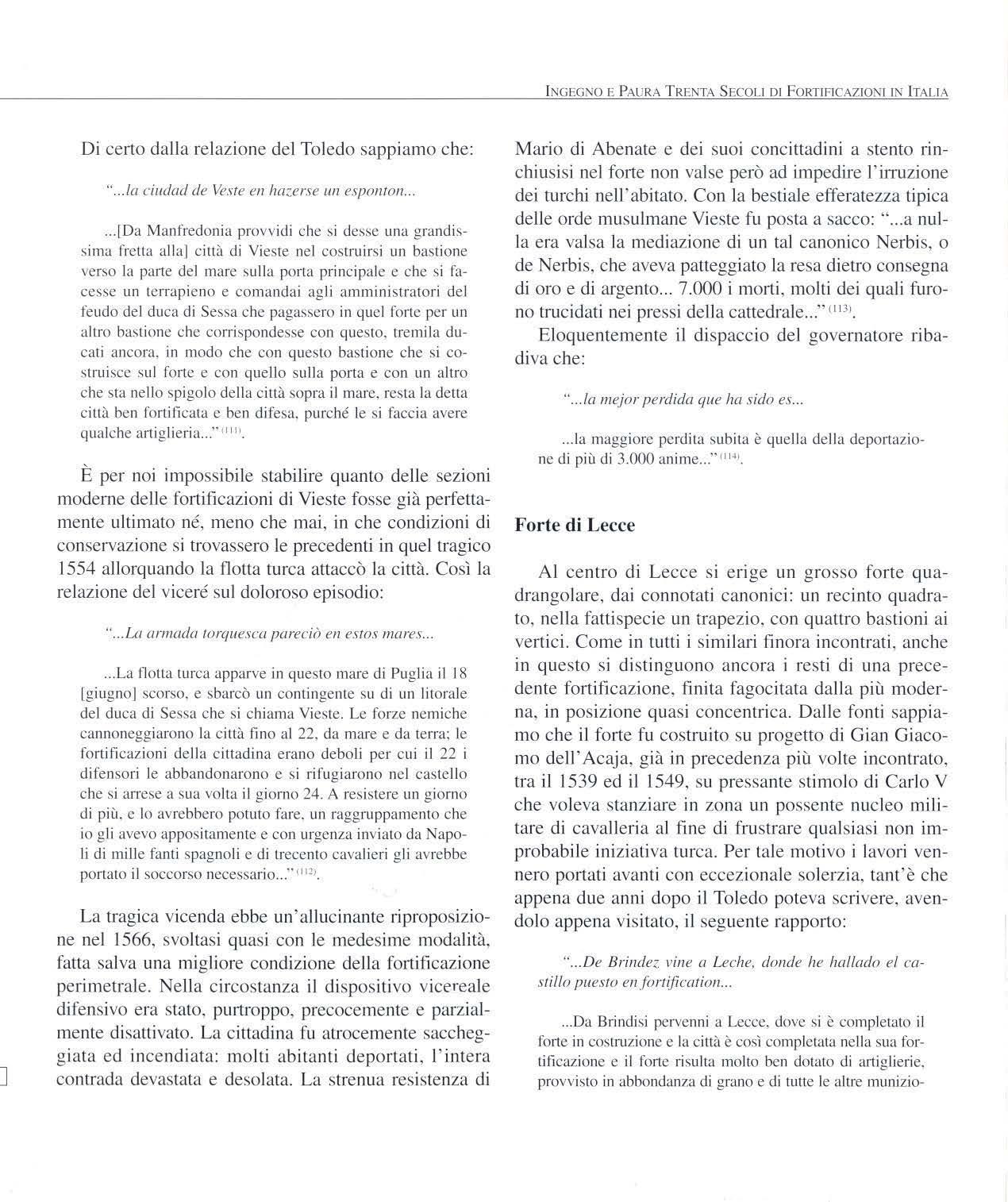
ni che sono neces sarie ed è stato fatto tanto ma tanto che non oso scriverlo per non ess ere scambia.LO per bugiardo, desidero dire su quanto ho dj più caro che d i tuLli quel li c.:he ho visitato e dei molti che conosco ci pare molto superiore e molto migliore ciel Castel Nuovo di Napol i.. .'' ' 115 J
Il lu singh i ero apprezzamento, privo di a n a lo gie altrettanto entusiastiche nel corso dello stessa lun ga ispezione generale, lascia su pporre la sos tanzial e ultim azione della costruzione ad o nta delle s ue eccezio na li dimen s ioni. Quant o a quest'ultime, infatti, il bastione: " ... di Sud-Est misura m. 180, quello di Sud-Ovest m:
150. la lunghezza cli quello di Nord-Ovest è di m. Ll 6 e di quello cli Nord-Est m. 124. Tu tta l'opera era circondata da un ampio fossato che dopo il 1870 venne colmato.
L a parte più interna con l ' atrio centrale sorge ov'era il castello medieva le fatto costru ire, secondo il Ferrari , da re Tancredi neg li ultimi anni del XII secolo Di questo castello non è visibi le alcu na parte , essendo stato rimaneggiato e comp letamen te ricostruito nelle epoche successive. Tanto c he l a parte più antica dell ' intero complesso ri sulta essere un poderoso mastio quadrango lare, probabilme nte angioino , del X l V seco lo ...
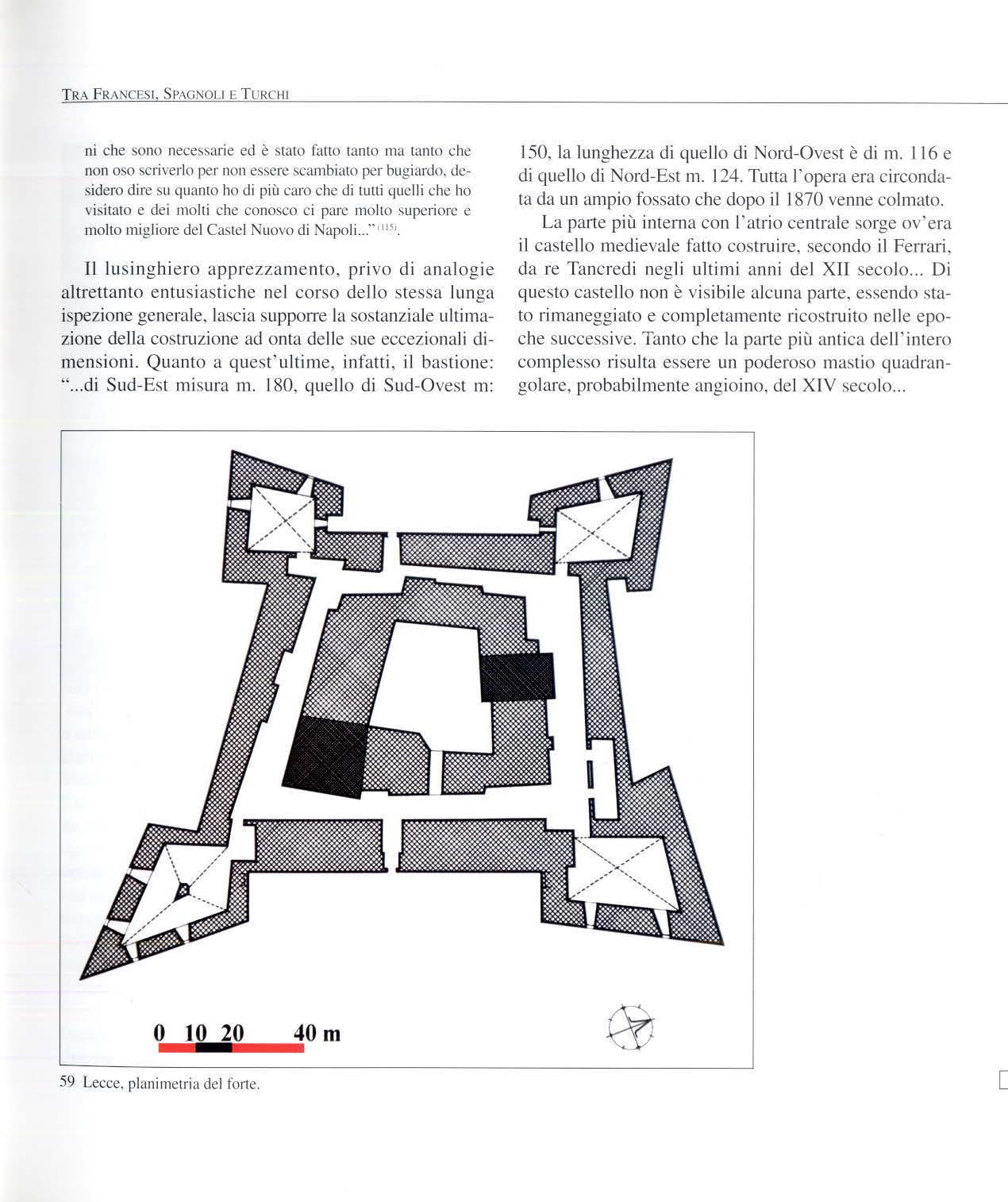
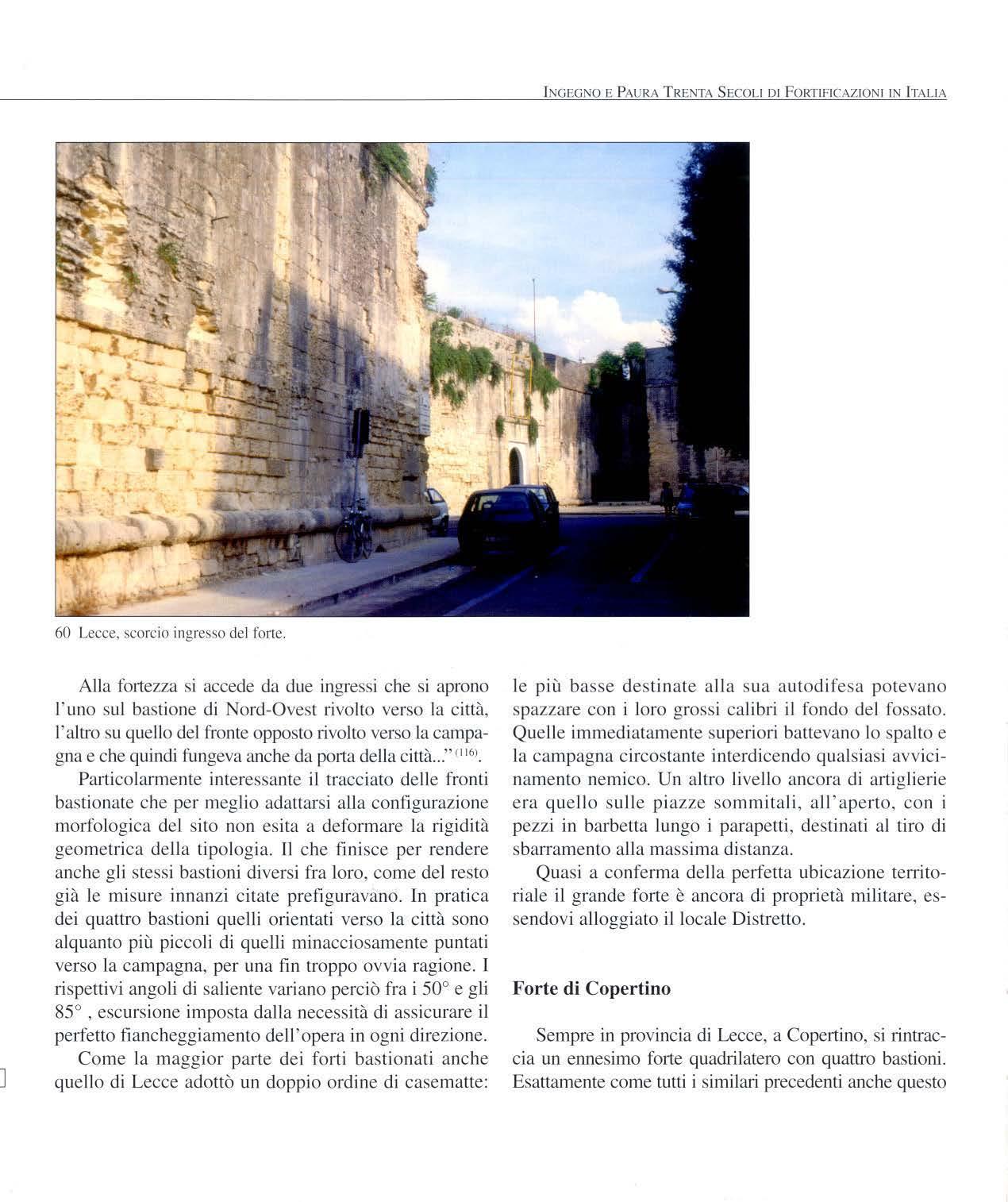
Alla fortezza si accede da due ingressi che si aprono l'uno sul bast ione di Nord-Ovest rivolto verso la città, l 'altro su que ll o del fronte opposto rivolto verso la campagna e che quindi fungeva anche da po1ta della c i ttà " 1116l
Pa rti co larmente in te ressan t e il tracciato delle fro nli bastionate che per meg1io adattarsi alla configurazio ne morfologica del sito non esita a deformare la rigidità geomelri ca della tipo logia. 11 che finisce per rendere a nc h e g li stessi bast io n i diversi fra loro, come del resto già l e misure innanzi citate prefiguravano. In pratica dei q uattro bastioni quelli o ri e nta ti verso l a città sono alquan t o più piccoli di quelli minacciosamente puntati verso la campagna, per una fin troppo ovv ia ragione . I rispettivi a n goli di sa li ente va ri a no perciò fra i 50° e gli 85 ° , esc urs io ne im posta dalla necessità di assic urare il perfetto :fiancheggiamento dell ·opera in ogni direzione.
Come la maggior parte dei forti bastio n a ti anc h e quello di L ecce adot t ò un doppio ordine di casematte:
le più basse destinate alla sua autodifesa potevano s pazzare con i loro grossi calibri il fondo del fossato. Quelle immediatamente s up eriori battevano lo s palto e la campagna circostante interdicendo qual siasi avvicinamento nem ico Un a ltro livello ancora di artig li erie era quello s ulle p iazze so mmitali, a ll 'a perto, con i pezzi in barbetta lungo i parapetti, destinati al tiro di sbarrame nto alla massima di stanza .
Qu asi a conferma d e ll a perfetta ubicazione territorial e il grande forte è ancora di proprietà militare, esse ndovi a ll oggiato il lo cal e Distretto.
Sempre in provincia di Lecce, a Copertino, si 1intraccia un ennesimo fo1te quadrilatero con quattro bas tioni. Esattamente come tutti i sim il ari precedenti anc he q uesto
ingloba e conserva al s uo interno i resti di una precedente fortificazione, la cui maggiore permanenza è l'alto mastio medievale, retaggio forse dei No1111anni. DalJ 'esterno, in prima approssimazione, non s i discosta dai canoni tipologici ad eccezione dell'adozione di un doppio redondone. Qu esto dettaglio, spesso confuso con un ornato architettonico non deve in realtà essere attribuito ad una maggiore ricercatezza formale, scarsamente credibile in un'opera militare, ma alla volontà progettuale di fornire una migliore protezione ai suoi difensori. Essendo infatti il forte dotato cli due ordini di casematte disposte su tre livelli, facenti capo a ben 90 cannoniere, molte delle quali, disposizione alquanto insolita, aprentesi semp re su due ordini persino lun go le facce dei bastioni, poteva estrinsecare una reazione balistica di straordinatia vio-
lenza. Il che sembra testimoniare il timore di un investimento ossidionale altrettanto esasperato, con ampio ricorso alle artiglierie d'assedio e conseguente esposizione dei difensori alle micidiali rosate di schegge lapidee eruttate dagli estradossi delle muraglie allorché vi impattavano le palle di fen-o. Onde evitare che le stesse potessero proiettarsi ve,ticalmente, radendo le cortine e 1imbalzando nelle cannoniere ferendo chiunque si fosse trovato sulla loro imprevedibile traiettoria, si segmentava la cortina stessa con il caratteristico cordone torico, dalla precipua funzione di devia-schegge. 11 raddoppio, pe1tanto, si deve rapportare ad un eccesso di prudenza a sua vo lt a suggerito dalla suddetta rilevanza della difesa attiva.
Al di l à delle caratteristiche architeltonico-militari ciò che più stupisce del forte sono le sue eccezionali dimensioni di un paio di metri maggiori anche del suo celebre coetaneo di Capua. Per l'esattezza vanta una distanza fra gli spigoli dei baslioni di l I 6. 7 m contro i 114 m del campano ed una lunghezza delle co 11ine intermedie di 53 m contro 50 m. Riguardo all ' articolazione: ·· nella cortina 01ientale si apre il portale rinascimentale preziosamente decorato e fiancheggiato da due altissime co l onne che son-eggono un coronamento di forma composita a duplice cornice L'ingresso immette, attraverso un androne vo ltat o, munito di piombatoi e con pianta a squadra per maggior difesa, nel cortile interno sul quale si affacciano corp i di fabbrica appartenenti ad epoche diverse Il complesso vanta ben novanta cannoniere. I corridoi hanno tre piani sovrapposti. Il più basso corrisponde quasi a l Jivello del fossato ed è privo di cannoniere in quanto serviva per comunicazione e per ricovero sotten-a neo.
[È altresì probabile che serv isse da co ntromina avendo que ste gallerie 1' andamento perfettamente aderente a quello del perimetro esterno . n.d.A.l 11 piano intermedio ha cannoniere dirette oltre il fossalo. n corridoio superiore e le casematte dei puntoni battono tutla la campag na c irco s tant e. Il braccio Ovest ospitava a pianterreno le scuderie. Nell'angolo Sud-Ovest sale una larga scala scoperta , addossata a circa metà del lato Sud, che dà alle camere del piano superiore " (llì>
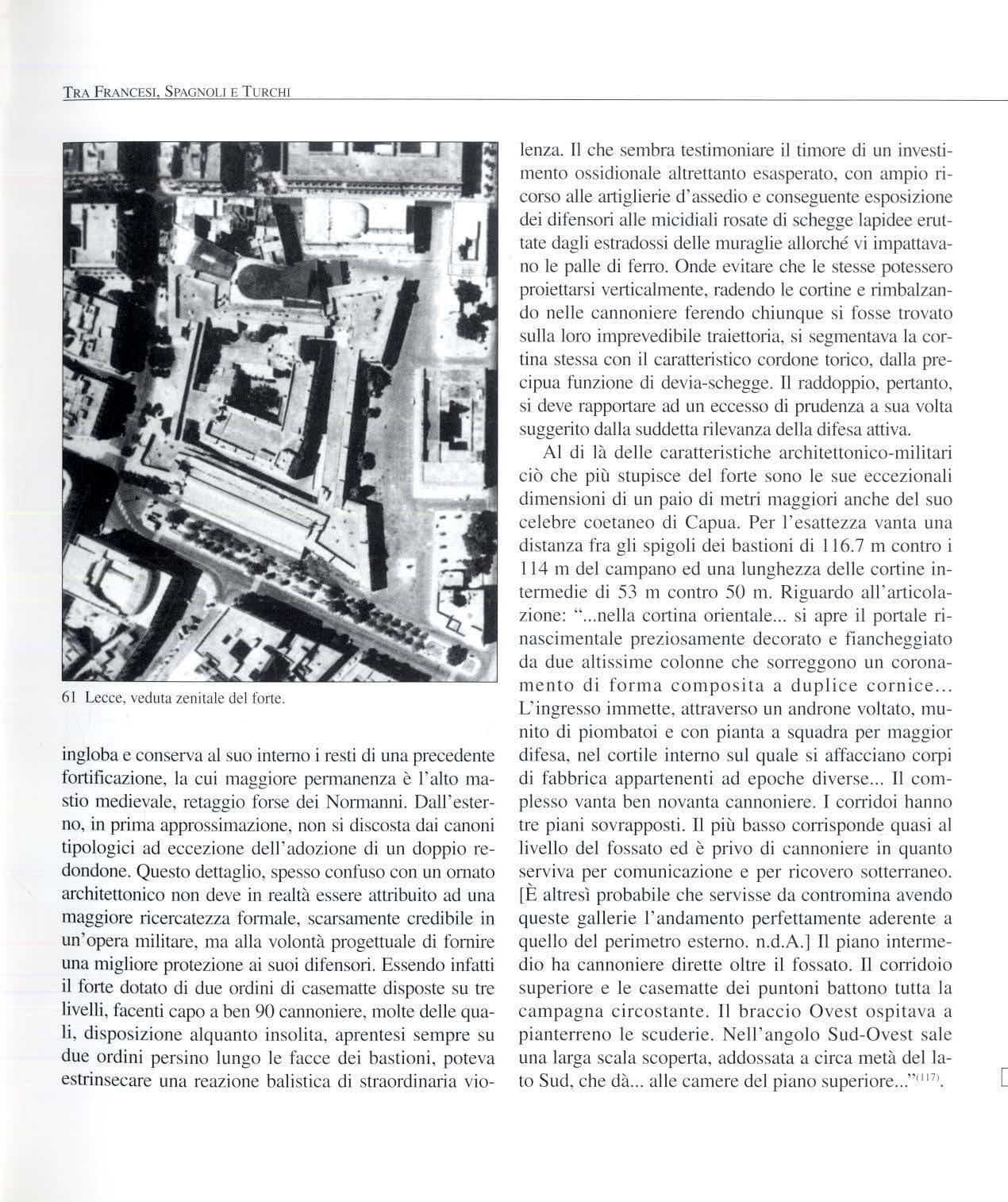 TRA FRANCESI, SPAG OLJ E T URCHI
61 Lecce, veduta zenita le del forte.
TRA FRANCESI, SPAG OLJ E T URCHI
61 Lecce, veduta zenita le del forte.
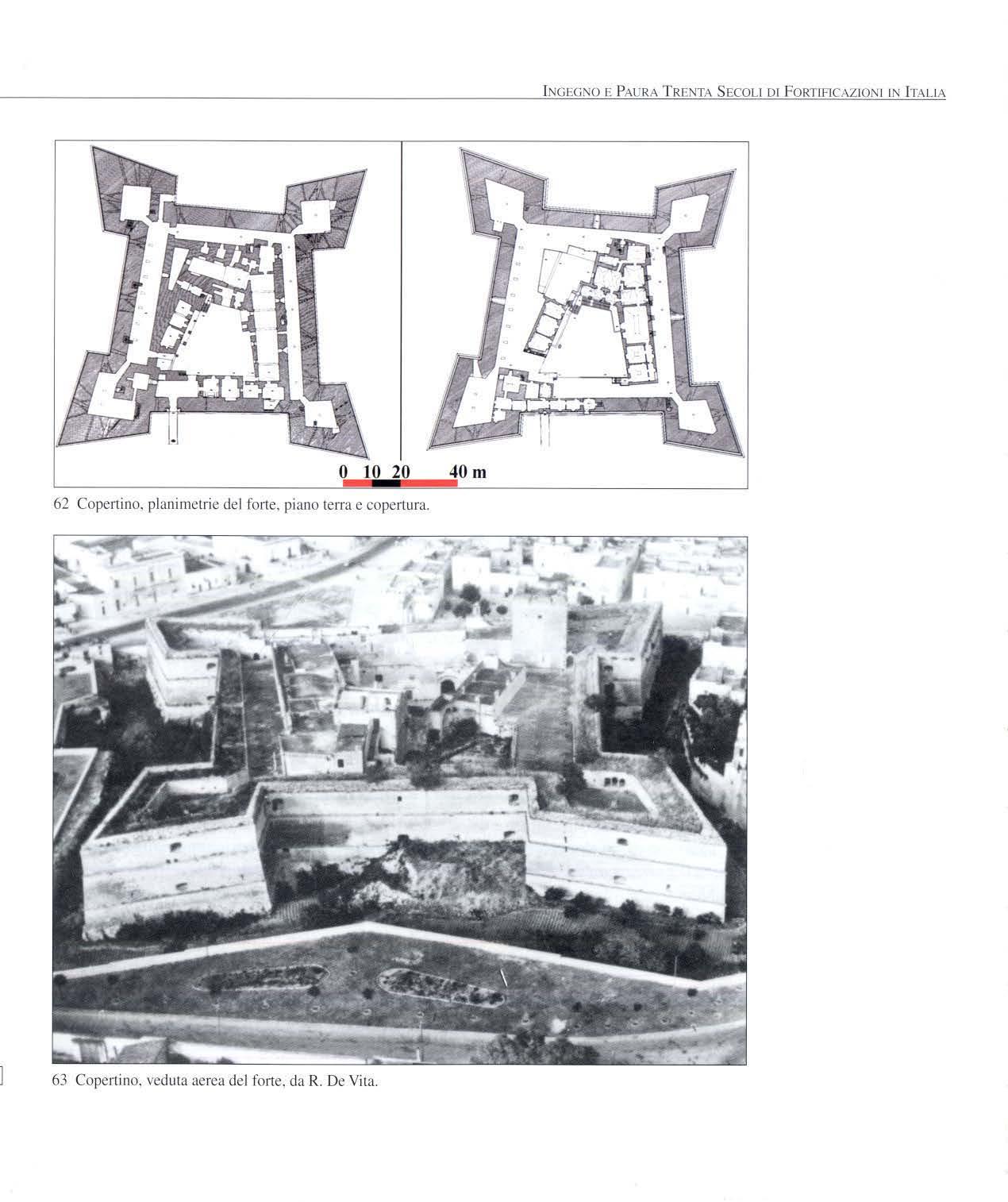
La collocazione del vano d ' ingresso quasi a ridosso del vecchio mastio nonnanno-svevo , che finisce perciò fagocitato nelJ'innesto del bastione immediatamente sulla destra del portale, ma non demolito, lascia intuire la volontà di adibirlo ad ulteriore difesa del corpo di guardia, ennesima confenna dell'eccesso di prndenza del progettista.
giorni della s ua visita, in ogni caso però ben lontano dall'ultimazione. Significativo che nella circostanza il donativo di 4.000 ducati offerto dalla città a Carlo venisse prontamente devoluto per l e fortificazioni.
Nel suo viaggio di rientro dopo la vitto1ia conseguita a Tunisi nell'estate del 1535 11181 • Carlo V sb,u·cò a Napoli il 25 novembre, trattenendovisi per un lungo soggiorno. Da lì, infatti, il 23 marzo seguente, in procinto di partire per Roma, si recò a Capua. soggiornandovi anche il 24, per meglio valutare le condizioni della città, ben consapevole del suo ruolo strategico. Che le potenzialità difensive di Capua fossero all'epoca per icolosamente insignificanti lo si può desumere dall'aver l'imperatore sollecitato sin dal '33, attraverso il viceré Toledo , l'ammodernamento della sua cerchia. È anche probabi le che tale lavoro fosse in qualche modo già in corso nei
11 Tol edo, a sua volta, tornò a Capua nel '37, confermando la rilevan za assegnata all'impresa, o forse anche in previsione della erezione di un mod e rno forte, sul modello di quello dell'Aquila ini ziato da un paio di anni. Nel '38, infatti, di ritorno da un altro sopralluo go nella città il Toledo così rappo1tava alrimperatore:
" Y esta11do Capua
E 1itrovanclosi Capua come si co nvi ene, ed io spero sarà fortificata e completandos i di fortificare il monte S.

Martino fcastel S. E lmo a Napo li l , la cap ital e del regno sarà la più sicura e potente piazza forte in Italia.. : · "''" .
Nessuna meraviglia, pertanto , che: ' ·... le fonti d'archivio indicano nel dell' Acaya l'autore del disegno che fu redatto nell'ottobre 1542. al ritorno da un viaggio ali ' Aqui la dove era già in fase di costruzione un altro maestoso castello, anch'esso dedicato a Carlo V I lavori di

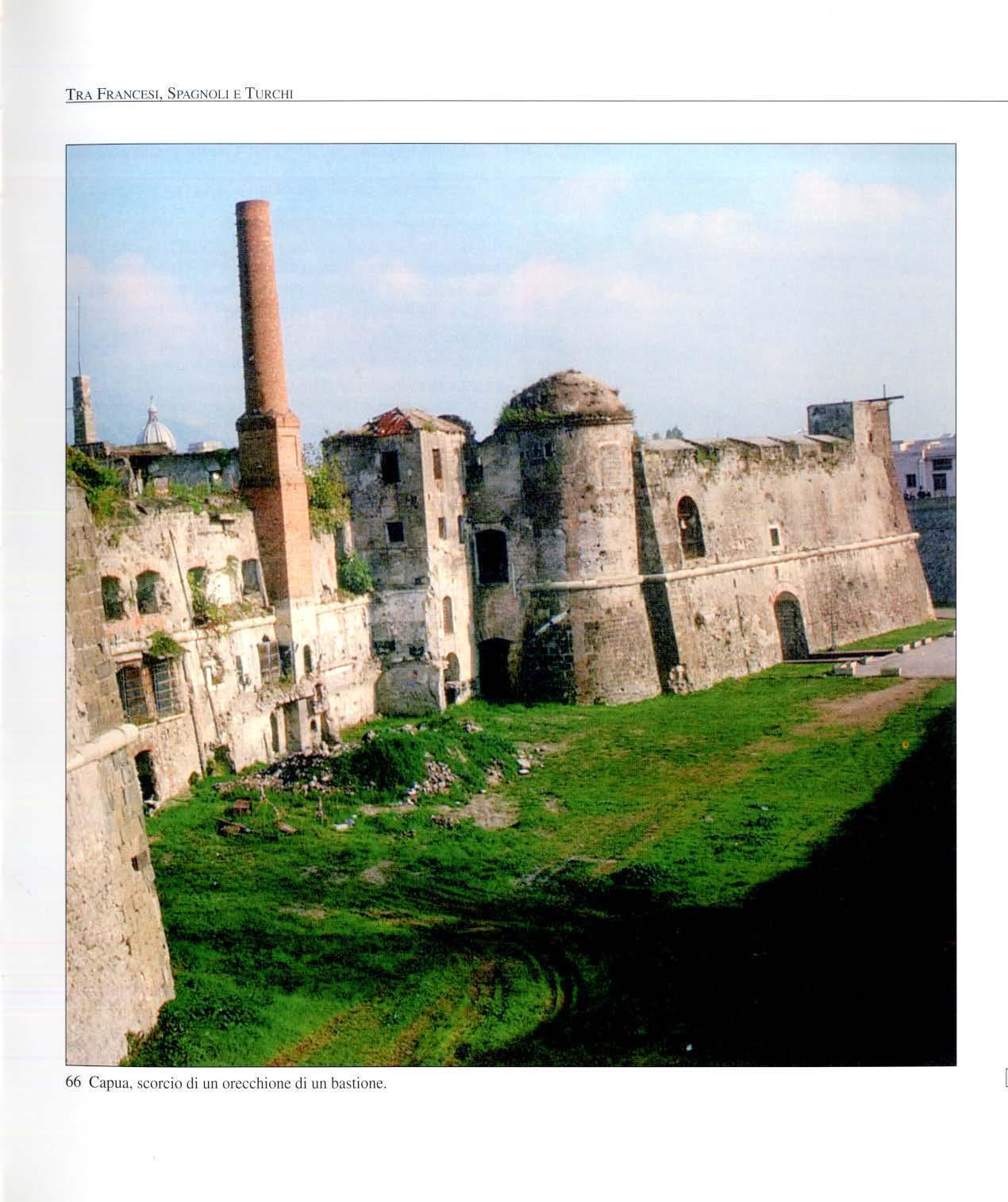
67 Capua, dettag lio cannonjera Lraditora , seminterrata.
steno per le fondazioni della fabbrica capuana ebbero inizio a novembre dell'anno 1542 cui seguirono quelli murari, senza interruzioni, sotto il diretto controllo dell'ingegnere Ambrogio Attendolo, commissario della regia fabbrica, con l'incarico di redigere disegni, prendere misure, emettere mandati di pagamento per i lavori eseguiti ... È da ricordare, infine, che Ambrogio Attendolo aveva già sperimentato una co ll aborazione di tal genere co l barone dell' Acaya a Crotone dove lavorarono entrambi, nel 1541-43, per la ridefinizione del recinto fo rtificato e per il castello ... detto di Carlo V..." n20i
Circa il s it o prescelto per l'e,igenda opera, va osservato che, ancora una vo lta , esplicita conferma, se mai ve ne fosse bisog no , della ristrettissima idon eità dei punti ottima li per l'impianto di nuove fortificazioni: " .la costruzione cinq uecentesca occupò il posto dì una precedente analoga fabbrica longobarda no n lontana da] 'ponte ,·omano' ; l a sua realizzazione risultò molto onerosa per gli abitanti e durò alcuni anni ."' <12 1l
Le dimensioni del forte di Capua possono così ria ss umers i:
lunghezza delle cortine comprese fra due bastioni distanza tra i vertici cli due bastioni lunghezza della faccia del bastione lato cortile
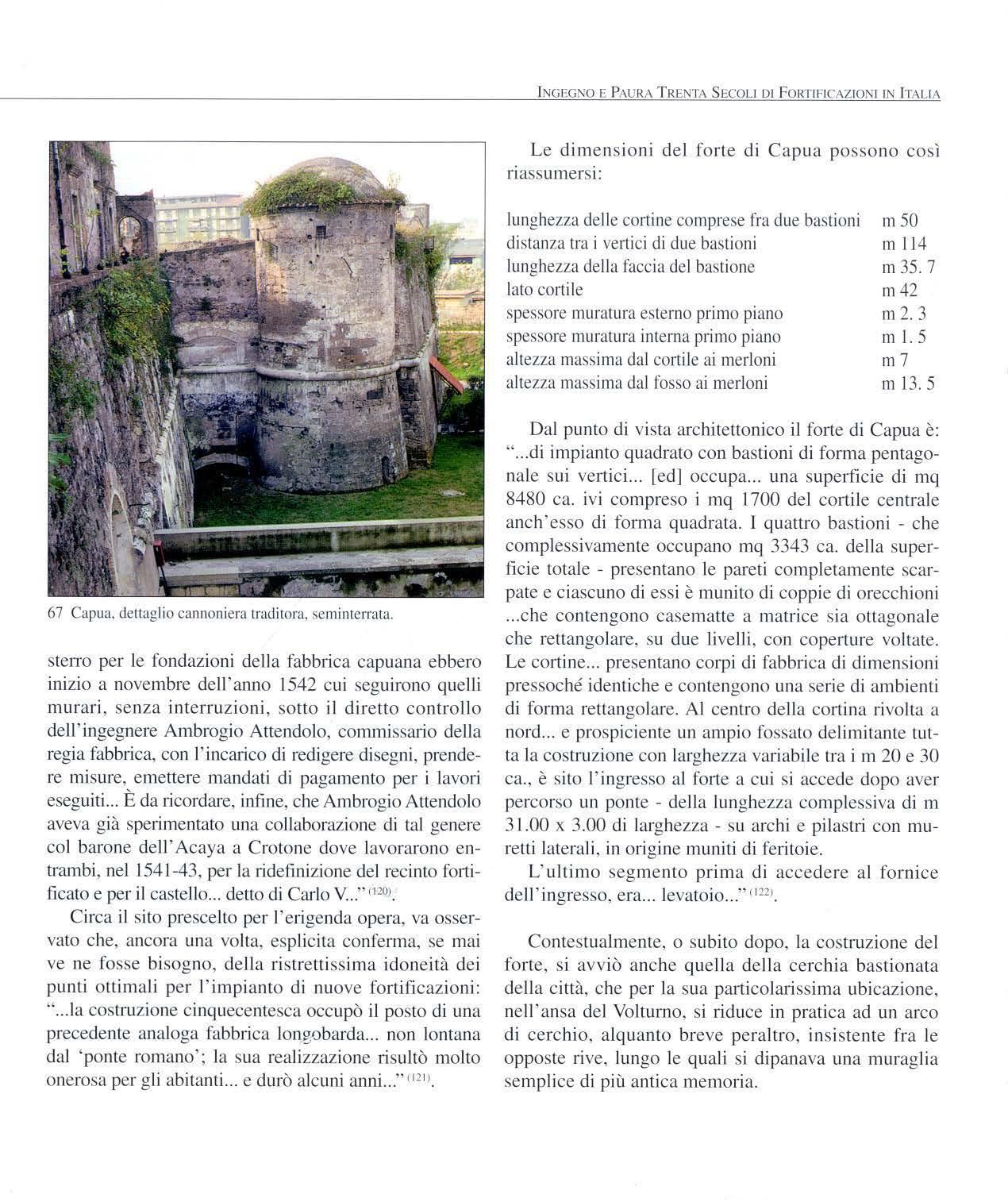
spessore muratura esterno primo piano spessore muratura interna primo piano altezza massima da l corti le ai merloni a lt ezza mas sima dal fo sso ai merloni
Dal punto di v ista architettonico il forte di Capua è: " .. .di impianto quadrato con bastioni di forma pentagonale s ui vertici ... [ed] occupa ... una superficie di mq 8480 ca. ivi compreso i mq 1700 del cortile centra le anch ' e s so di forma quadrata. I quattro bastioni - che comp l essivamente occupano mq 3343 ca. della s uperficie totale - presentano le pareti completamente scarpate e ciascuno di e ss i è munito di coppie di orecchioni ... che contengono casematte a matrice s ia ottagonale che rettango lare. su due liveJJi, con coperture voltate. Le cortine presentano corpi di fabbrica di dimensioni pressoché identiche e contengono una serie di ambienti di forma rettangolare. Al centro della cortina rivolta a nord ... e prospiciente un ampio fossa to delimitante tutta la costruzione con larghezza variabi le tra i m 20 e 30 ca., è s i to l'ingresso al forte a cui sì accede dopo aver percorso un ponte - della lunghezza comp l essiva di m 31.00 x 3.00 di larghezza - s u arc hi e pilastri con muretti laterali, in origine muniti di feritoie.
L 'ultimo s egmento prima di accedere al fornice dell ' ingresso, era levato io " " 22 1 •
Contes tualmente, o s ubito dopo , la costruzione del forte. si avv i ò anc h e quella della cerchia bastionata della città, che per l a sua particolari s sima ubicazione, nell'ansa del Volturno, si riduce in pratica ad un arco di cerchio, alquanto breve peraltro , in sistente fra le opposte rive, lun go le quab si dipanava una muraglia semp li ce di più antica memoria.
1 Per avere un'idea di qwmlo amp ia fosse !"indifferenza dei ceti popolari e dei suddit i in genere ve rso la dinastia aragonese è suftìcìente ric o rdare la brevità del le operazioni per la conqu ista cie l i' in tero Regno. Ricorda D. AHULM IA, i re[l,ni del Medùerran eo occidentale dal /200 al 1500. La lotta per il dominio. Bari l 999, p. 249. che nel 1495 i Francesi:'· entrarono nel regno di Napo li ne l febbraio il 24 febbraio ... Carlo VlJT fece il suo ingresso a Napol i... Con Car lo a Napoli e Fem111dino ad Ischia g li aragonesi persero gran parte del paese. anche se alcune lontane città resistettero ai francesi. Eppure la posizione di Carlo non era così sicura come il suo trionfale ingresso a Napol i poteva forse far pensare; i l regno di Napo li era cli gran lunga il più vasto Stato italiano e il conu·ollo delle zone più lontane era sfuggito a molti dei suo i predecessori ·'. E che l'imbe ll e collas so dipese molto dalla estranei tà delle popolazione alle sorti della dinastia lo conferma da un lato l'es istenza cli un discreto apparato militare che avrebbe nella circostanza potuto egreg iamenLe difendere il regno, e dalra.lu o dalle violente insurrezioni innescale dall'arrivo dei Francesi. Circa la prima giustamente ril eva l'Ajello, // problema slOrico del Me-;:, z of!,iomo. L'anomalia socio isritu -;,ionale napoletana dal cì11q11ece11to al sette<;ento, Napoli 1996. p. 5 I , che: ·'... è difficile negare la capacit~t di armamento terrestre e marillima dimostrata dagli ultimi Aragones i ed indicata da molte fonti: ad esempio la flotta di 96 vele allestita sono Alfonso rr nel 1494 e composta di 45 galee. e l'esercito pre sente a San Germano nel febbraio del 1495 di cui parla Giul iano Passm·o. Vero è che scarse furono le capac ità di re s istenza di fron te all'esercito francese d i Carlo VIII: ma non seppero far meglio g l i altri principi e g li a ltri eserc iti ita lian i.". li che è senza dubbio esatto ma i loro S tati avevano dimensioni e potenzial ità socio-econom iche ben minori: quanto a San Germano, dove s i è concentrata la difesa napoletana. precisa P. PTERI. il Ri11ascìm e 1110 e la crisi militare italiana. Tor i no 1952. p. 337, che:'' ... i l 9 febbraio il re di Francia fa assa lire il cas tello di Monte San Germano ... dopo quattro ore di bombardamento sono ape1te tre brecce e tre colonne montano ardi tam ente all'assal to. In meno di un'ora la posizione è conquistala e il presidio cli quasi 700 uomini ... massacrato. "Circa l'insorgenza lo stesso au tore non manca di far notare. a p. 336. che appena pochi g iorni prima della tragedia di Monte San Germano: ·· tutto l'Abru zzo con una rapidit à cd un·unanimità impressionante si solleva in favore dei Francesi. e una turba di forse 15.000 contadini. avida di novità e di sacchegg io. si unisce a i v in citori ...".
i In merilo cfr. A. ROVIGIH. L'occide111e cristiano difiv111e al/'(4fe11siva del turco in Italia nel /480-1481: aspelli 111ilirari. in Orranco 1480. Alli del conv. inter. V Centenario, Otranto 19-23 maggio 1980. Lecce 1986. vo i. I pp. 74 -13 5. Ed anche V. ZACCll!NO La guerra di Otranro del 1480-1481 , opera-;.ioni strategiche e militari. in Ani cic., voi. TI, pp. 265-3)9.
' Un signilìcativo riscontro della in suffic ienza rnilitare del regno di Napoli souo la dinastia aragonese può ravvisars i nell'entità del s uo 'eserci to· , che all'apice non oltrepassò mai i 3000 uomini a cava ll o più un numero imprecisato di fanti che in reallà emno dei semp lici contad ini riciclati alla megl io. Un progetto di potenziamento fu redatto da Orso degli Orsini in torno alla metà cie l XV secolo, ma in pratica 1imase lettera mo1ta per i l costo non compatibile con le disponibilità de ll a corona. A l ri guardo cfr. P. P!ERI. // ';Gorer110 er exerc itio de la militia" di Orso degli Orsini e i Memoriali di Diomede Carafa. in Archivio Storico Napo letano XIX. I 9 I 3. p. I 07 e sgg.
Cfr. A. T.H. MAHAK. L'h!/luen-;.a del potere marittimo nella storia risi. Roma I994. pp. 62 -64.
5 G. PARKF.R. La rirnlu::.ione miliwre. Le ù11101 1a::. ìcmi milìwri e il sorgere del/ 'Occidente. Bologna 1989 , p. 23, ricorda che sign ificativamente. quasi in prev isione del reiterarsi dell'evento, nel: " ... 1478 il senato veneziano ebbe a dichiarare che "le gue rre di oggigio rn o so no innuenzate più dalla potenza delle bombarde e dell'artiglieria che dagli uomini d'armi" e si mise frenetirnmente adacquis tare armi da fuoco. Altri stati segu irono rap idamente r esempio di venia e ne ll o spazio di poch i mrni l' in vasione francese finì per essere considerata un fattore decis ivo cieli' innovazione mil i tare :·.
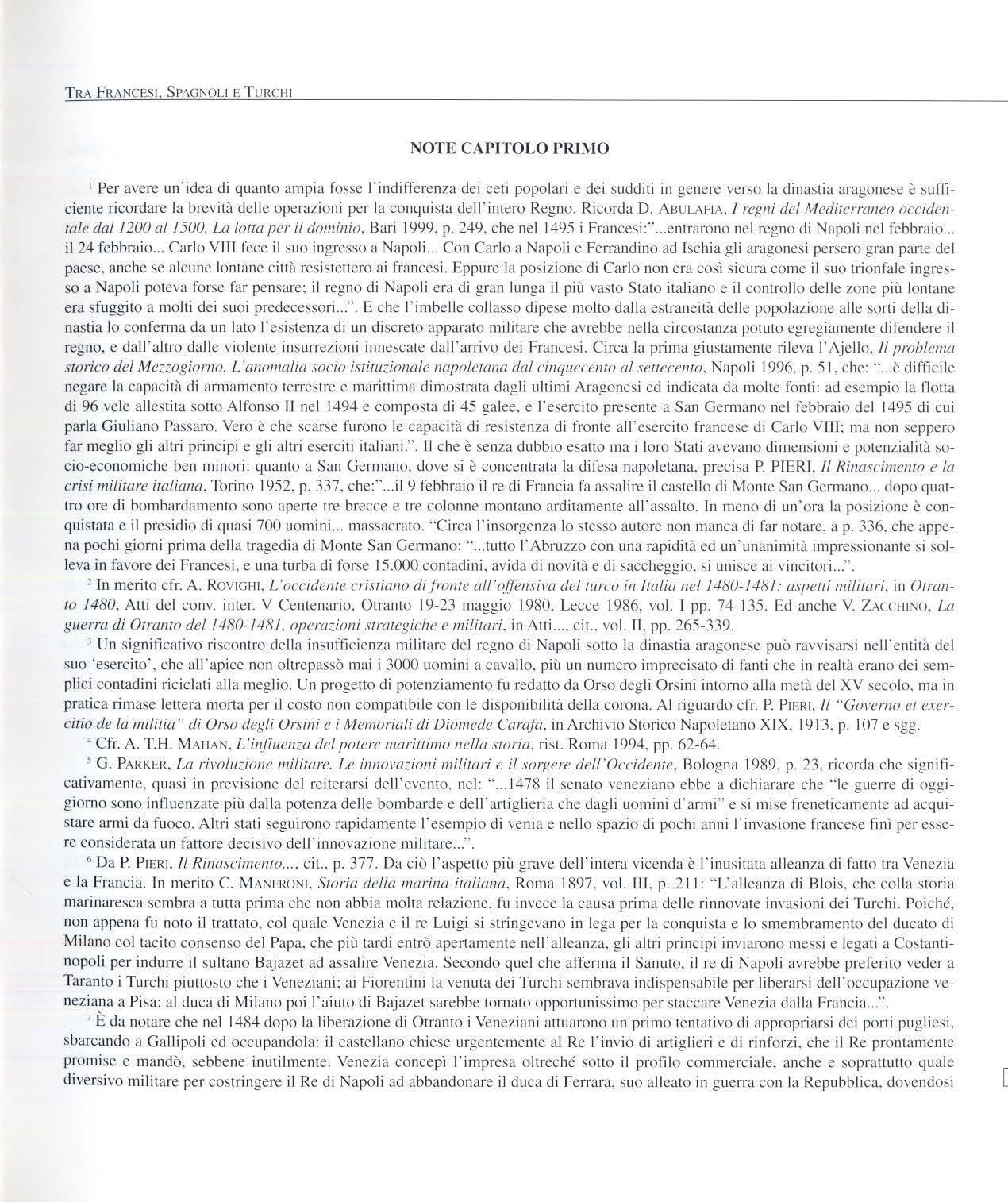
6 Da P. P IERJ. // Rùwsci111en1U .... c it.. p. 377. Da ciò l'aspetto più grave de trinlcra vicenda è l' inusitata al lea nz a di fatto tra Venezia e la Francia. l n merito C. MANFRONI. Storia della marina italiana. Roma 189 7. vo i. IIL p. 2 11: ''L'a lleanza di B lo is. che colla stor ia marinare sca sembra a tutta prima che non abbia molta relazione, fu in vece la causa prima delle rinnovate invas ion i dei Turchi. Po iché, non appena fu noto il trattato. col quale Venezia e il re Luigi si st rin geva no in lega per la conquis ta e lo smembrame nto del ducato di Milano co l tacito consenso del Papa. che più tardi entrò apertamente nell'alleanza, gl i allri princ ip i inv iarono mes si e legat i a Costantinopo li per indurre il sultano Baja ze t ad assalire Vene zia. Secondo quel che afferma il Sanuto, il re cl i Napo li avrebbe prefer ito veder a Taranto i Turchi piuttosto che i Veneziani; ai Fiorentini la ven uta dei Turchi se mbrava indispensab il e per liberar:;i cleJl'occupazione venez iana a Pi sa: al duca di Mj lano poi l'aiuto cli Bajazet sarebbe tornato oppo rtunissimo pe r stacca re Venezia dalla Franc ia .''.
7 È eia no tare che nel .1484 dopo la liberaz ione di O tranto i Venezian i attuarono un primo tentativo di appropria rsi dei porti pug liesi, sbarcando a Gallipoli ed occupandola: il cas tellano ch ie se urgen tem e mc a l Re l'i nvio di artiglieri e d i rin forzi. che il Re prontamente prom.i se e mandò. sebbene inutilmente. Venezia concepì l' i mpresa oltreché sotto il profilo comme rciale, anche e sop rattutto quale diversivo mi litare per costringere i l Re di Napoli ad abbandonare i l duca d i Ferrara, suo alleaw in g uerra con la Repubb li ca. dovendosi [
lNGEG NO E PA URA TRENTA SECOLI DI FORTifl CAZION I IN ITALIAoccupare della difesa del Regno. Nella circostanza una potente squadra agli ordini del Capitano Generale Giacomo Marcello fu spedita ad assaltare Monopoli. Manfredonia e Gallipoli. li 7 maggio le forze venete sbarcarono a poche miglia da Gallipo li ed avviarono immed iatamente le operazioni d'assedio, essendosi rifiutata la città d'arrendersi . Al terzo furibondo assa lto, nel qua le perì lo stesso Marcello, la città fu presa con il conseguente saccheggio. Non risulta tuttavia dalle cronache dell'epoca che il castello con le sue artiglierie abbia sostenu to un ruol o attivo nella difesa della stessa. Si può però accettare l'ipotesi che le sue armi riuscirono ad evitare l ' attacco anche dalla zona orientale (scirocco) dove le mura ancora non erano terminate. La vicenda non ebbe ulteriore segu ito.
Dieci anni dopo, in vece , la dinastia aragonese fu costretta ad implorare quasi mendicare l'aiuto degli altri Stati ital iani per scacc iare i Francesi di Carlo VTTT e recuperare così la corona. Venezia fu tra questi e non perse l'agognala occasione per farsi affidare a titolo di pegno. quindi fino a ll a restituzione delle spese da lei sostenute in operaz ioni militari, le c ill à fortezze di Brindi s i. Trani ed Otranto nel 1496, raggiungendo con la loro occupazione un traguardo da tempo ambito. Al 1iguardo cfr. F. Russo, La difesa costiera del Regno di Napoli dal XVI al XJX secolo, seconda edizione, in corso di stampa, voi. I.
9 Da P. PrER J, Il Rinascimento , cit., p. 308, nota n° I. Per ulteriori approfondimenti cfr. G. COGO, L'ultima invasione d ei Turchi in Italia in relazione alla politica europea dell ' estremo quattrocento. in Alli della R. Uni versità di Genova, voi. XVTI, Genova 1901.

10 Da P. P1 ERI, // Rin ascimento , cit., p. 308, nota n° I. Per ulteriori approfondimenti cfr. MALPrERO. Annali Veneti , in Arc h. Stor. It., 1843, tomo VrI, parte T , pp. 69 e sgg.; ed anche SABELLICO, Historie venetiwze. tradotte da L. DOLCE, Venezia 1544; ed ancora F. MusoNr, Sulle incursioni dei Turchi in Friuli. Udine 1890: ed infine A. DE PELLEGRINI, Timori dei Turchi in Friuli durame la guerra di Cipro, Pord enone 1922.
11 Da P. PIER!,// Rinascimento ... , cit.. p. 389 , nota n 2. Al riguardo cfr. F. MUSONI, Le ultime incursioni dei Turchi in Friuli, in Atti dell'Accadem ia di Udine, Udine 1894. serie ili, pp. 99 - 123.
12 Circa le operazion i di riconquista della città di Otranto e le probabili conseguenze su ll' evo luz ione della fort ifi cazione cfr. L. MAGGIOROTTl, Le origini della fortificazione bastionata e la guerra di Otranto, in Ri vista d'Artiglieria e Genio, Roma 193 1, pp. 11-19.
13 Sc1iveva il 23 seuembre del 1453, pochi mesi dopo la conquista di Costantinopoli Enea Si lvio Piccolomini. futuro papa Pio li, dando prova di straordinaria sagacia e lungimiranza: " E certo, poiché non ci scuoti amo né cambiamo costum i. egli sfrutta la sua vittoria: invade tutte le Cicladi, sotlomelle al suo dom.inio l'Egeo e lo Ionio. distrugge rutto ciò che rimane della Grecia. si volge anche verso g li ungheresi per non lasciare dietro di sé nulla di ince1to. nulla di ostile. Coloro che non gli si oppongono sono facilmente prostrati e vinti. Ha deciso di assalire l'anno prossimo l'Ilali a, sta preparando una flotta immensa. procura anche ciò che è necessario alla gue1rn. Ha sce lto come punto di transito il tratto da Durazzo a Brindisi ". La lettera è pubblicata in La caduta di Costantinopoli, a cura di A PERTUS I, Verona 1976, voi. U. p. 65.
14 Per un approfondimento sulle caratterist iche della flotta di Venezia cfr. F.C. LAN E, Le navi di Vene -;, ia fra i secoli Xlii e XVI. Torino 1983, pp. 251 -283.
15 Da P. Pieri, li Rinascimento , p. 394-95. Quale fosse nel fra ttempo il con testo be ll ico in Adriatico lo lascia immaginare la caduta di Modo ne , piazza marittima non a torto ritenuta uno deg li occhi della Repubblica. il 9 agosto 1500 ad opera dei turchi, ad onta deg li immani sforz i co mpiu ti dalla flotta venez iana per ev it are tale fine. Cfr C. MANFRONJ. Storia .... cit., voi. lll, pp. 2245 -28.
16 Sull'episodio cfr. G.C. SPEZIALE, Storia militare di Taranto, Ba.ii 1930, pp. 55-72. L'invio di Co nsalvo di Cordova -Gonzalo de Còrdoba - ne l Regno d i Napoli, rimontava al 1495, per I' esatlezza dopo l'entrata di Carlo VITT a Napoli. J .H. ELLIOTI. La Spagna imperiale 1469-/ 7 16, Bolog na 1982. p. 148, così ne sint etizza la v icenda: "Un corpo di spediz ione, inviato in Sici lia al comando di quel valoroso general e della ca mpag na contro Granada che era il gra n capitano Gonzalo de Còrdoba, ne l 1495 varcò lo stretto e pose piede in Ca lab1ia. Nel co rso delle sue campagne di guerra in Italia -quell a degli anni 1495-97 e quella de l 1501-4- Gonzalo ebbe modo di dare dimostrazione della sua gen ial ità e ne ll o stesso tempo seppe apprendere la lez ione a lui in segnata dal nemico ed app licarla alle proprie forze militari E, come in queg li ann i fu c reato un servizio dip loma ti co cope rto da profession isti ... così si eb be anche la fonnazione di un esercito di mestiere. la cui ab ilità e il cui spirito di corpo dovevano p rocurare alla Spagna le gran di vi ttori e che essa riportò nel Cinquecento e ne l Seicento "
In merito a lla v ittoria scriveva lo stesso Consalvo: "Oggi per la gralia di nost ro signore Dio senno entrati in questa città di Taramo, la quale, una con lo cas tello. è divenuta alla obedien za et divotione delle predette cattoliche Maestà con bona volontà de tutti li cittadini et ne hanno recepwi con grande amore allegre zza et jubilazione, et n ' hanno fatto amorevoli demostrazioni piene d'afj'erione ".
Circa la fine, po i, d i re Federico m e di s uo fig lio Ferd inando va ri co rdato che il primo si costituì a re Luigi Xll. ced e nd ogl i llltli i suo i d iritt i su l regno in camb io di una pensione annua e del ducato d ' Angiò: mo rì ne l 1504 e con lui si estinse la dinastia aragonese Suo figlio, infatti. catt urato dal Consalvq e deportalo in Spagna vi morì a sua vol ta se nza e red i. È interessante precisare che allorquando Fede1ico ebbe se ntore de l precipitare degli eventi. si rifug iò ad Isch ia. dove al riparo delle massicce mura della cittadella eretta sullo scog lio di Gerone v i concentrò i suo i migliori cannoni. S i u·attò probabilmente d i quelli più appariscenti e più artisticamente decorati, fo rtun osamente
scampati a l sacco francese del '94 e forse anche di fabbricaz ione successiva. l suoi vinc itori però non degnarono quei pezzi di soverchia attenzione , seg no indiscutibile della loro aiTetratezza tecnologica, de l resto tipica dell'intera produzione militare aragonese , e li svendettero per meno del la qua1ia parte del valore originale del metallo a due capitani della squadra pontificia. Questi, caricatili sulle loro galere, guadagnata la foce de l Tevere e risalito il fiume. li inviarono a Caste l S. Ange lo , in veste di antesignan i repe rti musea li.
17 Da P. GIANNONE, Istoria civile del R egno di Napoli, rist. Como 1971, voi. V, p. 280 .
18 Sulla ce leb re sfida cfr. A. DE FERRARIS, detto il Galateo, De pugna tredicim, in Collana di opere scelte edite ed inedite di Scrittori di Terra d'Otranto, diretta da Salvatore Grande. Lecce 1867. voi. TT, pp. 261 -70: ed anche P. G 1ov 10, La vita del Gran Capitano e del Marches e di Pes cara, a cura di C. P,W IGADA, Bari 1931, pp. 91 -98. Dal punto di vista tecnico appare indubbio che la vittoria degli italian i fu agevolata da armi migliori. nella fattispecie lance più lungh e appositamente scelte da Pro spe ro Colonna. Quanto al contesto bellico in cui l'epi sod io si colloca, precisa al riguardo L. BL ANCH, Della scien~a militare. Livorno , I933. pp. 93-94: "La campagna del gra n capitano Consa lvo sul Garigliano, qu e lle di tutta la sc uola dei cap itani spagnuoli sotto Carlo V, le sue imprese di Africa. (ove era indispensab il e la cooperazione della mai'ina militare che si pe rso nificava in Andrea Doria), tutto prova il progresso in cui erano le co mbin azioni mil ita1i, giacché uno de' suoi segni più evidenti è quella della combinazione degli eserciti con le armate di mare ".
19 Ri corda P. PIER! , li Rinascimento , cit., p. 415: "La battaglia d i Cerignola si dis ti ngue anche per la brev ità massima del conflitto, la sproporz ione grandissima delle perdite dalle due parti e l'ampiezza del risultato strategico. In mezz'ora l' esercito francese fu sbaragliato, ebbe uccisi un a ci nqu anti na d'uomini d'arme e o ltre 3.000 fanti, senza i feriti e lasciò 600 prigionieri. Gli spag nuoli al contrario non dovettero lamentare, a quanto se mbra. che un centinaio in tutto fra mo1ii e feriti! Ma di Cerignola appare grande sopratt utto il ri su ltato stra tegico: poco più di due settimane dopo la battaglia Consalvo entra in Napo li. mentre il grosso delle forze superst iti francesi non trova riparo che dietro il Garigl iano e in Gae t.a 1". Cfr. M. MALLEIT, Signori e mercenari, la guerra del Rinascimento. Urbino. 1983, pp. 255 -256.
20 Per app rofondimenti su lla formazione dello Stato dei Presid i, cfr. G. CACIAGLI, Lo Stato dei Presìdi , Roma l 972, pp. 3-46.

21 Per un sintetico quadro storico di quel crucia le s nodo sto rico cfr. H PIRENNE, Storia d'Europa dalle invasioni al XVI secolo, Roma 1991, pp. 420-437.
21 Cfr. A. GHIRELLI. Storia di Napoli, ri st. Torino 1973. pp. 25 e sgg.
23 Cfr. P. MARAVIGNA, Storia dell'arte militare moderna, Tor in o 1926, pp. 124-26. Circa la min a R. FII.ANG ERJ, Castel Nuovo. Napoli, 1964, p. 196 , così ricostruisce la conquista del castello p rincipale di Napoli: " .li capitano spag nolo Pi etro Navarro che assediò il castello ... ri petette, il 12 giugno 1503 la min a ad esplos ivo sotto la vecchia cit tadella fcome ne l 1495 n.d.A. J. .. dalla parte del parco. cioè sotto il giardino del Paradiso. Ed il successo non mancò neanche que sta volta; perché g li assed ianti entrati per la breccia penetrarono nel castello :·.
24 Cfr. F. Russo, La difesa costiera del Regno di Napoli , II ediz.. cit.. tomo I, in corso di s tampa.
25 Da P PIER!, li Rinascimento c it. , p. 455
26 Per approfondimenti cfr. T. CELOTn. Storia di Spagna, Milano 1940, p. 438.
27 Cfr. J.H. ELuorr, La Spagna imperiale /469 - 1716. U rbino 1982. pp. 155-161.
28 Cfr. F. Russo, La d(fesa costiera dello Stato dei Presidi dal XVI al XIX secolo, Roma 200 l , premessa.
29 Si trattava per l'esattezza cl i papa Clemente VTT, al seco lo Giulio de· Medici, nato a F ire nze il 26 maggio ciel 1479 ed eletto papa il 19 novemb re de l 1523. Morì il 25 settemb re del 1534. Così J .N.D. KELLY, Vite dei papi. Asti 1995 , pp . 437-439. ne delinea gli avvenim e nti esse nzia li del s uo pontificato: " Giuli o de ' Med ici figlio illegittimo di Giu liano de ' Medici e di una certa Fiammetta, era nato a Fire nze il 26 magg io 14 79 poco dopo l' assassinio de l padre e ve nne allevato da ll o z io Lo renzo il Magnifico .. . Nel 1513 Leone X , s uo cugino lo nominò arcivescovo di Fi re nze e ca rdinale ll a sua elezione a papa avvenuta il 19 novembre de l 1523] fu acco lta con gran de g ioia, ma ben presto di ve nn e evide nt e che egli, ecce ll ente come comandante in seco nd a, non aveva il carattere e l'abilità necessari per occupare la massima ca rica in un momento di crisi [per c ui] si compo rtò come un qualunque principe italiano. o piuttosto come un Medici ... Coinvolto nella lotta tra Carlo V e Francesco I.. . s i adoperò per istaurare la pace t ra le potenze cristiane... ma in rea ltà per assicurare la tranqu ill ità d i Fire nze e de ll o Stato Pontificio deluse le attese di Ca rl o. L'anno dopo tutta via, essendo stati sco nfitti i Fra ncesi a Pavia ... fu cost retto a cerca re di nuovo la protezione d i Car lo V. Ma ne l maggio del 1526 cambiò di nuovo atteggiamento un endos i alla lega di Cognac [ il c he) pr ovocò come ri s ultato immediato l' inva sione dell'Italia da parte delle truppe imperiali e i l sacco cli Roma ... decise [qu ind i] d i restare dalla parte dell ' imperatore ... [e] recuperò l a maggior parte del suo potere tempora le, ma rimase s ubord in a to all' imperatore TI precario ra pp or to tra Clemen te e Carlo impedì una pronta reazione ai successi riportati dai Turchi in Unghe ri a ne l 1526 ... Da ve ro Med ici, Clemente protesse letterat i... e a rtisti come il Cellini, Raffaello e Michelangelo. A quest'ultimo commissionèJ. poco p rim a d i mo rire, il "Giudizio Universale" [morì il 25 settembre ciel 1534J.'' Quanto alle [
clausole fatte sottoscrivere a Francesco I nella famosa Concorda di Madrid del J4 gennaio 1526 dopo un anno di squa ll ida prigionia ne l castello di Madrid, così le s intetizza T. CELOTr l. Storia di Spaf?na. Milano 1940. pp. 496 - 97: " I 0 - Pace e amic iz ia perpetua tra l'imp erato re di Gennania e il re di F rancia. 2 ° - Libertà di comme r cio e comunicazioni tra i suddit i di Francia e Spagna. 3° - Consegna all'imperato re del ducato di Borgogna, non oltre sei se tti mane dopo il giorno in cui Francesco I rientrasse nel suo regno. Questo ducato resterebbe in perpetuo separato dalla corona di Franc i a. 4 ° -I due figl i maggiori di Francesco I sarebbero consegna ti come ostaggi e resterebbero in Spagna fino al comp leto adempimen to degli obbligh i derivanti a Francesco l dagli articoli della Concorda. 5 ° - Rinunc i a asso luta e completa di Francesco I ad og ni s uo diritto e pretesa s ul Napoleta no, sul Milanese, su Genova, sul l'Artois e I' Hainaut. 6 ° -Matrimonio di Fra ncesco I con Eleonora sorella di Carlo V e vedova de l re del Po1togallo. 7° - Obbligo per Francesco T di indurre Giovanni d' Albret a rinunziare al t itolo cli re cl i Navarra. 8 ° - Francesco Tsi impegnava ad a ll estire 12 galere. 4 navigli e 4 galeoni ogni vo l ta c he l'imperatore volesse passare in Ita li a. e fo rnire la paga di 6 mila fanti in Italia, 500 lance e alcuni pezzi cli artig li eria e alla res titu zio ne degli ostagg i. 9 °- A pagare a l re d'Inghilterra con decorTenza da l giugno 1522. la somma annua di scucii I 33.305 dovuti dall'imperatore. I 0°- A restituire al duca di Borbone i suoi feud i , titoli e beni che godeva prima di abbandonare la Fra ncia. 11 ° - A restituire il p1inc ip ato all"Orange. e tutt o quello c he possedevano prima della g uerra a Margherita vedova de l duca Filiberto di Savoia, e a l marchese di sal uzzo. 12°- Di comune acco rd o i d ue sovra ni s uppli chereb bero il papa di convocare un conc ili o genera le per trattare del bene della C1is1ian ità, nell'impresa con tro i T urc hi e gl i e retici. e perché co ncedesse una crocia ta generale per tre a nni. 13° - Francesco I ratificherebbe in Fra nci a i capi toli della Concordia. 14 ° - Se alcuno dei ca pitol i non fosse eseguito, Francesco I dava la sua fede e parola di tornare prigioniero in Spagna ". Intui bile l' ass urdità delle p retese e la conseguente inev itabi le non rat ifi ca!
30 V. M ELEGAR I, I grandi assedi. Mi l ano 1972. p. I 24. così s intet izza l'assedio di Vienna. precisando che: " i Turchi reduci dal sa ng uin oso trionfo di Mohacs (1526), che aveva ass ic urato loro il contro llo del territorio magiaro rientravano in forze in Ungheria per se d are una ribe ll ione a l loro dominio e rim ette re s ul trono un loro re- fa ntoccio Giovanni Zàpolya. Travolti a Budapest gli avamposti di Ferdinando T, fratel l o di Carlo V. al coma nd o del s ultan o Soli m a no I il Magnifico marciarono su Vienna Il g rosso delresercito lLrrco an i vò sotto Vienna ne l se tt embre del 1529 ". e ne intra p rese l' assedio , fortunatamente rim osso il 6 ottobre dopo un ennesimo assalto fall ito, e dopo la fine della buona stagio ne.
' 1 Circa le fasi delravvicinamento e del sacco propr iamente detto cfr. A. CHASTEL, li sC1cco di Roma 1527, Torino 1983. pp. 6 -96
32 Per una accurata ricostruzione del tragico evento cfr. U. BoNCOMPAGNI L uoov1s1. Il Sacco di Roma. A lbano. 1929. Più in generale c fr. A. CHASTF.L. Il s acco di Roma I 527. Tori no l 983, pp. 67-96.
33 È interessante ricordare il ru o lo che nella circostanza ebbero le fortificaz ioni della Città. Secondo P. PrERI. Il Rinascimento , cit., p. 58 I , nola n° l:" dalle numerosissime relazioni e narrazio ni s i può argomentare che le mura erano debolissime, e che l a difesa fu in complesso assai tenace ...".
34 Cfr H. PJRENNE, Storia d'Europa dalle invasioni al XVI secolo ri st. Roma 1991, p. 423.
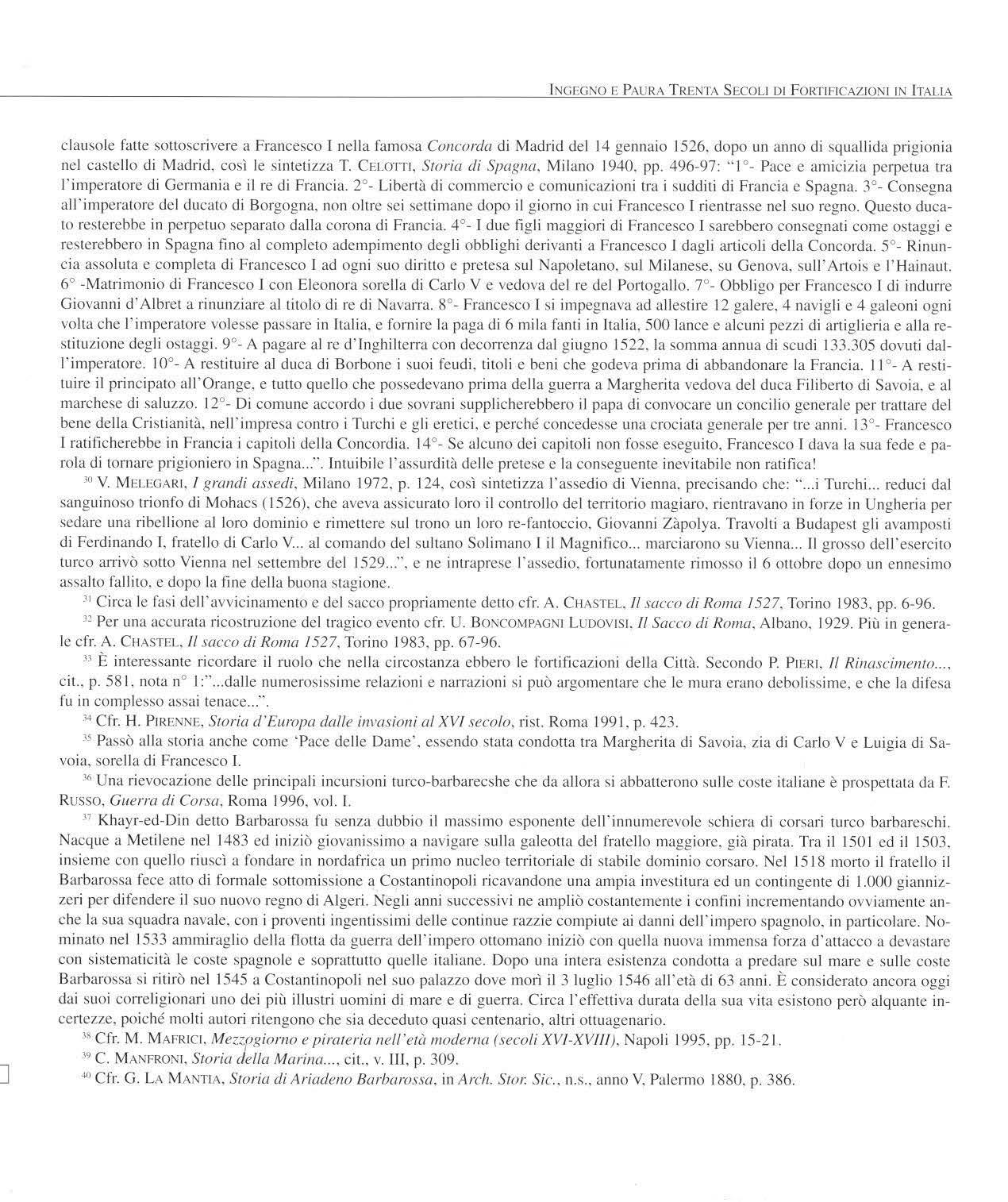
35 Passò alla storia anche come 'Pace delle Dame·. esse nd o stata condotta tra Marghe1ita di Savoia, zia d i Carlo V e Luigia di Savo ia, so rella di Francesco I.
36 U na ri evocazione d elle princ i pali incu rsioni turco-barbarecshe che da a ll ora s i abbattero no s ull e coste italiane è prospettata da F. Russo, Guerra di Corsll Roma 1996. vo i. T.
37 Khayr-ed-Din detto Barbarossa fu se nza dubbio il massimo esponente dell'innumerevole schiera d i corsari turco barbareschi. Nacque a Metilene ne l 1483 cd ini ziò giovaniss imo a navigare s ull a galeotta de l frate ll o maggiore , g ià pira ta Tra il 1501 ed il 1503. insieme con quello ri uscì a fondare in nord africa un primo nucleo territoria le di s tab il e dom ini o corsaro. Nel 1518 morto il fratello il Barbarossa fece atto di formale sottom i ss io ne a Costantinopoli ricavandone una ampia in vestitura ed un contingente di I .000 giannizzer i per difendere il suo nuovo reg no d i A lgeri . Neg li anni s uccessivi ne ampliò cos tantemente i co nfini incrementando ovviamen t e anc he la sua sq uadra nava le, con i proventi ingentissimi delle continue razzie comp i ute ai dann i delrimpero spag nol o. in partico lare Nomin ato nel 15 33 anuniragl i o del la flotta da guerra dell'impero ottomano iniziò con quella nu ova immensa forza d'attacco a devastare con s iste maticità le coste spag nol e e so prattutto quelle italiane. Dopo un a intera es is ten za condotta a predare su l mare e s ull e coste Barbarossa si ritirò nel 1545 a Costantinopoli nel suo palazzo dove morì il 3 lu g li o 1546 all'età di 63 anni. È considerato a ncora oggi dai s uoi corre li g io nari uno de i più illusu·i uomini di mare e di guerra. Circa l'effettiva durata de ll a sua vita esis tono però alquante incertezze. poiché mol ti au tori rit e ngo no che sia deceduto quasi centenario, a ltri o uu agemLr io.
:: Cfr. M. MAFRICJ. t~ezzpgiomo e pirateria nell'età moderna (secoli XVI-XVT/1), Napoli 1995. pp. 15-21.
· C. M ANFRON I, Stona della Manna ... , c1t.. v. III , p. 309 .
4° Cfr. G. LA MANTlA. Storia di Ariadeno Barbarossa, in Arch. Sto,: Sic., n. s., a nn o V, Pale rm o 1880, p. 386.
41 Cfr. R. PA ETTA, Pirati e corsari turchi e barbareschi nel Mare Nostrum, Milano 1981. pp. 68 -81. E più in generale A. GALLICO. Tunisi i Berberi e /'Italia nei secoli, Ancona 1928 , pp. 147-97.
42 Cfr. G. PARKER, u1 rivoluzione militare, le innova zioni militari e il sorgere dell'Occidente. Bologna 1989. pp. 21-66.
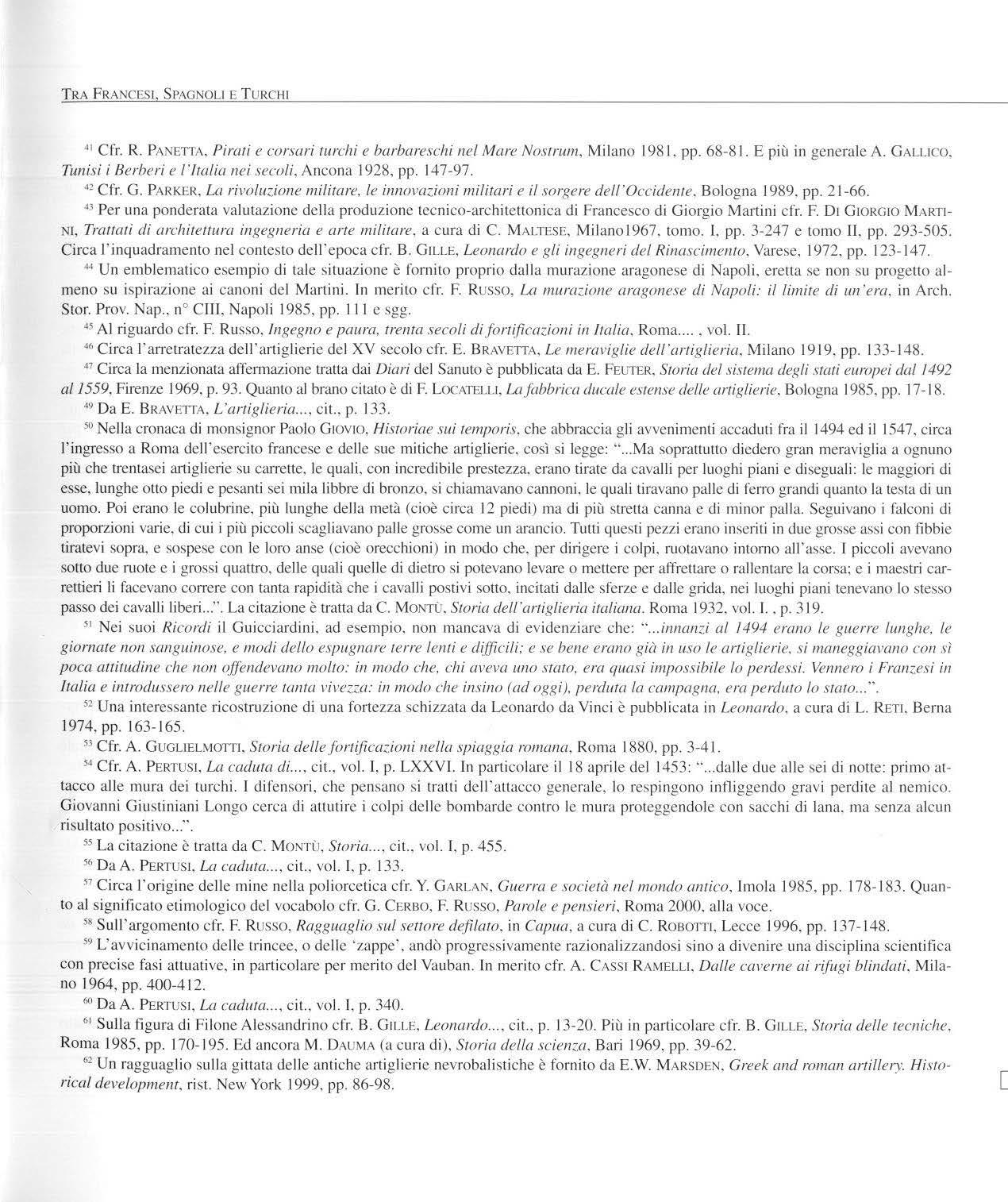
• 1 Per una ponderata valutaz ione della produzione tecnico-arch itettonica di F rancesco di Giorgio Martini cfr. F. Dt GIORGIO MARTtNt. Trattati di architettura ingegne ria e arte militare, a cura di C. MALTESE. Milanol967. tomo. 1. pp. 3 -247 e tomo II , pp. 293-505. Circa l'inquadramento ne l contesto dell'epoca cfr. B . GtLLE. Leonardo e gli ingegneri del Rinascimento . Varese, 1972, pp. 123 -147.
44 Un emb lematico esempio di tale situazione è fornito proprio dalla murazione aragonese di Napoli, eretta se non su progetto almeno su ispirazione ai canoni de l Martini. In me,ito cfr. F. Russo. La mura:ione aragonese di Napoli: il limite di un'era, in Arch. Stor. Prov. Nap., n° CIII, Napo li 1985, pp. 111 e sgg.
45 Al riguardo cfr. F. Russo, Ingegno e paura, trenta secoli di fortifica zioni in Italia, Roma .... , voi. II .
46 Circa l'arre tra tezza dell'artig lierie del XV seco lo cfr. E. BRAVETTA, Le meraviglie dell'ar1iglieria. Mil ano 1919, pp. 133-148.
47 Circa la menzionata affe rmazione tratta dai Diari de l Sanuto è pubblicata da E. F'EUTER, Storia del sistema dep,li stati europei dal /492 al 1559, Firenze 1969. p. 93. Quanto al brano citato è di F. LOCATELU. La fabbrica ducale estense delle artiglierie, Bologna 1985, pp. 17-18.
49 Da E . BRAVETTA , L 'artiglieria ... , c it. , p. 133.
50 Nella cronaca di monsignor Paolo G1ov10. Historiae su i temporis che abbraccia gli avvenimenti accaduti fra il 1494 ed il 1547. circa l'ingresso a Roma dell'ese rc ito francese e delle sue mitiche a1tiglierie, così si legge: ·'... Ma soprattutto d iedero gran meraviglia a ognuno più che trentasei artigl ierie su carrette, le quali , con incredibile prestezza, erano tirate da cavalli per l uogh i piani e disegual i: le maggiori di esse, l unghe otto p iedi e pesanti sei mila libbre di bronzo. si chiamavano cannoni, le guaii tiravano palle di fe1TO grand i quanto la testa di un uomo. Poi erano le colubrine, più lunghe della metà (cioè circa 12 piedi) ma cli più stretta canna e di minor palla. Seguivano i falconi di proporzioni va1ie, d i cui i più piccoli scagliavano palle grosse come un arancio. Tutti questi pezzi erano inseriti in due grosse assi con fibbie tiratev i sopra, e sospese con le loro anse (cioè orecchioni) in modo che, per dirigere i colpi. ruotavano intorno all ' asse. I p iccoli avevano sotto due ruote e i grossi quattro, delle quali quelle di dietro si potevano levare o mettere per affrettare o rallentare la co rsa; e i maestri carrettieri li facevano correre con tanta rapidità che i cavalli postivi sotto, incitati dalle sferze e dal le giida, nei luog h i piani tenevano lo stesso passo dei cavalli liberi ...". La citazione è tratta da C. MoNTù . Storia italiana. Roma I 932. voi. T. • p. 3 I 9.
5 1 Nei suoi Ri cordi il Guicciardini, ad esempio. non mancava di evidenziare che: " innan zi al / 494 erano le guerre lunghe. le giornate non sanguinose, e modi dello espugnare terre lenti e d(fficili; e se bene erano già in uso le artiglierie. s i maneggiavano con sì poca attitudine che non offendevano molto: in modo che, chi aveva uno stato. era quasi impossibile lo perdessi. Vennero i Fran-;:.esi i11 Italia e introdusse ro nelle guerre tanta vi1·ezw: in modo che insino (ad oggi). perduta la campagna. era perduto lo stato ".
52 Una interessa nte ricostruzione di una fortezza schizzata da Leonardo da Vinci è pubblicata in Leonardo. a cura di L. RETI. Berna 1974, pp. 163 - 165.
53 Cfr. A. GUGLIELMOTTI, Storia dellefortificazioni nella spiaggia romana, Roma 1880. pp. 3-41.
5 ~ Cfr. A. P ERTUS I, La caduta di .. . , cit., voi. I, p. LXXVI. In particolare il 18 ap ril e del 1453: " ... dalle due alle sei di notte: primo attacco a ll e mura dei turchi. I difensori. che pensano si tratti del l'attacco genera le. lo respingono infliggendo gravi perdite al nemico. Giova nn i Giust iniani Longo cerca di attu ti re i colpi delle bomba rde contro le mura proteggendole con sacc hi di lana. ma senza alcun ri sultato p ositivo..." .
55 La citazione è tratta da C. MONTÙ, Storia , cit., vo i. I, p. 455.
56 Da A. PERTUS I, La caduta ... , cit. , vo i. L p. 133.
57 C irca l'origine de ll e mine nel la polio rcetica cfr. Y. GAR LAN, Guerra e società nel mondo antico, Imola 1985, pp. 178 - 183. Quanto al sig ni ficato e timo logico de l vocabo lo cfr. G. CERBO, F. Russo, Parole e pensieri. Roma 2000. alla voce.
58 S ull' argome nto cfr. F. Russo, Ragguaglio sul setrore defilato. in Capua, a cura di C. ROBOTTI, Lecce 1996, pp. 137 - 148.
59 L'avv icinamento delle trincee, o delle 'zappe', andò progressivamente razionalizzandosi sino a di ve nire una disciplina scientifica con prec ise fas i attu ative. in part icola re per me rito del Vauban. ln merito cfr. A. C/\SS! RAM ELLI, Dalle caverne ai r(fugi blindati, Milano 1964, pp. 400-412.
60 Da A. PERT USI, La cadwa , c it.. vo i. I. p. 340.
6 1 Sull a figura d i Filone Alessandri no cfr B. G tLLF. , Leonardo ci t ., p. 13 -20. Più in particolare cfr. B GtLLE, Storia delle tecniche, Roma 1985 , pp. 170-1 95. Ed a ncora M. DA UMA (a c ura di ), Storia della sc ien:a. Ba1i 1969, pp . 39-62 .
62 Un ragguag lio sulla gittata de ll e antic he artiglie rie nevrobalis tiche è fornito da E.W. MARSD EN. Greek and roman artillerv. Historical development , rist. New York l999 , pp 86-98
6 1 Cfr F. Russo, La difesa costiera dello Stato Pontific io dal XVI al XIX secolo. Roma 1998, pp. 60-75.
°' Da A. CASSI RAMELLI. Dalle caverne , cit., pp. 361-362.
6 5 Cfr. A. GuGLJELMOn 1 , Le fort/fìcazioni sulla spiaggia romana, Roma 1880, pp. 171 e sgg. Inoltre circa la trace iralienne , cfr. W. H. Mc NE IL L, Caccia al potere, Varese 1984, p. 78
66 Da A. CASSI RAM ELLI. Dalla caverna cit., p. 334.
c, 7 Da L. SANTORO, Napoli nel Cinquecento Op ere difensive nel Viceregno, Napol i 1980, p. 130.
68 Da T. ARGIOLAS, Armi ed eserciti del Rinascimento italiano, Roma 1991. p. I02.
69 Da M HOWARD. La guerra e le armi nella storia d'Europa, Ba1i 1978, pp. 69 -70.
70 A. Guglie lm otti, Storia de/le.fortificazioni .. .. cit., p. 180.
71 TI ·prospetto cronologico' s ulla vita di Antonio da Sanga ll o redatto dal Vasari, così ne s intetizza le fasi es istenziali salient i: "1455- Nasce da Francesco di Bartolo Giamberti. 1488- È mandato a Sarzana a mostrare il nuovo modello di quella fortezza fatto da lui e da Giuliano suo fratello. 1492- Rifonda le difese de l caste l Sant' Ange lo in Roma. 1495- Fa i tor ri on i, le fosse e le altre fortificazioni del detto castello. .. 1497... e fatto capomastro delle mura d i F irenze e di Poggio Impe riale ... 1497 , 14 novembre- È mandato arivedere la fortezza di Brolio 1504. 28 marzo - È mandato a provvedere alla fo rtezza disegnata pe r Castrocaro l 504, 2 giugno- Ingegnere del campo fiorentino contro Pi sa. 1504, 11 giugno- Disegna il bastione di Stagno s ulla strada di Livorno. .. Fa un disegno per fo11ifica re Librafratta Va a fortificare Marracli. 1505 , 12 giugno-Torna a rivedere la fortezza di Arezzo Mun isce i luoghi della Valdambra ... 1506. 30 marzo - Parte da Livorno co l di seg no delle fort ifi caz ioni di quel luogo ... 1508- Fortifica Fucecchio ... Va a provvedere alla fortificazione del Borgo San Sepolcro, di Marradi e della Verrucola. 1509, 8 luglio- Va a Pisa con i modelli della nuova cittadella ... 1511. 13 giugno- È mandato a sopravvedere ai lavori disegnati per la fortezza di Poggio Imperiale... 1526- Di segna i bastioni che si do veva no fa re per la nuova fortificazione cli Firenze Papa Clemente Vli lo manda a Piacenza per cagione di quella fortezza 1534. 27 dicembre - Muore in Firenze ed è sepolto in Santa Maria Novella.'' È emblematico della incomprensione della eccezionale novità del forte di Net tuno che in tanto tu rb in io d'incari chi militari nessuna menzione venga fatta dal Vasari per l'eccezionale opera!
72 A. GUGLJELMOTTI. Storia dellefort/fìcazirmi , c it. , p. 176.
73 In merito è emblematico il caso de ll a murazione aragonese di Napo li superata concettualmente ancora prima de ll a sua ultimazione. Al riguardo cfr. F. Russo. La nwrazione cit.
74 A. G t.:GLLELMOTT I, Storia dellefortfficazioni , cit., p. 184.
75 Archiv io di Stato di Roma, Fondo Soldatesche e Rlliere, b. 4, fase. l 6. f. 14 sgg- da G. M. DE Rossi, Torri costiere del Lazio, Roma 1971. p. 72.
; 6 Le notizie biografiche su Giu li o Cesare Grillo, possono così schematizzarsi: tra il I616 cd il 1624 fu Provved itore Generale delle Fortezze cli mare e di teJTa, Commissar io e Pagatore della Camera Apostolica Nel 1624 divenne capitano del la galera S. Bastiano, della flotta ponti fi cia. Raggiunse nel 1629 il grado cli Provvedito re nello Stato Maggiore della Flotta, e quindi nel 1636 q uello di Provveditore genera le clell'annamen to, incarico c he mantenne fino al 1643. Morì ne l 1643 e 1iccvettc ono revole sepo ltura nella ch iesa de i Filippini all a Vallice lla.
77 Manosc1i tt o de l XVII seco lo s ulle torri costie re de l lit ora le romano, conservato ne ll a Bib. de ll' Istituto Storico e d i Cultura cie li' Arm a del Gen io: co ll ocaz ione 37 C, 3259. La pa1te citata è il f. I 8r.
78 A.S.R., Fo nd o Soldatesche e Go/ere-Inventari delle fo rt ezze e galere, busta 4 voi. 19.
79 Ci rca la fo rt ifica zio ne di Cas tello Eurialo a Siracusa cfr. L. MA UGF'RI. Il castello Eurialo nella storia e Catania l 981. pp . 47 e sgg.
so Cfr. L. SANTORO, Le mura di Napoli, Napoli 1984. pp. 97 -148
s i Cfr. A. RI GILLO. Napoli: nuova le/tura di s 1oria urbanistica , in Costruire, n° 84, l974 , pp. 8-9.
82 Su ll a biografia e le opere dello Scrivà. cfr. A. SANCHEZ GJION, Pedro Luis Escrivà, caballero Valenciano, cons 1ru ctor de Cas1illos, Va lencia 1995.
&J Da L. M AGLIO Architellurefortijicate vicereali spagnole nel regno di Napoli nei secoli XVI e XVII. Napo li 2001, p. 67.
84 Da E . PIROVINE. Napoli e i suoi castelli. Napo li 1974, p. l 88.
ss Cfr. A. SANC'HEZ GJION, Pedm ci t.
86 Per approfondimenti cfr. G. DELLA MONAC A. D. Ros ELu, G. Tosr, Fortez;:,e e 1orri dell'Argen1ario, Giglio e Gianutri. Grosse to 1996, pp 117-119.
s 7 Cfr. F. Russo. La difesa costiera dello Stato dei Reali Presidi di Toscana dal XVI al XIX seco lo. Roma 2002 . p. 230.
ss Da G. DELLA MONACA, D. ROSELLI. G. Tosi. Forte;.ze , cit.. p. 117- 1l 9
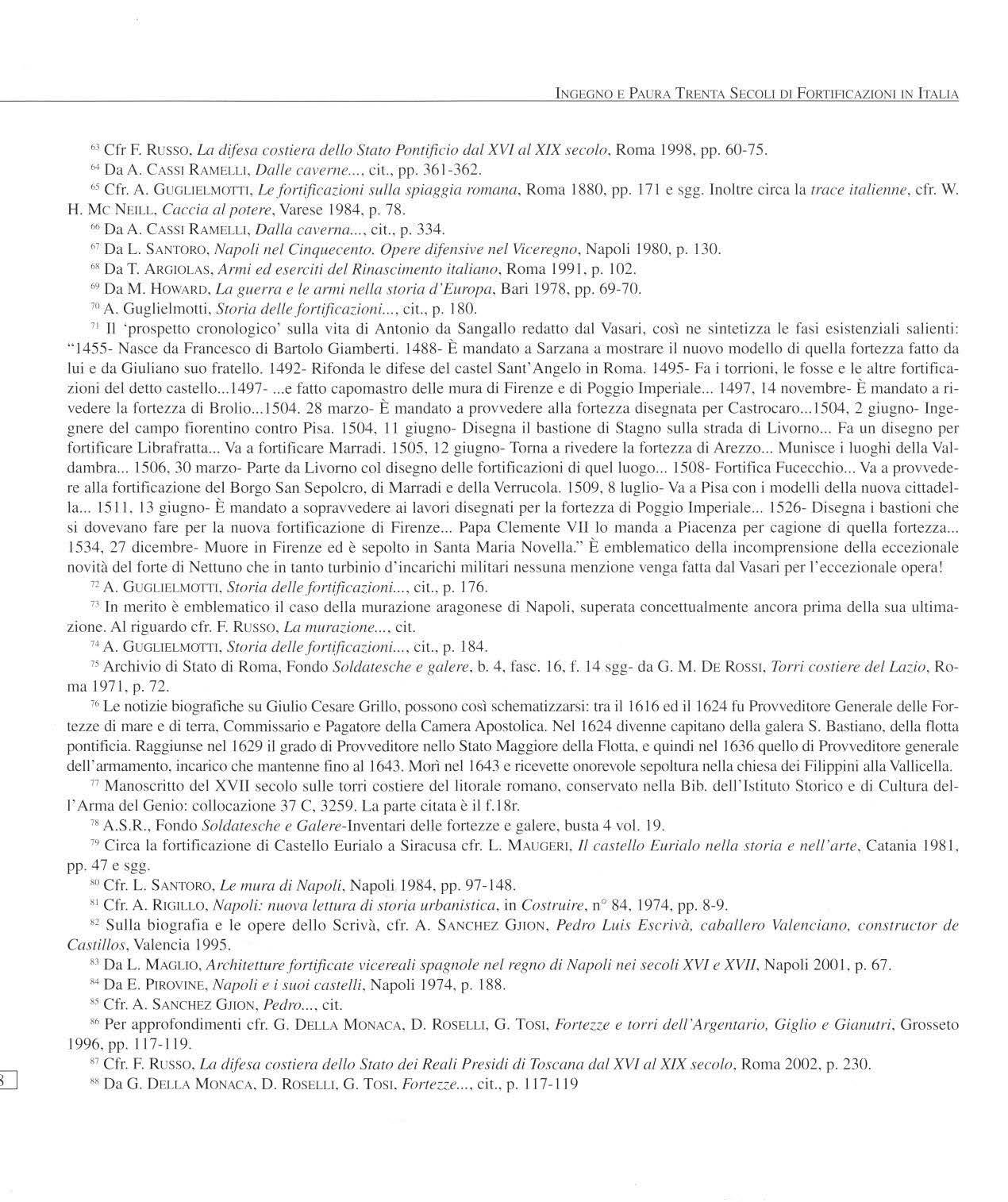
8Y Da L. SANTORO , I Castelli d'Abru zzo ne/l'evolu zi one dell'architettura difensiva, in ABRUZZO dei Castelli. Brescia I 988, p. 148.
!IO La citazione è tratta da C. PEROGALLI, Castelli del/ 'Abru:w e del Molise, Milano 1975. p. 90.
9 ' Da C. PEROGALU, Castelli , cit., p. 91.
92 C irca la biografia dell'illusLre ingegnere militare così da M. CAZZATO. A. COSTANTINI, Guida di Acaya. Galatina 1990, p. 11: " Gia n Giacomo, la figura più interessante di tutta la st irpe dei deirAcaja Divenne uno dei più prestigiosi architetti militari della prima metà del Cinquecento, nominato in un anno imprec isato- ingegnere militare del Regno-. Dal 1539 è impegnato nella vasta opera di ricostruz ione delle mura e del castello d i Lecce; sempre per ordine vicereale fortifica Crotone ( l 543) ed al l 546 è a Napoli per completare Castel S. E lmo e successivamente fo rtificare Sorrento, Capua e Cosenza... Ma è proprio a Segine che Gian Giacomo lascia la tes timon ianza p iù ev idente della sua poliedrica ed aggiornatissima personalità Egli sperimentò, una delle prime volte in Italia e la prima volta nel Mezzogiorno, lo schema rinascimentale della città idea le La ricostruzione di Segine terminò nel 1535 -36 e per l'occasio ne Gian Giacomo vol le mutarne il nome conferendogli quello della sua casata. Tn questo radicale intervento il punto fisso rima se solo i l castello che, mun ito di nuove cortine e di un potente baluardo per controllare la porta di accesso alla piazzaforte, divenne uno dei q uatt ro ve rtici de l nuovo perimetro murario rinforzato agli angoli da bastioni e integralmente circondato da fossati .''.
93 Da R. DE VITA, Castelli, torri ed opere fortijìcate di Puglia, M il ano 1982, p. 177.
94 Precisa F. Russo, La difesa costiera del Regno di Napoli dal XVI al XIX secolo. Roma l989, p. 48, che: '·... un interessante 1ilievo p lan imetrico conservato presso l'Istituto Storico de ll 'Arma cie l Genio fconcorda) sostanzialmente in ogni dettaglio con una analoga p lan imetria esistente presso gli Uffizi di Firenze -tanto da far ragionevolmente ipotizzare quest'ultima preparatoria di quella di Romaestrapo lata ino ltre da un taccuino di rilievi di piazze puglies i di tipo speditivo ...'·.
95 Archivio Genera le di Simancas-A.G.S Esrado Napolès. I033. 7.
96 Da R. DE VITA. Castelli , cit.. p. 122.
97 Cfr. G. BACILE 01 C ASTIGLIONE, Castelli pugliesi, Roma 1927, p. 79.
98 Cfr. P. PEDUTO, Nasci/a di un mestiere, lapicidi, ingegneri, architetti di Cava dei Tirreni. Cava dei Tirreni l 983. pp. 15-30.

99 TI registro dei pagamenti dell'erigendo castello si trova, secondo l'indicazione del Bacile di Castiglione all' A.S.N., Sezione Fi· nan ze, Inv. 3 , Fascio 192 .
wo Cfr. L. S ANTO RO, Castelli , cii., pp. 54-73
101 Da R. DE VrTA, Castelli , ci t. , p. 93.
102 Così l'iscrizione: ''CA ROLUS QUINTUS IMPERATOR ROMANORUM SEMPER AUGUSTUS MCCCCCXXXVII".
io3 A.G.S., E Nàpoles, 1033, 7.
104 Cfr. G. BAC ILE DI CAST IGLIONE, Castelli , c it., p. 92.
105 È presumibile però. come vedremo pe r C rotone, che una rilevante aliquota cont1ibutiva fosse esatta in natura.
106 La citazione è tratta da T. Cou, ETIA, Le pia zzefo rti , cit.. p. IO l nota n° 14.
107 Cfr. A. BELTRAMF.LU, // Gargano, Bergamo 1907, pp. 98- 108.
108 Da R. DE V ITA, Castelli , cit., p. 74
100 Tgrafici d i E. G 1ov 1No fanno parte del fondo Carte Montemar, A .S.N .. col. 73, 19, p1incipio sec. XVTTI.
11°Cfr Pianta del forte di Vieste-Legenda, E G1ov1 NE, Carte cit.
Hi A.G S E Nàpol es 1033. 7.
112 A G.S E Nàpoles. 1046. 57.
113 Da M. MAFR ICJ. Me~ogiorno ... , cit., p. 61.
114 A G.S E Nàpoles. 1035, 60. Sulr argomento cfr. V. GIULIAN I, Memorie storiche della città di Viest e Napoli 1748. pp. J l 9-23
115 A.G.S E Nàpoles 1033. 7. La citazione è tratta da G. CO NIGLIO, Il vicereino di don Pietro di Toledo (1532-53), Napoli 1984, voi. rr, p. 428.
116 Da R. DE VITA, Castelli .... cit., p. 196 -200.
117 Da R. DE VITA, Castelli , cit.. p. 186.
118 Cfr. D. MUONI, Tunisi. Spedizione di Carlo V impera/Ore 30 maggio · 17 agosto I 535, Milano I 876, pp. 23 e sgg .
119 La c itazione è tratta da A. SA NC HEZ GJION. Pedro ci t. , p. 69-A. G. S. , Estado. leg. 1015 , f. 37.
120 Cfr. C. ROBOTTl. Capua , ci t .. pp. 123- 124.
12 1 Da L. SANTORO, Napoli cit., p. 137
122 Da C. ROBOTTJ, Capua c it., pp . 1 12- 113.

La bas tionatura de ll e ce rc hi e e le cerchi e b as tion a te
Come evidenziato nel precedente capitolo la fortificazione bastionata dimostrò sin dal suo avvento, oltre ad un ' indiscutibile efficacia difensiva, un esorbitante costo. In assoluto non era una novità poiché le fortificazioni da sempre risultavano onerose: si trattava piuttosto di una esagerazione insostenibile. Nella fattispecie ad incrementarne esponenzialmente gli importi contribuivano una se rie di caratteristiche fino ad allora assolutamente inedite. In particolare, tanto per esemplificare, gli immensi movimenti di terra imposti dai perimetri sterminati che tal i opere dovevano necessariamente attingere; le innumerevoli strutture accessorie che in rapida successione s i andavano agg regando alla principale, dalle strade coperte ai muri di controscarpa, dai riv e llini alle gallerie di contromina , ecc. OJ _
A differenza dei forti bastionati, di relativamente co n tenute dimensioni, le cerchie urbiche bastionate attingevano sviluppi planimetrici inusitati. Del resto è facile immaginare l'ingombro di una fortificazione desti nata a racchiudere una città quando quella posta intorno ad un cortile di circa 1.000 mq ne occupa oltre 25.000! Indispensabili a ll ora per ridurre gli altrimenti esasperant i tempi di realizzazione migliaia di sterratori, di manovali, centinaia di capimastri e teor ie infinite di carri, di mu l i, di buoi. Assurdo ipotizzare standard più modest i, dimensioni più contenute: se in p recedenza, i nfatti, un fossa to ven iva scavato secondo una l ogica puramente ostativa e soggettiva, cioè per form are semp l icemente un ostacolo la cui ampiezza e profondi tà restavano a discrezione de l progettista, col fron te bastionato tale criterio si di sso lve. La larghezza e la p rofo ndità doveva attingere valori tali da forn i re le cubat u re di te r ra d i riporto necessar ie a co l mare i grandi bastioni e le grandiose cortine: tutt'al più l'in-
gegnere poteva scegliere se abbassare il fondo del fossato o accrescerne l'ampie zza.
I n prima lettura quanto appena accennato se mbra di agevole attuazione: chiunque abbia un minimo di confidenza con la progettazione s tradale sa perfettamente i vantaggi derivanti dalla contiguità tra le tratte da s bancare e quelle da rilevare, ovvero allorquando il materiale di scavo può essere costipato a brevis s ima distanza per formare i riporti. Ma nella costruzione delle cerchie bastionate pur configurandosi indubbie analogie, concettuali ed operative, con la prass i oggi genericamente etichettata come 'movimento di terra ' la realtà fu ben altra. Tanto per cominciare il terreno andava scavato manualmente, spesso in località ammorbate dalle paludi, le cui mo1tifere esalazioni s i accentuavano proprio per quei lavori. Andava trasportato a spalla, più spesso in ceste s ulla testa di disgraziate portatrici che percorrevano centinaia di volte al giorno , nel fango e nella polvere il medesimo tragitto, in salita, letteralmente per un tozzo di pane.
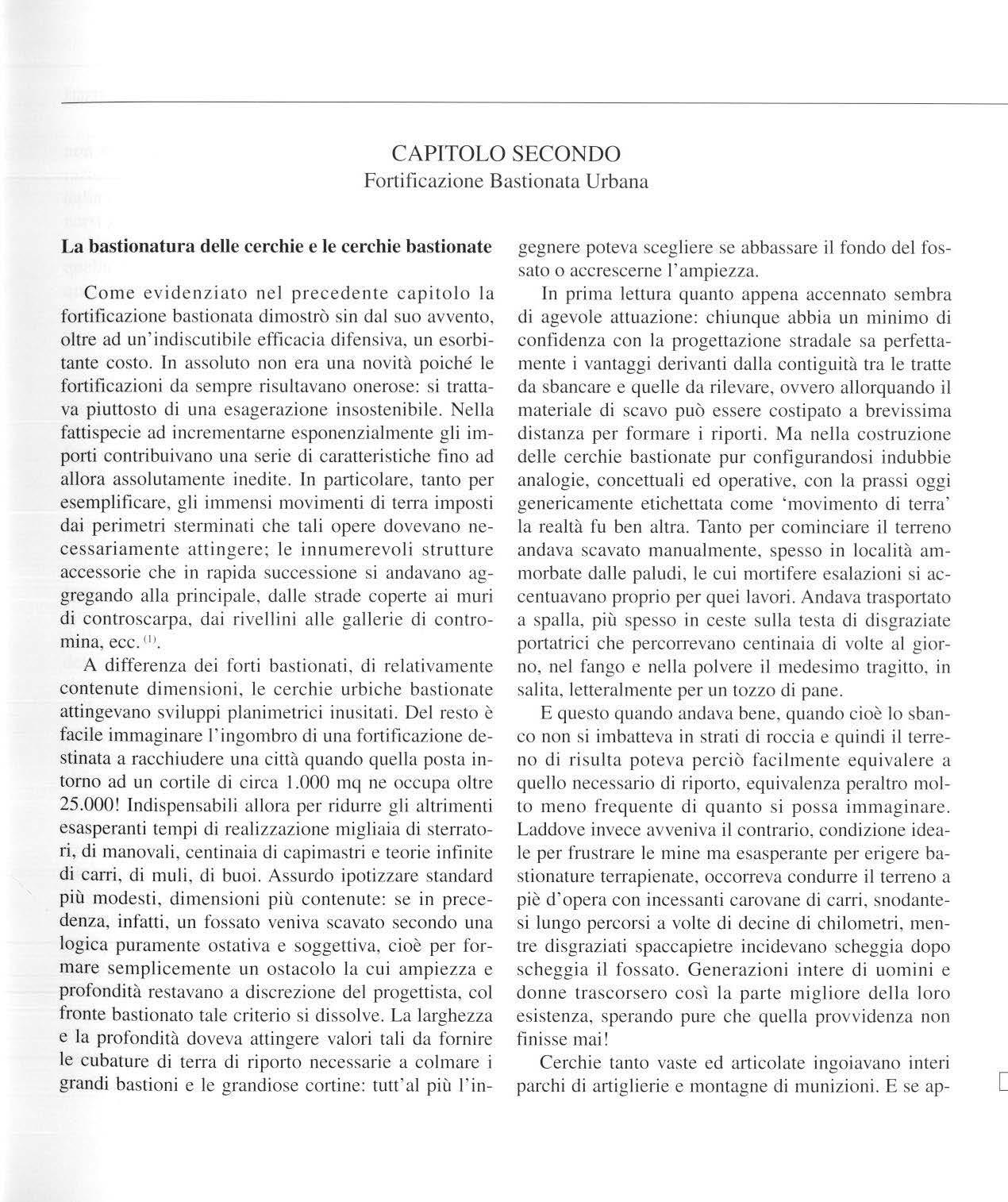
E questo quando andava bene, quando cioè lo sba nco non si imbatteva in strati di roccia e quindi il terreno di risulta poteva perciò facilmente equivalere a quello necessario di riporto, equivalenza peraltro molto meno frequente di quanto si possa immaginare. L addove invece avveniva il contrario, condizione ideale per frustrare le mine ma esasperante per erigere bastionat ur e terrapienate, occorreva condurre il terreno a piè d'opera con incessanti carovane di carri, snodantesi l ungo perco rsi a vo lte d i dec ine di chilometri , mentre d isgraziati spaccapietre incidevano scheggia dopo scheggia il fossato. Generaz i oni intere di uomini e donne trascorsero così la parte migliore della loro esistenza, s perando pure che quella provviden za non finisse mai!
Cerchie tanto vaste ed articolate ingoiavano interi parc hi di artiglierie e montagne di munizioni. E se ap-
pena mezzo secolo prima un paio di bocche da fuoco determinavano le sorti di un assedio , al punto che Carlo VIII conquistò senza resistenza l'Italia per la sua trentina di cannoni, ora per difendere una cittadina ne occorrevano centinaia. Si innescò così una seconda età del bronzo <2l, i cui es tremi non ricusarono di trasformare i pacifici rintocchi delle campane nei terrificanti boati delle artiglierie. E l'apic e s i raggiunse quando, nel 1632 anche le tegole di bronzo dorato del Panteon, scampate al saccheggio dei barbari finirono nel crogiolo rigenerandosi in colubrine per volontà di papa Urbano VIII, al seco lo Maffeo Barberini c 3 J _
Fonderie , fabbriche, officine co n ritmi febbrili di produzioni, vera e mi sco no sc iuta premessa d e lla rivolu zio ne industriale c 4 J, ma anche vera ed altrettanto misco no sc iuta premessa del disastro ambientale del di s-

boscamen to scriteriato e suicida. Bastioni e cannoni dietro ai quali difettavano gli artiglieri propriamente detti e s ufficientemente qualificati, carenza che determinò in breve il coinvolgimento di tutti i cittadini nella loro difesa, non di rado donne comprese es> Sappiamo di granc:Jli città nelle quali ogni corporazione artigiana si fec·e carico di servire con i propri membri i pezzi di un singolo bastione: falegnami sulla piazza e nelle casematte del primo , fabbri a quelle del secondo e magari sarti per il terzo e così via. Ed anche questa fu una premessa di un aspetto della no s tra società, quello della coscrizione obbligatoria <0 > , ben prima quindi della rivoluzione francese e infinitamente prima dell 'a rruolamento femminile.
In definitiva una nuova logica della difesa ed un a nuova logica soc iale: ovviamente tanta innovazione
non si estrinsecò immediatamente ma con una accelerazione progressiva, per cui solo dopo oltre un seco lo dalla comparsa del bastione tali standard possono ritenersi generalizzati.
Non tutti gli sta ti, quindi, potevano permettersi quella nuova fortificazione, o per lo meno non dovunque. A differenza dei castelli, infatti, a rendere difficilmente adottabile il fronte bastionato non giocava soltanto il s uo onere, ma anche, e forse di più, il s uo ingombro ed il suo condizionante impatto sociale. A voler ridurre ad una so rta di aforisma la questione, a quel punto non si trattava più di fortificare una città ma di trasformarla in fortezza, cioè militarizzarla profondamente subordinando qualsiasi funzione c ivile ai rigidi vincoli precipui delle piazzeforti. Una simile penalizzazione poteva trovare giustificazione so ltanto quando una di s iffatte immense strutture tornava utile non solo alla difesa della sua popolazione, che quasi sempre ne avrebbe volentieri fatto a meno se avesse appena immaginato la quantità di sacr ifici e di costrizioni alle quali sarebbe andata incontro, ma a quelle dello Stato. Per cui alla valenza inevitabilmente tattica del vetusto castello, si ini ziava a sost ituire la dim e nsione s trategica delle piazze oJ .

Le risultanti di quelle tante e divaricate componenti possono ridursi sostanzialmente a due tipologie: da un lato limitare l 'adozione delle cerchie bastionate ai pochi casi veramente basilari per la difesa nazionale, erigendole secondo tutti i più avanzati ed ottimali criteri della recente disciplina. In si nte si costruirne poche, senza risparmio e soprattutto ex novo, unica maniera per evitare i troppi condizionamenti imposti dalla configurazione geomorfologica dei siti d'impianto ed urbanistica delle preesistenti città. Dall'altro riqualificare le vecchie fortificazioni perimetrali munendole di bastioni, innestandoli con opportuni accorgimenti integrativi alle s tes se . Questo seco ndo criterio aveva quale logico corollario di limitare quei pote nziamenti alle sole sezioni critiche e più esposte delle stesse, erette a suo tempo sfruttando al mas s imo le impervietà naturali.
In questo secondo criterio informatore il bastione venne ritenuto una sorta di elemento fortificatorio autonomo, esatto sostituto di una torre. Si rinunciò pertanto, e non certo per incompetenza, ad impiegarlo come modulo di un sistema l a cui ideale funzionalità scaturiva dall'interrelazione di più bastion i mutuamente cooperanti, in un insieme geometricamente chiuso. La procedura pur confermandosi di gran lunga meno valida di una vera cerchia bastionata, si confermava tuttavia di gran lunga più valida di una semplice cerchia turrita di medievale concezione.
Tra questi due estremi che potremmo definire il primo delle cerchie bastionate ed il secondo della bastionatura delle cerchie, si collocava una particolariss ima categoria, ottenuta circondando con relativamente piccole cerchie bastionate, omogenee, vecchie fortezze dell'ultima transizione la cui mole se oppo1tunamente defilata prometteva ancora s ign ificativi apporti difensivi. Sebbene numericamente di non rilevante consistenza questa sol uzione originò impianti difensivi di notevole resistenza, con nocciolo centrale, antesignano delle cittadelle del XVII secolo, che assolsero la funzione di estremo ridotto nell e molte città che se ne dotarono. Rappre sentanti per antonomasia della tipologia il complesso romano di Castel S. Angelo ed a Napoli quello del Castel Nuovo, entrambi in qualche modo derivati concettualmente dal castello di Bari, precursore in materia.
Da quanto delineato emerge una razionale suddivis ione tipologica delle opere bastionate edificate in Italia tra il XVI ed il XVII secolo. Grazie a tale convenzione è possibile vagliarne all'interno di ciascun ambito i più significativi esempi ed i più consequenziali apporti evolutivi. Va da sé che se i castelli trasformati in cittadelle sono rari, appena più frequenti sono le cerchie bastionate di radicale costruzione e, per contro, innumerevoli quelle adattate. Sarà inevitabile atteners i a questa suddivisione, compensandola con una più approfondita indagine s ulla seconda tipologia, la vera rappresentante del fronte bastionato.
Superata questa prima distinzione, proprio per il grande numero delle fortificazioni riqualificate tramite l'inserimento di bastioni, occorre operare ulteriori suddivisioni , corrispondenti all'epoca ad altrettanti criteri specifici d'intervento. Infatti , se le opere erette ex novo supponevano quale condizione irrinunciabile la conformazione pianeggiante del si to d 'im pianto, presupposto per l'esa ltazione delle loro prestazioni balistiche , raramente un'identica idoneità, si coglieva nelle cerchie da riqualificare. Nella stragrande maggioranza dei casi quelle fortificazioni ostentavano quale basilare criterio informatore l'impianto apicale, in stretta aderenza alle asperità naturali, prime fra tutte quelle orogenetiche. L'arroccamento di un abitato su di un cocuzzolo collinare, lungo il cui ciglio veniva condotto un muro continuo fornì per secoli un discreto apporto difensivo , ma divenne, dopo la metà del XVI secolo, la fortificazione perimetrale più rigida e più ostica anche per l'inserimento di una approssimata bastionatura <81 •

Al di là delle difficoltà derivanti dalla ristrettezza degli spaz i di s ponibili, uno o più bastioni che fossero sta ti impiantati su cerchie del genere, avrebbero fornito una ben misera prestazione non esistendo al loro esterno il necessario campo pianeggiante. Il loro tiro di basso fiancheggiamento radente, con trai etto ri e non più alte s ul terreno di un metro , non avrebbe potuto in alcun modo effettuarsi positivamente, per cui l ' investimento, che nel passato era ostacolato dall'impervietà del sito a questo punto ne veniva favorito. Gli attaccanti, infatti, finivano per essere defilati non più dagli angoli morti orizzontali, ormai eliminati dal bastione, ma da quelli verticali dell'altura, ineliminabili.
Ben diverso il caso di analoghi interventi in pianura o lungo la costa, che esenti dalla suddetta inadeguatezza vantavano perciò esiti pos itivi sig nificativi, comunque congrui agli oneri sostenuti per la loro attuazione. A questa prima basilare di stinz ione fra fortificazioni adattate d'altura e di pianura, fa seguito una seconda fra quelle interne e quelle costiere. Tra opere cioè destinate a difendere da attacchi di eserciti nemici, oppure dì grosse bande annate, o da sbarchi incur-
s ivi od invasivi: facile sup porre le dissimili articolaz ioni ed il diverso armamento.
Un'ulteriore puntualizzazione deve, però. applicarsi a quest'ultime, in funzione della loro finalità. Se infatti si trattò di una cittadina semplicemente collocata sulla riva del mare, ubicazione da attribuirsi ad una più o meno remota prevalenza dell'attività marinara, pesca o commercio, la fortificazione dovendo farsi carico di difendere un mod es to nucleo abitato raccolto intorno ad un porticciolo, non si discostò se nsib ilmente dalle coeve interne. Ci fu certamente una tendenza a privilegiare le dife se verso il mare, criterio che finì per rendere anisotrope quelle ce rchie , abitualmente in s ignificanti sul fronte a terra. Ma se l'abitato trovava la s ua ragion d'e ssere in un grande porto dove abitualmente facevano scalo le unità da guerra, all' epoca le famigerate galere, con i relativi cantieri di costruzione e riparazione , nonché i reclusori per i forzati, i lazzaretti per le prede, ecc., la concezione fortificatoria mutava drasticamente rispetto alla precedente. Nella fattispecie, infatti, la bastionatura che si andava a sovrapporre in maniera più o meno rilevante alle preesistenti fortificazioni, pur continuando ad esercitare una funzione difensi va, proteggendo una forza di attacco mobile quale una squadra navale, ne condivideva a sua volta la valenza offensiva e connotazioni precipue. In breve tanto l 'a bitato , quanto il porto civile e la darsena militare , nonché tutte le accennate pertinenze finirono per fondersi in un ' unica struttura, meglio nota come base navale , o piazzaforte marittima. Dal che fortificazioni assolutamenle incomparabili con le precedenti, per entità e caratteristiche, a cominciare dal criterio stesso d ' impianto. Essendo, infatti, le sue navi , l'arma più temibile di una piazza marittima, il fronte a mare ebbe meno pesantezza di quello terrestre, destinato ad impedire che attacchi di eserciti nemici potessero averne ragione ferma restando la predominanza navale.
Delineate , sia pur schematicamente le principali su ddivi s ioni tipologiche della fortificazione bastionata urbana, per agevolarne la leggibilità saranno debita -
mente esemplificate a partire dalle prime due. In dettaglio quelle dei castelli tardo medievali inglobati in cerchìe bastionate e delle cerchie aggiornate con innesto di bastioni, in ogni ulteriore suddivisione. Nel capitolo successivo, invece, le cerchie bastionate erette ex novo.
I bas tionj d e l Cas te llo di B ari
L a genesi e l'evoluzione dei primi secoli di esistenza delJe fortificazioni della città di Bari <9l rispecchiano in sostanza lo schema classico più volte già delineato.
Origine normanna <1oi, ricostruzione sveva, aggiornamenti angioini ed infine potenziamento aragonese , interventi tutti agevolmente identificabili nelle strutture superstiti e nei rilievi planimetrici, per non parlare delle fonti d'archivio <1 n . In particolare nel castello di Bari: " .. .le due principali fasi costruttive ... quella federiciana e quella aragonese ... immagliarono un nucleo preesistente. I nfatti la parte più antica, normanna, è quella rivolta a Nord verso il mare e risale al tempo in cui Roberto il Guiscardo occupò la città (107]). Una delle torri normanne , anzi, si impianta sui resti di una precedente fortificazione, probabilmente di epoca romana ... Successivamente fu Federico II a dare incarico a Guido del Vasto di restaurarlo ed ampliarlo. Così tra il 1233 ed il 1240 assunse un impianto quadrangolare
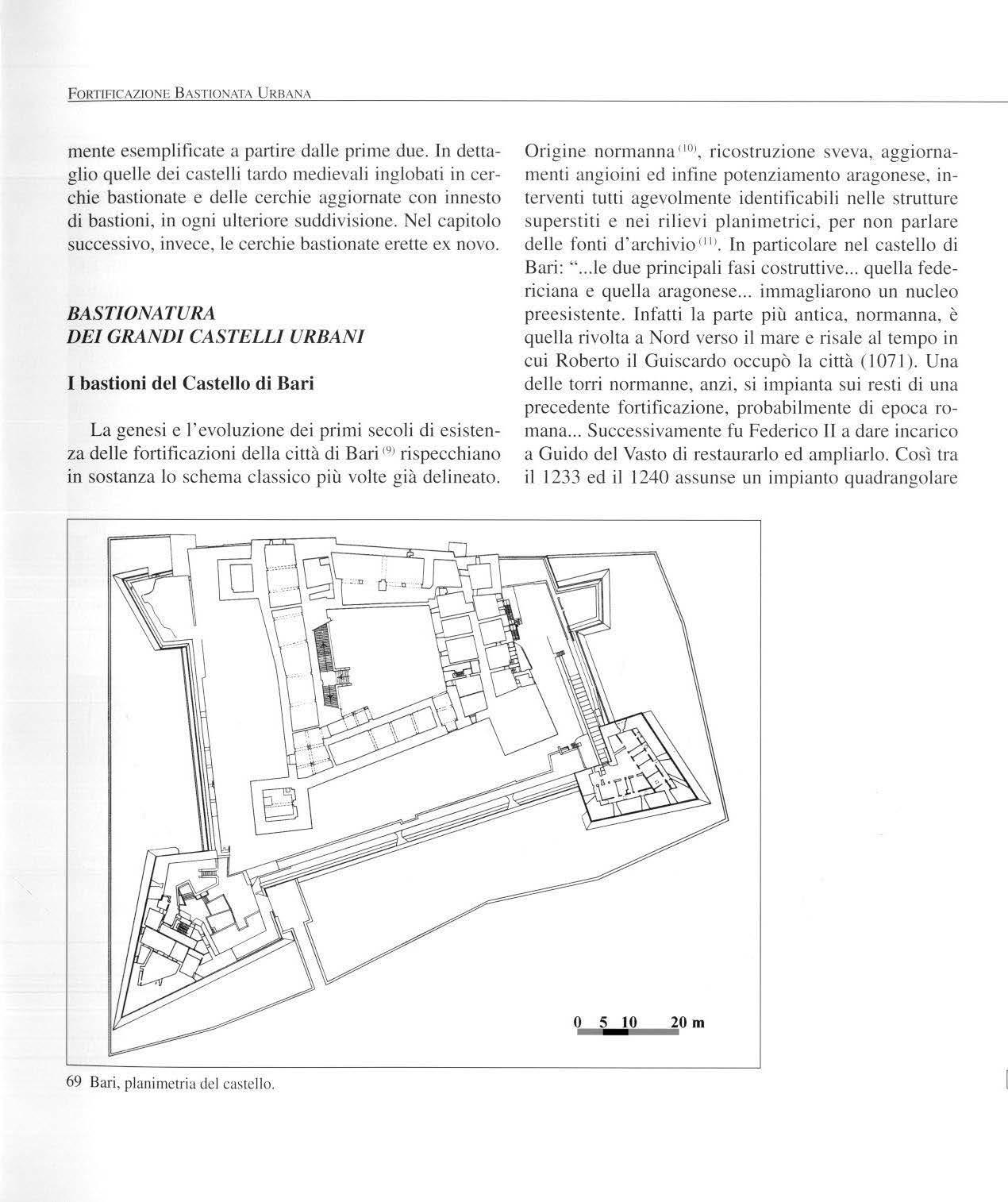
rafforzato agli spigoli da tonìoni parallelepipedi [la cuij altezza doveva raggiungere i 30 m . .. Nel 1276 Carlo I d ' Angiò fece restaurare il castello che risultava rovinato specialmente sul lato 1ivolto verso il mare ... Dopo essere passata nelle mani di vari feudatari, nel 1463 la città di Bari divenne dominio regio di Ferrante d ' Aragona, quindi fu degli Sforza nel 1465 in seguito alle nozze tra Alfonso, Duca di Calabria, e la figlia del Duca di Milano. Dopo alterne vicende ... il castello ed il suo territorio passarono ad Isabe lla definitivamente nel 1500 " <12 l
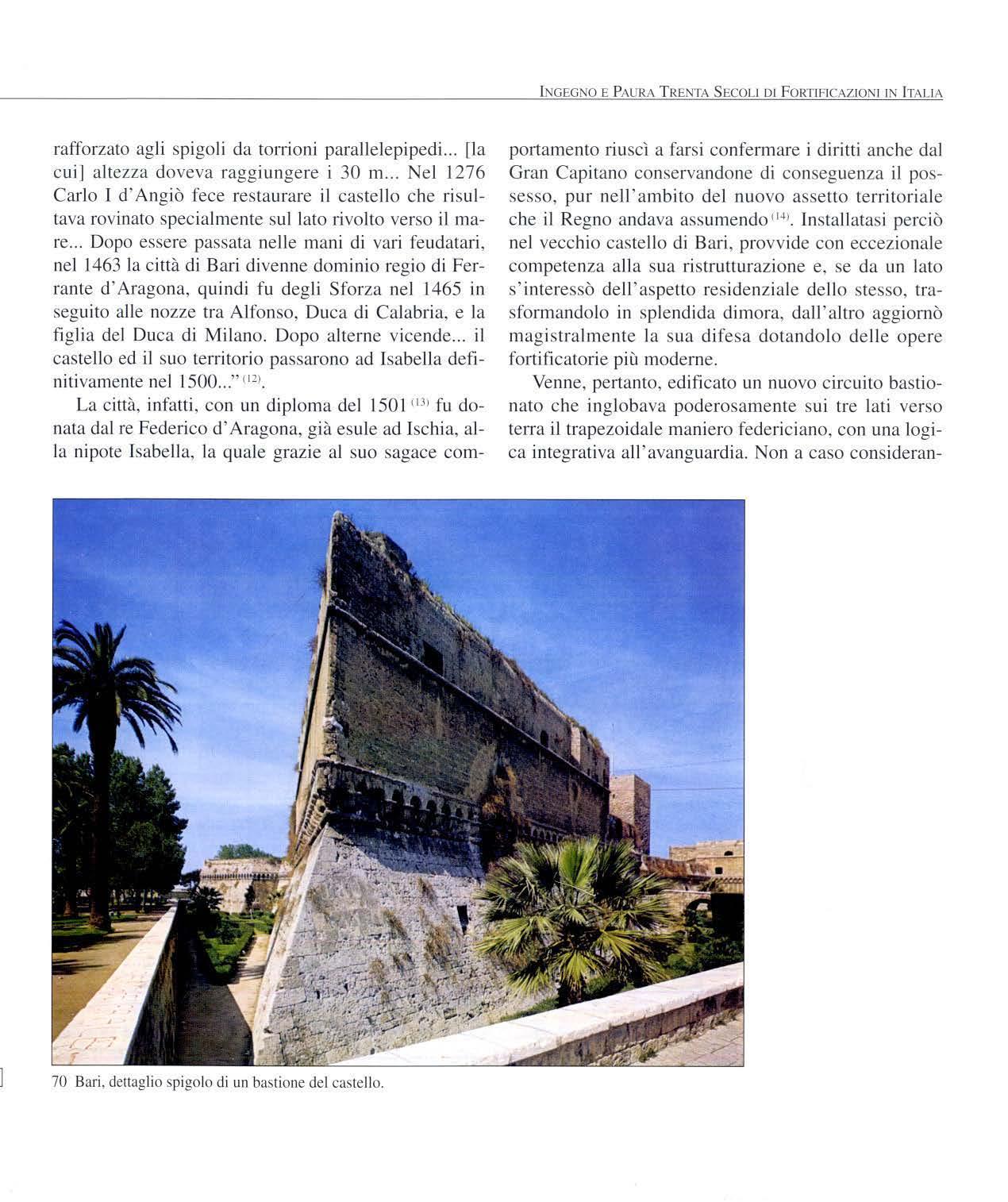
La città, infatti, con un diploma del 1501 113 J fu donata dal re Federico cl' Aragona, già esule ad Ischia, alla nipote Isa beJla, la quale grazie al suo sagace com-
portamento riuscì a farsi confermare i diritti anche dal Gran Capitano conservandone di conseguenza il possesso. pur nell'ambito del nuovo assetto territoriale che il Regno andava assumendo 11 ~i Installatas i perciò nel vecchio caste llo di Bari , provvide con eccezionale competenza alla sua ristrutturazione e, se da un lato s'i ntere ssò dell'aspetto residenziale dello stesso, trasfo rmandolo in sp lendida dimora , dall'altro aggiornò magi stra lmente la s ua difesa dotandolo delle opere fortificatone più moderne.
Venne , pertanto , e dificato un nuovo circuito bastionato che inglobava poderosamente su i tre lati verso ten-a il trapezoidale maniero federiciano, con una logica integrativa all'avanguardia. Non a caso consideran-
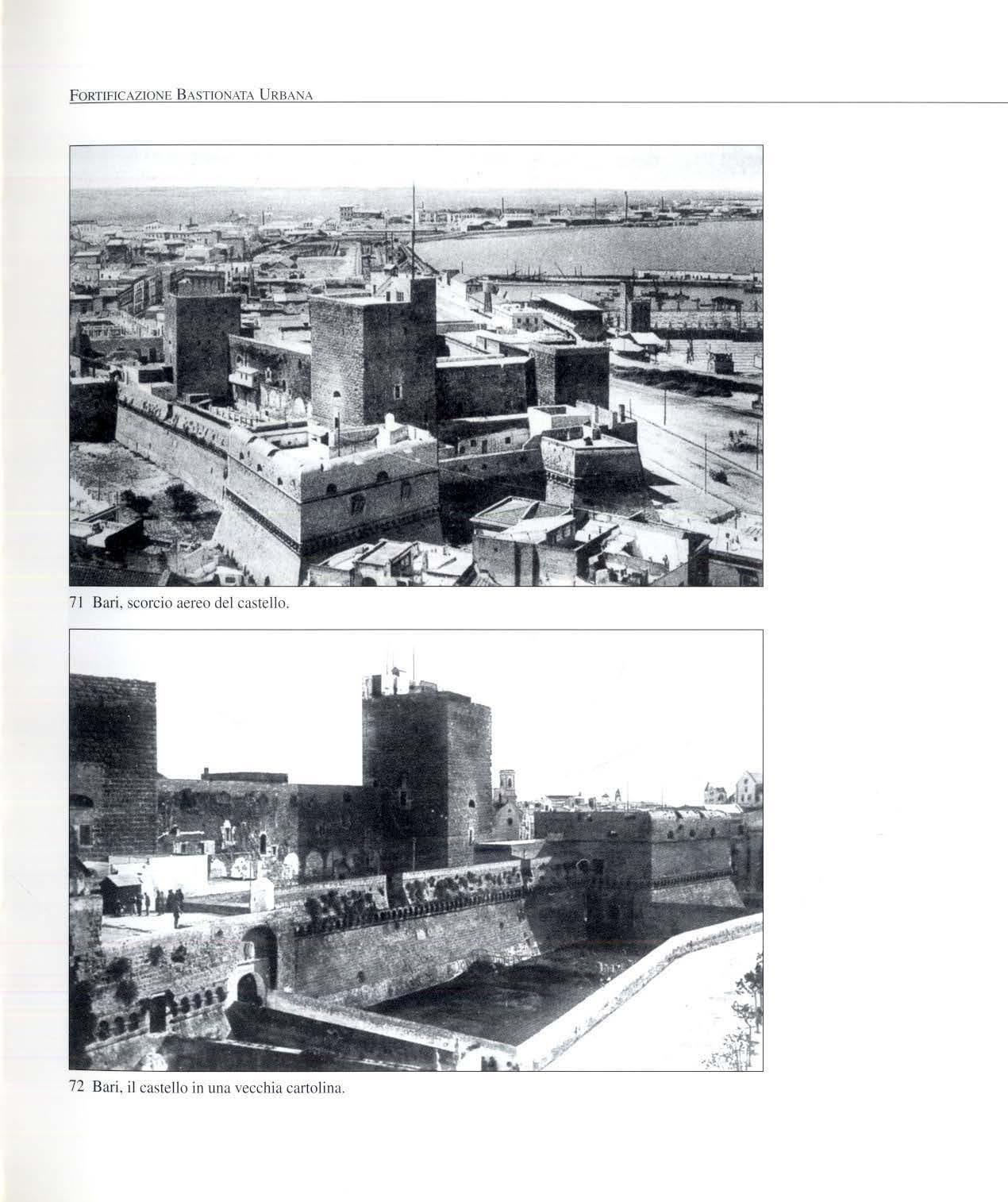
do che: " co desta opera fu cost ruita parecchi a nni prima del J524, a nno in c ui morì Isabe ll a, la si dovrà indubbiamente ritenere come un o dei più antichi esemp i d e lla nu ova mani era di fortificare, quale ne lla mente di ... Giulian o da S a nga llo si era andata maturand o . Bari e bbe così la g lori a e d il vanto di adottare l e nuo ve forme d e ll' a r c hitettura mi li tare d e l Rin ascimento ... Codesti a nti c hi bastioni ... ri velano in mod o ev id e nt e, massime in alc uni particol ari la loro immediata derivazione d all a fortificazione d e l periodo di tra nsito ... I bastioni d e l castello di B aò rappresentano perciò uno d ei più rari esempi di a rcai c he forme d e ll a fortificazione bas tionata ...

L e tre fonti bastionate, mi surate d a sa lient e a salient e hanno lun g h ezze di rn . 62 quella rivolta ad oriente, di m. 150 quella a mezzogiorno, e di m. l 15 quella occidenta le. I b as ti o ni hanno anch'ess i dim e ns ioni e fo rm e differe nti. Il maggiore è quello dell ' angolo sud -ovest: il s uo saliente mi s ura circa 60 m; l e due facce hanno lun g h ezza di m 45 e di metri 50 c irca ; i fianchi formano angolo ottuso co n le co11ine, e d angolo acu to co n le linee di difesa. Presso l 'angolo di s p a ll a d e ll a facc ia meridionale è l 'i n gresso d e l caste llo , preceduto dal pont e in muratura, che ha sost ituito l 'a ntico ponte l eva to io. L 'a ndron e d ' ingresso tortuoso era chiuso da più por t e successive e munito di dife se fianch eggia nti L'altro bas tion e della front e meridionale, quello cioè d ell'a ngo lo su d -est, ha facce di circa 2 1 me tri di lungh ezza, fianchi c he formano con le cortine a ngolo li eveme nte ottuso, e sa li e nte di circa 7 0 rn.
Le due fronti terminano verso il mare con un m ezz o bas tion e ciascuna. Tutte e tre le fronti bastionate avevano due ordini di casematte: il più ~ass o batteva il fosso, il più alto lo s palto. I pia zza li snperio ri avevano ordinamento in barbetta. Il muro di scarpa ... con inclin az i o ne molto se ns ibil e di oltre un quarto ... è rec into di cordone di coro n ame nto a beccate lli e d archetti ...' · 115l
In merito alla cinta che girava intorno a l promontorio s ul quale era edificata l a c ittà , in prim a appressi-
mazione retta ngo lare co n tre lati su l mare ed un quarto ve rso terra. non si osservano particolari innovazioni. L a massiccia murazione aragonese c ustodi t a da ben sei torrioni ci lindri ci con antista n te largo fossa to debita me nt e controscarpato, fu ritenuta suffic i en te per la sa l vag uardia della c ittà 110i JI possente cas te ilo re nd eva non imp e ll e nti, ulterioò opere . Giu s tific a t a p ertanto , alla luc e di quanto d e lin ea t o, la entus i as ti ca re la z ion e del Toled o c he così s i es p rimeva:
·' Bari adonde esra rambie 11a hecho y tambienforrijìcado .. .
... Bari dove tutto s ta così ben fatto e così ben fortificato, tamo al forte quanto a lla città, nonché abbondan teme nte provvi sto d i ottima artigl ie ria, non mj lascia nulla da aggiungere. oltre alla grati tudin e verso la ser. ma regin a per l e buon e preca u z ioni e fortificazion i c h e ha real izzato ."' 1171 •
Il nome già ne s ugge.ti sce l a sua più recente costruz ione ri spe tto a Castel d e ll ' O vo e d a Castel Capuano: variazione cronologica c h e a Napoli, il più d e ll e vo lte, so ttinte nd e un a muta z ione dina st ica. Ed infatti mentre il primo v ie ne in qu alc he modo fatto ri salire al periodo bizantino ed il seco ndo ai sovran i normanno - svevi, que s t ' ultimo fu opera d e l monarca franc ese C a rlo d 'A ngiò. Sebbene l'avvio dei l avori s ia collocato ne l I 279, l a costruzione d eve in serirsi nel tormentato conte sto dei Vespr i Siciliani. In particolare a qu a ndo ad una ini zial e ambizione di una regg ia , più consona a ll a tradizione d ' o ltralp e, s ubentrò pressa nte l 'es i ge n za di una fortificazione mo lto più s ic ura di qu e lle es i s te nti , capace pe rciò di r es is tere s ia da te rra , a qu a ls iasi a ssa lto dell ' infida popo l azione, che da mare, a qual s i asi scoITe ria d egli a ncor più temibili ex s udditi s iciliani osi Si s pieg a così il fe bbril e avanzamento dei lavori c he, stando a ll e rare fonti disponibili a pp e n a quattro a nni dopo ri s ul tano ultimati.
l.NGEGNO E PAU RA TRENTA SECOLI DI FORTLFI CAZION J IN I TALIA
Ovviamente il castello , eretto presso il Molo dei Pi sa ni non era completo in ogni suo dettaglio , né pera lt ro va confuso con q uello che vediamo oggi. La sua costruzione fu pertanto continuata, ed ampliata, dapprima da Carlo II e quindi da Roberto d'Angiò occupando buona parte della pr im a metà del secolo success ivo. Di questo primo edificio non abb iamo alcuna raffigurazione , per cui: " ... non siamo in grado di formulare un a qualsia si i potesi sul s uo aspetto; poss iamo solo s upporlo .. . un castello-p a l azzo avente la duplice caratteristica di difesa e di magnifica dimora del signore . .." i 19 1
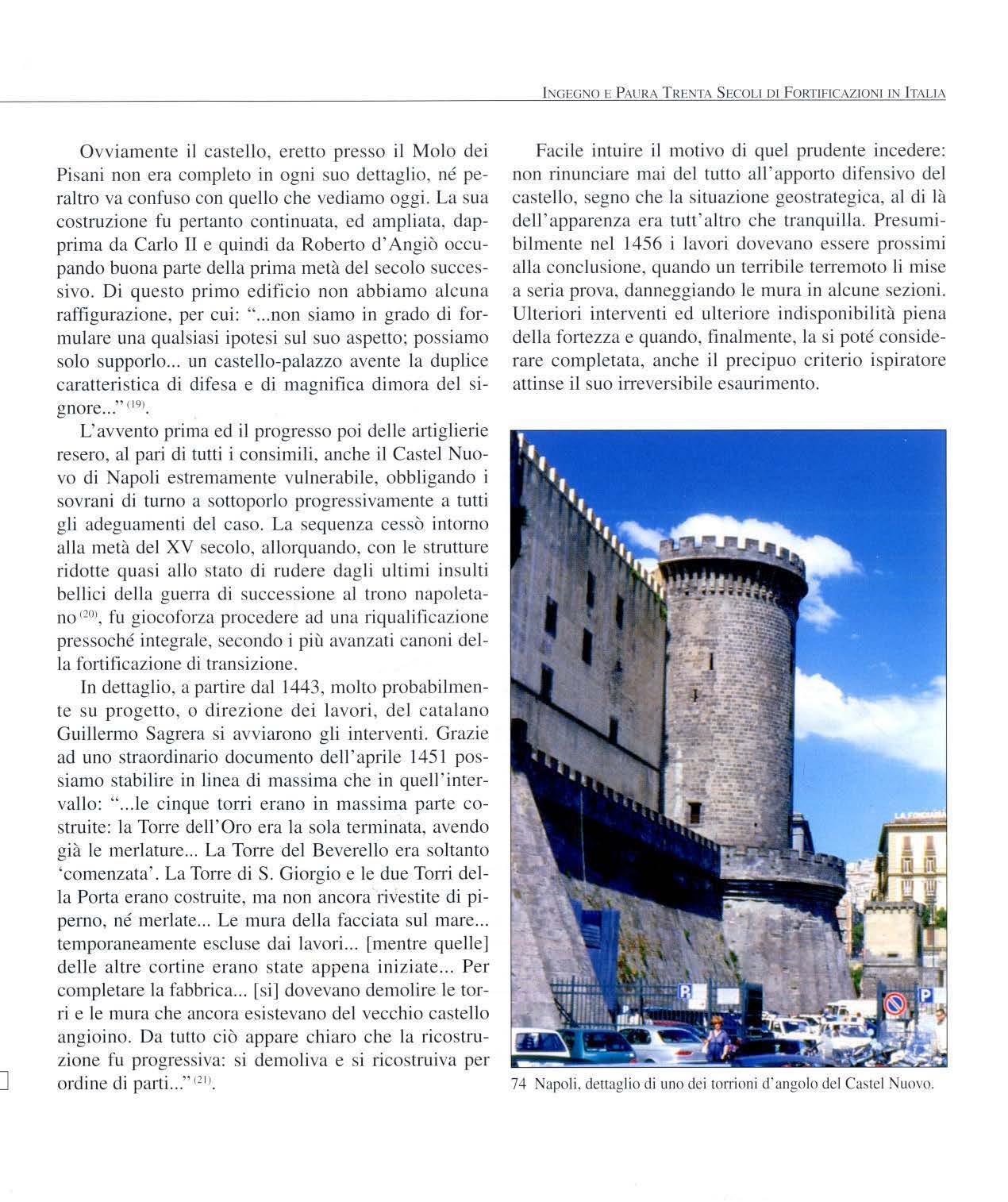
L'avvento prima ed il progresso po i delle artiglierie resero , al pari di tutti i consimili, anche il Cas tel Nuovo d i Napoli estremame n te vulnerabile, obbligando i sovrani di turn o a sottoporlo progress ivamente a tutti gli adeguamenti del caso. La sequenza cessò intorno a lla m età de l XV seco lo, a ll orq uando, con le s trutture ridotte q u as i allo s tato di rudere dagli ultimi in sulti bellici della gueJTa di successione al trono napoletano (10l, fu g i ocoforza procedere ad una riqualificazione pressoché integra le, secon do i più avanzati canoni della fortificazione di transizione.
[n dettaglio , a partire dal 1443, molto probabilmente su progetto , o direzione dei lavori , del catalano Guillermo Sagrera si avviaro n o gli interventi. Grazie ad un o straordi n ario documento dell'aprile 1451 possiamo stabil ire in lin ea di massima che in quell'intervallo: " .. .le cinque torri erano in massima parte cos tmite: l a To rr e dell'Oro era l a sola terminata, avendo già le merlature ... La ToITe del B everello era so ltanto 'co menzata' . L a Torre di S. Giorgio e le due Torri della P orta era no costr uit e, ma non ancora rivestite di piperno, né merlate ... Le mura della facciata su l m are .. . te m pora neamente escl u se dai lavori .. . [mentre quelle] delle a ltr e co rtin e erano sta te appe na ini z i ate . .. Per completare la fabbrica ... [si] dovevano demolire le torri e le mura che ancora es i steva no del vecchio castello angio in o. Da tutt o ciò appare c h iaro c h e la ri cos truzione fu progressiva: si demoliva e si ricostruiva per ord in e di parti " (21 >
Faci l e intuire il motivo di quel prudente incedere: non rinunciare mai del tutto all ' apporto difensivo del castello , segno che la s itua zione geostrategica, al di là dell'apparenza era tutt'a lt ro che tranquilla. Pres umibilmente nel 1456 i lavori dovevano essere prossimi alla conclusio ne , q uando un terribile terremoto li mise a seria prova, danneg g iando le mma in alcune sezioni. Ulteriori interve nti ed ulteriore indisponibilità piena della fortezza e quando, finalmente , la si poté considerare comp l e tata, a nche i I p recipuo cri terio ispiratore attinse il suo irreversibi l e esaurimento
L ' inad eguate zza, in fatt i , a lle nuo ve artiglierie, sia io fazione difensiva che offensiva, si palesò appena po chiss imi a nni dopo costiingendo già ag li ini zi del '500, a porvi in qu alche modo rimedi o . L' ultim o sovrano aragonese intrapr ese perciò , sotto la direzione cli A ntonio Marc hesi, l a costruzio n e di un a poderosa cerchia estern a che allo nta n asse la minacci a da quelle mura ormai tro pp o fragili. Il grande la voro proseguì sotto il v iceré Tol edo, con g li imm a n ca bili aggiornamenti . In dettaglio, la: " .. . nuo va cinta venne eretta lungo tutto il fossato e rinfor zata con quattro robusti torrioni ci lindri ci merlati che presero il no m e di torrione de l Molo, dell'Incoronata, del Santo Spirito e del Parco " 122>
Già d a ll a breve descrizione s i cogl ie la grave a rc a icità di que lle opere s in dal loro avvio, per c ui a ppare scarsamente probabile c he fossero s ta te così eseg uit e sotto il Tol edo. P iù verosimil e c re de re che prossime alla co nclu s ion e ve nn ero so lo ultimat e nei p1imi a nni del Toledo, che peraltro non tardò molto ad accorgersi della lor o gi ubil ata concez i one . Dal che a deciderne la riqualific az ion e trascorse un breve intervallo.
In un disegno redatto da Francisco de H ol landa ne l 1540, compare il castello già racchiuso in una cerchia munita di alme no un bastione. In d e tt aglio: ·• l'area
impegnata. di fonna trapezoidale , comprendeva circa sessa ntamila metri quadrati; su tre angoli furono, in principio, costru iti torrioni cilindr ic i, del tipo usato da Francesco di Giorgio , nelle rocche di San Leo e del Sasso di Montefeltro ... solo nell'angolo sudorientale venne innestato un gran de baluardo pentagonale , detto 'to rri o ne del Parco' e più ta rdi 'totTione di Santo Spirit o'. È probabile c he tal e inno vazione sia stata ispirata da una v is ita del M arches i a Civitavecchia, dove l ' architetto aveva preso visio ne delle mura di quella città, realizzate da Antonio da Sangallo co n baluardi pentagonali neg li angoli ... " (.!.•• .
Non può però escludersi, non fos se altro che per la permanenza dei nomi , ch e quel bastione. peraltro estre mam e nt e rozzo ed a ppro ssi mat o fosse il sostitut o di un precedente torrione cilindrico, ed ifi cato per potenziare il fronte a terra , altrimenti ancora troppo d ebo le ed antiquato . È co munqu e interessante osservare che nei rilievi redatti dal Genio Austriaco nel 1820-21, sono chiaramente riportate tutte le ga ll er ie sottostan ti la muratura del s udd et to bastion e : s i tratta quasi certa m e nt e dei primi cunicoli di co ntro -mina, sig nifi ca ti vamente adottati a poc hi m etri di distanza da dove qualche decennio innanzi era es plosa la prima mina.
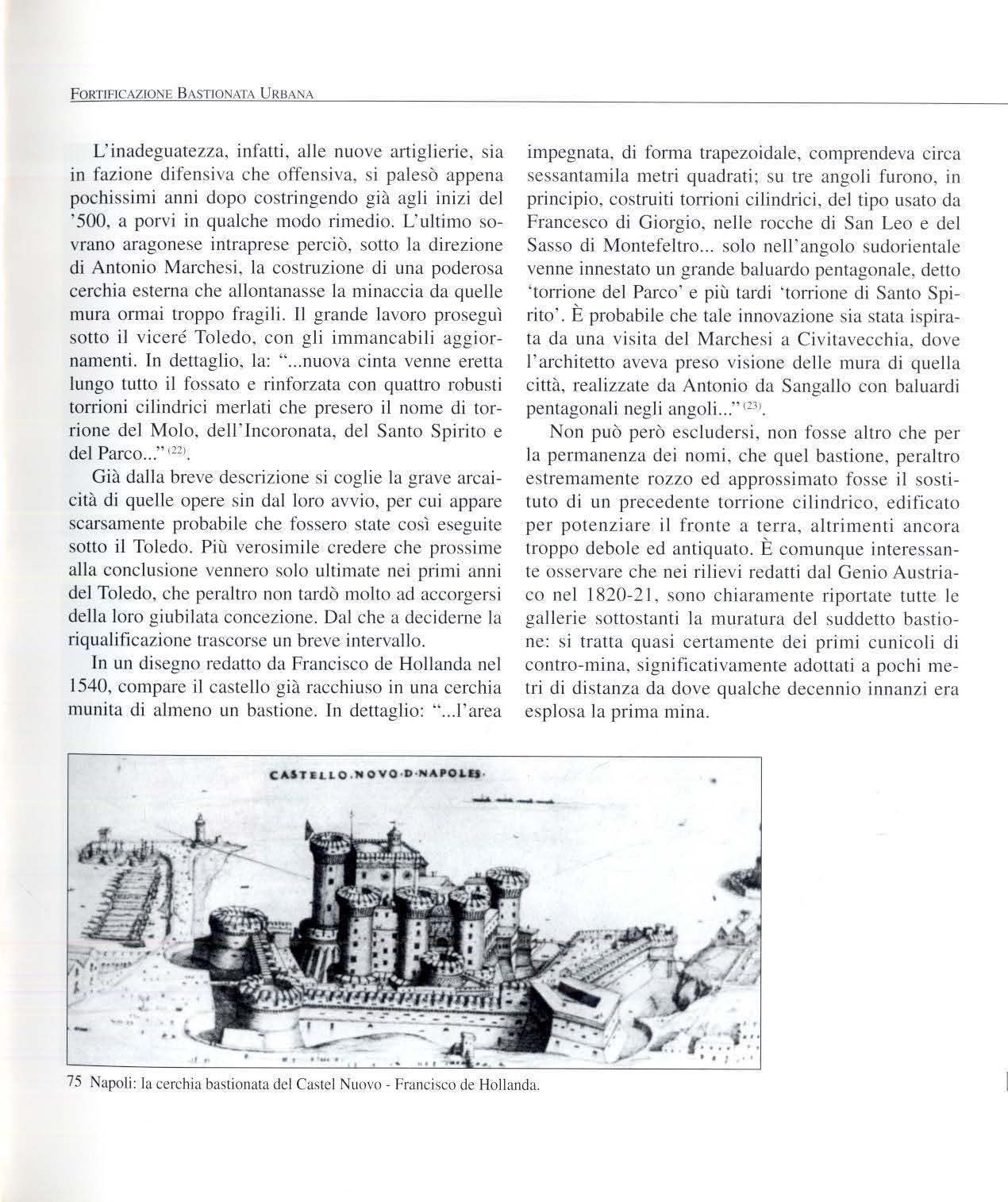 CAST U LO , NO YO •D •NAl'O LQ ,
75 Na poli: la ce rchia bas ti onata de l Castel Nuovo - Fra ncisco de Hollanda.
CAST U LO , NO YO •D •NAl'O LQ ,
75 Na poli: la ce rchia bas ti onata de l Castel Nuovo - Fra ncisco de Hollanda.
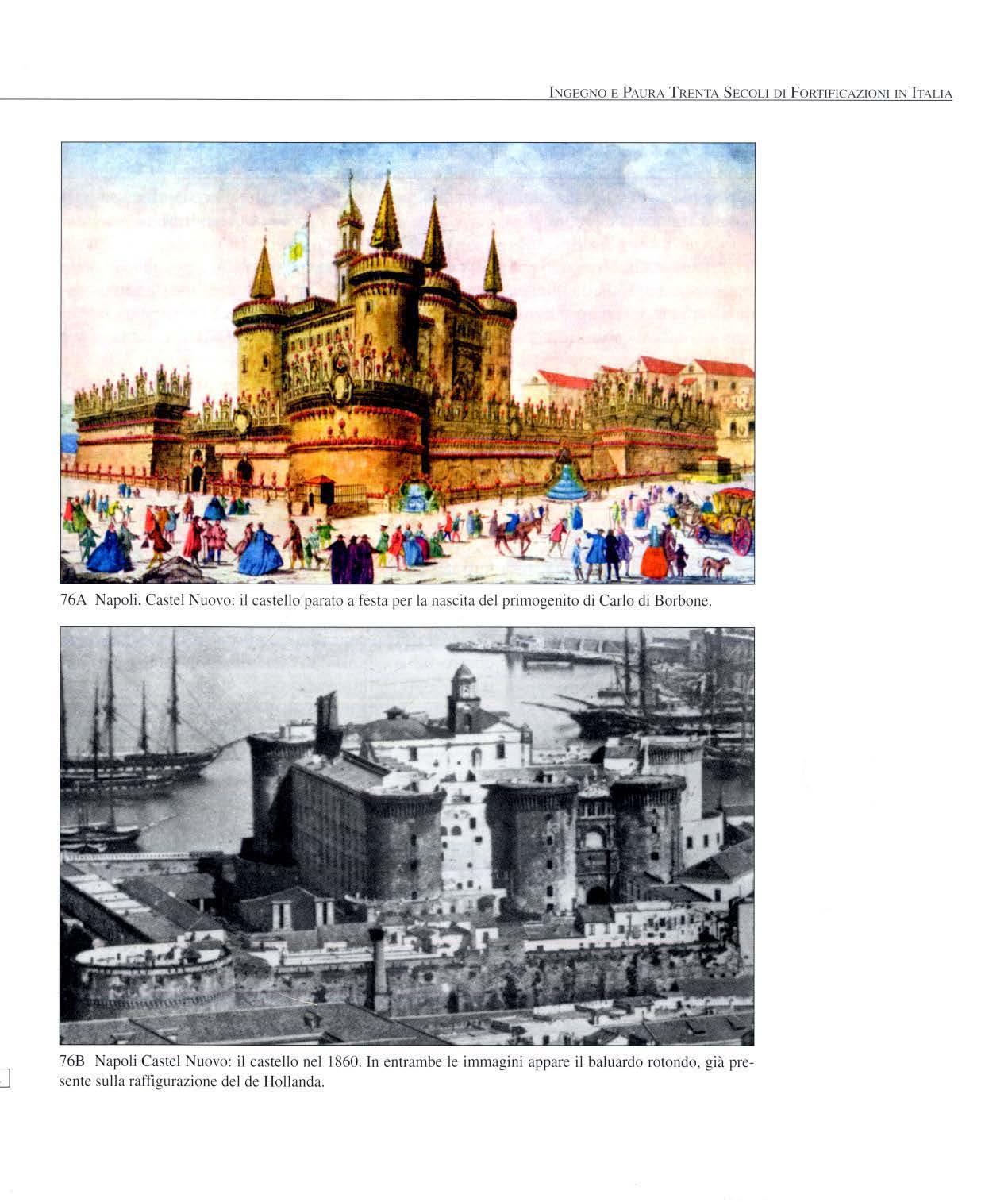
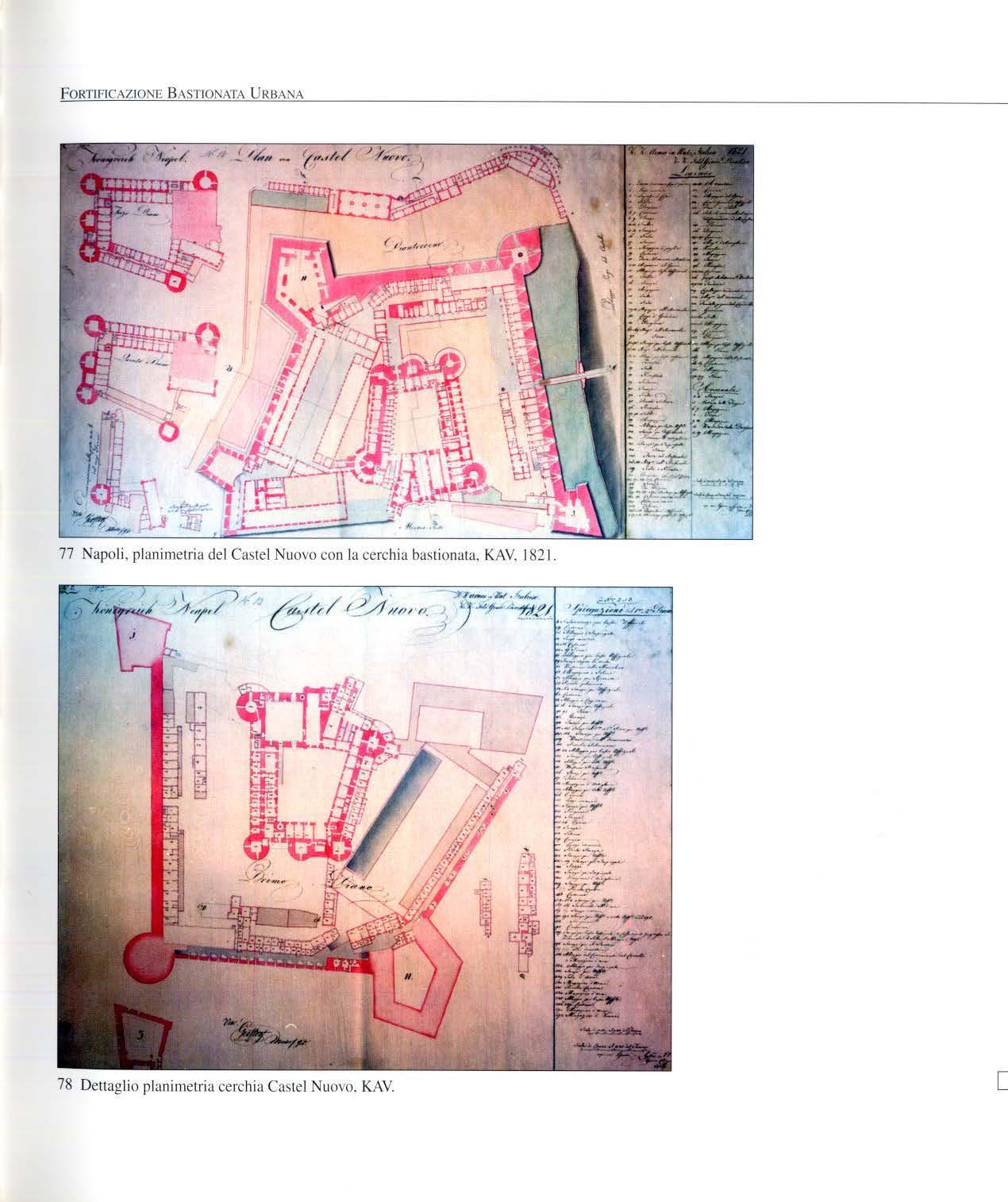 77 Napoli , plan imetria del Castel Nuovo con la cerch ia bas ti onata, KAY, 1821.
77 Napoli , plan imetria del Castel Nuovo con la cerch ia bas ti onata, KAY, 1821.
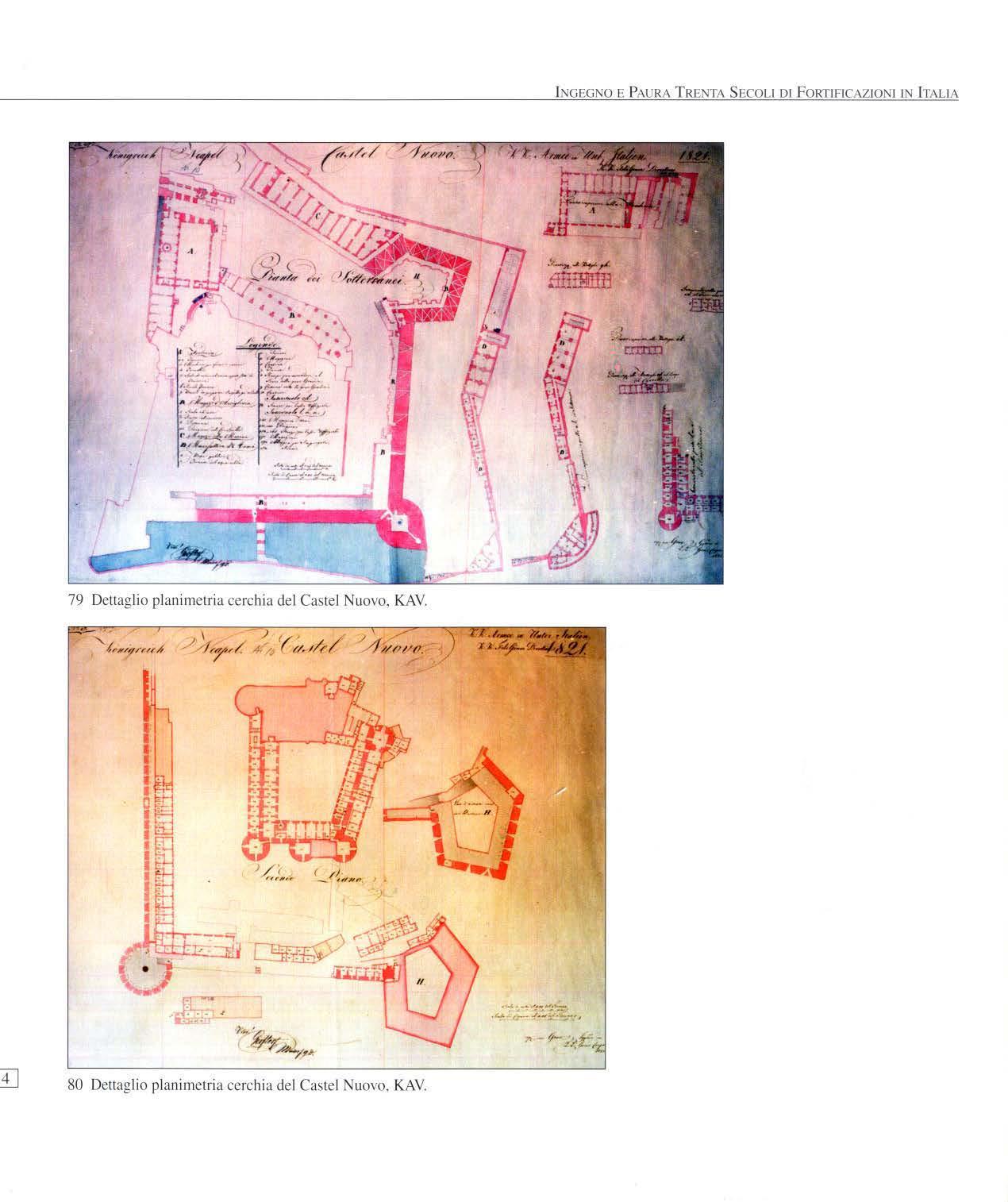

A quel punto pur essendo quanto visibile del castello angioino squisitamente aragonese, somigliando ad un maschio di medievale memoria finì per divenire nelle dicitura popolare il Maschio Angioino!
Come accennato la polarizzazione fondamentale della fortificazione cinquecentesca, e quindi bastionata, deve individuars i nell a strenua resistenza alla s pinta ottomana. E se le coste meridionali furono l 'es trema frontiera della cristianità occidentale, ogni abitato che non se ne discostava a sufficienza ne condivideva l'esposizione, indipendentemente dall e sue dimensioni , in particolare se lambito da un fiume. Lo scarsissimo pescaggio delle galere ed ancor di più delle fuste, battelli corsari per eccellenza ne consentiva la facile ri salita, trasformando il corso d'acqua in ideale via di penetrazione. Pertanto anche Roma finì per condividere tutti i rischi delle città riviera sc he, senza goderne i vantaggi, tanto più che riguardandosi come città santa della opposta religione ass ur se ad obiettivo primario dell'aggressività islamica.
Recepì tosi l' i neq ui vacabile preci pi tare della situaz ione anche la dirigenza pontificia dovette prodigarsi per l' aggiornamento delle fortificazioni della città, sia di quelle perimetrali che di quelle del Castello per antonomasia, l'antico mausoleo di Adriano, già riadattato con periodici cicli di interventi in massiccia cittadella.
P e r la verità, dal punto di vista difensivo, queHa sorta di gigantesco tamburo eccelleva soltanto come s truttura pa ss iva di incomparabile solidità, che per dirla con il Guglielmotti, quand'anche: " ... spog liato dai barbari e dal tempo dei s uoi ornamenti, restò duro e fermo testimonio del!' altrui rovina e della propria saldezza: non più ricettacolo di morti imperatori contro l 'oblio dei seco li , ma rifugio di viventi tapini contro la ferocia degli invasori ..." < 24 > _ Ma fu proprio per evitare che torna sse ad essere un ricettacoli di morti , o più
esattamente di moritmi, che la sua riqualificazione difensiva s'impose per l 'ennesima volta secondo le più avanzate concezioni.
Persino ad una superficia le indag ine poche costruzione di rilevante mole risultano tanto intrinsecamente incompatibili con i criteri architettonici che si erano andati progressivamente affermando nel corso del XV secolo, prodromici del fronte bastionato del mausoleo di Adriano, già castello medievale. La s ua vertiginosa altezza, circa m 60, non ammetteva alcuna ipotesi né di cimatura né, m eno che mai, di defila.tura con volumi e ma sse coprenti; la sua configurazione cilindrica non consentiva neppure una larvata parvenza di fiancheggiamento, per cui la campagna esterna s i proponeva al riguardo come un unico immen so angolo morto. E , fenomeno al limite dell'incredibile, finanche la difesa piombante di preistorica memoria, nonostante l'adozione d'un apparato a sporgere s u beccatelli trilobati ed archetti, non poteva esple tar s i isotropamente lungo l'intero diametro. L'antica base , infatti, non presentava l'indispensabile verticalità del!' estradosso, Iimite che detenninò l'innesto di vistose bertesche. In conclusione una sorta di collina artificiale il cui valore difensivo consisteva nell'indistruttibilità e nell 'a lt ezza, entrambe connotazioni spiccata mente passive.
Del re sto per l 'ambito cronologico al quale se ne fa rimontare l'iniziale adattamento da tomba a fortificazione, per la rozzezza dei tempi , garantiva esiti straordinari a quella sia pur infima protezione. La definitiva ristrutturazione in castello si ritiene avvenuta all'inizio del VI secolo, tesi confortata da alquante fonti che citano un Castello di Adriano. Per cui: " ... quando il teatro di Marcello, e il sepolcro di Cecilia, e l ' anfiteatro Flavio, e gli altri più sald i monumenti dell 'a ntichità metteansi in fortezza, allora pure i I mau so leo di Adriano diveniva castello: Romani e Goti , Alberigo e Crescenz io, Ghibellini e Guelfi, tutti facevan capo a quel propugnacolo dove senza troppo di spe ndio trovavano s icurezza ..." <25 > .
La comparsa delle bombarde ed il potenziarsi del loro tiro pose termine a quella fase protrattas i per oltre
 INGEGNO E PA URA TRENTA SECOLI DI FORTIFI CAZIONI I N JTALIA
INGEGNO E PA URA TRENTA SECOLI DI FORTIFI CAZIONI I N JTALIA
sette secoli, imponendo i primi radicali interventi miranti ad allontanare il più possibile l'offesa ed al contempo a fornire un perimetro fortificato dal quale sostenere una difesa attiva non esclusivamente ficcante.
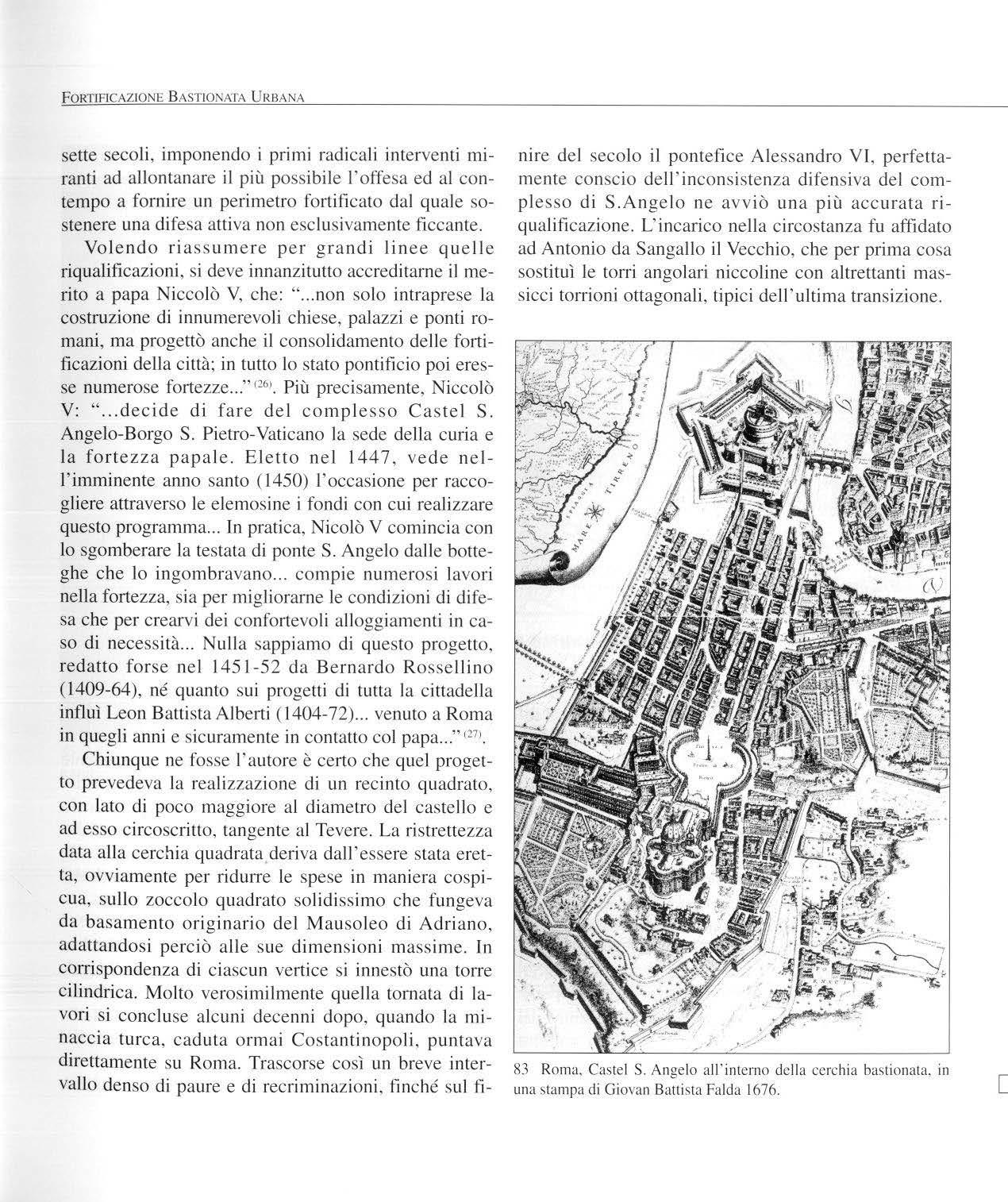
Volendo riassumere per grandi linee quelle riqualificazioni, si deve innanzitutto accreditarne il merito a papa Niccolò V, che: " non solo intraprese la costruzione di innumerevoli chiese, palazzi e ponti romani, ma progettò anche il consolidamento delle fortificazioni della città; in tutto lo stato pontificio poi eresse numerose fortezze ..." 126> Più precisamente, Niccolò V: " ... decide di fare del complesso Castel S. Angelo-Borgo S. Pietro-Vaticano la sede della curia e la fortezza papale. Eletto nel 1447, vede nell'imminente anno santo (1450) l'occasione per raccogliere attraverso le elemosine i fondi con cui realizzare questo programma... In pratica, Nicolò V comincia con lo sgomberare la testata di ponte S. Angelo dalle botteg h e che lo ingombravano ... compie numerosi lavori nella fortezza, s ia per migliorarne le condizioni di difesa che per crearvi dei confo11evoli alloggiamenti in caso di necessità ... Nulla sappiamo di questo progetto, redatto forse nel 1451-52 da Bernardo Rosse I I i no (1409-64), né quanto sui progetti di tutta la cittadella influì L eon Battista Al berti (1404- 72) ... venuto a Roma in quegli ann i e sicuramente in contatto col papa " c27J _ Chiunque ne fosse l'autore è certo che quel progetto prevedeva la reali zzazione di un recinto quadrato, con l ato di poco maggiore al diamelro del castello e ad esso c ircoscritto, tangente al Tevere. La ristrettezza data alla cerchia quadrata deriva dall'e sse re stata eretta, ovviamente per ridune le spese in maniera cospicua, sullo zoccolo quadrato solidissimo che fungeva da basamento or i ginario del Mausoleo di Adr i ano, adattandos i perciò alle sue dimensioni massime. In corrispondenza di ciascun vertice si innestò una torre cilindrica. Molto verosimilmente quella tornata di lavori si conc lu se alcuni decenni dopo, quando la minaccia turca, caduta ormai Costantinopoli, puntava direttamente su Roma. Trascorse così un breve intervallo denso di paure e di recriminazioni, finché su l fi-
nire del secolo il pontefice Alessandro VT, perfettamente conscio dell'inconsistenza difen s iva del complesso di S.Angelo ne avviò una più accurata riqualificazione. L'incarico nella circostanza fu affidato ad Antonio da Sangallo il Vecchio , che per prima cosa sostituì le torri angolari niccoline con altrettanti massicci torrioni ottagonali, tipici dell'ultima transizione.
fORTIFICAZIONE B AST IO NATA URBANAAncora una volta l'impianto architettonico poco felice deve attribuirsi alta scarsa competenza de ll a dirigenza pontificia, che probabilmente dovette imporre al prestigioso ingegnere militare una soluzione di compromesso piuttosto che l'innesto di quattro bastioni del tipo di quelli di Nettuno. Giustamente osserva i l Guglielmotti che: " ... se bene la giunta dei baluardi a cantoni ottagoni già sufficientemente dimo s tri la novità ed il progresso dell'arte , nondimeno ad un papa come Alessandro ... e ad uno architetto come Antonio da Sangallo , non dovevano parer s ufficienti le angustie della seconda cinta, senza le larghezze della terza. Di ciò lo stesso Architetto ne faceva fede perché non osava mettere gli ottagoni all'estremo, ma so lo dentro dei recinti primari. Dunque intendeva alla terza cinta: e aveva g ià in punto il disegno sopra grande e bello pentagono bastionato " < 28 l
Le tragiche vicende storiche che seguirono, culminate per Roma con il s uo terribile 'sacco', provocarono una battuta d 'aITesto a tutti i lavori, ma ss imamente a quelli deile fortificazioni che notoriamente richiedevano finanziamenti colossali. Quando si superò lo stallo fu necessa1io, e sempre sotto l'incubo turco, dare la precedenza alla riqualifica z ione della cerchia della città e so l o dopo l'inizio della seconda metà del XV I secolo quel grandioso progetto del Sangallo potette trovare finalmente attuazione.
Infatti: " ... non potevano allora essere dimenticati in Roma i modelli del Cas triotto , né i disegni del Sangallo: certamente esisteva l'e sem plare in Civitacastellana alla vista di chiunque avesse voluto bastionare sulla figura ciel pentagono. Perciò senza nes s uno stento , e nel brevissimo giro di quindici giorni. la terza cinta di cas tello in pentagono regolare , cordeggiata da Camillo,
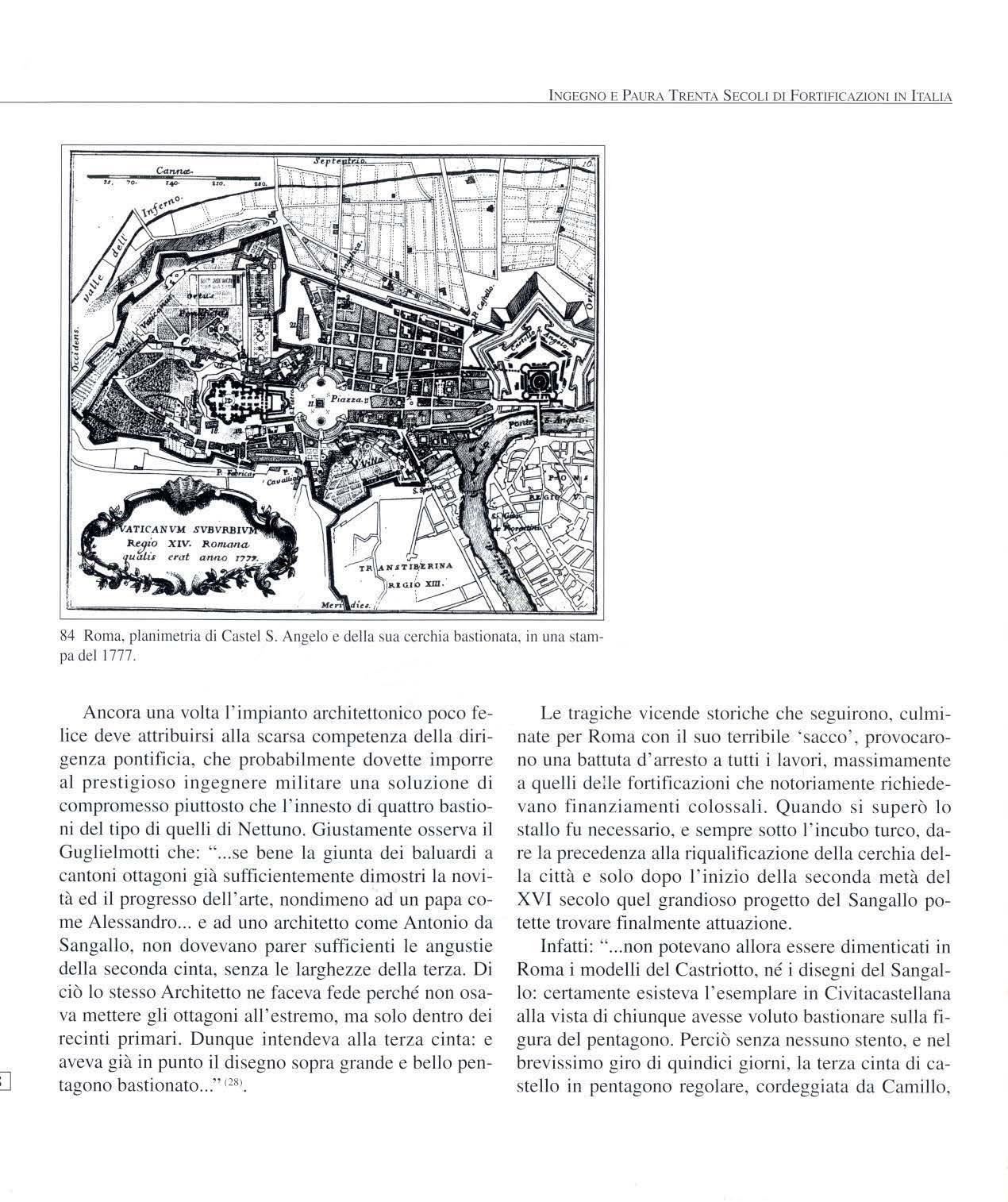
85 Affreschi del Palaz zo Vaticano: la cerchia bastionata del Vaticano e sullo sfondo quella di Castel S. Angelo.
sul terreno, venne levata s u da Latino Orsini suo figliuolo. Opera campale di fascina e terra, so pra ampia spianata all'intorno, e so mmamente acconcia ai lavori della zappa, per essere sedimento di alluvione fino al letto del Tevere ..." (29)
Un ' ultima annotazione s i impone: i lavori della cerchia bastionata descritti dal Gughelmotti di terra e fascine, cioè di tipo campale, in realtà non erano affatto tali o almeno non sarebbero restati indefinitamente con tale connotazione. Se mai quella era la procedura canonica per realizzarli , poiché le masse di terra tratte dai fossati. approssimatamente sagomate in forma di
bastioni e trattenute mediante fascine e legname, operazione tecnicamente definita all'epoca 'imbastitura', costituiva l'inevitabile prima fase di costruzione del bastione stesso. L ' edificazione della sua camicia muraria, infatti, poteva effettuarsi so ltanto dopo un determinato periodo di tempo durante il quale il rilevato si assestava definitivamente, dal momento che la stessa non aveva la so lidità di un muro di contenimento, capace quindi di neutraliz zare eventuali sp int e del terreno.
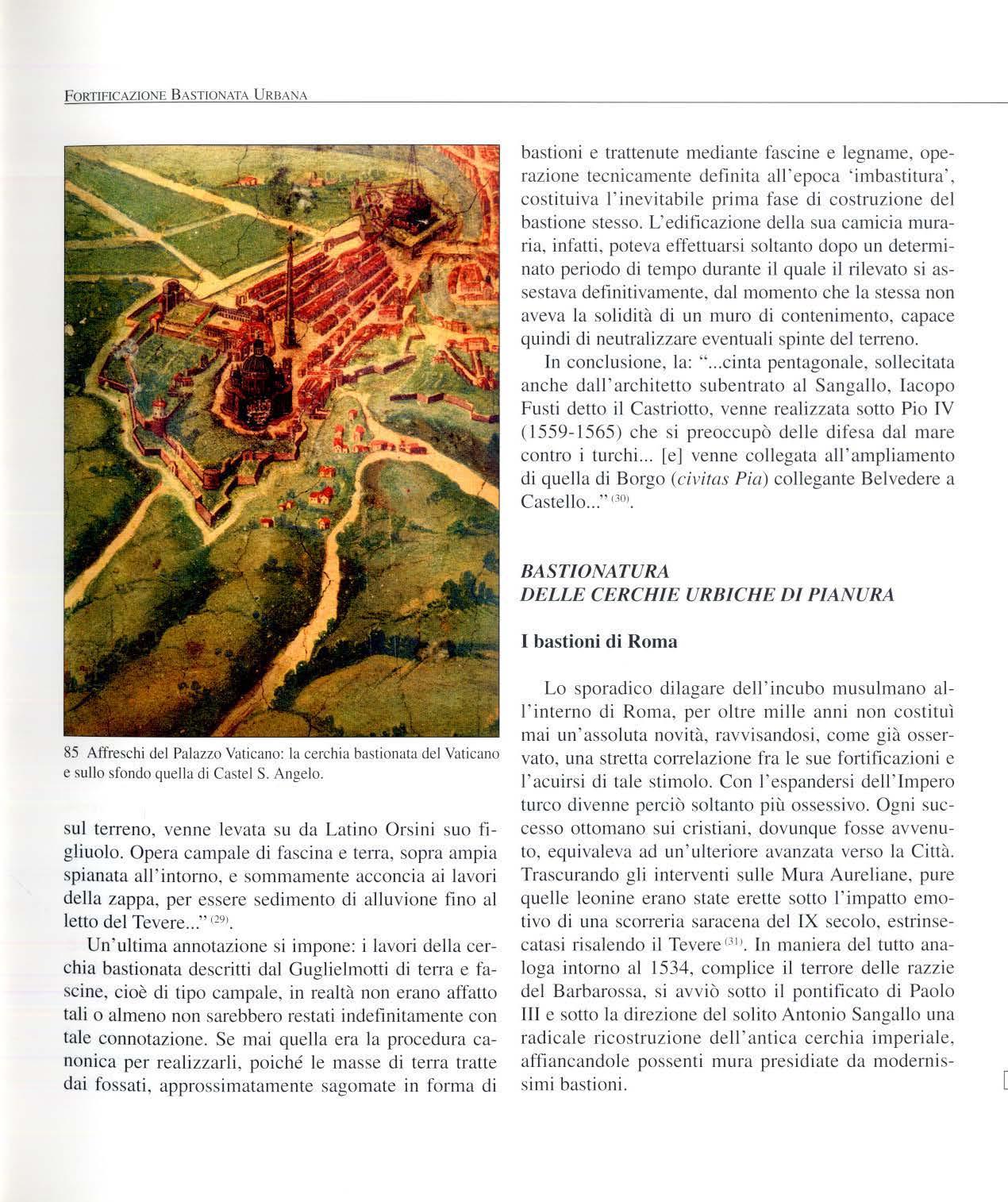
In conclusione, la: " ... cinta pentagonale, sollecitata anche dall'architetto s ubentrato al Sangallo, Iacopo Fusti detto il Castriotto, venne realizzata sotto Pio IV (1559-1565) che s i preoccupò delle difesa dal mare contro i turchi [e] venne collegata all'ampliamento di quella di Borgo (civitas Pia) collegante Belvedere a Castello " uo) _
Lo sporadico dilagare dell'incubo musulmano al1' intemo cli Roma , per oltre mille anni non costituì mai un 'asso luta novità, ravvisandosi, come già osservato, una stret ta correlazione fra le sue fortificazioni e l'acuirsi di tale stimolo. Con l'espandersi dell'Impero turco divenne perciò so ltanto più ossessivo. Ogni s uccesso ottomano sui cristiani, dovunque fosse avvenuto, equivaleva ad un 'u lt eriore avanzata verso la Città. Trascurando gli interventi su lJ e Mura Aureliane, pure quelle leonine erano state erette sotto l ' impatto emotivo di una scorreria saracena del JX secolo, estrinsecatasi ti salendo il Tevere 131 ) In maniera del tutto analoga intorno al 1534 , complice il terrore delle razzie ciel Barbarossa, si avviò sotto il pontificato di Paolo fil e sotto l a direzione del so lito Antonio Sangallo una radicale ricostruzione del!' antica cerchia imperiale, affiancandole possenti mura presidiate da modernissi mi bastioni.
Il criterio in formatore della grandiosa opera può sintetizzarsi nel voler, ad un tempo , dim ezza re il perimet ro difensivo della giubilata, ma non fatiscente murazione di Aureliano 1321, includendo però a l I' interno del moderno tracciato le vivaci realtà urbane aggregatesi tumultuosamente all'esterno del medievale bor-
go. 1 12 secoli ed i 18 km della g lorio sa fortificazione romana erano ormai e ntrambi troppi per dispen sa re un minimo di s icurezza ai cittadini e per suscitare un minimo di di ss ua s ione ad un eventuale aggressore. Ad ogni buon conto la nuova realtà s ociale non forniva uomini s ufficienti per un circuito tanto lungo , né le ri-
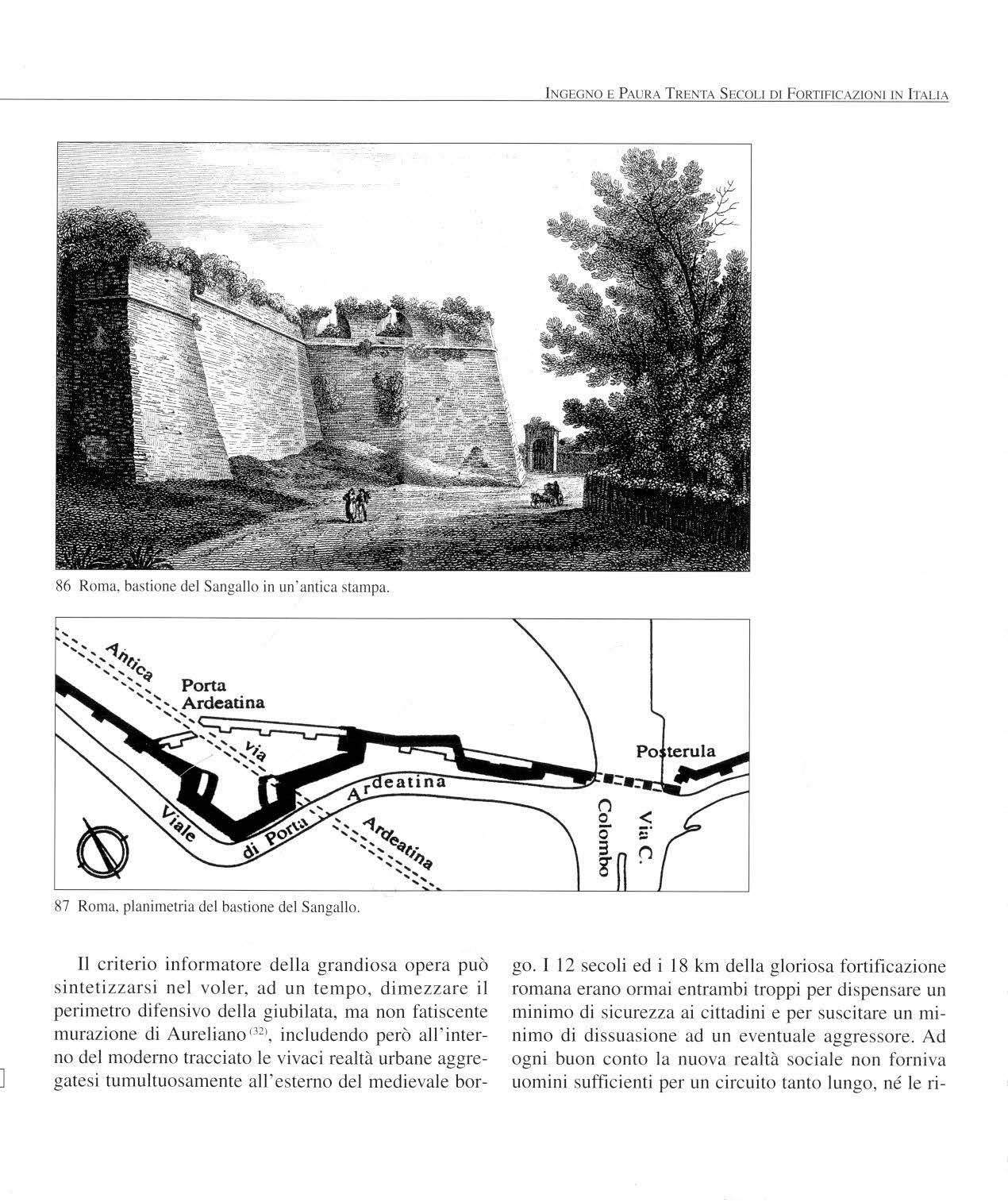
s or se economiche ne consentivano un congruo armam e nto balistico: troppi po c hi g li uni e tropp e poche le altre. La o nniprese nza de ll e artig li er ie, impon endo un debito conto della loro az ion e difensiva e so prattutto offensiva consentiva, e d a l contempo obbligava, ad una sensibi le decurtazione: unica permanenza Castel Sant' Angelo, peraltro in un a rinnovata veste arch ite ttonica.
Al pari delle molte c itt à che s ubiron o into rno alla m e tà del '500 l 'aggiornamento delle fo rtifi cazioni perimetrali , anche per Roma il prin c ipal e problema da s up erar e co n sis te tte ne l neu trali zzare la s ua grav issima soggez ion e tattica alle colline circostan ti . Una fa -
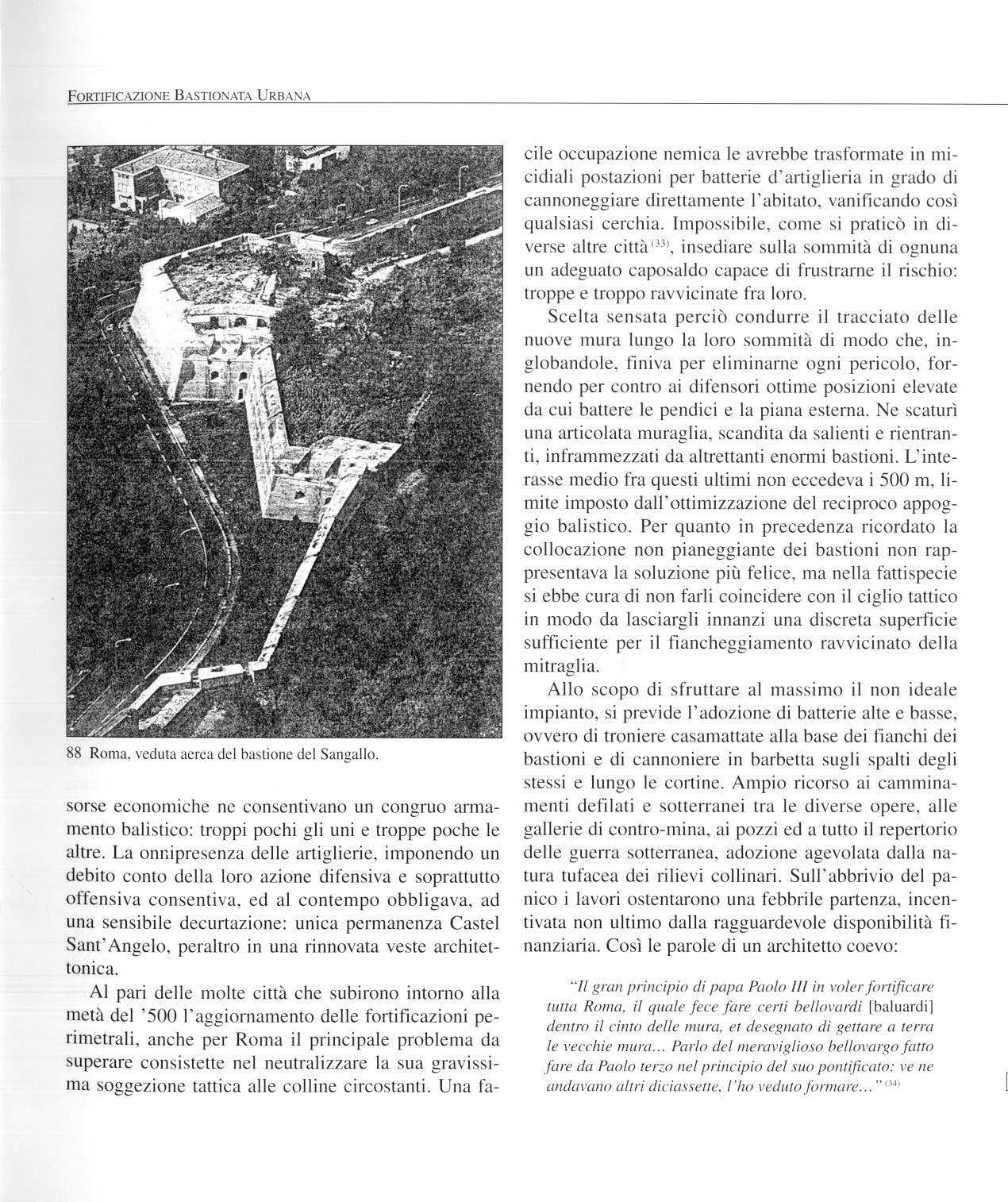
cile occupaz ione nemica le avrebbe trasformate in micidiali postazioni per batterie d'artiglieria in grado di cannoneggiare direttamente l'abitato, va nifi cando così qualsiasi cerc hi a. Imp ossib il e, come si praticò in diverse alt re c itt à m, , insediare sulla sommità d i ognuna un adeguato caposaldo capace di frustrarne il rischio: troppe e troppo ravv ic in a te fra l oro.
Scelta se n sata perciò condurre il tracciato delle nuove mura lungo l a loro sommità di modo che, inglobando l e, finiva per el iminarn e og ni pericolo, fornendo pe r contro ai difensori ottime posizioni e levate da cui battere le pendici e la piana esterna . Ne scaturì una articolata muraglia , sca ndita da salienti e rientranti, inframm ezza ti da altrettanti enormi bastioni. L'in terasse medio fra questi ultimi non eccedeva i 500 m , limite imposto dall 'o ttimizzazione de l reciproco appogg i o balistico. Per quanto in precedenza ricordato la collocazione non pianeggiante dei bastioni non rappresentava la so lu zione più felice , ma nella fattispecie s i ebbe cura di non farli coincidere con il ciglio tattico in modo da lasciargli innanzi una d iscreta s up e rfi c ie sufficiente per il fiancheggiamento ravvicinato della mitr ag lia.
Allo scopo di sfrutta r e a l massimo il non ideale impianto, s i p rev id e l 'adoz i o ne di batterie alte e basse, ovvero di troniere casamattate a ll a base dei fianchi dei bastioni e di ca nnoni ere in barbetta s ugl i spa lti degli stess i e lun go le cortine. Ampio ricorso ai camminame nti defi l ati e sotterranei tra le diverse opere, alle gallerie di co ntro-min a, ai pozzi e d a tutt o il repertorio dell e g uerra sotte rran ea, adozione agevolata dalla natura tuface a d e i ri lievi collinari. Sull ' abbrivio del panico i lavo ri ostentarono una feb bril e part e nza, inc e ntivata no n ultimo d a lla ragguardevole disponibilità finan ziaria. Così l e p aro l e di un a r c hitetto coevo:
·'!{ gran principio di papa Paolo Ili in voler.fortificare tu/fa Roma, il quale fece fare certi hello vard i (ba l uardìl dentro il cinto delle mura, et desegnato di gettare a terra le vecchie mura Parlo del meraviglioso bellovargo fatto fare da Paolo terzo nel principio del suo polltificato: ve ne andavano altri diciassette l'ho veduto.formare " ' 14 1
Diciotto bastioni su dodici km dì cerchia, per giunta con andamento altimetricamente variabile, costituivano un'impre sa non so lo tec ni camente improba, ma economicamente ciclopica. Ed infatti l'ultimazione del primo bastione notificò con il s uo esorbitante costo, anc h e ai meno qualificati e preparati, quella sco nfortante realtà, s pegnendo ogni facile entusiasmo. P er cui: ·'... fu fatto del 1534 ... quel famosissimo baluardo in Roma, con fianchi doppi, e piazze alte e basse, e contromine, e casematte, e pozzi, di tanto smisurata grandezza et grossezza del muro, che costò infinito tesoro .'' <3si _
La percezione inconfutabile del salasso patrimoniale prodotto da q uell'unico elemento innescò le prime incertezze sulla effettiva potenzialità di condurre a t e rmine, in tempi ravvicinati, l'intera costruzione. Incertezze ancora maggio1i però, sulla loro reale necessità , le istigò la gloriosa ed inattesa conquista di Tuni si
compiuta da Carlo V nel 1535. L a concomitanza delle due rifle ss ioni determinò un rapido rallentamento e quindi l'an-esto dei lavori. Si gi un se così al 1541 ed alla disgraziati ss ima spediz ione di Algeri, nel corso della qua le le fo r ze anfibie spagno le ed alleate s ubiron o una allucinante disfatta. A R oma, poche se ttimane dopo , n ell'angoscia genera le si tornò immediatamente a riattivare gli ormai abbandonati cantieri . Nuovi bastioni si innalzarono seguendo tuttavia minuziosamente i precetti del Sa n ga ll o, per cui in concreto:
·'... nel J 543 ebbero inizio i lavori per la fortificazione della città leonina e l 'anno s uccessivo v'erano costruiti i baluardi e le mura che dal monte di S. Spi1ito , propaggine nord del Gianicolo , s i protendevano verso il Te vere ... " <36 l In modo asso lut amente id entico al '35. l' avanzamento dei lavori produsse da un lato una veloce ridu z ione della paura e dall 'altro una a ltrettanto veloce riduzione dei fond i. I primi s int omi del conte-

stuale scadimento cli interesse si colgono già ne11 ·anno s uccessivo, tanto che per alcuni attenti studiosi l'intera opera s ubì una nuova battuta di arresto, per cui: " .. .il progetto di cingere Roma con una cerchia di diciotto possenti ba s tioni fu abbandonato nel 1542 quando si accertò che la costruzione di un so lo bastione era costata 44.000 ducati " (37 )
I n realtà i lavori continuarono, sebbene con un 1itmo notevolmente stentato e singhiozzante, almeno fino al 1544 quando la tentata conquista di Civitavecchia, da parte di una poderosa flotta turco-barbaresca agli ordini del Barbarossa, provocò una nuova ondata d i panico ed il conseguente riattivarsi dei cantie1i. La base navale pontificia grazie alle s ue fortificazioni riuscì a resistere evitando lo scemp io , non così però le località vicine ed in particolare l'isola del Giglio. L e terribili notizi e delle atrocità e delle deva staz ioni perpetrate dalle orde ottomane agirono da sferza sulla dirigenza romana per recuperare il tempo perduto. E
quando finalmente nessun ostacolo burocratico od economico ostacolò l'impre sa, un in ed ito motivo di perplessità si interpose contribuendo a sua volta ad un ulteriore incepparsi dei lavori. Per molti aspetti fu ancora più paralizzante dei precedenti, mettendo in discuss ione proprio l'affidabilità di quelle fortificazioni tanto complesse e costose.
La grandiosità della fortificazione perimetrale di Roma ed i I s uo elaboratissimo tracciato si prestavano egregiamente a fomentare interminabili disquisizioni tecniche, alle spa lle dell e quali sì intuivano, oltre ad una malcelata ostilità verso il progettista, anche larvate accuse di sperpero di d e naro. A dar manforte ai detrattori contribuì, da un certo momento in poi lo stesso Michelangelo, che re se la diatriba di una asprezza paralizzante. Tant' è che dis so ltasi altrettanto rapidamente di come era esplosa la paura turca, non s i dissolse affatto la controversia degli architetti. Assottigliandosi di g iorno in g iorno la disponibilità

econom ica, nell'autunno del 1545 si sospesero nuovamente i lavori. Poco meno di un anno dopo, il 29 settembre del 1546 moriva il Sangallo (38 > , ponendo termine con la sua scomparsa ad ogni controversia Michelangelo, come facilmente prevedibi1e, g li subentrò, ma restò alla guida della fortificazione pochissimo, poiché già nel 1548 se ne dimise per dedicarsi, senza alcun impaccio, a ll a sua più congenia le professione artist ica. T rascorse un altro anno e nel novembre del 1549 scomparve anche P ao l o III che tanto impulso aveva impresso al l a difesa della città ed alla fortificazione dello stato pontificio. Per i cantieri significò l'arresto assoluto, stasi protrattasi quasi per una dozzina d'anni.
È certamente vero che nel corso di quel lungo intervallo non mancarono i motivi di preoccupazione per l'ennesimo aggravarsi della pressione ottomana e per le incessanti azioni corsare barbaresche. Ma la presenza di una flotta costantemente impegnata in crociere di polizia navale, suscitando se non altro una pa r venza di dissuasione nei piccoli predatori, alleviava le conseguenze. Disgraziatamente, proprio per i suoi reiterati successi, quel modesto rimedio finì per essere ri gua rdat o come un efficace strumento militare suscettibile di impiego offensivo: e fu la tragedia delle Gerbe <39i _
In perfetta continuità con quanto evidenziato nell'immediato passato, il sopraggiungere delle funeste notizie della disfatta stroncò improvvisamente l 'imbelle letargo. Pur osservandosi la riproposizione pedissequa della farsesca tradizione, il contesto di quest'ultima ondata di tenore non trovò neppure a ll ora puntuali analogie con i precedenti. L a protezione della squadra della guardia non esisteva più, né era lecito sperare negli aiuti militari degli alleati, dovendo ciascuno provvedere urgentemente alla propria difesa, senza ulteriori indu gi e senza poter stornare uomini e mezzi. I quasi dodici anni di asso lut a inattività vennero nel breve volgere di pochi giorni completamente dimenticati ed una travolgente fase di frenetica attiv ità si abbatté sulle abbandonate fortificazioni.

L'8 maggio del 1561, con la solennità e la pompa
riservata alle cerimonie particolarmente solenni e s ignificative , papa Pio IV pone la prima pietra della nuova tratta di fortificazione perimetrale, sotto la guida di quel Francesco Laparelli. L'anno dopo lo stesso pontefice: " ...decide di completare la cerchia di nuove mura costruite da Paolo IJ I e che aveva recinto il Vaticano lungo tutti i lati collinosi; nella pianura tra il cortile del Belvedere e Castel S. Angelo la difesa rimaneva costituita dal vecchio muro sotto al corridore di Alessand ro VI.
È qui che Pio IV fa costruire una nuova muraglia più esterna completata da un fossato in cuì vengono convogliate le acque della valle dell'Inferno; contemporaneamente, anche ì bastioni esterni di Castel S. Angelo, e quasi certamente le recenti mura dì Paolo III, so n o oggetto di lavori di rinforzo e di miglioramento. Sì tratta dì una muraglia dritta con un dente nella parte centrale e due porte in corrispondenza delle analoghe nel co1Tidore ... Lo spazio compreso tra le due mura è più grande di tutto il vecchio Borgo e , fino al 1562, c'erano soltanto l a fonderia dei cannoni e le due piccole chiese di S. Egidio e di S . Anna; contemporaneamente alle nuove mura viene tracciato un piano di lottizzazione di questo enorme spazio - il più grande finora messo a disposizione per un ampliamento a Roma - ad opera dello stesso Laparelli. L'area più vicina a l Vatica n o è lasciata libera... serviva da campo di esercitazioni. La restante parte fino all'esterno dei fossati di Castel S. Angelo è destinata alle costruz ioni: una strada, chiamata Borgo Pio, viene tracciata sulla direttrice dell'ingresso al cortile del Belvedere ...
Sette strade parallele dividono l'area tra il corridore e le nuove mura ... Borgo Pio segnava l ' inizio di un nuovo quartiere radicalme nt e concepito come ta l e, ben diverso dalle aree concesse agli illirici e ai lombardi a Rip etta o di quelle ancor più gener icamente avviate a edificazione a S. Maria Maggiore. Ma in quel momento no n v i era più a Roma un ' affluenza organizzata per nazioni o spinta da difficoltà internazionali: il nuovo quartiere stentò a forma rsi malgrado le consuete facilitazioni promesse dal pontefice ..." , 4oi .
l:-J GEGNO E PA URA TRE NTA S ECOLI DI FORTIFIC A ZIONI IN ITALIA
I tisultati di tanti lavori e potenziamenti e di altri ancora, compiuti nel corso del secolo successivo, in partico lare intorno al 1642, non valsero ad eliminare le originarie deficienze della cerchia bastionata di Roma. Agli inizi del '700 così relazionavano, infatti , i generai i pontifici circa la s ua valenza militare: " ... Quanto alla difesa, pare che gli offiziali di Guerra sieno di sentimenti che le muraglie di Roma non siano presentemente capaci di difesa così per il longo giro come per le debolezze di esse per la maggior parte, e per non essere iso late ma occupate da giardini, vigne et a ltro , et anche per il poco numero di so ldatesche, e queste poco espe rte, e m ale armate e non meno per la mancanza delle vettovaglie nece ssa rie, et i l far re sistenza i n tale stato di cose (qua ndo non potesse servire per ottenere qualche capito l azione vantaggiosa che non è verisimile perché li Generali alemanni saranno bene informati dello stato de ll a Città) darebbero
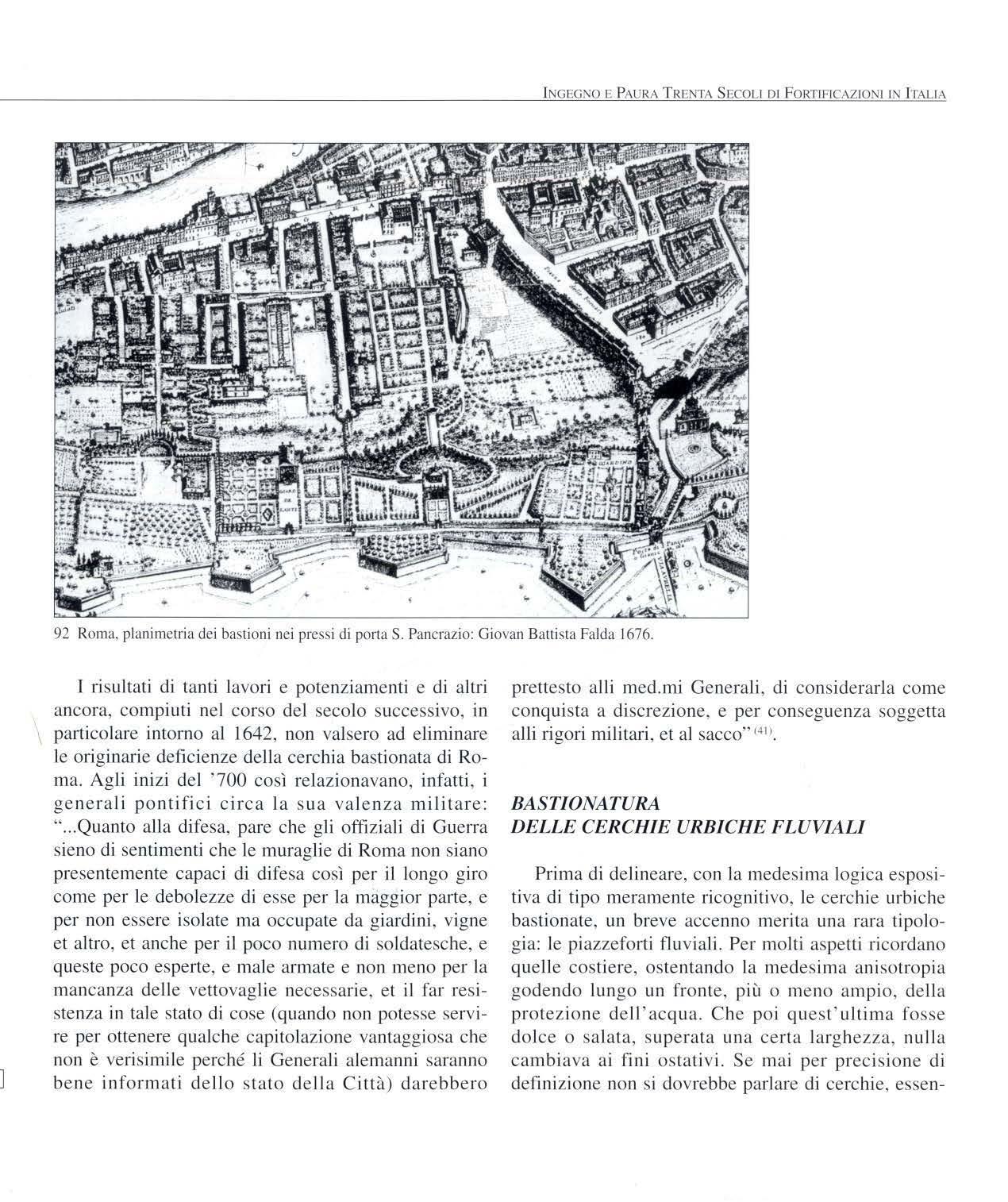
prettesto alli med.mi Generali , di considerarla come conquista a discrezione. e per conseguenza sogge tta aJli rigori militari, et al sacco" 14 n.
Prima di del i neare, con la medesima logica espositiva di tipo meramente ricognitivo , le cerchie urbiche basti onate. un breve accen no mer i ta una rara tipologia: le piazzeforti fluviali. Per molti aspetti ricordano quelle costiere, ostentando la medesima anisotropia godendo lungo un fronte, più o meno ampio, della protezione dell'acqua. Che poi que s t ' ultima fosse dolce o salata, s uperata una certa larghezza , nulla cambiava ai fini ostativi. Se mai per preci sione di definizione non si dovrebbe par.lare di cerchie, essen-
do dei semplici archi , compresi fra i 90° ed i 180 ° , con gli estremi sulla sponda. Tra gli esempi certamente più significativi e per il molo storico sostenuto fino all ' Unità d'Italia e per la limitatissima ampiezza angolare all'interno di un ' ansa del Voi turno e per l'essere stata sin dalla progettazione strettamente connessa con il forte di Carlo V. già descritto nel precedente capitolo, la cerchia di Capua.
La città di Capua fu eretta sui resti dell'antica Casilinum, che a sua volta sostituì un remotissimo ab i tato italico la cui origine si perde nella notte dei temp.i < 42 > Il fattore che rendeva quel particolarissimo sito ambito persino nella preistoria, deve individuarsi ne ll a protezio ne e l argitagli dal] ' ansa del fiume, una
sorta di ampio fossato allagato che finiva per circondare per quasi due lerzi tanto l'arcaico in sediamento quanto la moderna città < 4 3i _ Facile perciò , realizzando uno sbarramento dì raccordo fra le opposte sponde del corso d ' acqua distanti pochi centinaia di metri, ottenere uno sbarramento di ri levante i nviolabilìtà. Nel corso dei secoli siffatta concezione fortìficatoria rimase in s ostanza priva di alternative migliori. Ovvio, pure che l'idea di condurre una cerchia bastionata s econdo quel medesimo criterio fosse pienamente matura intorno alla metà del XVI secolo.
Sin dal 1495 , infatti, si tentava di ridtme la tragica esposizione di Capua dopo la sua pronta re sa all'armata di Carlo VI II Qualcosa in merito venne finanche realizzata, log icamente secondo i canoni della tran s iz ione, ma quando la sera del 23 marzo del 1536 l'imperatore Carlo V giunse in visita ufficiale nella città, dove si trattenne per tutto il giorno success ivo , 1'irrile-
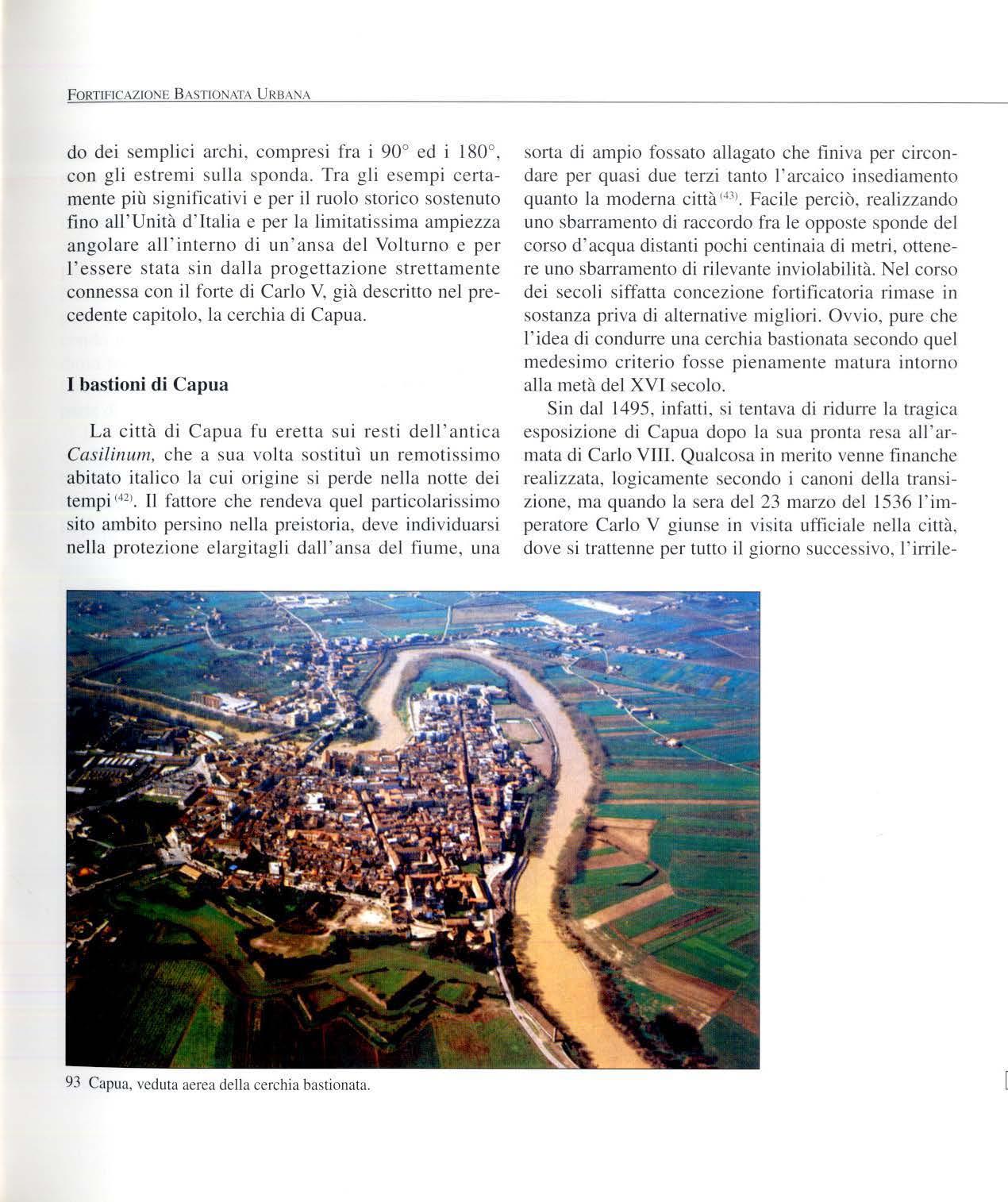
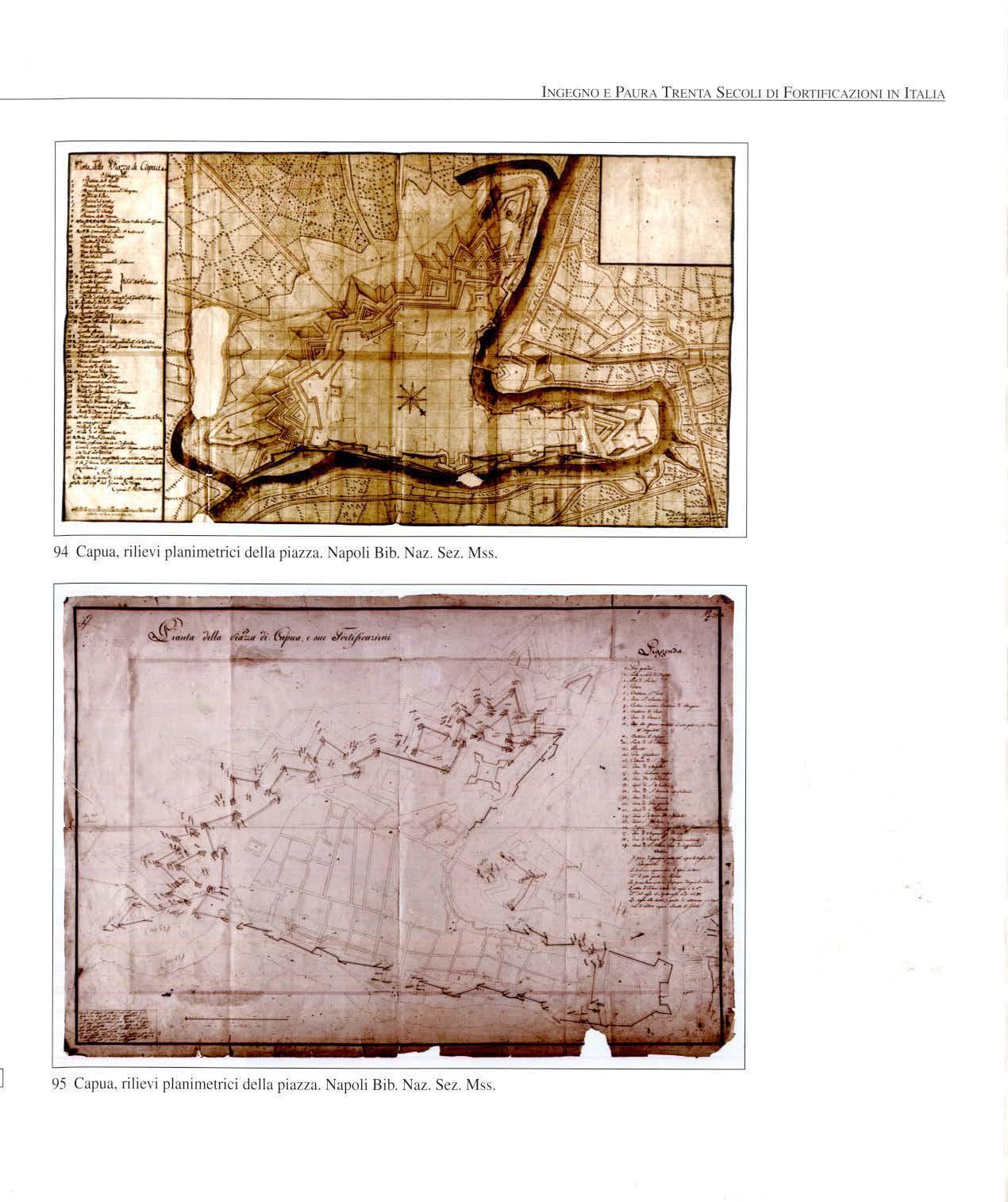
vanza delle sue difese si impose senza alcuna attenuante. Il sovrano. ripartito alla volta di Roma dove arrivò il 5 ap1ile, non mancò in seguito di sollecitarne il potenziamento che richiese però una lunga gestazione amministrativa, da relazionarsi probabilmente al già gravoso onere imposto dalla costruzione del forte. Nessuna meraviglia pertanto che i lavori della cerchia potettero avviarsi solo dopo la sua ultimazione. Secondo molti studiosi, infatti, il vero avvio della grandiosa fortificazione deve farsi risalire all'incarico professionale commissionato ad Ambrogio Attendolo da parte di Filippo II nel 1557.
Il celebre tecnico, valutata attentamente la configurazione dei luoghi e, soprattutto. tenuta nel debito conto la presenza del forte, optò per una serie di 6 bastioni, fra loro molto diversi per forma e grandezza. I n particolare gli ultimi due, ricalcando quelli del for-
te, risultarono cli gran lunga più piccoli, mentre quello ad essi immediatamente contiguo. peraltro il maggiore dell'intera cerchia, fu dotato di un unico fianco rientrato, dal lato opposto al forte. Probabile che s i volesse in quel modo subordinarlo al tiro del forte stesso evitando il contrario, concezione che si ritrova anche in altre fortificazioni perimetrali , s pecialmente costiere, come ad esempio nella piazza di Civitavecchia.
La valenza complessiva della cerchia di Capua fu accentuata verso la fine dello stesso secolo, tramite l ' ultimazione di un profondo e largo fossato, scavalcato in corrispondenza di Porta Napoli da un lungo ponte, in origine parzialmente levatoio.
Intorno alla metà del '700, sotto Carlo ID , si effettuarono ulteriori potenziamenti alla fo1tificazione facendola precedere dalle famose sette 'frecce', opere difensive avanzate che implicarono una più complessa articolazio-

ne dei fos sati e dei cammi nam e nti so tt erra nei. Ed ancora agli inizi del XIX seco lo il Genio militare borbonico ne incrementò le opere, disl ocan do in oltre a ll ' inte rn o della città un ampio compl esso ospedaliero per la cura delle più frequent i m a la tti e di c ui all 'e po ca erano affetti g li ese rciti , suddi v id endolo i n vari ed ifici quali il Sifilicornfo, il Qu artiere della Rog na, e cc. D che, implicitamente , tes timonia 1' irr eve rsibile tramonto s trateg ico della p iazza di Capua, già chiave del Regn o . U n ultim o assedio però ancora attendeva quei vetusti bastioni.
Do po la ce l ebre battaglia del Volturno fra g aribaldini ed eserc ito regolare borbonico (44 ', c h e vide la
v itt oria dei primi , nei g i o rni l e 2 ottobre l 860 la g u a rni gio ne di Capua rima se abba nd o n ata a se stessa carente di viveri e dì muni z ioni. A difendere la pia zza in effetti erano rima s ti c irca 10.000 uomini sotto il coma nd o del brigadiere Raffae l e d e Cornè , co n un parco di ar ti glierie a pp a r ente m e nte num erosissime ma composto nella s tragrand e maggioran za di pezzi g iubilati , non di rado degli ini z i del se colo precedente : in ogni c aso ness uno verame nt e ri gato Contro i vetusti bastio ni e g li a ltr e ttant o arcaici pezzi di Capua g uid ava l ' inve s timento il genera l e piemontese D e lla R occa, c he diede subito l ' ordine di all esti r e circo l a nn e nt e otto batt e ri e per iniziare il bombarda-


mento. I lavori procedettero alacremente per tutto il 29 , 30 e 3 J ottobre .
Alle ore 16 del 1 novembre, sferzata dalle raffiche di vento e dalla pioggia battente, una rossa bandiera, in so s tituzione dei segnali luminosi regolamentari , venne innalzata nella pianura a pochi chilometri dalla città. 1n rapidissima successione setle batterie dell ' esercito sardo aprirono il fuoco. Dai loro 23 cannoni, di cui otto modernissimi cannoni 'Cavalli' <4 5 ) ad anima rigata, un diluvio di proietti prese a convergere sulle mas sicce opere della leggendaria 'chiave del regno'.
La reazione napoletana non si fece attendere e con identica violenza, e forse persino con una più accurata punteria, i pezzi dagli spalti e dalle casematte controbatterono gli a s sedianti, fracassandone dopo pochi minuti una cannoniera. Ma già dai primi tiri parve a tutti evidente la risaputa disparità tecnologica delle opposte artiglierie. talmente rilevante da sovvertirne ampiamente la pur rimarchevole differenza numerica.
Ben I 50 bocche da fuoco , infatti , armavano la cerchia, ma costituivano dal punto di vista militare un assortito insieme assolutamente degno di esporsi alla curio s ità dei visitatori in un museo piuttosto che al tiro nemico sui rampari di una piazza s trategica. Quasi non bastasse, il doverle impiegare contro cannoni di gittata efficace notevolmente superiore imponeva, nel disperato tentativo di riuscire a stabilire un contatto balistico significativo, il ricorso al valore massimo di alzo con conseguenze devastanti per gli affusti, anch'ess i ovviamente di remota concezjone e comunque non progettati per un sjmile tom1ento djnamico.
Trascorse circa quattro ore si registrò un significativo diradarsi del fuoco di controbatteria, provocato, come affem1ò il Delli Franci nella sua Cronaca della campagna d'autunno del 1860, dall ' inevitabile cedimento di gran: " ... parte delle artiglierie della piazza [cheJ non più sparavano. dappoiché i loro affusti , a cagione del rincular dei cannoni e dell'angolo di elevazione col quale dovevasi tirare per far lunga gittata, mal reggendo a tali s forzi erano renduti sconci e disadatti ..." <~61
Nel frattempo gli effetti del bombardamento piemontese si confermavano, di minuto in minuto, terribili per la popolazione civile. Molti i morti, ancora cli più i feriti. Prostrato dal massacro di tanti innocenti il cardinale della città, Cosenza, supplicò le autorità militari di porre fine all'inutile resistenza , consegnando la piazza. Da notare cbe fra i difensori impegnati sui bastioni le perdite erano fino a quel punto irrisorie. Il de Cornè pressato da ogni parte a cedere. con s cio peraltro de.ll'assurdità della situazione, fece avviare nella mattina del 2 novembre le trattative pur nell ' intima convinzione che arrendersi con i bastioni, le can-

non i ere ed i depositi di munizioni pressoché intatti fosse un atto disonorevole e vile : ma la guerra era ormai indiscutibilmente persa per i Borboni e la c itt à s i arrese nello stesso giorno.

U bastio ne del reg no, il suo estremo baluardo, capitolò cosi dopo una so l a nottata di bombardamento! Di lì a breve anc he Gaeta, quindi Messina e Civitella del Tronto s i sarebbero arrese, ponendo fine co nt e mp oraneamente alla dinastia borbonica ed a ll a indipendenza de l regno del Sud. il primo e maggiore stato dell'Italia. Co n esso s i co ncludeva pure l'epopea del fronte basti onato.
Al tramonto de l 13 settembre de l 1535, Carlo V e nt rava in P alermo da P orta Nuova <rn, fra ali di popolo acclaman te e sfarzos i addobbi, dir i gendosi al Du o mo . La folla degli schiav i lib era ti c he l' osa nn avano, il tripudio dei sudd iti s ici Jiani e l a magnificenza degli o rn ame nti profusi lun go il tragitto, non b as tarono però a nascondergli la fin troppo palese fatiscenza de ll e fortificazioni della ca pit a l e. Redu ce da un fortunato assedio, ne va lut ò con cog ni z ion e di ca usa l'insignificanza difensiva delle mu ra norm ann e, traendon e conclusioni preoccupanti. L a cons tatazione c he P alermo n on rientrasse a buon diritto ne lla fronti.era marittima propriamente detta, non costituiva una duratura ce rt ezza di immunità. La città : " infatti era dislocata in un ver san te geografico d e l!' Iso la che non costituiva di per sé uno degli obiettivi del nemico . E sso probabilmente sa r e bb e stato preso in co n sideraz i one d ai Tur chi soltanto in un secondo temp o, qualora , presa M ess in a In questa ottica P ale rmo si do veva se mpr e fortificare ma il pericolo non era cos ì in combente come per Mess ina e le città ne lla cos t a orientale" 14 8 >
I n linea di massima si può 1itenere che all'epoca le fortificazioni della città fossero costituite essenzialmente della murazione peJimetrale normanna e del castello. Qu esto a sua volta: " si presentava completo ne ll e sue struttu re ma sprovvisto di opere di bastionamento. In effetti esso ri usciva difficilmente attaccabile dal mare per avere mura alte e spesse ed inoltre l' antico Don gio ne c he a ncora s i trovava rinse rrato nel centro del p erimetro funzionava da "caval iere" consentend o di dominare il circuito delle mura e parte della città. Dalla pa11e di terra l'efficienza delle mura era più precaiia essendovi quasi addossate alcu ne costruzioni ed anche delle chiese" (·!9\ A pp are , stando ad una serie di ri sco ntri , più o meno attendib ili , che in epoca aragonese alla cerchia vennero apportati alcuni pote nziamenti , forse mediante l 'i nserimento di grossi torrioni. Di certo però l a s u a sca nsio ne permase immutata per tracciato e logica d'impianto.
P ertanto nei piimi decenni del '500, l ' esigenza di procedere da capo a ll a ricostruzione de ll e s trutture difensive della città secondo i criteri del fronte bast ionato, divenne improrogabile. L a sua concreta attuazione , però, potette avviarsi solta nto dopo l 'arri vo da Bergamo dell'ingegner Ferramolino agl i inizi deg l i anni '30. L a compa rsa de l tecnico a Palermo può ascriversi ad un in carico probabi lm e nte ricognitivo o di co nsulenza, tale comunque da consentirgli la redazione di un primo programma di la voro per la t rasformazione dell · arcaica cerchia i n una moderna for tifi cazione, massicciamente bas tion ata Ma accorse ancora attende re l a nomin a de l Gonzaga a v ice ré, perché il suo progetto divenisse esecutivo
La città cli Palerm o s i presentava a li ' epoca planimetricamente affine ad un vas to retta ngo l o : a settentrione ed a meridione i l ati maggiori, a l evante e ponente qu e lli minori. In casto nato ne ll ' ultim o il menz i o nato castello su l m are La particolare configurazione, vagamente regolare, suggerì e consentì al Ferramo lino i co nc e tti o rdin ato ri per la e ri genda grand iosa fortificazione. Per persona le e diretta esperie nza in attacchi anfi bi, il bergamasco volle prioritariamente ga - [
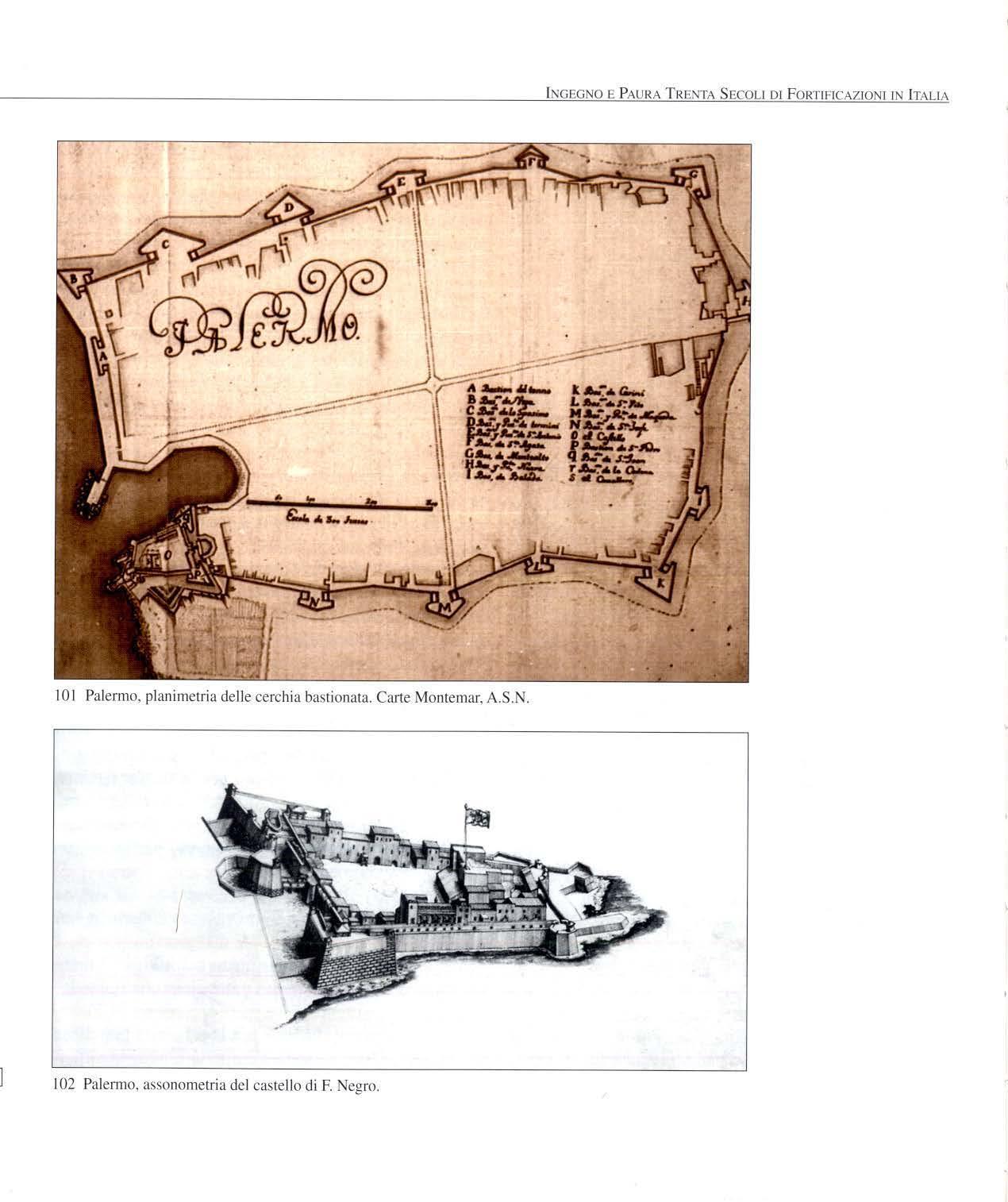
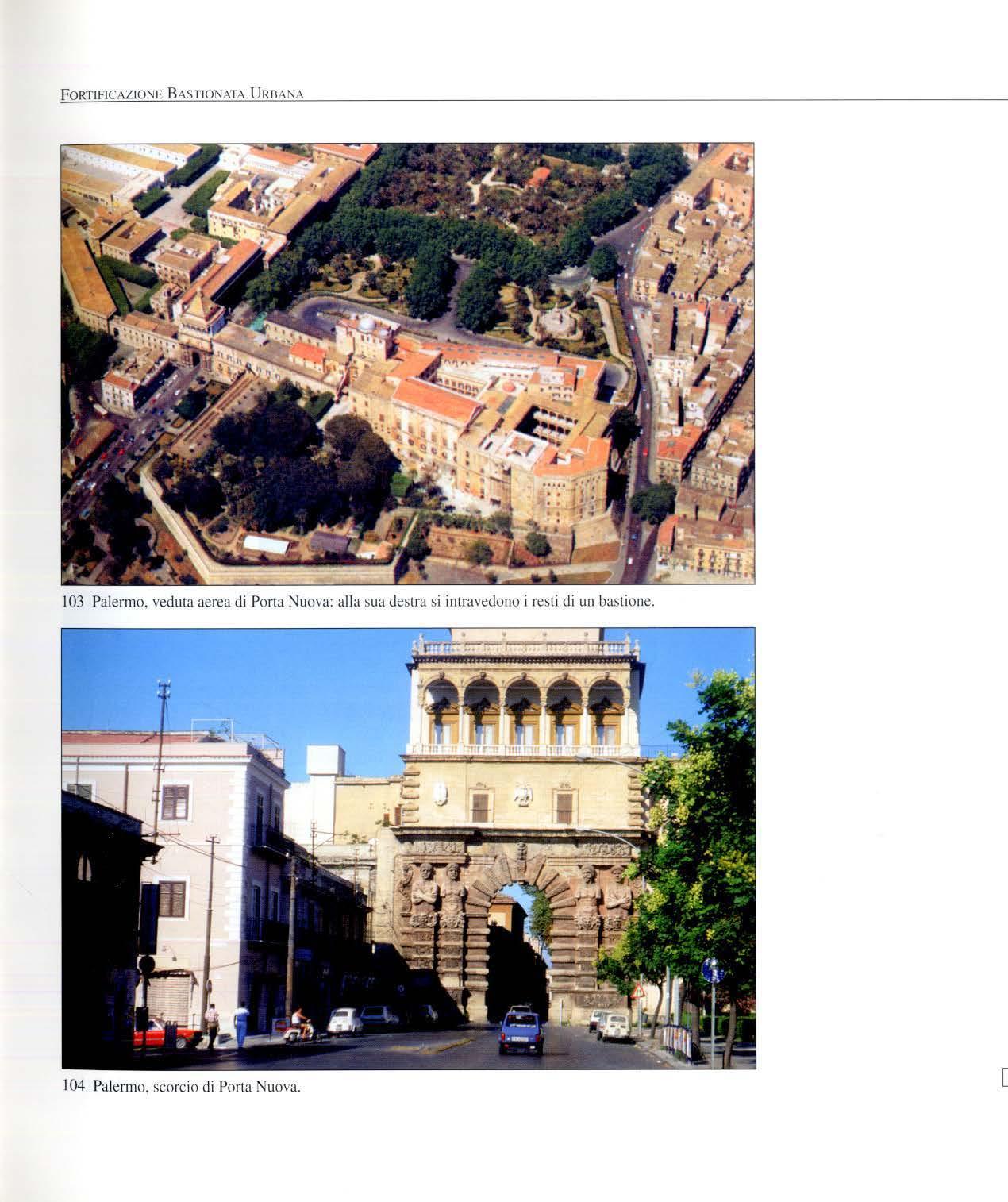
l 05 Palermo. scorcio di un bast io ne nei pressi del Palazzo Real e.
rantire massicciamente il fronte a mare della città, potenziando co n poderose bastionature l 'anacronistico maniero medievale e lo s pigolo a mezzog i orno del lato minore cu i apparteneva. Volle , parimenti, creare un identico caposaldo di maggior resistenza , sul lato s immetrico al porto, s ul fronte a ten-a , ad immediato rido sso del Pala zz o R ea le, conseg ue nd o, a un tempo , l'ir ri gidì mento della sez ione più debole e l a sa lvaguardia del pres tigio so edificio.
Da tale v is i one ne conseguì un a c hi ara polarizzaz ione della cerch i a, sc h e m a arc hit etto ni co entro il qual e, senza eccessiv i s bilanciamenti s i sa rebb e dovuta realizzare l'intera costruzio ne n ei decenni succe ss iv i. Prec isa ti i criter i progettua li , avutone pro nta accettaz ion e dal v ice ré e certa m ente dallo s te sso imperatore, esiste nd o l a di s po nibili tà eco nomica, almeno per avv iar li, il Ferramo l ino ne fissò rigidamente le caratteristiche ed il dimens ionamento, nonché una min u-
z iosa tabella di avanzamento da rispettare in fase esec ut iva. Per una fortunata circosta nza, il pacchetto re l ativo ci è pervenuto i nt eramente. consentendoci interessa nti precisazio ni , peraltro di va le nza genera le.
La dinamica di appro nt amen to della cerchia bast ionata di Pal ermo si att uò, come accennato e seco ndo la pras s i, per grad i ed una vo lta ultim ata sc hierò: " .in tutt o ... dodici bas tioni , due di mare e d ieci di terra , due da o ri ente, quattro da tramo n ta na con l' an go lo, quattro da pon e nte con l 'an go lo, e due da mezzogiorno co n l'angolo, c he tutti si riducono a i predetti dodic i " < 50 ) La procedura, se nza dubbio più lenta d i un a co ntemp ora nea demolizione, evi tava però il ri sc hio s iss imo scade re della sicurezza de ri vante d a lla e liminazione delle vecc hi e s trutture in manca nza dell e nu ove ed aJla a ncora più frustrante care n za di denaro. Al fine di sco ngiurare a l ma ssimo tale pericolo Jo stesso ingegnere sta bilì con pedantesca pignoleri a la prio -
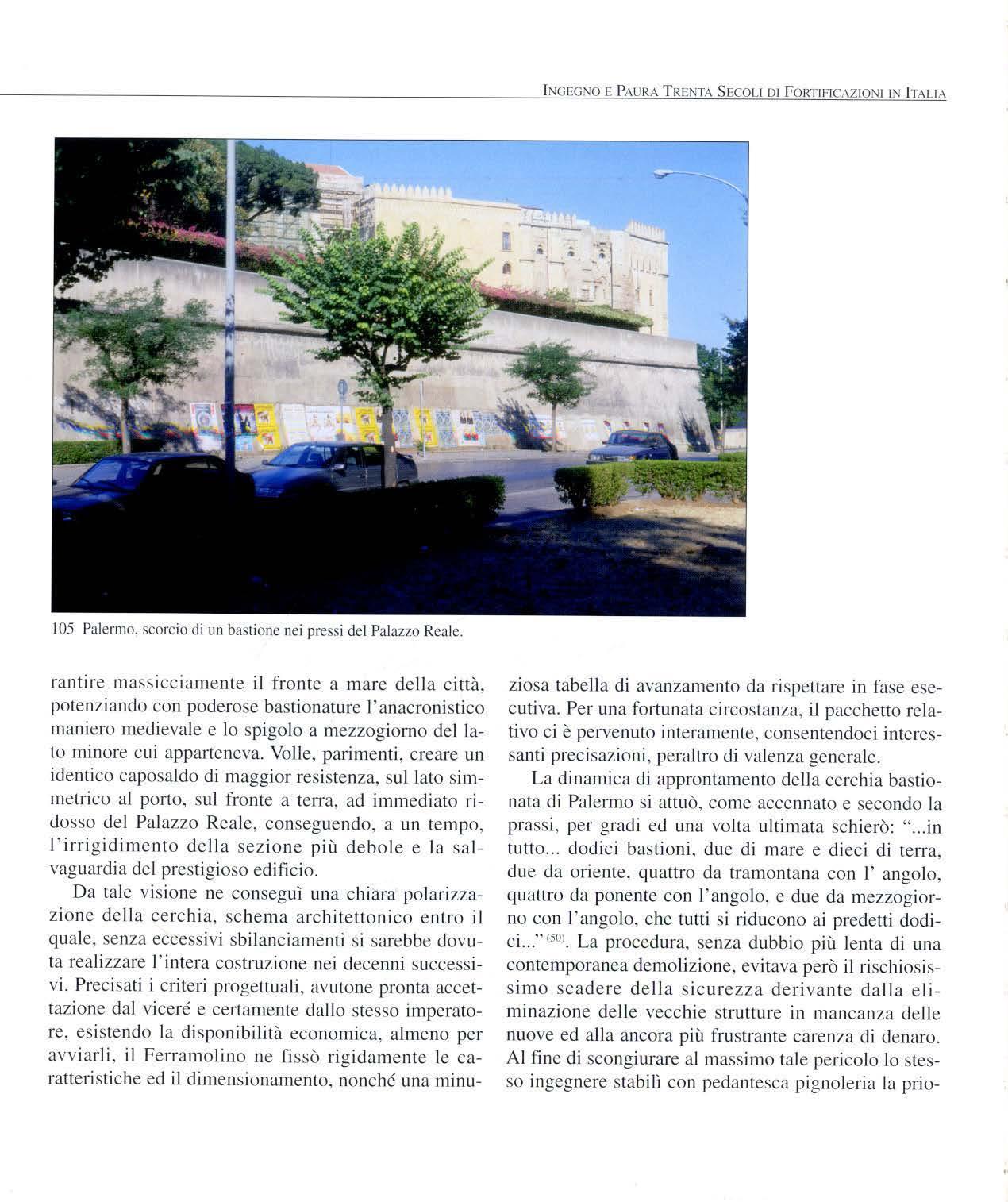
rità da assegnare a ll a r ea li zzaz i o ne di c i ascun bastio ne Da quanto a l presente deducibile, tuttavia, l'and a ment o dei lavori in pratica si d iscostò alquanto dal pi ano del Ferramolino. L a principale ragion e deve individuar s i proprio n e ll e sue disposizioni richiedendosi per i setto ri da lui va lut at i criti c i , e quindi da fortificare meglio, tempi di attuazione più es tesi.
In s intes i s i può rite ne re che così si estrin secò l' intera vicenda:
n e l 1 53 6 , s i ope r a lun go il lato maggiore , a se tte ntrion e, applicando alla mura zio ne ancora idon ea ed a quella sostituti va i bastioni di S. Giorgio, di S. Giuliano, di S. Vit o, e di Porta di Carini 15 1', vertice verso te n-a di quel lato; contemporaneamente s i proc ede anche su qu e llo op posto, ovve ro s ul l ato maggiore meridionale, e ri ge ndo i bastioni di Port a M azzara e di Po1ta S. Agata.
nel 1537 s i costruiscono su l l ato minore , a ponente, il bastione di S. Giacomo, e quasi all'estremità ad est del lato maggiore m er idi o nal e quello dello Spasimo. nel 155 0 è l a vo lta quin di dei bast i o ni sul lato minore, a mare, detti del Vega e del Tu o no, e su l lato minore a terra di quello di S. Pietro a P alazzo. Gli altri, si erigera nno do po l a morte del bergamasco nel corso di quel seco l o e di parte del s uccess iv o
Torn ando alle di sposizioni del F e1rnm0 Iin o, se mpre ne l 1536 ri sulta prevista J'edificazion e di cinq ue bastioni. o baluardi, all 'epoca be/guardi, fra i quali i quattro più urgenti ad a lzars i so no indicati con i nomi di be /guardo dello Spasimo, be/guardo a Turri runda, a Porta di Santagati, a Tri Tundi e di Porta Mazzara. D a ll e nomenclature citate si desume la presenza di alquanti to rrioni rotondi , finiti ingl obati nei bas tioni , e c he costituiscono la riprova degli aggiornamenti aragonesi di transizione
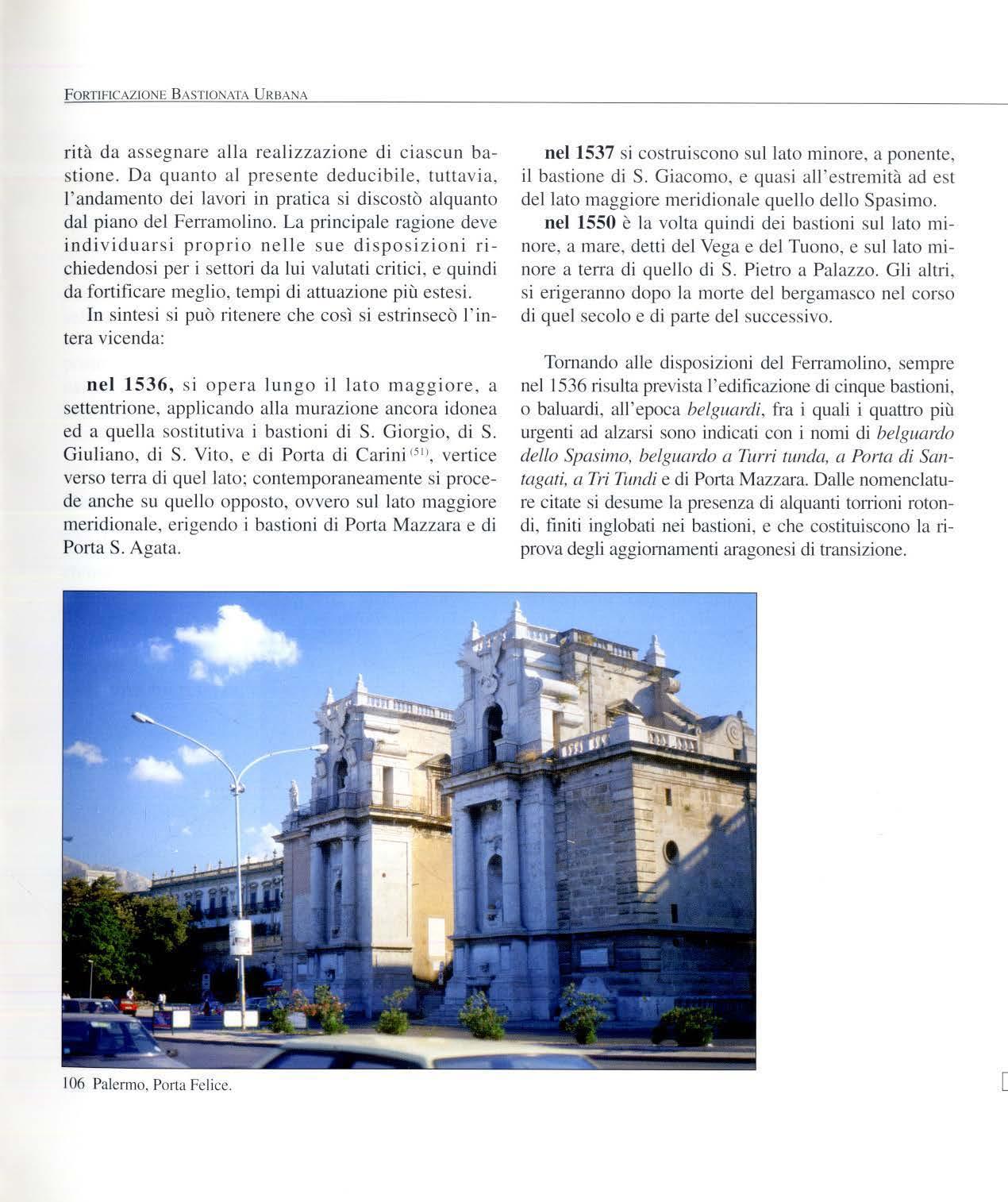 106 Palermo . Po rt a Fel ic e.
106 Palermo . Po rt a Fel ic e.
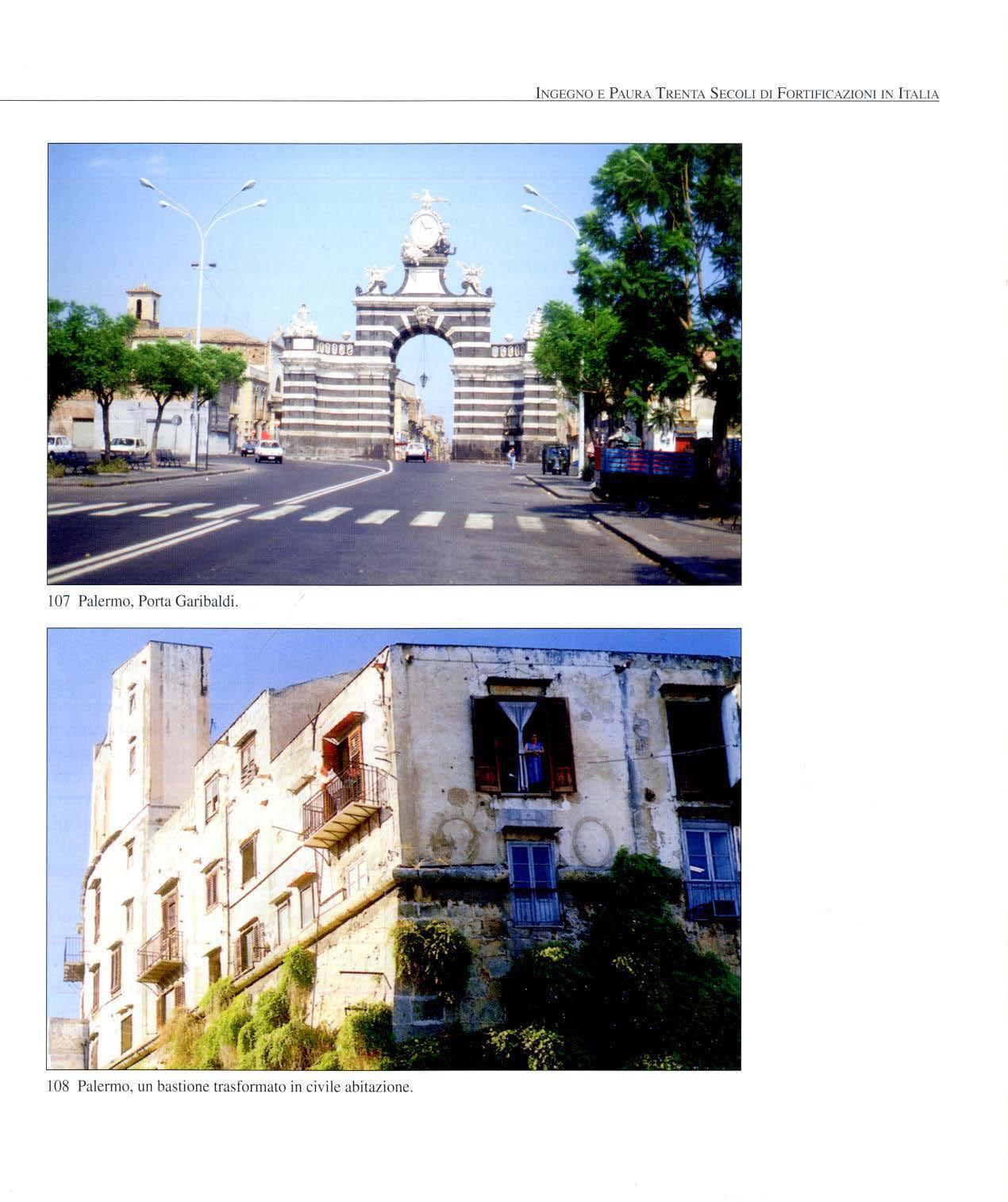 INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI fORTlFICAZIONI IN ITALIA
l07 Palermo, Porta Garibaldi.
108 Pale rmo, un bas ti one trasfo rma to in c iv ile abitaz ione.
fORTIFI CAZJON E B ASTIO NATA. URBANA
INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI fORTlFICAZIONI IN ITALIA
l07 Palermo, Porta Garibaldi.
108 Pale rmo, un bas ti one trasfo rma to in c iv ile abitaz ione.
fORTIFI CAZJON E B ASTIO NATA. URBANA
S e n z a vo l e r c i a dd e ntrar e ulte ri o rmente nell a e nn es ima rip ro p osizione del d oc u mento d el Fe r ramol i no, indubbi ame nte i nteressa n tiss im o m a eccess i vamente s pec ifi co, ne tran-emo alc un e s ig ni fica t ive osse r vaz i oni di natura dim e n s io na le e tec ni ca, attes t a n t i la co mp l ess it à d e ll ' o p e ra e la st up eface nte mo d e rni tà de ll a co nc ez i o n e . In s i ffa tt a o t t i ca a n a li zzeremo p e r tutti , sebb e ne di g r a ndezza legge rm e nt e magg iorat a, i I b as tione d e ll o Spasi m o, pera lt ro il p ri m o ad essere proposto d al F e IT amo lin o, ricava ndo c i d a ll e qu ote ori g inali di proget t o espresse in ca nn e s ic i l ia ne le a ttu a li in m e tri , e d a ll e p recip ue co n notazi oni u na valenza generaliz zab il e.
Dati car atte r istici d el B astio n e de llo Sp as im o
Form a: tipica l anceo l a t a, co n fian c hi rie ntrati ad o recchioni, al zato sca r pa te fin o al cordo n e e ve rti ca le a l d i so p ra
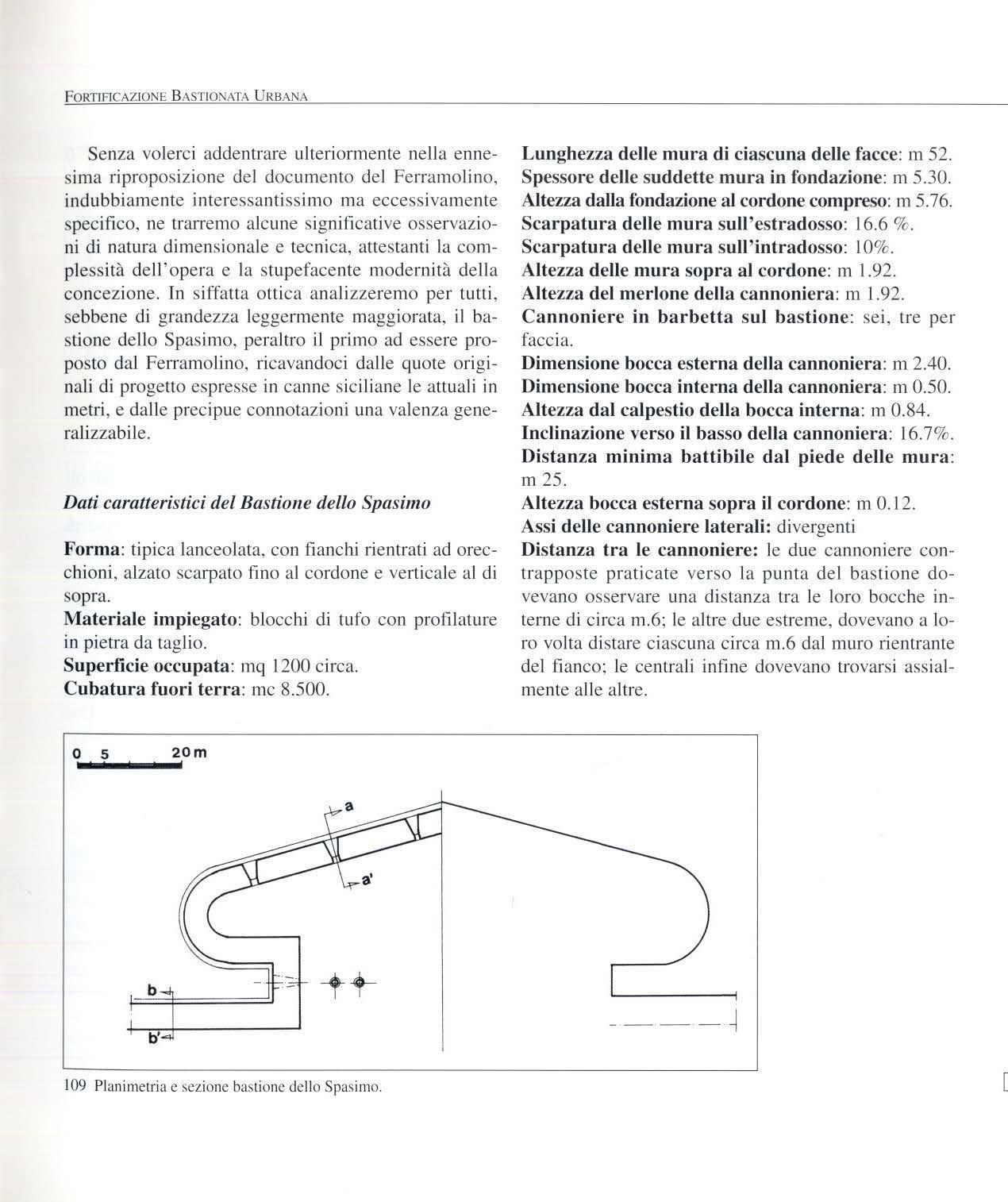
Materiale im piega to: bl occ hi d i tufo con profilature in pi e tra d a tagl io.
Superficie occ upata : mq 1200 c i rca. Cuba tura fuo r i t erra : mc 8 . 5 00.
o s 20m
109 Pla ni met ri a e se2-ione bastio ne de ll o Spasimo
Lun gh ezza de ll e mura di ci ascuna delle facce : m 52.
S p essore delle sudd ette mura in fondazione: m 5.30.
Altezza dalla fondazione al cord one co mp reso: m 5 76.
S ca rp a tu ra dell e mur a s ull 'estra d osso : 16.6 %
Scarpatura d e ll e mu ra s ull'in tra d osso: 10 % .
A lte z za d e ll e mura s op ra a l c ord o ne : m 1 .92 .
Altezza d e l m erlon e d e ll a cann oni era : m 1.92.
Ca nnoni ere in b a rb e tt a s ul b as ti o n e : sei , tre per facc i a .
Dimens ion e bocca es te rn a d e ll a cannoni era : m 2.40.
Dime nsio ne b occa in te rn a d e ll a cann o niera: m 0. 50 .
A ltezza dal calp es ti o d e ll a bo cca int ern a: m 0.84. Inclin az ion e ve rs o il b ass o d e ll a cannoniera : 16.7 % .
Dis tan za minim a batti bile d a l p ie d e de ll e mu ra: m25
A ltez za bo cca este rn a s opra il co rdon e : m 0 .1 2. Ass i d e ll e canno ni ere late rali : d ive rgenti
Dista nza t ra le ca nnoni e re : le d ue ca nn o n iere co nt rappos t e pra ti ca t e verso la p u nta del bastio n e dovevano osservare u na d is t a n za t ra le loro bocc he i nte rn e d i ci rca m. 6; le al tre due es treme , dovevan o a l oro volta d is t are ciascuna c i rca m 6 da l muro rientran te d el fianco : le ce ntra li i nfi ne doveva no tro vars i ass ia lm e nte a ll e a ltre
Profilo esterno dei merloni: a se ttor e circo l are, ovvero a quarto di cerchio, meg l io noto in seguito come profilo balistico
Dati caratteristici per le cortine laterali al bas tione
Lunghezza di quella a levante : m 80.
Lunghezza di quella a ponente: m 67 .
Spessore in fondazione: m 2.40.
Abbattimento dell'estradosso: 16.6 % .
Abbatti m ento dell'intradosso : 10%.
Altezza fino al cordone : uguale a que ll a de l bastione.
Altezza dei m er loni sopra il cordone : m 1.44, mezzo metro in meno di quella del bastione.
Cannoniere disposte lungo la prima sez ione : n ° 8 in ba sso casemattate e n ° 8 in alto in barbetta (le casamatte per le art ig li erie sarebbero state costru ite in un secondo momento, allorché si fosse terrapienata la muraglia . In tal modo si aveva già all'indomani della s ua erezione un primo liv e llo di difesa).
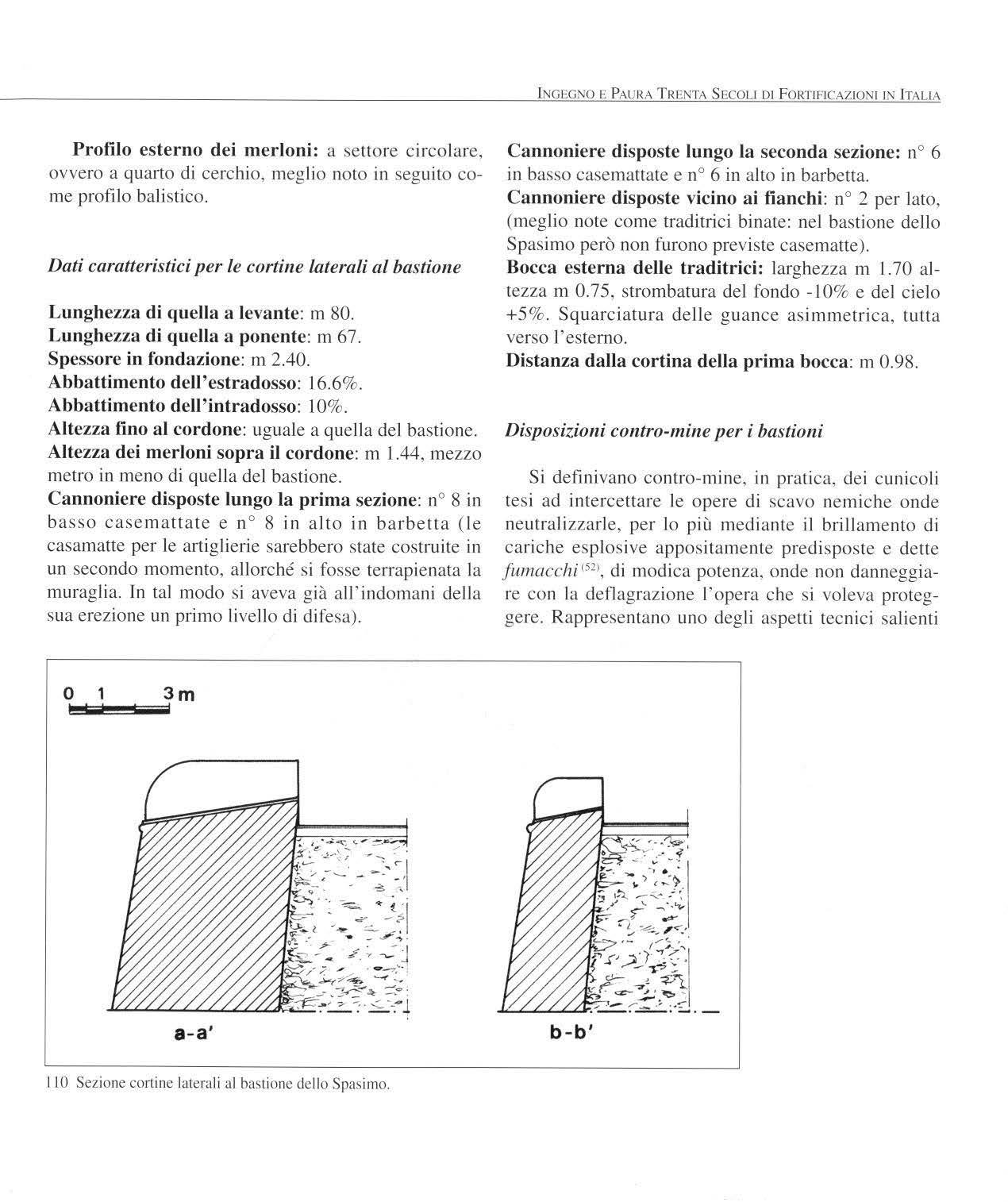
Cannoniere disposte lungo la seconda sez ione : n° 6 in basso casemattate e n° 6 in a lto in barbetta.
Cannonjere disposte vicino ai fianchi : n ° 2 per lato , (megl io note come traditrici binate: nel bastione dello Spasimo però non furono previste casematte).
Bocca esterna delle traditrici: larghezza m 1.70 altezza m 0.75, stro mbatura del fondo -I 0 % e del cielo +5 % . Squarciatura delle guance asimmetrica, tulta verso l'e sterno .
Distanza dalla cortina della prima bocca : m 0.98.
Dispos iz ioni contro-min e per i bas tioni
Si definivano contro -m ine , in pratica, dei cunicoli tesi ad intercettare le opere di scavo nemiche onde neutra] iz zarle, per lo più mediant e il brillamento di cariche esplosive appositamente predi sposte e dette fumacchi (52 > , di modica potenza. onde non danneggiare con la deflagrazione l 'opera che si vo l eva proteggere. Rappresentano uno degli aspetti tecnici salìenti
della progettazione del Ferramolino e risultano in notevole anticipo su i tempi. Nella fattispecie furono previste scavate nella roccia tufac ea sottostante la fondazione, con una larghezza di circa un paio di metri, coperte da una vo lta a botle. Il loro andamento coincideva con l'asse longitudinal e del muro de l bastione. In altri termini s uppo sto questo largo m 5, la galleria sarebbe stata scavata in maniera da lasciare ancora per l 'appogg io della predetta fondazione m 1.5 verso l'e s terno e m 1.5 verso l'interno , per l'intero perimetro del bas tione , collegando perciò un orecchione con l'altro.
A re ndere ulteriormente intricato il dipanarsi del cunicolo contribuiva la sua segmentazione in tante celle quadrate di circa m 2x2x2, separate fra loro da un settore tra sve rsa le di circa m l di spesso re. In quello andava ricavato il vano di passaggio dall ' una all'altra , previsto largo m 0.70 ed alto m 1.20, ciascuno dotato di un robusto cancello a lancioni. A loro volta i vani si sarebbero dovuti s us seg uire sfalsati , ovvero il primo addossato alla paret e verso l 'es te rno della galleria ed il s ucce ss ivo a quella verso l 'i nterno. La curiosa precauzione scaturiva dall 'es igenza di evitare che un eventuale nemico , penetratovi da una galleria di mina , potesse tirare d'infilata lungo gli stess i. Ad ogni buon
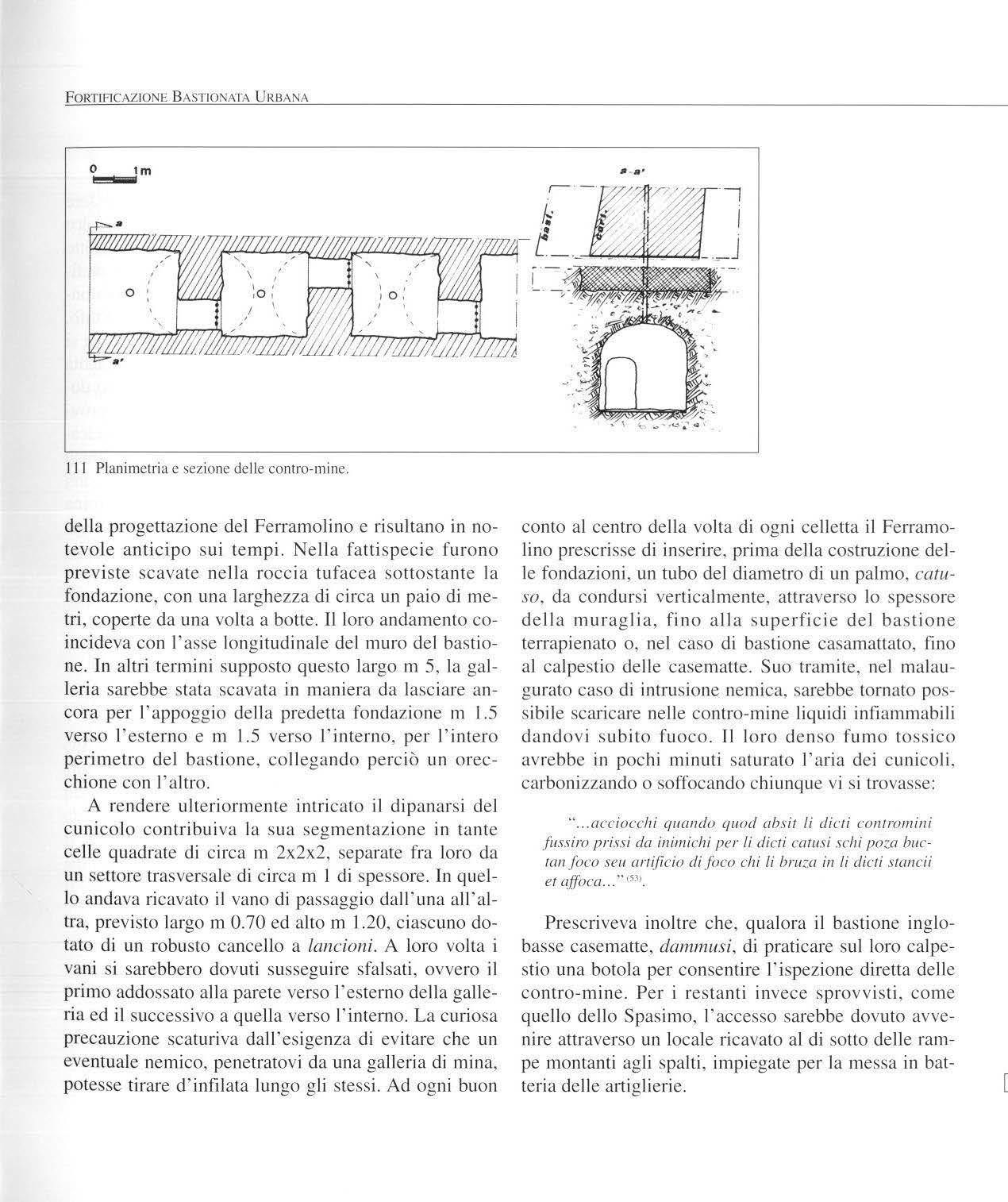
conto al centro della volta di ogni ce ll etta il Ferra m olino prescrisse di in se rire , prima della cos truzione delle fondazioni , un tubo del diametro di un palmo , catuso, da co ndur s i verticalmente, attraverso lo spessore della mura g lia, fino alla superficie del bastione terrapienato o, nel caso di bastione casamattato, fino a l calpestio delle casematte. Suo tramite, ne l malaug urato caso di intru sione nemica, sarebbe tornato possi bile scaric are nelle contro-m in e liquidi infiammabili dandovi subito fuo co. Il loro denso fumo to ss ic o avrebbe in pochi minuti saturato l'aria dei cunicoli , carbonizzando o soffoca ndo c hiunqu e vi si trova ss e:
acciucchi quando quod absit li <lieti cuntromini fussiro prissi da inimichi per li dicti catus i selli po-::,a buctan .foca seu artifi c io di focu chi li bru::,a in li dicti stancii et l!tfoca " •5» ,
Presc riveva inoltre che , qualora il bastione inglobasse casematte, dammusi, di praticare s ul loro cal pes tio una botola per consentire l'ispezione dirett a delle contro-mine. Per i restanti inv ece sprovvisti, come quello dello Spasimo, l'accesso sarebb e dovuto avvenire attraverso un locale ricavato al di so tto delle rampe montanti agli s palti , impiegate per la messa in batteria delle artiglierie.
All'interno delle casematte occorreva la luce naturale ed un rapido ricambio dell'aria. In entrambi i casi l'esigenza derivava dalla presenza, e soprattutto, dall'uso della polvere pirica: rischiosissimo impiegare lampade a combustione e prioritario evacuare i fumi di sparo dopo ogni salva. Il Ferramolino, pertanto, adottò la soluzione di lasciare nel cielo di ogni casamatta due grosse aperture circolari, quasi un paio di occhi come le chiamò negli Ordini , del diametro di circa un metro, munite di opportuno risalto, una sorta di mastra, idoneo ad ospitare una botola di chiusura, in modo da eliminare dalla sovrastante piazza d 'arm i pericolo se voragini per la manovra delle artiglierie.

Quanto alle cannoniere, che costituivano pur sempre delle comunicazioni con l'ambiente esterno, onde evitarne il sia pur remoto imbocco da parte dei proietti nemici, non di rado agevolato dalla tradizionale configurazione a tramoggia, le prescrisse gradinate, connotazione destinata da allora a perdurare sino ai nost1i g10rm.
I fossati delle fo1tificazioni costiere potevano essere allagati con acqua salata, meno insalubre di quella dolce stagnante , a condizione di scendere alquanto al di sotto del livello minimo di marea. Nel caso di Palermo prefigurandosi estremamente oneroso uno scavo tanto profondo essendo l'area d'impianto un compatto banco di tufo, si ricorse ad una si ngolare incentivazione. In pratica si stabili di cavare, ai piedi di ciascun bastione, la quantità di blocchi necessaria per la sua edificazione. Subito dopo, tutti i costruttori della città avrebbero dovuto approvvigionarsi per l'edilizia soltanto da quelle medesime cave, fino al raggiungimento delle dimensioni prefissate per il fossato che, via via, veniva così a crearsi.
La sol uzio ne se nza dubbio sca ltra ed economica dovette rivelar s i però alquanto lenta, a differen za degli altri lavori , tant'è che in procinto di lasciare la Sicilia nel 1546 il vicerè Gonzaga così delineava la questione di Palermo:
" lo l'ho circondata di bastioni che l ' un vede l'altro, talmente che, accompagnata da un bellissimo sito piano.
et per haver d'attorno assai buona muraglia. a11chor che vecchia, io l'ho per inexugnabile, né vi si può desiderare altro per hora eccetto il fosso, il quale con alcune difficoltà vi si può fare, perché essendo il terreno di tuffo non si può cavare se non con picconi, che se ne por1ano grandissimo tempo né vi è migliore spediente che quello trovato da me, ciò è, che colo,v, i quali fabbricano case dentro la Città, faccino cavare le pietre dal luogo di eletti fossi et con questo verranno a farsi senza spesa, anchora che ne porteranno grandissimo tempo, ma in fine altro rimedio non vi si può trovare. né per ciò è la Città così debile c he non sia per resistere a qualsivoglia potenza, secondo quel che giudico ... "
E quanto esasperatamente prolungato si dimostrò quell'espediente lo dimostra , se mai ve ne fosse bisog no, una perizia del 1570, che così esponeva in me1ito:
" Perche la fortezza di questa cita è di ha vere fossi attorno le muri , li quali se trovano incomensati et non computi, per questo li pirriaturi deveno cavar petra intro dilli fossi lllalche si compliscano f ed I è necessario promulgarsi publico bando, co n pena, che 11011 presumano li pirriaturi far petra in altra parte salvo che in li fossi preditti; li quali non essendo computi come esser deveno, la cita non è forte ne in cunto nixuno se intende essere in fortilizi " ' 55 '
Nel frattempo, comu nque, lo stadio att int o dalla cerchia garantiva una sicurezza incomparabilmente super iore a quella dei decenni passati, consen tendo perciò di attivarsi pe r repe rir e le bocc h e da fuoco, anch'esse molto costose e di lento approvvigionamento. 11 24 febbraio del 154 3 s ull 'onda emotiva di un en nesimo avv iso di prossimo assal to navale turco , s i emise il segue nte bando:
"Sia nolo e manifesto ad omni persuna in quista Citati di palermo si havi déliberato di fari alcuna quantitati di artiglaria per la defensione di quista Cita et gia si havi incominsato afarla et giaforafìnita si s'havissi potuto haviri ramo a sufficiencia. Per lo che officiali prelUri et )urati di quista Citali exhortano e pregano a tu/li .. . chi vogliano acomodari et aiutari. e vindiri tutta quilla quanti/a di ramo et mitallo chi omni uno polrà la quali serrà pagata di conianti ... " c~M
È interessante infine, dopo questa serie di schematiche puntualizzazioni sulle difficoltà incontrate dalla d iri genza palermitana per ven ire a capo della co lo ssale impresa, e di renderla operativa, spendere alcune righe circa gli uomini da schierarsi lungo quelle mura, o da impiegarsi su quei bastioni al servizio dei cannoni. Come in precedenza accennato non s i trattò di soldati di profess ione, o di guarnigioni sedentarie poste così in una sor ta di antesignano collocamento a riposo. Queste forme certamente ebbero vasta adozione nell ' istituzione militare spagnola, ma per la difesa delle c ittà si ricorse agli stessi abitanti, del resto le mag g iori vittime in caso di espugnazione. In particolare li si sudd iv ise in base alle corporazioni artigiane, come si evince chiaramente dal seguente documento del 4 ottobre 1543 anch'esso come i precedenti di valenza generalizzabile:
" l nstrucioni et ordini lassa/o per nui don petro Consales de Mendoza marchisi de la valli siciliana et rende Regio Collettore Consiliario in lo rew10 di napuli Castellano de lo Castello novo et Capitan Generali di sua maestà in questo fide/e regno li quali per servilio di la maesta sua et conservatione di questa felici Cira di patermo si haveranno di exequiri e1 observari in dilla Ci1a ...
Principalmente essendo dilla Cita divisa in cinco quartieri in li quali bisogna farse tanti Capitane i persone pratiche habile et più exeperti a la guerra se hanno da fare in questo modo: vidi!icet ad ogni 300 homini un Capitaneo il quale se jèirra il suo al.fieri et officiali di sua Compagnia et si jèll'ra w1 sergente magiare persona diligente e pratica.
Item sifarra subito resigna di tutti li gemi di ditta Cita et a/listare quelli chi si trovi ranno de 18 fin a 50 anni et provedere che le persone basse el agricole se debiano conperare una pica per uno hartisani de qualsivoglia arte uno arcabuxo per uno li gintilhomini et mercanti il coxalello et pica et li Cava/eri li loro cavalli et armi " <571
L a v icenda evo lutiva delle fortificazioni di Crotonefino al secolo sco rso chiamata Cotrone - ripropone sen- [
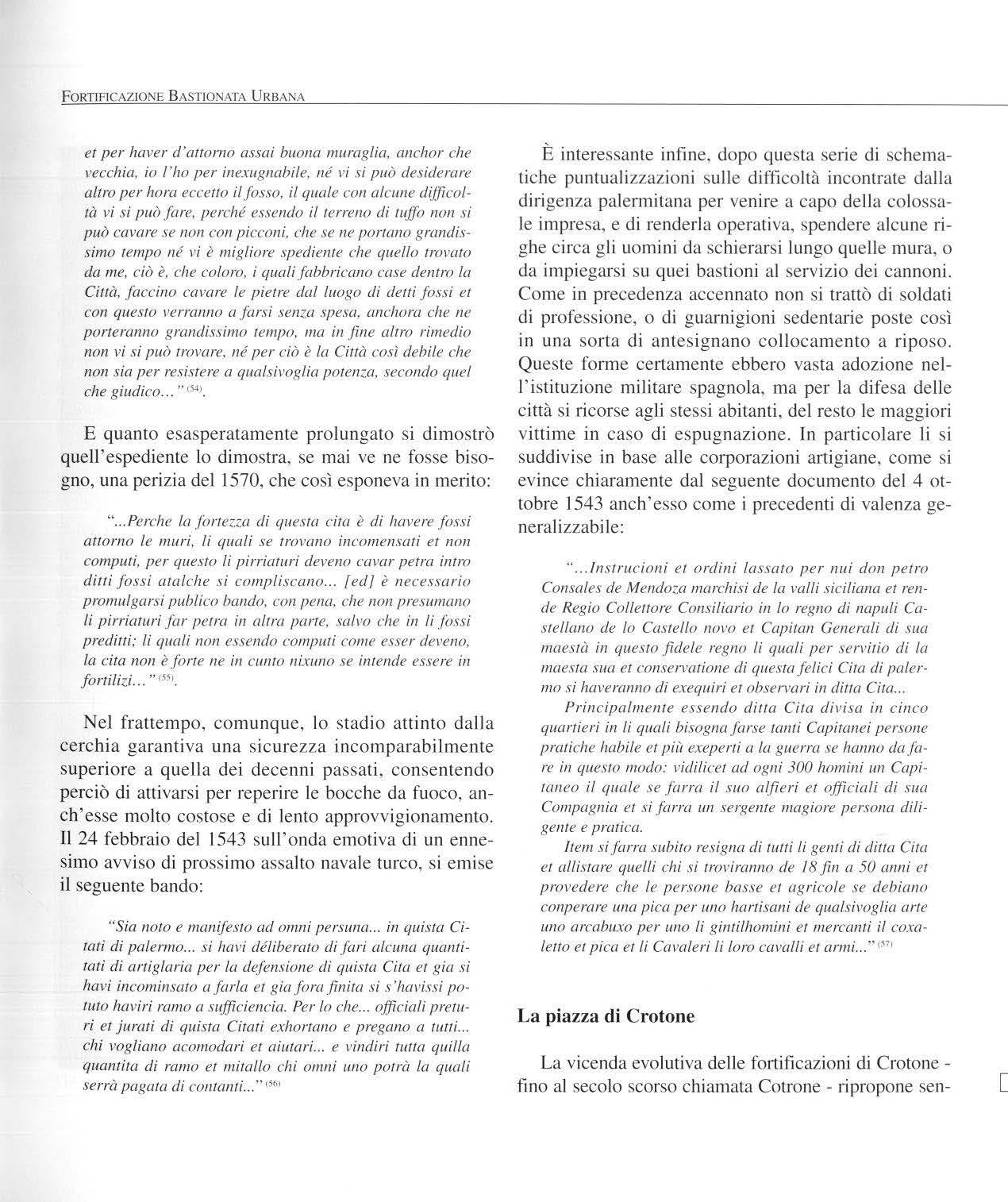
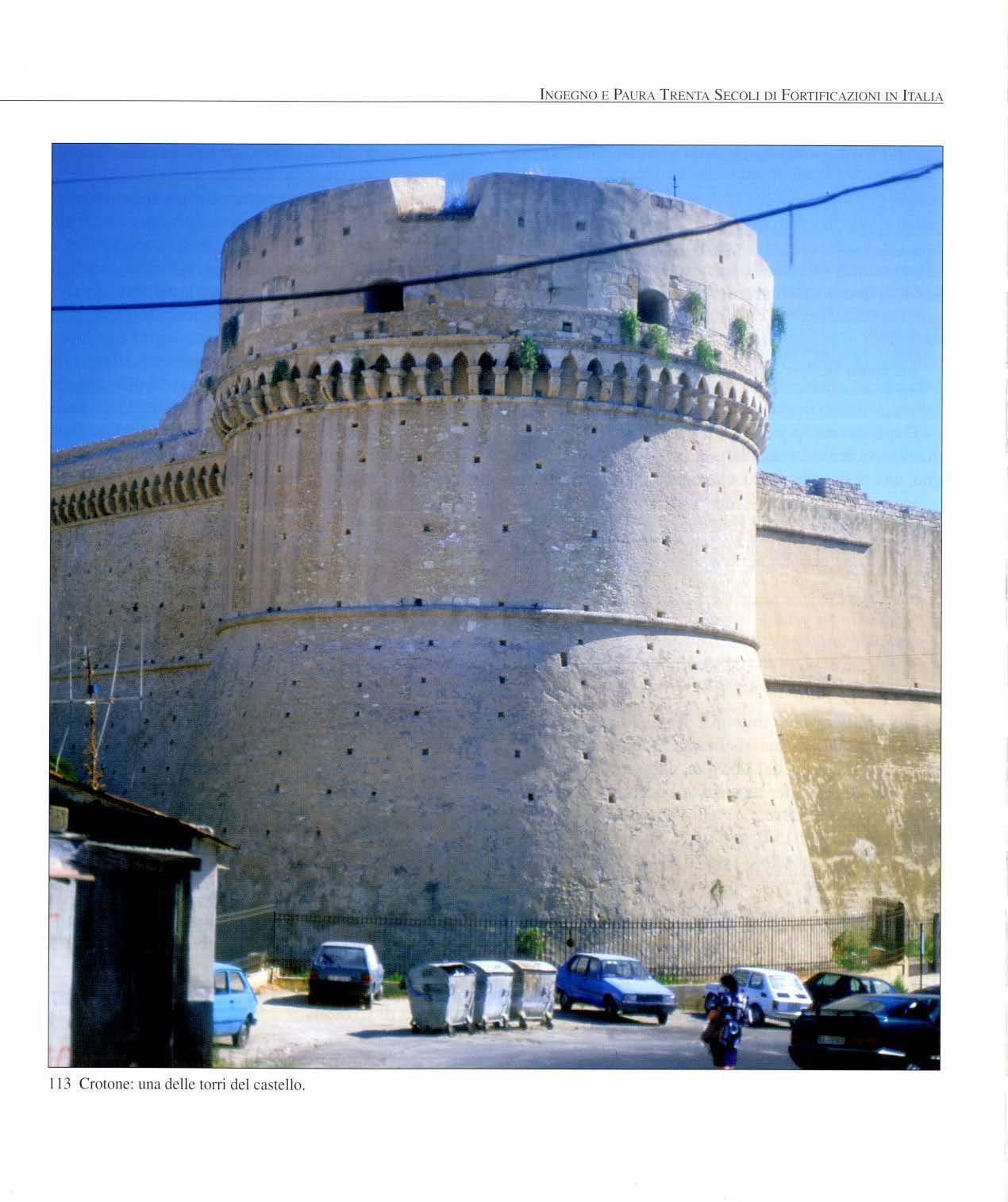
za significative diversificazione gli snodi tecnico -cronologici già delineati. Anche qui gli ultimi aggiornamenti al vetusto castello medievale devono ascriversi al 1485-86 <581 , quando le s ue: '·... quattro torri angioine innestate agli angoli della pianta quadrilatera ... [furono] sostituite ... lconJ le due superstiti (a nord-est): basse,
con la cortina interposta, sottolineata dalla linea continua del redondone e, più in alto, dall'archeggiatura r (ogivale) di coronamento s u men so le ... [e le dueJ verso il mare fcon] bastioni cinquecenteschi a punta dovuti all'intervento (1541) del viceré spagnolo don Pedro de Toledo che fece cingere di nuo ve mura anche l ' abitato ..." <59l .
In effetti fu appunto dal 1541 che, contestualment e ai lavori di parziale bastionatura del castello, si avviarono i progetti per trasformare l'arcaica cittadina murata in una moderna piazzaforte marittima. Per grandi linee la sua arcaica cerchia si sarebbe dovuta trasformare in una nuova opera a pianta poligonal e irregolare con un bastione ad ogni vert ic e appoggiata al castello. Anche in questo caso, perciò,

solo parziali demolizioni e sost ituzioni con seg menti più consoni all'innesto con i ba stio ni. Le planimetrie ed i grafici abbastanza numerosi dissolvono qualsiasi incertezza in materia.
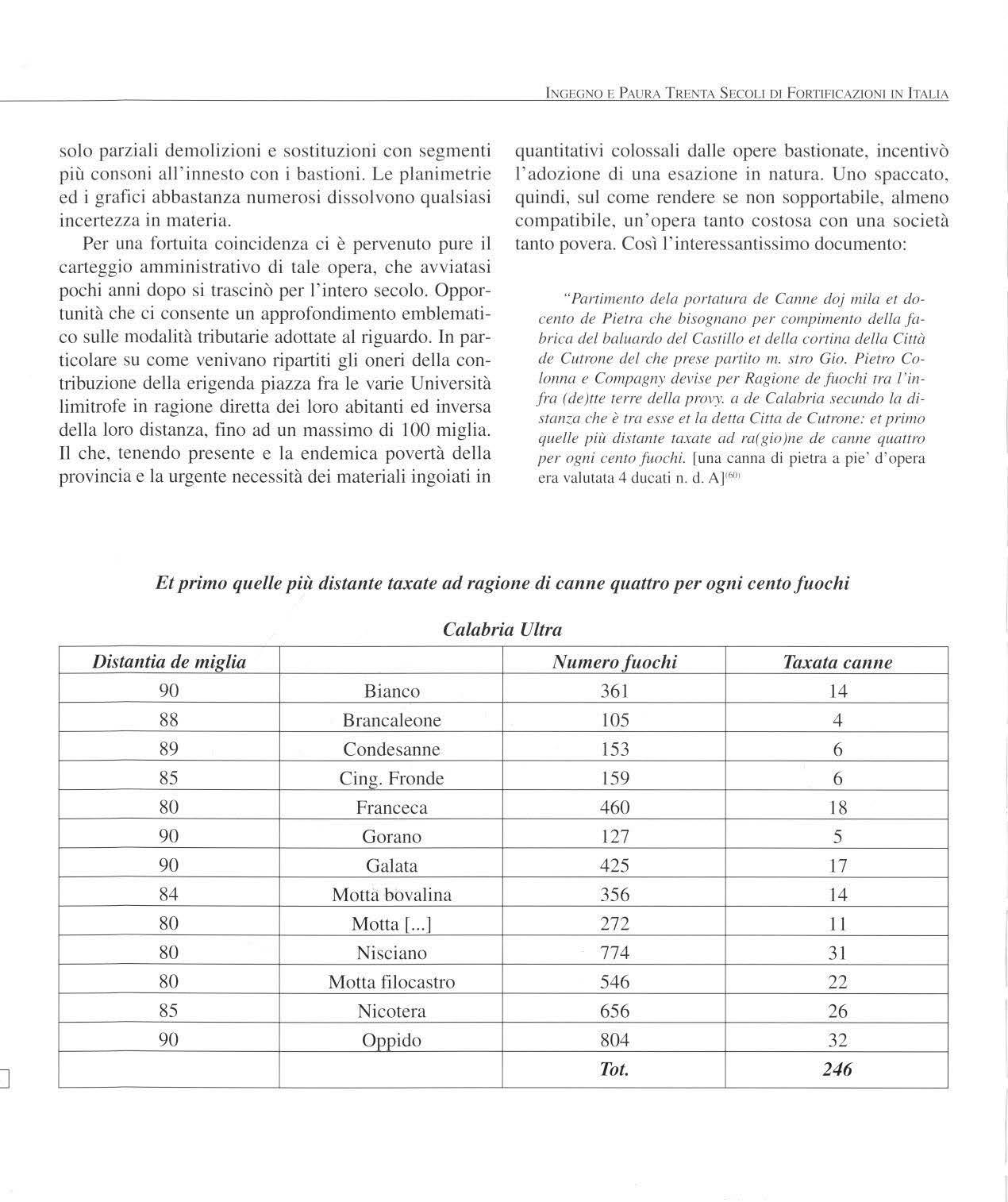
P er una fo11uita coincidenza ci è pervenuto pure il carteggio amministrativo di tale opera, che avviatasi pochi anni dopo si trascinò per l'intero seco lo . Opportunità che ci consente un approfondimento emblematico sulle modalità tributarie adottate al riguardo. In particolare su come venivano ripartiti gli oneri della cont1ibuzione della erigenda piazza fra le vruie Università limitrofe in ragione diretta dei loro abitanti ed inversa della loro distanza, fino ad un massi mo di I00 miglia. Il che, tenendo presente e la endemica povertà della provincia e la urgente necessità dei materiali ingoiati in
quantitativi colossali dalle opere bastionate, incentivò l'adozione dì una esazione in natura. Uno spaccato, quindi, s ul come rendere se non sopportabile, almeno compatibile, un 'ope ra tanto costosa con una società tanto povera. Così l'interessantissimo documento:
"Partimenlo de/a portatura de Canne doj mila et docento de Pietra che bisognano per compimento della fabrica del baluardo del Castillo et della cortina della Città de Cutrone del che prese partito m. stro Gio. Pietro ColOJzna e Compagny del'ise per Ragione de fuochi rra I 'infra (de)tte /erre della provv. a de Calabria secundo la disfllnza che è rra esse er la derra Cirta de Currone: et primo quelle più distante raxate ad ra(gio)ne de canne quattro per ogni cento fuochi. runa canna di pietra a pie ' d'opera era val utata 4 ducati n. d. A) <60 1
Et primo quelle più distante taxate ad ragione di canne quattro per ogni cento fuochi
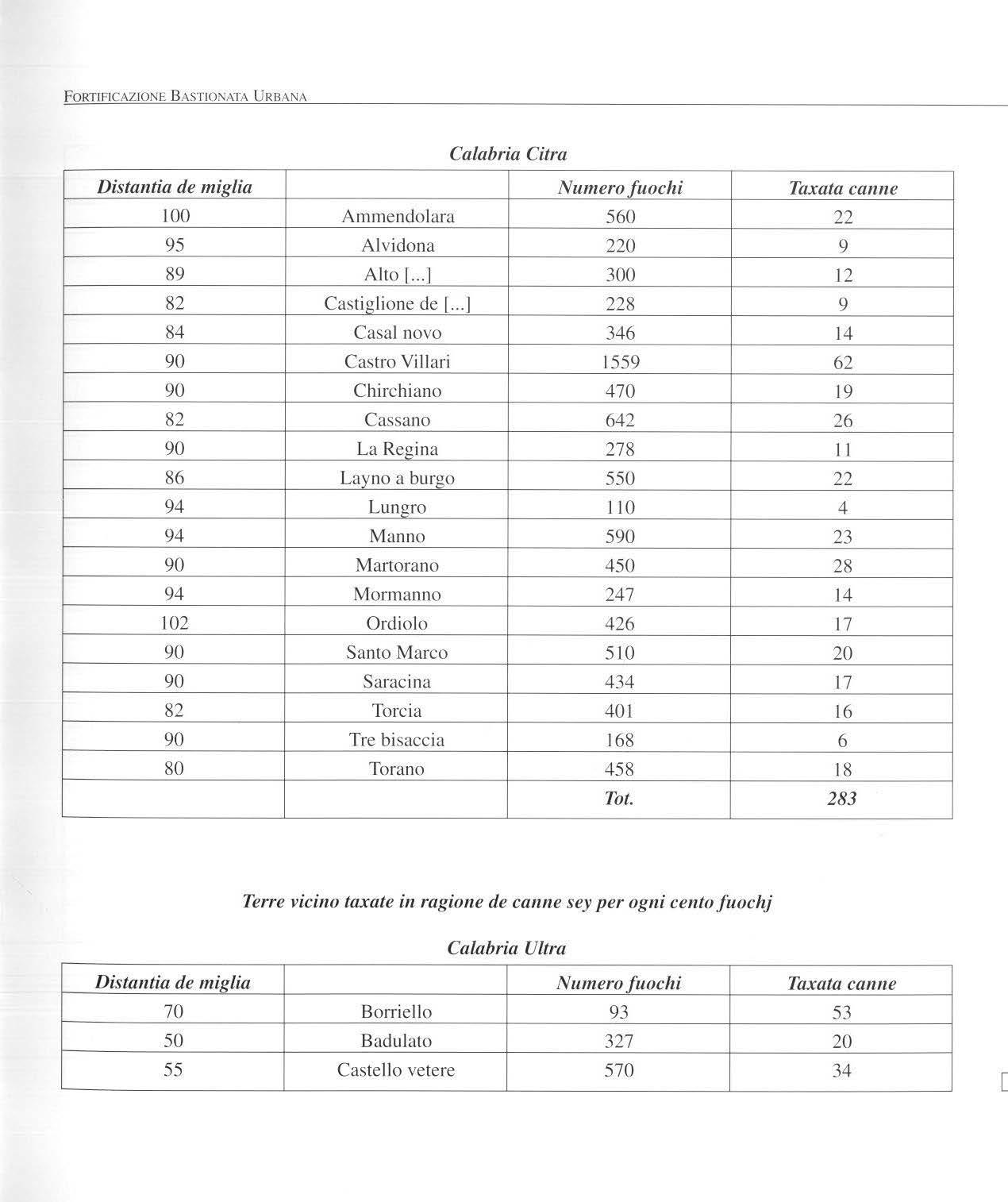

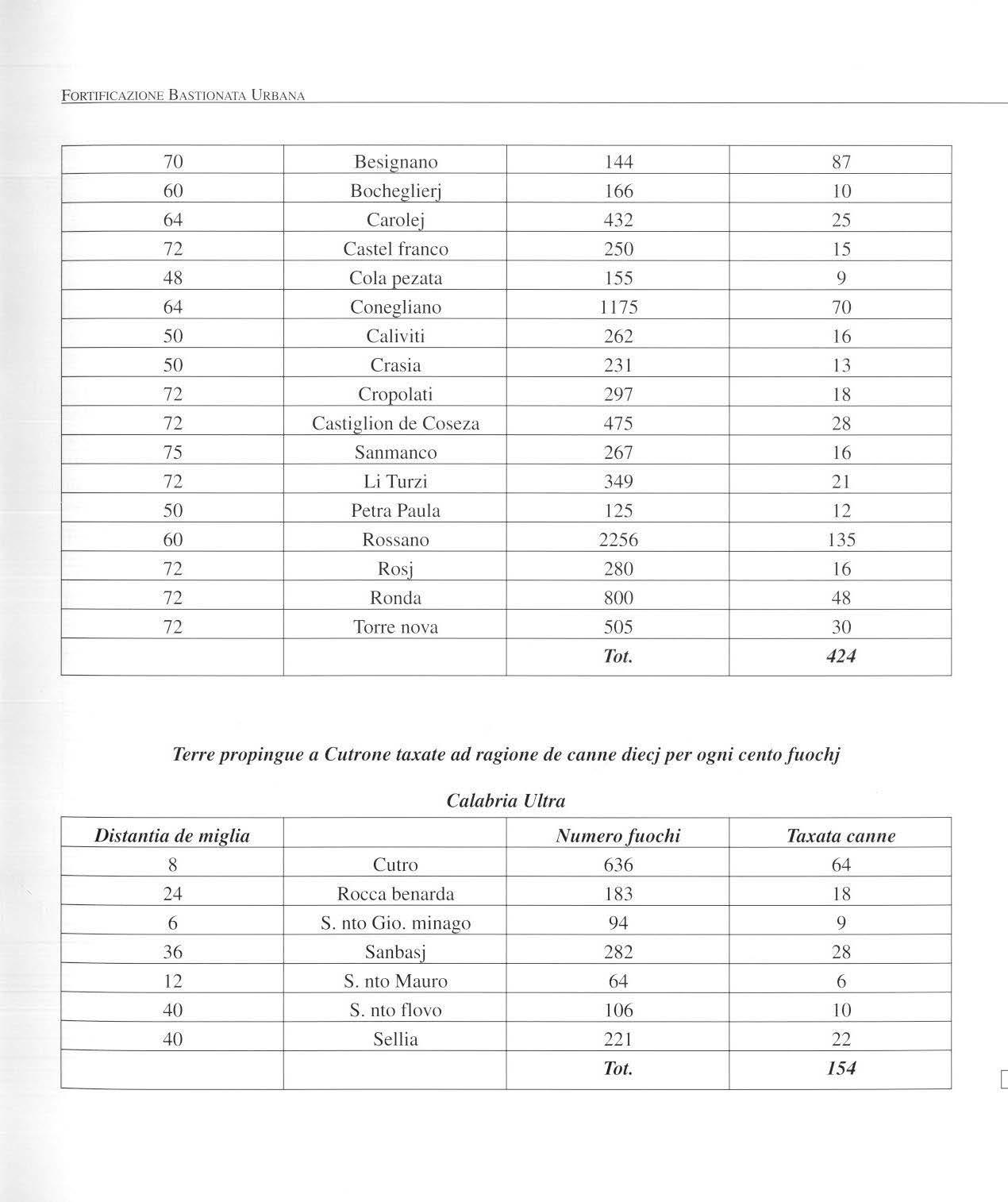
Terre taxate a dar carra per portar la frasca dalli boschi alle calcare et per basciar la piedra da far calce
marina et.far altri se rvitio per la ditta calce
Terre taxate a dar guastadori per agiutar a carri car [icare] et discaricar li calcare
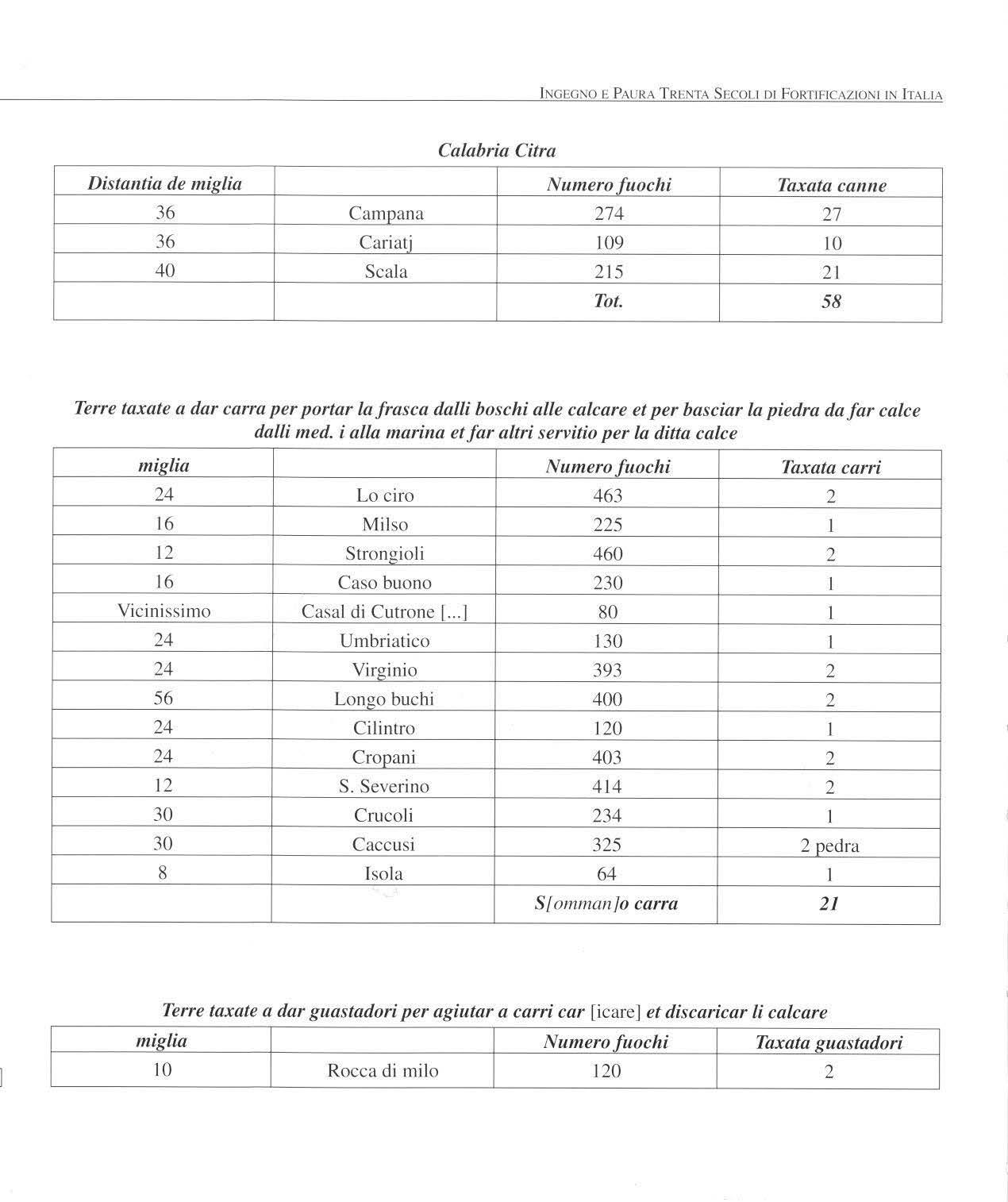
P er quanto deducibile l 'arti co l ato dispositivo dovette creare gravi problemi proprio ai comunì meno pover i, che tentarono di affra ncarsi da quell'anacronis tic a corvè , s ub- appa lt andola . L'alternativa, inizialmente se non autorizzata almeno tollerata dal commissario ge nera le de ll a fab bri ca, tal Rafael Mill as, dere spon sabi li zza nd o i diretti tributari fi nì però per provocare continue recriminazioni e contumelie fra i fornito ri e l a direzione lavori. Dal che la revoca con la seg uente apposita e de ttagliata ord in anza :
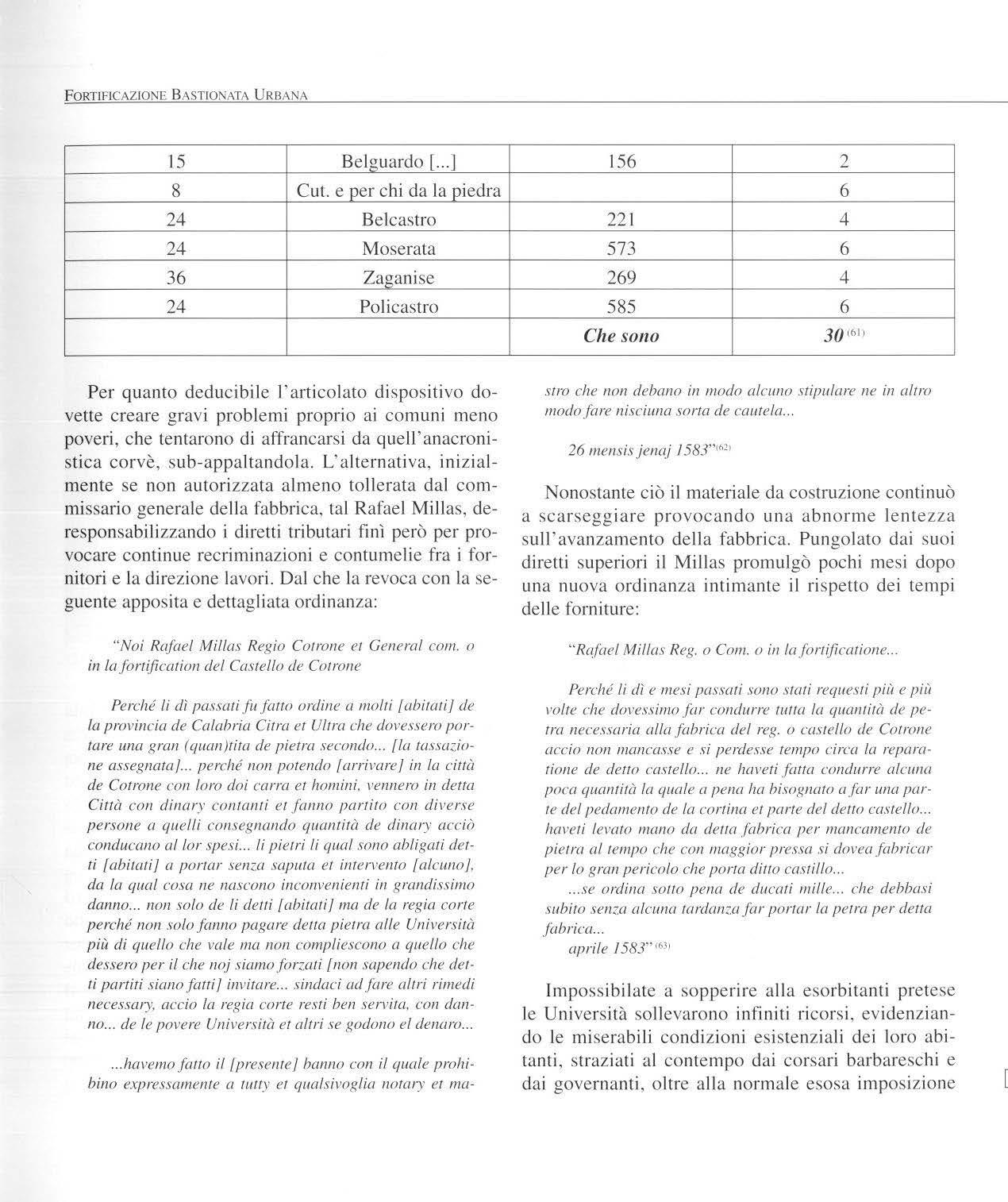
"Noi Rafael Mi/las R egio Co1ro11e e! Generai com. o in lafortifìcation del Castello de Co!rone
Perché li dì passati fu fatto ordine a molli [abitati} de la provincia de Calabria Citra et Ultra che dovessero portare una gran ( quan)tita de pietra secondo [la tassa;,ione assegnata] perché non potendo {arrivare] in la città de Cotro11e con loro doi carra et ho111ini, ve1111ero in detta Città con dinary conianti e! fanno partito con diverse persone a quelli consegnando quantità de dina,)' acciò conducano al lor spesi li pietri li qual sono abligati detti { abilati] a por1ar sen;.a saputa et intervento {alcuno], da la qual cosa ne nascono inconvenienti in grandiss im o danno non solo de li de/ti [abitati} ma de la regia cori e perché 11011 solo fanno pagare detta pietra alle Università più di quello che vale ma 11011 compliescono a quello che dessero per il che noj sia mo.forza li [non sapendo che de11i partiti siano fatti] invitare sindaci ad fare altri rimedi necessary. accio la regia corte resti ben servila, con danno ... de le povere Università et altri se godono el denaro ...
... havemo fatto il [preseme] banno con il quale prohibino expressamente a tutty et qualsivoglia 11otary et ma -
stro che non debano in modo alcuno stipulare ne in altro modo fare nisciuna sorta de cautela
26 mensis jenaj J583"' 6 11
Nonostante ciò i l materia l e da costruzione continuò a scarsegg iare provocando una abnorme lentezza sull'avanzamento della fabbrica. Pun go l ato dai suoi diretti superiori il Millas promulgò pochi mesi dopo una nuova ordina nza int im ante il rispetto dei tempi delle forniture:
"R(ioel
Perché li dì e mesi passati sono stati requesti più e più volte che dovessimo far condurre tutta la quantità de petra necessaria alla fabrica del reg. o castello de Cotrone accio non mancasse e si perdesse tempo circa la reparatione de detto castello ne haveti fatta condurre alcuna poca quantità la quale a pena ha bisognato a.far una parte del pedamento de la cortina et parte del detto castello ... haveti levato mano da det1a fabrica per mancamento de pietra al tempo che con maggior pressa si dovea .fabricar per lo gran pericolo che porta dillo casti/lo
. ..se ordina so flo pena de ducati mille ... che dehhasi subito sen;.a alcuna tardan--:.a far porlar la petra per della fabrica ...
aprile 1583" < 63
Imp oss ibilat e a sopperire alla esorb itanti pretese l e Università sollevarono infiniti ri corsi, evidenziando l e miserabili condiz ioni esistenziali dei l oro abitanti, straziat i a l conte mpo dai corsari barbaresc hi e dai governanti, oltre a ll a normale esosa imp osizione
fiscale ed alle ricorrenti epidemie . I mprobo accertare gli esiti di quelle opposizioni: di certo i materiali da costruzione continuarono a difettare, provocando lo stallo dei cantieri e la costipazione delle strutture non ancora ultimate da parte di una poverissima ediJizia abi t ativa che si appoggiava alle cortine della erigenda piazza.
T1 povero Millas ritenne a quel punto indispensabile un atto di fo r za che recidesse con una ennesima ordinanza l'intricato coacervo d' inadempienze ed illegalità: vietò perciò qualsiasi costruzione civile. I l ragionamento, peraltro non mancava di una certa logica: bloccando l 'e d il izia privata si rendevano disponibili molte maestranze qualificate, sempre sca rse . costrette da quel momento, per ovvi motivi, a lavorare anche con salari minimi. I noltre si monopolizzava l'e straz ione della pietra eliminando ogni concorrente. Non ultimo s i stimolavano le popolazioni limitrofe a prodigarsi ad ultimare le fortificazioni per pon-e rapidamente fine a ll a vessazione. Così il bando:
l NGEGNO E PA URA TR ENTA S ECOLI DJ FORTIFJ CAZIONI IK TTAI.IAPersino i ruderi finirono fagocitati in quella in saz iabile voragine, s is te m aticamente tras formati in comode cave. È importante, in conclusione. so ttolineare che le citate contribuzioni rappresentavano, comunque, una frazione esigua del costo complessivo delle opere e che il sis tema escogitato era valido soprattutto per la contrazione dei tempi , reperendos i all'epoca a buon mercato mano d'opera straordinaria. Un tu1ista dell'800 osservava stupito che nei bastioni di Crotone ogni s ingola pietra tradiva di: " ... essere antica perché g li ingegneti s pagnuoli, per ri s parmiarsi la pena di traspmtare da lontano il material e di fabb1ica. fecero quel che prima di loro si era già fatto nel le a ltre recenti costruzioni della città: vale a dire sfruttarono come una cava le rovine della Cotrone greca, s parse per la campagna " < 65 ' Mai come in quel caso non s i trattò di un risparmio di pena degli ingegneri ma la muta te stimo nianza dell'ennesima pen sa ta del regio commissario generale don Raffaele , il quale alla men peggio riuscì così ad ultimare la s ua piazza. che ri s ultò agli inizi del XVII seco lo una dell e miglio1i del Regno!

Pel'Ché m11l1i volti vennero ord inato che dobbiamo con ogni diligentia ull e ndere alla fahrica del Cas t e llo e, I della cerchia della} ci11à {questo e] quella accelerando quanto più. s ia possib ile fasso puhlicare il presente banno con il quale se ordina a tutti e qualsivoglia pers ona che 11011 debbano fabricare t anto dentren za come fora de la ci 1tù de Cotrone et 11wxit1111e vi c i110 l e 11111ra sen::,a espressa nostra licentia in scriptis ... so110 pena de d. ti mille
ltem ché 11esciu110 persona de qua/si voglia sfato grado e conditione se siano ardesca de wgliar petra nel territorio de Cotrone e t quella taglia/O ve ndere
l! e111 che nisciuna {persona}. .. vada nel territorio de Cotrone a tagliarfmsca e qu ella wgliata vendere [la legna se rvi va come combustibile per le fornaci del l a calce. altrimenti dette ca rcare n.d. A.J
Item nisciuna persona no possa ne debba nel territorio d e della Città de Cotrvne fare o far fare ca rea re de calce sen:a expressn licentia
die 16 111 e11sis july J583" 1641
Fu questa la piazza marittima sarda per antonomas ia e l ' unica costantemente aggiornata , sempre relativamente parlando . Giustamente rappo11andone le s ue fortificaz ioni al reticolo urbano la si è reputata piuttosto una fo rte zza abitata che u n abitato fortificato . Del resto s in dalla sua i n iziale aggregazione, verosimilmente intorno agli inizi del X II secolo, su ista n za genovese. la nota distintiva appare squis itamente difens iva.
Fu infat t i prop r io il porto, scalo maritt i mo floridiss imo e quindi ambito da molti pretendenti. che obbligò i Genovesi, o per meglio dire la famiglia Doria < 66 ', ad erigervi le p r ime mura. Sensato ravvisare a lle s palle di tanta prosperità il cosiddetto 'oro ro sso' il cora ll o < 67 > ed il s uo indotto dalla pesca alla lavorazione ed aUa commercia l izzazione. Non a caso le barche coralline sono state una presenza endemica lungo la banchina del porto di Alghero.
''Rafael Millas Reg. o Com. o fil la for1ijìca:ione
Non diversamente dalla tradizionale logica d'insediamento. la particolare natura del sito d'impianto su di un piccolo promontorio bagnato per tre lati dal mare ne determinò l'originaria configurazione planimetrica, che perman-à poi sos tanzialmente immutata per quasi sette seco]j, Per contro l'appartenenza alla sfera di interessi genovesi non si protrasse a lungo, pur non mutando la s ua fedeltà alla Repubblica. Già nel 1283, infatti, dopo uno stre nuo assedio condotto dalla flotta pisana, la cit l à dovette capitolare, ma so lo dopo la sconfitta della Meloria '68 > il destino sto1ico di Alghero ri su lta iITeversibilmente segna to. Caparbiamente i s uoi abitanti riuscirono a procrastinare la l oro fagocitazione nei possedimenti della Corona a· Aragona cui erano stati assegnati da Bonifacio VIII per quas i sessa nta anni. Nel 1353, però, Pietro III d 'A ragona, conscio del la rilevanza strateg ica di que ll a fiera

cittadina , ne pretese la definitiva sottomissione, avviandone con l ' avvento dell'estate la conquista tramite una massiccia spedizione anfibia. Il positivo esito non gratificò il sovrano, tanto più che l'entità demografica di quell'infida conquista non eccedeva l 'eq uipaggio di una galera! Ad ogni buon conto su l fi nire di quel secolo A l ghero appariva una piccola enclave di catalani potentemente fo rtifi cata aJJ 'i nterno di una grande iso la pressoché disabitata.
Tutti i ricorrenti tentativi di riconquistare la città espletati da Genova in quello scorc io storico. s i infran sero sempre contro l e s ue inviolabili fortificazioni. Anche quando i Francesi nel l 412, osarono inv est ire d'as sedio la pia zza, se ne dovettero 1itrarre dopo aver subito sa nguino se perdite . Nessuna meraviglia pertanto che quelle dife se fossero sis tematicamente riparate e freguentement.e potenziate. Ancora nel 1424 s i ap-
paltavano s arciture di le s ioni e di sgrottamenti di fondazion e, prodotti come in tutt e l e piaz ze marittime dalle mareggiate, nonché s os tituzioni degli apparati a sporgere ammalorati.
Circa un seco lo dopo il quadro risulta profondamente mutato: le mura che circondano Alghero giacciono da te mpo abbandonate ed appaiono giubilate e fatiscenti esattamente come quell e delle altre cittadine s arde. Ne approfittarono i France si che , attaccata l' isol a nel 1527, saccheggiarono Sassari , m e ntre un contingente franco-genovese, agli ordini del Daria, comparve a largo cli Alghero. Nel timore di un assalto combinato eia mare e da tena, i difensori affondarono all ' imboc c atura del porto numero se coralline cariche di maci g ni, ostruendolo totalmente. Il dra co niano es pedi e nte dettato dal te n-ore , a campagna conclusa, s i rivelò il peggiore danno s ubìto dalla piazza, responsabile dell 'a nnient a mento della lucro s iss ima pesca del
corallo. Ed al contempo costituì un esplicito seg nal e d 'a llarm e c irca l a sua inadegua te zza difensiva.
Nel 1541 Carlo V, agli ini z i di ottobre, in procint o di sa lpare con la s ua flotta per l'impresa algerina, sos tò alcuni giorni a d Alghero, cog liendo l'occasione per ispezionarne personalmente lo stato delle fo11ificazioni. Stando alle solite mirabolanti cronache ne res tò talmente ammirato d a lodarle con gli astanti. Più veros imile che tanto compiacimento. se mai provato , fosse limitato alla so la torr e d e ll ' Es però piuttosto che alla cerchia nella s ua intere zza
Qual.i fortificazioni infatti avrebbe visto in quel momento da giustific,u-e tanta ammirazione?
Di certo agli occlù dell ' imperatore non comparve affatto una cerchia bastionata, ma una anacronistica murazione turrita raffa zzo nata e rabberciata alla meglio, differenza s ignific at i va e rimarchevol e, tale co-
 117 Al ghero to rre dell' Es però.
INGEGNO E PA U RA TR ENTA SECOLJ DI FORTIFICAZION I IN I TALIA
117 Al ghero to rre dell' Es però.
INGEGNO E PA U RA TR ENTA SECOLJ DI FORTIFICAZION I IN I TALIA
munque da non poter certo su scitare entu s iasmi di sorta. Massicce, quanto s i voglia , mura e torrioni non appartenevano più al rep e rtorio difensivo rina s cimentale e nes s un militare al loro cospetto ne avrebbe tratto motivo di orgoglio. Ed infatli ad onta della proverbiale lentezza della burocrazia spagnola, appena pochi anni dopo l'ingegnere Rocco Capellino s i portò in Alghero per s tudiarne le ormai improcra s tinabili nuove fortificazioni, la sciandoci alquanti disegni delle poss ibili soluzioni.
I dettagliati grafici preliminari del celebre ingegnere, redatti nella duplice forma cli rili e vo dell ' e s istente e di progetto di ma s sin, ':i, ci consentono alcune significative preci s azioni. La prima è ins ita proprio nell'e ssere il suddetto rilievo quello di una cinta turrita , conseguendone irrefutabilmente che fino alla metà del
'500 que s ta fosse la sola ed unica fortificazione di Alghero , tanto da poter essere facilmente mi surata. Ness una tracci a di bas tionature , compl e te od in alle s timento: la principale piazzaforte s arda è sempre racchiu s a nelle sue mura medievali!
In merito a queste , infine , s i impongono alcun e sintetiche osservazioni. Innanzitutto e s se appaiono differenziate, come logico in una piazza marittima , in fronte a teti-a più robusto e con più torrioni propriamente detti e fronte a mare, dall'andamento molto irregolare per l'adeguamento foraneo , scandito d a num e ro s is sim e toJTette a pianta quadrata , fors e pe rs ino troppe per e ss er tali. Potrebbe e ssers i trattato, infatti, piuttosto di contraffo11i o cli aggetti per un mode s to fiancheggiamento 169 ) Su quell ' arcaico di spos itivo, comunque , quasi all a met à del XVI secolo , s i s arebbe [
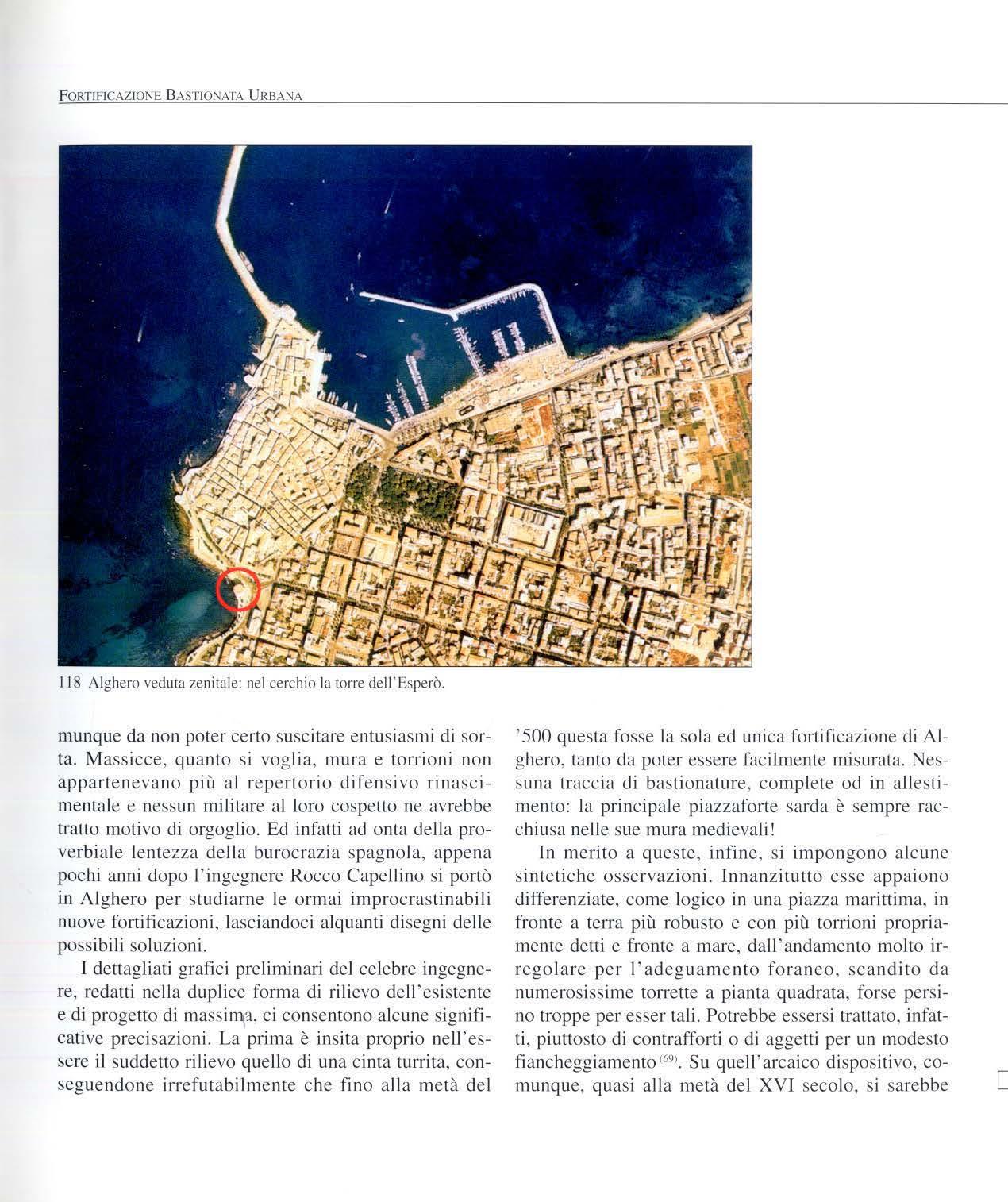
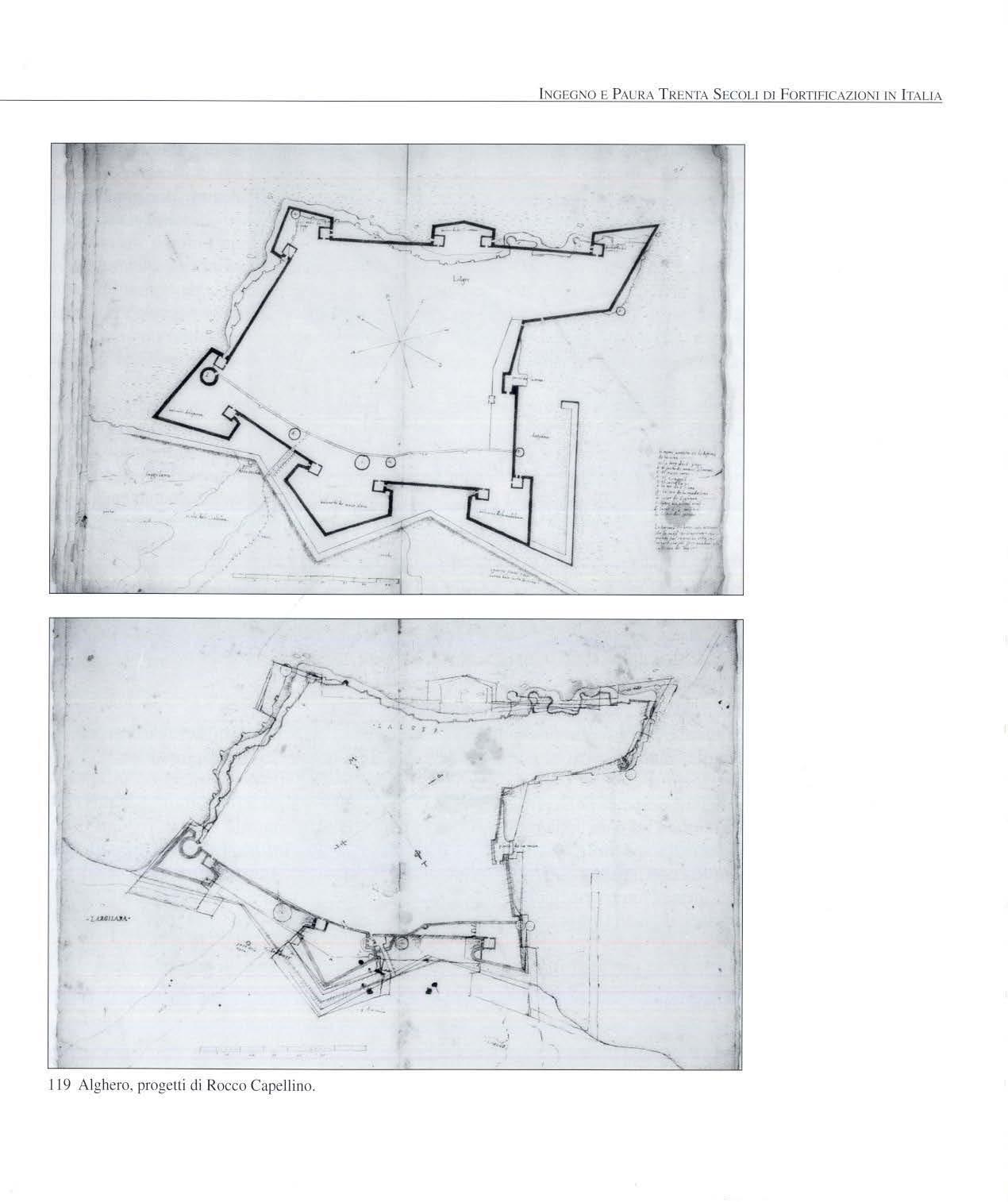
dovuto innestare il progetto de l Cape llin o. tramite la prassi detta del "'tracc i amento interno" 1701 , rispetto ad un id ea l e poligono. È ab basta nza sempli ce per noi sulla falsariga di quei disegni indi v iduarne la logica d'inter ve nto e rico struire l a dinamica dimensionale dell'elaborato. La prima infatti è in eq uivo ca b ilmente finaliz za ta alla e dificazione di una cinta bast io nata in linea con i tempi, inglobante nel suo fronte a mar e una vasta darse na , anch ' essa fortificata. La seconda, invece, per la ril eva nza che assumerà la pi azza. ri ch iede un maggior a ppro fond i mento.
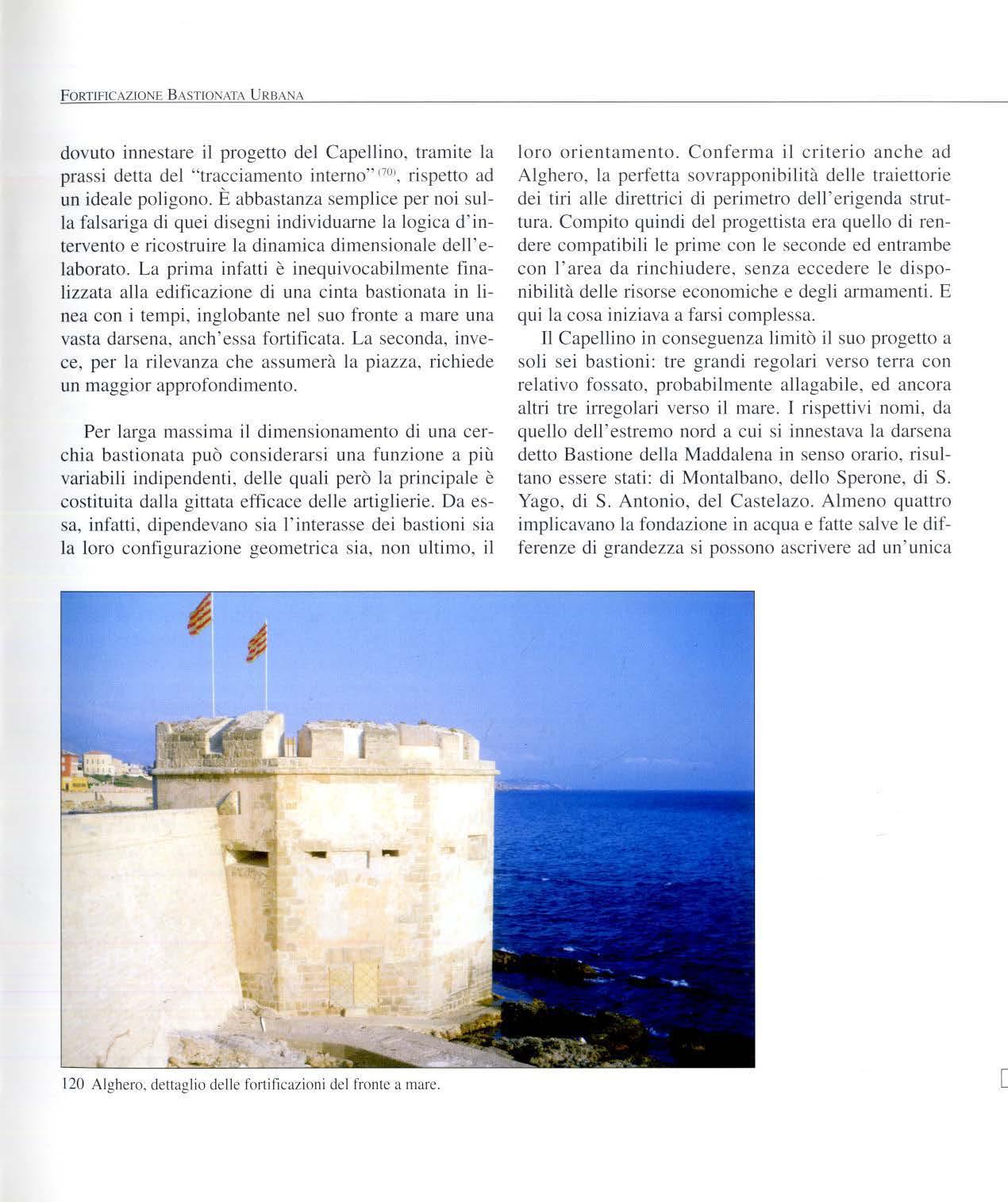
P er larga ma ss ima il dim e ns io namento cli una ce rchia bast ion ata può considerarsi una funzi o ne a più variabili indipendenti, d e ll e quali però la principale è costituita dalla g ittata efficac e delle artiglierie. D a essa, infatti , dipendevano s i a l 'i nt erasse dei bast ioni s ia la loro co nfi g urazi o ne geome tric a s ia , non ultimo, il
loro orientamento. Conferma il cri terio anche ad Alghero, la perfetta sovrappo nibili tà delle traiettorie dei tiri alle direttrici di perimetro dell'erigenda stru ttura. Compito quindi del progettista era quello di rendere compatibili le prime co n le seco nd e ed e ntramb e co n l'area da rinchiudere , senza eccedere le disponibili tà delle risorse eco nomi che e deg1i armamenti. E qui l a cosa ini z ia va a farsi complessa.
Il Capellino in co nseg ue nza limit ò il s uo progetto a so li se i bastioni: tr e grandi regolari verso terra con re lati vo fossato, probabilmente allaga bil e, ed ancora al tri tre itTego ]a ri ve rso il m are . I rispettivi nomi, da qu e llo dell'estremo nord a cui si innestava la da rsena detto Bas tion e della Maddal e na in senso ormio, risultano esse re s tati: di M o ntalban o, dello Sperone, di S. Yago. di S. Antonio, del Castelazo. Almeno quattro imp l icavano la fondazione in acqua e fatte sa lve le differenze di g rand ezza si possono asc ri ver e ad un 'unica
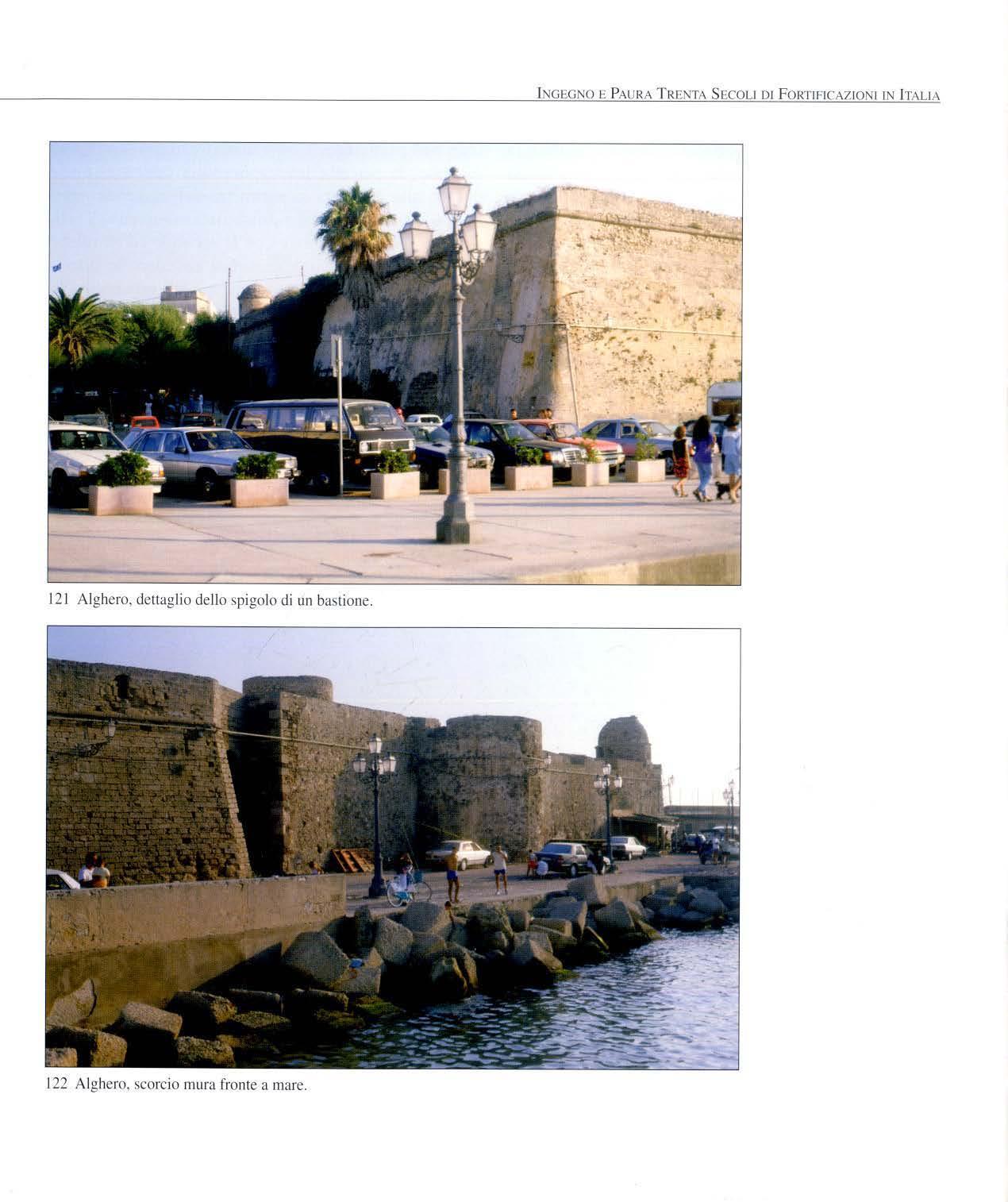
tipologia, quella pentagonale con fianchi rientranti a musone, con casematte quadrate accessi bi Ii dall' interno della piazza, e troniere traditrici. Il fossato, cavato in stretta corrispondenza con i bastioni , appare sul grafico sprovvisto del muro di controscarpa, caratteristica senza dubbio conseguente alla natura rocciosa del suolo puntualmente evidenziata dal Capellino.
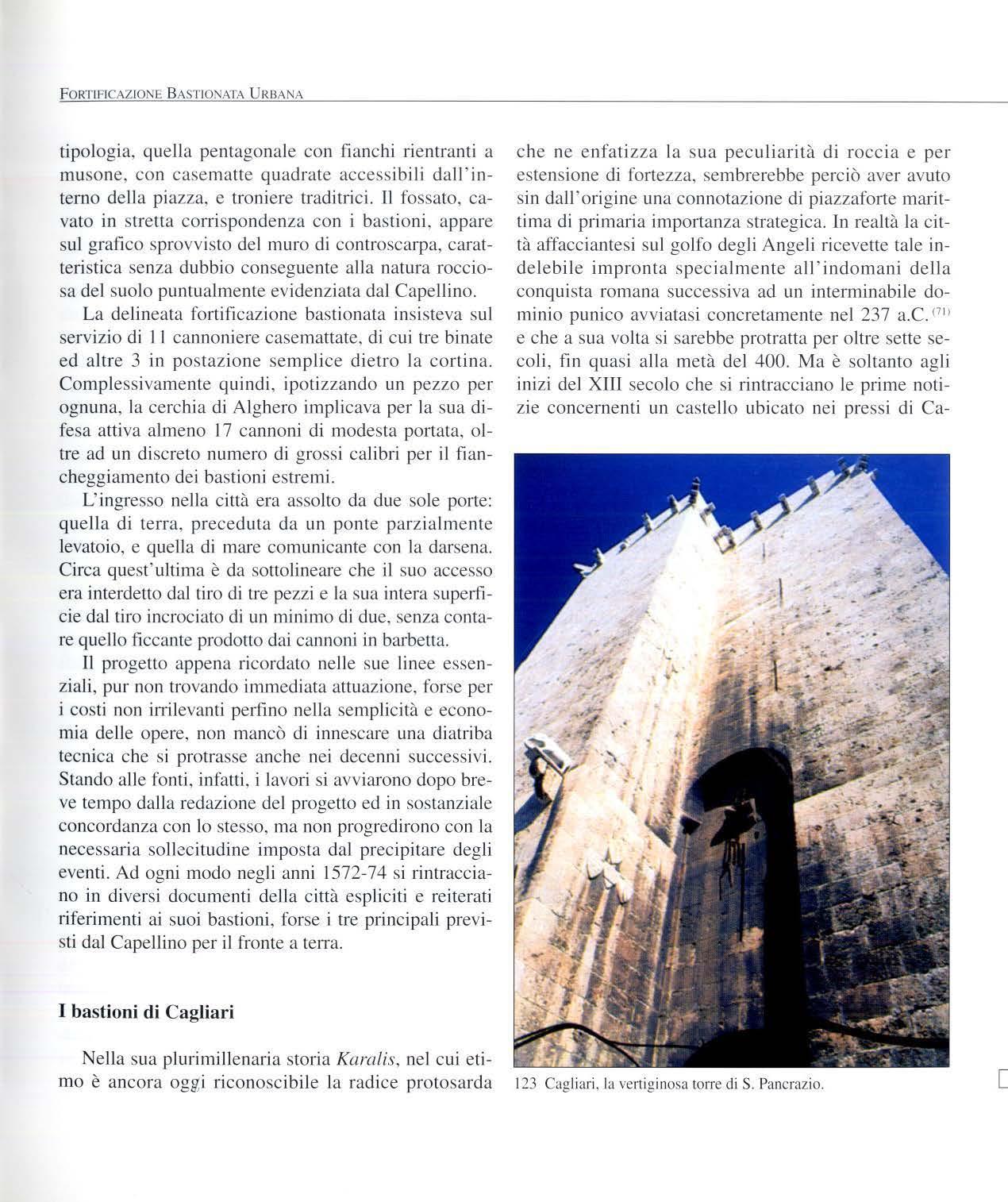
La delineata fortificazione bastionata insisteva sul servizio di 11 cannoniere casemattate, di cui tre binate ed altre 3 in postazione semplice dietro la cortina. Complessivamente quindi, ipotizzando un pezzo per ognuna, la cerchia di Alghero implicava per la sua difesa attiva almeno 17 cannoni di modesta portata, oltre ad un discreto numero di grossi calibri per il fiancheggiamento dei bastioni estremi.
L'ingresso nella città era assolto da due sole porte: quella di terra, preceduta da un ponte parzialmente levatoio, e quella di mare comunicante con la darsena. Circa que s t'ultima è da sottolineare che il suo accesso era interdetto dal tiro di tre pezzi e la sua intera supetiìcie dal tiro incrociato di un minimo di due, senza contare quello ficcante prodotto dai cannoni in barbetta.
Il progetto appena ricordato nelle sue linee essenziali, pur non trovando immediata attuazione, forse per i costi non irrilevanti perfino nella semplicità e economia delle opere, non mancò di innescare una diatriba tecnica che si protrasse anche nei decenni successivi. Stando alle fonti, infatti, i lavori si avviarono dopo breve tempo dalla redazione del progetto ed in sostanziale concordanza con lo stesso, ma non progredirono con la necessaria sollecitudine imposta dal precipitare degli eventi. Ad ogni modo negli anni 1572-74 si rintracciano .in diversi documenti della città espliciti e reiterati riferimenti ai suoi bastioni, forse i tre principali previsti dal Capellino per il fronte a te1n.
che ne e nfati zza la sua peculiarità di roccia e per estensione di fortezza, sembre rebbe perciò aver avuto s in dall ' origine una connotazione di piazzaforte marittima di primaria importanza strategica . In realtà la città affacciantesi sul golfo degli Angeli ricevette tale indelebile impronta specialmente all'indomani della conquista romana successiva ad un interminabile dominio punico avviatasi concretamente nel 237 a.C. 0 1 > e che a sua volta si sare bbe protratta per oltre sette secol i, fin quasi alla metà del 400. Ma è so ltanto agli inizi del XIU seco lo che si rintracciano le prime notizie concernenti un castello ubicato nei pressi di Ca-
Nella sua plurimillenaria stmia Karalis, nel cui eti-
gliari su di una collina, costruito dai Pisani , assurti nel frattempo a padroni di turno della città e di buona parte dell'isola. Di certo la presenza pisana stabilmente insediatasi, oltre al discusso caposaldo di S. Michele, impresse una vistosa riqualificazione all'apparato portuale correlandolo alla città che contemporaneamente presero a fortificare, ammorzandone le possenti murazioni ai fianchi di una vasta collina. Sulla stessa, inoltre, eressero altissime torri apicali, con soluzioni d'impianto talmente accorte da non subire più modifiche future.
In pratica: " .l'autentico colpo di genio dei pisani fu di impadronirsi dì quel certo colle e di fortificarlo. È una svolta importante nell'evoluzione urbana e sociale di Cagliari, che per lunghi secoli ve1Tà caratterizzata da una presenza così ingombrante e da una funzione quasi esclusiva: quella militare. Con la differenza che mentre per i pisani Castello e fortificazioni erano solo il presupposto di un vivo dinamismo economico, i s uccessivi dominatori li renderanno lo scopo stesso dell 'es istenza della città. In mancanza di prove contrarie, il colle si può ritenere beniss imo vuoto di costruzioni di qualche significato quando i pisani se ne impadroniscono , e si presentava come una stretta rocca naturale, di forma trapezoidale, di circa venti ettar i, col lato più corto rivolto verso la Marina e il lato più lun go, quasi uno strapiombo di una trentina di metri che non richiedeva alcuna opera muraria, ad oriente su un piano sensibilmente inclinato verso il mare. Non è possibile determinare con sic urezza le varie fasi di costruz ione delle torri e delle altre opere difensive: l'unico punto fenno riguarda l 'ed ifi cazione delle spettacolose torri di S. Pan crazio e del Leone , le prime due elevate ri spettivamente nel 1305 e nel 1307 da tal Giovanni Capula architector optimus ritenuto di nazionalità sarda..." <72 )

Al di là della eccezionale rilevanza architettonica è indubbio che sotto il profilo militare l 'edificazione delle mura e delle vert i g ino se toITi tradiva un co n testo di paventata minaccia aragonese contro la città. Il timore sembra a n zi addirittura crescere con lo scorrere
degli anni, tanto da imprimere a Cagliari, in breve volgere, la definitiva trasformazione in munitissima piazzaforte, forse tra le migliori del momento. La natura dei luoghi e le opere dell 'uomo congiurarono a connotarla come inespugnabile , fama del resto, alla luce dei successivi eventi bellici, pienamente meritata.
In dettaglio la cinta urbica dell 'epoca risulta: " ... quadrangolare, ma le porte, ciascuna cinta a sua volta di mura , fossi e dotata di ponte levatoio e di porta falsa, sono so ltanto tre in con-ispondenza delle tre torri maggiori, e di queste certamente più antiche: a sud quella del Leone per le comunicazioni con la Marina; a ovest col quartiere di Stampace que1Ja dell'Elefante ... a nord verso i Campidani e guardata dal non lontano castello di S . Michel e quella di S. Pancra z io; nessuna comunicazione diretta , invece, con Villanova, sovrastata com'era dalla rupe rettilinea " m 1•
Nella Città risiedevano all'epoca circa 20.000 abitanti, consistenza demografica intorno alla quale in effetti oscillò fra l'età romana ed il XIX secolo. Urbanisticamente non differiva poi dagli altri equivalenti centri medievali italiani, con strade longitudinali strette e vicoli trasversali ancora più st retti, lungo i quali gravitavano basse casupole a due piani, senza alcun palazzo propriamente detto e meno che mai case -t orri o signorili. Gli eventi militari che videro coinvolte di lì a breve le rievocate fortificazioni possono s intetizzarsi nella loro consegna ad Alfonso IV, avvenuta il 9 g iu g n o del 1326. Ces sava così dopo ottanta anni il dominio di Pisa e si instaurava quello aragonese che, a sua volta, si sa rebb e protratto per quasi un seco lo e mezzo.
Il nuovo sovrano intraprese immediatamente una vasta ri stru ttura zione delle difese cagliaritane, accentuandone la già rilevante grandiosità. Esauriti gli interventi nel 1345 occorsero, significat ivamente, ben 31 anni prima che qualcuno osasse investirle e quando ciò avvenne per iniziativa degli Arboresi fu giocoforza desistervi, dopo una lunga se rie di inconcludenti assa lti. Altri potenziamenti sulle mede sime strutture si elabora r o n o, ed in parte si attuarono, su volere di re
lNGEG NO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN lMartino nel 1396. Questa volta per rintracciare un significativo episodio ossidionale contro il Kastrum Calaris si devono attendere 77 anni: ed ancora una volta le possenti mura urbiche non capitolano di fronte alle truppe Arboresi, comandate da L eonardo Alagon. Analogo esito, tre anni dopo, frustrò gli sforzi di s uo figlio Artaldo , che vide i suoi risoluti impeti infrangersi contro la micidiale murazione. In conclusione l'intera dinastia aragonese si avvicendò al riparo delle inviolabili opere della capitale, esaurendosi infine nel 15 l 6, anno in cu i la Sardegna facente parte dei beni della Corona d'Aragona si ritrovò nell'Impero spagnolo restandovi per quasi due secoli e mezzo 0 4 l
Come in d iverse altre città anche la riqualificazione difensiva di Cagliari prende l'avvio da una visita di Carlo V. Per l'esattezza nel giugno del 1535, quando nel quadro dell'operazione di conquista di Tunisi, l'intera flotta s pagnola e dei suoi alleati si raduna nel golfo di Cagliari. Il giorno l l l'imperatore sbarca e visita la città. Ri serva una particolare attenzione alle sue fortificazioni, che valuta per quello che so no: anacronistiche e necessitanti di riqualificazione radicale. Del resto l'idoneità del sito quale piazza marittima, con quell'eccezionale brulichio di navi comodamente a ll a fonda, si perorava da sé Fu la logica scel ta del momento e sarà la nu ova veste di Cagliari per i secoli a veni re. Il successo della spedizione nordafricana ed il conseguente trionfalismo provocarono , però , il rinvio indeterminato dell'aggiornamento della cerchia.
P er la verità qualche premessa g i à vi era stata ag li inizi del '500, proprio p resso l a torre di S. P ancrazio, mirante alla creazione di un moderno baluardo, per neutralizzare in qualche modo la om1a i fin troppo palese v uln erab ilità del setto re. li v ice ré Dusa i n e fu l'artefice 0 5 1 : l'allora imperatore Ferdinando il Cattolico vag li atone il progettò lo reputò dilettantesco e vell eitario, intimando di avvale rsi per l 'avvenire delle prestazioni di tecnici qualificati , evitando lo sperpero di denaro pubblico.
T rascorsero così quindici anni ed il sopraggiun t o vicerè Fe rn andez de H eredia ritenne ormai impro -
crastinabile la riqualificazione delle fo1tificazioni di Cagliari. Del resto le conseguenze della spedizione nordafricana del 1541 , risoltasi in un tragico disastro sotto le mura di Algeri, sembravano incentivare l ' iniziativa. Stando alla tradizione corrente, il de Heredia inviò al iiguardo una relazione, illustrata al sovrano dal governatore di Cagliaii, don Gerolamo de Aragal. L' imperatore, vuoi per tener fede ad una vecchia promessa, vuoi per lo stimolo del precipitare degli eventi, oltre all'impegno formale, diede finalmente seguito al programma, nominando quale ingegnere preposto alla redazion e de l progetto specifico, nonché alla conseguente direzione dei l avori il cremonese Rocco Capellino.
Da quel momento i tempi di attuazione se mbrano assumere un andame n to accelerato, tant'è che l' ingegnere tornato i n Sardegna nel l 552, può già nel '53 dichiarare compiuto il bastione della Leona , intervallo che conferma pienamente la solerzia con cui furono affrontati i lavori. Nel 1568, l'opera del Capellino sarebbe stata praticamente ultimata, avendo richiesto appena quindici anni, t e mpo non eccessivo per quel tipo d'intervento.
In realtà, s i deve ritenere che i lavori piuttosto che a comp im ento fossero soltanto imbastiti, sostanzialmente operativi però secondo la pras s i dell 'e poca. Il Capellino, parallelamente al l 'ava nzamento delle opere, redasse una ser ie di appunti ed annotazioni planimetriche graz i e ai quali è possibile ricostruire le fasi ciel s uo intervento a Cagliari. P articolarmente utile è un rilievo della piazza che appai·e frazionata in tre sezioni: il balu ardo di S. Pancrazio, il Castello di Cagliari ed il borgo della Marina.
Propr io il baluardo di S. Pancrazio fu l'oggetto iniziale della ristrutturazione del cremonese, a seguito della sua disastrosa conformazione . Alle deficitarie s truttur e furon o perciò aggregate alcune bastionature, dotate di fossato antistante . In tal modo s i veniva a proteggere specialme nt e il lato occide nt ale, nel quale s i ap ri va l ' unica porta del settore, attraversata da una stradina che conduceva a ll a chiesa di S. P a n crazio. App aiono ben ev id enz iate, a ll 'i ncrocio dei due bastioni a
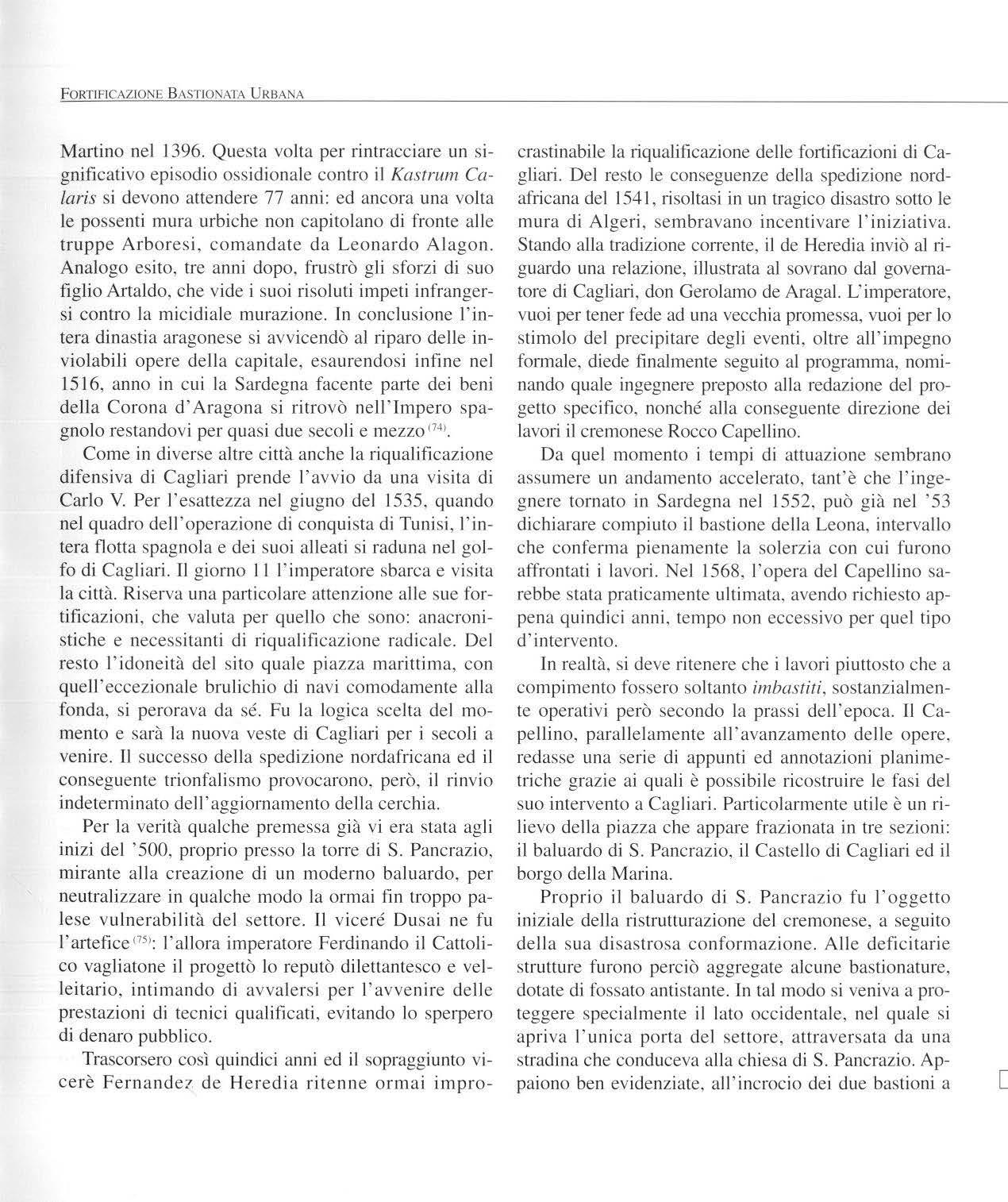
124 Cagliari. progetto di Rocco Capellino.
nord, le cannoniere. All ' interno del baluardo la compartimentazione originale permase, con il fossato ed il ponte levatoio. Entrambi gli ostacoli progressivi veniva no a trovarsi sotto il tiro della t01Te di S. Pancrazio, che risultando per i nuovi avancorpi alquanro arretrata, recuperava una significativa validità. Attraverso essa si accedeva al Castello propriamente detto. L ' intervento fu ultimato nel 1563.
In merito al Castello, il Capellino, analogamente a quanto attuato con il baluardo, non fortifica quasi il lato verso Villanova, di per sé abbondantemente protetto dagli strapiombi e dalle rocce d'impianto, ma vi. conserva la vecchia rnurazione, spiccata sul ciglio tattico. A partire dalla T one del Leone che rispetta, vi erige un secondo bastione, ovv iam ente del Leone, a g ua rdi a della omonima porta.
Fu questo il primo ad essere ultimato nel 1553. Una deviazione di 90° rappresentava da quel punto
l'origine del nuovo perimetro difensivo prospiciente il borgo della Marina. Detta sezione appare serrata fra due bastioni pentagonali, parzialmente conformati, come il rilievo autografo attesta , con troniere traditrici spazzanti la cortina interposta e le facce degli stessi.
Vi è da osservare al riguardo che nel suddetto grafico i bastioni in questione sono p ri vi di spalle rientrate per il miglior defilamento delle troniere, privi cioè tanto di musoni che di orecchioni. Tuttavia, sulla lin ea marcata di perimetro s i osserva una seconda traccia sottile nella quale, invece, vi è chiaramente proposto l'arrotondamento da aggiungersi ai bastioni medesimi, del tipo perciò ad orecchione. Nei progetti del Fratin ° 61 il dettaglio risulta ormai acquisito, a lmeno per quei primi due bastioni, mentre permangono ancora oggi senza il caratteristico arrotondamento, probabilmente non ritenuto indi-
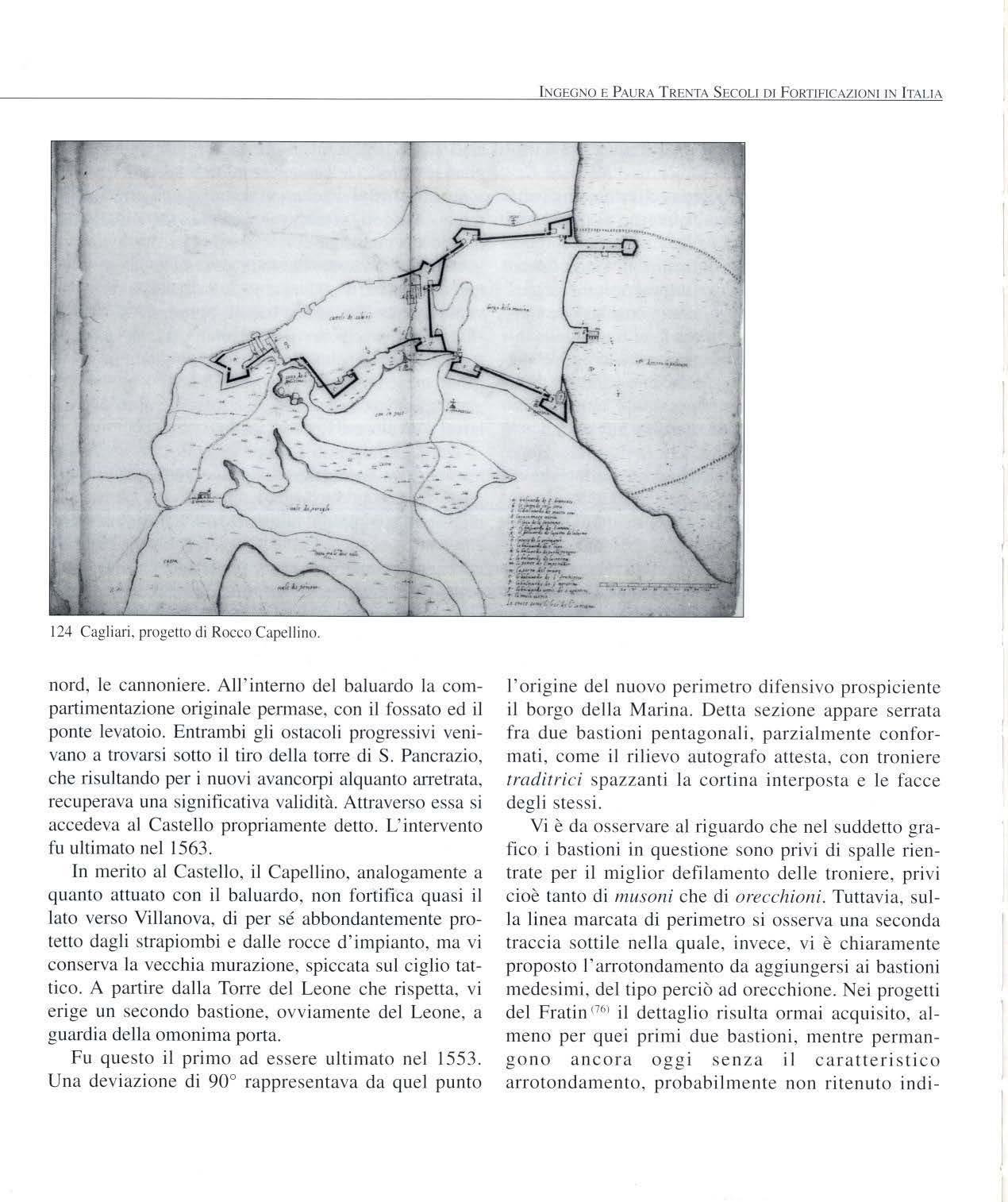
spensabile in relazione ad una loro presunta minore vu ln erabilità.
In ossequio alla tradizione militare i citati bastioni si chiamavano rispettivamente l ' uno del lo Sperone e l'altro di S. Antonio del Salice, minuziosamente citati nella legenda del progetto del cremonese. P arimenti sullo stesso doc um e n to è facile cogliere, in posizione a lqu anto più interna della cortina bastionata, la prees istente murazione turrita, in cui si apriva la Porta del L eone, difesa da ll a sovrastante torre omonima.
Appena scapoJa to il secondo bas tione , quello di S. Antonio, il tracciato compiva una seconda virata di al -
tri 90° c irca, fiancheggiando Stampace (che l'ingegnere riporta nella sua dicitura pisana arcaica di Sta in Pace). Infatti a partire dalla Porta dell'Elefante aprentesi immediatamente a rido sso dell ' orecchione del bas tione e guardata dalla reintegrata omonima torre , la cortina proseguiva con andamento quasi rettilineo, fino al successivo bastione detto de ,nosen Osai che diven-à in seguito di S. Giov ann i (qu indi di S. Croce). Qui un'ultima deviazione ortogonale la ricollegava con il baluardo di S. Pancra zio. La configurazione planimetrica complessiva risultante era. per larga approssimazione, quella di un grosso trapezio isoscele ai cui vertici s i ammorzavano i tre bastioni ed il propugnacolo di S. Pancra z io.
Ma ancora un'altra area distinta venne fortificata dal Capellino: quella del borgo della Marina. P er le s ue bastionature però si deve ipotizzare una edificazione radicale e non riqualificativa. Ciò s i g iu st ificava per essere quella la zona a più alto rischio in caso d'assedio, come d'incursione , in quanto assolutamente priva delle asprezze orogenetiche che preservavano g li altri due settori. Obbligatorio quindi un più vasto ricorso all'arte.

Sempre secondo il so lito percorso orario gli elementi nodali dife ns ivi del borgo , dal suo innes to con il bastione del Leone, possono così identificarsi: un primo bastione pentagonale, s ul lato orientale detto baluardo de S. la go, completato nel 1562, anch 'es so dotato di cannoniere traditrici. A questo seg uiva, in posizione verticist ica , quello ricordato dal progettista come baluardo de porto fangoso alla cui gola lato sud s i innestava il lungo molo, terminante a sua volta nel baluardo de la reina.
La costa re stava racchiusa così da due archi murari, separat i al centro da una porta chiamata logicamente di Mare preceduta da un pontile appellato , per ovvi motivi e note r e mini scenze storiche , dell ' I mperatore. Quindi un altro bastione verticistico , quello di S. Agustina, inglobante il baluardo vet io de S. Agustina. Il grafico del Cape llin o ci tramanda inoltre una v is to sa pali zzata che recingeva il porto interdicendolo. Il suo
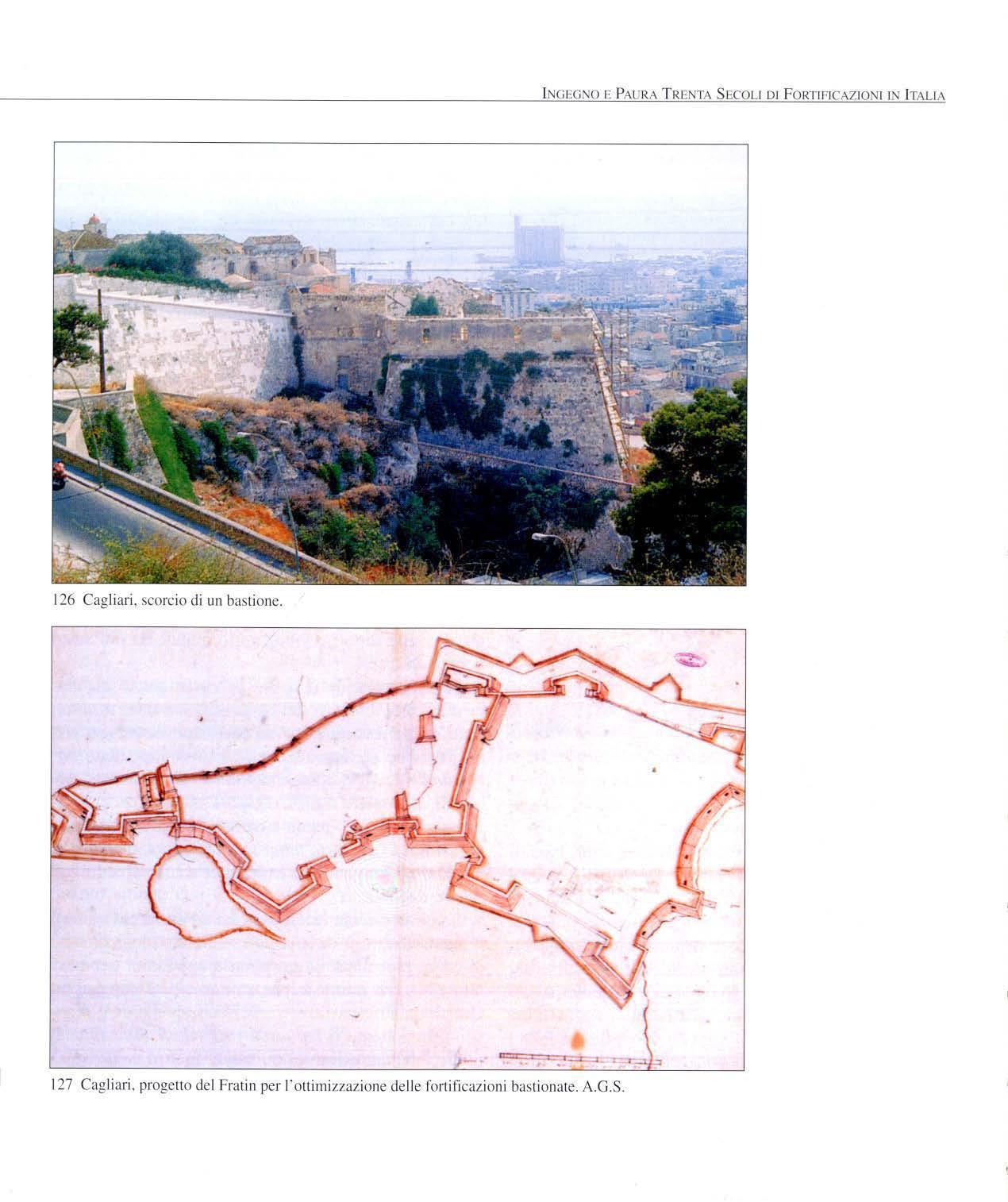
impianto quasi a semicerchio la raccordava ai bastioni di Porto Fangoso e di S. Agu s tino. Un unico s tretto varco, ostruibil e perciò la notte tramite una catena , prassi universale per tutti i porti rinascimentali, ass icurava l ' accesso ai natanti.
Ancora un ' altra tratta di cortina rettilinea fino all 'ultimo bastione, il baluardo de S. Francesco , dopo il qua l e ed immediatamente prima di quello ad es s o adiacente nonché sovrastante di S. Anton io si apriva u na terza porla, auraversata da una strada proveniente , per quanto è possibile argu ire, da Decimo, fiancheggiando la chiesa di S. Francesco.
È, a questo punto , ben evidente come la compaitirnentazione delle fo11ificazio1ù cagliaritane ne s ia in sostanza la principale peculiarità. Tramite suo le tre distinte sezi~m i avrebbero potuto in caso di emergenza esplet~U"e una res istenza a u tonoma e progressiva, che in pratica neutralizzava qualsiasi investimento a ll a piazza.
L e p iazze mari ttime rin as cim e ntali
Nella descrizione delle località fortificate co s tiere si è util izzata spesso la dizione cli piazzaforte marittima. I n realtà , però , tale definizione si è adottata per conformità con le fonti , non e ss endo affatto corretta né ora né a ll ora. Le cittadine fin qui descritte. infatti, a giusta ragione avrebbero dovuto etichettarsi piuttos to porti fortificati dal momento che le loro dife se , come accennato, proteggevano gli abitanti e le loro imbarcazioni , da pesca o mercantili , ma non certo abitualmente le unità da guerra. Né meno che mai queste co s tituivano una loro pertinenza stabile . come i velivoli imbarcati s u di una portaerei.
Fu s olo quella, infatti , la precipua nota di stintiva di u na piazzaforte mar ittima propriamente detta. lo g ica-
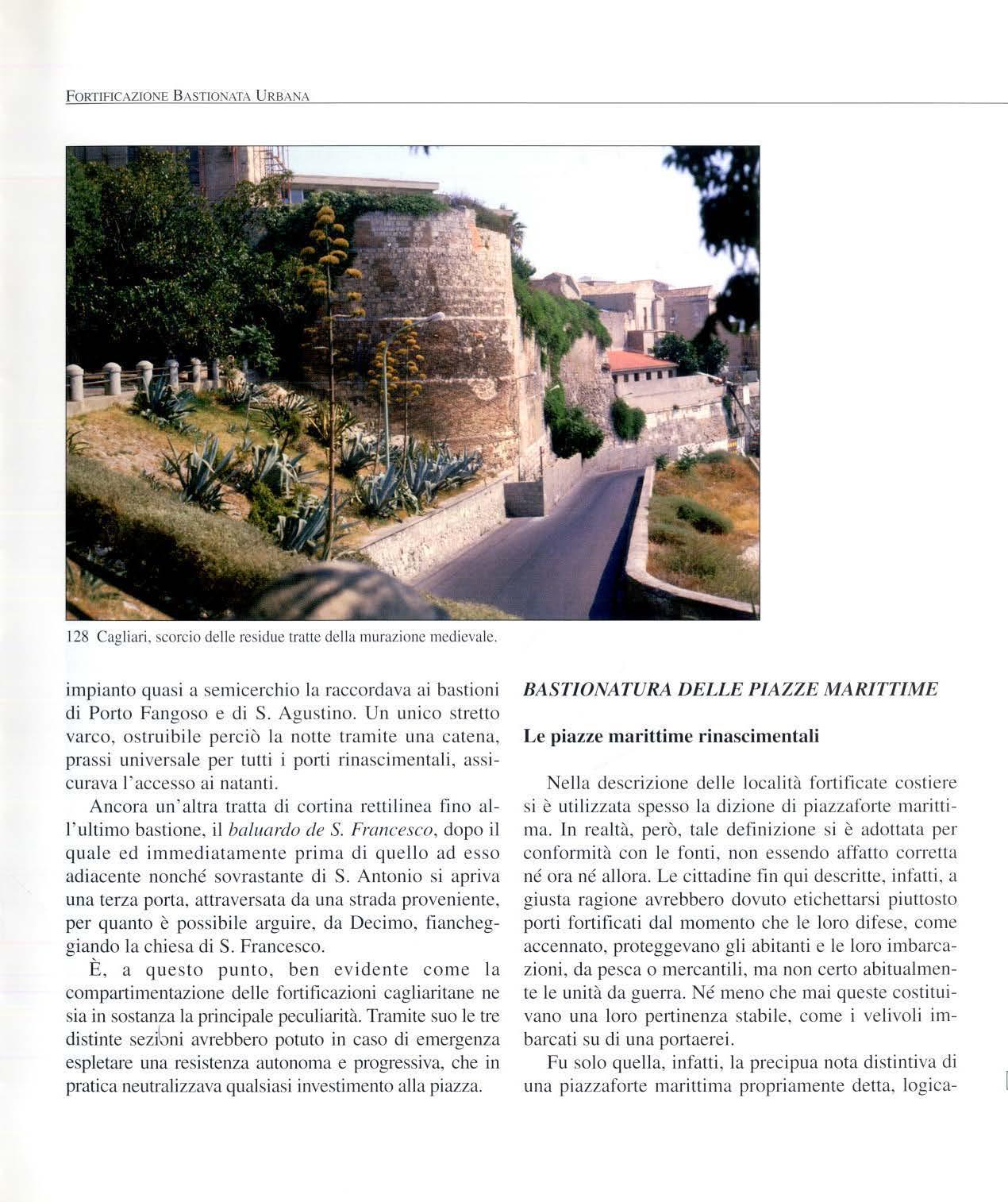
mente comprensiva di tutte le articolazioni e le attrezzature specifiche. In definitiva la concomjtanza di una temibile squadra navale, con un sicuro porto, dotato di vasti arsenali , di molteplici cantieri e di numerose maestranze specializzate, il tutto protetto da una poderosa fortificazione presidiata da una consistente compagine militare. La presenza fissa, quindi, de l le unità da guen-a trasformava il semplice ancoraggio, più o meno fortificato, in quel particolare grande complesso militare, certamente ben difeso, ma realizzato per finalità offensive a medio e lungo raggio, sviluppatasi nella sua moderna accezio ne proprio agli albori del rinascimento m> , definito anche, e forse con maggiore proprietà , base navale.
In età rinascimentale la piazzaforte marittima proprio per essere finalizzata ad ospit~ffe una più o meno nutrita squadra navale, oltre alle suddette pertinenze doveva necessariamente disporre di altre rilevanti strutture, indispensabili alla funzione . Tali furono i grandi stabili per la detenzione degli schiavi rematori, tristemente celeb1i da una sponda all'altra del Mediterraneo come bagni (78 1, i padiglioni appartati per la quarantena dei prigionieri catturati negli scont1i e delle cimme stesse dopo azioni in area musulmana, meglio noti a loro volta come la zz aretti, data la presenza endemica della peste nell'universo ottomano (79>, nonché i depositi di viveri a lunga conservazione csoi, per l'approvvigionamento delle unità ed, infine, di armi e munjzioni. Altrettanto basilare, proprio per l'afflusso di tante e svariate necessità, un capace porto mercanti le con comode ed estese banchine.
Ovvio, qu i ndi, che la dimensione architettonica per la espletazione di così diversificate e comp lesse funzioni dovesse atti ngere sistemat icamente scala urbana . Senza contare che l'intensificarsi dell'attività marittimo - militare finiva per innescare, a r idosso de ll a piazza, un vivace mercato, a sua volta motore trainante di una economia commerciale agente da richiamo per ulteriori abitanti.
La piazzaforte marittima rinascimentale era perciò l'insieme di quanto sinteticamente esposto, racchiusa
da una poderosa cerchia difensiva snodantesi in particolare lungo il fronte a terra , ma articolata anche s ul mare per proteggere in primo luogo il naviglio rrulitare e gli impianti. Le unità militari infatti, a differenza dei normali mercantili che si attraccavano alle banchfoe portuali, venivano ormeggiate abitualmente all'interno di un bacino più piccolo. Completamente ser ra to da mura, era separato dal maggiore tramite un ' inviolabile compartimentazione di sicurezza. Rigidamente interdetto ai civili, lo scalo delle galere si chiamò da quei giorni 'darsena' <81 > .
Lì si concentrava l'intera capacità offensiva della piazza, proiezione sul mare della potenzialità offensiva dello stato di appaitenenza, emblematizzata quasi dalla fortezza che immancabilmente si ergeva lungo il suo perimetro bastionato. È forse in questo esasperato dualismo, apparentemente antitetico, che si può cogliere la principale specificità di una piazza marittima rispetto ad una tenestre e la sua assoluta modernità. A differenza della seconda , infatti, la reazione bellica della prima non si esamiva nella resistenza ad oltranza o nell'interdizione lirrutrofa ma si protendeva, grazie alle sue navi, a centinaia di chilometri di distanza, non di rado a migliaia, riuscendo così a condizionare ampi settori marittirru con la sua semplice esistenza <s 2i Anche in ciò per molti aspetti potrebbe paragonarsi ad una attuale portaerei, senza dubbio ricovero e protezione per i suoi aerei che però, dal canto loro , sono in grado di colpire lontanissimo, dominando perciò interi scacchieri marittimi.
Fondato, pertanto, reputare che una so l a di siffatte fortificazioni, qua lora opportunamente dotata di un ità da inte rcettazione e d'attacco, riuscisse perfettamente a co ntrollare una front iera marittima di a l meno alcune centinaia di miglia rappresentando perciò un credibile deterrente persino agli sfuggenti corsari barbareschi, specie se integrata da una catena d.i torri costiere sia pur scadenti. L a brevità della tratta marittima da pattugliare, inframmezzata da po,ticcioli e scali abbastanza protetti, consentiva i noi tre di derogare ali ' altrimenti insormontabile l imite stagionale d ' impiego delle gaie-
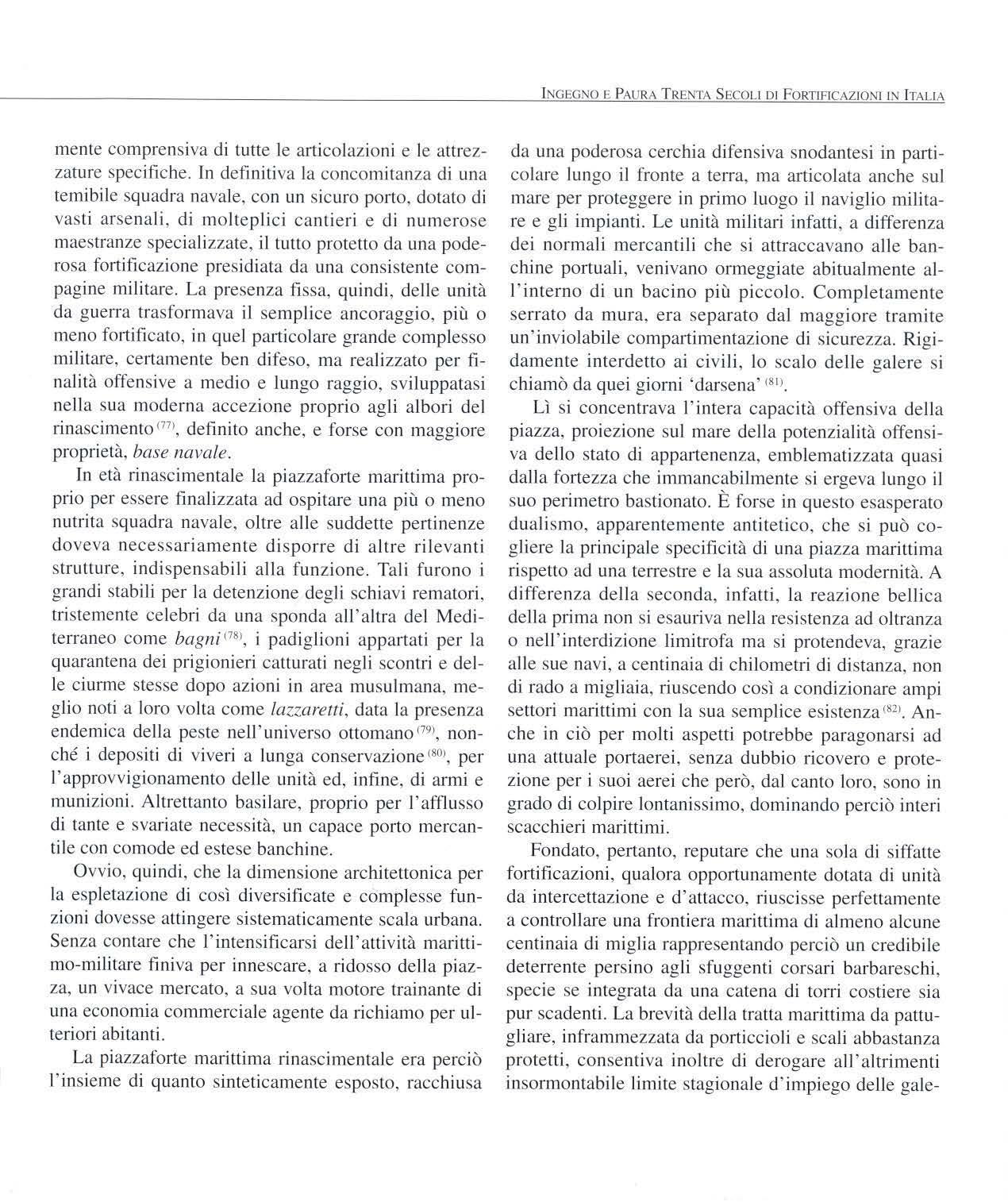
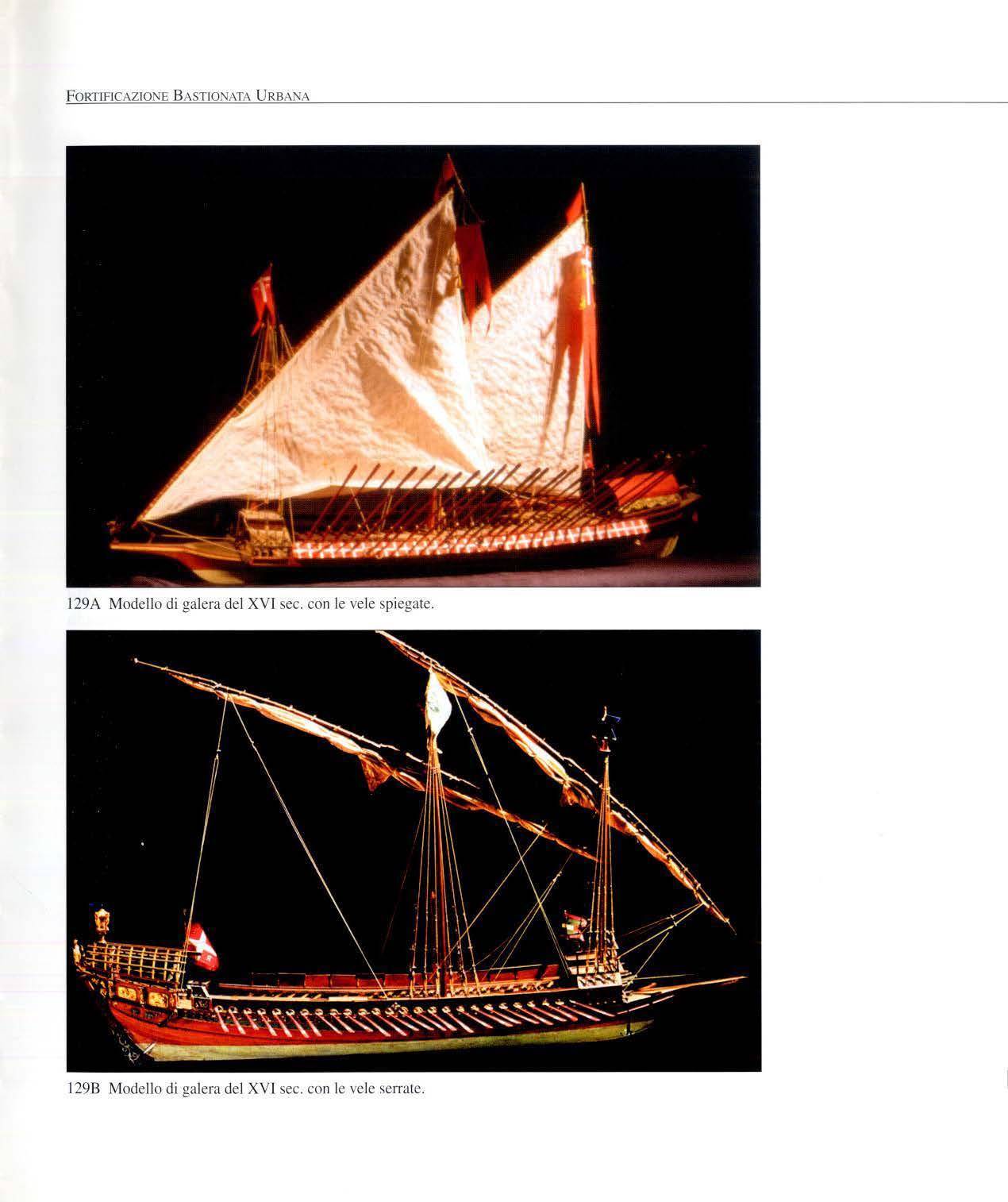
re. Al pari di tutti i battelli a propulsione remica anche quei sottili scafi non erano in grado di tenere il mare appena perturbato , ed al minimo accenno di mutazione dovevano immediatamente rientrare.
li coesistere di tante ciurme , di tanti soldati, di tanti marinai e di tanti operai, senza contare la massa della popolazione , obbligava ogni piazzaforte marittima a disporre in abbondanza di acqua sicuramente potabile, il che non sempre trovava una naturale soddisfazione. L'esigenza immutata si n dall'antichità classica, di cui un ' emb lematica testimonianza è fornita dall ' immensa cisterna, conosciuta come piscina mirabilis e ancora integralmente conservata presso Pozzuoli, utilizzata dalla flotta romana di stanza a Miseno m> , richiedeva la costruzione di grandi acquedotti e vaste conserve sotterra nee. Ed anche queste possono riguardarsi come una precipua connotazione di una piazza marittima propriamente detta. Ma forse la connotazione senza dubbio più esc lu siva deve individuarsi in un detestabile commercio che avveniva all ' interno delle stesse , e che per secoli imperversò da un parte e dall'altra del Mediterraneo, indipendentemente dalla religione imperante: quello degli schiavi.
Poiché la guerra navale anticorsara si estrinsecava in una continua sequela di intercettazioni , di abbordaggi e di catture capitava abbastanza spesso che le unità della guardia rientrassero alla base trainando al rimorchio numerose prede. Tra queste , oltre ai battelli nemici sconfitti ed ai mercantili crist iani fortu nosamente liberati, interi equipaggi turco-barbareschi e, non di rado, folti gruppi di musulmani razziati in azioni di rappresaglia o di contro-corsa sulle loro coste. Per questi ultimi , a l pari dei corsari non reputati idonei al remo, l a prassi contemplava abitua lm ente la immediata vendita ali' incanto, non diversamente dai restanti beni materiali catturati. La procedura spiega chiaramente perché nelle piazze marittime non solo si sviluppò un florido commercio di prodotti internazionali ma, anche e soprattutto, di sc hi avi , persino all'interno di uno stato ad ispirazione evangelica. Non a caso quando, intorno alla metà del XV I seco l o, le cattu-
re divennero inusitatamente abbondanti, fu promulgato da parte del pontefice Paolo III un ba ndo (iµ, che autorizzava , chiunque lo desidera ss e, a pos s edere schiavi e schiave di origine musulmana , sen z a alcuna riprovazione di ordine morale o giuridico. In pieno rinascimento l'abiezione della guerra di corsa rigenerò l ' abiezione della schiavitù persino all'interno dello Stato Pontificio!

Nell'ottobre del 148 I , quando Otranto era stata appena riconquistata dalle forze cristiane, il pontefice Sisto IV, dopo aver visitato la rocca di Ostia, intraprendeva un viaggio ispettivo a Civitavecchia, per sincerarsi di persona sul!' effettivo stato dei luoghi , ovviamente paventando imminenti ed ulteriori iniziative turche.
Certamente con l'immagine ben impres sa nella mente de ll a moderni s sima fortezza ed edotto circa la sua avanzata concezione, l'impres s ione che ricevette dalle cadenti fortificazioni medievali cli Civitavecchia dovette riuscire avvilente Inut ile, persino, ipotizzarne un ennesimo intervento riqualificativo , non prospettandosi sensato alcun potenziamento integrativo per strutture ormai inesorabilmente giubilate sotto il profilo architettonico e fat i scenti sotto quello statico 185 l . Nessuna illusione di recupero: indispensabile , invece, quale prima fase per l'adeguamento difensivo dell'intera Civitavecchia, procedere alla sua immediata sost ituzione con una moderna e poderosa fortezza , inserendola poi in una altrettanto moderna ed artico lata cerchia. La decisione di demolire preliminarmente la vecch ia rocca scaturiva dalla volontà di erigervi nello s tesso sito, e quindi secondo l'identica logica d'impianto, la nuova , quasi che nella tecnologia militare nulla fosse mutato tra le due costruzioni.
In dettaglio la cittadina, di cui la rocca occupava l ' estremità settentrionale del fronte a mare , appariva serrata nelle antiche mura di remotissima costruzione
e di inconsistente apporto difensivo. Il loro a nd amento, in linea di larga mass ima ricordava un trapezio isosce l e, l a cui base maggiore coincideva con la costa mentre la minore, di estens ion e eq ui valente a i l at i o bliqui, fonnava con g li stess i il delicatissimo fronte a terra. Cortine retti li nee infr ammezzate da torrette a pianta quadrata di infima consiste n za e di insig nifi ca nt e agge tt o sca ndi va no quell'estremo retaggio di fortificazione urbana medieva le. Pe r le endem iche ri s trett ezze economiche, tutt avia, l'un ico intervento che si poté appena avvia re fu l a ricostruzione della fortezza.
I l avori, quindi, d opo il soprall u ogo papale s i intrapresero, co n l a tipic a solerzia dei momenti d'emergenza , sotto l a gu id a di G iovan nin o de ' D o lc i <86> È credibile c he in quella breve tornata si scavasse un a sezio ne delle fondazioni , per l 'esa ttezza que ll e esterne a l perimetro della vecchia rocca, non osando ancora demolirla per non privarsi del suo sia pur debole apporto d ifensivo. Nel 1482 assu nse la dire zione dei lavori B accio P ontelli : l a scarsità del denaro dopo poco arrestò le opere Finalmente co n l 'ascesa al pontific ato di Giulio II la riqualificazione della piazza di Civitavecchia ricevette un ' assoluta priorità a partire d a l 150 8 L a progettazion e fu affida ta al Brama nt e, che appena due anni prima aveva fondato sul co ll e del Vati cano la g r and io sa b as ili ca di S. Pietro. L ' in car ico, tra i ma gg iori della s tor i a, a ttesta la stim a di Giulio II per l'architetto: nessuna meraviglia perciò c h e a ll ' illustre artista venisse co mmi ss ion a ta la fortezza di Civitav ecc hia, abbandonando quindi i g i ace nti progetti e g li a bortiti lavori .
Quas i a voler test imoniare l a s ua se ns ibilità classica il Bramante indi v iduò una collocazione alternativa per l' erigenda fortezza, impiantandola su i ruderi ancora perfettamente int erpretabili dell ' antichis s im o porto romano cellulare. La sce lta ubic ativa rappresentava certamente una sign ificati va novità , non al trettanto , inv ec6, può dirsi circa la co ncez ion e architettonica d e lla fortezza s t essa, tipico prodotto d e ll ' ultima tr a ns izion e, un netto passo indietro rispetto al forte cli
Ne ttuno. La curiosa vicenda appare emblematica della scarsiss ima condivisione, conseguenza dell'ancora più inconsistente comprensione del bastione, in venta to o adottato dal Sangallo a Nettuno. Il tornare perciò a canoni più arcaici ma proprio perc hé ta li , compresi e condivisi, costi tui sce un 'i ndubbi a testimonianza dell a difficoltà con l a quale s i impose il fronte bastionato nei primi decenni del XV I seco lo .
Il Bram ante, infatti , in materia di architettura militare affondava le s ue radici nella sc uola di Ciro Ciri da Urbino 187 !, celebre per il ru o l o soste nuto nella riconquista di O tra nt o e per le successive reali zzaz ioni aragonesi, a s ua vo lt a grande caposcuola dell'ultima fase della transiz ion e e divulgatore della concez ione di Fra ncesco di Giorgio M arti ni. E mentre il grande arc hit etto si prodigava per erigere la sua fortezza, non si perdeva tempo per approntare il comp leme nt o militare de ll a base: la s u a flotta. Ne l 151 1 Giulio II aggregando l e galere costruite ad Ancona a quelle in servizio a Ci vitavecchia, ottenne un a consistente sq uadra navale. Né s i fe rm ò lì, poiché vi aggiunse ancora altre galere nonché un paio di brigantini. Con le ultime quattro unità però cost ituì , forse sarebbe più esa tto dire ri cost itu ì, un a flottiglia destinata esclusivamente al pattugli amento anticorsaro lungo i l li to r a le tin-enico, la già ce lebre squadra della guardia <881 •
Il Bramante allorquando avviò la gra nd e fortezza era già avanti negli anni ed in condizion i d i sa lut e alqu a nto provate per c ui affi d ò la quotidiana direzione dei lavori ai s uoi aiu tanti e, fra qu esti, in particolare ad Antonio Picconi <89 > nipote dell ' omonimo Sangallo. Al momento d e ll a posa della prima pietra contava ap p e na 23 anni. Nonostante l a g i ovaniss ima età dimostrava un a competenza straordin a ria e pre coce n e l settore dell ' architettura militare . Comprensibili per tant o g li sc hi zzi ritrovati fra le sue carte miranti a ricavare dalla fortezza del Bramante una fo rtifi caz ione meno arcaica e g iubilata: ma al ri g uardo ben poco potette fa re . L a fama de l maestro era ta l e che persino dopo la sua mo 11e, nel 1514 , divenuto il s ucc essore a lla g uid a del cantiere insieme al co ll ega Giovanni Giu li ano Le no r90 > , non osò
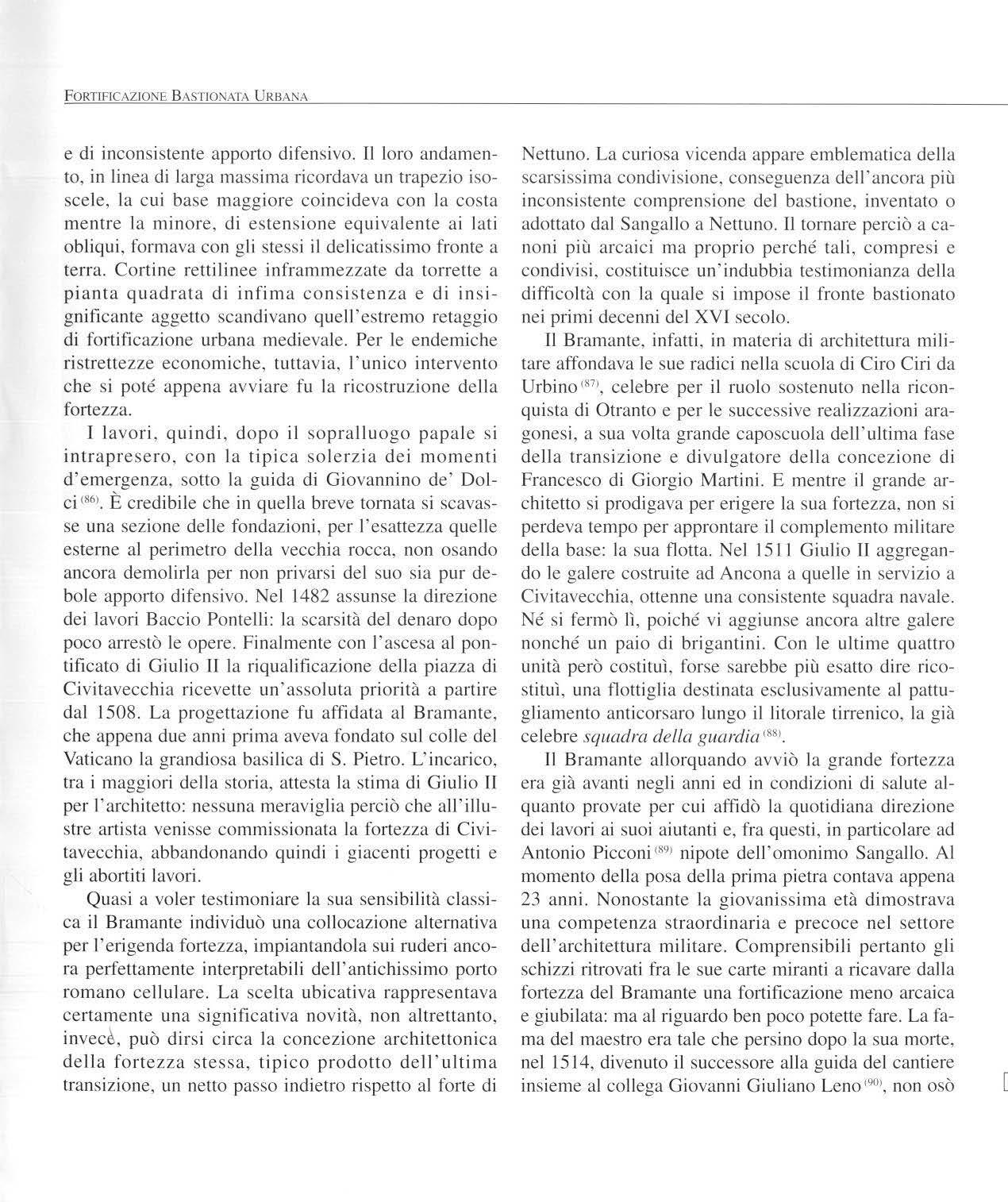
neppure proporre un qualsiasi aggiornamento a quell'ultimo scampolo della transizione sopravv is s uto alla sua epoca e pers ino al s uo ideatore. Otto anni dopo , eccez ion fatta per il maschio, risultava completata, tanto da poter ricevere l ' arn1amento.
A quel punto , però. il precipitare degli eventi costrinse Paolo 111 ad occuparsi affannosamente della fortificazione di Roma. Essendosi nel frattempo compresa perfettamente la valenza del fronte bas tionato e del s uo primo propugnatore, lo stesso pontefice volle a capo dell ' immane opera l'ormai quotati ssimo Sangallo, sos titu e ndolo sul cantiere di Civitavecchia , con Michelangelo che completò il celebre ma schio nel 1537 in religio so rispetto del progetto bramantesco.
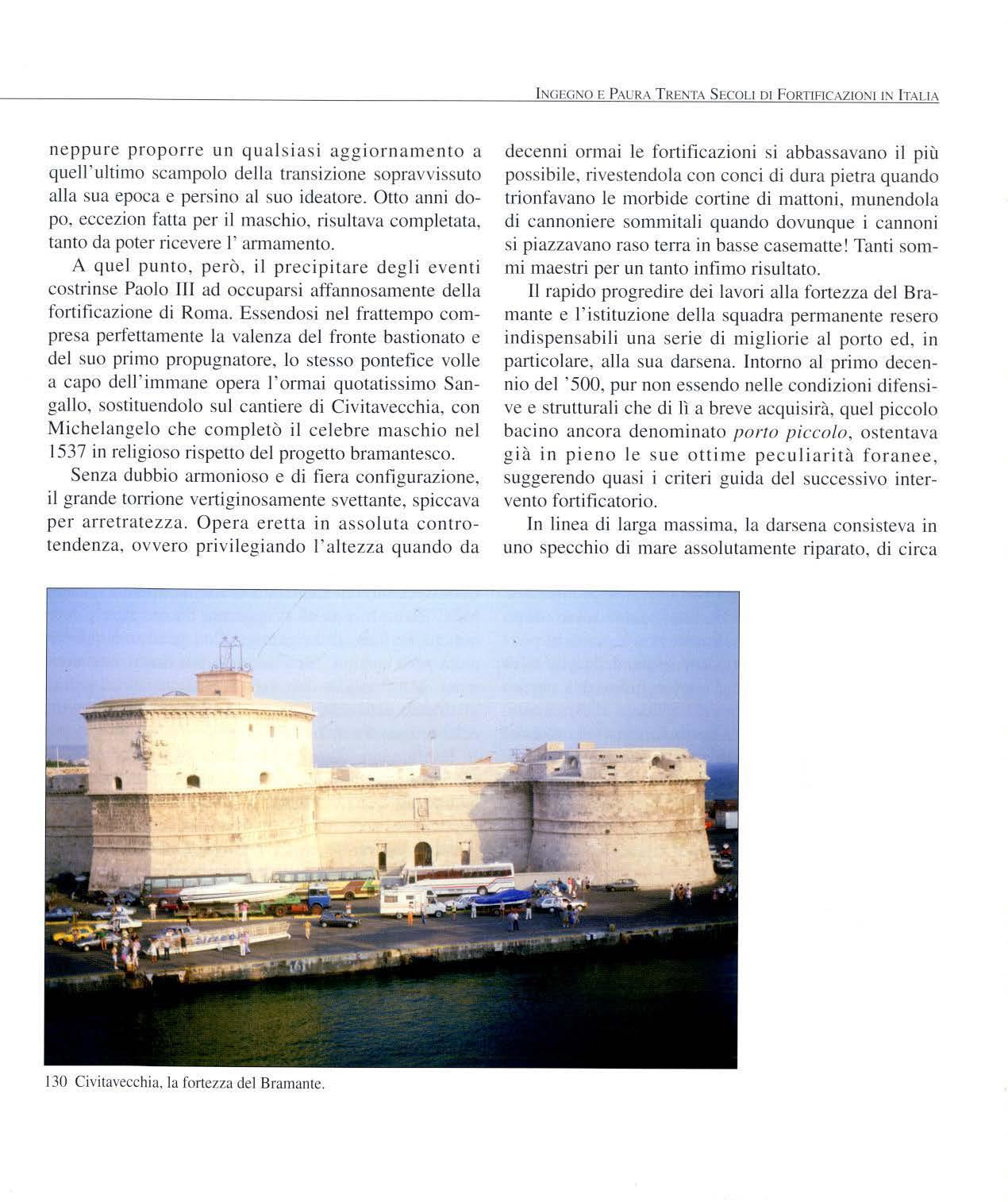
Senza dubbio armonioso e di fiera configurazione, il grande torrione vertiginosamente svettante, spiccava per arretratezza. Opera eretta in assoluta controtendenza, ovvero privil egian do l 'a ltezza quando da
decenni ormai le fo1tificazioni s i abbassavano il più possibile, rivestendola con conci di dura pietra quando trionfavano le morbide cortine di mattoni , munendola di cannoniere so mmitali quando dovunque i cannoni s i piazzavano raso terra in basse casematte! Tanti sommi maestri per un tanto infimo ri s ultato.
Il rapido progredire dei lavori alla fortezza de l Bramante e l'i sti tuzione della squadra permanente resero indispensabili una se rie di migliorie al porto ed, in particolare , alla sua darsena. I ntorno a l primo dec e nnio del ' 500 , pur non essendo nelle condizioni difen s ive e strulturali che di lì a bre ve acquisirà, quel piccolo bacino ancora denominato porlo piccolo, ostentava già in pieno le s ue ottime peculiarità foranee, suggerendo qua si i criteri guida del s uccess ivo intervento fortificato1io.
In linea di larga massi ma , la darsena consisteva in uno specchio di mare assolutamente riparato, di circa
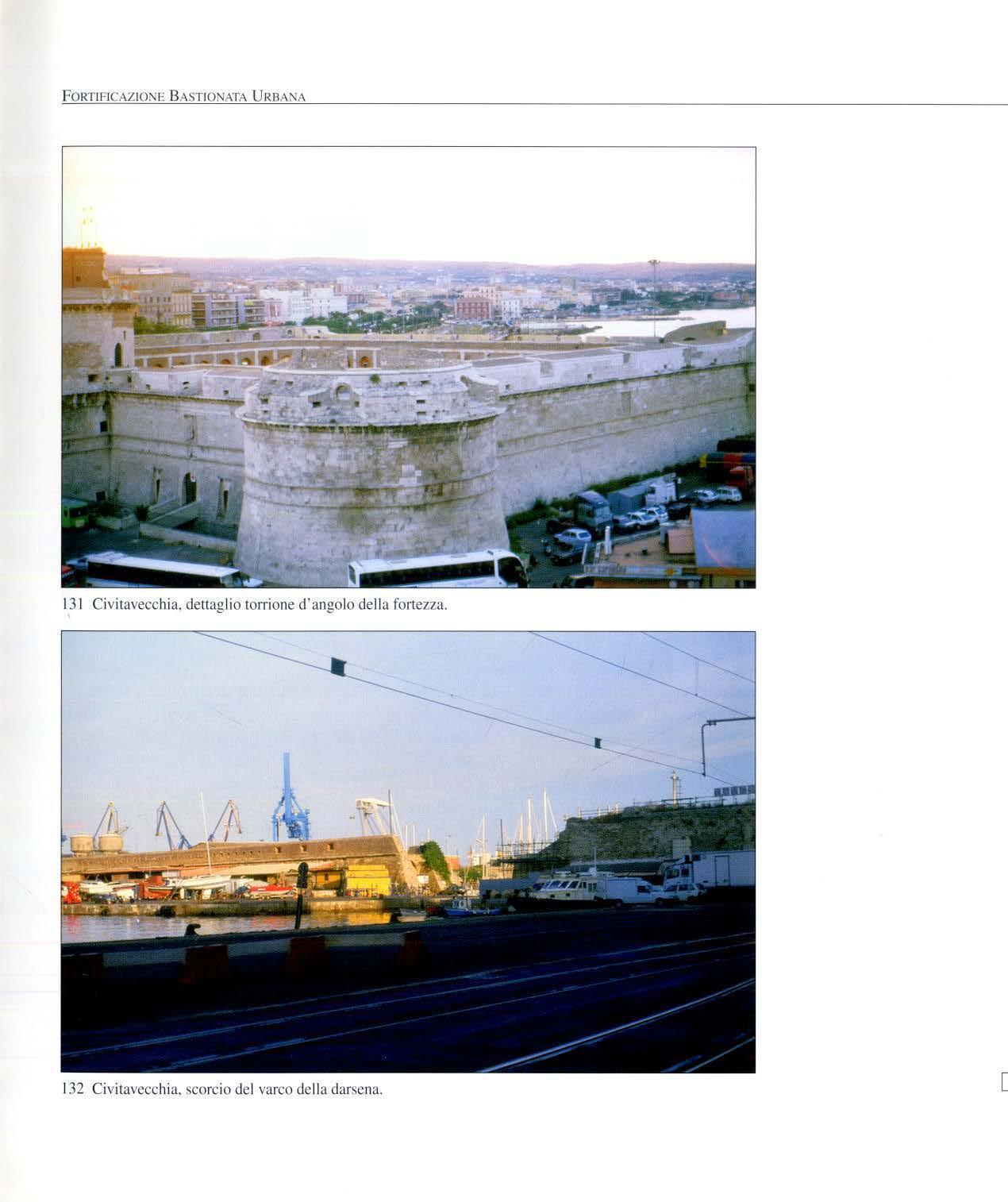
133 Civitavecchia, sco rcio delle antich e mura dell a darse na
due ettari e me zzo di s uperficie , con eccellenti condizioni di ormeggio e di protezione, a patto di dragarne i I fondale , operaz ione eseguita fra il 1513 ed il 1518. E mentre que s te pre me sse venivano esaurite, il giovane Sangallo s i esercita studiando una ideale cerchia capace di difendere il fronte a terra di quella vasta ed art i colata città, racchiudendo ìn mani era organica la fortez z a , l'abitato , il porto mercantile , l ' arsenale e l a dar sena, eliminando ogni pos si bile intralcio. intorn o a l J 5 J5, accadde la prima delle c ircostanze propizie a ll o sca lpitante progetti s ta: la morte del s uo illustre parente gli consentì, per l a ormai ri sa puta affinità professional e e per la ri scontrata serietà pers onale , di subentrargli nel ruolo dì ingegnere.
Nella nuova veste ufficiale , appena pochi mesi dopo, non si l ascia sfuggir e una occasione probabilmente irripetibile. Nel corso di una visita a Civitavecc hia di Leone X 191 , finaliz z ata a ll a formulazione di decisio -
ni in merito a ll a rifortificazione d e l fronte a te rra, richiesto del parere, co n una p erfetta sce lta de i tempi , pr esenta al pont efice la raffigurazione grafica dettagliata del s uo progetto di cerchia bas tion ata.
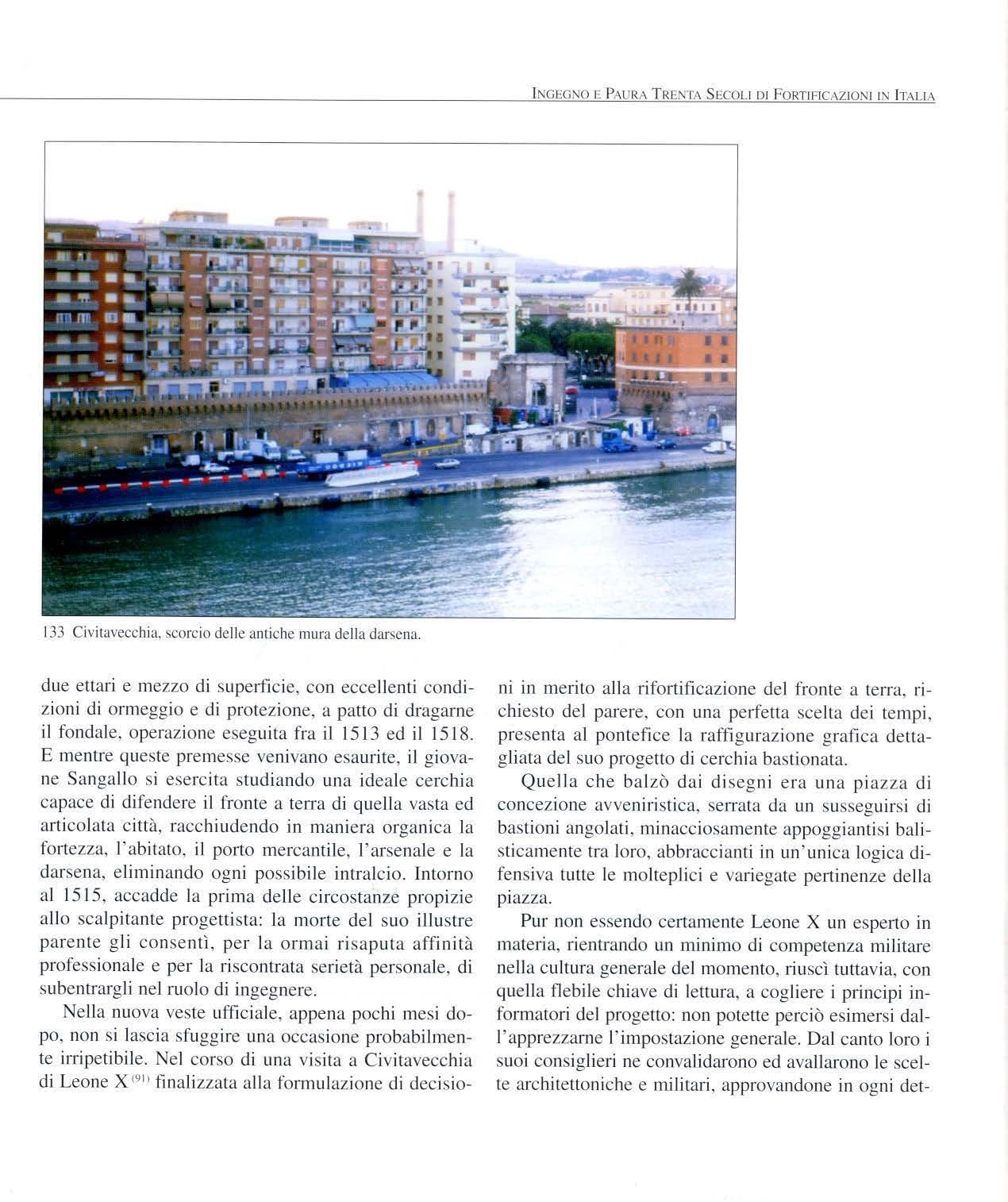
Quella che balzò dai di seg ni era una pia zza di concezione avveniristica, senata da un s usseg uirsi di bas tioni angolati, minaccio sa mente a ppoggianti s i balisticamente tra loro , abbraccianti ìn un ' unica logica difensiva tutte le molteplici e variegate pertinenze de ll a piazza.
Pur non es se ndo certamente Leone X un esperto in mate1ia , rientrando un minimo di competenza militare nella cu ltura genera le del momento , riu scì tuttavia , con qu e lla flebile chiave di le ttura , a cogliere i principi informatori del progetto: non potette perciò esimers i dal! ' app rezzarne l ' impostazione generale . D a l canto loro i s uoi cons iglieri ne convalidarono ed avallarono le sce lte architettonich e e militari, approvandone in ogni de t-
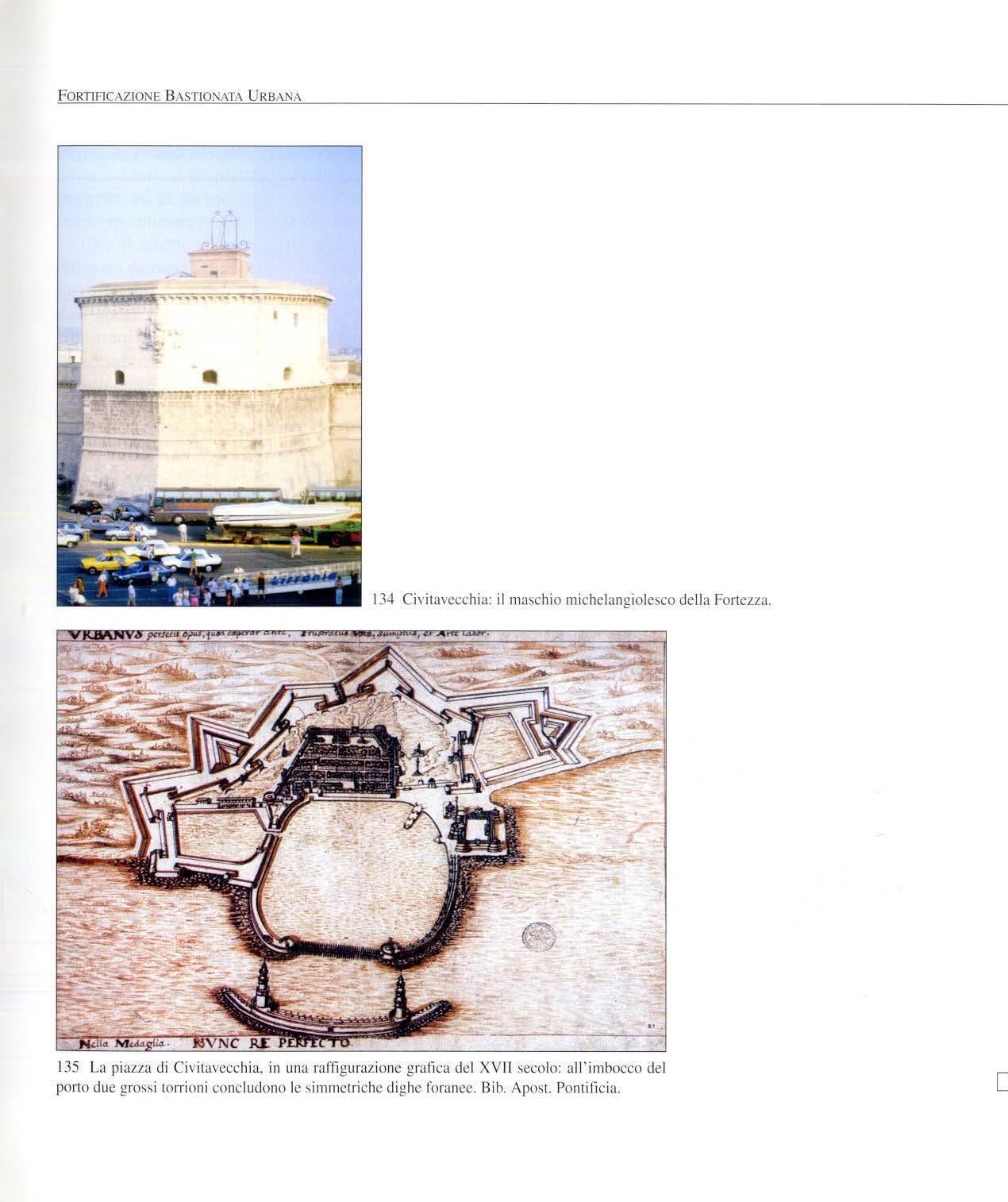

taglio Ja ponderatissima elaborazione. Nessuna obiezione e nessuna resistenza , quindi, all'accettazione del progetto ed al pronto incarico al Sangallo dì trasformarlo in concreta realtà, nel minor tempo possibile.

Che il tempo stringesse terribilmente l o si ricava dal paio di mesi intercorrenti dal giorno della visita a quello dell ' avvio dei lavo1i, nonostante la grandiosi t à dell'opera che si andava ad in traprendere, ed i suoi comprensibilissim i immensi costi. Tra il novembre ed il dkembre di quello stesso anno , incuranti dell ' avversa stagione, si scavarono gli e n ormi fossati e si accumularono su l loro c ig li o interno le masse di terra di risulta, ini ziando a configurarle e compattarle secondo l a pianta della cerchia. Faceva segu ito , dopo la naturale stabilizzaz ion e ed assestamento dei rilevati di riporto, la costrnzione in aderenza delle camicie murarie che ne avrebbero garanti to la stabilità futura e la perfetta confo rmit à ai grafici.
L'insediar si ad Algeri del Barbarossa e l'assurgere della città a vertic e della corsa barbaresca fu vista come il terribile prodromo di una immane sciagura. Nella Capitale ìl panico dilagò , materializzandosi in interminabili processioni e funzioni religiose. Leone X tuttavia ribadì solennemente che Je preghiere non bastavano a frustrare Ja minaccia: occorreva combatterla con le armi per garantirsi la libertà. Intuibile, imperversa nd o tale contesto , quale sollecitudine ricevessero i lavori a Civitavecchia! Ed infatti non erano trascorsi nemmeno tre anni dal loro avvio, che già nel 1519, il rivestimento murario dei bastioni e delle cortine poteva ritenersi praticamente ultimato, al punto da tornare possibile appo rvi i mastodontici stemmi di travertino tipici dello Stato Pontificio.
Nei primi mesi del 1522 papa Adriano VI cni, appena eletto, trasferendosi dalla Spagna a Roma via mare fece ovviamente scalo a Civitavecchia, dove poté am-

mirare la quasi ultimata gran de pi azzaforte marittima. Le memorie dell'epoca sono tutte sostanziai mente co ncordi nel ric o rd a re l a s ua soddisfazione alla vista delle opere, tanto maggiore in qu an to ardente fau tore della lott a antiturca.
Se le fortificazioni perimet ri c he di Civitavecchia potevano dirsi ultimate int orno ag li anni venti del XVI secolo, non altrettanto avvenne inv ece per una ]oro pertinenza: il muro di controscarpa d ei fossati. La c uriosa deficienza deve essere ascrit ta a l pro g ress ivo esau ri rsi del gett ito economico destinato a ll e opere ed , al contempo, alla suffi c i enza con la quale ve niva rig uardata tale struttura. Quand o nel 1546 il Sangallo, oberato da un a se ri e inte rminabil e di incarichi pres tigiosi m o rì , la controsca rpa non era ancora ultim ata. Altri direttori dei l avori g li successero, tra i quali intorno a ll a m età del '500 Flamini o Ors ini e quindi Francesco L a parell i da Cortona ed ancora Gi ammaria Agamondi dal Bosco, ma so lta nto ag li ini zi degli anni '70 la cerc hi a bast ionata di Civitavecchia poté co nsiderarsi completata in ogni sua parte.
Schematicamente l a gra nd e cerc hi a s i dipan ava dall'estremo cos ti ero opposto a quello dove era sorta la fortezza de l Bramante, ovvero dal linùt e setten t1ionale del porto , in adiacenza alla da rse na. Il primo bastio ne fu pe rt anto e r e tto in s tr e tta adere n za con il molo de l Lazzare tto. e co rrentem ente d efin ito della Casaccia per la prese nza nell e vici nanze, a i g iorni d e ll a costruzio ne, di alcuni ruderi . In seg uito fu 1ibattezzato con il nom e di S. Teofania. e d a ncora della Macina. Non si trattava tutta v ia di un bas tione completo, o vvero s imm e trico ri spetto alla lin ea capitale, m a più esattame nte di una sola metà essendo, l 'a ltr a pros piciente il porto , formata da una lun g a muraglìa, alla c ui dife sa pro vvedeva un a pia zz a bassa posta ali 'imbocco della dar se na.
D al fianco ri e ntrato della m e tà canonica, dotato di batteria traditora coperta dal relativo musone s i origina va un a cortina re ttilinea , circa m 140 , che termin ava nel fianco s ini stro d e l seco nd o bas tione, d e tto allora di Mare, e quindi di S. Barba ra. Qu es t ' ultimo se bb e ne di
co mp l eta co nfi gurazione, quand'anche non perfettamente simmetrico, occupava un a posizione a ngolare, iniziando proprio dal s uo vertice il fronte a tena della piazza. Le direttrici delle facce, in fa tti , conco rd avano rispettivamente con l'and a m e nt o della costa e con la perpendicolare. Sempre dal suo verti ce partiva il fo ssa to, l a rgo m ediamente una trent in a d i met ri , che seg ui va le sp ezzate d ell ' int ero per i metro.

A l fianco o ri e ntal e del seco nd o bastione si innestava il successivo segmento di co rtina, di poco piL1 breve del precedente. Si esa uri va ne l fianco occ identale de l terzo bas tion e, detto di Terra , e quindi di S. R osa, al pari del l'altro di configurazione asimmetrica completa. La ragione de ll e co nti g ue an o m a li e va individuata nella posterla, la seco nd a dopo quella ancora più modesta d e ll a Marina, che si a priva al centro di q uesta tratta di cort ina, detta porta Cornetana , servi ta da un po nt e levato io . Da lì usce nd o dalla darsena si g uadagnava un vasto campo , noto all'epoca per prato del Turco, dall'ovvio s i gnifica to topo n omastico. Non rimase in funzione a lun go , finendo murata nei success ivi l avori di aggiornamento.
Il descritto gr upp o di tre bast ioni formava la difesa d e lla darsena, il c ui imb occo marittimo dal porto gra nd e stava serrato tra il p1i mo e la rocca vecchi a , a c ui sì inn estava la cerchia medi eva le. sca mpat a a l pari de l vetusto caposaldo alla demolizione.
All a rocca si i nnestava anche un a ltro robusto muro che, correndo para ll e l o a lla cos ta, raggiungeva il secondo bastione , iso l ando completamente l o specc hio d'a c qu a ri servato a ll 'o rm egg io della fl otta militare. Ad eccezione di un minuscolo varco ne ss una comunicazione era pert,mto consentita tra l' abitato e l a da rsena, assimilabile ad un a so rt a di c i tta dell a navale.
Un'estesìssima tratta, o ltre m 300 , di gra n lun ga eccedente l e p r es ta z ioni ottima li d ei pezzi del fiancheggiamento, forniva il collegamento obbligato tra il fianco di s ud-e st d e l te rzo bastione co n quello di nord-ove s t de l quarto. li Sangallo dando un' e nne s im a dimo s trazio ne della s u a gerualità in materia, ri so lse la grave deficienza. Con s iderando c he il quarto bastione,
detto dell ' Ulivo, e quindi di S. Ferma, per la sua posizione elevata d'impianto e per la sua grandiosa e perfetta configurazione - oltre m. 70 di faccia, 40 di semigola e 24 di fianco - rappresentava il massimo caposaldo dell ' intera cerchia, ne spezzò l'interass e in due distinte tratte formanti un angolo rientrante. Evitò però di unirle ed, in corrispondenza del loro vertice interno, inserì un breve segmento di cortina arretrato , equivalente a sua volta ad un inedito bastione inverso, dotato pertanto di due opposti fianchi con le relative batterie. Al centro vi collocò la porta detta Sutrina preceduta dallo scontato ponte. La s oluzione rese in definitiva ogni singolo segmento di cortina perfettamente fiancheggiabile da due opposte direttrici di fuoco , eliminando la pericolosa carenza.
Tra il quarto ed il quinto bastione detto della Porta, e quindi S. Antonio ed anche Barberini e Testaccia, intercorrevano circa m 150 di cortina rettilinea , forata
in posizione non baricentrica , dalla porta Romana , dotata del s olito ponte levatoio. Anche quest ' ultimo bastione o stentava una perfetta configurazione geometrica ed occupava una pos izione angolare. Dal suo fianco. infatti, l'andamento della cerchia puntava nuovamente verso la marina , interrompendosi , dopo circa un centinaio di metri, nel sesto bastione, detto dell ' Alto e quindi di S. Fran c es c o. La spiegazione del suo nome originario era insita nell ' innalzamento della quota del te1Teno, che giustificò la sua particolariss ima conformazione, priva del fianco a lato mare.
Tra le molteplici spiegazioni della vistosa carenza va segnalata quella di una precisa opzione tendente a 1idun-e le s ue potenzialità offens ive contro la fortezza del Bramante, lasciandole così un consi s tente predominio tattico. Di certo la cortina interposta tra i due dissimili caposaldi con-eva rettilinea per un ' ecces siva estensione difficilmente difendibile da entrambi, defi -
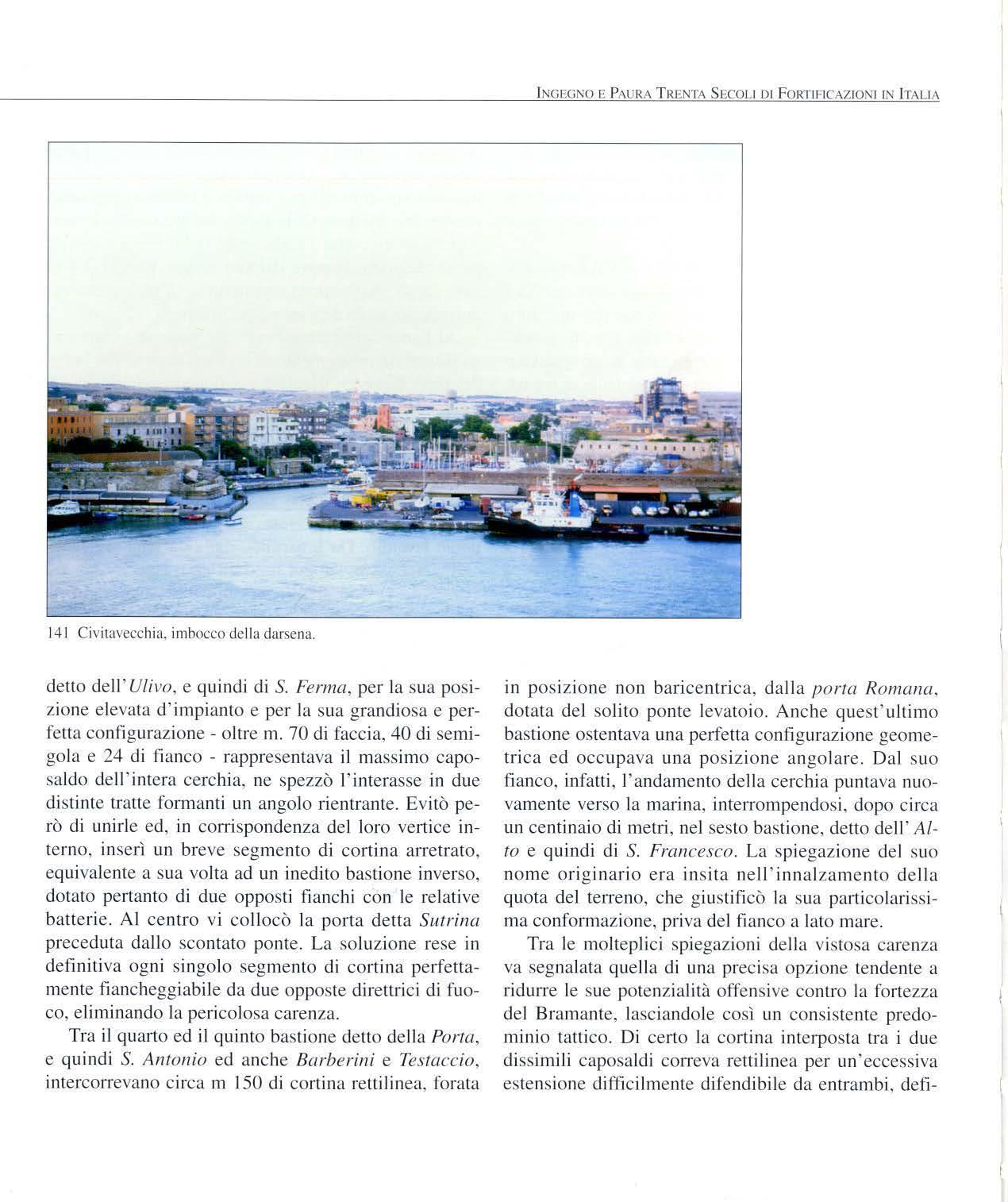 14 I Civita vecc hia, imbocc o dell a da rsena.
14 I Civita vecc hia, imbocc o dell a da rsena.
cienza che alla fine lo stesso Sangallo volle eliminare. Successìvamente, ìnfatti, non solo realizzò il fianco mancante ma completò il tracciato, al suo punto di innesto con la fortezza, munendolo di un u]tjmo bastione, il settimo , di configurazione parziale tant'è che lo definì puntone. Ad ogni buon conto il fiancheggiamento dell'intero perimetro della cerchia , circa 3 km, trovava in tal modo una omogeneità totale potendosi i n ogni punto incrociarsi i tir i della difesa.
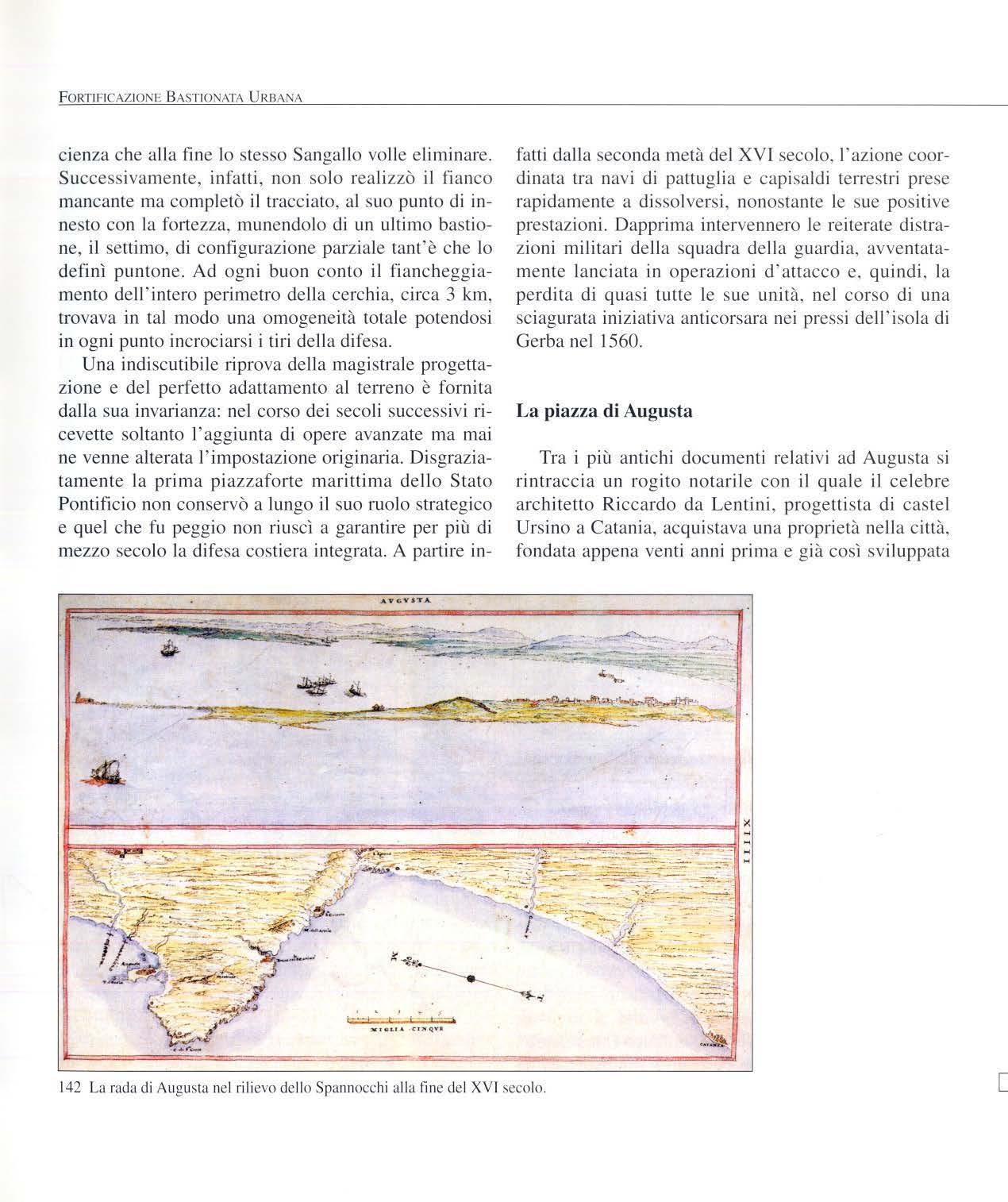
Una indiscutibile riprova della magistrale progettazione e del perfetto adattamento al teITeno è fornita dalla sua invarianza: nel corso dei secoli successivi ricevette soltanto l'aggiunta di opere avanzate ma mai ne venne alterata l ' impostazione originaria. Disgraziatamente la pr i ma piazzafor t e ma r ittima de ll o Stato P ontificio non conservò a lungo il suo ruolo strategico e que l che fu peggio non riuscì a garantire per più di mezzo seco lo la difesa costiera i n tegrata. A partire i n-
fatti dalla seconda metà del XVI s ecolo , l ' azione coordinata tra navi di pattuglia e capi s aldi terrestri prese rapidamente a dissolversi , nonostante le s ue positive prestazioni. Dapprima intervennero le reiterate distrazioni militari della squadra della guardia, avventatamente lanciata in operazioni d"attacco e, quindi, la perdìta di quasi tutte le s ue unità. nel corso di una scìagurata iniziativa anticorsara nei pressi del l'isola di Ge r ba nel 1560.
Tra i più antichi documenti relativi ad Augusta si rintraccia un rogito notarile con il quale il celebre architetto Riccardo da Lentini, progettista di castel Ursino a Catania, acquistava una proprietà nella cìttà, fondata appena venti anni piima e già così s viluppata
11 tragico destino degl i Sv e vi, di s graziatamente , troncò le a s pettative e la mura z ion e medievale, tangen te alla proprietà dell'ar chitetto , sopravviss e, offes a dal tempo e dagli uomini , sempre più sc a lcinata e fatiscente, ben oltre la metà del XV I secolo. Per almeno tr ecento a nni , quindi , Augu s ta altro non fu che una pittores ca penisola sormontata da un tetro q u anto sproporzio n ato castello, incombente s u un sottostante mi s ero borgo murato (931•
Dal punto di vista morfologico la s uddetta peni s ola consis teva in una stretta lingu a di terra, larga mediamente 350 meui e lunga qua s i 1400, con l'ass e maggiore orientato verso nord. Altimetricamente per gran parte emergeva appena di pochi metri sul ma.re. Solo
143 11 cas te llo di Au gusta: pianta.
da risu l ta re co nso na all ' illust re personaggio. D e l res to la strao rdin aria potenzialità s trategica del sito, la capace rada e la fel ice ubicazione barice ntri ca su ll a
cos ta orientale, che avevano mat eria l izza to agli occhi .., J cli Fede ri co 11 altrettante co nnot azio ni ottimali per l e s ue a mbi zioni n ava li , costitu i rono i presupposti delr asces a urbanistica cli Augusta. Non p uò esc lud ersi, pera ltro , c he il domiciliarsi in essa del protomaes tro comprov i un s uo maggiore coinvolg imen to nei poderos i lavori pro grammati p er adeg u ar l a a l ru o l o di primaria base nava le im per ia le, militare e mercantile, di c ui il s up erbo caste ll o costit ui va l'indispensabile
sa.

ad immediato rido sso dell'istmo, che la collegava alla terraferma , si innalzava s ino a quota 20 , originando un modesto pianoro, occupato ovviamente dal castello, un maestoso cubo di pietra.
Il maniero infatti , come tutti i coevi di matrice federiciana. era. ed in buona parte è ancora sfronda ndolo delle innumerevoli superfetazioni e deturpazioni successive, il soli to blocco quadrato con torri quadrate ai vertici e corte quadrata centrale. Una tetra s intesi fra un ideale di petfezione geomenica e la tecnologia avanzata medieva l e, retagg i o pietrificato di un sogno mai attuatosi . Agl i inizi del '5 00 anche quell'enorme blocco 1ap id eo appariva assolutamente incongruo per le armi da fuoco e pateticamente vulnerabile ad esse.
Sebbene l'ubicazione apicale del castello fosse vistosamente eccentrica rispetto a ll a proliferazione urbana succe ss iva , tatticamente s i confennò acce tt abile per la logica spag nola in quanto in grado di domi-
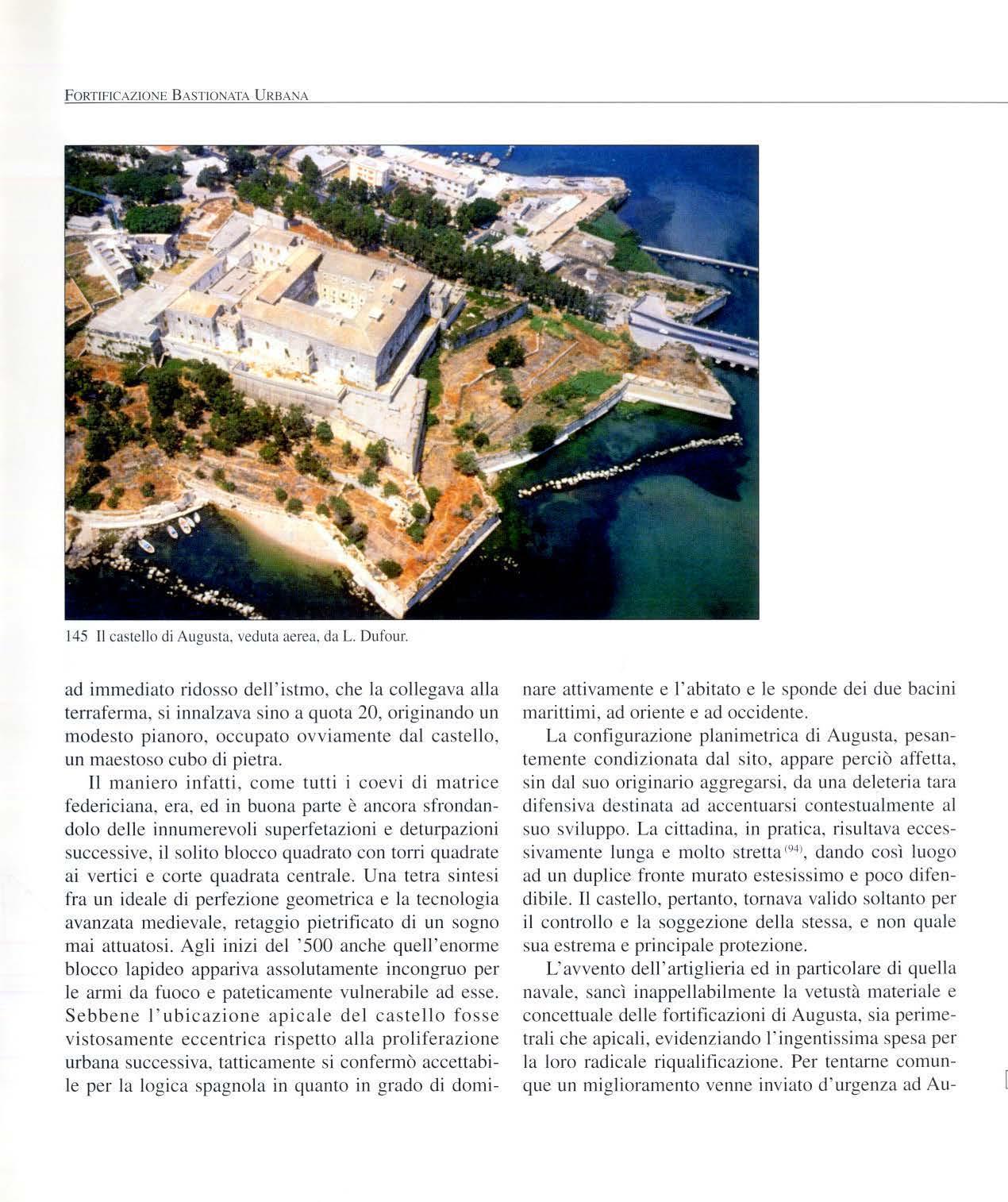
nare attivamente e l'abitato e le spo nd e dei due bacini marittimi, ad oriente e ad occidente.
La config u razione planimetrica di Augusta, pesantemente condizionata dal si to, appare perc iò affetta, sin dal suo originario aggregar s i , da una deleteria tara difen s iva destinata ad accentuarsi contestualmente al suo svi luppo. La cittadina, in pratica, r isultava eccessivamente lunga e molto s tretta < 94 1 , dando così luogo ad un dupl ice fronte murato es tesissimo e poco difendibile . Il castello, pertanto , tornava va l ido so ltanto per il co ntrollo e la soggezione della stessa, e non quale sua estrema e princ ip a le protezione.
L ' avvento dell'artiglieria ed in particolare di quella navale , sancì inappellabilmente la vetustà materiale e concettua]e delle fo rtifi cazioni di Augusta, sia perimetrali che apicali, evidenziando l'inge nti ssi ma spesa per la loro rad icale riqu alificazione. P er tentarne comunque un mi g li oramento venne inviato d ' urgen za ad Au -
g us ta ne l 1533 l' in geg ne r Fe rra mo lin o . con tas a ti v i o rdini di non ecce de re in a lc un mod o a qu ant o rea li zza bil e in poco tempo e co n poco d enaro. li be rgamasco, s trett o da ta li fru stran ti vi nco li, po té al ma im o pro ce d e re alla ri sa rc itura d e ll e s e col a ri e s brecc iate mura g li e de l cas te ll o e d ell a ce rc hi a, pur prosp etta ndo l 'ottima le p otenLia me nt o d e ll a pi azza. Solo co ì s i pu ò spi ega re l a s ua afferm az io ne di rite nere esa uribili i lavori ne ll'arco di pochi mes i, pe r la prec is ion e intorno al ma rzo de l J 53 4 . In de finiti va: ·'... Fc rT a mo lino c hi am ato a riso l ve re .. . qu e t o pro b le ma .. . id eò un o schem a pl anim e tri co ge ne ra le per le dife se di Au gus ta . Ma la rea lizzaz io ne di qu es te vas te o pere a rc hit e tto ni c he av re bb e d a so la asso rbito bu o na parte d e ll e fina nze de l reg no cd av re bb e r ichi es to un imp eg no co ntinuativ o ... s ul pos to . Tutto c iò non poté avve nire ed i lavori ... p roced et tero a s uss ulti e s t ra tto ni . .." 195 '
O vvia ment e l a s itu azi o ne, a l di l à d i qu e i ratto ppi de ll ' ultim o minut o, res ta va co munqu e tragi ca tant 'è c he all o rqu and o il v ice rè Go nzaga is pez io nò le pi azze s ic ili a ne ne l ·37, no tifi cò a lr imp erato re il segue n te giudi zio s u Au g u s ta:
" .la terra 1ta çituata sopra 1111 belliuimo porto e di wnw ~rande::..~a. che il castello 11011 si co110\ce bastante a porerlo defendere et che la forte-:::,a di dello castello è ,·osa 111 0 11 0 a nti ca. e t fa t ta d i 111 a n era c h e, q u a ndo fosse co111bo11111a. con diffirnltà, al giudicio 111io. si potria defendere "'"
Ed an co ra:
" il castello di Agosta. il quale per e1ser piccolo, senza .fìo11chi, e t co11 poco e 11111/a fosso io per 111e 110,1 lo g iu d ico d ife ndihile e t fo rr e o resis 1ere ad un a a n11 a w reale ·· ,•m
Com e se non bas ta ss e , po i, la pr ese nza dell e fo c i di due fiumi. nell e immediate adiacen ze de lla p e ni so la , p e rm etteva il sogg io rn o a gross i contin ge nti d 'a tl acco . se nza a lc un prob le ma di ap provv ig io na me nt o idri co , una dell e più vin co la nti es ige nze de ll e o pera z io ni os-
g li o il s uo pa rer e in un a rel azi o ne ri ass unti va, re d att a il 3 1 lu gli o d e l 154 6, in pr oc into q uindi d i tras f er irs i a l s uo nu ovo in carico ne l mil anese 1981 :
' 'Seg uit a il port o d'agosw. il qua l per esser ta n w grande che pi ù t osto si può chiamar golfo che por/O non solo 11011 è basll/11/e a tenere il pa uo a nessun 'armma che ,, 'e111ri et , i sria, ma se fossero tre castel/a di quella sorre, 110 11 basterebbero ad ossec ura rlo. Q 1t es ro p o r to è i l m af(gio r co11 t rlll'io eh 'hahbi il R eg n o, perché... dona grandissimo adito a penetrar<' le 1•iscere del regno et sfor:are chi / 'hm·ese a difendere. di m enturare ogni cosa. come ho de 11 0, i 11 u na hm w glia " •'I'>
Le acco rt e osse rvaz io ni d e l G o nzaga ce ntrava no in pi e no il p rob le ma, ev id e nzi a nd o non so lo l' imbattibilit à della rad a dalla pia zz a , ma financh e il s uo prop o rs i qu a le co m o da p o rt a d" acce . o all ' int e r a I so la. Qu a nto a ll ' i pe r bole ui tre ca te lli , in vo lo nta riam e nt e
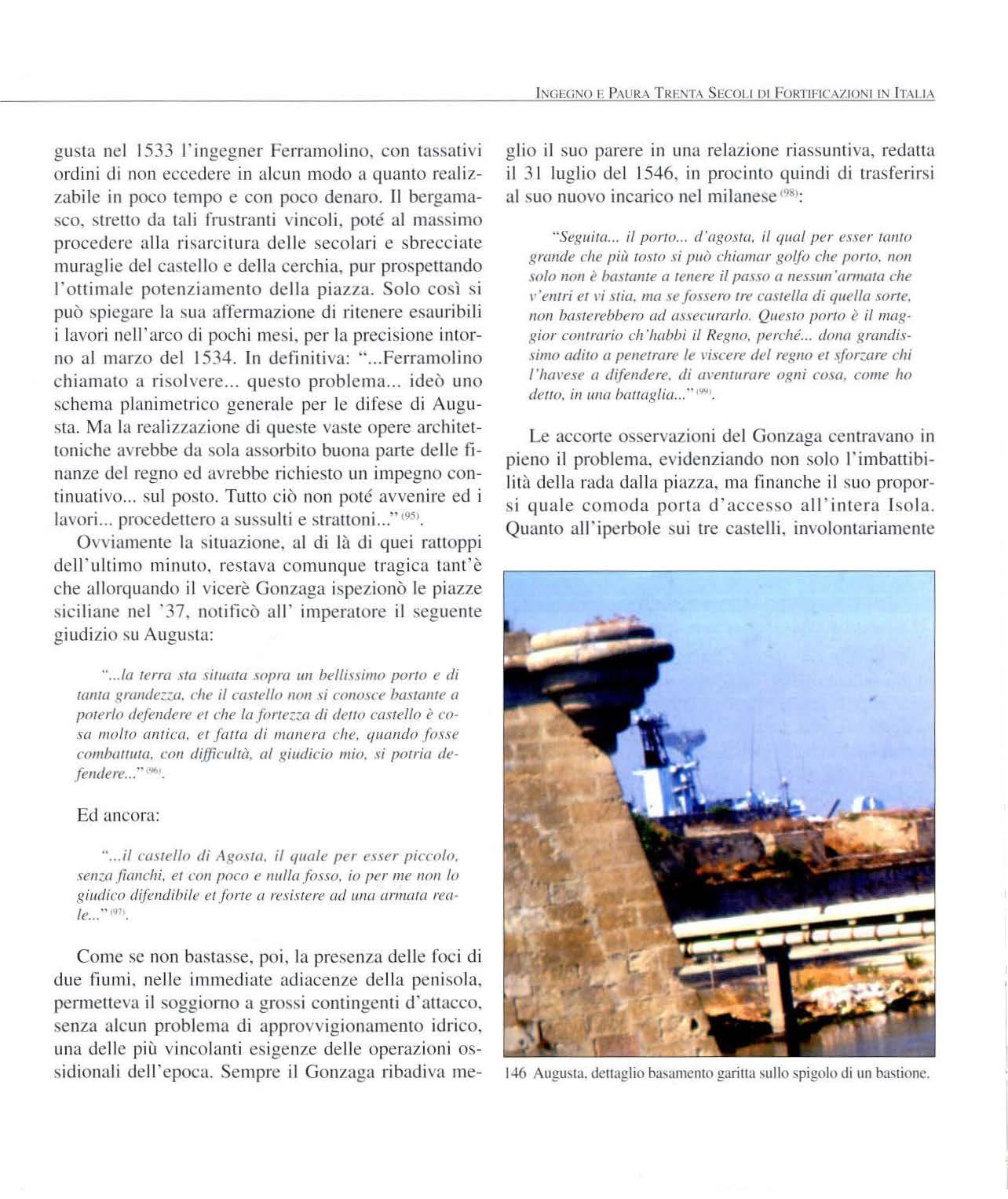 I NGEGNO I: PAURA T RE:S:Ti\ SECOLI D I FORTIFICAZ IONI lN I TALIA
s idion ali de ll 'e p oca. S e mpre i I Go nzaga rib adi va me - 146 Augusta. deuagl io basamento gariua sullo spigolo di un bastione.
I NGEGNO I: PAURA T RE:S:Ti\ SECOLI D I FORTIFICAZ IONI lN I TALIA
s idion ali de ll 'e p oca. S e mpre i I Go nzaga rib adi va me - 146 Augusta. deuagl io basamento gariua sullo spigolo di un bastione.
preconizzò il futuro: di lì a breve infatti vennero eretti, nel giro di pochi annì. appunto tre forti, per l'esattezza due da don Garzia di Toledo, figlio del più celebre don Pedro vicerè di Napoli per antonomasia 110<)) ed il terzo dal marche se di Pescara cl' Avalos.
Nel frattempo però i tempi stri ngevano e le finanze languivano, per cui s i ritenne quella parvenza di fortificazione se non altro credibile contro attacchi corsari, affidandosi alle forze terrestri per la sa l vaguardia del luogo. I grandi lavori , quindi, per la città di Augusta avrebbero dovuto ancora attendere momenti migliori per essere intrapres i. Per contenere il terrore s i delegò l ' esercito e la milizia, dislocando ne una forte aliquota nel perno strategico di Lentini, dove per l'appunto s'avv iò la costruzione di un vasto campo fo11ificato.
Trascorsi alcuni anni e crescendo la minaccia turca s i risolse di procedere, prima ancora di rifortificare la città, alla chiu s ura della sua rada tramite i famosi tre forti autonomi. Sotto il profilo architettonico si tratta-
va di una recentissima tipologia dj opere che applicava tanto iJ concetto del perimetro s pezzato. forti Garzia e Vittoria, per il tiro di fiancheggiamento totale, tanto quello del fronte bastionato , forte d' Avalos, con ba s tioni ad angolo rientrante , protetti alle spa ll e da

una enorme ma ss a inerte racchiusa in un involucro cilindri co.
Nel 1565 , don Garzia di Toledo ammiraglio in capo della flotta spag nola e vicerè di Sicilia, al ritorno da una mi ss ione navale di soccorso a Malta. dopo un o
sca lo a Siracusa pervenne a d A ugusta. I maggiorenti d e ll a città non si lasciarono sfu ggire l 'occasio n e per evidenziargli la tragica esposizione de lla stessa alle inc ur sioni turco-barbaresche. ll s uo porto, infatti , continuava ad offrirsi indifeso al pa ri dell'abitato, asso lutam en te indifendibil e pure dal vecchio cas te ll o federiciano . Con s tatata la situazione il viceré ritenne per lo meno urg e nte l'interdizio ne della rada tramite la cos truzione di due cap isa ldi s u altretta nt e isolette, in pratica due secche lontano dalla riva. I l avori, secondo le pitt attente indagini, ini z i a rono però so lt anto un paio di a nni dopo, per l' esa tte zza tra la fin e di agosto e gh inizi di se ttembre del 1567 ma vennero portati ava nti con in so lita so l e rzia.
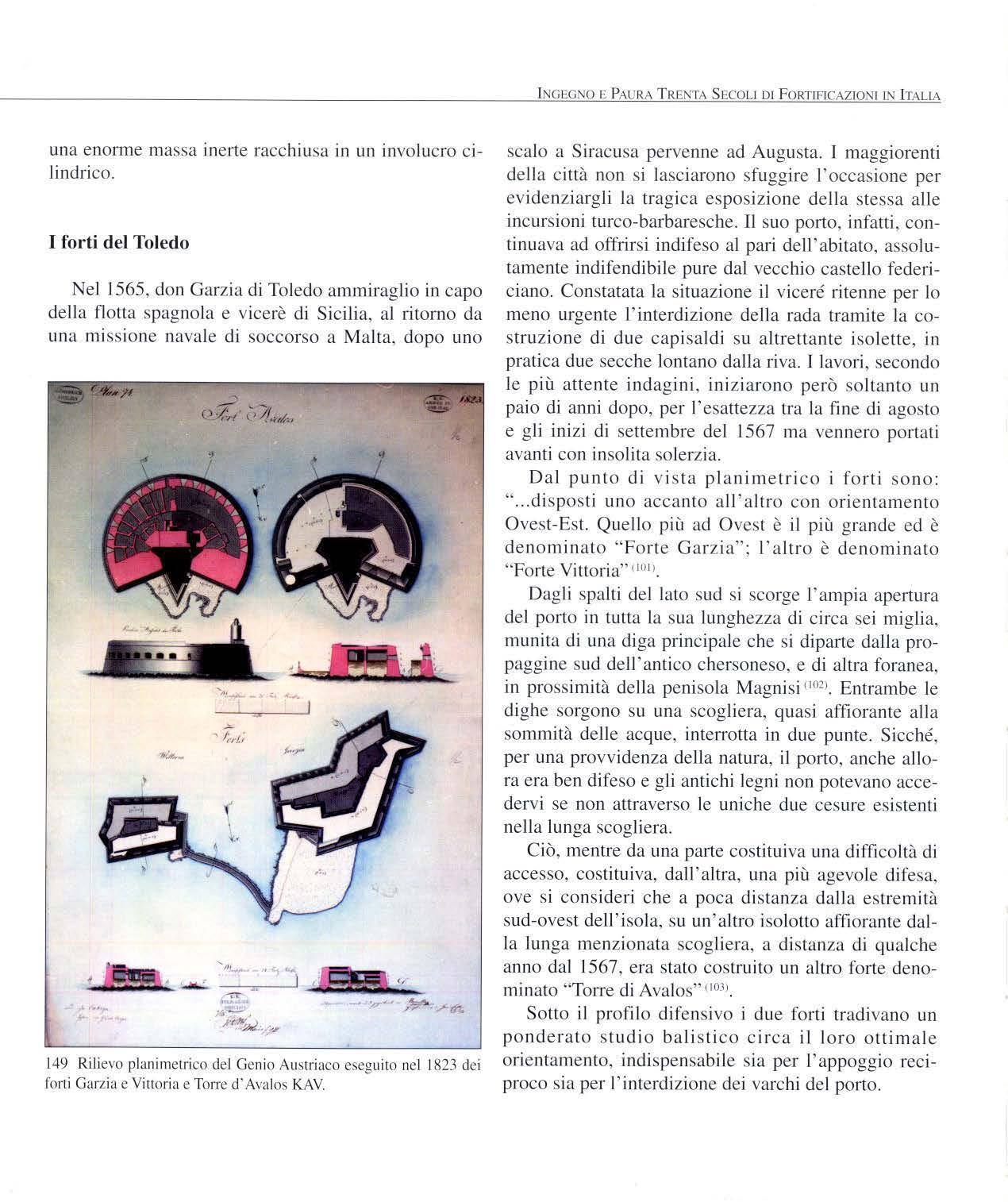
Dal punto di vista planimetrico i forti s ono: " ... di s posti uno accanto all'altro con orientamento Ovest-Es t. Qu ello più ad Ove s t è il più gra nd e ed è denom in a to " Fort e G a rzìa "; l 'a ltr o è d e nominato ·'Fo rte Vittoria" 1 w 11 •
Dagli s palti del lato s ud s i scorge l 'ampia apertura del porto in tutta la s ua lunghezza di ci rca sei m i glia, munita di un a diga principale c he si di parte da ll a propag gi ne su d deJJ'antico c he rso ne so, e di a ltra forane a, in pross imit à d e ll a penisola Magni s i 11021 • Entrambe le dighe sorgono s u una scogliera, quasi affiora nt e a ll a so mmità delle acq ue, interrotta in du e punte Sicché, per un a provvidenza della natura , il porto , anche all ora era ben difeso e g li antichi leg ni non potevano accedervi se non at traverso le uniche due ces ure es is tenti nella lun ga scogliera.
Ciò , mentre da un a parte cos tituiva una difficoltà di access o , cos tituiva , dall 'a ltra, un a più agevole dife sa , ove s i co ns id eri che a po ca distan z a dalla e s tremità s ud-o ves t dell'i so la. s u un 'a ltra isolotto affiorante dalla lun ga menzionata s cogliera, a distanza di qualch e ann o dal 1567 , era s tato cost ruito un altro forte denominato " Ton-e di Ava los" 003 l
149 Rili evo planimetrico del Genio Austriaco eseg uito ne l 1823 de i for ti Garzi a e Vi ttoria e Torre d' Avalos KAV.
Sotto il profil o difens i vo i due for ti trad ivano un pond erato s tudio bali s tico c irca il l oro otti m a l e ori e ntam ento, indispen s abile sia per l ' appo gg io reciproco sia per l'inte rdizione dei varchi del porto .
In dettaglio il Forte Garzia: " ha pianta poligonale i1Tegolare articolata da diverse parti aggettanti ed ango l ose Sul bastione prominente di levante si nota un'apertura a tutto sesto con conci in pietra arenaria , ora murata e resa non praticabile Detta apertura va ritenuta la principale del forte , in quanto è sormontata da uno stemma in maimo in cui è un ' aqui l a con le ali amp iam ente distese , in atto di reggere con gli artigli due scettri ... Attraverso un corridoio si giunge nell ' atiio diviso da una strozzatura, in due propaggini irregolar i, s icc hé la parte di ponente è molto più piccola di quella di levante. Sulla strozzatura sovrasta un arco rampante che serve a co lle gare g li s palti ove erano piazzate l e artiglierie.
Tutt'intorno all'atrio sono praticate trentatre aperture che immettono in trentotto vani di vai·ia ampie zza, di c ui a lc uni intercomunicanti, ma tutti privi di finestre prospicienti sul mare ... Di1igendoci verso il lato
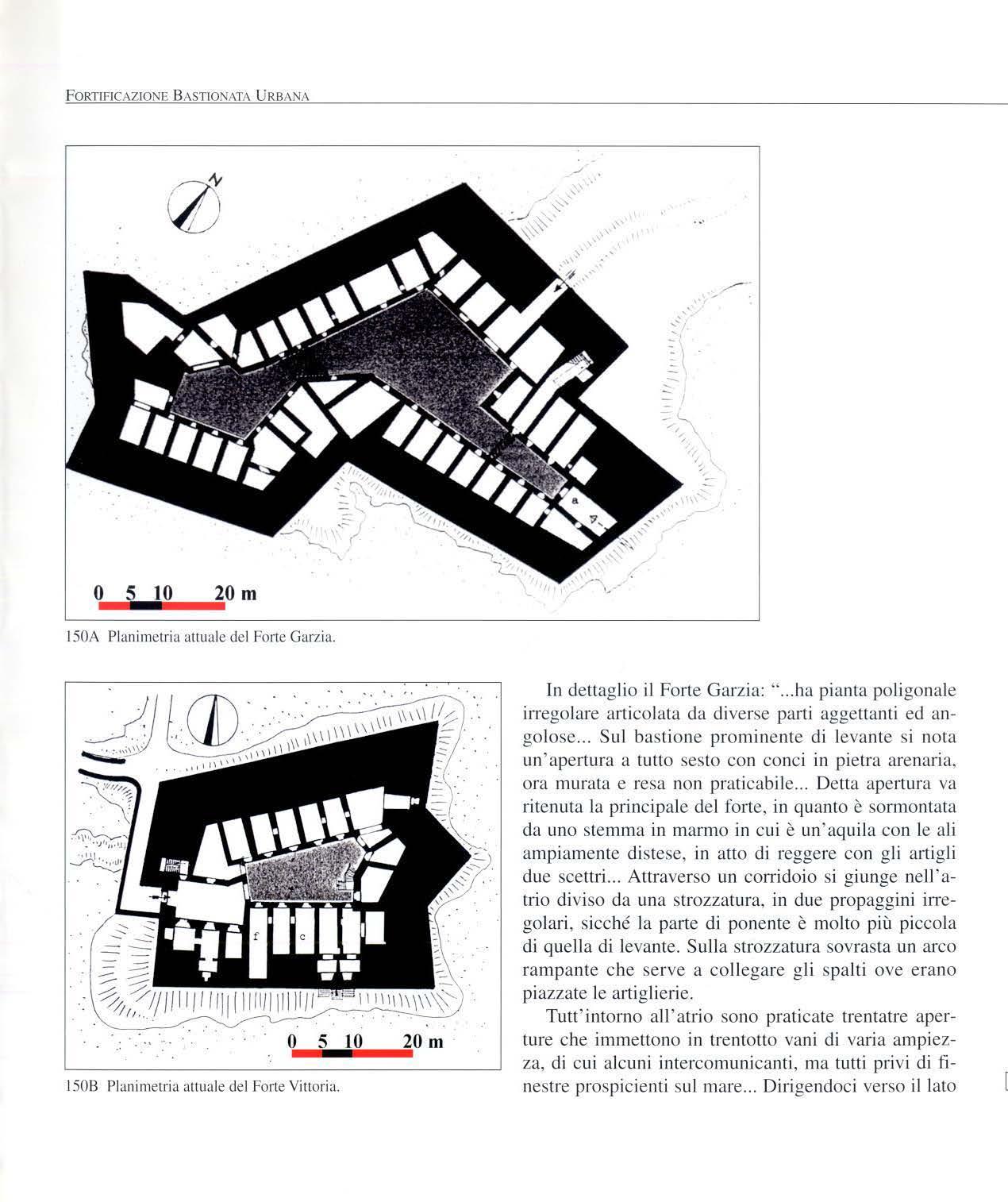
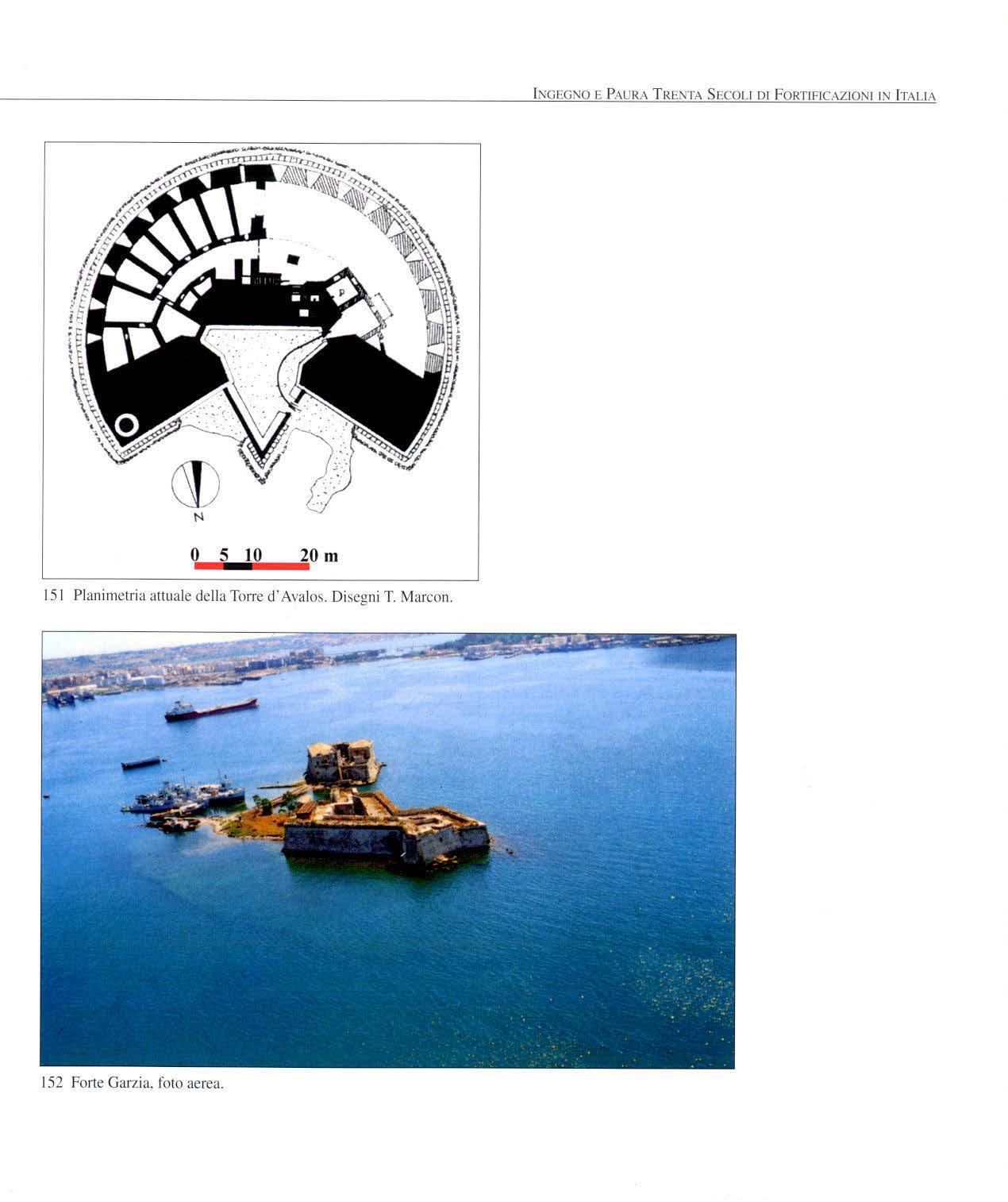
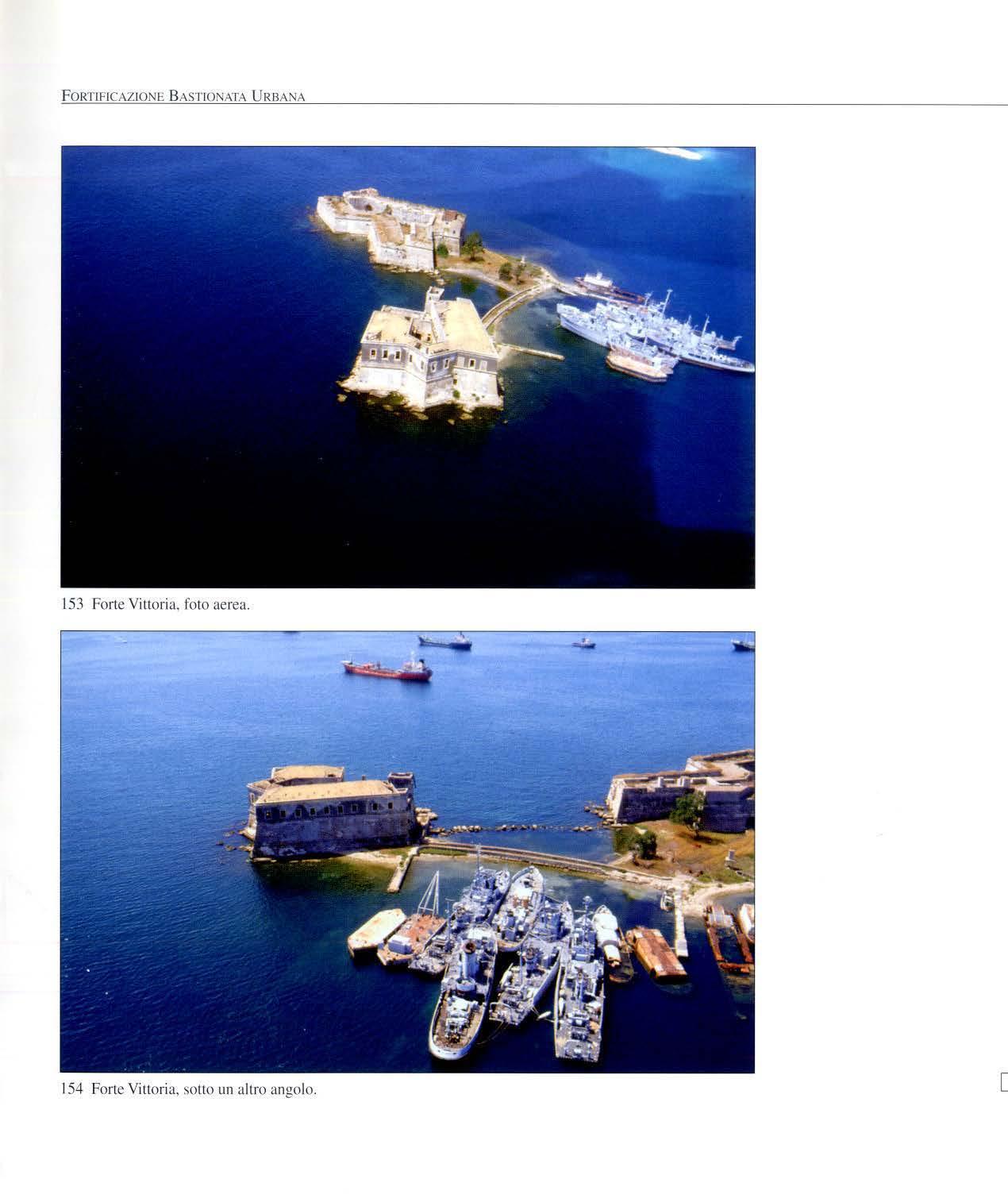 153 Forte Vittoria. fo to aerea.
153 Forte Vittoria. fo to aerea.
est della propaggine grande dell ' atrio , si può accedere al vano avente l'ingresso rivolto verso sud. Da qui attraverso una scala a due rampe ... s i giunge ad un pianerottolo abbastanza ampio. Subito scorgiamo due aperture: una s ulla destra e l'altra di fronte. La prima immette in un vano ammezzato ... [la seconda] inunette s u di una passe rella in fe1To che conduce a ll o s palto di mezzogiorno, su cui s i notano, quasi intatti , gU alloggiamenti dei vecchi cannoni ... [I due piani] erano muniti di circa quaranta bocche da fuoco , disposte s u un considerevole perimetro di circa 290 metri " 11 °")
Quanto a Forte Vitt01ia: " appare un po' più manomesso del forte Garzia. Presenta all'esterno le stesse st rutture del fo1te Garzia lal quale] è unito da una s tretta fascia di te,n. È munito di due ingressi a sesto riba ssa to praticati s ulla parete sud, che misura ben quarantadue metri di lunghe zza; sono stati resi impraticabili come quello ... del fo1te Garzia, però so no visibili i collegamenti con l ' interno al quale è possibile accedere attraverso l'ingresso con androne praticato s ulla parete ovest. La pianta è meno a1ticolata ... 11 piano terreno consta di venti vani di cui alcuni sono stati adibiti a cucina e servizi, altri a magazzini ed uno a cappella ... non vi sono aperture che dai vani guardano verso l'este rno. Il cortile, nel cui centro si nota un puteale rives tito di intonaco scorticato da cui appaiono alcuni conci di arenaria ... Una scala sul lat o est del cortile ed un 'a ltra praticata nell 'a ndrone di ingresso immettono al p1imo piano, in cui esistono ben trenta vani opportunamente dispo sti e disimpegnati e muniti di finestre che guardano su tutti i lati del porto megare se . Detti vani sono di epoca a lqu anto recente ..." <105J
In conclusione i: " ... Forti Vittoria e Garz ia che sorgono presso il massimo diametro del Porto a 400 metri dalla sua sponda nord, sono costruiti ad angoli rientranti e saglienti; si d(fendono tra Loro, ed incrociano i fuochi con la Cittadella distante 1400 metri e col forte Torre di Avalos distante da essi 1.800 m. Essi forti son rilevati dal mare m. 9; offrono un dupplicato ordine di fuochi, e possono contenere più di 60 bocche

da fuoco. Racchiudono tutti i comodi per 500 uomini sotto volte alla prova, le relative riserve, cisterne ed altro ... " (1061 •
Fatto sa lvo l 'ap porto della Torre di Avalos , che sarebbe stata edificata di lì a breve, le due razionali fortificazioni ridussero notevolmente la vulnerabilità del porto di Augusta.
Come accennato appena tre anni dopo la cos tru zio ne dei forti Garzia e Vittoria, si intraprese pure quella della cosiddetta Torre di Avalos, in realtà un altro grosso forte cooperante con i precedenti alla chius ura del porto d ' Augusta.
Promotore dell'iniziativa que sta volta fu un altro viceré di Sicilia don Francesco Ferdinando d'Avalos, marchese di Pescara, sebbe ne appaia estremame nt e verosimile che l'idea sia praticamente contemporanea agli altri due. Nonostante ciò il criterio informatore e la connotazione architettonica risultano notevolmente diversi, con l'adozione di un singo lare innesto dei due se mibas tioni bastioni ad un corpo cilindrico.
In particolare: " il Forte Avalos (10 7 > alla dritta della bocca de l porto espone ai legni un fronte curvo a 2/3 di cerchio, e verso la cinta s ud della città un fronte bast ionato ; esso è lontano dalla detta cinta 1.240 m. e dalla toITe della penisola di Magni se, posta sulla si ni strn della citata bocca , 3.650; è rilevato dal mare m 9, può ricevere presentemente circa 20 pezzi di a11iglieria, parte in casematte e parte sco perti ed ha uno s piazzo per le corri spondenti riserve ed alloggi. Esso era a doppio ordine di fuochi casamattati; nel 1823 soggiac que all'esplosione della polveriera che ne fece saltare la metà dal lato del porto, e poi s i riparò ad un piano per pezzi da costa sco perti" 11081 •
La puntuale descrizione può, tuttavia , ingenerare qualche dubbio sulla logica operativa del forte q uando la relaziona alla to1Te dj Magnisi, che in realtà venne e dificata ben due secoli e mezzo dopo, per iniziativa e
ING EGNO E P AURA TRENTA SECOLI DI FORTI FICAZIONI IN I TALIA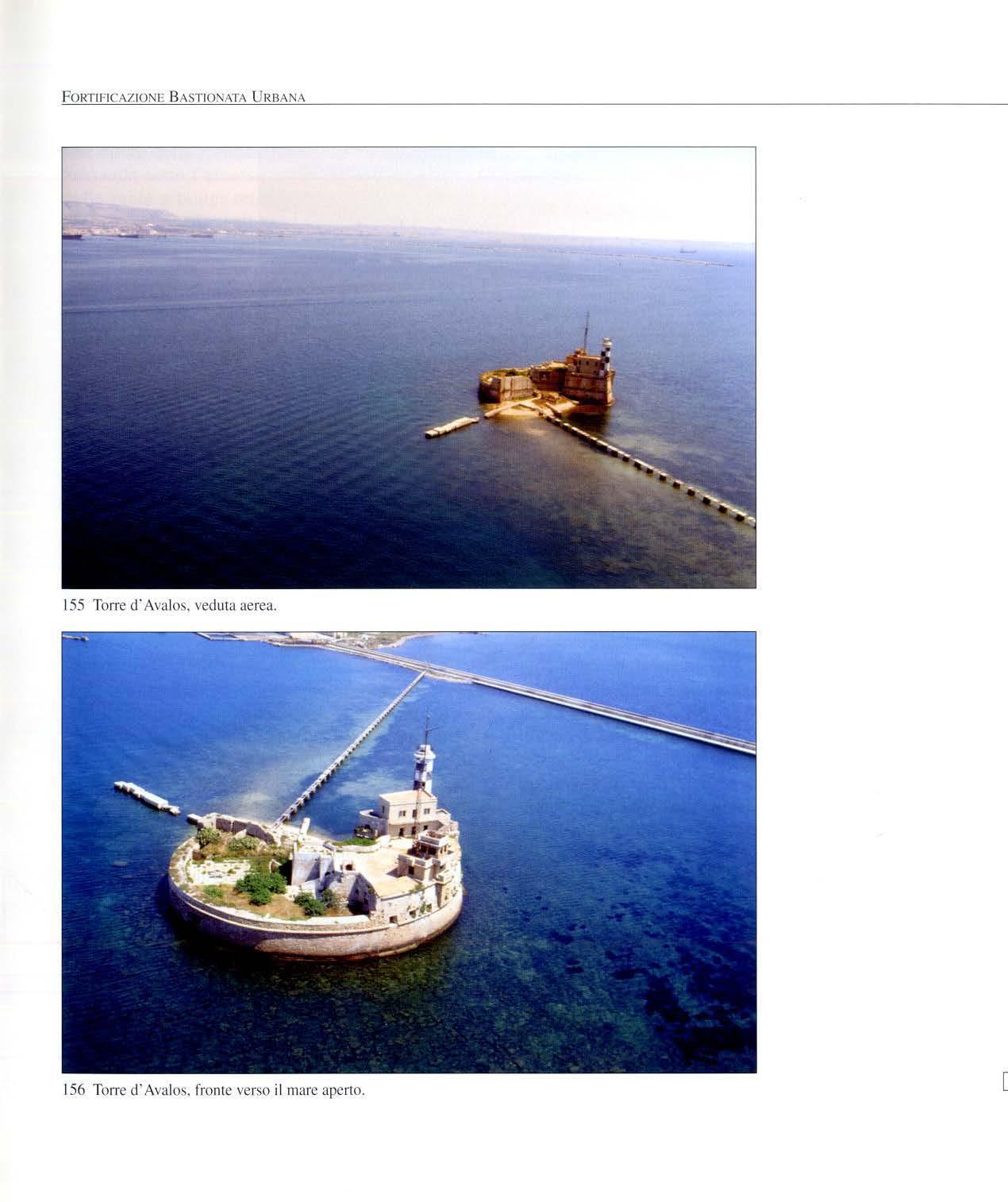
I57 Torre di Magni si. ved ut a aerea.
s u prog etto ingl ese , trattando si infatti di una delle rare Torri Martello e re tt e in Sicilia per dife nder e l ' iso la dai pav e ntati attaccru dei murattiani duran te il d ece nnio francese.
Scendendo ulte riorm e nt e in d e tta gl io è evide nte che la fortificazione occupa un a ltro scog lio, forse più esattamente un ' altra secca: " ... e d ha una pianta circola re di c ui un settore , pari ad un quinto circa dell ' intera area, è rimasto non cos truito. Questo settore g uarda il nord e costituisce l'atrio d'in g re sso . .. [all' e poca] accessibile solo d a mare...

Dall' atrio, il c ui piano di calpestio è a qualche m etro dal livello d e l m are , non è poss ibil e g uardare l'imboccatura del porto, a ca u sa dell'altezza dell e pareti della fortificazione. Dal l a to nord- es t del! ' atrio s i diparte, prote ndendo s i nel mare, l a pianta acuminata di uno sperone, sicch é s i può ritenere che l'ingre sso non fosse così ampio e d indifeso come oggi appare. Guar-
dando d a l l'i nterno dell' alrio ve r so s ud -es t si nota la b as tion a tura aggettante in cui è praticata una apertura c he co ndu ceva ad un a delle a ntich e polveriere. Sulla parete est si not a la lapid e marm o rea che ricorda la costruzione della fortezza ad opera di B e naviùe s, so rmontata dallo s temma del viceré
Sulla parete rivo lta ad est sono praticati tre gradini che immettono in un pianerottolo da cui si diparte una sca la che vo lge lieveme nte a ve ntaglio verso s ud -oves t e conduc e ad una terrazza [questal altro non era che un sec ondo cortile inte rno dal quale si accede alla parte c o p e rta della fortificazione, attraverso due aperture che immettevano , una ne lla zona s ud e l'altra nella zona nord. Qu es ta attualmente è diruta e non si scorge c he il rud ere di un bast ion e alla c ui es tremità nord è vis ibile lo sg uancio di una cannonjera in casamatta.
Sul lato sud un ampio arco a tutto ses to co n mod anature in pietra are na1ia p erm e tt e di acc e d e re al corpo
non diruto della fortificazione sulla zona sud-sud-est. Passando sotto l'arco si accede ad un corridoio con vo lta reale a botte , o r ienta t o di sg himb escio ve rso s ud -est, ne lle c ui p areti sono praticate le porte di accesso ai dieci va ni sfugg iti a lla devastazione [ciascuno dil lunghezza di m. 7 ed una larg hezza, in prossimit à dei ri s pe tt i vi ingressi, di m. 2 che man mano diviene più ampia... fino a raggiungere ... m. 3 . In ogni vano sulla parete esterna, il cui spessore è di m. 2, è praticata un a a pert ura a s trombo , il che significa c he detti l ocal i era no ad ibiti a case m a lt e ... [forse] spingarde o ... colubrine data l a maneggevolezza con c ui potevano ado pe rarsi ...
Sul lat o di l eva nt e d e lla te rr azza è praticata una sca l a coperta, a due ramp e ... [il tut to con l l'impronta inconfondibil e del g usto s pa g nuol o ..." t 1091 •
U n' ultima se ri e di a nnota zio ni c irca l' effettivo stato di servizio delle s udd ette fo rt ificazioni a questo punto s i imp one non esse ndo affatto l a solita tranquilla quiescenza tipica della st ra gra nde maggioranza dell e s tesse , che o ttennero s olo con la presenza l'esito inte rdittiv o ric ercato . P e r i for1i di A ug u sta, invece , i primi ri scon tri positivi si r eg is tran o tra il 15 85 ed il 1594 , a llorqu ando alc un e incursioni barbaresche cont ro l a c itt à ve ngo no frustrate con se n s ibili perdite. sp ec ial me nte l'ultima, d a] fuo co de i forti. Pe r null a pos iti vo, in vece, il ruolo svo lto c irca un seco l o dopo , per l' esa ttezza ne l 1675. contro un 'az ion e dell a s qu adra francese di ben 65 unità tra vasce ll i e ga le re al comando d e l duca di Vivonne 111<n . L a facilità con l a quale l a torre di Ava l os vie ne presa se mbra acc red itare tacitam e nte l 'i potes i di tradimento de l s uo co mandante che, infatti, poco dopo finirà g iu sti z i ato a Milazzo.
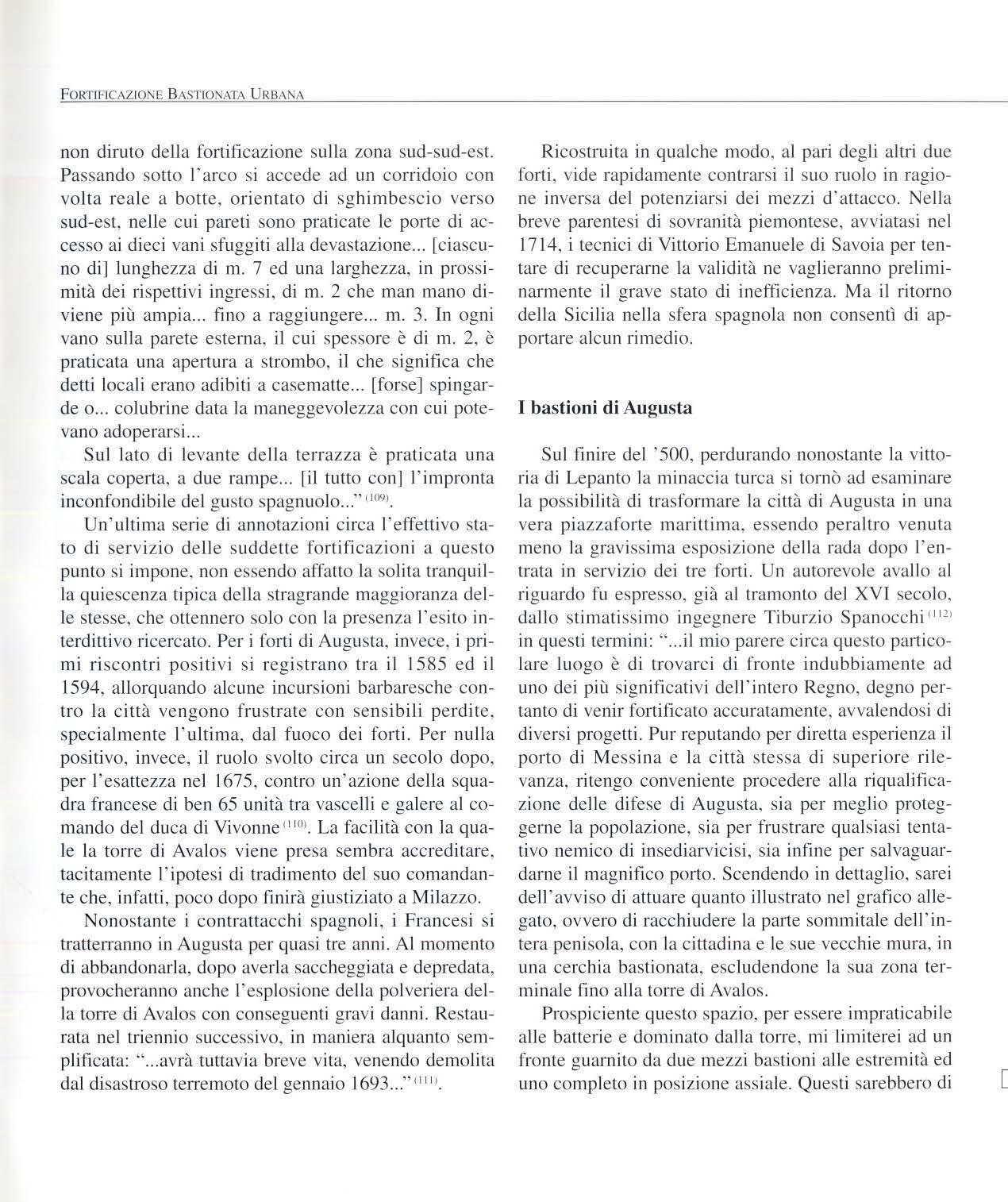
Nono s tante i contrattacchi s pag n o l i , i F ranc es i si tratten-anno in Augusta per qu asi tre anni. Al m o m e nt o di abbandonar l a, dopo averla sacc hegg iat a e depre d a ta, provoc h eranno anche l' esp los i o ne de lla pol ve1i era della torre di Ava lo s con conseg ue nti grav i danni. Res taur a ta ne l tri e nni o s ucc ess ivo, in maniera alq uanto semp l ificata: " ...avrà tuttavia breve v ita, ven e ndo de molit a dal di sastroso teITemoto del gennaio 1693 ... " 11 11 •
R ico s truita in qualche modo, a l pari degli altri due forti, vide rapidamente contrars i il s uo ruolo in ragione inversa del pote nz ia rsi dei mezzi d" at tacco . Nella breve parentesi di s ovranità piemontes e, avviatasi ne l 1714 , i tecnic i di Vittorio Emanuele di Savoia per tentare di recuperarne la va lidi tà ne vag li eranno pre li minarmente il grave s tato di i nefficie nza. Ma il ritorno della Sicilia nella sfera s pagnola non con s entì di apportare a lc un rimedio .
Sul finire de l ' 500, perd urando nono s tante la vittor ia di Lepa nt o la m i nacc ia turca s i tornò ad esaminare l a possibilità di trasfom1are la città di Augusta in una vera piazzaforte maTittima , essendo peraltro venuta meno l a gravi ss im a espos izione de ll a rada dopo l'entrata in servizio dei tre forti. Un autorevo le ava ll o a l riguardo fu es presso, g i à a l t ramonto de l XV I secolo , dallo s tim at issimo in gegnere Tibu rzio Spanocchi ( I Il> in questi termi ni: " il mio parere circa questo part icolare lu ogo è di trovarci di fronte indubbiamente ad un o dei più sign ific at i vi d e ll'intero Regno, degno pertanto di veni r fo rti ficato accuratamente , avval endosi d i di vers i progetti. Pur rep utand o per diretta esperienza il porto di M ess in a e la c itt à stessa di s up er io re ril evanza, riten go co n ve niente procedere alla ri qualifi caz io ne d e ll e di fese di Augusta, s ia per meglio proteggerne l a popolazione, sia per fru s trare qual s ia s i tentativo ne mi co di in se di arvic isi , sia infine pe r salvag ua rdarne i l ma g nifi co porto. Scendendo in dettaglio, sarei dell'avviso di at tuare quanto illustrato ne l g rafi co a ll egato . ovvero di racchiudere la parte somm it ale de ll ' intera pe ni so l a, co n la c ittadin a e le sue vecc hi e mura, in una cerchia bastionata, escl ud e ndon e la s ua zo na terminal e fino a ll a torre di Ava los .
Prospiciente questo spaz io , per esse re impr aticabi le a ll e batter ie e d o min a to dalla torre, mi limiterei ad un fronte g uarnito da due me zzi bastioni a ll e es tre mit à ed uno co mpl e to in posizione assiale. Qu esti sare bb ero di [
media grandezza, alti solo 4 canne, e quand'anche privi di fossato, non dovendo fronteggiare minacce di batterie nemiche, né di scavi per mine per la natura rocciosa del sito, sarebbero pienamente sufficienti.
Venendo alla cerchia che costeggerà i bordi della penisola, potrà strutturarsi tramite una semplice muraglia di 6 o 7 palmi di spessore, priva di scarpa e dotata di ton-ette aggettanti di almeno 2 canne, alla maniera antica, con interassi non eccedenti le 80. Per tutto il perimetro di questa murazione si imporrà il ricorso a contrafforti di circa 10 palmi di larghezza per 4 di spessore ad intervalli di 18, sostenenti volte destinate a camminamento, dell'identico tipo di quelle prospettate per Catania e Messina. Ritrovandosi però la sezione di levante maggiormente esposta alle mareggiate, ritengo utile incrementare lo spessore della cortina, munendola di una scarpa di almeno sei palmi di altezza ed altrettanti di cacciata, completamente di salda muratura: al di sopra di questa fino alla normale quota continuerà pe1fettamente a piombo.
Nella opposta banda, quella che guarda l'interno del porto, occorrerà completarla con un parapetto di 3 palmi di spessore per 6 di altezza, lasciandone l per la retrostante banchina, da eseguirsi conforme alle sezioni di dettaglio. Occorrerà inoltre, di tanto in tanto, costruirvi una scaletta, di I O palmi di larghezza per lo meno, per poter da più parti accedere contemporaneamente al camminamento. Nella tratta di massimo spessore, in particolare verso il nord dove non possono sostare i vascelli, si praticheranno altresì i vani indispensabili al commercio navale, proteggendo I i nella migliore maniera.
Il secondo fronte trasversale, quello verso te1Taferma, mi sembra logico erigerlo laddove la penisola è più stretta, raccordandolo al Castello Vecchio, curando di farne sporgere in mare le estremità di alcune canne, poiché altrimenti riuscirebbe difficile difenderlo con il tiro d'infilata della piazza. Tale ridottissima fronte andrà innalzata di 14 palmi di spessore, con la sua scarpa di 6 di cacciata e di 5 d ' altezza al di sopra del fossato , limitato a questa breve sezione e largo nel centro della
fronte tra i due mezzi bastioni 10 canne , e profondo fino al livello del mare. Non sarà molto poiché la ten-a in quel punto è particolan-nente bassa. I suoi contrafforti avranno 1Oo 12 palmi di larghezza e 4 di spessore con il solito interasse di 18; inoltre si farà anche il te1Tapieno di 7 canne di larghezza con la contro-parete interna di rincalzo dotata delle tradizionali scalette.
Fatto quanto esposto la piazza potrà definirsi sicura ed al riparo da qualsiasi minaccia , con il porto assolutamente sorvegliato e protetto. La spesa preventivabile appare modestissima , disponendosi in loco sia delle pietre che della calce e di quant'altro ancora necessiti, in grande abbondanza. Con la realizzazione della descritta opera si affrancherà la derelitta e scarsa popolazione dall'incessante onere della vigilanza costiera, estate ed inverno , non di rado prestata da tutti gli abitanti, come nella scorsa primavera, proprio per essere il loro litorale così vulnerabile" (ID> .
La pe1izia dell'illu s tre tecnico quand'anche condivisa non trovò però seguito concreto. Trascorse così quasi un secolo, finché nel 1671 l'ingegner Grunemberg fu convocato ad Augusta per studiare un possibile progetto di difesa.
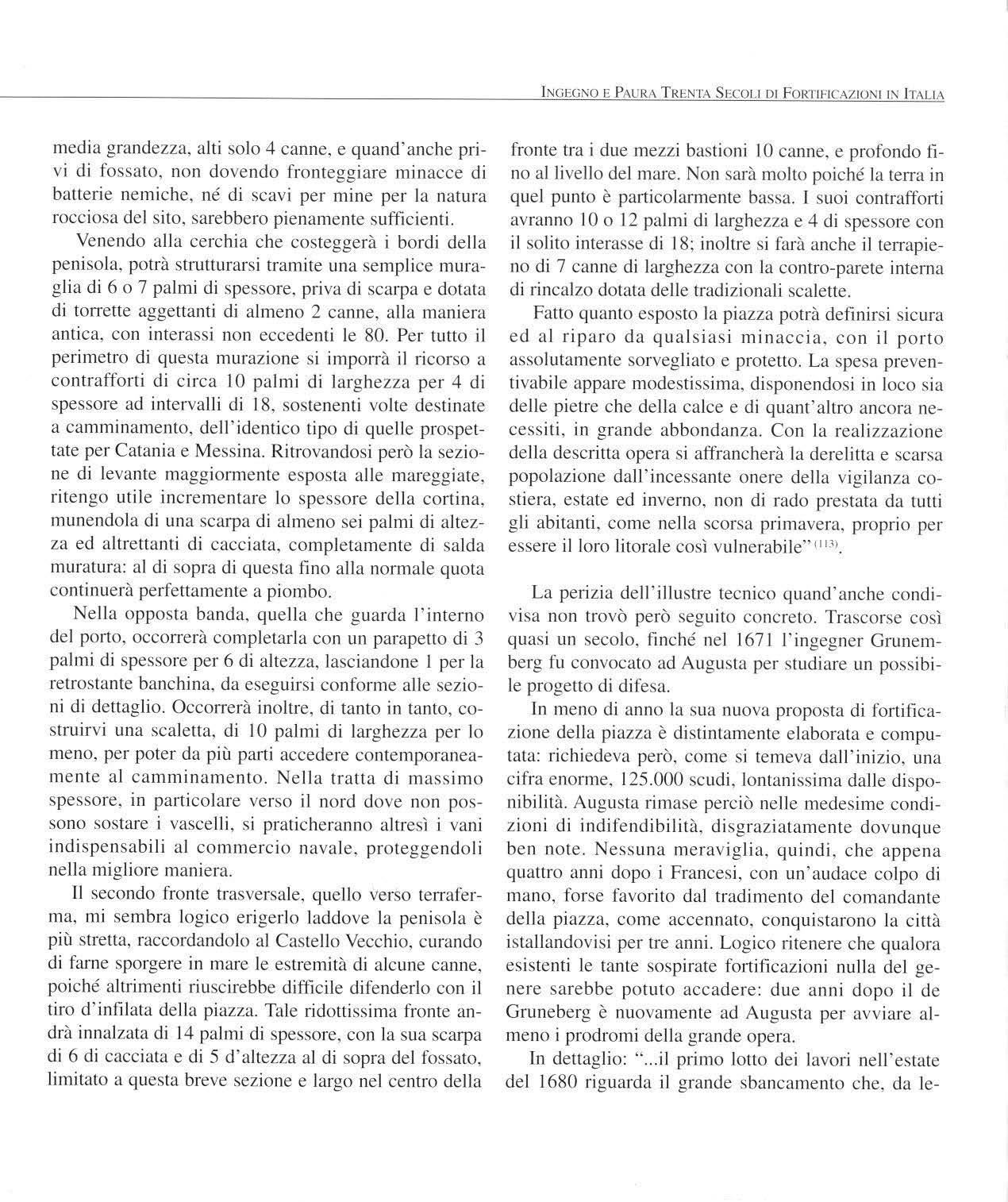
In meno di anno la sua nuova proposta di fortificazione della piazza è distintamente elaborata e computata: richiedeva però, come si temeva dall'inizio , una cifra enorme, 125.000 scudi , lontanissima dalle disponibilità. Augusta rimase perciò nelle medesime condizioni di indifendibilità, disgraziatamente dovunque ben note. Nessuna meraviglia, quindi, che appena quattro anni dopo i Francesi, con un'audace colpo di mano, forse favorito dal tradimento del comandante della piazza, come accennato, conquistarono la città istallandovisi per tre anni. Logico ritenere che qualora esistenti le tante sospirate fortificazioni nulla del genere sarebbe potuto accadere: due anni dopo il de Gruneberg è nuovamente ad Augusta per avviare almeno i prodromi della grande opera.
In dettaglio: " .il primo lotto dei lavori nell ' estate del 1680 riguarda il grande sbancamento che , da le-
vante a ponente , disegna davanti al castello la piazza d 'armi e isola la cittadella, terminando verso il porto con un'opera a corno o tenaglia, i cui baluardi si chiamano S. Francesco e S. Teresa.
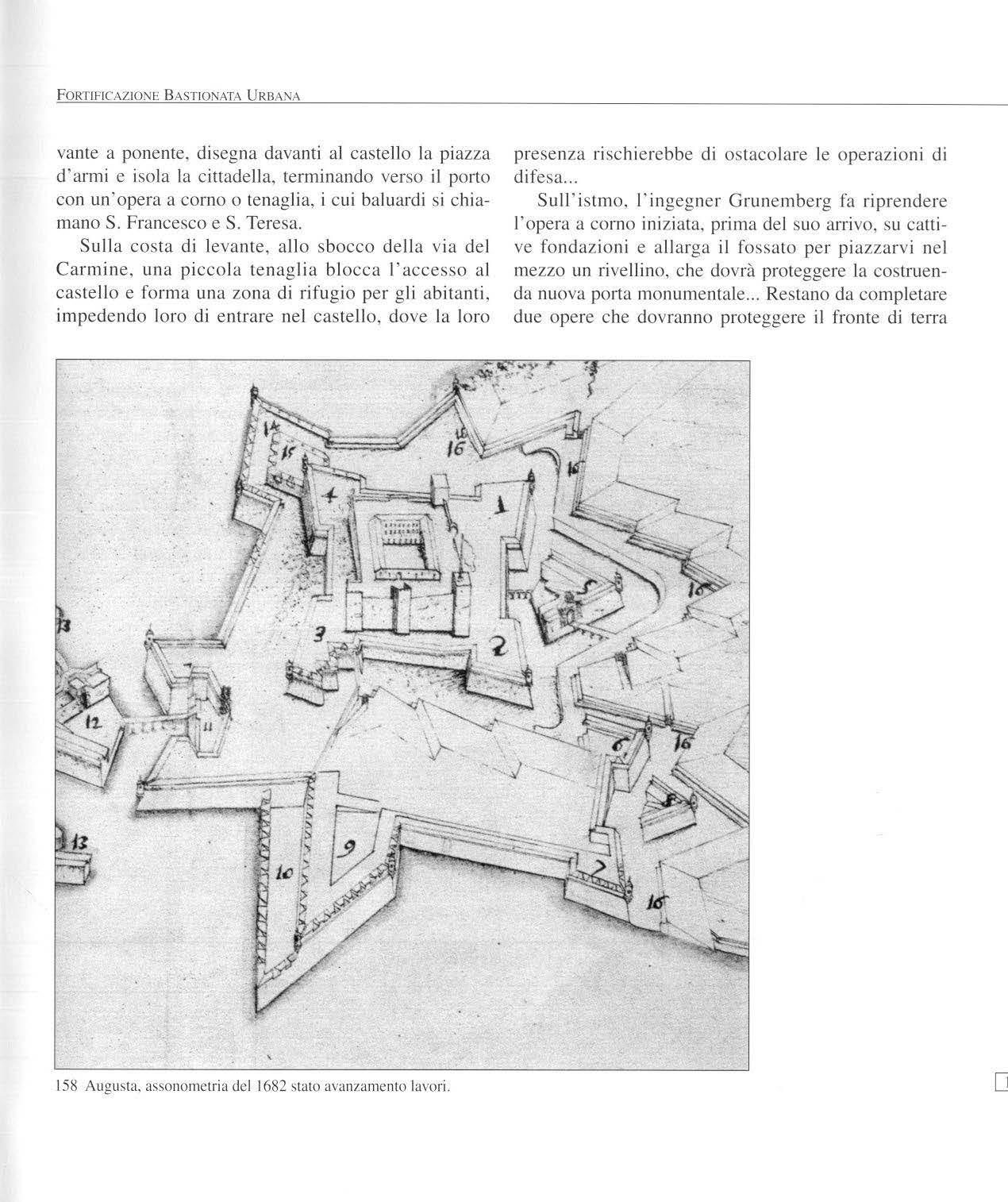
Sulla costa di levante, allo sbocco della via del Carmine , una piccola tenaglia blocca l 'accesso al castello e forma una zona di rifugio per gli abitanti, impedendo loro di entrare nel castello, dove la loro
presenza rischierebbe di ostacolare le operazioni di dife sa ...
Sull ' istmo, l'ingegner Grunemberg fa riprendere l'opera a corno iniziata, prima del suo arrivo, s u cattive fondazioni e allarga il fossato per piazzarvi nel mezzo un rivellino, che dovrà proteggere la costruenda nuova porta monumentale ... Restano da completare due opere che dovranno proteggere il fronte di terra
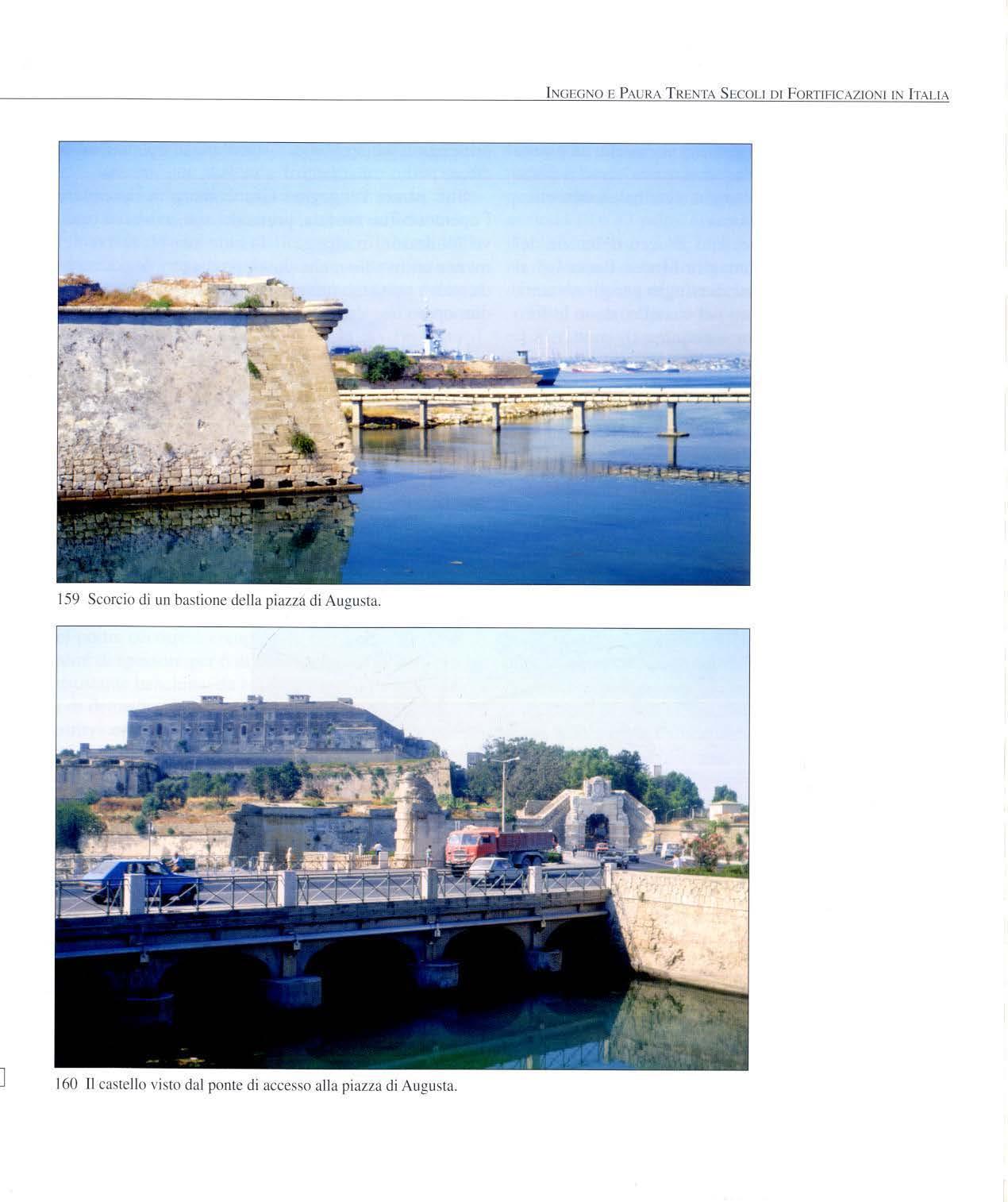
sotto il castello dai fuochi di un eventuale nemico insediato sulla terraferma: il baluardo S. Giuseppe rinforzato con una falsabraga, e il baluardo S. Carlo con un cavaliere addossato al bastione S. Bartolomeo. La veduta assonometrica della cittadella in corso di realizzazione intorno al J682, dà un'idea dell'ampiezza dei lavori realizzati da Grunemberg e dello scaglionarsi delle opere che dal castello vanno verso l'istmo , il porto e la città.
Tuttavia l'abitato ... resta considerevolmente sg uarnito dalla parte di Tenavecchia e lungo le spiagge cli levante e di ponente. Perciò durante l'estate del 1680 squadre cli soldati spagnoli e tedeschi, aiutati dagli abitanti, costruiscono un parapetto che dal Carmine arriva fino a S. Francesco di Paola e di là fino al baluardo di Calcarella ; sulla costa ovest, da S. Domenico fino al baluardo di Leonforte " (11 -1 1 •
Al di là della più o meno articolata scansione delle fortificazioni realizzate dal Grunembergh, al di là della loro compartimentazione ed ampiezza, debutta per
la prima volta una concezione difensiva assolutamente inedita. La cittadella progettata e reali zzata da: " ... Grunembergh non ha come obiettivo quello di sos tenere un assedio indefinito ; essa deve essere capace di opporre solo una re sis tenza che consenta al difen sore di organizzare la sua risposta , nell'attesa dei soccorsi " (1151 La novità, pertanto. non s i ravvisa nella limitazione dei tempi di resistenza, concetto praticamente da sempre risaputo s ia pure in modo più o meno confuso, ma nel de stinare tale intervallo alla riorganizzazione della difesa interna. Fino ad allora infatti la re s is tenza di una fortificazione serviva o a far desis tere l'attaccante o a consentire ai rinforzi este rni di poter sopraggiungere a s pez za re l'inv es tim e nto. Con qu es ta nuova concezione invece l'int era piazza si fraziona in più unità difen sive autonome mutuamente esaltantesi, trasformando in ultima analisi un investimento ossidionale in una so rta di corsa ad ostacoli. Sarà questa la logica delle maggiori strutture difensive del seco lo XIX.

1 C. SACHERO. Corso di.fortifica zione permanen1e d'atla<:eo e difesa delle pia-:,zeforti, Torino 1861, p 32, scriveva: ·· La fort i(ìcazione italiana moderna, appena nata nel 1500. fece in quel secolo rapidi progressi, stan te la p rodigiosa attività spiegata dai popoli e dai principi italiani per premunire le terre loro dalle straniere invasioni . E sruclianclo la fo rtifi cazione ita li ana avremo un'idea precisa dello stato dell'architettura milit a re di quelrepoca. poiché italiani erano all ora per la più pa rte deg li in gegneri di qualche nominanza ". Ne ll e sue parole si intravede una delle principali concause de ll' enorme cos to della fo rt ificaz ione bastionata: il suo eccessivo evolve rsi. che costringeva a cont inui aggiornamenti delle opere. Logico all ora che G. PARKER , La rivoluzione mi/ilare. Le innovazioni militari e il sorgere dell'Occidente, Bologna J989. p. 44. ricordi che la: ·· .. .trace italienne fece lent i progressi in Germania e a ltrove non solo per i suoi cos ti (sebbene pe r alcuni stat i ciò fosse un cleteITente suffic iente), ma anche per le d ifficoltà nel mantenerla aggiornata." Che, poi. in ultima analis i è la stessa cosa. ovvero un ulteriore incremento dei costi.
2 Precisa sull'argomento C.M. CIPOLLA. Vele e cannoni, Imola 1983. pp. 17-23: "T cannoni potevano essere cos truiti sia in ferro che in bronzo [quest ' ultimo] da l punto di vista tecnico, è più facile da fonde re e in tutta E uropa vi erano artigiani che conoscevano bene il procedimento pe r v ia dell'antica e diffusa 1ichies ta di campane ... Comunque l'artiglieria in bronzo comparve mollo p resto e incontrò subito grande favore , non so lo perché il bronzo è meno soggetto alla corrosione, ma anche perché il procedimen to d i fusione rendeva possibile la fabbricazione di cannoni ad avancarica ... Quanto all 'aspe llo eco nomico dell 'alternativa, non c'è dubbio che come materia prima il feITo cos tava mo lto meno del bronzo Il rame, la materia prima fondamentale per la fabbricazione dell 'aniglieria in bronzo. proveniva principal mente da!J'Ungheria, dal Tiro lo. dalla Sassonia e da lla Boemia. Lo stagno ... principa lmente da ll ' Inghilterra, dalla Spagna e dalla Ge1111an ia. Quantunque le materie prime proven isse ro da un li mitato numero di regioni, la fusione dei cannoni in bronzo ven iva praticata quasi dovunque da artig iani che non aveva no alc un a difficoltà ad alternare la produzione di campane con quella di cannoni e viceversa li guaio dell'artigl ier ia di bronzo era che costava troppo. li rame e lo stagno erano materie prime costose. e l' alto costo cie l bronzo divenne sempre più int ollerab il e ...". Dal che la menzionata secon da età ciel bronzo. che si manifestò anche con inusi tate disposizioni quali per tutte il cosiddetto 'd irill o a ll e campane·! In p ratica i maestri artiglieri e la loro compagnia avevano diritto cl i appropriarsi delle migliori campane in ogni paese conquistato. di ri tto che trasformatosi in consuetudine s i ritrova vigente ancora ag li in izi del 1800 sia ne!J'esercito francese c he in que ll o spagnolo.
3 Da J.N.D. KELLY. Vite , ci t. , pp. 469-471: "U rb ano VTU - Maffeo Barberini ... nato a Fi renze nel 1568 da una ricca famiglia di commerciant i studiò a Roma e conseguì il titolo di dottore in giurisprudenza a Pisa ( 15 89); con l'aiuto d i uno zio. protonotario apostolico, in com in ciò poi una brillante ca rri era nella cu ri a romana.. . nel 1601 in Francia come ambascia tore ... vi ritornò come nunzio ... nel 1604. Tn ri conoscimento dei s uo i ser vig i Paolo V lo nominò cardinale nel 1606, vescovo di Spoleto nel 1608. legato di Bologna nel 161 I e p re fetto della segna tu ra nel 16 17 leletto papa il 6 agosto 1623] Di carattere a uto1i tario Urbano si occupò personalmente degli affa ri de ll a chiesa e raramente li discusse con i cardinali ... Da esperto conosc itore della letteratura e proprietario di una splendida bibl ioteca compose e pubblicò vers i latini ben costruiti, anche se alquanto fio1iti Fu impud ente nepotista: diede la porpora cardina lizia a un frate ll o e a due nipot i, favorendo anche altri fratelli e aITicchendo tutti i famil iar i in modo .. . esagerato .. . Sostenne in gen ti spese per abbe ll ire Roma , e il 18 novemb re 1626 consacrò la nuova basilica di S. Pietro. Si preoccupò anc he deJ!a sicu rezza del la città e dello stato pontificio, cos truì Caste lfranco sulla frontiera setten tri ona le, fort ifi cò il po rt o di C ivitavecchia. rinforzò Caste l Sant' Ange lo e lo fornì di cannoni fatti col bronzo to lto dal Pantheon ... Il pontificato di Urbano coi nc ise con la guerra dei treni' ann i ( 16 I 8-1 648). Malgrado la sua si mpatia per la Francia e l'altrettanto aperta antipat ia per la Spagna, il papa s i sforzò di man tenere una non faci le neutral ità fra i con tenden ti ... Sotto di lui Galileo Galilei (1564 - 1642), che p ure era sta to suo persona le amico. fu condanna to per la seconda volta e costre tto (22 g iu gno J633) sotto la minaccia della tortura ad ab iu rare il sistema copernicano Urbano fu semp re fo rtemente preoccupato di conser va re l' in tegrità dello stato pontific io. tuttavia l'un ico successo che riuscì a ottenere in q ues to campo fu l' incorporazione di Urbi no Nei suoi ultimi anni di vita sì lasciò coinvo lge re in una g uerra per il feudo papale di Castro . ne ri sul tò una umiliante sconfi tt a dc li' ese rci to papale. Questa g uerra, benché picco la, ca usò devastazioni e paralisi finanz ia1i a ne llo s tato pontificio; non st upi sce quindi che la plebe romana, g ià crudelmente opp ressa da a llre spese inutili del papa, abbia acco lto la notizia della s ua morte [29 luglio 1644) co n num erose man ifes tazioni cli soddisfazio ne."
4 È interess ante costatare che la s tretta in terdi pendenza lra apparato mi litare e rivoluzione indu stri ale, ab itua lmente m isco nosciuta, venga invece evide nziata con tesi s imili a quella espos ta da W.H. Mc NEILL, Caccia al potere Ternofogia, anni. rea/1à sociale dalf'c111no Mif/e, Milano 1984. pp. 175 - 176: "La magg io r parte deg li studiosi della rivoluzione industriale 1ivolge scarsa attenzione alla guerra. Quelli che la p ren dono in considerazione d i so lito soste ngono o c he la guerra frenò . invece dì acce lerare, lo sviluppo industria le ing lese

o che comunque non apportò notevoli differenze. L'affermazione è discutibile. L'enorme aumen to de ll e spese s tatali, quas i tutte per scopi bellici. certamente influì sulla domanda e sull'offerta di ogn i articolo trallato nell'ambito dell'economia ingle se. Solo s upponendo c he qualche altro stimo lo avrebbe fornito occupazione a tutta la forLa lavoro e av rebbe dotato la parte del popolo ing lese in precedenza sottoccupata di un'effettiva capacità di acquisto equivalente a que ll a eserc itata da ll 'eserci to e dalla marina inglese. diviene plausibi le l' ipotesi che, senza guen-a, il passo dell'industrial izzazione in glese sarebbe stato pari o superiore a quello effettivamente verificatosi ".
5 L'impiego dei civili nella difesa delle mura è prassi abituale in ogni epoca storica. Quanto poi all'impiego delle donne gl i e se mpi so no innum erevo li: del resto la presenza femmini le nei combattimenti con ruoli non meramente pass ivi risale a tempi immemorabili , ritrovandosi sistematicamente in molte società primitive. In merito cfr. G. Bo urnouL, Trattato di sociologia. Le Guerre. Elementi di polemologia, Milano 1961. p. 141.
6 Va osse rva to, però. che il servizio sui bastion i non s i configurava quale prestazione di una vera e propria forza armata cittadina. ma piuuosto come una manifestazione di servizio civile. La presenza d i milizie cittadine. infatti. non fu ma i vista di buon occhio per il timore che le stesse potessero divedersi in fazioni e combatters i fra loro grazie a ll e armi d i cui disponevano. In merito cfr. V. LLAR I, Storia del servi zio militare in Italia (1506 -1870 ), Roma 1989, pp. 27 -4 5
7 Quanto limitato fosse il raggio di influenza di un castello lo si può facilmente dedurre ricordando che g li eserciti, se tali si po ss ono motivatamente delìnire le bande medievali armate alla meglio con attrezzi agricoli , avevano una mobilità li mjtati ssima. Oltre alla mancanza di s trade con tribui va a tale deficienza la scarsità dei viveri al seguito. in pratica mai eccedente l'autonomja di un paio di gio rni. TI che diede al la gue rra una conno tazione tattica esclusivamente difensiva. Per approfondimenti cl'r. R.A. PRESTON, S.F. W1 SE, Storia sociale della guerra, Verona 1973, pp. 100- 119.
8 Sull'argomento cfr. G. C..c\CIAGLI, li castello in //alia, Firenze 1979. pp. 82-1 I 8.
9 Una sintetica ri costruzione storica della città di Bari nel contesto della Puglia è tracciata da A. G UILLO U, La Pug lia e Biswdo. in La Puglia fra Bisa,do e l'Occ ideme. Venezia 1980, pp. 5 -36.
rn Circa l'arrivo dei Normanni in Puglia ed in particolare nel conte sto della rivo l ta di Melo , cfr. F. CIIALANDON. Storia della domina z ion e normanna in Italia ed i Sicilia, rist. Napoli 1999, pp. 49 - 1O1.
11 Cfr. G. BACIL E DI C ASTIGLIONE, Castelli.... cii., pp. 42 -51.

1= Da R. DE VITA Cast e lli , cit., p. 89.
n Cfr. G. BACIL E DJ CASTIGLION E, Castelli... , c ii. , p. 48.
14 Cfr. G. G AL ASSO. Potere e istitu zioni in Italia. M il ano J978 pp. I02 - 116.
15 Da G. BACILE 01 C ASTIGLIO NE , Castelli ... , cit., pp. 51-60.
I(, Per ulteriori approfondimenti cfr. L. MAGLIO, Architetture cit., pp. 42-46.
17 A.G.S., E Nàpoles. 1033. 7.
1 ~ Sulle origini del Castel Nuovo di Napo li cfr. R. F IL ANGER I, Castel Nuovo reggia angioina ed arag ones e di Napoli, Napoli 1964. pp. 3-10.
19 Da L. SA'.\'TORO. Castelli angioini e aragonesi nel regno di Napoli, Segrate I982, p. 67.
20 Sul contesto storico conseguente all'entrata in Napo li di A lfon so d'Aragona nel 1442 cfr. A. GHIR ELLI. S10ria di Napoli, Torino 1973, pp. 15-16.
2 1 Da L. SANTORO, Castelli angioini.... cit., p. 142 .
n Da E. PrROVINE, Napoli , ci t. , p. l 66.
13 Da L. SANTORO, Castelli angioini .. ., cit., p. I 65.
24 Da A. GUGLIELMOnr , Storia delleforti}ìcazioni sulla spiaggia romana, Roma 1880, p. 94.
25 Da A. GUGLI ELMOTr l, Storia delle , cit.. p. 94.
16 Da J.N.D. KELI Y, Grande di zionario , cit.. pp. 596-598: ''Niccolò V - Tommaso Parentuccclli. nato a Sarzana, eletto il 6 marzo 1447-moito il 24 marzo 1455... studiò a Bologna ... conseguito il dottorato in teologia prestò la s ua opera per venti anni al vescovo Niccolò Albergati di Bologna , trasferendosi poi a Roma in sieme con lui nel 1426 Eugenio TV. nel 1447 lo nominò vescovo di Bologna, carica che tuttav ia egli non poté assumere perché la città era in rivolta ... Nel conclave che seguì ... fu sce lto come candidato cli compromesso Era in buone relaz ion e con le famiglie romane e riuscì a ristabil ire l'ordi ne nella cillit, a liberare lo stato pontificio dalle truppe mercenarie ... In seg uit o ... fall a] notizia del saccheggio di Costantinopo li.. . N icco lò tentò di radunare la cristianità per una crociata (30 settembre 1453) ma senza esito. Convocò anche un congresso degli stati italiani a Roma per elaborare un trattato di pac e per l'Italia, ma sempre invano.. . La morte colse Niccolò... nel marzo del 1455. mentre era in preda alla delusione e alla s fiducia ...''.
L'IGEGNO E PAURA TREYfA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIA7 Dal. lNSOLERA. Roma. Immagini e realtà dal X al XX secolo, Bari 1980, pp. 27-28.
Jg Da A. GuGLJELMOTTI. Storia delle , cit., p. I O1.
29 Da A. G UGLI ELMOTTI , Storia delle , cit., p. 120.
30 Da L. CARD ILU. G. PISANI SARTORIO. Le Mura Aureliane e Gionicolensi, in Muro e porte di Roma antica, Roma 1995, p. 19 I.
·'
1 Cfr. L. VATTUONE, Le torri e le difese , in li Polaz,:,o Apostolico Valicano, Firenze 1992. pp. 255 e sgg.
12 La fortificaz ione perimetrale di Roma fatta erigere tra il 271 ed 275 d C. dal!' imperatore Aurel iano può senza dubbio considerars i tra le maggiori in assoluto de l genere. Si snodava infatti per oltre 19 km ed era fiancheggiata da ben 380 toni, collegate da una cortina continua spessa tra i m 3 e 4 ed alta mediamente m 8.
' 3 Una s ituazione ana loga si riscontra a Napoli. a Messina, a Cagliari. tanto per citare le p1incipali città che agli inizi de l '500 vennero munite di moderne cerchie bastionate. Tranne che per Napo li, nei res tanti casi si dove tte e rigere una apposita fortificazione su ciascuna collina completamente autonoma da ll a cerchia urba na, in grado comunque di evita re l'occupazione nemica de ll a stessa. A l riguardo è interessante ricordare per Napo li. le precisazion i d i L. SANTORO, le mura di Napoli, Napoli J984, pp 104- 1I 8 secondo cui è evidente che nelle: " .. .mo t ivazioni delle decisioni urban istiche di don Pedro d i Toledo ... abb ia predominato la necessità di assicurarsi il dominio del la città L'estrema altura del Vomero, la local ità de tt a appun to S Eramo o S. E lmo e po i anc he S. Martino, è un vero e proprio baluardo ... che domina tutta la città del tempo e la cui eventuale conquista da pa rte del nemico costringerebbe la c ittà stessa alla resa Ecco quindi la funzione cui deve assolve re la fortezza di S. Elmo : Per Cag liari cfr. F. Russo. La dijèsa costiera del Regno di Sardegna .... c i t., pp. 27 -29. Per Messina, infine. cfr. F. Russo . La difesa costiera del Regno di Sicilia ... , ci t. . pp. 59-64, che così de linea al riguardo: "Tn concre to il principale prob lema che angustiava i progettisti scaturiva, paradossalmente, proprio eia una delle peculiar ità difensive della città: le sue numerose alture limi trofe. La tormentata orografia che la cingeva da nord-ovest a sud-est , infatti. rendeva improbe , a qualunque attaccante, le operazioni di assedio e di avviciname nto. Ma al contempo g li consentiva, per il dominio che ta li colline possedevano sulle for tificaz ioni urbane immed iata mente sottoposte, di sp ianarle con un intenso t iro di artig lieria. una volta insediatovisi in cima''.
u Da A. MAGGI. Fortifica;.io11e, Venezia 1564, p. 1 15, citato dal Guglielmeotti, in Storia dellefortffì ca zioni... , c i t., p. 325.
35 Da V. SC AMOZZI, Architetrura universale, Venezia 1615. lib. II, cap. 28, p. I 08. La citazione è tratta da Guglie Imotti, S1oria delle fort(fìca ;. ioni , cit., p. 326.
36 G. SOMMELLA BEDA. Roma: le fortifica zioni del Trastevere. Lucca 1973. p. 64.
37 Da G. PARKER. La rivolu z ione militare. le innovazioni militari e il sorgere dell ' Occidente. Bo logna 1989, p. 26.
38 G. M ILANESI, Le opere di Giorgio ¼1sari con nuove annota zioni e commenti di Gaetano Milanesi, Firenze 1906. tomo V, pp. 469-472: " ... onde avvenne. per lo caldo che era grande ed alni disagi, essendo Antonio pur vecchio e cagionevo le. che si ammalò di febbre in Terni, e non molto dopo renclè l'anima Di che sentirono g li amici e parenti suo i infinito dolore; e patiro no molte fabbr iche, ma particolarmente il palazzo de' Farnesi vic i no a Campo d i Fiore... morto in Tern i, fu condotto a Roma, con pompa grand iss i ma portato a ll a sepoltura e fat to mettere il co rpo s uo in un diposito v icino alla cappe ll a di papa Sisto in San Pietro ".
39 La sped izione offensiva alle Gerbe f u compiuta da una fo rza navale di 47 ga lere, 4 galeotte, 3 galeoni, oltre a 36 navi da car ico. L'equipaggio ammontava a circa IO- J2. 000 uomini. Molto imp ru dentemente fu intrapresa ag li in izi di dicembre. q uando, cognizione arcinota da secoli. le condizioni meteoreologiche del Mediterraneo g ià da almeno due mes i non pem1ettevano l' i mp iego delle galere. Dal che ne derivarono due distinte disgrazie: una lunga sosta presso Malta, essendosi subi to compresa la eccessiva temera,ietà della nav igaz ione. con conseguenti gravissime ep idemie per gl i equipaggi . Alcune migliaia di uomini s i persero così ancor prima di combattere. Secondariamente la notizia rap idamente pe rvenuta a Costantinopoli consen tì u n comodo ant icipo per i preparativi di contrattacco turco. Sui de ttag li de ll'impresa cfr. C. MoNCHICOIJRT. L'e.,pédition espagnole de 1560 contre /'ile de Djerba, Pruis. 19 13, pp. 88 e sgg..
Circa il macabro tro feo, ricorda A. ROUSSEAU, Anna/es Tunisiennes, Alge ri 1864, p. 26:'' i Turc hi, pe r dimostrare la loro vittoria e tramandar la alle generazioni future. elevarono sul luogo stesso una piramide interamente composta di crani e d'ossa de i cristiani ucc isi. Tale abom in evo le ossa r io disparve nel I 846. M. dc Lagau , allora co nso le genera le d i Fra ncia a Tun is i, e monsigno r de Rosa lia, prefetto apostol ico. ne ch iesero e ottennero la demolizio ne. Detto prela to racco lse i resti gloriosi e dette ad essi degna sepoltura in una fossa com une ·. Anche F. Qu1uc1, Il riflesso dell"islam, Torino 1983, p. 19 ricorda, par lando di Djerba:" il 15 l uglio 1560 Filippo TT vide la sco mparsa di un'intera armata navale ... Sul la costa deJrisola dove il mare portò a terra mig liaia di uomini uccisi. venne eretta dopo la battag lia un'alta torre d i cui ancora ogg i u na lapide ne ricorda l'esatta ubicaz io ne la "10rre dei crani".
Tutte le teste deg li spagnoli uccisi erano state accatastate così da for mare un mucc hio al to circa venti metri." È cu rioso osse rvare che qualcosa di mo l to s imi le accadde circa 45 ann i dopo: P. DAN, Histoire de Barbarie, el de ses corsaires. Paris 1649, trattando de l-
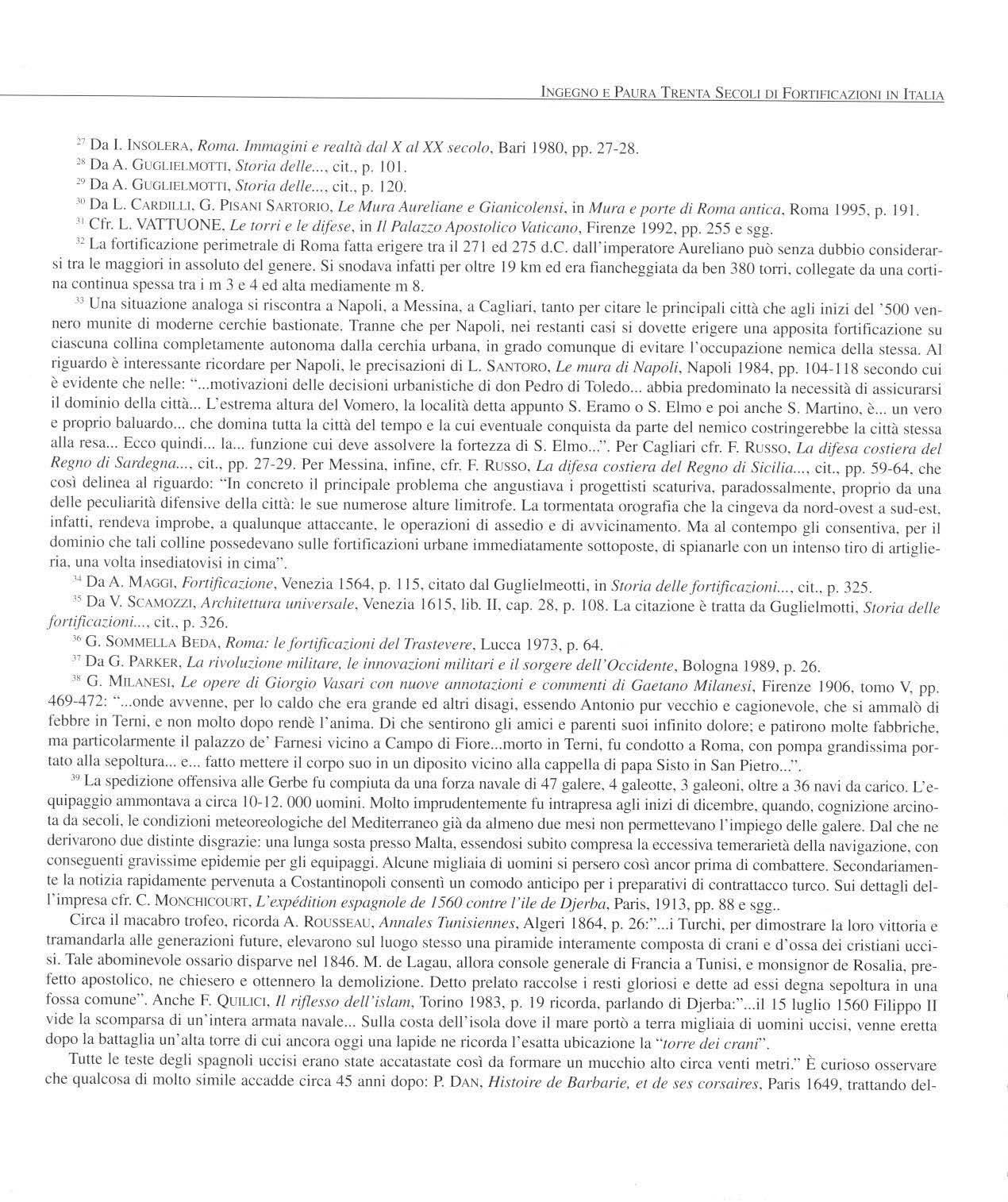
l'isola di Gerba, afferma a p. 165: '' Fu là che per una sfortunatissima circostanza, sette galere di Sicilia. e tre di Malta, vennero abbordate il 15 di agosto del I 605. 1.400 soldati linirono così quasi totalmente massacrati dai mori che. a ll'indomani, portarono a Tunisi, in tr ionfo. 600 delle loro teste con le quali costruirono un trofeo nel la loro città, mentre 120 linirono venduti come schiavi".
411 Da T. TNSOLERA, Le cirtà , cit., p. 132.
41 A.S.R., Soldatesche e Galere. b. 656, tratto da V. ILAR I, L 'ese rcito pontificio c il., p. 568, nota 23.
42 ln meritO a ll a fase arcaica di Capua crr. W. JOHANNOWSKY. Capua antica, Ercolano 1989, pp. 11-36.
43 Per alcun i ragguagl i su ll ' urban istica antica di Capua cfr. I. BROCK , P. G IULIANI. C. MO ISECU, Il centro antico di Capua, Padova 1972, pp. 21 e sgg.
44 Una partico lare ricostruzione de ll a battaglia del Vo lturno è que ll a tievoca da G. GARIBALDI j., La battaglia del Volturno, Roma 1981, pp. 9-38.
45 Circa le ult ime fas i dell'assedio di Capua, una sintetica ricostruzione è del ineata da P.G. JAEGER, Fran cesco li di Borbone, l 'u ltimo re di Napoli, T rento 1982. pp. 157 -1 76. Piì:t accurata la r icostruzione dell'invest i mento della piazza di Capua esposto da C. MoNTù, Storia ... , cit., voi. lll, pp. 895-909
16 Cfr. F. Russo, Trenta secoli di fortificazioni "' cit.. pp 235 -239.
47 Per un approfondimento sulle vicende storiche ed architettoniche della ce lebre porta cfr. C. F1zzoLA. Le porte di Palermo. Palermo 1973, pp. 36 e sgg.
48 La citazione è tratta da F. Russo. La difesa cos1iera del Regno di Sicilia dal XVI al XIX secolo. voi f p. 94 n° 122. Roma 1994.
49 Da R. SA NTORO, Bas1ionamen10 cos1iero in Sicilia. in Rivista Marittima, novembre 1980.
50 Da V. DI GIOVANNI. Topografia antica di Palermo. Pa lermo 1879, voi. I, p. 80.
51 Per una più dettagliata descrizione di tali bastioni cfr. V. D1 GIOVANN I, Pian/a delle fortiJica:ioni di Palermo esistenti nel 1571, in Doc. per servire alla Storia Siciliana, S. S. S. P , quarta serie. voi. I V, Palermo l 986. pp. 237 e sgg.
52 Al riguardo C SACHERO. Corso di cit., p. 320, precisa che: " L'as sediato non può ricorrere a mezzi che esigono un consumo eccessivo di poi vere, danneggiano le sue gaJlerie eh·ei vuol conservare a lungo per reiterare le offese. e preparano al)" aggressore troppo grandi incavi: usa i nvece di preferenza i fornelli contigui i fumacchi LedJ ha il grande vantaggio dell'iniziativa e di poter preparare la maggior par te dei suoi lavori ".
53 La c i tazione è tratta da V. 01 G10VA'.\'Nl. le Jor1ijìcazioni , cit., p. 72.
54 La citazione è tratta da ll a Relazione di Ferrante Gonzaga: F. GONZAGA, Relllzione delle cose di Sicilia farla da Don Ferrame Gon zaga all'imperatore Carlo V, Pale r mo I 896, p. 7.
55 Reg istro, Atti, Bandi. Provviste, I 570-7 I, Jnd. i 4.f 386, da V. D1 G IOVANNI. le fort(ficazioni cit.
56 Ivi, I 543 -44, Ind. 2
57 Iv i, 1548 -54, Tnd. 2.
58 Cfr. L. SANTORO. Cas1elli , cit.. pp. 168-78.
59 Da L. SANTORO, Castelli cit., p. 174.
60 A S.N , Torri e Cas1elli. vo i. 35. ff. 18-20.
61 A.S.N ., Torri e Cas1elli, vo i. 35, ff. 18-20.
62 A.S.N., Torri e Cas1elli, voi. 35. f. 77
63 A.S.N ., Torri e Cas1elli, voi. 35, f. 155.
64 A.S.N Torri e Cas1elli. voi. 35, f. 84
65 Da A. LENORMANT, La Magna Grecia. Croco ne 1932, voi. TT , pp. 238 -39.
66 Cfr. G. MELONI, la Sardegna nel quadro della politica mediterranea di Pisa, Genova, Aragona, i n S1oria dei Sardi e della Sardegna, Milano 1988. voi. 11, pp. 64 -65.
67 Sulla pesca de l cora ll o in Sardeg na cfr. B LIV ERINO. Il Corallo. Bo log na 1983. pp. 70 -71.
68 Per un approfondimento sulla battaglia della Me loria cfr. C. MA NFRON I, S10ria della marina ... , c it.. voi. TT, pp. I05 -45.
6 ~ Non si scorge del resto nessuna logica d'innesto o di co ll ocazione per r icavarne un reciproco appoggio. La presenza de i torrioni rotond i, ino l tre, ci sembra u lt eriormente suffragare l'interpretaz ione di identificarli piuttosto come contrafforti, non sp iegandosi altrime nt i la fu nzione d i ques ti ul timi
70 In me1ito cfr C. SACHERO, Corso di cit., pp. 26 -2 7. [
7 1 Su ll' argomento cfr. P. MELONI. La Sardegna e la Repubblica Romanll, in S1oria dei Sardi cit.. voi. I. pp.2I3-214.
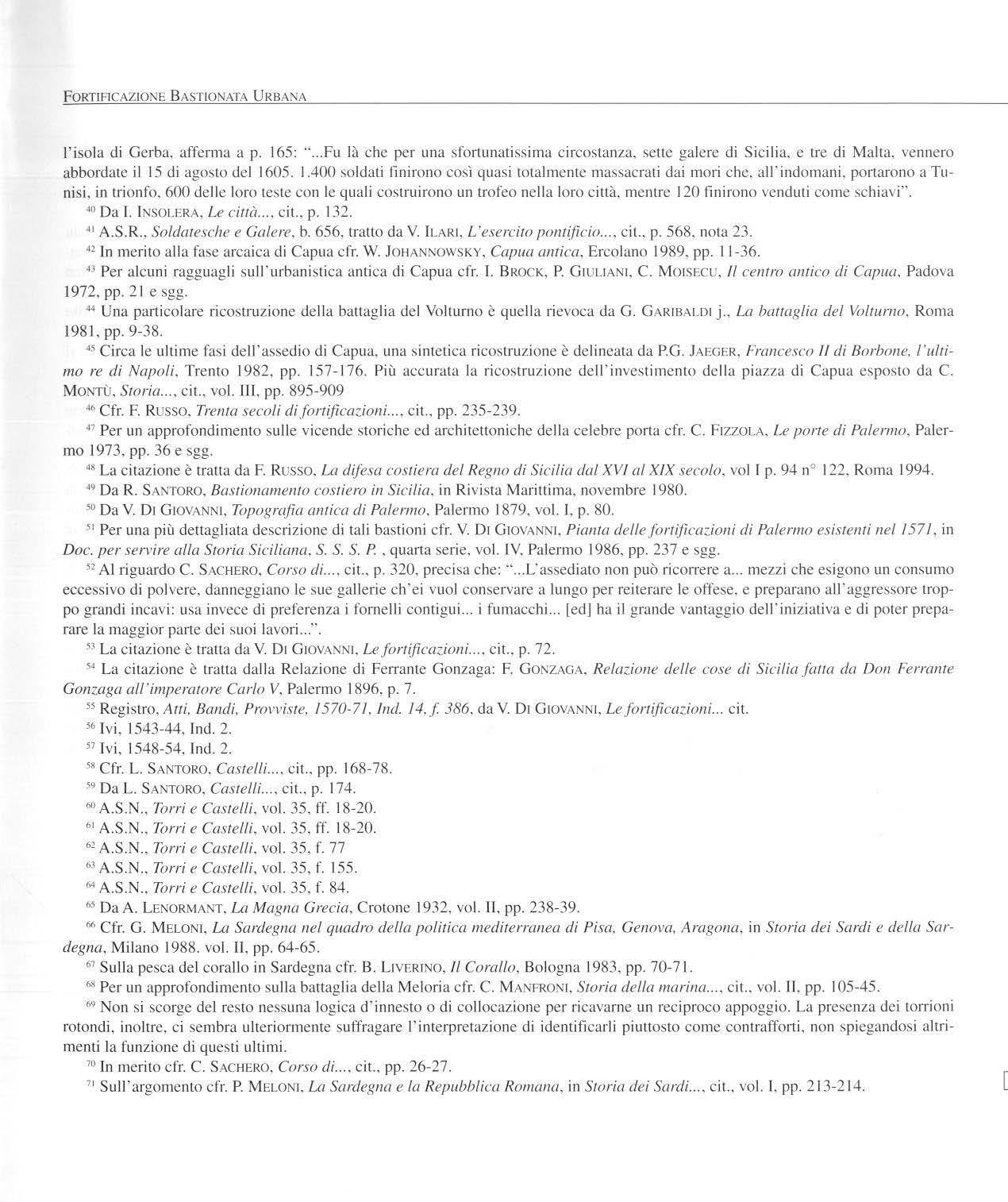
72 Da I. PRINCIPE, Cagliari. Bari 1988. p. 45. n Da 1. PRINCIPE. Cagliari ., cit.. p 45.
74 Cfr. E. BOTTINI-MASSA. La Sardegna solfo il dominio spa?,nolo, Torino 1902, pp. 33 e sgg.
7 1 Cfr. M. VALDES, Le fortifica zioni della 'cilfadella ·di Cagliari, in Srudi Sardi, voi. XXV, 1978 - 1980. p. 462.
76 I fratelli Giorgio e Giacomo Fratin, nativi di Marcontc in Svizzera, entrambi ingegneri militari di 1inomata capacità, giunsero in Sardegna per la prima volta quasi certamente ne l 1563. con incarico ricognitivo dei lavori a ll e piazze. In pratica avrebbero dovuto contro ll are le fortificazioni fino ad a ll ora edificate sia a Cag liari che ad Alghero. Tornarono nell'Isola nel 1575 per subentrare al Cape ll ino nel la direzione dei cantieri.
77 l i termine 'p iazzaforte· indica a partire dal XVI seco lo una fortezza di 1ilevanti dimensioni destina ta in tempo di guerra a serv ire da base d'operaz ione per le truppe, ed al cui interno a tal fine si accumulavano. e custodivano. notevoli quantità di armi, mun iz ioni e viver i. Per estensione concettuale qualora posta in riva al mare. e destinata a base de lla flotta da guerra, una fortificazione costiera si trasformava in 'piazza maritt ima·. Evidente quind i che la vera differenza con una semplice opera difensiva a valenza urbana consisteva proprio nella pro iezione offensiva peculiare della piazza marittima
;x li termine 'bagno· trova probabilmente o,ig inc dal fatto che essendo un luogo detentivo destinato esclusivamente alle ciurme delle galere, era costruito sempre nelle immed iate vicinanze del mare. Tuttavia esis tono a ltre version i sull "origine di ta le definizione: sull'argomen to cfr. G. AUDJSIO. Recherches sur l'origine et la sign(fìcation du mot '·bagne ··, in Revue Africaine, Cl, 1957. pp. 363 - 380
79 Precisa a l r iguardo D. DE MAJo. Fanòi, Calabria, Musulmani, Torri Costiere. Bergamo 1990, pp. 32 -40: ''Un focolaio naturale cli peste era verosimilmente localizzato nella zona d i confine tra J"lndia, la Cina e la Birmania Lo spostamento del con tag io si verificò ... con molta probabi lità, in seguito alla costruzione di questa nuova rete di comunicaz ioni apportata dai mongoli: contrade fino ad allora isolate ed incontam inate furono invase dal germe della peste che vi si riprodusse indisturbato ne lle tane de i roditori se lvatici. Le carovane, con il loro carico di uom ini e di cibo. costituirono dei centri di sopravvivenza e di ri produzione idonei per le popolazioni di ratti e di pulci che con esse viaggiavano da un caravanserraglio a ll' a ltro
Dalla 'Terra delle Tenebre'·, secondo la dizione di uno scrittore musu lmano , la pesce procedette verso l'India e le terre dell'Islam l ungo le v ie carovaniere...".
to È interessante ricorda re che il prob lema della conservazione dei viver i nelle piazze maritt ime a causa del c lima e dell'umidità risu ltava ancora più arduo che in que ll e terrestri. Un espediente molto pratico in ma teria di cerea li, ad esempio. consisteva ne ll'ammassare migl io al posto de l g rano. Prec isa F. BRAUDEL. Le srrutture del quotidiano. Torino 1982. p. 85: "li mig lio occupava un posto anche magg iore. Se Venezia, assediata da i genovesi. si sa lva nel 1378, è grazie al mig lio conservato nei suo i magazzini. Ancora ne l Cinquecento la Signoria immagazz inava vo lentieri questo cerea le cli lunga conservazione (anche fino ad una vent ina d'anni) nelle fortezze ... e miglio, pi ù che frumento, spedisce verso i presidi dalmati o le iso le de l Levante, quando c·è penu ria di viveri. Ne l Sellecento il mig lio è ancora co ltivato in Guascogna, in Italia, ne ll'Eu ropa centra le ...".
~ , [I termine è di origine araba è stava a significare la parte p iù sicura e più comoda di un grande porto, dove proprio pe r ta li motivi le unità navali milita ri svernavano . Cfr. A. GUGLJELMOTTI, Vocabolario marino e 111ili1are. Roma I889, alla voce .
x 2 Per essere pe rò le piazze marittime quelle più di rettamente e vis tosamente coinvolte nei prepara ti v i d i operaz ioni navali, e rano sottopos te da en t rambe le par ti in guerra ne l Medite rraneo ad una assidua sorveg lianza condotta da una re te di spie. Sull'a rgomento cfr F. Russo, La difesa cosriera del regno di Sicilia , cit., tomo l , pp. 126- 128.
x; Circa la Piscina Mirabilis così S. DE CARO, A. GRECO, Campania Bari 1981. p. 68: "Posta su ll a te rrazza superio re della collina più alta [di Capo Misenol che chiude ad o,ie n te il Mare morto, lungo l' od ierna v ia S. Anna, la ··Pi sci na Mirabilis", così de nominata dall'ant iq ua ria napoletane sei -settecentesca, diseg nata g ià da Giu liano di Sa ngallo è il pun to d i a rr ivo del grande acquedotto de l Serino, costruito in età augustea per approvvigionare d'acqua la base militare e la città di M iseno L'eno rme cis terna, a p ia nta rettango lare, è scavata nel tufo pe r m 70 cl i lu nghezza e 25, 5 d i larghezza, cd è p rofonda 15 me tri. Q uattro file cl i dod ic i p il astri cruciform i - fo rmanti una d ivis ione interna cli c in que navate lunghe e tred ici corte- sorreggono la vol ta a botte La capac ità del bacino è di 12.600 mc d'acqua.
84 In data 12 gennaio 1549 papa Paolo TH promulgò un apposi to bando che autorizzava qualsiasi c ittadino di Roma a comprare ed a possedere a sua discrez ione. sch iavi e sch iave, sottindentendosi cl i origine tu rco-barbaresca, e com unque di fede musul mana. 11 documento nella sua interezza. custodito presso la Biblioteca Casana tese nella collezione cl i bo ll e, editt i, bandi, ecc .. fu pubblicato eia A.
GUGLIELMOTTT , La guerra dei pirati , c it.. vo l. IL pp. 175 - 176.

85 Precisa C. CALISSE, Storia , cit.. p. 356:" Anche nei tempi passati si era a ciò provveduto: non lasciando mai il porto. né la rocca, né le mura senza i restauri e senza quei ,innovamenti che di tempo in tempo se ne rendevano necessari. Era però sempre un rifare l'antico. Sisto IV aveva già avuto l'idea di abbandonar questo, e fare, in luogo di parziali risarcimenti. opera nuova .''.
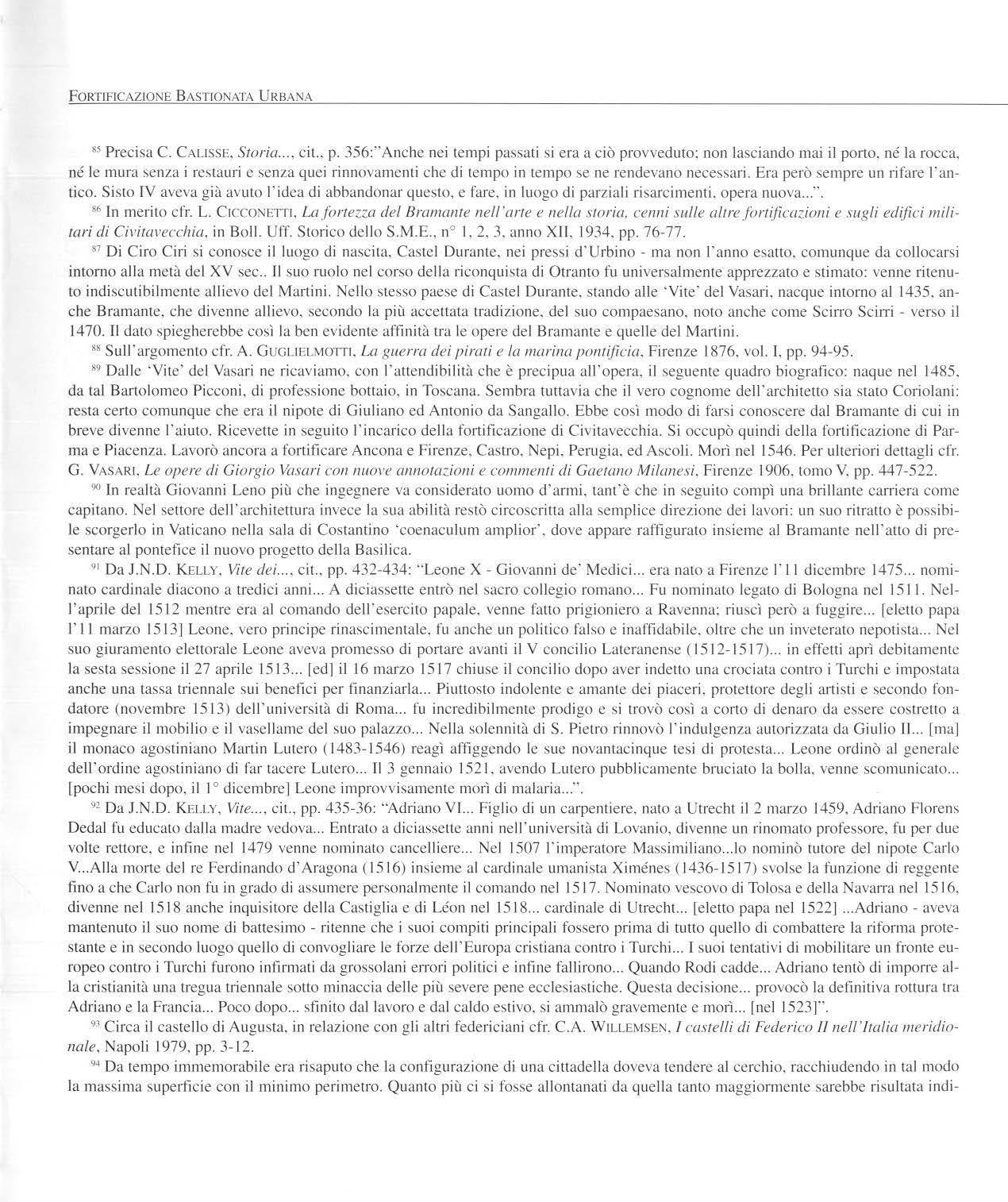
86 In merito cfr. L. CtcCONETT I, La forte z::,a del Bramante e nella s1oria, cenni sulle altre furt(ficaz.ioni e sugli edifici militari di Ci,·itavecchia, in Boli. Uff. Storico dello S.M.E., 11 ° I. 2, 3. anno Xll. I 934. pp. 76 -77.
87 Di Ciro Ciri s i conosce il luogo di nascita, Castel Durante, nei pressi d'Urbino - ma non l'anno esatto. comunque da collocarsi intorno alla metà del XV sec . . TI s uo ruolo nel corso della riconqui sta di Otranto fu universalmente apprezzato e stimato: venne 1itenuto indi scut ibilm ente allievo del Martini. Ne ll o stesso paese d i Cas tel Durante. stando alle 'Vite' ciel Vasa,i, nacque intorno al 1435, anche Bramante, che divenne allievo, secondo la più accettata tradizione. del suo compaesano, noto anche come Scirro Scirri - verso il 1470. TI dato sp iegherebbe così la ben ev id ente affinità tra le opere del Bramante e quelle del Martini.
88 Sull'argomento cfr. A. GUGLIELMOTTI. La guerra dei pira/i e la marina pontifi<.:ia, Firenze 1876, voi. I, pp. 94-95.
89 Dalle 'Vite ' del Vasari ne ricaviamo. con l'attendibilit~1 che è precipua all'opera, il seguente quadro biografico: naque nel 1485. da tal Bartolomeo Picconi. di professione bottaio, in Toscana. Sembra tuttavia che il vero cognome dell'architetto sia stato Coriolani: resta certo comunque che era il nipote di Giuliano ed Antonio da Sangallo. Ebbe così modo cli farsi conoscere dal Bramante cli cui in breve divenne l'aiuto. Ricevette in seguito l'incarico della fortificazione di Civitavecchia. Si occupò quindi della fortificazione di Parma e Piacenrn Lavorò ancora a fortificare Ancona e Firenze. Castro. Nepi. Perugia, ed Ascoli. Morì nel 1546. Per ulteriori eiettagli cfr G. VASARI, Le opere di Giorgio Vasari con num·e annota:ioni e commenti di Gaewnu Milanesi. Firenze 1906. tomo V, pp. 447-522.
00 In realtà Giovanni Leno più che ingegnere va considerato uomo d'armi. tant'è che in segu it o compì una brillante caJTiera come cap itano . Nel settore dell'architettura invece la sua abilità res tò circoscritt a alla semplice direzione dei lavo,i: un suo ritratto è possibile scorgerlo in Vaticano nella sala cli Costantino 'coenaculum amp li or'. dove appare raffigurato insieme al Bramante nell'ano cli presentare al pontefice il nuovo progetto della Basilica.
9 1 Da J .N.D. KELLY. Vite dei cit.. pp. 432 - 434: "Leone X - Giovanni de' Medici era nato a Firenze I' 11 dicembre 1475 nominato cardinale diacono a tredici anni ... A diciassette entrò nel sacro collegio romano ... Fu nominato legato di Bologna nel I 51 I. Nell'aprile del 1512 mentre era al comando dell'esercito papale. venne fatto prigioniero a R avenna; riu scì però a fuggire [eletto papa I' l l marzo 1513] Leone. vero principe rinascimentale. fu anche un po liti co falso e inaffidabile. oltre che un in veterato nepotista ... Nel suo giuramento elettorale Leone aveva promesso di portare avan ti il V conci lio Lateranense ( 1512-1517) in effett i aprì debitamente la sesta sessione il 27 ap,i le l 5 I 3 ... [ed] il 16 marzo 15 I 7 ch iu se il concilio dopo aver indetto una crociata contro i Tu rchi e impostala anche una tassa triennale sui benefici per finanziarla Piuuosto indolente e amante dei piaceri, protettore degli a rti sti e secondo fondatore (novemb re 15 I 3) dell'università cli Roma fu incredibilmente prodigo e si trovò così a corto d i denaro da essere costretto a impegnare il mobilio e il vasellame del suo palazzo Nella solennità di S. Pietro rinn ovò r indulgenza autorizzata da Giulio IL [ma] il monaco agostiniano Martin Lutero (1483- 1546) reagì affiggendo le sue novantacinque tesi di protesta Leone ordinò al generale cieli' ordine agostiniano di far tacere Lutero Il 3 genna io 1521. avendo Lutero pubblicamente bruciato la bolla. venne scomun icato lpoch i mesi dopo, il I O dicembre] Leone improvvisamen te morì di malaria..:·.
92 Da J.N.D. KEt.LY, \lite , cit., pp. 435 -36: "Adriano VI... Figlio di un carpentiere. nato a Utrecht il 2 marzo 1459, Adriano Florens Dedal fu educato dal la madre vedova ... Entrato a diciassette anni nell'università di Lovanio. divenne un rinomato professore, fu per due vo lt e rettore. e infine nel 1479 ve nn e nominato cancelliere Ne l 1507 l'imperatore Massimiliano lo nominò tutore del nipote Car lo Y... A ll a morte del re Ferdinando d'Aragona ( 1516) in s ieme al ca rdin ale umanista Ximénes ( 1436- 1517) svolse la funzione di reggente fino a che Carlo non fu in grado di a~su mere personalmente il coma nd o nel 15 l 7. Nominato vescovo di Tolosa e della Navarra nel 15 I6, divenne nel 1518 a nc he inquisitore de lla Castiglia e di Léon nel 1518 ... cardinale di Utrecht. .. le letto papa nel 1522] ... Adriano - aveva mantenuto il suo nome di battesimo - riten ne che i suoi compiti prin cipa li fossero prima di tutto quello di combattere la riforma protes tante e in secondo luogo quello cli co nvo gl iare le fo rze del l'Europa cristiana contro i Turchi ... I suoi ten tati vi cli mobilitare un fronte europ eo contro i Turchi furono infirmati eia g rosso lani errori politici e infine fallirono Quando Rodi cadde Adriano tentò cli imporre alla cristianità una tregua triennale sotto minaccia delle più severe pene ecclesias tiche. Questa decisione ... provocò la definitiva rottura tra Adriano e la Francia Poco dopo sfinito dal lavoro e dal caldo estivo. si ammalò gravemente e morì... f nel I 523]".
9J Circa il castello di Augusta, in relazione con gli altri federiciani cfr. C.A. WJLLEMSEN, / cas1elli di Federico li nell 'ltalio meridionale. Napoli 1979. pp. 3 - 12.
94 Da tempo immemorab il e era risaputo che la configurazione cli una cittade ll a doveva tendere al cerchio, racchiudendo in tal modo la massima superfic ie con il minimo perimetro. Quanto più ci si fosse allon tan at i eia quella tanto maggionncnte sarebbe risultata indi-
INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIAfendibile. Augusta sotto questo profilo si confe rma perciò quasi antitetica alla disposizione ollima le, con conseguenze future tragiche per i suoi abitanti.
95 Da R. SANTORO, Bastionamento , ci t. , p. 78.
96 La citazione è tratta da E. COSTA, Registri di lettere di Ferrante Gmr:,aga. Panna 1889. voi. I , p. 52.
" ' A.G.S Estado I Il 7/8 1.
9 x 11 viceré. co me più esplicitamente emerge rà negli anni s uccessivi, tentò di evidenziare la tragica situazione delle propaggini più periferiche dell'Impero spagnolo, cercando di farle porre al centro degli interessi strategici. ev ita ndo di disperdere le forze in Europa centra le. In merito cfr. F. CHABOD. Carlo V e il suo imp ero , Milano 1978, p. I 07.
99 La citazione è tratta da F.C. CARRER I, Rela::,ione delle cose di Sicilia faue da D. Ferrando Con:aga all'imperc11ore Carlo V, I 546, Palermo 1896, p. 10.
ux>Sulla figura e sull'opera del viceré don Pedro di Toledo cfr. G. CONIGLIO./ viceré spagnoli di Napoli. Napoli 1967. voi. I, pp. 38-78.
w, I due forti ricevettero perciò i nomi di battesimo del viceré e di s ua moglie. la celebre donna Vitto1ia Colonna. particolarmente stimata da Michelangelo.
10 2 Sulla torre di Magni si cfr. R. DI ROSA. La Torre Mar1el/o di Magnisi. in Studi Storico Militari 1994, pp. 283 -3 67.
103 Per una accurata descrizione del forte E. SAL ERNO . La torre Avalos di Augusta, in Arch Sto,: Siracusano, anno XTT, I966, p. 145 - 154.
11 Da E. SAL ERNO, I forri Garzia e Vittoria di Augusta. in Arch. Sto,: Siracusano, anno X. 1964. p. 160. ws Da E. SAL ERNO, !forti cit p. 162.
106 Da F. FERRAUTO, Augusta di Sicilia al Parlamento Italiano, 1862 p. 26 e sgg. La citazione è traila da E. SALERNO, / forti .... cit., p. 159.
107 Precisa riguardo alla denominazione del forte E. SALERNO. La torre Avalos... , cit.. p. 145: ·'... La costruzione rimonta al 1570 ... Gli stoiici dell'epoca sono tutti concordi nel denominare il forte "Torre Avolos". come appare anche da antiche stampe della città; e non c i si sa s piegare perché il nome del casato degli Aval os s ia stato mutato in Avo los lforse] sarà conseguenza di storpiatura cagionala da influ enze dialettali. ' ·
108 Da FERRAUTO, Augusw ... , cit. La citazione è tratta da E. SALERNO, ù, torre... , cit.. pp. I 51 -152.
109 Da E . SALERNO, La torre.... cit. , pp. 152 e sgg.
, io Sulla conquista di Augusta cfr. Relation de la prise d'Augu sta par le Due d e Vivonne, 2 settembre 1675, in Archjvio della Marina, B. 4 , 6 f. 126, pubblicata eia E. Sue in Augusta, di L. D UFOU R, Augusta da città imperiale a c ittà militare. Palermo 1989.
11 1 Da Rivi s ta Marittima, anno CXXXV. ap1ile 2002, pp. 45-60.
11 2 Circa la biografia dell ' ingegner Tiburzio Spannocchi e le sue principali opere cfr. C. PROMIS. Biog rafie di ingegneri militari italiani dal secolo XIV alla metà del XVlll, Torino 1874.
1 " La traduzione dell'intero manosciitto di T. SPAN NOCCHI, nonché la riprodu zione delle sue tavole è in F. Russo. La difesa costiera del Regno di Sic ilia , cit., vo i. l, pp. 174-304.
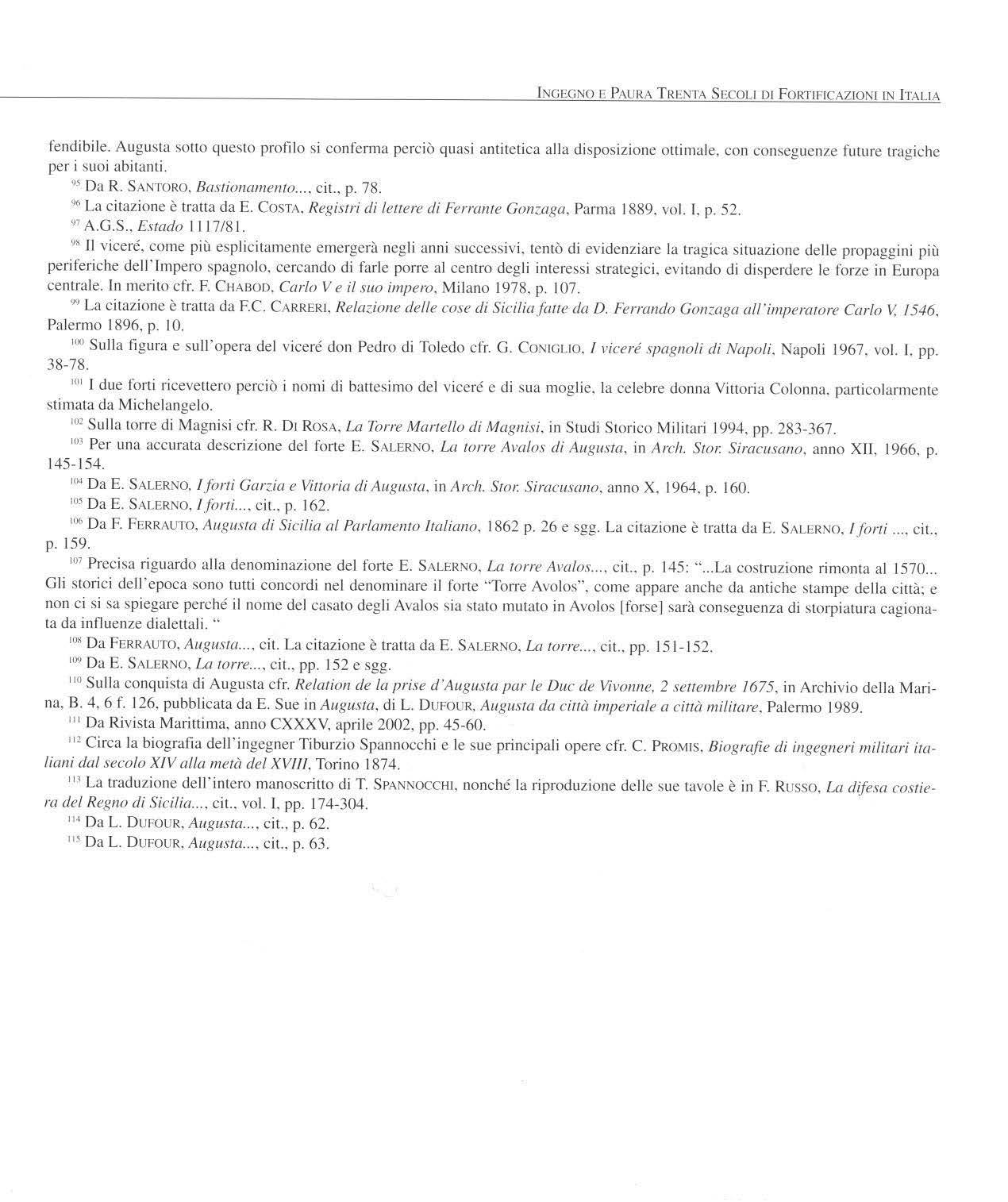
114 Da L. DUFO UR, Augusta , cit., p. 62.
11s Da L. DUFO UR, Augusta , cit., p. 63.
Cons id eraz io ni gen era li s ull e fo rtezze mar ittime d'a ltu ra
II fronte bastionato per la sua intrinseca concezione non si adattava all'impianto apicale più in generale alle opere erette sulle alture e meno che mai in montagna. In tali condizioni, infatti, le sue artiglierie non disponevano del terreno antistante necessario all' ottimale espletazione del fuoco d'interdizione < 1J Le bocche da fuoco, pertanto, non avrebbero potuto falcidiare con le micidiali traiettorie radenti le schiere attaccanti, defilate e disperse dalle asperità dei dirupi. La fortificazione quand'anche modernis s ima, scadeva vistosamente di efficacia non bastando a compensare la grave deficienza i pochi ma non trascurabili vantaggi, quali per tutti la minore vulnerabilità delle s uperfici esterne al fuoco nemico ed alle mine. In un contesto del genere, infatti , il cannoneggiamento ossidionale oltre a dovers i inevitabilmente condurre dai pochi erist retti settori concessi dalla accidentata morfologia dei siti, finiva inevitabilmente per percuotere gli estradossi delle fortificazioni sempre con grande obliquità. E l ' angolo delle traiettorie non di rado, attingeva valori prossimi, quando non superiori, a quelli di rimbalzo delle palle, trasformando così l' altrimenti devastante impatto in una insignificante deviazione. Parimenti di improbabiliss ima attuazione il ricorso alla guerra sotterranea , frustrato dalla durezza e dalla sa lde zza della roccia d'impianto. Nonostante ciò la sommatoria d ' entrambi i vantagg i, e di altri mi nori ancora, non compensava affatto l'impraticabilità del tiro radente, senza contare, poi , che anche il tiro dei pezzi sugli spalti diretto in depressione richiedeva accorgimenti di attivazione più complessi tormentando in maniera anomala gli affusti. Un'ultima osservazione delle conseguenze dell'insediamento di un 'ope ra bastionata su di un'altura deve ravvisarsi nella sua maggiore, e non
di poco, cubatura complessiva, richiedendosi alla stessa, per garantire anche il se mplice tiro ficcante lun go le pendici una maggiore elevazione delle strutture rispetto alle similari di pianura. II che unitamente alle difficoltà di trasporto dei materiali ne incrementava esponenzialmente i costi, ragion per cui la loro adozione deve supporsi semp re dettata da motivazioni pratiche imprescindibili, per lo più non st rettamente difensive.
È pertanto lecito affermare che il fattore di arroccamento tanto ricercato nei castelli medi eva li quale supporto esaltante l 'i nacce ssibilità e quindi la sicurezza passiva, nel caso di forti bast ionati si trasformava in una grave limitazione per la reazione attiva e quindi per l'efficacia complessiva dell'opera (2) . D'altronde per la difesa costiera che obbligava ad una rigida posizionatura delle fortificazioni in funzione dei porti, la prese nza di un 'alt ura limitrofa costringeva inevitabilmente ad occuparla con un caposaldo. In caso contrario si sarebbe la sc iata alla discrezione di un eventuale attaccante l'opportunità di avvalersi del suo dominio per bombardare il sottosta nte abitalo, con esiti devasta nti. Ovviamente costrizioni s iffatte divengono st ringenti laddove la natura dei luoghi non consentiva alcuna alternativa: tipico il caso dell 'Arge ntario , ali' epoca facente parte integrante del cosiddetto Stato dei ReaU Presidi dì To scana <3>
Consi derando la morfologia dello Stato dei Pres idi si assiste ad una sorta di paradosso difen s ivo mai toccato con identica sistematicità altrove. Pur trattando s i di piazze e di fortezze marittime si devono adottare per la loro migl iore comprension e i criteri e le peculiarità precipui di quelle di montagna! Tanto per esemplificare una fortezza moderna d'impianto tipicamente costiero gode del vantaggio di un campo di tiro assolutamente piatto ed omogeneo , privo di ostacoli e di asperità defilanti s ia verso il mare che verso terra. Go-
 Le Cerchie Bastionate ex novo Fortezze Bastionate d'Altura
Le Cerchie Bastionate ex novo Fortezze Bastionate d'Altura
de inoltre della facilità di approvvigionamento e di collegamento derivante dal disporre di un porto, per cui il suo isolamento può ottenersi soltanto con un duplice blocco da terra e da mare , prassi estremamente difficile in qualsiasi epoca storica.
Nel caso in questione pur esistendo alla base delle alture d'impianto delle principali fortezze un ampio ancoraggio, mancava però la stretta com unica zione tra le prime e le banchine per cui non riu sciva né facile né scontato il loro rifornimento co n convogli navali. Sia i viveri che le munizioni una volta sbarcati vi si sarebbero dovuti innalzare con lentissime e vulnerabilissime carovane di muli , con immaginabili difficoltà.
Scendendo in dettaglio l'adozione del tracciato bastionato in montagna , o più ge ner icamente sulla sommità di una collina. cost rin geva innanzitutto a rinunciare a lla planimetria simmetrica requisito canonico di tali fortificazioni. Suo tramite, infatti, si conseguiva l'isotropia della difesa, ovvero r assenza dei tanto 1icercati punti deboli sui quali concentrare gli attacchi, e l'interdipendenza tra le singole opere. È senza dubbio vero che in tutti gli esempi precedenti la bas tionatura non ostentava affatto la suddetta caratteristica, ma ciò derivava da una precisa scelta progettuale, e soprattutto econo mic a, ma non certo da un insormontabile condizio nam ento ambientale, per cui le asimmetrie possono riguardarsi come una sorta di risparmio compensando lo scadimento struttura le con l 'as perità geomorfologica. Nel co nt esto in questione la situazione non è in alcun modo equiparabile, essendo l ' irregolarità obbligata. In pratica sig nificava che in fortezze geometricamente irre go lari non s olo non si sarebbero potuti adottare bastioni uguali , e con identiche divaricazioni, ma nemmeno in numero conve ni ente, poiché il s ito d'impianto consentiva limitati ss imi adattamenti. La penalizzante costrizione attingeva il s uo apice in corrispondenza delle creste co llinari, laddove cioè lo spazio disponibile, sempre relativamente parlando, ostentava una netta prevalenza di un'unica dimensione. Dal che ne derivava necessariamente uno sc hema planimetrico eccessivamente allungato, con
bastioni non so lo d issimili ma per giunta troppo acuti e fragili, scarsa mente divaricati e, peggio ancora di disuguale altezza. Le con seg uenze s ul piano difensivo, oltre alla polarizzazione dell ' intera fortificazione, vanno ricercate nella precaria solidarietà tra le sue diverse sezioni, troppo distanti fra loro in caso di attacco, e nella subordinazione delle strutture più basse. Senza contare, infine la g ra ve decurtazione dell 'efficacia interdittiva nei confronti del naviglio nemico , troppo in basso rispetto ai loro cannoni. Quanto poi al fiancheggiamento ed al tiro radente sarebbe stato possibile, con le limitazioni accennate, soltanto nel caso che la pendenza dell'altura, dalle pendici alla somm ità. fosse ri sultata uniforme , esattamente come in una piramide , connotazione però che 1' orogenesi non ha mai adottato! Del tutto impraticabile. invece. nel caso contrario, poiché si s arebbero creati ampi settori defilati dalle stesse balze e dalle mutazione di pendenza. Inoltre, come accennato, dal punto di vista costruttivo, infine, edificare una fortezza bast ionata sopra una cresta rocciosa originava difficoltà tecniche e costi enormemente eccedenti una equivalente opera in pianura. A fronte del risparmio, peraltro non trascurabile , delle fondazioni e del le contromine, l ' impianto su rocce apicali imphcava il trasport o dal basso di tutto il materiale dalle pietre all'acqua per gl'impasti. Implicava inoltre, e riusciva ancora più esasperante, il trasporto della terra che in enormi quantitativi occorreva per costipare le muraglie, non potendosi utilizzare quella di risulta dello scavo dei fossati, quasi se mpre inesistenti. Quando previsti, poi, richiedevano lavori massacranti e gravosissimi imposti dal ta g lio a mano della roccia. E se era certamente vero che la ristrettezza del sito d'impianto non consentiva notevoli larghezze, era a ltre ttanto inevitabile che per conseguire una equiparabile valid ità occorreva che i fossati d'altura fossero notevolmente più profondi di quelli di pianura. In caso con trario infatti , sarebbero risultati rapidamente colm ab ili con le macerie prodotte dal ca nnon eggiamento ossidiona le co ntro le parti super iori delle mura più fragili e sgretolabili
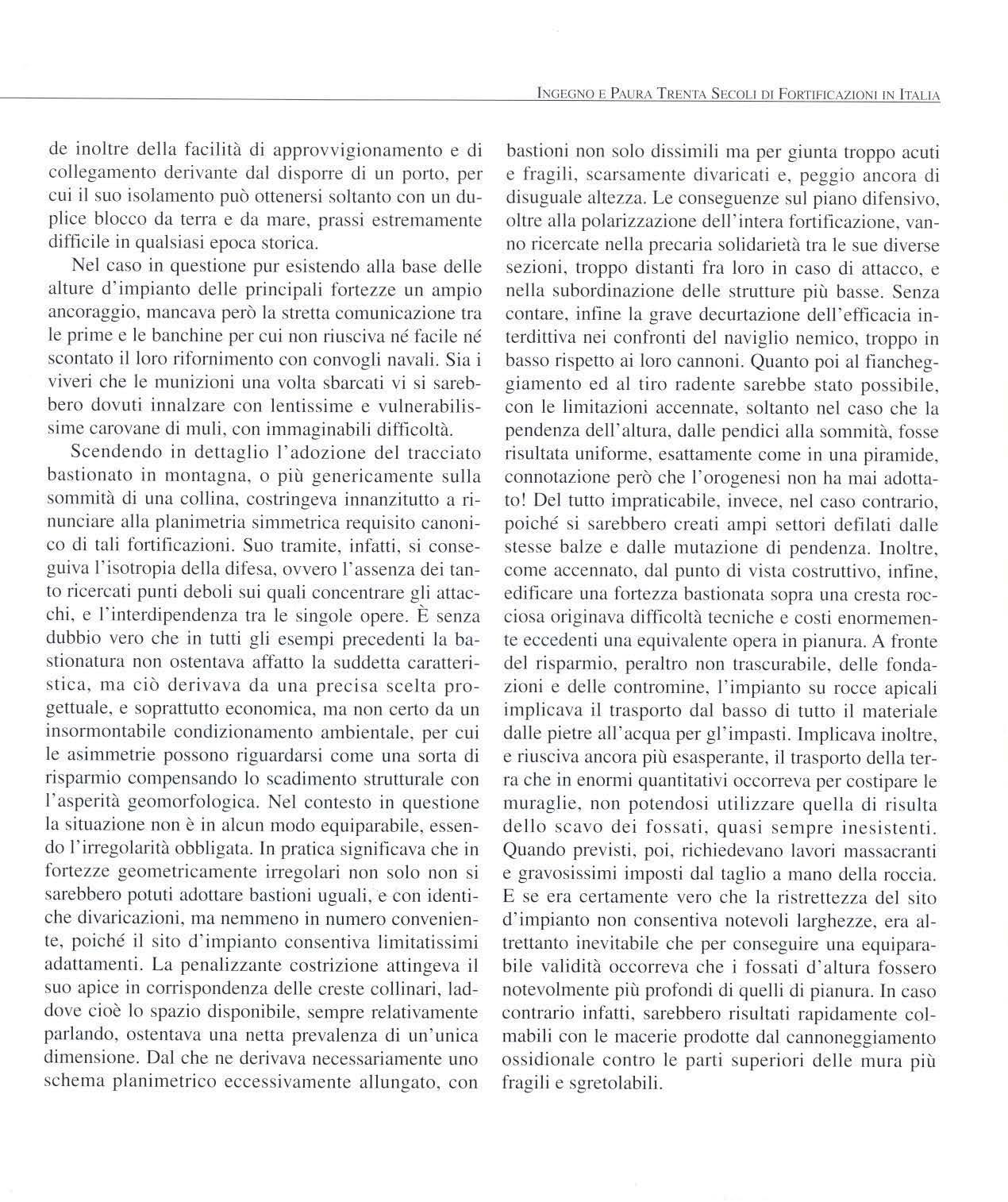 I NGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI fORTIFJCAZLONI IN lTALI A
I NGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI fORTIFJCAZLONI IN lTALI A
Tramite gl'interventi degli architetti Bernardo
Buontalenti < 4 i e Giovanni Camerini si provvide senza indugio al recupero di quanto ancora valido delle vecch ie fortificazioni di Porto Ercole, integrandole con nuove strutture. In particolare sotlo la s upervisione del genera le toscano Chiappino Vitelli si procedette al la radicale ricostruzione della Rocca, cancellandone ogni precedente connotazione architettonica, per cui l'opera che la sostituì conservò di immutato soltanto il nome. Pertanto sebbene continuò a chiamarsi rocca, fu in realtà una moderna fortezza bastionata d 'a ltura eretta ex novo, seco ndo una singol arissima concezio-
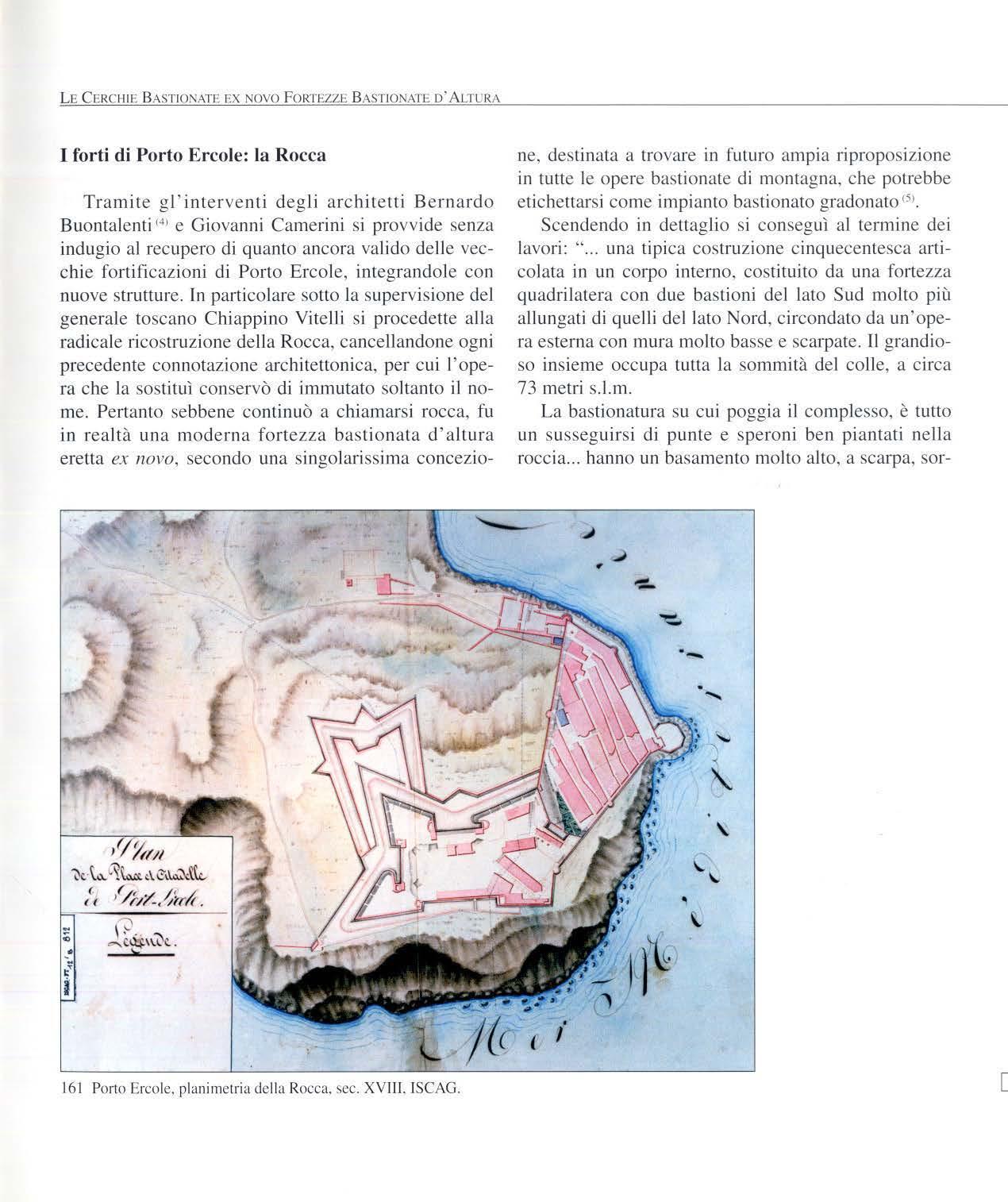
ne, destinata a trovare in futuro ampia riproposizione in tutte le opere bastionate di montagna , che potrebb e etichettars i come impianto bastionato grado nato < 51 •
Scendendo in dettaglio si conseguì al termine dei lavori: " una tipica costruzione cinquecentesca articolata in un corpo interno, costituito da una fortezza quadrilatera con due bast ioni del lato Sud molto più allungati di quelli del lato Nord, circondato da un 'opera esterna con mura molto basse e scarpat e 11 grandioso insieme occupa tutta la sommi tà del colle, a circa 73 metri s .1.m.
La bas tionatura su cui poggia il complesso, è tutto un s usseguirsi di punte e speroni ben piantati nella roccia ... hanno un basamento molto alto, a scarpa, so r -

montato da un cordolo sopra il quale corre un larghissimo parapetto stondato verso l'esterno ... i vertici dei bastioni sono guardati da garitte rotonde ed esagonali, munile cli feritoie biconiche, adornate di stemmi " (6 > L'ordine dei bastioni che fronteggia la sezione meno ripida del promontorio appare triplice, intervallato da altrettanti fossati, in modo che l ' insieme si propone di improbo scavalcamento. Pur non potendosi individuare un chiaro ed univoco disegno della fortezza quanto piuttosto una sintesi di diversi elementi difensivi fusi insieme , l'opera risultava di tenùbile articolazione. Ai suoi contrafforti, poi , si andavano a raccordare le mura del borgo che ri salivano da l mare, lungo l a pendice del promontorio, con andamento rettilineo e convergente. La config urazione complessiva so migliava ad una sorta di grande recinto triangolare con a ll a base la costa ed al vertice la rocca. Dal punto di vista strettamente difensivo, però, quella fortificazione
perimetrale non forniva un 'a ppre zzabile sicurezza, specie verso la base del promontorio. Meno che mai appariva capace di proteggere l'ancoraggio con un efficace tiro radente. La deficienza, fin troppo evidente, aveva s uggerito del re sto già agli inizi del XVI seco lo la cost ruzione de l fortino di S. Barbara, innestato alI'es tremità della sezione costiera della cerchia, predisposto per l'adozione di batte r ie basse s ull'acqua. Nella circosta nza venne pertanto potenziato e riqualificato, integrandolo con l'intera elaborazione fortificatoria della piazza di grandiosa impo staz ione. In fatti il complesso de ll a: " R occa di Porto Ercole con i suoi oltre 2,5 ettari di su perficie , di cui circa 1. 700 mq occupati da e lementi esclus ivamente difen s ivi e da altri fabb r icati quali caserme, depositi , cisterne , cappella, celle e magazzini era la fortezza più grande ed efficace di tutto il sistema difensivo de l Monte
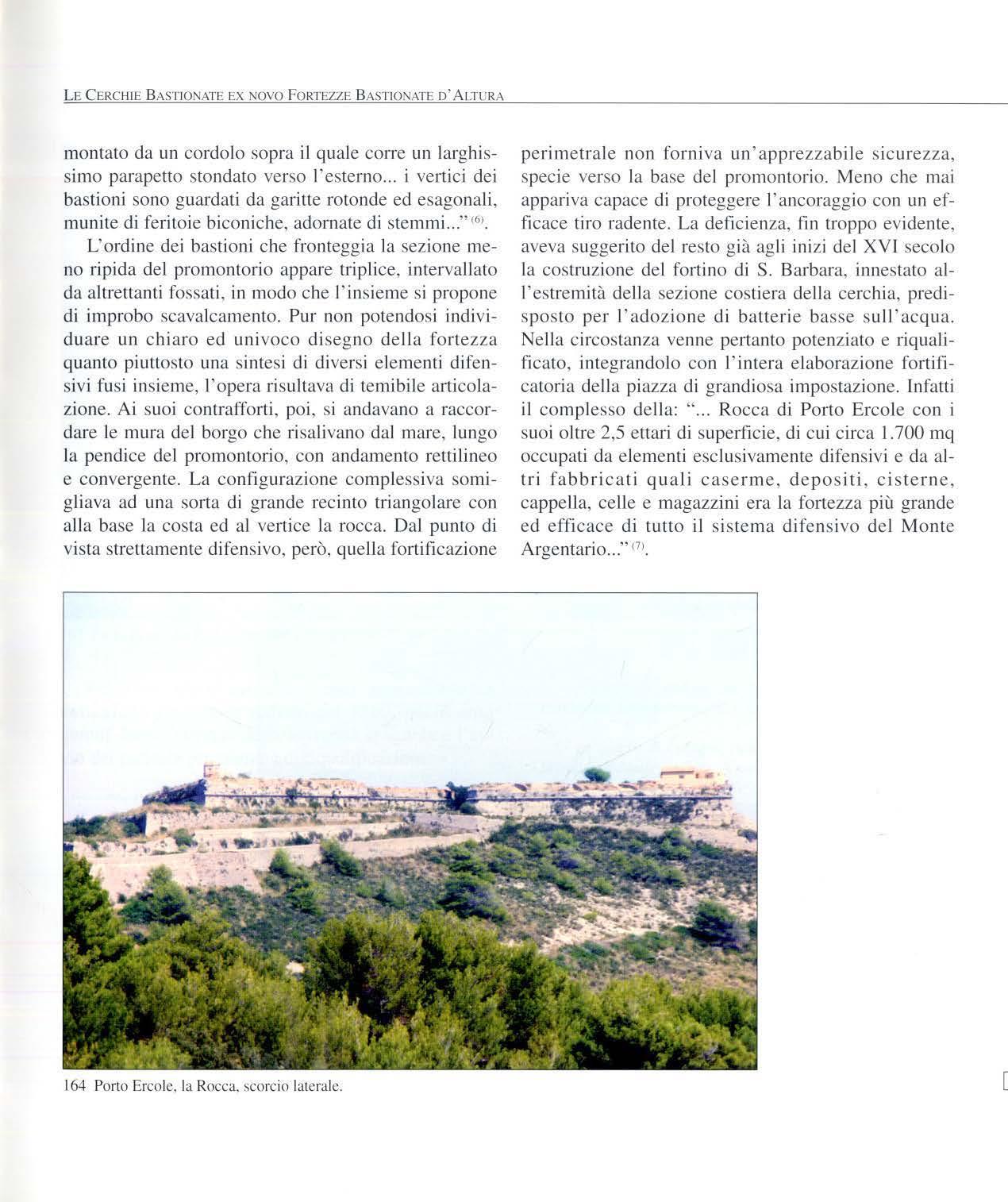
A rgentario .. ." m .
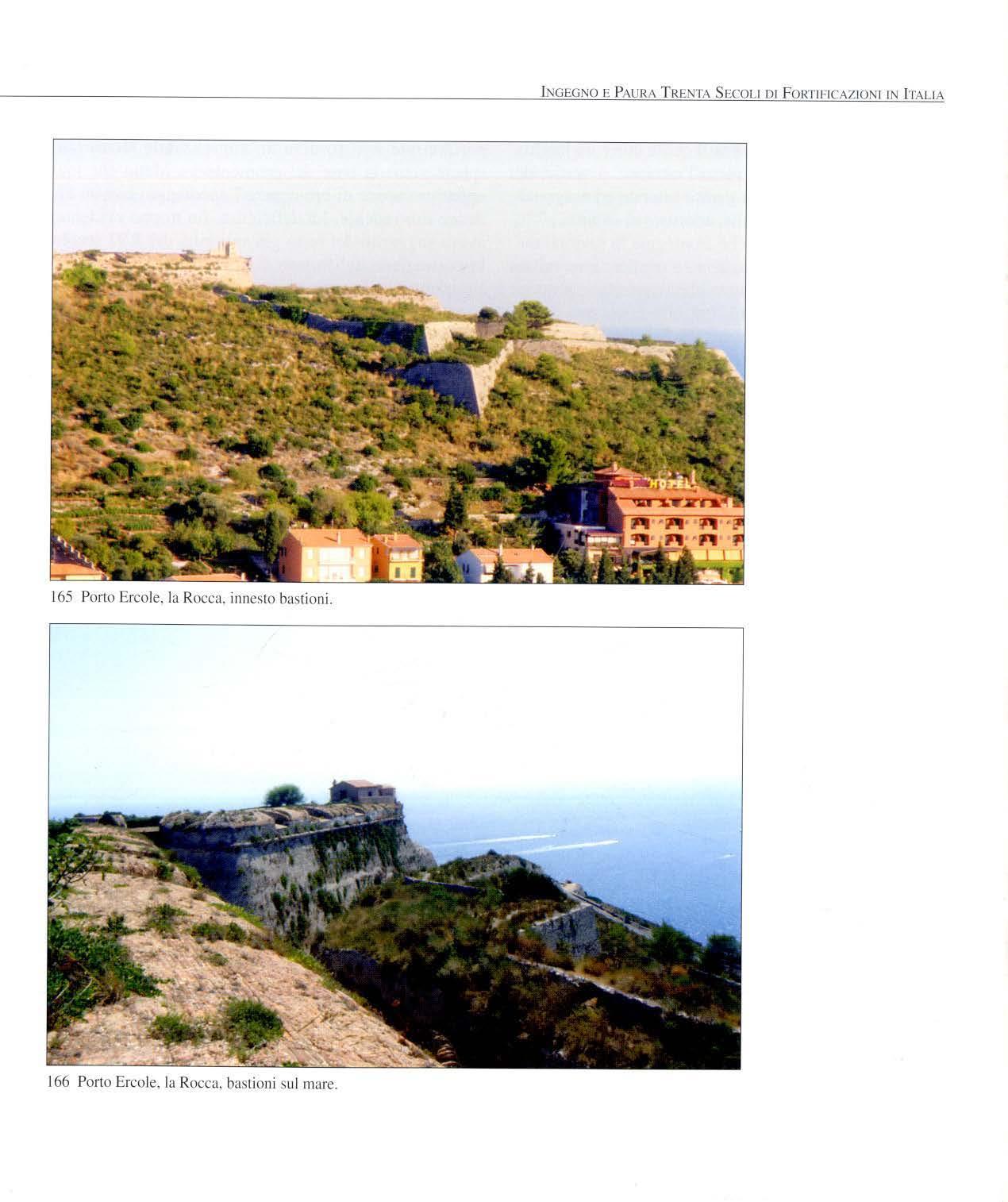 L'ìGEGNO E PAURA TRENlA SECOLI Dl fORTIFICA7. IONI
L'ìGEGNO E PAURA TRENlA SECOLI Dl fORTIFICA7. IONI
Relativamente al s uo armamento conserviamo un dettag li ato inventario redatto nel 1560. pochi anni quindi dopo l'avvento della sovranità spagnola e l'avvio del radicale programma di riqualificazione:
In Des 110111i11e. A111e11
In nome di Dio, amen . .. queslo pubblico slrumento desc riv e r A rti gl ieria e le munizioni che a l presente si trovano nei detti fo11 i. le quali co nsisto no in:
Nel forte de ll a cittadina

- un cannone che tiene il calibro di 55 ljbbre affus tato con ruote e cassa ferrate con il suo calcatoio, rifilatore , scovolo
- 312 palle di ferro da 55 libbre cada una per munizione del detto can non e
- una mezza colubrina bastarda di calibro di I 2 libbre affustata con cassa e ruote ferrate, con calcato io, rifilatore. scovolo.
- 304 palle di ferro del calibro di 12 libbre cada un a per muni zione de ll a detta mezza colubrina.
- un quarto di can none r inforzat.o . .. del calibro di 14 li bbre affustato con ruote e cassa ferrata con calca toio , rifilatore. e scovolo.
- 82 palle di fe1rn da 14 libbre cadauna per munizione ciel detto pezzo.
- un sagro tiene 6 l ibbre di calibro. è affustato su cassa e ruote fe1nte, con il s uo calcatoio, liii latore e scovo lo
- 29 palle di fen-o da 6 li bbre cadauna per mun i z i one de l detto sagro.
- un a lLro sagro ... tiene 8 li bb re di calib ro. è affustato su cassa e ruote ferrate. compl eto del suo ca lcatoio, rifil atore e scovo lo.
- 132 palle di ferro da 8 libbre per munizione del dello sagro.
- un mezzo cannone peuiero 90 libbre di portata <~i
affustaLO con cassa ferrata ma non le ruote, completo del suo ca lcatore, rifi latore e scovolo.
- un a ltro mezzo canno ne petriero ... 80 libbre di portata affustato su cassa ferrata. ma ruote sempl ici, comp leto del suo calcatoio. rilìlatore e scovo lo.
- 40 palle di pietra c•>i per muniLÌ<>ne di detti mezzi cannoni ...
- una mezza colubrina bastarda ... tiene di calibro 12 li bbre, affustata con cassa e ruote ferrate, e completa di calcatoio, rifìlatore e scovolo.
- 5 sme rigli di bronzo affustati sui loro cavalletti di legname, hanno di ca libro libbre I
- 140 palle di piombo da I libbra cadauna e 66 palle di piombo riv es tito.
- 5 moschetti di ferro tra i qua li uno rollo , con i loro cavalleni cli legno ed i loro calcatoi.. :· 111»
L a dotazione , pe r l" epoca di notevole entità, conferma già di per sé il ruolo affidato alla fortezza da i
governanti spag noli. Tuttavia l'ultimazione dei lavori di aggiornamento a quella data non sembra affatto conclusa tanto che, un paio di anni dopo si redigevano ancora precise relazioni circa lo stato d'avanzamento dei lavori. È presumibile che la fortezza s ia s tata effettivamente terminata int orno al 1565, quando quella di Monte Filippo si andava edificando s ull 'opposto promontorio
Forte Filippo - o di Montefilippo
Nella primavera del 1558 si avviò la costruzione di una poderosa e modernissima fortezza sull'altura prospiciente P orto Ercole Anche in questo caso si incontrano i nomi di Giovanni Camerino, quale progettista, e di Chiappino Vitelli quale cons igliere militare. fl sito , come accennato in precedenza, era stato perfettaDlSE!l;,J
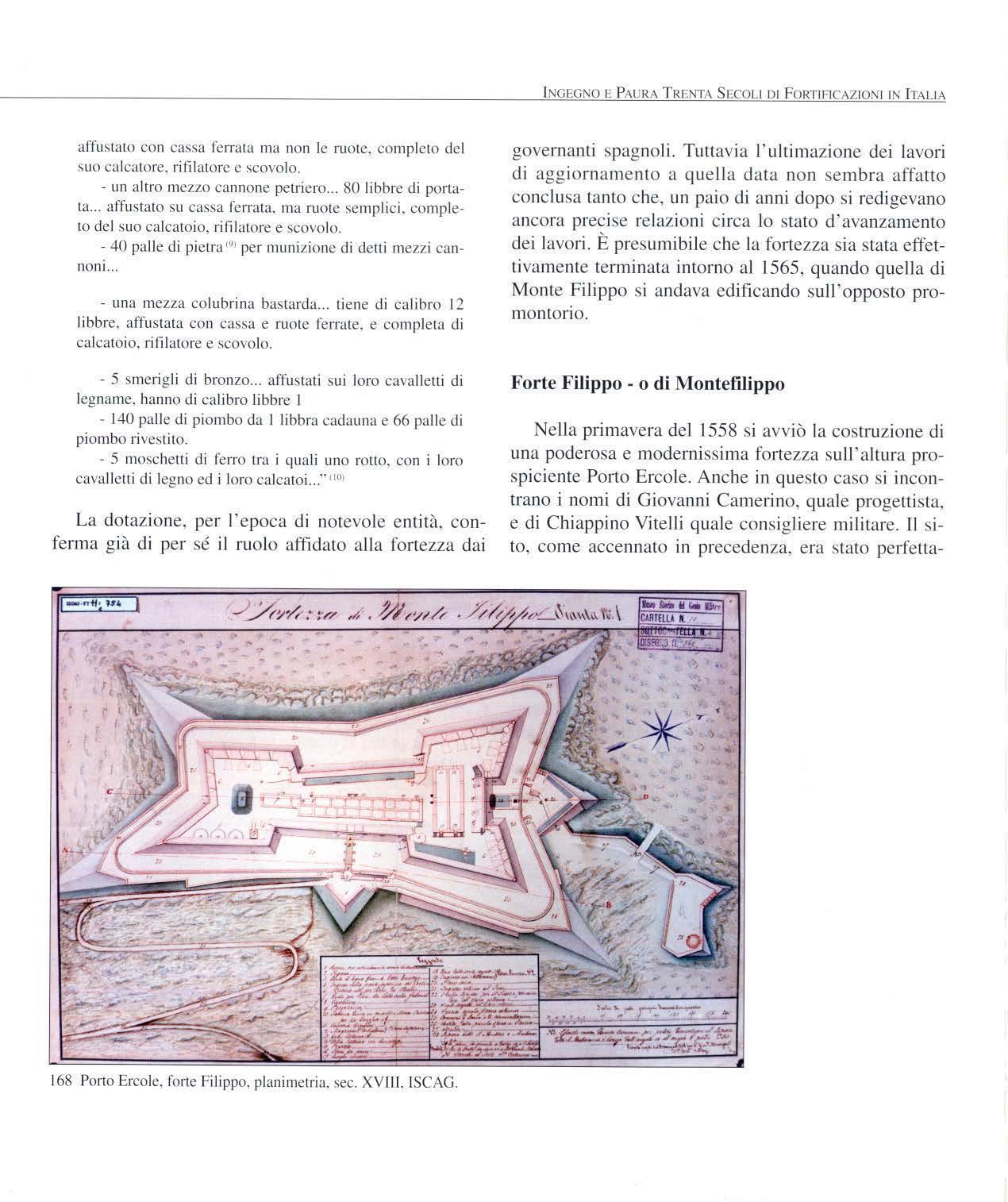 168 Porto Ercole. forte Filippo. planim e tri a. sec. XVIII. !SCAG.
lNGEGNO E PA U RA TR ENTA SECOLI DI FORT1F1CAZION1 IN ITALIA
168 Porto Ercole. forte Filippo. planim e tri a. sec. XVIII. !SCAG.
lNGEGNO E PA U RA TR ENTA SECOLI DI FORT1F1CAZION1 IN ITALIA
mente valutato per il suo asso luto dominio del porto e della città, presupposto pertanto irrinunciabile per la loro inviolabilità. La distanza , infatti, tra monte Filippo, a quota m. 118 s.l.m. e l a Rocca in lin ea d'aria non eccedeva il chilometro, ed anche meno quella con il porto e con il tombolo della Feniglia, per cui tutti rientravano ampiamente nell'ambito della gittata utile dei pezzi dell'epoca .
Per gli stringenti condizionamenti morfologici i mposti dalla cresta di roccia. i progettisti della fortezza, originariamente denominata di S. Ermo, dovettero rinunziare ancora una volta alla rigida sim metria prevista per le opere bastionate dalla precettistica coeva, adattandole per quanto possibile alle asperità naturali . I quattro bastioni, perciò, che andarono a munire il corpo di fabbrica centrale appaiono totalmente diversi fra loro ed asimmetrici persino rispetto ad un qualsiasi asse trasversale. Circa le caratteristiche salienti il forte rispecchia in sos tanza quelle proprie del pe1iodo, forse leggermente in ritardo sulle realiz zazio ni più evolute. Il suo contorno è scandito da un duplice ordine di fossati cavati nella roccia viva, non molto larghi ma notevo lm ente profondi , per sopper ire così ai rischi di colmata, innanzi esposti. Unico vantaggio derivante da
quella disposizione il maggiore defilamento delle sue supe rfici , difficilmente battibili dal basso.
A renderne oltremodo accentuata tale peculiarità le mastodontiche mura di sostegno delle controscarpe , sagomate a foggia di bastioni ed arditamente aniglia te nella roccia della cresta, tanto da farle assimilare ad un inedito ulteriore ordine i c ui: " ... bastioni esterni ... so no coronati da un camminamento sco pe1to, piuttosto ampio. Quelli interni si presentano molto compatti e hanno una scarpatura accentuata, con linee terminali affilate come lame. Sono inoltre dotati di un cordolo a toro " 0 1l
Al di là della sensaz ione di totale indifferenza alle asperità naturali, l ' intero forte ed in particolare proprio i suoi bastioni tradiscono gravi carenze. Inn anzitutto ne ss uno è munito di fia nchi rientrati, ritenuti probabilmente inutili per l a quota d'impianto, ma non per questo comp letamente irrilevanti. Secondariame nte il grado di fiancheggiamento comp lessivo dell 'o pera appare al di sotto del minimo indi spensabi le, anche per strutt ure <l 'a ltura, in conseguenza della scarsa divaricazio ne dei bastioni e per la contemporanea eccessiva estensione delle facce. Per il medesimo motivo le loro cannoniere non sono in grado di incrociare i fuochi [
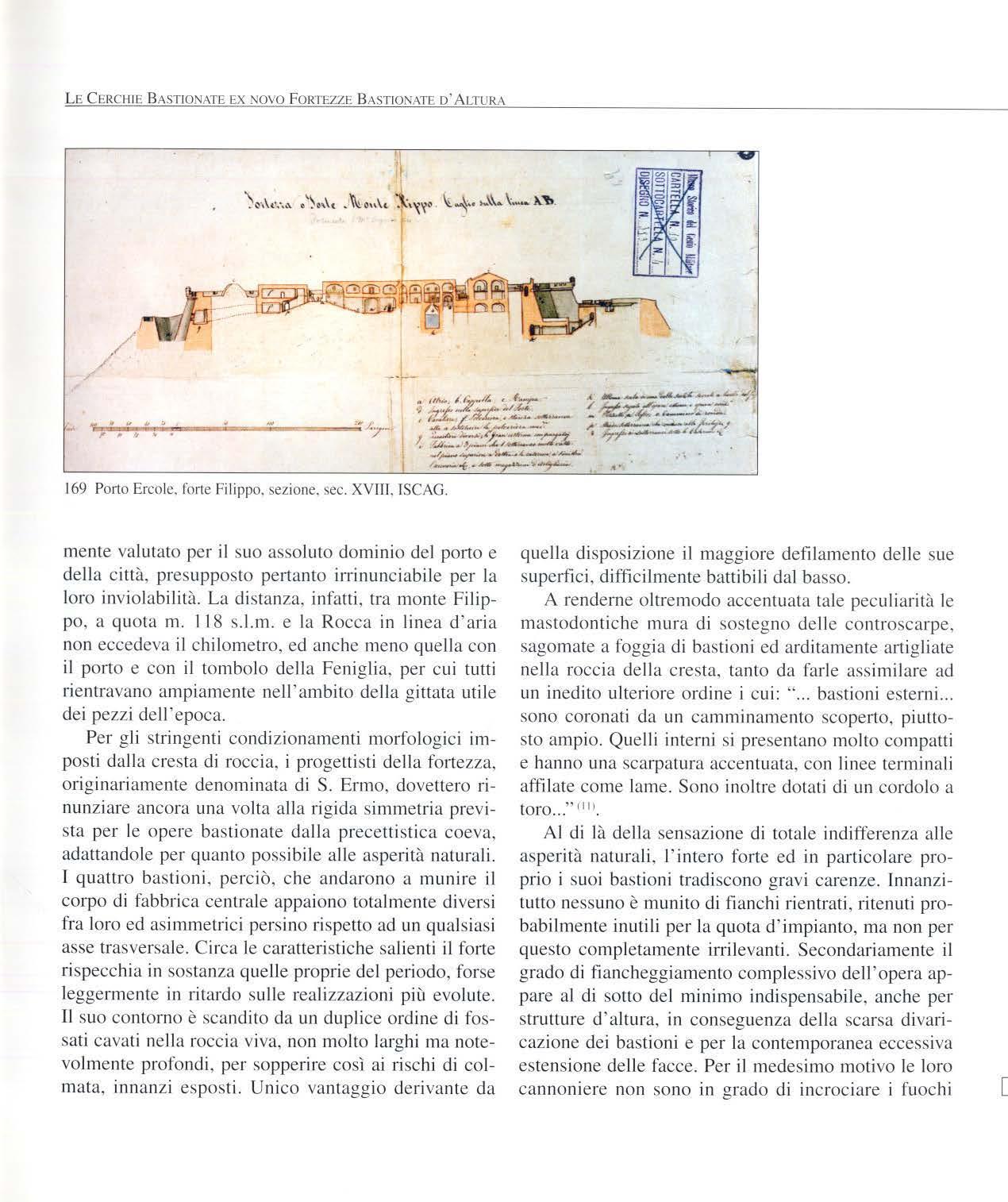
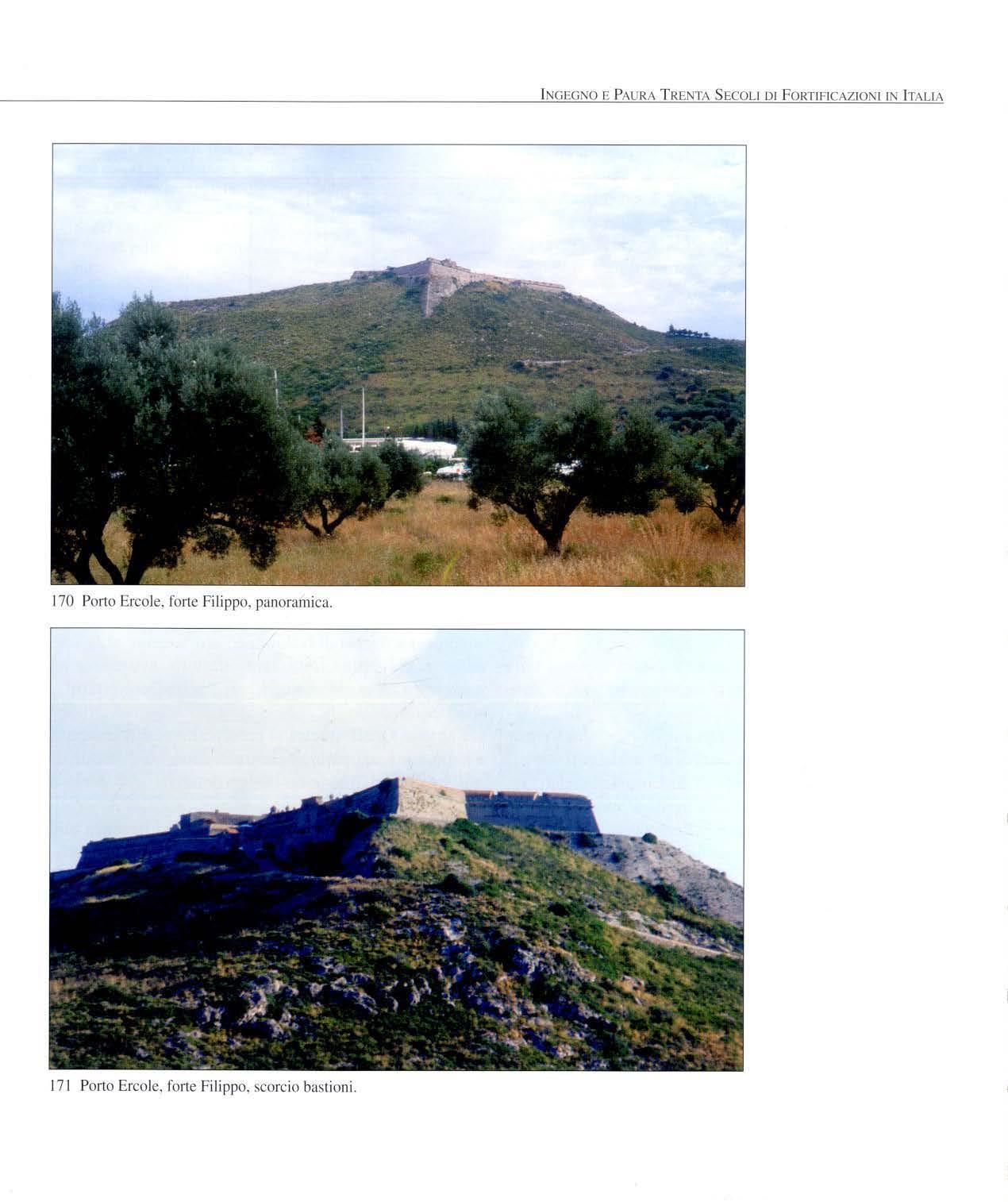
sui settori antistanti, né di appoggiarsi reciprocamente in maniera sign ificativa.
Certamente il verticistico impianto attenuava le suddette limitazioni, ma non al punto di evitare giudizi poco Jusinghie1i nei 1iguardi del forte, se non addirittura dispregiativi. Eppure non mancavano una serie di accorgimenti miranti a sopperire alle principali deficienze quali la: '·... presenza di quattro bombardiere a casamatta utilizzate per la protezione delle cortine centrali, nel punto più distante tra bas tione e bastione ..." mJ: per lo stesso motivo una particolare cura si e ra adottata per i settori contenenti i possibili. varchi d'ingresso, la cui entrata: " ... era difesa all'estremità 01ientale da un rivellino e in quella occidentale, cioè sul lato da cui s i accede al corpo centrale del forte, da un ingresso in galleria... Da notare, sul lato settentrionale del forte. la presenza di un seco ndo rivellino triangolare, molto robusto, simile a que ll o disposto a dife sa dell'accesso.
Dal lato Nord del forte s i distacca un camminamento che collega la fortezza al piccolo avamposto difensivo culminante con la tonella rotonda del Mulinaccio ..." (" 1 •
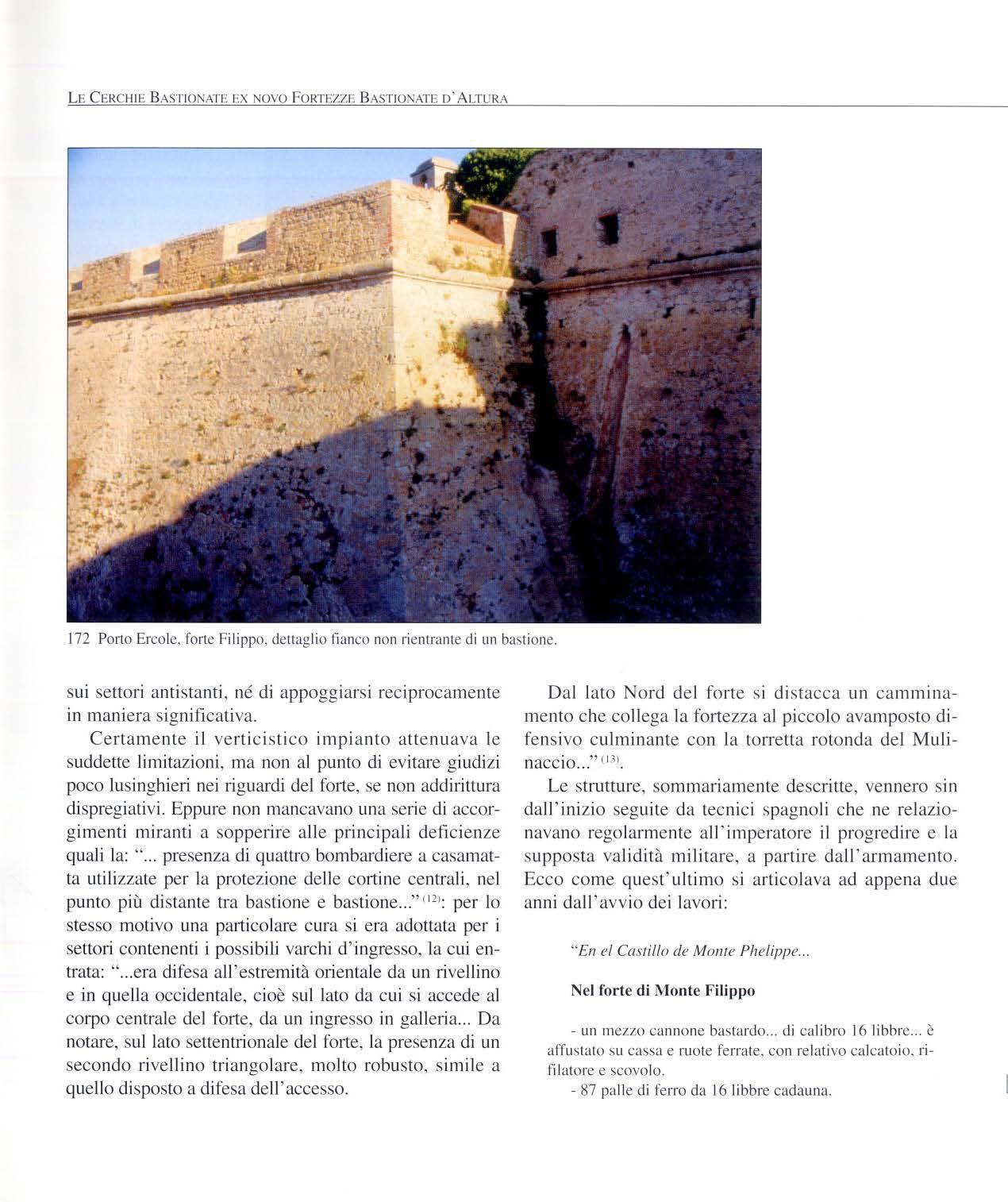
Le strutture, so mmariamente descritte , vennero si n datrinizio seg uite da tecnici spagnoli che ne relazionavano regolarmente all'imperatore il progredire e la s upposta validità militare, a partire dal! ' armamento. Ecco come quest ' ultimo si articolava ad appena due anni dall 'avv io de i lavori:
''En e/ Cas1i/lo de Mo111e Phelippe
Nel forte di Mo nte F ilipp o
- un mezzo cannone bastardo di calibro 16 libhrc è affu~Lalo su cassa e ruote ferrate. con relativo calcato io. rilì l atore e scovo lo.
- 87 pall e di ferro da 16 libbre cadauna.
l 73 Porto Ercole. forte Filippo, dettaglio ponte.
- due mezzi cannoni di identica fattura di calibro di 20 libbre cadauno ... entramb i affu s tati su cassa e ruote fe1ntc con calcatoi. rilìlaLoi e ~covoE.
- 205 palle di ferro di cal ibro di 20 libbre cadauna.
- due falconeui di bronzo di calibro di 2 libbre entrambi affustati su cassa e ruote ferrale , completi di calcatoi , rifilatori, e scovoli
- un altro falconetto di bronzo... del calib ro di 2 libbre... affustato con ruote fen-ate, calcato io, rifi l atore e scovolo.
- sei smerigli di bronzo afTustati sui loro cavalletti di legno
- l 00 palle di piombo per munizione dei detti falconetti e sme ri gl i. oltre a 12 pa lle di piombo rive s tite.
- cinque moschett i di ferro affustat i su cavalleu i di legno con i loro scovoli.
- polvere grossa: ve ne sono 199 barili che pesano a l nena della tara 88 quinta l i 30 rotoli e due terzi.
- polvere fina per archibugio: 80 b,uili che pesano al netto della tara 29 quintali e 37 rotoli " 1141 •
Al pari dell 'armamento che si conferma di tipo leggero, compatibile perfettamente con la difesa di un forte in costruzione, la massa variegata delle altre dotazioni lascia intravedere le necessità di un grosso cantiere, privo persino di adeguate cisterne per l'acqua potabile. piuttosto che non la dotazione di un opera militare. Nonostante ciò è degna d'interesse la celerità di approntamento, al punto che trascorsi altri due anni, stando ad una delle ricorrentj relazioni s ullo stato d 'ava nzamento dei l avori, le sue mura eq uip aravano ormai l'aJtezza de] cordone °"> . Praticamente nell'arco di sei anni il forte poteva iniziare ad esercitare la s ua funz ione. Ma forse per l a migliore definizione raggiunta dalla sua co nfi gurazione le crit iche divennero di giorno in giorno più serrate e malevole, appaiando da un ce1to momento
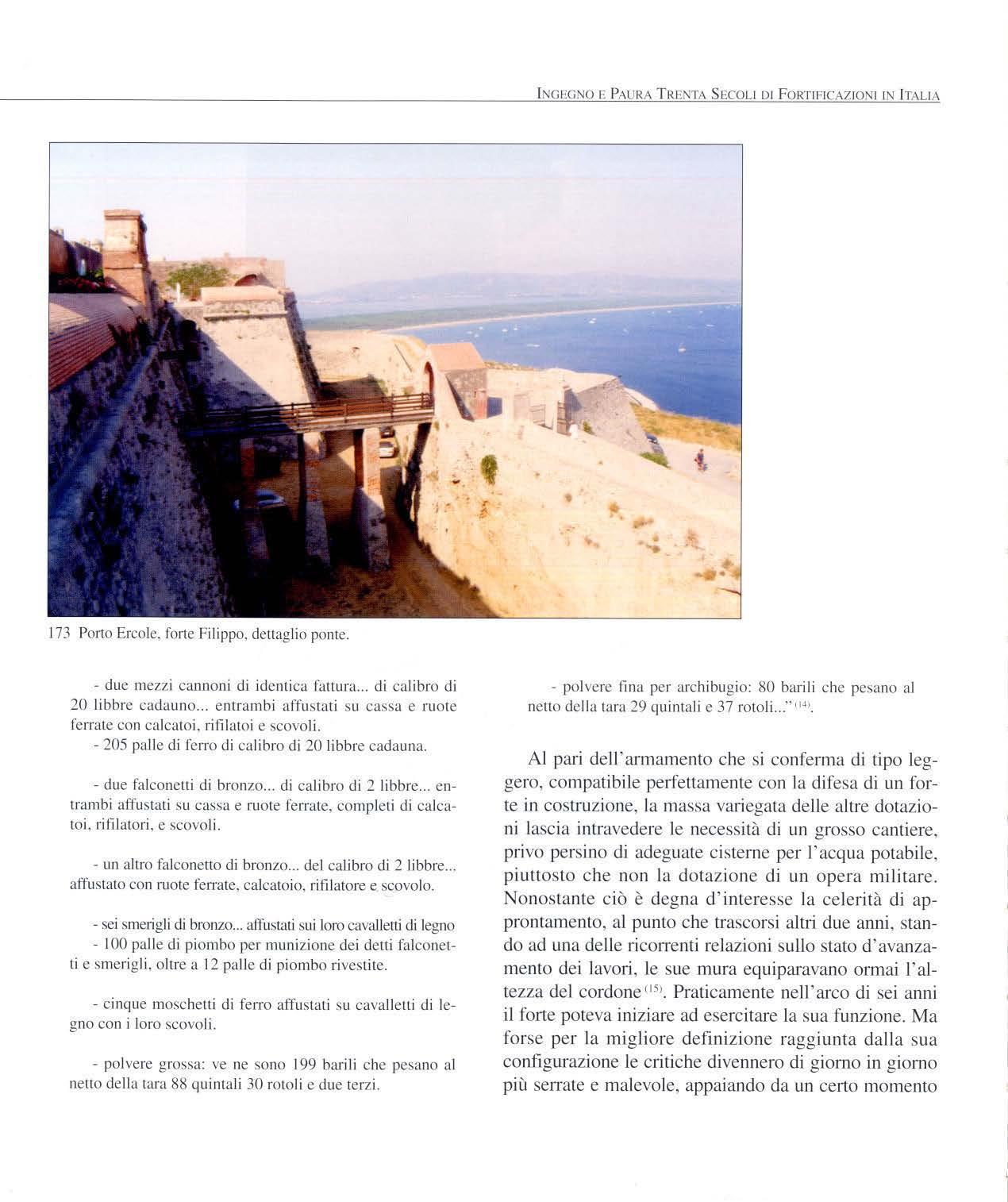 INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI Fo1mr1CAZIONI IN ITALIA
INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI Fo1mr1CAZIONI IN ITALIA
in poi entram be le fo rtezze di Porto Ercole nella identica riprovazione. Da qui le loro difese d'ufficio, come in questa re lazione d e l 157 J: " La costruzio ne dei due castelli di P o rto Ercole di cu i è incaricato il cap. no Geronimo d e Salinas ed anche nel la s ua assenza il cap.no Andrea de Orejon, si avv ia alla conclusione, ed appare potente e ben s trutturata, deg na di S.M., spec ie se entrambe le opere disponessero di più artig li e ri a c he al mom e nto è scarsa e per g iunta in buon a parte g ua sta. È necessario pe1tanto affinché VS.I.ma s ia se r v ita c he s i provved a ad acc resce rl a e d a inviare quella inutilizzabil e a G e nova, od in altra sede più vic in a, per rifon d erl a, mentre per quella c he g iace priv a di affusto sarà necessario dare ordine per farla riparare e sis t emare ..." 116> . In poch e parole secon do l'alto uffi c iale l'unico problem a dei forti consisteva nella carenza d e ll e rutiglierie, de g li uomini e dei v iv e ri , ovvero in deficienze facilmente 1imediabili. Ma il g iudi zio doveva costituire un parere poco cond i viso se il ce l e br e Gabri o Serbelloni e bb e l'incarico di una più attendibile valutazio ne. In essa, secondo la s ua indole pratica, pur non sottacendo affatto l a non felice ubicaz ion e e )'ancor più infelic e configurazione architettonica prospettò però conclusioni ottimi ste a patto di adottare alcuni modesti rimedi:
'·Port oe rco le et Monte fi Iipp o se ben potr ia no esse r meglio piantati et con più rag ione fondati con s ue piazze e lianchi più capace, nondimeno esse nd o Monte fi lippo superiore à tutt o il suo circui t o, et offese, situato sopra un· scoglio o monte di pietra dura. et il medesimo la R occa cli Port'erco le qual ha solamente un'incontro cli un a supe ri orità, di un luoco, dove era al tempo che s i prese Port'ercole un forte detto r Avoltor, qual s upe 1i o1ità non è capace de molli pezzi et anco è alla di co ns umarsi in parte come nella Re lall io ne se int e nd e rà. Pe r il chè di co che con qu est i pochi rimedj c he g li ma nca no à far. sara nn o queste fortezze à termin e che no n baster l' a nim o, o forza humana di promettersi di sforzarle, et queste reparationi. tassando da parte le s pese della comodi tà di alloggiamen ti non costerà d. 12.000 ' 17 '
Dopo i preliminari, peraltro es tre mam e nt e e loquenti. il rapporto do veva dilung ars i s ui 1imedi , m a di sgra -
z i atamente questa sez ion e del documento non c i è pervenuta. Qu e ll e c h e in vece possiamo leggere sono le cr itich e d e ll'in gegner Fratin a tali sem plici s ti c i adattamenti e forse a ll a maniera fin tropp o disinvolta ostentata dal milanese di int e nd ere l a fortificazione. Così il testo della controrelazione:

·'Parere del Fratin in 1ispos ta de un a relaLione de Gabrio de Serbeloni so pra la fortilìcacio ne di Montetilippo
Ho visto la relalione di Monte lìlippo , il quale luogo per esser una fortezza tulla int egra et per que ll o che mos tra in figura molto debile non potendo io g iudi care senza veder la natura del sito o Monte non po sso se non remettcndomi a la relatione. La qual pero in quello c he dice che sa ri a bene ad abassarla s in al cordone per che faria mig li or difes sa et che non costaria tanto il terrapienarla ne saria bi sog no alzar tanto la contrascarpa non mi piace perchè essendo la figura et misura del fo1te molto debile di tutti i s uoi membri et tutti in sieme molto piccolo la conlro sca rpa non può esser buona eia basso de un forte come questo anzi conforme a l sito sare bb e dannossa a causa c he le controscarpe che se fanno se 11011 sonno defes se de la forcezza. cli denlro sono più prolittevoli a l enernico che all'amico et questa fortezza s tando co me mo stra non e possibile che possa favorire la s ua contrascarpa :· 11 ~·.
Il giudizio è estremamente severo, ma se nza dubbio assol utam e nte inoppu g nabil e: al di là della natura del s ito d'impianto le s ing o le com ponenti d e l forte appaiono deboli e quindi asso lutamente non idonee a dife ndere una co ntro scarpa così masto dontica e d articolata. Per cui quella che dovrebbe costituire una protezione avanzata si tra sfo rma, in pratica, in un vantaggio p e r l'attaccante! Pertanto , proseguiva la controrelazion e, sa rebb e s t ato meglio teITapienare le s trutture abbassandone so ltanto i fianchi.
In sostan za il Fratin sco ns igliava quello che molto probabilmente s ug ge1i va invece. il Serbelloni. ovvero di abbassare le cortine e d i bast ioni. Per il milanese infatti, così facendo, per esse re s trutture sca rpate , perd e ndo in altezza avrebbero guadagnato in larghe zza, offrendo più s pa z io all'armamento. Os se rvav a a s u a volta il Fratin che l ' incre mento s are bb e ri s ultato mo -
destissimo a fronte della s pesa, per cui gli pareva più se n sa t o l asciare r altezza immutata , certamente v uln erabilissima una volta accostatosi il nemico ma vantaggiosa per battere a distanza le s ue trincee in fase cli avvicinamento. Precisava ancora il Fratin che per rendere il tiro meno ficcante, e quindi più radente, s i sare bb e r o se mai dovuti abbassare so lt anto i fianchi con le re l ative ca nn oniere e non l'intera opera, col rischio di renderla incapace di dominare le pendici dell'altura. P e r cui ribadiva di non mutarne minimam ente l'altezza complessiva ma so lo quella dei fianchi. Anche per la Rocca il Fratin esp resse nella circostanza una se ri e di riserve, dettate sempre dall'anomala disposizione dei bastioni. E cercò anche di fornire per qu anto po ss ibil e indicazioni su ll a maniera di ridurre le ma ggior i deficienze.
Diffi cile a questo punto precisare quanti dei s ug geri m e nti del Fratin abbiano poi trovato effettiva
attuazione: molto probabilmente ben pochi neutralizza ti dalle carenze economiche e dall ' incalzare degli eventi che impedivano ulteriori varianti consentendo, al massimo, i nt erventi integrativi marginali. E forse proprio per ovviare alle più gravi e pericolos issime carenze evidenz iate , q u ali per tutte quella della po s izion e tr oppo v uln erabile della Rocca di Porto Ercole soggetta al donùnio della cima del! ' Avvoltoio si procedette alcun i decenni dopo, costellati certamente seco nd o la prassi spagnola dell 'e poca da infiniti sopralluoghi, diatribe e disquisizioni t ecniche al limite del filosofico s u a ltre tt an t e propo ste di progetto, alla costruzione di un nuovo forte: il già ricordato forte Stella. Suo tramite occupando la sommità dell ' altura in questione, e i s uoi imm ediati paraggi , s i sar ebbe definitivamente scong iurato il rischio, tutt'altro che remoto, di bombardamento della R occa e della città stessa, dalle immaginabili conseguenze
 174 Porto Ercole, forte Filippo. muro di controscarpa
174 Porto Ercole, forte Filippo. muro di controscarpa
Com e in precedenza ricordato , un a delle ultime s correrie turche di notevole entità abbattutasi sui retroterra della Sereniss ima fu quella del 1499. Non a caso Ven ez ia, già dal XV seco lo , ad onta de l s uo mode st iss imo stato costituiva s ul mare grazie alla s ua podero sa flotta la punta più temibile de ll o sc hieramento antiottomano, ma a nche quella più debol e ed indifesa lungo i suo i co nfini te 1Tes tri ' 19 > .
A differenza, quindi, dell'immenso Mezzogiorno spagnolo che poteva riguardarsi alla stregua di un ' enorme quanto statico bastione proteso nel Mediterraneo, ottimo per la difesa ma del nttto inerte a pochi chilomet ri di distanza; a differenza dello Stato Po nti ficio che pur rapp re senta nd o il polo id eologico dell'intera c ri stian it à ed il suo stimol o ideale, si co nfermava altre tt an to imbe ll e e d inene, Venezia poteva a g iu s ta ragione reputarsi la punta di diamante della civiltà europea. Con le sue na vi , idonee a l co mm ercio quanto a ll a guerra , m osse in entrambe le ci r cos t anze dall'identica detenninata aggressività e maestria, cost ituiva il lungo braccio armato del mondo occidentale, capace di colpire i I fanatico turco ed i suo i all eati, in qualsiasi momento e dovunque uno specchio di m are l a mbi sse la loro terra. D i tale minacciosa potenzialità anche g li orgogliosi s ult ani di Costantinopoli erano perfettamente consapevo li , al punto di evitare accorta m e nte ogni occasione per c im entarsi con le galere di S. Marco , me no c he mai nel loro golfo, per l'epoca l'intero Adriatico fi no a l la cong iun gente Otranto-Va l o na , no no stante che l a spo nd a orienta l e fosse qua si interamente nel le loro mani.
Di sgraz i atamente però se l' lm pero spagno l o, l o Stato Pon t ificio e la R e pubbli ca di Ven ez ia, s i gnificativamente un a monarchia il primo. una so rt a di teocrazia il seco ndo e d una repubblica il terzo , temevano e com batt eva no un identi co nemico non per questo a l di là di ta l e concordanza polemologica ne oste nt ava n o a na loghe in qual siasi a ltro setto re. Anzi a voler meglio ind agare la v icenda ba l za evidente che in div e rs e circos tanze per contrasti rec iproci ed ostilità di g re tto potere avevano preferito favorire il turco, pur di dann eggiare l ' odiato e dete stato alleato cristiano. L'a pi ce fo attinto allorquando in qu e ll a infid a cobelligeranza si temette ro piuttosto le conseguenze di una vittoria su Cos tantinopoli c h e di un a sco nfi tta. In altr i termi ni c he un succe sso occide n tal e potesse agevolare i correligio nar i, con i quali peraltro motivi e cause di cos tante conflittu ali tà più o m eno late nte , più o m e no esp lic it a non mancavano mai, in partico l are agli ini zi de l
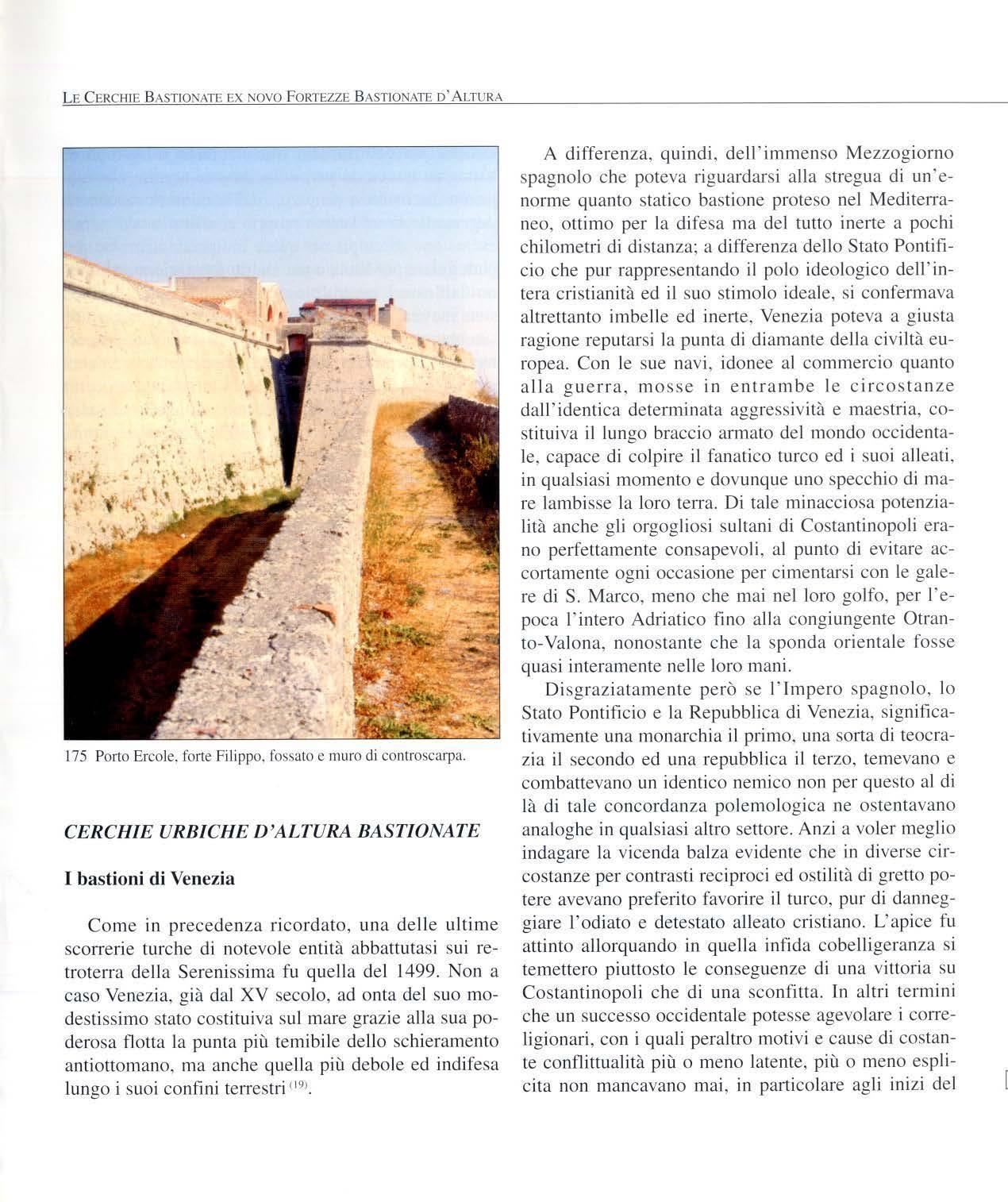
XVJ secolo. Nessuna meraviglia, pertanto che , proprio alle s egrete trattative tra Venezia ed il Turco si attribuì l'efferata scorreria dj Otranto condotta nel 1480 da una formazione navale d'estrazione balcanica <~<)) E nessuna meraviglia che anche l'altrettanto efferata scoITeria contro il tenitorio veneziano del 1499, condotla a nch'essa da un'orda di estrazione balcanica , è asc ritta alla trattativa altrettanto segreta fra Milano ed il Turco 12 ') ·
Nella circostanza la Repubblica, forse per insipienza o viltà dei suoi comandati militari di terraferma, forse per inadeguatezza del suo dispositivo difensivo, concause perfettamente identiche a que ll e ravvisa te a l le spalle della tragedia di Otranto, non seppe oppo r si efficacemente al dilagare dell'orda mus ulm ana. E questa, esattamente come diciannove a nni prima nella disgraziatissima cittadi n a pugliese, trasformò per mancanza di adeg uata reazione una iniziale scorreria corsara in una terribile azione militare. Co l senno d i poi anche Venezia al pari di Napo li corse ai ripar i avviando un grandioso programma di fortificazione delle sue frontiere: dal momento che su quella marinima non temeva alc un a minaccia gl i interventi dovevano concentra rsi lungo que ll a terrestre. Unica significativa differenza, determinata però dall'essere le vie di penetrazione al pin e poche. note ed immutabili; a differenza di quelle mediterranee non sarebbe stato necessario diluire g li interventi riqualificando ogni abitato ma concentrarli in pochiss imi punti nodali , bloccandoli irreversibilmente con altrettante piazzefo11i.
Ne i decenni successiv i, pertanto, la dùigenza milita r e venezia n a memore della terribile vicenda e constatando che il num ero dei probabili agg ressori da terra non si limitava più so lt anto agli ottomani ed ai loro gregari balcanici , ma includeva sempre più distintamente e concreta me nte le ma ggior i potenze militari del momento, prima fra tutte la Spagna e subito dopo la Francia, dovette stabi l ire una precisa mappatura delle rela Li ve direttrici d'attacco. Ad onta d a lr essere entrambe costantemente straziate da1 comune nemico, le due superpo te nze 1inascimen tali non perdevano oc-
casione per confrontarsi spietatamente s ul campo di battaglia, lasciando perciò facilmente arguire che aJla prima circostanza propizia quelle contese sarebbero degenerate in un vero e prop1io conflitto totale, senza esclusione di colpi, nel quale indipendentemente dal parteggiare per l 'una o per l ' altra formazione, o persino dall'essere neutrali , ogni altra compagine sarebbe stata in evitabilme nte ri succhiata. E magari l'occasione sarebbe s cat urit a proprio da un ennesimo successo ottomano. E sebbene la Francia esasperando la rivalità con la Spagna, avesse finito per adottare , da un certo momento in poi, una linea politica di aperta allea nza con i Turchi mJ , stigmat izzata all ' epoca come empia, questo non la rendeva agli occhi della Serenissima un a ll eato fidato né un nemico remoto.
Il quadro pertanto co n l'approssimarsi della metà del XV J secolo si confermava per il Senato veneziano, sotto qualsiasi punto di vista , asso lut amente gravido di minacciose potenzialità, con un'unica chiara ed inconfutab il e certezza: laddove non arrivavano le navi la vul nerabilità di Venezia appariva irrimediabile e terrificante, non potendosi fare affidamento neppure su appoggi di tipo meramente dissuasivo. Ed og ni anno che trascorreva rendeva l'esposizione se possibi l e sempre più temibile e sempre più incombente , da qualunque parte la si ipotizzasse.
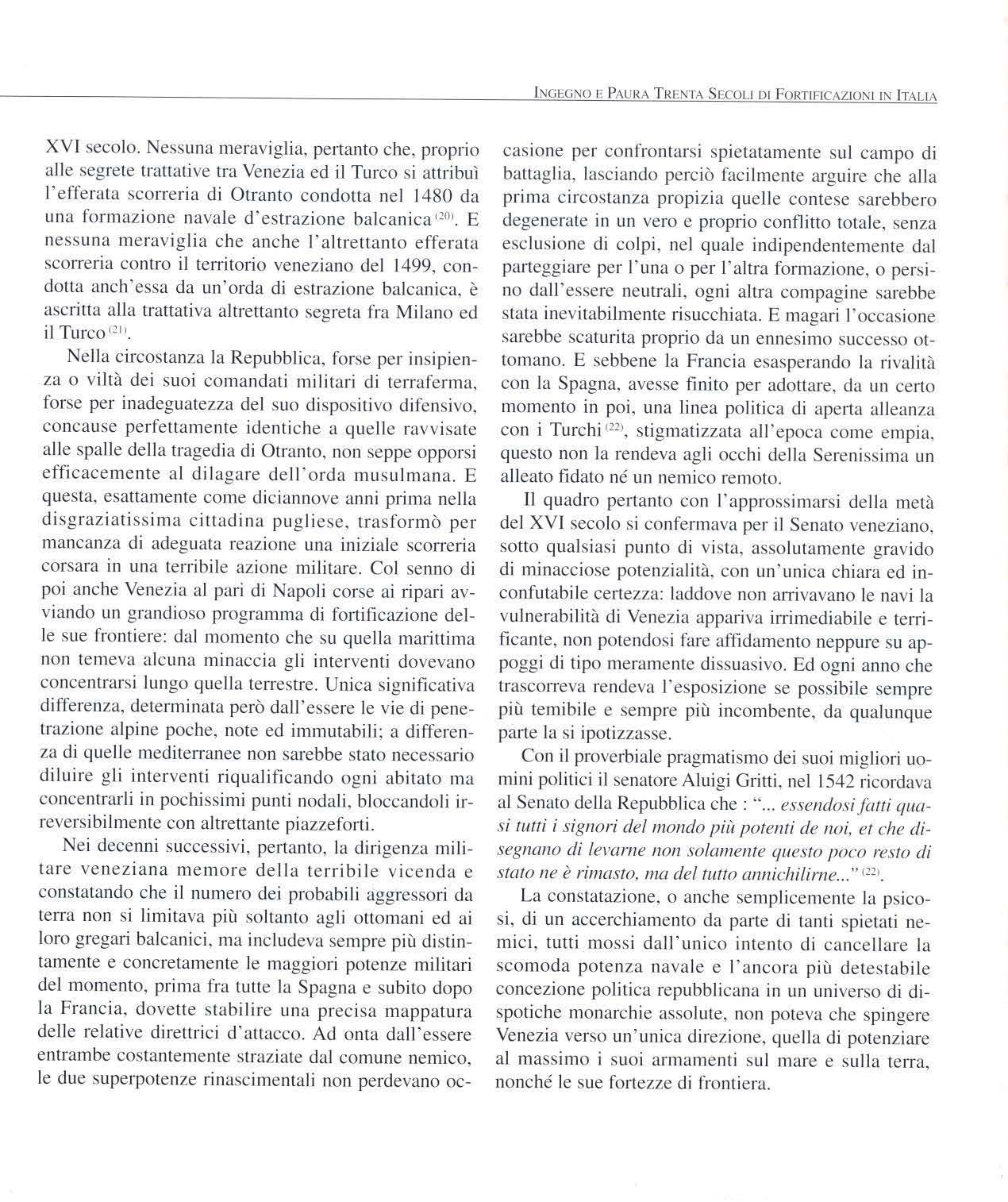
Con il proverbiale pragmatismo dei suoi migliori uomini politici il senatore A luigi Gritti, nel 1542 ricordava al Senato della R epubblica c he : " essendosifatri quas i tutti i .signori del mondo più potenti de noi, et che disegnano di levarne non solamenre questo poco resto di stato ne è rimasto, ma del tutto annichilirne... " <2 2 )
La constatazione. o anche semp li cemente la psicosi, di un accerch i a me nt o da patte di tanti sp ietati nemici, tutti moss i dall'unico intento di cancellare la scomoda potenza n ava le e l 'ancora più detestabile concez io ne poli ti ca repubblicana in un universo di dispot ic he monarchie assolute, no n poteva che sp in gere Venezia ve r so un ' uni ca direzione, quella di potenziare al massimo i suoi ar m amenti s ul mare e sulla te1Ta, nonché le s ue fortezze di fron ti era.
A rendere ulteriormente auspicabile qu est' ultima opzione g iocava una fin troppo facile osservaz i one: da decenni ese rciti imperiali agguerritissimi ed armatissimi venivano tenuti in scacco nelle Fiandre da poche pia zzefo rti , certamente dell'ultima concezione archiLettonic a, ma altrettanto certamente ine s pugnabili dalle altrettanto moderni ss ime artiglierie. La s oluzione dell'ecces s iva vulnerabilità del retroterra venezia no sarebbe s tata perciò l'erezione di analoghe opere difensive: poche e coriacee. M a per poch e che fossero state, fu s ubito evidente che il numero di qu e l le indispen sa bili non era affatto tra sc urabi l e: volendo adottare gli standard delle grandi piazze bas tionate sarebbero occorsi stanziamenti economici assolutamente esorbitanti dalle concr e te di s ponibil i tà, essendo pur se mpre la flott a la prima anna in assoluto. I ndi spensab il e p e rtanto s caglionarne l ' edific azione, procedura che implicava preliminarmente un 'accorta valutazione
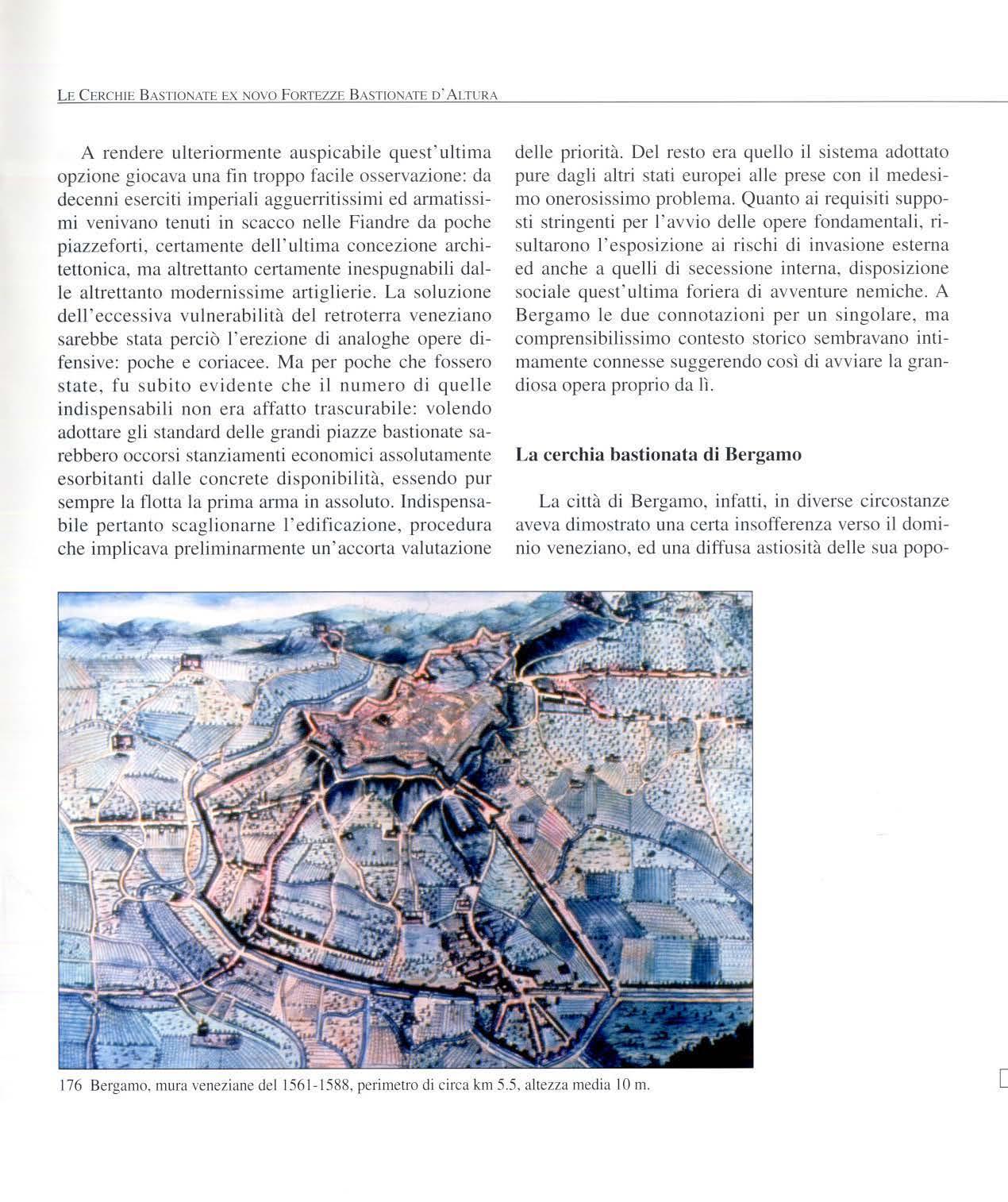
de ll e priorità. Del resto era quello il s istema ad o tt ato pure dagli altr i stati e urop ei alle prese con il medesimo onerosissimo problem a. Qu an to ai re qui si ti s upposti s tringenti per l'a vv io delle opere fondamentali, ris ultarono l'e spos izion e ai ri sc hi di inva s ione esterna ed anche a quelli di secess i o ne interna , di sposiz ion e soc iale que s t'ultima foriera di avve nture nemich e . A Berga mo le du e connotazioni per un s ingolare , ma comprensibilissimo contesto s tori co se mbra vano intimamente connesse s ugg e rendo così di avviare la gra ndjo sa opera proprio da lì.
La c ittà di Bergamo. infatti, in diverse circostanze aveva dimo s trato una ce11a insofferenza verso il dominio veneziano, ed una diffu s a m;tiosità delle s ua popo -
!azione vers o i suoi rappresentanti. Non erano mancati significativi episodi di aperta ribellione alla prima circostanza propizia e di 1ivolla alla prima occasione incentivante: la vicinanza di Milano , estrema propagg ine spagnola, e della Francia aggravava la situazione rendendola oltremodo instabi le.
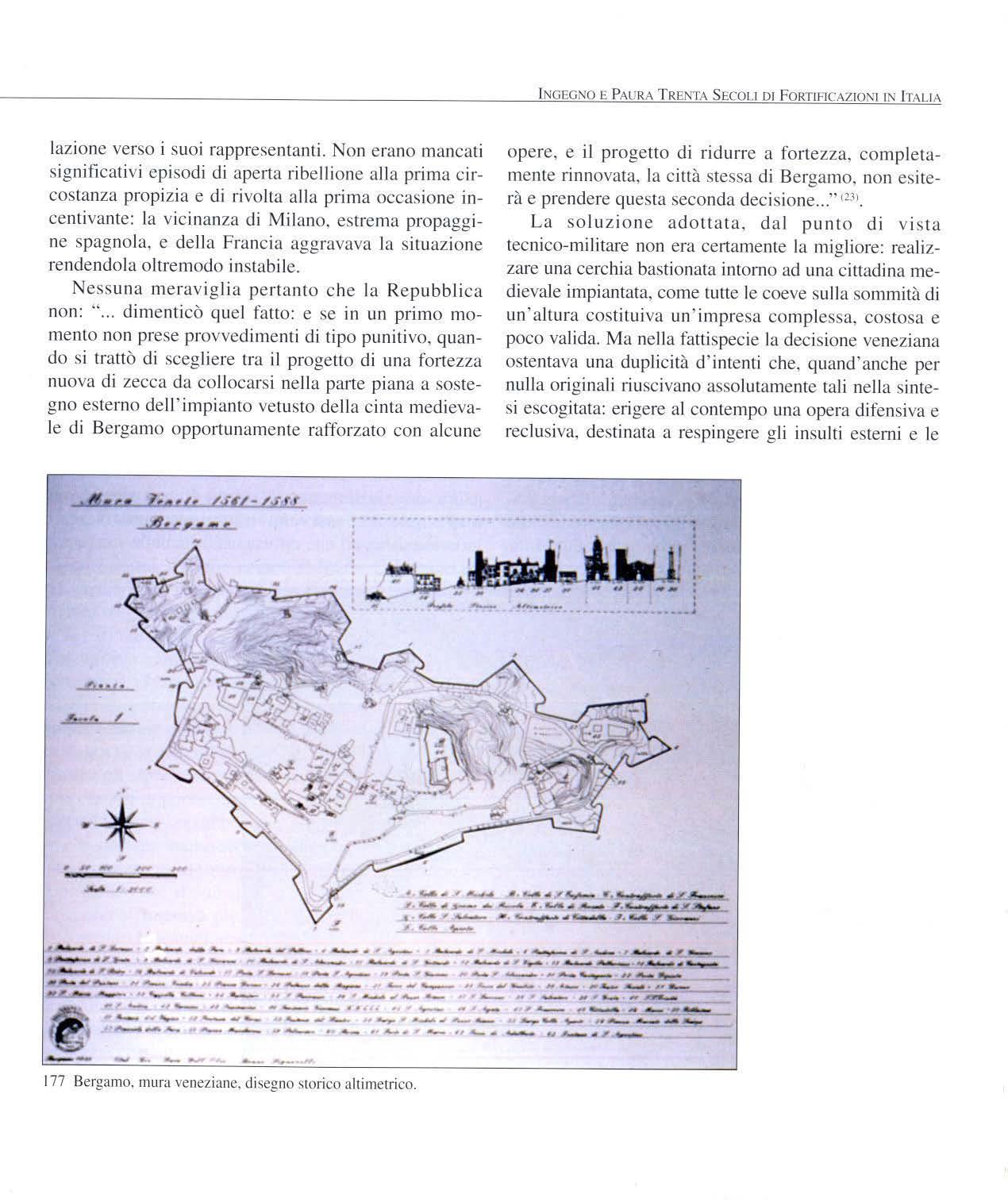
Nes s una meraviglia pertanto che la R epubblica non: " ... dimenticò quel fatto: e se in un primo momento non prese provvedimenti di tipo punitivo, quando si trattò di scegliere tra il progetto di una fortezza nu ova di zecca da collocars i nel la parte piana a sostegno esterno dell'impianto ve tu sto della cinta medievale di Bergamo opportunamente rafforzato con alcune
opere, e il progetto di ridurre a fortezza, completamente rinnovata , la città s te ss a di Bergamo. non es iterà e prendere que s ta seconda decisione ..." '23 l
La s oluzione adoltata, d a l punto di vi s ta tecnico-militare non era certamente la migliore: realizzare una cerchia bastionata intorno ad una cittadina medievale impiantata, come tutte le coeve su ll a s ommità di un'altura costituiva un'impre s a comples s a. cos tosa e poco va lid a. Ma nella fattispecie la decis ione veneziana ostentava un a duplicità d ' intenti che, quand ' anche per nulla origi nali riuscivano as solutamente tali nella sintesi e scogitata: er igere al contempo una opera difensiva e recJusiva, destinata a respingere gli insulti e s terni e l e
sollevazioni interne, una so1ta di corazza, un esoscheletro che sostenendo costringeva, impedendo perciò qualsiasi azione non ortodossa. In prima approssimazione la volontà di tenere in soggezione una popolazione infida con un 'opera militare di tipo difen s ivo non sembra discostarsi gran che dalla prassi vigente, della quale gli Spagnoli erano maestri. Ma fino a quel momento il compito di 'freno sociale' era stato affidato ad un fo 1te cittadino, o per meglio dire ad una cittadella, una sorta di estremo ridotto e non già alla stessa cerchia bastionata, come nel caso di Bergamo. La novità pertanto stava certamente nell'individuare nella particolare struttura un valido pretesto per procedere alla militruizzazione coatta dell'intera popolazione, trasformandola suo malgrado in una sorta di guru·nigione, assoggettata perciò alla disciplina militare precipua delle piazze di frontiera. Ed a tanto non erano mai giunti neppure gli Spagnoli nell'ultima loro colonia!
Pertanto se ufficialment e la nuova fortificazione sarebbe stata finalizzata alla difesa della popolazione e del territorio la infelice so luzione architettonica tradiva l ' intento politico. Infatti: " ... l 'aver diviso in due la città, per esempio, e l'aver costituito una piazzaforte d'altura , se poteva essere ritenuto logico nel medioevo, non altrettanto può considerarsi tale nel cinquecento inoltrato.
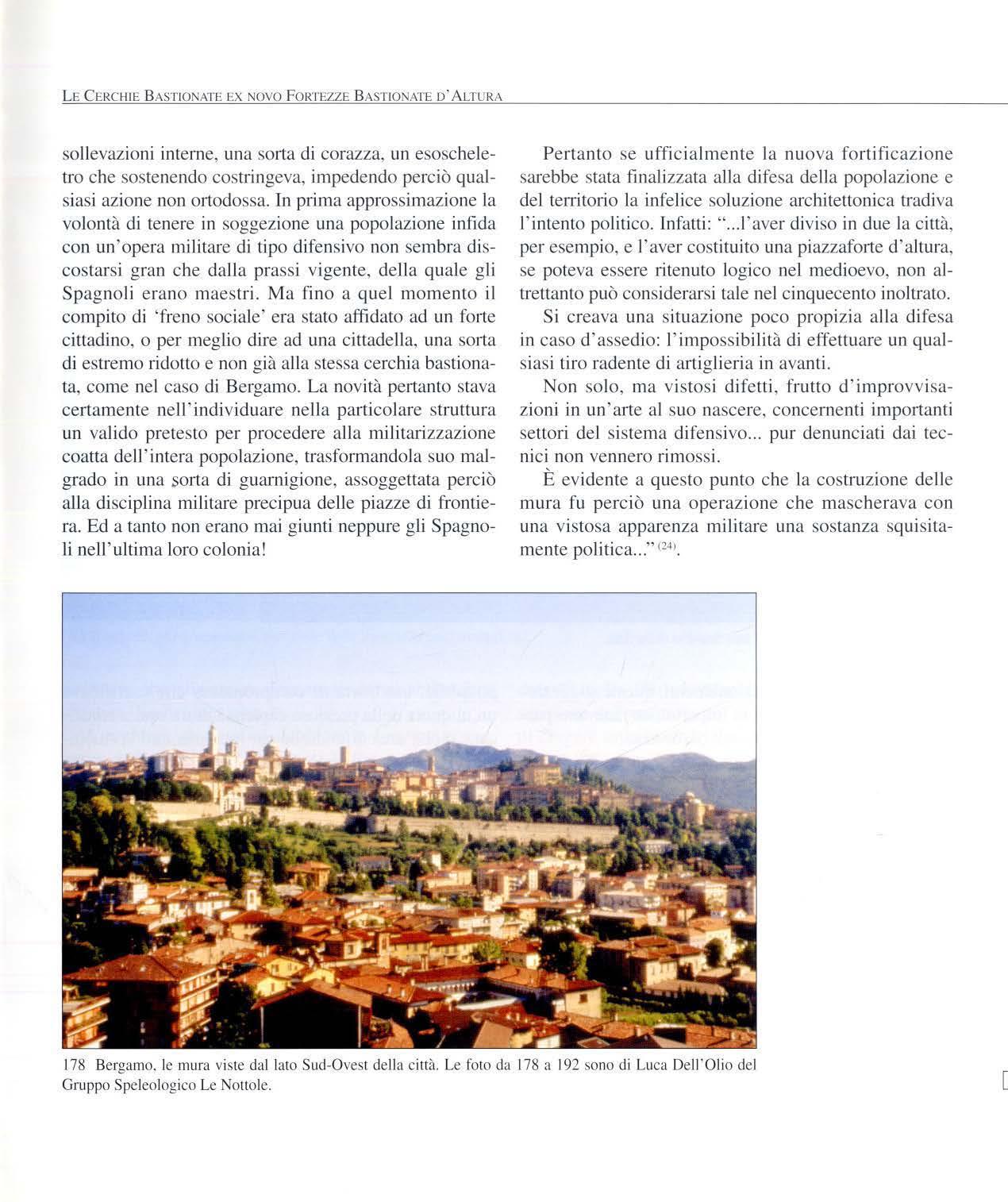
Si creava una situazione poco propizia alla difesa in caso d'assedio: l'impossibilità di effettuare un qualsiasi tiro radente di artiglieria in avanti.
Non solo, ma vistosi difetti, frutto d'improvvisazioni in un'arte al suo nascere, concernenti importanti settori del sistema difen s ivo pur denunciati dai tecnici non vennero rimossi.
È evidente a questo punto che la costruzione delle mura fu perciò una operazione che mascherava con una vistosa apparenza militare una sos tanza squi sitamente politica " 124 )
179 Bergamo. le mura viste da l lato Sud -Es t della città.
M a anche qu es ti condizio namenti, queste soggez ioni soc iali , que s te costrizioni imperialiste facevano parte de lla nuo va realtà del fronte bastionato.
In pratica B e rgamo adagiata sulla so mmilà di una collina non s i pres tava ad un tracc i ato s imm e trico id e al e, p ec uliare almeno in lin ea di principio della nuova concezione fo r tificatorja. Pertanto il tracciato perimetrico pre sc elto do ve tte n e c essa riamente de s treggiar s i adattandosi alla meglio a l ciglio tatti co dell 'al tura s te ssa qua s i una anacroni s tica ripropo s i z i one, fatta sa l va una lie ve conce ss ion e, l'unica del re sto possibi le limitatamente ad alcune tratte. In dettaglio l'e s pediente escogitato per r idurre se non altro l'incompat ibilit à tra ba s tioni e rilievi , consisteva, come g i à rim arcato in tutte l e co n s imili realiz zaz ioni , nell'arretrare al massimo il piede delle mura risp e tto a l ciglio de ll a so mmit à dell'altura. In tal modo veniva lasc iata la mass im a superficie di terreno pianeggiante
possibile, una s orta di co mprome sso che s acrificava un 'a liquota della pre z io sa capienza di un ' opera fortificata , cioè l 'area difendibile per incre me nt are la s ua interdi z ion e esterna, cioè l'area dife sa. L a preziosa fasc ia così ri s parmiata, non di rado ampia poche decine di metii, conse ntiv a un s ia pur minimo tiro raden te, di basso fiancheggiamento che impediva un fin troppo facile accostame nto ne mi co, tanto più ch e in costruz ioni del gene re abitualmente mancava il fo ss ato o, quando es is tente ri s ultava molto s tretto.
Venendo alla scan s ion e cronologica de ll a cerchia di Bergamo è possibil e individuarne i prodromi in un a relazione del 1553 nella quale il capitano Francesco Bernardo sc ons i g liava di tra sfo rmare la città in una piaz za di confine in guanto centro d'altura. Suggeriva , in vece , di fortificar e adeg uatam ente al s u o po s to la c itt ad in a di Romano a s uo parere ùi gran lun ga più idon ea in quanto di pianura. II che lasc ia facilmen te

intendere che alla stessa data fosse onnai abbastanza scontata l'individuazione.
A recidere gli estremi dubbi. o le loro parvenze , provvid e i I generale conte Sforza Pallavicino , su] finire dello stesso decennio. In particol are, in una s ua relazione del I 560 consigliava esplicitamente per l'erigenda piazza l'adozione di una cerchia ba st ionata. Modic a peraltro, a s uo parere, la s pesa fatta ascendere a so li J 00 mila ducati, di cui so lo un terzo a carico di Venezia, mentre i restanti due terzi da ripartirsi secondo logiche affini a quelle già incontrate altrove, sui territori limitrofi. Il vero e maggior onere sare bbe stato , sempre seco ndo il suo giudizio, quello derivante dai danni che inevitabilmente la nuova costruzione avrebbe provocato al patrimonio immobiliare di molti cittadini: ma sareb b e sta to un male necessario, di tipo chirurgico, indi s pensabile per la sa i vezza dell ' inLero organismo. Ne l la relazione conclusiva, compilata in
data 13 luglio 1561, lo Sforza forniva una migliore descr izione del suo progetto: " dopo aver scartato l'idea di cingere tutta la città. che aveva un perimetro di circa 6 miglia, perché l'op era ri s ultava troppo costosa e poco conveniente, egli tracciava le lin ee ge nerali del lavoro da compiere per fortificare la parte alta, il cui perimetro era circa la metà: l'opera più impegnativa era quella di « tagliar quella schiena, la qual viene dalla Cappella a congiungersi con la città»: in quella zona dovevano bastare 3 baluardi di terra, rivestili di muro fino all'a lt ezza di 12 piedi dal fondo della fossa; « i] resto del circuito di detta città è tanto erto, che non ha bisogno di fosso in luogo a lcuno, ovvero in poc hi ss imi. ma so lo di esser scarpato, e t esserv i fatto il suo parapetto et percioche il monte nella maggior parte de luoghi va fiancheggiandosi da se stesso havrà ancor bisogno di pochi altri fianchi che quelli che lanatura istessa vi ha fatti »" 1151 •
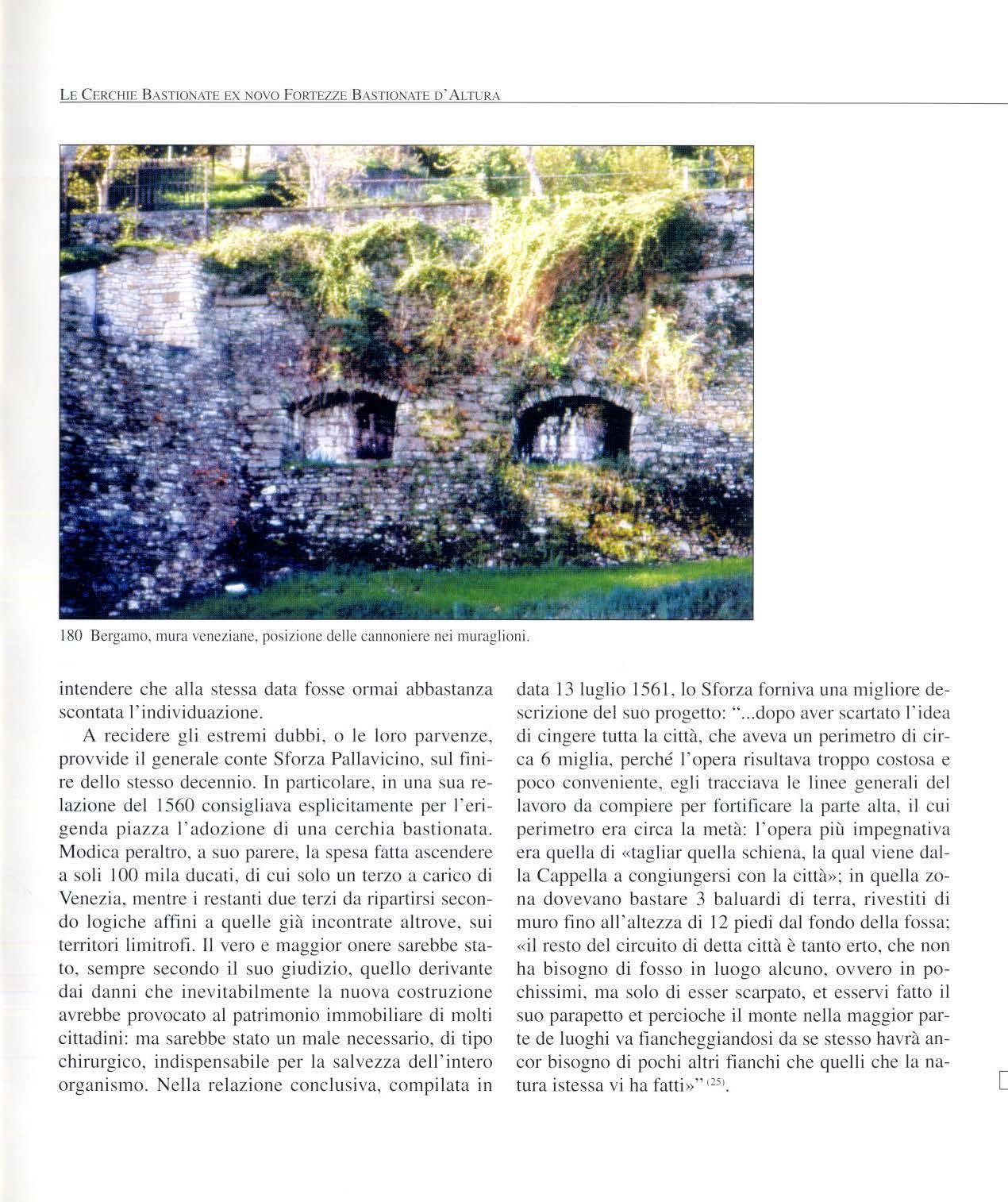
Nei mesi successivi l'illustre personaggio chiarì ancora meglio quel suo progetto dinanzi al senato della Repubblica: 3000 guastatori 40.000 ducati e circa due mesi di tempo, questo quanto strettamente necessario per concretizzare la cerchia bastionata di Bergamo, secondo le migliori e più avanzate concezioni difensjve:
in particolare dalle vallate e dalla pianura, chiariva che la cittadinanza di Bergamo era obbligata a provvedere di casa e di utensili i so ld ati, mentre le vallate e il resto del territorio dovevano provvedere alla legna, all'olio ... e al carbone occorrenti al corpo di guardia, senza distinzioni tra esenti e non esenti, p1ivilegiati e non privilegiati, dal momento che i soldati erano «s tati mandati de li per comuni benificio di tutta la città» ..." (27> .
"
...co ll a commodità che s i ha delli homini di quelle valli si potran tuor 3 mjla guastadori et far l'opera in doi mesi solamente et perchè fu detto che quello era un buon termine, rispose se io con questa gente e con questa cornmodità del denaro che d ico non lo meuo in d ifesa in doi mesi o doi mesi e mezo al più non vogl io esser tenuto per sano dicendo computare la s. tà v.ra a tutta la spesa che è a 3 ducati per homo per 3 mila guastadori 9 mila ducati al mese che in doi mesi sono 18 m. ducati ma voglio che siano 20 mila. 16 mi la poi vi andrà per far quella incamisada del muro , ma datene 4 mila di più che siano 20 mi la che con l a spesa de i g uastadori il tutto non passerà più di 40 mila ducati ... " 126'
L a migliore comp rensione del progetto ed il diffondersi dei suoi dettagli, sollevò nella città violente recriminazioni: le demolizioni previste non erano affatto insignificanti e gli oneri da sostenere, sia economici che esistenziali, molto gravosi per tutti i bergamaschi. Nonostante ciò, tra le comprensibili proteste ed ostilità i lavo1i, esaurita la dolorosa fase delle demolizioni, iniziarono so lennemente il l O settembre dello stesso anno con la posa della prima p ietra. Per prudenza l a guarnigione inca1icata ufficialmente di difendere la città durante i lavo1i ed ufficiosamente di reprimere qualsiasi resistenza al]' avanzamento degli stess i ve nn e raddoppiata. Stando ai documenti, infatti: " ... ai soldati normalme nte impiegati per la difesa della c ittà di confi ne (ci rca 400 ) furono aggiunti, coll'inizio dei lavori, altri 550 fanti e, a metà agosto, richiesti "con ogni prestezza" alu·i 500... fino a raggiungere il numero di 1700 fanti nel novembre I 561. Ol tretutto in mancanza di adeguati a llo ggiamenti militari , ai cittadini era imp osto a n che l'onere di osp itare i soldati . Successivamente il Se nato veneto ... per togliere i continui ricorsi e contestazioni,
Con incredibile energ ia in : " ... soli tre mesi (da agosto alla fine di ottobre), con il lavoro di 3760 "guastato1i", 263 "spezzamonti", 147 "murari" e 8 "proti", distribuiti in 9 punti diversi della città, lo Sforza era riuscito a tracciare quasi tutto il circuito della fortezza, nonostante l'amp li amento del progetto originruio e di conseguenza l 'aumento co ns id erevole del lavoro " <28>
Quanto alle distruzioni, difficilmente un investimento ossid ionale avrebbe potuto infierire peggio. Grazie ad un preciso documento sappiamo infatti che vennero demolite 276 case, tre chiese ed i relativi monasteri per un valore complessivo di 190.000 ducati. La cifra appare in tutta la s ua gravità considerando che l a fortezza finita ne racchiudeva so lt anto 550, per cui l'entità corrispondeva ad un terzo dell'intero patrimonio urbanistico della piazza!
È interessante a questo punto , per vagliare meglio lo stato d 'a nim o che circondava la realizzazione di q uelle grandi fortificazioni, altro aspetto abitualmente trascurato del fronte bastionato, scorrere una relazio ne del novembre di quello stesso 1561 inviata dal Veniero al Senato di Venezia che così enunciava :
" ... "Se r. mo Principe.
a quali so no state rovinate e case e vigne. sono mo lti c he hanno ric ev uto danno ne ll a maggior parte delle loro faco ltà et molt'altri che non havcvano altro al mondo che quello che loro è stato rovinato et destructo. Per la qual cosa sono rimasti miseri et mendici. cosa veramente degna di ogni compassione et della grati a di Vostra Serenità... ''.
Il Veniero co ntinu ava chiedendo che venissero almeno in parte risarciti questi danni o che ag i i abitanti danneggiati ve ni sse ro tolte certe tasse. Con ciò:
 INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN I TALIA
INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN I TALIA
« consolerebbe in gran parte gli animi di quel populo, il quale è rimasto tanto mal soddisfatto et mal contento di questa fortificazione che promello a Vostra Serenità che non so qual maggior dispiacere havesse potuto s entire quas i di qualsivoglia altra cosa che gli fusse potuta succedere, et tanto più res ta mal soddisfatto quanto chi dubita che i borghi di qualche tempo non habbino ad esser rovinati et des trutti »
Nel giugno dell'anno seguente il Senato disse la sua parola definitiva e chiara in merito: rispondendo a lla supplica degli ambasciatori della città di Bergamo, affermava che non era possibile accettare la richiesta di risarcimento, per non creare precedenti anomali, tenuto anche presente che la Repubblica aveva intrapreso quelle ingenti spese per la difesa della città stessa ." <29i _

Il buon inizio, mai come in questo caso, non corrispose affatto alla metà dell'opera, e si rivelò, invece, ben presto l'unica fase rapida della vicenda: occon-eranno infatti 29 anni ed oltre un milione di ducati per completare quella cerchia! Ad ogni modo c irca cinque anni dopo l'avvio, lo stato d'avanzamento dei lavori è così riassunto dalla relazione del: " cap. Lorenzo Donato, fatta davanti al Senato veneto nel dicembre 1565. Il ci rcuit o della fortezza è stabilito nella misura di passi 2944 (mt. 5117). Le mura nuove, rivestite di pietra fino all'altezza del cordone, chiudono tutta la zona compresa tra la porta di S. Alessandro e il baluardo di S. Lorenzo e, verso s ud- ovest, si innalzano a formare l a piattaforma di S. Grata e il bastione di S. Giacomo. In te rrapi e no erano costruiti il bastione e la piattaforma di Sant' Alessandro, la tenaglia di S. Agosti no con la porta, il bastione Belfante e la cort in a che co ntinua fino a S. Andrea. È ancora in funzione la muraglia vecchia fra i bastioni di S. L orenzo e di S. Agostino , fra S. Andrea e S. Giacomo e nei due tratti fra la piattaforma di S. Grata e i bastioni di S. Alessandro e di S. Giacomo .
Le spese sostenute fino a quel momento erano di 216 mila ducati e il Don ado prevedeva che l'opera sa-
rebbe stata completata con altrettanta spesa entro quattro o cinque anni, a condizione che Venezia continuasse a stanziare i fondi in misura sufficiente ..." 130>
In realtà, però , come accennato il dilatarsi abnorme dei tempi di costruzione finì per moltiplicare esponenzialmente i costi. Tredici anni dopo, infatti, mentre la spesa sostenuta ha ormai superato i 370.000 ducati, senza contare i quasi 250.000 impiegati per il soldo della guarnigione, l'ultimazione appariva lontana: appena tre capisaldi principali, fra baluardi e bastioni , dei sedici di progetto sono realmente finiti! Dodici anni dopo, per l'esattezza nel 1590 il capitano Alvise Gromaldi scriveva: " La città è tutta serrata con baluardi e i suoi membri quasi tutti terrapienati , compite le piazze, i parapetti e le traverse per coprirsi dalle vicine co llin e e l a fortezza col circuito di tre miglia è bellissima" < 3 1) Lo stesso relatore osservava però che molto vi era ancora da fare e, soprattutto, che quanto fatto, discutibile sotto il profilo tecnico, aveva comportato un costo esorbitante , a suo dire di circa un milione e mezzo di ducati. La cifra fornita dal Gromaldi per una serie di ragioni, faci lm ente intuibili, non doveva essere lontana dal vero: che dalle casse della Repubblica, poi, fossero usciti fino a quel momento soltanto 522.000, oltre al soldo dei militari sembrava piuttosto confermare l'affermazione che smentirla. A quell'importo infatti occorreva aggiungere l 'enorme va l ore delle contr ibu z ioni in natura, sia come prestazioni di mano d'opera sia come fornitura di materiali, sostenute dai paesi limitrofi. E la conclusione dei lavori non era ancora giunta, tant'è che alla fine del secolo si discuteva in merito alla migliore sistemazione da dare ad alcune sezioni delle fortificazioni Finalmente intorno al 1612: " ... tutte queste opere erano finite ma non risultarono del tutto soddisfacenti, dato che l'anno successivo il provveditore Marco Bragadin, cu i era stato affidato il lavoro, udito i l parere di alcuni esperti , nonostante la dura opposizione dell'ing. L orini, decise di rafforzare il terrapieno c he d ifendeva la s trada, incamiciandolo di pietra e costruendo anche due piazze .. . La strada che aveva una larghezza massi-
ma di 18 pass i ed era c ostata circa 41.000 ducati, venne smantellala da Napoleone ..." m> .
Fu solo intorno agli anni venti del XVII che la gra nd e fonificazione potette considerarsi esaurita, ma ormai anche la sua esigenza strategica era sostanzi,almente esaurita. L' I mpero ottomano non rappresentava più una minaccia imbattibile ed incombente, mentre la ricerca di nuovi equilibr i agitava le potenze europee.
La cerchia di Bergamo. come accennato, contava 16 caposaldi p1imari, fra bastioni, baluardi e piattaforme , raccordati da tratte di cortine per uno sv iluppo complessivo di circa 3 km. Il suo armamento doveva contare su di un centinaio di cannoni, dei quali aoli o 1ruz1 del '600 ne risultavano già posizionati 85. Di questi ben 67 nella so la fo1tezza. 4 nella Rocca e 14 ne lla Cappella. In base aJ calibro, stando ad un pedante inventario dell ' 8 febbraio del I 600 , po sso no così s uddivid ers i:
nella Forrez.-;.u
n° 2 cannoni da I00 Iibbre
n° 4 cannoni da 70 libbre
n° 13 cannoni da 50 libbre
11° 2 cannoni da 30 libbre
n° 2 cannoni ei a 20 libbre
11 ° 4 cannoni eia 14 libbre
11 ° l 2 sag ri da 8 libbre
n" l9 falconi eia 4 libbre
n° 9 falconctti da 2 libbre
nella Ro cca
n° I sagro da 8 libbre
n° I falcone da 4 libbre
n° 2 falconelli eia 2 libbre

nella Cappella
n° I ca nnone da 30 libbre
n° J colubrin a eia 20 libbre
n° I colubrina eia 14 libbre
n° 3 sagri da 8 libbre
n° 3 falconett i da 4 libbre
n° I falcone da 2 libbre
n° 4 petriere da 12 libbre equi valenti·' •33 •.
Quattro po11e assicw-avano l'accesso alla città: di esse tre ad impianto monumentale , S.Agos tino, Sant' Alessandro e S.Giacomo ed una soltanto di più modesto impianto S . Lorenzo.
Oltre a ll e articolazioni architettoniche di s uperficie la cerchia disponeva , al pari delle migliori coeve, di un intricatissimo dedalo di collegamenti ed ambienti sotterranei. La rete se rviva a pone in comunicazione fra loro le diverse sez ioni della fortificazione, nonché alla ottimizzazione del servizio alle batterie casamattate basse, vere caverne artificiali alle quali si accedeva anche da tenebro si cunicoli indipendenti. Non polendo , per ovvi motivi, dilungarci eccessivamenle nella d es cri zio ne dei criteri informatori di tali impianti e delle rispettive configurazioni strutturali, peraltro in ottimo s tato di con se rvazion e, ci limiteremo a precisarne i se mplici dati dimen s ionali rias s untivi dei bastioni. La defini z ione è forse impropria per la loro sistematica se mplificazione dettata dalla morfologia dei luoghi , pur trov an do conferma nelle compartimentazioni sotterranee, ques te senza dubbio canoniche del fronte ba s tionato, che ci consentono uno straordinario commento iconografico di valenza ancora una volta generalizzabi le a tutt e le coeve fortificazioni bastionate.
I Bastione di S. Lorenzo:
È un bastione asimmetrico con un unico fianco rientrante dotato perciò di un altrettanto unico orecchione . Le s ue dimensioni fondamentali sono <.1 -1 ,:
Sviluppo totale del perimetro di cresta ml 196.50
S v iluppo in cresta delle facce Est ml 53.40 O ves t ml 64.20
I NGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI fORTIFICAZlONl lN l TAUA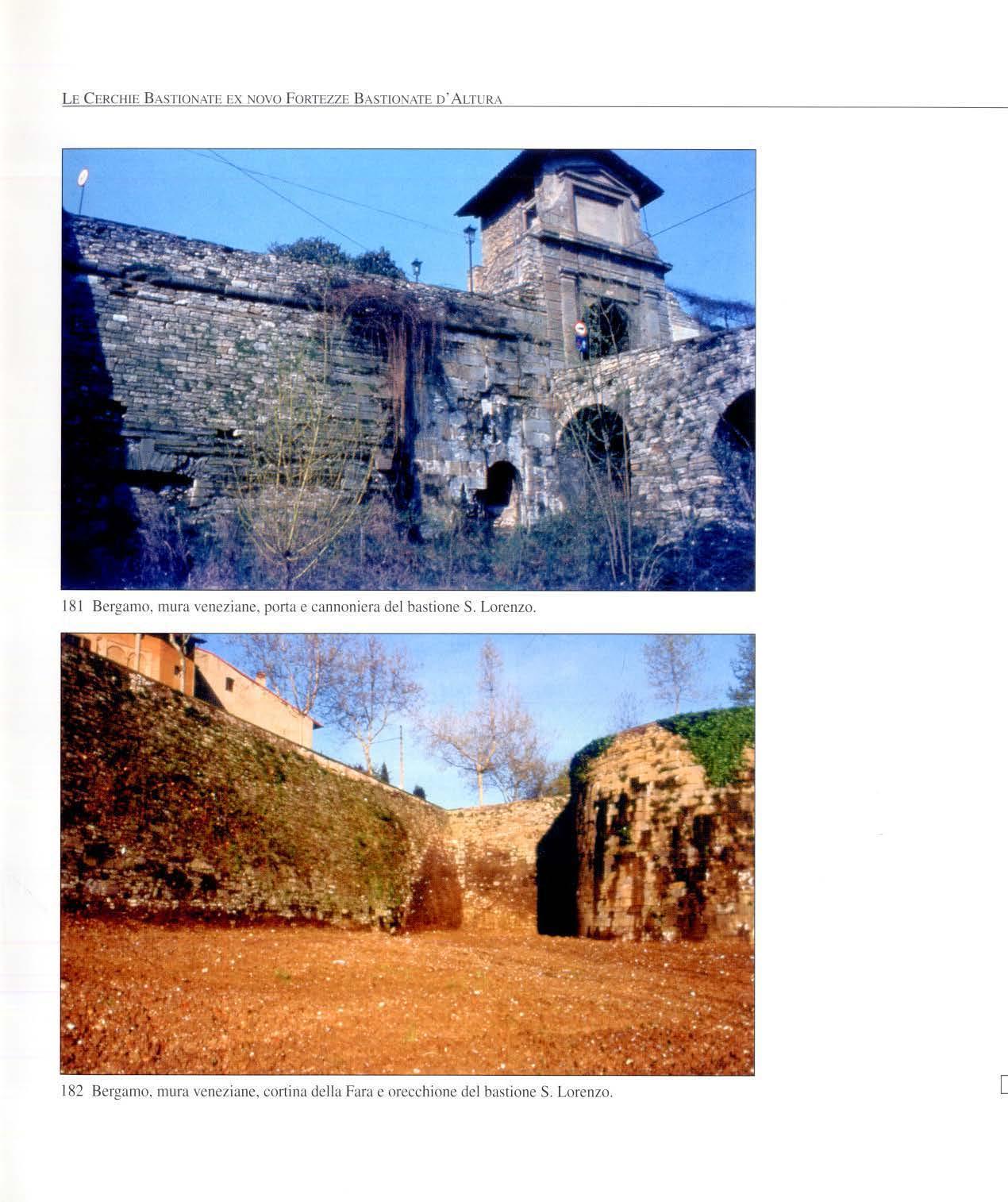
183 Bergamo, mura veneziane , cannoniera e sortita nel bastione S. Lorenzo.
Sviluppo in cresta dei fianchi Est ml 28 Ovest ml 41 .00
Sviluppo in cresta delle cortine laterali Est ml
120.00 + 62.00 Ov ml 91.00 + 56.00 ...
Angolo di spa ll a Ovest 131 ° Est 105 °
Ango l o di gola 14°
Angolo di fiancheggiamento 118 °
È anche questo un bastione asimmetrico dotato di un unico fianco rientrante con relativo orecchione. Le sue dimensioni fondamentali sono:
Sviluppo totale del perimetro di cresta ml 277.40
Sviluppo in cresta delle facce Est ml 128.00 Ovest ml 104.00
Sviluppo in cresta deJJe cortine laterali Est ml 112.00 Ovest ml 120.00+62 ...
Angoli di spalla Est 130°
Angolo di gola l 0° sfalsato
Angolo fiancheggiato 96° ...
Al pari dei precedenti anche questo terzo bastione è fortemente asimmetrico con un unico fianco rientrante sebbene ostenti due orecchioni di cui uno propriamente detto e completo. l'altro, invece, appena accennato e innestato direttamente alla cortina senza retrostante fianco. Queste le sue dimensioni p1incipali:

Sviluppo totale del perimetro di cresta ml 289.50
Sviluppo in cresta delle facce Est ml 5 l .00 Nord ml 149.50
Sviluppo in cresta dei fianchi Est ml 27.50 Nord ml 49.00
Sviluppo in cresta delle cortine laterali Est ml 54.00 Ovest ml 146.00
Angoli di spalla Est 141 ° - Ovest 91 °
Angolo di gola 46 ° sfalsato
Angolo fiancheggiato 86 °
Sempre asimmetrico ma completo in ogni sua parte il bastione di S. Agostino , possiede infatti due fianchi rientranti, di diversa grandezza ma entrambi protetti da orecchioni. Notevolmente diversa anche la lunghezza delle facce . Queste le sue dimensioni princ ipali:
Sviluppo totale del perimetro di cres ta ml 232.00
Sviluppo in cresta delle facce Ovest ml 116.00 Est ml 49.00
Sviluppo in cresta dei fianchi Ovest ml 32.00 Est ml 22.50
 184 B ergamo. mura veneziane , interno della ca nnoniera del S. Lorenzo.
184 B ergamo. mura veneziane , interno della ca nnoniera del S. Lorenzo.

Sviluppo in cresta delle cortine laterali Ovest ml 155.00 Est mJ 54.00
Angoli di spalla Nord 130° Sud 1 I 7 °
Angolo di gola 115 °
Angolo :fiancheggiato 6 1°
Glì ultinù due bastioni costituivano nel l oro insieme la Tenaglia di S. Agostino, situata nel settore nord-est della città. Tr a il bastione di S. Agostino e quello successivo di S. Michele, invece, s i apriva, quasi in posizione assiale la porta di S. Agostino.
Anche questo bastione appare fortemente asimmetrico, con due fianchi dei quali però uno so lo rientrante protetto da un orecchione. Molto diversa l a lunghezza del le facce. Queste le sue dimensioni principali:
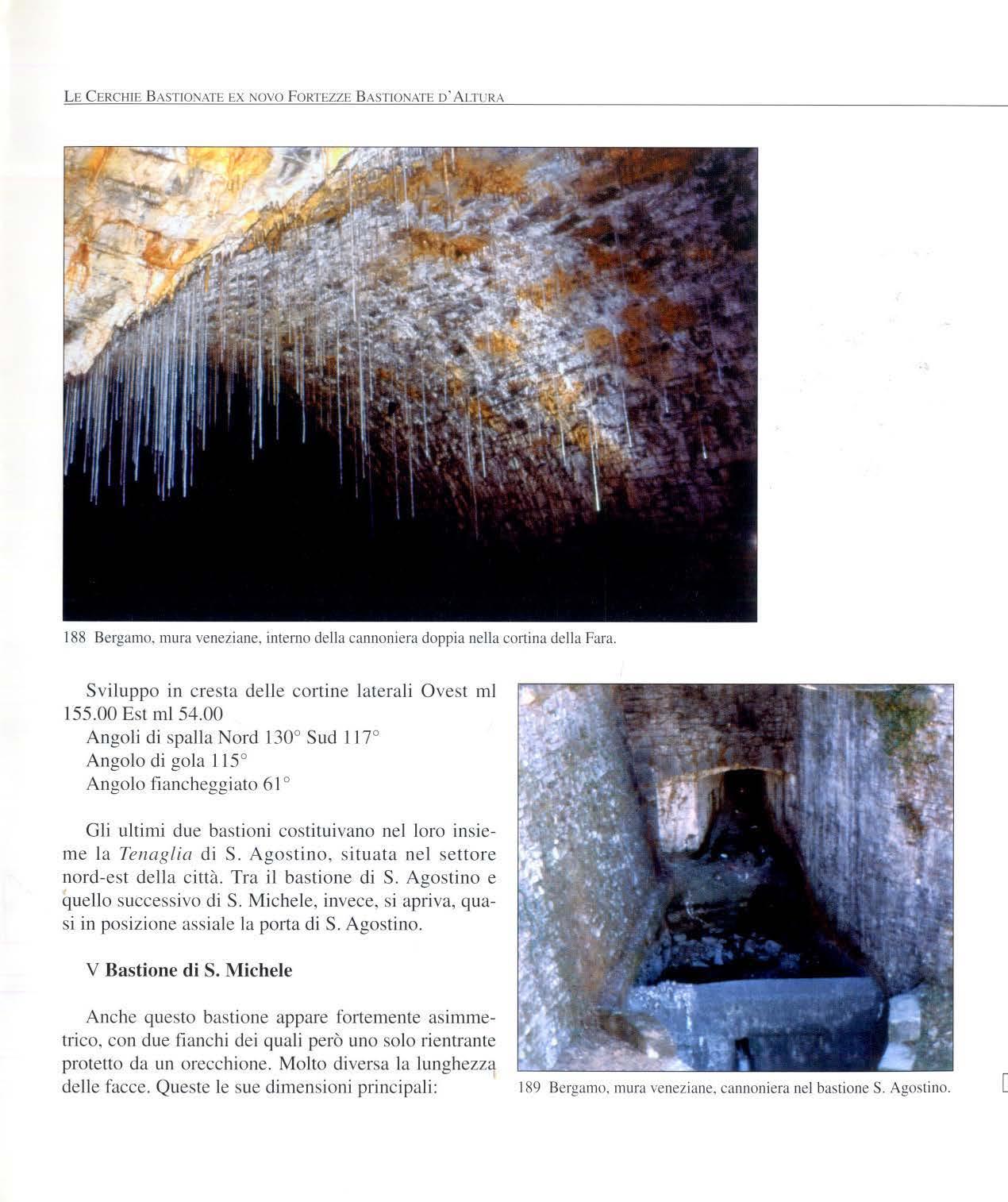
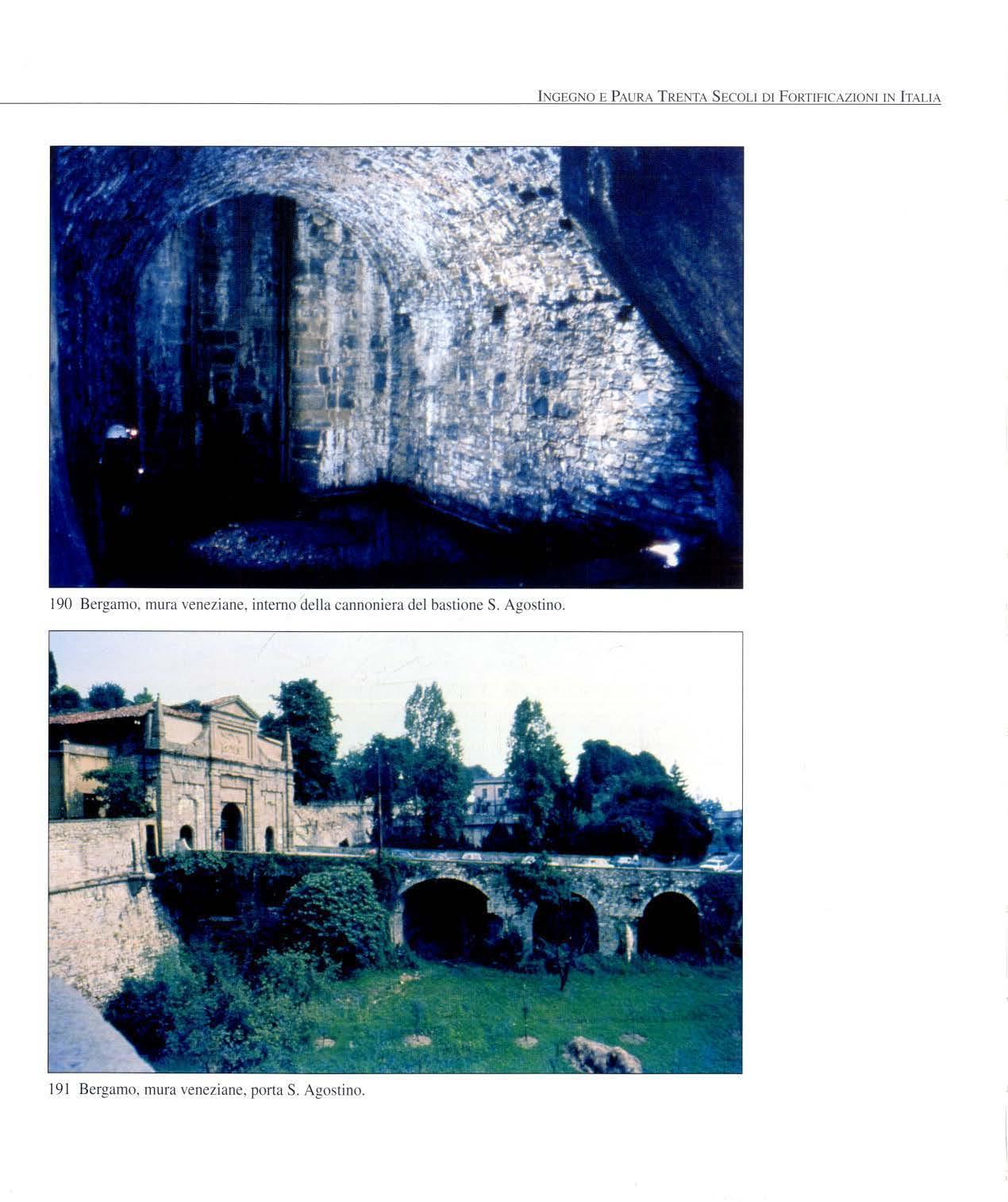
Sviluppo tota le del pelimetro di cresta ml 227 .70
Svi lup po in cresta de ll e facce O vest ml 103.50 Est ml 66.00
Sviluppo in cresta dei fianchi O vest ml 26 .20 Est ml 28.00
Sviluppo in cresta delle cor tin e laterali O vest ml 246.5 0 Est ml 155.00
Angoli di s palla Es t 1 I0 ° - O vest l 02 °
Angolo di gola 133 °
Angolo fiancheggiato 97 °
Quando lo spigolo di un ba s tione toccava i 180° la s ua configura z ion e div e ni va quella di un corpo aggettante rett a ngolare d ai cui due fianchi paralleli era po ss ibile fiancheggiare le contigue cortine. Un a disposizione del ge nere poteva adottarsi quando d i fettava lo s pazio per un ba s tione pentagonale pur avendosi la necessità di interrompere la cortina altrimenti troppo lunga. Nel caso in qu es t ione queste le dimen s ioni fondamentali:
Sviluppo totale del perimetro di cresta mJ 291.50
Sviluppo in cresta delle facce Oves t ml 117 .50 Esl ml 119.00
Sviluppo in cresta dei fianchi O vest ml 24.40 Est ml 23.00
Sviluppo in cresta delle cortine l aterali O ves t m I 148.00 Es t ml 249.00 ...
Angoli di s palla Est 100° - O ves t 120°
Angolo di gola 152 °
An go lo fianche gg iato 178 °
Tra l a piattaforma cli S. Andrea ed il Bas tione di S. Giacomo si apriva l a porta di S. Gi aco mo , p::u-zialmente demolita pe r ragioni di via bilità.
Esattamente come tutti i precedenti anche il bastione di S. Gi acomo è asi mm e tric o . Dotato di due fianc hi , ne ss un o dei quali rientrante , non di s poneva per conseguenza di alc un orecch ione cli protezione. Queste le sue dimensioni fondamenta] i:

Sviluppo tota le del pe rimetro di cresta ml 232.70
Sviluppo in cresta d e lle facce Nord ml 124.80 Est ml 6 1.60
Sv ilu ppo in cresta dei fianchi Nord ml 27 .80 Sud m l 148.00
Angoli di spall a Nord 102° Est 94 °
Angolo di gola 97 °
Angolo :fiancheggiato 7 1°

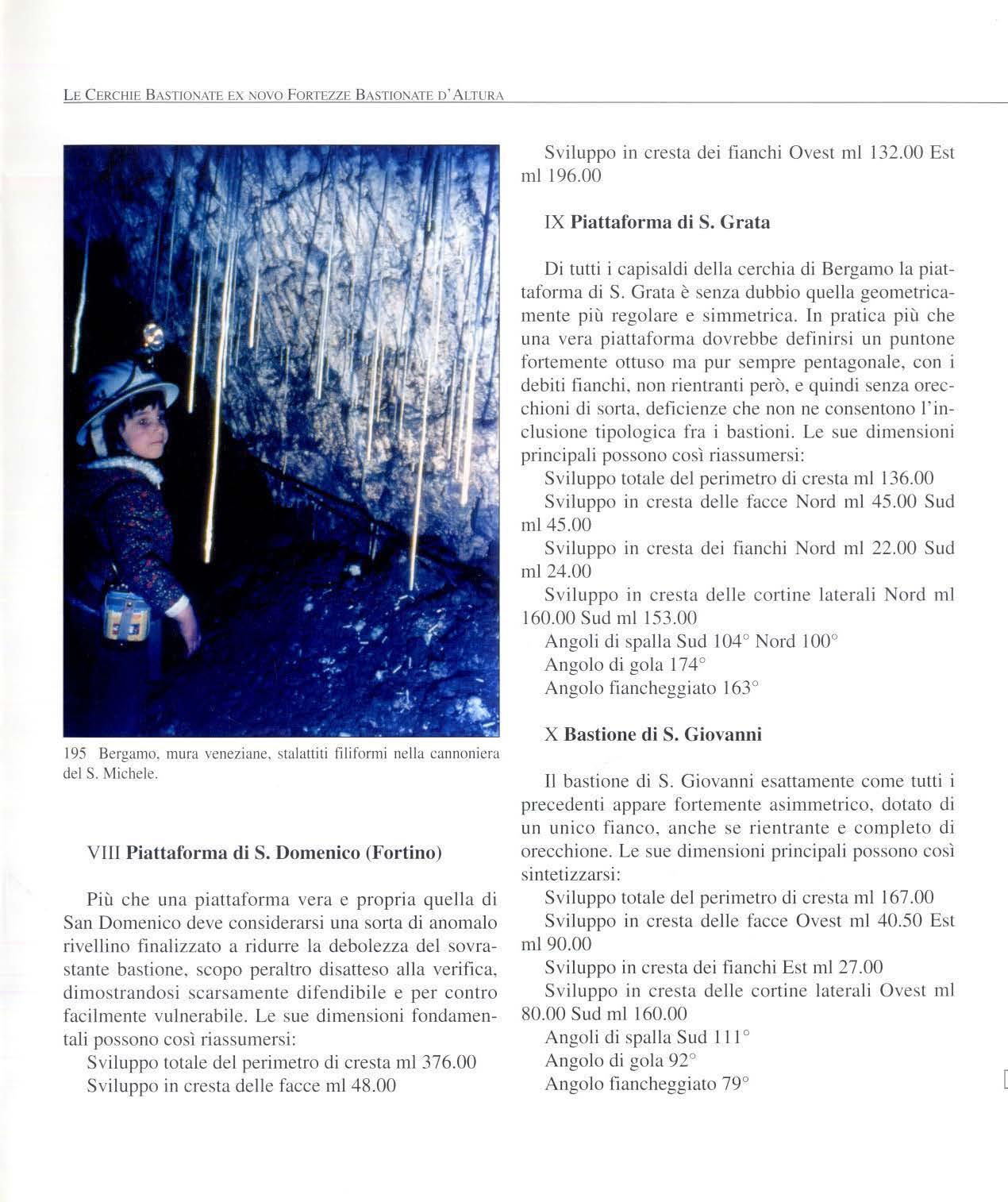
Più che una piattaforma vera e propria quella di San Domenico deve co n siderar si una so rt a di anoma lo rivellino finalizzato a ridutTe la debolezza del sovrastante bastione. scopo peraltro disatteso a ll a verifi ca , dimostrando s i scarsamente difendibi l e e per contro facilmente vulnerabi le . Le s ue dimensioni fondamentali possono così riassumersi:
Sv ilupp o totale de l perimetro di cresta ml 376.00
Svi lup po in cresta delle facce ml 48 .00
Sviluppo in cresta dei fianchi Ovest ml 132.00 E s t ml 196.00
Di tutti i capisaldi della cerch ia di Bergamo la piattaforma di S. Grata è senza dubbio quella geometricamente più regolare e simmetrica. In prati ca più che una vera piattaforma dovrebbe definirsi un pun t one fortemente ottuso ma pur sempre pentagonale , con i debiti fianchi, non rientranti però, e quindi senza orecc hi oni di so rt a, deficienze c h e non ne consento n o l ' inclusione tipologica fra i bastioni. Le sue dimensioni principali possono così riassumers i:
Svil upp o totale del perimetro d i cresta ml 136.00
Sviluppo in cresta delle facce Nord ml 45.00 Sud m145.00
Sviluppo in cres t a dei fianchi Nord ml 22 .00 Sud rnl 24 .00
Sviluppo in cresta delle cortine laterali Nord ml 160 .00 Sud ml I 53.00
Angoli di spalla Sud 104° Nord 100°
A n golo di gola 174°
Angolo fiancheggiato 163 °
X Bas ti one d i S . G iova nn i
Il bastione di S. Giovanni esattamente co m e tutti i precedenti appare fortemente asimmetrico. dotato di un unico fianco, anche se rientrant e e completo di orecch i one. Le sue dimen s ioni principali possono così si nt et i zzarsi:
Sviluppo totale del perimetro di c res ta ml I 67 .00
S viluppo in cresta delle facce Ov est ml 40 .50 Es t ml 90.00
Sviluppo in cresta dei fianchi Est ml 27.00
Sviluppo in cresta delle cortine laterali Ovest ml 80.00 Sud ml 160.00
Angoli di spalla Sud I 11 °
Angolo di gola 92°
Angolo fiancheggiato 79°
In origine doveva ostentare una sia pur approssimata simmetria che in epoca recente però ha per so irreversibilmente per l'attraversamento del viale delle Mura. Dal punto di vista architettonico doveva trattarsi piuttosto che di un bastione propriamente detto di un'altra piattaforma , sebbene munita di fianchi rientranti con orecchioni. Le sue dimensioni fondamentali possono così riassumersi:
Sviluppo totale del perimetro in cresta ml 150.20
Sviluppo in cresta delle facce ml 80.20
Sviluppo in cresta dei fianchi Nord ml 35.00 Sud ml 21.00
Sviluppo in cresta delle cortine laterali Nord ml 50.40 Sud ml 80.00
Immediatamente dopo il bastione di S. Alessandro si apre l'omonima porta, colJocata in posizione assiale nella cortina compresa fra il suddetto bastione ed il successivo di S. Gottardo. Quest ' ultimo faceva parte di un insieme di bastioni e di cortine che pur dipanandosi sempre lungo la medesima cerchia essendo parte integrante del suo perimetro , venivano correntemente definiti Forte di San Marco. Il che deve attribuirsi alla loro maggiore autonomia difensiva che li faceva assurgere quasi al ruolo di una sorta di cittadella. Come facilmente intuibile la causa di tale distinzione deve attribuirsi ad una preminenza morfologica che finiva per rendere quella struttura non solo esternamente più impervia ed inaccessibile ma incombente sulla città in maniera dominante, appunto come una cittadella. In dettaglio i cap isaldi che lo costituivano possono schematicamente ridursi a sei bastioni tutti, come precipuo della cerchia bergamasca asimmetrici ed irregolari. Partendo da quello di S. Alessandro il primo del fo11e è in realtà il:
Si tratta di un ennesimo bastione asimmetrico, irregolare ed incompleto. Dispone infatti di un solo
fianco, sia pur rientrante e munito di orecchione. Quanto alle facce notevole è la loro diversità di lunghezza. Nel fianco rientrato si scorgo no due bocche cannoniere collegate ad appositi ripari per i pezzi. In pratica quelle strane costruzioni possono definirsi: " ... case cannoniere ... [cioè] due ampi locali aventi la copertura a botte; essi sono chiusi su tre lati mentre il quarto è interamente aperto; Ja loro funzione era quella di permettere il ricovero dei pezzi impedendo che rimanessero esposti alle intemperie, il che avrebbe danneggiato gli affusti; immediata inoltre doveva risultare la collocazione dei medesimi in posizione di tiro e ciò doveva realizzarsi con ordine e celerità ..." <35 >
Anche in questo caso un unico fianco rientrato dietro un grosso orecchione ed una forte sproporzione fra le due facce. Una singolare novità si coglie sullo spigolo dello stesso, rappresentata dalla presenza di una garitta: non si trattava però all'epoca dell ' unica dell'intera cerchia ma è invece soltanto l'unica ad essere scampata alle successive demolizioni. II piccolo sporto, peraltro abbastanza frequente nel fronte bast ionato, veniva ammorzato proprio sugli spigoli per consentirne una migliore ispezione avanzata.
D ue facce, un unico fianco non rientrante nessun orecchione. Mai come in questo caso la precipua connotazione del caposaldo è quella sotterranea. 1nfatti di: " notevole complessità le parti interne del baluardo; non tanto ... la cannoniera che ripropone, per quanto riguarda la disposizione generale delle sue parti, la solita successione dei due spazi: la piazza e la casa , ma l'ampia strada coperta, proveniente dalla piazza S. Marco, che sfocia a l centro del lato sud della casa cannoniera e da qui prosegue ad est con un lungo tratto piegando, infine lievemente verso nord fino ad immettersi in una casamatta. Questo ampio edificio ha forn1a
 INGEGNO E PAURA TRENTA S ECOLI DI FORTIFICAZIONI IN I TALIA
INGEGNO E PAURA TRENTA S ECOLI DI FORTIFICAZIONI IN I TALIA
rettangolare ed è coperto da una grande volta a botte. Si dispone parallelamente alla faccia ovest del baluardo ad una quota che dovrebbe corrispondere alla parte inferiore della scarpa..." (36 J.
Si tratta di una sorta di perfetto semibastione, tranciato lungo il suo asse di simmetria verticale. Completo pertanto il lato destro con fianco rientrante, orecchione e relative cannoniere. Inesistente del tutto quello sinistro, ridotto in pratica ad una cortina sostanzialmente rettilinea.
Anche questo bastione al pari di quello di S. Gottardo fu in realtà una piattaforma, peraltro anche in origine abbastanza irregolare dal punto di vista geometrico. Disponeva infatti di un unico fianco 1ientrante, quello destro, con relativo orecchione, di tipo quadro, propriamente detto musone. Dall'altra parte invece si innestava tramite un settore curvilineo alla cortina. Tale connotazione fu ulteriormente stravolta nel 1908, allorquando prop1io il fianco sinistro ed un terzo almeno dell ' antistante faccia vennero demoliti per consentire il passaggio di una strada e la costruzione di una nuova scuola. Due cannoniere si aprivano nel fianco suddetto, mentre ben tre costituivano l'armamento del fianco curvilineo.
Sebbene il nome sia pur sempre quello di bastione, in effetti mai come in questo caso la configurazione geometrica del caposaldo appare lontanissima dalle prescrizioni canoniche. Significativamente: " non regge il confronto con nessun altro del forte. È privo di postazioni cannoniere ... Mancano la piazza e le uscite di sortita; il muro si riduce poi alla semplice scarpa. Presente e ben identificabile è invece la fossa che cinge sia il lato nord che quello est..." n 1 1 •
Da quanto sinteticamente esposto e merge con a ss oluta chiarezza la fin troppo irregolare conformazione dei bastioni della cerchia di Bergamo, talmente anomali ed approssimati da riuscire difficile , come accennato, ritenerli persi no tal i. Tanta soggettività non deve però semplicisticamente ascriversi all ' imperizia dei progettisti ma soltanto agli stringenti condizionamenti ambientali. Per cui, in definitiva, l'intera opera conferma, se mai ve ne fosse la nece ss ità. che una fortificazione bastionata anche quando eretta ex novo sulla somnùtà di un'altura finiva inevitabilmente per perdere la sua precipua regolarità e con essa la sua valen z a interdittiva ottimale. Parlare perciò di fronte bastionato d ' altura o apicale implicitamente equivaleva ad un'opera adattata, frutto di un compromesso e pertanto inevitabilmente secondaria, avallando ulteriormente la stretta corrispondenza tra opere del gen e re e d ubicazione pianeggiante. Ma una simile condi z ione oltre a dimostrarsi al linùte dell'as tratto ideale, la sciava immaginare motivatamente oneri immensi essendo il suo sviluppo planimetrico e, per conseguenza. perimetrico rilevantissimo. Il che finiva per obbligare ad un numero di bastioni, perfettamente configurati, altrettanto rilevante. Impossibile infatti limitarli non potendosi ampliare il loro interasse al di sopra di un preciso valore , alquanto inferiore alla gittata efficace delle artiglierie del fiancheggiamento , ed impossibile pure contenerne la mole a sua volta direttamente proporzionale all'interasse.
Quanto detto spiega a sufficienza il perché della estrema inconsistenza di città con cerchie bastionate perfettamente isotrope, soluzione che ebbe una maggiore applicabilità nelle cittadelle. Queste , infatti , recingendo spazi di gran lunga più modesti di una sia pur piccola città richiedevano un perimetro estremamente contenuto , per il quale bastavano perciò pochi bastioni, difficilmente eccedenti la mezza dozzina.
Ciò premesso uno straordinario esempio di cerchia urbica bastionata perfettamente isotropa e geometricamente regolarissima è quella che circonda Palmanova. Prima però di rievocarne le connotazioni salienti è

preferibile fornire una a ltre ttanto sintetica descrizione della tipologia mino re, quella delle cittade ll e bastionate rego l ari. delle quali uno de i più significativi esempi fu senza dubbio quella di Messina, contro la quale s i cimentò, su l finire de ll 'i n verno del 1861 , il neonato Esercito It aliano.
La seco nd a metà del XVll seco lo fu caratterizzata in Sicilia dal ripropo rsi di annate agrarie magre al Limite della car estia, in un ambito economico già d i per sé avaro. La situazione nei maggiori centri abitati dell 'Isola, il cui fabbisogno alimenta re dipendeva per lo più dalle impo,tazioni via mare, primo fra tutti Messina, appar i va ancora più grave ed allarmante. Gli esped ie nti tentati dalla dirigenza della città per allevia re la crisi lungi dal risolverla l'aggravarono u lt eriormente, inne scan do n ella sua popolazione un c li ma di into ll eranza e d i sfiducia dapprima nei confronti di M adrid quindi de ll a stessa P a l ermo. In altri tennini si riproponeva la sugges ti o ne endemica di indipenden za dall'Impero e di autonomia dal R egno. La crescente debolezza politica dei viceré s pagnoli , oberali da d iffico l tà eco nomico-milita ri immense, parve q uasi avalla re la percezione del momento idea l e per rivendicare a lla città un a maggiore a ut onomia da ottenersi con ogni mezzo. T disord ini , pertanto, da sporadici iniziarono a d int ensifica rsi trasform a nd osi se mpre più frequentemente in apert e rib e lli oni, che a loro vo lta contagiaro n o progress ivamente altre cittadi ne sic ili ane. Si g iun se così al 1674 , a ll orqua nd o in M essina si azzuffarono violenteme nt e le due fazioni che nel frattempo s i erano in qualche modo o rganizzate, fede le a ll a Spagna la prima, osti1e la seconda. Cia sc una di esse tendeva a prevalere sull'altra, premessa indispensabile per decidere l a sorte dell'intera città. U
vice r é d el momento, Francesco Ba zan de Bonavid marchese di Bajon a c,si. vo lendo domare con la forza l a fratricida co nte sa diresse verso la c ittà. Non riuscendovi, però , in alcun modo ad entrare, per l a furia dei 1ivoltosi si vide invece costretto a ,iparare senza indu g i n e1 castello di Mi lazzo. Dando prova di inus itata moderazione, da quella piazza promulgò nei giorni s ucce ss ivi una se rie di indulti nel disperato tentativo di placare gli animi. Purtroppo , ma gari motivatam ente, quel suo prodigarsi venne scambiato per palese debolezza. incrementando l'intolleranza. Il Gran Consiglio cli Me ss ina , dal canLo s uo , ratificò una risolu z ione che ripudiando la sovra nità spagno la aus picava que ll a francese. collocando in tal modo la città al!' interno dell'ennesimo acuirsi dei rapporti tra le due superpotenze d e ll' epoca, assurgendo così a fattore di destabi li zzazione per l'intera regione.
La situazione che di lì a breve si manifestò in Messina per molti aspetti appare paradossale, estrema conseg uen za del la concezione dualistica delle fo1tificazioni urban e spagno le. La g uarni gione imp e rial e, infatti, si rinchiu se nei vari forti della c ittà mentre i rivoltosi a loro volta s i impadronirono dei suoi bastioni! Dopo una irreal e calma tra le due parti l'unico rapporto divenne esclusivamente balistico, ritrovandosi da entrambi i fronti un di sc reto num ero di can noni ed una abbon d ante riserva d i munizioni '391 • Trascorse così l ' es tate ed esau rit esi le scorte. le forze spagnole, un forte dopo l'a lt ro, si arresero, mentre una cintura di s icure zza si chiudeva intorno a i 1ibe ll i, convergendo nell'I so la le truppe tratte da Milano, dal regno di Napoli, di Sardegna e pe rsino dalla Corsica e d all'A lbania.
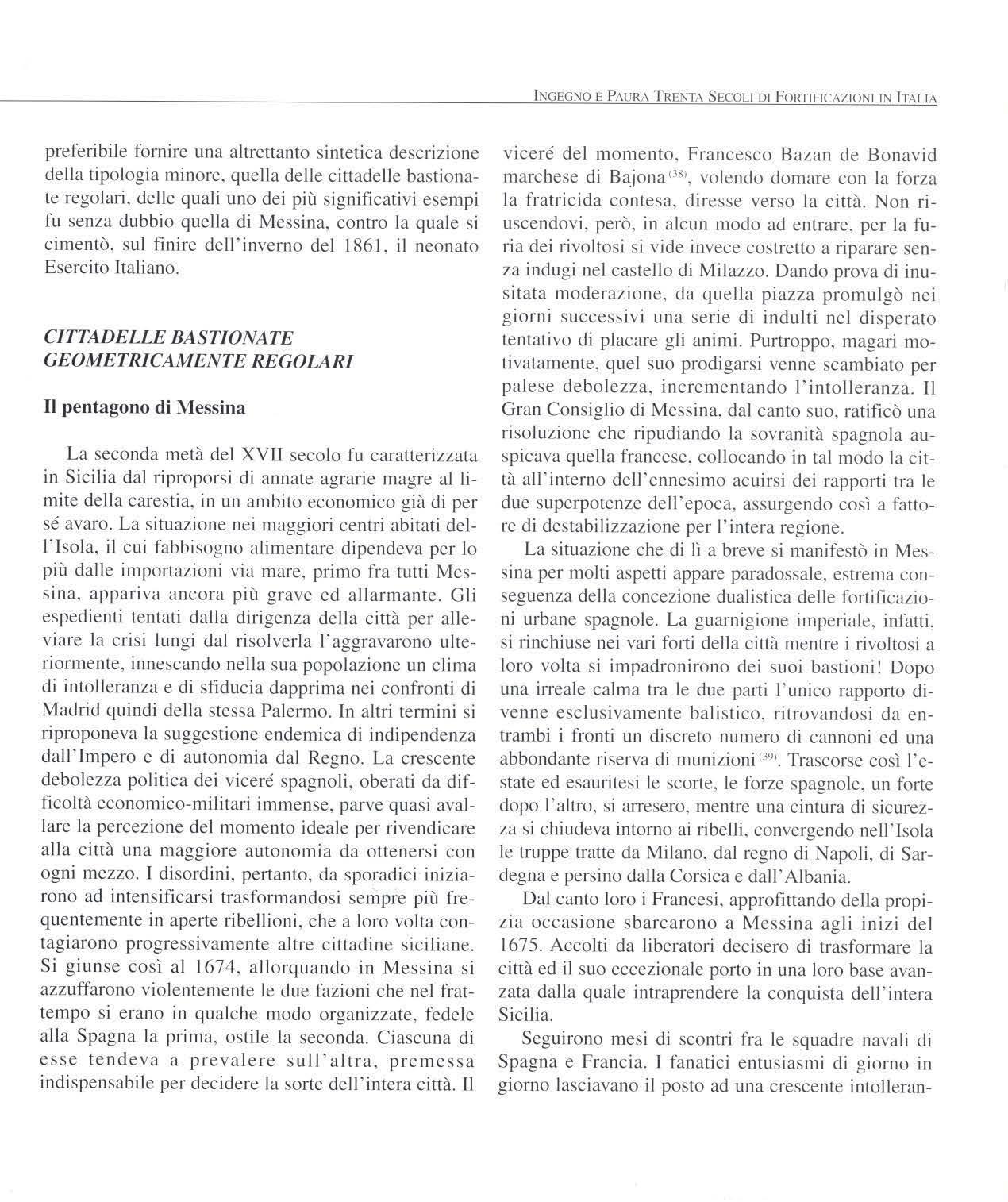
D al canto l o ro i Franc esi. approfittando della propizia occas ion e sba r carono a Mes s ina ag li inizi del 1675. Accolti da liberatori decisero di trasform are la c itt à ed il suo eccezio n ale porto in una loro base avanzata dalla qual e intraprend ere la co nq uista dell 'i ntera Sicilia.
Segui rono mesi di scontri fra le sq uadre nava li di Spagna e Francia. 1 fanatici entusiasmi di giorno in giorn o lasciavano il po sto ad una crescente intolleran-
I NGEGNO I:: PA URA TR ENTA SECOLI DI FORTlrtCAZIONI IN TTAI.IAza verso i nuovi venuti. Ad onta dell'arroganza, le truppe sbarcate non erano Iiuscite ad estendere oltre Augusta l'enclave controllata. L'i1Tilevanza dell'impresa e le Iibellioni sempre più frequenti indussero i Francesi ad abbandonare l'Isola sul finire del 1677. seguiti nella 1itirata da oltre 30.000 messinesi troppo compromessi con l'illegale regime per non temere vendette popolari ed epurazioni governative. Partite le truppe la città proclamò immediatamente la sua piena sottomissione all'Impero, professione di fede che non valse a scongiurare le prevedibili reazioni, che si abbatterono infatti pochi giorni dopo.
Una serie di provvedi menti specifici vennero promulgati nella circostanza contro la città, reputata morta civilmente e incapace di qualsiasi comportamento onorevole ,-1o, . Di tutti, quello senza dubbio più vessa-
torio concerneva la co s truzione a spese del la stessa di una possente cittadella destinata in futuro a tenere a freno i facinorosi. Sito prescelto il promontorio falcato di S. Ranieri , capace di controllare al contempo l'abitato ed il porto, pur restando facilmente i s olabile dall'uno e dall'altro.
11 progetto fu affidato ad uno dei migliori tecnici del momento l'ingegnere de Grunemberg che così lo relazionò: " La cittadella prospettata sul braccio di S. Ranieri trova quali sue giustificazioni le seguenti: tenere ininterrottamente sotto controllo difensivo l ' accesso alla Città ed al contempo dominare il suo porto, allontanandosi al massimo dalle colline retrostanti e dalle case. nonché per es sere in grado di presidiarla, in periodi privi di minaccia nemica, con pochissimj uomini, evitando qualsiasi scambio o contatto per qua-
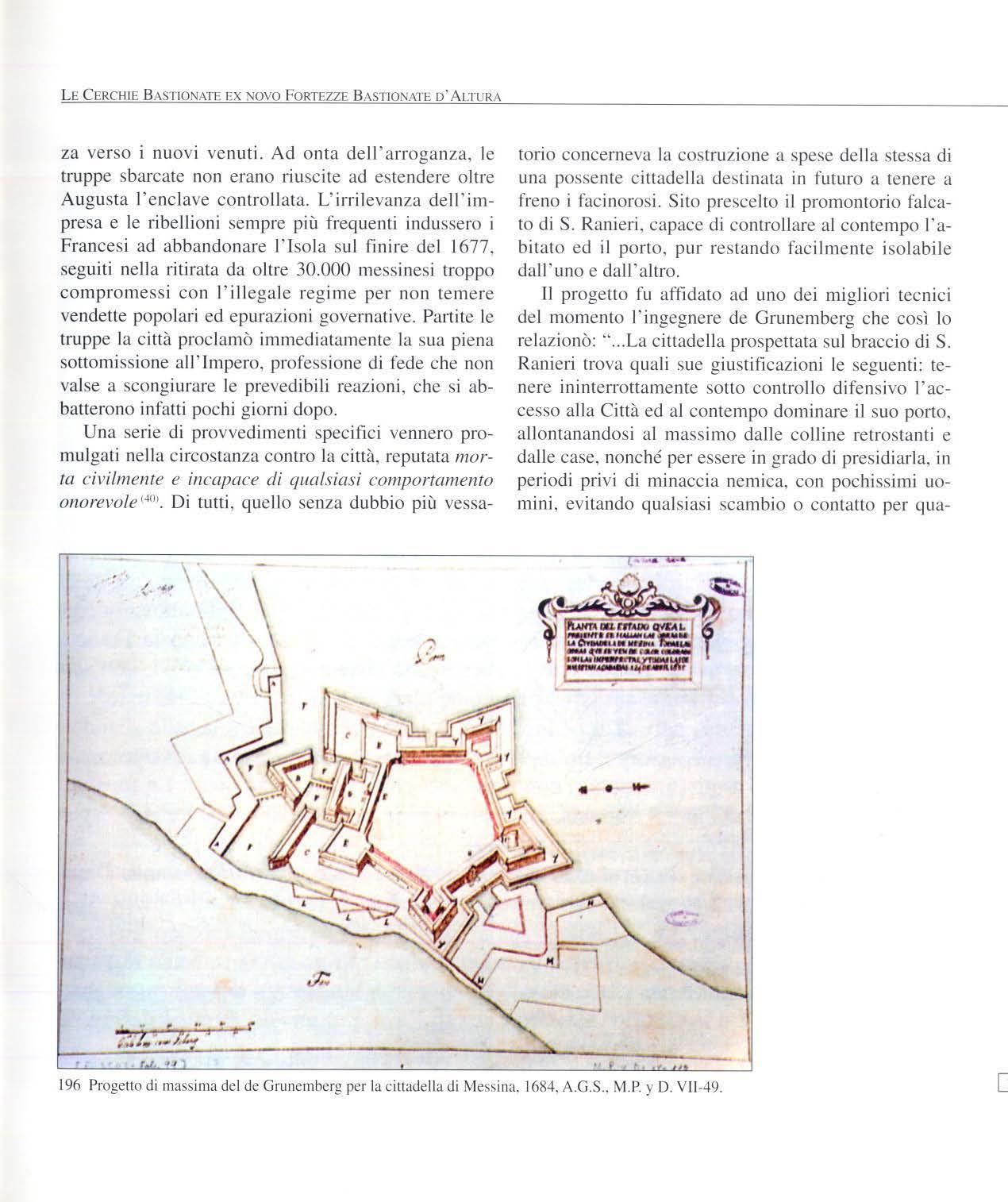
I97 D. Speck le , rilievo e studio geomeLrico delle proporzioni della cittadella di Anversa. 1589.
lunque ragione tra i soldati ed i cittadini, servendo pertanto in definitiva da freno " <~1>
Con straordinaria solerzia il de Grunemberg completò il suo progetto nel giro di pochi mesi ed i lavori avviati nel l 680, vennero condotti avanti con notevole rapidità. In linea di massima la cittadella si componeva di un recinto pentagonale, di perfetta defini-
zione geometrica, con ai vertici altrettanti bastioni altrettanto geometricamente regolari e perfettamente canonici. Un ampio fossato cingeva completamente la fortificazione , debitamente controscarpato e munito all ' esterno di tutte le opere accessorie che via via si erano andate elaborato nel corso dell'ultimo secolo , articolandosi in rivellini , lunette , cavalieri , guardie, frecce, ecc. secondo un repertorio vastissimo e suddiviso tipologicamente 142 > Unica ad ogni modo la risultante: una struttura di straordinaria valenza dissuasiva s ia verso l'esterno che verso 1' interno. Pochi decenni dopo la sovranità spagnola sul regno di Sicilia si dissolse e lo stesso dopo un periodo di incertezza dinastica finì assegnato a Carlo di Borbone. I suoi discendenti agli inizi del XIX secolo riuscirono a riunificarlo anche istituzionalmente con il regno di Napoli, riesumando l'antico stato normanno delle Due Sicilie. Tante novità non attenuarono le rilevanza della cittadella di Messina che continuò a rappresentare i I caposaldo per antonomasia dell ' intera Isola. E non a caso fu proprio quello che , conclusasi , dopo un'epico assedio l'epopea di Gaeta, insieme a Civitella del Tronto continuò ad issare il vessillo borbonico. Per la verità i 4.000 soldati napoletani che resistevano alla fine di febbraio al suo interno agli ordini di 152 ufficiali comandati dal generale Pergola, vi stavano asserragliati già da oltre otto mesi, in una sorta di assedio dimenticato. La caduta della prima piazza del Regno e l'esilio del re valse a concentrare sugli stessi l ' attenzione e l'investimento. Dimostratisi vani tutti i tentativi espletati dal governo italiano per evitare un inutile spargimento di sangue, il generale Cialdini avviò il bombardamento della cittadella intorno al 14 febbraio. Nonostante la superiorità delle artiglierie degli assedianti la cittadella resistette quasi un altro mese ancora. li 13 marzo quando le reazione balistica non poteva più effettuarsi neppure a livello simbolico il pentagono di Messina alle ore 7 capitolò.
Pochi anni dopo quella splendida fortificazione fu radicalmente ablasa !

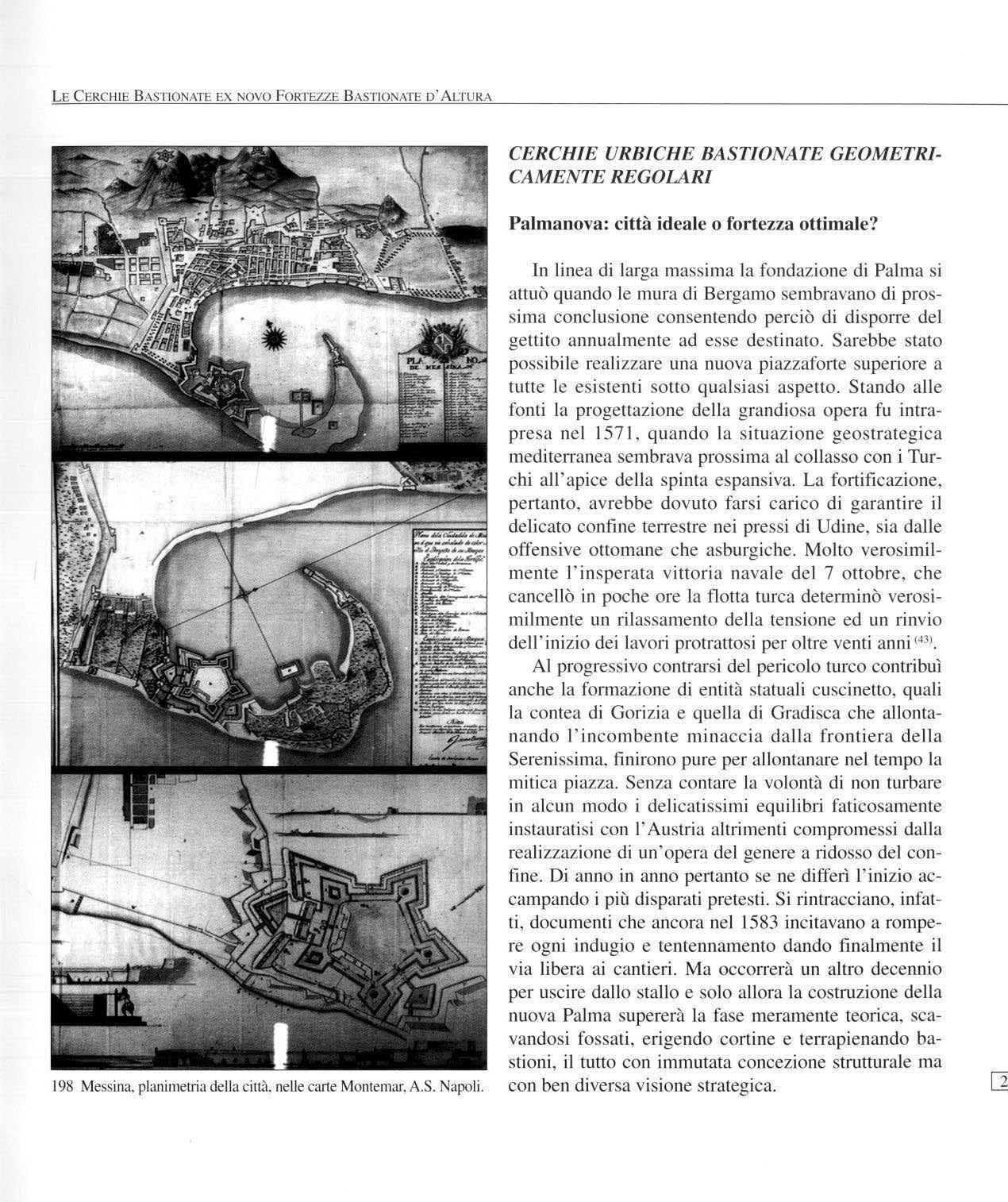
Palmanova: città ideale o fortezza ottimale?
In linea di larga ma ssi ma la fondazione di Palma si attuò quando le mura di Bergamo sembravano di prossi ma conclusione co nsentendo perciò di disporre del gettito annualmente ad esse destinato. Sarebbe stato possibile realizzare una nuova piazzaforte superiore a tutte le esistenti sotto qualsiasi aspetto. Stando alle fonti la progettazione della grandiosa opera fu intrapresa nel 1571, quando l a situazione geostrategica mediterranea sembrava prossima al collasso con i Turchi all'apice della spinta espa nsiva . La fortificazione , pertanto , avrebbe dovuto farsi carico di garantire il delicato confine terrestre nei pressi di Udine , sia dalle offensive ottomane che asburgiche . Molto verosimilmente l ' in s perata vittoria navale del 7 ottobre, che cancellò in poche ore la flotta turca determinò verosimilmente un 1ilassa mento della ten s ione ed un rinvio del!' inizio dei lavori protrattosi per oltre vent i an ni l43J _
Al progressivo contrarsi del pericolo turco cont1ibuì anche la formazione di ent ità statuali cuscinetto, quali la co ntea di Gorizia e quella di Gradisca che allontanando l'incombente minaccia dalla frontiera della Serenissima, fin irono pure per allontanare nel tempo la mitica piazza. Senza contare la volontà di non turbare in alcun modo i delicatissimi equilibri faticosamente instauratisi con l ' Austria altrimenti compro messi dalla realizzazione di un'opera del genere a ridosso del confine. Di anno in anno pertanto se ne differì l ' inizio accampan d o i più disparat i pretesti. Si rintra cc iano, infatti, documenti che ancora nel 1583 incitavano a rompere ogni indugio e tentennamento dando finalmente il via libera ai cantieri . Ma occorrerà un altro decennio per uscire dallo stallo e solo allora la costrnzione della nuova Palm a supererà la fase meramente teorica, scavandosi fossati, erigendo co rtine e terrapienando bast ioni, il tutto co n immutata concezione s truttural e ma
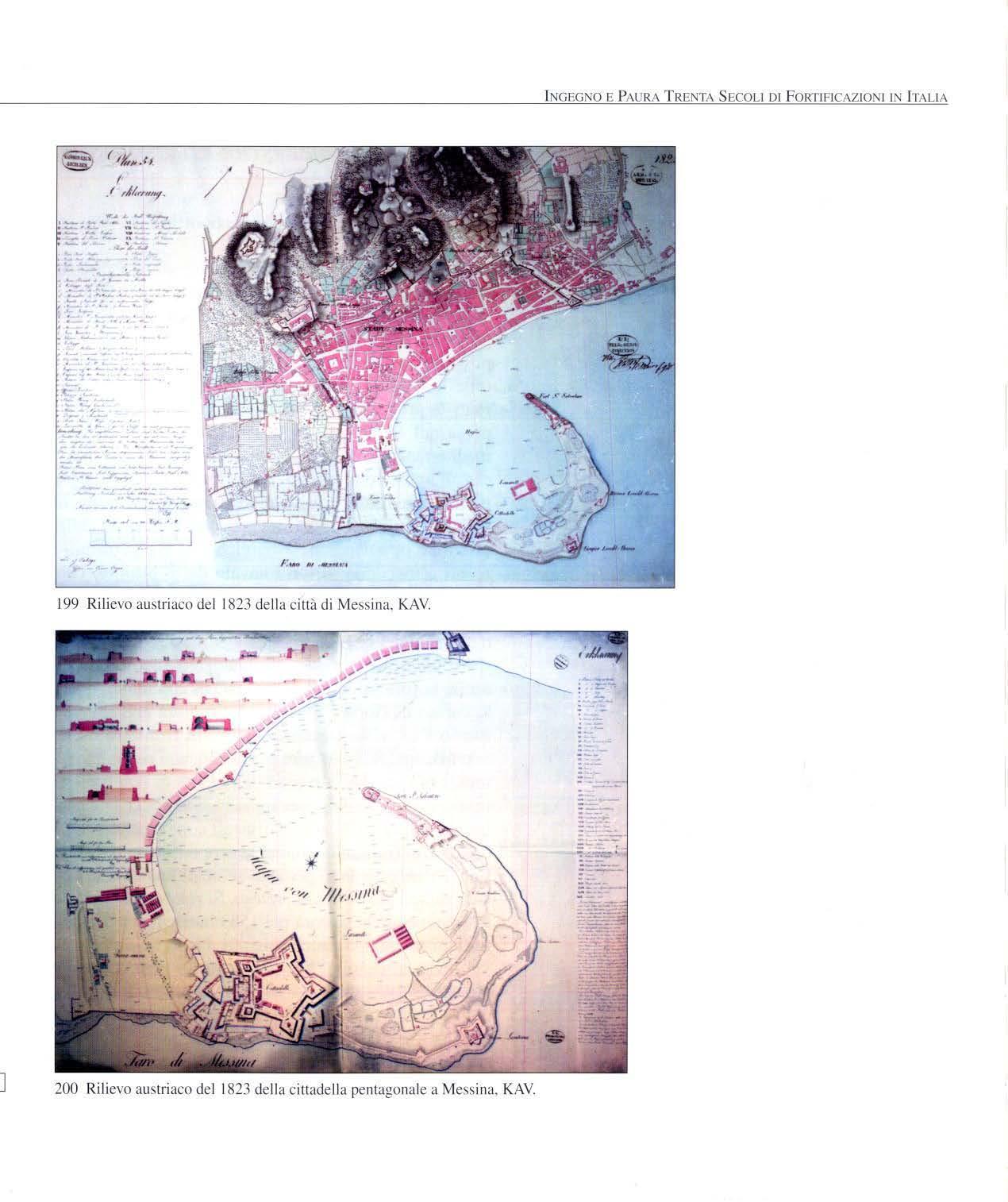
Dal punto di vista architettonico l'erigenda piazza a differenza delle precedenti non avrebbe dovuto subire alcun condizionamento né di tipo politico né meno che mai ambientale: non sarebbe stata cioè destinata a tenere a freno riottosi sudditi né s i sarebbe dipan ata su cigli collinari adattandosi ad un abitato medievale. Sarebbe invece scaturita da una progettazione scevra da ogni compromesso, materializzando in tal modo la tanto ricercata isotropia difensiva, conseguenza di un impianto regolare , e la ancora più decantata città ideale. In altri termini una città perfetta dife s a da una cerchia bastionata perfetta 144 >
Un cri s tallo di ghiaccio il cui nucleo di condensazione s arebbe stata una piazza baricentrica e s a g onale ed il perimetro a nove cortine da 230 m di l a to cias cuna per uno sviluppo comples s ivo di 1440. il tutto s candito da nove ba s tioni impiantati in o g ni v ertic e, anch ' essi di assoluta regolarità geometric a 1 51
In pratica: " ... dal 1593. data di fondazione. a quasi tutto il I 600 , la fortezza e la città prendono forma . quella forma che è aITivata fino a noi , che fu deci sa in gran parte sul posto, non appena i tecnici presero diretto contatto con il sito interessato e che fu variata , corretta e smussata, anche a co s to di vibrate protes te presso il Doge, fino a quando non ne fu considerata l'aderenza fra modello militare e modello civile " 140i
In realtà sebbene di improbo accertamento anch e In fortezza di Palma la Nuova al pari di tutte le altre ebbe i s uoi progettisti. Paradossalmente a differen za d e lle tante elucubrazioni su ll a città ideale , ne s suna dell e quali peraltro mai edificata e nota soltanto per la rinom a n za più o meno ampia del propos itore, nella concreta fatti -
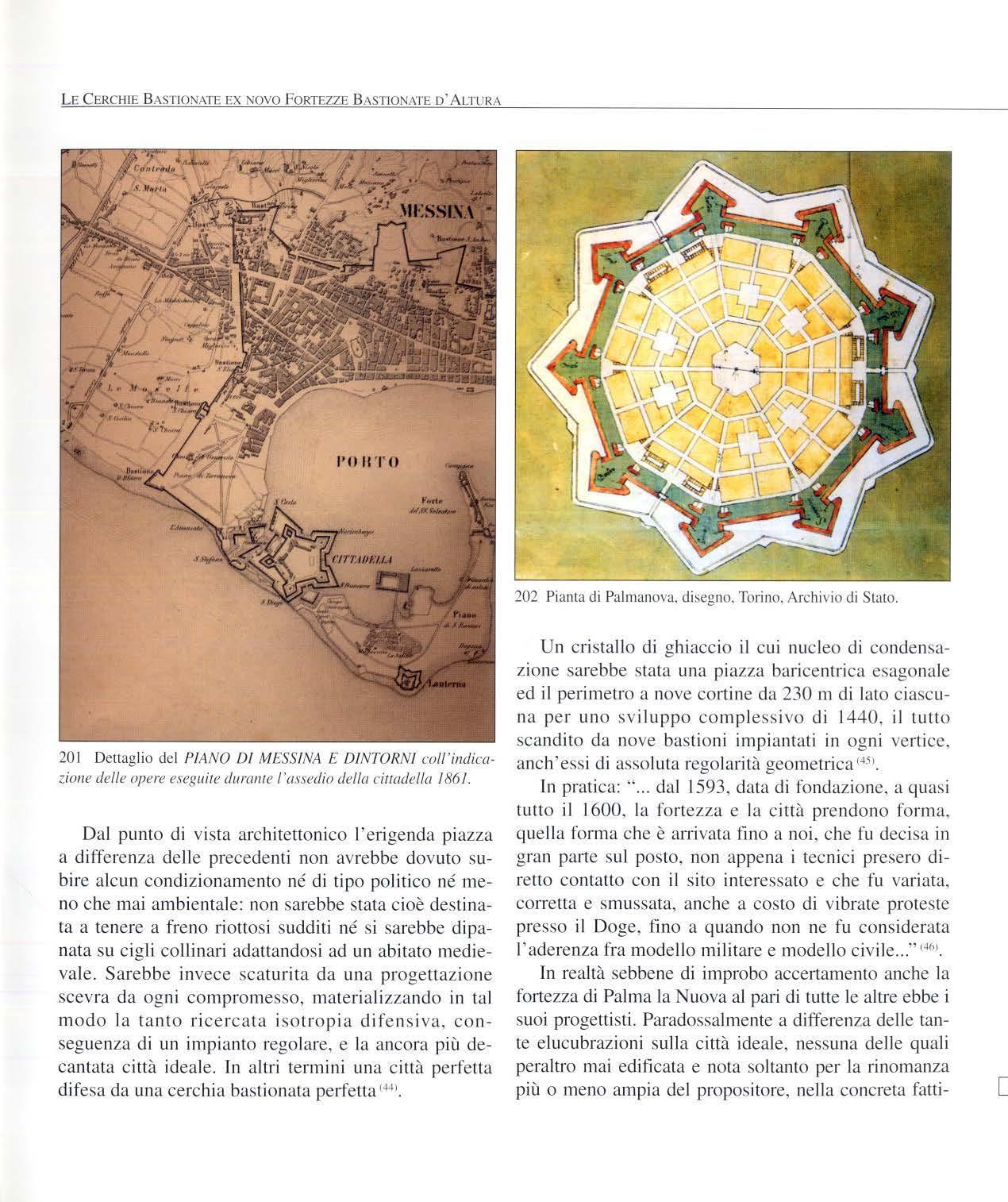
specie di Palma non si nutre alcuna certezza in merito. 11 che potrebbe dipendere dall'essere scaturita da più cervelli in più fasi ciascuna delle quali importante e nessuna predominante. Tra i più coinvolti risultano nel1' ordine Giulio Savorgnan (1509-1595) , Bonaiuto Lorini (1540-c. 1611) , Vincenzo Scamozzi (1552-1616)
Circa il p1imo sappiamo che fu un: " nobile friulano fedele alla Repubblica di Venezia, [che] durante la sua lunga vita diede il meglio del suo intelletto come condottiero, governatore , ingegnere militare e provveditore al le fortezze , delle quali si curò nei territori d'oltremare , come in quelli metropolitani. A giusta ragion e, quindi, anche la fortezza di Palma può e s sere ascritta alla s ua esperienza e a quella dell ' Ufficio cui era capo" <41 >
Il secondo , invece, di origine fiorentina: " ... impers ona il tecnico militare fra i più preparati d i cui la
Sereni s sima poté avvalers i, gra z ie alle sue es perienze acquisite all'estero e pres so altre signorie. La chiarezza delle sua forma z ion e culturale è te s timoniata dalla s ua opera principale " Delle fortificazioni libri cinque " . Dopo la morte del Savorgnan fu rigoro s o e s ecutore delle s ue idee" c48J
Quanto al terzo: " ... Vicentino, può essere considerato ... l ' esperto in architettura civi le. Continuatore di diverse opere di P alladio ed esecutore di molte altre in Venezia, sc1isse " Dell'Idea del! ' Architettura Universale" e può essere a buona ragione considerato il progettista delle porte e del duomo della forte z za di Palma" <49 > _
Scendendo ulteriormente in dettaglio le motivazioni che si ravvisano aJle s palle della piazzaforte di Palma s ono sempre le mede s ime, ed in quanto tali
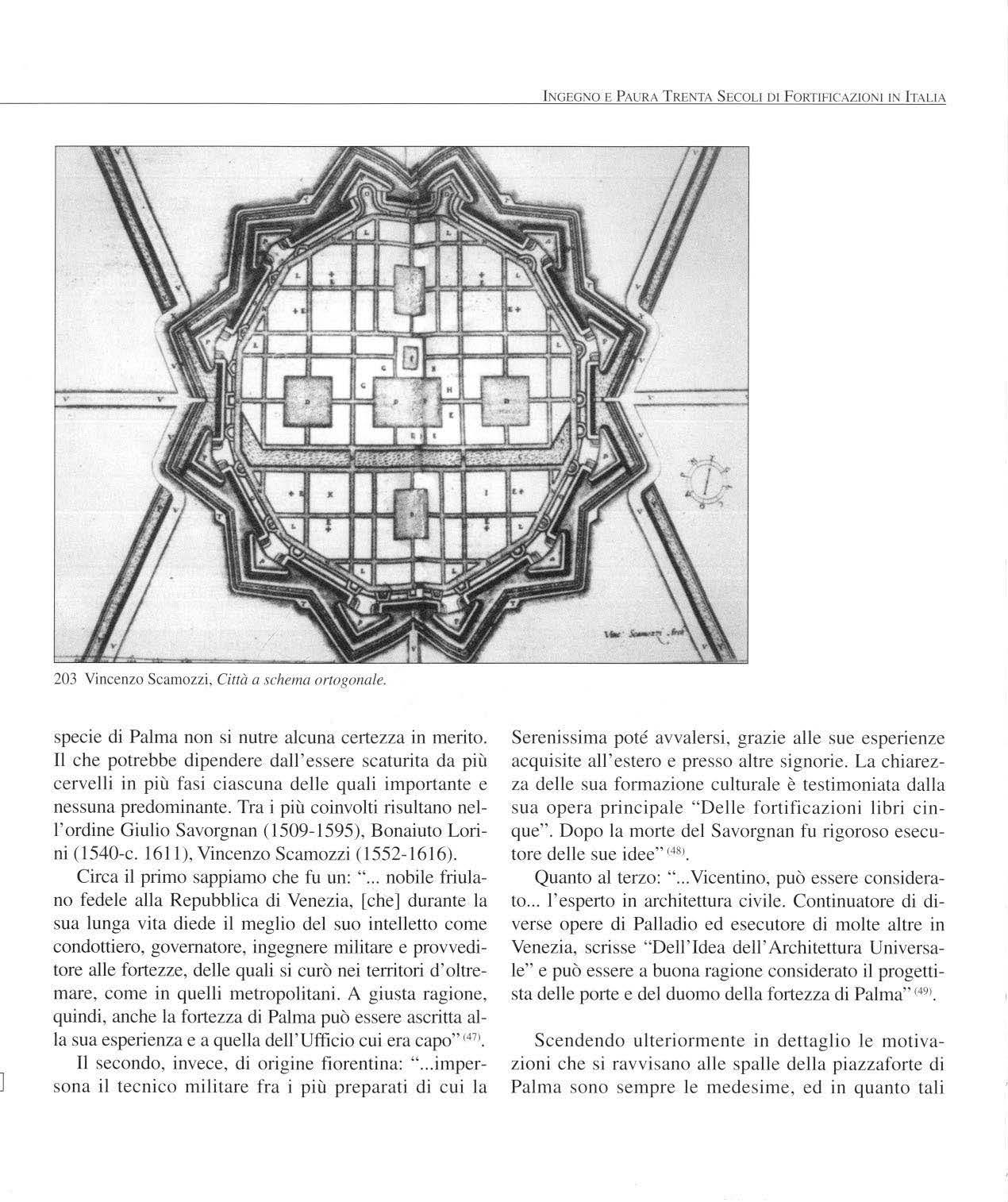
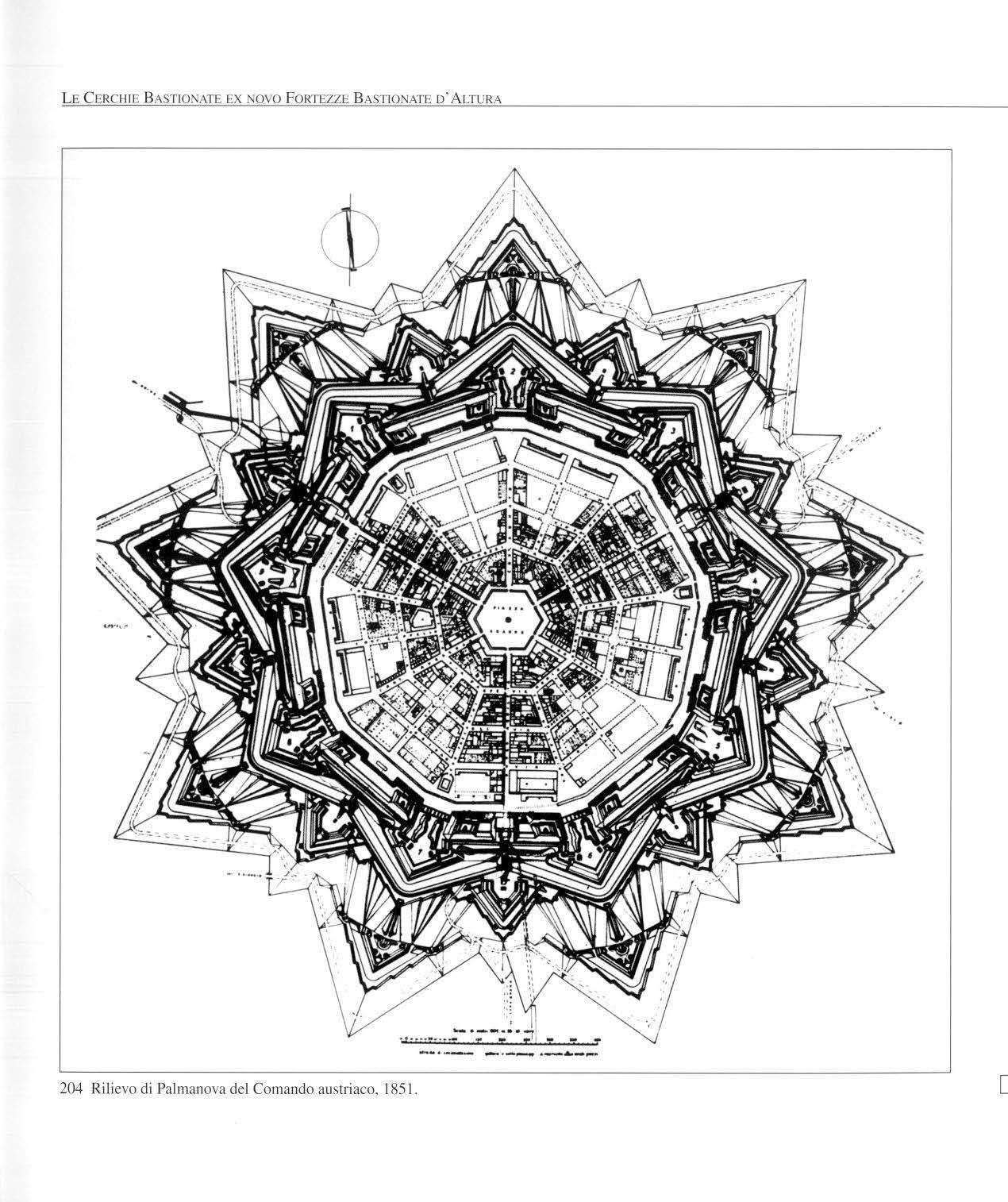
coeve, di quelle già esposte per Bergamo. Anche in questo caso i prodromi dell'iniziativa si individuano a partire dal 1527 , allorquando si in i zia a discettare sull'opportunità di ridu1Te la stessa Udine in fortezza, con ancora lo strazio turco della regione dinanzi agi i occhi. J Gemoneis tuttavia non consentono l' intervento, perfettamente consapevoli della distruzione di ogni libertà che ta1e trasformazione avrebbe inevitabi I mente richiesto. Ma l'idea torna a riproporsi pochi anni dopo rilanciata da Francesco Maria della Rovere con una apposita relazione trasmessa da Pesaro a Venezia nel 1536-37. Sebbene anche in questo caso la proposta restò priva di conseguenze si continuerà a parlare di fortificare Udine almeno per altri venti anni ancora, fino oltre metà del XVI secolo. Sotto il profilo strettamente geometrico la cerchia di Palmanova è un poligono regolare a nove lati: ad ogni spigolo sta innestato un bastione dì tipo canonico con due fianchi rientranti, protetti da altrettanti orecchioni. Tutt ' intorno corre un fossato che riproduce l'identica configurazione perimetrica. Urbanisticamente la città appare frazionata in sei fette, o sestieri, triangoli acuti con il vertice smussato di 60 °, ampiezza facilmente compatibile con il poligono d"impianto il cui lato corrisponde ad un angolo cenLrale di 40 ° : un lato e mezzo. 11 che in pratica cordsponde al succedersi dì assi stradali radiali che partendo ciascuno dalla mezzeria del lato della piazza esagonale terminano alternativamente una volta sullo spigolo e la successiva sulla mezzeria di ognuno dei nove lati. Per cui ciascun bastione può idealmente considerarsi la cuspide di una freccia la cui asta è la suddetta strada. Quanto alla scansione concentrica viene assicurata da quattro anelli sempre esagonali concentrici ad intervallo costante. Il suddetto reticolo viario, molto simile ad una ragnatela, determinava in s ule abitative a forma di trapezio rettangolo, con basi progressivamente minori ed altezza invariata verso l'esagono centrale.
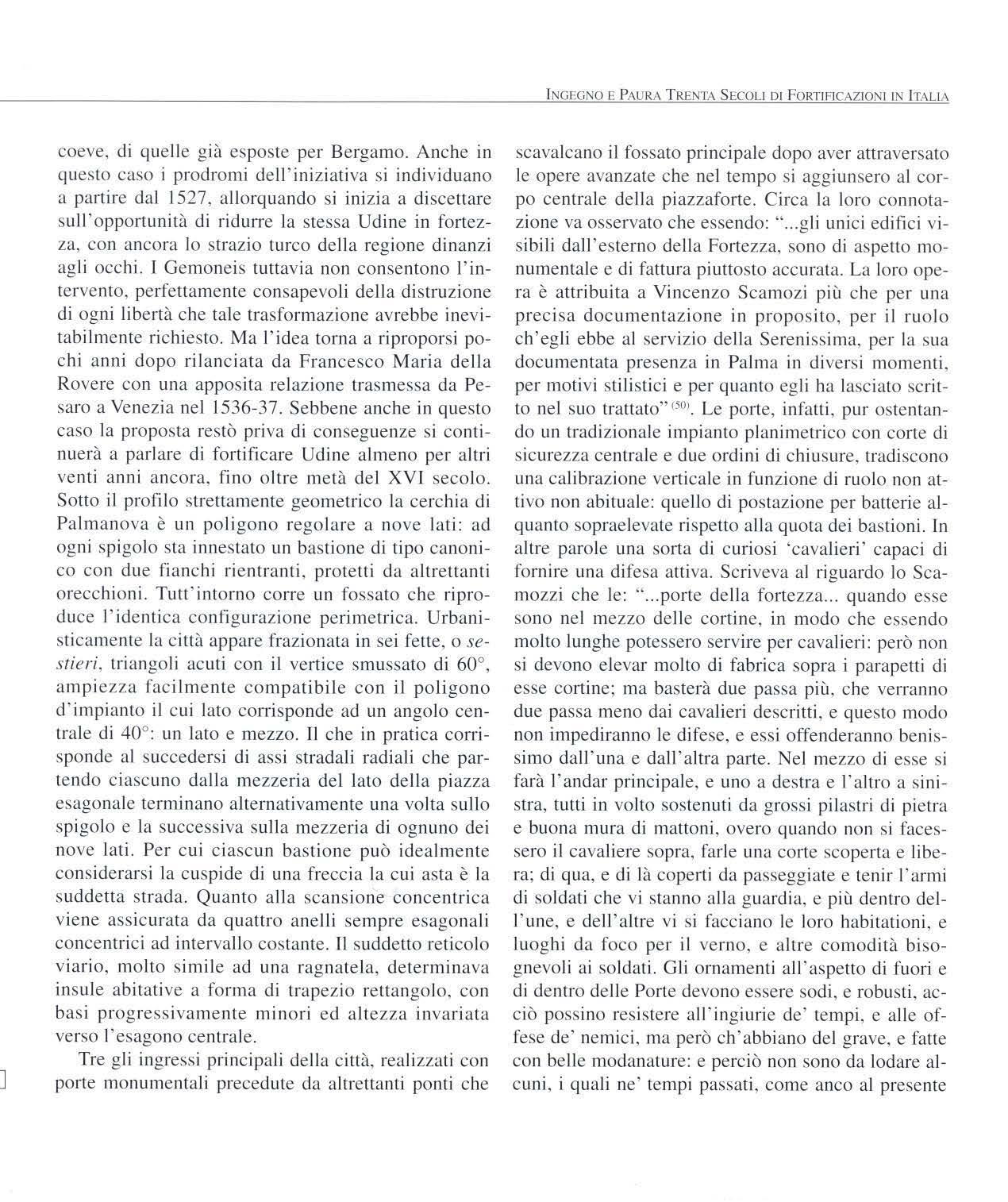
Tre gli ingressi principali della città, realizzati con porte monumentali precedute da altrettanti ponti che
scavalcano il fossato principale dopo aver attraversato le opere avanzate che nel tempo s i aggiun sero al corpo centrale della piazzaforte. Circa la loro connotazione va osservato che essendo: " gli unici edifici visibili dall'esterno della Fortezza, sono di aspetto monumentale e di fattura piuttos to accurata. La loro opera è attribuita a Vincenzo Scamozi più che per una precisa documentazione in proposito, per il ruolo ch'egli ebbe al servizio della Sereni s sima, per la sua documentata presenza in Palma in diversi momenti , per motivi stilistici e per quanto egli ha lasciato scritto nel suo trattato" 150 ) Le porte , infatti , pur ostentando un tradizionale impianto planimetrico con corte cli sicurezza centrale e due ordini di chiusure, tradiscono una calibrazione verticale in funzione dì ruolo non attivo non abituale: quello di postazione per batterie alquanto sopraelevate rispetto alla quota dei bastioni. In altre parole una sorta di curiosi 'cavalieri ' capaci di fornire una difesa attiva. Scriveva al riguardo lo Scamozzi che Je: " ... porte della fortezza ... quando esse sono nel mezzo delle cortine, in modo che e ss endo molto lunghe potessero servire per cavalieri: però non si devono elevar molto di fabrica sopra i parapetti di es se cortine; ma basterà due passa più , che ven-anno due passa meno dai cavalieri descritti, e questo modo non impediranno le difese, e essi offenderanno benissimo dall ' una e dall'altra parte. Nel mezzo di esse si farà l'andar principale, e uno a destra e l'altro a s inistra, tutti in volto sostenuti da grossi pilastri di pietra e buona mura di mattoni, overo quando non s i facessero il cavaliere sopra, farle una corte scoperta e libera; di qua, e di là coperti da passeggiate e tenir l'armi di soldati che vi stanno alla guardia, e più dentro dell'une, e dell'altre vi si facciano le loro habitationi, e luoghi da foco per il verno, e altre comodità bisognevoli ai soldati. Gli ornamenti all'aspetto di fuori e di dentro delle Porte devono essere sodi , e robusti, acciò possino resistere all'ingiurie de' tempi, e alle offese de' nemici, ma però ch'abbiano del grave, e fatte con belle modanature: e perciò non sono da lodare alcuni, i quali ne· tempi passati, come ance al presente
hanno fatto Porte di tanta delicatezza, che paion o Archi trionfali: laonde quando so no s tate offese d a l] ' artiglierie. allora s ono rima s te come trofei di nimi c i , e altri poi all'opposto le hanno fatte tanto vili, e abbiette , così di forma, come di materia , che non s i converrebbero piuttosto ad ogni altro genere d 'ed ifi c io pubblico, e privato , che alla di g nità di recinti d e ll e Città e Fort ezze" <511 •
Un complesso siste ma di cana li zzazio n e, tipico della competenza in materia dei Veneziani , fu adottato per fornire d 'ac qua la città e p e r allagarne i fossati, s en za però che ri stag nando v i finisse co n ammorbare l 'a ria. In pratica un g ro sso flu sso idric o , un vero fiume ve nn e diretto ve r so Palm a. Prim a di p enetrar v i la s ua corrente ve ni va divisa in due p ar ti , dell e quali la prima d es tinata alla di s tribu z i o n e civile , s i immetteva in una apposita canalizzazione senza alcun salto di li ve llo. La penetra zio n e avve niva
ne i press i di porta Udine mediante l'acquedo tt o monumentale fa tto cos truire da Alvise Molin ne l 1665 : e g ià quest ' ultim a data per una pertinenza vitale di una piazzaforte confe rma implicitamente l'abnorme protrars i dei l avo ri.
Quant o a ll ' acqua di uso militare , dopo una se nsibile caduta veniva in cana l a t a verso il fossato, circondando l a fo rt ezza pe r l ' int ero p e rim e tro , costruito con una se n s ibil e pendenza io modo da favorire il formarsi di una leggera corrente. Ed il deflu sso infatti grazie a tal e acco rg im e nto avveniva ne i press i di P o rta Aquilea, diri ge nd o da lì ve r so il mare , formando così un canale navigabile. Prim a però conflu i va nello stesso a n c he l ' acqua r es idua civ il e, fuoriusce ndo dalla rete fognaria attrave rso du e fori praticati ne l basamento bugnato dell a s te ssa porta. In ne ssun punto sottosta nte alla ce rc hia quindi le acque di sco lo l a mbi va no, s i a pur diluite la s te ssa, accorta
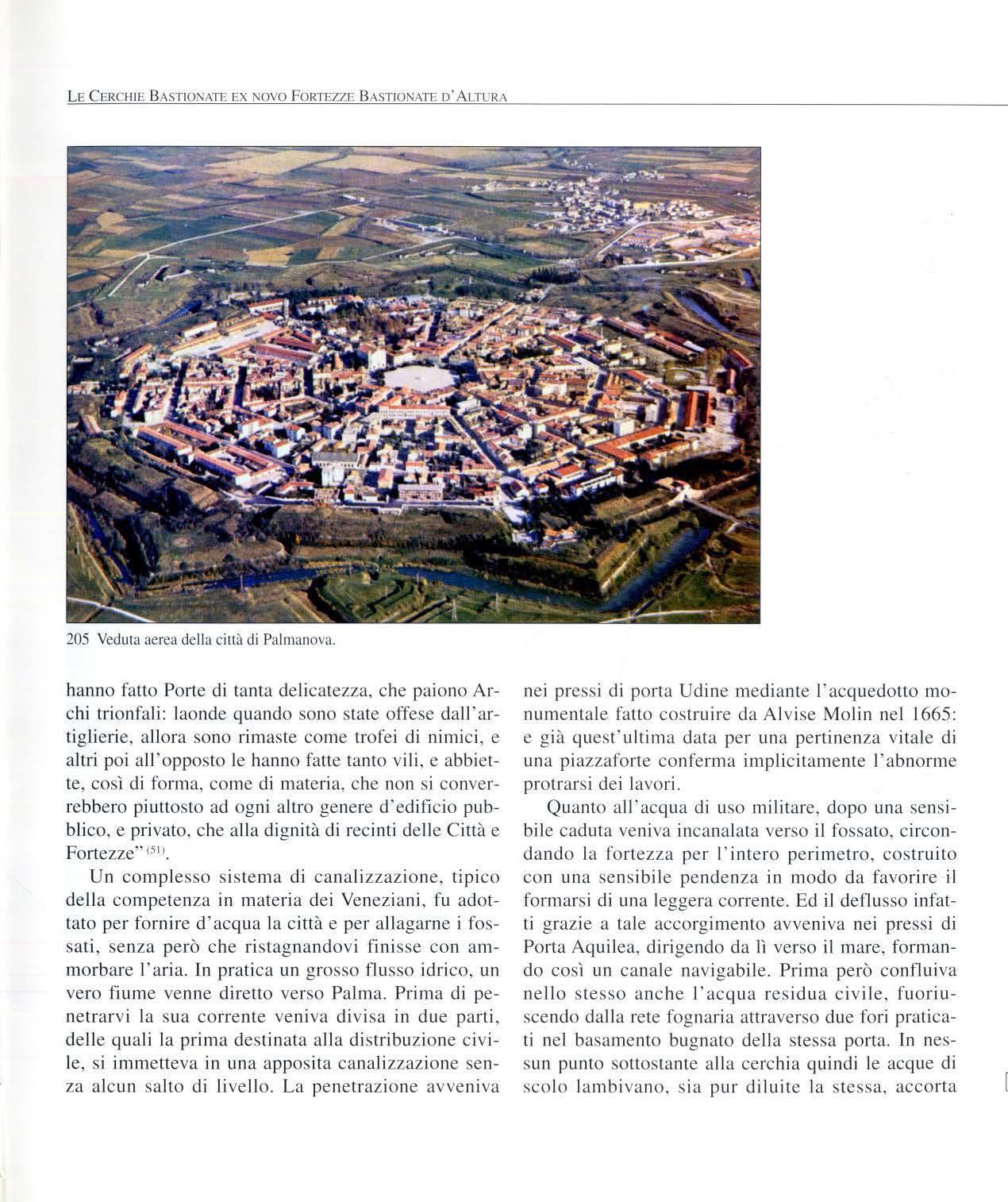

precauzione per evitare la sia pur minima possibilità di esalazioni.
Dal punto di vista cronologico l'avanzamento dei lavori , dopo un veloce avvio, iniziò progress ivamente a rallentare, forse anche per il contestuale venir meno degli aiuti esterni. Per i primi anni infatti: " ... Crema fornì a nche due centurie di steITatori al cantiere della nuova fortezza. Per l 'a pprovvigionamento dei materiali da costruzione, dal momento che il s ito non poteva fornire che ghiaia, si doveva Iicorrere per i materiali lapidei alle vicine cave di Medea per i mattoni , invece, non si esitò a se rvirs i anche di quelli che costi-

tuivano alcuni tratti delle difese di Treviso, che - conseguentemente - veniva a perdere d'importanza nello scacc hiere veneziano.
Con l'andar del tempo, però, l'entusiasmo iniziale andò scemando e ogni pro vved itore generale a Palm a aveva il suo bel daffare a ricorrere al Senato per concludere i vari settori, che potessero dare all'insieme de lle fortezza una parvenza di essere realmente tale ... Ma evidentemente Vene z ia non se ne adonta. Con ogni probabilità è già paga dei risultati ottenuti, avendo impostato concretamente una macchina del gene re; e solo questo fatto serve a intimidire l'avversaiio , comunque ad allertarlo su lle serie intenzioni di lei .. .'' 1521
1 Tn realtà veniva a mancare il terreno che avrebbero dovuto percorrere gli attaccanti so tto i l tiro radente ed incrociato dei bastioni. L'altura infatti non si equiparava ad esso poiché essendo le sue pendici di roccia non potevano ridurs i a pendenza costante, supposto ind ispensabile per l'ottimizzaz ione del tiro radente. La pendenza naturale, estremamente variab ile fin iva inevitabilmente per creare numeros i settori battibili soltanto con il tiro ficcante, con evidentissima contrazione di efficac ia. Non a caso il gen. E. ROCCHI, Traccia per lo studio della fortificazione campale, Torino 1904, p. 153, ricordava per la difesa in montagna: "ln generale la difesa dovrà fare larghissimo assegnamento sul fuoco mirato e diretto con precisione... eia buoni tiratori .. .''.
2 Per stabi lire quanto una fortezza bastionata di montagna fosse deficitaria rispello ad una coeva di pianura, basta val utare quanto si discost i dalle principali rego le dei maggiori trattatisti i n materia intorno al 1560, che in pratica possono ridursi alle seguenti: I ) La fortificazione risulta più efficace quando, a parità di supertìcie racchiusa, è magg iore il numero dei bastioni e minore l'estensione delle co rti ne i nterposte; 2) I bastioni ottusi sono di gran lunga da preferire rispetto a quell i acuti: 3) Tfianchi devono rientrare rispetto alle facce, d isponendosi quasi ortogonalmente, con vari ordini di cannoniere.
Nella maggioranza delle fortezze dei Presidi abbiamo appena 4 bas tion i, con angol i molto acuti e cortine interposte molto lunghe. senza a lcun tipo di fianco rientrato , conseguenze tutte impu tabili al loro impianto apica le!
3 U na pu ntuale descrizione de ll e connotazioni morfologiche de l l'Argen tario, logicamente a l l'epoca delle vicende in questione , è forn ita da L. BUZZELU, Descri zione di Orbetello e Monte Argentario 26 ottobre 1613, ms Archivio Comunale d i P iombino, Fondo Cardare ll i, B. 131, c 37.
4 Così G. VASAR I Le opere , cit. tomo VII, pp. 614 -616: "Bernardo (nato nel 1536; morto nel 1608) Bernardo Timante Buontalent i... ebbe nella sua fanciu ll ezza i primi princiP.i della pittura dal Vasari; poi, cont inuando, ha tanto acquistato che ha servito molti an n i e serve con mollo favo re l' illustrissimo signor don Francesco Med ici , pr incipe di Firenze, il qua le l'ha fa tto e fa continuamente lavorare ... E se avesse costui quando era giovinetto (se bene non passa anco trenta anni) atteso agli studii de l l'arte, sì come attese al modo di fortificare, i n che spese assai tempo, eg l i sarebbe per avventura a ta l grado d'eccellenza, che altri stup irebbe :·.
5 In merito alla for tificaz ione in montagna cfr. M. Ascou. F. Russo, La difesa dell'arco alpino 1861-1940, Roma 1999, parte prima, pp. 54-60.
6 Da G. DELLA MONACA , D RoSELLI, G. Tosi, Fortezze e torri , cit., pp 124-25.
1 l dem, p. 126 .
x Per i cannoni petr ie ri che tiravano proietti frammentati, schegge di pietra o di ferro, non era possibile esprimere il calibro assoluto che a ll 'epoca corr ispondeva a l peso de ll a palla. In particolare d ivenne prassi consolidata quando le palle furono esclus i vamente di ferro es istendo allora una immutab il e co rr ispondenza b iunivoca fra la l oro massa ed il loro d iametro, appena inferiore a quello dell'an i ma. Pe rtanto per dimensionarli si faceva riferimentO a l calibro che avrebbe dovuto avere l 'eve ntuale palla compa t ib ile con la loro anima.
9 Come già osse rvato in precedenza. non di rado negl i in ventari delle munizioni presenti nelle piazze marittime rinascimentali anche in quelli del XVII secolo compaiono alquante palle di pietra. Non si tratta di residui de i secoli p recedenti ma palle di recente fabbricazione, realizzate per almeno d ue probabili ragion i: forse per carenza di palle cli fe rro, forse pe r effettuare impatti più devastant i sugli scafi nemici a distanza ravvicinata . Le palle di pietra infatti impattavano con veloc ità mo l to minori di quelle di ferro e quindi non trapassavano gl i scafi da parte a part e ma si l imitavano a schiantarne da un solo la to il fasciame, ap rendovi perciò falle molte volte irreparabili . La co nd izione ind ispensab il e quanto rara d' impiego, dal che la presenza irrilevan te d i siffatti proietti, era che l'imbarcazione nem ica offrisse la fianca ta a b reve distanza dalle batterie costiere. manovra peraltro s u icida. Ad ogni buon conto non essendo la pie tra co rros i b il e a nche in ambienti fo rtemente sa lmastri non esistevano l imi ti alla lo ro co nservazione.
10 A.G.S., Estado 1475, f. 100.
11 D a G. DELLA MO NACA, D. ROSELLI, G. Tosi, Forte zze e torri , cit .. p. 135.
12 Idem, p. 136.
13 Idem, p. I36.
14 A.G.S .. Estado 1475, f. 100.
15 Così rec ita il verbale de l 1564: " .. .// for1e di Monte Filippo si 11vva entro l'altezza che deve avere fino al cordone. Mancano per completare la porta del detto forte, oltre ad alcuni particolari che si devono eseguire al! 'interno e che sono avviati, il corpo di guardia e la casa del castellano che deve essere collocato supra la sressa porta f Inoltre] si devono riempire quattro cannoniere, i due

cavalieri e la tenaglia e le sue casematte Sono da complewrsi quattro camerate per i soldati oltre a/Le sei che già ultimate .''.
A.G.S., Es1ado 1052, f. 79.
16 A.G.S Estado 1060, f. 121.
17 A.G S., Estado 1065, f. 41
18 A.G.S., Estado 1062, f. 155.
19 In merito cfr. F. Russo. Guerra di corsa, Roma 1997, tomo I, pp. 43-49.
20 Al di là di tutte le notizie più o meno attendib ili sulla segreta regia cli Venezia nell'attacco turco ad Otranto è certo c he la caduta della disgraziata citta din a pugliese seguita da l massacro di un miglia i o dei s uoi abitanti e la deportazione per la sc hiav itù di tutti gl i altri, fu sa l utata a Venezia con manifestazioni di gioia. In una lettera ad Ercole d'Este dell'8 agosto del 1480, quando ancora la città tentava di speratamente di res istere all'assedio. si può leggere :" ... qua se ne ride et se fusse liciro alla brigata io credo che /ariano fogi e campane .' '. La citazione è tratta da P. EGIDI, La politica del Rei,w di Napoli negli 11/ti111i mesi def/'anno 1480, in Arch. Stor. Nap , n° XXXV. Napoli I 91 O, p. 706.
2 1 L'ipotes i non appare affatto assurda essendo quella procedura. sosta nzialmen te suicida, la prass i politica dei var i potentati italiani all'avven to de ll' età moderna. Fra ess i non mancò nemmeno lo Stato Pontificio che in va ri e c ircostanze s i tro vò all eato con le forze turche. Per approfondimen ti cfr. P. P1 ER1, J/ Rinascim ento , ci t. , pp. 320 -398.
22 La c itazione è tralla da A. FUMAGALLI, Fortifiw-:, ioni venete a Be1ga1110, in Le mura di Bergamo, AA. VV., Bergamo 1977 . p. 4 .
2 3 Da A F UMAGALLI. Fortfficazioni cii., p. 6.
24 Da A. FUMAGALLI, Fortfficazioni , cit., p. IO.
25 A.S.V.. Delih. Senatao, F. 34, Rela-::,ione di -~for-:,a Pallavicino, 13 lug li o 156 1 La c itaz io ne è tratta da V. FOPPOLO, La costru-::,ione delle mura venete. in Le mura , c it., p. 32
26 A.S .V., Deli/J. Senato. F. 34, 15 lug li o 156 l. La citaz ione è tratta da V. FOPPOLO, La cos tru : ione cit., nota n 13, p. 57
27 I dati so no ri cavat i da lle relazion i coeve custod i te nell'A.S.V. , S e nato, Terra. R e la -::, G. Gabriel. 20 ott 1561 e rei. F Venerio 6 no v 1561, in Re/a : dei Podestà e Capitani veneti al Senato, voi. I. La citazione è tratta da V. FOPPOLO, La cost ru:ion e cit., nota 11 ° 23, p. 57
28 Da V. FOPPOLO. La costru -:, ione c ii.. p. 35.
29 Biblioteca C ivica di Bergamo, Rela -:, ione di F Venerio, 6 nov. 1561 La citazione è tratta da V. FOPPO LO u, custru:ione , cit.. nota n° 44, p. 58.
30 Da V. FO PPO W. La costru:ione c it., p 39. Agg iun ge inoltre I' A ., nota 11° 54 p. 59. la: " relazione era accompagnata da un grafico della fo rtezza, dove era no seg nati in rosso i tratti di mura in pietra già costruiti, in verde i tratti di semp lice terrapieno, in bi anco i tratti d ifesi ancora da lla muraglia vecc hia .''. TI grafico, purtroppo, è scomparso per cui le conclusioni esposte dalr A. sono dedotte dalla interp retaz ion e della re lazione.

3 1 A.S. V., Collegio rela:ioni. B. 52, 17 lu glio 1590 La ci tazione è tratt a da V. FOPPOLO. La costru:ione cit.. p 42.
31 Da V. FOPPOLO. La costru:ione , c it.. p . 46.
3 1 T dat i su ll'armamento so no tratti da u na re lazione de l capitano Stefano Tri visan compilata 1'8 febbra io del 1600. Da V. FOPPOLO, La costru-::,ione cit., nota 11 ° 93, p . 6 1.
3-1 1 dati so no tratti da G. De ll a Chiesa, Le mura c inquece111esc lze da Pur/U S. Loren-::,o a Porta S Alessandro, in Le mura , cit., pp 66- 107.
15 Da G. LABA/\ , Il Forte di S. MARCO in Le mura. cit., p. 118.
Jh Da G. LABAA, Il Forte ... , cit.. p. 121.
1 7 Da G L ABAA ll Forte cit., p. 131.
38 li viceré Francesco Bazab de Bonavid mare. di Bajona. restò in carica fino a l 1676 . Per approfondimenti cfr. G .E. D1 BL ASI. Storia cronologica de' Viceré, Luogo1ene111i e Presidenti del R egno di Sicilia, Palermo 1974. vo i. L pp. 623-83
19 Sull'episodio cfr. G. ROMANO e COLONN/\, Della c ongiura d e i Ministri del re di Spagna contro la fedelissima ed esemplare c ittà di Messina , Messina 1676, pp. 354- 355.
10 La citazione è tratta da P. SIGILLO. Una vecchia forte-::;:.a messinese mvina: Don Blasco, origini e vicende, in Boli. ISCAG 11° 4. Roma 1936.
• 1 Traduzione de ll ' A. ciel documento spag nolo originale cus tod i to pre sso A.G.S .. Estado, 3527, 135 apri le 1680 .
41 Per approfond i menti cfr. l. HoGG, Storia dellefortijìca:ioni, Novara 1982, pp. 129 e sgg.
43 Circa le conseguenze politi co-militari e psicologi che de ll a vittoria di Lepanto cfr. F. BRAUDEL, Civiluì e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo Il. Torino 1976, voi. II , pp
44 Cfr. W. 0ECHSL1N. l/ mito della città ideale, in Pri11cipii e forme della città, Milano 1993. pp. 419 -456.
45 Per ulteriori approfondimenti tecnici. cfr. A. CASS I- RAMELU, Dalle caverne.... cit., p. 351.
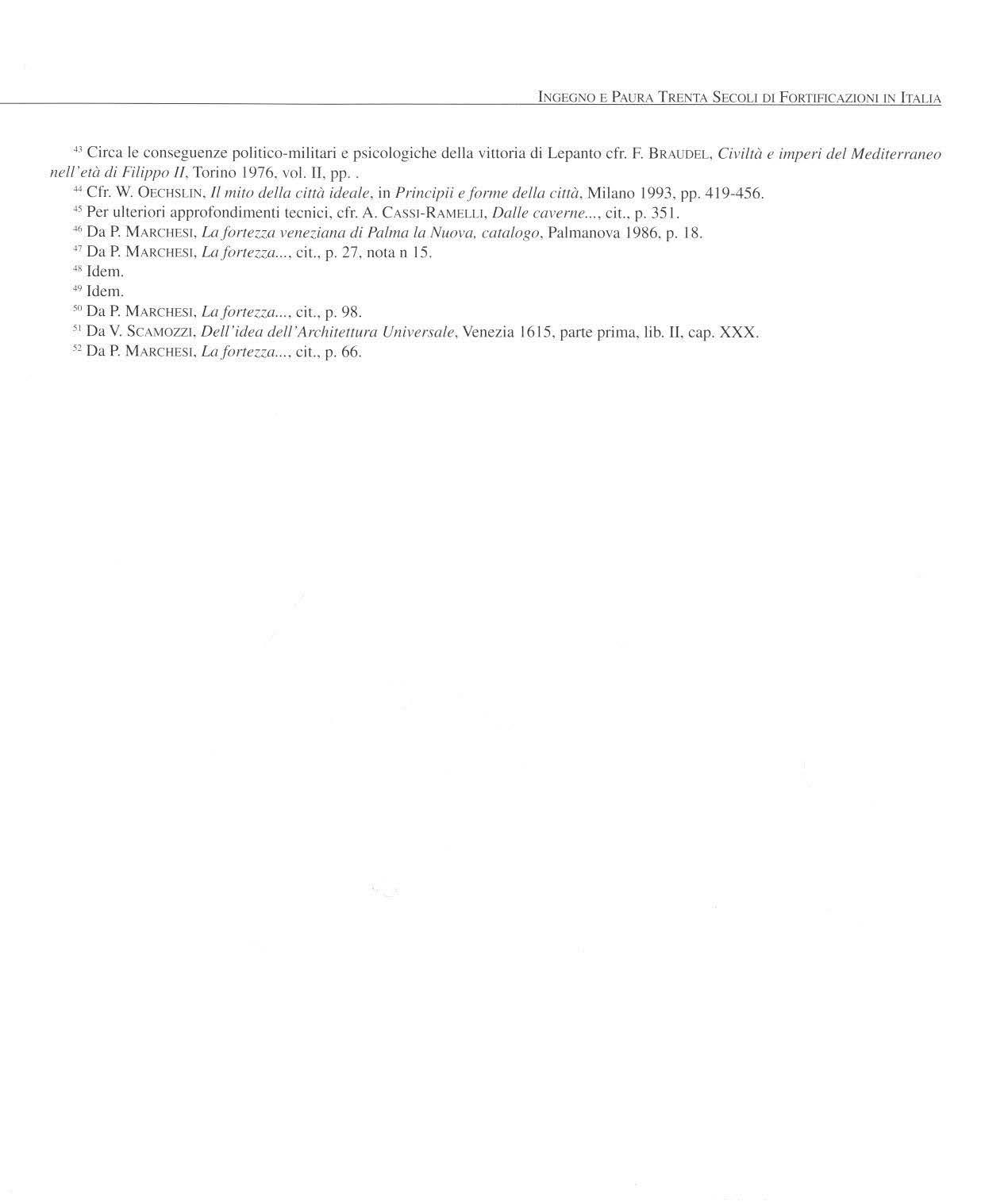
J(, Da P. MARCHESI, Lafor1ez::,a veneziana di Palma la Nuova. catalogo. Pa l manova 1986, p. 18.
47 Da P. MARCHESI, Lafor1ezza cil., p. 27, nota n 15.
Jg Idem.
49 Idem.
50 Da P. MARCHESI, Lo.fortezza cit.. p. 98.
51 Da V. SCAMOZZI. Dell'idea dell'Archi1e11ura Universale. Venezia 1615, parte prima. lib. II, cap. XXX.
52 Da P. MARCHESI, u1.forte zza , cit., p. 66.
Alle ore 12 del 7 ottobre del 1571 appena un miglio di mare separava le armate navali più potenti che fino ad allora si erano fronteggiate nel Mediterraneo (1> . Circa 500 galere, equamente suddivise tra g li opposti schieramenti, si acci ngevano a cozza re , modalità di combattimento immutata da millenni sul mare. Irril evanti le differenze fra le occidentali e le levantine: unica eccezione sei gross i e tozzi vasce lli che si cullavano pigramente davanti ali' ordinanza cristiana. Imbarcazioni di recentissima invenzione dimostrarono in quel debutto le loro infime p restazioni nautiche obbligando a rimorchiarle fino a quella posizione, tra i lazzi e gli scherni dei Turchi. La distanza non gli consentiva di interpretare in alcun modo q uella strana teoria di finestrelle semisocchiuse praticate lungo la murata né, meno che mai, di scorgervi dietro le minacciose volate dei terribili cannoni di grosso ca lib ro. Oltre sessanta pezzi , costituivano infatti l'armamento cli ciasc un a galeazza, peculiarità che finiva col renderla s im ile ad una poderosa cittade ll a gallegg iante. E dopo pochi minuti q uel che non si riusciva a vedere da bordo al l e unità della mezzaluna si fece niti dame nt e sentire. Con una te rrifi ca nt e sincro ni a, in fa tti , quando ormai l e ga lere d el s ult ano avevano coperto quasi la metà della distanza che le separava dalle nemiche, peraltro stra name nte immobili, g l i e ni g m atic i portelli s i i llumin aro no s ini stramen te di bagliori intermittenti. In pochi i s tanti fu ch i ara non solo l a funzione d ei portelli ma anche la tattica della man ovra cr ist ia na : a quel pun to però indi et reggiare sarebbe stato anche peggio c he contin u are sotto l a micidiale g r andine, c he co n micidiale frequenza sc hi a ntava a lb e ri , pennoni, remi, maciullando intere fi l e di remat ori. L'ordine di voga arrancata fu impartito con disperazione ed esto rto dagli aguzzini con spieta ta efferatezza: impossibile però
appurare con quanta passività eseguito da pai1e degli schiavi cristiani. Di certo quando le prime unità turche finalmente agganciarono quelle cristiane, apparivano talmente p rovate e malconce da soccombere una dopo l'a l tra, in una mattanza allucinante. li nuovo connotarsi della guen-a sul mare prendeva così il suo avvio in un episodio marginale, nell'ambito di una battaglia per molti versi unica quanto epica. Ma la manifestazione che più di ogni altra s i avviava a scomparire per sempre dalla logica della guerra sul mare era di natura diversa , insita nella stessa epicità di quello scontro immane: mai più si sarebbero affidate le sorti di una potenza , o peggio ancora di una confederazione di stati, ad un unico risolutivo scontro, azzardando di vedere così in poche ore svanire completamente la prop1ia forza e la propria sicurezza per ritrovars i esposti, indifesi, alle ritorsioni nemiche. A Lepanto oltre 100.000 uomini si batterono in un estremo tentativo di cancellare dal mare l 'opposta presenza ed entrambi i vertici militari e politici accettarono il terribi l e rischio ritenendolo in qualche maniera congruo ai benefici ottenibili in caso di vittoria.
Ad ottobre nel Mediterraneo il tramonto sopraggiunge abbastanza presto: ancora il so l e non era scomparso dietro le onde , che le ultime galere turche a ncora in grado di navigare tentavano di sottrar si alla cattura. Nella crescente osc uri tà della calan te notte la piccola flottiglia di U l ag h-A lì, più tristemente ce l ebre co m e il corsaro Uccialì (2 > , abbandonate tutte le prede c h e era riuscita ad arraffare, p unt ò a g u adagnare il mare aperto Co nfondendosi con la m assa nera della costa, e filando con spe ri co l ata manovra fra l e scogliere affiorant i di q ues ta e l ' estrema ala dello schierame n to cristiano, dimostrando in c iò la s u a a rdit a maestria, il predone pilotò il suo branco fuori dalla gabbia nemica. E f u un o dei pochissimi a farla franca, confe rm a nd o quasi le potenzialità supe-
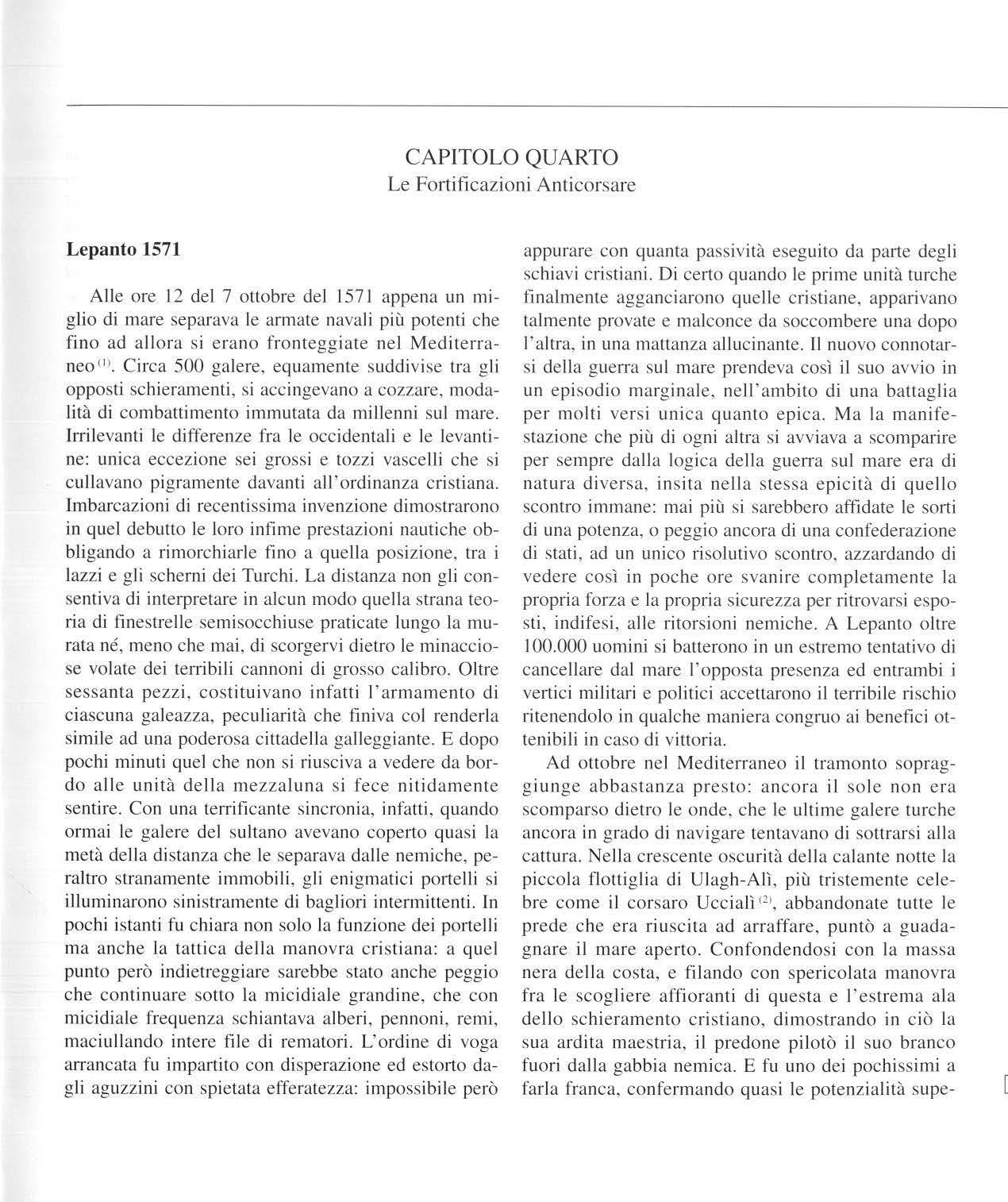
riori che poteva ostentare la marineria corsara ,n qualsiasi circostanza.
L'impero turco in quel mome nto non aveva ormai sul mare nessuna possibilità di difesa concreta e credibi l e e nel giro di circa cinque ore era scaduto da orgogliosa compagine aggressiva a pavida preda inerme. A Costantinopoli, a ll orché fu noto l'infausto esito della battaglia, s i paventò di ora in ora lo s barco cristiano finalizzato allo sfruttamento militare della indiscutibile vittoria. Ma nulla del genere avvenne: la sera s te ssa a Lepanto quando molti comandanti realizzarono che l'azione offensiva era esaurita e che si sarebbe fatta rotta per casa iniziarono a circolare insi ste nti e de stabilizzanti voci di presunti tradimenti e patteggiamenti con l'odiato avversario, voci che nel tempo lungi dal rientrare c rebbero a dismisura fornendo uno di quei tanti esempi, di cui è ricca la storia, di vi ttoria tradita o comunque sve nduta (31 •
Si trattava in realtà di una singolarissi ma situazione che vedeva contrapposta ad uno schiacciante successo tattico un' altrettan lo incontrovertibile sco nfitta strategica. I Turchi. ne ss uno lo ignorava, avrebbe ro rapidame nt e ricostruito la flotta ed un'occasione analoga difficilmente s i sare bbe ripre se ntata nel futuro. Sui motivi , noti e non , della mutila v ittoria occidentale sono sta ti profu si fiumi d'inchiostro, con ana li si più o meno plausibili, tutte però incentrate s ulla so l a logica politico-militare, che indubbiam ente stava alla base del comportamento delle armate, ma pochi ssime ricos truzioni hanno tenuto conto di un fattore di natura psico logica che, in segu ito ebbe modo di estrinsecarsi ampiamente.
La battaglia s i era svolta infatti agli inizi di ottobre, periodo in cui le galere normalmente già venivano ritirate dal mare non potendo resi ste re alla benché minima tempesta. Le rare volte che si volle, per disperata nece ss ità o per incosciente fanatismo, contraddire questa immutabile re a ltà s i erano se mpre risolte con allucinanti catastrofi. Un banale fortunale, ad esempio, di forza se i bastava ad eliminare una agguerrita sq uadra in poche ore. Logico quindi che don Giovanni
d'Austria ed i suoi g regar i fossero tutt'altro che disponibili ad un protrarsi della campagna con l'inverno alle porte, specie con una flotta, se nz 'a ltro vincitrice , ma proprio per questo abbastanza provata e danneggiata negli scafi come negli equipaggi. Un risultato straordinar io e quasi incredibile, del re s to, era stato pienamente conseguito, anche con la so la dimostrazione incontrovertibile che i Turchi potevano essere battuti e di strutti. E dopo seco li di umilianti sco nfitte pareva il ma ss imo dei risultati e quando tre anni dopo il gran sultano pareggiò moralmente i conti con la vittoria de La Prevesa (4 1, l'opzione di non tentare mai più la sorte in uno sco ntro risolutivo trovò d'accordo entrambe le fazioni. Da quel momento le galere iniziarono a marcire nei loro arsenali.
Quanto brevemente esposto, se da un lato liberava il Mediterraneo da tali ecatombi dall'altro, però, lo consegnava per ovvia conseguenza, alle meno sa n g uinose, ma non per questo meno devastanti, scorrerie dei corsaii che si avviarono a rappresentare per la marineria ottomana la forza offensiva per antonomasia. La collaudatissima corsa barbaresca si proponeva, infatti, come la più efficace modalità di guerra in grado non so lo di infligg e re uno s tillicidio continuo e umiliante di perdite ma persino, qualora non affrontata adegua tamente , di mettere in ginocchio qualsiasi economia mercantile s troncandon e i l libero commercio su i mari ( S) _ E gli esi ti della sua incentivazione ad oltranza non tardarono a manifestarsi lungo le coste peninsulari.
L ' etimologia di so ldato rievoca esplicitamente la sua paga regolar e, quella di corsaro, invece, in quanto assonante col verbo correre sembrerebbe anagliarsi ad un combattente sfugge nte , veloce, inafferrabi le perché se mpre in movimento, quasi un brigante del mare. Il che sare bbe certamente esatto se la derivazione fosse dal latino currere, correre appunto, e per estens ione
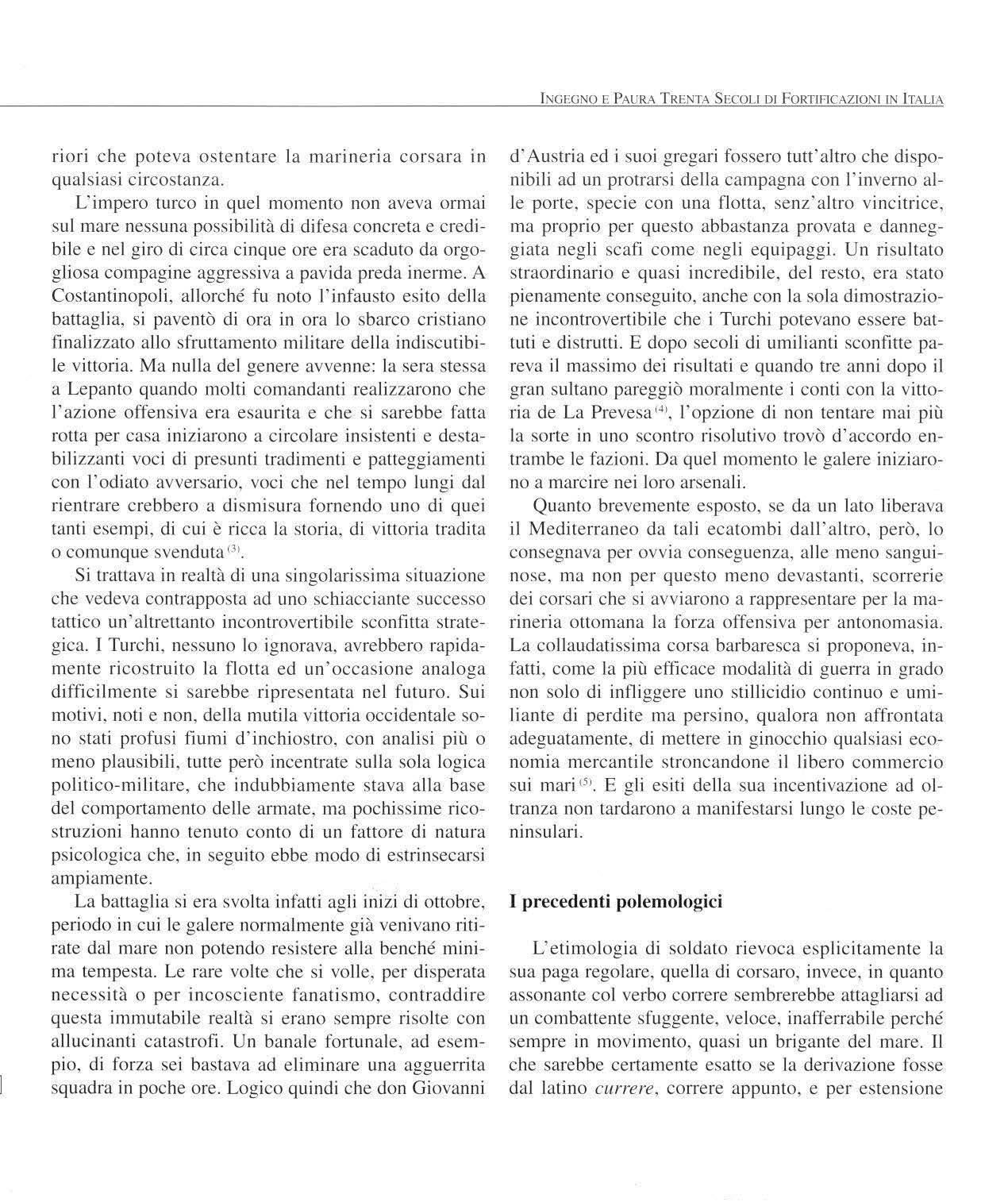 INGEGNO E PAURA TRENTA S ECOLI DI FORTIFICAZIONI IN lTALIA
INGEGNO E PAURA TRENTA S ECOLI DI FORTIFICAZIONI IN lTALIA
I prece denti polemo lo g iciANTI C ORSARE
anche fuggire o scappare ma in ogni caso spostarsi continuamente in un ambito conflittuale con rapidità. In realtà però la derivazione è dal greco kurseuo, prima persona del presente indicativo del verbo saccheggiare, razziare, fare bottino 16' Quindi nessuna modalità disinvolta e sbrigativa di combattere ma soltanto una sistematica perpretazione di un'attività criminale al di fuori di qualsiasi legge, sia pure di guerra m Ora essendo la corsa un metodo e non una destinazione non vi fu mai una guerra da corsa, quasi un sorta di blizt-krieg ante littera, ovvero una tecnica di combattimento al pari delle automobili programmata per essere veloce, ma sempre e soltanto una guerra di corsa cioè di razzia e di preda. Una gue1Ta quindi che della violenza organizzata del combattere cooptava ed esaltava unicamente la fase più efferata, brntale e primitiva, quella dell'indiscriminato saccheggio.
A renderla ulteriormente più abietta , lontanissima perciò dagli stereotipi romantici dei corsari, più o meno variopinti , e dalle infantili narrazioni di vascelli a vele spiegate fu la sua connotazione di strazio degli inem1i, puro bestiame da catturare e rivendere. E soprattutto per incatenare ai remi di fetide imbarcazioni, sottili e veloci impiegate per le incursioni. Schiavi per prodmTe altri schiavi , che a loro volta con la sottrazione della I ibertà, ovvero di qualsiasi aspettativa di vita, finivano per far prosperare l'economia delle città-stato corsare ( R> Città per lo più nordafricane prime fra tutte Algeri, Tunisi e Tripoli (9 ' , sviluppatesi e prosperanti sullo sfruttamento intensivo della cattura di prede, dal1'intero mercantile all'intero abitato rivierasco , entrambi da cedere all'incanto sui rispettivi mercati nel1' assoluta indifferenza verso l'essere o meno oggetti od uomini. Vituperio esaltato non di rado quale meritoria professione di fede islamica. Repubbliche marinare ad economia parassita e lavoro coatto, forma istituzionale mai più fortunatamente eguagliata ma non per questo scevra da estreme conseguenze che ancora affliggono e funestano il Mediterraneo 1 10i

Come appena accennato, assurta la corsa ad esclusiva prassi offensiva ottomana con le tutte le possibili
agevolazioni logistiche ed economiche che un immenso impero poteva elargirgli, non stupisce che l'entità delle catture per quasi l'intero XVI secolo segnò un vistoso incremento. Non di rado interi grossi abitati vennero deportati nelle città barbaresche , o nella stessa Costantinopoli. Innumerevoli disgraziati trascinati in catene finirono così ridotti al rango di animali da soma, strappati dalle loro terre e persino dal conforto della loro religione. Per molti studiosi l' approvvigionamento ed il commercio degli schiavi fu il principale movente delle razzie corsare: in realtà più attenti calcoli sembrano, invece, smentire la tesi. L'obiettivo primario restarono sempre le imbarcazioni che assicuravano, con un unico assalto a bassissimo rischio, il possesso del battello, dell'equipaggio e del carico. E dettaglio non trascurabile, un apporto strategico al confronto tra i due antitetici universi.
La scorreria a terra costituiva un'alternativa di gran lunga meno remunerativa e molto più pericolosa, spesso necessaria al termine di una crociera steri le. Ma non fu mai quella la maniera di approvvigionamento all'ingrosso di schiavi cristiani , affluendo nei bazar torme di prigionieri tratti in massa per questo scopo dalle disgraziate città europee, sistematicamente devastate dalle armate ottomane 111 >
Con l'intensificarsi della vigilanza e della difesa, ovviamente, sbarcare divenne sempre più temerario e per contro inadeguato: rientrare dopo una 1ischiosa crociera, con le ciurme massacrate dallo sforzo, e nelle sentine un pugno di disgraziati contadini sorpresi in qualche sperduto tugurio, non bastava a compensar nemmeno i viver i consumati. Difficile, pertanto, stabilire l'ammontare comp lessivo dei deportati dall'avvento del XVI secolo alla fine della corsa nel 1830: non si va lontani dal vero stimandolo intorno ai due milioni di individui , per lo più italiani , in particolare meridionali. Di essi appena il 10-15 % riuscì, dopo un periodo medio di sfruttamento servile di almeno un decennio , trascorso spesso in condizioni disumane, a recuperare la libertà previo pagamento di un cospicuo riscatto. Considerando che un'imbarcazione corsara in [
un'incursione estremamente fortunata riusciva ad imbarcare al ma s simo IOO prigionieri, l'utile massimo non eccedeva i 15.000 scudi: meno del valore del carico di un solo mercantile!
Un ultimo dato interessante è la progressiva ed irreversibile contrazione del numero degli schiavi cristiani in Algeri , la indubbia capitale della corsa, dal! ' entrata in servizio delle torri. Fin quasi al 1580 le cronache ci tramandano mediamente 35.000 presenze annue, ammontare che inizia, dapprima lentamente quindi rapidamente a decrescere con 1'avanzare del XVII secolo, attestandosi sul suo finire a poco meno di un migliaio. Appena inferiore la situazione di Tunisi e di Tripoli , seguite a discreta distanza dalle altre città nordafricane. Da una serie di riscontri deve ritenersi che il completo ricambio della popolazione servile avvenisse nell ' arco di un quinquennio, per decesso o per riscatto. La mortalità fu sempre altissima sia per la brutalità della sorveglianza e delle punizioni, sia per la frequenza delle epidemie , endemiche per l ' altissima densità delle città islamiche e le loro pessime condizioni igieniche. Dal che , applicando le stime innanzi esposte, è facile ricavare che nella sola Algeri la tratta degli schiavi ad opera dei cors ari forniva introiti annuali per oltre un milione di scudi! La cifra immensa per l ' epoca, non trova un evidente con-ispettivo nello sviluppo e nel lusso che la città ostentò nella seconda metà del ' 500. La ragione va ascritta al costante ritorno in Europa di gran parte di quel denaro, per gli acquisti di materiale per costruzioni navali ed armamenti indispensabili al prosieguo della corsa, il che spiega implicitamente una delle ragioni del perdurare di tanto abom inio.
Come fu possibile, infatti, che covi famosi di delinquenti di ogni risma e nazionalità, crocevia di tante aberrazioni e violenze potessero sopravvivere sostanzialmente indisturbati per oltre tre secoli, vessando e grassando alcune tra le maggiori potenze europee, senza subirne le intuibili e devastanti rappresaglie? La spiegazione per casi del genere è abbastanza semplice: alle loro spalle esistevano almeno due livelli
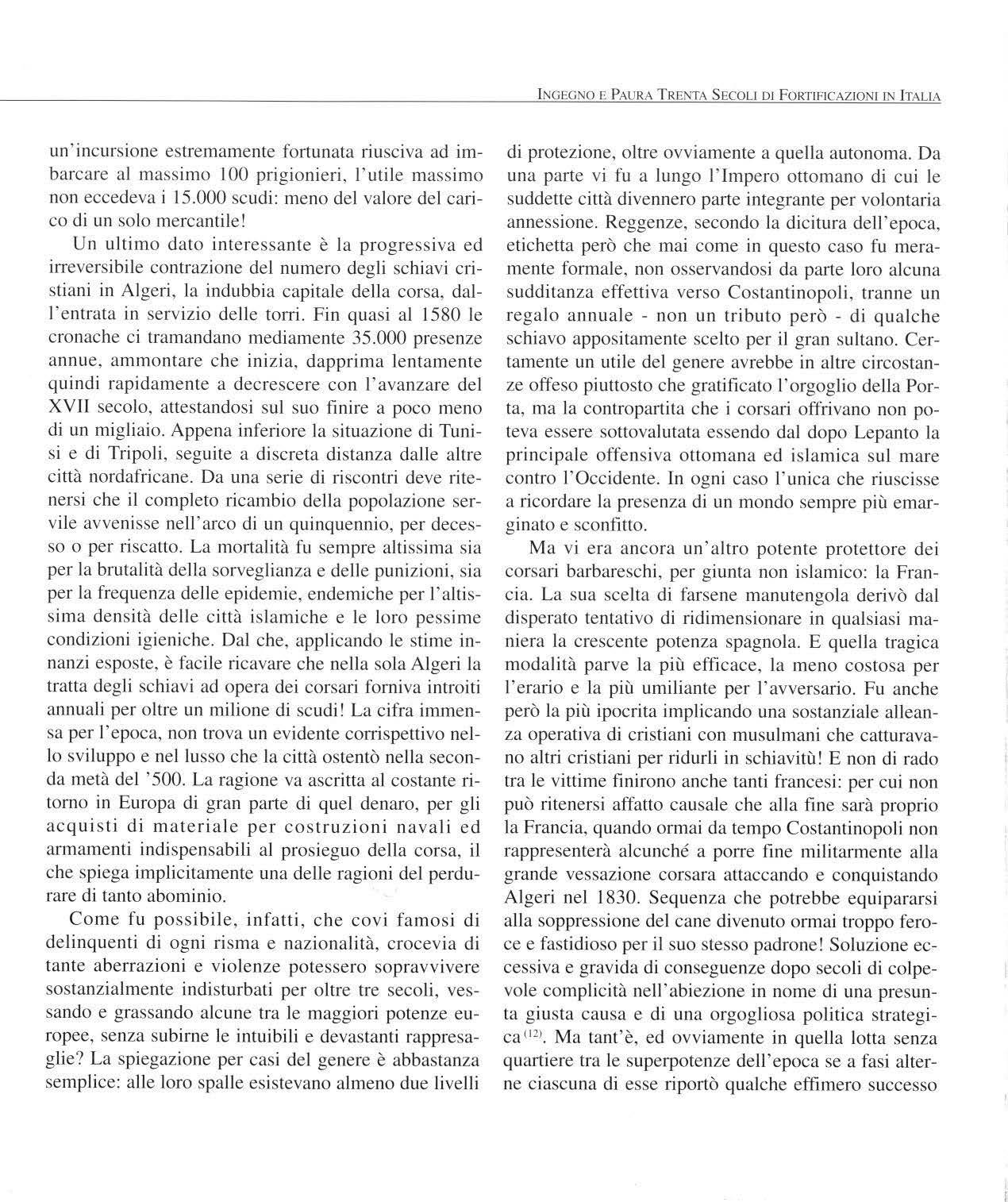
di protezione, oltre ovviamente a quella autonoma. Da una parte v i fu a lungo l ' Impero ottomano di cui le suddette città divennero parte integrante per volontaria annessione. Reggenze , secondo la dicitura dell ' epoca , etichetta però che mai come in questo caso fu meramente formale , non osservandosi da parte loro alcuna sudditanza effettiva ver s o Costantinopoli, tranne un regalo annuale - non un tributo però - di qualche schiavo appositamente scelto per il gran sultano. Certamente un utile del genere avrebbe in altre circostanze offeso piuttosto che gratificato l'orgoglio della Porta , ma la contropartita che i corsa1i offrivano non poteva essere sottovalutata essendo dal dopo Lepanto la principale offensiva ottomana ed islamica sul mare contro l ' Occidente. In ogni caso l'unica che riuscisse a ricordare la presenza di un mondo sempre più emarginato e sconfitto.
Ma vi era ancora un'altro potente protettore dei corsari barbareschi, per giunta non islamico: la Francia. La sua scelta di farsene manutengola derivò dal disperato tentativo di ridimensionare in qualsiasi maniera la crescente potenza spagnola. E quella tragica modalità parve la più efficace, la meno costosa per l'erario e la più umiliante per l'avversario. Fu anche però la più ipocrita implicando una sostanziale alleanza operativa di cristiani con musulmani che catturavano altri cristiani per ridurli in schiavitù! E non di rado tra le vittime finirono anche tanti francesi: per cui non può ritenersi affatto causale che alla fine sarà proprio la Francia, quando ormai da tempo Costantinopo l i non rappresenterà alcunché a porre fine militarmente alla grande vessazione corsara attaccando e conquistando Algeri nel 1830. Sequenza che potrebbe equipararsi alla soppress ione del cane divenuto ormai troppo feroce e fastidioso per il suo stesso padrone! Soluzione eccessiva e gravida di conseguenze dopo secoli di co lpevole complicità nell'abiezione in nome di una presunta giusta causa e di una orgogliosa politica strategica (12l Ma tant'è, ed ovviamente in quella lotta senza quartiere tra le superpotenze dell'epoca se a fasi alterne ciascuna di esse ripo1tò qualche effimero successo
te1Titoriale, o qualche altrettanto insignificante danno economico, l'esito non interferì in alcun modo con la corsa. Questa garantì sempre un ragguardevole utile, imponendo un'emorragia socio-economica. E le vittime furono altrettanto ovviamente gli abitati e gli abitanti dei centri rivieraschi più vicini alla costa nordafricana, o albanese: in pratica e nell'ordine di vessazione i sudditi del regno di Napoli, di Sicilia, di Sardegna, ed in misura progressivamente minore dello Stato Pontificio, dello Stato dei Presidi, del Granducato di Toscana, della repubblica di Genova. Per nulla azzardato, quindi, reputare la drammatica esposizione come una delle maggiori concause della tragica ed irrisolta questione meridionale <13>
Dal punto di vista difensivo ognuno dei suddetti stati, constatata l'impossibilità di eliminare il flagello militarmente, di soffocarlo politicamente, di ridurlo alla ragione con appropriate rappresaglie, od ammansirlo con cospicui donativi, finì per realizzare che l'unica contromisura capace di contenere l ' offensiva corsara sarebbe stata di tipo ostativo. Sarebbe occorso un dispositivo perimetricamente continuo, una sorta di muraglia virtuale capace di chiudere drasticamente il litorale alle razzie. Una muraglia che poteva intorno alla metà del XVI secolo realizzarsi in parte con strutture materiali in parte con traiettorie balistiche. Occorreva soltanto vagliarne accortamente le connotazioni ottimali e le sue articolazioni migliori in funzione della difesa anticorsara globa l e. E logicamente lo stato p i ù interessato, in quanto maggiormente vittima della corsa ed in quanto più grande per uomini e mezzi fu il Regno di Napoli che non a caso fu il primo a studiare ed a dotarsi di un dispositivo di difesa costiera anticorsara lungo oltre 2000 km.

ra rilevare che quasi i due terzi delle realizzazioni vennero edificate, o riqualificate , per fronteggiare quel pericolo , massimamente lungo le fasce costiere mediterranee. 11 perché è abbastanza semplice da spiegare: da un lato, infatti, la spinta espansiva ottomana sia militare che corsara si manifestò fondamentalmente con attacchi ed incursioni da mare; dall'altro perché le fortificazioni moderne, integrate con l'ultima generazione di artiglierie si dimostrarono efficaci e quindi tatticamente paganti.
Un'epidermica verifica di quanto delineato la si può agevolmente cogliere nella scansione cronologica dei grandi attacchi turchi, tra quello che catturò e deportò l'intera popolazione di Otranto nel 1480 e quello che devastò in Friuli traendo in schiavitù un numero persino maggiore di disgraziati abitanti intercorsero appena 19 anni. Occorsero però ben 58 anni per registrare con l ' attacco a Massa Lubrense e Sorrento una identica tragedia, che si dimostrò l'ultima del genere. E se da quel momento 1' iniziativa offensiva fu soltanto sostenuta dalle razzie corsare ciò dipese non dal semplicistico esaurimento della volontà aggressiva, mai venuta meno , ma dalla constatazione dell'incapacità di aver ragione delle fortificazioni occidentali.
Come evidenziato in apertura, la fortificazione moderna in Europa e soprattutto in I talia, è fortemente condizionata da ll a minaccia turca li ~> Si può addirittu-
Pertanto se agli inizi del XVI secolo il massimo sforzo fu rivolto all'approntamento di una linea di piazzeforti, o di città fortificate costiere, in modo da frustrare tentativi d'invasione ottomana, dalla metà dello stesso secolo la tipologia fortificatoria più adottata è finalizzata a frustrare gli assalti corsari. Il che praticamente in tutti gli stati italiani preunitari equivalse all ' erezione ed all'attivazione di sistemi di control l o attivo delle frontiere marittime mediante catene di torri armate. Sistemi che al di là del!' apparente identità in realtà furono notevolmente diversi fra loro, ciascuno calibrato in funzione della specificità dei rischi e delle disponibilità di risorse sociali, economiche e tecnologiche. Logiche d ' impianto diverse, torri diverse, armamenti diversi che dopo circa quattro secoli dall'entrata in servizio finiscono però tutti nel comune calderone del la dicitura di torri saracene , o [
per i più dotti di torri d'avvistamento approssimazioni che obbligano perciò, data la pennanenza di ancora un migliaio di tali m a nufatti a tracciarne una più puntuale desc ri zio ne, preceduta da un s int et ico ap profondime nto s ull a concezione stessa di difesa anticorsara e di guerra di co rsa
L'impi ego di torri a scopo difensivo si perde nella notte dei tempi. l so late o variamente raccordate da mura g lie , se ne eressero innumerevoli in og ni epoca, persino nel corso della Il Gue1Ta Mondiale. Simili a gigantesche se ntin e ll e di pietra, le torri hanno da sempre asso l to a tre funzioni bas il ari: di avvistamento, di difesa del presidio e dei v ic ini , e soprattu tto di offesa degli aggresso ri. Ora essendo l'avvistamento espletato se nza interruzione per l' int era v ita o perati va di una torre, mentre la difesa e l'offesa so l o molto sa ltuaii amente, non di rado m ai, non presentandosene la n ecess it à, finì per d ivenirne la qualifica per anto nomasia Torri d'avvistamento quindi, passive vedette, assolutamente pri ve di reatt iv it à: sempl ificazione che purtropp o ne ha inficiato un corretto approccio, a nche turi s ti co.
D al punto di vista s torico l'impianto di torri lungo le coste, ha effettivamente un a ge nes i eminentemen te p assiva, me ri s upporti per vedette , indi spe nsabili per conse nt i re di s up era re con la loro a l tezza l ' intrico della macc hi a mediteITanea e sc rut ar e liberamente l' or izzo nt e. Funzione c he s i ri scontra esp le ta ta già agl i albori della c iv iltà, qu a ndo comme r c iare e pirateggiare e rano pratiche compl eme ntari e no n disprezzate, dei navigatori. Vitale distinguere con il massimo anticipo le imbarcazion i amiche da que1Je ostili, o sos pette . L a s itua z ion e, protrattasi per ol tr e un mill e nnio , cessò sol tanto quanto l ' Imp ero romano circondò l'intero Mediterra neo determinando, s itu az ion e m a i più ripropostasi, il suo comp leto co ntroll o senza bisogno di nav i. Essendo a qu e l punto qualsiasi azione piratesca un crimine interno fu e ne r gicame nte perseguita e s pi etatamente st roncata. L e toni furono pe rc iò dismesse, o trasformate in pa c ifi c i fari: ce leb ri quella di T rapani,
l' a nti chiss im a ·Colombara' , e quella di Messina, il 'Faro ' per antonomasia, nonché la cosiddetta torre dell a Serpe di Otranto.
L a recuperata sicurezza durò poche centinaia dianni , dissolvendosi tragicamente con l o sgreto larsi dell'Impero. In breve si r i gene rò l 'e nd em ico flagello della pirateria, incentivato dal l'inesistenza di qualsiasi apparato difensivo. La morte di Maometto nel 632 1151 , avviando la prim a espans i o ne is l am ica ne determinò l ' ult eriore incre m e nt o . Per le ma1ine occidentali f u il prodromo dell'abbandono, unica alternativa a l.le massicce mura di cinta. Solo c hiud endosi in poderose fortificazioni s i poteva sperare di scampare alle scorrerie dei Vandali od alle razzie de i Saraceni 116l De l tutto velleitarie le con tromi s ure navali bizantine, che finirono per decadere in stagionali scorribande marittime, non dissimili dalle incursioni musulmane a cacc ia di bottino. E per q ue 1Ja sp ietata beli igera nza la dirigenza imperiale riesumò la vecchia voce verbale kurseo, essendo la più calzante al fenomeno e per co nseguenza corsari ne divennero i protagonisti. Definizioni e prassi dest inate ad avere un portentoso futuro ancora non del tutto esaurito, ad onta delle p eriod ic h e riproclamazioni dei diritti dell'uomo e del l a messa a l bando dei c rimjni co ntro l'uma nit à C17,.
La bipartizione del Mediterraneo tra un occidente cristiano ed un o ri e nt e islamico , pervase ben presto ogni rapporto fra gli opposti schierament i. I1 Jahad prima e le Crociate poi, lungi dal favorire l'instaurarsi di un minimo di tolleranza, esaspera ron o, in vece, la contesa. L a g uerra di corsa si radicalizzò, ass um e ndo le caratteristiche di uno scontro ideologico efferato, incessante e remun erativo. L'a ncestra le predisposizione delle e tni e nom adi al l a razz ia e la miseria delle loro società, dete1minò i l proliferare di corsari mu sul m an i , o sedicent i tali, trasformando la corsa in un monopolio is l amico. L a violenza delle incursioni su ll e po po laz io ni rivierasche italiane traspare evide nt e in innumerevoli rievocaz io ni a rti st ic he, folcloristiche e consuetudinarie.
Pe r tutt e valgano le notissime strofe .. presenti in og ni ambito dialettale dalla Li gmia alla S ic ili a:
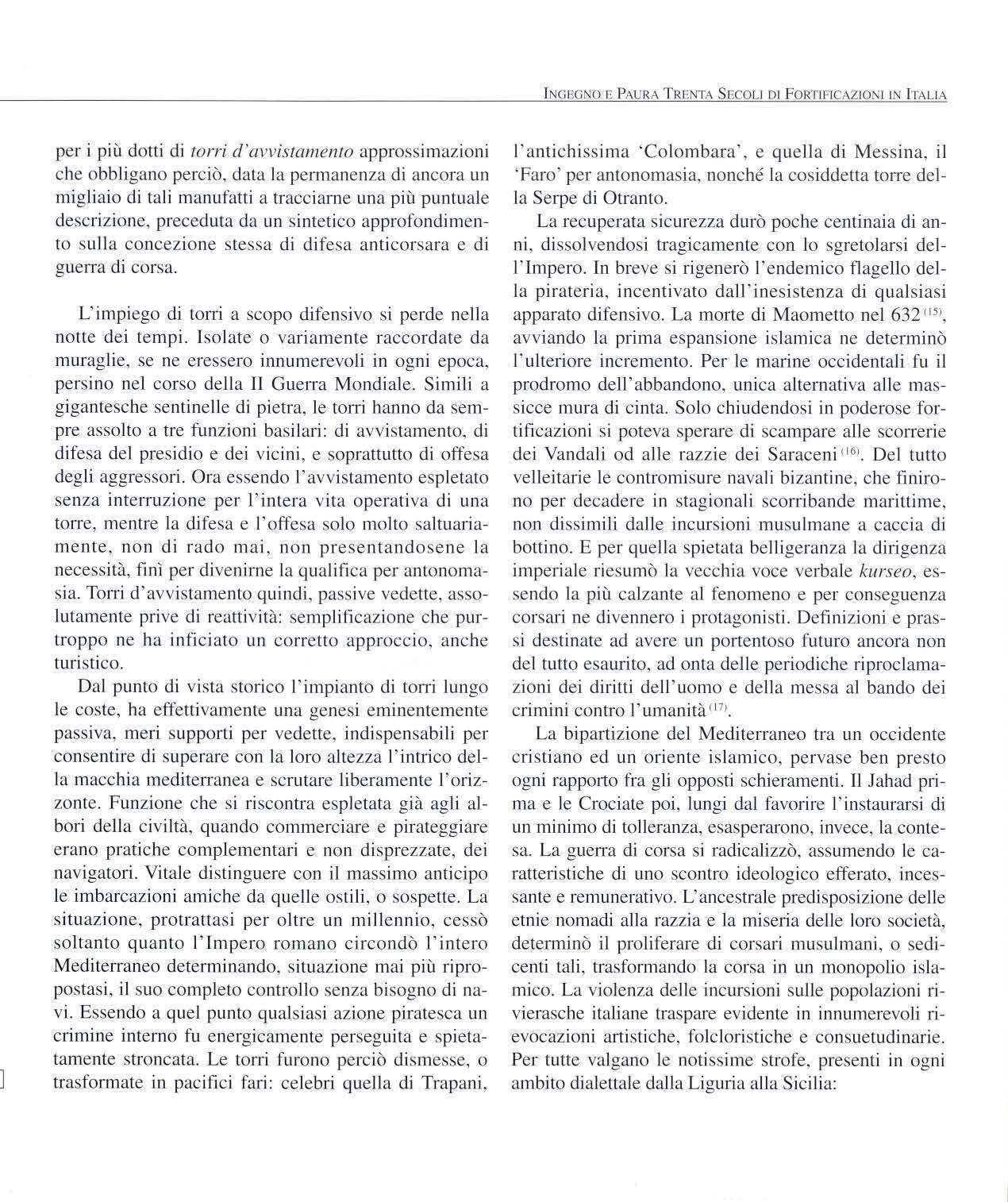

A tocchi a tocchi a tocchi la campana sona
Li turchi so' calati alla marina
Circa il riferimento ai rintocchi della campana, va precisato che per secoli il suonare a stormo o da un campanile o da un rara t01Te costiera suggerì l'unico rimedio alle incursioni: la fuga! Del resto a nessuno sarebbe venuto in mente di poter respingere uno sbarco di centinaia di predoni con qualche tiro di balestra. E se allontanarsi dalla sponda del mare costituiva la salvezza di chi vi abitava, cercare di g uadagnarla rappresentava l'estrema s peranza di ogni marittimo al profilarsi di un battello corsaro. Il che contribuì a far navigare le imbarcazioni dell'epoca ancor più aderenti alla costa. Rimedio che tentando di limitare i 1ischi fin} rapidamente per incrementarli, dimostrando s i facilissimo per i Barbareschi appostarsi dietro un promontorio, scattando fulminei a forza di remi non appena un ignaro mercantile lo avesse doppiato. Jmpos s ibile per la disgraziata vittima qualsiasi manovra elusiva: nel giro di pochi secondi finiva abbordata e catturata. 1 rarissimi superstiti si ritennero se mpre dei miracolati, e gli ex voto lo te stimoniano eloquentemente e 181 • La gravità della situazione suggerì cli abbinare al suono delle campane dei segnali a fuoco a fumo , percepibili a differenza dei primi anche da bordo. fornendo così un chiaro avviso ai naviganti 1191 •

La so luzione dovette confermarsi valida, tant'è che le torri si moltiplicarono. In pratica ogni abitato, ogni porticciolo, ogni ancoraggio finì per erigerne una, più o meno grande più o meno robusta. Fu allora ovvio collegare fra loro molte torri, magari costruendone altre con funzione di raccordo, in modo da consentire tramite il rilancio del segnale un preallruu1e maggiore. Potenzialità che pe1metteva di far confluire neUe zone minacciate nugoli di cavalleria miliziana, antesignana contromisura dissuasiva. Un sistema del genere nel Regno di Napoli 1isulta attivo già sotto Crufo I d'Angiò , intorno alla fine del XIIl secolo 1201 • Analogie non mancano tuttavia anche in Sicilia ed altrove. La successiva dinastia aragonese incrementò lo schieramento delle torri costiere edificandone , anche in Sardegna e persino in Corsica, cli nuove più
tozze e mas sicce delle precedenti , che finirono perciò quasi sempre o demolite o inglobate. La ragione di quel ridondante dimensionamento deve ricondursi al diffondersi delle rudimentali armi da fuoco. Solo una fortificazione sufficientemente solida e larga poteva sopportare le sollecitazioni delle arcaiche bombarde, le quali nonostante la risaputa insignificante cadenza dì tiro e l'approssimatissima punteria costituivano se non altro un deteITente anticorsaro (2 11 • Senza contru·e che il terribile boato di quei pezzi , ostentava una inequivocabile eloquenza capace cli scuotere dal sonno più profondo.
Anche in questo caso il positivo riscontrn fornito da siffatte torri costiere s uggerì di ru·marle, per analogia di bersagli, esattamente come le coeve imbarcazioni.
lNGEGNO E PA URA TRENTA SECOLI DI fORTlFIC AZ IO'JI IN ITALI ,\ 208 Cercola. NapoLi. santuari o della Madonna dell ' Arco: ex-voto di marittimi di piano di Sorremo ridotti in schjavitù dai barbareschi.quando s ul finire del XV secolo le artig l ie1ie superarono finalme nt e una int e rmin abile infan z i a, diversificandos i e specializzandosi in funzione de ll 'i mpi ego, occorsero meno di cinq ua n t'a nni per di s porne di squisitam ente navali. Cannoni c io è c he per dimen s ioni , s truttura e d affus to ri vol uzionaro no g li sco ntri s ui mari ed, ovv iam e nte, anche la difesa costiera, che mai come in quel particolare scorc io stori co sem bra va del tutto impotente co ntro l'e s plodere della co rsa .
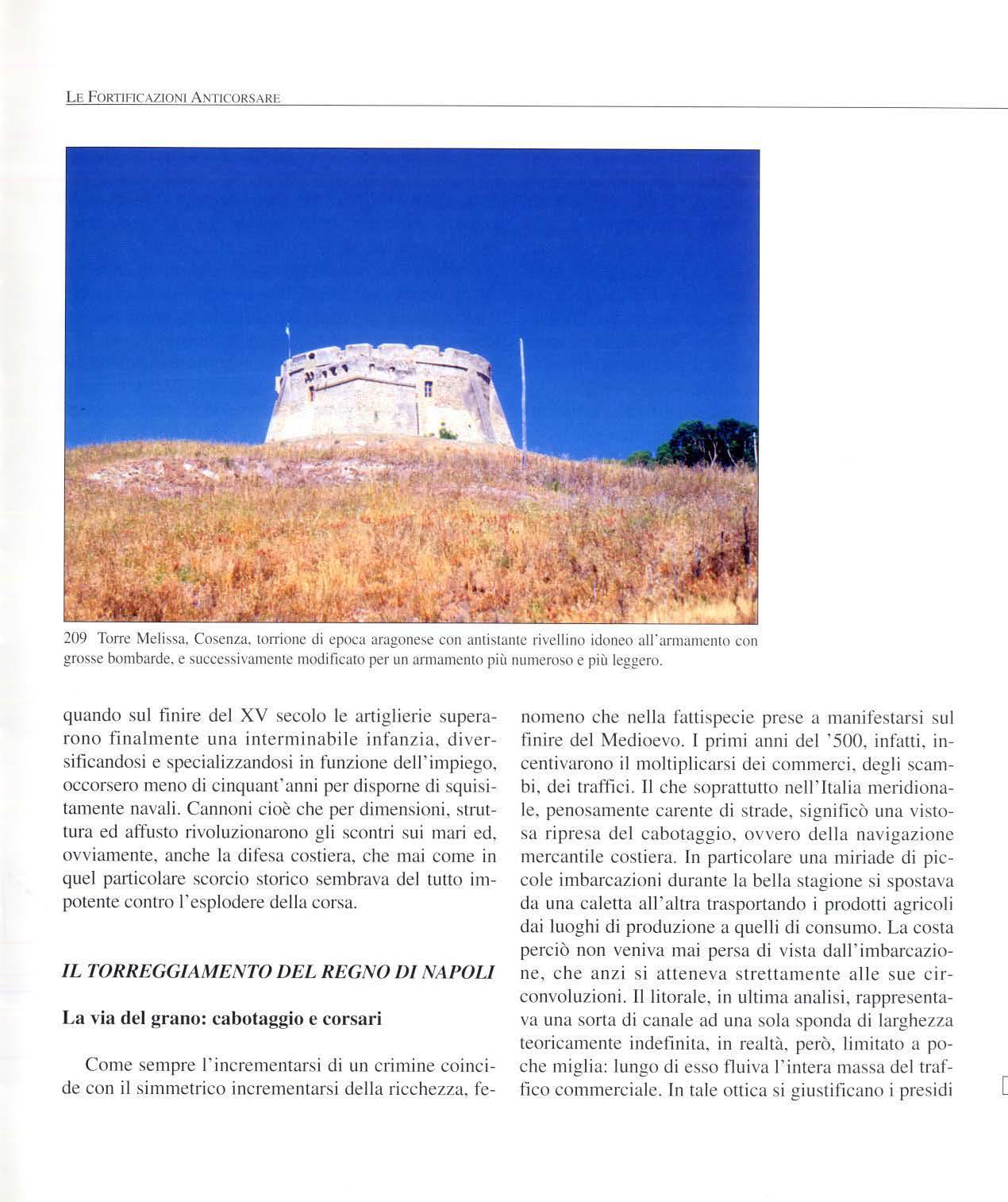
La vi a d el g ran o: c ab o taggio e corsar i
Come sem pre l'incrementarsi di un crimine co incide con il s imm etrico incrementars i della ri cc hezza, fe-
nomeno c he nella fa tti s peci e prese a manifestarsi sul fi nire del Med ioevo . I p1irni anni del '500, i nfatti, incen ti varo no il moltiplicarsi de i commerci, deg li scambi, dei traffici. Il che sopratt utt o nell'It a li a meiidionale, penosamente carente di s trade , s ignificò una vistosa ripresa del cabotagg i o, ovvero della navi gazio ne me rc ant il e costiera. ln pa,ticolare una miriade di picco le imbarcazioni durante la bella s tagione s i s postava da una ca le tta a ll'altra trasporta nd o i prodotti agrico li dai luo ghi di produzione a qu e lli di consumo. L a costa perciò non veniva mai pe rsa di vista dall ' imb arcazion e, c h e a n z i si a tt e neva s tr e tt amente a ll e s ue ci rco nvo lu z ioni. Il litoral e, in ultima analisi, rappresentava una so rta di canale ad una so la s ponda di l a rghe zza teoricamente indefini ta, in realtà, p e rò , limitato a poche migli a: lungo di esso fluiva l'intera massa de l traffico commerciale. In tale ottica s i g iu s tificano i pres idi [
di Orbetello, Porto S. Stefano e Porto Ercole , che garantivano all ' Impero spagnolo la discrezionalità s ulle rotte da e per Genova e l'alto TiJTeno (221 • ln quella stretta fascia, pertanto, circolava la maggiore aliquota dei trasporti commerciali, senza soluzione di continuità < 231 • E tanta abbondanza di potenziali prede finì per richiamare branchi di predoni del mare! I corsari barbareschi, infatti, potevano facilmente assalire, abbordare e rimorchiare i mercantili sorpresi lungo quella stretta via d'acqua frequentatissima, semplicemente comparendo ali' improvviso, dopo essere rimasti in agguato dietro uno scoglio od un promontorio. La temibilissima insidia contribuiva a far navigare lungo rotte ancora più aderenti alla costa per gettarvisi rapidamente, spesso anche a nuoto, al minimo profilarsi di battelli sconosciuti.
Le ridotte dimensioni della stragrande maggioranza del naviglio impiegato nel cabotaggio lo rendevano assolutamente inadatto a difendersi imbarcando artiglierie o armi da fuoco in genere, come illusorie disposizioni insistentemente cercarono per secoli di stimolare <~4 1 • Del resto anche fra i più grossi vascelli soltanto una ristretta frazione si risolse in tal senso. Gli armatori furono sempre contrari, non tanto per l'alto costo delle armi e delle munizioni, ma soprattutto perché fortemente restii a trasformare le loro navi in incrociatori ausiliari. A loro volta gli equipaggi preferivano , senza alcuna eccezione, cercare la salvezza nella foga con le lance , abbandonando la nave, piuttosto che abbozzare una sterile difesa, esponendosi poi alle immancabili vendette dei corsari nel caso di probabilissima cattura.
La fagocitazione del Regno di Napoli, al pari di quello di Sicilia e di Sardegna nell'Impero spagnolo , scandì la sua tragica equiparazione ad antemurale nella guemt contro l'Impero ottomano. Su di esso perciò s i abbatterono con crescente frequenza le incursioni corsare. In breve il cabotaggio fu stroncato , gli abitati rivieraschi abbandonati e l'imposizione fiscale divenuta insostenibile, per sopperire agli oneri della difesa , moltiplicò il numero dei miserabili. Schiere di de-
relitti iniziarono perciò a riversars i su Napoli, attratti dalle sue ri sapute e s en z ioni tributa1ie e dal miraggio di un qualsia s i lavoro. In pochi decenni il numero di abitanti della Capitale si moltiplicò a dismisura , creando problemi altrettanto smisurati per l'ordine e la sanità pubblica, e soprattutto per l'alimentazione <25 > _
Intorno alla metà del '500. come delineato , Napoli è la città più popolosa del Mediterraneo. Indispensabile perciò un continuo approvvigionamento di viveri in notevoli quantità. Le campagne circostanti non sono assolutamente in grado di sopperire all'enorme esigenza di derrate: manca soprattutto il grano. Al pari dell ' olio non difetta nel Regno, producendosene in straordinaria abbondanza in Puglia, per cui sarebbe bastato farne incetta sulle sue a s solate pianure e convogliarlo nella capitale: ma come? li vero problema era appunto quello. Alla luce dei moderni mezzi di trasporto, su strada o su rotaia la questione non si pone nemmeno.
Volendo, per semplicità di calcolo , assumere la razione quotidiana per abitante pari a 300 grammi , entità esigua anche in tempo di guerra, se ne ricava un totale di quasi 90 tonnellate. Le cronache, in realtà tramandano una quantità s ensibilmente inferiore , pari ad un terzo , riprova, se mai ve ne fosse bisogno , dell'indigenza vigente 126 i Nonostante ciò sarebbero occorsi quasi cento carri , tirati da diverse centinaia di buoi , in continuo movimento lungo un itinerario di oltre 200 km. Mancava la strada, mancavano i cani, mancavano i buoi mi : ma anche dandone per scontata la disponibilità, quanto foraggio avrebbero divorato i pazienti animali nella decina di giorni di traino? Molto di più della quantità di cereale trasportato, per cui inutile persino pensarci. L'unica via praticabile restava , e doveva restare praticabile a qualsiasi costo, il trasporto via mare , che per una serie di ragioni squisitamente marittime non poteva effettuarsi soltanto d'inverno quando la corsa era quiescente. Va infatti evidenziato che il prezioso cereale costituiva una delle prede più ambite e remunerative per i corsari, essendo insufficiente quello prodotto in Nordafrica. Non a caso, nei
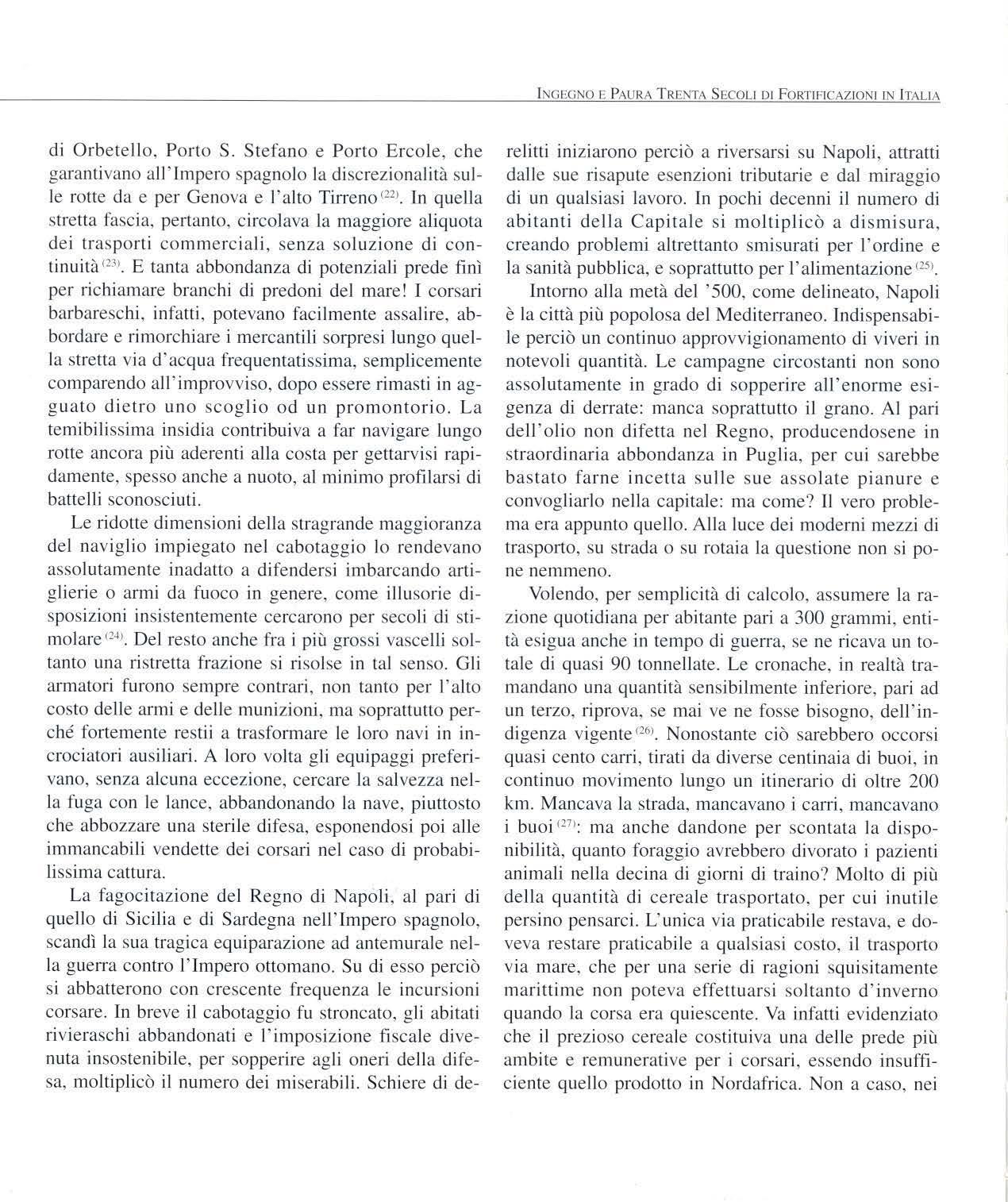
secoli precedenti, molti stati magrebini avevano regolarmente acquistato grano in Puglia ed in Sicilia, senza alcuna recriminazione <281 • Il fanatismo e l ' intolleranza religiosa, caratteristiche tipiche della Spagna imperiale cinquecentesca, vietandone r esportazione , annientarono quel delicato equilibrio commerciale vigente tra le due sponde. Considerazioni strategiche posteriori ribadirono tassativamente l'interdizione e per conseguenza molti corsari si specializzarono nella caccia ai mercantili ed ai convogli carichi di grano. Fu questo il motivo che rese particolarmente pericoloso il mestiere di marittimo, implicando per giunta ogni periplo quasi un mese di navigazione. Ovvio che il dispositivo di difesa anticorsara che i viceré spagnoli si accingevano a varare fosse auspicato, ancor più dalle popolazioni rivierasche, proprio dalla derelitta categoria con immaginabile partecipazione. Del resto la difesa dei mercantili in rotta dalla Puglia <29 > ostentava indubbie valenze politiche delle quali i viceré si dimostrarono sempre estremamente consapevoli. Il far per-
venire regolarmente il grano a Napoli, infatti, non costiluiva una conferma della sensibilità dei governanti verso i suoi abitanti, ma soltanto un efficace espediente per evitarne le paventate rivolte popolari, che di tanto in tanto esplodevano con inaudita ferocia. Il che obbligava ad escogitare un sistema di difesa costiera capace di proteggere anche le imbarcazioni naviganti lungo le coste, senza nulla logliere alla protezione degli abitati, non fosse altro che per giustificarne il mantenimento economico da parte degli stessi. Pertanto come si era drasticamente frustrata la minaccia invasiva ottomana tramite un 'efficace catena di piazzeforti marittime, si sarebbe dovuto tenere sotto controllo quella corsara. tramite un'ininterrotta catena di torri costiere armate con i moderni cannoni navali, ormai pienamente disponibili.
Molti autorevoli storici hanno sempre sostenuta la tesi che una vera e più efficace difesa anticorsara del Regno si sarebbe potuta, e dovuta, effettuare sul mare. Una nutrita flotta di unità da guerra pattugliando la

frontiera marittima, sorvegliando le rotte e magari attaccando i covi corsari avrebbe dapprima annientato le incurs ioni e quindi estirpato il crimine stesso. Quanto poi al perché della mancata attuazione di un progetto tanto ovvio e risolutivo, vengono accampate motivazioni politich e, per tutte quelle dell'opposizione spagnola alla creazione di uno st rum e nto bellico tanto potente da la sc iare poi nell e mani di sud diti più o meno infidi <30> ln realtà però la causa fu sem pre e soltanto economica, occorrendo per una iniziativa del genere una disponibilità di ri sorse lontanissime da quelle del Regno e non ultimo di forzati per i re mi. Ogni galera, infatti , ne richiedeva dai 180 ai 300, e ntità perciò che ascendeva ad oltre 15.000 per una squadra di so le cinquanta unità , tenendo conto delle immancabili sostituzioni per infermità, morte , ecc. 15.000 individui che oltre ad essere in qualsiasi modo acquisiti, o acquistati , dovevano incessa ntemente essere nutriti , custoditi e so r veg liati per oltre sei mesi l'anno in appositi reclu so ri , meglio noti come bagni. E nonostante la cinica buona vo lontà dei tribunali, l'intero Reg no mai di spose di tanti condannati, ovviamente dai requisiti fisici compatibili con il massacrante impiego. Quanto poi all ' approvvigionamento di sc hiavi musulmani, di ingentissimo costo avendo tutte le marinerie dell'epoca l'identica esigenza, l'offerta fu sempre cli gran lunga inferiore ai bisogni.

Tra sc urando per semplicità tutti i menzionati insormontabili ostacoli, quale sa rebbe stato l 'effe ttivo apporto di una cinquantina di galere diluite lungo un perimetro di oltre 2000 km rispetto alla ventina concretamente disponibile? Attualmente la so la costa pugliese è sorvegliata costantemente d a sofisticati impianti radar, per lustrata giorno e notte da decine di velocissime motovedette, scrutata da frequenti so rvoli di elicotteri, solcata da innumerevoli unità navali mercantili e militari , eppure qua si ogni notte battelli di clandestini riescono ad atterrare su di essa. Un barcone ogni 40 km di litorale quale guardia avrebbe potuto espletare? E quante probabilità avrebbe avuto di avvistare un ' unità corsara in avvicinamento o di incocciarla in fase
di attacco? Praticam ente insignificante la differenza tra quella flotta meramente teorica, quanto irraggiungibile, e quella regnicola. Nel 1798, quando nessuna restrizion e spagno la impediva al Regno di Napoli di incrementare la sua flotta, peraltro ormai affatto insignificante, il s uo comandante in capo, certamente competente in materia più dì un qualsiasi moderno studioso, scriveva al riguardo: " in idea generica non si crede di alcuna utilità un corso di Legni da Guerra sciolti, che vadano nella vastità dei Mari cercando i Corsari nemici, essendo riflessione dolorosa, ma vera . che i Corsari Barbareschi preparati per una scappata di pochi giorni hanno un cammino molto superiore; onde in tutte le cacce contro i medesimi nella proporzione di dieci, uno sarà predato dai nostri Legni, e nove sono solamente scacciati da un luogo all'altro, e se non possono fare prede dentro il limitato Orizzonte del Legno da Guerra, che gli ha scoperti, e inutilmente inseguiti, passano in poche ore a fare prede in mille altri punti inosservati e soli ... " (3 1l
Si spiega così la s traordin aria impunità operativa goduta dai corsari , che appaiono quasi immuni ad ogni cattura e sembrano sfuggire fortunosamente alle infinite perlustrazioni ed ai minuziosi pattugliamenti espletati sistematicamente dalle galere della flotta ispano-napo letana- s iciliana , da quella veneziana, da quelle de i due ordini militari di Malta e S. Stefano. Queste vo lendo tentare un stima ammontavano , sempre alla stessa epoca, a circa 60 quelle di Venezia, a 10 quelle dello Stato Pontificio e dell ' Ordine Stefaniano, a 4 quelle di Malta e a 50 al massi mo quelle spagno le. Ad opporvisi, e ludendone la vigilanza, un nugolo di battelli di tutte le dimensioni composti da un centinaio di unità d'as sa l to maggiori, oltre ad una pletora di imbarca zioni minori ed ausiliarie, di improba quanti zzazione 132 J _ Circa la tipologia prevalente si trattava per lo più di fuste, unit à dai requi siti ideali per l'attività corsara fra il XVI-XVII secolo, appena più piccola della famigerata galera ma quasi sempre con un maggior rapporto peso/potenza mi In sos tanza un 'imbarcazione molto sottile, di notevo le finezza, lunga circa
INGEGNO E PAURA TRE NTA SE COLI D I fORTIFICAZIONI IN l TAL!A50 m e larga 4 m. Scarsissimo il pescaggio, mai superi ore a 1.5m e pressappoco equivalente l ' altezza dell'unico ponte sul galleggiamento. La propulsione era remi ca per gli spostamenti veloci, le manovre, gli atterraggi e gli abbordaggi, velica per le crociere di trasferimento e caccia. In questo caso un unico albero, facilmente ammainabile lungo la corsia per meglio mimetizzarsi, ne sopportava la grossa vela latina. Normalmente contava dai 18 ai 22 banchi di voga per lato con due uomini per remo, non di rado persino quattro, fittamente costipati sull'unico ponte, divisi in due bande: configurazione e connotazioni praticamente identiche alla galera per prestazioni migliori. Unico loro vero limite, comune ad entrambe, la risicata autonomia idrica mai eccedente i cinque-sei giorni. Indispensabili perciò le famose acquate, ovvero i rifornimenti presso le foci dei fiumi, prassi risaputa e pertanto di fondamentale interdizione nel dispositivo anticorsaro. Un'altra prestazione critica delle fuste di cui si tenne debito conto fu la loro velocità di navigazione a vela. In tale circostanza, indispensabile per disporre di ciurme pronte allo sforzo al momento opportuno t 34 i, la fusta non superava i cinque nodi. Poiché anche i corsari navigavano lungo la costa, i I loro avvistamento prontamente trasmesso con segnali ottici li precedeva non di rado di alcuni giorni, consentendo perciò di predisporre gli opportuni rimedi, consistenti nei casi più gravi nell'evacuazione dell'intera fascia costiera con l'arresto della navigazione commerciale. Ed anche di tale opportunità il dispositivo difensivo tenne debito conto, adeguando la catena di torri alla funzione di stazioni semaforiche di ricetrasmissione degli avvistamenti, in maniera da scongiurare simili paventatissime sorprese 135 J Tuttavia fu solo col superamento dell'avvilente sorveglianza, cioè dell ' aleatorio allarme lanciato con il suono della campana o della brogna, che la difesa anticorsara poté iniziare a definirsi realmente tale. Il che avvenne, come accennato, quando fu concretamente possibile cannoneggiare le unità corsare in fase di atterraggio o di agguato, ovvero quando la tecnologia rese disponibili artiglierie ad
anima prolungata ed a sezione maggiorata , propriamente definite navali. Cannoni acco1tamente progettati per tirare rapidamente e con una traiettoria tesa più lunga contro bersagli fragili e sfuggenti. Nati per colpire le navi tirando dal ponte di altre navi pezzi siffatti garantivano prestazioni persino migliori quando tiravano da terra.
La difesa costiera continua proprio per i suoi immensi sviluppi , e quindi costi, è da sempre funzione di un preciso progetto d'intenti, con rigidissimi parametri da soddisfare. Di essi senza dubbio condizionante è quello del tempo di resistenza in opposizione ad un ben determinato nemico, che essendo tradizionalmente noto è altrettanto abitualmente definito nelle sue potenzialità offensive. È talmente vincolante que s to dimensionamento che, lungo le marine italiane a partire dallo scadere del medioevo, si iniziarono ad approntare due diversi sistemi di interdizione costiera , antinvasivo ed antincursivo. Precipue le relative fortificazioni calibrate per le antitetiche esigenze, non potendosi sopperire all'una potenziando le piazzeforti del primo o all'altra moltiplicando i capisaldi del secondo. Ed in ciò giocò la notevole evoluzione del I' ingegneria militare che si manifestò sul finire del Medioevo.
Indubbiamente la consapevolezza della superiorità della propria ingegneria militare fece prefeiire la condotta difensiva a quella offensiva. E se interessi strategici obbligavano le armate ottomane a cimentarsi contro le fortificazioni occidentali con investimenti ossidionali, puntualmente risoltisi in altrettante allucinanti ecatombi, persino quando coronati da successo, nessuna ragione spingeva i corsari barbareschi a seguirne l'esempio. Per cui evitarono accuratamente ogni contatto persino con le opere più elementari quali appunto una torre dalla cui reazione balistica avevano tutto da perdere e dalla cui conquista nulla da guadagnare.

L'avve nto di un· artiglieria m o derna , le ggera ed e fficace re se perciò finalment e attuabile que ll o che inutilme nte s i andava e lu c ubrand o da tempo: la difesa a tti va e continua, quasi una chiu. ur a virtuale, dell'int era frontiera marittima. Facile concret izzar la tramit e l'impianto opportunamente scag lionato di piccole p ostaz io ni d i a rtiglieria . L'opzione o ltre ad offrire alle popolazioni riviera sc he una s ufficiente ga ranzia esistenz ial e. consent iva. con opportune s oluzioni c irca il tipo di s truttura da impie gare , d i e tend ere un· efficaciss ima protez ione al ca botag gio.
Prim a della metà del '500 ipoti zzare torri in grado di batt e re co n i loro ca nnoni lo pecchi o di mare anticante, in te mpo util e e con tiro mirato efficace appariva mera utopia. L e coeve bombarde, p es anti ss ime e di infima caden za cli fuoco , non consentivano alcuna illu s ione al rigu a rd o: tirar e a ll e imbar caz ioni. certamente fra g ili ssime, ma altrettanto certamente sfu gge nti esulava dalle l oro potenzialità n61• I rari toriioni appo s itam e nte eretti ostentavano dimen io ni colo~. ali. ve ri castelli s ul m a re, co n esiti 1idic o li . B e n di ve r e le caratterist iche e l e pre s tazioni delle artiglierie navali e l aborate appe na pochi de ce nni dopo. a com in c iare dai loro ag ili affusti a quattro rotelle. a cassa. c h e posso no così s intetizza rs i:
l" Calibro modes t o. esse ndo inutili gra ndi en erg i e cinetich e residue per la fragilità dei bersagli.
2a Minim o peso del pe::,::,o e quindi di fari/e manovra e di contenuto cos to.
3a Grande celeriTà di brandeggio, m •1•ero ampia m ob ilità rota t or ia del pe::,::,o p e r seg uire lo spos tam ento dei bersa g li
4° Nolel'ole cele rit à di ca ri came n to e di punt eria, anche c on soli due serventi, e quindi alta ca d e nza di jiwco.
sa Minimo co nsumo di muni::, i o ni , req uis ito c he oltre ad abbattere i tempi di attiva::,ione ed i costi di gestione aume1/ta1 1a l'au10110111ia del ca po s aldo.
6" Estrema comra::,ione d e ll e dim e nsioni d e ll e pia::,::,ole di Tiro , d efinite architetlo11icame111e 'pia::,::,e ' .
7a Minim e so llec ita ::, i o ni di reaz ion e e quindi s trutwre di supporto, nella fa1tispecie 1orri più leggere e se mplic i.
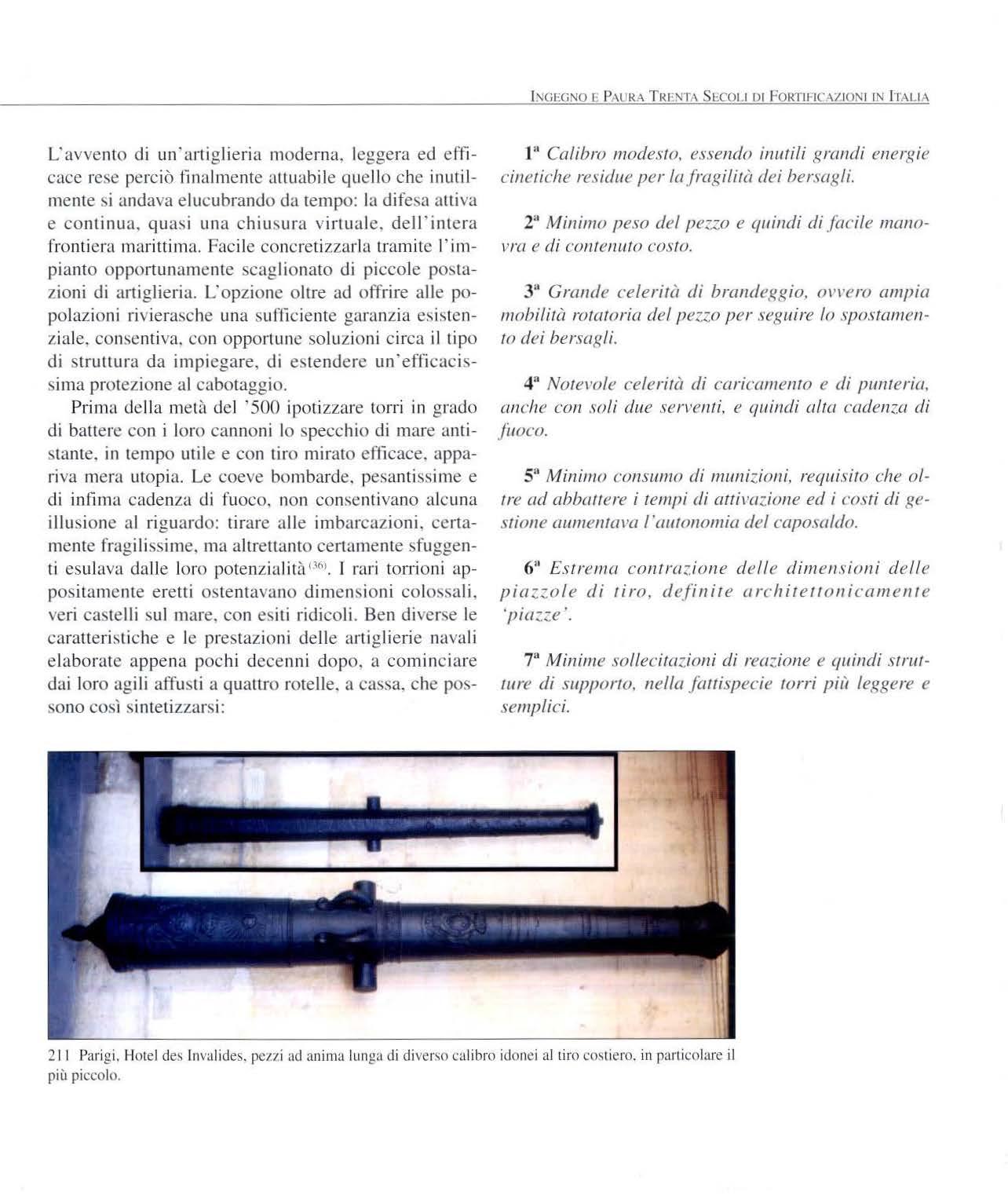 ['IGEGNO E PAURA TREN TA SECOLI DI rORTlflCAZ ION I IN I TALIA
2 11 Parigi. H otel des ln va lide s pezzi ad anima lu nga di diverso ca li bro idonei al Liro cos iiero. in pani co lare il più piccol o.
['IGEGNO E PAURA TREN TA SECOLI DI rORTlflCAZ ION I IN I TALIA
2 11 Parigi. H otel des ln va lide s pezzi ad anima lu nga di diverso ca li bro idonei al Liro cos iiero. in pani co lare il più piccol o.
L'elaborazione di una torre per artiglieria radicalmente innovativa, supponeva la disponibilità di cannoni radicalmente innovativi, cioè di bocche da fuoco nettamente diverse per conformazione, caratteristiche tecnologi.che, modalità d'impiego e potenzialità distruttive, dalle arcaiche bombarde. Ed intorno alla metà del ' 500 pezzi del genere, come accennato , non solo esistevano ma si erano già specializzati in funzione del precipuo impiego in ambito navale. In particolare i calibri minori, ma non per questo meno micidiali ,.m, sembravano ideali allo scopo. Pochi serventi bastavano al loro maneggio, pochissima la quantità di polvere necessaria , minimo lo spazio di rinculo: del resto tirare contro bersagli di legno mobili non richiedeva enormi energie cinetiche residue ma soltanto grande celerità di manovra. Non implicavano, inoltre, rilevanti esperienze balistiche: basti pensare che per mirare si traguardava sopra la canna , esattamente come in un attuale fucile da caccia! Sotto tutti gli aspetti ottimi per armare toni costiere di contenute dimensioni e di ancor più contenuta guarnigione. L'ado zione di pe z zi di piccolo calibro per respingere le unità corsare potrebbe a prima vista sembrare una marchiana incongruenza. Quale danno, infatti, poteva arrecare una palla di ferro grande come un arancio ad uno scafo di oltre cinquanta metri? Occorre però considerare che essendo le imbarcazioni corsare, esattamente come le galere propulse a remi, sul loro unico ponte si costipavano centinaia di schiavi, per cui una solitaria palla che vi fosse pervenuta con traiettoria radente ne avrebbe dilaniato molti. A quel punto compromessa la sincronia di voga, decurtata la velocità e notificata la presenza, sfuggire alle unità della guardia, o ad a ltri colpi, diveniva estremamente difficile. Senza contare che r obbedienza della ciurma, estorta col terrore dello scudiscio, svaniva col terrore del cannone, innescando disperate ribellioni che imponevano nella migliore delle ipotesi rinterruzione dell'azione.
Sebbene efficacis s imi a battere ogni tipo d'imbarcazione, cioè in fazione offensiva, i cannoni navali di qualsiasi calibro risultavano assolutamente
inutili per il tiro ravvicinato, cioè in fazione difensiva. In poche parole quand'anche s uJla piaz z a di una torre in caso di a s salto alla stessa non s ervivano a nulla , evento che per risaputa esperienza costituiva spess o il prodromo di un·incursione. La grave deficienza fu ris olta con un secondo pezzo, paradossalmente una delle più vetuste e rudimentali bocche da fuoco: il petriero. Già il nome mutuato da una catapulta medievale ne evidenzia r arcaicità: s i trattava, infatti, di una s orta di tubo di ferro forgiato, alla cui estremità po s teriore veniva incastrato un otturatore, bloccandolo con una braga. Il termine otturatore per la verità è alquanto anacroni s tico , trattandosi di una sorla di boccale da birra , contenente al suo interno sia la polvere che il proietto , per lo più schegge di pietre o di metallo tenute ferme da un tenero diaframma di legno. Al momento dello sparo, fragorosissimo , il petriero eruttava perciò una micidiale rosata , mortifera in un raggio di una cinquantina di metri , s imile quindi ad una gigante s ca lupara . Considerando , infine, che ogni petriero di s poneva abitualmente di alm e no tre otturatori ric,uicabili anticipatamente e che poteva tirare vers o il bass o , quasi in verticale è facile immaginare la fine riservata agli incauti as s alitori dalle sue sventagliate. Ovviamente a condizione che la fortificazione dispone ss e di idonee cannoniere verticali, ricavate magari al di sotto di quelle orizzontali che scandivano il parapetto.
Ad una catena di torri, contiguamenre intervis ibili , concepite per l'impiego di artiglie1ie leggere, di tipo navale, ciascuna presidiata da due o tre uomini, s i delegò la difesa anticorsara, definita nella dizione del!' epoca torreggiamento. Il loro intervento balistico e cli allarme, ottico ed acustico , contenne per circa tre secoli gli insulti corsari turco-barbareschi finalizzati alla presa di inermi abitanti e di pacifici mercantili.
È fondamentale, per meglio recepire la modernità del piano vicereale di torreggiamento del Regno di

Napoli, ribadire che soltanto pochi decenni prima del suo avvio nel I 563 sarebbe stato assolutamente utopico contemplare una medesima concezione di interdizione attiva. Tecnicamente ed economicamente fattibile, quindi, solo dopo tale data: " ... costruire su tutti i punti della costa, dietro indicazione dei regi ingegneri , torri in vista una dell'altra in modo da costituire nell'insieme una continua ininterrotta fortificazione: tutto il regno doveva essere chiuso da ogni banda " (38> Pur configurandosi i capisaldi vicereali abbastanza simili architettonicamente in prima approssimazione, alle più antiche tolTi costiere a pianta quadrata, delle quali condividevano esclusivamente i compiti di avvistamento e segnalazione, rappresentavano in effetti fortezze in miniatura.
Il modernissimo dispositivo di difesa costiera imperniata su diverse centinaia di siffatte torri dotate di adeguare artiglierie, suscitò diffusi consensi per i suoi modesti oneri, economici ed umani, nonché per la sua intuibile affidabilità. Superflui tra l 'a ltro i tanto aborriti stanziamenti di guarnigioni spagnole nelle adiacenze dei centri abitati, tanto vessatorie nella quotidianità quanto passive al momento del bisogno per la loro scarsa mobilità, ed inutili ulteriori arruolamenti. Le stesse torri , opportunamente dislocate , si sarebbero fatte carico, non soltanto di frustrare le funeste razzie rivierasche, ma soprattutto della protezione del vitale fluire del cabotaggio, sventando gli agguati, coprendo costantemente la teoria dei mercantili con le artiglierie. Senza contare che tramite la loro diuturna vigilanza sarebbe stata perennemente attiva una sensibilissima linea perimetrica di preallarme affinché:
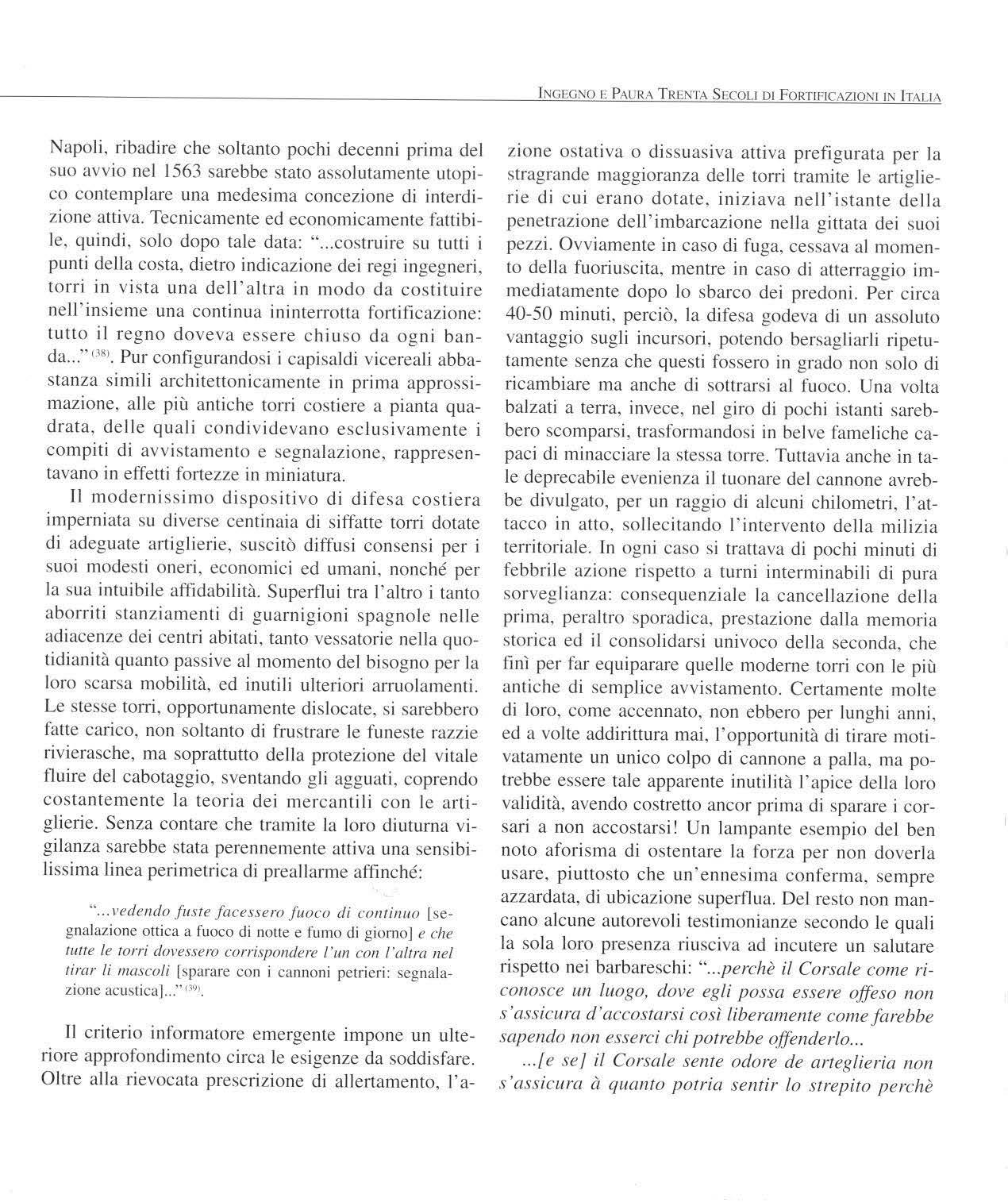
" ... vedendo fuste facessero fuoco di con tinuo lsegnalazione ottica a fuoco di notte e fumo di giomoJ e che lutte le torri dovessero corrispondere /"un con l'altra nel tirar li masco/i [s parare con i cannoni petrieri: segna laz ion e acustica l .'' ,w>
Il criterio informatore emergente impone un ulteriore approfondimento circa le esigenze da soddisfare. Oltre alla rievocata prescrizione di allertamento, I' a-
zione ostativa o di ss uasiva attiva prefigurata per la stragra nde maggioranza delle torri tramite le artiglierie di cui erano dotate , iniziava nel! ' istante della penetrazione dell'imbarcazione nella gittata dei suoi pezzi. Ovviamente in caso di fuga, cessava al momento della fuoriuscita, mentre in caso di atterraggio immediatamente dopo Io sbarco dei predoni. Per circa 40-50 minuti, perciò , la difesa godeva di un assoluto vantaggio sugli incursori , potendo bersagliarli ripetutamente senza che questi fossero in grado non solo di ricambiare ma anche di s ottrarsi al fuoco. Una volta balzati a terra, invece, nel giro di pochi istanti sarebbero scomparsi, trasformandosi in belve fameliche capaci di minacciare la stessa torre. Tuttavia anche in tale deprecabile evenienza il tuonare del cannone avrebbe divulgato, per un raggio di alcuni chilometri, l'attacco in atto, sollecitando l'intervento della milizia territoriale. In ogni caso s i trattava di pochi minuti di febbrile azione rispetto a turni interminabili di pura s orveglianza: consequenziale la cancellazione del la prima , peraltro sporadica, prestazione dalla memoria storica ed il consolidarsi univoco della seco nda , che finì per far equiparare quelle moderne torri con le più antiche di semplice avvistamento. Certamente molte di loro, come accennato, non ebbero per lunghi anni, ed a volte addirittura mai, l 'opportunità di tirare motivatamente un unico colpo di cannone a palla, ma potrebbe essere tale apparente inutilità l 'a pice della loro validità, avendo costretto ancor prima di sparare i corsari a non accostarsi! Un lampante esempio del ben noto aforisma di ostentare la forza per non doverla usare , piuttosto che un 'e nnesima conferma, sempre azzardata, di ubicazione superflua. Del resto non mancano alcune autorevoli testimonianze secondo le quali la sola loro presenza riusciva ad incutere un salutare rispetto nei barbareschi: " perchè il Corsa/e come riconosce un luogo, dove egli possa essere offeso non s'assicura d'accostarsi cosi liberamente co me.farebbe sapendo non esserci chi potrebbe offenderlo ...
.[e se] il Corsa/e sente odore de arteglieria non s'assicura à quanto patria sentir lo strepito perchè
s 'ha immaginare, eh'/ Corsa/e sempre và per f?uadagnare al sicuro, et dove egli ha niente di disavantaggio cerca oini sua sicurtà salvarsi.
Il Corsale non si ,netterà dove riconosca riuscirne con perdita certa e f?uadagno dubbio ... " < 40l
Ad ogni buon conto, vuoi per a ll ontanare i corsari a cannonate, vuoi per non farli avvicinare per paura delle cannonate, fu proprio per tale scopo che si dedicarono immensi sforzi umani, materiali, tecnici ed architettonici alla meticolosa elaborazione del sistema delle torri armate.
L' articolato e complesso dispositivo difensivo varato dal viceré don Parafan de Ribera < 4 1>, ci è pervenuto limitato alle so l e torri superstiti, spesso devastate e stravolte dalle successive rielaborazioni e ristrutturazioni. Pochi, disparati e scarni i documenti d'archivio chiaramente esplicativi al riguardo, parzialmente distrutti durante l'ultimo conflitto <42 > . Ignoti pertanto i progetti originali del modulo elementare del caposaldo, tanto abbondantemente riprodotto , i parametri di impiego delle sue molteplici tipologie, le logiche di ubicazione ed orientamento, certamente non arbitrarie.

Non altrettanto rari fortunatamente i coevi e successivi rapporti tecnici, le perizie, le relazioni ispettive, gli inventari ed i tabulati degli armamenti e degli organici, sempre però frammentari ed episodici. Posso no, pertanto, fungere esclusivamente da riscontri e da convalide indispensabili peraltro ad una se ri a ipotesi int erpretat iva del comp l esso apparato, impostata su lla lettura tecnico-militare delle vetuste torri e delle loro peculiarità.
L a coerente analisi delle dimensioni , degli angoli, delle connotazioni geomorfo lo giche delle coste integrano le lacunose e spesso persino contraddittorie fonti. L'identificazione delle st rutture, obbedienti come ogni prodotto dell'ingegneria alle rigide esigenze fruitive ed economiche, può esternarci i c rit eri infonnatori a cui si atte nn ero gli sconosci uti id eatori . Similmente il rin ve nim ento dei piani di similar i torreggiamenti generali dei perimetri costieri del regno di Sicilia e di
Sardegna, quand'anche non del tutto analoghi, e per logica difensiva e per manufatto architettonico sotteso, forniscono ulteriori chiarimenti interpretativi. Il risultato, pur non essendo necessariamente incontrovertibile, è senza dubbio il più attendibile vantando corrispondenze e concordanze statisticamente assai probatorie. Di viene, a questo punto , oziosa la ricerca vanamente perseguita da oltre mezzo secolo negli in sondabili archivi di Simancas e di Napoli del piano originale e del progetto del modulo di base della torre costiera vicereale napoletana, ammesso che nei termini moderni presunti sia mai esistito. È, se mai, proprio l'assenza di un'a ssol uta identità formale, strutturale, volumetrica e d ' impianto delle oltre 330 torri a lasciar trasparire gli accennati criteri infom1atori del piano.
L'iniziativa anticorsara che a quel punto il Regno di Napoli si accingeva ad avviare non aveva alcun sig nificativo prec e dente e per ampiezza dello schieramento e per la modernità della torre base. Que sta , infatti , come meglio ana li zzeremo in seguito, fu appositamente progettata per integrarsi con l' armamenro balistico offensivo e difensivo, costituendo perciò l'archetipo di tutte le success ive torri d'artiglieria. Al pari di ogni opera pubblica di ragguardevole onere e complessità, anche il torreggiamento si intraprese sull'onda emotiva di una tragedia: ne lla fattispecie furono due graviss im e incurs ioni corsare, terribile per numero di vittime la prima, e spaventosa per audacia la seconda. In dettaglio nella notte del 13 giugno del 1558 una grossa formazione navale turco-barbaresca assalì e devastò Massalubrense e Sorrento deportandone oltre 5.000 abitanti. Di tanti ad eccezione di un centinaio, nessuno tornò <4,> Gli anni successivi si spesero nel potenziamento delle cerchie urbiche degli abitati rivieraschi, nonché nella messa a punto del piano esecutivo, nell'individuazione dei siti d'impianto delle erigende torr i , nell 'e l aborazione del relativo finanziamento, attar-
dandosi nella miriade di difficoltà burocratiche. Tanta frenetica attività, inserita nel più generale contesto di un vistoso riaimo del blocco occidentale, ovviamente non sfuggì agli osservatori turchi , convincendoli che la risposta migliore sareb be stata un potenziamento della guerra di corsa contro il cabotagg io e le coste cristiane - in particolare italiane - condotta dalle unità barbaresche. Rischi e bottini ad esclusivo beneficio dei rais nordafricani, vantaggi strategici e debilitazione del nemico ad utile di Costantinopoli. Il che significò una vistosa impennata del plu1i seco lai·e flagello , specie quando le squadre dei predoni del mare agivano di concerto con cospicue aliquote della flotta da guerra turca. Talmente grave apparve allora la situaz ione che nel maggio del 1561 il viceré di Napoli so llecitava al papa di autorizzare Marcantonio Colonna a partecipare alla difesa attiva della sua capitale 1++ 1• Nell'anno successivo si regi s lrò un ulteriore incremento della ini z iativa corsara imputabile tra l 'a ltro ad una pessima annata agricola, con magrissimi raccolti in tutto l 'area medio-orientale. La caccia ai mercantili che trasportavano grano alla volta di Napoli, o di Roma divenne sp ietata. Si ritenne nece ssa rio perciò far rientrare le galere imperiali della squadra di Napoli, temporaneamente alla fonda in Spagna , per alleggerire la pressione di Dragut, che blocca va con 35 imbarcazioni ogni traffico marittimo. Così sc ri veva al1' imperatore il vescovo di Limoges:
" è urrirnto un cor rie re del marchese di Tarifa, g overnatore di Napoli per pregare Filippo Il «di rimandare le dell e g alere, esse11do altrimenti quelli della R eliiione, di Sicilia e di altri porri vicini tanto turbwi e bloccati dal dello Dragut ch e 11110 so lo di loro non ha possibilità di passare da un luogo all'altro poiché pochi pirati e mariuli ten go no qu es 10 prin c ipe , dallo stretto di Gibilt e rra s in o alla Sic ilia, in wle servirù che gli infedeli discendono do ve loro aggrada sulle s ue rerre. se non vi sono dei forti »" c• 5>
Anco ra nella prima vera del 1562 ben 32 ga le re della s quadra napoletana e sici liana al coma nd o di Ju an Mendoza perlustrarono interrottamente il litora-

le tirrenico sp ing e ndo si, per espl icit a richiesta del papa, si no alla foce del Tevere. Ma il provvedimento si dimo strò insufficiente. Come se non bastasse, nel settembre, durante una crociera di tra sferime nto , l e navi del Mendoza incapparono in un violentissimo fortunale presso Malaga: appena 3 galere su ventotto scamparono ali' affondamento che costò la morte di quasi 5.000 uomini. Il disastro lasciò le coste senza la minima protezione. Ini z iò allora uno sforzo ciclopico per la costruzione a ritmo se rrato di nuove unità. Tutti i cantieri occidentali da quelli spag noli , a quelli napoletani e sici li ani, impostarono s ui loro scali decine di scafi di galere, tanto che osservava il già citato vescovo:
" da 11me le parti si co struisco no attivamente e di nu ov o sono sta ti tagliati in Catalogna e nei reami vicini, più di quartromila piedi di a beti per soddisfarvi. oltre quelle ga l e re che s i fabbricano a Napoli e in Sicilia, essendo venuti mastri e operai da Genova e alcuni dalla nos tra Proven ;,a ""M
Il che però non s ignificava l'immediata di spo nibilità delle navi , mentre le razzie in terra e le catture in mai·e s i moltiplicavano paurosa mente. Alla fin e il viceré di Napoli , don Parafan de Ribera , nel I 563 previa la debita autorizzazione imperiale, promulgò le ordinanze per la costruzione di un'ininterrotta catena di torri costiere armate, lungo l'intero pe rim etro mai-ittimo d e l Regno, o ltre 2.000 km, per la difesa anticorsara. Ma a far superare gli ultimi indugì dovette contribuire un'ennesima incursione, tragica quanto oltragg iosa al limite dell ' insolenza.
Nella notte de.I 28 maggio del 1563, centinaia di Bai·baresc hi sbarcai·ono a Napoli da tre imbarcazioni. a pochi pass i claJ pa la zzo di don Parafan. I prigionieri , nella circos tan za furono pochi, a differenza della paura che fu immensa, essendosi sem pre s upposto , ingenu amente, che la Capitale per le sue guarnigioni e per i suoi castelli fosse immune da qual sia s i insu lto corsaro (47i _ Nessuna meravig li a c he nel giro di poche settimane si intraprese il torreggiamento del R egno.
INGEGNO I::. PAURA TRENTA SECO LI D I FORTlACAZIONJ IN ITALI AIl progetto esecutivo, del resto, già da tempo era s tato ultimato ed approvato, per cui della grande opera si conosceva ogni dettaglio. Nonostante l'epoca , la procedura adottata per redigere e computare economicamente simili progetti appare straordinariamente moderna. Sebbene nessuno stralcio ci sia pervenuto di quello del Regno di Napoli, basandoci sui coevi di Sardegna e di Sicilia , e parzialmente dello Stato Pontificio di poco più tardi ed appena più modesti, possiamo tratteggiarne le caratteristiche salienti. Per una imperscrutabile quanto incredibile coincidenza, infatti , del piano di torreggiamento del regno di Sardegna ci è pervenuto il progetto d ' intenti e la s ua rielaborazione in progetto di massima. Di quello di Sicilia, invece, ci è pervenuto il rilievo grafico preliminare ed il progetto architettonico militare. mentre per lo Stato della Chiesa una se rie di documenti s ugli appalti e sull'armamento delle torri. Ovvio quindi che l'in -
sieme di questi parziali aspetti, che di volta in volta saranno evidenziati sia pure schematicamente, forni sce la percezione più attendibile dell'intero iter di ciascun piano del genere nella seco nda metà del XVI seco lo.
Tornando al regno di Napoli. e stando a quanto accennato, è estremamente probabile che il sopralluogo preliminare lungo il s uo intero sv iluppo costiero, indispensabile per la con-ena stesura del progetto fosse s tato effettuato da una apposita commissione itinerante, composta di tecnici e militari. Spiaggia dopo spiaggia, cala dopo cala il parere di ciascun membro confluiva in un particolareggiato documento. Al termine del periplo si di sponeva di un pacchetto di schede dettagliate ed aggiornate costituenti la premessa ambientale del torreggiamento ed il suo onere economico. Un accorto piano di finanziamento e di annamento bastava a renderlo esecutivo: nella fattispecie
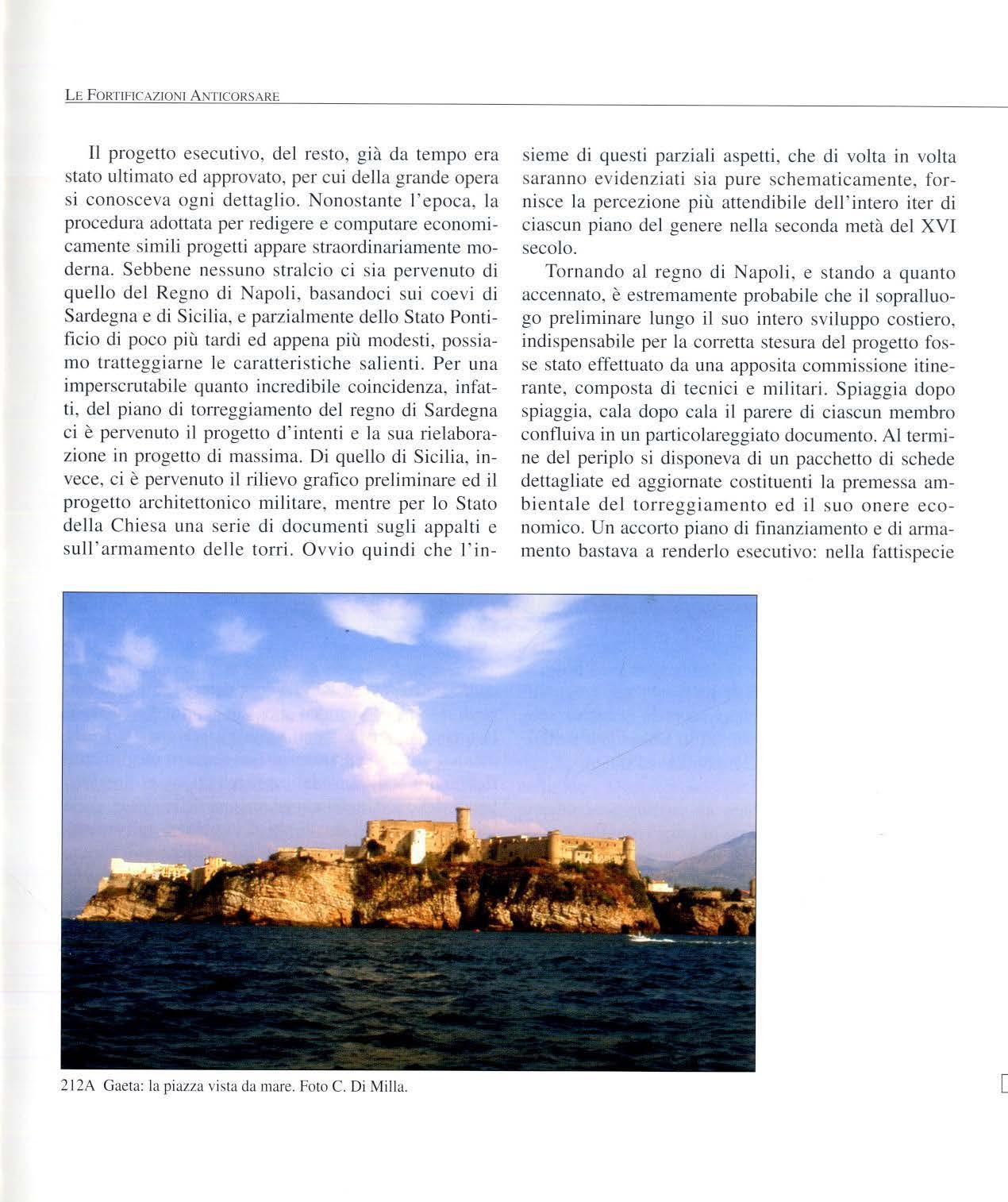
prevedeva oltre 300 toni , da incrementarsi progressiva mente fino a 400, insediate s eco nd o la logica anticors ara a distanza variab ile ma in vi s ta l ' una dell'altra, da San Benedetto del Tronto fino a G aela
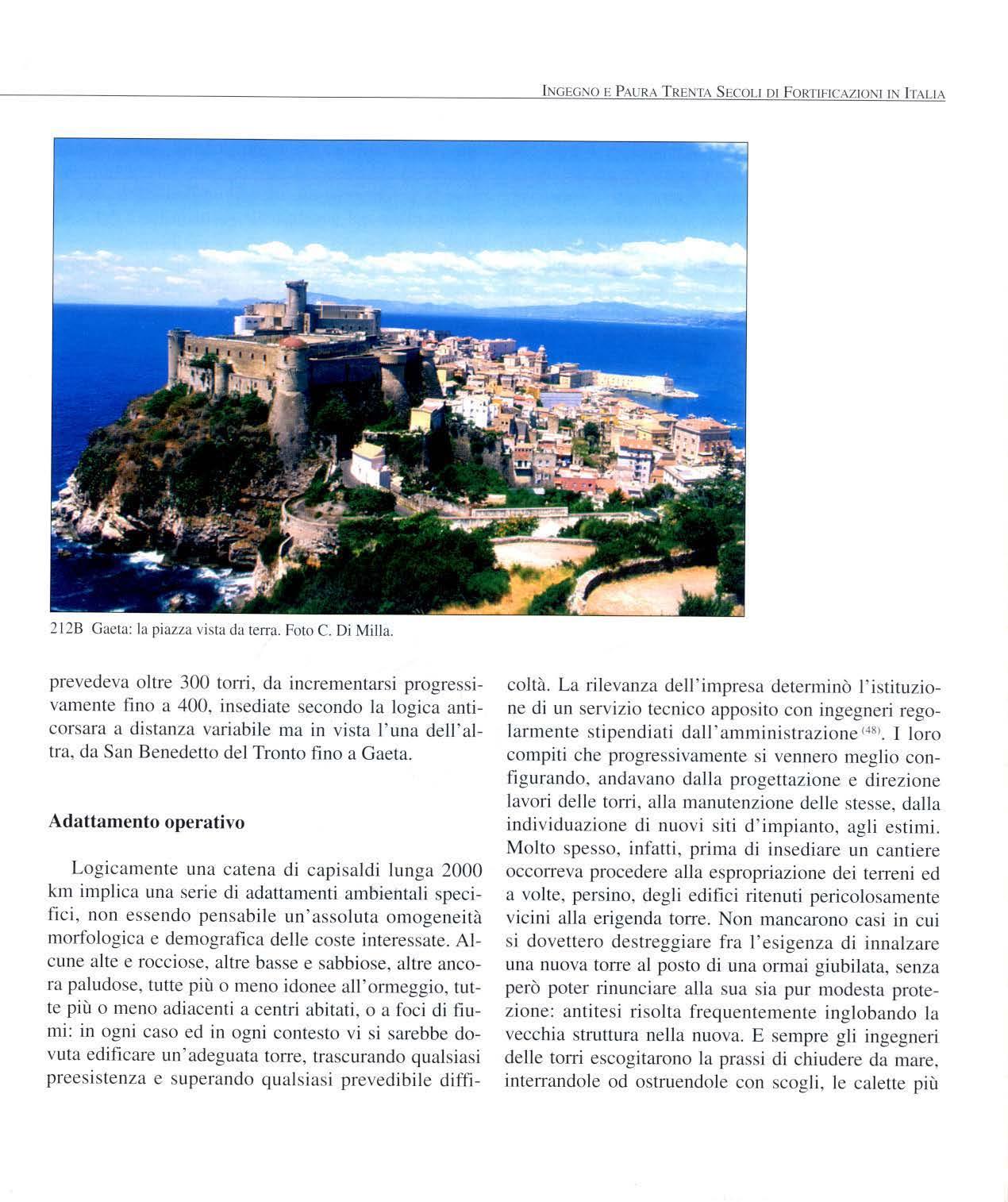
Logicamente una catena di capisaldi lunga 2000 km implica una serie di a datt amenti am bientali specifici, non esse nd o pensabile un'assoluta omoge n e it à mo rfologica e demografica delle coste interessale. Alcune a lte e rocciose, al t re basse e sa bbiose, altre ancora paludose , t utte p iù o meno idonee all ' ormeggio, tutte più o me no adiacent i a ce ntri ab it ati , o a foci di fiumi: in og ni caso ed in og ni contesto vi si sa reb b e dovut a e dificare un 'adeguata torre, tra scurando qual siasi preesistenza e s up erando qual sias i prevedibile diffi-
coltà . La rilevanza dell'impresa deternùnò l ' is titu z ione di un servizio tecnico apposito con ingegneri regolannente s tipendiati dal!' amministraz ione 148 > I l oro com piti c h e progressivamente si ve nn ero meglio configurando, a nd ava no dalla progettazione e direzione lav01i delle toni , alla manutenzione delle stesse, dalla individuazione di nu ovi siti d ' impi an to, ag li es timi Molto spesso, infatti , prima di insediare un cant iere occorreva procedere a ll a espropriazio ne dei terreni ed a vo lt e, persino, de gli ed ifici 1itenuti pericolosamente vicini alla e rigenda torre. No n mancaro no casi in cui s i dovettero d estreggiare fra l ' esigenza di innalzare un a nu ova tone al p os to di una o rm ai giubil a ta , se nza pe rò poter rinunciare alla s u a s ia pur modes ta protezione: a ntit esi risolta frequentemente inglobando la vecc hia strutt ura ne lla nuova. E se mpre gli in gegne1i delle torri escogitarono la prassi di chiudere da mare intenandole od ostrue nd o le con s cog li , le calette più
2 l2B Gae ta: la piazza vis ta da temt. Foto C. Di Milla.nascoste ed indifendibili. Come pure di spianare i promonlori minori, che non giu s tificavano l'impianto di una torre ma consentivano l 'agguato corsaro.
L'esecuzione pratica degli ordini ebbe rapidissima estrinsecaz ion e. 11 programma già nel '69, sebbene non esauJ·ito, poteva ritenersi operativo. Centinaia di toni appena collaudate ed armate di appropriata artiglieria entrarono in serv izio. Tuttavia. poiché l'assegnazione degli appalt i si attuò per province, in funzione forse del livello di rischio, l'ultin1azione della rispettiva frazione di torreggiamento non fu contemporaneo dovunque. Alla costa abruzzese e molisana, ad esempio, si presc1issero in totale circa 20 torri ma so ltanto dopo il 1568, nonostante ch e 6 di quelle ri entravano tra le commissionate nel 1563 con obbligo di consegna in 18 mesi. Quanto influirono sul ristabilimento della sicurezza pubblica lo dimostra che lungo lo stesso litorale abruzzese e molisano ancora nell'estate del 1566. prima quindi del loro avvento , l'unica difesa contro l e in cessanti incursioni turco-barbaresche consisteva nell ' evacuazione degli ab itati. Il 29 luglio Francavilla , totalmente deserta venne incendfata dai turchi e così pure, pochi giorni dopo, Ortona. La fascia in teressa ta si estendeva per una decina d i miglia verso l'interno, tant ' è che la penetrazione delle bande co rsare fino a Serracapriola, ad 8 miglia dalla costa, compiuta nella stessa crociera non fruttò alcuna cattu ra. Con l'entrata in serviz io delle torri, di tali estremi rimedi, rimase il semp li ce ricordo. 11 che non sig1ùficò affatto che a tale data il programma fosse ultim ato, traguardo am bito e mai conseguito, ma so lta nt o c he con un'accorta scal a di priorità a nc he con un numero ridotto di torri s i 1iusciva a sorveg li a re l'intero pe1irnetro costiero . Ovviamente nell e tratte c1itiche, nelle inevitabili soluzioni di continuità, il co nlrollo ed il co ll egamen to veniva assicurato da battitori a cavalJo, aJtrimenti detti cava llari .
industria regnicola fornire un numero tanto grande di cannoni in così breve tempo. Infatti , sebbene quasi certamente l'ordine di approntare alcune centinaia di pezzi deve ritenersi contestuale a quello di costruzione delle torri , alJa loro entrata in servizio solo poche risultavano adeguatamente armate. Si spiega così la pressante ordinanza v icereale relativa al reperimenlo di altri cannoni da distribuire lungo le marine, ovviamente al minor prezzo possibile (4 91 •

La precisazione che può sembrare una pleonastica formula burocratica in realtà nascondeva una tragica realtà: il concentrarsi in così breve tempo degli oneri di edificazione e di armamento delle to r ri esulava dalle concrete possibilità del gettito fiscale. Il completamento del sistema parve allora compromesso, proprio mentre i primi indubbi riscontri positivi in iziavano a manifestarsi: inevitabile un ulteriore aggravio della pressione tributaria, estendendo la contribuzione anche agli abitati meno prossimi al mare. È significativo, per comprendere l'entità degli sforzi sostenuti, ricordare che appena cinque anni dopo pressoché tutte le torri avevano i rispettivi cannoni. Si trattava di pezzi in molti casi di qualità più scadente e di prestazioni inferiori a quelle previste nelle relative schede di progetto, ma senza dubbio validi allo scopo .
I l vero problema co ntinu ava ad essere quello dell'armamento. non essendo alla portata della coeva
Un'al tra eno rme diffico lt à che dovette essere superata fu quella concerne nte il personale da destinare nelle toni. O cco rr evano uomini fom iti di una minima preparazione mili.tare, dovendosi maneggiare armi da fuoco e polveii, ca pa ci di sape r leggere e scrivere, non fosse altro che per contro ll are i documenti delle imbarcazioni sospe tte o per redigere i verbal i di carico e scarico delle munizioni e dei v iveri. M a dovevano pure, e forse so prattutto , ri sultare di assol u ta fedeltà all ' Impero affida ndo se n e nelle loro mani una so rta di varco d ' i n g r esso. L a scel t a cadde allora sui capora l i d e ll 'esercito regolare previo un acc urat o accertamento dell'idoneità, attestata con una precisa patente che l i tra sformava una vo lt a al co m ando di una torre in cas t ellani, con uno stipe ndi o mensile di 4 ducati, non disprezzabile per l'epoca. Qu anto ai loro subordinati, [
uno o al massimo due, venivano scelti dai paesi territorialmente competenti ed assoldati, da cui la definizione di soldati, per la so la buona stagione.
La configurazione prescelta per la torre vicereale fu un tronco di piramide quadrata , sormo ntato da un parapetto aggettante in contropendenza scandito da alquante cannoniere orizzontali e ve1iicali. Po ss ibile perciò posizionare i cannoni in batte1ia come sui ponti dei vascelli, difendere il perimetro senza soluzioni di continuità e sfruttare meglio gli ambienti interni. Vantaggi tutti di tipo squisitamente militare , sufficienti a giustificarne l'adozione nonostante il maggior costo. Quanto alla scarpatura, che in ogni fortificazione è attribuita ali' esigenza di provocare impatti balistici obliqui, nella fattispecie deve ascriversi ad almeno due precipue motivazioni, non rientrando il cannoneggiamento nella prassi corsara. La prima indispensabile per neutralizzare le so llecitazioni statiche e dinamiche derivanti dall'uso delle artiglierie. La seco nda , forse la prioritaria riscontrandosi adottata pure nelle torri gentilizie prive di qualsiasi armamento balistico , va ricondotta alla esigenza di tenere gli eventuali assalitori discosti dal piede della torre, costringendoli così nel settore di fuoco del petriero, capace di tirare verso il basso ma non in verticale. Come deli neato, per ogni ambito costiero s i stabilì il numero ed il calibro dei cannoni navali: al massimo una coppia di cui il maggiore non eccedente le 6 libbre , contro le 3 libbre abituali Difficile per noi comprendere quale differenza potesse sussistere tra un cannone che scagliava una palla di circa 62 mm di diametro pesa nte 900 grammi ed un altro che scagliava a sua vo l ta una palla di circa 78 mm di diametro pesa nte 1800 grammi. All'epoca però quei 16 millimetri di differenza implicavano un abbondante raddoppio del peso del pezzo , da 8 a 18 quintali, ed un incremento del 50% della gittata massima <501 Il costo complessivo che tale opzione comportava eccedeva,
però, notevolmente il doppio poiché un cannone da 6 richiedeva spazi di manovra alquanto più ampi di uno da 3: ovvero una torre più grande. Tenendo conto dell'esistenza anche di cannoni da 2 e da 4 libbre, parimenti adottati nell'armamento delle torri, ne derivò una se rie di varianti del modulo base della torre vicereale. Ovviamente ad esaltare le differenze tipologiche giocarono anche altre conseguenze funzionali impo s te tutte dalla ottimizzazione del se rvizio, quale ad esempio , per restare ancora all'intervento attivo. l 'o rientamento della torre. Dalla s ua piazza quadrata, infatti, i pezzi potevano tirare perpendicolarmente ai lati, ma non in corrispondenza degli s pigoli, dove il parapetto essendo più fragile strutturalmente e più ampio, non consentiva le cannoniere. Il fuoco di ogni torre pertanto non risultava omogeneo a 360° . ma presentava dei settori morti in corrispondenza, appunto, dei prolungamenti degli spigoli, avvalendosi dei quali, in via teorica, un attaccante ri s ultava imbattibile. Indispensabile, pertanto. farli coincidere volta per volta con gli ambiti costieri meno idonei agli sbarchi od agli agguati orientando opportunamente la totTe.
Più appariscenti architettonicamente, le funzioni autodifensive, per le quali si riesumò l'intero repertorio medievale. L' in vio labilità passiva si ottenne così incrementando l 'a ltezza della torre ed elevandole l' accesso, interdicendolo magari tramite un piccolo ponte levatoio od una scala retrattile. Qu e lla attiva esaltando la ro sata del tiro del petriero , praticando Iungo iI coronamento in controscarpa delle originali troniere verticali trapezoidali a forma di sp atola rsi) _ Il loro numero per lato dipendeva dalla larghez za della piazza. ovvero dal calibro del pezzo principale, per cui la corrispondenza biu n ivoca fra il loro numero e la rilevanza della torre appare coerente. Assolutamente incoerente, invece, la loro equiparazione con caditoie dalle quali la s paruta guarnigione avrebbe lanciato pietre od olio bollente, a dispetto persino d e Ua mancanza di verticalità dell'estradosso delle torri vicereali! Identiche cannoniere verticali s i pos sono osservare lungo la Linea Maginot senza alcuna reminiscenza castel lana. Da
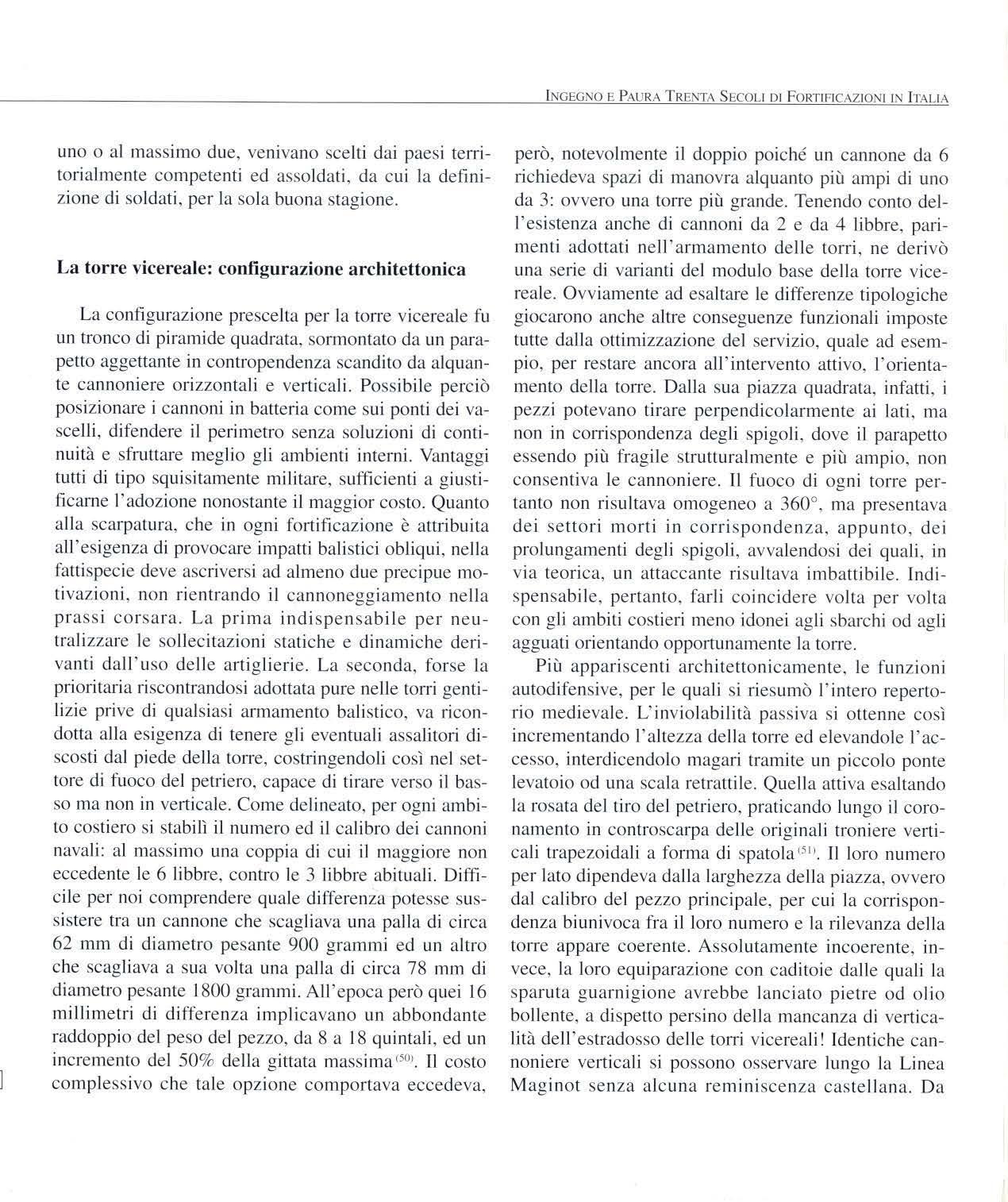
quanto appena tratteggiato deriva una class ifi cazione delle torri vicereali napoletane, così artico lata:
1) Torri se n z a a lcun a t ro ni er a , dalla tozza sagoma tronco piramidale quadrata. Non rappresentano una ca t ego ri a particolarmente ric ca né ben definita . I nfatti di esse so lt a nt o alcune furono co n cert ezza costruite orig in ariamente in tal mod o, m agari per co nt e nere i crescen ti o n eri d e l piano, o perché l e troni ere ve ni va no ritenute superfl u e ne llo spec ifico contesto ubi cativo. La più parte in vece lo dive nn ero per s ucce ss iva ri s trutturazione, allorché necess itando il coro nament o di manutenzione , esse ndo la co mpon e nt e s trutturale più d e li ca ta e so lle c itata nonch é l a più costosa e co mplic ata, s i optò p e r il s uo radica l e sve llim e nto. È certo c h e il coronamento a troniere o bliqu e mantenne inalt erata la s ua va lidit à difen s iva ne i seco li seg ue nt i : fu a n cora reali zzato s i ste maticamente in tutte l e torri e rette ne l XV II I sec olo. L a categoria in co nclu s io ne non pu ò e sse r e rep utat a il modulo base ma so lt anto una s u a s emplificazione.
1 1 5 5 6 6 3 9
2) Torri ad un a so la tro ni era. Sono da considerarsi piuttos to affini a ll e prece denti co m e vice nda attuativa che non a quelle con più troniere. G li ese mpi so no pertanto rarissimi e n on nec essariamen te ta li dall'origine esse nd o sca r sa la poten z ialità difensiva. L' unica tro niera presente, infatti , pu r co ns entendo un minim o di intervento interditti vo è sostanzialmente e quip arabi le a lle piombatoi e po s te ad interdiz ione dei vani fine s tre e porte. Il crite rio è simi le a quello applicato n e ll e cost ru z i o ni fortificate civ i li, quali le ma sserie pugliesi.
3) To rri a tre t ro ni ere. È la ca tego ria di gra n lun ga ma ggior itari a, la vera ossa tura portante dell ' intero sis te ma Contempla a l su o interno una così estesa esc ursio ne dimen s ion ale, an d ando da g li sc ars i I O m pe r lato di base d elle pi cco le agli o ltre 16 m delle grandi , da farla considerare a sua volta susce ltibil e di so ttoclas ificazio ne tipolo gica . È qua s i ce rtam e nt e in questa co mp ag in e c h e deve co llocar s i l 'archetipo o ri g inal e del capo sa ldo. osservandos i per la stessa un· eccez ionale funzionalità. e

214 Spaccato assonomcLrico torre vicereale a tre troniere
4 ) Torri a quattro troni ere. Costiluiscono una categoria non molto frequente, forse una ottimizzazione della torre a tre troniere grande: è azzardata qualsiasi ipotesi in merito tacendo completamente le fonti a riguar do. Non ostenta specifiche connotazioni e peculiarità.
5) Torri a cinque troniere . È subito dopo que ll a a tre, la categ01ia più nume rosa . Ad essa, che va nta costantemente ingenti cubature e amp i e piazze, vanno ascritte tutte le torri dalle spiccate finalità m ilitari. l n alcune di esse, ricordate come torri cavallare, in virtù proprio del maggiore volume vennero iicavate anche le stalle per i cavallì delle pattug l ie montate c he pe rl ustravano sistematicamente i l itorali. Furono erette ovviamente nelle loca lità ad alto rischio di sbarco o con
forte densità abitativa o con connotazioni particolannente atlrattive: dovunque cioè fosse giustificato il rilevante onere di costruzione e sostenibile quello a l trettanto amplificato di gestione.
6 ) Torri a doppia alt e zza . Rappresentano architettonicamente un adattamento intelligente alla conformazione scoscesa delle coste rocciose ed infatti appaiono esclusivamente, ma sporadicamente, su queste, richiedendosi anche una inderogabile esigenza ubicativa. Sono in definitiva un ripiego che consentiva di evitare una eccessiva altezza alla torre. garantendola pariment i a ll e spalle tramite un settore murario fungente da scudo: non a caso sono state definite anche torri scuciate. Senza tale espediente la piazza si sarebbe trovata mo lto bassa ed esposta verso monte ad un qua lsiasi assalto. Non rappresentano una peculiarità vicereale, peraltro limitata alla sola costiera amalfitana, riscontrandosi torri scuciate anche nello Stato Pontificio lungo il promontorio del Circeo e sempre per la medesima ragione. Data la sostanzi.aie contemporaneità delle due realizzazioni è impossibile stabilirne la paternità 152 l Sotto il profilo funzionale la soluzione però riduceva considerevolmente la piazza, decurtandone la validità comp lessiva, anche per l ' eccessiva compartimentazione interna. Mil i tarmente quindi di dubbia validità.

7 ) Torri mag giorate a molte troni ere. Sono eccezionali, costituite da pochissimi esemplari, quali tanto per c i tare: la Rocca di Po1to S Stefano, nello Stato dei Presidi !53 ) c he ricadeva sotto la dirigenza napoletana, l a cos iddetta Torre Imperatrice in provincia d i Potenza, o q uella chiamata Torre Normanna a Maiori, in provi nc ia d i Sa lerno. A l di là della logica d'adozione, attual mente ininterpretab i le, rapp rese nta no una di mostrazione dell'estrema fless ib i lità del modulo di base ed indirettamente de ll 'autonomia del sistema difensivo costiero delle torri che conservava sue precise connotazioni anche dove sarebbe stata più rispondente una s tru ttura tipo fortezza.
8 ) Torri rotond e. Costituiscono u n a categoria estranea alla logica de l piano come precedentemente
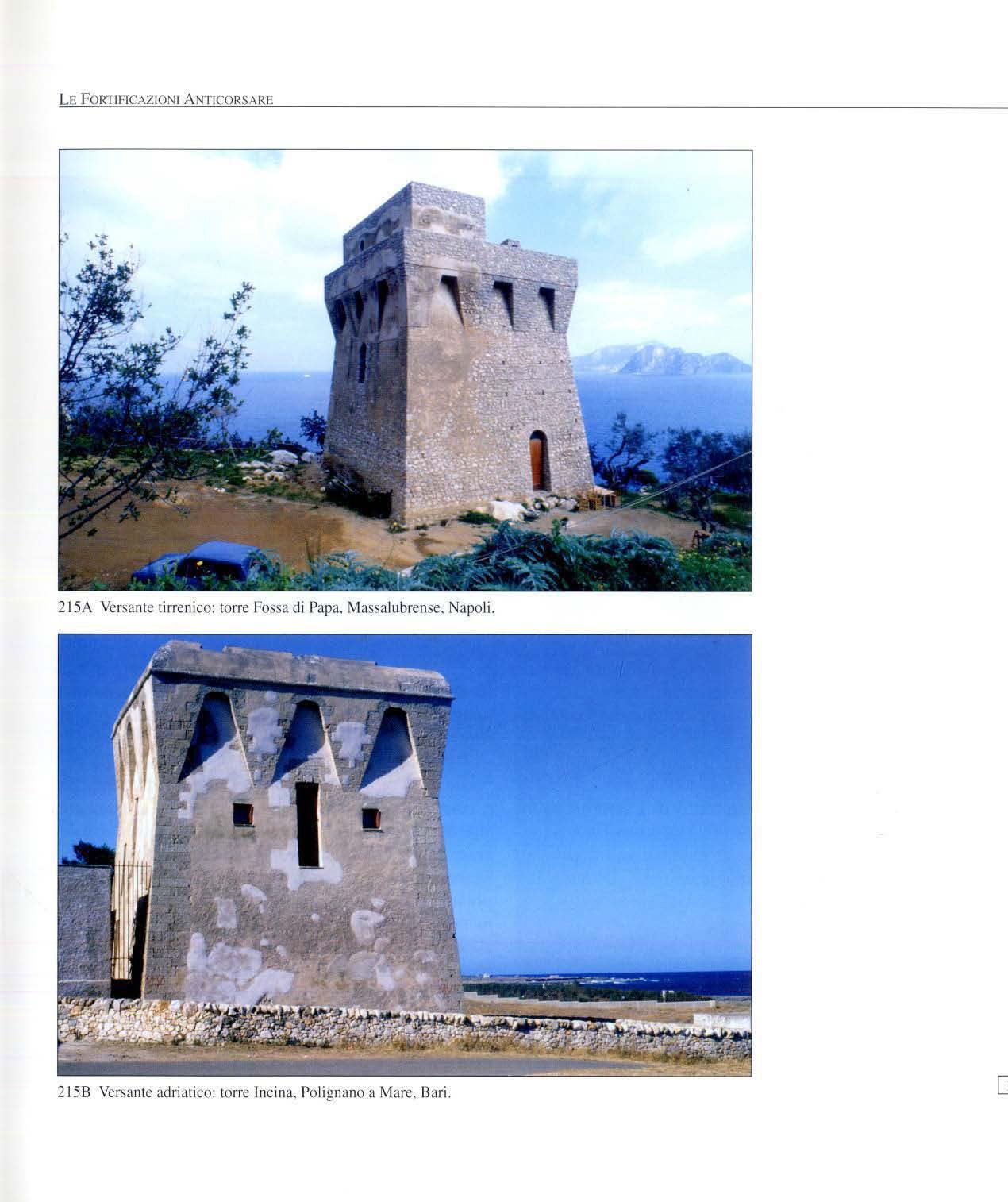
enunciato, ed infatti se ne incontrano attualmente soltanto cinque esemplari dei sette originariamente edificati, tutti ubicati a s ud di Salerno in s ucces sione. in corrispondenza della foce del Sele. Non sono le uniche torri rotonde, o atipiche, dell'intero sistema risco ntrando sene altre, soprattutto in Calabria: ma si tratta di torri più antiche ritenute in prima istanza idonee a sopportare l'arma mento e quindi all'inserimento nella catena, dopo so mmarie modifiche. Di que ste se ne rinvengono anche nel salemitano, alcune di epoca angioina come torre Assiola a Positano, altre di epoca aragonese come quella inglobata nella torre vicereale di Castellabbate ed ancora lungo Ja costa pugliese come torre Sant' Emiliano.

Quelle sa lemitane invece vennero erette ex no vo e rappresentano. in un certo senso, la variante a pianta rotonda della torre piccola a tre troniere: di questa conservano sig nificative analogie formali e strutturali.
Identiche ad esempio le troniere a spatola e la doppia scarpatura toITe-coronamento, nonché le sud divi s ioni fruiti ve interne come la cisterna a s pesso re di muro.
Uguale anche la cesura d'ingresso e la garitta sovrastante la piccola piazza. La scars issima cubatura ed il contenuto diametro escludono qual s iasi armamento che non fosse il solito petriero polivalente. La loro presenza per molti versi enigmatica, potrebbe giustificarsi re lazionandola alla palude che dopo aver spopo l ato l ' intero territorio ne in sa bbiò lo specchio di mare antistante, costringendo anche il naviglio ad allargarsi. A quel punto assurdi gli s barchi, impossibili gli agguati alle suddette torri, re s tò so l tanto da garantire la continuità semaforica del sistema: il cedevole se dimento d'impianto avrà consigliato allora la riduzione dei caiichi unitari, costringendo alla pianta rotonda, quella a ma ss imo volume utile a parità di massa inerte.
2 16 Erchie. Salerno, ton-e di Erchie.
L'avvis t ame nto pe r qu a nto d e lin eat o no n fu cetto la funz i one b as il are de ll e torri vice rea l i ma soltanto il pres upp os to de l lo ro in terve n to, a tt ivo o passivo c h e fosse. D a l p unt o di v is t a s truttu ra l e l a s ua co m pat ibilità con le al tre fun zion i non con sen t iro n o alla pi azza d i s up erar e la q uota m assi m a di un a q ui ndi ci n a d i me tri A tal e live lJ o s ul mare no n si ol trepassa no i 15 k m d i vi sibili t à, corrispondenti a poco meno di u n paio d'ore di n avigazio n e 11 m a r g in e teo r ico m i ni mo, per l' avvis t ame nt o d iretto no n poteva perciò eccedere tale ris i cati ssimo limi te, p ro pri o per l e toni di mass i ma di-
gia. In pratica però si tendeva ad avvalersi di qualsiasi modesta asperità naturale per incrementarne l'altezza senza decu rt arne l'efficacia Quanto al]' allarme diretto a ll a popolazione limitrofa si effettuava con lo sparo del petriero, sicuramente percep i bile ovunque e in quals iasi c ircos tanza . Per il resto la tone non differiva da un piccolo casale isolato di un unico stanzone. con la sottostante cisterna. il suo focolare, u na rudimentale latrina e qualche nicc hi a nel muro come arredo, mai i nferiore ai 25 mq mai superiore ai 70, non di rado soppalcato per aumentarne la capac ità ricett iva. Le ape11ure, c he l o ill u mi n avano ricordavano, per la vifesa, q ue ll e c ioè ad imm ed i a t o co nta tt o co n la sp i ag -
s uale obbligata, costantemente la sorveglianza che tassativa doveva effettuarsi sulla sovrastante piazza, a ll a quale conduceva una rampa di scale, ricavata nello s pessore del muro. Su di essa nella buona stagione si succedevano i turni di guardia e si ricevevano e trasme tt evano i segnali. Sempre su di e s sa nei momenti di frenetico , quanto raro, in tervento a fuoco, tuonava il cannone ed a volte vi si moriva, colpiti da
Una torre , due cannoni e tre uomini: questo il caposaldo anticorsaro tipo, schierato con un intervallo medio di circa 5 km, lungo l ' intera frontiera marittima del Regno e rima sto in s ervizio per oltre due secoli e mezzo! Complessivamente, quindi , non più di 1000 uomini e non più di 700 cannoni: ma quale fu il bilancio del loro lavoro?
In molte cronache napolet,me , come del resto siciliane, sarde , romane, toscane e liguri successive alla entra-
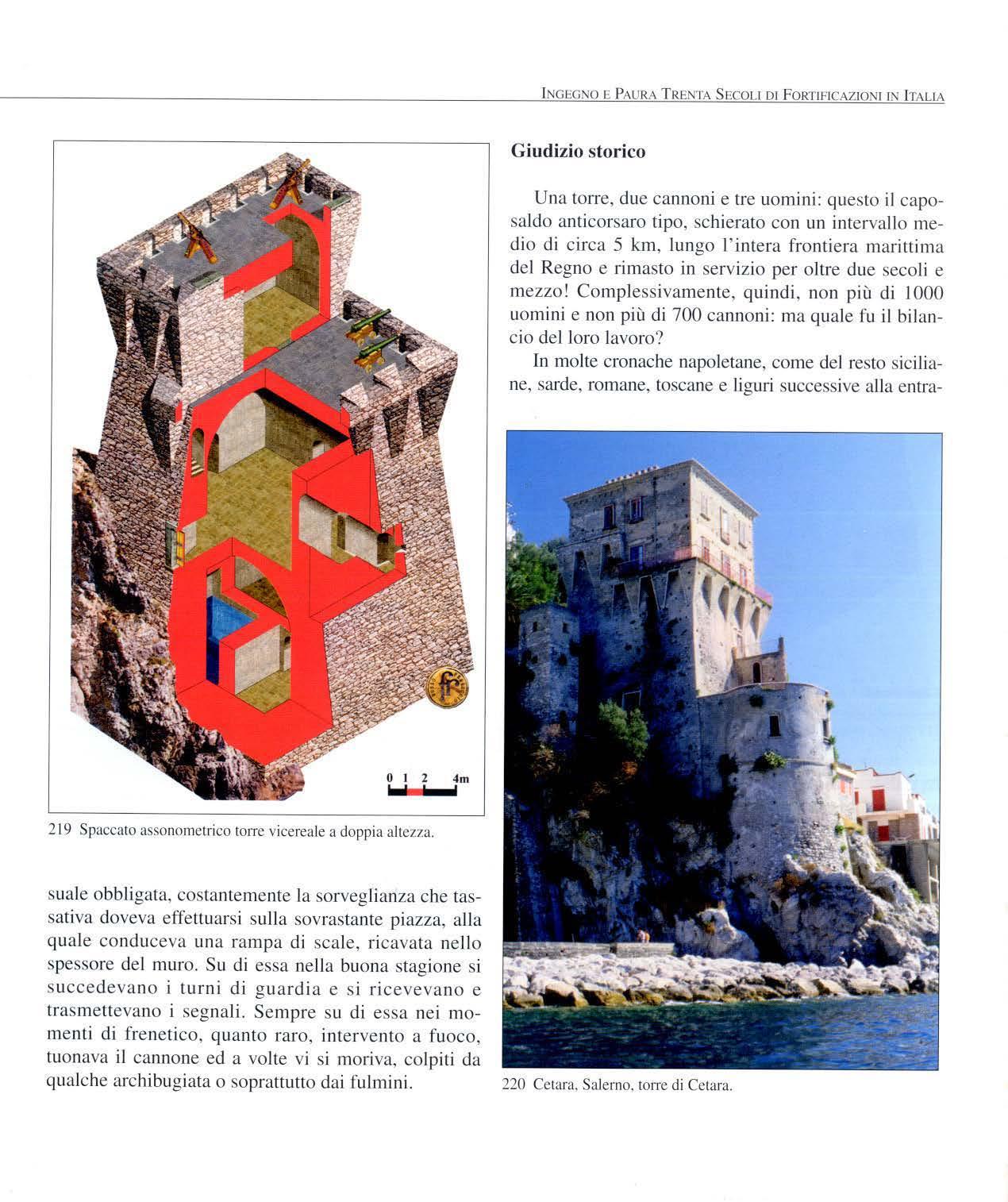
ta in servizio delle torri si rintracciano descrizioni di incursioni e di razzie perpetrate dai Barbareschi. In molte altre si coglie pure un'esplicita critica aUe toni, incapaci di fornire sicmezza. È certamente innegabile che il flagello della corsa non fu drasticamente estirpato dalle toni vicereali: ma il prodigarsi delle attuali, cospicue e combattive , forze dell'ordine ha elimina to il crimìne? E q uante volte, dopo i più efferati delitti le iispettive compagini sono state tacciate di inutilità? Ma attribuire a quelle isteriche recriminazioni una valenza oggettiva , o una imparzialità di giudizio, appare a tutti manifestamente assurdo: eppure è quanto avvenne per le torri vicerea li napoletane, ritenute per le suddette ragioni dalla pubblicistica specializzata velleitarie, inutili, assurde e fuori tempo massimo. Un giudizio meno convenzionale potrebbe derivare soltanto dal vaglio del loro operato, estremamente complesso se non impossibile. Una significativa convalida si coglie però in una facile osservazio-
ne: il numero delle donne schiave dei Barb,u-eschi , passa dal 52 % ciel totale dei detenuti, valore antecedente all ' entrata in servizio delle torri allo scarso 3-4 % dei decen ni successivi <s.i, Entità che non sarà più modificata fino alla conquista di Algeri nel 1830. Essendo ovvio che la cattu ra di donne poteva avvenire esclusivamente a terra, la loro drastica 1iduzione percentuale certifica la contestuale contrazione deg l i sbarchi corsari , e per conseguenza la validità in terclittiva delle torri stesse.
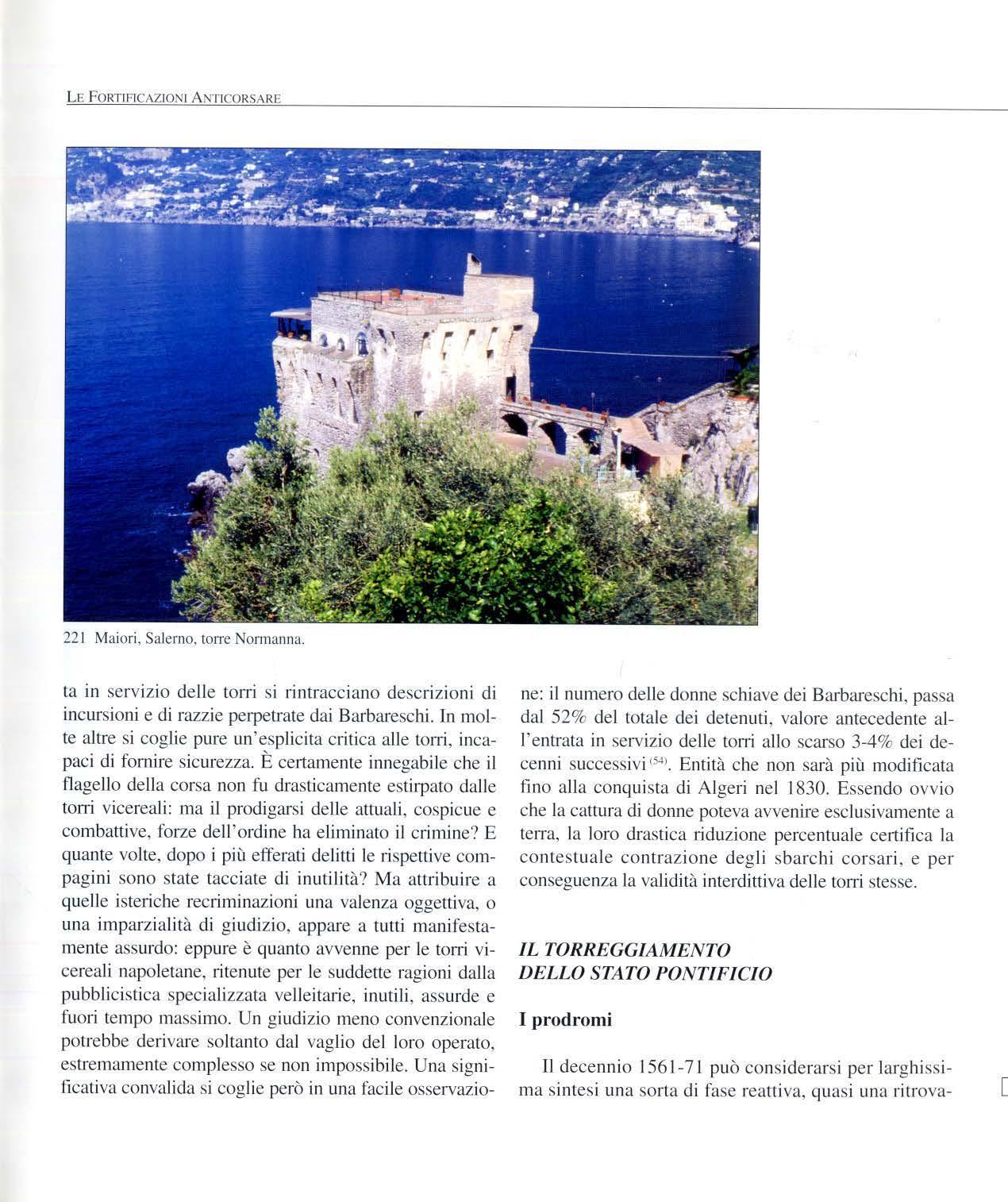
I pro dro mi
Il decenn io l 561-71 può considerarsi per larghi ss ima sintesi una sorta di fase reattiva, quasi una ritrova-
1560 e s i estese d a Pal e rmo e Me ssi n a a tutte le coste dell ' It alia occidentale e a tutte le coste medit erranee della Spagna" (551 • Sensa to ravvisar e in quell'immane riarmo il ruolo affatto tra sc urabile del torreggiamento napol e tano. Sin dai primi ri sco ntri , intorno alla metà degli anni ' 60 ne fu infatti recepita ovunque l a sostanziale ri s pondenza , a differenza dell a pres unzione di ripulir e il mare dai corsari avvalendosi di nutrite s quadre di ga lere. I pianificatori pontific i seg uiva no con comprens ibil e int e resse quanto in corso di attuazio ne nel napoletano , di cui peraJtro non erano mai s tati all'oscuro. Una premess a infatti della grande
222 Pos ita no, Salerno, torre Assio la.
ta consa pevolezza della non invincibilità dei Turchi, ribadita alla fine dalla vittoria di Lepanto . P er mo lti sto ri c i , infatti , il s uccesso d e lle armi ottomane alle Gerbe nel 1560 costit uì il canto del cig n o seg uito da un rapido declino , conseguenza non ultima del rapido evo I ve r s i della tecnologia occidentale. P er cui il: " ... disa s tro di Gerba , in un certo senso, fu sal u tare. Mise l'impero di Filippo II di fronte ai suo i co mpiti mediterran e i ; lo costri nse a reag ire . G e rba e il 1560 seg narono il momento culminante della potenza ottomana. Ciò eq ui va le a dire che, dopo il I 560, essa declinò Non per colpa s ua, ma per effetto dell ' ampio
l avoro di armame nt o marittimo, che cominciò nel 223 Cas tell abbate, Salerno. la t o 1Tc.
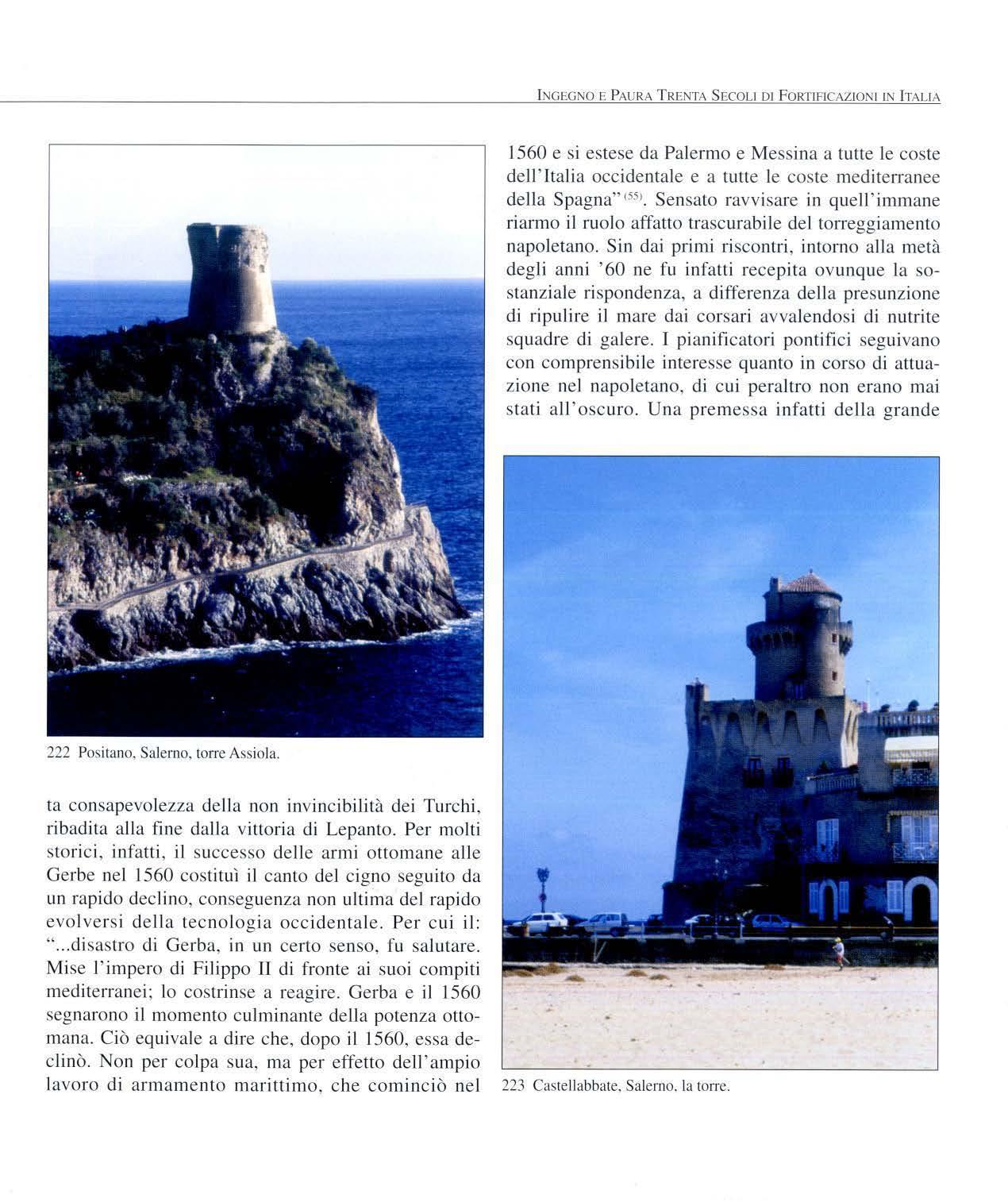 INGEGNO E PA U RA TRF.NT;\ SECOLI DI FORTIFI CAZION I IN lTALIA
INGEGNO E PA U RA TRF.NT;\ SECOLI DI FORTIFI CAZION I IN lTALIA
224 Otra nto. torre Sant'Emi liano.
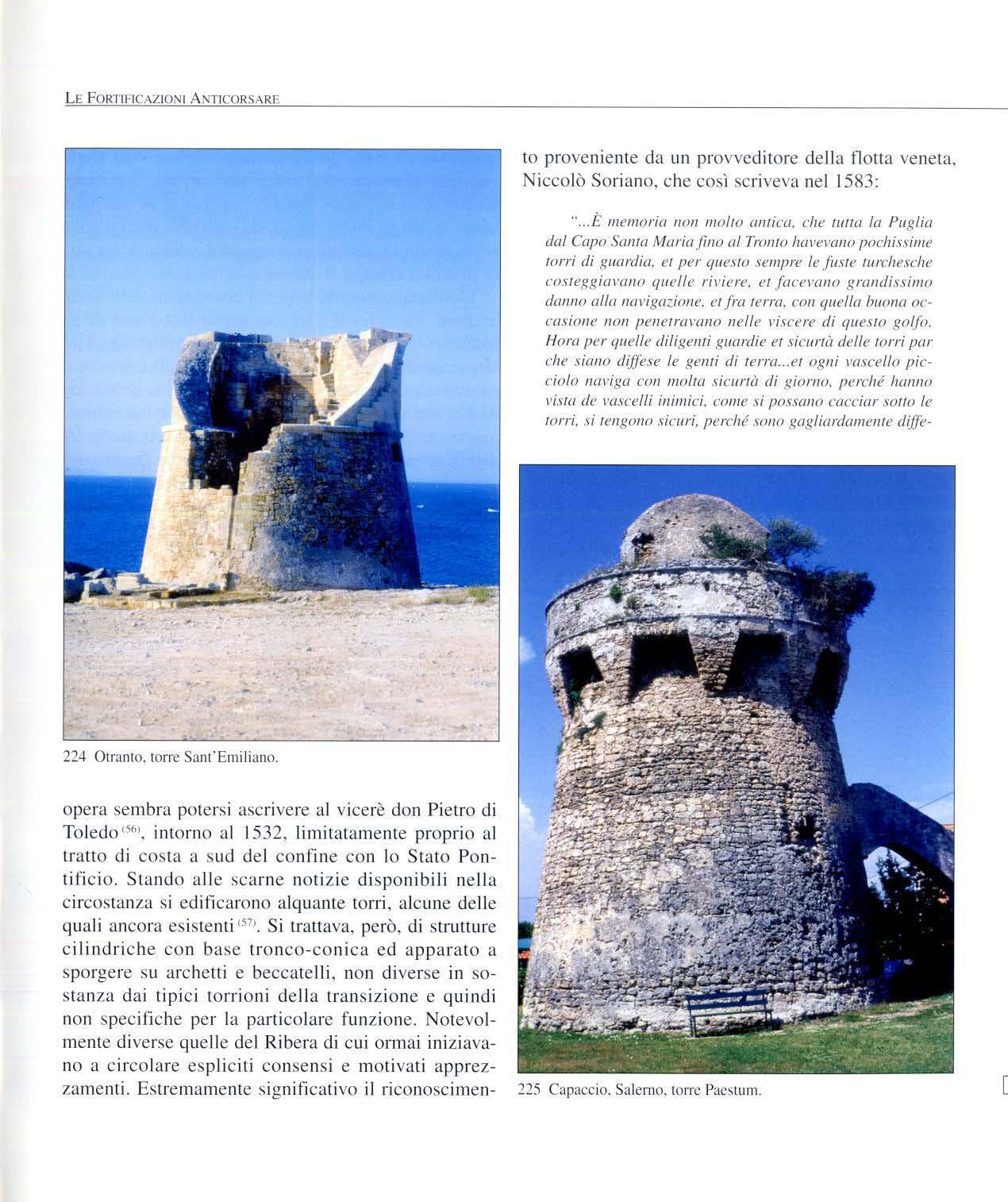
o pera se mbra po ter s i asc ri ve re a l vicer è d o n Pi etro di T o l e d o (56> int o rn o a l 15 32 , li m it a ta m e n te proprio al t ratt o d i costa a s ud d e l c onfin e co n l o S t a to P ontifi c i o Sta nd o a ll e sca rn e n o ti z i e di s pon i bili n e ll a c ir cos ta nza s i e difi caro no a lqu a nte to rri , a lcun e de ll e quali a ncora es iste n ti (571 Si t ra tt ava, p e rò, di s trutture cili ndr iche co n b ase tr o nc o - co n ica e d a pp arato a s p o rge re s u a rc h e t t i e b ecca te ll i, no n d ive r se in sos tan za d a i ti p ic i to rri o n i d e ll a tran s i z io n e e quindi no n spec ifi c h e pe r l a pa rti cola re fun z i o ne. No tev olme nte di ve r se qu e ll e d e l Rib era di c ui orm a i ini z ia vano a c ir co lare es p lic i t i co nse ns i e m o ti va ti a ppr ez-
to proveniente da u n provved i tore del1a flotta veneta. Nicco lò Sor i a no, c he cos1 scriveva nel 1583:
" ... È memoria 11011 molw antirn, c he rema la Puglia dal Capo Santa Maria fino al Tronto lcaveva110 pochis s im e torri di guardia , e1 per ques/U sempre le fuste 1urrhesr/c(' cos Te!!,giavano quelle ri viere, er facerano grandissimo danno alla nav igaz ione, et fra terra, c on quella huona occasione non pe11etrarnno nelle viscere di questo golfo. Hora per quelle diligenti guardie er sicurtà delle torri par che s iano dijfese le genti di terra e t ogni vascello picciolo ,wi·iga co11 moira sicurtà di g iorno. perché hanno vista de vascelli inimi ci, c o111 e s i po ssano cacciar sollo le rorri, si rengo 110 sicuri, perché sono gag liardam en te dif.f'e-
s i da/1 'artig lieria, de lla qual e 11wlw so no f o mite, e , per qu es/U al pres ente le.fi,s re possan o il m o nl e di An cona, s icure di tro var g rosse pred e con po co pe rico lo ... " 158 1 •
li documento di basilare importanza ci con sente un paio di significative precis azioni. Innanzitutto risulta dimostrato da un testimone competente il duplice ruolo protettivo, marittimo e terrestre, del moderno torreggiamento. Inoltre, aspetto ancora più interessante, l'azione dissuasiva delle torri spostando verso l'Adriatico settentrionale il settore di caccia dei corsari barbareschi , dimostrava implicitamente che temevano di più le torri che le galere della Serenissima ad onta del loro numero e della loro aggressività. La risalita, ovviamente ebbe un'attuazione maggiore nel Tirreno attingendo il parossismo sui litorali pontifici. In pratica al progressivo chiudersi della costa campana e calabra faceva riscontro una sempre più inerme esposizione di
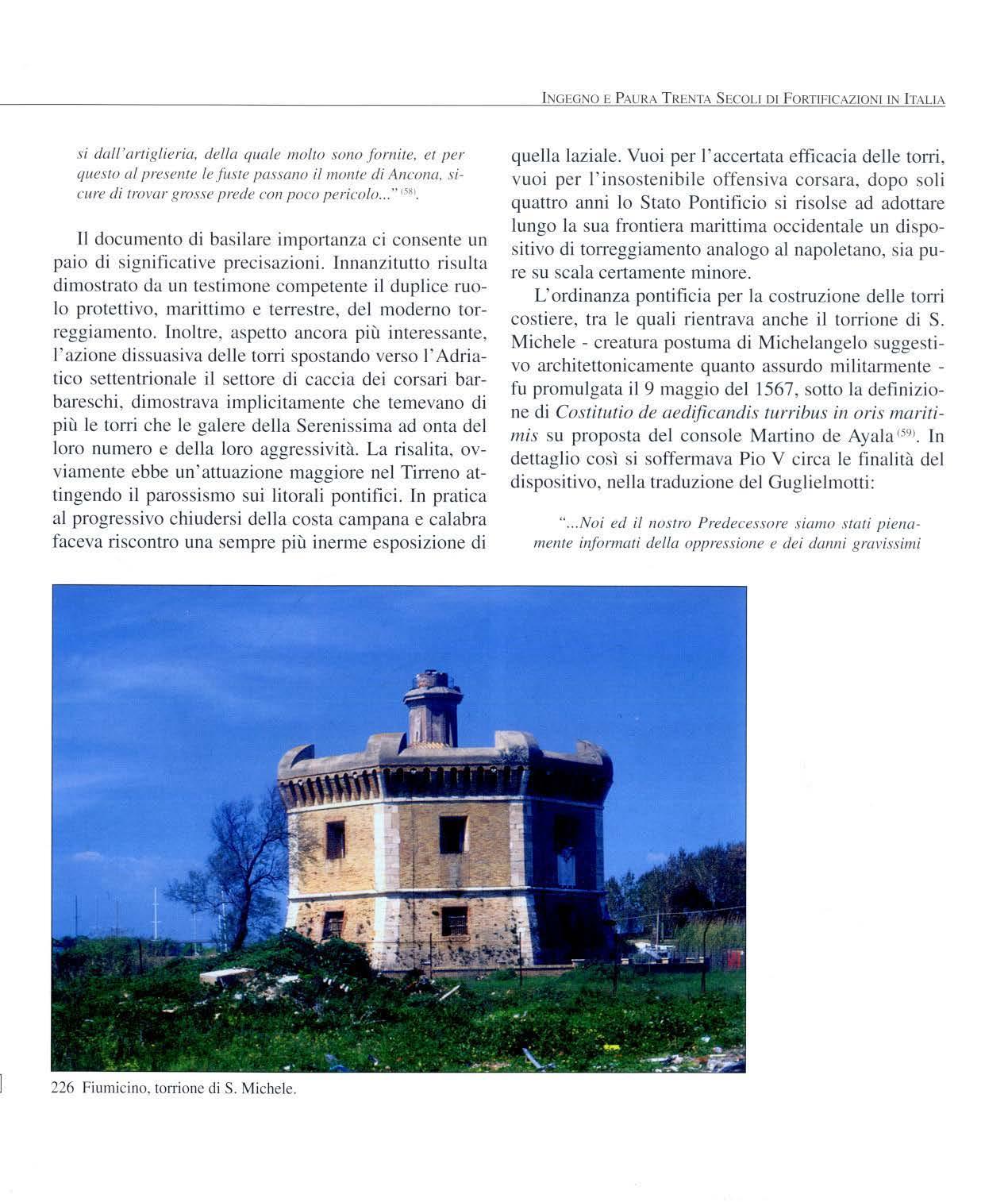
quella laziale. Vuoi per l ' accertata efficacia delle torri, v uoi per l ' inso s tenibile offensiv a cors ara, dopo s oli quattro anni lo Stato Pontificio si ri s olse ad adottare lungo la sua frontiera marittima occidentale un di s positivo di torreggiamento analogo al napoletano , sia pure su scala certamente minore.
L'ordinanza pontificia per la costruzione delle toni costiere, tra le quali rientrava anche il torrione di S. Michele - creatura postuma di Michelangelo suggestivo architettonicamente quanto assurdo militarmentefu promulgata il 9 maggio del 1567, sotto la definizione di Costitutio de aedificandis turribus in oris marìtìmis su proposta del console Martino de Ayala (59 > _ In dettaglio così si soffermava Pio V circa le finalità del dispositivo , nella traduzione del Guglielmotti:
'· N o i ed il nostro Pred ecessore si am o s t a ti pie nam ente informati de lla oppre ss ion e e d ei da 1111i g ra viss imi
che pa,isconu i marinari e i mercadallli sulla spia[?gia romana per 111i!>}'a1to dei pircui. nemici del nome cri.1·1iano, i quali della is1essa deso/a zio11e nostra facendo loro prò. si mel/onu a w/ento nei luoghi più acconci al nascondiglio e all'agguato; e uscendo fuori improvl'isa111e11te sugli incauli, assaltano. uccido110. cattivano rubano bastimenti. danaro: e me11ansi via le persone a s 1ra-::.io perpe1uo in Barberia .'' 1fi(11 •
La costruzione in sintesi concerneva in 15 torri. oltre al torrione S. Michele, entità che rapportata aJJe oltre 300 di Napoli potrebbe la sc iare dubbi circa la validità del provvedimento. Ma quell'apparente inconsistenza trova una sua spiegaz ione innanzitutto nella preesist e nza di numerosi castelli costieri, che giubilati in quanto tali tornavano ancora validi nella difesa anticorsara, e non ultimo nella conformazione morfologica del litorale. Le coste tra Civitavecchia e Gaeta, ad eccezione della modesta preminenza del Circeo, appaiono, ed apparivano ancor di più all'epoca, con connotazioni e caratteristiche assolutamente omogenee. Arenili ampi, sabbiosi, privi di insenature, assolutamenle inadatti agli agguati corsari e per le estese paludi retrostanti , inadatti pure agli sbarchi, che finivano perciò per concentrarsi su pochi e ben noti ambiti. Con una visibilità tanto estesa ed una esposizione tanto bassa tornava poss ibile scag lionare le torri con i massimi interassi ammessi da sistemi del genere pari a 7-10 km. li che già porterebbe iJ lotto delle 15 in questione , oltre al torrione, ad una copertura di quasi 150 km sui circa 200 del perimetro costiero tin-enico. Computando pure i menzionati castelli costieri e le fortezze, si potrebbe s timare il di s positivo varato di densità non minore del napoletano.
In realtà la situazione ri su lt ava ancora migliore, poiché già esistevano lungo la costa alquante toni . Innalzate per iniziativa privata , o su sollecitazione della Reverenda Camera Apostolica, benché di disparata connotazione rispondevano invariabilmente alla protezione anticorsara . Pertanto interponendo tra loro le quindici in questione , o sostituendo dove necessario le meno valide, il sistema sarebbe risultato perfettamente
congruo aUe necessità, con interassi infe1iori addirittura alla metà di quello esposto. Tullavia anche in questo caso, stando ai documenti, ci si accontentò di quella iniziale chiusura, peraltro scarsamente coordinata, ma s i continuò ad infittire la rete di torri erigendone altre ancora sia nel secolo s uccessivo sia in pieno '700. E solo intorno alla sua metà può riten ersi completato il torregg iamento del litorale tirrenico, pur esse ndosi ormai da seco li ottenuta la continuità semaforica tra i caposaldi ci,i, _
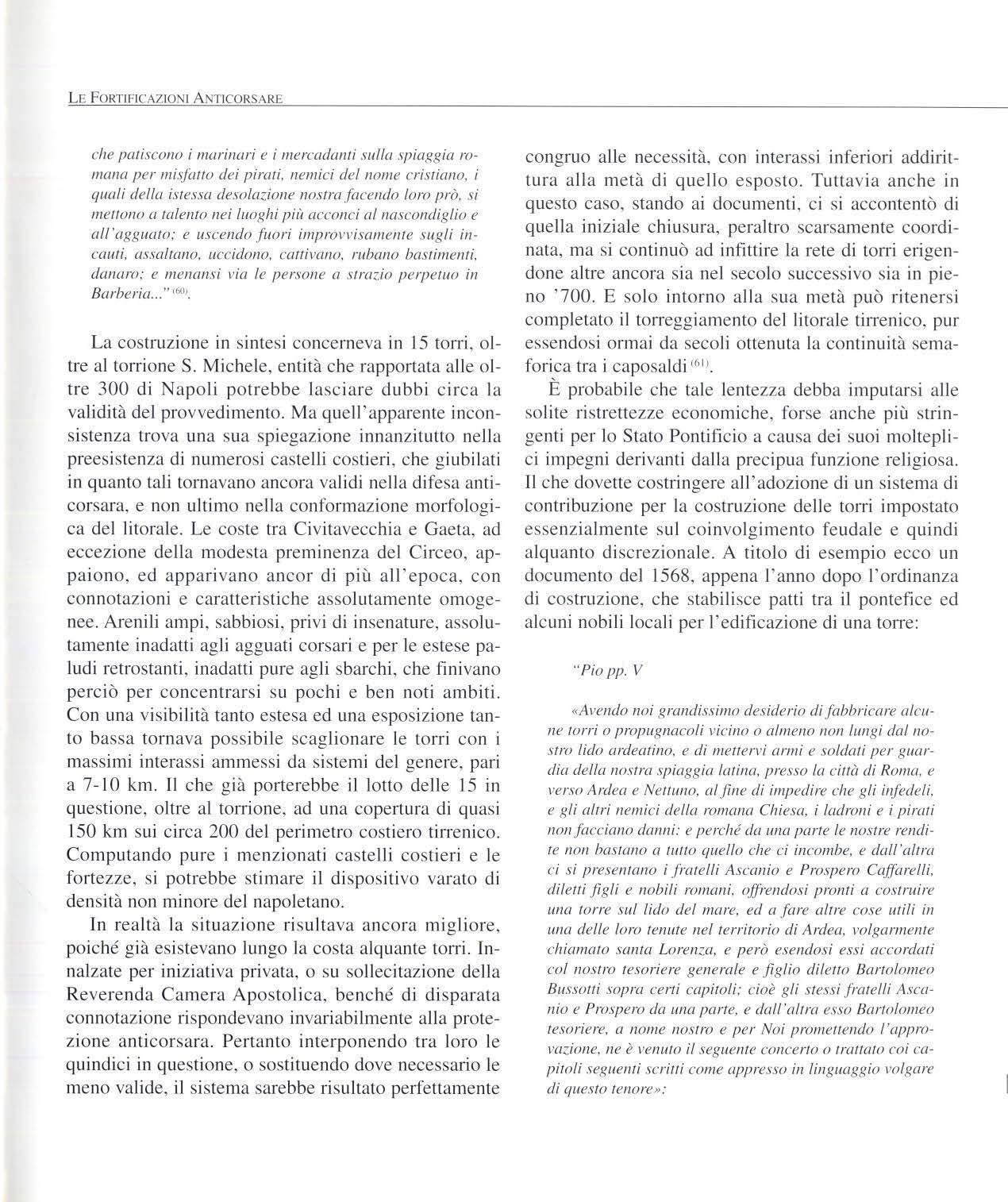
È probabile che tale lente zza debba imputarsi alle solite ristrette zze economiche, forse anche più s tringenti per lo Stato Ponlificio a causa dei s uoi molteplicì impegni derivanti dalla precipua funzione religiosa. Il che dovette costiingere all'adozione di un sis tem a di contribuzione per la costruzione delle torri impostato essenzia lmente sul coinvolgimento feudale e quindi alquanto discrezionale. A titolo di esempio ecco un documento del 1568, appena l'anno dopo l 'ordina nz a di costruzione, che stabi li sce patti tra il pontefice ed alcuni nobili locali per l'edifica zione di una tolTe:
"Pio pp. V
«Avendo noi grandissimo desiderio di.fabbricare alcune 1orri o propugnaco li vicino o almeno 11011 lungi dal nostro lido c11deati120. e di met1erl'i anni e soldali per guardia della nostra spiaggia latina. presso la ci/là di Renna, e verso Ardea e Nettuno. al fine di impedire che gli infedeli. e gli alrri nemici della romana Chiesa. i ladroni e i pirati nonfacc:iano danni: e perch é da una parie le nostre rendit e non bas1a110 a tu/lu quello che ci incombe, e dal/ 'a ltra ci si presentano i ,lì-atei/i Ascanio e Prospero Caffare//i, di/elfi figli e 110bili romani. ojjirndosi pronti a costruire una torre sul lido del mare, ed a fare altre cose utili in u11a e/elle /o,v tenute nel territorio di Ardea, l'olgarmente chiama10 sa111a Loren::,a , e però esendosi essi acco rdali col 11os1ro tesoriere generale e figlio di/elfo Barwlomeo Bussotti sopra certi capi10/i; cioè gli s te ss i fra1efli Ascanio e Prospero da una parte, e esso Barto/0111eo 1esoriere. a nome 11os1ro e per Noi pro111e/te11do l 'a pprovazione , ne è venuio il seguenle co11certo o 1ro1ta10 co i capilo/i seguenti scrilti come appresso in linguagg io \'Ol[?are di questo tenore »:
« Volendo la Santità di nostro Signore papa Pio V fare qualche JHOl'Fisiom• di alcune guardie dietro alle 111arine del Latio di Roma per ostare a/li corsari che non siano così sicuri a smontare in rerm e fare dietro le marine del u1tio bottini d'ani111e, di came, et d'altre cose; et levarli questa occasione per la quale più frequentano questo more; et 11011 si possendo mettere e Tenere quelle guardie se non si fanno dietro alle dette marine ji·a un luogo e l'altro alcune torri e T propugnacoli. nelle quali le dette guardie si possano sicuramente tenere; et il voler fare queste torri di quello della Camera saria dispendioso et si edificariano in fondi di prirati. Per questo Sua Samitù con maturo consiglio ha deliberato di farfare queste torri dietro le marine ad alcuni privati. et fm gli altri alti nobili uo111i11i e signori Ascanio , e Prospero Caffarello, in la tenura di santa Lorenza del tenimento d'Ardea co n la quale per commissione er ordine di Sua Santità 111011signor Barrolommeo Bussotlo. lesoriere generale di Sua Santità, a nome di sua !Jea1itudi11e, per la quale sua Signoria promette che ratificherà li presenti capitoli per un suo Moto proprio. da un pane. er li signori Caffarelli da/l 'a/rra. sono convenuti e vengono nelle irifrascrifle reciproche conventim 1i et c api rul a Tio11i: c ioè in primis che e/erti signori Ca_ffarf'lli acceuano il peso che Sua Santità l'impone di fare in la de TTa lo,v tenuta di Sanra Lorenw a canro alla marina, d01·e li sarà segna to et ordinato per mandato della Camera apostolica, una torre q11adrara , in quartro faccie, larga per faccia palmi quaranra et di alte::za di canr1e 110\'e, ben fondala et fabbricata, e t quella applicare all'uso e, servitio della Camera per le delle guardie in perpetuo. et fare questa fabbrica ù1 mesi otro. cioè in due invernare cominc iando da hoggi; er quesli si è perché 111w invernata va in fondare in paese arenoso, e /'a/ira invernata i11 tirarla su a pe1.fet1ione: e questo per causa che /' es rate 11011 si può lavorare. sì per il malaere, come per il rimare de li rurchi. Et 1·icel'ersa detto monsignor Te soriere promette che sua Santità concederà per ajutare la fabb ri ca la rratra libera e fra n ca di mille rubbia ' fi 21 di g rano per terra o per 111are; cioè adesso per rubbio cinquecento, el per / 'a/ere rubbio c inque ce nro quando la deua to r re sarà.fondata e si tuata sopra terra a me::zo tratto; et inoltre pagarli dieci sc udi il mese ogni vol ra che la torre sarà finita e messa in gua rdia per tre uomini; quando essi signori Caffarelli ve li Tengono per gua rdia di detta torre: e r darli I 'a rliglieria e munitioni necessarie: o vero se piacerà alla reverenda Camera apostolica, habhia la cura lei di deua provvisione di scudi dieci il mese.
Et più. perché le ma c chie che sono in ques ti luoghi sono laccioli che iJ11 ,i1mw i corsari e ladroni a 1·e11ire piiì animosame11te a fare delle prede in questv Latio, per quesTO sua Beatitudine ha delibero/O di fare s111acchiare dette renure e loro selve et macerie; et perché non è expediente fare questi ragli a spese della reverenda Camera aposwl ica, sebbene fosse il beneficio della sicurezza di questi paesi ta1110 in terra quanto in mare, però sua Samità si conrenra che li detti signori Caffarelli facciano loro wgliare. e 1 smacchiare, et schocchare derte selve o posTe; eT per invicarli a questo sua Beatitudine li dà e T concede in ricompensa di quello al/i detli signori Cc1ffarel/i er loro heredi et successori i11 pe11Jetua /icen::a di poter es rrarre per ,nare e per rerra e per qualsivoglia banda e transito dalla della renwo /WTO, grano biade. e legumi, che lotv e/ loro heredi e successori predetti ricoglieranno del/i t erreni di detta tenuta. che in vista della presente capitu/a:,iune raglieranno 1111acchieranno, schioccheranno, in questo senza peso di nessuna gabella o rrcma. imposta o da imporsi, le quali se gli ri111ertono per questa causa onerosa. perché de r1i signori Ca.ffarelli non haPrebbero altri111e11ti farro impresa di 1agfiare smacchiare er schioccare delle selve : riservando però che quando per mala annata o per guerra o per alrro bisog110 il Papa o La Camera se ne ,·a/esse per bisogno del corpo di Roma, che in quel caso li detti signori Cajfarelli 11011 lo possino eslrarre, ma condurlo a R oma per beneficio della città: con questo però che la e/erra Camera sia tenllta restituire ad essi signori Ca.ffarelli l'anno seguente che lei 11011 lzavesse bisogno per corpo di Roma. come cli sopra, ra111a tratla qua1110 imporrerà il grano e t l 'al tro che havesse condo u o i11 Rom a per beneficio della città, dia la tratta per altri grani. biade e legumi che si raccogliera11110 nelle alrre loro te1/l(te del loro terrilorio d'Ardea
Dar o in R oma . presso sc,11 Pi e rro, addì veruiclue di gennc;jo ed ann o 1568. ricevuto e registralo per decreto de/a Cwnera - Collcdonaro e concorda. Girolamo da Taranto" <631
È fondamentale per co mpr e nd e re lo spi rit o del co ntra tt o, evidenz ia r e c he l a procedura espos ta - l a qu a l e non trovava eq ui va lente nel torreggi ame nt o napoletano e p er essere la s tra gra nd e ma gg ioran za de ll a fascia costiera ge lo sa proprietà d emaniale e per esser e l e fortificazioni di matri ce militare di stre tta co mp ete nza gove rnati va - offriva so l o appa r e nt e m e nte un
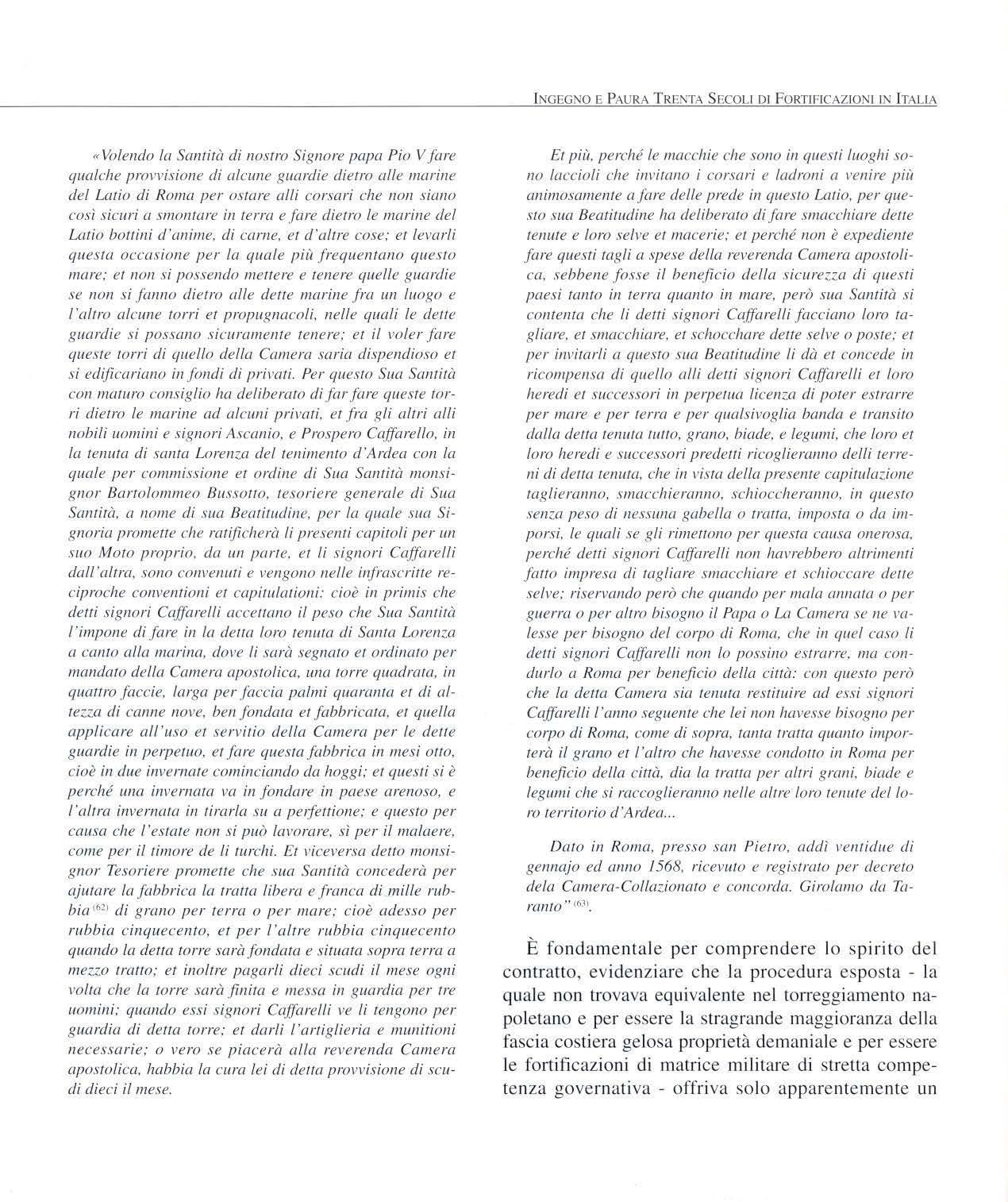 lNGEGNO E PAURA TRENTA SJ°\COLI DI FORTIFICAZIONI IN lTALIA
lNGEGNO E PAURA TRENTA SJ°\COLI DI FORTIFICAZIONI IN lTALIA
vantaggio per lo stato. ln realtà i maggiori beneficia1i di siffatti accordi erano i feudatari ed i possidenti terrieri interessati localmente.
La concessione di esportazione del grano, infatti , sebbene limitata, assi.curava consistenti profitti che compensavano già in buona pa1te gli oneri di costruzione, affrontata peraltro nel la cattiva stagione quando la disponibilità di mano d'opera era abbondante e molto economica. L'imposizione della guardia poi, a rotale carico della Camera Apostolica , consentiva di coltivare ampi appezzamenti fino a quel momento abbandonati perché troppo a rischio e troppo esposti ai saccheggi ed alle devastazioni corsare. La proprietà pertanto subiva una cospicua rivalutazione tanto in valore assoluto quanto di reddito. Senza contare che I' esigenza di deforestare la costa per consentire una perfetta visibilità, conseguita mediante una ulteriore concessione ad esportare. in cambio della deforestazione costiera imposta dal servizio di s orveglianza, forniva altri enormi appezzamenti fertili ss imi per giunta gratificati dalla libera commercializzazione dei raccolti. In questo caso, quindi, i benefici per i p1ivati appaiono addirittura tre , ovvero l'utile costituito dall"ingentissima mas s a di legname, quello derivante dal recupero di terreni abbandonati e quello dell'esportazione dei prodotti agricoli, sempre ovviamente grazie alla protezione delle torri. Facile a rguire che un governo forse meno corrotto, o più oculato, avrebbe potuto imporne l'edificazione senza alcun contributo bastando abbondantemente la riappropriazione di appezzamenti abbandonati.
re la morsa corsara, poco prima del 1567 , la s tandardiz z azione delle torri risultava un crite1io ormai scontato. Se mai restava indeterminato il modulo a rchitettonico di torre tipo da riprodurre: in altre parole uguale o meno a quella napoletana? Forse per dirimere la questione si restrinse la valutazione alle sole torri appena innalzate sulla spiaggia romana per iniziativa
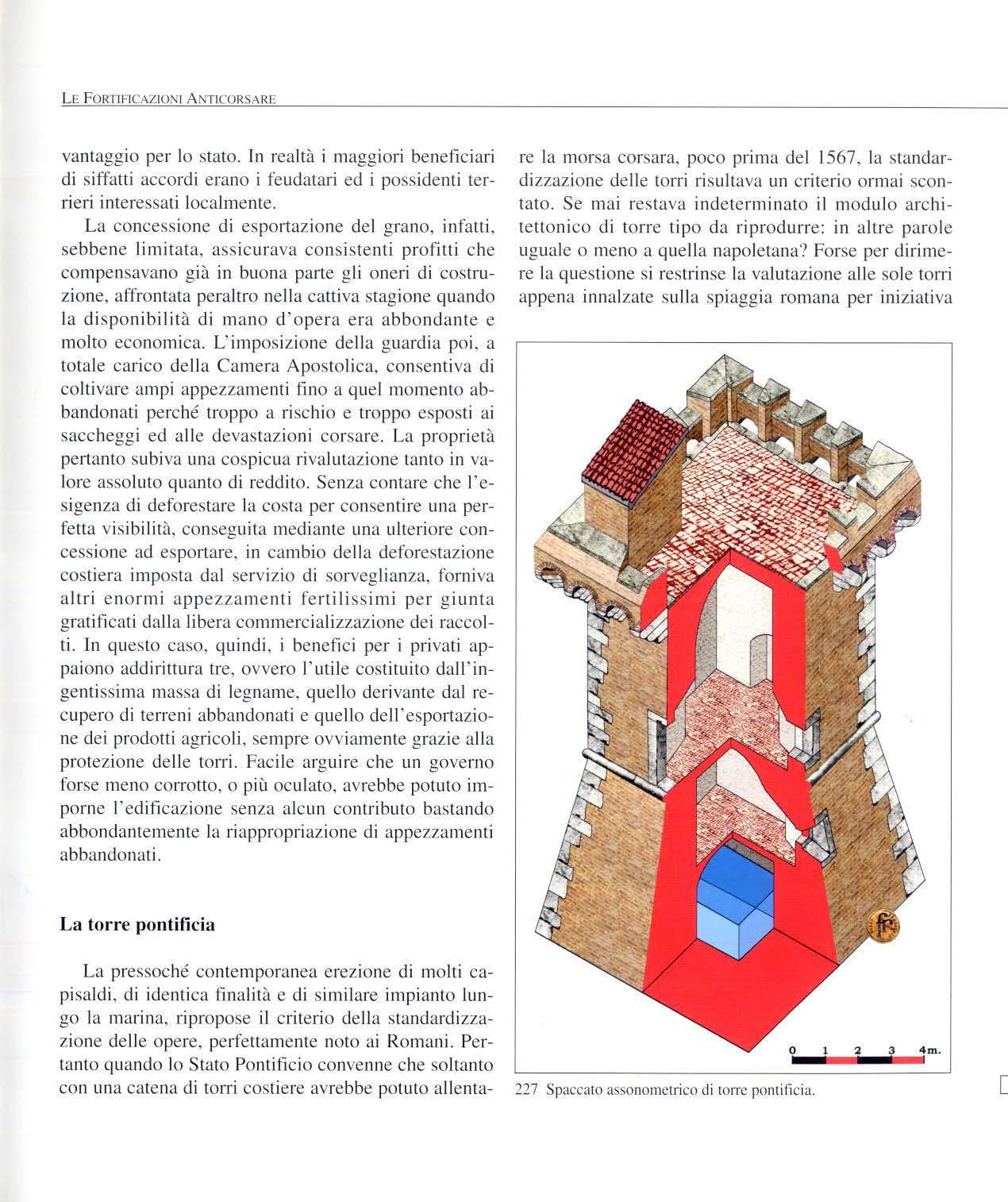
La pressoché contemporanea erezione di molti capisaldi, di identica finalità e di s imilare impianto lungo la marina, ripropo se il criterio della standardizzazione delle opere. perfettamente noto ai Romani. Pertanto quando lo Stato Pontificio convenne che soltanto
con una catena di toITi cos tiere avrebbe potuto alle nt a-
228 Latina, torre Olevola.
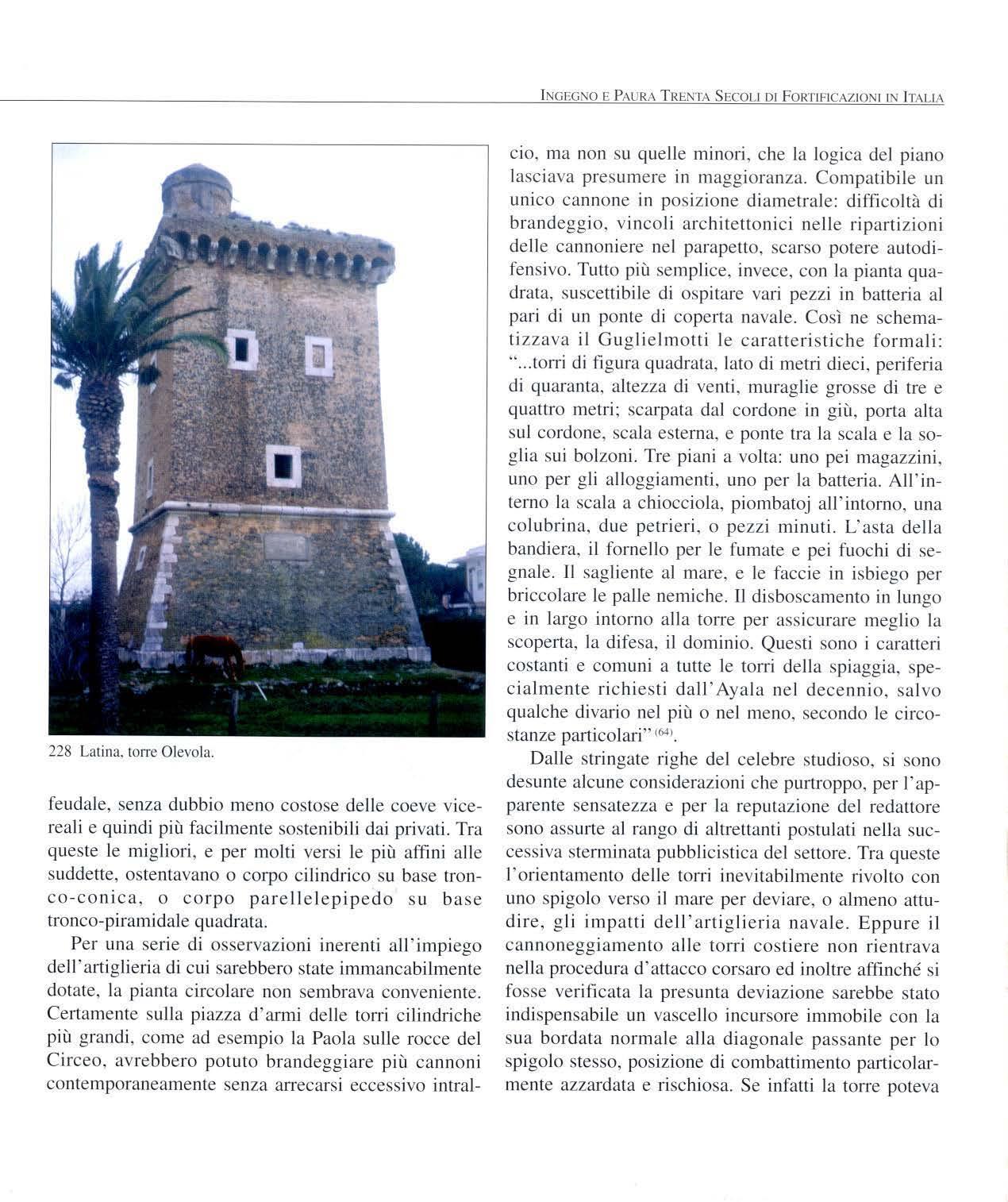
feudale, senza dubbio meno costose delle coeve vicereal i e quindi più facilmente sostenibi]j dai privati. Tra queste le migliori , e per molti versi le più affini alle s uddette, ostentavano o corpo cilindrico su base tronco-conica, o corpo pare l lelepipedo su base tronco-p iramidale quadrata.
Per una serie di osservazioni inerenti all'impiego dell'artiglieria di cui sarebbero state immancabilmente dotate, la pianta circolare non sem brava conveniente. Certamente sulla piazza d 'amu delle torri cilindriche più grandi, come ad esempio la Paola sulle rocce del Circeo avrebbero potuto brandeggiare più cannoni contemporaneamente senza an-ecarsi eccessivo intral -
cio, ma non su quelle minori , che la logica del piano lasciava presumere in maggioranza. Compatibile un unico cannone in posizione diametrale: difficoltà di brandeggio, vincol i architettonici nelle ripartizioni delle cannoniere nel parapetto, sca rso potere autodifensivo. Tutto più sem plice , invece, con la pianta quadrata, suscettibile di ospitare vari pezzi in batteria a l pari di un ponte di coperta navale. Così ne schematizzava il Guglielmotti le caratteristiche formali: " ... torri di figura quadrata, lato di metri dieci, periferia di quaranta, altezza di venti , muraglie grosse di tre e quattro metri; scarpata dal cordone in giù, porta alta sul cordone, scala esterna, e ponte tra la scala e la sog lia s ui bolzoni. Tre piani a volta: uno pei magazzini, uno per gli alloggiamenti, uno per la batteria. Ali' interno la scala a chiocciola, piombatoj all'intorno, una colubrina, due petrieri, o pezzi minuti. L'asta della bandiera, il fornello per le fumate e pei fuochi di segnale. li sagliente al mare , e le faccie in isbiego per briccolare le palle nemich e. U disboscamento in lungo e in largo intorno alla ton-e pe r assicurare meglio la scope rta, la difesa, il dominio. Questi sono i caratteri costanti e comuni a tutte le torri della spiaggia, specialmente richiesti dall' Ayala nel decennio, sa lvo qualche divario nel più o nel meno, secondo le circostanze particolari" \64 )_
Dalle stringate righe del celebre s tudio so, s i sono desunte alcune considerazioni che purtroppo, per l'apparente sensa te zza e per la reputazione del redattore sono assurte al rango di altrettanti postulati nella successiva sternunata pubblicistica del setto re. Tra queste l'orientamento delle torri inevitabilmente rivolto con uno spigolo verso il mare per deviare, o almeno attudire, g l i impatti dell'artiglieria navale. Eppure il cannoneggiamento alle torri costiere non rientrava nella procedura d 'a ttacco corsaro ed inoltre affinché si fosse verificata la pres unta dev ia z ione sa rebbe sta to indispensabile un vascello incursore immobile con la sua bordata normale alla diagonale passante per lo spigolo stesso, posizione di combattimento particolarmente azzardata e 1i sc h iosa. Se infatti la ton-e poteva
essere battuta da mare anche l'imbarcazione poteva essere battuta da terra ed es sendo la preci sione del tiro costiero dj gran lunga superiore per la stabilità della postazione, il duello si risolveva a danno della seconda. Del resto ad eccezione di quella risicatissima posizione , improba da mantenere per l'intera durata di un duello balistico a causa dei venti e delle correnti marine, uno scarto di pochi gradi appena avrebbe vanificato la presunta prestazione dello spigolo. L'01ientamento , quindi , anche delle torri pontificie scaturiva da una logica intrinsecamente opposta imperniata sull ' incremento delle potenzialità offensive delle torri e non di queJJe meramente difensive. Discorso sostanzialmente analogo per la scarpa basamentale concettualmente del tutto identica alla scarpatura continua già esaminata nelle toni vicereali napoletane.
Torre quadrata, pe 11anto, su base tronco-piramidale ed a lzato verticale, con alle spalle oltre un secolo di esperienza fruitiva. È emblematico che la torre sull'isola di I schia, dove secondo la tradizione soggiornò per breve tempo Michelangelo, appartenga a questa tipo l ogia ' 65 1 • Di simili torri , infatti , per uso costiero ne erano state erette prima di quel 1560 alcune, ma anche a JJ ora non potevano considerarsi , al contrario delle vicereali , una rivoluzionaiia novità. La toITe pontificia, in definitiva, r i proponeva con lievissime m igl io ri e la torre ge n tilizia quattrocentesca e cinquecentesca. Del resto la minore esposizione alla corsa consentiva tale semplicazione.
Una più p untua l e identificazione delle cai·atteristiche salienti del modulo di base della torre pontificia è possib il e s ull a fa lsar i.ga de l capi tolato d'appalto della ton-e di Foceverde. Nel ca s o specifico la modernità del documento, 1677 , rende più comprens ibi l e la term in olog ia tec nica, ferma restando la concezione progettuale, immutata peraltro sino alla dismiss ione
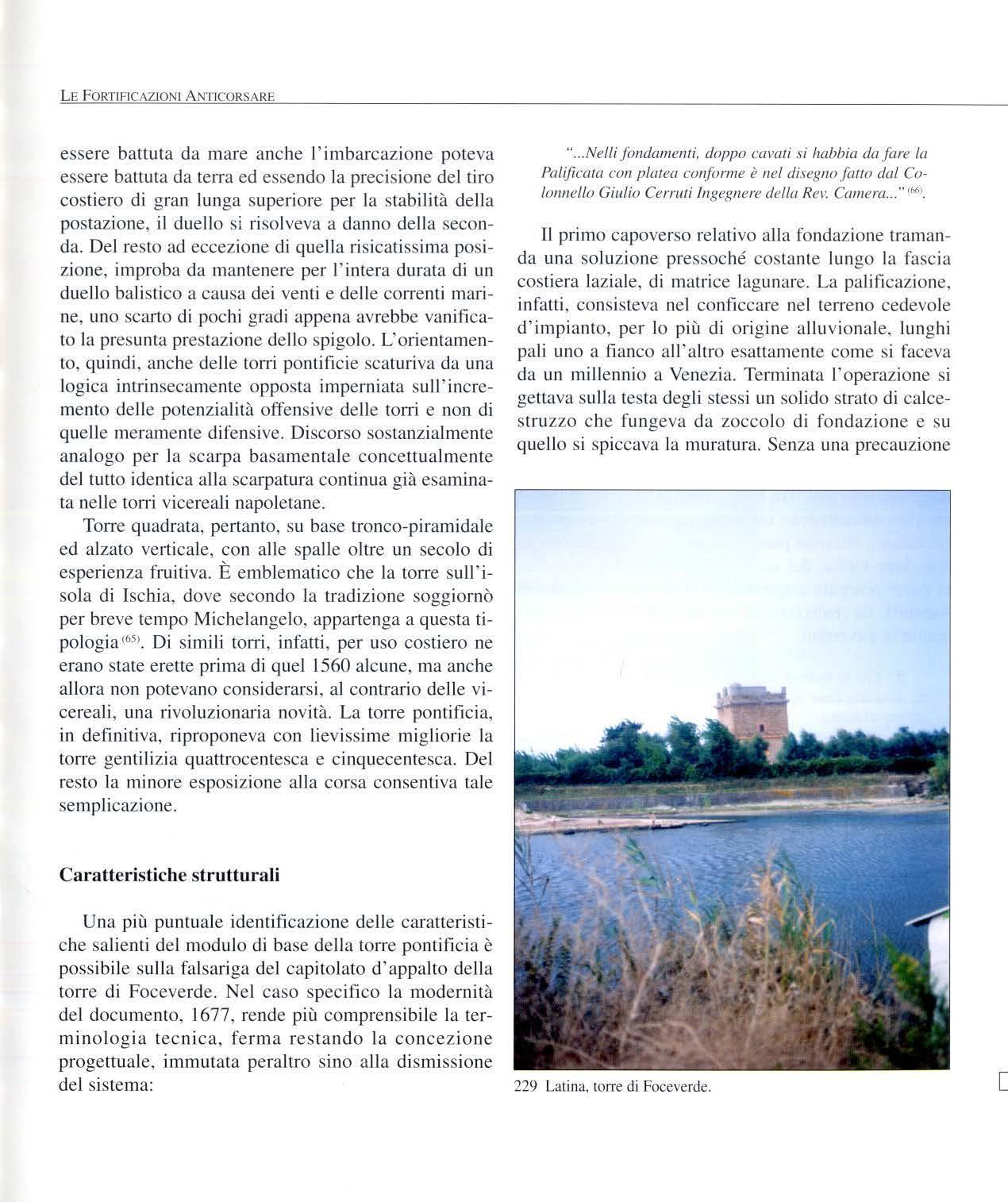
" . N e /li f ondam e nti, d oppo ca vati s i habbia da fa re la Pa lifica ta con plat e a confo rm e è n el d isegn o f a rro da l Colonnello Giulio Ce rri/li In gegn e re d ella Rev. Cam e ra " Hì<I I _
Il primo capoverso relativo alla fondazione tramanda una s oluzione pres soché costante lungo la fascia costiera laziale, di matrice lagunare. La palifica z ione , infatti . consisteva nel conficcare nel terreno cedevole d'impianto , per lo più di origine alluvionale, lunghi pali uno a fianco all'a ltro esattamente come si faceva da un millennio a Venezia. Terminata l ' operazione si gettava sulla testa degli stessi un solido strato di calcestruzzo che fungeva da zoccolo di fondazione e su quello si spiccava la muratura. Senza una precauzione
del genere non sareb be sta to possibile cost ruire a lcun a torre p er l a forte pr essione c he Je sue fondazion i avrebbero esercitato s ul cedevo le s uo l o.
2 • Che li muri per di ji,1ori siano nari di tal'olla di grossezza palmi 1,5 da stuccarsi co11 la cortina all'uso di Roma.
3 · Che li muri di denrm siano di pietra buona e resis tente conforme ordinerà il sud.lo Colonnello.
4 · Che li co rdoni in c ima d i delta rorre e 111od e lli [ga11011ij che vanno in cima so llo al parapelto rulli di 1rnverti11 0 o alrra pietra forre lavorata da scarpellù1i •1 • 11 •
La muratura de lla torre è prevista a secco co n un a parete esterna, di circa 40 c m di s pesso re, con estrado sso intonacato , ed un a parete intern a in pietra di adeguato s pesso re. Tra le du e un riempimento in te nacissimo calcestruzzo ottenuto impas tando calce con po zzo lana. Previ st o pure un duplic e ordine di cordoni a sezione to rica , dei quali il primo a ll 'attacc a tura fra 1a parte sc arpat a e quella vert ical e e d il secondo in so mmità , d a reaJi zza rsi al pa ri de i gattoni delle piombatoie in travertino.
5 - Che l e vo /re di detta rorre , che si devono fare buone, lavorate bene in calce con sassi piccoli. ben bagnati all"uso di Roma.
6 · Che sopra la vo/,a di cima c1 si debbia fare il massiccio co n il suo lastri co sopra. ben Lavorato acciò non p e netra l'acqua.
7 • Che la prima volra di sorro e quella di c ima si debb ia fare /"astri co per habirarci, e stab ilirla con farli le 4 g uardiole sopra la loggia o 11ol1u scoperta sta n e l profilo del disegno '68\
Le volte so no pr esc ritt e con conci di pietra opportunamente tagliata. Al di s opra di quella di copertura andav a eseg uito un robusto ma sse tto , completato da una impermeabilizzaz ione in conglomerato battuto dotato di modesta p e nd enza, in modo da favorire il deflu sso delle acque ve rso le pluviali sfoc ianti nella ci s terna. La resistenza dell'in siem e doveva essere compatibile e sos tenere senza la minim a les ion e le so llecitazioni dell ' armamento, comunque rilevanti e
reiterate nel tempo. Interessante l a menzion e d e ll e qu a tt ro ga1itte i n serite agli spi go li della piazza: l a solu z ione c he vantava g i à numerosi precedenti par z i a li , derivava dalla necess ità di di sporre s ulla copertura di opportuni d e pos iti riparat i nei quali conservare una certa quantità di munizioni , mate riali infiammabili per le segnalazioni , e non ultimo d ei pi ccoli ambienti dove riparars i durante i turni di guardia. Esse ndo gli spigo li privi di cannoniere costitivano il punto di inn es to nùgliore.
8 - Che la sca letta a lu111aga che va in d. a torre hubbia da essere di pierra anche li scalini.
9 ·Chela porricina o altrefinesrre o bale striere, che li stipiti di.fuori s i a no di pietra di h11 0 11 e conforme a modelli e co rdoni
IO · Che d e lta.fabbrica si habbia da fare a tu/la po zzolana di Conca e buona c alce ·· <&J,.
E sse ndo la ton-e prevista di tre piani , in que1lo inferiore ven nero ubicat i i d epos iti e la ciste rn a, in quello interm ed io l 'a llo gg iamento de lla g uarn i gio ne e s ulla co pe rtura la batteri a e le ga ritte. Il collegamento verticale s i disimpegnò co n una scala a chiocciola di pietra in spesso re di muro , nel lato a monte lo stesso dov e si apriva per moti vi di s icurezza l a porta so prae le va ta e dotata di a nti stante ponte levatoio. Pur non risultando ne l documento citato, in ogni torre vi era una c isterna per la riserva idri ca del pres idio. La scarsa evidenza potr e bbe attTibuirsi al ruolo non es iz ial e svo lto dalla stessa in re g ioni paludo se, e per g iunta so ttopo s te a bradi sisma.
Le dimen s ioni non appaiono me nz ion a te probabilmente per essere sosta nz ialm e nte s tandard lun go l ' intera catena per omogeneità ambientale.
Nei rarissimi contesti anomali la torre s i discostava se nsibilmente dalla media , come n e l caso di Tor S. Lorenzo così presc ritta nel relativo capitolato:
"La forre che si ha da fare nel luoio det ro sa nto Loren w . territorio de/li Cl~ffàrelli. del'e essere quadra. Lunga pe r ogn i quadro quaranracinque palmi /m. 10,050): alra so prn il li ve llo della p/a1èa palmi n ol' a11tuno [m. 20, 320}; con tre vo lle d ent ro. Sopra ne/I 'a llo le sue can-
 IN GEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTLH CAZIONI IN I TALIA
IN GEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTLH CAZIONI IN I TALIA
 230 Ladispol i, Roma, torre Flavia: emblema tico esempio di bradisisma nella fa e ia cos ti era laz iale
230 Ladispol i, Roma, torre Flavia: emblema tico esempio di bradisisma nella fa e ia cos ti era laz iale
noniere. e piombatori per tutto. Grosso il muro Jìno al cordone palmi quindici fm. 3,350}; il quale co rdone deve essere di travertino; et alto sopra la sogl ia palmi venticinque f m. 5,580]. D e lì in su.fino alla sommità lungo palmi dieci fm. 2,234}, con la s ua scala a/lumaca de palmi quattro e me zzo [m. 1 J larga nel luogo: come particolannente li sarà designato da/li depu 1ari di sua Santità et architetto. D evono paf!,are le spese d e l fabbricarla gli stessi Cajfarelli, per essere il lerritorio suo. Deve contribuire Gianfllippo de Serlupis per la tenuta che tiene presso al Casrro :· no, .
Le eccezionali dimen s ioni di Tor S. Loren zo non trovano alcun equivale nt e lun go l ' intero sc hieramento tirre nico Qu a nto al litorale adriatico, in linea di larga massima, conobbe l'edificazione di pochiss ime torri di analoga concezione e configurazione architettoruca, per gi unta con not evo l e ritardo. La bass a es posizione ai ri sc hi incursiv i va imputata da un lato alla presenza d ella flotta veneta dall 'altro alle mura di c ui erano muniti tutti gli abitati s in dall ' alto m e dioevo. Nessun s i s te ma quindi ma s olo una teo ri a di autonomi capi sal di. Tu ttav ia di torri con l e caratteristiche canoniche dello Stato Pontificio al presente di sic uro se ne po sso no individuare almeno due delle quali una a Portono vo s ull ' omonima baia press o Ancona e l 'altra torre Cervia presso Ravenna, Ja maggiore in assoluto. Di: " ... pianta qu a drata, più ampia d e l normale (m. l 3 .50x 11.30) e pure piuttos to alta (m. 27) [altezza d e lla copertura probabilment e s ucce ss iva per ragioni climatich e, restando invec e Ja piazza intorno ai 20 n.d.a.] qua s i interamente in mattoni , essa è costituita da un part e basamentale a sc arpa , s partita mediante un toro in pietra dalla mediana appiombo; la superiore è a lieve s porto , con una grande caditoia nel mezzo d 'og ni lato "m 1•

Com e accennato oltre al le torri di nuova costruzione lo Stato Pontifi c i o, al pari di tutti gli a l tri , re c uperò
ed ins erì nel s iste ma di dife sa anticorsara qualsias i al-
tra reputata s uscett ibil e ili in tegraz ion e, indip en dentemente d a1l a s ua vetustà. Alcune di esse infatti vantavano già secol i di esistenza e di fun z ione anticorsara, altre pochi decenni ; qualche caposaldo poi non era nemmeno una torre: tipico il caso del Pesco Montano di Terracina, una guglia di roccia adattata a pos ta z ion e d 'artiglieria.
Di tutte senza dubbio la più interessa nte dal punto di vista storico ed architettonico riman e ToITe Astura , nei press i di Nettuno. sin go lare coacervo di aggiornamenti e alterazioni fino quasi alla Seco nda GueITa MondiaJe m l. La s ua origine s i perde ne l buio del medioevo, iniziandosene ad individuare precis i riferim e nti docu-
lNGEG O e PA URA TRENTA SECOLI DI fORTLf'I CAZIONI IN l TALIA 232 Terracina, Latina , Pesco Montano.mentali so ltanto dal 1193 , nell ' ambito d e l feudo dei Frangipane . Sotto la signoria di Giovanni Frangipane, nel 1268 , vi avvenne l'epi sodio, universalmente tacciato d'infamia, della cat tura , per tradimento, di Co1Tadino di Svevia , reduce dalla sfortunata giornata di Tagliacozzo. Il patibolo di pi azza Mercato a Napoli rec ise la giovane e tragica esistenza dell'ultimo erede di Federico rr m,. La vendetta quand'anche tarda non mancò: nel 1286 la flotta siciliano-arago n ese attaccò la fortifica zione e, avutane ragione , vi ucc ise nella circostanza il figlio del Frangipane. La ton-e , o forse più esattamente l a piccola rocca, fu 1icost.ruita pochi anni dopo , per finire in cendiata nel 1328 e se mpre ad opera della flotta arago nese Nel 1367 Astura divenne proprietà degli Orsini , ne l 1383 dei Gaetani e quindi di nuo vo degli Orsini, per passare a di s tanza di un cent in aio d 'a nni a i Colonna , che la tennero con alterne v icende per tutto il XV I secolo , cedendola allora a ll a Camera Apostolica.
Sotto i I profilo arc hi tettoni co la ton-e, s i impiant ò dir e ttamente su ruderi romani affioranti dal mare e d un lungo pontile ne ga ranti va l' accesso. Originari amente fu forse una s nella costruzione parallelepipeda , una sorta di clongione marittim o a lto quas i 3 0 metri. Il mutare delle es igenze difen s ive comportò dapp1ima la trasformazione in puntone con lo s pigolo verso terra , integrato in breve da un recinto quadrilatero con alcuni corp i di fabbrica adibi ti ad abitazione. L a distanza da terra e lo spessore delle mura evitaro n o ulteriori modifiche: anzi probabilmente proprio in virtù dell a s ua s traordinaria a ltezza fu ritenuta vantaggiosissima per la difesa anticorsara, e pe1tanto in se rita nella lin ea a di spetto della cons id e revo le età. lndi s pen sabile tuttavia il raffo rzamento di alcune s trutture , per adeguarla all ' impi ego dell 'artiglieria. Stando infatti ai verba li del XVII seco lo l a torre di spo neva di un re lati vamen t e di screto armamento, per l 'esa tte zza di du e p ezz i di
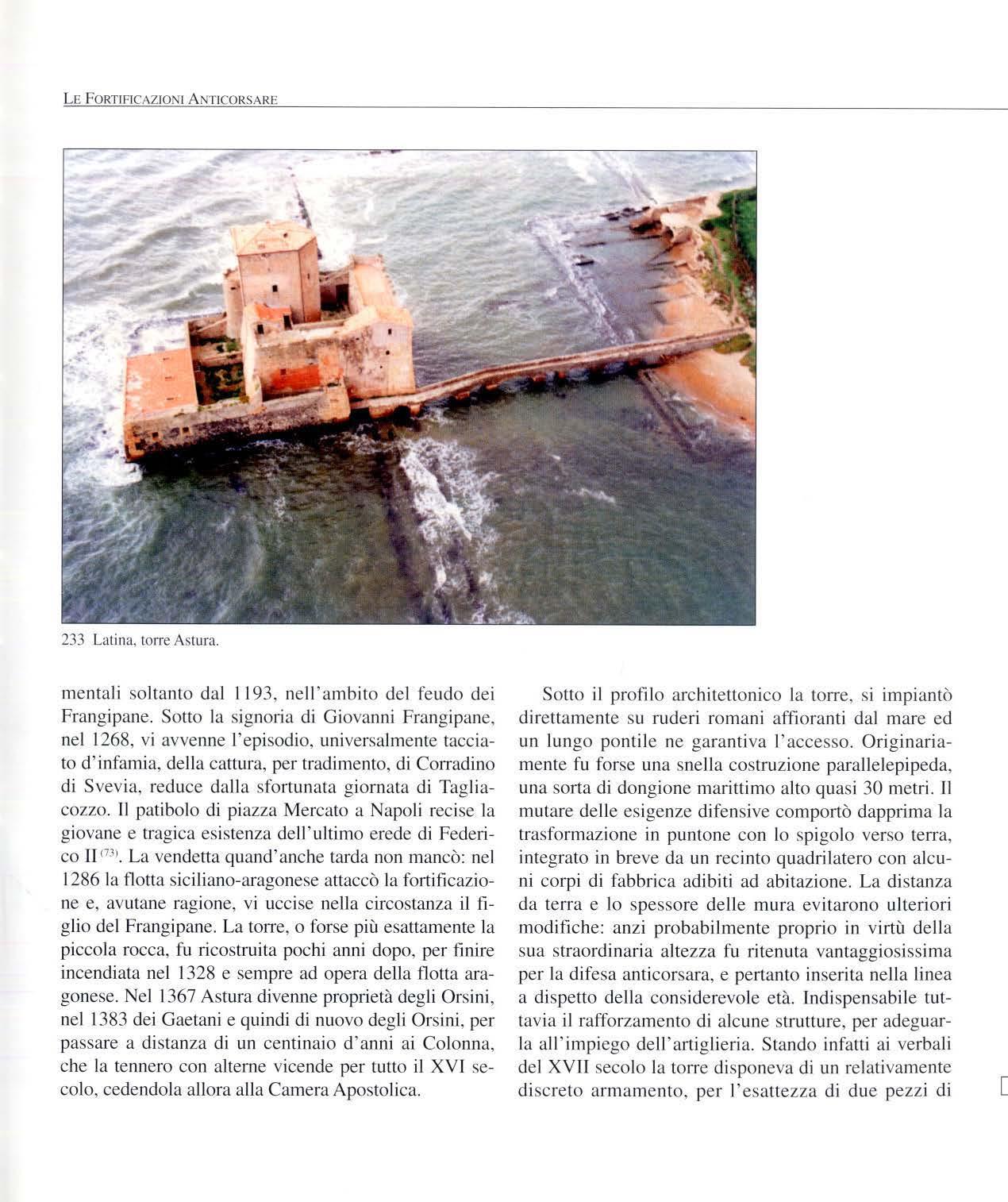
piccolo calibro , di due spinga rde e di due petrieri con una congrua riserva di munizioni. Di sso lta si la minaccia corsara intorno a l I 830, finì tra l e proprietà d e i Borg hese che ne avviarono il re sta uro seco ndo la logica dell 'e poca.
Poche decine di chilometri prima di torre Astura s picca la mole rocciosa del promontorio del Circ eo, talmente infido e ri sc hio so da richiedere un più accorto toITeggiamento, qua s i una so rta di precipuo sott o s is tema. L e stesse cinque torri che lo compongono ostentano una singolare co nfigurazion e, a pianta circolare e piazza sc ud a ta a monte da un mas sicc io s opralzo. Concettualmente sono a naloghe alle v ic erea li napoletane a doppia altezza.
La più importante del gruppo appare se n za dubbio to rre Paola. così detta in quanto fatta erigere da Paol o lii nei press i d i Sabaudia. In s iem e alle altre quattro , però, faceva capo ad un unico comando, ubicato in quella d e tta di S. F e lice o Vittori a, dal quale dipendeva pers ino la co rres pon sio ne di s tipendi e muni z ioni , nonché il coo rdinamento della vigilanza. Pur ri s ultando ultimata nel primo semestre del '63 non si rin viene ness un inventari o cinquecentesco del s uo armamento che ini z ia a fi g urare, invece, a partire d a l seco ndo d ecennio del XVII seco lo. Il rit ardo , pertanto, sembra avvalorare l'ipotesi che per l 'e ntrata in servizio si attese l ' ultim a z ion e d e ll 'in tero g ruppo , essendo altrimenti inutil e la funzio ne e troppo es po sta la guarnigione. Ad ogni b uon co nto primo a fame menzione fu il march ese del Grillo, che lo trovò cos tituito da un unico pezzo da IO libbre affia ncato dall'immancabil e petri ero . Pochi anni dopo subì un leggero increm e nto , stabilizzando si da quel momento su due pe zz i.
Sebbene intorno alla met à del XV I secolo il cosiddetto Stato dei Re a li Pres idi di To sca na c14 J fosse ormai esattamente definito s ia nell a s ua configurazione terri -
 l NGEGNO E PAURA TREKTA SECOLI DI FORT IFICAZIONI JN I TALIA
l NGEGNO E PAURA TREKTA SECOLI DI FORT IFICAZIONI JN I TALIA
to rial e che in quella dinastico-a mmini strati va, in re a lt à ben poco di esso s uggeriva un a sia pur modes t a realtà statuale. Scars i ss ima e non omogeneamente di s tribu i t a la popol azio ne, insignificante l ' economia, trasc urabil e il gett it o fiscale, inesistente un qualsiasi apparato militare locale anche a liv e llo mili ziano. Quanto alla difesa cos tiera in generale ed anticorsara in particolare le poch e compagnie s pagnole, peraltro s is tem a ticamente sottorganico, acquartierate nei pressi dei gross i centri abitati, non potevano fornire alcun valido aiuto contro le incursioni. Soprattutto lungo l'Arge ntario , promontorio che ne costituiva la pa rte maggiore del territorio, dove i barbaresc hi spadroneggiavano indi s turbati. Ve ssaz ione ormai protraentes i da secoli e perfettamente ri s aputa s in dai tempi della sovranità, a lmeno formale , di Siena. Stando infatti ad una relazione d e l 1334 , emblematicame nt e identica alle consimili di duecento anni dopo:
" ... è il Monte Ar,:entaio lu ogo cli 1110/ta stil/l a ... Vi sono vene d 'ar,:ento, dalle quali il monte piglia il nome s uo Produce 1110/te e rb e appre-::;::.ate da ' Medici.. . ma le più sono incognite, perché il timore dei corsari vieta ag li herbatori, la prati ca del Luogo
Decemb re 1334'' 175 •
Oro ed argento in r ea ltà al di l à dell e leggende originate ma g ari dal luccichio della vile pirit e non se ne trovava affatto. L ' unica ricche zza di s ponibil e sare bbe s tata perciò la ben più concreta raccolta di erbe officinali, magari dei p asc oli ma la minaccia dei cors ari rendevano anche quell e poverissi me attività persino più ri sc hiose del!' es traz ione au ri fera. Dalle fonti risultano com unqu e rilasc iate alquante concess ioni minerarie, tutte regolarmente dimostrate s i illu sorie. Ma in una di esse, relativ a pure all'impianto di una tonnara , rilasciata nel I 441 ad un certo Morosini, s i rintraccia una esplicita allusione al la volontà di provv e dere alla dife sa anticorsara d e l promontorio mediante una serie di fortifica z ioni , che andrebbero perciò riguardate come il nucleo originario del futuro torreggiamento. Con una precisa clau so la il contraente s i imp egnava a:
·' .fare in detti porti o vero Monte, dove meglio gli piacerà. 11110 castello e torri fortissimi da difendarsi dà inimici, in modo che si porrà difendere da ch i li volesse occupare per honere della V. S. et stato di questa ciuò. El in questa primavera rominciarò a fare detle forle~'?,e, e1 seguirò con solleci1udine, che in breve sarà fortifica10 et in tempo d i qua trro anni finito
5 ot1obre 1441 ·· PM
La vic e nda della dife sa del promontorio e delle sue ri sorse terrest ri e marittime, nonch é dei s uoi sca li portuali, tramite forte zze e torri, ini ziò d a quei giorni il suo le nti ssimo iter a s ua volta prodromo obbligato del decollo demogr a fic o . E che qualcosa concretamente dovette esse re attuata di lì a bre ve lo s i evince da un altro documento immediatamente s uccessivo , del 1442, che così ricordava l'arrivo a porto Ercole di un piombinese tramite un ' imbarcazione del Moro s ini: " qui nunc e difi ca ! fortelliciam in Monte Argentario " ml _ Ed un decennio dopo in un 'e nn esima concessione mineraria si può leggere un indubbio riferimento alla realtà di alquante torri costiere. Conse ntiva infatti il contratto:
" che a esso Bartolomeo, suoi compagni e lavoratori per sicurlà de' corsari sia lici10 potersi riduciare, quando lò paresso essere di bisogno colle persone e robbe loro, nelle torri e fortezze del Mon1arge111ario, excepto che ne la torre de la Pesch i era, nella quale non possa riduciarsi senza licentia del Comune d'Orbete llo
15 giugno 1451" 08 >
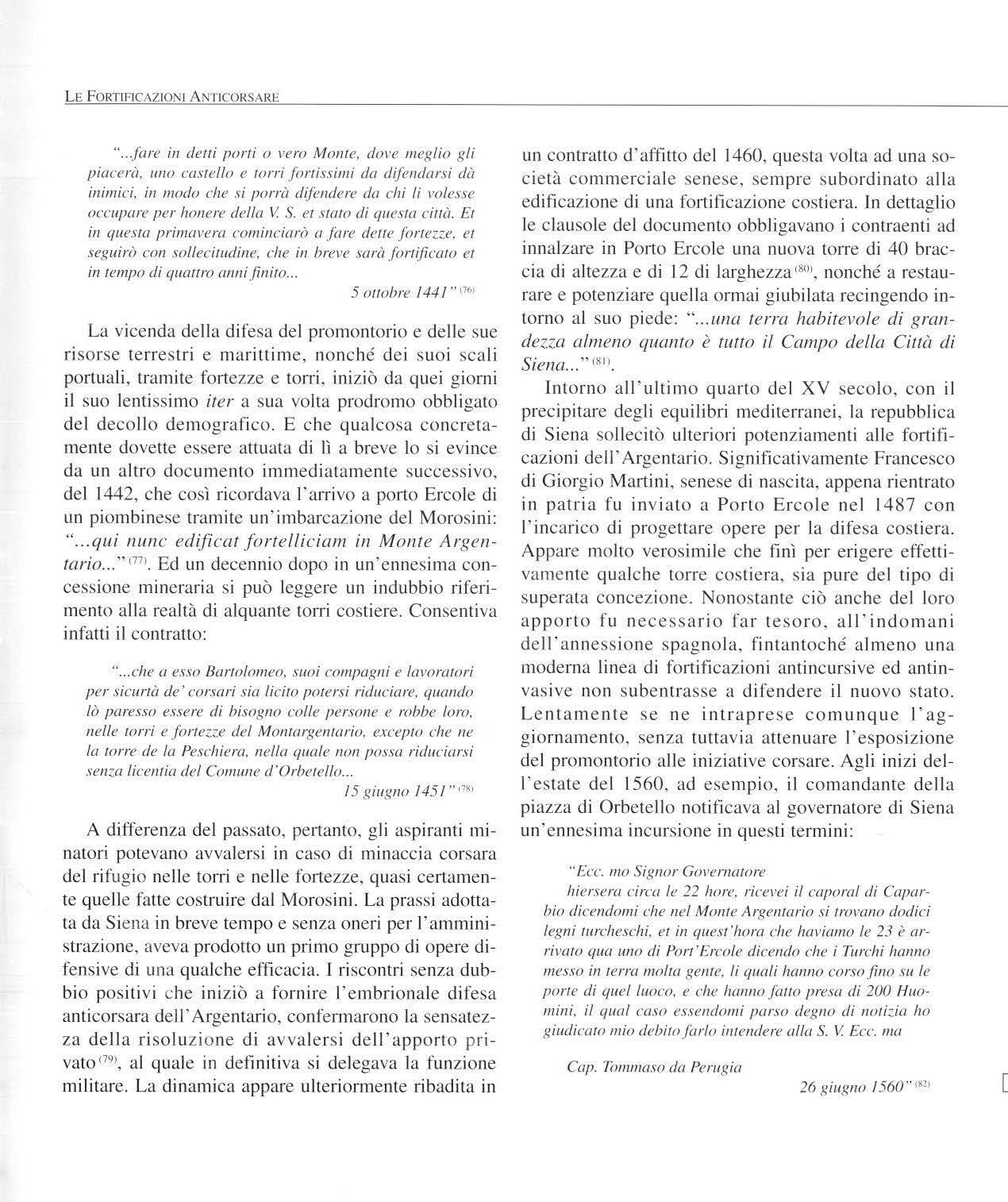
A differenza d el passato, perta nt o , gli aspiranti minatori potevano avvalersi in caso di minaccia corsara del rifu v io nelle torri e nelle fortezze, quasi cert ame n- o te qu elle fatte costruire dal Morosini. La prassi adottata da Si ena in breve te mp o e se nza oneri per l ' amminis trazi o ne , aveva prodotto un primo gruppo di opere difensive di una qualche efficacia. I ri sco ntri se nza dubbi o po s iti vi c he iniziò a fornire l 'e mbrionale dife sa anticorsara dell 'Argentario , confermarono la se nsa tezza della risoluzione di avvale r si dell'apport o privato 09> , al quale in definitiva s i delegava la fun z ione militare. La dinamica appare ulteriormente rib adita in
un co ntratto d'affitto de l 1460, que s ta vo lt a a d una socie tà co mm ercia l e senese, se mpr e s ubordinato a ll a edificazione di una fortificazione costiera. In de ttagli o le clausole del documento obbli gavano i contraenti a d innalzare in Porto Ercole una nuova torre di 40 braccia di altezza e di 12 di larghezza (80!, nonch é a res taurare e potenz iare que ll a ormai g iubil ata recingendo intorno a l s uo pi e de: " una terra habitevole di grandezza almeno quanto è tutto il Campo d ella Città di Siena " (sii _
Intorno all'ultimo quarto del XV secolo, co n il precipitare degli equilibri mediterranei. la repubblic a di Sie na so llecitò ulter iori potenziamenti a ll e fortificazion i d ell' Arge ntario. Significativamente Francesco di Giorgio Martini , se ne se di nascita, appena ri entrato in patria fu inviato a P or t o Ercol e n e l 1487 con l 'i nca ri co di progettare opere per la dife sa costiera . Appare m ol to veros imil e che finì per er ige re effettivamen te qu alc he torre costiera, sia pure d e l tipo di s up e rat a co ncezion e. Non os tante c i ò anche del loro appo rt o fu n ecessar io far tesoro, a li ' indomani del l'annessione s pagnola, fintantoch é almeno un a moderna linea d i fortificazioni antincurs i ve ed a ntinvas ive non s ub en tra sse a difender e il nuovo sta to. L entamente se ne intrapr ese comunque l'a gg i ornamento, senza tuttavi a a ttenuare l 'es po s i z ione del promontorio alle iniziative corsare . Agli inizi del1' es t a te del 1560, ad esempio, il comandante della piaz za di Orb etello notificava al governatore di Siena un'enne s im a incursione in questi termini:
'Ecc mo Signor Governatore hiersera circa le 22 hore, ricevei il capora l di Caparbio dicendomi che nel Monte Argentario s i trovano dodici legni turcheschi. et in quest'hora che haviamo le 23 è arrivato qua uno di Port 'Erco le dicendo che i Turchi hanno messo in terra molta gente, li qua li hanno corso jìno su le porte di quel fuoco, e che hanno fatto presa di 200 Huomini. il qual caso essendomi parso degno d i notda ho giudica to mio debi to farlo i111endere alla S. V. Ecc. mo
A peggiorare la situazione contribuivano anche gli isolotti ad immediato ridosso della costa , molti dei qua li ritrovandosi al pari di Giannutri totalmente disabitati, si erano trasformati in altrettante basi corsare, evento peraltro comune in tutto il Mediterraneo occidentale, senza contare la miriade di grossi scogli litoranei idonei agli agguati navali. Per la loro vicinanza rappresentavano una minaccia gravissima poiché l'aggressione barbaresca poteva scatena r si in qualunqu e momento e senza il benché minimo preavviso. Il rimedio sarebbe stato quello di presidiarle con picco le guarnigion i in apposite fortificazioni, ma ancora una volta le risorse eco nomiche facevano difetto, ingoiate dalle grandi fortezze alla cui ultimazione era stata assegnata la comprensibile priorità. Nel frattempo, però, i famigerati isolotti continuavano a falcidiare le rendite, ma neppure negli ann i successivi fu possibile e limin are il problema che ricompare in questa relazione del 1571, la quale evidenzia:
"Corno tambien pro ceda
Come tuttora ne derivi danno alla rendita sui pascol i di S. M. dal non essere cu stodita l' Isola di Giannutri Detta isola è per i corsari un luogo perperuo cli scalo da cui si s pingono sulle coste romane e su quelle di questo Regno attaccando quanti vascelli di piccolo bordo vi navigano ... Si potrebbe fortificarla con tremila ducati ci rca facendovi nella cala grande una torre sopra di un poggio che vi si trova Si avrà così un'opera benedetta degna di S. M un transi to li bero e sicuro per queste marine in direzione d i Roma e di questo Regno .. .'' 183 ,
Ad onta della sensatezza del ragionamento la tragica ca ren za di denaro impediva di infrangere quel c ircolo vizioso . Nel frattempo, tuttavia, l' i nt ensificarsi delle razzie barbaresche ed iI conseguente progressivo rarefarsi della navigazione commerciale C84> , sommandosi a l ricordato in gentissimo danno erariale finirono per porre in primo piano la questione del torreggiamento dei P residi, inducendo la dirigenza spagnola a co ll egarlo a quello del Regno di Napoli di prossimo avvio.
Disgraziatamente le poche torri costruite negli ultimi decenni non si pres tavano , così com ' erano e lì dov ' erano, all'attuazione di un identico sistema, dimostrandosi incompatib ili con l'installazione dell ' armamento balistico. I cannoni, infatti, richiedevano torri con adeguate dimensioni delle piazze di copertura, munite di apposite cannoniere e robusti parapetti attraverso i quali poter tirare nella massima sicurezza per i serventi Ma richiedevano anche torri con un'ubicaz ione ed un orientamento accurato in funzione dei settori di massimo rischio e soprattutto , con un impianto non molto alto su l mare. In caso contrario il fuoco sarebbe scaduto dal micidia le tiro radente a quello quasi trascurabile ficcante e , non di rado, la stessa spiaggia sarebbe ri sultata addirittura oltre la gittata. I n breve lungo le coste alte e rocciose dell'Argentario, pochissime delle torri esistenti apparivano per struttura e per ubicazione integrabili nel s istema di torreggiamento rinascimentale.
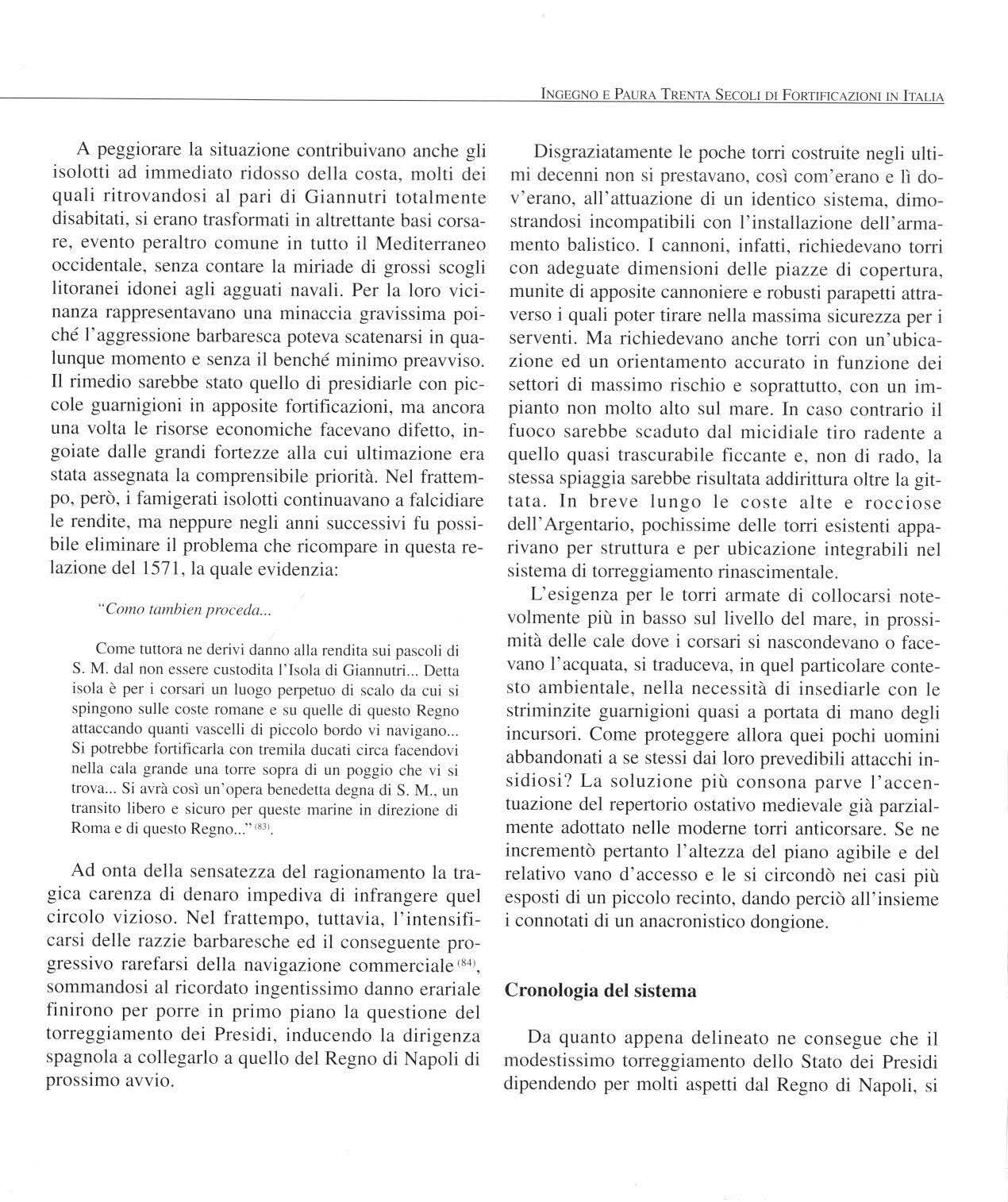
L'esigenza per le torri armate di collocarsi notevolmente più in basso sul livello del mare, in prossimità delle ca le dove i corsari si nascondevano o facevano l'acquata, si traduceva, in quel particolare contesto ambientale , nella necessità di insediarle con le striminzite guarnig ioni quasi a portata di mano degli incursori . Come proteggere allora quei pochi uomini abba ndon ati a se stessi dai loro prevedibili attacchi insidiosi? La soluzione più consona parve l 'accentuaz ion e del repertorio os tativo medievale già parzialmente adottato nelle moderne to rri anticorsare. Se ne incrementò pertanto l ' altezza del piano ag ibil e e del relativo vano d ' accesso e le si circondò nei casi più esposti di un piccolo recinto, dando perciò ali' in s ieme i connotati di un anacron ist ic o dongione.
Da quanto appena delineato ne consegue che il modestissimo torreggiamento dello Stato dei Presidi dipendendo per molti aspetti dal Regno di Napoli , si
INGEGNO E PAU RA TRENTA SECOLI DI FORTIFIC AZIONI JN ITALIAattuò quasi contestualmente al maggiore. Oltre ai due promontori di Talamone e dell'Argentario, la presenza di vasti e malsani acquitrini sia a nord che a sud degli stessi valse, se non altro, a contenerne il numero di torri strettamente indispensabili. In definitiva poche torri elementari a notevole distanza fra loro. Quanto ai promonto1i, invece , per le loro coste alte e frastagliate, con diverse sorgenti alla base e discreti abitati alle spalle, senza contare un vivace traffico mercantile nello specchio di mare antistante, la situazione appariva radicalmente antitetica, ideale per la guerra di corsa in ogni sua manifestazione. In definitiva molte torri armate a breve distanza fra loro. Suscettibili di reintegrazione le vecchie torri nel primo caso, del tutto incompatibili nel secondo, ferma restando l'esigenza di limitare al minimo i costi unitari e quelli complessivi del sistema essendo già esorbitanti le risorse fagocitate dalle grandi piazzeforti in costruzione. Si spiega così il perché soltanto due torri rispecchino i canoni di quelle vicereali napoletane coeve, certamente più moderne e senza dubbio più costose, mentre tutte le restanti, invece ricordino in genere quelle adottate dallo Stato Pontificio, ovvero torri a pianta quadrata con basamento scarpato e corpo parallelepipedo, apparato a sporgere su mensole e beccatelli ed ingresso sopraelevato. La non adozione del modello napoletano, tuttavia, dovette ufficialmente vantare una qualche motivazione di conforto, al di là di quella meramente economica. Non si spieghe r ebbe altrimenti come la medesima dirigenza politica e militare, nello stesso contesto storico e per identiche finalità riuscisse a giust ific are alla comm i ss ion e tecnica imperiale l a preferenza per una tipologia tanto dissimile in un sito di rilevante interesse strategico
È probabile che le ragioni prioritarie siano ascrivibili entr ambe alle connotazioni sociali esistenti a ll e spalle delle torri. In particolare in un caso alla insignificante densità demografica dell'Argentario e nell'altro invece a quella eccezionale di Napoli. Nel primo, infatti, la scarsa popolazione locale risulta quasi ne lla totalità concentrata in Po rto Erco le, in Talamone
ed in Porto S.Stefano, tutti centri peraltro debitamente fortificati. Tra di loro praticamente il vuoto, connotazione che rendeva non remunerativa ogni incursione a terra e privi d'alternative gli agguati ai mercantili.
Ma anche in questo caso l 'arcaicità, però di siffatto modulo ne decurtava la congruità all'impiego rispetto al napoletano, in particolare per l'anacronistico apparato a sporgere. Circa quest'ultimo occorre precisare che mentre la stragrande maggioranza delle torri pontificie pervenuteci ne conserva l'impianto, più o meno integro , quelle dei Presidi ne appaiono sistematicamente prive. Persino nei disegni se icenteschi del Fabroni <85 ) non se ne scorge traccia, come pure in ogni rilievo posteriore. Difficile ritenere che tutte lo abbiano potuto perdere per le vicende belliche immediatamente successive o per i cedimenti strutturali s ubito dopo l'entrata in se rvizio. Un gran numero di esse, invece, ostenta una o due piombatoie al mas simo. In buono sta to di conservazione, o ridotte ai soli su pporti lapidei, garantivano l ' inviolabilità del vano d'accesso o di una finestra: potenzialità interdittiva ben lontana, quindi, dal controllo totale del perimetro di base delle coeve torri napoletane ed in misura appena minore di tutte le altre. L'anomalia appare assolutamente inedita nel pur vastissimo repertorio delle torri costiere italiane, inducendoci a relazionarla ad una seco nda peculiarità a lt rettanto precipua di molte di quelle dei Presidi: i piccoli recinti a 'coda di rondine ' che ne serrano la rampa d'accesso. Loro tramite era poss ibile tenere eventuali assalitori a discreta distanza dalla torre , consentendo alla difesa di inquadrarli per la maggior distanza con una rosata più ampia del petriero.
Premesso ciò quanto esistente all'avvento dell 'annessione spagno la , ascrivibile alla iniziativa senese lungo il perimetro dell ' Argentario non offriva, a differenza della costa fino a Talamone, alcuna possibilità di recupero. In dettaglio: " si trattava di torri alte dai IO ai 15 metri, costruite in posizioni dominanti in prossimità della costa, a una distanza non superiore alle tre miglia l'una dall'altra. La modestia delle dimensioni di dette strutture s i spiega col fatto che i loro compiti
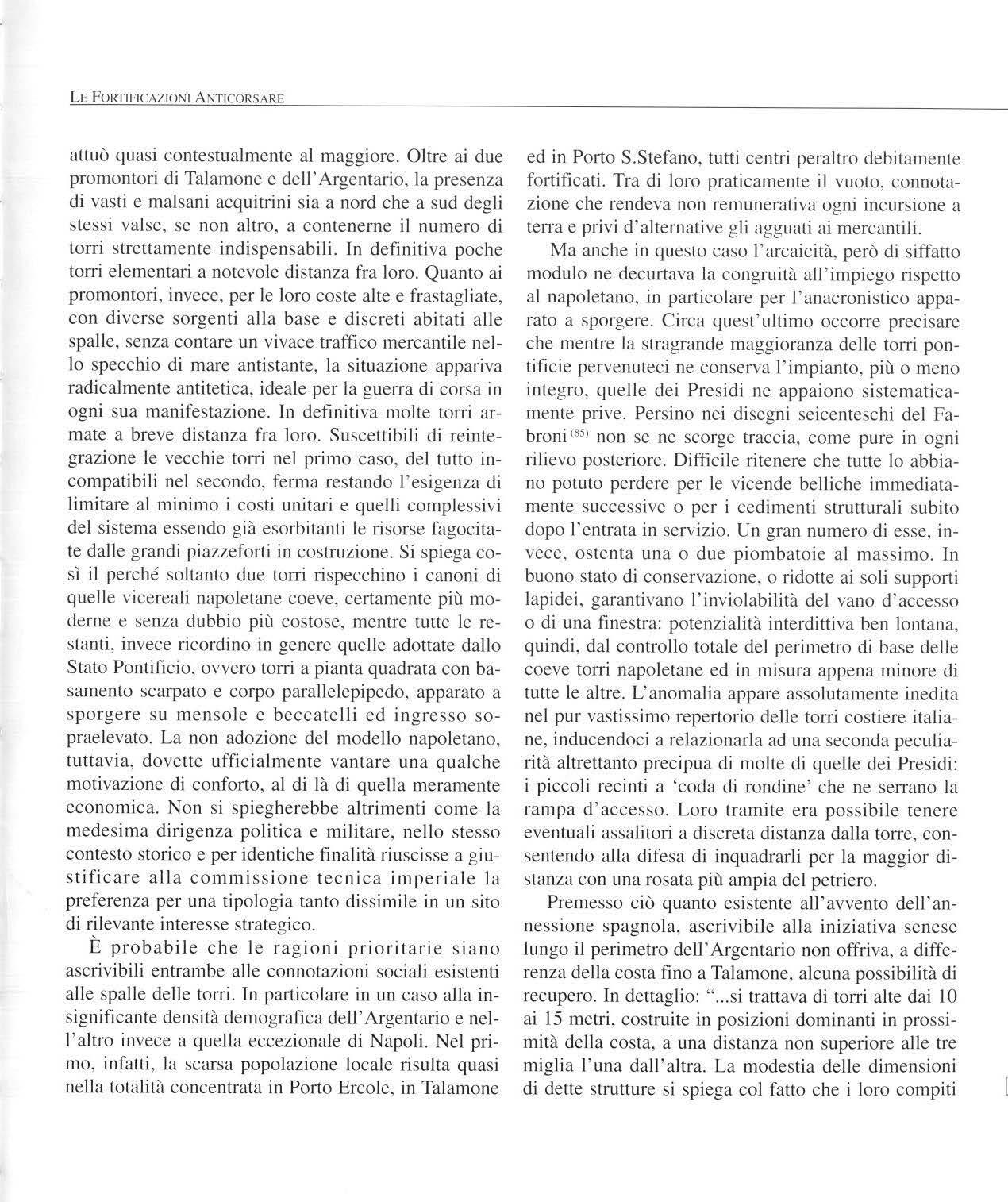
non era no stre tt amente difen s ivi, ben s ì legati s oprattutto aJJ' avvistament o e a ll a seg n alazione " < 8 6 > Stando alle cronache correnti inlorno al 1569, il viceré di Nap o li don P arafan d e Rib era duca cl ' Alca là, compì una v is ita i s pettiva n e i Pres idi. Qui alla luc e d ei po siti vi ri s ultati del tcmegg iamento napoletano, conslatando l'inadeguat ezza d ell'e s istente ne .so ll ecitò un pronto adeguamento, come s i evince da un s ucc ess ivo rapporto del 28 aprile 1571, in cui tra l'altro s i precisava:
Cuordanse estas do s pla ças y do ze torres que es a la marina ...
Si presidian o queste due piazze e dodici torri poste l ungo l a marina [pe rò] i capi tani non possono as solvere a quanto devono difendere dal momento che per ordine d el d etto duca di Aka là s i sono cos tru ite lun go le marine di quei Pres idi le tre torri sopra d ette e le altre che man ca no da fare ..."<~7 '
Di certo, quindi, due anni dopo la vis ita v ice reale almeno tre nuove toITi risultavano opera ti ve ed a ltre, di numero imprecisato, in costruzione , m e ntre ben 12 dipendenti da Orb e te llo difendevano l a cos ta fin o a Talamon e. A rendere p e rò l a ques tion e più complicata inte rvengono altri docum e nti dai quali è faci le ev inc ere che già anterio rment e al '69 altre torri risultavano ultimate: il che sembrerebbe confe1mare la sosta n z ial e contemporaneilà fra l 'avv io de l torreggi am e nto de i Presidi e quello d e l re g no di N apo Li nel 1563. D e l res to ad un 'analog a conclusione induc e pur e un a mi ss iva d e l 25 marzo d e l 1564 in viata al Segreta1i o del Con sig li o di Stato, n e ll a quale s i m e n z ion ano alcune torri in avanzata fase di approntamento < 88 l S e mpre in quell o s t esso anno, in un a ltro documento d e l I' 11 se ttembre s i fa iiferimento a tre torri g ià in funz ione ed altre pro ss ime ad esser l o <891 • O vv io concludere che allo scadere del '64 almeno sei nuove toITi costiere fossero in ser vizio.
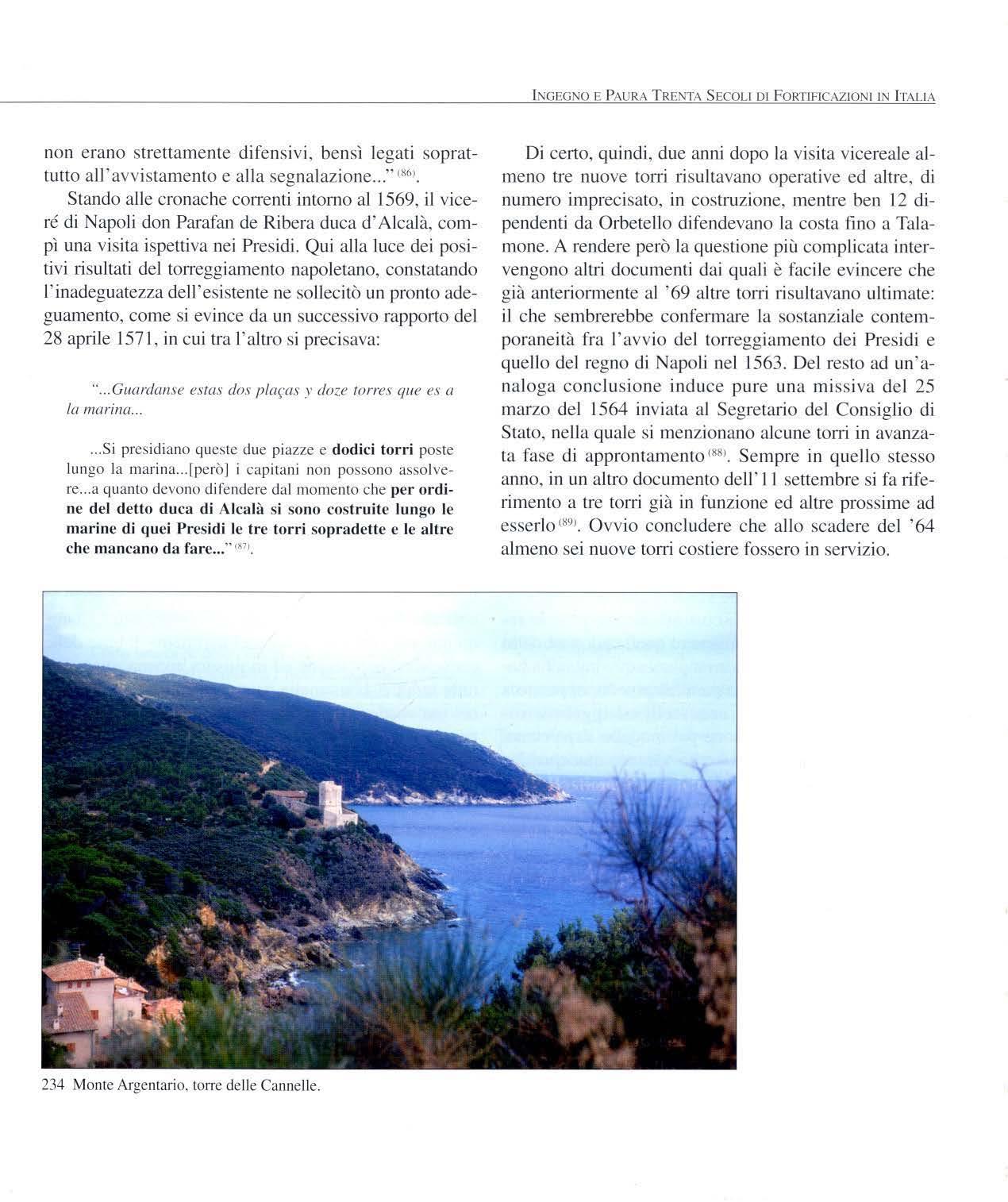 234 Monte Argentario. lOJTe dell e Cannelle.
IKGF.GNO E PAURA TRE:-rlì \ S ECOLI DI FORTIFI CAZIONI JN [ TALIA
234 Monte Argentario. lOJTe dell e Cannelle.
IKGF.GNO E PAURA TRE:-rlì \ S ECOLI DI FORTIFI CAZIONI JN [ TALIA
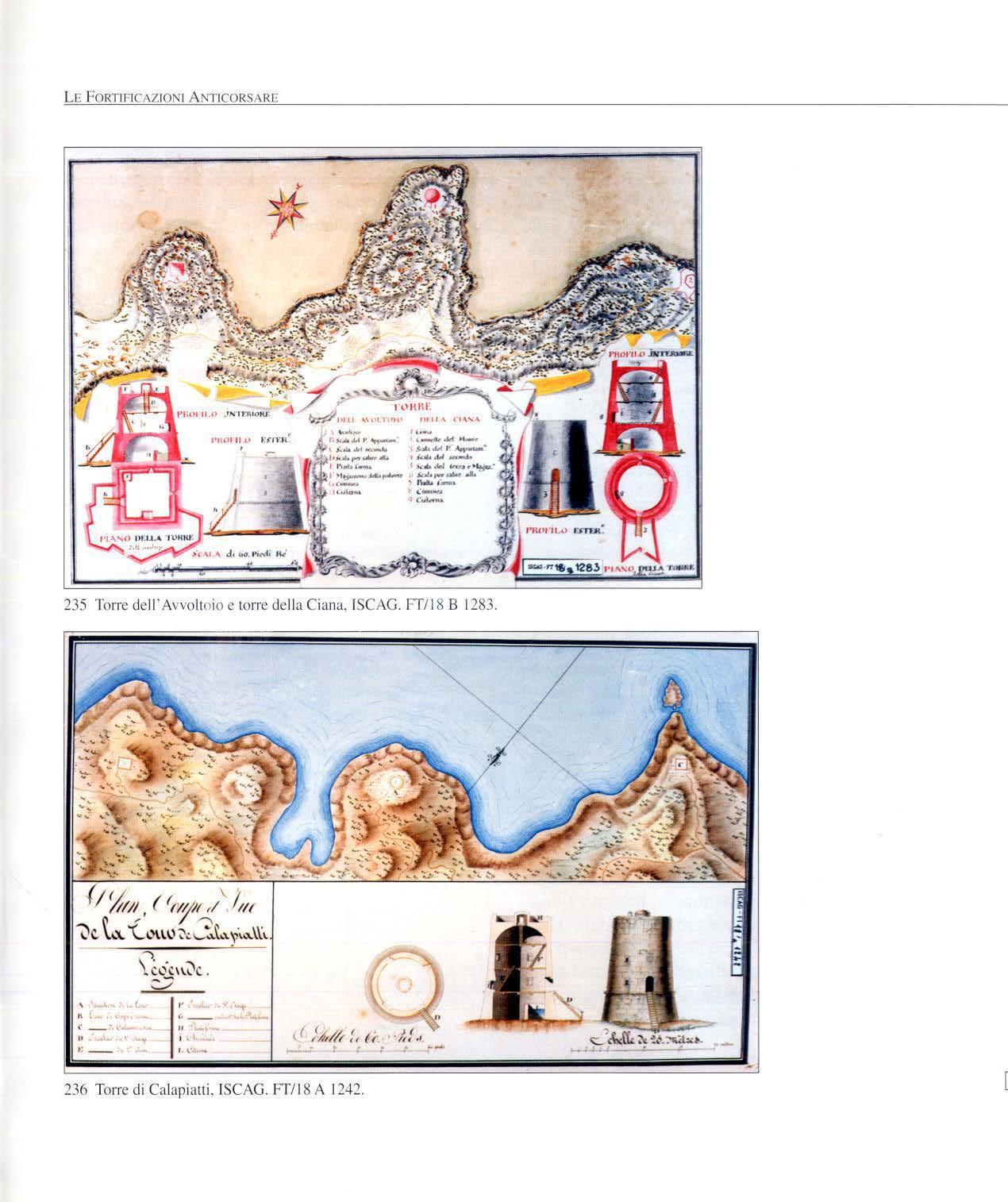
To rn a nd o a ll a cro n ologia de ll 'ap prontamento d elle torri, ap p are estremame nte probabile che da l 1569 si pro vv ide so ltanto a raccordarl e s tJ·ettame nte t ra di loro, ma ga ri in se re ndone d i ulteriori per eliminare da ll a ca tena l e ultime cesure, onde conseguire la co ntinuità, pres upp osto operativo di s iffatti di spos iti v i. Difficile comu nqu e stab ilire quante ne ven nero effettivamente cos truit e in quell 'a rco di tempo, di s icuro oltre un a doz zi n a a cui s i aggiunsero tutte Je altre in qualche modo recuperate o iiqualificate e d aggiornate, per un totale oscillante intorno alla trentina. In una re l az io ne de l 16 13 si rinlraccia in propo s ito c he :
· in questo luogo è Sfata fabb ri ca l a la prima torre e ben guardata per si cure-;.za de' naviganti e 1 altri, come a/Ire quattordic i le quali circondano ques10 Monte. già ricetto di Turchi e ladroni , et oggi così fallo sicuro
26011obre 1613" 1<JO •
L a singo lare la conicità de ll e fon ti ci rca 1'e ntità e la di s locazion e delle torri può esse re in var io modo interpretata. Inn anz it utto essendo poco numero se e di re lativamente facil e e rapi da cost ru zione, a lm eno ris petto aJl e fortez ze, non obbl i gavano a lunghe e minuz iose contabilità no nc hé a fre qu enti is pezio ni. Seco nd a riamenle l ' int era vic enda edi fi cat oria fu contraddi st int a da un a notevole approssimazione e s up erfi cialit à, fors e imputabile al particolare co nte sto politico, c h e te mend o di alienar s i g li appoggi medicei finì pe r adottarne acriticamente progettisti e tecnici, non se mpre di s p er im e ntata cap ac it à.
Con seq ue nz iale , pe rt a nt o, c h e qu an do s i avv iò fin a lm e nte un a più sc rupolos a inda gin e va lutati va affidandola al co nte Gabiio Serbe11oni (9 ll, in geg nere nùlita re di ri sa put a competenza e progettista della Città L eo nina di Roma ne l 1560, nonché figura di spicco ne lla conquista di Sie na e brillante combattente a Lepanto , le co nclu sio ni furono tutt 'al tro c he p os iti ve . R e du ce da un rec e nti ss imo sopra llu ogo ad a lcune fortific azio ni cos ti e re sic ili a ne, per l a precis ione compiuto nell 'es tate de l 15 72 '92l, e perfettamente aggiornato per i s uoi fre qu e nti s postamenti co n la flotta , s ul tor-
lNGl:GNO E PAURA TRENTA SECOLI DI fORTIFICAZIONl IN ITALIAreggiam e nto napo letano, non può asso luta mente ritenersi incompetente od app e na inform ato in m erito. L a sua relazio ne ass urge, pertanto, ad ineq ui vocabile perizia. Eccone allora la im pi etosa conc lu sione sulle torri g i à costru ite od in corso di approntamento dello Stato dei Pres idi :
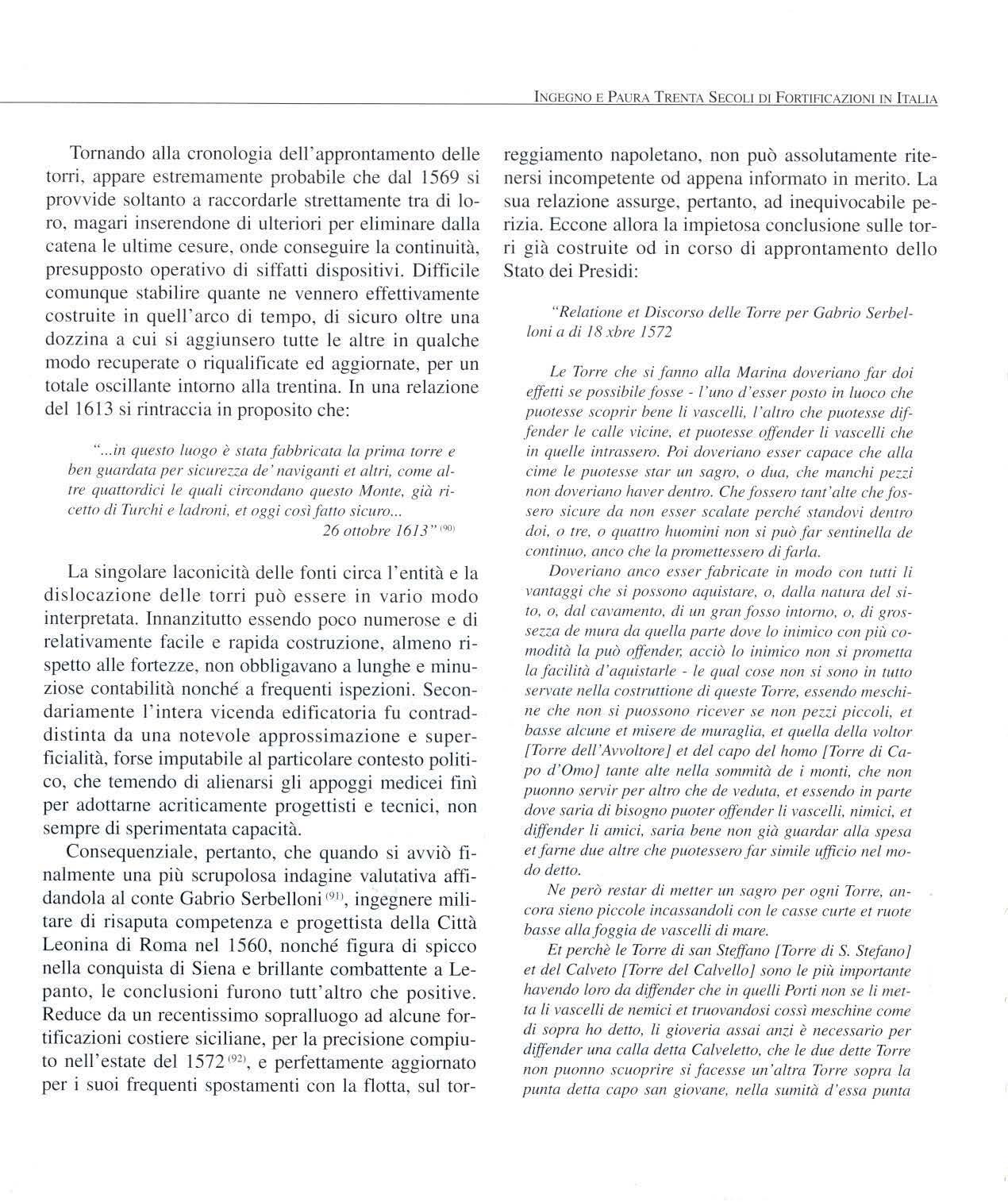
" Relatione et Discorso delle Torre per Gabrio Serbe/Ioni a di 18 xb re 1572
Le Torre c he si fanno alla Marina doveriano far doi effet 1i se possibile .fosse · l'uno d'esser pos10 in fuo co che puotesse scop rir bene li vascelli, /"al11v che puoresse d{f· fender le calle vicine. et puo1esse u.ffender li vascelli c he in quelle inrra ssero. Poi doveriano esse r capace c he alla cime l e puotesse sfar un sag ro. o dua , che man chi pe::.::.i non doveriano haver dentro. Che fossero tallt 'alte che fossero sicure da 11011 esser scalare perch é standovi de111ro dai, o tre, o qua11ro ltuomini non si puà far sentinella de colllinuo. anco eh.e la promettessero di farla.
Doveriano anco esser fabricate i11 modo con rutti li vantaggi c h e si possono aquistare. o, dalla nalllra del si10 , o dal cai•wnento di un gran fosso i1110rno, o. di grossezza de mura da qu e lla parte dove lo inimico con più comodità la può offender; acciò lo inimico non si pro111e1ta la facilità d'aquistarle - le qual cose non si so110 in ttl!to serva,e nella cos trutt ione d i q ueste Torre , essendo rneschine che non s i puossono ricever se non pez::.i piccoli, et basse a l cune et misere de muraglia, e 1 quella della voltor {Torre de/l'Avvo ltorej et d el capo del homo [Torre di Capo d'Omo} tante alte nella. somrnità de i monti, che non puonn o servi r per a ltro che de vedu 1a, et essendo in parte dove sa ria di bisogno puoter offende r li vascelli. nimici. et diffender li amici, sa ria bene non già g uarda r alla spesa e1fa rn e due altre c h e puotesse,vfar simile ufficio nel modo detto.
Ne però restar di metter un sagro per ogni Torre, anco ra sieno p iccole incassandoli con le casse cune et ruote basse alla fogg ia de vascelli di mare.
E, perchè le To rre di san Stejfano [Torre di S. Stefano] et del Calveto [Torre del Ca/vello} sono le più importante havendo lo,v da diffender che i11 quelli Porti 11011 se li metta li vascelli de nemici e t truovandosi coss ì meschine come di sopra ho detto, li gioveria assai an zi è necessario pe r diffender una calla detra Ca/veletta. che le due dette Torre non puonno scuopri re si facesse un 'altra Torre sopra la punta derra capo san giovane, nella sum ità d'essa punta
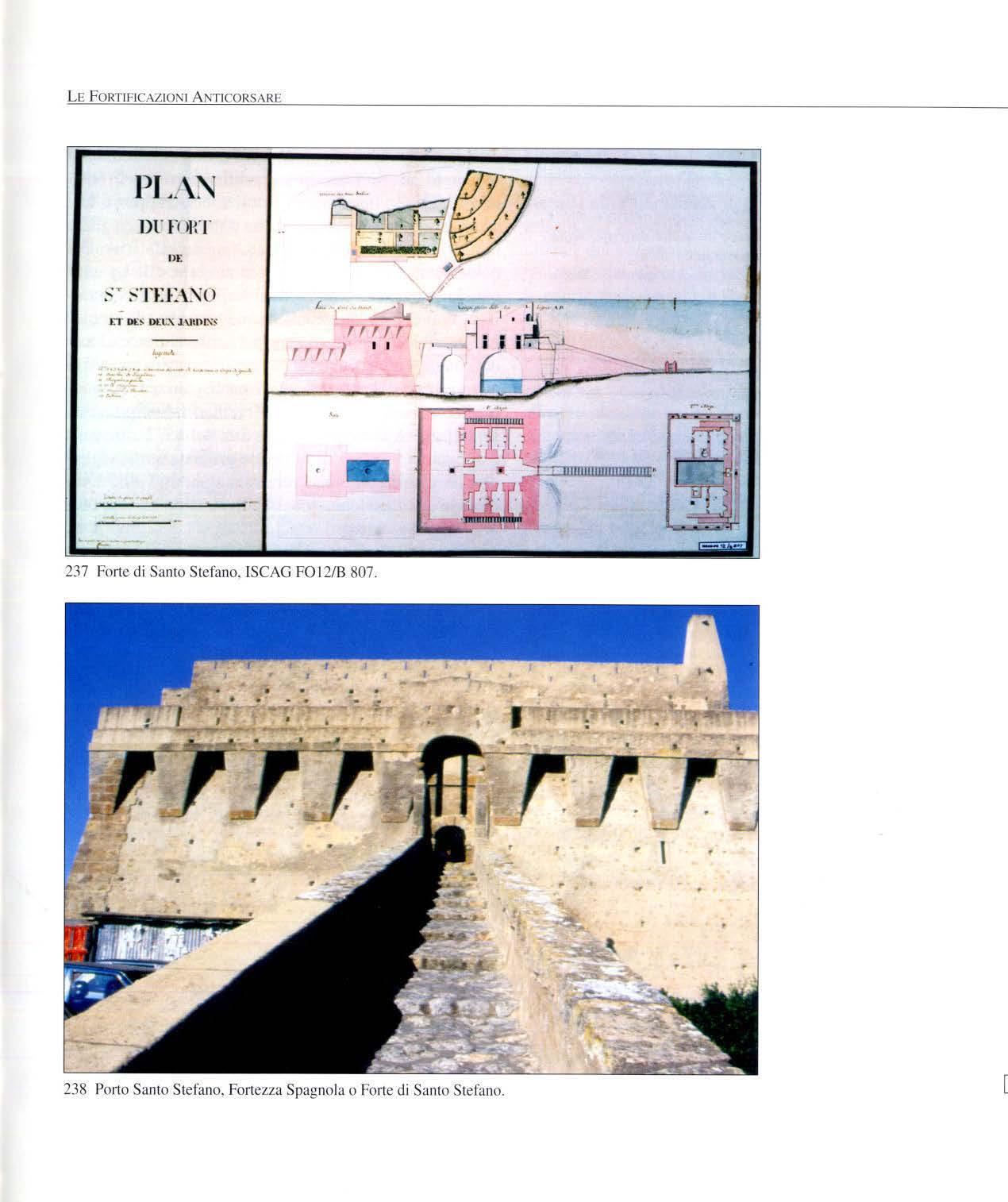
qual scoprirà delta calle, et aiutarà la Torre di san Ste.ffa110 à dijfender la rnUa 111aggiore defla san giornne, et fosse fatrn nella 11wniera et qualità che di sopra ho detto.
Si doi·eria finire t111te le Torre de suoi servir) a quelle che 11011 le hano complite, cioe de{{e sue cisterne, scale, pone. et parapetti alti à bastanza nella cima.
Le sumi là de monti che sono Ficine al porto san Stej]à110 sono nella 111aniem che tanti giuditiosi hano de110, che 11011 se li può arcomodar cossa sicura, chi 11011 volesse estendersi dalla ci111a de monti venendo al basso verso detto porto. e! saria una longura de circa 300 canne, dove intrarebhe due gran cortine e, Tre Baluurdi, per pane, ocrnpando una larghe::.::.a. nella sumità de cento. e più canne. quale essendo cossa di /anta spesa à conslruerla, e/ maggior à tenerla pressidiata, mi par cosa di non raggionam e, ne pensarci, e ,amo pilÌ esse 11do tllfta quella parte scoglio pe/(1/0 Non apmvo mw1co si faccia le Tre Torre, dove ha sig nato il Bagiolo con + perchè in quelli fuochi 11011 p110111w giovare alla Marina, ne sono sicure da se, che bisogneria per assicurarle, fame altre alle cime de mo111i superiori che li sop ra s1an110.
Et se hene queste tal Torre 11011 sariano suffi.cien te a resister a una armow potente che 11011 godesse de quelli porti, e però 1anto e/ servitio che si11 hor ha11no fatto et che fanno sendo siate causa sin hora seco11di 111i è detto di safrar la libenà a picì de mille huomini. per el qual benefitio non s i e/oreria restar di fame più presw due più rhe 1111a 111eno essendo di ra1110 benefitio" 193
Dall e critiche del Serbelloni si ricava che molte torri g ià costru ite non ri s ultavano affatto idonee né per ubicazione, né per s truttura , né per dimensioni, ai co mpiti precipui. In capaci di interdire le ca le sottostanti o perché troppo alte o perché troppo s triminzite per contenere congrue ar ti g li erie od ancora perché troppo fragili per so pp ortarne le solleci t az ioni, la se nsaz ione che g li ingen e rarono fu di palese in affi dabilità. P e r s ino in prossim i tà di Porto S. Stefano la torre erettavi g li si confermò di totale in adeguatezza difen s iva, tanto da indurl o a prospe ttarn e una seconda adiacen te . ma di ben altra cons i stenza, indispensabile per neutrali zzare la per icolo sa deficienza. Attua lm e nte Porto Santo Stefano è sovrastato da un a gra ndio sa torre , ri batt ezza ta per le s ue dimensioni 'Fortezza Spag nol a', per cui è assurdo identificare in questa qu e ll a
deprecata dal Serbelloni. De l re s to diversi documenti inducono ad ascrivere la sua edificazio ne tra il 1604 ed il 1622 <9.ii, lasciandoci in tal modo s upporre che propr io l ei sia la toITe auspicata dal celebre ingegnere nel 1572. Ed è allora estremame n te s ignificativo che quest' ultim a, di c ui il Serbelloni sos ti ene di aver indica to la corretta impo staz ione d ' impianto ed a rc hit ettonica , a pp ar te nga quand'anche maggiorata al l a tipologia vice real e napo letana, in particolare alla variante d efi nit a a doppia altezza e maggiorata abbasta n za frequente lungo la cost ie ra amalfitana, non a caso geomorfologicamente simile all'A rge nta ri o. Sempre da l la s u a re l azione si cog li e c he a ll a fine del 15 72 altre torri era no ancora in fase di se mplice progettazione, vigendo al riguardo a lqu anta incertezza persino s ul punto esat t o di edificazione
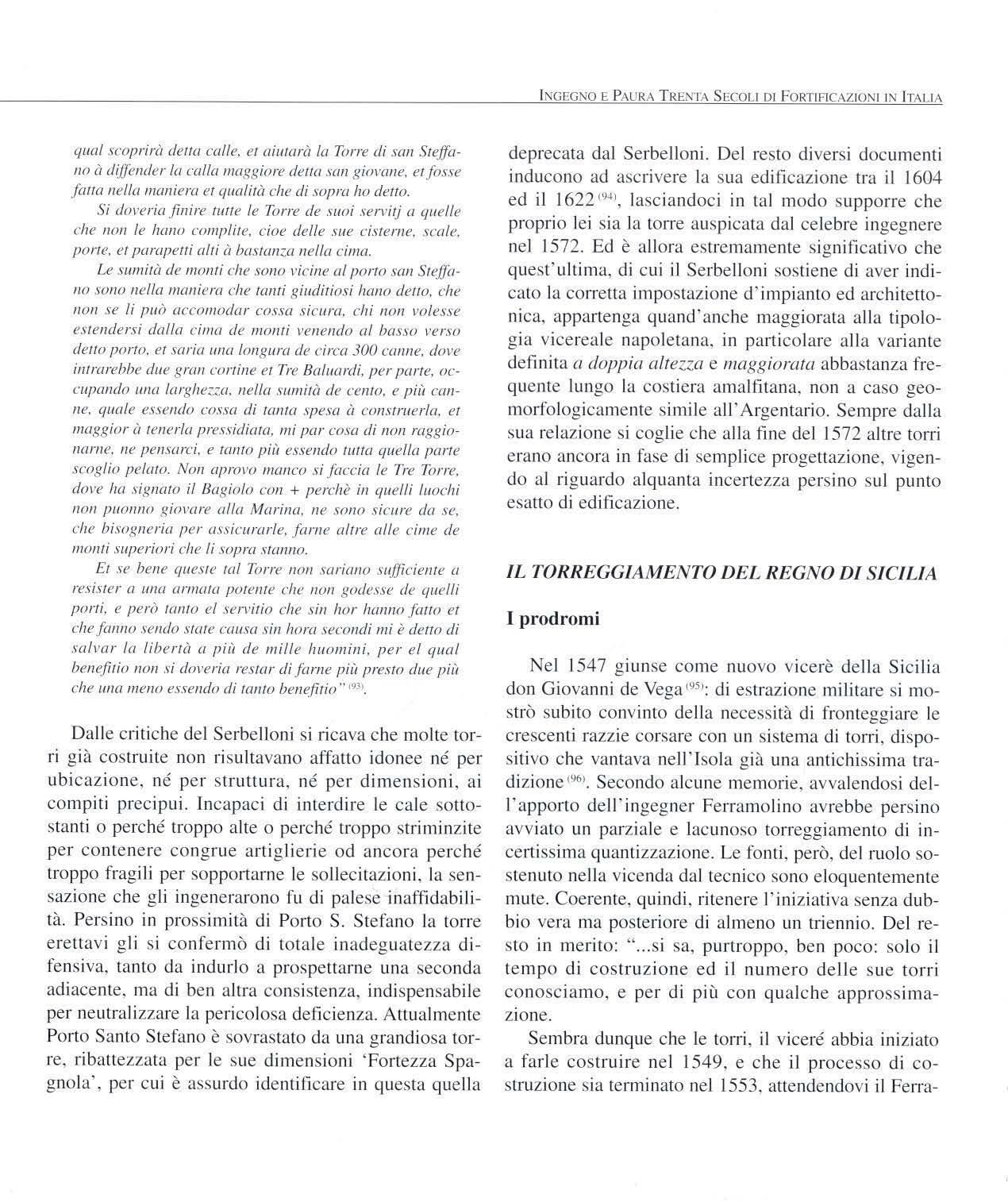
Nel 1547 g iun se come nuovo vicerè della Sicilia don Gi ova nni de Vega 195 ): cli es tra z io ne militare s i m ostrò s ubit o convi nto della neces sità di fronteggiare le crescen Li razzie co rsare con un s i ste ma di ton-i, dispositivo c he va nt ava nell ' I sola g i à un a antichiss im a tradizione <%)_Secondo alc un e memorie , avva le nd osi del1'appo r to del l ' in geg ner Ferramolino avrebbe persino avv iato un parziale e l ac uno so torreggiamento di ince rti ssima quantizzaz io ne. Le fonti, però, del ruolo sos ten uto ne ll a vicenda dal tecni co so no e loq uenteme nt e mute . Coerente, quindi , ritenere l'ini z iati va se nz a dubbi o vera ma po ste ri o re d i a lm eno un triennio. De l res to in m er it o: " .. .si sa, purtroppo , be n poco: so lo il t e mpo di costruz i one e d il n umero delle s ue torri conosciamo, e per di più con qualche appro ss imazione
Sembra dunqu e che le torri, il viceré abbia ini z ia t o a farle cost ruir e n e l 1549 , e che il proc esso di costruzio ne sia term in ato nel 155 3, attendendovi il Ferra-
fNGEGNO E PAURA TRE/\ IA SECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIAmolino da Bergamo, Domenico Giunti, Pietro del Prado, Arduino Anclronico, celebrati architetti militari ...
Si s uole poi fissare a 37 il numero delle torri edificate, che è per la verità un numero assolutamente sproporzionato rispetto alle necessità difensive dell'isola, ed al conseguente impegno che ci consta essere stato profuso negli anni seg uenti, costruendo nuove torri destinate a completare il sistema di Vega , ufficialmente considerato carente" < 97 l _
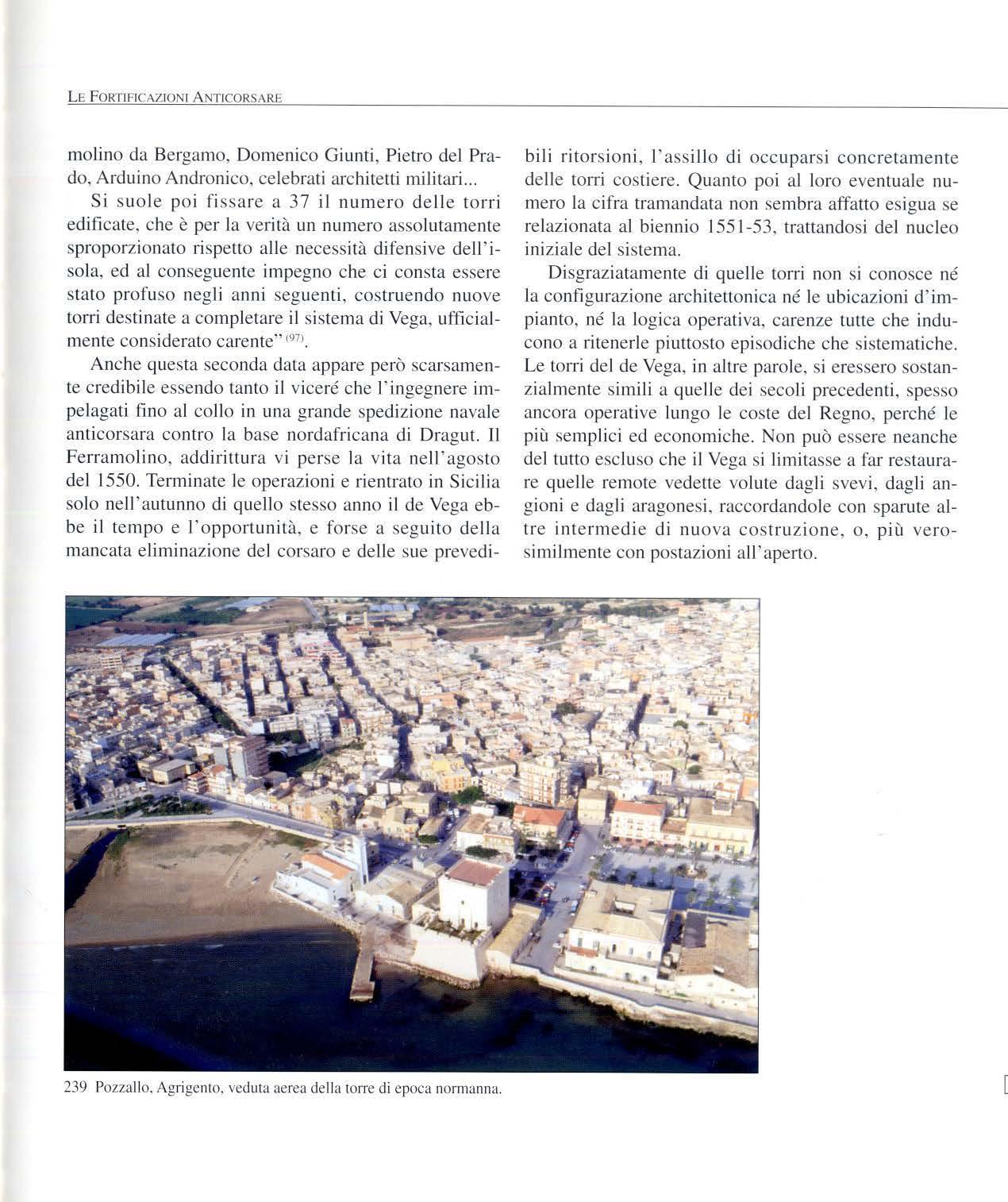
Anche questa seconda data appare però scarsamente credibile essendo tanto il viceré che l'ingegnere impelagati fino al collo in una grande s pedizione navale anticorsara contro la base nordafricana di Dragut. Il Ferramolino, addirittura vi perse la vita nell'agosto del 1550. Terminate le operazioni e rientrato in Sicilia solo nell'autunno di quello stesso anno il de Vega ebbe il tempo e l'opportunità, e forse a seguito della mancata eliminazione del corsaro e delle s ue prevedi-
bili ritorsioni, l'assillo cli occuparsi concretamente delle toJTi costiere. Quanto poi al loro eventuale numero la cifra tramandata non se mbra affatto esigua se relazionata al biennio J551-53, trattandosi del nucleo iniziale ciel sistema.
Disgraziatamente di quelle torri non si conosce né la configurazione architettonica né le ubicazioni d ' impianto , né la logica operativa, carenze tutte che inducono a ritenerle piuttosto episodiche che sistematiche. Le torri del de Vega, in altre parole, si eressero sostanzialmente sim ili a quelle dei secoli precedenti, spesso ancora operative lungo le coste del Regno , perché le più semplici ed economiche. Non può essere neanche del tutto escluso che il Vega s i limitasse a far restaurare quelle remote vedette volute dagli svevi, dagli angioni e dag l i aragonesi, raccordandole con sparute altre intermedie di nuova costruzione, o, più verosimilmente con postazioni a li' ape110.
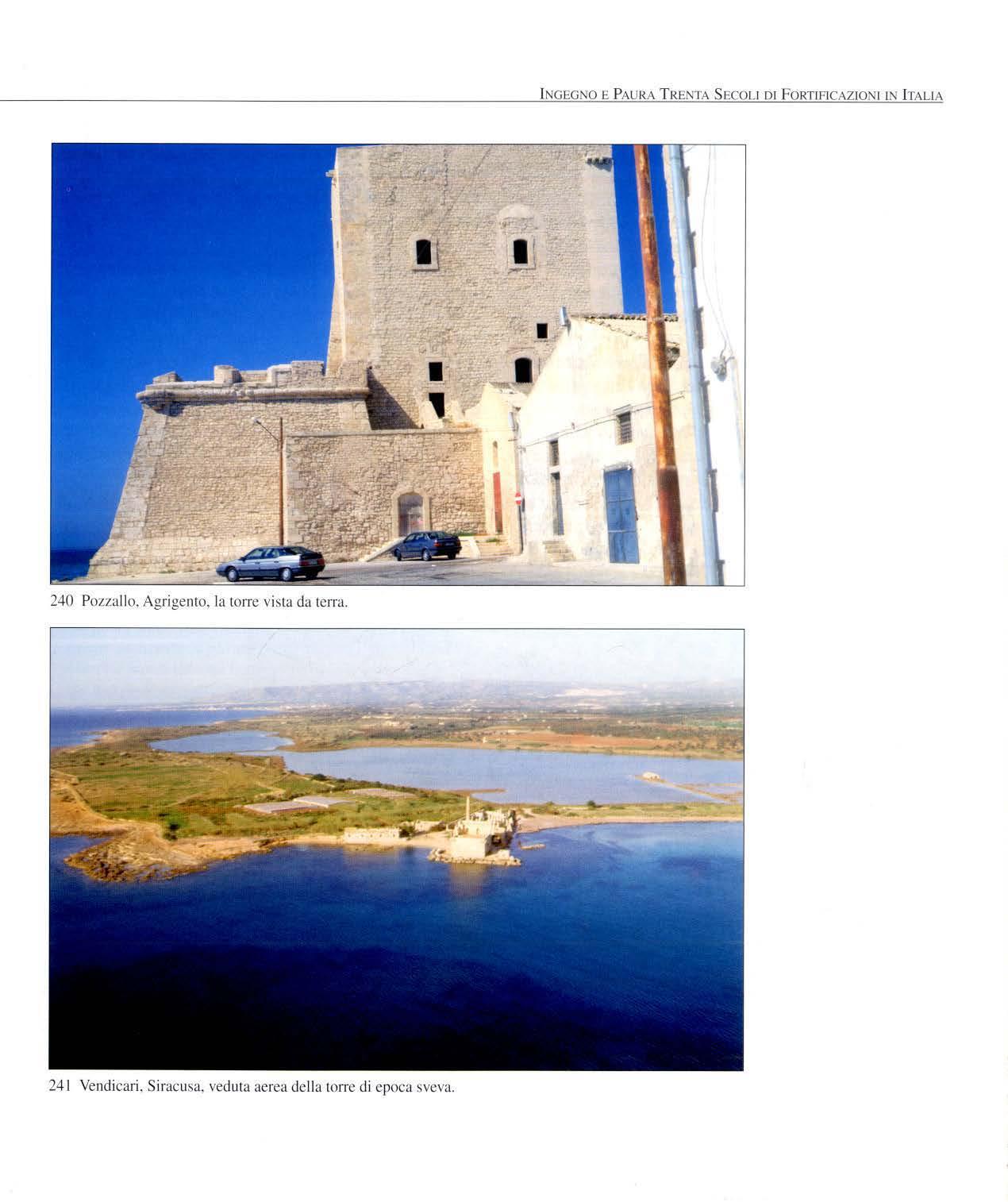
Si s pi eg h ere bb e in tal modo l'assenza di un qual si as i progetto o relaz ion e tecnica, in un contes to di iperattivit à fortificatoria s upportata da innumerevoli relazio ni , grafici e rilievi. Non mancavano certamente gli ingegneri n é la preparazio ne s pecifica p er poterlo fare , eppure s tranamente un'imp resa tanto rilevante non ha la sciato alcuna traccia, pers ino indiretta, nei cosp ic ui fondi d ' archivio , al co ntrari o di qu an to invece accadrà a partire dal 1579.
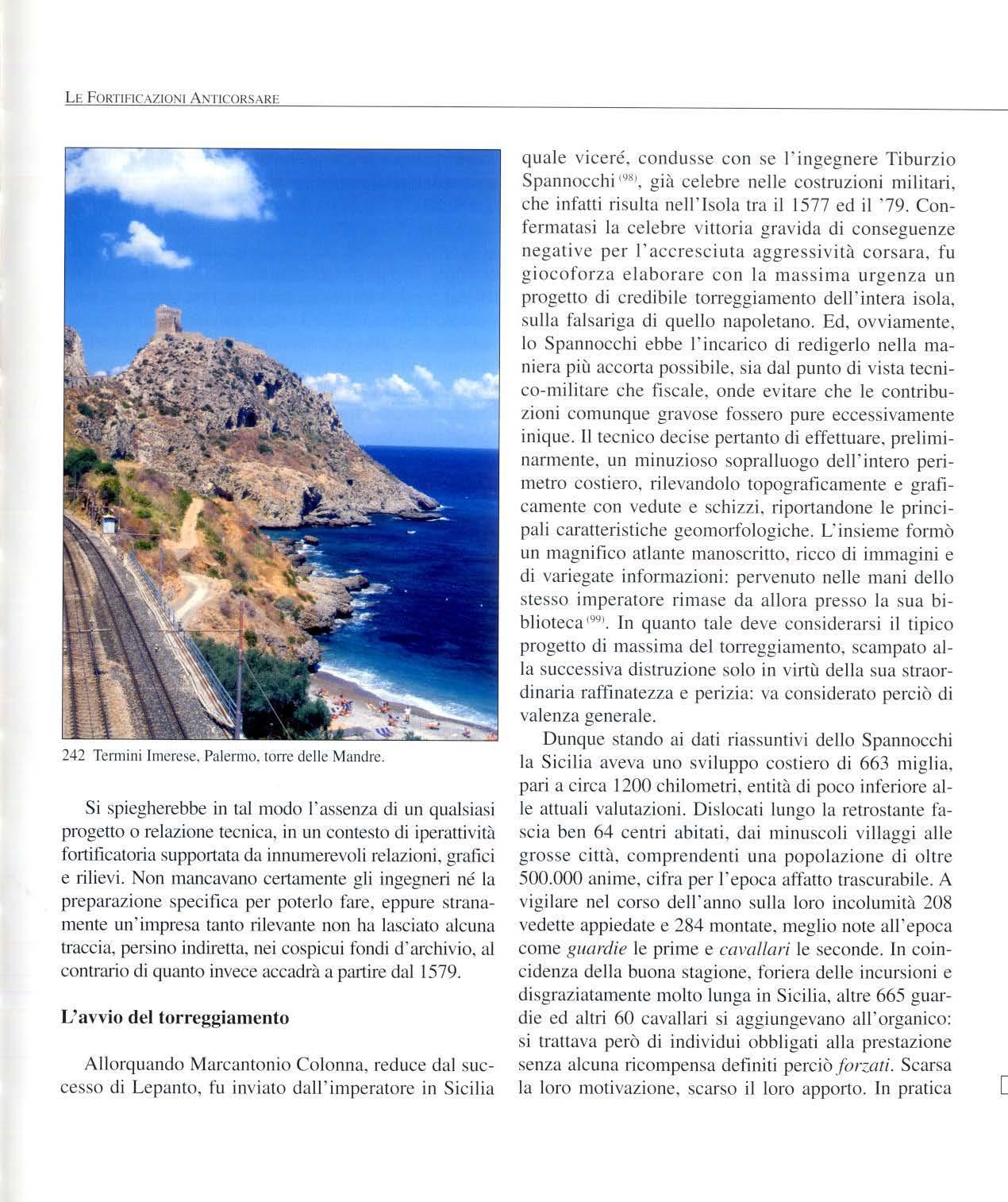
Allorqu a ndo Marcanto nio Colonna, redu ce dal s u ccesso di L epa nto , fu inv iato dall'imperatore in Sicilia
quale viceré, condusse con se l'ingegnere Tiburzio Spannocchi 198 ), già celebre nelle costruzion i militari , che infatti risulta ne ll ' Iso la tra il 1577 ed il '79. Confermatasi la celebre vitto ri a gravida di conseguenze negative per l'accresciu t a aggressività corsara, fu g i ocoforza elabora r e con la massima urgen za un progetto di cred ibil e torreggiamento dell ' intera isola, s ulla fa lsa r iga di quello napoletano. Ed, o vv iamente, lo Spannocchi ebbe l'incarico di redigerlo ne ll a mani era più accorta pos s ibile, s ia dal pun to di vista tecnico-rnililare che fiscale, onde evitare che le contribuzio ni co munqu e gravose fossero pure eccessivamente inique. lJ tecnico decise pertanto di effettuare, preliminarmente , un minuzioso soprall u ogo dell 'i ntero perimetro cos ti ero, 1ilevandolo topograficamente e graficame nt e con vedute e schizzi, riportandone le principali caratteristic h e geo morfologiche. L'i n s ieme formò un magn ifi co at l ante manoscritto, ricco di immagini e di vari egat e in formazio ni: pervenuto nelle mani dello s tesso imperatore rima se da allora presso la s ua biblioteca '99 l In quanto tale de ve considerarsi il tipico proge tto di m assima del torregg iamento, scam pato alla s u ccessiva di stru z ion e solo in virtù della sua straordinaria raffinatezza e p erizia: va co n s id erato perciò di va lenza ge n erale.
Dunqu e sta ndo ai dati ria ss unti vi dello Spannocchi la Sicilia aveva uno s viluppo costiero di 663 mi g li a, pari a circa 1200 c hilomet1i , e ntità di poco inferi ore alle attuali va lut az io1ù. Dis lo cat i lun go la retrostante fasc ia ben 64 ce ntri abitati , dai mi nu scoli villaggi a ll e grosse città , co mpr e nd enti un a popola z ione di o ltre 500.000 anim e, cifra per l 'e poca affa tto trascurabile. A v igilare ne l corso d e ll ' anno s ulla loro in co lunùt à 208 vedette appiedate e 2 84 montate, meglio note ali ' epoca come guardie l e piime e cavallari le seco nd e. In coi ncidenza della buon a s tag io ne, foriera d elle in c ur s ion i e disgraziatamente m o lt o lun ga in Sicilia. altre 665 g uardi e ed alt1i 60 cavallari si aggiungevano all ' organico: s i trattava però di individui obbligat i alla pre staz ione se nza alcuna iico mp e n sa definiti perciò forzat i. Scarsa la l oro motivazione , sca rso il l oro apporto. In pratica
quasi un uomo per chilomet ro, dato che di per sé è già una eloquente testimonianza del dramma.
Ne l corso de l periplo Spannocchi rilevò come operative, indip endentement e dalla tipologia e vetustà, ben 62 toni: si trattava però di struttu re arcaiche residu e di tut te l e precedenti dominazioni. In ogni caso ingoiavano per l e loro di sc utibili prestazioni 1.200 ducati, ragion per cu i l' importo globa le a nnu o della vigilanza cost iera attiva e pas s iva ascendeva ad oltre 15.000 duc a ti , e ntità colossale pari a l costo di circa 40 nuo ve torri di media dimen s ione! Per un torreggiamento credibile della Sicilia, però , secondo lo stesso tecnico ne sarebbero occorse a lm eno il triplo c h e, quand 'a nch e de lla tipologia più eco nomi ca, avrebbero i mphcat o uno sta n z ia m e nt o di preventivo pari a 13.300 ducati 0 00l Ma un a cifra del gene re mai fu realmente di spo nibile in bilancio e so lo dopo oltre un secolo di di atri be , inframmezzate da lutt uose conseg ue nze, f-u s tentata m e nte attinta nell'ambito di un sia pur mod esto tOTreggiamento. Ma chi ne fu a quel punto l'autor e?
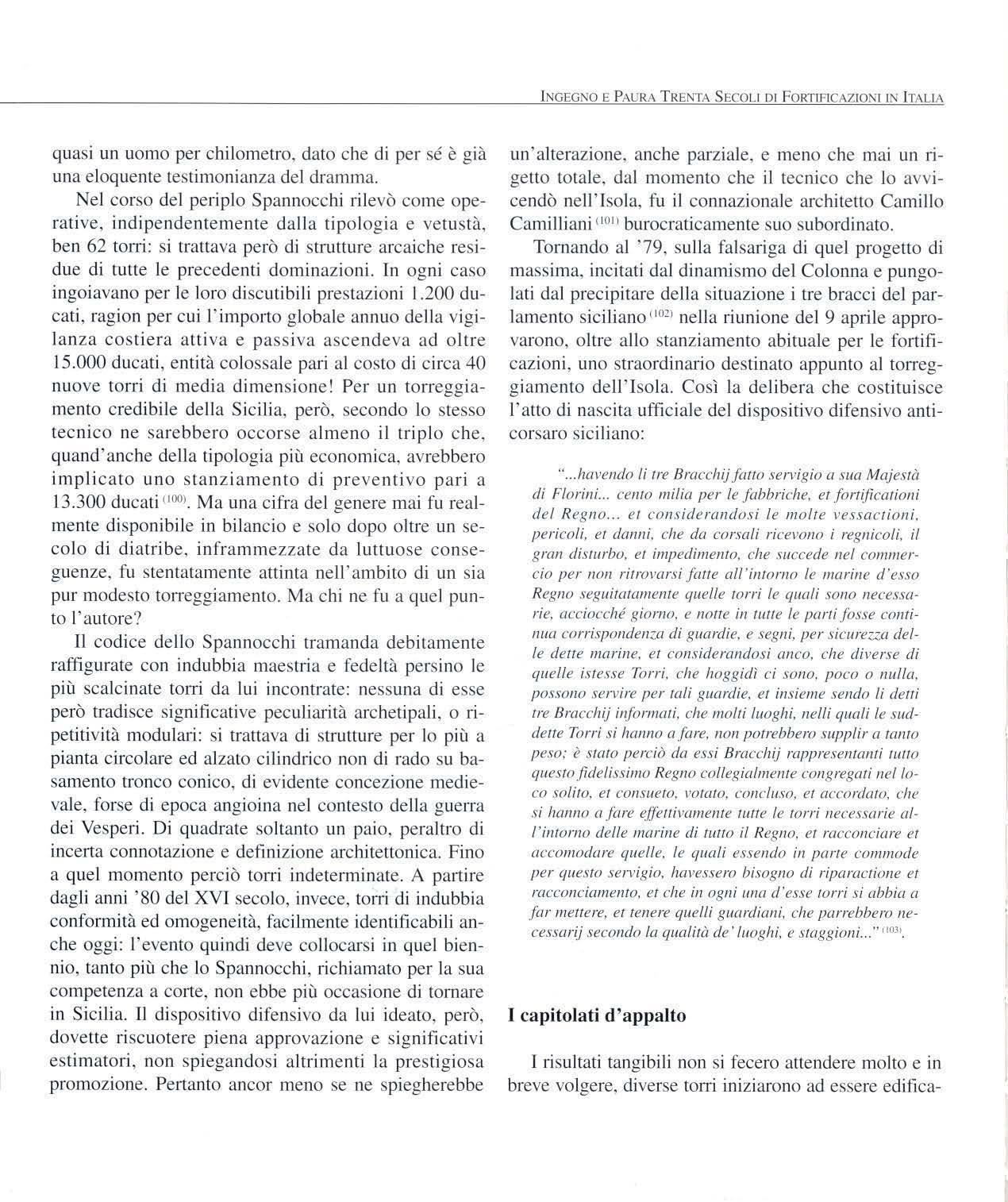
Il codice dello Spannocchi tramanda debitamente raffigurate con indubbia maestria e fede lt à persino le p i ù scalc inat e toni da lui in co nt rate: ne ss una di esse però tradisce sig nifi ca ti ve peculiarità archetip ali, o ripetitività modulari: si trattava di str utture per lo più a pianta circolare ed alzato cilindrico non di rado su basamento tronco co ni co, di evidente concezione medieva le , forse di epoca angio in a nel co ntesto della g ue rr a dei Ves p eri. Di quadra te so ltant o un paio, peraltro di incerta conno taz ion e e definizione architettonica. Fino a quel mom e nto perciò torri ind ete rmin ate A partire dagli anni '80 d e l XVI seco lo, in vece, torri di indubbi a conformità ed omogeneità, facilmente identifica bili a nche oggi: l'evento quindi deve collocars i in quel biennio , ta nto più che lo Sp annocchi , 1ichiamato per la s ua competenza a co rte, no n ebbe più occasione di tornare in Sicilia. Il dispositivo difensivo da lui ide ato, però, do ve tte ri sc uotere piena approvazione e sig nifi ca ti v i es t i m a tori , non sp iega nd os i a ltrim enti la prestigiosa promozione. Pertanto ancor meno se ne spiegh e rebbe
un 'a lterazione, anche parziale. e meno che mai un iigetto totale, dal momento che il tecnico che lo avvicendò ne ll ' rsola, fu il connazionale architetto Camillo Camilliarù ( IOI ) burocraticamente s uo s ubordinato.
Tornando al '79, s ull a fa lsariga di quel progetto di massima, incitati dal dinamismo del Colonna e pun golati dal precipitare della situazione i tre bracci del parlamento siciliano e 102i nella riuni o ne del 9 aprile approvarono, olt re a11o s tanziamento abituale per le fort ificaz io ni , un o s traordinario destinato appunto al torreggiamento dell'Isola. Così la delibera che costituisce l'atto di nasc ita ufficiale del di spos itivo difensivo an tico r saro s ic ilian o:
" havendo li tre Bracclzij fotto servigio a sua Majestà di Fiorini cento milia per le fabbriche, et fort((ìca1ioni del Regno ... e, considerandosi le molte vessactioni. pericoli. e, danlli. che da corsa/i ricevono i regnicoli, il gran dis111rbo. et i111pedi111ento, che succede nel com111ercio per 11011 ritrovarsi fatte all'intorno le marine d'esso Regno seguitatamente quelle 1orri le quali sono necessarie, acciocché giomo. e notte in tutte le parti fosse continua corrispondenza di iuardie. e segni, per sicurez;:,a delle dette marine, et considerandosi anco, che diverse di quelle istesse Torri. che hoggidì ci so n o. poco o nulla, possono servire per tali guardie et insieme se11do li detti tre Bracchi) infor111a1i. che molti luoghi. ne/li quali le suddette Torri si hanno a.fare 11011 potrebbero supplir a tanto peso; è s taro perciò da ess i Bracchi) rappresentanti llllfo questo fidel issi1110 R egno col/egialme111e con gregati nel loco solito, e 1 con suero. votato. co11cluso, et accordato che si hanno a fare ejf'effivwnente tutte le torri necessarie all'i11rorno delle marine di tutto il R egno e , racconciare et accomodare quelle. le quali essendo in parte commod e per questo servigio. havessero bisogno di riparactione et raccollciwnento, et c h e in ogni una d'esse 10 rri si abbia a far mettere, et tenere quell i guard iani, che parrebbero necessarij secondo la qualità de· luoghi, e staggioni " , io3 ,_
I ri s ultat i ta ngi bili no n s i fecero at te ndere molto e in breve volgere. diverse toni ini z ia rono ad essere edifica-
IN GEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTTF!CAZIOKl lN l TAL!AI cap it olati d 'a ppalto
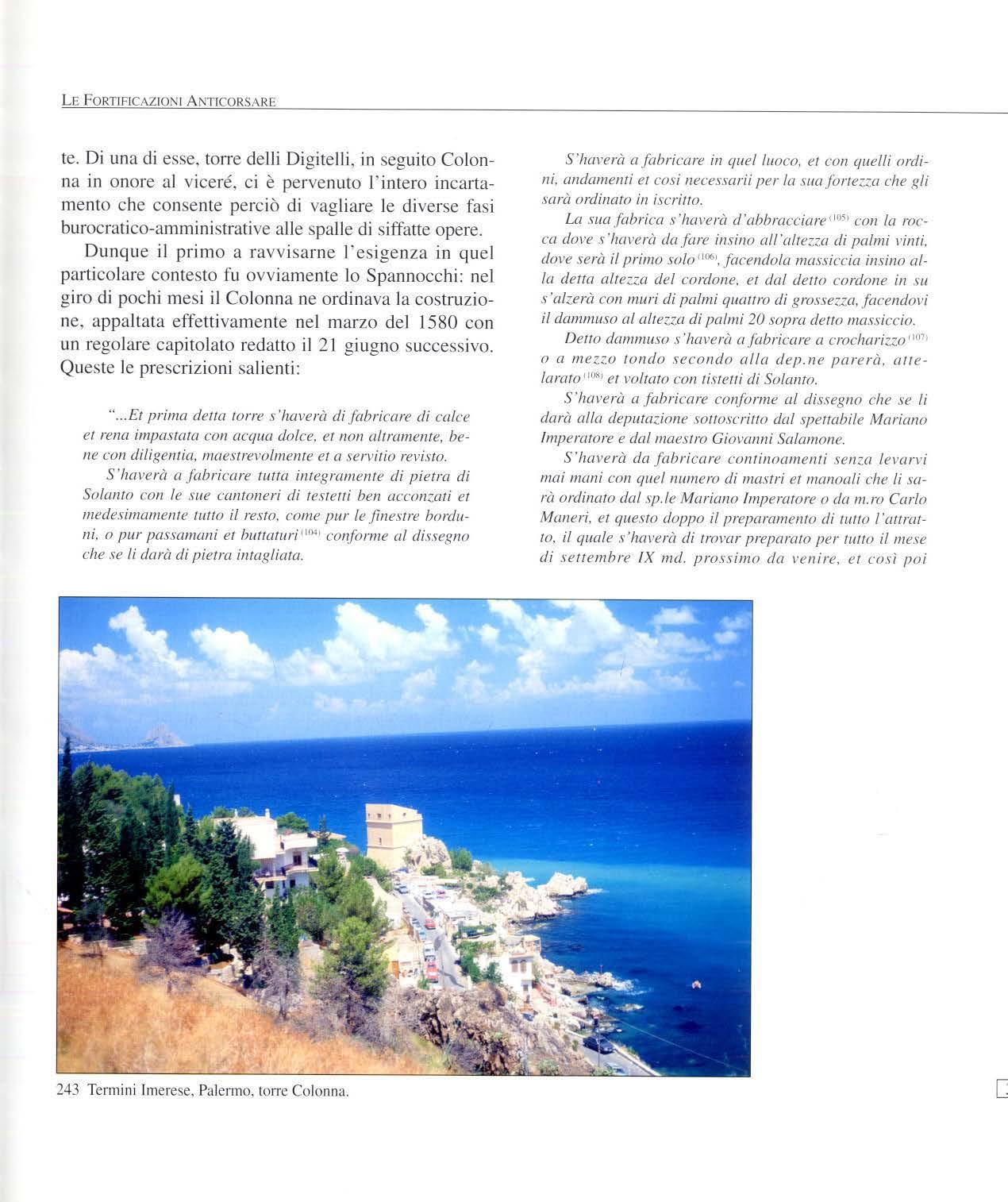
te. Di una di esse, torre delli Digitelli, in seguito Colonna in onore al viceré, ci è pervenuto l'intero incartamento che consente perciò di vagl iare le diverse fasi burocratico-amministrative alle s palle di siffa tte opere.
Dunque il primo a ravvisarne J" esigenza in quel particolare contesto fu ovviamente lo Spannocchi: nel giro di pochi mesi il Colonna ne ordinava la costruzione , appaltata effettivamente nel marzo del 1580 con un regolare capitolato redatto i I 21 giugno s ucce ss ivo. Que ste le prescrizioni sa lienti:
· Et prima detta t0rre s '/zaverà di fabricare di calce et rena impastma con acqua dolce, et non altramente, bene con diligentia. 111aestrevol111ente e t a servii il> revisto.
S 'haverà a fabr icare tutta integramente di pietra di S0la11to con le sue cantoneri di testerri ben accon::.ati et medesimamente tutto il resto. come pur le finestre borduni. o pur passama n i et buttaturi "o.,' conforme al dissegno che se li darà di pietra intagliata.
S'haverà a .fabricare in quel fuoco. et con quelli ordini. andamenti et cosi necessari i per la sua forte-;:,::,a che gli sarà ordinato in iscritto
La sua .fabrica s'hm•erà d'abbracciare 'w;, con la rocca dove s '//averà da fare insino ali 'a/te-:,::.a di palmi 1•inti. dove serà il primo solo "°"', facendola massiccia insi110 alla detta altez::.a del cordone. et dal detto cordone in su s'alzerà con muri di palmi quauro di grossezza, facendm·i il dammuso al altezza di palmi 20 sopra detto massiccio. Deno dammuso s '/wverà a fabricare a crochari z zo ,u,, o a me z zo wndo secondo alla dep.ne parerà, a11elaraco '' "x , er voltato con listelli di Solanto.
S'haverà a fabricare conjèJ1me al dissegno che se li darà alla deputazione souoscritto dal spettabile Mariano Imperatore e dal maestro Giovanni Sala111one.
S'haverà da fabricare co11ti11oa111enti sen::.a leFan i mai mani con quel numero di mastri et manoali che li sarà ordinato dal sp.le Mariano Imp eratore o da m.,v Carlo Ma11eri e/ questo doppo il preparamento di tutto /'attratto. il quale s'haverà di trovar prepara/O per tutto il mese di settembre I X md prossimo da l'enire, et così poi
243 Termi ni 'lm erese. Pale1mo, torre Colonna.conseguen/emenle l'haFerà di dar spedila et perfetionata per IUIIO il mese di aprile di detto anno IX in pross. da \'enire. et lui/o ques/0 11011 li mancando il danaro per occasione de/a deputatione o qualche a/Ira provenienti da essa e/ 11011 dal staglianti
Li nwramrni s'haveranno a mensurare lo vacante per lo pieno, fan/o del da111 muso d'onde incomincia la volta per fini sopra la groppa. quan10 del/i fi11is1ri e / twti altri aperturi, et detra fahrica s 'haverà a mensurare al modo ord in ario cioè dui palmi di grosse-;.-:.a e! canna una di quatro si come è consueto in Palemw < 11 M
El per delta torre esserfa1w conforme al dovere et per securtà della dep ne haverà di dar piaggeria della somma del danaro come la fabrica per qualtro ann i poi che sarà fini la di 1u110 punto.
Et per ques10 se li da lo swglio a onz.e 1.9 la canna a rutti spesi del s1aglian1e, in wnto che né per calce. né per pielra, né per legnami per li forni. né per nessun 'altra cosa passi conseguir a//ro che lo prezzo accorda/O.
Se li haveranno di pagare antecipati om,e {***] per preparare li clflralfi, e/ dopo se li somministrerà il denaro di mano in mano secondo il necessario.
S'haFerà d'imbiancare dalla parte di fuori di ri::,z,o, e/ dalla pane di demro di liscio a una mano, el così il e/ammuso.
S'haverà d'imhattumare. o pure ammadonare, o pure restare in piano ben conditionato al prima entrata, et sopra il dammuso si ammadona doppiamenle, cioè il primo con calcina et l'altro con tuffo , et se ci haveranno a fare le sue huttacqui d'intaglio.
Lafabrica se li haverà a mensurare tanti volle quan1i al!a dep.ne parerà, e1 secondo che ella ordinerà.
Se li farà dare la comodità di far calcare, legni morti, et pietre con pagare lo stagliante il gius/o prezza.
Se li farnnno teiere favorahili soliti farsi per li mastri del/i ponti.
La piaggeria da prestarsi potrà essere data per diversi pleggi. ciascuno per la rata che prometterà. et succede1 1do che morisse alrnn de pleggi haverà a dar piaggeria di nuovo per la rata di quel pleggio che sarà morto, et saranno obbligati presentare alla dep.nefede ogni anno della vita di detti plegii.
Mastro Giuseppe Ciacalone offerse per il de 11 0 s faglio del!a torre del/i Digitelli con.forme alla presinserta capitulatione a ragion di on-;.e 1 et tarì novi la canna.
La quale offerta pos/ll alla candela <1 mi et preconi-:.ata al solito, nè comparendo altri che facessero miglior i conditione et offerta estillla la cande la, fu liberato il detto staglio al deuo Ciaca!one a detta ragione di on-:.e una
e/ tarì novi la canna come 11!1i1110 licitatene et qfferenti conforme alla sude11a capitulatione et <4fer/a ad extillfu111 candele" 111 11 •
Nel documento s i fa incidentalmente riferim e nto ad un di seg no della erigenda torre da ri spe ttare: l a modalità e la marginalità della precisazione sembrano suggerire che si trattasse piuttos to della copia di un prototipo generico che del progetto specifico. Del res to l' incaricato del controllo dei lavori non è ricordato né come ingegnere né come architetto: plau s ibile perciò la s upposi z ione che la connotazione architettonica del manufatto fosse già perfettame nte nota , riportandone i g rafici so lo le precipue dimen s ioni , varia bili caso per caso. Dando per sco ntata la pianta quadrata la sce lt a se mbra infatti poters i re s tringere a sole tre config ura z ioni , matrici di altrettante tipologie: torre perfettamente parallelepipeda, parallelepipeda s u base tronco piramidale, tutta tronco piramidale. Scartata la prima, fin troppo fragile ed indifendibile , le possibilità r es tav ano due corrispondenti nella fattispecie o alla torre pontificia o a quella napoletana. Il regno di Sicilia appartenendo alla stessa compagine imperiale di quello di Napoli, avrebbe razionalmente dovuto optare per l a seconda, peraltro perfettamente nota sia allo Spannocchi che al Colonna per precedenti incarichi militari ne l napo letano. Ma ev idente mente qualco sa di quelle ottime e modernissime torri non dovette convincerli. L' ipotes i meno improbabile deve ancora una volta individuar s i nella loro finalizzazione primaria alla protezio ne del cabotaggoio e subordinatamente a quella del territorio , esigenza che nell' Isola non ebbe mai unarilevanza tale da g iustificarne il maggior costo. La Sicilia, infatti, non vantava un identico cabotaggio né quello che avveniva rivestiva valenza strategica. Disponeva certamente di alquanti porti caricatori dai quali però non si originava alcun circuito mercantile.
Per contro vaste aree coltivate a ridos so della costa andavano protette attivamente, magari accogliendo nelle stesse torri i contadini sorpresi da un ' incursione. E di tale pres tazione accessoria, espressamente vietata

alle torri napoletane, si trova piena conferma negli ordini di servizio delle torri sic iliane come pure in quelli delle torri pontificie. Situazione complessiva, quindi, sostanzialmente s imile alla vigente nella campagna romana dove lo stesso Colonna aveva eretto un paio di torri per assicurare i coloni del s uo feudo.
Alla luce di quanto appena delineato e magari da ulteriori motivazioni a noi o rm ai purtroppo ignote , non de sta eccessive meravig li e che la sce lta cadde sulla tipologia pontificia, di cui il Colonna quale capo delle forze armate papaline ed il s uo ingegnere militare , erano per ovvi motivi perfettamente edotti. La torre dei Digitelli quindi fu eretta secondo quei canoni, sanzionandone l 'adoz ione per il torreggiamento siciliano. In meno di un anno la torre di discrete dimen s ioni fu ultimata e, con la medesima solerzia, già nel luglio del 1581 le s i destinava una guarnigione di tre uomini.

Quas i certamente dopo il richiamo dello Spannocchi a Madrid per più alti incarichi onde evitare che il suo progetto, peraltro di massima, subisse deleteri arresti , s i individuò in un altro tecnico fiorentino, l 'a rchitetto, Camillo Camilliani un valido successore. Forse fu lo stesso Spannocchi a suggerirlo, non spiegandosi altrimenti la coincidenza di un secondo toscano nell'Isola con le medesime incombenze profess ionali. Quanto al Camilliani, volendo assolvere responsabi lm ente al s uo incarico , mostrandosi magari non inferiore al predecessore te ntando così di em ul arne il successo, decise di riformulare l'intero dispositivo a com in c i are dalla ricognizione dei s i ti d'impianto delle erigende torri, redigendo un nuovo at lante di concezione sostanzialmente simile a quello dello Spannocchi < 11 2 ; P ertanto nell '83 nuova delibera del parlamento e nuovo periplo prodromico:
" .. . Con /'occasione de/a visita delle Torri & guardie mariti ime. che hor deve fa re il Capii ano Gio. Baltista Fre-
sco si mandi insieme con lui Camilla Camigliani con particolar cura di riconoscere insieme la circonferen:;e del Regno & descriverla in carra, specificando rune le Cale. &i luoghi dm·e siano le Torri & i Porri mari11i111i. & dm •e si disegnerà jàr a/ire Torri segue11do il principio dello dal Ca1,aglier Tiburrio " 11 u 1•
Circa le istruzioni impartite al Camilliani così la mi ssiva dello stesso Marcantonio Colonna:
"Tstuttritione al magnifico ingegniero
Camillo
CamiglianiConciosia che la deputa7,ione del reRIIO ha cura d'allfeporre er cmi l"appmbarione nostra ordinare. che all'intorno del regno si facciano quelle wrri che paia11 esser necessarie; et si ripa rin !'a/ire Rià fatte. le quali hahbian bisogno di racconcia111e11to: et inspe:;ie di prm·edere con l'istesso nos1ra approbatione che si pongano e tengano a fuochi opporumi quelle guardie che per sicure~;.a delle marine fa di mesriere renere con <.:0rrisponde11~a co111inova1a de segni di fumo er foco, er con la prunre;.;.a di bas1evole numero di cava/lari che a vicini fuochi velocemenle portino gli avisi di scuoperri vascelli nimici; et conciasiaché per la buona esseculione di questo servigio è necessario havere piena notizia della qualità et circ01!fere11w di tutti i liri marini; è staro ordinato che lo spettabile commessa rio generale delle suddette fabriche et Rllardie vada personalmente a rie<moscerli dove per mare et dove per rerra (comunque sia cli bisogno), per riportare piena infonnatione del tutto, co111probando egli con rel'ista sua a/ire rela1ioni a !empi addietro havute di queste materie. Et perché cosa molto difficile sarebbe ard pericolosa, farsi poi qua solamente sopra informationi di scriflura le dererminario11i che occorreranno, è s1a10 perciò appunwlo che fomzatamente si faccia far anco insiememenre disegno verace in prospet/iva di lulfa la sudeua circonferenza et liii; e/ voi per l'ingegno el sufficienza vostra siete stato eletto sopra ciò.
Anderete dunque in compagn ia del sudetto Sp. commessario generale riconoscendo di passo in passo rullo il sudetto lito, misurando per mare el per terra le distanze. et mettendo in disegno la cosmografia d'esso.
Usere1e particolare diligen:;a a misurare in ogni cala et fuoco atto a ricevere er occultare vascelli nemici, la grande:za d'essa et il fondo del mare. accioché si possi far giudicio del numero el della qualirà di tali vascelli che ci capiscano; et nel disegno scrivere/e anca il nome di ciascheduno d'essi luochi.
Rappresenterete con particolare distinzione quelle cale et grotte. le cui bocche con la comodità d'imminenti scogli o altrimenti convenga. et si possan chiudere.
Noterete etiandio i.fiumi et i fonti, che a liti et cale siano. et i nomi d'essi con distinta avverten::.a di quelli che porgan comodità di.fare acqua ai nemici.
Me11erete anco in disegno con aspe/IO della l'ista quelle cilfà. terre, castel/a. 1•il!e, casali e torri, che dal! 'e111i11en ::.e vicine al lito si sctwpron. notando i nomi di ciascheduna et riportando il sito con quella p,vportionata misura di distan:-,a che ricercare si possa
Singolare studio s'ha a.fare in descrivere il sito dol'e già sian fabricate, o dove convenga di nuovo fabricare torri di guardia notando le corrispondenze che così a/l 'intomo del lito, come addentro terra possan havere et dare di soliti segni, et la pianta de tali torri fatte
Non lascierete di specificar quei siti vicini a liti dove fuori de torri si tengcm poste di guardia da piè et de cavallo per esser punto sostanziale da sapersi.
Separntameme anco metlerere in disegno le citlà et
iKGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI D I FORTIFICAZIONIcaste/la principali mari time, levando la pia111a et alzato di prospettiva d'esse.
Formerete rutti questi disegni co11 awertenza er regola wle che quindi co111111odamenre si possa ridurli poi in quella maggior et menore f!.randezza che occorrerà ordinarli; et a n elerete mandandoci quelli delle sudef/e cilfà er cmre/la prencipa/i per nostra satisfat1io11e. presentando poi al vostro ritorno i consimili del tuffo insieme alla depurazione sotfoscritti di vostra mano, et separatamente anco quelle aFverten::.e di scrittura che vi pareranno degne di noti::.ia.
Per puoter riconoscere l'aspeffo di mare er far quelle indagini che di rerrajàre non si potranno, lo SP commessario generale farà provedere di vascelli dove sia bisogno er il medesimo havrà cura di procurar anco indiri::.zo et assisren::,a di persone pratiche di ciaschedun fuoco per aiuro, facilità er sicurezza del/'essecutione dell'alrre cose sudette. affinché l'opera riesca con la desiderara pefe1tio11e come importante eh 'ella è. et necessaria al servaggio d'lddio et di sua maestà et al beneficio unil'ersale del regno.
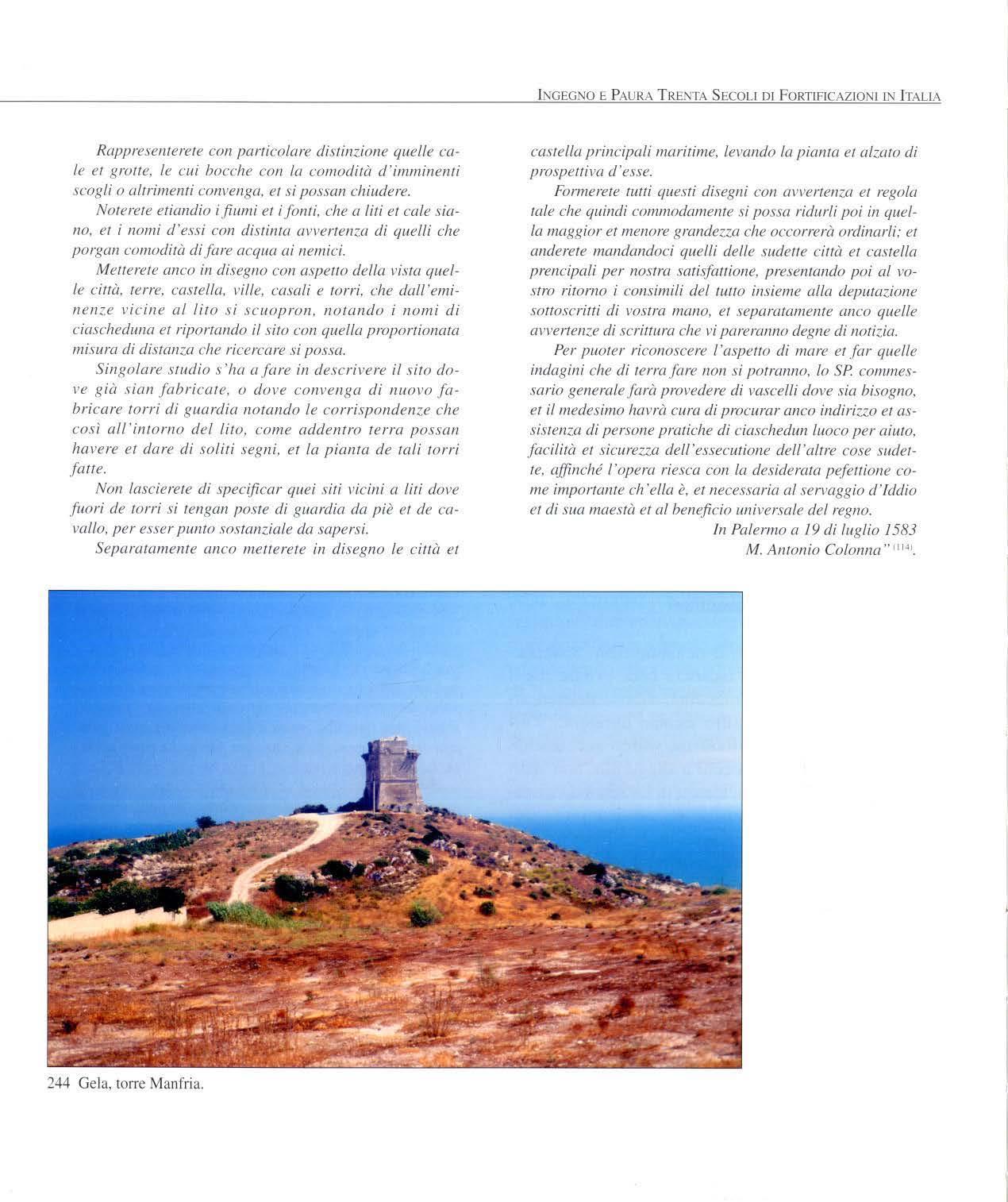
In Palermo a 19 di l11glio 1583
M. A111onio Colonna" 111 • 1 •
244 Gela, torre Man fr i a. IN lTALlAFu questo uno degli ultimi atti anuninistrativi del viceré don Marcantonio Colonna compiuti in Sicilia. Poche settimane dopo lo sostituì un nuovo viceré e mentre il suo successore iniziava a cimentarsi con le tragiche necessità dell'Isola, il Colonna si spegneva a Medina innescando con la sua improvvisa morte oscure clicerie /11 5> Il Camilliani, dal canto suo, intraprese la impellente ricognizione in quella stessa p 1imavera, procedendo con accuratezza e scrupolo ad espletare tutte le richieste formulategli, impegnandosi anche a reiterate successive ispezioni. 11 suo incarico infatti finì per divenire stabile e monotematico. Da qui forse la tradizione storiografica di attribuirgli per antonomasia tutte le torri costiere sici l iane, almeno quelle successive al 1580. Del resto la tesi non appare poi tanto peregrina, in quanto l'architetto restò nel suo incarico per i successivi 20 anni , concludendo con la sua motte avvenuta nel 1603 quella significativa esistenza dedicata
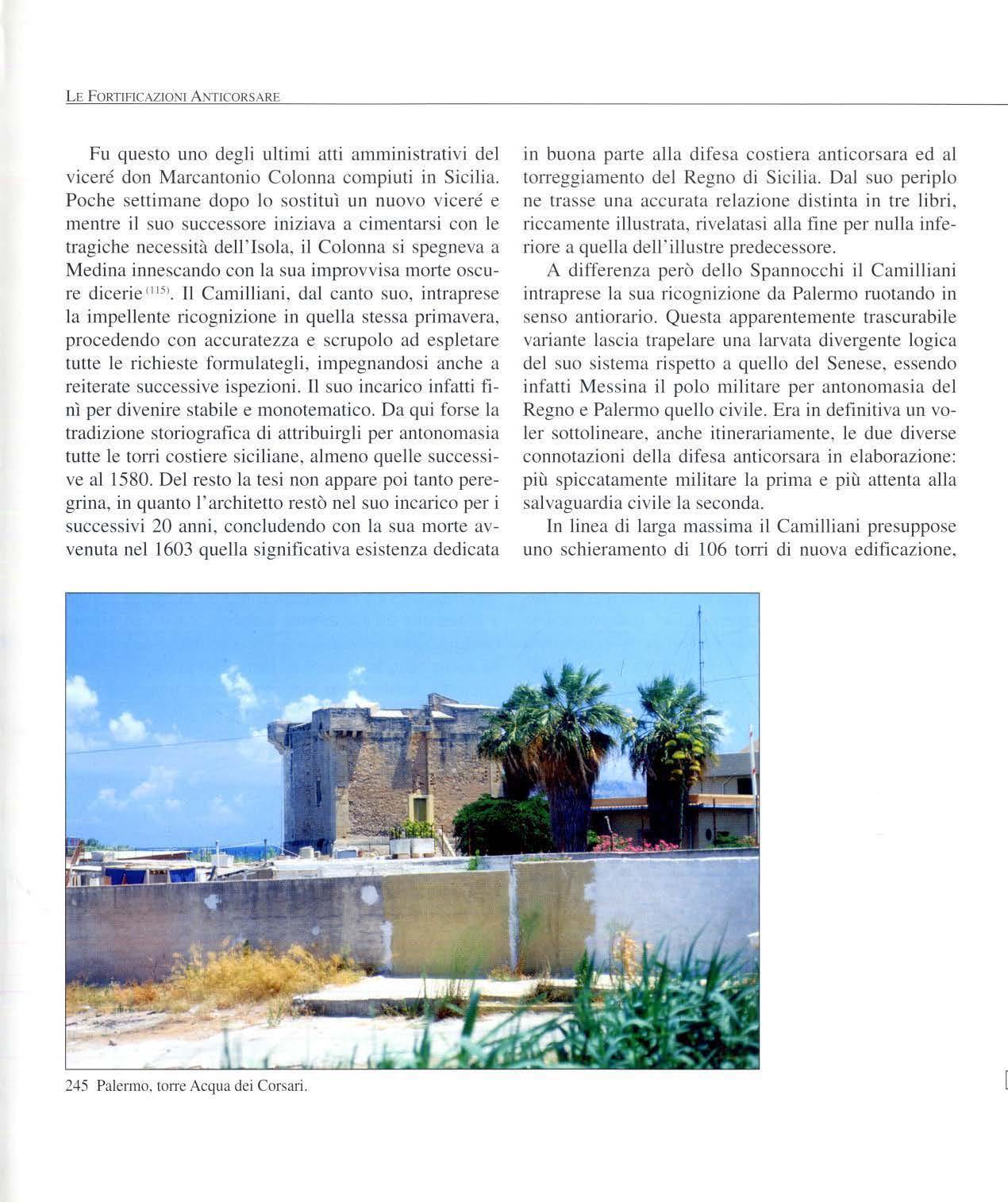
in buona parte alla difesa costiera anticorsara ed al toneggiamenlo del Regno di Sicilia. Dal suo periplo ne trasse una accurata relazione distinta in tre libri, riccamente ilJu s trata, rivelatasi alla fine per nu.lla inferiore a quella cieli' illustre predecessore.
A differenza però dello Spannocchi il Camilliani intraprese la sua ricognizione da Palermo ruotando in senso antiorario. Questa apparentemente trascurabile variante lascia trapelare una larvata divergente logica del suo sistema rispetto a quello del Senese, essendo infatti Me s sina il polo militare per antonomasia del Regno e Palem10 quello civile. Era in definitiva un voler sottolineare, anche itinerariamente , le due diverse connotazioni della difesa anticorsara in elaborazione: più spiccatamente militare la prima e più attenta alla salvaguardia civile la seconda.
In linea di larga massima il Carnilliani presuppose uno schjeramento di 106 toni di nuova edificazione,
quasi un a ve ntin a in meno di quelle ipotizzate da ll o Spannocchi. A queste si sarebbero dovute aggiungere le circa 40 già esistenti ritenute a suo gi udi zio integrabili nel sistema, anche q ueste inferiori di una ventina rispetto alle indicazioni dello Spannocchi. App li cando però a l progetto del senese i debiti correttivi le sue prescrizioni sembrano co in cidere sostanzia lmente con quelle del fiorentino, confem1andoci se non l ' interdip e nde nza dei du e progetti la o rm ai acquisita oggettività concettuale della d ifesa anticorsara.
costruzione di queste torri va fino al primo trentennio del ' 600. Poi. il fervore cos trutti vo di parte della deputazione cessò , ed il problema divenne essen z ialmente ge s tionale, pur non mancandosi s i sottoporre s pess o a revisione questi im portanti element i del s istema, fino alla sua fine , che si colloca nel primo ve ntenni.o del XIX secolo .. ." (1171 •
Completate l e sue osservazio ni , esposte le acc uratamente in un puntiglioso a tl ante s up erbamente illustrato, il Camilliani ri entrò a P alermo verso la metà del 1584. Esaurit a la fase teorica iniziava q ue ll a esecutiva: ma non divers amente da quanto verificatos i nel passato il processo di conc retizzazione si rilevò irto di diffico lt à . Pe r c ui : ' ... nessuna meraviglia . .. può provarsi se alla completa realizzazione del progetto camillaneo non s'arrivò mai, sebbe ne il parlamento non s i sia limitato allo s tanz iam ento del 1579, m a lo abbia se mpre periodicamente rinnovato , ed anzi aumenta to in seguenti sess ioni
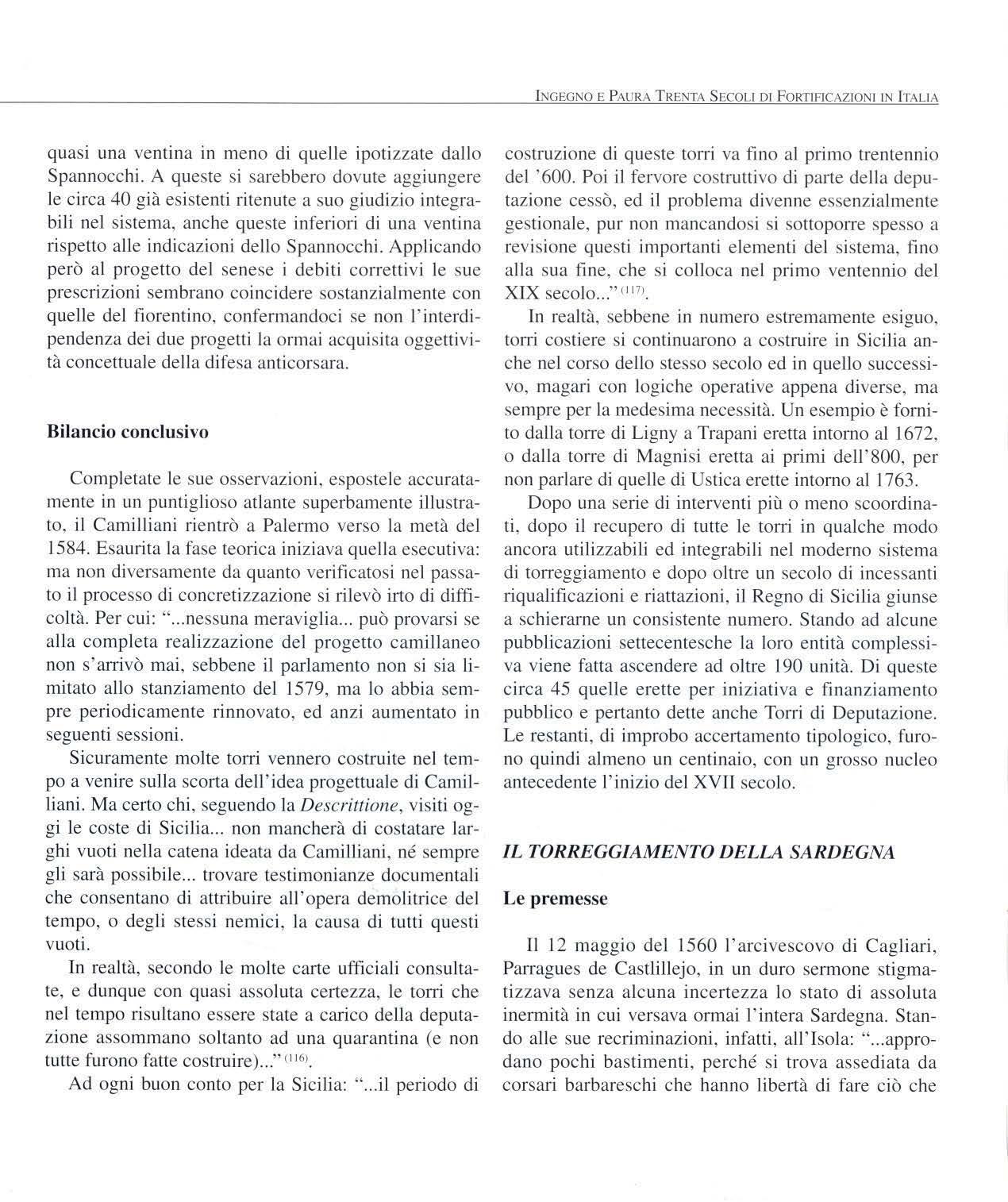
Si cura me nt e molte toni vennero costruite nel tempo a ve nire su ll a scorta de l! ' idea progettuale di Camilliani. M a cer to chi, seg ue ndo la D escrittione, visiti ogg i le cos te di Sicilia non mancherà di costatare larg hi vuoti nella catena ideata da Camilliani , né sempre gli sar à poss ibil e tro vare te stimonian ze documentali c he co ns entano di attribuir e a l l'opera d e molitri ce de l tempo, o degli stess i ne mici , l a causa di tutti que sti vuoti.
In realtà , seco ndo le molte carte uffi c ial i consultate, e dunqu e con quasi asso luta certezza, le torri che ne l tempo risultano essere state a caiico de ll a deputazione assommano soltanto ad una quarantina (e no n tutte furono fa tte costruire) ..." (116 > .
Ad ogni buon co nt o per l a Sicilia: " .. .il p eriodo d i
In realtà, sebbene in numero estremamente e s iguo, torri costiere s i continuarono a costruir e in S ic il ia anche nel co rso dello stes so secolo ed in quello s uccessivo, magari co n log iche operative appena diverse, ma se mpre per la medesima necessità. Un esempio è fornito dalla torre di Li gny a Trapani eretta intorno al 1672 , o dalla torre di M agnisi eretta ai primi dell ' 800, per no n parlare di quelle di Ustica erette intorno a l 1763.
D opo una serie di interventi più o meno scoo rd inati, dopo il recupero di tutte le torri in q ualche modo a ncora utilizzabili ed integrabili nel moderno sistema di toneggiamento e dopo oltre un secolo di incess anti riqualificazioni e riattazioni, il Regno di Sicilia gi un se a sc hi erarne un consistente numero . Stando ad alcune pubblicazioni settecentesc h e la loro entità complessiva viene fat ta ascendere ad oltre 190 unità. Di queste c irca 45 quelle erette per iniziat i va e fi n anziamento pubblico e pertanto dette anche To rri di Deputazione. Le restanti , di improb o accertamento tipologico, furono quindi a lmeno un centinaio, con un g ro s so nucl eo a nt ecedente l ' ini zio de l XVII seco l o.
Le premesse
Il 12 m agg i o del 1560 l 'arc i vescovo di Cagliari, Parrag ues de Castlillejo , in un duro se rmon e s ti gmatizzava senza alcuna incertezza l o s tat o di a s so lu ta inermit à in c ui ve rsava o rmai l' intera Sardegna. Stando alle s u e recriminazioni, infa tti , all' Iso la : " approdano pochi bastimenti, perché s i tro va assediata da co r sari barbareschi c he hann o libertà di fa re ciò c he
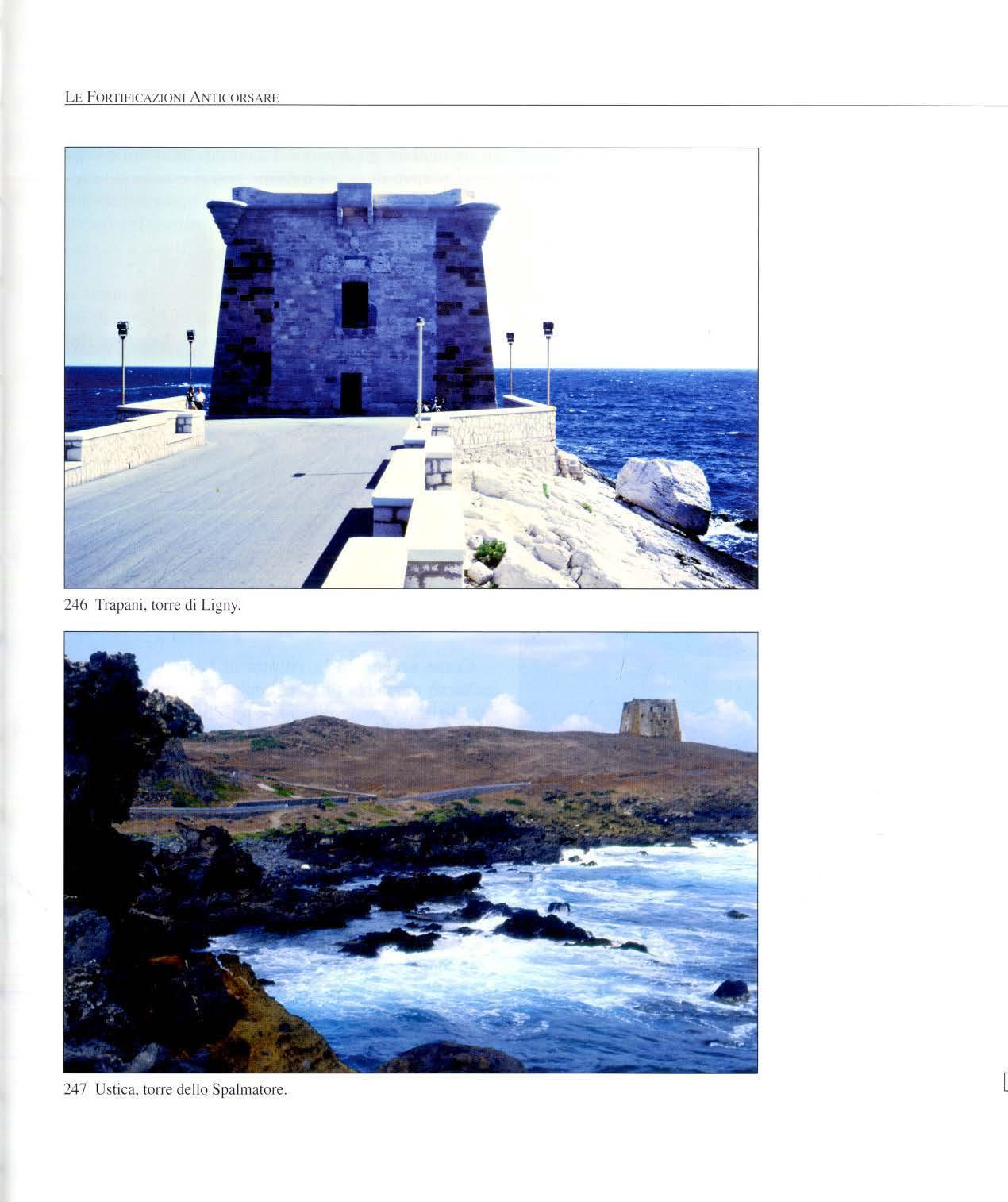
vogliono. giacché dessa è abbandona ta dal re, e tenuta in nes s un conto dai suoi mini s tri e da tutto il mondo " ( 11 s)
L a vibrata denuncia non era disgraziatamente un ' esagerazione reto1ica ma la tragica realtà della Sardegna decaduta , per neg li gente abbandono , ad una regione di razzia is l anùca. La sua esposiz ion e, in assolut o n o n dissimile da quella degli alt ri s tati, veniva purtroppo esas perata dalla rilevante distanza dalla terrafenna ed acuita da ll a limitatissima densità demografica, co nca use peculiaii che co ngiurava no a renderne l e coste praticainente aperie Ne l passato , per La ve1ità, qu alche rimedio era stato preso per dotare alme no i siti più a ri schi o di un minimo di protezione anticorsara.
In particolare gli aragone s i avevano fatto erigere un certo numero di gro ss i torrioni: non si erra molto s upponendoli una decina, alcuni dei quali ancora presenti ed in ottime condizioni di co nservazione. T ra questi quello di P orto Scuso, di Oristano, di Bosa. d ' Alghero, di Po rto Conte e di P o rto Ton-es.
Come faci lm ente recipibile dai ri s pet ti vi nomi s i trattava di capisa ldi finalizzati alla protez ione di un porticciolo, o come nel caso di B osa di una foce fluvia le fungente da ancoraggio , tramite le grosse bombarde per le quali vennero dimen s ionati e di cui erano dotati. Pur non essendo q uelle mastodontiche e malagevo li bocche da fuoco ideali per l a difesa cos ti era rapp r esentavano pur sempre un di sc r eto passo avanti rispetto a ll 'assoluta passività dell ' a ll arme , cos tituendo perciò un indubbi o deterrente anticorsaro. Quei torri o ni a l oro volta si prestavano a ricevere un armamento più moderno senza alcu n a modifica.
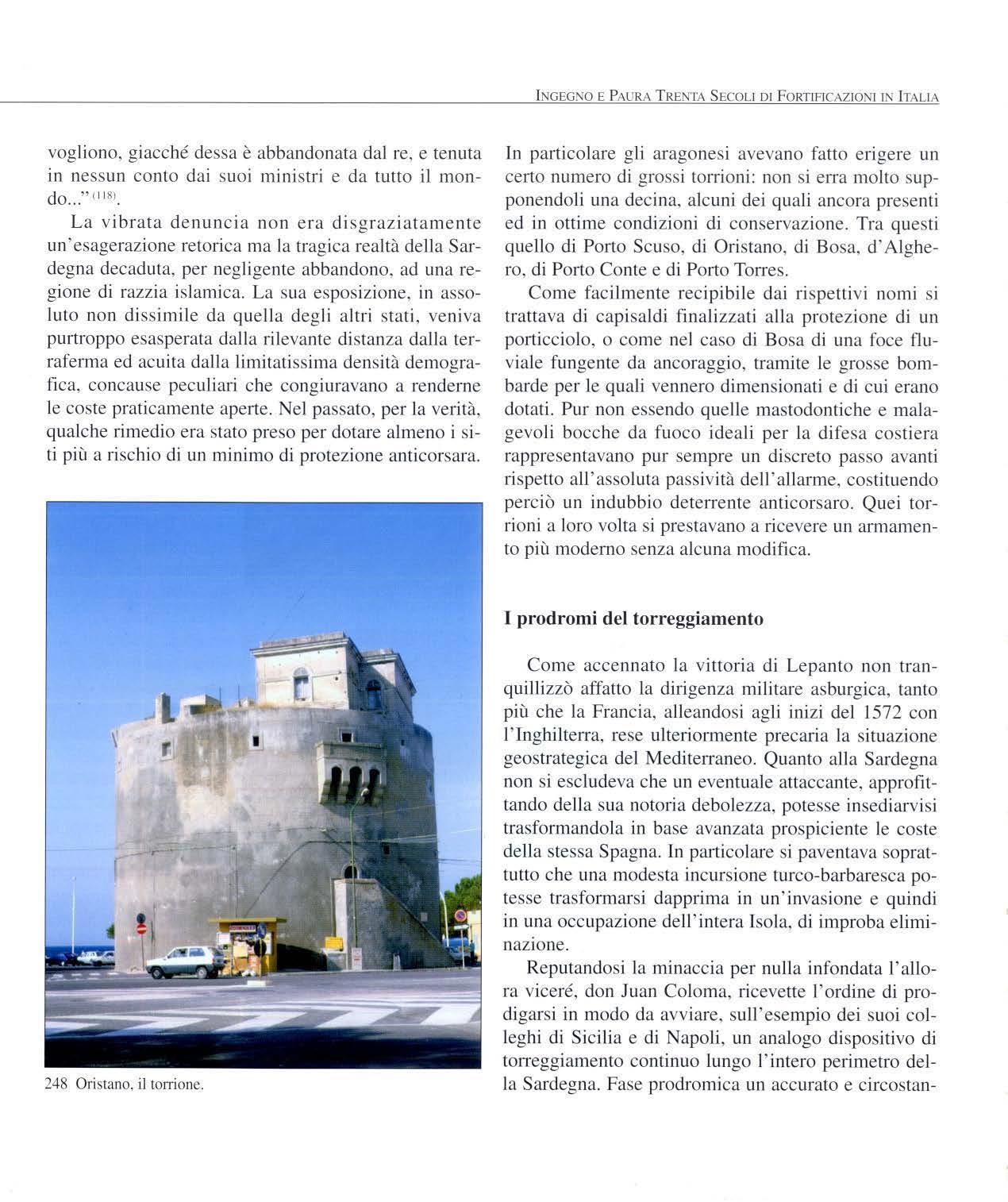
Come accen na to la vittoria di L epan to non tranquilli zzò affatto la dirigenza mili tare asburgica , tanto più che la Francia, a ll ea nd os i agli inizi de l 1572 con l'Inghilterra, rese ult eriormente precaria la s itu azione geos trat egica del Mediterraneo. Quanto alJa Sardegna non si esclu deva c he un eve ntu ale attaccante, approfittando della s ua noto ri a debolezza, potesse insediarvisi tra sfo rmandol a in base ava n za ta prospiciente le cos te della stessa Spagna. In particolme si paventava sopratt utto che una modes ta incursione turco-barbaresca potesse trasformarsi d ap prima in un ' inva s ion e e quindi in un a occupazione dell'intera Isola, di improba elim inazione.
Rep uta ndo si la minaccia p er nulla infondata l'allora viceré, don Ju an Coloma, ricevette l'ordine di prodigarsi in m odo da avviare, sull'esempio dei s uoi colleghi di Sicilia e di Napoli , un analo go dispositivo di torreggiamento continuo lun go l' int e ro perimetro dell a Sardegna. Fase prodro mi ca un accurato e circostan-
248 Oristano, il torrione. I NGEGNO E PAURA T RENTA S ECO LI DI f O RTIFI CAZIONl IN ITALIAziato progetto d'intenti, compilato nel corso dj un· accurata quanto rischiosissima ricognizione dei luoghi. Con la solerzia dei momenti cruciali. la delicata incombenza venne immediatamente affidata ad un gjovane notabile di risaputi dinamismo ed ambizione: don Marcantonio Carnos, capitano di Iglesias •119i.
Stando alJ' interessantissimo documento , interamente pervenutoci e che ancora una volta deve essere considerato tipico per tutti i progetti di torreggiamento continuo, i] Camos, per meglio attendere alla missione, prima di partire. selezionò, secondo la prassi, una sorta di commissione itinerante che lo avrebbe seguito nel minuzioso periplo della Sardegna. A fame parte designò un ufficiale di artiglieria, un pilota di marina, un ingegnere militare, un appaltatore di opere pubbliche, un disegnatore topografo ed u no scrivano. In ogni sito ritenuto a rischio , l'artigliere d'accordo con il navigatore avrebbe indicato il
tipo di armamento necessario a frustrare ogni insidia corsara. A sua volta l ' ingegnere ne avrebbe stabilito, in un ambito di tre modelli base , quale torre fosse congrua al suddetto armamento. mentre l'appaltatore ne avrebbe precisato il costo, tenendo in debito conto sia le difficoltà di accesso al luogo sia le infra s trutture dì s upporto indispensabili. Espletati quei preliminari e raggiunto un accordo, il disegnatore doveva tracciare un sommario rilievo della costa con una precisa indicazione del punto prescelto per I' erigenda torre, indicandone con sufficiente chiarezza oltre alle connotazioni essenziali anche il debito orientamento. Ne l frattempo lo scrivano avrebbe fissato in un'apposita scheda tutti i dati tecnici , economici e geografici. Progressivamente si sarebbe formato in tal modo un codice di schede fungente , alla fine del periplo , da progetto d'intenti dell'intero piano di torreggiamento .
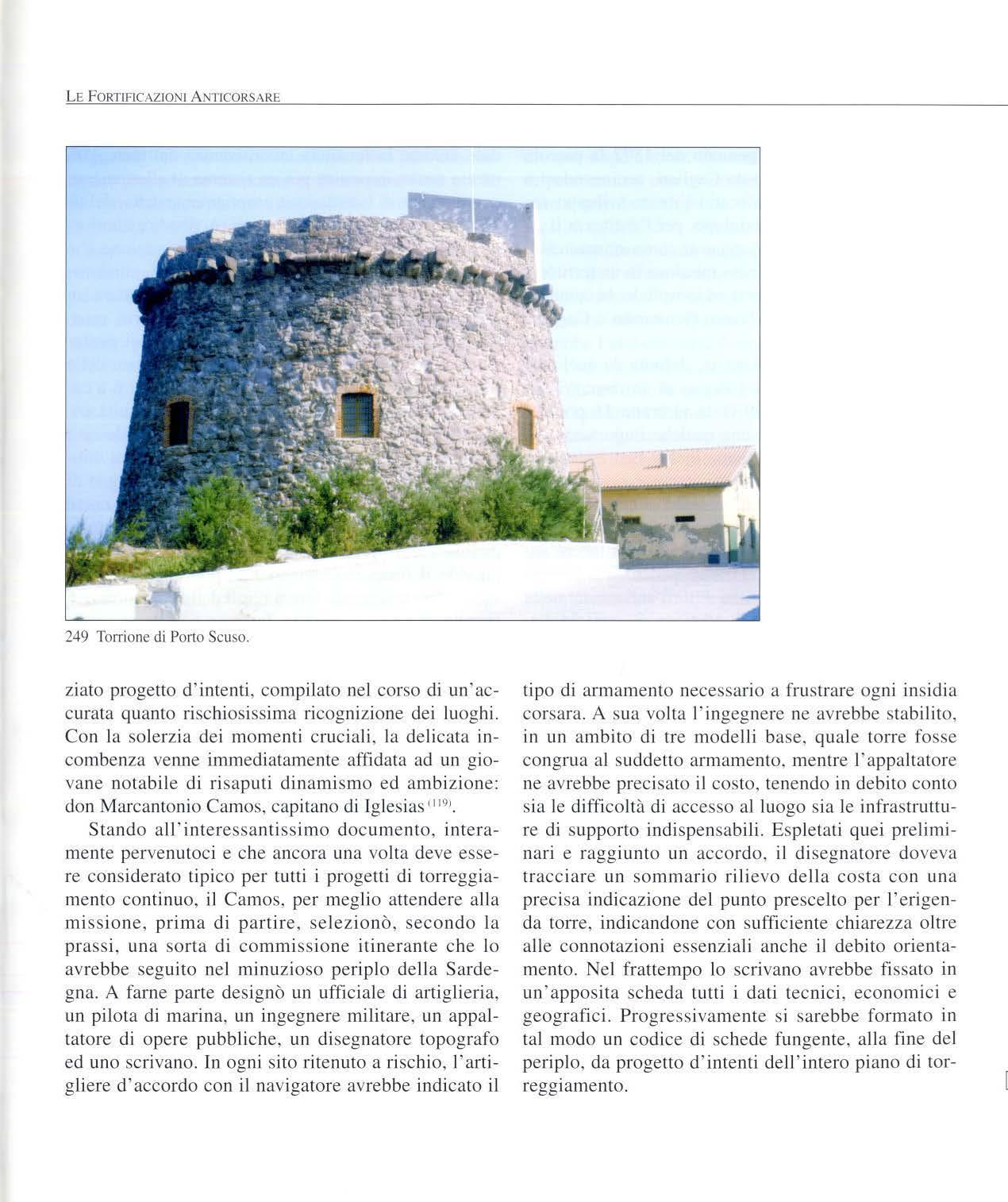
L'ultimo giovedì del gennaio del 1572 la piccola pattuglia si mise in moto da Cagliari, accingendosi a vagliare secondo il verso orario l'intero sviluppo costiero sardo. Circa tre mesi dopo, per l'esattezza il 26 aprile dello stesso anno, dopo aver corso innumerevoli pericoli connessi alla faticosa missione in un territorio per la maggior parte deserto ed inospitale, la commissione concludeva il suo lavoro rientrando a Cagliari dalla opposta direzione.
In sintesi nella sua relazione, definita da quel momento Torreggiamento del Regno di Sardegna 1120 i, il Camos ricordava che nell'isola vi erano 15 porti, 4 porti-canale, I 05 cale di una qualche importanza, da difendere attivamente. Vi erano inoltre ben 26 località costiere nelle quali in qualsiasi stagione riusciva possibile prelevare acqua potabile, senza contare le isolette litoranee suscettibili di trasfonnarsi in basi corsare, delle quali però al momento non si doveva tenere ancora conto. Parimenti la relazione evidenziò la presenza a ridosso di alquanti abitati di torri anticorsare nelle quali si effettuava la guardia continua sia pure finalizzata al semplice allarme limitrofo. Al riguardo il Camos, dando prova di un'indubbia competenza , non mancò di evidenziare che quel modesto espediente, oltre che di scarsa efficacia per gli abitati protetti, si trasformava in ultima analisi in un'agevolazione per i corsari. Non essendo infatti continuo finiva per canalizzarne le incursioni verso le località totalmente indifese, con esiti tragici quanto numerosi. Inoltre, ricordava ancora lo stesso autore, quella ten-ibile esposizione aveva permesso la penetrazione dei razziatori fino a 25 miglia verso l'interno, rendendo l'intera fascia costiera, peraltro la più fertile e remunerativa deserta.
Premesso ciò per il ton-eggiamento di prima istanza sarebbero occorsi 73 capisaldi per la guardia, che al netto degli esistenti scendevano a soli 64. Di questi, però, circa una decina, previsti sulla sommità di alture litoranee, non implicavano strutture murarie per cui le torri propriamente dette si riducevano soltanto a 54, su di un perimetro di oltre l 500 km. Già da questo primo
dato emerge la inusitata inconsistenza del ton-eggiamento sardo, in pratica più un si stema di allertamento continuo che di interdizione propriamente detta, del tipo cioè di quelli appena illustrati. A ribadire ulteriormente la sensazione contribuisce la precisazione che delle 54 torri solo 4 erano previste massicce, altrimenti dette torri gagliarde capaci perciò di sopportare u.n armamento costituito da due pezzi di artiglieria, mentre le restanti 50 erano invece delle semplici postazioni di vedetta. Circa 150 uomini l'ammontare delle loro guarnigioni, mentre 1O esploratori, di cui 6 a cavallo e 4 a piedi avrebbero garantito la continuità anche nelle tratte critiche. Quanto al costo complessivo sarebbe asceso a circa 14.000 scudi , cifra senza dubbio considerevole ma appena sufficiente nel Regno di Napoli all'erezione di una ventina di torri. Un onere del genere tuttavia non risultava in alcun modo compatibile con le misere finanze del Regno, per cui s e ne previde il finanziamento tramite una apposita ta ss a sulle esportazioni di formaggio ed il mantenimento tramite un'apposita rendita. In brev e ogni torre sarebbe stata dotata di un appezzamento di terra limitrofo in grado di garantire un utile sufficiente alla sua manutenzione.

Il dettagliato progetto pervenne a Madrid qua s i certamente nel corso della successiva estate , mentre l'imperatore tentava di aggregare gli alleati dell'anno precedente per infliggere al Turco una nuova disastrosa sconfitta. In quel febbrile contesto quanta attenzione potette trovare un progetto anticorsaro finanziato con il formaggio è facile immaginarlo!
Trascorsero così alcuni anni fino a quando nel ' 74 il Serbelloni, che nel frattempo aveva assunto il comando della fortezza presso la Goletta di Tunisi (12 11 , non fu costretto ad arrendersi consegnando la città ai Barbareschi. La minaccia corsara tornò rapidamente ad incrementarsi ed il progetto di toITeggiamento della Sardegna fu riconsiderato dal suo autore, che ne ricavò una variante ulteriorn1ente più modesta impostata appena su 44 ton-i. In realtà le ton-i risultavano non più di una trentina con meno di un centinaio di uomini
di guarnigione, per un costo complessivo pari alla metà del precedente dispositivo. Nonostante ciò anche per quel secondo piano la disponibilità economica non fu trovata e nell'estate del '75, fra le tante prede dei corsari nelle acque non lontane dalla Sardegna vi fu persino una nave da guerra imperiale. Si trattava della galera El sol a bordo della quale viaggiava il comandante in capo dell'artiglieria napoletana ed un oscuro soldato privo dell'uso di una mano, un certo Miguel Cervantes <1221•
Nel 1578 giunse in Sardegna un nuovo viceré, don Miguel de Moncada: non gli occorse molto tempo per realizzare il terribile degrado provocato dalle razzie corsare sul!' Isola, abbandonata ormai a se stessa. Convinto assertore della necessità cli contrastare tanta vessazione divenne il più attivo sostenitore del torreggiamento, che in qualsiasi maniera avrebbe dovuto attuarsi. E subito dopo aver inviato ai suoi diretti superiori un ennesimo prospetto circa la situazione militare delle piazze, ne inviava un altro relativo ai siti prescelti per l'impianto delle agognate torri anticorsare, completato dai relativi preventivi, sulla falsariga di quello del Camos (123! _
Il documento, però, per quanto è possibile giudicare dalla parte pervenutaci, sembrerebbe più che altro un tabulato informale e riassuntivo, supponente necessariamente u n precedente studio di fattibilità di migliore definizione, divergente per logica tattica da quello del '72 e del '75 del Camos. In esso, infatti, sono previste 82 torri certe, più una decina di probabili, di gran lunga eccedente quindi sia le 54 iniziali che le 30 finali del capitano di Iglesias . Anche da l punto cli vista economico il piano de l Moncada si discosta nettamente dai precedenti, prospettando un costo di oltre 15.000 ducati, all'indomani per giunta di un'umiliante bancarotta imperiale e di una gravissima crisi economica isolana! D iverso sensib il mente persino l'importo

di ogni singola torre. Diversa infine la stessa modalità di percorrenza, con avvio del periplo da Capo Carbonara e non dalla Capitale. Né sembra credibile che le località da difendere con una torre citate nel documento fossero frutto di un mero inserimento teorico, prive cioè di una effettiva necessità e di un preciso riscontro, non fosse altro che gli onnai risaputi contesti di endemica miseria. Quanto osservato perciò confermerebbe l'elaborazione di un nuovo studio di fattibilità del torreggiamento su incarico proprio del Moncada, soltanto in minima parte sovrapponibile ed appaiabile a quelli del Camos. Di più ampio respiro e portata, ostenta quasi una maggiore ingenuità e un rinnovalo entusiasmo, doti peraltro calzanti alla recente investitura vicereale del Moncacla.
Ovvio concludere che il suddetto piano si connotasse, in breve volgere, come una utopica visione o come un ottimale traguardo cui tendere nel tempo , al pari di tutti gli altri progetti di massima già esaminati. Resta comunque un documento interessante per favorire la comprensione della complessa vicenda che quelle colossali opere difensive implicarono. Di certo qualche torre di lì a breve dovette effettivamente iniziarsi a costruire, rintracciandosene menzione in una relazione ufficiale trasmessa all'imperatore nel I 580 e postillata dall'ingegner Fratino. Nel documento , del quale citiamo la traduzione di alcuni stralci evidenziando in corsivo i commenti del Fratino, tra le varie necessità, il Moncada ricorda di aver inviato: " ... don Martino de H errera ed il capitano di quelle marine che si chiamano Casalabria a trattare con gli abitanti delle stesse per convincerli a costruire un paio di torri, a loro spese, alle Bocche di Bonifacio, con l a guardia relativa sempre a loro ca rico. Non ho ancora una risposta diretta su ciò ma ritengo che accetteranno. Ne darò al riguardo comunicazione a V. M.
(Un paio di torri alle Bocche di Bonifacio saranno ben poca cosa per esservi oltre 40 miglia di costa tra gli abitati e Castel Aragonese e ancora 30 tra questo e gli altri abitati Occorrerebbero perciò almeno 4 torri per di più massicce, complete di rivellino , o non
si potrà salvare nessuno che si rifugi in esse, come già lo esposi per iscritto a V. M )
A Sassari [neiJ settori costieri dove si stanno cos truendo due torri molto imp ortanti ...
Ad A l ghero s i sta nn o co mpletando la torr e di Capo Galera ed un 'a ltra che s i erige a spese dei vassalli della baronia di Mo nte leone ... In quella di Capo Galera, per essere mo lt o i mportante. so no stat i pos tati anche due pezzi di artiglieria ed un artighere a spese della c itt à. rn tal modo alla s u a base potranno ormegg i arsi in tutta tranquillità le navi che att ua lm ente non sanno dove lipararsi
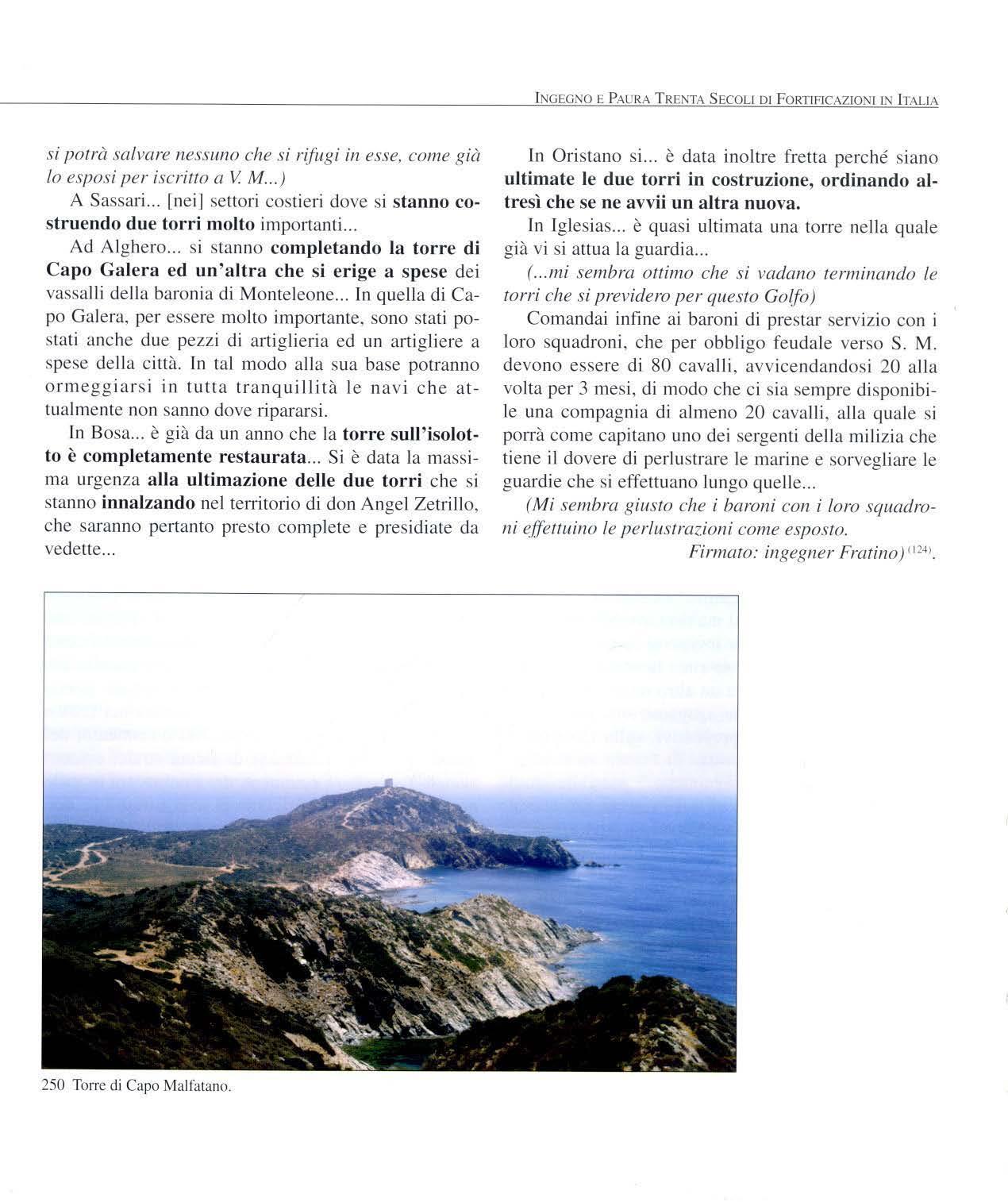
In Bosa... è g i à da un anno c he la torre sull'isolotto è completamente restaurata ... Si è data la massima urgenza alla ultim az ion e deJle due torri c he si stanno innalzando nel tenitorio d i don Angel Zetrillo , che sara nn o pertanto presto complete e presidiate da ve dette ...
I n Ori stano s i è data inoltre fretta perché siano ultima te le due torri in cost ruzion e, ord inando altresì che se ne avvii un altra nuo va .
f n (glesias ... è quasi ultimata una torre nella quale g ià vi si attua la guardia ...
(. .. mi sembra ottimo che si vadano terminando le rorri che si previdero per questo Golfo)
Comandai infine ai baroni di prestar serviz io con i l oro squadroni, che per obbligo feudale ve r so S. M. devo no essere di 80 cavai Ii, avvicenda nd osi 20 alla volta per 3 mesi, di modo che ci sia sempre disponibile una compagn ia di almeno 20 cavalli , alla q ua le s i porrà come capitano uno dei sergenti della mili zia che t ie ne il dovere di perl u strare le marine e so rvegliare le guardie che si effettuano lungo que ll e
(Mi sembra g iu sto che i baroni con i loro squadroni effettu ino le perlustra zioni come esposto.
Firmaro: ingegn e r Fratino) 112~>
250 Torre di Capo Malfatano. iNGEGNO E PA URA TRENTA SECOLI DI FORTI FI CAZIONI L'l 1TAL I AIn definitiva, intorno aJ 1580, i cantieri delle torri , sotto la spinta del viceré don Miguel de Moncada presero ad operare.
Servendosi magari di finanziamenti l ocali, sopportati dagli ab it ant i o dagli stessi feudatari, forse più raramente elargiti dalla fi nanza imp eriale, in diversi punti della costa sarda squadre di muratori, s paccapietre, legnaioli, carpe nti er i e barcaioli si dedicarono a concret izzare il tanto agognato e lungamente atteso progetto. Purtroppo nes s una fonte esplicita ci consente di appurare quante torri fossero co nt emporaneame nt e in costruzione in quella estate del 1580 . Una s tima prudente ci porterebbe a non superare la
decina, cifra senza dubbio modestissima, ma incontestabile avvio del torreggiamenro sardo Del resto se la seconda re la zione del Camos ne prevedeva complessivamente una trentina, e la carta dell'isola del 1577 del Capellino, frutto in merito di informazioni piultosto che di oggettivi riscontri, ne riportava 33 ed il Fara. a sua volta, nella Cronographia ne prospettava 31, quella frazione rappresentava una consistente aliquota. pari ad un terzo .

L'a ttuazione così intrapresa ricevette la prima investitura ufficiale soltanto nel 1583 allorché il: " Parlamento convocato dal viceré Miguel de Moncada ha fra g li argomenti in discussione proprio la questione della difesa delle coste d e ll ' iso la. Gli s tamenti propongono capitoli pressoché identici sul sistema difensivo: in primo luogo le torri devono essere erette nei golfi, nei porti e a dife sa dei centri abitati: le torri che sorgono nelle marine delle città o dei feudi devono essere mantenute dal le amministrazioni municipali o dai signori feudali; le torri sarebbero, di fatto, inutili se non si procedesse anche al re s tauro delle piazzeforti di Cagliari, Alghero, Caste11aragonese e alla fortificazione delle altre città. Viene, infine, proposta l ' istituzione di una Diputaciò. espressione dei tre bracci del Parlamento, per l'amministrazione dei fondi 1icavati dalle tasse previste per finanziare la costruzione e il mantenime n to delle torri " 11 25 1 •
Non è affatto da escludere che la presa di posizione del Parl amento sardo avvenisse s ulla s pinta emozionale dell'ennesima tragica razzia abbatt ut asi l 'a nno innanzi s u Quartu, a poche miglia da Cagliari, dove l ' appara to di vigilanza e difesa anticorsara tardava ad essere attivato. Altresì a l tamen te probabile s upp orre , dietro la c it ata de lib era, l a vo lo nt à imperiale, apparentemente dispersasi nei meandri burocratici. E fo rse proprio a seguito della inarrestabile e crescente pressione barbaresca s ull e torme nt a te marine dell ' indifeso R egno, l 'imperatore Fi lippo II , alla fine s i espresse a l riguardo in maniera inequivocabile. Pertanto nel 1587, quindici an ni dopo gli accorati solleciti di don Marcantonio Camos, l a prammatica del 29 [
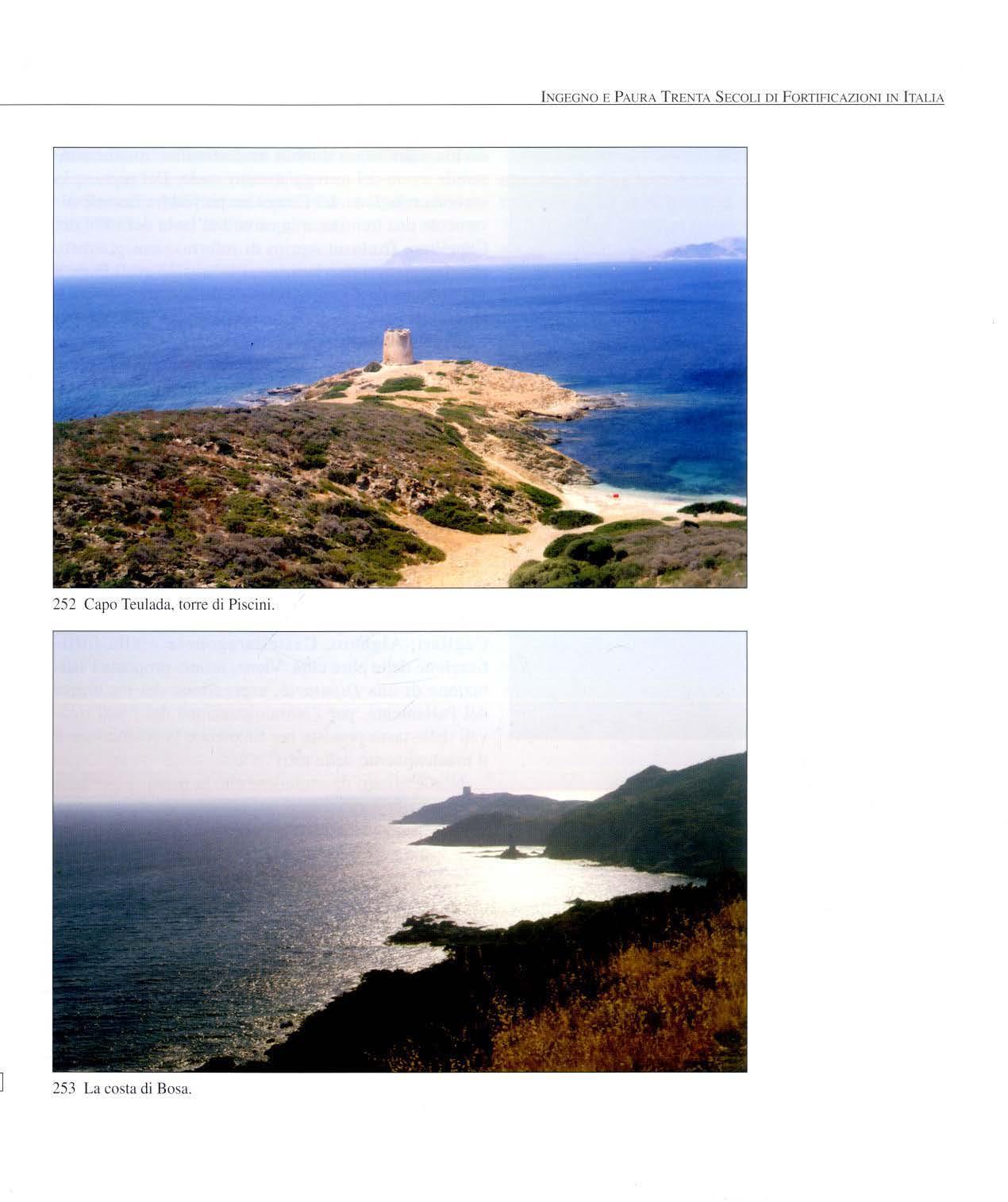 L"IGEGNO E PAURA TRENTA S ECOLI DI FORTIFICAZJONJ [N lTALlA
252 Ca po Teulada. to rre di Pi sc ini
253 La costa di Bosa
L"IGEGNO E PAURA TRENTA S ECOLI DI FORTIFICAZJONJ [N lTALlA
252 Ca po Teulada. to rre di Pi sc ini
253 La costa di Bosa
settembre sancì la nascita istituzionale del toneggiamento della Sardegna:
... Quale terzo ed ultimo punto disponemmo che il detto Regno, che è isola, fosse protetto per l'intero suo perimetro da torri di pielra <126 , con frequenti postazioni di sold ati e depositi munizioni nei luoghi più elevati ed impervi. Quanto esposto non so lo gioverà alla sicurezza del Regno e dei suo i abitanti ma alla stessa navigazione. quindi a l commercio e provocher~t la sconfitta de i pirati. Le prospettate torri. inoltre, potranno fornire riparo anche a tutt i coloro che s i rifugeranno presso di esse, sia col mare ca lmo che agitato. agevo lando come afferma to la navigazione.
Erette in prossimità dei siti dove i pirati sono soliti appostarsi con i loro navigli, potranno con il fuoco delle artigJierie di cui saranno dotate inficiarne gli agguat i. proteggendo i nostri sudditi dalle conseguenti violenze. Parimenti porranno. qualora le imbarcazioni di questi ultimi s iano inseguite, ripararsi presso le stesse , sfuggendo in tal modo la cauura
Tramite le stesse sarà reso sicuro l'esercì.do della pesca intorno al Regno e le ciltà potranno ammassare molte ri sorse provenienti dal mare. Quanto detto, in p<trticolare. se sarà introdotta come da pochi anni si verifica ne l nostro Regno di Sicilia, la pesca dei tonni, che vi ha generato grandissime ricchezze. Persino le terre costiere troveranno beneficio dal dispositivo difensivo. e potranno essere finalmente coltivate e fornire, per la loro risaputa fertilità abbondanza cli frumento, e pascoli per gli armenti.
Tramite sempre le suddette torri indurr emo nel potenziale allaccante un salu tare terrore. che lo coslringerà a rem>cede n:, spi nto da.Il a minacciosa presenza de lle artiglier ie, con il ri su ltalo che i te1Titor i a l p resente negle tti pe r la costante vessazione corsara saranno i più feraci ed ambiti dell"inte ro Regno, e lo stesso ricco di risorse e di v ive ri. scaJo di commercio e cl.i traffici lucrosi. Se Dio vuole. fra gl i altri nostri regni a buon diritto potrà fregiarsi dell" appellativo Felice e Fausto. non ricusando noi e la nostra corona. ma al contrario fornendole grandiss imi apporti.
Di più lo s tesso Regno prospiciente le coste d'Africa e posto aJ centro degli altri nostri Dom in i assurgerà al rango cli forteZLa e di bast ione per tutti : anche ciò sarà frutto delle p redette to rr i, er ige ndos ene tante e sì possenti.
Per la cos truzion e di queste, però, necess itano grand iss ime so mm e di denaro che, qualora ipotizzate con
finanziamento esterno ovvero dalla Spagna. dall ' Italia e dalla Germania per la presumibile discontinuità del gettito potrebbero arrecare gravi danni proprio alle erigende torri. Infatti la temporanea sospensione del sold o potrebbe produrre l'abbandono delle stesse da parte delle loro guardie. con il risultato che quelle saJebbero immediatamente spianate, con a ltri infiniti danni conseguenti.
Per la qual cosa è sembrato assai giusto accordarsi che il denaro indispensabile per le stes~e sia attinto non dall' esterno del Regno ma dal suo interno. non potendosi peraltro prelevare dal nostro patrimonio la cui penuria e tenuità attualmente ci angustia. Penanto delegammo ad alcuni uomini onesti il compito di individuare da dove, e come, si sarebbero potuti rintracciare nel detto Regno i fondi necessari, senza disagio o danno per i nostri suddiLi. La risposta ricevuta affennò che nessuna altra so lu z ione appariva più conveniente di quella di tassare le merci in espo rtazione, ottenendone il lìnanziamemo per la costrnzione e la manutenzione delle predette torri. Appurato ciò demmo incarico a don Michele de Moncada. nostro luogotenente e capitano generale, delresp letazione. ed egli dopo averne discusso al riguardo con i notabili del Regno e con i tre Stamenti. ci confe1mò che in nessun alu·o modo era possibile infatti reperire i fondi nel Regno se non tassando i formaggi. i cuoi . le lane. la pesca ciel corallo e forse anche altri generi di espo1iazione. Con questa procedura si sarebbe potut o nel corso dei successivi anni accumu lare la somma di 12.000 ducati, somma mediante la quale si potrnnno erigere e mantenere le predette toni, quelle cioè la cui costruz ione e manutenzione sarebbe spettata a noi ed al la nosu·a Regia Curia.

Apprese tutte queste informazioni ed al contempo valutata nel nostro S.S.R. Consiglio questa deliberazione , si è da no i imposto che tale tassa venga resa esecu tiva sui predetti generi di esportazione. risultando la stessa non solo necessar ia ma della massima utilità per il Regno. Pe1tanto don Michele de Moncada, nostro luogotenente e capitano generale, convocò a suo tempo nella nostra città di Cagliari i tre Stamenti del Regno per illu su are agli stessi la nostra vo lom à: appresaJa acceuarono l' imposizione così id eata e la ratificarono come assai valida e provvida per il Regno :• c1211 •
La to rr e tronco-conica, come già più volte precisato, era l'archetipo senza dubbio più noto ed economico, se bbene quello meno ido neo ad integrarsi con l'ar-
tiglieria. Nel contesto del torreggiamento sardo, però, l'intervento di ssuas ivo al di là della enunciazione imperiale non costituiva la finalità precipua essendo quel particolare sistema meramente di vigilanza e segnalazione. Ovvio allora che appunto quella torre, tanto simile agli ultramillenari nuraghi dell'isola sia stata 1a prescelta per il torreggiamento.
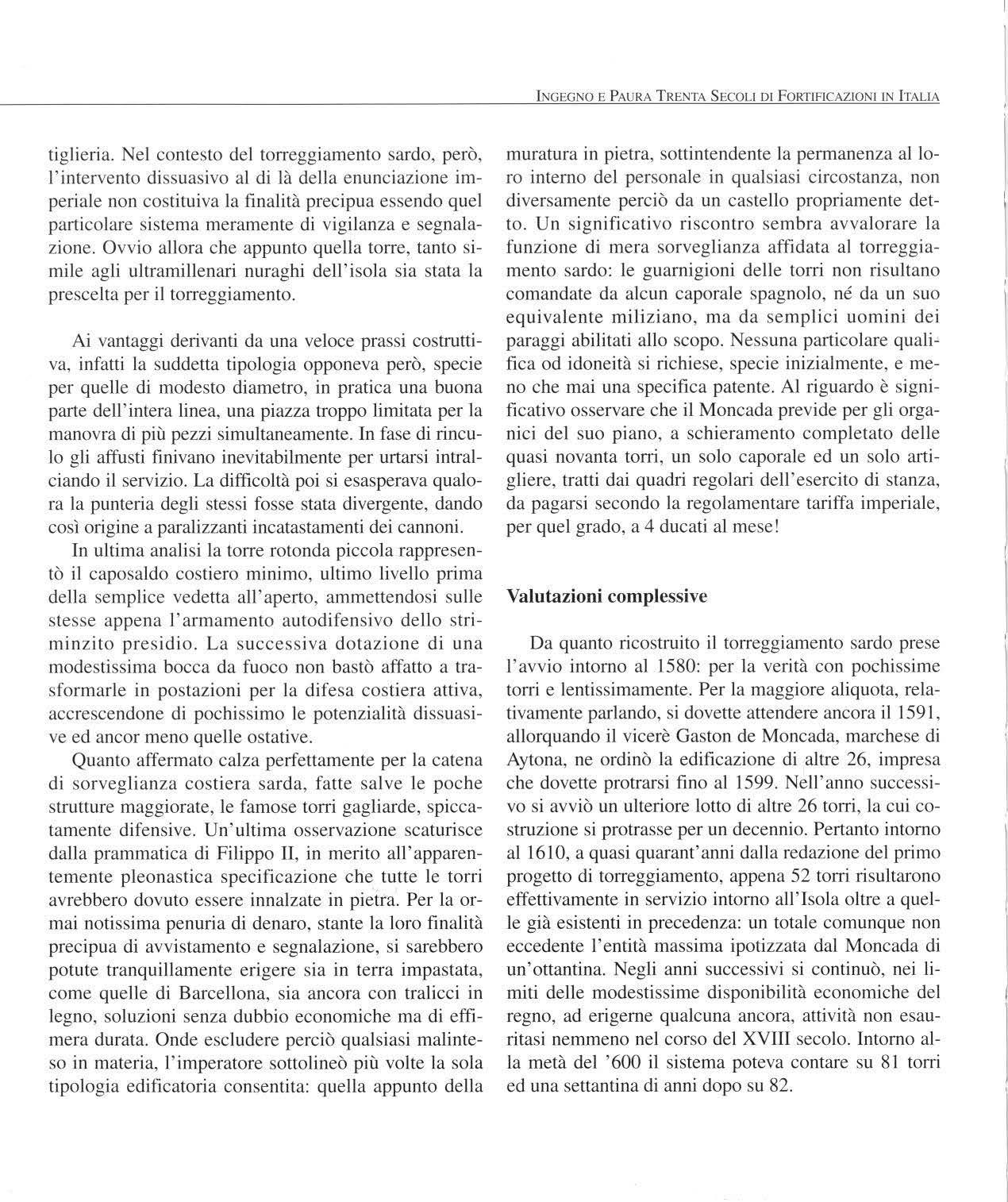
Ai vantaggi de1ivanti da una veloce prassi costruttiva, infatti la suddetta tipologia opponeva però, specie per quelle di modesto diametro , in pratica una buona parte dell'intera linea, una piazza troppo limitata per la manovra di più pezzi simultaneamente. In fase di rinculo gli affusti finivano inevitabilmente per urtarsi intra lciando il servizio. La difficoltà poi si esasperava qualora la punteria degli stessi fosse stata divergente, dando così origine a paralizzanti incatastamenti dei cannoni.
I n ultima analisi la torre rotonda piccola rappresentò il caposaldo costiero minimo , ultimo livello prima della semplice vedetta all'aperto, ammettendosi s ulle stesse appena l'armamento autodifensivo dello strim i nzi to presidio. La successiva dotazione di una modestissima bocca da fuoco non bastò affatto a trasformarle in postazioni per la difesa costiera attiva, accrescendone di pochissimo le potenzialità dissuasive ed ancor meno quelle ostative.
Quanto affermato calza perfettamente per la catena di sorveglianza costiera sarda, fatte salve le poche strutture maggiorate, le famose torri gagliarde, spiccatamente difensive. Un'ultima osservazione scaturisce dalla prammatica di Filippo II, in merito all 'apparentemente pleonastica specificazione che tutte le torri avrebbero dovuto essere innalzate in pietra Per la ormai notissima penuria di denaro, stante la l oro finalità precipua di avvistamento e segnalazione, si sarebbero potute tranquillamente e r igere sia in terra impastata, come quelle di Barcellona, sia ancora con tralicci in legno , soluzioni senza dubbio economiche ma di effimera durata. Onde escludere perciò qualsiasi malinteso in materia , l'imperatore sottolineò più volte la sola tipologia edificatoria consentita: quella appunto della
muratura in pietra, sott intendente la permanenza al loro interno del personale in qualsiasi circostanza, non diversamente perciò da un castello propriamente detto. Un significativo riscontro sembra avvalorare la funzione di mera sorveglianza affidata al torreggiamento sardo: le guarnigioni delle torri non risultano comandate da alcun caporale spag nolo , né da un suo equivalente miliziano , ma da semplici uomini dei paraggi abilitati allo scopo. Nessuna particolare qualifica od idoneità si richiese, specie inizialmente , e meno che mai una specifica patente. Al riguardo è sig nificativo osservare che il Moncada previde per gli organici del suo piano, a schieramento completato delle quasi novanta toni, un solo caporale ed un solo artigli ere, tratti dai quadri regolari dell ' esercito di stanza, da pagarsi secondo la regolamentare tariffa imperiale, per quel grado, a 4 ducati al mese!
Da quanto ricostruito il torreggiamento sa rdo prese l 'avv io intorno al 1580: per la verità con pochissime torri e lentissimamente. Per la maggiore aliquota, relativamente parlando, si dovette attendere ancora il 159 I , allorquando il vicerè Gaston de Moncada, marchese di Aytona , ne ordinò la edificazione di altre 26, impresa che dovette protra rsi fino al 1599. Nell'anno s uccessivo si avviò un ulteriore lotto di altre 26 torri, la cui costruzio ne si protrasse per un decennio. Pertanto intorno al 1610, a quasi quarant'anni dalla redazione del primo progetto di torreggiamento, appena 52 torri risultarono effettivamente in se rv izio intorno all'Isola oltre a quelle già esistenti in precedenza: un totale comunque non eccedente l'entità massima ipotizzata dal Moncada di un'ottantina. Negli anni successivi si continuò, nei limiti delle modestissime disponibilità economiche del regno, ad erigerne qualcuna ancora, attività non esauritasi nemmeno nel corso del XV III secolo. Intorno alla metà del ' 600 il sistema poteva contare su 81 torri ed una settantina di anni dopo su 82.
INGEGNO E PA URA TRENTA SEC OLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIA1 Poche battaglie hanno avuto tante ricostrnzioni e rievocazioni da parte degli storici come quella di Lepanto Nessuna di certo è ancora oggi, ogn i a nn o, festeggiata dalla stessa Chiesa il 7 ottobre, giornata consacrata alla Augusta Reg in a delle Vittorie. li perché di tanto int e resse e di t anta emoz i one deve individuarsi soprattutto nella sua va lenza psico logica, ovvero nel cons id erarsi la prima inversione di tendenza nei confront i della potenza ottomana, fino a quel momento dovunque invincibile ed avanzante. Una interessante e si n tetica ri costru zio ne è q ue ll a forn it a da J.F.C. F ULLER. Le battaglie decisive del mondo occidentale, rist. Roma 1988. tomo I, pp. 489 - 503. D al punto di vista delle perdite Lepanto si rivelò una strage priva di s ignificati vi precedenti: dei c irca 180.000 uom i ni che compless ivame nte presero parte allo scontro, poche ore dopo almeno 50.000, secondo le stime più prudenti, erano sta ti uccisi.
2 Su ll a figura de l celebre co rsaro, rinnegato cal ab rese di nome Giovan Dionigi Galcni, cfr G. VALENTE, Le Castel/a, Catanzaro 1993, pp. 47 -49. Più in dettaglio ancora sempre lo stesso autore ne de lin ea l a bi ografia in Vita di Occhialì da schiavo a re di Tunisi Tripoli e Algeri, Reggio Calab ri a 1994.
3 A l ri g uardo prec isa F. BRAUDEL, Civiltà ... , cit., voi. II , p. 11 83: ·'Quando si conosce la conc lu sione, è troppo facile spiegare, come fa padre Serra no, l'u l timo e mi gl io re storico di Lepanto, che q uesta vi tt o ri a non poteva dare alcun frutto. né servi re a qualcosa. La so la cosa c he si possa dire è c he Lepanto era so lta n to una vitto 1ia navale e che, in quel mondo liquido ci rcondat o e s barrato da terre. non poteva bastare a distruggere le radi c i turc he, che erano lun ghe radici continentali ".
4 Sp iega magistralmente quel si ngola re s nodo s t o ri co F. BRAUDEL, Civiltà ... , cit., voi. TT , p. 1273: " ... La pace nel Medite1i-aneo ... s i ristabilisce so ltanto perché la g uerra si insedia ne i grand i spaz i vicini: Atlantico , ovest; contini pers iano e Oceano Indiano, a est A l movimento di oscillazione della Tu rchia verso est, ri sponde il movimento de ll a Spagna verso ovest... il b locco de ll a forze spagnole e il blocco delle forze turche , a lungo oppost i in Mediterran eo, s i staccano l'uno dall'altro , e di co lpo il Mare Inte rno si libera dalla guerra dei grandi stati che dal 1550 al 1580 ne era stato il fatto principale ...". li che sign i ficò l ' in c rem e nto della g uerra di corsa.
5 La situazione non differiva sostanzial mente dall'offens i va co ndotta nel seco ndo con flitto mondial e dai sommerg i bi li ge rmanici , adottata in breve da tutte le potenze in guerra. In m e ri to cfr. F. RuGE, La guerra sul mare 1939-45, Milan o l 970, pp. 14-22.
6 C. H. B ECKER, L 'espansione dei saraceni in Africa e in Europa, in Storia del mondo medievale , Cambridge Un iversity Press, Milano 1979, voi. 11, p. 86: " .. .la guerra regolarmente in corso fra arabi e bizantin i s i esp rimeva in si ngole campagne estive. denominate xoursoi, che s i svolgevano s ia per terra sia sul mare Anche il nome '·corsaro" deriva etimo logicamente dalla parola xourson. L'invio della flotta da parte di Ibn Hud aig [contro la Sicilia] fu uno di questi xoursoi. 11 bottino consisteva in schiave, tesori tolti a ll e chiese e immagini sacre. che secondo gli storici arabi Mu 'awiya cercava di scambiare con oro con gli indiani idolatri ".
7 L a gue1Ta di co rsa fu abolita ufficialmente nel 1856 a Vienna ma non tutte le nazioni so ttoscrissero allo storico atto, a cominciare dagli Stat i Un iti che ne vo levano una più dettagliata definizione. Circa poi l'evolversi delle leggi di guerra cfr. A MARCHEGG IANO, Diritto umanitario e sua introdu z ione nella regolamenta zione dell'Esercito Italiano, Roma 1990. voi. l.. pp. 17-108.
8 Sull'argomento c fr. C. M ANCA. Il modello di sviluppo economico delle ci/là mari/lime barbaresche dopo L epanto, Napoli 1982.
9 Cfr. F. CHARLES-Roux, France et Afrique du nord avanta 1830 , Paris 1932, pp. 48 e sgg. Una fonte coeva può ritenersi G.B. SALVAGO. Africa overo Barbaria, relazione al doge di Venezia sulle Reggenze di Algeri e Tunisi del dragomanno Gio. Balla Sa/vago ( 1625), a c ura di A. SACERDOTI, Padova 1937 , p. 55.
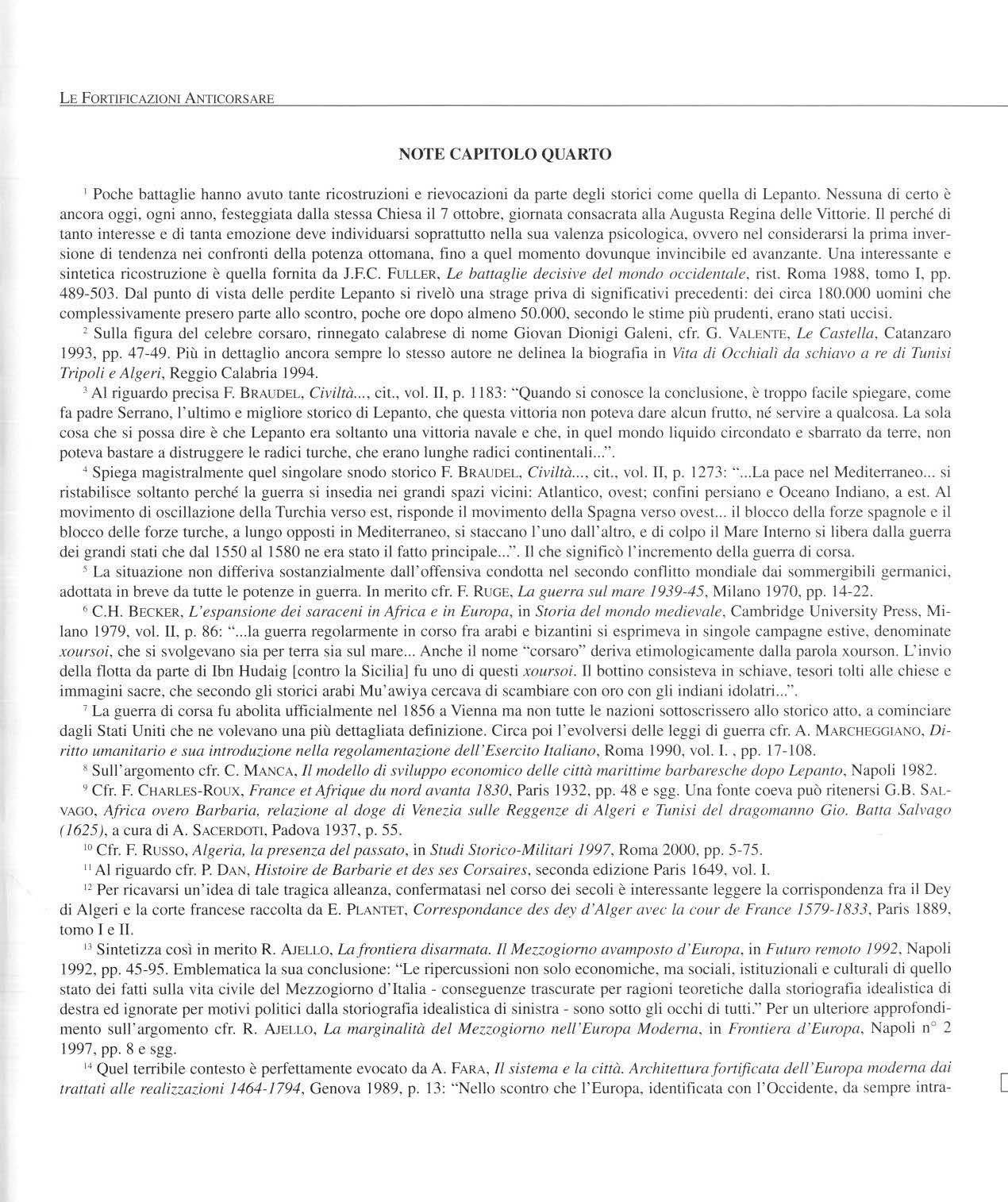
1°Cfr. F. R usso, Algeria, la presen za del passato, in Studi Storico-Militari 1997, Roma 2000, pp. 5 -75.
11 Al ri g ua rdo cfr. P. DAN, Histoire de Barbarie et des ses Corsaires, seconda edizione Paris 1649, vol. l.
12 Pe r ri cava rs i un ' id ea di ta le tragica alleanza, co nfermatas i nel corso dei secoli è interessante leggere la corrispondenza fra il Dey d i Algeri e la co rte francese raccolta da E. PL ANTET, Correspondance des dey d'Alger avec la cour de Fran ce 1579-1833. Pari s 1889, to m o I e Il
13 Sintetizza così in merito R . AJELLO. La.frontiera disarmata . Il Me zzog iorno avamposto d'Europa, in Futuro remo/o 1992. Napoli 1992, pp. 45 -95. E mblematica la s ua conc lu s ione: "Le ripercussioni non solo econom iche, ma soc i a li , istituzionali e culturali di quello stato dei fatti s ulla vita c ivile del Mezzog iorno d'Ita li a - conseg uenze tra sc urate per ragioni teo retiche dalla s toriografia id ea listica di destra ed ig no rate per motivi politici dalla s to ri ogra fia id ea li s ti ca di sinistra - sono so tto g li occhi di tutti. " Per un ulteriore approfondimento s ull 'argo mento cfr. R. AJ ELLO, La marginalità del Me zzogio rno nell 'Europa Moderna. in Frontiera d'Europa. Napoli n° 2 1997, pp. 8 e sgg.
14 Qu el terribile contesto è p erfetta me nte evocato da A. FARA, Il sistema e la città. Architettura.fortificata dell'Europa moderna dai tra/lati alle realizzaz ioni 1464 -1794, Genova 1989, p. 13: " Nel lo scontro che l' E uropa, id e ntifi cata con l'Occidente , da sem pre intra- [
prende con l'Oriente. l'a rchitettura fortificata alla moderna trova una sua ragion d'essere. Gli ingegneri sono sorretli, nell'escogitare fortificazioni, da istanze difensive nei confronti del Turco.
Il pe1icolo di una barbarie moderna prospettata a Oriente, vede il difensore occidentale disposto sui bastioni della Ciistianità, dove i particolarismi per lo p iù si acquietano. La difesa sugli spalti è un atto sacro condotto co1mo un nemico comune Le difese contro il Turco presuppongono nuove concezioni spaziali della città fortificata e una sua adeguata rappresentazione cartografica. In vari Stati dell'Europa si diffonde , allora un sapere scientifico ed esclusivo, che perde la sua esclusività mano a mano che ne progredisce la d iffusione ... I soldati de ll' Occidente sanno che la perdita della fortezza comporta quella della libertà e la caduta in schiavitù ... La fortificazione occidentale alla moderna è una macchina che presuppone un'abilità tecnica da parte di chi la usa, per opporsi a un elevato numero di assedianti fanat icamente coagulati intorno a un capo ...".
15 Cfr. V. GH EO RGHI U, La vita di Muome/lo, Milano 1991. pp. 302-305.
16 Per nu lla casuale che la paro la ·razzia' derivi daJJ' arabo Gha~wah. 'assa l to'.
17 Nel corso de ll a Seconda Guerra Mondia le, nella Marina da Guerra Germanica vennero arma t i alquanti mercanti li per condurre una moderna ·guerra d i corsa'. li più famoso, ed anche il pi ù fortunato, fu senza dubbio l'Atlantis. che rimase in crociera continua per circa due ann i Un nuovo filone attua tivo vede nei dirottamenti aerei l'u l tima manifestaz ione della gue rra d i corsa, finalizzata come sempre a compromette re. grazie alle violenze di crimina li comuni sui civ ili inermi. g li interessi commerc ia li di uno Stato.
i g Una eloquente panoramica sugli ex-voto offerti dai marittimi scampati ai corsari barbareschi tra il XVT ed il XTX secolo la si ritrova nell'opera di A.E. GJARDINO. M. RAK. Per grazia ricevutu. Le /Uvolette dipinte ex voto per la Madonna dell'Arco. Pompei 1983. pp 280-343.
19 Precisano S MAZZA RELLA, R. ZANCA, // libro delle torri Le torri costiere di Sicilia nei secoli XV I-XX, Palermo l 985, p. 75: "Qualora un vascello nemico andava a 'mettersi alle cale', si sparava un tiro di mascolo, o due se più erano i vascelli; acciocché i passegge ri e vascelli. che occorresse passare, fossero avve rt ili del perico lo" si faceva inolt re un segno di fumo o di fuoco, continuamente per un'ora. a seconda che si fosse di giorno chiaro ovvero di nolle o giorno scuro Per contro c'era il segno di 'sicuranza·. benigno. che consentiva a ciascuno di continuare tranqui ll amente ne ll e proprie occupaz ioni ".
20 L. SANTORO. Castelli angioini , c i t., p 93, trascrive un ord i ne di servizio a quelle torr i così formulato: " e che gli uomini di guardia siano a/lenti a sollecitamente avvertire l'avvicinarsi al lido di navi nemiche e dei ribelli. con il segno di fumo di giorno e col fuoco nella noae . e nel modo consueto per indicare il numero delle navi ... ".
21 I. HoGG. Storia delle.... cii.. p. 107, ricorda che prima dell'avvento dell'a rt iglier ia: " ... l' idea di colpire e disorganizzare il nemico pr ima ancora che sbarcasse non era nemmeno presa in consideraz ione, po iché non esistevano anui a lunga gittata che potessero asso lvere a questo compito. Tuttavia ai tempi di Enrico [VIU) , la presenza di un 'a rtiglieria relativamente affidabile, capace di co lp i re a qualche centinaio di metri d i distanza rendeva possibile danneggia re e persino affondare, un' imbarcazione prima ancora che essa fosse in grado di iniziare le operazioni di sbarco de ll e proprie truppe ... [Se a ciò si aggiunge] quello di una piattaforma di ti ro i nfin itamente più stabile. laddove di cannoni imba rcati e rano disturbati nel la punteria da l rollio e dal beccheggio della nave, ce n'è abbastanza per fare della difesa costiera mediante batterie d'artig lieria una tattica d ifensiva formidabile, che durò a lungo, fin quasi ai nostri g iorni ... " .
22 Cfr. F. BRA UDEL , Civiltà , cit., p. 97.
23 Riporta F. BRAUDEL. Civiltà , cit., p. 96: ··.. .il caso del principe di Monaco e del duca di Savoia. ambedue possesso ri di un rid ico lo pezzo di costa, eppur smaniosi di associarsi al ricco traffico che passa sotto il loro naso; essi pretendono di far pagare al le navi il se mplice cos tegg iare le loro rive. Guai ai vel ieri che le loro galere riescono a fermare!''
2 • Le ordinanze, riproposte per l'ennesima volta come Reali Editti ancora ne l l 751 sono riportate da R CiSTERNINO e G. PORCARO. La marina mercamile napoletana, Napoli 1954, pp. 67 -68.
15 Cfr. F. STRAZZ UL LO, Edilizia e urbanistica a Napoli dal '500 al '700, Napoli 1968. pp. 9- 24.
26 Cfr. F. Russo, Fuste. farina e forza, la via del grano, in Rassegna del Cen t ro di Cultura e Storia Amalfitana, n° 4 Dicembre 1992 n.s , pp. 44 e sgg. Tn partico lare circa la convenienza economica del trasporto mari tt imo cfr. F. BR AUDEL, Le strutfure del quotidiano, Torino 1982, pp. 392-396.
27 Immancabil mente i viceré del momento facevano notare al l'imperatore che per il traspo rt o de l grano: " .per terra da Puglia con carrette, come se trofica in Alemagna et altre parti, dico essere impossibile. perché bisognano almeno diecimila ca rri di grano di Puglia, et ogni carro ha bisogno de 0110 bovi che per la Puglia piana lo conducano con sei, di modo che è intrattabile il condurre, considerando quanti carri e quanti bovi sariano necessari e tanto più che nel regno a pena smw tanti !JOvi che bastino per /'agricoltura .''. La citazione è tratta da mss. Bmncacciana, TI R 5, r. 122, Bib. Naz. Napoli .
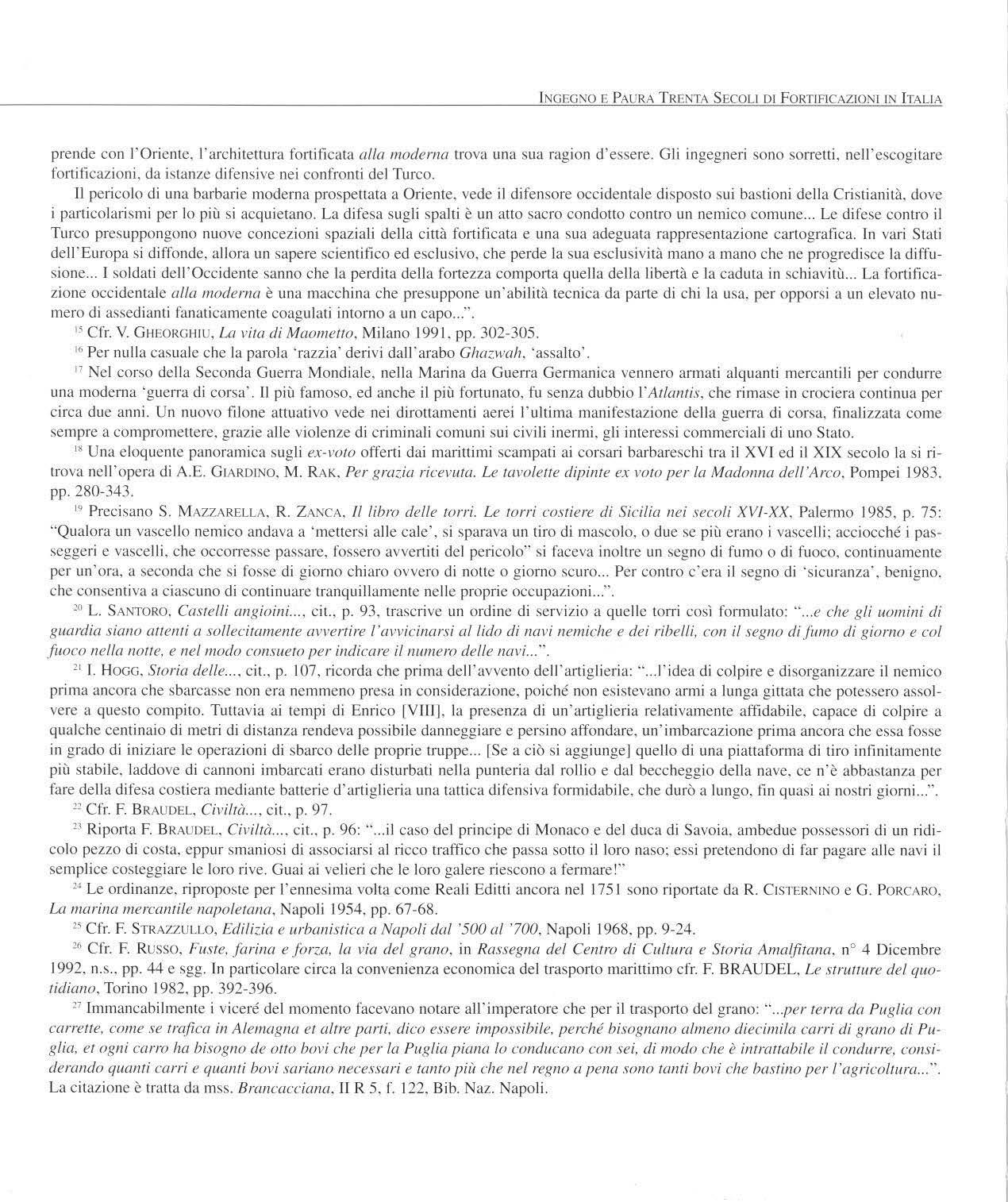
28 In merito cfr. E. KANTOROWICZ. Federico II. impera/ore, rist. Milano 1976, pp. 11 - 11 4.
! 9 Per val utare quanto ri sc hi oso fosse all'epoca anche sempl icemente conservare de l grano è sufiìc icnte osservare l a necessità di c ustodi rl o in appos ite masserie fortifica te, dette appunto per grano . Di esse ne so pravvive ancora un discreto numero in Puglia, per lo più ri sa le nti al XVI-XYll seco l o. Sull'argomento cfr. F. Russo. La dUèsa delegala, Rom a 1994, pp. I 58-190.
30 Di questo avviso tra g li a ltri ma con ben diversa autorevolezza R. AJELLO, Laf,vnfi era , cit., pp. 52- 3 . Più in generale osse r vava al ri guardo P.M. D oRJA, il regno di Napoli nel 1713. in Territorio e socielà nella storia del Me::,zogiorno, a c ura di G. DE ROSA, A. CESTARO. Po mpe i 1973 , pp. 21 4 -2 15: ' ... Quanto sa di militare ha pochi ss i ma a ut ori t à e decoro nel paese. G li spag nu o li no n di sc iplinarono la mili z ia indigena. perc hé s timaron meglio perd erne i l vantaggio che avere un popolo agguc1Tito e diflìc il c da dominare. Intesero in vece amm o llirl o e avvilirl o. E però oggi, oserei di.re, non si troverebbero in tutto il R egno tremila uom ini capaci di tener fe rm o alpericolo delle arch ibugiate li p oco c he la po l itica spagnuola fece qui d ella milizia produsse la scarsa stima che i napoletani hanno de' m ilit ari "
31 D a B. Fo RT EGUERRl. Propos 1a di campagna marittima per i bas1imen1i de/fa Marina di S. M. il R e delle Due Sicilie, Palermo 1798.
11 C irca la stima dell'entità della flotta corsara, S. BONO, / corsari barbareschi, Torin o 1964, pp. 87 - 88 affe rm a: "Le notizi e s ulla cons iste nza nelle varie epoche delle flotte barbare s che non manca no ma so no frammentarie s uccint e e non d i rado co nt rastanti. Le indi caz io ni sull'entità delle fl otte c i attesta no. sem pre l a diversa imp o rt anza propo rzio nalme nte avuta dalle tre Reggenze nello svil u ppo della g uerra corsara: Algeri eb be un netto prim ato e Tunisi a sua vo lt a, soprava nz ò Tripoli A lge ri a quanto r isulta disponeva di 60 legni corsari già nel 1530; nel 157 1 la flotta a lgerina con tava una cinq uant in a di unila fra gale re, galeotte e brigantini nel 1634 il numero era salito ad oltre 80 " .
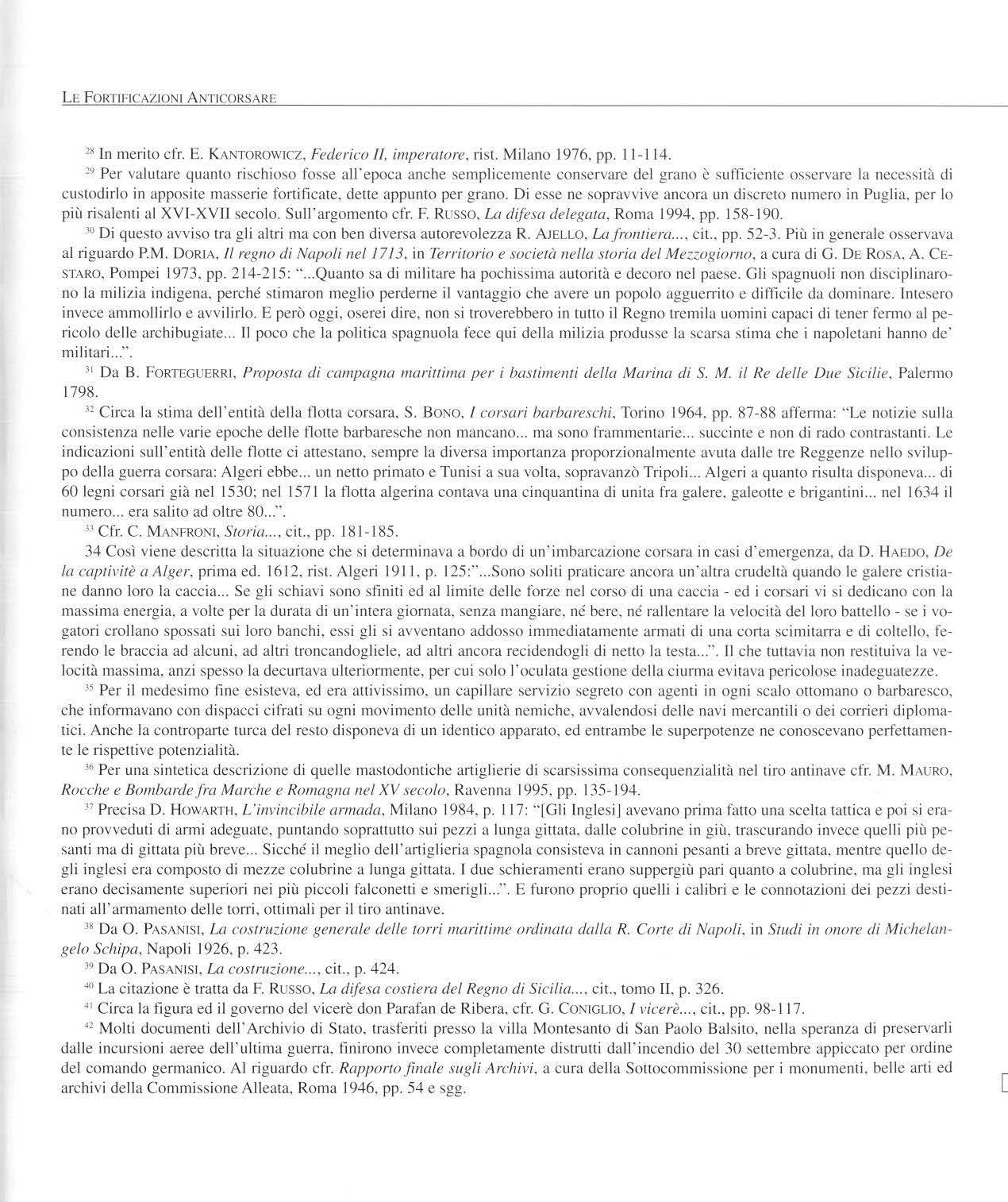
.n Cfr. C. M ANFRON I, S1oria , ci t. , pp. 181-185.
34 Così vie ne descrit ta la s ituazione che si d e t erminava a bordo di un ' imbarc azione co rs ara in casi d'e m e rgenza, da D. HA EDO, De la cap ti vitè a Alger, prima ed. 1612, ri s t. Algeri 1911, p 125:" Sono so liti pratica re ancora un'altra c rude ltà quando le ga le re c ri stiane danno loro la caccia ... Se gli sc hiavi so no s finiti ed a l limit e delle forze nel co rso di una cacc ia - ed i corsari vi si dedicano con l a massima energia, a volte per la durata di un'intera giorna t a, senza mangiare, né bere, né rall e ntare la ve locità de l loro batte ll o - se i vogatori crollano spossat i s ui loro banchi, essi g li si avven tano a dd osso imm ediatame nte a rm ati di una corta sci mi tarra e d i coltello, ferendo le braccia ad a lcuni , a d a ltri troncandogliele, a d a ltri a ncora rec idendogli di ne tto la testa " Il c he tuttavia non restituiva la velocità massima, anzi spesso l a decurtava ulteriormente, per c ui solo l' oc ul a ta gestio ne della c iurma ev itava pericolo se inadeguatezze.
35 Per il medes i mo fine es isteva, e d era au i viss imo. un cap illare se r viz io seg r e to co n age nti in ogni sca lo ottomano o barba resco, c h e i nfo rma vano co n di spacci c ifr ati s u og ni movimen t o de ll e unit à nemiche , avvale ndo s i delle navi mercantili o dei corrier i dip lo mati c i Anc he la co ntropa rte turca de l res to disponeva di un identico apparato. ed e ntrambe le s uperpotenze ne conosceva no perfettame nte le 1ispe t1i ve potenzialità.
3 ~ Pe r una s intet ica desc1i z io ne d i quelle ma~todontich e artig li e ri e d i scarsissi ma con sequ enzialit à nel ti ro antinave cfr. M M AU RO , Ro cch e e Bom harde fra Marche e Rom agna nel XV secolo, Rav en na 1995. pp . 135-194.
• 17 Preci sa D. HowA RTII L 'invin cib ile armada, Milano 1984. p I I 7: ''(G li lngl esi J avevano prima fa tto una sce l ta tattica e poi si erano provved uti di a nni adeguate, puntando so prattutto s ui pezzi a lun ga gittata. d alle colubrine in g iù. trascurando in vece quelli più pes anti ma di g i ttata più breve Sicché il me g lio d e ll 'a rti g li er ia spag nol a co nsisteva in canno ni pesanti a breve g itt ata, mentre quello deg li in g les i era composto d i mezze colubrine a lun ga g ittata I due sc hi era m e nti era no sup perg iù pari quanto a colu brin e. ma g li ing les i e rano decisamente super io ri ne i più picco li falconett i e s mer ig li ". E furono proprio quelli i calibri e le con no t azion i dei pezzi des tinati a ll ' armame nto delle torri , ottima li per il tiro a ntin ave
3 8 Da O. PA SANISI, La cos tru z ion e generale delle 1o rri mari/lime ordinata dalla R. Corte di Napoli, in S1udi in onore di Mi ch elangelo Schipa, Na poli 1926, p. 42 3.
39 Da O. PAS AN ISI, La cos 1ru zione , cit., p. 424
40 La citaz ione è tratta da F. Russo La difesa cos1iera de l R eg no di Sici lia cit., tomo II, p. 326.
41 Circa la figura e d il governo de l vicerè don Para fan de Ribera. cfr. G. CO NIGLIO, 1 vicerè , c ii. , pp 98- 1 17.
4 2 Molti doc ument.i dell 'Archivi o di Stato, trasferiti pre sso la vi lla Montesanto di San Pa o lo Ba ls it o, ne lla speranza di preservarli dalle incur sio ni aeree de ll ' ultima g uerra, finirono invece com pletam e nt e distrutti d all'incend i o d e l 30 sc lle mbre appiccato per ord in e del co mando ge rmanico. Al riguardo cfr. Rapporw finale sugl i Archivi, a cura della Sottocommissione per i monumenti, be lle arti ed archivi della Commissione Allea ta, R oma 1946, pp. 5 4 e sgg.
J J Cfr. S. FERRARO. La distruzione di Sorrento ad opera dei Turchi, in Rassegna del centro di Cultura e Storia Amalfitana. anno JT 1984 , n° 4. p. 67.
44 A.G.S. , E. 1051, f. 78 - Vicerè di Napoli a Marcantonio Colonna, Napoli 9 maggio 1561.
45 La c itazion e è tratta da F. BRAUDEL, Civiltà e imperi... , cit., voi. II, p. 1062.
46 La citazione è tratta da F. BRA UDEL, Civiltà e imperi , cit., voi II, p. 1081.
4 7 L'episodio è narrato da R. COSTO, Compendio dell ' istoria del Regno di Napoli, Venezia 1613, ed è riproposto da A. V ENTURA , Il Regno di Napoli di Pirir Reis, Lecce 1990, nota 11.
48 In me1ito cfr. F. STRAZZU LLO, Architetti e ingegneri napoletani dal '500 al '700, Napoli 1969, p. 200. In dettaglio stando ad una relazione dell'ing. Gisolfo Orazio, compilata nel 1623: " l'officio del/'lngegnero delle Torri del Regno non fu istituito dal principio di dette rorri. ma dal governo del S. r Conte di Lemos il quale considerando li disordini rappresentati da chi si fusse, che ogni giorno suc cedea110 n ella costru z ion e di detle torri vi istituì l' ingegnero appartato ".
49 Circa la fornitura delle artiglie1ie per le torri, l'ordine è riportato in un preciso documento custodito nell'A.S.N. Col!alerale Curiae, voi. XXTT , f. 64 , datato 1569 Si tratta però de ll a riproposizione di altri ordini analoghi di alcuni anni prima in particolare del '66, a sua vo lta cu s todito nel!' A.S.N., Diversi della R. C. Sommaria, voi. 192, ff. 60-61, 1566.
50 La interdipendenza dimensionale fra calibro e piazza, è desumibile da un esplicito ordine del 1636, in cui si notifica: " al monitioniero del Ca stello nuovo de Napoli, [che/ consegni al /JrO C re legittimo di dette torri due pe zz i. Le due torri nominale l'una Domine/la et l 'altra de Capogrosso floc. Casalicchio - Porto S. Matteo/ cioè a Dominella che è de palmi 40 de larghe u.a un falcone et alla de Capogros so de palmi 46 un me z zo sagra con la solita monitione per guardia di dette torri. " - A.S.N., Tesoreria Antica, Contabilità Ca s sa Militare , 359-366, pp 21-22.
5 1 A.S.N , Fondo torri e Castelli, voi. 115 , fol. 60-63.
52 Cfr. F. Russo , La difesa costiera dello Stato Pontificio , cit.. pp. 222-231.
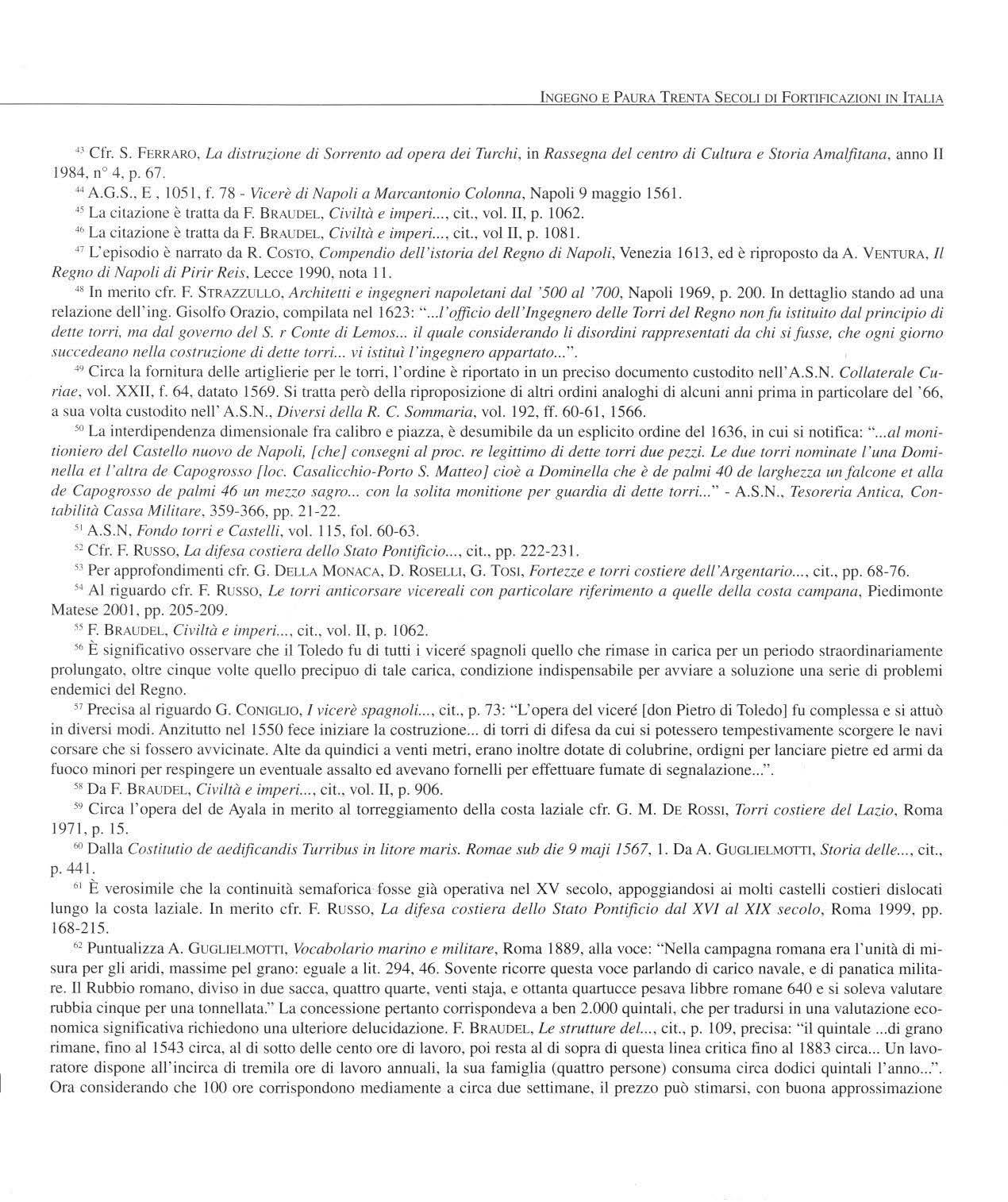
53 Per approfondimenti cfr. G. DELLA MO NACA, D. RoSE LLI, G. Tosi, Forte zz e e torri costiere dell 'A,gentario , cit., pp. 68-76. -~ Al riguardo cfr. F. Rus s o. l e torri anticorsare vi ce reali con particolare riferimento a quelle della costa campana, Piedimonte Matese 2001. pp. 205-209.
15 F. BR AUD EL. Civiltà e imperi , cit., voi. il, p. 1062.
I'> È significativo os servare che il Toledo fu di tutti i viceré spagnoli quello che rimase in carica per un periodo straord inariamente pro lungato, oltre cinque volte quello precipuo di tale carica, condizione indispensabile per avviare a soluzione una serie di problemi endemici del Regno.
57 Precisa al riguardo G. CONIGLIO,/ vicerè spagnoli. , cit., p. 73: "L' opera del viceré [don Pietro di To ledol fu complessa e si attuò in diversi modi. Anzitutto nel 1550 fece iniziare la costruzione ... di torri di difesa da cui si potessero tempestivamente scorgere le navi cors are che s i fossero avvicinate. Alte da quindici a venti metri, erano inoltre dotate di colubrine, ord igni per lanciare pietre ed anni da fuoco minori per respingere un eventuale assalto ed avevano fornelli per effettuare fumate di segna lazione ...".
58 Da F. BRAUD EL, Civiltà e imperi , cit., voi. li, p 906.
59 Circa l'opera del de Ayala in merito al torreggiamento della costa laziale cfr. G. M. DE Ross i, Torri costiere del La zio, Roma 1971, p. 15.
60 Dalla Cos tilutio de aedificandis Turribus in litore mari.i· Romae sub die 9 maji i 567, 1. Da A. GUGLIELMOTII, Storia delle , cit., p. 441.
6 1 È verosimile che la continuità semafo1ica fosse già operat iva nel XV secolo, appoggiandos i ai molti castelli costieri dis locati lungo la costa laziale. In merito cfr. F. Russo, La difesa costiera dello Stato Pontificio dal XV I al X IX secolo, Roma 1999, pp. 168-215.
62 Puntualizza A. GUGLIELMOTII, Vocabolario marino e militare, Ro ma 1889, alla voce: "Nella campagna romana era l'unità di misura per gli aridi, mass ime pe l grano: eguale a lit. 294, 46. Soven te ricorre q uesta voce parl ando di carico navale, e di panatica militare. li Rubbio romano , diviso in due sacca, quattro quarte, venti staja, e ottanta quartucce pesava libbre romane 640 e si so leva valutare rubbia cinque per una tonnellata " La concessione pertanto corrispondeva a ben 2.000 quinta li, che per tradursi in una valu tazione economica significativa richiedono una ulteriore delucidazione. F. BRAUDEL , le strutture del..., cit., p. 109, precisa: "il quintale di grano rimane, fino al 1543 circa, a l di sotto delle cento ore di lavoro, po i resta al di sopra di questa linea critica fino al 1883 circa. .. Un lavoratore dispone al l'incirca di tremila ore di lavoro annuali , la sua famiglia (quattro persone) consuma circa dodici qu intal i l'anno ". Ora considerando che 100 ore corrispondono mediamente a circa due settimane, il prezzo può stimarsi, con buona approssimaz ione
L'JGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFI CAZIONI IN ITALIApari quasi ad uno scudo al quintale, per cui, considerando il guadagno sull'esportazione pari almeno al 50%, la concessione implicava un utile di almeno 1.000 scudi, cifra che copriva tranquillamente il costo della torre stessa!
6 1 Da A. GUGLIELMOTII, Storia dellefort(fi.cazioni , cit., pp. 476-478.
64 A. GUGLIELMOTII, Storia delle.fortificazioni. .. , cit. p. 446.
65 Sull'isola di I schia di fronte al Castello Aragonese si erge una sol itaria torre: non appartiene architettonicamente alla tipologia delle torri costiere vicerea li napoletane, ma curiosamente a quella dello Stato Pontificio. Secondo la tradizione, abitando Vittoria Colonna dopo il suo matrimonio (1509) con il marchese di Pescara Ferrante d' Avalos nel castello, la torre sarebbe stata fatta costruire - o soltanto abitata - dallo stesso Michelangelo per poter così stare saltuariame nte vicino alla donna a cui era legato da una profonda intesa spirituale. Al di là del legame, storicamen te indi scutibile, nu ll a però semb ra confermare la tradizione ad eccezione della singolarità architettonica della torre.
66 Da G.M. DE Rossr, Torri , cit.. p. 82.
6 7 Idem.
6 ij ldem.
69 Idem.
10 Da A. GUGLIELMOTTI, Storia delle.fortifica zioni , c il., p. 445.
7 1 C. PEROGALLI, Castelli e rocche di Emilia e Romagna, Novara 1981, p. 158.
72 In merito a Torre Aslllra cfr. G.M. DE Rossi. Le torri costiere , cit., pp. 76 -81.
73 Sulla fine di Corradino a piazza Me rcato a Napoli cfr. E. KANTOROwrcz, Federico Il... , cit., pp . 675 -677.
1 • In realtà nemmeno la defin iz ion e territoriale dei Presidi negli anni successivi al 1557 sembra risultare acquisita ed indiscussa. In data 9 settemb re 1564 un dispaccio indirizzato al v ice ré di Napoli, competente dei Presidi, ricordava: "Tambien nos ha informado de/o mucho que importa acabarse de declairar la d[fferençia que hay sobre lo delos confines entre aque/las mis tierras y las del Duque de florençia porque se escusen las contençiones que cada dia suelen naçer sobra elio, y porque esto nos pareçe que conviene assi os encargamos y mandamos que hagais que no se alçe la mans del que sobre eslo se /rara hasta que este acabado de concertar y asentar del todo(que en ello me hareys mucho plaser y serviçio) yen avisarme de/o que en elio se habiere hecho porque holgace de antendello De Madrid a 9 de setiembre 1564 "A. G. S. E 1053, f. 158
75 Il brano citato è di Giucurta Tommasi, Historia di Siena, II, pp. 260-5, ed è tratto da G. DELLA MONACA, D. ROSELLI, G. Tosr, La torre , c it., p. 32.
76 TI documento citato è custodito presso I' A.S.S., li Ca/effetto, c. 6 I, ed è tratto da G. DELLA MONACA, D. ROSELLI, G. Tosr, La torre , cit., p. 34.
77 G. DELLA MONACA, D. RosELLI, G. Tosi, Fortezze e 1orri costiere dell'Argentario , ci t. , pp. 20 -1. Il documento è custod ito nel1 ' Archivio di Stato di Piomb ino, Piombino, n. 0 14, c. 41 B.
78 Il documento citato è cus todito presso I' ASS, Consiglio Generale, voi. 225, c. l 74t, ed è tratto da G. DELLA MONACA, D. ROSELLI, G. Tosi, La torre dei misteri: l'Argentiera, Grosseto 1995 , p. 36.
79 Non si trattava di una sostanziale novità in quanto l'iniziati va privata nell'ambito della d ifesa vantava a ll'epoca già una lun ghissima tradizione. Sull'argomento cfr. F. Russo, La difesa delegata , c it., pp . 239-45.
8°Circa l'enti tà del 'braccio ' precisa A. GUGLIELMOTII, Vocabolario marino... , c it., alla voce:" 'Mis ura di tre pa lmi'. Unità di misura lineare, uguale in lunghezza al braccio di un uomo Due brac cia fio rentine facevano un passetto; quattro una canna, e c iascun braccio antico de l seco lo XV era uguale a m. 0.5833 ." Pertanto la torre in questione misurava m 23. 2 di a ltezza e m 7 d i larghezza, a lq uanto più s nella quindi delle s uccess ive di epoca rinasc imentale.
8 1 La c itaz ione è tratta da G. DELLA MON ACA, D. ROSELLI, G. To s i, Fortezze ... , cit., p. 20, ed è contenuta in un documento custodito presso I' A.S.S., Capitoli, Cale_ffetto, c. 132 B-1 37 B.

82 La lettera citata è tratta da I. B1A GG1oss r, Le torri costiere della Toscana, Roma 1988, p . 222: manca però il riferimento archivistico. Vi è da aggiungere che quell'estate fu caratterizzata da un v iole nti ss imo mo ltiplicars i delle incursioni barbaresche rese particolarmen te audaci da l di sastro accaduto a ll a flotta confederata cris tiana , nella q ua le si trovavano pure due galere di Fire nze, nel maggio alle Gerbe. Al ri g uardo cfr. F. R usso, La difesa costiera dello Stato Pont(fi.cio dal XV I al XIX secolo, Roma 1998, pp. 134-1 49.
83 A.G.S, E I060. f. 126.
84 È in teressan te osse rva re c he re lati vamente a q uesto per iodo le assicuraz ioni marittime per navigli operanti in zona mostrano un se ns ibile 1ia lzo in st retta corre lazione co n il ri sc hi o co rsa ro. G. G 1ACCHERO, Storia delle assicurazioni marillime , Genova 1984. pp.
lNGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORT!F1CAZI0NI IN ITALIA94-5. precisa che in: ·' linea genera le può dirsi che la sensazione di rischio maggiore 1ispetto anche ad un recente passato stimola il ria lzo dei tassi di copertura... Per la navigazione interna dell'Adriatico da Ancona a Ragusa erano praticati tassi minimi del 2 per cento ossia quasi due terzi in meno del tragitto Livorno-Roma, ma per Barletta- Valona, siccome le rouc si avvicinavano all'area musulmana, il premio risaliva al 7 . Messina-Livorno al 5 e Livorno -Marsiglia al 4 inducono a pensare che nel primo caso tutto il percorso fosse aperto all'aggressione dei barbareschi, mentre nel secondo. sia per il facile ricovero nelle insenature sia per la zona neutra non appena si e ,mava nelle acque francesi, il premio poteva assumere una minore gravosità. Ancora conviene mettere nel conto che le navigazioni Porto Ercole -Londra e Candia-Tamigi entrambe al 13 per cento. Erano possibili per la fiducia che gli assicuratori riponevano nelle risorse difensive dei vascell i nordici, per il cui abbordaggio gli algerini - i più arditi ed intraprendenti fra i barbareschi ed anche gli autori de lle più sperico late imprese - dovevano mettere ne l conto un cos to di uomini e di navi che rendeva problematica l'impresa ".
85 Cfr. 1. FABRO NI. Album di ricordi di viaggi e di naviga-:,io11i sulle galere toscane dall'anno 1664 all'anno 1687, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Co/le zione Rossi -Cassigo li , Mss. 199.
Rii Da G. DELLA MO NACA, D. Ros ELu, G. Tosi, Torre Ciana, Grosseto 1996, pp. 6-8.
x7 A.G.S., Es/(/do 1069, f. 123-24.
Rx A.G.S., Estado 1479, f. 20-25.
x9 A.G.S., Estado l 053, f. I58.
0 li brano è tratto dall'Archivio Giucciarclini di Firenze. Mis ce llanea, li, Rela z ioni diverse n° 4, ed è citato da G. DELLA MO NACA, D. Ros ELLI, G. Tosi, La torre , cit.. p. 39
9 1 li conte Gabrio Serbel loni (1508 - 15 80) o ltre ad essere un cap it ano milanese fu anche un valente ingegnere militare e la doppia qualifica ne rendeva più credibile il parere. Come cava li ere di Malta combatté nel 1543 contro Solimano quando invase l'Ungheria. Quindi al serviz io di papa Pio lV fortificò la città Leonina in Roma. ed ancora so tto Fi li ppo Il, fortificò varie città del Regno di Napoli. Combatté a Lepanto e difese Tunisi. dove fu fatto prigioniero dai turchi e r il asciato a Costantinopoli, dove venne deportato, mediante riscatto. Combatlé ancora al se rvizio della Spagna nelle gue rre di Fiandra fino a l 1578.
92 In particolare il duca di Terranova, ricchissimo reudatario sic ili ano as s urto al rango di viceré ad interim del regno di Sicilia sol lecitò il parere del Serbelloni circa la fortificazione di Palermo, di Termini Tmerese e di Milazzo. ln merito cfr. F. Russo, La difesa costiera del regno di Sicilia , cit., tomo I, pp. 160-1.
9 A.G.S., Estado 1065, f. 39
94 In mer ito cfr. F. Russo, La difesa costiera dei Reali Presidi di To scana dal XVI al XIX secolo, Roma 2002, pp. 189-200.
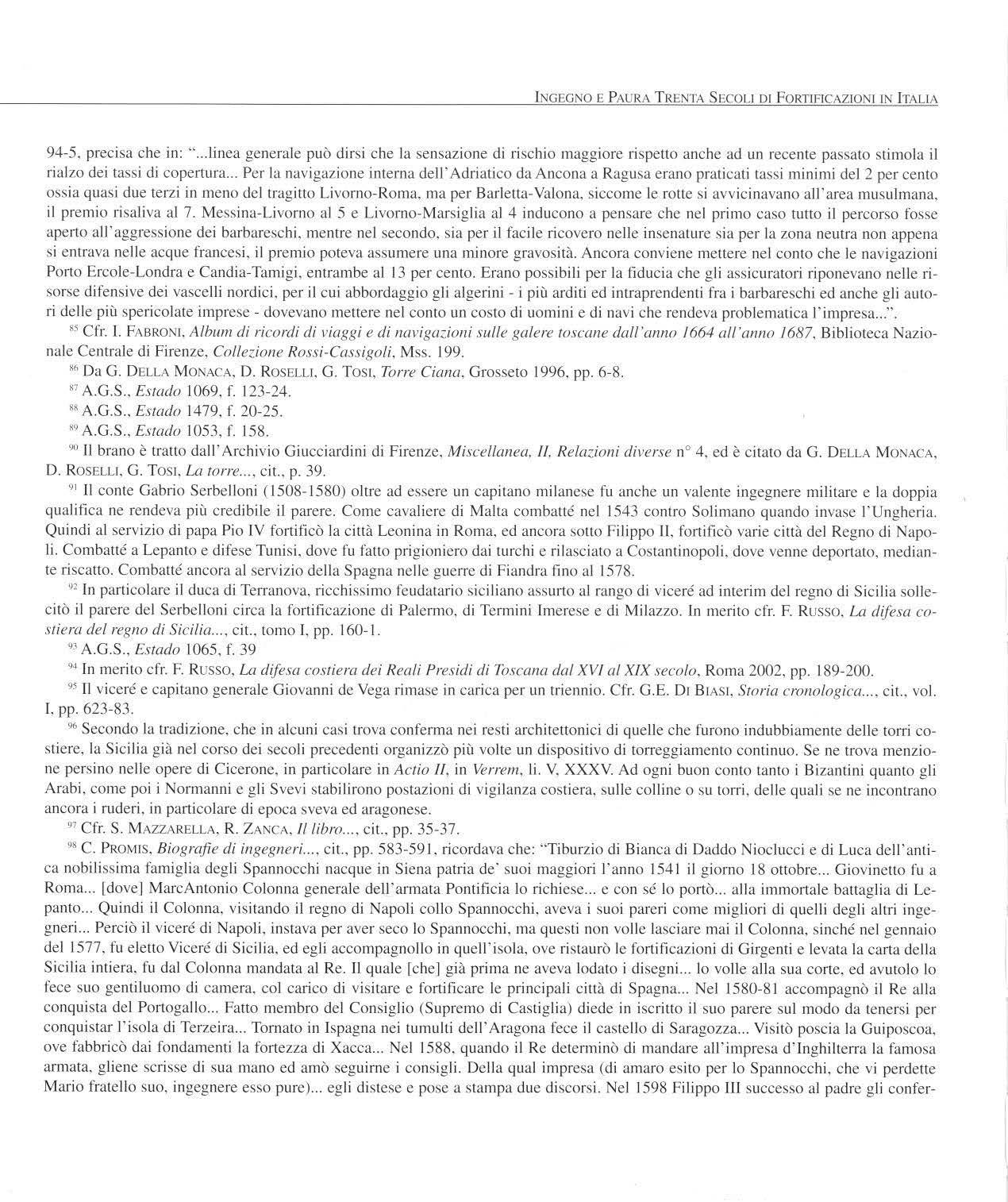
95 Il viceré e capitano generale Giovanni dc Vega rimase in carica per un triennio. Cfr. O.E. Dr B1As1, Storia cronologica .... cit.. voi. L pp. 623-83.
96 Secondo la tradizione, che in alcuni casi trova conferma nei resti architettonici di quelle che furono indubbi amente delle torri cos ti e re, la Sicilia già nel corso dei seco li precedenti organizzò più volte un dispositivo di torreggiamento co ntinu o. Se ne u·ova menzione persino nelle opere cli Cicerone, in particolare in Actio Il, in Verrem , li. V, XXXV. Ad ogni buon conto tanto i Bizantini quanto gli Arabi, come poi i Normanni e g li Svev i stabilirono postazioni di vigilanza cos tiera, sulle colline o su torri. delle quali se ne incontrano anco ra i ruderi, in particolare di epoca sveva ed aragonese.
97 Cfr. S. M AZZA RELLA, R. ZANCA , Il libro , cit., pp. 35 -37.
98 C. PROMIS , Biografie di ingegneri ... , cit.. pp. 583 -59 L ricordava che: 'Tiburzio di Bianca di Daddo Nioclucci e di Lu ca dell'antica nobili ss ima famiglia degli Spannocchi nacque in Siena patria de' suoi maggio1i l'anno 15 41 il giorno 18 ottobre Giovinctlo fu a Roma .. . ldove] MarcAntonio Colonna genera le dell'arma ta Pont ificia lo richiese ... e con sé lo portò .. . alla immortale battaglia di Lepanto Quindi il Colonna, v is itando il regno di Napoli collo Spannocchi, aveva i suoi pareri come migliori di quelli degli altri ingegneri ... Perciò il viceré d i Napoli. instava per aver secolo Spannocchi. ma quest i non volle lasc iare mai il Colonna, sinché ne l ge nnaio del 1577. fu ele tto Viceré di Sicilia. ed eg li accompagnollo in quell ' isola, ove ,is taurò le fo rtificazioni di Girgenti e levata la ca rta del la S ici li a intiera, fu da l Colo nn a mandata al Re. Il quale fche l g ià prima ne aveva lodato i disegn i lo volle alla sua corte, cd avutolo lo fece suo gentiluomo di camera, col carico di visitare e fortificare le principali città di Spagna... Ne l 1580-81 accompagnò il Re a ll a conquista del Portogallo Fatto membro del Consiglio (S upremo di Castiglia) diede in iscritto il suo parere su l modo da tenersi per conquistar l'i so la di Terzeira Tornato in Ispagna nei tumulti dcl i' Aragona fece il castello di Saragozza Visitò poscia la Guiposcoa, ove fabbricò dai fondamenti la fortezza di Xacca... Ne l 1588, quando il Re detem1inò di mandare all'impresa d'Inghilterra la famosa armata, g liene sc ri sse di sua mano ed amò seg uirn e i cons igl i De ll a guai imp resa (di a maro esito per lo Spannocchi, c he vi perdette Mario frate ll o suo, in gegnere esso pure) ... egli d istese e pose a stampa due d iscorsi. Ne l I 598 Filippo Ill successo a l padre g li confer-
mò il posto di Sop1intendente delle fortificazioni d i tutti i suoi regni, volendolo subordinalo so lamente al Re ed al Supremo Consiglio il 4 novembre de l 1606, egli venne a morte in Mad,id in età di 65 ann i ".
99 TI ms dello Spannocchi sulla S ici l ia , c he stando sempre al la biografia del Promis il Re: " talmente se ne d il ettava che, fissati [ i d isegni] con bu ll etti ne d'o ro. pe r aver li sempre sott'occhio, teneva l i nella sua piC, segreta galleria " , è ancora cust0d i to nella Bib l ioteca de l Palazzo Reale.
100 Per avere un mig lior dato di valutaz ione c i rca l 'en t ità della spesa della vigilanza cost iera pass iva, non astrallamente in assoluto, ma concretam ente in relaz ione al b il ancio de ll o Stato. bisogna ricordar e che su d i un reddito annuo. p revisto di c irca 600.000 ducati quell'esbo rso ne rappresentava il 4%.
10 1 TI Cam il lian i era gi u nto in Sic i lia nel 1574 per montare a Palermo la fontana d i piazza P retoria opera di suo padre e dello scu l tore Naccherin i. Le sue refere n ze per sost i tu i re lo Spannocchi dovevano tuttav i a esse r e adeguale, tanto p iù che non può escludersi per la sovrapposiz ione de lle date un suo in contro con i l pi L1 ce leb re collega e conterraneo. Del resto non è se r iamente credibile il suo avv icenda mento se n za il be neplac i to de l p r imo non fosse al t ro come gara nt e.
102 Ne l q u indicesimo secolo s u lla falsariga de lle isti tuz ioni aragonesi anche in Sicilia il par lamento f u diviso in tre bracci, o camere, che dovevano riunirsi per vaglia re separata m ente le proposte de l vice ré. La votazio ne pe rò era pubblica. De i tre bracc i i l p1imo era quello ecclesiastico. dei vescov i e degl i abati; seguiva q u ind i que llo militare o de l baronato, formato da i princ ipali feudatari del Regno, obbligati alla prestaz ione de l 'serv iz io m i litare'; u ltimo i l terzo. cos ti tu ito da i rapp resentanti delle c ittà direttamente soggette al re e l ibe re da v i ncoli feudal i . Per ulter ior i approfond ime n ti cfr. D. MACK SM ITH, Storia delle Sicilia medievale e modema, Bari 197 1, pp. 156-166
101 Parl amento L1 V, 9 apri le 1579. in A . MoNGITORE. Parlamenti generali, Pa lermo 1749, voi. I, pp. 390-39 1.
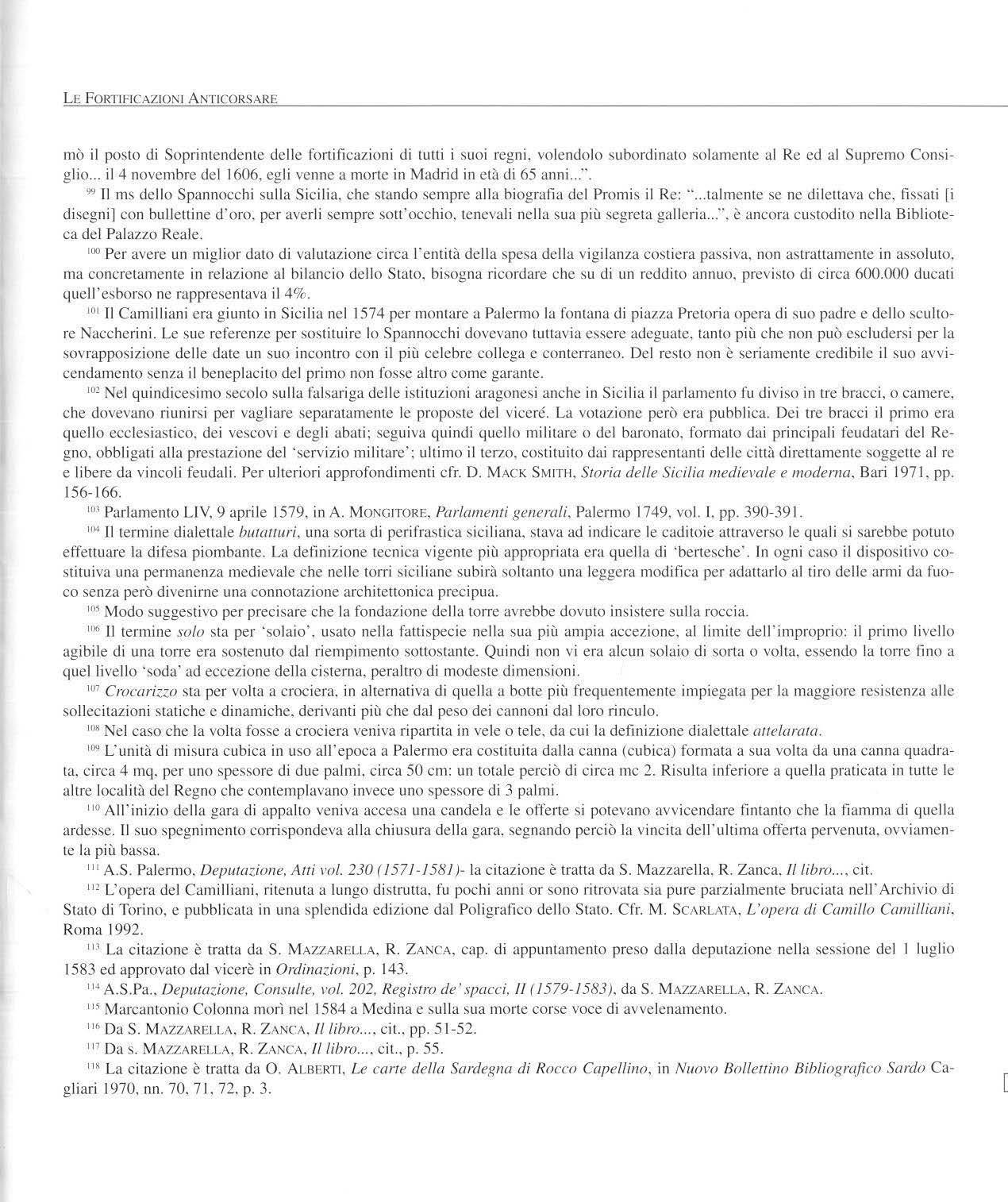
i ().I li termine dia lettale buratturi. una sorta d i per ifrast ica s ic il iana. stava ad indicare le caditoie attraverso le qua l i s i sarebbe potuto effettuare la difesa piombante. La definizione tec ni ca v igente più appropr iata era que !J a di 'bertesche ' . ln ogni caso il d ispositivo costituiva una permanenza medievale che nelle torri siciliane subirà so ltanto una leggera modifica per adattarlo al tiro delle armi da fuoco senza però divenirne una connotazione architettonica precipua.
io, Modo suggestivo per precisare che la fondazione della torre avrebbe dovuto ins istere su ll a roccia.
1011 Il termine solo sta per 'solaio'. usato nella fattispecie ne ll a sua p iù ampia accezione, al limite dell'improprio: i l primo live llo ag i bi le di una torre era sostenuto dal riempimento sottostante Qu indi non v i e ra alcun solaio di sorta o vo lta , essendo la tor re fino a quel live ll o ·soda' ad eccezione de ll a cisterna, peraltro d i modes t e dimensioni.
101 Crocarizzo sta per volta a crociera, in alternativa di quella a botte più frequentemente impiegata per la maggiore res istenza a ll e so l lec i taz ioni statiche e dinamiche, derivanti più che dal peso dei cannoni dal loro rinculo.
108 Nel caso che la vo l ta fosse a crociera veniva ripartita in vele o t ele, da cui la definizione dia letta le atte/arata.
I O'l L' un it à di m is u ra cubica in uso all'epoca a Palermo era costituita da ll a canna (cubica) formata a sua volta da una canna quadrata, ci r ca 4 mq. per u no spessore di due pa l mi. circa 50 cm: un tota le perciò di circa mc 2. Risulta inferiore a quella praticata in tutte le a l t re località de l Reg no che contemplavano invece uno spessore di 3 pa l mi.
11 0 A ll ' ini zio della gara d i appa lt o ven i va accesa una candela e le offerte s i potevano avvicendare fintanto che la fiamma d i quella a rdesse. Il s uo spegn i me n to conispondeva a ll a chiusura della gara, segnando perciò la v i nci t a dell'ultima offerta pervenuta, ovv iamente la più bassa.
111 A.S. Pale rm o, Deputazione, Atti voi. 230 ( 1571-1581 ) - la citazione è tratta da S. Mazzare ll a, R. Zanca, li libro , cit.
112 L'ope r a del Camill iani, riten u ta a lu ngo distrutta, fu pochi ann i or sono ritrovata s i a pure parzia l mente brucia t a nell'Arc hi vio di Stato d i Tor in o, e p u bb li cat a in u n a sp le ndida ed iz ione d al Poligrafico d ello S t a t o. Cfr. M SCARLATA. L'opera di Camil/o Camilliani, Ro m a 1992.
113 La c i taz io ne è t ratta da S. MAZZAREL LA. R . ZANCA, cap. di appuntamento preso da ll a depu tazione nella sessione del I lug li o 1583 ed approvato da l vice rè in Ordina~ioni, p. 143
11 4 A.S.Pa., Deputazione. Consulte, voi. 202, Registro de· spacci, li (1579 -1583), da S. MAZZARELLA, R. ZA:--!CA .
11 5 Marcantonio Colon na morì nel 1584 a M ed in a e s ull a sua morte corse voce d i avvelenamen t o.
11 6 Da S . MAZZARELLA. R. ZANCA, Il Libro ... , c il., pp. 51 - 52 .
11 7 Da s MAZZARELLA, R ZANCA. !I libro ci t.. p 55.
11 x La ci t azione è t ratta da O. ALBERTI, le carte della Sardegna di R occo Capellino, in Nuovo Bolletti110 Bibliografico Sardo Cagliari 1970, nn. 70, 71. 72 p. 3 [
119 Secondo E. PILLOSU, Un indedito rapporto cinquecentesco sulla difesa costiera della Sardegna, in Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo , Cagliari 1959, n° 21, p. 7: " nel 1577 era Capitano e Castellano della città rdi Iglesias] il nobile don Francesco de Camo s e nel 1573 la stessa carica era ricoperta da don March Antoni Camos, veros imilmente figlio del precedente È da ritenere che i componenti della famiglia Camos - di piccola nobiltà - ricoprissero frequentemente cariche pubbliche di fiducia Nell'En c iclopedia Universai lllustrada Europea-Americana , p. 1183 Camos de R equenses Marco Anto ni o è menzionato quale militare, teologo, predicatore e poeta, nato a Barcellona nel I 543 e morto a Napoli nel 1606 Premesse queste notizie , risulta evidente che Marco Antonjo Camos intraprese , in qualità di governatore d'lglesias il periplo della Sardegna nel 1572, a ll ' età di 29 anni per assumere tre a n11 i dopo la carica di governatore di Alghero e comandante del Logudoro. "
120 Il p1imo a dar notizia del rinvenimento del prezioso documento giacente nell'Archivio di Simancas fu F. BRA UDEL. Civiltà ... , cit., voi. TJ , p. 907. La collocazione archivistica indicata è A.G.S., E 327.

12 1 Circa la fortezza della Goletta a Tunisi ed al ru olo svolto nella sua difesa dal Serbelloni, cfr. F. Ru sso, La forte zza de la Goletta , in Studi Storico-Militari, Roma 2001.
122 Il Cervantes trascorse cinque anni in sch i av itù ad Algeri , e di quel triste periodo ne ha lasciato alquante allusioni e desc1izioni nelle s ue opere letterarie.
12 1 A.G.S., G. M. 3694.
124 A.G.S., G. A., Leg. 104 .
125 Da A. MATTONE, Le istituzioni militari. in Storia dei Sardi ... , cit., vo i. Ili, pp. 68-69.
126 Alla foce del fiume Ebro, dove non mancavano s poradi che incursioni co rsare vi vennero edificate alcune torri , innalzandole in terra. Si trattava di un s istema molto econom ico di costruzione ma estremamente degradabile: da qui forse la precisazione dell'imperatore circa la tipologia muraria da impiegarsi lungo le coste della Sardegna, senza badare ad alcun risparmio.
127 li testo in latino della storica o rdinan za è riportato tra le citazioni nel Piano per migliorare la difesa del litorale del Regno di Sardegna, del 170, Biblioteca Reale di Torino, Ms mise. 104-8.
I criteri fondamentali dell'architettura bastionata a partire dalla metà del XVII seco l o, iniziarono a sub ire vistose e significative modifiche. L 'avv io della nuova fase evolutiva fu in buona parte una conseguenza della Guerra dei Trent'anni <1J, che d evastò l'Europa central e ed i P aesi B assi in particolare. Per nulla casuale, pertanto, che il primato in materia di fort ifi cazion i perimetrali passò d a ll ' It a li a all'Olanda , i cu i tec ni ci furono ben presto ovunque ricercati per l'acclarata competenza.
Quanto alle innovazioni c he s i imp osero e diffusero non costituivano di per sé rivoluzionarie concezioni , ma piuttosto dei gradual i amp li amenti concentrici dei ci rcuiti difensivi t ra mite una i nterminabile teoria di opere addizionali ed avanzate. R aggiungere le cortin e di c inta divenne , quindi, la conclusione del supera m e nto di una se ri e di os t acol i via v ia più co riac ei e micidiali, singo l armente presi, già impiegati da oltre un seco l o . Il c h e pur non rendendo drasticamente obso l ete l e fortificazioni già esis t enti, ne ridim e ns ionava senza eccezioni la validità e l 'efficacia persino delle più r ecent i , imponendo colossali lavori di adeg uam e nto.
Per ass urdo che po ssa sembrare i prodromi di questa e nne s ima rielaborazione dell'ingegneria mili tare non scaturirono da un improvv iso e s travol ge nt e salto tecnologico dell'artiglieria ma dalla lenti ss ima conclusione dell ' imperc etti bile perfe zio n ame nto dell 'arm a m e nto individuale <2J. Solo in un seco ndo momento pesò nella vicenda il potenziamento delle bocch e d a fuoco, ma a quel punto l 'età moderna era ormai agli sgocc ioli , spazza t a via dalle armate napoleoniche e da ll a ri voluzion e indu s tri a le (3)
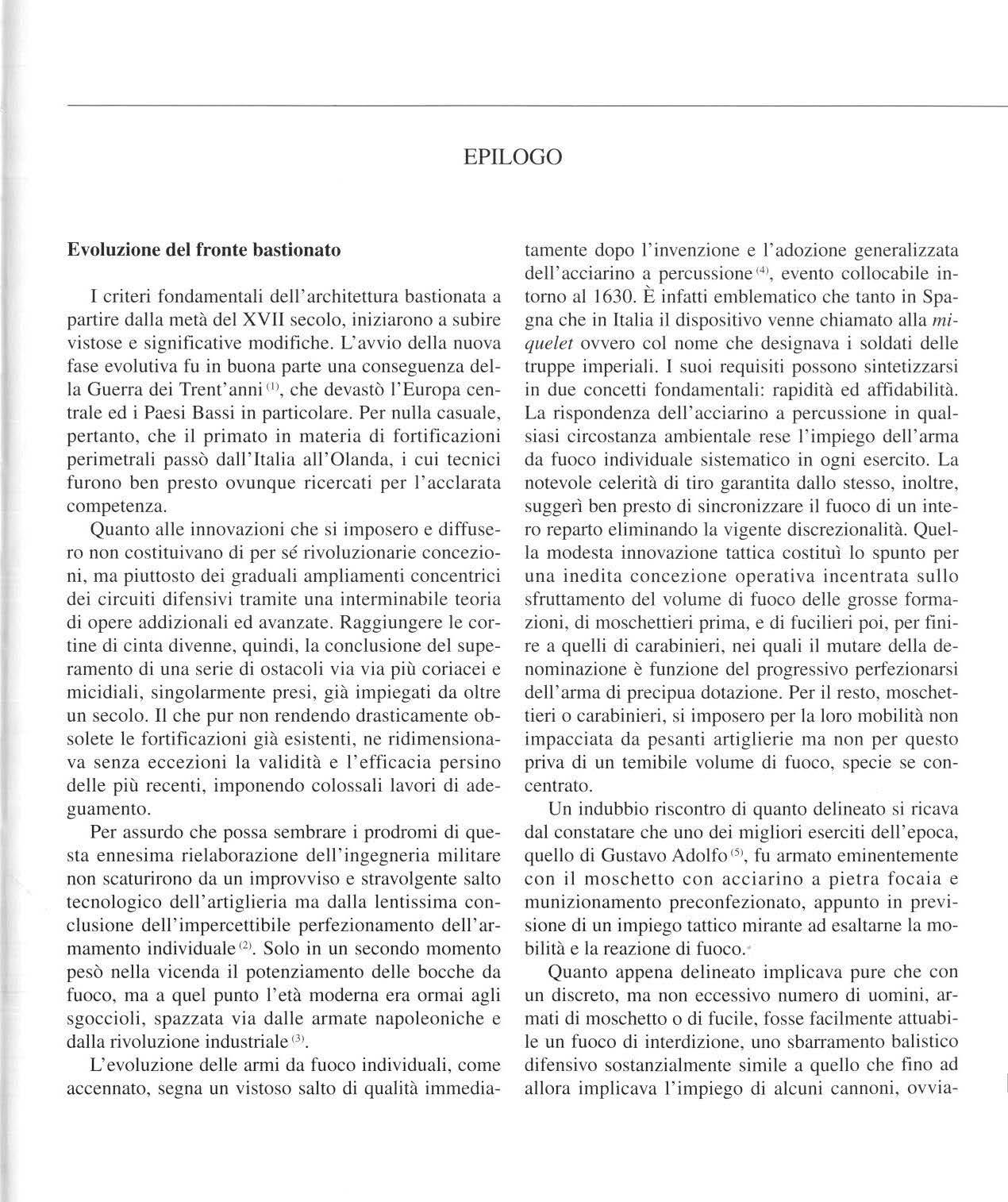
L 'evo luzion e delle armi da fuoco individu a li, come accennato, seg na un vistoso sa lto di qualità immedia-
tamente dopo l'invenzione e l'adozione generalizzata dell 'acciarino a percussione < 4 ', evento collocabile intorno al 1630. È in fatti emb l ematico che tanto in Spag na c he in It alia il di sposi tivo venne chiamato alla miquelet ovvero col nome che de s ignava i soldati delle truppe imp eriali I suoi requisiti possono sintetizzarsi in due concetti fondamentali: rapidità ed affidabilità. La rispondenza dell'acciarino a percussione in quals ias i circostanza ambienta l e rese l'impiego dell'arma da fuoco individuale sistematico in ogni eserci to. La notevole ce leri tà di tiro garantita dallo stesso, inoltre, suggerì ben presto di s in cro ni zza re il fuoco di un intero reparto eliminando la vigente discrezionalità. Quella modesta innovazione tattica costituì lo spunto per una in ed i ta concezio n e operativa incentrata s ullo s fruttamento del volume di fuoco delle grosse formazioni, di moschettieri prima, e di fucilieri poi, per finire a quelli di carabi ni eri, nei quali il mutare della denomi nazione è funzione del progressivo perfezionarsi dell'arma di precipua dotazione. Per il resto, moschettieri o carabin ieri, s i imposero per la l oro mobilità non impacciata da pesanti artiglierie ma non per que sto priva di un temibile volume di fuoco, specie se concentrato.
Un indubbio riscontro di quanto delineato si ricava dal cons ta tare c he uno dei m ig liori eserc i ti dell'epoca, quello di Gu stavo Adolfo <5l, fu ar m a to e min entemente co n il mo sc h etto con acciarino a pietra focaia e munizionamento pr eco nfez ionato, appunto in pr evis ion e di un impi ego tattico mirante ad esa ltarne la mobi lità e la reazio ne di fuoco.
Qu a n to a ppena de line ato impli cava pure che con un discreto, ma non eccess ivo numero di uomini , arm ati di moschetto o di fucile, fosse facilmente attuabile un fuoco di in te rdi z ion e, un o s barramento ba li stico difensivo sos tan z ia lm e nt e s imil e a quello che fino ad allora impl icava l'impiego di alcuni cannoni, ovvia -
ment e caricati a mitraglia. Le manovre cadenzate imposte dalle innovazioni di Maurizio di Nassau, principe d'Orange (1567-1625) non a caso scaturite anch'esse nel contesto delle guerre nei Paesi Bassi, avevano finito, infatti, per garantire alla fanteria annata di moschetto un inusitato volume di fuoco. La no v ità si spiega osservando che :" .. .i soldat i si muove vano tutti contemporaneamente e con lo stesso ritmo, erano tutti pronti a far fuoco nel medesimo istante, ottenendo una 'salva' facile e naturale il cui effetto tra le file nemiche era sconvolge nte. La cosa più importante era però che a questo punto i soldati caricavano e sparavano molto più rapidamente " <6>
Significativamente lo stesso principe aveva introdotto anche delle fortificazioni campali ottenute con grandi movimenti di ten-a, compiuti dai medesimi soldati, a simil itudin e dei leg ionari romani. Espediente tattico che si ritrova peraltro ab bondantem e nt e contemplato nell 'opera del Montecuccoli, a conferma della sua diffusione. L'abbinamento della straordi naria potenzialità ostativa del volume di fuoco provocato da una salva di fucileria e del riparo fornito alle unità di tiratori dalle masse di terra opportunamente configurate, costituì indubbiamente la premessa di un'inedita tipologia di opere difensive. In ultima analisi una fortificazione squisitamente campale mutatasi in fortificazione permanente, grazie alla sua apparente dote di estrema se mplicità
L'innovativa concezione, infatti, fu accolta favorevolme nte non solo dagli s tati maggiori ma so prattutto dalla dirigenza politica in quanto consentiva l'adozione di st rutture difensive di rapido approntamento, almeno inizialmente , quindi s icuramente meno costose e non implicanti l'immenso numero di cannoni che con il loro ragguardevole prezzo contribuivano a far levitare enormemente l'onere globale della fortificazione perimetrale. Per tradurre in pratica quelle interessa nti premesse e que ll e accattivanti promesse, superando la fase di me re linee di tend enza, occon-eva però apportare alquanti adeguamenti strut turali alle fortificazioni canoniche, nate ed elaborate, come in
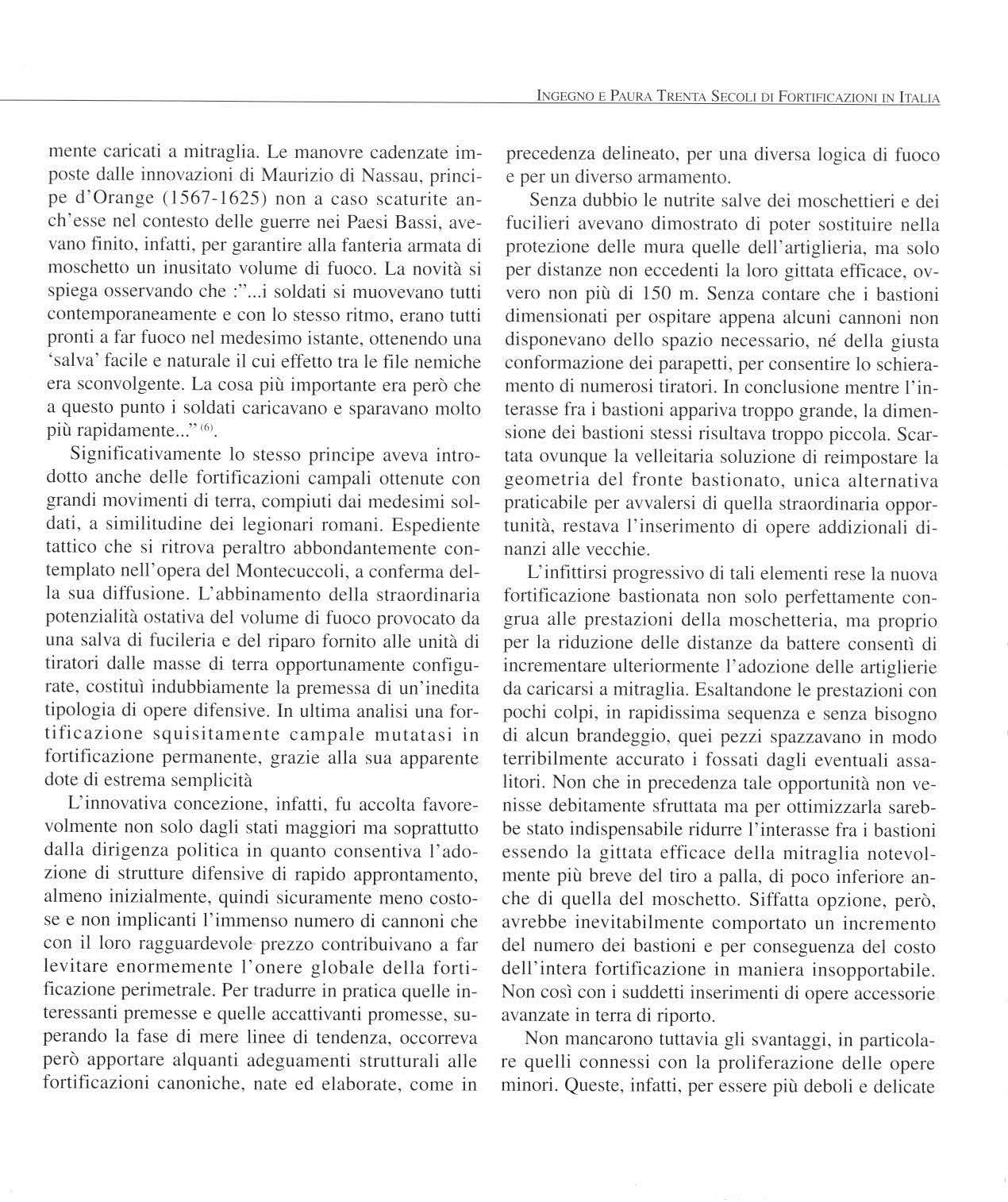
precedenza delineato, per una diversa logica di fuoco e per un diverso armamento.
Senza dubbio le nutrite salve dei moschettieri e dei fuci !ieri aveva no dimostrato di poter sost ituir e nella protezione delle mura quelle dell'artiglieria, ma solo per distanze non eccedenti la loro gittata efficace, ovvero non più di 150 m. Senza contare che i bastioni dimensionati per ospitare appena alcuni cannoni non disponevano dello spaz io necessario, né della giusta co nformazione dei parapetti, per consentire lo schieramento di numerosi tiratori. In conclusione mentre l'interasse fra i bastioni appar iva troppo grande, la dimensione dei bastioni stessi ri sultava troppo piccola. Scartata ovunque la ve ll e itaria sol uzione di reimpostare la geometria del fronte bastionato, unica alternativa praticabile per avvalersi di quella straord in aria opportunità, restava l'inserimento di opere addizionali dinanzi alle vecchie.
L ' infittirsi progressivo di tali elementi rese la nuova fortificazione bastionata non so lo perfettamente congrua alle prestazioni della moschetteria, ma proprio per la riduzione delle distanze da battere consentì di incrementare ulteriormente l'adozione delle artiglierie da caricarsi a mitraglia. Esaltandone le prestazioni con pochi colpi, in rapidissima seq uenza e senza bisogno di alcun brandegg io , quei pezzi spazzavano in modo terribilmente accurato i fossati dagli eventuali assalitori. Non che in precedenza tale opportunità non venisse debitamente sfruttata ma per ottimizzarla sarebbe sta to indispensab ile ridun-e l 'in tera sse fra i bastioni esse ndo la gittata efficace della mitraglia notevolmente più breve del tiro a palla, di poco inferiore anche di quella del mo sc hetto. Siffatta opzione, però , avrebbe inevitabilmente comportato un incremento del numero dei bastioni e per conseguenza del costo del l'intera fortificazione in maniera in sopporta bile. Non così con i suddetti inserimenti di opere accessorie avanzate in terra di riporto.
Non mancarono tuttavia gli svantagg i, in particolare quelli connessi con la proliferazione delle opere minori. Queste, infatti, per essere più deboli e delicate
INGEGNO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTIFI C AZIONI IN I TA LIAfinivano per accrescere le vulnerabilità complessiva dell'intera piazza ai pezzi nemici. Facile impadronirsene da parte degli assedianti trasformandole in ottime postazioni d'artiglieria avanzate, e per contro improbo riconquistarle da parte degli assediati. Per frustrare la temibile evenienza si finì per renderle gradatamente più resistenti, fino a renderle a ltretta nti capisaldi autonomi. Il che obbligò ad una maggiore articolazione dei movimenti della terra antistante, realizzando rilevati accortamente sagomati per cop rirn e la sagoma. La definizione complessiva essendo frutto di una decisione progettuale più o meno discrezionale e soggettiva divenne l a precipua nota distintiva delle diverse scuole europee. D i tutte quella certamente più interessante ed emblematica fu l'olandese, che influenzò persino il celeberrimo Vauban. Non potendo e non essendo inoltre significativo ai fini della ricerca, approfondire i tantissimi sistemi fortificatorii da quel momento elaboratisi (7> , neppure quello olandese in ognuna delle sue innumerevoli varianti evolutive, ci limiteremo a delineare di quest'ultimo una brevissima sintesi evidenziandone appena le peculiarità salie nti che saranno poi i canoni base della fortificazione della seconda metà del XVIII secolo.

La caratteristica sub it o evidente del sistema olandese, fu la sua straordinaria ampiezza: in esso quasi sempre la s up erficie complessiva delle difese s up erava abbo nd antemente quella difesa! Ovviamente ciò tornò attuabile in virtù dell'assoluta uniformità del terreno, priva della sia pur minima as p erità, del sia pur minimo rilievo e per giu nta con una falda freatica quasi affiorante, ideal e per allagare gli immensi fossati senza ricorrere a cana li di derivazione e c hiu se. Entrambe le caratteristiche non costituivano di per sé una eclatan te novità, ma lo divennero per le dimensioni inusitate c he consentiro no opere, prive di qualsiasi precedente. Si eressero così enormi bastioni , relat ivame nt e bassi nei fossati e grandi spalti con conseguenti eccezionali movimenti di te rra ed altrettanto consi d erevo li occupazioni di aree circostanti la piazza. Pe r garant ire un maggior volume di fuoco radente vi erano poi a ll a
base delle cortine delle cosiddette falsehraghe, ovvero una sorta di percorso protetto da palizzate e gabbioni, di altezza uguale a quella del muro di controscarpa esistente sull'altro lato del fossato: in sostanza delle antesignane trincee di notevole larghezza. Quanto alla funzione prioritaria della falsabraga consisteva nel permettere di battere il ciglio dello spalto e la strada coperta, nel malaugurato caso fossero caduti nelle mani del nemico. Quest ' ultima , infatti, era un ampio camminamento completamente defilato che si snodava quasi ai piedi del muro di controscarpa, necessaria per i movimenti dei difensori.
Volendo meglio dettagliare:" .. .il profilo della fortificazione olandese consiste in un rampale più o meno a lt o, con parapetto rivestito in terra a scarpa naturale ; a poca altezza dal pelo dell 'acqua havvi un'ampia berma con parapetto al primo che prese il nome di falsa braga ... su di essa ponevas i palizzate, steccate, cavalli di frisia e simili: col munirla poi di parapetto si ottenne una seconda linea di fuoco in rinforzo della principale.
11 tracciato poco di ssimile dall 'i taliano , fu completamente descritto da Freitag nel l 630. I bastioni sono ampi coi fianchi perpendicolari a ll a cortina; le linee di difesa del recinto principale sono, come presso gl'italiani, dirette a due punti della cortina, e quelle della falsabraga ag li a ngo li della cort ina. Al di là di un fosso pieno d'acqua largo da 30 a 40 metri havvi un piccolo rivellino senza falsabraga dinanzi alla cortina, ed una lunetta s imil e rimpetto al sagl ien te del bastione. A questa lunetta Freitag dà il nome di mezzaluna il qual nome passò in seg uito . .. a l ri vellino ampliato. Gli olandesi fecero frequente uso di opere add iz ion ali esterne, quali sono le opere a corna e le corone semplici e doppie, imitate poi dal Va uban " 18 l
Per evitare che la falsabraga da micidiale ostacolo si trasformasse in vantaggio per gli assedianti, in quanto spezzando l'altezza delle cortine ne agevolava l a sca l ata, decimando per giu nt a i difensori con le schegge provocate dagli impatti delle palle sulla sovrastante cortina battuta in breccia, si impose senza al-
ternativa l'ampliamento a dismisura dei fossati ed il loro allagamento. Solo così le batterie d'assedio non avrebbero potuto portarsi a tiro smantellando la cerchia principale e le ondate d 'assa lto non avrebbero potuto avventarsi sulla stessa. Indispensabile complemento a quel punto la strada coperta, l'unica soluzione capace di consentire alla fucileria dei difensori di sc hierarsi al di là del fossato in modo da poter battere gli attaccanti, indipendentemente dalla sua larghezza. Per scongiurare l'eventualità che il nemico collocando in un settore appena conquistato i propri cannoni con un appo s ito angolo potesse prend e rla d ' infilata mas sacrandovi schiere di soldati, la sua lunghezza fu segmentata tramite delle robuste muraglie trasve rsali, dette appunto traverse , sufficientemente solide per arrestare le palle di qualsiasi calibro.
Intorno agli anni '70 del XVII seco lo , le descritte fortificazioni del sistema olandese subirono ancora ulteriori adeguamenti per renderle capaci di sos tenere gli a sse di scientifici del Vauban. In larga s intesi consistevano nel defilare tutte le ma sse murarie alla vista diretta dal)' es terno; nel ri st rutturare i bastioni con fianchi a grande sv iluppo; nell ' i so lare i capisaldi esterni, ovvero nel compartimentare il perimetro, in maniera che la perdita di un settore non implicasse lo scadimento dell'intera piazza; nel ridurre al mass imo il terreno antistante alle opere avanzate, indi s pensabile al nemico per l'istallazione del suo parco d 'assedio.
Ques t ' ultima caratteristica significava in pratica l' occupazione massiva degli spazi disponibili o , nel caso di piazze costiere il loro isolamento tramite un ' enorme tagliata od un ordine plurimo di fossati e rivellini. In definitiva tale sistema, meglio noto come del Coehoorn, architetto militare (9> salito alla ribalta con l'invasione dell'Olanda da parte di Luigi XIV nel 1672, si può assimilare più che a un fronte bastionato di rinascimentale memoria, ad un colossale campo trincerato. Una fortificazione quindi molto articolata e rivestita di muratura, protetta anteriormente da un fosso asciutto e quindi da opere a tenaglia ed ancora da un secondo fos s ato, più esterno allagato, oltre il quale
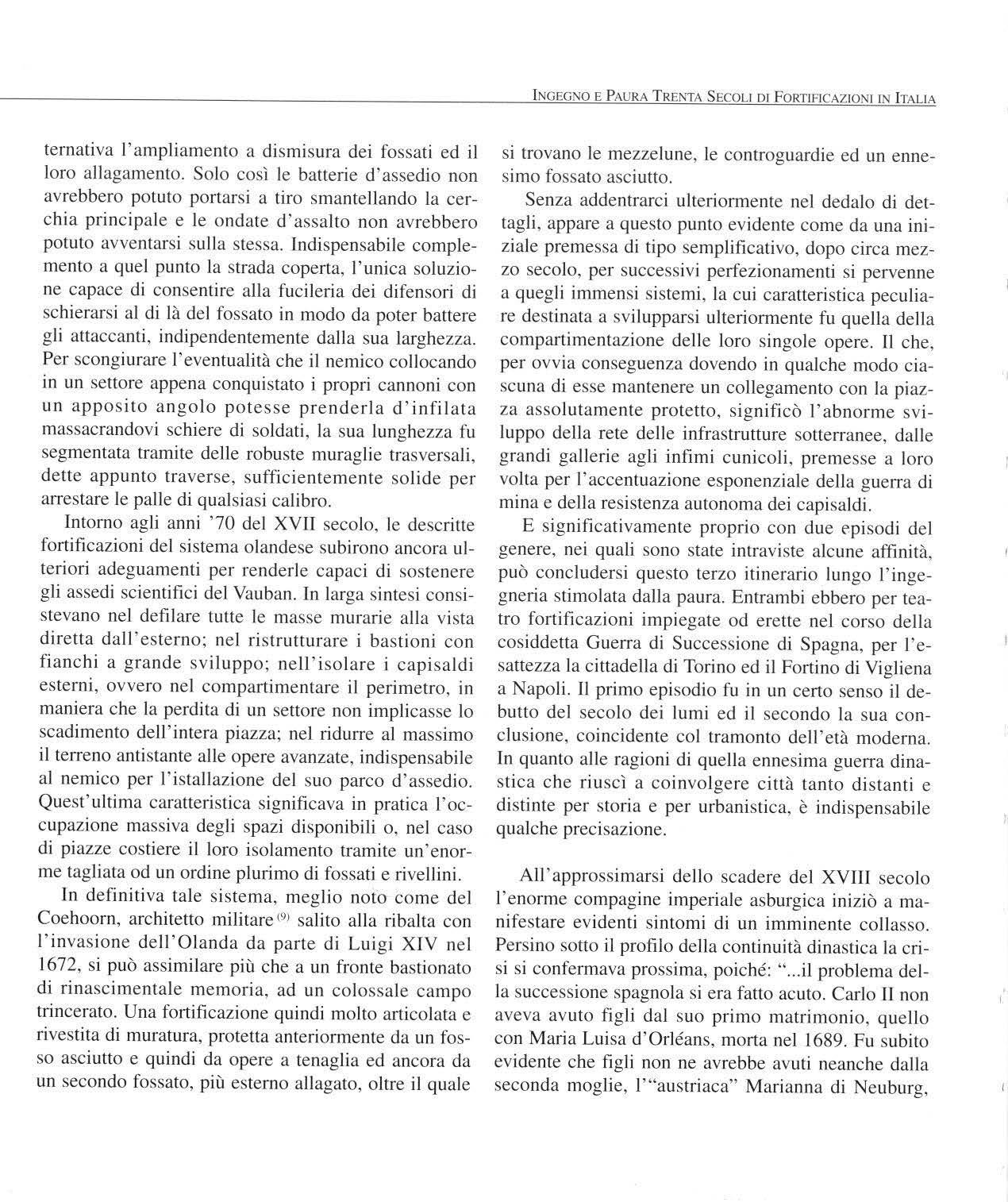 IN GEGNO E PAURA TR ENTA SECOLI DI FORTIFICAZIO NI TN I TAL IA
IN GEGNO E PAURA TR ENTA SECOLI DI FORTIFICAZIO NI TN I TAL IA
si trovano le mezzelune , le controguardie e d un ennes imo fossato asciutto.
Senza addentrarci ulteri ormente nel dedalo di dettagli, appare a ques to punto evidente come da una iniziale premes sa di t i po se mplificativo , dopo circa m ezzo seco lo , per s ucces s ivi perfezionamenti s i pervenne a quegli immens i s ist emi, la cui caratteristica peculiare de st inata a sv ilupparsi ulteriormente fu quella d e lla compartimentazione dell e loro s ingole opere. Il che, per ovvia conseguenza dovendo in qualche modo ciasc una di esse mantenere un collegamento con la piazza assolutamente protetto , significò l'abnorme sv iluppo della rete delle infra s trutture so tterranee, dalle grandi gallerie agli infimi cunicoli, premesse a loro volta per l'accentuazione esponenziale della guerra di mina e della re s istenza autonoma dei capisaldi.
E sig nificativamente proprio con du e episodi d e l genere, nei quali so no state intravi ste alcune affinità , può concludersi questo terzo itinerario lungo l ' ingeg ne ria stimolata dalla paura. Entrambi e bbero per t eatro fortificazioni impiegate od erette nel corso della cosiddetta Gueri-a di Successione di Spagna, per l 'esa ttezza la cittadella di Torino ed il Fortino di Vigliena a Napoli. Il primo episodio fu in un certo senso il debutto d e l seco lo d ei lumi e d il sec ondo la s ua conclusione, coincidente col tramonto dell ' età moderna. In quanto alle ragioni di quella ennesima guerra dinas tica che riu sc ì a coinvolgere città tanto di sta nti e di s tinte per storia e per urbanisti ca, è indi s pensabile qualche precisazione.
All ' approssimarsi dello s cadere del XVIII secolo l'enorme compagine imperiale asburgica ini z iò a manifestare evidenti sintomi di un imminente collasso. Pers ino so tto il profilo della continuità dinastica la crisi s i confermava prossima, poiché: " .il problema della s ucce ssi one s pagnola si era fatto acuto. Carlo II non aveva avuto figli dal s uo primo matrimonio , quello con Maria Luisa d'Orléans, morta nel 1689. Fu s ubito evidente che figli non ne avrebbe avuti neanche dalla seconda moglie , ! "'au s triaca " Marianna di Neuburg,
figlia del!' elettore palatino e sorella dell'imperatrice. Via via che svanivano le speranze che il re spagnolo avesse un erede, le potenze europee si impegnavano in intricate manovre per mettere le mani sul retaggio della Corona spagnola. Le seconde nozze di Carlo 11 avevano indotto Luigi XIV a dichiarare ancora una volta guerra alla Spagna..." (J OJ _
Le ostilità, tuttavia, si conclusero nel 1697 con il Trattato di Ryswick e nella circostanza il Re di Francia si dimostrò ast ut amente generoso, cercando di conseguire diplomaticamente ciò che militarn,ente appariva più difficile: insediare sul trono spagnolo un esponente della casa di Borbone. Il 1° novembre del 1700, l'ultimo e derelitto sovrano della monarchia asburgica spagnola, Carlo 11, morì.
Non si trattò di un evento improvviso e meno che mai imprevisto: da anni, infatti, le condizioni fisiche e mentali del re lo avevano preannunciato. Da mesi, poi: "intorno al morituro Carlo II ... [si tesseva] una fitta rete di intrighi a servizio dei Borboni di Francia o degli Asburgo d'Austria gli uni e gli altri bramosi di carpirne, a dispetto dei principi di equilibrio europeo banditi solennemente nelle paci di Westfalia la pingue eredità del ramo spagnolo degli Asburgo " (11 > Il disgustoso mercanteggiare pervenne a livelli tali che lo stesso Carlo, in un estremo sussulto di dignità, temendo lo smembramento dell'Impero, prescelse a succedergli il principe Giuseppe Ferdinando di Baviera, un bambino di appena sette anni, figlio dell'Elettore di Ba viera. La prematura scomparsa, questa sì improv visa ed imprevista, dell'erede designato nel 1699 riacutizzò la questione ed incrementò le trame europee. Nel maggio successivo, prossimo a lla fine, Carlo II nelle dispos i z ioni testamentarie nomin ò il duca Filippo d' Angiò, secondogenito del Delfino, e quindi nipote di Luigi XIV, suo s ucc essore, sperando c he la scelta costituisse il minore dei mali per l'Impero e per i sudditi. Nell'aprile del 1701 il nuovo Re, designato come Filippo V di Borbone, di soli 17 anni, fece la sua solenne comparsa in Madrid, ben accolto dalla popolazione. Ma, in breve, gli eventi van ifi carono l a spe ranza
del defunto sovrano concretizzandone, invece, il timore: la Guerra di Successione Spagnola, che si sarebbe protratta per ben 11 anni, scoppiò nel 1702, e vide contrapposte le forze franco-ispaniche a quelle austro-britanniche.
Quando il de Grunemberg progettò la cittadella pentagonale di Messina, molto probabilmente si ispirò non solo a quella di Anversa, o di Lilla, capolavoro quest'ultima del Vauban, ma forse più verosimilmente a quella di Torino. Fatta erigere da Emanuele Filiberto a partire dal 1564 aveva anch'essa, infatti, la configurazione di pentagono regolare con cinque bastioni ai vertici e due porte di collegamento con l'esterno. Di esse la prima, detta del Soccorso, si apriva verso la campagna, mentre la seconda sboccava invece su di un ponte che la collegava con l'antistante mezzaluna, dal che la designazione di Mezzaluna del Soccorso. Nonostante l'evidente grandiosità della fortificazione perimetrale di Torino, l'apice della sua complessità risultava asso lutamente invisibile, dipanandosi a diversi metri sotto terra. Ben 14 km di gallerie e cunicoli correnti a varie profondità costituivano il suo intricatissimo dedalo d i contromine. E quelle interminabili ed anguste viscere della piazza ad intervalli regolari si allargavano, formando dei piccoli vani, detti camere di mina. In esse s i sarebbe dovuto costipare l'esplosivo da far brillare non appena le sensibili orecchie delle sentinelle avessero percepito, con assoluta precisione, l'adiacenza della testa di uno scavo nemico da mina. Una guerra di talpe, condotta nel tenue barbaglio delle lucerne cieche, in amb ie nti poveri di aria e trasudanti umidità, col ri schio continuo di frane ed esplosioni.
Allorquando Luigi XIV manifestò al Vauban l'intenzione di attaccare Torino, questi non mancò di fargli osservare c he l a città, per molti aspetti simile a quella di Lilla, era protetta da una cinta di diciassette o diciotto bastioni, da una c ittadella pentagonale di notevole

solidità , e soprattulto era reputata inviolabile per l'articolatissimo sistema di contromine. Anzi , volendo chiarire senza ombra di dubbio il suo parere, a costo di apparire cinicamente brutale, in quella rete di cunicoli il re avrebbe finito per seppellire vivo il suo esercito <121 •
Nonostante la sensatezza del parere che, implicitamente suggeriva di non cimentarsi in un investimento ossidionale tanto azzardato, nell'agosto del 1705 nel1'ambito delle operazioni dell ' accennata Guen-a di Successione di Spagna, le truppe francesi comandate dal generale Louis Françoìs Aubusson , duca de la Feuillade , circondarono Torino accingendosi ad assediarla. In realtà occorsero ancora alcuni mesi affinché tutto fosse concretamenle pronto per 1' avvio del] ' assedio propriamente detto. A quel punto , però, mentre intorno alle mura stavano posizionati oltre 40.000 assedianti all ' interno se ne contavano appena J0.000. Un rapporto quindi di uno a quattro, asimmetria perfettamente compensata dall ' efficacia delle fortificazioni che spiega pienamente la titubanza francese ad aprire il fuoco.
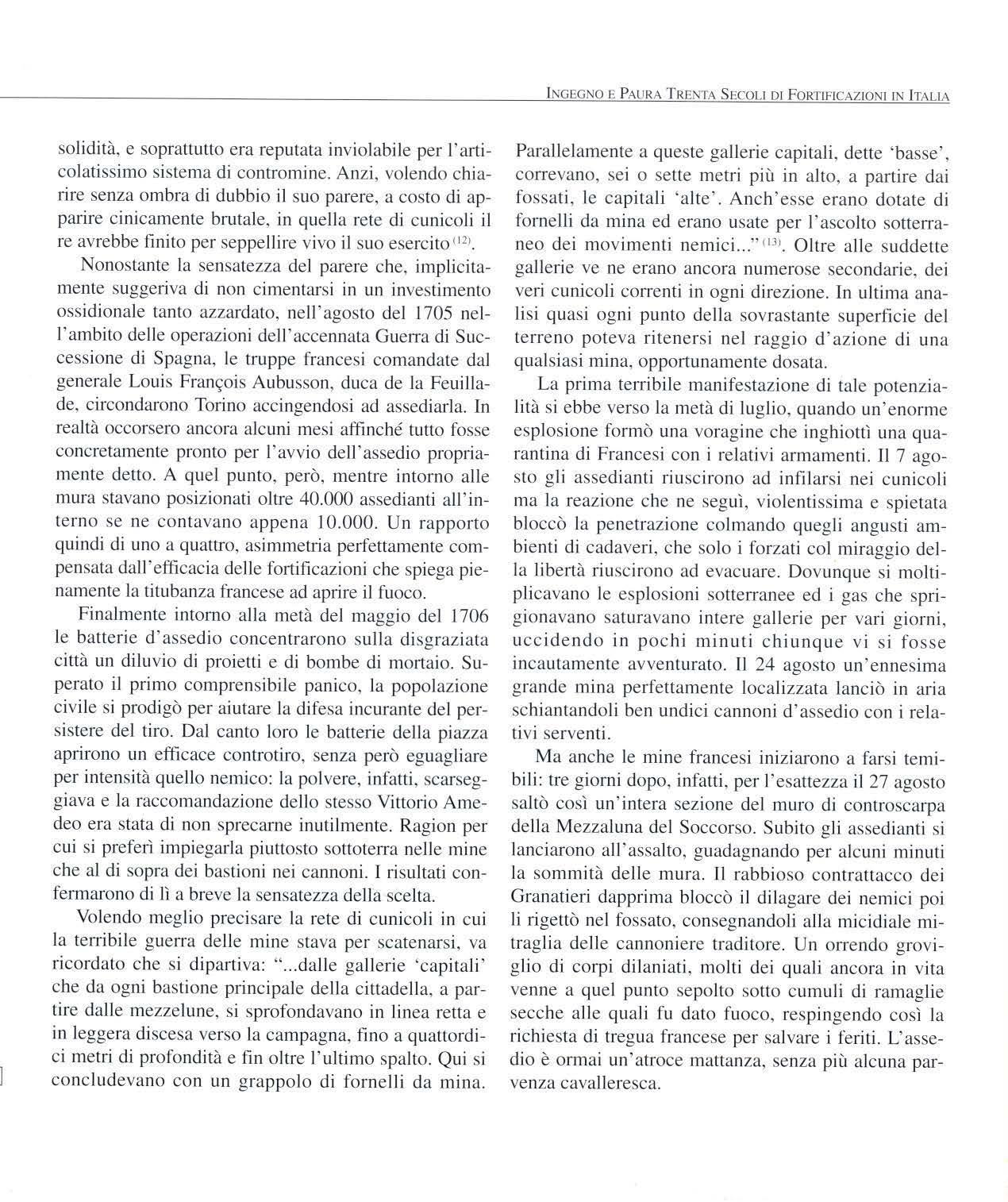
Finalmente intorno alla metà del maggio del 1706 le batterie d'assedio concentrarono sulla disgraziata città un diluvio di proietti e di bombe cli mortaio. Superato il primo comprensibile panico, la popolazione civile si prodigò per aiutare la difesa incurante del persistere del tiro. DaJ canto loro le batterie della piazza ap1irono un efficace controtirn , senza però eguagliare per intensità quello nemico: la polvere, infatti, scarseggiava e la raccomandazione deJlo stesso Vittorio Amedeo era stata di non sprecarne inutilmente. Ragion per cui si preferì impiegarla piuttosto sottoteITa nelle mine che al di sopra dei bastioni nei cannoni. I risultati confermarono di lì a breve Ia sensatezza della scelta.
Volendo meglio precisare la rete di cunicoli in cui la ten-ibile guerra delle mine stava per scatenarsi, va ricordato che si dipartiva: ·• ... dalle gallerie 'capitali' che da ogni bastione principale della cittadella, a partire dalle mezzelune, si sprofondavano in linea retta e in leggera discesa verso la campagna, fino a quattordici metri di profondità e fin oltre l'ultimo spa l to. Qui si concludevano con un grappolo di fornelli da mina.
Parallelamente a queste gallerie capitali , dette 'basse' , con-evano , sei o sette metri più in alto, a partire dai fossati, le capitali ' alte'. Anch ' esse erano dotate di fornelli da mina ed erano us ate per l'ascolto sotten-aneo dei movimenti nemici ... " <13 J _ Oltre alle suddette gallerie ve ne erano ancora numerose secondarie , dei veri cunicoli correnti in ogni direzione. In ultima analisi quasi ogni punto della sovrastante superficie del terreno poteva ritenersi nel raggio d ' azione di una qual s iasi mina, opportunamente dosata.
La prima terribile manifestazione di tale potenzialità si ebbe verso la metà di luglio, quando un'enorme esplosione formò una voragine che inghiottì una quarantina di Francesi con i relativi armamenti. Il 7 agosto gli assedianti riuscirono ad infilar s i nei cunicoli ma la reazione che ne seguì, violentissima e spietata bloccò la penetrazione colmando quegli angusti ambienti di cadaveri, che solo i forzati col miraggio della libertà riuscirono ad evacuare. Dovunque si moltiplicavano le esplosioni sotterranee ed i ga s che sprigionavano saturavano intere gallerie per vari giorni, uccidendo in pochi minuti chiunque vi si fo s se incautamente avventurato. Il 24 agosto un ' ennesima grande mina perfettamente localizzata lanciò in aria schiantandoli ben undici cannoni d'assedio con i relativi serventi.
Ma anche le mine francesi iniziarono a farsi temibilj: tre giorni dopo , infatti. per l'esattezza il 27 agosto s altò così un'intera sezione del muro di controscarpa della Mezzaluna del Soccorso. Subito gli assedianti si lanciarono al l'assalto, guadagnando per alcuni minuti la sommità delle mura. Il rabbioso contrattacco dei Granatieri dapprima bloccò il dilagare dei nemici poi li rigettò nel fossato, consegnandoli alla micidiale mitraglia delle cannoniere traditore . Un on-endo groviglio di corpi dilaniati, molti dei quali ancora in vita venne a quel punto sepolto sotto cumuli di ramaglie secche alle quali fu dato fuoco , respingendo così la richiesta di tregua francese per salvare i feriti. L' assedio è ormai un'atroce mattanza, senza più alcuna parvenza cavalleresca.
I N GEGNO E PAURA TRE l\'TA S ECOLI DI FORT IFI CAZ IONI IN lTALIA
Il 29 agosto una nuova infiltrazione france se raggiunge la capitale alta. e so praffatta la guardia vi penetra dirigendosi tramite una scala verso la capitale hassa: poche centinaia di metri ed il manipolo di incursori sarebbe pervenuto all ' interno della cittadella, con conseguenze tragiche. La base della scala, però, era stata prudentemente minata in precedenza ed un paio di granatieri vi si trovavano di guardia, uno dei quali di nome Pietro Micca. All ' irrompere dei Francesi i due uomini ebbero la prontezza di chiudersi alle spalle la ma ssicc ia porta, e mentre gli intrusi febbrilmente cercano di sfondarla il Micca, facendo allontanare con la celebre frase il suo compagno, provvedeva ad accendere la miccia della mina. L' imminente cedere della porta lo aveva costretto a ridurre al minimo la sua lunghezza e quando l'esplosione avvenne,
oltre a dilaniare gli attaccanti, scag liò anche l'eroico difensore contro la parete del cunicolo, provocandone la motte. Il commilitone sopravvissuto racconterà di averne sentito gli ultimi gemiti.
Otto giorni dopo i Francesi so rpre si dal contrattacco austro-piemontese, rotto l 'assedio abbandonarono la città in di so rdinata fuga.
Proprio nell ' anno della morte di Carlo Il era giunto a Napoli, con l'incarico di viceré , don Giovanni Emanuele Femandez Pacheco duca di Escalona e marchese di Villena. Cinquantenne cli estrazione militare non impiegò molto per realizzare l 'asso luta inconsistenza difensiva della
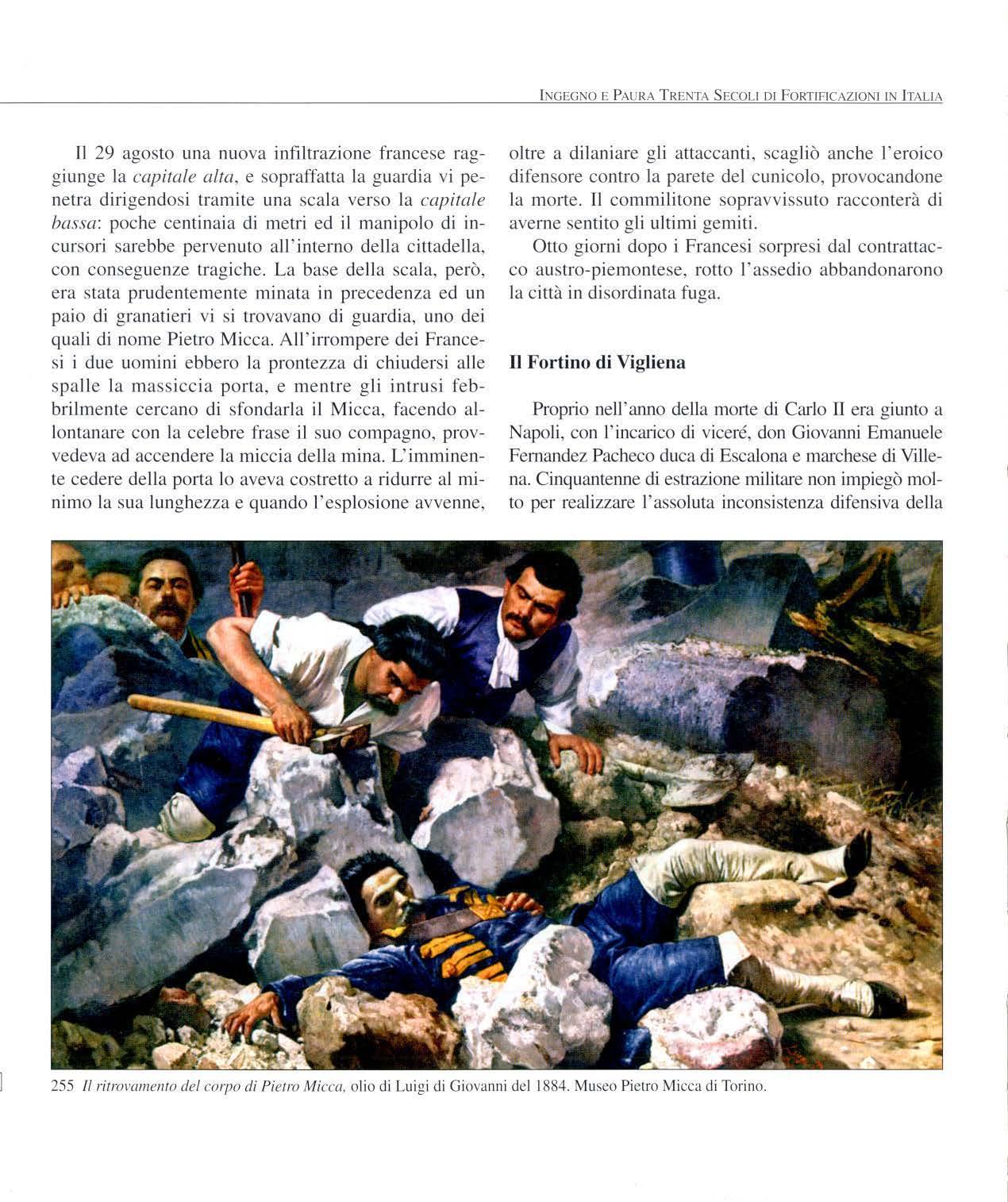 ING EGNO F. PA U RA TR ENTA S ECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIA
255 li ritmvamenro del corpo di Pie1m Micca. o l io di Luigi di Giovanni del 1884. Musco Pietro Micca di Torino.
ING EGNO F. PA U RA TR ENTA S ECOLI DI FORTIFICAZIONI IN ITALIA
255 li ritmvamenro del corpo di Pie1m Micca. o l io di Luigi di Giovanni del 1884. Musco Pietro Micca di Torino.
capitale al profilarsi di probabili attacchi navali inglesi. Senza alcun indugio, agli inizi di marzo , emanò le apposite ordjnanze per la realizzazione di cinque modernissimi fo1tini costieri da scaglionare tra Napoli e Castellammare, ovvero in media uno ogni tre chjlometri 114 > Per l'esattezza il primo, che ne tramanderà il nome, f-u insediato sulla spiaggia dell'attuale S. Giovanru a Teduccio <15l : di tutti fu senza dubbio il più razionale ed avanzato. Progettato dal1'_ingegnere napoletano don Filippo Maiinello, ostenta significative analogie con coeve fortificazioni francesi, reputate al momento tra le migliori del settore.
Dal punto di vista formale ricorda un grosso cuneo con lo spigolo volto al mare: Je sue due facce convergenti, lunghe circa 36 metri, sopportavano cias cuna tre cannoni di grosso calibro s chierati in barbetta, mentre un settimo sovrastava lo spigolo stess o. Verso terra il forte si concludeva con due piccoli fianchi , lunghi a loro volta circa 20 metri, formanti fra le loro estremità un segmento rientrante contenente l'ingresso, servito da un ponte levatoio scavalcante il modesto fossato, ampio mediamente 9 metri , che circondava quasi interamente il fortino. Una fitta teoria di fuciliere assicuravano il rispetto alle s palle.
Secondo i dettami dell'epoca l ' opera risultava particolarmente bassa, circa 5-6 metri dal fondo del fosso, ben defilata al tiro navale , e difesa da possibili colpi di mano da due piccolissimi bastioni disposti simmetricamente alla base del 'cuneo ' Tutto il perimetro era debitamente tenapienato all ' interno , con spessori che attingevano oltre 7 m sul fronte a mare , interpretati fino ai recenti ss imi s cavi come casematte, altrettanti alloggiamenti di una nutrita guarnigione. L'acce s so alla sovras tante piazza d'armi avveniva attraver s o una rampa lunga circa 18 m., montante dal corti letto i ntemo t1iangolare. Nessun sotterraneo, tranne una cisterna centrale, e due piccole casematte nei bastioncini per la difesa radente del fossato: al di sopra di queste ultime in quello di sinistra, a livello ciel cortile, la polveriera ed in quello di destra un deposito di attrezzi. La costruzione fu portata innanzi a tempo di primato tanto che in soli tre anni il fortino fu ultimato: nel 1705 risulta già armato e presidiato 11 ">
Gli eventi che seguirono non videro la paventata aggressione biitannica: Vigliena ed i con s imili capisaldi non ebbero pertanto occasione di tirare neanche un colpo. La pace ratificata nel 1713 con il Trattato di Utrecht, sancì di fatto lo smembramento dell'Impero spagnolo. li Regno di Napoli passò così all'Austria, e con esso i famosi fortini che si avviarono , in ottemperanza alla mutata visione strategica. ad una tranquilla obsolenza. Ma, non trascorsero neppure vent'anni, che il precario assetto fu posto nuovamente in discu ss ione

da un ' ennesima crisi dinastica, pas sata alla storia come guerra di Success ione di Polonia, conclusas i nel 1734. Il regno di Napoli, dopo una s erie di combattimenti tornò alla Spagna, per essere ceduto insieme a quello di Sicilia, in data I 5 giugno dal s ovrano Filippo V, al suo primogenito Carlo III, in entità autonoma.
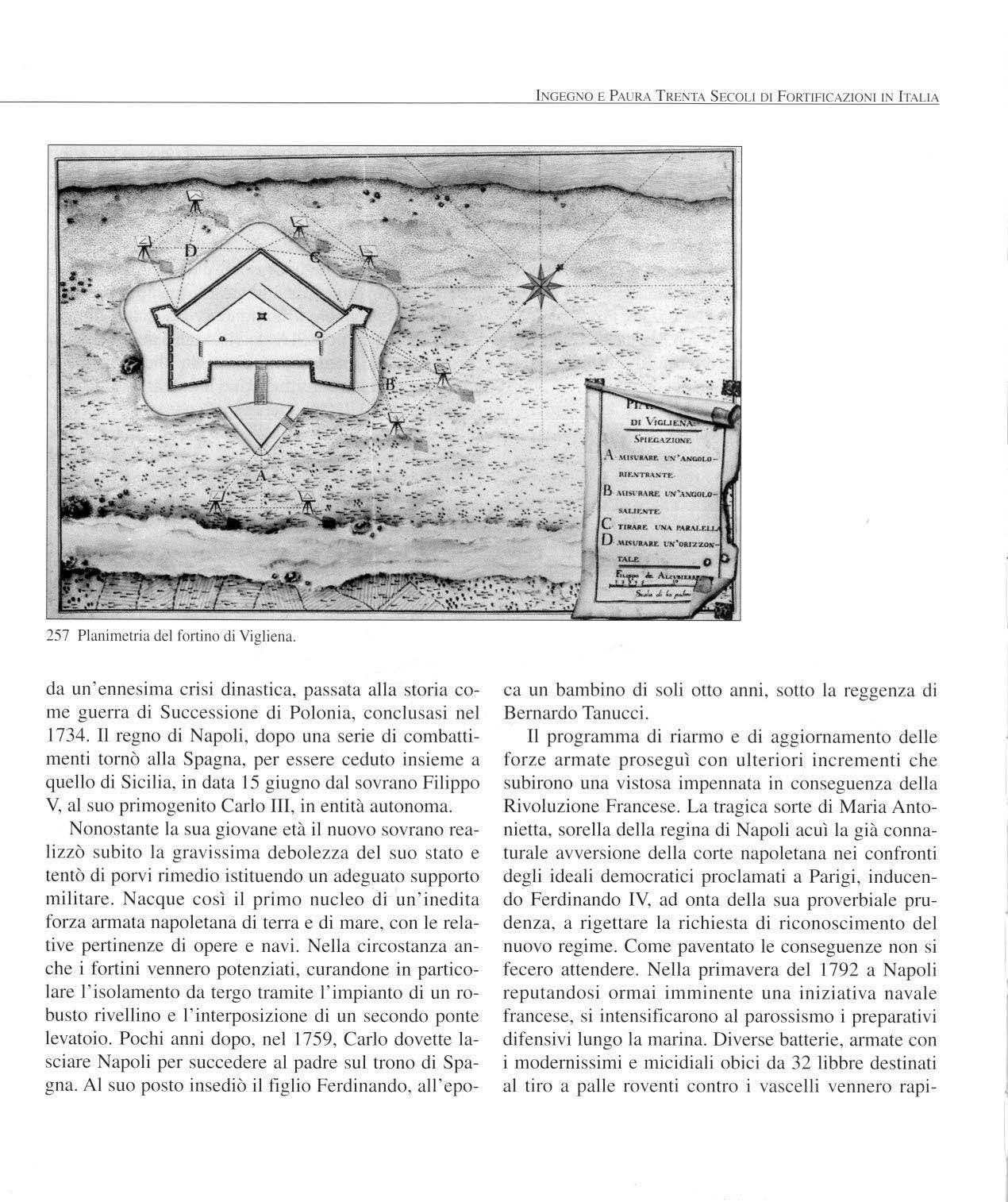
Nonostante la s ua giovane età il nuovo sovrano realizzò s ubito la gravi s sima debolezza del s uo stato e tentò di porvi rimedio istituendo un adeguato supporto militare. Nacque così il primo nucleo di un'inedita forza armata napoletana di terra e di mare , con le relative pertinenze di opere e navi. Nella circos tanza anche i fortini vennero potenziati, curandone in particolare l'i s olamento da tergo tramite l' impianto di un robusto rivellino e l'interposizione di un secondo ponte levatoio. Pochi anni dopo , nel 1759 , Carlo dovette lasciare Napoli per succedere al padre sul trono di Spagna. Al s uo posto insediò il figlio Ferdinando , all'epo-
ca un bambino di s oli otto anni , s otto la reg genza di Bernardo Tanucci.
Il programma di riarmo e di aggiornamento delle forze armate pro s eguì con ulteriori incrementi che s ubirono una v isto s a impennata in cons e guenza dell a Rivoluzione Frances e. La tragica sorte di Maria Antonietta , sorella della regina di Napoli acuì la già connaturale avvers ione della corte napoletana nei confronti degli ideali democratici proclamati a Parigi, inducendo Ferdinando IV, ad onta della sua proverbiale prudenza , a rigettare la richiesta di riconoscimento del nuovo regime. Come paventato le cons eguenze non si fecero attendere. Nella primavera del 1792 a Napoli reputandosi ormai imminente una ini z iativa navale frances e, s i intensificarono al paros sismo i preparativi difens ivi lungo la marina. Diverse batterie , armate con i modernissimi e micidiali obici da 32 libbre de s tinati al tiro a pall e roventi contro i vas celli vennero rapi-
257 Planimetria del fortino di Yigliena.damente attivate e, tra queste, anche quella di Vigliena. Da un'estremità all ' altra del golfo si susseguivano postazioni di artiglieria, forti complessivamente di quasi 500 pezzi, mentre circa 15.000 uomini di truppa regolare e 12 reggimenti di milizia presidiavano ogni metro di arenile.
Ma quando alla fine comparve la squadra francese, peraltro di insignificante entità, l'isterico terrore di Ferdinando inibì ogni resistenza.
Il pavidissimo comportamento del sovrano trovò nei giorni successivi una plausibile giustificazione nella presenza di circa 50 .000 giacobini pronti ad insorgere al primo colpo di cannone. Si trattava di una diceria ovviamente non vera, ma disgraziatamente molto verosimi le, serpeggiando da tempo esplicite simpatie rivoluzionarie. In fatti, allontanatisi i vascelli non si allontanò il sospetto, ed il contagio ideologico che la corte borbonica cercava disperatamente di tenere lontano, proprio con il vile episodio, si era diffuso ulteriormente fra gli strati più colti e più benestanti dei sudditi, incrementandosi negli anni successivi. E quando un esercito francese nel 1798 superò le frontiere del Regno parve a molti i1 tanto auspicato avvento della repubblica. li re il 22 dicembre fuggì alla volta di Palermo , mentre a Napoli il 25 gennaio si insediava un governo provvisorio: quanto all'ese rcito regio, sbandato e disperso, ne sopravvisse soltanto l'aliquota di stanza in Sicilia.
La vergognosa disfatta trovò nel card in ale Ruffo un fanatico vendicatore A so l e due settimane dalla proclamazione della repubblica, l'a lto prelato sbarcava in Calabria, deciso con l'aiuto di raffazzonati seguaci a riconquistare il Regno. Il trascorrere delle settimane v ide un incessante affluire sotto le sue insegne, più note come della ' Santa Fede' sch iere di popo l ani ed alcuni contingenti militari inviati dallo zar di Russia e dal Sultano di Costantinopoli: fu quello l'unico esempio di truppe ottomane comandate direttamente da un cardinale cristiano!
Con l'incrementarsi dei realisti si dissolveva ogni resistenza, poiché quasi tutti g li abitati si consegnava-
no al Ruffo temendo il saccheggio a cui sarebbero stati so ttoposti in caso contrario. Ai primi di giugno la situazione nella Capitale è ormai disperata: manca il pane e scarseggia persino l 'acq ua, mentre i sanfedisti sono ormai a pochi chilometri di distanza. Il giorno 11 il fortino è attaccato contemporaneamente da mare e da terra: i difensori tuttavia riescono a resi stere. All'estremo della disperazione il governo repubblicano decreta per la sola città la coscrizione obbligatoria, requisendo persino i cavalli da tiro. Trascorre in quegli angosciosi preparativi anche il giorno 12 e dopo una notte insonne spunta l'alba del giovedì 13.
L'orda del Ruffo è ormai a ridosso di Napoli dirigendovi per la direttrice più breve , l'antichissima strada per le Calabrie, all'epoca ancora libera dalla teoria ininterrotta di caseggiati che in seguito l'avrebbero costipata. A contrastargli la marcia , soltanto gli scarni e scoraggia ti manipoli repubblicani e, qualche chilometro più ad est, il vecchio fortino di Vigliena, estremo retaggio dei viceré spag noli ed ultimo avamposto repubblicano: sette cannoni di marina ed un pugno di calabresi comandati da un certo Toscani, fervente patriota, già prete in Cosenza (17}
Con l'inoltrarsi del la mattinata alle orecchie della sua guarnigione il cadenzato frangersi della risacca iniziò a dissolversi nel crescente e terrificante clamore della massa in avvicinamento. Il gridio, dapprima indistinto e confuso, sembrò ben presto ai difensori sovrastato da una parlata nota, quasi familiare. Non si sbagliavano poiché a fianco ai soldati dello zar, del s ult ano e di Ferdinando IV avanzavano torn1e di miserabili calabresi, formando nel l oro in sieme un 'o ndeggiante e policroma marea che, istante dopo istante, ricopd dappertutto la grigia sabbia vesuviana, trasformando il piccolo caposaldo in una sorta di isola biancastra, appena affiorante e sempre più minuscola.
Pochi minuti ancora ed al barbàglio delle tante lame di falcioni, di roncole e di baionette si inframmezza l ' intermittente sfavi lli o crepitante della fucileria. L'attonito stupore sugli spalti cessa di colpo ed il cupo tuonare dei pezzi ristabilisce i precis i ruoli. Una densa coltre [

di vo lute di fumo rotola dalle cannoniere verso la spiagg ia, rischiarata frequentemente da rossastre vampate che preannunciano agli incauti attaccan ti le mic id iali sa l ve a mitraglia. Ag li strepit i degli esa ltati succed o no gli urli dei dilaniati, mentre la cadenza di fuoco divenuta spasmod ica, impone a ll a massa un rapido riflu sso.
Ma la tac it azione del caposa ld o non p uò rinviarsi perché quelle stesse artig li erie, sebbene postate or iginariame nt e per i l tiro nava le riescono a battere anc h e l a v ic in a strada, scompag in a ndo l'avanzata. Le truppe msse , probabilmente l e sole d otate della capaci tà militare di affrontare un in vestimento coordinato tentano a ll ora di espug narl o d'assalto. Con perdite inge nti il rabbioso tiro dei difensori ri caccia i sol d at i dello zar a distanza di sicurezza. L'iniziat i va passa a llora ad un a batteria ca mpal e realista, che fa convergere le traiettorie s ul fianco del caposaldo, spesso meno di un paio d i me tti In poch e ore la m uraglia di tufo sconvo lt a dai devastanti impatti s i sgretola irreparabilmente. A l diradarsi della densa polvere appare una vasta breccia: le s ue m acerie hanno per g iunta co lmat o il fossato, co nsentendo perciò l'im1zione: dei difensori molti giacciono uccisi, molti altri feriti mentre i restanti b,u-collano stordi ti. La z u ffa divampa te rribil e e spietata a ll'arm a bianca non di rado tra compae s ani . Il Toscani a ll ora, acco rt osi della imminente sopraffaz ion e, conscio dell ' inesorabile destino dei s uo i co mmilitoni, benché trafitto più vo .lte, barco ll a ve r so l a polveriera, ed invocando Di o e l a Lib ertà fa brillare i tanti barili di polvere accatas tat i.
Qu esta, almeno, sta ndo a ll a ricostruzione del Coll e tt a , sino a poche sett im ane prima ufficiale di a rtiglieria dell'esercito borbonico e quindi passato nelle file dei repubblicani, la g lorio sa fine del fortino di Vig li e n a e della sua guarnigio ne
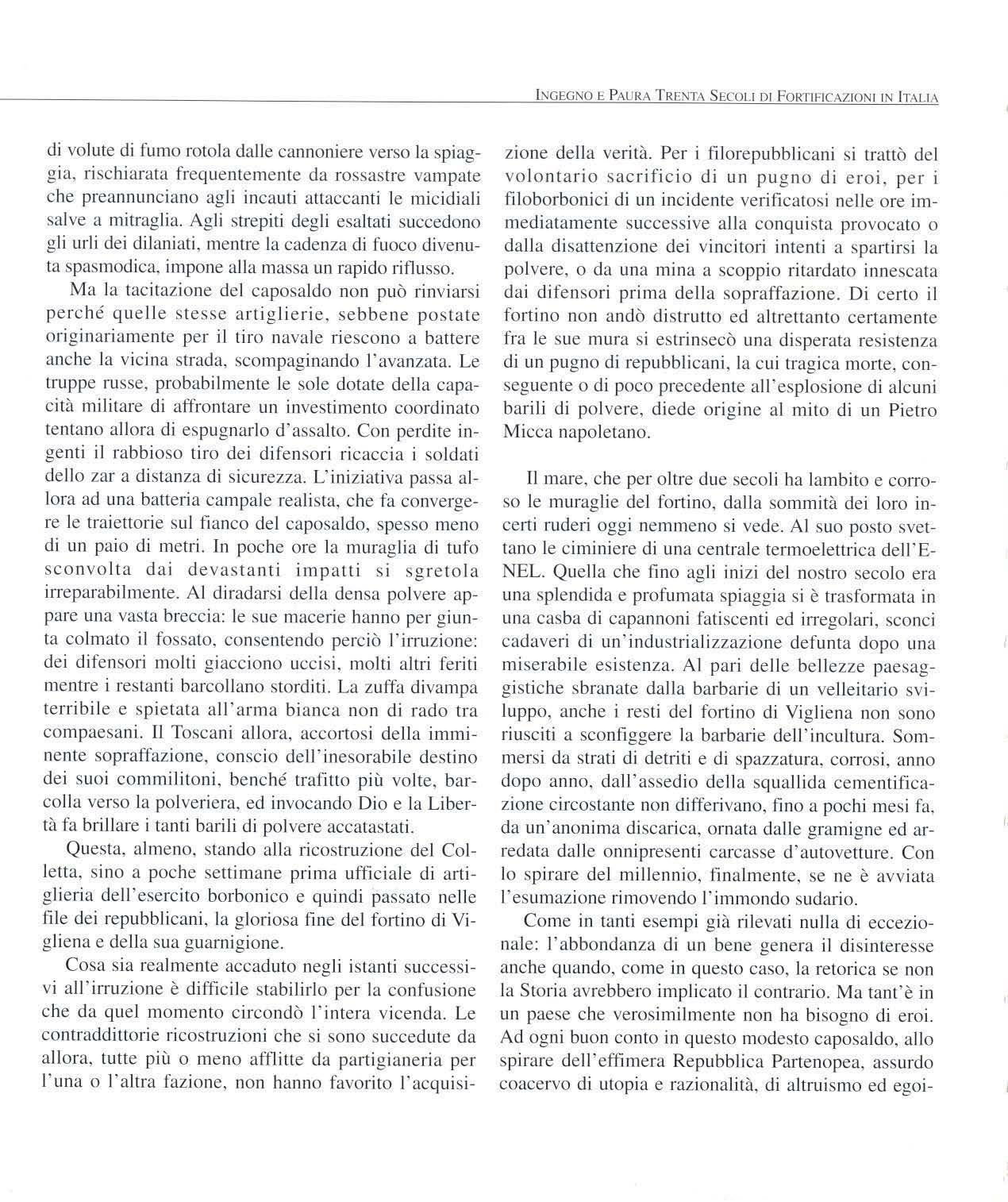
Cosa s ia rea lm ente acca duto negli is ta nti s ucc essivi all ' irru z ione è difficile stabil irl o pe r l a confusione c h e da quel momento circo nd ò J" intera v icend a . L e contraddi ttori e rico stru zio ni che si sono s uccedute da allora, tutt e più o meno afflitte da partigiane1ia per l ' una o l'altra fazione, non hanno favorito l'acquisi-
zione della verità . Per i filorepubb li cani si trattò del volonta r io s acrificio di un pugno di eroi , per i filoborbonici di un in cide nte verifica tosi nelle ore immediata m e nte s uccessive alla co nqui sta provocato o dalla disattenzione dei vi nc it ori intenti a sparti rsi la po l ve re , o da un a min a a scoppio ritardato innescata dai difensori prima della sopraffazio n e. Di cer to i l fortino non andò distrutto ed a ltr ettanto ce rt ame nte fra le s ue mura si estri nsecò una disperata resistenza di un pugno di rep ubbli cani, la cu i trag ica morte, conseguente o di poco precedente a l l'esplosione di a lcun i barili di polvere, diede or igine al mito di un Pi etro Micca napol etano.
Il mare, c he per oltre due seco li ha lambito e coIToso le mur aglie de l fo11ino, dalla somm it à dei loro incerti rud e1i oggi nemmeno si vede. Al suo posto svettano le c imini ere di una ce ntr a le termoelettrica de l] ' ENEL Qu ella che fino ag li iniz i del nostro secolo era un a s plendida e profumata sp i aggia si è trasformata in una casba di capannoni fatisce nti ed irregolari , sconci cadaveri di un' industriai izzazione defunta dopo un a mi serabile esis te n za. Al pari delle be ll ezze paesaggistiche sbra na te dalla barbarie di un ve ll e it ario sviluppo, anc h e i resti del fortino di Vigliena non sono riusciti a sco nfi gge re l a barbarie dell'incultura. Sommersi da s trati di detriti e di spazzatura, co rro s i, anno dopo a nn o, dall ' assed io d e lla sq uallida cementificazio ne c iJ'cos ta nte non differivano, fino a pochi mesi fa , da un'anonima discarica, ornata dall e gramigne ed arredata dalle onnipresenti carcasse d'autovetture. Con lo spirar e del mill e nnio , finalmente, se ne è avv iat a l ' esumaz io ne rim oven do l ' immondo su d ario
Come in tanti ese mpi g ià rilevati nulla di eccezional e: l ' a bbond a nza di un bene ge nera il disinteresse anche quando, co me in qu es to caso, la retorica se non l a Storia avrebbero impli cato il contrari o. M a tant ' è in un paese c he veros imilm e nte non ha bisogno di ero i Ad ogni buon conto in qu es to mod esto caposaldo, a ll o s pir are de ll 'effimera R e pubbli ca P arte nop ea , assu rd o coace r vo di utopia e razion ali tà, di a ltrui smo ed egoi -
L\IGEGNO r. PA URA TR ENTA SECOLI 1)[ FORTIFl CAZ IONI I N ITALJ Asmo, di vi g liacch e ria ed eroismo, di cultura ed ig noranza . la fede di pochi ge nero si ri sca tt ò l ' ipocri s ia cli tanti sed i cen ti p at rioti. L e poche ore di s tr e nu o combattimento e di tem e rario furore dimo s trarono se non altro l 'aspiraz ione al la dignità di un int ero popolo, indipend entemen te dalla s ua s trum e ntale s uddi visione. Dis perato coraggio ebbero infatti i suoi s paruti dife n so ri. co nsapevo li de i rischi m o rtali a c ui l 'esponeva quell'inutile resistenza. Ma a ltr e ttanto coragg io e bb ero pure molti a tt acca nti anch'essi consapevoli dei rischi mort a li a cui r es pon eva l'altrett a nto inutil e investi me nto di quell ' ultimo ed isolato caposaldo. Ness un a ricompensa o g lori a per gli uni , nessuna g lori a o bottin o per g li a ltri. Moti v i en trambi va lidi prima e dopo l 'U nit à d'Ital ia per preservare quel mi g liai o di mq dalla becera de vas ta zione: ma p ers ino la proposiz ion e a monumento na z ional e di quel fazzoletto di maceri e nel s uo prim o ce ntenario di a bband o no non
tro vò accog lim ento. Valse ap pena a restringere l'offesa a qu e lle malconce mura, g i à mart o riate dall' artig li eria it a li a na - in qu anto assurte a comodo bersag lio - alle so le viole nze della natura. peraltro affatto trascurabili qu a nd o concomitanti in ri va al m are . Ma a llorquand o nel seco nd o dopoguerra la pr es unz io ne di ri so l vere sem p l icistica m e nte e rapidamente la questione meridionale individuò nelle sp iagge, ad oriente e ad occidente di Napoli, i siti id ea li per r ins e diam en to di tutt e le più s tra vo lgenti attività indu striali , in pe rfe tta co ncordan za co n quanto già avv iato d a i Borboni , pe r il fortino di Vigliena, cessò il coma e d ini z iò l' agonia. Sopra vv iss uto ind e nn e agli sco nvolgenti bombardamenti alleali, sopravvissuto a due seco li di m a regg iat e, ne ll' arco di poche stagio ni sva nì , dapprima sa l assa to come cava urbana poi sommerso dai rifiuti, per ri affiora re alla vi.g il ia del seco ndo centenario .
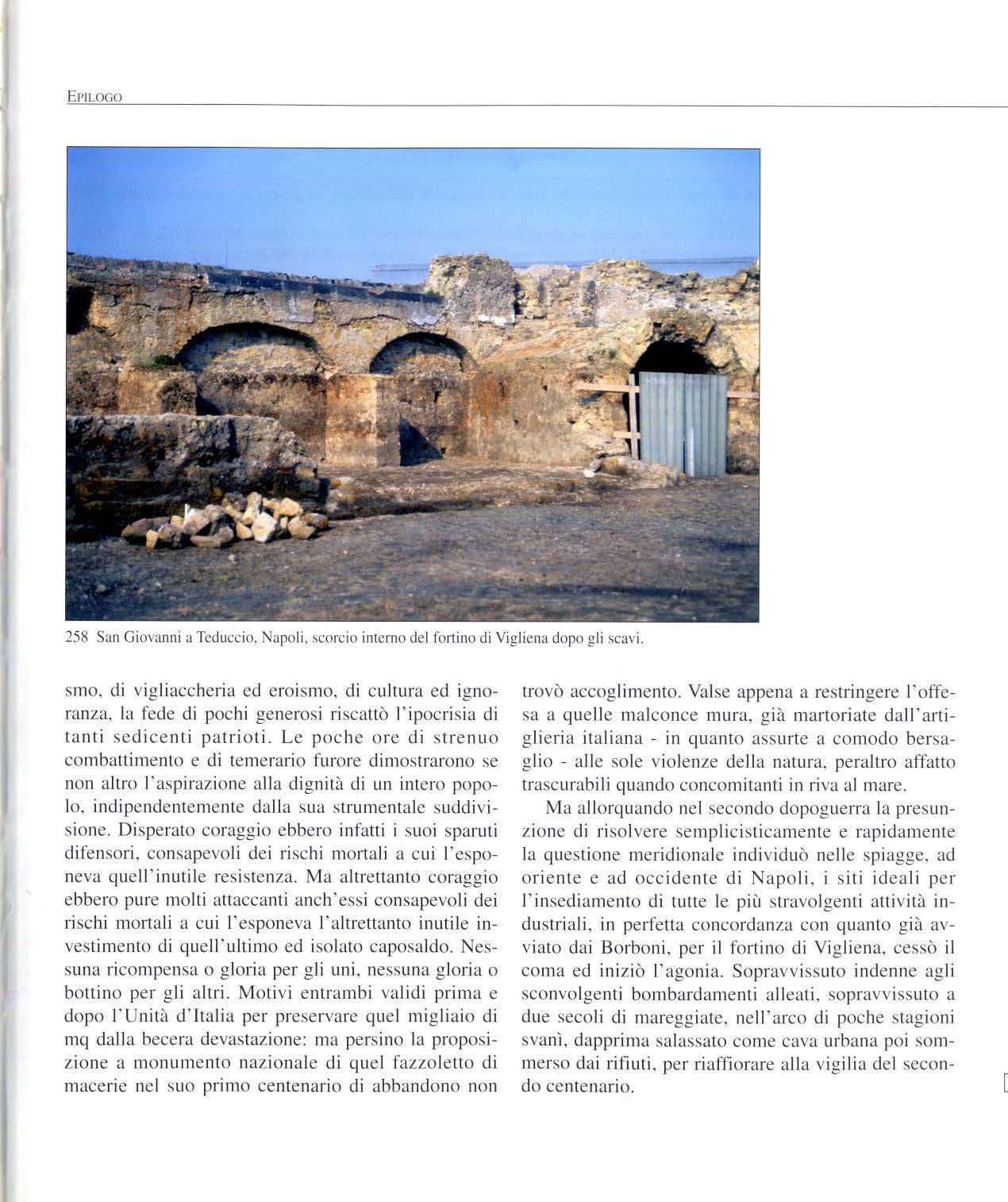
1 Circa le condizion i vigenti al la vigilia della Guerra dei Trent'anni, cfr. J.Y. PousENSKY, La guerra dei trent'anni, Torino 1982, pp. 15 -80.
2 Sulla vicenda cfr. S. MASIN I, G. ROTASSO. Dall'archibugio al Kalashnikov, selle secoli cli anni da fuoco , Milano 1982, pp. 72 - 118. Riguardo alle conseguenze in campo militare della rivoluzione industriale e francese cfr. W.H. Mc NEII.L, Caccia al potere , cit.. pp. 156- 184.
• 1 Precisano al 1iguardo S. MASINI. G. ROTASSO, Da/l'archibugio al..., cit.. p. 77: "L'acciarino detto co nve nzionalmente 'alla micheletta' si diffuse in tutta l'area del Mediterraneo e venne costruito, ol tre che in Spagna (ad Eibar e a Ripoll ), anche nei territori soggetti al Regno di Spagna, in Italia e nell'America del Sud, e presumibilmente su ordinazione anche in E uropa Centrale, restando in uso su armi militari e civ ili fin o a tutto il XYlll seco lo, con esemplari fabbricati anche all'inizio dell'Ottocento".
5 Ri corda B. MONTGOMERY, Storia delle guerre Milano 1970, p. 276: " La base del successo di Gustavo Adolfo fu la sua int elligente conoscenza dell'organizzazione lo gistica led un] esercito nazionale reclutato, pagato, nutrito ed equipaggiato dallo stato L'eserc ito svedese differiva, come struttur a ed equipaggiamento, dagli altri eserciti e uropei in quanto cor ri s p o nd eva alla concezione tattica del re, nella quale avevano s uprem a importanza il fuoco e la mobilità ".
6 La citaz ion e è Lratta da W.H. Mc NEtLL, Caccia , ci t. , p. 109. Sulle conseg uenze del fuoco a 'raffica ' cfr. G. PARKER, La rivolu::.ione militare. Le innova::_ioni militari e il sorgere del/ 'Occidente, Bologna 1989, pp. 35 e sgg.
7 Per un quadro ria ssuntivo dei diversi sis temi fortificato1i europei e laborat i tra il XVII cd il XVITT secolo cfr. A. FARA, Il sistema ... , cit.,pp.15 1-252
" Da C. SACHERO, Corso di.fortificazione... , cit., pp. 71- 72 .
" Circa la co nc ez ione del sistema ideato da Men no van Coehoorn, I 641-1704, cfr A. FARA, 11 sistema , cit., pp. 210 -213.
w Da J.H. EL LI OTT. La Spagna imperiale ... , ci t. , p. 43 1.
11 Da T. CELOTTI, Storia di Spagna, Milano 1940, p. 638.
I ? La ci tazio ne è tratta da V. MELEGARl, J grandi assedi, Milano 1972, p. 167.
13 Da V. M ELEGARI, i grandi c il. , p. 167.
1 ~ Di essi, oltre a quello di Yigliena sop ravv i ve so ltanto quello di Rovigliano , si tuato su di uno scog li o ant istante la foce de l Sarno a ToJTc Annunziata. Completamente distrutto quello di Caste ll ammare, di Torre del Greco e di Portici.
15 Per un approfondimento su ll a genesi del fortino cfr. D. DEL Rio, S. ESPOS ITO, Vigliena, Napo li 1986, pp. 12 e sgg.

16 Una puntuale descrizione di com'era il fortino di Vigliena la forn isce G. ABATINO , // forte di Vigli ena, in Napoli Nobilissima. fase. Ottobre-Novembre 1899.
17 L'episodio è ricostruito più dellagliatarnente da F. R usso, Vigliena: autopsia di un fortino, in Studi Stor ico M ilitari 1999, Roma 2000, pp. 4-85.
