TURISMO NEL SEGNO DI NATURA E CULTURA
Nell’Italia delle bandiere blu e arancioni, l’economia del settore sta ritornando ai livelli pre pandemia


Nell’Italia delle bandiere blu e arancioni, l’economia del settore sta ritornando ai livelli pre pandemia

11
EDITORIALE
Tra vecchi arnesi e desiderio di rinnovamentodi Vincenzo D’Anna
PRIMO PIANO
Natura e cultura l’accoppiata vincente del turismo in Italia di Rino Dazzo
Alla scoperta della buona tavola di Rino Dazzo
Blu e arancioni, è l’Italia delle bandiere di Rino Dazzo
20 Cancro, allarme degli esperti: casi in aumento anche prima dei 50 anni di Domenico Esposito
Il virus Epstein-barr possibile causa della sclerosi multipla di Domenico Esposito
Allarme obesità tra i bambini italiani di Domenico Esposito
L’importanza della forma del cervello di Domenico Esposito
Artrite reumatoide. Ogni anno 5mila nuove diagnosi in Italia di Carmen Paradiso
Malattie cardiovascolari: 18 milioni di decessi annui in tutto il mondo di Carmen Paradiso
INTERVISTE
Predire l’uscita dal coma? Un tentativo grazie a un modello matematico di Chiara Di Martino
Alzheimer: se gli astrociti non si accendono, funzioni cerebrali a rischio di Ester Trevisan

Testate due nanoparticelle che potrebbero rallentare i tumori di Elisabetta Gramolini

Lavoro, salute e famiglia ecco lo “stressometro” degli italiani di Barbara Laurenzi
Staminali sempre in movimento per stabilire la colorazione dei capelli di Biancamaria Mancini
Salute a rischio, italiani minacciati da stili di vita e scarsa prevenzione di Barbara Laurenzi
Actinidia arguta: ingrediente in prodotti per la cura della pelle di Carla Cimmino
AMBIENTE
Navigando nel mediterraneo tra i principi del blu di Gianpaolo Palazzo
Mobilità sostenibile: Milano la più vicina all’obiettivo europeo di Gianpaolo Palazzo
Spiagge italiane come pattumiere a cielo aperto di Gianpaolo Palazzo
Che aspetto avevano i primi animali? La risposta arriva dai cromosomi di Sara Bovio
Lucciole “spente” con la luce artificiale di Eleonora Caruso
INNOVAZIONE
Previsioni mirate per localizzare le proteine nella cellula e far progredire la ricerca di Sara Bovio
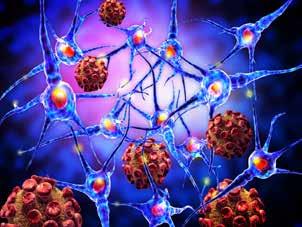
Tumore prostata: scoperta una causa di Pasquale Santilio
Alimenti da forno con scarti agroalimentari di Pasquale Santilio
Prevenire i blackout elettrici? Ora si può di Pasquale Santilio
Nuova generazione di celle solari di Pasquale Santilio
C’è vita nella galassia spt0418-47? di Michelangelo Ottaviano
La partenogenesi nei Crocodylia di Michelangelo Ottaviano
BENI CULTURALI
Boom di presenze: agli italiani piacciono musei e teatri hi-tech di Rino Dazzo
SPORT
Le “mani” di pafundi dietro il triplete del Man City di Antonino Palumbo
Notti (quasi) magiche: Italia under 20 argento mondiale di Antonino Palumbo
Ferrari, la felicità è una 24 ore (di Le Mans) di Antonino Palumbo
Parigi incorona Djokovic dei record di Antonino Palumbo
SCIENZE
I marker biologici per la diagnosi dei disturbi psichiatrici di Lorenzo Varriano
Trattamento della mastite puerperale durante l’allattamento al seno di Daniela Bencardino
Comunicazione scientifica e studi su salute umana e natura: progetti europei di Cinzia Boschiero
Così soleva dire don Lorenzo Milani, grande pedagogo toscano, passato alla storia per la celebre scuola di Barbiana (piccola frazione di Vicchio, in provincia di Firenze), esperienza educativa sperimentale riservata a ragazzi poveri e disagiati.
Don Lorenzo Milani diceva che la scuola era il luogo deputato alla formazione e che la buona istruzione formava, a sua volta, buoni cittadini

Lorenzo Carlo Domenico Milani Comparetti (questo il suo vero nome) era un prete scomodo, che abituava i suoi scolari a un esercizio morale, che oggi è
raro trovare nella veloce società digitale dei social network: quello di esprimersi chiaramente, di avere il coraggio di dubitare e di denunciare i mali e le diseguaglianze del mondo. Non a caso il sacerdote fiorentino amava ripetere che la scuola era il luogo deputato alla formazione e che la buona istruzione formava, a sua volta, buoni cittadini. Un’opportunità, quest’ultima, che andava riconosciuta a tutti i ragazzi senza lasciare indietro nessuno.
Ora, venendo a noi: è risaputo che in democrazia la società è governata attraverso il libero voto
“Se non direte cose che spiacciano a qualcuno non avrete mai detto la verità”.D’Anna Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
del popolo sovrano ed è sorretta dalle istituzioni politiche e parlamentari.
È dal mandato ricevuto dagli elettori che discende la legittimazione a esercitare il potere; se invece chi lo esercita non ha ottenuto alcun mandato, ecco allora che questi si trasforma in un usurpatore, un tiranno, un despota che viola la legge della democrazia stessa e, con essa, la volontà popolare. In buona sostanza: si può giungere al potere anche con l’inganno e gli stratagemmi degli eletti che tradiscono il mandato ricevuto nelle urne. In quest’ultimo caso chi pretende di detenere il potere decisionale è un abusivo, un trasformista che non merita alcuna considerazione.
È dal mandato ricevuto dagli elettori che discende la legittimazione a governare, altrimenti ci si trasforma in un usurpatore
rificata all’esito delle elezioni dei componenti il Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini Regionali dei Biologi (FNOB). Ed è questa, per dirla alla don Milani, la triste e spiacente verità che va disvelata ai Biologi Italiani e più precisamente ai 27mila colleghi che, nei mesi scorsi, si sono recati ai seggi per eleggere i direttivi degli Ordini territoriali. Ebbene, proviamo a riepilogare i fatti, così, per fare chiarezza.
Una condizione, quella innanzi descritta, che purtroppo, si è ve-
Come si ricorderà, in ben dieci regioni su undici è risultata vincente la lista “Biologi per il Rinnovamento” che ha conquistato la totalità dei seggi messi in palio. A loro volta, i componenti dei Direttivi sono stati chiamati a eleggere le quattro cariche previste dalla legge per le “cabine di
regia” dei vari Ordini regionali: il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Infine, gli undici presidenti designati hanno partecipato alla scelta dei componenti il Comitato Centrale della Federazione (in pratica: il governo dell’Ente).
Un meccanismo semplice che avrebbe dovuto, per coerenza e specifico mandato elettorale, scegliere tutti e quindici i componenti della squadra presentata a Roma. Quella, appunto, risultata vincente: la lista dei Biologi per il Rinnovamento. Tuttavia, così non è stato per volontà dei presidenti di alcune regioni e macroregioni di optare sia per i candidati della lista alla quale appartenevano (Biologi per il Rinnovamento) e nella quale, fino a prova contraria, essi stessi erano stati eletti, sia
per quelli di una lista “civetta” appositamente organizzata per realizzare un... ribaltone!
In ben dieci regioni su undici è risultata vincente la lista “Biologi per il Rinnovamento” che ha conquistato la totalità dei seggi messi in palio
Alla base di questa decisione - in molti casi non condivisa dai Direttivi regionali tenuti completamente all’oscuro di quello che appare, a tutti gli effetti, come un vero e proprio complotto ordito a loro insaputa - la volontà di ottenere un’autonomia piena ed assoluta dalla FNOB, alla quale limitarsi semmai a riconoscere un contributo economico striminzito. Contributo, si badi bene, che pure la legge prevede, in base alle esigenze stabilite dalla FNOB!
Per capirci: pur in presenza di maggiori spese (dodici sedi territoriali da mantenere al posto di una sola, 202 dirigenti eletti al posto dei nove che un tempo costituivano il vecchio Consiglio
dell’ONB), i nostri “franchi tiratori” non hanno fatto mancare nei loro bilanci previsioni relative a stipendi e rimborsi che assorbono circa il 20% dei fondi disponibili. Inoltre, hanno istituito in loco, servizi che la FNOB (e prima ancora di essa l’ONB) avrebbe erogato gratuitamente agli iscritti! Insomma: uno svuotamento di compiti, funzioni e servizi che la Federazione avrebbe tranquillamento mantenuto garantendo un grande risparmio in termini di risorse!
opportunità e limitare il ruolo e la funzione della nostra categoria sul piano nazionale.
Quello che si è palesato in queste ultime settimane, è un clamoroso ribaltamento delle scelte fatte dai Biologi Italiani nel gran segreto dell’urna
Sì, avete capito bene: quello testé tratteggiato è un piano egoistico che oltre ad apparire contro legge, appare del tutto estraneo alla logica di operare nel superiore interesse degli iscritti. Spogliare di risorse la FNOB significa, d’altronde, cancellare servizi e
Questa visione è condivisa, allo stato, da un imprecisato numero di eletti in seno al Comitato Centrale, ancorché alcuni siano stati cooptati su base fiduciaria della Presidenza senza passare per il vaglio elettorale. Ma tant’è! In sintesi, quello che si è palesato in queste ultime settimane, è un clamoroso ribaltamento delle scelte fatte dai Biologi Italiani nel gran segreto dell’urna. Risultato: da questo anomalo comportamento è uscito fuori un Comitato Centrale diviso e litigioso a maggioranza variabile e forse anche opportunistica, che non rispecchia affatto il mandato elettorale dei Biologi. Peraltro, il numero degli aventi diritto a sedere nel Comi-
tato Centrale e ancora sub iudice essendosi già verificato, con un accesso agli atti che i dottori Marzia Bedoni e Luciano Cavedoni (ultimo degli eletti) hanno ricevuto lo stesso numero di voti (90) e che pertanto, all’ulteriore verifica ordinata dal Tribunale adito
(CEEPS - Comitato esecutivo esercenti professioni sanitarie) verosimilmente entrerà la dottoressa Bedoni, più giovane di età, al posto del dottor Cavedoni.
Da questo anomalo comportamento è uscito fuori un Comitato Centrale diviso e litigioso a maggioranza variabile e forse anche opportunistica
Un organo che non rispecchia né la volontà dei presidenti né l volontà degli elettori, frutto di manovre e di trasformismi. Il tutto, lo si tenga bene a mente, costruito sulla pelle dei Biologi e delle decisioni che essi hanno liberamente espresso con il proprio voto!
Innanzi a siffatta situazione
la scelta più onesta e legittima è quella di azzerare il Comitato Centrale e richiamare i presidenti regionali al voto. Se cedessimo, infatti, alla tentazione di fare compromessi, come qualcuno ci richiede, scomparirebbe la FNOB e, con essa, il corredo dei servizi gratuiti che la neonata Federazione intende confermare agli iscritti.
Siamo innanzi ad un pericoloso scontro di mentalità e di propositi, di idealità contro l’egoismo dei singoli, della priorità di spendere soldi per fornire ausilio ai Biologi che li sborsano rispetto alle pratiche di chi vuole dissiparli! Insomma, uno scontro tra vecchi arnesi e il sincero desiderio di rinnovamento. Qualunque cosa accadrà siano ben chiari a tutti i presupposti che lo hanno determinato.
Il volume d’affari legato ai viaggi è tornato ai livelli precedenti alla pandemia
In cima alle preferenze vacanze a sfondo ecosostenibile e in località fuori rotta

Quant’è bello viaggiare in Italia. Lo Stivale si conferma uno dei principali poli d’attrazione turistica sia per quel che riguarda il turismo interno – italiani che si spostano da una località all’altra alla scoperta delle infinite attrazioni del Bel Paese – sia per quel che concerne il turismo da altre nazioni. Solo Spagna, Francia e Germania hanno attratto più visitatori nell’Unione Europea, nell’ultimo anno. Per l’Italia, che ha catalizzato il 14,5% dei turisti in ambito
Ue, i dati sono relativi al 2022 e sono molto incoraggianti. Le presenze complessive sono risalite: 142 milioni, circa 40 in meno rispetto all’ultimo anno prima della pandemia, il 2019, con saldi raddoppiati e triplicati rispetto al 2020 e al 2021, gli anni più bui segnati da virus e restrizioni. E le proiezioni per il 2023 sono ancora più rosee. Le ha formulate l’Istituto di Ricerca Ircm, sulla base dei numeri forniti dall’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart) per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio: previste 158 milioni di presenze, di cui 87 provenienti dall’Italia e 71 dall’estero.

Ma quale tipo di turismo è praticato dai tanti che scelgono il nostro paese per le vacanze, i weekend o per soggiorni più prolungati? Gli esperti del settore, tra cui gli analisti di Vamonos Vacanze, hanno tracciato l’identikit perfetto dei viaggiatori, con differenze anche marcate tra un “tipo” e l’altro. La prima motivazione che spinge così tanti turisti ad andare in giro per l’Italia è di tipo naturalistico. Al di là dei monumenti, dei borghi, dei musei e degli innumerevoli poli d’attrazione di un paese che racchiude un numero elevatissimo di patrimoni UNESCO nei suoi confini, sta prendendo sempre più piede un tipo di turismo esperienziale, in cui il territorio diventa luogo dove immergersi tutto d’un fiato, vivendolo in ogni suo aspetto. Passeggiate a piedi o in bici, trekking, escursioni, scampagnate in montagna, al lago, in spiaggette nascoste, spesso fuori dai grandi circuiti: è il turismo 3.0 tanto amato di questi tempi, in cui il luogo visitato è apprezzato e soprattutto rispettato. Un turismo sostenibile e bioetico, dove il soggiorno in case e dimore rustiche supera quello nelle strutture alberghiere e che predilige in particolare territori come la Maremma toscana e laziale, il Gargano, il Salento interno, ma anche la Riviera romagnola, i grandi laghi del Nord, la Versilia, Langhe e Roero.

Al secondo posto nelle preferenze dei viaggiatori c’è un tipo di turismo più classico, quello

E il budget? Andare in giro per musei e siti di interesse culturale, ad esempio, costa mediamente qualcosa in più (140 euro al giorno) rispetto a un turismo più prettamente naturalistico (127), mentre la classica giornata al mare si rivela più economica, sia pure relativamente: 116 euro.
legato all’eccezionale patrimonio culturale italiano. «Il profilo è del tutto trasversale perché si tratta di un viaggiatore alla ricerca e all’apprezzamento del patrimonio storico-artistico e architettonico, ma anche ai tesori naturalistici e all’enogastronomia, insomma attento alla cultura a 360 gradi», scrivono gli specialisti di Vamonos. «Una volta a destinazione, il turista culturale si dedica a visite in centri storici (35,3%), monumenti (30,1%), palazzi e castelli (28%), musei (25,3%) e siti archeologici (18%). Ma il dato più interessante è quello che vede il turista culturale fare anche tante escursioni e gite nella natura (57,1%), più del turista medio italiano (47%)», si legge invece nell’ultima relazione dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart). Un profilo di turista, al pari di quello precedente, dalla notevole dimestichezza con gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie: il 65%, infatti, utilizza esclusivamente canali online per scegliere, pianificare e prenotare il soggiorno nelle destinazioni preferite.
E il budget? Anche quello è influenzato dal tipo di vacanza che si sceglie. Andare in giro per musei e siti di interesse culturale, ad esempio, costa mediamente qualcosa in più (140 euro al giorno) rispetto a un turismo più prettamente naturalistico (127), mentre la classica giornata al mare si rivela più economica, sia pure relativamente: 116 euro. Ci sono poi differenze significative tra italiani e stranieri. I primi sono più tirati (74 euro al giorno per l’acquisto di beni e servizi durante la vacanza), i secondi più di manica larga (93). «Un turista su cinque è alla ricerca di nuove esperienze e destinazioni da scoprire», osserva la nuova presidente Isnart, Loretta Credaro. «Questo è un fenomeno emergente da non sottovalutare nella programmazione dell’offerta turistica locale e che ha l’obiettivo di mettere in luce anche le piccole eccellenze del territorio. Il buon rapporto qualità/prezzo è un must del turismo culturale che rappresenta un fattore decisivo di scelta per italiani e stranieri, complice anche il carovita degli ultimi mesi. La tendenza, sempre più condivisa tra la domanda turistica, è rivolta a una ricerca di qualità dell’intero sistema di offerta locale. La vera chiave di successo per una destinazione turistica italiana è da ricercare nel dialogo e nel coordinamento delle iniziative messe in campo dai vari soggetti attivi, pubblici e privati, della filiera di ospitalità allargata».
Di pari passo con la crescita vertiginosa del turismo naturalistico e culturale, negli ultimi anni è esplosa un’altra forma sempre più specifica e mirata di viaggi, un fenomeno noto come turismo enogastronomico. Secondo quanto riportato null’ultimo Rapporto sul turismo enogastronomico italiano, il sesto della serie, curato da Roberta Garibaldi, il 58% dei viaggiatori italiani nel 2022 ha compiuto un viaggio finalizzato principalmente alla scoperta delle eccellenze alimentari e vinicole del territorio: nel 2016 erano appena il 21%. Quasi dieci milioni di turisti che si sono spostati perché animati dal desiderio di conoscere meglio i prodotti dei posti di destinazione.
Tra le attività più gettonate, come si legge nel rapporto, ci sono «le degustazioni in vigna e negli uliveti, eventi che abbinano gusto-arte-musica, lavoro abbinato alla vacanza nelle aree rurali, sino ad arrivare a nuove proposte quali andar per boschi a raccogliere piante e frutti selvatici, corsi di sopravvivenza e attività ludiche come escape room e caccia al tesoro». Le escursioni in fattorie, cantine e caseifici sono tra le prime richieste dei viaggiatori. Tra le altre caratteristiche del «nuovo» turismo enogastronomico, poi, ci sono il desiderio di staccare dalla routine quotidiana e dalla tecnologia e di stare il più possibile a contatto con le comunità locali, praticando uno stile di vita sostenibile e salutare.
Come spiega la curatrice del rapporto, Roberta Garibaldi, professore di Tourism Management presso l’Università degli Studi di Bergamo, «tutte le regioni vantano una ricchezza che può essere ulteriormente valorizzata. È importante preservare e valorizzare il patrimonio culinario italiano, i paesaggi, le piccole botteghe e gli artigiani del gusto, per garantire una crescita nel lungo periodo costante, armoniosa ed equilibrata nel rapporto tra mete più rinomate e le meno note aree in-
Cresce sempre di più il turismo enogastronomico legato ai prodotti e alle eccellenze del territorio

terne. Il turismo enogastronomico riduce l’overtourism e gli squilibri, contribuisce a mantenere le attività tradizionali nei piccoli borghi e nelle zone rurali, porta entrate aggiuntive ai produttori stimolandoli a tutelare attivamente il paesaggio».
Ma quali sono le mete preferite dai viaggiatori interessati al food & beverage più autentico e genuino? I numeri non mentono e indicano che le strutture agrituristiche sono aumentate del 24% dal 2011 al 2021 (dati Istat) soprattutto al Centro e nel Nord-Est. In crescita anche le aziende specializzate nella produzio -
ne di prodotti agroalimentari di qualità certificati dall’Unione europea. In Sardegna è forte l’interesse per le produzioni lattiero-casearie, nel Trentino per quelle di tipo ortofrutticolo, in Toscana o in Puglia per quelle olivicolo-olearie. Le attività di trasformazione sono ripartite soprattutto tra Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Sicilia, mentre un dato curioso riguarda i turisti interessati alla scoperta della vera dieta mediterranea, che sono per lo più stranieri e concentrati nei luoghi simbolo di questo stile alimentare sano ed equilibrato: i borghi del Cilento. (R. D.)

Si moltiplicano le spiagge, di mare e d’acqua dolce, con attestati di qualità. Aumentano i riconoscimenti ai borghi
Tuffarsi in Italia, mare o lago che sia, è garanzia di qualità. L’undici per cento delle spiagge premiate a livello mondiale, infatti, si trova nel Bel Paese. Nel 2023 sono diventate 458 le Bandiere Blu, che contrassegnano le spiagge più belle o pulite della Penisola. Un quarto del totale nazionale, oltre un decimo – appunto – dei luoghi certificati dalla Fondazione FEE in tutto il globo. Bandiere Blu che sono aumentate di 17 unità rispetto all’anno precedente. All’elenco si sono aggiunte le spiagge di Catanzaro e Rocca Imperiale in Calabria, di San
Mauro Cilento in Campania, di Gatteo in Emilia-Romagna) Laigueglia e Sori in Liguria, Sirmione e Toscano Maderno in Lombardia, Porto San Giorgio nelle Marche, Termoli nel Molise, San Maurizio D’Opaglio e Verbania in Piemonte, Gallipoli, Isole Tremiti, Leporano e Vieste in Puglia, Orbetello in Toscana.
A livello regionale la prima posizione è occupata sempre dalla Liguria con 34 tratti di costa premiati davanti alla Puglia (22), a Calabria, Campania e Toscana (19), Marche (18), Sardegna (15), Abruzzo (14), Sicilia (11), Lazio e Trentino con 10. I criteri di
assegnazione dell’ambitissima etichetta non riguardano solo la pulizia delle acque, che rimane comunque condizione imprescindibile: i parametri presi in considerazione sono 32 in totale e spaziano dalla funzionalità dei depuratori alla percentuale di allacci fognari, dalle gestione dei rifiuti all’inclusività e all’accessibilità dei lidi, oltre naturalmente alla sicurezza dei bagnanti, all’educazione ambientale e al rispetto dell’ambiente, oltre che alla trasparenza e alla certificazione del lavoro di tutti gli addetti. A eseguire tutte le analisi necessarie sono le varie Arpa, le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente.
«Anche quest’anno registriamo un notevole incremento dei Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu» è il commento del presidente della Fondazione Fee Italia, Claudio Mazza. «Le bandiere sono ormai uno strumento di impatto sociale e territoriale, che vede nuove sinergie fra pubblico, privato e cittadini, e la collaborazione tra enti di ogni livello al lavoro sull’immagine della propria località nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio».
E insieme alle Bandiere Blu, aumentano di anno in anno le Bandiere Arancioni, nate oltre vent’anni fa su iniziativa del Touring Club Italiano allo scopo di valorizzare i piccoli borghi dell’entroterra, veri e propri scrigni di tesori a livello ambientale, culturale, enogastronomico e sociale. Nel 2023 le località contrassegnate dalla speciale bandierina che contraddistingue quelle considerate più a misura d’uomo e orientate a modelli di crescita durevoli e orientati al futuro si sono arricchite di 12 nuovi ingressi, passando da 262 a 274. Tra i parametri funzionali alla premiazione non rientra solo l’importanza del patrimonio storico, culturale e ambientale del singolo borgo, ma anche e soprattutto la capacità dello stesso di offrire al turista un’accoglienza di qualità. (R. D.)
Tutte
*Calabria Campania-Molise
Emilia Romagna-Marche
Lazio-Abruzzo
Lombardia
Piemonte-Liguria-Valle D’Aosta
Puglia-Basilicata
Sardegna
Sicilia
Toscana-Umbria
Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige
L’ONB si è trasformato Sono stati costituiti la FNOB e gli Ordini Regionali dei Biologi*
Identificato un set di variabili in grado di predire l’esito clinico dei pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite. Ne parla Antonio Cerasa (Cnr-Irib)
Un modello che consente di prevedere l’uscita dal coma di pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite, cioè di danni cerebrali estesi tali da determinare una condizione che può durare per brevi o lunghi periodi: è quello che hanno sviluppato ricercatori dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche di Messina (Cnr-Irib) e dell’Istituto di analisi dei sistemi ed informatica del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr-Iasi). La ricerca, pubblicata su Scientific Reports, ha messo insieme dati raccolti da uno studio condotto dall’Istituto S’Anna di Crotone e altri centri clinici nazionali e ha riguardato, in particolare, 156 pazienti, arrivando a prevedere, per ciascuno di loro, le “traiettorie” degli esiti clinici.
L’analisi della condizione clinica lungo tutta la degenza ha permesso di modellizzarne l’evoluzione tramite una equazione matematica, identificando un set di variabili in grado di predire l’esito clinico dei pazienti con una accuratezza elevatissima. A dirci di più è il neuroscienziato Antonio Cerasa, ricercatore di I° livello dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche di Messina, che, più nello specifico, si occupa di Neuroscienze traslazionali, un nuovo settore caratterizzato dal trasferimento delle conoscenze prodotte dalle scienze di base nella pratica clinica e sociale.
Come e quando è nato lo studio?
A seguito dei miei lavori sull’uso degli algoritmi di intelligenza artificiale per predire gli esiti dall’uscita dal coma ,quello di cui ci accorgemmo - con i colleghi clinici che ogni giorno lavorano nei reparti di riabilitazione intensiva - era che questo tipo di informazione non porta ad una reale ricaduta sulla pratica clinica. I medici sanno molto bene qual è la probabilità e il grado di recupero di un paziente che esce dall’unità di rianimazione degli ospedali ed entra nei centri di riabilitazione. Quindi non hanno bisogno di un algoritmo che gli dica cosa guardare. Quello che i medici non sanno è quando avverrà il miglioramento clinico e soprattutto come la terapia che è stata scelta per i pazienti migliorerà (o meno) gli esiti finali. Quindi c’era bisogno di un modello statistico meno “statico” è più dinamico.
Che tipo di pazienti ha avuto come target?
Per questo primo studio abbiamo preso pazienti con danno cerebrale ricoverati presso i più importanti centri di riabilitazione italiana. La patologia rientrava nei danni di natura vascolare o tramautica o anossica.
Quali i risultati?
Il modello matematico che i colleghi dell’Iasi-Cnr di Roma hanno utilizzato ci ha permesso di visualizzare le traiettorie degli esiti clinici dei pazienti dall’inizio del loro ricovero fino alle dimissioni, dividendo quasi perfettamente
(intorno al 90% di accuratezza) i pazienti che avranno un esito negativo da quelli che invece avranno un esito positivo. Inoltre il modello riesce anche a dirci in quale giorno del ricovero la divisione tra le due curve avverrà. Questa informazione è critica per i medici perché secondo il modello il futuro del paziente (se migliorerà molto o poco) si determina nei primi 80-90 giorni dal ricovero. Dopo questo lasso di tempo è molto difficile che i trattamenti utilizzati possano influire sull’esito finale.
È una “prima volta”?
Con questo modello matematico, in questo settore, assolutamente sì.
Qual è l’importanza dei modelli matematici in studi come questo?
Quello di fornire un punto di vista diverso da quelli offerti dall’intelligenza artificiale. Un approccio più dinamico, centrato su quello che il medico fa ogni giorno durante la sua pratica clinica e non affidato ad un computer.
Lo studio proseguirà?
Stiamo per partire con un nuovo studio multicentrico promosso dal gruppo delle gravi cerebrolesioni della Società Italiana di NeuroRiabilitazione per aumentare la casistica così da
La ricerca, pubblicata su Scientific Reports, ha messo insieme dati raccolti da uno studio condotto dall’Istituto S’Anna di Crotone e altri centri clinici nazionali e ha riguardato, in particolare, 156 pazienti, arrivando a prevedere, per ciascuno di loro, le “traiettorie” degli esiti clinici.
permettere al modello matematico di dividere le capacità di predire le traiettorie degli esiti clinici anche per le singole patologie (vascolari, traumatiche o anossiche). Il futuro prossimo saranno programmi informatici che includeranno questi tipi di modelli matematici e che potranno essere usati ogni giorni dai medici per vedere come cambia la traiettoria del esito finale del paziente grazie al trattamento scelto.
Quante professionalità ha coinvolto lo studio?

Citarle tutte è difficile perché sono almeno 10 strutture per il primo lavoro, mentre per il prossimo siamo già arrivati a 16 centri. Mi limito a citare le persone che hanno supportato questo progetto, in primis Francesca Lucia Lucca, responsabile dell’Unità Risvegli dell’Istituto S’Anna di Crotone; Simona Panunzi e Andrea De Gaetano, matematici dell’Iasi-Cnr di Roma. E, infine, la Società Italiana di NeuroRiabilitazione. Le professionalità vanno ovviamente da fisiatri, neurologi, fisioterapisti passando per statistici, matematici, per terminare a figure ibride come la mia che si occupano di traslare gli avanzamenti tecnologici in altri campi nella pratica clinica per la salute mentale.

Intervista con Micaela Zonta, ricercatrice del Cnr-In di Padova e autrice dello studio pubblicato sulla rivista Nature Communications
Un team di ricercatori dell’Istituto di neuroscienze del Cnr e dell’Università degli Studi di Padova ha indagato le alterazioni dei segnali intracellulari nella malattia di Alzheimer, individuando nella mancata attivazione degli astrociti, un tipo di cellule presenti nella corteccia cerebrale, un deficit che pregiudica la funzionalità del cervello nei modelli murini.
Dottoressa Zonta, cosa sono gli astrociti e qual è il loro ruolo nel sistema cerebrale?
Gli astrociti sono, con microglia e oligodendrociti, le cellule gliali del sistema nervoso centrale. Nel cervello umano ci sono circa 80 miliardi di cellule gliali e 86 miliardi di neuroni, ed ogni astrocita contatta con la sua rete di processi circa 2 milioni di sinapsi. Gli astrociti hanno un ruolo fondamentale in diversi fenomeni: ad esempio, guidano la crescita assonale dei neuroni durante lo sviluppo, regolano la composizione ionica e molecolare extracellulare durante l’attività sinaptica, contribuiscono alla regolazione locale del flusso sanguigno in dipendenza dall’attività neuronale. I loro processi concorrono a formare la barriera ematoencefalica e garantiscono l’apporto di nutrienti ai neuroni convertendo il glucosio in lattato. Ma gli astrociti hanno anche un ruolo più attivo nei circuiti cerebrali: sono infatti in grado di comunicare in modo dinamico con i neuroni, di “accendersi” in risposta ai neuro-
trasmettitori, con una eccitabilità mediata da aumenti della concentrazione intracellulare di calcio, e di rilasciare gliotrasmettitori che modulano l’attività sinaptica.
Cosa accade se queste “stelle del cervello” non si accendono?
Se gli astrociti non si accendono viene a mancare una componente modulatoria essenziale per il funzionamento del cervello, con conseguenze diverse a seconda dei circuiti interessati. Numerosi studi documentano come l’attività degli astrociti influenzi molteplici fenomeni un tempo ritenuti regolati solo dai neuroni, come la plasticità sinaptica e la memoria, l’attività sincrona dei circuiti cerebrali, il sonno, la respirazione, l’ansia e la risposta alla paura, i comportamenti alimentari e quelli legati ai circuiti di ricompensa e dipendenza.
Perché il segnale degli astrociti si indebolisce?
Il segnale calcio negli astrociti origina principalmente dall’attivazione di recettori legati a proteina G, che porta al rilascio dello ione dai depositi intracellulari. Accanto a questa via, vi sono anche canali ionici di membrana che ne mediano l’influsso dall’ambiente extracellulare. In alcuni casi, queste vie sono collegate: nell’omeostasi ionica intracellulare, lo svuotamento del reticolo viene “percepito” da una proteina sensore (STIM1) che comunica ad un canale di membrana la necessità di
far entrare calcio per ricaricare il deposito e ripristinare la capacità della cellula di rispondere agli stimoli.Ogni alterazione di questi meccanismi coinvolti nel segnale calcio può portare all’indebolimento del segnale stesso.
Quali sono le evidenze principali emerse dalla vostra ricerca in relazione all’attività degli astrociti e all’insorgenza dell’Alzheimer?
Nel modello murino di Alzheimer familiare analizzato nel nostro studio abbiamo rilevato un deficit del segnale calcio negli astrociti, che si sviluppa in concomitanza con la deposizione delle placche di amiloide e prima dell’insorgere dei deficit cognitivi. Il meccanismo molecolare alla base di questo deficit è una diminuzione dell’espressione del sensore STIM1, che si riflette in un minore livello di riempimento del reticolo. La conseguenza è una ridotta capacità degli astrociti di generare un segnale e quindi di esercitare la loro funzione modulatoria. Questo deficit compromette una forma di potenziamento sinaptico specifica della regione somatosensoriale ed è associato ad un successivo difetto di ritenzione della memoria tattile. Il risultato centrale della nostra ricerca è che la sovra espressione specifica del sensore STIM1 negli astrociti è in

La dottoressa Micaela Zonta si è laureata in Biologia e ha ottenuto il Dottorato in Biologia e patologia cellulare e molecolare presso l’Università di Padova, studiando nel laboratorio del Dott. Carmignoto il ruolo del segnale calcio negli astrociti nella regolazione del rilascio di gliotrasmettitori e nell’iperemia funzionale. Fa parte dell’Istituto di Neuroscienze del CNR di Padova, dove approfondisce la ricerca sul ruolo degli astrociti in patologie del sistema nervoso centrale.

grado di recuperare completamente sia il loro segnale calcio sia la plasticità sinaptica dei circuiti neuronali somatosensoriali.
Come incidono i risultati del vostro studio sul piano diagnostico e terapeutico?
I nostri risultati individuano nell’ipoattività degli astrociti un biomarcatore precoce della patologia e in STIM1 un obiettivo farmacologico su cui agire per recuperare i deficit cognitivi.
Da chi è composto il gruppo di ricerca?
Lo studio è frutto della collaborazione tra gruppi di ricerca di CNR e Università di Padova e Pisa. La maggior parte degli esperimenti sono stati realizzati dalla dottoressa Annamaria Lia, che si è occupata di imaging del calcio ed elettrofisiologia, e dal dottor Gabriele Sansevero, che ha condotto i test di comportamento. Il lavoro è stato guidato dal dottor Giorgio Carmignoto, dalla professoressa Cristina Fasolato e da me, con il supporto della professoressa Nicoletta Berardiper gli studi di comportamento, ed è dedicato alla memoria del professor Tullio Pozzan, scienziato di fama internazionale, pioniere della ricerca sul segnale calcio, mentore e amico di molti di noi.
Popolazione sempre più anziana e in sovrappeso. Urgente invertire la rotta L’allarme lanciato attraverso il rapporto Osservasalute 2022
Peggiora la salute degli italiani. A metterla a rischio sono stili di vita scorretti e mancata prevenzione. A lanciare l’allarme è il nuovo rapporto Osservasalute 2022, curato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane che opera nell’ambito di Vihtali, spin off dell’Università Cattolica, presso il campus di Roma. Giunto alla sua XX edizione, lo studio è il frutto del lavoro di 225 ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano che operano presso università, agenzie regionali e provinciali di sanità, assessorati regionali e provinciali, aziende ospedaliere e aziende sanitarie, l’Istituto superiore di sanità, il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, il ministero della Salute, l’Agenzia italiana del farmaco e l’Istat.
Dalle 628 pagine dell’indagine emerge una fotografia in cui gli italiani sono sempre più anziani, in sovrappeso e, in parte, depressi. In assenza di una quota sufficiente di nuovi nati, che nel 2021 sono stati poco più di 400 mila, 4.500 in meno rispetto al 2020, l’età media del Bel Paese è inevitabilmente destinata a superare i 50 anni tra meno di 30 anni, quando con pochi bambini diverremo un popolo di anziani e adulti attempati. Inoltre, nei prossimi decenni si prevede proseguirà il calo della popolazione residente dovuto al protrarsi del
regime di bassa fecondità e alla diminuzione dei flussi migratori dall’estero. Si prevede, infatti, che la popolazione residente passerà dai 59,2 milioni di abitanti attuali ai 54,2 milioni di abitanti residenti nel 2050.
Non va meglio dal punto di vista del benessere psicologico. Stando ai dati rilevati nel report, infatti, nel 2021 il consumo di farmaci antidepressivi ha fatto registrare un aumento del 2,4 per cento rispetto al 2020. Lo studio racconta inoltre di un Paese in cui il 12 per cento della popolazione, quasi 6 milioni di adulti, è obesa e, complessivamente, il 46,2 per cento dei soggetti entro i 18 anni è in eccesso ponderale. Come se non bastasse, gli italiani appaiono poco attivi, con più di un terzo delle persone (il 33,7 per cento) che ha dichiarato di non praticare sport o attività fisica nel tempo libero. La sedentarietà è aumentata dal 22,3 per cento al 27,2 per cento. Dallo studio, inoltre, emerge come anche la sedentarietà sia ormai dilagante tra i più giovani. Infatti, tra il 2020 e il 2021 si evidenzia un forte decremento della pratica sportiva tra i bambini e adolescenti di età compresa tra 3 e 17 anni. Sovrappeso e scarso movimento fanno male alla salute, se si considera che il diabete dilaga tra gli obesi (il 15,5 per cento di loro ne soffre) e i sedentari (quasi il 12 per cento).
Italiani rimandati anche dal punto di vista della prevenzione. I dati sulle morti evitabi-
li, infatti, lanciano un campanello di allarme su quanto sia necessario recuperare dal punto di vista degli screening. L’analisi della mortalità evitabile riconducibile ai servizi sanitari, che nel periodo 2018-2019 è pari a 63,98 per 100.000 mentre era 65,53 nel biennio 20162017, mostra che, nonostante la diminuzione complessiva del dato, è ancora molto alta la quota di decessi attribuibili ai tumori e alle malattie cardiocircolatorie. Questi decessi si sarebbero potuti evitare se le condizioni che li hanno causati fossero state intercettate per tempo con le campagne di screening.


Secondo i ricercatori la scarsa prevenzione, i postumi del Covid e una popolazione sempre più vecchia fanno rischiare la collisione con un sistema sanitario sotto-finanziato, se lo si confronta con quelli dell’Unione Europea. Nel 2022 la spesa sanitaria pubblica si è attestata a 131 miliardi (6,8 per cento del Pil), la spesa a carico dei cittadini a circa 39 miliardi (2 per cento del PIL). Il nostro Paese si colloca così al tredicesimo posto della graduatoria dei Paesi UE per la spesa pro capite, sotto Repubblica Ceca e Malta e molto distante da
In assenza di una quota sufficiente di nuovi nati, che nel 2021 sono stati poco più di 400 mila, 4.500 in meno rispetto al 2020, l’età media del Bel Paese è inevitabilmente destinata a superare i 50 anni tra meno di 30 anni
Klobut/shutterstock.com© Kasia
Francia (3.807 euro pro capite) e Germania (4.831), mentre la Spagna presenta un valore di poco inferiore a quello dell’Italia (2.588). Netto l’appello del direttore del rapporto Osservasalute, il professore Walter Ricciardi. «Il nostro paese non ha ancora capito che, se non facciamo adeguata prevenzione, saremo inondati di casi di malattia che non potremo affrontare perché non avremo la possibilità di curare tutti i malati. Le liste di attesa sono incredibili dal punto di vista della durata e della quantità di persone e questo si verifica per patologie sempre più gravi. Di conseguenza si lasciano in condizioni di grave difficoltà persone che non riescono ad accedere ai servizi. Se non affrontiamo questa problematica in maniera strutturale, il destino sarà quello di avere un servizio sanitario nazionale pubblico sempre più povero per i poveri, che rimarranno in lista d’attesa e sulle barelle dei pronto soccorsi per giorni prima di essere ricoverati, e un servizio sanitario differenziato per chi, grazie al proprio livello economico-sociale, avrà la possibilità di pagarsi il servizio».
Il fenomeno preoccupa gli oncologi: fattori di rischio, caratteristiche e possibili contromisure “Se si nota qualcosa di strano, bisogna parlarne subito con un medico”

Non sono dati incoraggianti quelli che arrivano dal congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology, celebrato lo scorso 2 giugno in quel di Chicago. In quello che rappresenta senza dubbio l’appuntamento più importante per gli oncologi di ogni angolo del pianeta, gli esperti hanno lanciato l’allarme: non solo il numero dei nuovi casi di cancro è in crescita, ad aumentare in maniera costante è anche la quota di chi si ammala prima dei 50 anni, senza peraltro che se ne conoscano pienamente le ragioni. La buona notizia è che almeno il 40% dei casi potrebbe essere prevenuto in modo abbastanza semplice, soltanto seguendo stili di vita corretti; quella negativa è che purtroppo le cattive abitudini sono sempre più radicate.
Le stime più recenti sostengono che un italiano su tre finirà per ammalarsi nel corso della sua vita. Nel 2022 si sono registrati quasi 400mila casi: la crescita, poiché le patologie sono più frequenti dopo i 65 anni, sembra collegata all’invecchiamento generale della popolazione. All’avanzare dell’età corrisponde infatti una minore capacità dell’organismo di riparare le mutazioni del Dna che favoriscono la formazione della neoplasia, oltre ad un accumulo degli effetti dei vari fattori cancerogeni. Ma se più del 90% dei nuovi casi di cancro registrati annualmente, in Italia come nel resto del mondo, interessa cittadini over 50, studi recenti hanno sottolineato un progressivo aumento dei tumori anche prima di quest’età. Le ragioni sono ancora da indagare, ma è chiaro che fattori di rischio legati agli stili di vita, dall’obesità a una dieta scorretta, dal fumo all’abuso di alcol, sono tra le cause principali del fenomeno. Eppure ci sono altri fattori esterni su cui è necessario porre l’attenzione. Si pensi per esempio all’inquinamento ambientale (in particolare quello atmosferico), che comprende varie sostanze cancerogene provenienti da attività umane (traffico dei veicoli, industrie, riscaldamento domestico) o da sorgenti naturali (radiazioni ionizzanti, raggi ultravioletti), ed è responsabile mediamente del 5% di casi di cancro, ma la percentuale si raddoppia nelle aree più inquinate.
Ad oggi negli uomini italiani under 50 i tumori più diffusi sono quelli del testicolo, il melanoma cutaneo, i linfomi non-Hodgkin, il tumore della tiroide e quello del colon-retto; nelle donne invece sono diffusi il cancro al seno,
L’UE ha raccomandato di anticipare gli screening all’età di 45 anni. Eppure in Italia ancora troppe persone rifiutano l’invito a fare mammografia, Pap o Hpv test, esame per la ricerca del sangue occulto nelle feci. A questo riguardo il consiglio del professor Lambertini è il seguente: «Non si può fare un elenco completo» dei sintomi da tenere sotto controllo, ma in generale «la regola è una: se si nota qualcosa di strano, senza andare nel panico, bisogna parlarne con un medico, senza perdere tempo che potrebbe essere molto prezioso in caso di una diagnosi di cancro». Sì, la prevenzione resta l’arma migliore per contrastare le malattie.

utero-cervice, tiroide, melanoma e colon-retto. Ma una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica “Nature Reviews Clinical Oncology” dai ricercatori della Harvard Medical School, analizzando i registri dei tumori di 44 Paesi, ha rilevato un’impennata nei casi di ben 14 tipi di cancro nella fascia d’età compresa tra i 20 e i 49 anni. L’incremento ha riguardato in particolare i tumori di seno, colon-retto, endometrio, esofago, dotto biliare extraepatico, cistifellea, testa e collo, reni, fegato, midollo spinale, pancreas, prostata, stomaco e tiroide.
Matteo Lambertini, professore associato di Oncologia medica all’Università di Genova, ha spiegato che «il rischio di svilupparli è cresciuto generazione dopo generazione, in particolare dagli anni Novanta, e l’incidenza maggiore è stata registrata tra il 2000 e il 2012. È il cosiddetto “effetto coorte”: significa che i nati negli anni Novanta hanno un rischio maggiore di sviluppare un cancro a esordio precoce nella loro vita rispetto ai nati negli anni Ottanta, e così via a ritroso». La previsione degli autori dello studio è che il livello di rischio continuerà a crescere anche nelle generazioni successive. Per difendersi è necessario porre attenzione alle abitudini (soprattutto alimentari) fin dall’infanzia: bisogna infatti osservare come ben otto dei 14 tumori ad esordio precoce ravvisati dagli scienziati di Harvard interessino proprio l’apparato digerente. Un motivo in più per indagare la relazione fra tumori e microbiota intestinale. A preoccupare gli esperti, infine, anche il fatto che i tumori nelle persone under 50 risultino spesso più aggressivi che negli anziani. Questo succede perché spesso i giovani arrivano tardi alla diagnosi, con neoplasie in stadio avanzato. I campanelli d’allarme possono essere moltissimi: sangue nelle urine o nelle feci, masse palpabili in qualunque punto del corpo, linfonodi ingrossati, febbre o dolori che non passano: tutto, ovviamente, dipende dalla sede del tumore. A questo riguardo il consiglio del professor Lambertini è il seguente: «Non si può fare un elenco completo» dei sintomi da tenere sotto controllo, ma in generale «la regola è una: se si nota qualcosa di strano, senza andare nel panico, bisogna parlarne con un medico, senza perdere tempo che potrebbe essere molto prezioso in caso di una diagnosi di cancro». Sì, la prevenzione resta l’arma migliore per contrastare le malattie. (D. E.).
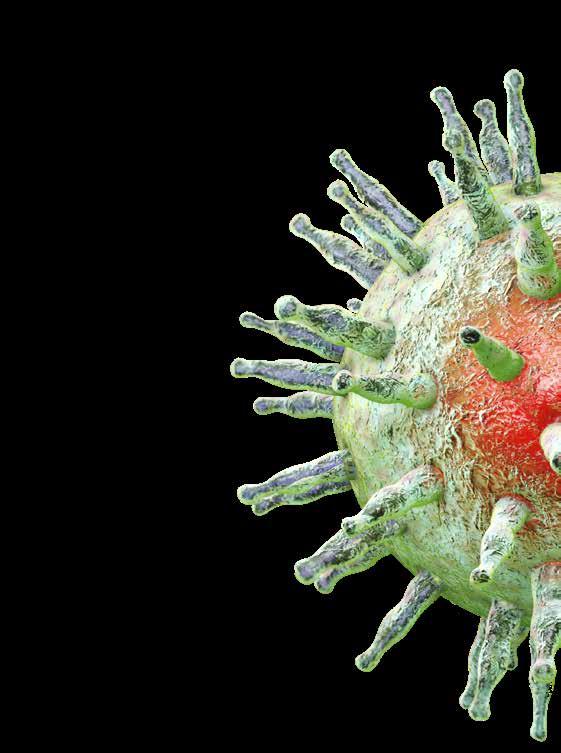
Per giungere alla loro scoperta, i ricercatori del Karolinska Institutet hanno analizzato i campioni di sangue di 700 pazienti affetti da sclerosi e di 700 sani
Promette di rivoluzionare o quanto meno aggiornare molte delle conoscenze sulla sclerosi multipla fino ad oggi date per consolidate lo studio, fresco di pubblicazione sulla prestigiosa rivista Science Advances, realizzato dagli scienziati dal Karolinska Institutet. Secondo quanto dimostrato dagli esperti, infatti, un comune virus potrebbe essere un complice importante, se non decisivo, nello sviluppo e nella progressione della patologia infiammatoria del sistema nervoso centrale caratterizzata dalla perdita di mielina (la sostanza che riveste le fibre nervose della sostanza bianca) in più aree (da cui deriva la definizione di “multipla”). La ricerca dell’università medica svedese nella città di Solna ha evidenziato che il virus in questione è quello Epstein-Barr (EBV), noto per provocare la cosiddetta malattia del bacio, ovvero la mononucleosi. Questo è solito infettare la maggior parte delle persone all’inizio della vita, per poi restare all’interno dell’organismo in maniera perlopiù silente, ovvero senza causare sintomi. Gli studiosi hanno notato che gli anticorpi diretti contro questo virus sono in grado di provocare anche lesioni cerebrali e midollari corrispondenti a quelle che emergono in presenza di sclerosi multipla.
Per giungere alla loro scoperta, i ricercatori hanno posto sotto la lente di ingrandimento i campioni di sangue di oltre 700 pazienti affetti da sclerosi multipla e di 700 individui sani. Così
facendo hanno osservato come gli anticorpi che si legano ad una proteina del virus Epstein-Barr, EBNA1, possono fare lo stesso anche nei confronti di una proteina simile presente nel cervello e nel midollo spinale, denominata CRYAB, e che ha funzioni protettive. Il cattivo indirizzamento di questi anticorpi e la reattività incrociata sono in grado di danneggiare il sistema nervoso e determinare gravi sintomi nei pazienti affetti da sclerosi multipla, quali problemi di equilibrio, mobilità e affaticamento. La correlazione tra questi anticorpi del virus e la malattia
è emersa in maniera chiara quando si è osservato che essi erano
Oltre il 90% della popolazione mondiale entra in contatto con il virus nei primi anni di vita, durante l’adolescenza o in età adulta. L’ipotesi più probabile, suggerita da numerosi studi, è quella che ritiene la patologia il risultato di una serie di diversi fattori, genetici ed immunologici. Ad oggi, secondo le ultime stime rilasciate dall’Associazione
Italiana Sclerosi Mutipla (AIMS), ad essere colpite nel mondo dalla malattia sono circa 2,5/tre milioni di persone, di cui circa 122mila in Italia.
senti in circa il 23% dei pazienti con sclerosi multipla rispetto al 7% riscontrato nei soggetti appartenenti al gruppo di controllo. La professoressa Olivia Thomas, ricercatrice post-dottorato presso il Dipartimento di Neuroscienze Cliniche del Karolinska Institutet e primo autore condiviso del lavoro, ha commentato: «Questo dimostra che, sebbene queste risposte anticorpali non siano sempre necessarie per lo sviluppo della malattia, possono essere coinvolte nella malattia in fino a un quarto dei pazienti con sclerosi multipla». Dallo studio, secondo la scienziata, si ricava anche «l’elevata variazione tra i pazienti, evidenziando la necessità di terapie personalizzate».
Nel recente passato altri studi avevano suggerito che l’infezione da Epstein-Barr potesse precedere la sclerosi multipla e che gli stessi anticorpi contro il virus potessero risultare coinvolti nello sviluppo della patologia che colpisce soprattutto le donne (in numero doppio rispetto agli uomini) e i soggetti di età compresa fra i 20 e i 40 anni. In questo senso si possono citare due articoli pubblicati lo scorso anno sulle riviste scientifiche Science e Nature, ma è da tempo che la questione anima il dibattito scientifico tra i ricercatori. La dottoressa Thomas ha dichiarato: «La sclerosi multipla è una malattia incredibilmente complessa, ma il nostro studio fornisce un importante tassello del puzzle e potrebbe spiegare perché alcune persone sviluppano la malattia». La ricercatrice ha poi riconosciuto che «le attuali terapie sono efficaci nel ridurre le ricadute nella sclerosi multipla, ma sfortunatamente nessuna può impedire la progressione della malattia». Ecco perché il prossimo passo sarà cercare di indagare ulteriormente a partire dai risultati emersi dallo studio. Come ha chiarito Mattias Bronge, ricercatore del Karolinska Institutet e altro autore dello studio, «ora stiamo espandendo la nostra ricerca per studiare come le cellule T combattono l’infezione da EpsteinBarr e come queste cellule immunitarie possono danneggiare il sistema nervoso nella sclerosi multipla e contribuire alla progressione della malattia».
È necessario comunque precisare come l’infezione provocata dal virus Epstein-Barr non può essere l’unico fattore capace di innescare i meccanismi patogenici della sclerosi multipla. Ciò lo si deduce in considerazione del fatto che il virus infetta la maggior parte delle persone.


Italia maglia nera d’Europa secondo i dati OMS: sedentarietà e cattive abitudini alimentari tra i fattori negativi
Sono a dir poco allarmanti i numeri emersi da un’analisi svolta da Coldiretti e diffusa in occasione della recente Festa dell’educazione alimentare nelle scuole, con l’inaugurazione della prima fattoria didattica e migliaia di bambini provenienti da tutte le scuole d’Italia al Villaggio contadino di Bari. Sulla base di dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, nella Penisola il 42% dei bambini fra i cinque e i nove anni risulta obeso o in sovrappeso. Si tratta del risultato peggiore di tutta l’UE, dove la media, invece, è del 29,5%.
Preoccupante anche la situazione dei bambini e dei ragazzi di età compresa tra i dieci e i 19 anni: qui la percentuale di obesità o sovrappeso è pari al 34,2% rispetto al 24,9% dei coetanei europei.

Secondo Coldiretti, ad incidere su questa situazione sono la diminuzione forzata dell’attività fisica e il maggior tempo trascorso in casa davanti alla televisione negli anni della pandemia. Ma anche l’adozione di modelli sbagliati di consumo alimentare all’interno dei nuclei familiari, che hanno visto il progressivo, e preoccupante, abbandono dei principi della
dieta mediterranea. Si pensi a questo proposito che sei adolescenti su dieci riferiscono di non mangiare frutta e verdura ogni giorno, andando così incontro non soltanto ai rischi correlati all’obesità, ma pure alle malattie ad essa connesse. I bambini italiani sono anche meno sportivi dei loro coetanei europei: la percentuale pari al 95% indica che i piccoli del Belpaese non praticano un livello adeguato di attività fisica. Roma è all’ultimo posto fra i Paesi Ocse, un posizionamento emblematico della situazione. Non è dunque un caso che il 70% circa dei bimbi italiani trascorra almeno due ore al giorno guardando tv, smartphone, pc e tablet. Peggio fanno solo i vicini di casa di San Marino. A preoccupare anche i 2,3 milioni di adolescenti che in Italia - rileva la Coldiretti - si trovano giornalmente alle prese con le conseguenze dei disturbi dell’alimentazione. Queste patologie si manifestano in prevalenza a partire dai 12 anni, ma negli ultimi tempi sono arrivate ad interessare anche bambini dagli otto anni in avanti.
Proprio al fine di aiutare i piccoli italiani a mangiare meglio e a prevenire malattie nell’età dello sviluppo e in quella successiva, Coldiretti si è posta l’obiettivo di formare dei consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti, così da valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati quotidianamente. Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, ha dichiarato: «Occorre creare le condizioni per una crescita qualitativa nell’alimentazione dei nostri figli. Il tema dell’educazione alimentare delle nuove generazioni diventa cruciale con la necessità di qualificare anche l’offerta delle mense scolastiche con cibi locali a chilometri zero che valorizzino le realtà produttive nazionali e garantiscano genuinità e freschezza». (D. E.).
Uno studio per conoscere meglio il cervello, per capire in che modo la sua forma eserciti un’influenza diretta sul modo in cui pensiamo, percepiamo e ci comportiamo. È quanto realizzato dai ricercatori del Turner Institute for Brain and Mental Health presso la Monash University in Australia, autori di una ricerca che si è concentrata su più di 10.000 mappe dell’attività cerebrale umana, ottenute grazie alle risonanze magnetiche. Secondo quanto appurato dagli esperti in uno studio che ha visto pubblicazione sulla rivista “Nature”, grazie a quanto scoperto potrebbero adesso spalancarsi nuove strade per giungere ad una migliore comprensione del cervello, dei suoi meccanismi di sviluppo e di invecchiamento e, insieme a tutto ciò, delle sue possibili malattie. Tra le varie indicazioni emerse dal lavoro dei ricercatori, infatti, c’è quella che ha dimostrato come sia forte il vincolo fra la forma del cervello e la funzione cerebrale. Il professor Alex Fornito, coordinatore del team di studio, ha paragonato il legame a quello che viene ad instaurarsi tra la forma di un tamburo e i suoni che esso, a secondo della sua morfologia, è in grado di emettere.
È abbastanza sconvolgente apprendere che il nostro modo di pensare dipende largamente dalla forma del nostro cervello. Fino ad oggi, infatti, era convinzione comune che i nostri pensieri e le nostre esperienze fossero determinate dal modo in cui le diverse regioni del cervello comunicavano tra loro mediante una complessa rete fatta di miliardi di connessioni cellulari. Ma gli approcci tradizionali alla mappatura del cervello - rimarcano adesso gli scienziati australiani - hanno mostrato soltanto la punta dell’iceberg rispetto al funzionamento cerebrale. A tal proposito i risultati conseguiti, ha spiegato ancora il professor Fornito, «aumentano la possibilità di prevedere il funzionamento del cervello
Un nuovo studio promette di superare la “teoria della rete” e di aiutare a combattere alcune malattie cerebrali

direttamente dalla sua forma, aprendo nuove strade per esplorare come il cervello contribuisce alle differenze individuali nel comportamento e al rischio di malattie psichiatriche e neurologiche».
A fargli eco è stato anche il professor James Pang, primo autore dello studio, secondo cui «il lavoro apre alla possibilità di comprendere gli effetti di malattie come la demenza e ictus prendendo in considerazione i modelli della forma del cervello, che sono molto più facili da gestire rispetto ai modelli dell’intera gamma di connessioni del cervello». Del re-
sto già in passato alcuni studi avevano suggerito che il modello di funzionamento del cervello variasse da individuo a individuo. Uno in particolare era stato pubblicato su “Science”, con la neuroscienziata Stephanie Forkel, della Radboud University di Nimega, in Olanda, tra le autrici del lavoro, pronta a sottolineare: «Ognuno ha un cervello diverso, che non è per niente come quello che conosciamo dai libri di testo». Proprio questo è l’aspetto più importante delle recenti scoperte dei ricercatori australiani, tali da poter portare al superamento della “teoria della rete”. (D. E.).
Causa dolore intenso alle articolazioni, gonfiore, rigidità e perdita di funzionalità. Di solito colpisce le mani, i piedi e i polsi, e la stanchezza è un sintomo comune. I pazienti possono sperimentare improvvisi peggioramenti dei sintomi, noti come riacutizzazioni, che sono difficili da prevedere. Pertanto, la remissione clinica rappresenta un obiettivo cruciale per i reumatologi, considerando le opzioni terapeutiche attualmente disponibili.
L’artrite reumatoide è una patologia reumatica infiammatoria e cronica che ha un impatto significativo sulla vita delle persone, sia dal punto di vista emotivo che fisico, oltre a rappresentare un onere economico rilevante in termini di costi diretti e indiretti. Colpisce circa 23,7 milioni di persone in tutto il mondo, di cui circa 300mila in Italia, con 5mila nuove diagnosi ogni anno. Dal punto di vista economico, l’artrite reumatoide comporta costi diretti legati alle spese sanitarie per il percorso assistenziale dei pazienti, come ricoveri ospedalieri, cure infermieristiche, prestazioni specialistiche, fisioterapia, dispositivi ortopedici e farmaci. Inoltre, le persone affette da questa patologia spesso subiscono una riduzione della produttività lavorativa, il che si traduce in costi indiretti come l’assegno ordinario di invalidità, le pensioni di inabilità e le indennità di accompagnamento.
Sono state condotte delle analisi sui costi della malattia, realizzati in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che hanno evidenziato l’impatto economico legato alla gestione dei pazienti adulti con artrite reumatoide in fase attiva da moderata a severa. Lo studio sottolinea l’importanza della remissione clinica come obiettivo comune per i reumatologi e i pazienti, poiché ciò consentirebbe di ridurre il peso economico sia per il sistema sanitario nazionale sia per i pazienti stessi. Questa patologia causa dolore intenso alle articolazioni, gonfiore, rigidità e perdita di funzionalità. Di solito colpisce le mani, i piedi e i polsi, e la stanchezza è un sintomo comune. I pazienti possono sperimentare improvvisi peggioramenti dei sintomi, noti come riacutizzazioni, che sono difficili da prevedere. Pertanto, la remissione clinica rappresenta un obiettivo cruciale per i reumatologi, considerando le opzioni terapeutiche attualmente disponibili.
Negli ultimi 20 anni sono stati compiuti notevoli progressi che hanno permesso a molti pazienti di raggiungere la remissione, caratterizzata dall’assenza completa o rara manifestazione dei segni e dei sintomi della malattia. I pazienti in remissione hanno una migliore qualità di vita, maggiore funzionalità fisica e una maggiore capacità lavorativa rispetto a quelli con bassa attività di malattia. In Italia, l’onere economico associato all’artrite reumatoide supera i 2 miliardi di euro all’anno. Circa il 45% di questo onere (circa 931 milioni di euro) rappresenta i costi diretti sostenuti dal sistema sanitario nazionale. Circa 205
milioni di euro sono spese dirette non sanitarie sostenute dai pazienti, mentre circa 900 milioni di euro sono costi indiretti attribuibili alla perdita di produttività dovuta a giorni di lavoro persi o prestazioni previdenziali.
Americo Cicchetti, professore ordinario di Organizzazione Aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore di Altems, afferma che i risultati dell’analisi rappresentano i primi dati italiani sul valore economico della remissione nell’artrite reumatoide. Si evidenzia l’impegno economico sia del paziente che del caregiver. La mancata remissione, soprattutto nelle forme più gravi della malattia, comporta assenteismo e perdita di produttività, sia per il paziente sia per il caregiver. I pazienti possono perdere oltre 5 giornate lavorative al mese, corrispondenti a una perdita economica annua di più di 12mila euro, mentre i caregiver perdono in media 25 ore al mese, pari a una perdita economica di circa 450 euro all’anno.
Il supporto e il coinvolgimento delle associazioni di pazienti sono fondamentali. Antonella Celano, fondatrice e presidente dell’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr), afferma che la remissione clinica deve essere l’obiettivo principale nel trattamento dell’artrite reumatoide. La remissione può essere interpretata in modi diversi da paziente a paziente. Alcuni la considerano come l’assenza totale di sintomi, mentre per altri si verifica solo occasionalmente. La remissione, specialmente quando è continua e duratura, consente alle persone con artrite reumatoide di condurre una vita normale, continuando a lavorare e mantenendo una vita sociale appagante. L’obiettivo delle associazioni di pazienti è fornire un supporto concreto a tutte le persone affette da malattie reumatiche. Il percorso verso l’accettazione della malattia è lungo e difficile, e l’artrite reumatoide è spesso un argomento tabù poiché non è ancora molto conosciuta come le malattie cardiovascolari o oncologiche. Vivere con l’artrite reumatoide rappresenta una sfida non semplice che impone di fare delle rinunce. Numerosi pazienti affetti da artrite reumatoide, non essendo in grado di raggiungere una remissione completa della malattia, si trovano costretti a vivere una vita compromessa. Tuttavia, è importante sottolineare che il lavoro sinergico tra aziende, professionisti clinici, associazioni di pazienti e istituzioni riveste un ruolo fondamentale per migliorare la qualità di vita di questi pazienti. (C. P.).


Si tratta di una patologia reumatica infiammatoria e cronica che ha un impatto significativo sulla vita delle persone dal punto di vista emotivo, fisico ed economico

Rappresentano la prima causa di morte in Italia. Gli obiettivi sanitari sono quelli di garantire la continuità assistenziale sul territorio, prescrivendo le cure adeguate
Le grandi sfide del sistema sanitario riguardano l’implementazione delle conoscenze dei medici per aumentare la prescrizione delle terapie raccomandate per le malattie cardiovascolari, garantire una continuità assistenziale e terapeutica ai pazienti sul territorio e rafforzare la rete per il trattamento dell’insufficienza cardiaca. Queste sfide sono evidenziate dai numeri: ogni anno nel mondo muoiono 18 milioni di persone a causa di malattie cardiovascolari, di cui l’85% per malattia cardiovascolare aterosclerotica. In Italia, le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte.
Le malattie cardiovascolari hanno anche un impatto economico significativo, non solo in termini di costi diretti, ma anche indiretti, come la perdita di produttività. I clinici concordano sul fatto che livelli elevati di colesterolo LDL non sono solo un fattore di rischio, ma la causa stessa della malattia, con alterazioni che iniziano già in giovane età. Circa il 73% degli uomini e il 43% delle donne nella mezza età mostrano segni di malattia subclinica.
L’esposizione accumulata al colesterolo-LDL rappresenta un fattore predittivo fondamentale per il rischio di malattia. Inoltre, lo
scompenso cardiaco rappresenta una sfida significativa. In Italia, è la principale causa di ospedalizzazione nelle persone oltre i 65 anni, con un impatto clinico, sociale ed economico rilevante. Ogni anno, provoca circa 190mila ricoveri, con una spesa annua di circa 3 miliardi di euro, di cui l’85% è attribuibile ai ricoveri stessi. La spesa media per paziente è superiore a 11.800 euro all’anno. Il 50% dei pazienti con scompenso cardiaco muore entro cinque anni dalla diagnosi. In Lombardia, ci
sono oltre 26mila ricoveri per scompenso cardiaco ogni anno, con un tasso di riospedalizzazione del 13,7% e una mortalità del 9,2% entro 30 giorni. Il costo medio annuo per questi pazienti è di 11mila euro, con l’80% correlato ai ricoveri. Tuttavia, solo il 58% dei pazienti cardiologici assume le nuove terapie raccomandate, che riducono la mortalità e le ospedalizzazioni. È necessario intervenire per implementare le conoscenze dei medici affinché prescrivano maggiormente tali farmaci e per garantire che i
La maggior parte dei pazienti con scompenso cardiaco viene ricoverata in Medicina interna e spesso sono fragili. Questa fragilità dovrebbe essere un motivo ulteriore per ottimizzare la terapia medica. Anche nei pazienti con scompenso cardiaco cronico noto e ben compensato, è necessario rivalutare la terapia poiché l’assenza di una cura ottimizzata, in conformità alle linee guida, porta a un alto numero di ricoveri per recidiva di scompenso acuto. Inoltre, esiste una gamma di farmaci ben tollerati dai pazienti che possono essere utilizzati in questa situazione.
pazienti ricevano una corretta assistenza e follow-up regolare.
La fragilità del paziente, secondo il direttore del Dipartimento di Area Medica Ao Asst Settelaghi e presidente nazionale Fadoi-Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, Francesco Dentali, non dovrebbe essere un motivo per non prescrivere la terapia. Anche nei pazienti “stabili”, è necessario rivalutare la terapia poiché le evidenze scientifiche dimostrano che questi pazienti avranno frequenti ricoveri per scompenso nel follow-up, in queste situazioni è opportuno agire preventivamente.
Il Direttore sanitario della Asst Spedali Civili di Brescia, Camillo Rossi, afferma che i pazienti cronici con scompenso cardiaco presentano una prevalenza significativa a livello internazionale e richiedono una gestione integrata, multidisciplinare e multiprofessionale. Rossi sottolinea l’importanza di avvicinare il luogo di cura al paziente e di utilizzare sistemi integrati di monitoraggio e controllo mediante strumenti avanzati. Inoltre, le importanti innovazioni nella ricerca di nuovi farmaci richiedono un approccio multidisciplinare e la revisione delle linee guida internazionali.
Carlo Borghetti, membro della III Commissione sanità della Regione Lombardia, ritiene che migliorare la presa in carico delle persone a rischio di scompenso cardiaco possa aiutare a prevenire le complicanze di questa patologia cronica, che è una delle principali cause di ospedalizzazione, soprattutto tra gli anziani, e che il Servizio Sanitario Nazionale debba investire maggiormente in risorse umane, strutture, ricerca, farmaci e innovazione per garantire una migliore presa in carico.

© Leyn/shutterstock.com
Infine, Giulio Gallera, membro della III Commissione sanità della Regione Lombardia, evidenzia l’importanza di monitorare attentamente i cambiamenti della società al fine di individuare le criticità e rispondere adeguatamente con campagne di prevenzione specifiche; di investire risorse, inclusa l’implementazione della telemedicina, per portare le competenze dei professionisti sanitari in tutte le aree della Lombardia. L’integrazione tra medicina ospedaliera e territoriale è fondamentale nella gestione dei pazienti cronici, garantendo un monitoraggio costante dell’efficacia terapeutica.
Uno studio pubblicato su Pnas, a cui ha contribuito l’Università di Trieste, ha progettato e sintetizzato due “cavalli di Troia”, capaci di trasportare la terapia nella cellula
Guerrieri piccolissimi, ma attrezzati per colpire il nemico con precisione chirurgica. Un team di ricercatori di diversi centri internazionali, fra i quali l’Università di Trieste, la China Pharmaceutical University, l’Università di Lodz e l’Aix Marseille University, ha progettato due nanoparticelle capaci di trasportare all’interno della cellula in modo selettivo terapie a base di acido nucleico con l’obiettivo di contrastare la progressione dei tumori. Le terapie moderne basate sul trasporto e sul rilascio di acidi nucleici-macromolecole di due tipi (Dna e Rna) che trasportano o modificano l’informazione genetica nelle cellule, sono un importante campo di ricerca oggi per contrastare malattie gravi, come il cancro metastatico e le malattie genetiche rare.
Il lavoro, pubblicato a maggio sulla rivista Proceedings of the national academy of sciences (Pnas), non si è limitato alla progettazione delle due nanoparticelle ma le ha anche sintetizzate e testate, descrivendo che, per raggiungere la cellula, devono essere “mascherate” perché altrimenti verrebbero riconosciute come agenti esterni e attaccate dal nostro sistema immunitario. I ricercatori dell’Università di Trieste, in particolare, hanno cercato un modo per “ingannare” la cellula, creando due diversi tipi di vettori che utilizzano nanomateriali autoassemblanti: dei “mattoncini” che, ravvicinati, riescono a organizzarsi autonomamente
attorno a questi acidi nucleici, nasconderli e trasportarli dentro le cellule in modo selettivo, come una sorta di cavallo di Troia. Gli autori inoltre hanno realizzato due nanoparticelle con caratteristiche diverse tra loro, una specifica per le terapie a base di Rna, un’altra per quelle a base di Dna. È un risultato molto importante perché queste molecole hanno meccanismi e caratteristiche diverse ed è necessario, affinché svolgano la loro funzione terapeutica in modo efficace, che il vettore sia costruito sulla base del modo con cui ciascuna di esse penetra nella cellula.
«Strumenti tailor-made che soddisfino requisiti specifici per diverse applicazioni sono di grande importanza nella ricerca biomedica – sottolinea Sabrina Pricl, professoressa di ingegneria chimica e responsabile scientifico del team Molecular biology and nanotechnology laboratory (MolBnl@UniTs), presso l’Università degli studi di Trieste -. Con questo studio, siamo riusciti per la prima volta a creare due nanoparticelle estremamente selettive. Abbiamo studiato e capito come gli acidi nucleici a base Rna e Dna entrano nella cellula e creato il trasportatore “su misura” per ciascuna di esse, testandone l’efficacia sia in vitro che in vivo e verificandone una grande capacità terapeutica. È un importante traguardo per una medicina sempre più personalizzata». Gli sviluppi dello studio sono vari e riguardano soprattutto la possibilità di produrre le nanoparticelle, che
richiede il soddisfacimento di una complessa serie di requisiti imposti dalla prassi relativa alla produzione di materiali per uso farmaceutico e la loro successiva possibilità di essere portati finalmente alla fase clinica di verifica. Al riguardo, lo studio ha dimostrato l’efficacia e la non tossicità delle nanoparticelle.


«Anche se - aggiunge Sabrina Pricl, professoressa di ingegneria chimica e responsabile scientifico del team Molecular biology and nanotechnology laboratory dell’Università degli studi di Trieste -, quando si tratta di nuove molecole di uso farmaceutico, è sempre molto difficile fare previsioni e non bisogna creare false illusioni, queste nanoparticelle sono promettenti per un ingresso nella pratica clinica in tempi rapidi. Vi sono due condizioni che favoriscono questa prospettiva: da una parte, un sistema di nanoparticelle è stato recentemente approvato velocemente in quanto farmaco orfano per una malattia genetica rara, la malattia di Fabry, dall’altra una richiesta ufficiale di sensibilizzazione verso una maggior regolamentazione e un miglioramento dell’iter approvativo dei sistemi nanotecnologici in campo terapeutico è stata consegnata alla Commissione europea dall’Azione Cost “Cancer nanomedicine: from the bench to the bedside”, di cui sono chair – conclude -, congiuntamente ad altri enti che includono, tra l’altro, associazioni di pazienti e enti di sorveglianza e vigilanza sui farmaci».
©
Le Azioni Cost sono reti finanziate dal programma europeo Cost. La finalità non è dare risorse ad attività di ricerca ma incentivare opportunità di networking per ricercatori e innovatori al fine di rafforzare la capacità dell’Europa di affrontare le sfide scientifiche, tecnologiche e sociali. In particolare, i ricercatori possono proporre la creazione di reti basate sui propri interessi in qualunque campo scientifico e tecnologico (www.cost.eu).


In cima ai motivi di preoccupazione, la quotidianità vince sulle bollette Cresce però la fiducia negli psicologi. Nuova indagine dell’Istituto Piepoli
Lavoro e famiglia stressano più delle bollette. In tempi di inflazione e caro-vita, in cima allo “stressometro” degli italiani ci sono a sorpresa gli impegni della quotidianità, dall’ufficio alla conciliazione con la dimensione domestica. A dirlo è l’Istituto Piepoli nell’indagine realizzata per il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi e presentata in occasione degli ‘Stati generali della professione psicologica’, organizzati dal Cnop con il patrocinio del ministero della Salute lo scorso 21 giugno a Roma.
Secondo la ricerca, condotta nella prima metà di giugno attraverso 1007 interviste su un campione rappresentativo della popolazione italiana dai 18 anni in su, in cima alle preoccupazioni degli italiani c’è la situazione lavorativa, giudicata prima fonte di stress dal 18 per cento degli intervistati, seguita dalla salute fisica, 16 per cento. Sale in terza posizione, con un +5 per cento rispetto al mese di aprile, l’organizzazione famiglia lavoro, causa di stress per il 14 per cento del campione. Nonostante l’inflazione, arrivano solo quarta la condizione economica, 13 per cento, quinto l’aumento dei prezzi dei beni di consumo e le bollette, giudicati causa di stressa dal 9 per cento degli intervistati.

Aumentano del 2 per cento le condizioni di stress di carattere personale, come la condizione di malessere psicologico, il rapporto con i figli e il rapporto con il partner, rispet -
tivamente al 6, 5 e 4 per cento. «Lo stress, in lieve calo rispetto a quello rilevato all’inizio della guerra in Ucraina, è sempre più correlato alla situazione economica e lavorativa e alle difficoltà di conciliare il lavoro con la famiglia, soprattutto nella fascia 35/54 anni, forse colpita dal rientro in ufficio dopo fasi più intense di smart working», ha spiegato il presidente esecutivo dell’Istituto Piepoli, Livio Gigliuto.
Lo stress, però, non fa male solo alla mente. Al contrario, rappresenta un grande rischio per la salute del corpo, come ha ricordato anche il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi David Lazzari commentando proprio i risultati dell’indagine nel corso degli Stati generali della professione. “I maggiori fattori di rischio per le malattie cardiovascolari sono di natura psicologica, il doppio del colesterolo, il rischio di diabete aumenta del 60 per cento, un disagio psicologico prolungato aumenta il rischio di ammalarsi e accorcia la vita. La prevenzione dovrebbe essere in buona parte una questione di psicologia. Così come la cura e la riabilitazione. Nelle malattie fisiche, i problemi psicologici aumentano i costi in media del 50 per cento. Se invece vengono trattati, non c’è aumento di costi ma un risparmio netto, così come un euro investito per trattare ansia e depressione produce oltre 2,5 euro di risparmi.
«Maggiore qualità della vita, migliore rispondenza alle cure, minori complicazioni e
ricadute, maggiore recupero, migliore alleanza terapeutica, migliore gestione dei problemi cronici: la psicologia fa la differenza nella cura dei disturbi e malattie fisiche – ha sottolineato Lazzari -. Ma anche nei disturbi psichici e nelle malattie mentali: la psicoterapia è spesso più efficace dei farmaci, senza effetti collaterali e con risultati più duraturi. Ma ancora nel 2023 gli psicologi sono un lusso negli ospedali, nelle scuole, nelle strutture per anziani, persino nei centri di salute mentale».


Se, secondo gli psicologi, lo Stato non sembra ancora accorgersi a pieno dell’utilità della psicologia come prevenzione, chi invece lo ha senza dubbio colto è la popolazione italiana, che negli ultimi anni ha mutato il proprio atteggiamento riscoprendo la figura dello psicologo. Sempre secondo l’indagine Piepoli-Cnop, rispetto a dieci anni fa, l’immagine di questo professionista nella società è migliorata per il 43 per cento degli intervistati. Tanto che il 23 per cento dichiara di essersi rivolto a uno psicologo o psicoterapeuta, con un + 6
© VGstockstudio/shutterstock.com
per cento rispetto ad aprile 2023. Gran parte di coloro che hanno fatto questa scelta sono donne e giovani: il 27 per cento del campione che ha risposto affermativamente è femminile e di età compresa tra 18 e 34 anni. Ancora il 23 per cento degli intervistati dichiara che si rivolgerebbe a un esperto se avesse problemi di tipo psicologico e, anche in questo caso, si registra un +6 per cento rispetto a due mesi fa. Più della metà delle risposte affermative (55 per cento) provengono da over 54. Spicca poi un ruolo determinante per il bonus psicologico, la cui notorietà è cresciuta del 18 per cento in un anno. Più di un italiano su due ritiene che potrebbe spingerlo a rivolgersi a un esperto, qualora ne avesse bisogno. Infine, oltre il 90 per cento degli intervistati dichiara di ritenere utile l’introduzione degli psicologi negli ospedali, nelle scuole e nei servizi sociali. Inoltre, l’80 per cento del campione ritiene che il ricorso allo psicologo sia di aiuto per superare periodi particolari di stress e disagio. (B. L.)
DIMOSTRAGLI IL
Il microchip è il modo migliore per ritrovare il tuo amico a quattrozampe in caso di smarrimento.
E allora cosa aspetti?
Se il tuo cane o il tuo gatto non lo hanno ancora, recati dal tuo veterinario o al servizio veterinario pubblico competente per territorio, per identificarlo e iscriverlo in anagrafe degli animali d’affezione!
COS’È IL MICROCHIP E A COSA SERVE?
● Il microchip, obbligatorio per legge per il cane e presto anche per il gatto, è un piccolo dispositivo elettronico che identifica il tuo amico a quattrozampe e lo lega a te in maniera unica. L’identificazione con microchip di cani, gatti e furetti è inoltre obbligatoria per poter acquisire il passaporto europeo, per recarsi all’estero.

● Non temere per la sua salute: l’inserimento del microchip è sicuro e indolore!
È un’iniziativa del Ministero della Salute in collaborazione con LAV
Un team di ricercatori dell’Università di New York ha scoperto che l’incanutimento dei capelli è dovuto ad un fallimento cellulare delle cellule staminali dei melanociti
Icapelli bianchi sono stati spesso argomento di dibattito estetico: lasciarli naturalmente grigi, tingerli, tagliarli, ma ora dopo più di 10 anni di lavoro, un team di ricercatori dell’Università di New York ha scoperto che l’incanutimento dei capelli è dovuto ad un fallimento cellulare delle cellule staminali dei melanociti. È proprio così, ogni capello contiene delle cellule staminali nella zona del bulge, a metà altezza del follicolo; queste staminali nel tempo più che esaurirsi rimangono bloccate ed è arrestando la migrazione nei compartimenti di differenziazione che cessa la produzione di melanina e i fusti ingrigiscono perdendo il colore naturale.
Bibliografia
• Qi Sun, et al: “Dedifferentiation maintains melanocyte stem cells in a dynamic niche”
Nature 616, 774–782 (2023).
• B. Mancini “La biologia dell’incanutimento”
Giornale dei biologi Novembre/dicembre 2020.
Anno III - N. 11/12. Pag 52-53.
Già nel 2011 si era scoperto come due gruppi di cellule staminali controllano congiuntamente il colore dei capelli: le staminali follicolari e le staminali melanocitarie (McSC). Si era già visto inoltre come la proteina Wnt fosse la coordinatrice dell’attivazione di queste cellule e determinasse il funzionamento dei melanociti.

Questo nuovo lavoro, condotto dai ricercatori della Grossman School of Medicine, si è concentrato sulle McSC della pelle dei topi, presenti anche nell’uomo. Il colore dei capelli dipende dal fatto che le McSC, che si moltiplicano continuamente e si spostano lungo il follicolo, vengano segnalate per diventare cellule mature che poi produrranno i pigmenti proteici responsabili del colore. La novità è che la ricerca pubblicata su Nature dimostra che queste cellu-
le sono straordinariamente plastiche: durante la normale crescita dei capelli, queste cellule si muovono continuamente sull’asse di maturazione mentre transitano tra i compartimenti del follicolo pilifero in via di sviluppo. Nello specifico, il team di ricerca ha scoperto che le McSC si trasformano tra il loro stato di cellule staminali più primitive ad una fase successiva di maturazione a seconda della loro posizione, una trasformazione spesso reversibile. Infatti, è proprio all’interno dei diversi compartimenti anatomici follicolari che le McSC sono esposte a diversi livelli di segnali proteici (WNT) che ne influenzano la maturità.
I ricercatori sono riusciti a seguire e tracciare gli spostamenti delle cellule in vivo nei topi, grazie a tecniche per la visualizzazione in vivo in 3D e a tecnologie per il sequenziamento dell’RNA in tempo reale. Incredibilmente le McSC si differenziavano mentre si muovevano tra un compartimento e l’altro del follicolo pilifero e poi ritornavano indietro ripristinando lo stato di staminali. Un dato davvero nuovo che smantella il dogma della unidirezionalità staminale-cellula differenziata. In aggiunta, i dati raccolti dimostrano anche che col passare del tempo, man mano che i capelli cadono e ricrescono durante i
diversi cicli vitali all’interno del follicolo, sempre più staminali perdono la loro peculiare capacità di muoversi su e giù bloccandosi letteralmente in alcune zone del follicolo e perdendo la capacità di rigenerare pigmento. In pratica, con l’invecchiamento le McSC restano intrappolate nel rigonfiamento della zona del bulge, non maturano e non riescono a scendere nella zona germinale del bulbo dove la proteina Wnt le avrebbe indotte a trasformarsi in melanociti che

producono pigmento. Durante l’invecchiamento, vi è quindi un accumulo di McSCs bloccate che non contribuiscono più alla rigenerazione della progenie dei melanociti.
Questo nuovo modello di manutenzione McSC evidenzia un livello di plasticità precedentemente sconosciuto. L’obiettivo degli esperti è ora capire come ripristinare la motilità dei melanociti per riportarli fisicamente nel loro compartimento germinale, dove possono continuare a produrre pigmento.
Tutto il mondo cosmetico si sta domandando se questa scoperta possa davvero portare a recuperare il colore dei capelli senza dover più ricorrere alla tintura o ancora meglio a prevenirne l’incanutimento.
I meccanismi rivelati in questa nuova pubblicazione si riferiscono a condizioni biochimiche e biologiche presenti nei topi, ma è possibile che tali meccanismi siano gli stessi anche nell’uomo, servono senza dubbio ulteriori studi di conferma. Se così fosse sarebbe utile, e di grande potenziale, studiare un procedimento capaci di invertire o prevenire l’ingrigimento dei capelli umani aiutando le cellule bloccate a tornare tra i compartimenti di differenziazione dei capelli nel follicolo. Il grande entusiasmo sollevato per questa scoperta necessita ancora di alcune riflessioni da considerare: l’elevata prevalenza dell’ingrigimento dei capelli nella storia evolutiva dell’uomo suggerisce che potrebbero esserci svantaggi specifici nel mantenimento a lungo termine delle McSC. Su questa linea, un’implicazione di questa scoperta è che la marcata capacità dei melanociti normali di mantenere la capacità di auto-rinnovamento dopo aver subito la differenziazione potrebbe almeno in parte essere alla base della natura plastica del melanoma, patologia in cui non si arresta la produzione di melanina.

Tra i suoi componenti c’è vitamina C, acidi clorogenico e neoclorogenico, acido caffeico, quercetina, catechina, kaempferolo, acido p-cumarico, minerali e acidi grassi

L’Actinidia arguta è una pianta da frutto rampicante che ha suscitato molto interesse, perché durante la sua produzione, vengono generati diversi sottoprodotti (frutti, foglie, steli, fiori e radici), riconosciuti per gli effetti sulla salute, il cui riutilizzo è una sfida da superare da parte dei produttori di cosmetici. Tra questi svolgono un ruolo fondamentale: la vitamina C, gli acidi clorogenico e neoclorogenico, l’acido caffeico, la quercetina, la catechina, il kaempferolo, l’acido p-cumarico, i minerali e gli acidi grassi.
Tratto da “Extraordinary composition of Actinidia arguta by-products as skin ingredients: A new challenge for cosmetic and medical skincare industries”, di Ana Margarida Silva, Paulo C. Costa, Cristina Delerue-Matos, Piotr Latocha, Francisca Rodrigues.
Negli ultimi anni, i sottoprodotti alimentari e i problemi ambientali associati a questi sono diventati una sfida per le industrie agroalimentari, per i governi e la società civile (Fernández, Espino, Gomez e Silva, 2018). Gli ultimi dati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) rilevano che i sottoprodotti pari all’
8% dello spreco alimentare totale (Stenmarck A et al., 2016), sono composti: da bucce, fiori, steli, foglie, semi e polpe (Comunian, Silva e Souza, 2021), e la maggior parte di questi residui non viene trasformata per limitazioni tecniche o difficoltà di accesso al mercato.
L’UE ha come obiettivo di dimezzare lo spreco alimentare pro capite a tutti i livelli entro il 2030, i ricercatori mostrano interesse sulla composizione bioattiva degli scarti alimenta-

ri, dai quali potrebbero essere ottenuti nuovi principi attivi, un’idea in linea con l’economia circolare, compresi gli aspetti economici, sociali e ambientali dell’Agenda 2030, il tutto dovrebbe essere attuato da diversi settori, comprese le industrie cosmetiche che si dedicano alla produzione di prodotti destinati alla cura della pelle. Tra l’ampia gamma di composti bioattivi, i polifenoli, sono i più interessanti, essendo particolarmente presenti nei sottoprodotti della frutta, di questi sono ampiamente riconosciute le attività antiossidanti, antinfiammatorie, antimicrobiche o persino antitumorali.
I consumatori moderni pongono attenzioni ai prodotti naturali per vari morivi: potenziali azioni biologiche, sicurezza, efficacia e redditività, ecco che così si crea una nuova nicchia di mercato. È indispensabile però effettuare per ogni sottoprodotto un’analisi approfondita e imparziale, evidenziando i vantaggi ma anche la normativa attuata. I prodotti cosmetici hanno un ruolo importante nell’aspetto della pelle, perché devono fornire una sensazione e un odore gradevole, mantenendo e migliorando la salute di essa.

Proprio perché gli ingredienti cosmetici aumentano, il regolamento dell’UE estremamente restrittivo, ha implementato un vasto elenco di test da eseguire per convalidare nuovi ingredienti, essendo vietati i test sugli animali in Europa dal 2004 per i prodotti finali e successivamente (2009) per gli ingredienti, è stata introdotta come alternativa il test in vitro, perché valutare la sicurezza di ciascun ingrediente cosmetico è alla base della valutazione della sicurezza di un prodotto cosmetico. La struttura della pelle si basa su una disposizione di cellule, tessuti ed elementi della matrice che raggiunge quasi il 16% del peso corporeo. L’epidermide, strato più esterno, costituito da cheratinociti, melanociti, cellule di Langerhans e Merkel, responsabili di fornire una barriera tra l’ambiente e il corpo interno. Lo strato corneo, livello superficiale dell’epidermide, è un sottile strato eterogeneo è la principale barriera al trasporto di ingredienti, vale a dire composti bioattivi.
Il derma promuove la forza, il sostegno e la flessibilità della pelle ed è composto da uno strato papillare superiore, che contie -
ne fibre di collagene disposte in modo non serrato e da uno strato reticolare con fibre di collagene dense disposte parallelamente alla superficie. I fibroblasti situati nel derma producono collagene, elastina e proteoglicani strutturali, infatti, parliamo di una struttura vascolare, irrigata da vasi sanguigni e linfatici, con nervi, ghiandole sebacee, follicoli piliferi.
I composti bioattivi non raggiungono il derma e agiscano principalmente nello strato superiore della pelle, che dovrebbe essere garantito e verificato dall’industria cosmetica e dalle autorità di regolamentazione.

Alla luce del crescente interesse per l’utilizzo di sottoprodotti vegetali o rifiuti generati durante la produzione di frutta sotto forma di additivi alimentari, integratori, cosmetici, l’actinidia può diventare una preziosa fonte di tale materia prima, infatti è stata finora al centro dell’interesse mondiale. L’interesse per la coltivazione di Actinidia arguta per il suo frutto (kiwiberry) è aumentato per i diversi sottoprodotti e rifiuti generati durante la loro produzione, per la ricchezza di
composti bioattivi, come polifenoli, vitamine, minerali, pigmenti e sostanze volatili.
In Actinidia arguta (kiwiberry) ci sono più di 20 nutrienti essenziali, essendo uno dei frutti più ricchi di nutrienti, e soprattutto una fonte preziosa di vitamine tra cui la C. È possibile ottenere numerosi composti bioattivi dai sottoprodotti di A. arguta, ma, nessuno di essi è stato incorporato in formulazioni cosmetiche per la cura della pelle, nonostante questi potrebbero avere un effetto benefico sulla pelle se somministrati come ingrediente cosmetico, infatti qualsiasi studio ne ha esaminato le potenzialità proprio come possibili ingrediente.
I prodotti cosmetici contenenti sottoprodotti di A. arguta per la cura della pelle sono visti come una modalità sostenibile ed ecologica, che oltre a contribuire all’aspetto e alla salute della pelle, può fornire effetti: fotoprotezione, antietà e antinfiammatori, depigmentanti ed emollienti. Infine l’impatto sulla valorizzazione dei sottoprodotti alimentari e sull’economia circolare sarà il futuro della cosmetica.

Balene, delfini e tartarughe: solo nel 2022, in 40 giornate di monitoraggio, su oltre 10mila km percorsi, i ricercatori ISPRA hanno registrato un totale di 556 avvistamenti
Da secoli il Mediterraneo è stato testimone d’innumerevoli vicende storiche, ma ora è diventato anche una finestra privilegiata per osservare uno spettacolo naturale unico. I ricercatori dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) hanno documentato, infatti, un numero record di avvistamenti riguardanti balene, delfini e tartarughe nel corso delle spedizioni nel 2022.
Durante
quaranta giornate di monitoraggio, gli studiosi hanno registrato ben 556 avvistamenti, coprendo oltre diecimila km e dedicando 288 ore all’osservazione. Tra i rilevamenti spiccano 465 stenelle striate, 67 tursiopi, 13 incontri con i cosiddetti “giganti del mare” come la balenottera comune e il capodoglio, e alcune individuazioni isolate con il delfino comune e il grampo. Un evento straordinario è stato osservare sei salti da parte di un capodoglio. Questi ri- sultati sono il frutto del primo anno legato al progetto “Life conceptu maris” (CONservation of CEta -
ceans and Pelagic sea TUrtles in Med: Managing Actions for their Recovery In Sustainability). Tra gli obiettivi si vuole contribuire alla conservazione e protezione degli ospiti presenti nel bacino del Mediterraneo, integrando tecniche classiche con tecnologie all’avanguardia. La presenza di attrezzi da pesca abbandonati, il traffico marittimo e l’inquinamento da plastica stanno, difatti, avendo effetti sempre più negativi sulla vita dei cetacei e delle tartarughe marine. Per questo motivo, è diventato urgente comprendere meglio la distribuzione delle specie più diffuse al fine di adottare strategie di conservazione efficaci.

Nel periodo 2022-2025 si prevede di raccogliere nuovi dati sulla concentrazione della fauna marina, sulle loro preferenze ecologiche e sulle principali pressioni antropiche. Le procedure adottate in questa prima fase saranno replicate a partire da questo mese anche nel Santuario dei cetacei Pelagos, dentro il Corridoio di migrazione spagnolo e nella regione Adriatico-Jonio orientale. Inoltre, nell’ambito della campagna citizen science, Ispra ha presentato il progetto e reclutato già colleghi e cittadini interessati a collaborare nelle attività di raccolta dati da traghetto. «È essenziale - si legge sul sito https://www. lifeconceptu.eu/ - il sostegno delle compagnie di navigazione Balearia, Corsica & Sardinia Ferries, Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines, Minoan Lines, Tirrenia, che mettono a disposizione del progetto i loro traghetti passeggeri. Sarai in grado di identificare le specie durante una formazione teorica (online) e pratica a bordo di traghetti, su una delle 16 diverse rotte disponibili nel bacino del Mediterraneo occidentale».
Finora sono stati coinvolti a livello internazionale oltre 70 ricerca -
Da gennaio 2022 è stato avviato il programma finanziato dallo strumento Life dell’Unione Europea per l’Ambiente. Si concentrerà su molte sfide per i prossimi quattro anni, utilizzando strategie di conservazione, oltre a unire gli sforzi e le competenze d’importanti enti italiani e internazionali: Ispra, in qualità di beneficiario coordinatore, Area Marina Protetta “Capo Carbonara”, CIMA Research Foundation, CMCC Climate, ÉcoOcéan Institut, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Triton Research, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Palermo, Universitat de València - UV, Università degli Studi di Torino.
tori, 42 esperti di 27 enti, tra autorità nazionali, locali, sovranazionali, organismi di ricerca e compagnie di navigazione. Grazie a questo impegno congiunto, è stato possibile conquistare tutti gli obiettivi prefissati per il primo anno.
Numerosi sono stati anche i contatti con la tartaruga comune (256), in gran parte giovani individui “scrutati” in riposo sulla superficie. Tra gli altri rappresentanti della biodiversità, sono state registrate 250 osservazioni occasionali per diverse varietà di meduse, pesci e uccelli marini. Oltre ai dati, provette di acqua per l’estrazione del Dna ambientale sono state raccolte in ventotto stazioni di campionamento fisse e due in contemporanea al controllo di una balenottera comune e un capodoglio.
Gli esperti dell’Università Milano Bicocca li analizzeranno dal punto di vista genetico, mentre il team dell’Università di Palermo si occuperà di ricostruire le catene alimentari marine dell’area tenuta sotto controllo. Queste informazioni permetteranno di comprendere come la relazione preda-predatore possa influire sugli spostamenti di cetacei e tartarughe marine. I risultati verranno, infine, diffusi al termine della stagione d’indagine 2023. Ogni ricerca visiva di un abitante del mare nostrum ci ricorda la necessità di adottare misure concrete per proteggere l’ecosistema marino e preservare la diversità a rischio per la sovrapesca, l’inquinamento acustico, lo sfruttamento delle risorse e i cambiamenti climatici.
(G.
P.).Lo studio analizza i dati della mobilità e della qualità dell’aria al 2022 nelle 14 città metropolitane italiane. Al capoluogo lombardo seguono Firenze, Venezia e Bologna

Il risveglio della mobilità urbana nel 2022, dopo il lungo letargo post-pandemia, ha visto i trasporti pubblici che hanno faticato a riprendersi dalla drastica riduzione dei passeggeri imposta dalle restrizioni sanitarie, mentre l’automobile ha continuato a dominare gli spostamenti cittadini, anche se non ha raggiunto i livelli del 2019, influenzata dal lavoro agile. Parallelamente, rimane ancora incerta la crescita dei trasferimenti a piedi e in bicicletta nei prossimi anni. Oltre agli obiettivi necessari per ridurre le emissioni inquinanti, la congestione, gli incidenti e la mortalità stradale, ora si aggiungono quelli di decarbonizzazione entro il 2030, che devono essere perseguiti con urgenza per trasformare le città in ambienti a emissioni zero nell’orizzonte finale del 2050.
Il Rapporto “MobilitAria 2023”, realizzato da Kyoto Club e dall’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA), ha analizzato in dettaglio i dati su movibilità e qualità dell’aria in quattordici città metropolitane, immortalando l’Italia in viaggio.

Come nelle edizioni precedenti, si guarda a ciò che finisce nei nostri polmoni, determinando le concentrazioni d’inquinanti e i superamenti dei limiti nel periodo 2006-2022. Rispetto a due anni fa, si è osservato un aumento nel biossido di azoto (NO2) in quasi tutte le località. Per quanto riguarda il PM10, le quantità medie annue nel 2022 sono rimaste al di sotto dei limiti, ma si è delineata una realtà differenziata: cinque capoluoghi del Sud hanno registrato una diminuzione nelle stazioni di traffico, mentre sei del Nord hanno fatto rilevare una crescita. Napoli e Roma non hanno subito variazioni significative, tuttavia, molte continuano a superare più di 35 volte il limite giornaliero del PM10 nel corso di un anno.
I “sorpassi” relativi a biossido d’azoto e le particelle PM10 e PM2,5 si discostano significativamente dalle soglie stabilite nella nuova Direttiva europea e dai limiti raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo la ricerca, sulle nove città italiane candidate a raggiungere zero emissioni entro il 2030, quelle totali derivanti dal settore dei mezzi rappresentano il 23,5%.
Una novità è l’indice sintetico della distanza rilevata dei grandi poli cittadini rispetto ai
Nel rapporto vengono affrontate diverse questioni in modo approfondito: si forniscono verifiche e proposte per centri sempre più vivibili; viene analizzato l’impatto della nuova Direttiva europea sulle caratteristiche di ciò che respiriamo; ci sono le considerazioni sulle mete per il periodo 2020-2030 in modo da raggiungere, il più possibile, bassi rilasci dannosi per l’ecosistema, osservando la situazione attuale e vagliando le risposte dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di promuovere azioni su misura. Oltre a questi resoconti, ci sono cinque contributi esterni redatti da esperti, due dei quali offrono una prospettiva europea, mentre gli altri trattano tematiche come la sicurezza stradale e la pianificazione urbana.
propositi di taglio delle emissioni di gas serra e vivibilità. L’osservazione, basata su un modello dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, ha misurato la condizione attuale basandosi su cinque indicatori chiave (trasporto pubblico, mobilità attiva a piedi e in bicicletta, condivisa, tasso di motorizzazione e ripartizione modale) e ha fornito una valutazione complessiva. È emerso un numero che rappresenta il “Deficit di mobilità sostenibile” di ciascun protagonista. Successivamente, è stata stilata una classifica in ordine crescente con lo scopo di confrontare il contesto, sia nel complesso sia per ciascuno dei cinque riferimenti considerati. Ricordiamo che tra i traguardi al 2030 vi è quello di ridurre del 50% il numero di veicoli in circolazione, potenziare ed elettrificare i mezzi di locomozione pubblici, promuovere percorsi ciclabili, pedonali e favorire la ripartizione modale verso sistemi amici dell’Ambiente.
«Il Deficit di mobilità sostenibile al 2030 complessivo e le differenze delle 14 città che emergono dal Rapporto sono evidenti. Sicuramente i PUMS e la loro attuazione sono lo strumento efficace delle Amministrazioni per far crescere la mobilità sostenibile. MobilitAria - dichiara Marco Talluri, Gruppo di Lavoro “Mobilità sostenibile” di Kyoto Club - contiene le proposte di Kyoto Club e CNR-IIA per la mobilità sostenibile e appoggiamo quelle città che si stanno impegnando per andare nella giusta direzione. Infine, sul PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) vogliamo che, in linea con le altre associazioni ambientaliste, venga aggiornato e rivisto dal Governo per adeguarlo ai target del green deal».
Milano si avvicina di più alle sfide europee 2030 con un “passivo” del -32%, mentre Catania è la città più lontana con un grave -76%. Approfondendo i cinque segnalatori, il capoluogo lombardo risulta essere più vicino per quanto riguarda la mobilità condivisa, la ripartizione modale e il tasso di motorizzazione, laddove per i vettori pubblici e la circolazione attiva mostra un maggiore divario. L’adozione di politiche e interventi efficaci per limitare l’impatto ambientale dei veicoli, risulta, quindi, fondamentale per creare luoghi più vivibili, salubri e in linea con gli obiettivi di sostenibilità a livello nazionale ed euro-continentale. (G. P.).
Sorprendentemente, circa la metà di quanto osservato (52%) proviene solo da dieci tipologie di oggetti, su un totale di 180 categorie considerate. Tale dato mette in luce due aspetti: in primo luogo, l’entrata tra i primi dieci posti, direttamente al quarto, dei detriti edilizi, che rappresentano il 5,8%; in secondo luogo, la diminuzione delle stoviglie usa e getta, che quest’anno si posizionano none (3%). Per combattere questa situazione e prendersi cura delle coste, l’associazione ambientalista invita tutti alla campagna “Spiagge e Fondali Puliti”. È un’iniziativa che mira a sensibilizzare coloro che continuano a utilizzare scogliere e fondali come una discarica. La salvaguardia di zone costiere, fiumi e acque riveste un’importanza cruciale e tutto inizia dai nostri stili di vita.
Le spiagge italiane continuano a rivelarsi dei luoghi contaminati a causa delle nostre abitudini sbagliate. Dalla plastica ai mozziconi di sigaretta, dai cotton fioc agli assorbenti igienici, i rifiuti rinvenuti testimoniano abitudini dannose per il Pianeta. Un monitoraggio effettuato su 38 arenili in 15 diverse regioni (Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia, Sardegna) ha rilevato che su una superficie totale di 232.800 metri quadrati campionati, sono stati contati ben 36.543 rifiuti, con una media di 961 ogni cento metri di costa. Inoltre, il 72,5% di essa è composta da polimeri artificiali e plastica, che confermano, ancora una volta, la loro posizione come il materiale più comune trovato. Quest’anno, a peggiorare la situazione, si sono aggiunti gli scarti di vetro e ceramica (9,2% del totale), principalmente costituiti da materiali da costruzione, come tegole, mattoni e piastrelle, smaltiti in modo irregolare. Seguono il me-

tallo (6,8% tra quanto raccolto), carta e cartone (3,9%). Gli altri ritrovamenti includono tessuti, legno trattato, gomma, bioplastica, avanzi alimentari e sostanze chimiche.
Si attestano primi i frammenti plastici, che sono il 10,9%; seguono i tappi e i coperchi, i quali contribuiscono all’8,6% e i mozziconi di sigaretta (6%). Alla quinta posizione ci sono i cotton fioc (4%). Alla sesta e alla settima si trovano, rispettivamente, pezzetti di polistirolo, bottiglie e contenitori per bevande. Chiudono l’elenco, all’ottavo e al decimo altri oggetti plastici e le bottiglie di vetro, che costituiscono una nuova e negativa entrata tra gli “spiaggiati”. Fra le materie plastiche raccolte, il 46% è costituito da

10+1 oggetti considerati nella SUP (Single Use Plastics), la Direttiva europea che mira a limitare l’uso di plastiche monouso, non biodegradabili e non compostabili, e che è stata applicata in Italia a partire da gennaio 2022.

Le bottiglie in Pet (Polietilene tereftalato), inclusi i tappi e gli anelli, si confermano ancora una volta come la tipologia più comune sui litorali campionati dai collaboratori di Legambiente, contati ben 5.487 volte. Seguono i mozziconi di sigaretta, reti, attrezzi da pesca e acquacoltura in plastica, entrambi rappresentanti
il 15% nella categoria SUP. Per quanto riguarda i contenitori per alimenti, si fermano sull’1% di quanto rinvenuto, i bicchieri sono solo lo 0,7% e il 3% degli oggetti della SUP. Completano la categoria alimentare le posate e i piatti, l’1% degli oggetti SUP. L’elencazione si conclude con le cannucce e gli agitatori per cocktail e le buste di plastica. Infine, gli assorbenti igienici e i palloncini di gomma, per i quali è stata proposta un’etichettatura chiara per indicarne l’impatto sull’ambiente e la presenza inquinante.E’ fondamentale anche il nostro coinvolgimento attivo: il mare dipende da noi. (G. P.).
Il più recente antenato comune di tutti gli animali, vissuto 600 o 700 milioni di anni fa, era una creatura dal corpo molle, trasparente e iridescente, simile agli attuali ctenofori
Più di mezzo miliardo di anni fa, negli antichi oceani primordiali comparvero i primi animali. Su quale aspetto avessero, continua da oltre un secolo, un acceso dibattito tra gli scienziati ma pare che ora, grazie a una nuova tecnica di analisi cromosomica, sia pronto il loro “identikit”. Si tratterebbe di minuscole creature, trasparenti, iridescenti, talvolta fosforescenti somiglianti agli odierni ctenofori.
Cercando il primo ramo dell’albero della vita animale tra gli animali di oggi dall’aspetto più primitivo, gli scienziati hanno progressivamente ristretto le possibilità a due gruppi: le spugne che trascorrono l’intera vita adulta sempre nello stesso posto filtrando il cibo dall’acqua di mare, e le gelatine a pettine, voraci predatori quasi tutti planctonici, dotati di otto serie di pettini (cteni) che consentono loro di muoversi attraverso gli oceani di tutto il mondo. Contrariamente a quanto si è creduto finora, da un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature, questi primi animali che si spostavano nell’acqua in cerca di cibo sono comparsi prima delle spugne, che erano invece stanziali.
Grazie a un approccio innovativo basato sulla struttura dei cromosomi, un team internazionale di scienziati dell’Università della California, Berkeley e dell’Università di Vienna è arrivato alla conclusione che le gelatine a pettine, o ctenofori (dal greco ktenos, “pettine” e phoros, “che porta”), sono stati il primo gruppo a stac-
carsi dall’albero degli animali. Nonostante ctenofori e spugne abbiano in seguito continuato a evolversi dal loro antenato comune, i biologi evoluzionisti ritengono che questi gruppi condividano ancora caratteristiche con i primi animali e che lo studio di questi primi rami dell’albero della vita animale possa far luce su come gli animali si siano sviluppati ed evoluti fino alla diversità di specie che vediamo oggi.
«Il più recente antenato comune di tutti gli animali - ha dichiarato Daniel Rokhsar, professore di biologia molecolare e cellulare dell’Università della California, Berkeley e autore del lavoro insieme a Darrin Schultz e Oleg Simakov dell’Università di Vienna - è vissuto probabilmente 600 o 700 milioni di anni fa». «È difficile sapere come fossero - spiega Rokhsar - perché erano animali dal corpo molle e quindi non hanno lasciato una traccia fossile diretta. Possiamo però usare il confronto tra gli animali viventi per conoscere i nostri antenati comuni». «È emozionante – continua l’autore - stiamo guardando indietro nel tempo e grazie al raffronto tra i genomi stiamo scoprendo tante cose su questi primissimi antenati».
Come spiega Schultz, le meduse, gli anemoni di mare, le spugne e gli ctenofori, hanno un corpo semplice e mancano di molte caratteristiche bilaterali - per esempio, non hanno un cervello definito e possono anche non avere un sistema nervoso o muscoli - ma condividono comunque i tratti distintivi della vita animale,
in particolare lo sviluppo di nuovi individui a partire da un uovo fecondato.
I metodi filogenetici usati finora e basati sulle sequenze geniche non sono riusciti a risolvere la controversia se le spugne o le gelatine a pettine fossero il ramo più antico dell’albero animale. Per questo motivo, nel nuovo studio i ricercatori hanno utilizzato un nuovo approccio basato sullo studio dell’organizzazione dei geni nei cromosomi. Ogni specie ha un numero caratteristico di cromosomi e una particolare distribuzione dei geni lungo di essi. Rokhsar, Simakov e collaboratori avevano in precedenza dimostrato che i cromosomi di spugne, meduse e molti altri invertebrati possiedono diversi insiemi di geni simili, nonostante più di mezzo miliardo di anni di evoluzione indipendente. Questa scoperta ha suggerito che i cromosomi di molti animali si evolvono lentamente e ha permesso al team di ricostruire computazionalmente i cromosomi dell’antenato comune di questi diversi animali.

Nello studio i ricercatori hanno pensato di sequenziare i genomi di una gelatina, di una spugna e di tre creature unicellulari che non
Daniel Rokhsar.“È difficile sapere come fossero perché erano animali dal corpo molle e quindi non hanno lascia-to una traccia fossile diretta. Possiamo però usare il confronto tra gli animali viventi per conoscere i nostri antenati comuni”.
appartengono al genere animale: un protozoo coanoflagellato, un’ameba e un parassita dei pesci chiamato ittiosporeo. Quando il team ha confrontato i cromosomi di queste diverse specie, ha trovato alcuni riarrangiamenti condivisi dalle spugne e dagli animali non ctenofori. Al contrario, gli ctenofori assomigliavano di più ai non animali. «La spiegazione più semplice è che gli ctenofori si siano staccati prima che avvenissero i riarrangiamenti. Le impronte digitali di questo antico evento evolutivo sono ancora presenti nei genomi degli animali a distanza di centinaia di milioni di anni» ha spiegato Schultz. L’ipotesi opposta che vedrebbe le spugne comparire prima potrebbe essere vera se molteplici riarrangiamenti convergenti fossero avvenuti sia nelle spugne sia negli animali non ctenofori, il che secondo l’autore è molto improbabile.
Secondo gli scienziati, il nuovo studio potrà essere utile anche per comprendere meglio le funzioni di base che tutti noi animali condividiamo, per esempio il modo in cui percepiamo l’ambiente, il modo in cui mangiamo e ci muoviamo nello spazio. (S. B.)

poi iniziare a esaminare quanto tempo impiegassero a trovare una femmina simulata utilizzando un dispositivo Light Emitting Diode (LED) di colore verde che imitava il bagliore femminile.
Successivamente, i ricercatori hanno acceso una luce bianca sopra il labirinto, variando l’intensità da 25 Lux (25 volte più luminosa della luce lunare) a 145 Lux (equivalente alla luce di un lampione). È emerso che tutte le lucciole hanno individuato il LED al buio, ma solo il 70% ha trovato il LED ai livelli più bassi di luce bianca e solo il 21% è riuscito a individuarlo alla luce più intensa. Inoltre, la luce bianca ha influenzato negativamente la capacità dei maschi di trovare una femmina, aumentando anche il tempo impiegato per raggiungere il LED. Al buio, le lucciole impiegavano 48 secondi per raggiungerlo, mentre con livelli bassi di luce bianca hanno impiegato 60 secondi.
L’Università del Sussex ha dimostrato come l’inquinamento luminoso modifica il comportamento di questi insetti
L’Università del Sussex ha condotto uno studio sulle lucciole, dimostrando che la luce artificiale rende difficile per i maschi individuare le femmine luminose. Ciò potrebbe avere conseguenze disastrose sulla riproduzione delle future popolazioni di lucciole nel mondo. Nonostante le luci brillanti delle città siano considerate meraviglie del mondo moderno e utili per il lavoro, la sicurezza e il godimento del mondo circostante anche dopo il tramonto, l’illuminazione artificiale ha un prezzo per gli animali notturni, comprese le lucciole e persino le persone stesse.
L’inquinamento luminoso colpisce molti animali, inclusa la lucciola comune (Lampyris noctiluca). Le femmine di questa specie emettono una luce verde dall’addome per attirare i maschi in volo, ma a causa dell’inquinamento luminoso non sono in grado di volare verso nuovi luoghi per sfuggirgli.

Per studiare gli effetti della luce artificiale sul comportamento delle lucciole, Estelle Moubarak dell’Università del Sussex ha raccolto esemplari dalle South Downs, nel Regno Unito, e li ha portati in laboratorio. Qui ha trasferito gli insetti maschi in un labirinto a forma di Y, privo di luce artificiale, per
L’illuminazione del labirinto ha anche comportato un aumento del tempo che i maschi hanno trascorso nella parte inferiore senza muoversi verso una femmina. Al buio, gli insetti trascorrevano solo 32 secondi nella parte inferiore della Y, mentre con l’illuminazione più intensa trascorrevano 81 secondi. Le lucciole, quando abbagliate dalla luce bianca, hanno oscurato i loro occhi composti con uno scudo sulla testa, riducendo la quantità di luce brillante che vedono. Questo comportamento mostra che cercano di evitare l’esposizione alla luce bianca, che sembrano non gradire.
«Quando la luce bianca illuminava l’area con il finto Light Emitting Diod (LED) femminile – ha commentato Estelle Moubarak - le lucciole hanno oscurato i loro occhi per circa il 25% della prova, rispetto a solo lo 0,5% del tempo quando il labirinto era al buio».
«Se questa tendenza si confermerà - ha affermato Jeremy Niven, dell’Università del Sussex, nel Regno Unito - i prati e le brughiere di Europa e Asia che per milioni di anni si sono illuminati con lo scintillio delle femmine delle lucciole diventeranno bui».
Individuare precocemente un tumore può fare la di erenza. Il Servizio sanitario nazionale o re screening gratuiti, sicuri e attendibili, per la prevenzione dei tumori al colon-retto, al collo dell’utero e alla mammella.
Aderisci all’invito della tua Azienda sanitaria. Non rinviare l’appuntamento con la salute.
Scopri di più su salute.gov.it
#laprioritàseitu
Aggiornato MULocDeep, il software di intelligenza artificiale che identifica la posizione delle proteine a livello subcellulare e apre la strada a nuove scoperte biologiche
Poter prevedere la posizione di una proteina all’interno della cellula è importante per comprendere i meccanismi patologici associati a diverse malattie. Questa previsione può portare a nuove scoperte scientifiche legate a numerose applicazioni come la formulazione di nuovi farmaci o il trattamento di malattie neurologiche come l’epilessia.
Per predire computazionalmente la localizzazione delle proteine, è possibile addestrare un modello di apprendimento automatico che fornisce le probabilità di appartenenza di una proteina a diversi compartimenti cellulari utilizzando le proprietà della proteina o altre informazioni rilevanti. Questo processo però spesso si complica poiché alcune proteine sono note per esistere in più di un organello e perché nella maggior parte degli scomparti cellulari esistono diversi compartimenti sub-organellari. Inoltre, i meccanismi alla base della localizzazione delle proteine e dei peptidi targeting non sono ancora del tutto compresi.
Recentemente Dong Xu, professore presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica dell’Università del Missouri, e i suoi colleghi hanno aggiornato il loro modello di previsione della localizzazione delle proteine, chiamato MULocDeep, con la capacità di fornire previsioni più mirate, compresi modelli specifici per
animali, esseri umani e piante. Il modello è stato creato 10 anni fa da Xu e dal collega Jay Thelen, professore di biochimica, per studiare inizialmente le proteine nei mitocondri.
Per la previsione della localizzazione delle proteine sono stati sviluppati nel tempo numerosi approcci basati sull’apprendimento automatico e i relativi strumenti. Tra i metodi più importanti per questo scopo vi sono in generale ProtT5_LA, DeepLoc e MULocDeep. Questi metodi variano nelle caratteristiche di input, si rivolgono a specie diverse e si concentrano su problemi di localizzazione specifici.
Xu, autore principale del lavoro che è stato pubblicato sulla rivista Nucleic Acids Research, spiega così lo scopo del suo team: «Molte scoperte biologiche devono essere convalidate da esperimenti, ma non vogliamo che i ricercatori debbano spendere tempo e denaro per condurre migliaia di test per arrivarci». «Un approccio più mirato fa risparmiare tempo». «Il nostro strumento – aggiunge Xu - fornisce una risorsa utile ai ricercatori, aiutandoli a raggiungere le loro scoperte più velocemente, perché possiamo aiutarli a progettare esperimenti più mirati da cui partire per far progredire la loro ricerca in modo più efficace».
Addestrando i computer a fare previsioni utilizzando i dati esistenti, gli autori sfruttano
la potenza dell’intelligenza artificiale attraverso l’apprendimento automatico. Il loro modello può aiutare altri ricercatori che studiano i meccanismi associati alla localizzazione irregolare delle proteine, nota come “dislocazione”, che accade quando una proteina si dirige in un posto diverso da quello previsto. Quest’anomalia è spesso associata a malattie come i disturbi metabolici, i tumori e i disturbi neurologici.
«Alcune malattie sono causate da un’errata localizzazione, che impedisce alla proteina di svolgere correttamente la funzione per cui è stata progettata poiché non riesce a raggiungere il suo bersaglio o ci arriva in modo inefficiente», ha detto Xu.
Nell’articolo il team dei ricercatori descrive anche un’altra importante applicazione del modello predittivo: l’assistenza alla progettazione di farmaci mirata a spostare nella posizione corretta una proteina localizzata in un punto errato.
In futuro, Xu spera di ricevere ulteriori finanziamenti per aumentare l’accuratezza del modello e sviluppare ulteriori funzionalità. «Vogliamo continuare a migliorare il modello per arrivare a capire se una mutazione in una proteina può causare una localizzazione errata, se le proteine sono
Addestrando i computer a fare previsioni utilizzando i dati esistenti, gli autori sfruttano la potenza dell’intelligenza artificiale attraverso l’apprendimento automatico.

distribuite in più di un compartimento cellulare o, come i peptidi di segnale possono aiutare a prevedere la localizzazione in modo più preciso», ha detto Xu. «Noi non offriamo soluzioni per lo sviluppo di farmaci o trattamenti delle malattie, ma il nostro strumento può aiutare altri a sviluppare soluzioni mediche». «Oggi la scienza - continua Xu - è come una grande impresa: persone diverse giocano ruoli diversi e lavorando insieme possiamo ottenere risultati utili a tutti».
Nell’articolo gli autori hanno presentato il design dell’applicazione web MULocDeep, le tecniche e i dati utilizzati per perfezionare il modello MULocDeep originale. Per il team risulta inoltre fondamentale garantire che i metodi computazionali siano facilmente accessibili a utenti con background diversi. Per questo motivo Xu sta lavorando con i colleghi per sviluppare un corso online gratuito per studenti delle scuole superiori e dell’università basato sui concetti biologici e bioinformatici utilizzati nel modello. Lo scopo del servizio web è quello di fornire agli utenti un modo semplice per accedere a MULocDeep. L’applicazione web MULocDeep è disponibile all’indirizzo https://www.mu-loc.org/.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Cancers

Una delle neoplasie più frequenti negli uomini è certamente il tumore della prostata; al fine di individuare le possibili cause e i processi che portano il tessuto prostatico sano a diventare tumorale sono stati condotti numerosi studi tra cui quello relativo all’esame dell’infiammazione cronica della prostata. Infatti, questo processo genera una serie di eventi chimici, biochimici e cellulari all’interno della ghiandola prostatica e, pertanto, potrebbe rappresentare un potenziale fattore di rischio di sviluppo o di progressione del tumore.
Recentemente su questa forma tumorale è stato pubblicato sulla rivista internazionale Cancers uno studio, il Pros-IT2, promosso dall’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche di Padova e diretto da Stefania Maggi, dirigente di ricerca della sezione di Padova-Invecchiamento del Cnr-In.
A proposito del Pros-IT, la studiosa ha dichiarato: «Oltre al coordinamento dello studio, il Cnr ha curato la creazione della banca dati ed effettuato le analisi statistiche, grazie alla stretta e continua collaborazione tra Marianna Noale, ricercatrice del Cnr-In e respon-
sabile statistico del progetto, e i referenti clinici dei centri partecipanti. Il progetto Pros-IT Cnr, il cui scopo era il monitoraggio della qualità della vita nei pazienti affetti da tumore di prostata, ha permesso di raccogliere dati in 97 centri di urologia, radioterapia e oncologia italiani e di rispondere a numerose e importanti questioni inerenti alla qualità di vita dei pazienti trattati per tumore di prostata, evidenziando la centralità dell’approccio multidisciplinare, con oltre 10 lavori pubblicati su riviste indicizzate».
Per il Pros-IT2, sono stati raccolti i dati da circa 200 pazienti, di ciascuno dei quali sono stati valutati in media 11 prelievi bioptici prostatici, per un totale di oltre 2mila prelievi analizzati.
Stefania Maggi ha spiegato: «La maggiore criticità negli studi in questo campo è rappresentata dalla complessità nel definire e quantificare l’infiammazione prostatica. In particolare, la sede del tessuto ghiandolare interessata dal processo infiammatorio, il grado e l’estensione dell’infiammazione possono variare molto da soggetto a soggetto. Pertanto, gli studi su piccole popolazioni presenti in letteratura danno spesso risultati parziali e inconcludenti».
Lo studio ha permesso, invece, di definire per la prima volta con grande precisione il rapporto tra infiammazione e tumore prostatico. A tal proposito, Marianna Noale ha precisato: «In particolare, abbiamo chiarito che la presenza di infiammazione di grado elevato, localizzata in sede peri-ghiandolare (nel tessuto stromale che circonda il tessuto ghiandolare) e con un pattern di presentazione multifocale, è più frequentemente associata a neoplasia prostatica».
Questa importante scoperta può avere immediate ricadute cliniche, suggerendo ad esempio uno screening mirato per determinare una diagnosi precoce nei soggetti che presentano una infiammazione prostatica.
Il progetto triennale denominato Provide, acronimo di PRotein and biOmolecules sources for nutritional security and biodiversity of bakery products in a circular food system, conta su un finanziamento di circa un milione di euro e vede la partecipazione di un Consorzio di sei partner internazionali, tra cui Enea. L’obiettivo è la realizzazione di nuovi prodotti da forno ad elevato valore aggiunto attraverso l’utilizzo di proteine e molecole benefiche ricavati da scarti dell’industria agroalimentare.

Claudia Zoani, ricercatrice Enea della Divisione Biotecnologie e agroindustria e referente del progetto, ha spiegato: «Pane, pizza, biscotti e molti altri prodotti da forno sono tra gli alimenti più comuni e convenienti da consumare in luoghi, tempi e condizioni diverse. Ed ora, grazie a questo progetto, avranno tra i loro ingredienti nuove fonti proteiche e molecole dalla funzione nutrizionale e nutraceutica per rispondere alla crescente domanda di una dieta diversificata, sana e sicura. Inoltre, queste molecole possono essere estratte direttamente da sottoprodotti di altre filiere agroalimentari. In questo modo, saremo in grado di promuovere concretamente la sostenibilità e la circolarità delle produzioni e ridurre gli scarti, garantendo qualità e sicurezza dei nuovi prodotti». I ricercatori sono al lavoro sui nuovi ingredienti benefici provenienti da scarti lattiero-caseari, semi oleaginosi e residui di fermentazione della birra.
La ricercatrice di Enea ha aggiunto: «Abbiamo concluso due attività strategiche per il progetto, ossia l’identificazione e l’estrazione delle molecole e le attività dei focus group nei diversi Paesi, Italia inclusa, finalizzate a valutare l’accettabilità dei nuovi prodotti da parte dei consumatori. Ed ora sono in corso le prove di panificazione e la caratterizzazione dei nuovi prodotti da forno in termini di qualità e sicurezza alimentare».
È questo l’obiettivo del progetto Provide, che coinvolge un consorzio di sei partner internazionali, tra cui Enea
Per il progetto Provide Enea ha impiegato diverse tecnologie di estrazione a basso impatto ambientale, come quella a membrana che consente di separare componenti mirati come proteine, lattosio e riboflavina (vitamina B2) dal siero di latte e fibre dal grano esausto dei birrai senza l’uso di additivi chimici, oppure l’impianto a CO2 supercritica (pressione a 73.8 bar e temperatura a 31°C) che rappresenta un’alternativa non tossica ed economicamente vantaggiosa per l’estrazione di composti aromatici (polifenoli e flavonoidi) e volatili da sottoprodotti alimentari, in parti -
colare dai semi oleaginosi come quelli di girasole.
Claudia Zoani ha concluso: «Il progetto Provide valorizzerà i diversi sottoprodotti per ottenere cibi sempre buoni, più sani e a zero sprechi. Pensiamo al siero del latte: con 10 litri di latte si producono un Kg di formaggio e ben 9 litri di siero di latte ma questo “residuo” contiene sostanze benefiche come vitamine o proteine. Si può così ottenere una maggiore disponibilità di ingredienti fondamentali, che possono migliorare la salute e il benessere dei consumatori». (P. S.).
Definito un sistema basato sull’intelligenza artificiale per prevenire blackout elettrici causati da ondate di calore

Un team di ricercatori di Enea, Politecnico di Bari e Università Roma Tre ha realizzato un sistema, che grazie all’automazione e all’intelligenza artificiale è in grado di prevenire possibili blackout elettrici causati da ondate di calore. Questo approccio innovativo basato su tecniche di machine learning è stato testato su una grande rete di distribuzione elettrica nel Sud Italia e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica IEEE Transactions on Industry Applications.
Maria Valenti, responsabile del
Laboratorio Enea Smart grid e reti energetiche e coautrice dell’articolo insieme a Mauro Atrigna, Amedeo Buonanno, Raffaele Carli, Graziana Cavone, Paolo Scarabaggio, Mariagrazia Dotoli e Giorgio Graditi, ha spiegato: «Le infrastrutture di distribuzione dell’energia sono sistemi particolarmente vulnerabili a disastri naturali e a eventi meteorologici estremi, come le ondate di calore soprattutto nelle grandi aree urbane. Per questo risulta importante individuare nuove soluzioni di monitoraggio e di gestione della rete per la previsione di eventuali guasti, come ad esempio le
tecniche di data analysis e di machine learning che utilizziamo nel nostro innovativo approccio. Avere la possibilità di prevedere malfunzionamenti consente potenzialmente all’operatore di rete di attuare azioni correttive orientate a minimizzare i disservizi per gli utenti del servizio elettrico».
In una prima fase il team di ricerca ha “addestrato” l’algoritmo sui dati relativi ai guasti intercorsi tra il 2015 e il 2020 in una grande rete elettrica del Sud, alle condizioni meteo e ai flussi di energia, con l’obiettivo di identificare le possibili correlazioni. Nella successiva fase operativa, i ricercatori hanno provato il sistema così addestrato per l’analisi di una serie di dati di input. Valenti ha sottolineato: «I cambiamenti climatici hanno determinato un aumento delle ondate di calore, con una tendenza destinata a peggiorare nei prossimi anni a causa del riscaldamento globale. L’intensità e la durata di questi fenomeni stanno causando un numero crescente di guasti alla rete di distribuzione elettrica, soprattutto, in ambito urbano con un conseguente impatto negativo sui costi di manutenzione, sui servizi e in generale sulla vita delle persone».
In città la rete è soggetta a maggiori sollecitazioni di carico, per l’aumento della domanda di energia elettrica concentrata in particolare nelle ore più calde della giornata, a causa del maggior utilizzo degli impianti di climatizzazione. Infatti, di giorno la temperatura dell’aria supera spesso i 40 °C.
La ricercatrice Enea ha aggiunto: «Dai nostri studi è emerso che la maggior parte dei guasti si è verificato a livello di giunti dei cavi e che, pertanto, tali elementi soffrono maggiormente le problematiche delle ondate di calore. Questo risultato fornisce un elemento utile agli operatori e ai produttori di componentistica elettronica, che potranno condurre analisi più mirate per ottenere reti più resilienti». (P. S.).
Celle solari ad alta resa grazie all’utilizzo di materiali, architetture e processi innovativi per moduli fotovoltaici sostenibili, affidabili ed efficienti, da integrare in ambito urbano, nel paesaggio e nei siti di interesse storico-architettonico, con l’obiettivo di ridurre il costo dell’energia elettrica e il consumo di suolo. Queste celle solari di nuova generazione sono state realizzate nell’ambito del programma “Ricerca di Sistema elettrico- Progetto integrato Fotovoltaico ad alta efficienza” condotto da Enea in collaborazione con Cnr, Rse e varie Università. In particolare, Enea sta lavorando nei Centri ricerche di Portici (Napoli) e Casaccia (Roma), in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, allo sviluppo di nuove celle solari con la tecnologia “tandem” perovskite/silicio in grado di raggiungere efficienze maggiori del 28% nella conversione dell’irraggiamento solare in energia elettrica.
Il team di ricerca sta inoltre lavorando allo sviluppo di soluzioni innovative che integrano l’utilizzo della luce solare per fotovoltaico e fotosintesi, in grado di trasmettere la radiazione solare necessaria alla crescita delle piante e contemporaneamente generare energia elettrica. In questo contesto si stanno sperimentando coperture fotovoltaiche da applicare in serre agricole con approcci su scala di laboratorio e su larga area: strutture semitrasparenti a film sottile spettralmente selettive (aree fino a 100 cm2) e moduli fotovoltaici semitrasparenti opportunamente progettati da Enea per essere inseriti in contesti di pregio.
Paola Delli Veneri, responsabile Enea del Laboratorio Dispositivi innovativi, ha evidenziato: «Il nostro obiettivo è migliorare le prestazioni delle celle solari e studiare soluzioni applicative che promuovano la penetrazione della tecnologia fotovoltaica nel sistema produttivo e, dunque,
Moduli fotovoltaici sostenibili, per applicazioni urbane e rurali, realizzati con materiali e processi innovativi
nel sistema elettrico. Siamo fiduciosi sulla possibilità di riuscire a superare a breve la barriera “psicologica” del 30% di efficienza per le celle tandem, avvicinandoci allo stato dell’arte mondiale della tecnologia».
Oltre al miglioramento delle prestazioni dei moduli fotovoltaici attuali e all’integrazione del fotovoltaico nel contesto urbano e rurale, gli studi hanno posto grande attenzione all’utilizzo di materiali e architetture di dispositivo con prestazioni stabili nel tempo e con processi innovativi tali da risultare potenzialmente promettenti anche in un’ottica industriale di
medio/lungo termine.
Delli Veneri ha concluso: «Trasformare l’energia del sole in energia elettrica mediante la tecnologia fotovoltaica è una tra le opzioni più concrete per la decarbonizzazione del sistema energetico, in grado di contenere l’innalzamento medio globale della temperatura e contrastare i cambiamenti climatici. Ma, è altrettanto cruciale supportare l’industria italiana del settore, sostenendo anche la creazione di nuove filiere produttive e facilitando in tal modo il percorso indicato nel piano energetico nazionale». (P. S.).

A individuare le molecole è stato un team di ricerca internazionale, guidato da scienziati di tutto il mondo
C’è vita nell’universo oltre la Terra? Una domanda ancestrale, che ogni essere umano del nostro Pianeta si è posto almeno una volta nella sua esistenza. Una domanda a cui, tuttora, nonostante gli sconfinati progressi della scienza, nessuno è in grado di rispondere con certezza.
Quello che si può senz’altro affermare è che la vita è un dono raro nell’universo. Ciononostante, considerando i miliardi di pianeti che compongono la nostra galassia, e le miliardi di galassie che compongono il cosmo, è improbabile che quello terrestre sia l’unico habitat
in cui la vita si è sviluppata. Un piccolo passo in avanti nel rispondere a questo interrogativo atavico è stato mosso di recente. In una galassia distante ben 12 miliardi di anni luce dalla Terra sono stati rilevati composti organici complessi; molecole costituite, e quindi caratterizzate, dalla presenza di atomi di carbonio, cioè quelli che si possono definire i veri e propri “mattoni della vita”.
Le informazioni in nostro possesso risalgono a quando la galassia SPT041847, appartenente al cosiddetto Universo “bambino”, aveva meno di 1,5 miliardi di anni, circa il 10% della sua età attuale. La presenza di composti organici ai
primordi di tale Universo suggerisce che questi elementi potrebbero essersi diffusi ovunque, e potrebbero aver innescato la vita su una moltitudine di pianeti. Ad individuare le molecole organiche complesse nella galassia SPT0418-47 è stato un team di ricerca internazionale, guidato da scienziati dell’Istituto di Fisica Fondamentale e Astronomia presso l’Università Texas A&M, in collaborazione con i colleghi del Dipartimento di Astronomia dell’Università dell’Illinois, del Cosmic Dawn Center dell’Università Tecnologica della Danimarca, dell’Università di Montreal e di numerosi altri istituti nel mondo. La scoperta è stata possibile solo grazie a una perfetta combinazione di due elementi: la straordinaria potenza del Telescopio Spaziale “James Webb” (lanciato nello spazio il giorno di Natale del 2021) e un fenomeno noto come lente gravitazionale. La galassia SPT0418-47 si trova infatti in perfetto allineamento con la Terra e con un’altra galassia posta nel mezzo, a circa 3 miliardi di anni luce da noi.
La gravità di quest’ultima causa un vero e proprio effetto lente, grazie al quale la luce della galassia sullo sfondo, l’oggetto dello studio, viene distorta fino a formare un “anello di Einstein” (fenomeno particolare previsto dalla relatività generale). La combinazione di questo fenomeno e il potere risolutivo del “James Webb” nell’infrarosso ha permesso di analizzare i diffusi granelli di polvere della galassia. I granelli, assorbendo parte dell’energia emessa dalle stelle e riemettendola proprio nell’infrarosso, hanno poi permesso all’occhio del telescopio di rilevare gli elementi presenti. Il risultato è di fondamentale importanza per la comprensione dei processi chimici che hanno permesso la formazione stellare nell’universo primordiale. Gli astronomi pensano infatti che molecole di questo tipo siano indicative della presenza di regioni di formazione stellare, anche se le nuove osservazioni del Webb stanno modificando tali ipotesi per quel che riguarda l’universo primordiale.

Nel “Parque Reptilandia” di Dominical, un particolare zoo della Costa Rica tutto dedicato ai rettili, una femmina di Crocodylus acutus (volgarmente noto come “coccodrillo americano”) si è riprodotta da sola. Il fenomeno in questione si chiama partenogenesi, ed è il primo caso osservato nei Crocodylia, il grande ordine di rettili che tra le sue file annovera diverse specie di coccodrilli, alligatori e caimani.

La partenogenesi, che letteralmente significa appunto “nascita vergine”, è un tipo di riproduzione sessuale caratterizzata dallo sviluppo in assenza di fecondazione della cellula-uovo, ed è un fenomeno abbastanza comune in varie specie di uccelli, pesci, serpenti e lucertole ma, appunto, mai osservato in questo ordine animale. Sulla rivista scientifica Biology Letters un gruppo di ricercatori statunitensi in collaborazione con i responsabili del “Parque Reptilandia” ha raccontato il singolare evento.
Gli studiosi, attraverso test del DNA e ad alcuni esami condotti su 7 delle 14 uova deposte dall’esemplare femmina nel 2018, hanno verificato la presenza di un feto di coccodrillo completamente formato (sebbene non vitale), che condivideva quasi per intero con la madre lo stesso materiale genetico (eccezion fatta per le estremità dei cromosomi del feto). Le analisi suggerivano poi che la cellula uovo prodotta dalla madre non si fosse unita con uno spermatozoo, come avviene normalmente nella fecondazione, ma con un globulo polare, una delle piccole sacche cellulari che si formano insieme alla cellula uovo vera e propria contenenti cromosomi molto simili a quelli materni. I globuli polari sono solitamente materiale di scarto e non sono coinvolti direttamente nella riproduzione, ma in alcuni casi si possono fondere con la cellula uovo a completamento del materiale genetico in assenza di uno spermatozoo, facen-
Si tratta del primo caso osservato in questo grande ordine di rettili che tra le sue file annovera diverse specie di coccodrilli
do sì che si verifichi la partenogenesi. È infine importante specificare come l’ipotesi di un concepimento ritardato (altro fenomeno possibile) è stata scartata dal momento in cui la femmina di coccodrillo dopo essere stata introdotta nel parco (nel 2002, all’età di due anni), non ha più avuto contatti con propri simili. L’importanza di questo fenomeno non sta tanto nella sua straordinarietà quanto nel contributo che darà nella ricostruzione della storia evolutiva di questi rettili.
La scoperta, infatti, avvalora ancor di più le ipotesi di un’origine evolutiva comune tra alcuni ordini
dei rettili e gli uccelli. La partenogenesi è stata così documentata nei due rami principali degli Archosauria attuali, e offre spunti importanti sulle possibili capacità riproduttive degli Archosauria estinti, parenti dei coccodrilli e degli uccelli, in particolare dei membri di Pterosauria e Dinosauria. Non è ancora chiaro come mai alcuni animali riescano a riprodursi per partenogenesi: alcune ipotesi sostengono la funzionalità di questo fenomeno, che avverrebbe in assenza di maschi disponibili per la riproduzione e/o nelle specie a rischio di estinzione. (M. O.).
Visite in aumento costante, anche grazie agli investimenti sulle nuove tecnologie. Audioguide, droni e soluzioni eco-friendly: ma l’accessibilità è sempre un problema

Risboccia l’amore per musei e teatri e aumenta la vocazione degli stessi a sfruttare più compiutamente le eccezionali potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Nel 2022 i dati relativi agli accessi in presenza ai poli museali, ma anche ai monumenti e alle aree archeologiche italiane, così come agli spettacoli teatrali, si sono avvicinati sensibilmente ai livelli precedenti alla pandemia. Appena il 7% dei visitatori e il 4% delle entrate in meno rispetto a tre anni prima per i musei, mentre per i teatri i ricavi sono stati inferiori soltanto del 6% rispetto al 2019. Lo certificano le indagini dell’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali della School of Management del Politecnico di Milano, diretto da Eleonora Lorenzini.
«Il clima positivo generato dal ritorno dei flussi, insieme alle misure per la ripartenza, si riflettono sulla capacità di innovazione delle istituzioni, che ruota attorno a tre tematiche principali: trasformazione digitale, accessibilità e sostenibilità. Questi temi sono al centro anche dei progetti presentati a valere sui fondi

del PNRR», le parole della direttrice. «Il 30% dei teatri e il 38% dei musei, monumenti e delle aree archeologiche che hanno partecipato alle nostre indagini, infatti, hanno presentato almeno un progetto in questo senso su fondi PNRR e circa la metà di questi ha ottenuto finanziamenti che ricadono principalmente proprio sui temi della rimozione delle barriere fisiche e cognitive e dell’efficienza energetica».
I poli museali, e i siti archeologici spesso attigui, negli ultimi anni hanno arricchito l’esperienza di visita con l’implementazione di strumenti tecnologici quali QR-code, beacon, audioguide e touch screen. La prossima sfida è rappresentata dalla catalogazione e della digitalizzazione delle collezioni, oltre che dall’ulteriore potenziamento delle biglietterie online, attualmente presenti solo nel 46% delle strutture. In aumento anche i progetti relativi all’utilizzo di droni, particolarmente utili nella scansione dei siti archeologici o per lo sviluppo di contenuti tridimensionali. Per i teatri, invece, i maggiori investimenti hanno riguardato marketing, comunicazione e attenzione per i clienti.
Come sottolinea Michela Arnaboldi, responsabile scientifico dell’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali, «anche l’intelligenza artificiale inizia a essere utilizzata dai musei. I player del settore non possono trascurare questa tecnologia. Un ulteriore trend di innovazione che il comparto culturale, al pari di altre filiere, punta a integrare nel suo proces-
so di digitalizzazione. Le possibili applicazioni sono vastissime: dalla generazione di contenuti testuali per le attività di comunicazione al supporto nella gestione delle recensioni, anche in lingua straniera, e nella gestione complessiva della relazione con i visitatori, fino alla creazione di veri e propri prodotti potenzialmente commercializzabili».
Altra strada battuta fortemente da musei e teatri riguarda la sostenibilità ambientale. L’83% dei primi e l’84% dei secondi ha intrapreso almeno un’iniziativa in tal senso, a cominciare dall’efficientamento energetico degli impianti (effettuato da più della metà delle strutture), per passare poi al riciclo dei materiali e a campagne di sensibilizzazione del personale su comportamenti sostenibili. Progressi non ancora significativi, invece, sul fronte dell’accessibilità. Il 38% dei musei presenta barriere architettoniche che limitano l’accesso e la mobilità negli edifici. Più di un museo su due non offre alcun tipo di servizio per superare le barriere cognitive e senso-percettive di non vedenti e non udenti. Migliore è la situazione dei teatri, ma solo sul fronte delle barriere architettoniche (solo il 13% non è attrezzato): per quel che concerne le barriere cognitive e sensoriali, le strutture adeguate sono appena il 28% del totale.

Quanto alla possibilità di effettuare visite guidate, di partecipare a laboratori, workshop oppure sviluppare altri contenuti on line, sei musei su dieci si sono organizzati in tal senso. L’offerta è piuttosto diversificata da struttura a struttura: nella maggior parte dei casi le possibilità di accesso sono gratuite, ma esiste anche una percentuale minore in cui sono fornite a pagamento. Solo il 24% dei teatri, invece, propone spettacoli sul web. Offerte fiorite soprattutto nei periodi più bui della pandemia, quelli segnati dal maggior numero di restrizioni, per consentire al pubblico di continuare ad assistere a esposizioni o spettacoli, ma che oggi – a dispetto delle dichiarazioni soddisfatte delle varie realtà impegnate – incontrano un favore decisamente meno marcato da parte del pubblico, maggiormente orientato al definitivo ritorno delle attività in presenza. Insomma, se molto è stato fatto – soprattutto negli ultimi tempi – in favore della digitalizzazione e della vocazione hi-tech di musei e teatri, sono ancora tante le cose da fare. E i fondi del PNRR possono offrire un’eccezionale opportunità in tal senso.

Il fisioterapista di Pietragalla (Potenza) è dal 2016 nello staff della squadra allenata da Pep Guardiola. Nel “suo” palmares, prima della Champions League, anche Tour de France e titoli olimpici

Cosa accomuna Sir Bradley Wiggins ed Elia Viviani, campioni olimpici di ciclismo, e Erling Haaland, micidiale centravanti del Manchester City fresco vincitore della Champions League di calcio? Le mani, la sensibilità e la competenza di uno Sport Therapist di primo livello. Ex ciclista, italiano di Pietragalla (Potenza), da sette anni nello staff dei Citizens, Mario Pafundi continua a impreziosire la sua bacheca di successi e trofei sportivi, alla corte di un allenatore epocale come Pep Guardiola. In diretta tv, il gigante Haaland lo ha elogiato come «il miglior fisioterapista del mondo, ha rimesso in forma il mio corpo giorno per giorno». Lui, con la sua umiltà, preferisce parlare con il suo lavoro. E quando, lontano da telecamere e microfoni, si confida, con la stessa umiltà dona qualche me-

rito anche alla buona sorte: «Alla base di quanto ho costruito però in primis il lavoro e poi la resilienza, la concentrazione, la metodologia e, forse, un po’ di fortuna» è il pensiero di Mario.
La prima vita di Pafundi è stata quella di giovane talento ciclistico, partito dal paese a 15 anni per cercare di far notare le sue virtù. Per anni, all’ingresso del suo paese d’origine, ha campeggiato la scritta “Vai Mario”. La seconda vita è partita nel 2004, dal Team Barloworld di Claudio Corti, per poi passare cinque anni più tardi alla Sky Professional Cycling Team dove ha lavorato (e vinto) negli anni successivi con i vari Bradley Wiggins, Chris Froome ed Elia Viviani. C’è stato il suo prezioso contributo dietro ai successi di questi grandi campioni alle Olimpiadi, al Tour de France, alla Vuelta a Espana, a Mondiali ed Europei su pista. Nel 2016, la terza vita ha portato Mario Pafundi al Manchester City dove, in sette anni, il lucano ha vinto 5 Premier League (la Serie A inglese), 4 Coppe di Lega, 2 FA Cup, un Community Sheld (la supercoppa nazionale) e, finalmente, a inizio giugno 2023, la Champions League.
«Per molti passare dal ciclismo al calcio – è il pensiero di Pafundi, confidato a chi lo conosce bene - era una sfida ardita. Per me no, non sono fra quelli che pensano “chi nasce tondo non muore quadrato”. Nel ciclismo sono stato fortunato a collaborare con squadre importanti con la Barloworld di Claudio Corti, poi col Team Sky e quindi con la Ineos. Nel calcio ho portato la mia conoscenza e la mia esperienza, premiate da risultati incomparabili fra loro: vincere il Tour è diverso da vincere la Champions League che è diverso da vincere un’Olimpiade». Incontrare le persone giuste è un dettaglio importante, ma affatto scontato, per quanti hanno dei talenti professionali. Mario lo sa e per questo si ritiene «fortunato nel passaggio dal ciclismo al calcio a incontrare un uomo come mister Guardiola: una persona generosa, rispettosa, che si fa voler bene da tutti e non si tira mai indietro di fronte alla richiesta di un consiglio o di aiuto».
Al Manchester City, Pafundi si occupa di

“Siamo quello che mangiamo e tutti dobbiamo avere un occhio di riguardo sulla nutrizione, l’idratazione e tutto ciò che concerne il recupero biologico dell’atleta”.
tutto ciò che riguarda la prevenzione infortuni, la preparazione pre-allenamento e pre-partita il recupero post attività. Con gli anni, l’esperienza e l’intuizione, ha certificato un concetto: non esiste un solo metodo di lavoro, né uno che abbia più successo per tutti. La capacità di un professionista, in qualsiasi ambito, dev’essere quella di adattare il proprio metodo alla necessità dell’atleta e della persona. «Non è accettabile generalizzare un metodo, che per me va ottimizzato in ogni caso» il suo credo. Un po’ come la nutrizione, sul cui fronte Mario ritiene che la collaborazione tra fisioterapisti, preparatori atletici, nutrizionisti, sport science e reparto medico è fondamentale: «Siamo quello che mangiamo e tutti dobbiamo avere un occhio di riguardo sulla nutrizione, l’idratazione e tutto ciò che concerne il recupero biologico dell’atleta».
I trascorsi da atleta hanno dato una mano al fisioterapista italiano, che di recente ha collaborato anche con gli staff nazionali di Ucraina e Norvegia: «Nel rapporto con gli atleti in generale mi ha aiutato tanto è l’essere stato atleta a mia volta: nel rapporto professionale e umano, nella metodologia, nel sistema di lavoro, nel capire la persona che si ha di fronte». E di fronte, l’ex promettente ciclista diventato fisioterapista di fama mondiale, se n’è trovati un bel po’ di atleti, dai re delle velocità e della montagna nel ciclismo al goleador del momento: «L’importanza di una persona che lavora nello sport, nel mio caso, è ottimizzare, individualizzare la necessità di un atleta. Capire ciò di cui ha bisogno. L’esperienza ti porta a essere flessibile, incontrando l’aspetto culturale, la motivazione, le esigenze fisiche. Ecco: un metodo fondamentale è responsabilizzare l’atleta, far capire che il punto non è fare quello che dice l’allenatore, il preparatore, il fisioterapista, ma essere il king di se stesso».
Professionista di successo, sposato e con due figli, con il triplete del Manchester City Mario Pafundi ha realizzato l’ennesima impresa. Di sogni, però, ne ha ancora: «Tanti. Ma li tengo per me. Altrimenti, come dicevamo da bambini, se li dici poi non si avverano».



Gli operatori sanitari e socio-sanitari lavorano tutti i giorni per la tua salute. Aggredirli verbalmente e fisicamente è un reato e un atto di inciviltà che va contro il tuo stesso interesse e quello della collettività.


























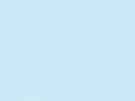
















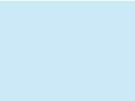
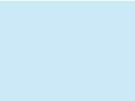
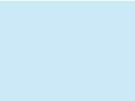
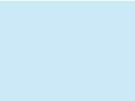
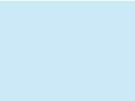
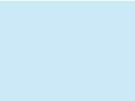
Campagna contro la violenza verso gli operatori sanitari e socio-sanitari








#laviolenzanoncura






Tra maggio e giugno, la giovane Nazionale allenata dal ct Nunziata è giunta a un pass dal titolo iridato battendo corazzate come Brasile e Inghilterra, prima di cedere all’Uruguay
Quant’è verde l’azzurro del calcio. Aspettando, da troppo tempo, notti magiche in un Campionato del Mondo, l’ultima parte della primavera ha fatto “sognare” gli appassionati italiani alle imprese della Nazionale Under 20, assoluta protagonista ai Mondiali in Argentina. Casadei, Baldanzi, Prati, ma anche Pafundi, Desplanches, Giovane: nomi che sono risuonati, prima insoliti poi sempre più familiare, sugli organi d’informazione, man mano che il cammino dell’Italia allenata da Carmine Nunziata assumeva contorni sempre più eroici. Il sogno è sfumato a quattro minuti dalla fine della finale, quando l’Uruguay ha spezzato la resistenza degli azzurrini vincendo, con merito, la coppa. Ma quanto fatto dalla giovine Italia del calcio ha ricordato a tutti che no, nel nostro Paese non c’è lo strapotere economico della Premier League, degli emiri e dei campionati dove vanno a svernare e alimentare il loro conto in banca troppi campioni a corto di motivazioni, ma ci sono ragazzi di valore che chiedono spazio per esprimere il proprio talento.
«Faccio i complimenti ai calciatori, al tecnico, al coordinatore Viscidi e a tutto lo staff – ha dichiarato il presidente della Federazione italiana giuoco calcio, Gabriele Gravina - quello che sono riusciti a fare in Argentina, nonostante la sconfitta in finale, è stato uno spot meraviglioso per il calcio italiano. Abbiamo giovani talenti che richiedono di essere impie-
gati, senza cercare in maniera spasmodica giocatori dall’estero a mio avviso non sempre di grande qualità. In questi anni è stato fatto un lavoro strategico nel Club Italia con tecnici e staff molto preparati. Noi svolgiamo un ruolo di investimento e di formazione per questi ragazzi che riteniamo insostituibile, devono però crederci anche le società».
Dalla vittoria all’esordio con il Brasile alla finale persa di misura con l’Uruguay passando per i successi contro Repubblica Dominicana, Inghilterra, Colombia e Corea del Sud: per tre settimane la squadra di Carmine Nunziata ha fatto emozionare milioni di italiani. Tra i singoli, il ravennate Cesare Casadei è quello che ha letteralmente rubato la scena: mezzala con fisico e senso dell’inserimento, il ragazzo acquistato dal Chelsea un anno fa è stato premiato come miglior giocatore e capocannoniere del Mondiale, con 7 reti.
Con Casadei, ci sono stati altri tre gioielli di Romagna in bella mostra nel mondiale U23 in Argentina: l’atalantino Samuel Giovane, di Lugo, capitano capace di giocare da terzino sinistro di costruzione ma anche mezzala, come nell’Ascoli; Matteo Prati, una delle poche note liete della triste stazione della Spal in B, a segno contro il Brasile e brillante sia da mezzala sia da vertice basso; Riccardo Turicchia, esterno difensivo della Juventus Nex Gen, bravo sia a difendere sia a spingere: se ne sono accorti Brasile e Corea del Sud.
Dai romagnoli a Tommaso Baldanzi, 20 anni, mancino, 30 partite e 4 gol con l’Empoli nel recente campionato di Serie A. Al Mondiale ha firmato due gol e due assist, mettendo in mostra tecnica, carattere e gambe da trequartista moderno. Prestazioni di spessore anche per Simone Pafundi, il più giovane della nidiata di talentini azzurri, eppure l’unico dell’U20 ad aver toccato con mano i raduni della Nazionale maggiore. Alti e bassi nel suo Mondiale, ma la rete con la Corea del Sud è stata di un bagliore accecante e di un valore incommensurabile.
Che l’Italia avesse i numeri per stupire, l’ha dimostrato al debutto col Brasile: tre gol in 35 minuti (Prati, doppio Casadei) prima dell’incompleta rimonta verdeoro nel finale. Lo 0-2 con la Nigeria ha riportato Faticanti e compagni coi piedi per terra, prima del secco tris alla Repubblica Dominicana siglato da altri due gol di Casadei e dal primo squillo mondiale di Ambrosino.
Agli ottavi gli azzurrini hanno trovato l’Inghilterra, che un anno fa si era imposta contro lo stesso gruppo nella finale dell’Europeo
“Faccio i complimenti ai calciatori, al tecnico, al coordinatore Viscidi e a tutto lo staff – ha dichiarato il presidente della Federazione italiana giuoco calcio, Gabriele Gravina - quello che sono riusciti a fare in Argentina, nonostante la sconfitta in finale, è stato uno spot meraviglioso per il calcio italiano”.

U19. Italia avanti con Baldanzi, su assist di Ambrosino, poi il pari immediato di Devine prima del rigore stappa-gioia di Casadei. Belli e concreti, i ragazzi di Nunziata hanno continuato a regalare meraviglie anche nei quarti di finale, stendendo 3-1 la Colombia grazie alle reti di Casadei, Baldanzi ed Esposito di tacco, il tutto nei primi 47 minuti. Ancora Casadei, sempre Casadei (al settimo gol nella competizione) ha punito un balbettante disimpegno difensivo nella semifinale con la Corea del Sud, che però ha pareggiato col capitano Lee. Nel finale, però, dopo alcune provvidenziali parate di Deslplanches, l’ingresso del baby Pafundi dopo due partite viste dalla panchina si è rivelato decisivo: punizione mancina all’incrocio di pali, al minuto 86, e Italia in finale. Lo stesso minuto, però, è stato fatale ai nostri ragazzi contro l’Uruguay, nel match che ha assegnato la coppa. Un’ombra finale che non cancella un torneo meraviglioso. Chissà se servirà a far capire ai club che i talenti, in Italia, ci sono eccome. Basta saperli valorizzare. (A. P.)

Il Cavallino Rampante è tornato a gareggiare nella mitica gara endurance francese, rompendo un tabù che durava dal 1965
“After 50 years we are back”. Ovvero: dopo 50 anni, siamo tornati (a vincere). A chi ama i motori, la “24 Ore di Le Mans” dirà più di qualcosa. Per chi non ha dimestichezza con l’argomento, basti dire che si tratta di una delle più prestigiose competizioni automobilistiche della storia, assieme al Gp di Monaco di Formula 1 alla 500 miglia di Indianapolis, alla Parigi-Dakar e al Rally di Finlandia, solo per citarne alcune.
A rendere ancor più speciale l’edizione del Centenario di questa corsa, disputata per la prima volta nel 1923,
è stato appunto un grande e vittorioso ritorno: quello della Ferrari. Assente, infatti, da mezzo secolo alla “24 Ore di Le Mans”, il Cavallino Rampante è infatti andato a segno con il terzetto formato da Alessandro Pier Guidi, James Calado e la new entry Antonio Giovinazzi. I tre piloti scrivono il loro nome nell’albo d’oro, succedendo nella storia di Maranello a Masten Gregory, Jochen Rindt e Ed Hugus, che si imposero nel lontano 1965.

A La Sarthe, la Ferrari ha posto fine a cinque anni di dominio della Toyota, giunta stavolta seconda con Sebastien Buemi, Brendon Hartley
e Ryo Hirakawa, mentre il trio Kobayashi-Conway-Lopez, vincitore del 2021, è uscita anzitempo dalla contesa per un incidente nelle prime fasi notturne. Pier Guidi è stato capace di mantenere ritmo e concentrazione, anche dopo un fuori pista nella nottata e anche sotto il nubifragio: in condizioni assai difficili è arrivato a girare 15 secondi più veloce dei rivali. È stato lui, Alessandro, a portare la Ferrari verso la bandiera a scacchi nell’ultimo stint, e a commentare via radio: “After 50 years we are back”. Grazie anche ai suoi compagni di team: Calado si è confermato rapidissimo, soprattutto negli stint della domenica mattina, e Antonio Giovinazzi ha dato il suo contributo di pulizia e freddezza, pure quando ha dovuto girare con gomme da asciutto mentre iniziava a diluviare.
«Sapevamo di avere una buona macchina, molto veloce - ha raccontato Alessandro Pier Guidi, 39enne piemontese - ma è un progetto giovane, e può succedere di tutto. Siamo riusciti a spingere per 24 ore. Non sapevo cosa aspettarmi, ma alla fine è riuscita a condurci al traguardo». Ingegnere meccanico, Pier Guidi è stato il primo a salire sulla Ferrari 499P, quando sono iniziati i test a Fiorano, nel luglio 2022. E aver sviluppato la vettura gli ha permesso non solo di gestire al meglio un paio di pit stop da brivido (con la Ferrari che non partiva), ma anche di cercare il setup migliore.
Dal canto suo, Antonio Giovinazzi si è preso una bella rivincita, dopo l’agrodolce esperienza in Formula 1 (terzo pilota Ferrari, poi Sauber e Alfa Romeo) e la trascurabile parentesi in Formula E. Per il driver pugliese, però, vincere con la Ferrari qualcosa di importante era soprattutto «il sogno che avevo da bambino». Com’è maturato, è presto detto: «Grazie all’unione tra noi piloti, ingegneri e meccanici. E poi col lavoro: lungo, sfiancante, ma determinante». (A. P.)
Lo hanno ribattezzato Plastic Man, per la sua capacità di rispondere colpo su colpo quando l’avversario crede di averlo messo all’angolo. O anche Nole, diminutivo del suo nome di battesimo: Novak. Un nome che ha ispirato, facile facile, anche il maligno soprannome di No Vax perché, pur non essendosi mai apertamente dichiarato tale, il tennista serbo Novak Djokovic ha sempre rivendicato la libertà di scegliere di non farsi somministrare il vaccino anti-Covid. Scelta discussa che lo ha tenuto fuori da alcuni dei tornei più importanti del circuito Atp nel 2022, per poi tornare a dominare ovunque quest’anno. E con la recente vittoria al Roland Garros, a Parigi, il 36enne serbo è diventato il tennista più vincente di tutti i tempi, oltre a essere l’uomo dei record. Il successo in finale contro Casper Ruud è stato il numero 1058 (su 1268 partite) da professionista, quinto nella storia dopo Jimmy Connor (1274), Roger Federer (1251), Ivan Lendl e Rafael Nadal (1068).

Con 23 successi in 35 finali (primato di finali), Djokovic è il tennista più vincente nelle prove del Grande Slam in ambito singolare maschile superando Rafael Nadal (22): 10 Australian Open (record assoluto), 7 Wimbledon, 3 Us Open e 3 Roland Garros. Nessun altro atleta è stato capace di aggiudicarsi almeno tre volte tutti i tornei dello slam. «Sono particolarmente felice ed emozionato – le parole di Djokovic durante la premiazione dello Slam francese-. Questo è sempre stato lo Slam più difficile per me. Raggiungere questo record è un sogno che si avvera e ai più giovani voglio dire che se vogliono raggiungere un traguardo, nella vita, con impegno e dedizione potranno farlo».
Nell’era Open, Djokovic è uno dei due tennisti – con Rod Laver - ad aver vinto consecutivamente (anche se non nello stesso anno solare) tutte e quattro le prove dello Slam, ma il solo a realizzare l’impresa su tre superfici differenti. Come Rafa Nadal e Ken Ro-
Il 36enne (primo nel ranking mondiale) serbo ha vinto lo Slam numero 23: nessuno come lui, neppure Federer e Nadal
sewall, Nole ha vinto uno Slam in tre decenni diversi: 2000-2010-2020.
Nato a Belgrado nel 1987, lunedì 12 giugno Djokovic è tornato al numero 1 del ranking Atp all’età 36 anni e 21 giorni: ha aggiornato le statistiche che già lo fotografavano come il secondo tennista più anziano a salire sul tetto del mondo. Meglio di lui soltanto Roger Federer, che ci è riuscito all’età di 36 anni e 195 giorni. Con lo svizzero e Rafel Nadal, è stato protagonista di un’età dell’oro del tennis mondiale, formando un trio di campioni praticamente imbattibile, i Big Three, cui per un periodo si è aggiunto Andy Mur-
ray (trasformando la compagnia in “Fab Four”). Dei quattro, Nole è però il tennista che ha ottenuto i maggiori guadagni nella storia del tennis: 168,5 milioni di dollari.
Del resto, “qualche” vittoria l’ha ottenuta: con 67 successi in singolare maschile è naturalmente il numero 1 nella classifica delle vittorie dei “Big Titles”, i tornei di tennis più importanti e prestigiosi al mondo. Con il Roland Garros, ha inoltre portato a 98 il numero dei tornei vinti, 94 dei quali in singolare. In questi ultimi casi c’è ancora chi lo precede. Ma Nole non ha ancora deciso di smettere. (A. P.)
Le voci che nessuno ascolta sono quelle delle differenze biologiche, fisiologiche e antropologiche che la scienza deve ascoltare per offrire le cure giuste a ciascuno di noi
di Anna LaviniaValeria Raparelli, Daniele Coen
“Quella voce che nessuno ascolta”
Giunti, 2023 – 18 euro
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, la medicina di genere è «lo studio dell’influenza delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite dal genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona». Dati epidemiologici, clinici e sperimentali affermano l’esistenza di differenze tra uomini e donne nelle malattie, nelle risposte agli eventi avversi, nei trattamenti terapeutici e nell’accesso alle cure. Il libro esplora dettagliatamente il modo in cui le disuguaglianze interagiscono con la salute. Basta pensare che il termine isteria (usato per la prima volta da Ippocrate) deriva dalla parola greca ὑστέρα “utero”, per capire che questo disturbo della sfera psichica ha una connotazione femminile. Il pregiudizio secondo cui tutte le azioni e le reazioni delle donne siano guidate unicamente dal loro utero è ancora oggi fortemente radicato nella società. E troppo spesso per le donne, le diagnosi in seguito a sintomi di cui il medico non riconosce la causa, sono risolte con un veloce “sarà ansia o stress”. Effettivamente differenti ricerche citate e ben analizzate nel saggio riferiscono che
in Italia «poco meno del 4% della popolazione femminile e dell’1% di quella maschile è interessato dai disturbi d’ansia». È anche per questa ragione però che molte malattie vengono diagnosticate tardivamente o in errore, una su tutte quelle cardiache. Contrariamente all’idea fortemente radicata che l’infarto sia una cosa da uomini, non si tiene (quasi mai) conto che le donne al contrario possono esserne colpite e anche spesso.
Di contro, non va bene nemmeno per il genere maschile: siamo convinti che gli uomini non possano soffrire di osteoporosi. È una malattia prevalentemente femminile ma gli uomini affetti da questa patologia hanno una maggiore probabilità di avere rotture e fratture rispetto alle donne. Tuttavia raramente questa condizione viene indagata nella sfera maschile.
Siamo davanti ad una serie di convinzioni stereotipate su quali siano i problemi di cui si dovrebbero occupare le une e quali invece gli altri. Ma attenzione, non si tratta dei soli pazienti, questo riguarda anche chi si occupa della cura. Già dal nome di uno dei capitoli del libro “medicina a senso unico” è ben chia-
ra la questione della ricerca fatta dagli uomini per gli uomini sugli uomini. Tradizionalmente nei trial clinici vengono arruolati in misura maggiore ma le donne anche essendo sottorappresentate nelle sperimentazioni, verranno comunque prese in considerazione una volta dimostrata l’efficacia del farmaco o del trattamento in questione, anche a loro verrà somministrato senza esitazioni.
La questione delle disuguaglianze non è affare solo delle donne, come racconta l’autrice «questo non è un libro femminista» ma tutti devono trarre benefici da una maggiore conoscenza della situazione. Paradossalmente, coloro che rischiano di più e che si trovano maggiormente a contatto con le malattie, sono quelli che vengono discriminati maggiormente negli studi: gli anziani. Non siamo “tutti uguali”. È arrivato il momento in cui la medicina si apre a diversi aspetti, le caratteristiche biologiche di un individuo devono interagire con la sua condizione sociale ed economica. La buona notizia però c’è: manifestare la consapevolezza del problema, come fa questo prezioso testo, è già un passo importante per la sua “cura”.


Valeria Margherita Mosca
Alla ricerca della natura selvatica Fabbri, 2023 – 17 euro
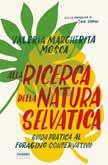
La natura è cambiata e con essa deve mutare anche il nostro modo di raccogliere le erbe e i frutti selvatici (foraging). In un rapporto sinergico e mutualistico con l’ecosistema. Da una delle maggiori esperte sul campo in Italia e in Europa, una guida pratica e consapevole su come procacciare il cibo da sé, in modo conservativo. (A. L.)
Susan Goldwin Meadow
Thinking with your hand

Basic books, 2023 – 29,50 euro
Gli scienziati danno una risposta alla tanto amata e irrinunciabile gestualità degli italiani. Non solo per spiegarsi meglio, muovere le mani aiuta ad organizzare il ragionamento e migliorare le performance cognitive. Il nuovo saggio della psicolinguista statunitense indaga sul modo in cui i gesti danno forma ai nostri pensieri. (A. L.)
Bruno Cianci
Una lanterna nel buio
Laterza, 2023 – 24 euro
Durante la guerra di Crimea di notte si aggirava tra i soldati feriti, poi è riuscita ad illuminare con la sua luce l’intera infermieristica mondiale. L’incredibile storia della donna visionaria che ha modificato il Novecento, ha salvato vite di intere generazioni di uomini e donne, restando troppo spesso nell’ombra. (A. L.)
UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Scadenza, 5 luglio 2023
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali. Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20-06-2023.
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Scadenza, 6 luglio 2023
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinicaLaboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, area della medicina diagnostica e dei servizi. Gazzetta Ufficiale n. 42 del 06-06-2023.
UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA
Scadenza, 13 luglio 2023
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, per la facoltà dipartimentale di medicina, in lingua inglese. Gazzetta Ufficiale n. 44 del 13-06-2023.
UNIVERSITÀ DI ROMA “TOR VERGATA”
Scadenza, 13 luglio 2023
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di biologia. Gazzetta Ufficiale n. 44 del 13-06-2023.
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Scadenza, 13 luglio 2023
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico o dirigente biologo - responsabile della struttura complessa medicina di laboratorio, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica - laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia. Gazzetta Ufficiale n. 44 del 13-06-2023.
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Scadenza, 13 luglio 2023
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico o dirigente biologo - responsabile della struttura complessa microbiologia e virologia, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di microbiologia e virologia. Gazzetta Ufficiale n. 44 del 13-06-2023.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE – ISTITUTO PER L’ENDOCRINOLOGIA E L’ONCOLOGIA “GAETANO SALVATORE” DI NAPOLI
Scadenza, 17 luglio 2023
È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica “Scienze Biomediche” da usufruirsi presso l’Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Sperimentale “G. Salvatore” (IEOS) del CNR di Napoli, nell’ambito del contratto di Ricerca preclinica con Dompé farmaceutici S.p.A.
Tematica: Ricerca pre-clinica: Supporto per lo sviluppo di un database relazionale
per la realizzazione della knowledge-based platform. Per informazioni, www.cnr.it, sezione “concorsi”.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO PER L’ENDOCRINOLOGIA E L’ONCOLOGIA “GAETANO SALVATORE” DI NAPOLI
Scadenza, 31 agosto 2023
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Assegno di Ricerca Professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l’Area Scientifica “Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie - AGR/07 – Genetica Agraria” da svolgersi presso l’Istituto di Bioscienze e BioRisorse di Palermo del CNR, che effettua uno studio sulla “Variabilità dell’espressione genica in piante in funzione dell’ambiente (GxE - Genotype x Environment)”, nell’ambito dell’autofinanziamento del progetto di ricerca “ANCIENT.” SOTTOMISURA 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”, per la seguente tematica: “Verifica dell’effetto dell’ambiente sul profilo trascrittomico (RNAseq) in piante di interesse e/o sulla loro componente microbica associata”. Per informazioni, www.cnr.it, sezione “concorsi”.

Segui la sezione Bandi e Concorsi sul sito della FNOB
Troverai gli avvisi pubblici dedicati ai Biologi
www.fnob.it
Nell’era della psichiatria evidence-based, gli endo-fenotipi misurabili oggettivamente e in modo univoco potrebbero essere di ausilio nella valutazione clinica dei pazienti psichiatrici
Carlo (nome di fantasia) ha 21 anni. Si presenta dal medico di base riferendo frequenti mal di pancia, talvolta mal di testa che lo costringono a casa. Il medico gli misura la pressione, che risulta piuttosto alta, e gli prescrive una serie di esami dai quali purtroppo non emerge nulla di significativo. Così Carlo prosegue la sua vita finché il giorno del suo ventiduesimo compleanno viene spronato a organizzare una grande festa nonostante il suo malessere generale. Avrebbe evitato volentieri, ma la circostanza questa volta glielo impediva. A un certo punto della festa, un suo caro amico, pensando di fare cosa gradita, inizia a cantargli Tanti auguri.
Gli altri ragazzi del locale non impiegano molto a unirsi al coro. Carlo si sente in imbarazzo, ma può gestirlo. Terminata l’ovazione, la folla del bar urla: «Discorso!». La voce non è neppure familiare, probabile che qualche bontempone volesse fare il simpatico. Si innesca una reazione a catena per la quale tutte le persone della stanza, amici e sconosciuti, chiedono a gran voce un discorso. Carlo inizia a sentirsi accaldato, così accaldato da sudare. Il sudore però non è tiepido, ma freddo. Il fiato gli si spezza, il respiro fatica a uscire, sente la bocca molto asciutta, al punto che la lingua gli si attacca al palato. Il petto gli stringe e i pensieri affollano la sua testa: «Che faccio? Non posso parlare a tutta questa gente. Non ne conosco neppure la metà». Inizia a tremare, i suoi amici lo spronano fino a quando non prende in mano il microfono del karaoke
* Psicologo Clinico, assistente di studio medico Collaboratore di BioPills
e… sviene. Nei giorni successivi Carlo è così imbarazzato da non uscire di casa. Decide di farlo solo per tornare dal medico quando il bruciore di stomaco è così forte da impedirgli anche di mangiare. L’empatico dottore si insospettisce quando, oltre al mal di pancia, Carlo riferisce rigidità muscolare e vertigini. La pressione alta permane. Nella pletora di possibili diagnosi, una in particolare cattura la sua attenzione, così chiede al paziente se è successo qualcosa nei giorni passati.
A quel punto Carlo, nonostante l’imbarazzo, descrive l’accaduto nei particolari, mantenendosi sempre un po’ distaccato e freddo nei confronti della vicenda, come se in realtà non lo avesse turbato così tanto. Il clinico ha un’intuizione: ricorda che da recenti studi è emersa un’associazione tra i valori pressori elevati e disturbi di natura ansiosa [1]. Unendo gli altri pezzi del puzzle, suggerisce a Carlo una visita psichiatrica. Lui, un po’ scettico, accetta il suggerimento e pochi giorni dopo si reca dallo specialista. Finalmente il colloquio con lo psichiatra porta ad una diagnosi: pare che Carlo abbia un disturbo d’ansia. Una fobia sociale, nello specifico. Il nuovo dottore gli prescrive dei farmaci e lo indirizza da un terapeuta con il quale inizia un lungo ma soddisfacente percorso. Con la giusta guida, Carlo ci racconta che tutto iniziò al liceo, o forse alle medie; fin dai primi anni faceva fatica ad andare a scuola, non perché non volesse studiare o perché non gli piacessero le materie, ma perché da un lato era spaventato dagli insegnanti, dall’altro dai compagni di classe. Le interrogazioni erano una tortura, preferiva di gran lunga gli esami scritti, meglio se a risposta chiusa, dove non era necessario produrre nulla di personale.
Neurologia e psichiatria, diverse ma non molto
Il caso clinico riportato non è reale, anche se prende spun-
to da situazioni di vita realistiche. «Carlo» non esiste, ma tanti pazienti come lui affollano gli studi di medicina generale, cercando dal dottore vicinanza e supporto psicologico più che terapie farmacologiche. Nel caso, ideale, di Carlo un medico trae delle conclusioni brillanti a partire da pochi elementi clinici. Il paziente a sua volta si rivela molto collaborativo e accetta i consigli del dottore senza riserve. Purtroppo, però, nella vita reale vicende di questo tipo non hanno sempre un lieto fine. I pazienti non sono sempre disposti ad ammettere disturbi di natura psicologica, o magari non li riconoscono. Nell’imbarazzo o nel timore che il paziente si offenda, talvolta gli stessi medici esitano nel suggerirgli un professionista della salute mentale, che sia uno psichiatra, uno psicologo o un neuropsichiatra. Al contempo, i pazienti tendono a rifiutare le diagnosi psichiatriche, oppure le tengono nascoste come se ci fosse qualcosa di sbagliato in loro e nel loro disturbo. Fa eccezione (ma non troppo) la neurologia grazie agli anni di evidenze scientifiche dalla sua parte che «giustificano» la follia del paziente con cause di natura anatomo-patologica concreta, strettamente biologica-cerebrale.
Il paziente afasico che straparla e condisce i suoi discorsi con neologismi e frasi senza senso sembra un po’ matto, ma è giustificato dal fatto che le sue aree cerebrali sono state danneggiate da un trauma o da un ictus. Un altro paziente che sproloquia come il precedente, i cui discorsi deragliano, è del tutto matto, e anche un po’ strano, fino a quando uno psichiatra non comunica alla famiglia che il poveretto è schizofrenico, oppure ha un disturbo bipolare. A quel punto resta comunque matto, quantomeno per la maggior parte delle persone. Ovviamente questo paragrafo va ad estremizzare una situazione che per fortuna non è così estrema. Al contrario, l’interesse per il disturbo mentale è sempre maggiore negli ultimi anni e
continua a crescere di giorno in giorno. Tuttavia, è vero che a oggi si tendono ancora a vedere di sbieco i disordini psichiatrici/psicologici, probabilmente perché a lungo la mente è stata vista come un’entità astratta e distinta dal corpo, con un carattere quasi spirituale, e il più delle volte alla patologia venivano date interpretazioni legate alla superstizione e al sovrannaturale; la si spiegava ad esempio come manifestazione del demonio. Comprensibile, quindi, che il disturbo mentale mantenga una certa accezione negativa. In futuro, però, verrà posto sullo stesso piano di quello organico, come attesta la gran quantità di marker biologici, molecolari, genetici e neuroanatomici che negli ultimi anni stanno arricchendo la conoscenza dei disturbi psichiatrici e che testimoniano il fatto che il disordine mentale non è astratto ma presenta una base organica, seppur complessa e multifattoriale.
Biomarker: anatomia e molecole
I «marker biologici» (biomarker) sono elementi fisiologici misurabili in modo affidabile e che consentono di identificare e caratterizzare lo stato di salute del paziente, sia in condizioni fisiologiche, sia patologiche. Un buon esempio sono le analisi del sangue di routine, che misurano appunto alcuni biomarker i cui valori nei pazienti in salute rimangono all’interno dei rispettivi range fisiologici. In caso di malattia, invece, si potranno osservare significativi discostamenti dei valori dei biomarker, che siano in termini di alterazioni biochimiche, molecolari, microstrutturali (sinapsi, microcircuiti) o macrostrutturali (connettività tra aree cerebrali). Ad esempio, secondo la teoria metacognitiva di Adrian Wells, rimuginìo e pensieri negativi, tipicamente presenti in disturbi psichiatrici quali ansia e depressione, sarebbero causati da un’alterata connettività tra la corteccia prefrontale dorsolaterale e l’amigdala. La corteccia avrebbe meno controllo sull’amigdala, che sarebbe libera di attivarsi. Una ricerca del 2014 ha verificato questa ipotesi lungo l’arco di vita, osservando un’effettiva alterazione di connettività tra queste aree [2]. Un altro studio ha mostrato un particolare pattern elettroencefalografico tipicamente presente nei disturbi d’ansia [3].
Ciò detto, in futuro sarà sufficiente effettuare una risonanza o un EEG per diagnosticare un disturbo d’ansia? Probabilmente no, poiché alterazioni di questo tipo non sono patognomoniche, né sono presenti in tutti i pazienti. Andrebbero valutati tanti altri elementi. Il più noto è il fattore neurotrofico cerebrale, dall’inglese brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Crescenti evidenze mostrano che lo stress diminuisce l’espressione del gene BDNF nelle strutture limbiche che controllano l’umore e che il trattamento antidepressivo inverte o blocca gli effetti dello stress. Livelli ridotti di BDNF, così come altri fattori neurotrofici, potrebbero contribuire

all’atrofia di alcune strutture cerebrali, tra cui l’ippocampo e la corteccia prefrontale, rilevata in soggetti depressi. Al contrario, l’azione neurotrofica degli antidepressivi potrebbe invertire l’atrofia neuronale e la perdita cellulare [4]. Il BDNF è riscontrabile nel sangue periferico: dosandolo potremmo dedurre che disturbo affligge il paziente? In caso di depressione ci si potrebbe aspettare livelli sottosoglia di BDNF ematico, ma la ricerca suggerisce di porre attenzione. Siccome i risultati delle più recenti analisi cliniche sono contrastanti, Arosio e colleghi in un articolo del 2021 concludono: «In general, blood BDNF cannot be recommended for use as a biomarker in clinical practice» [5]. Probabilmente sono necessari altri elementi per tracciare un quadro più definito. Anche nel caso delle patologie organiche non è sufficiente un solo valore ematochimico per la diagnosi; nei disturbi mentali la situazione è altrettanto complessa per via delle frequenti comorbilità e per la natura multifattoriale delle condizioni cliniche. Disturbi psichiatrici: esami di laboratorio per la diagnosi Prendiamo d’esempio i disturbi d’ansia. Sono condizioni complesse, con meccanismi eziologici non del tutto definiti. Si pensa che numerosi fattori siano coinvolti nella loro genesi: psicologici, genetici, biologici e chimici. Sebbene la diagnosi dei disturbi d’ansia sia in continua evoluzione, i manuali diagnostici a oggi tendono a basarsi su elenchi di sintomi a dispetto di biomarcatori oggettivi.
I fattori biologici sottostanti potrebbero essere importanti per il progresso della medicina personalizzata. Per questo, lo studio dei metaboliti e delle molecole ematiche ha di recente preso piede nella diagnosi della malattia, nel monitoraggio dell’efficacia terapeutica, nella progressione del disturbo e nella definizione di obiettivi terapeutici [6]. Un altro esempio è quello dell’Hikikomori, grave forma di sindrome da ritiro sociale, un problema in crescita nel Paese del Sol Levante e a livello internazionale. La sua fisiopatologia non è stata ancora chiarita e resta da stabilire un trattamento efficace. Recentemente, è emerso che il disturbo evitante di personalità è la comorbidità più comune dell’Hikikomori ed è stata analizzata la relazione tra questo disturbo e gli squilibri biochimici dei pazienti per una diagnosi il più obiettiva possibile. I tratti di personalità evitanti sono stati associati negativamente con colesterolo lipoproteico ad alta densità (HDL-C) e acido urico (UA) negli uomini, e positivamente ai prodotti della degenerazione della fibrina (FDP) e alla proteina C-reattiva ad alta

sensibilità (hsCRP) nelle donne. Successivamente, sono stati reclutati individui reali con Hikikomori e sono stati confrontati tratti di personalità evitanti, biomarcatori del sangue, caratteristiche psicologiche tra individui con Hikikomori e controlli sani di pari età. Gli individui con Hikikomori avevano punteggi di personalità evitante più alti in entrambi i sessi e mostravano livelli sierici di UA più bassi negli uomini e livelli di HDL-C più bassi nelle donne rispetto ai controlli sani [7]. Uno studio più recente ha proseguito la ricerca dei metaboliti nell’Hikikomori e nella depressione per rendere ancor più precisa la diagnosi sulla base degli elementi ematochimici. I livelli di acilcarnitina a catena lunga risultano notevolmente più alti nei pazienti; bilirubina, arginina, ornitina e arginasi sierica erano significativamente differenti nei pazienti maschi.
L’acido urico sierico e gli esteri del colesterolo plasmatico hanno contribuito alla definizione della diagnosi [8]. Per quanto il modello definito da Setoyama e colleghi risulti essere molto promettente, è limitato all’Hikikomori. È vero che questo disturbo condivide con ansia e depressione una notevole quantità di sintomi, ma proprio per via dell’elevata comorbilità è necessario identificare ulteriori marcatori, possibilmente più precisi, per ciascun disturbo. In generale, i disturbi da stress (tra cui ansia e depressione) condividono l’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), che si traduce in sintomi simili e condivisi. Tali patologie sono strettamente correlate tra loro: si verificano simultaneamente o si susseguono, per cui la diagnosi non è una procedura perfetta. Non vi sono esami di laboratorio che possano dissipare i dubbi del clinico che diagnostica e che possano consentire di at-
tuare quanto prima il trattamento più appropriato. Pertanto, uno studio del 2021 [9] ha esaminato alcune componenti della saliva che potrebbero essere utili per uno screening rapido e univoco. Tali potenziali marcatori potrebbero rivelarsi utili anche nel monitoraggio dell’efficacia terapeutica. Sono stati dosati cortisolo, immunoglobulina A (sIgA), lisozima, melatonina, α-amilasi (sAA), cromogranina A (CgA) e il fattore di crescita dei fibroblasti 2 (FGF-2). Tra i migliori marcatori dello stress, cortisolo, lisozima, sAA e CgA si sono rivelati promettenti. Per differenziare la depressione dallo stress, il cortisolo salivare e la melatonina.
Verso la medicina di precisione
Se il medico di Carlo avesse prescritto subito degli esami di laboratorio per il dosaggio delle succitate molecole, il paziente non sarebbe svenuto, il suo disturbo sarebbe stato identificato in anticipo e probabilmente Carlo avrebbe fatto scelte diverse nella vita. Senza la costrizione dell’ansia avrebbe vissuto appieno le esperienze adolescenziali, le uscite di gruppo, sarebbe andato meglio a scuola e questo avrebbe dato un meritato boost alla sua autostima. Nessun medico si sentirebbe in imbarazzo nel prescrivere una TAC o una visita dal neurologo in seguito a un trauma cranico; ma tanti clinici sarebbero restii nel suggerire un colloquio psicologico a un paziente che manifesta ansia, anche perché spesso e volentieri è il paziente stesso a non riferire la difficoltà perché non desidera la diagnosi o perché non ritiene necessario un supporto. Gli esami di laboratorio contribuirebbero a normalizzare una situazione che purtroppo oggi non è ancora tale. Le diagnosi precoci sarebbero anche un notevole investimento per il Sistema Sanitario Nazionale perché sul lungo termine andrebbero a ridurre il numero di ospedalizzazioni, ricoveri e riabilitazioni dei pazienti più gravi (che lo diventerebbero senza una terapia tempestiva). È vero che si potrebbe trovare lo stesso squilibrio in diversi disturbi vista l’elevata comorbilità tra le patologie psichiatriche, il punto però è che ciascuno ha degli elementi caratterizzanti differenti e unici che lo distinguono dagli altri, che si tratti di dosaggi differenti oppure di compresenza di varie molecole. Identificare queste regolarità spiana la strada alla medicina di precisione (di conseguenza alle terapie patient-tailored). Tuttavia, quando si parla di disturbi psichiatrici, le variabili in gioco sono davvero tante ed è difficile tenerle tutte a mente per trarre la giusta conclusione diagnostica. Per giunta, le variazioni nei dosaggi biochimici tra un disturbo e l’altro potrebbero essere minime, quasi impercettibili; dunque, la diagnosi differenziale potrebbe non essere così immediata. Per questo motivo sono nati progetti come RDoc (Research Domain Criteria) che desiderano definire una serie di criteri diagnostici basati su quanti più possibili elementi del «sistema uomo»: variabili genetiche, epigenetiche, biochimiche, cliniche, anatomiche… Altri gruppi di ricerca si stanno occupando di raccogliere e catalogare questi marcatori, provenienti da più fronti, per poi darli in pasto a si-
stemi di machine learning che siano in grado di effettuare delle analisi certosine sui dati. Prove crescenti suggeriscono che gli esiti del trattamento sono meglio prevedibili in sottogruppi di pazienti psichiatrici identificati dagli algoritmi rispetto alle diagnosi DSM/ICD.
Nell’era della psichiatria evidence-based, gli endo-fenotipi misurabili oggettivamente e in modo univoco potrebbero consentire il rilevamento precoce della malattia, la selezione del trattamento individualizzato e l’aggiustamento dei dosaggi per ridurre il carico della malattia [10]. In futuro sarà, quindi, sufficiente analizzare un adeguato set di biomarker per diagnosticare un disturbo mentale? Probabilmente no, ma con ogni probabilità sarà un valido ausilio alla valutazione clinica operata dagli psichiatri.
Verosimilmente la strada della psichiatria sarà ancora lunga; ci vorrà altro tempo affinché i disturbi mentali si affermino tra le patologie organiche, ma le premesse del secolo corrente lasciano spazio alla speranza.
[1] Cai L, Liu Y, He L (2022). Investigating genetic causal relationships between blood pressure and anxiety, depressive symptoms, neuroticism and subjective well-being. General Psychiatry 2022;35:e100877
[2] Birn RM et Al. (2014). Extreme early-life anxiety is associated with an evolutionarily conserved reduction in the strength of intrinsic functional connectivity between the dorsolateral prefrontal cortex and the central nucleus of the amygdala. Molecular psychiatry, 19(8), 853-853.
[3] Shadli SM et Al. (2021). Right frontal anxiolytic-sensitive eeg ‘theta’rhythm in the stop-signal task is a theory-based anxiety disorder biomarker. Scientific reports, 11(1), 1-12.
[4] Duman RS & Monteggia LM (2006). A neurotrophic model for stress-related mood disorders. Biological psychiatry, 59(12), 1116-1127.
[5] Arosio B et Al. (2021). Blood brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and major depression: do we have a translational perspective? Frontiers in behavioral neuroscience, 15, 626906.
[6] Humer E, Pieh C, Probst T (2020). Metabolomic biomarkers in anxiety disorders. International Journal of Molecular Sciences, 21(13), 4784.
[7] Hayakawa K et Al. (2018). Blood biomarkers of Hikikomori, a severe social withdrawal syndrome. Scientific reports, 8(1), 1-9.
[8] Setoyama D et Al. (2021). Blood metabolic signatures of hikikomori, pathological social withdrawal. Dialogues in Clinical Neuroscience, 23(1), 14-28.
[9] Chojnowska S et Al. (2021). Salivary biomarkers of stress, anxiety and depression. Journal of clinical medicine, 10(3), 517.
[10] Bzdok D & Meyer-Lindenberg A (2018). Machine learning for precision psychiatry: opportunities and challenges. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 3(3), 223-230.
L’allattamento favorisce il processo di guarigione e le terapie farmacologiche previste per i casi più gravi non rappresentano un rischio per il neonato
Quello dell’allattamento è un periodo importantissimo della vita perché contribuisce a rafforzare il prezioso legame tra madre e figlio/a che si crea già durante la gravidanza. Tuttavia, il verificarsi di alcuni eventi possono turbare questi preziosi momenti con conseguenze per entrambi. Tra questi, la mastite è un’infiammazione del seno che si verifica frequentemente e può essere dovuta a una serie di cause, anche infettive. Secondo l’Academy of Breastfeeding Medicine, una mamma su cinque soffre di almeno un episodio di mastite nel corso dell’ allattamento ed è possibile che insorga più di una volta nella vita e più volte durante lo stesso periodo di allattamento [1]. Purtroppo, sono ancora molto frequenti i casi in cui le donne interrompono prematuramente l’allattamento al seno a causa del dolore, del timore che la terapia antibiotica possa compromettere la qualità del latte oppure a seguito di consigli errati degli operatori sanitari [2]. L’area del seno interessata si presenta rigida, gonfia e arrossata. Questa sintomatologia può essere aggravata da febbre superiore ai 38°C, brividi e malessere generale simile all’influenza. Spesso, il principale fattore scatenante della mastite non infettiva è la stasi del latte causata dal blocco dei dotti mammari, da un ingorgo e da lesioni al seno. A influire sono una serie di fattori come il prolungamento del tempo che trascorre tra una poppata e l’altra oppure una ridotta durata dell’allattamento, l’errata posizione di attaccamento del neonato al capezzolo, la mancata suzione, eventuali malattie infantili
o malformazioni congenite, la sovrapproduzione di latte, lo svezzamento rapido e non graduale, la pressione esercitata dal reggiseno, oppure da una ferita del capezzolo che causa dolore e quindi ritarda la poppata successiva.
Durante l’allattamento, inoltre, può succedere che i capezzoli subiscano delle screpolature oppure altre lesioni traumatiche attraverso cui i batteri fanno il loro ingresso nel seno innescando una mastite infettiva, con successiva comparsa di una macchia bianca di circa 1 mm sul capezzolo dolorante. I microrganismi responsabili della mastite possono essere quelli presenti sulla pelle e nella bocca del lattante oppure sulla pelle della madre. Ma possono raggiungere il seno anche attraverso il flusso retrogrado del latte che dalle ghiandole acinose, dove viene prodotto, è poi trasportato al capezzolo dai dotti mammari [3]. Infatti, il latte umano è colonizzato da un’ampia varietà di batteri, alcuni dei quali potrebbero provenire dall’intestino materno seguendo pathway endogeni. La stessa mastite, poi, porta a un processo di disbiosi che sbilancia la composizione del microbiota presente nella ghiandola mammaria e di conseguenza nel latte materno si verificherà una crescita sproporzionata di alcune specie batteriche a dispetto di altre. Grazie alle tecniche di sequenziamento di nuova generazione è stato possibile rilevare una ridotta diversità del microbiota nel latte delle donne con mastite, con la crescita di patogeni opportunistici e la riduzione dei commensali.
Spesso, la mastite puerperale è clinicamente descritta come “autolimitante” poiché solitamente segue un decorso blando e benigno che tende a risolversi spontaneamente senza alcun intervento medico. Inoltre, le neomamme si prendono cura del loro seno massaggiando le zone del
seno interessate dall’infiammazione, allattando o spremendo frequentemente il capezzolo in modo da svuotare il seno. Nei casi più seri di mastite infettiva è necessario, però, ricorrere a terapie antibiotiche per curare l’infezione. Infatti, se non trattata, la mastite infettiva può causare un ascesso del seno con formazione di pus che richiede il ricovero in ospedale e, talvolta, un intervento chirurgico [2].
La mastite granulomatosa idiopatica
La mastite granulomatosa idiopatica merita un’attenzione particolare perché, seppur benigna, è una condizione infiammatoria molto rara della ghiandola mammaria le cui cause non sono ancora del tutto note. Tuttavia, risulta confermata l’associazione dell’infiammazione a traumi, processi metabolici e ormonali, reazioni autoimmunitarie e all’infezione da Corynebacterium kroppenstedtii, un patogeno opportunista frequentemente isolato da infezioni mammarie. Può verificarsi a qualsiasi età ma la maggior frequenza è osservata tra i 30 e i 40 anni.
La sua rilevanza clinica è dovuta al fatto che spesso presenta caratteri molto simili a quelli di una mastite infettiva ma soprattutto del tumore al seno. Oltre all’infiammazione e al dolore, infatti, la sintomatologia include aumento di massa e ipereremia (aumento della quantità di sangue localizzato in corrispondenza della zona del seno interessata), i classici sintomi del tumore al seno.

Nella valutazione della clinica, la risonanza magnetica con mezzo di contrasto è fortemente raccomandata per migliorare la specificità della diagnosi rispetto alla tradizionale mammografia e il livello dei globuli bianchi fornisce informazioni utili per differenziarla dagli ascessi mammari comuni alle altre tipologie di mastiti. Tuttavia, è l’esame istopatologico della lesione il metodo considerato gold standard per la diagnosi. Solitamente, a livello macroscopico si riconosce una massa solida, dura e debolmente nodulare mentre microscopicamente emerge una formazione granulomatosa combinata con un’infiltrazione localizzata di cellule giganti multinucleate, istiociti epitelioidi e plasmacellule [4].
Il complesso quadro clinico e la scarsità di dati raccolti su questa patologia contribuiscono a renderne controversa il trattamento. Il regime terapeutico maggiormente adottato si basa su antibiotici e corticosteroidi, seguiti dalla sola terapia steroidea e da intervento chirurgico nelle pazienti dove i sintomi sono persistenti. Purtroppo, la rarità della malattia non consente di avviare studi con un elevato numero di pazienti da arruolare ma viene fortemente raccomandata l’implementazione di un registro o di uno studio multicentrico che possa aiutare a raccogliere più dati [5].
Il trattamento della mastite
Il trattamento della mastite puerperale può essere di supporto oppure farmacologico nei casi di mastite infettiva. L’ottimizzazione della tecnica di allattamento e la rimozione del latte per evitare la stasi rappresenta senza dubbio il metodo preventivo più efficace. Il corretto posizionamento del lattante e il suo attaccamento al seno gli consentono di poppare bene e ricevere la giusta quantità di latte ma contribuiscono anche a evitare l’insorgenza di eventuali lesioni del capezzolo. La posizione del bambino può variare a seconda delle varie esigenze del momento ma si raccomanda di tenere il bambino con il volto di fronte al seno con testa, spalle e corpo allineati e il naso o il labbro superiore devono trovarsi di fronte al capezzolo. Questo gli consente di raggiungere facilmente il seno senza bisogno di allungarsi o girarsi. Se si allatta da seduta, assicurarsi di avere la schiena diritta e sostenuta, con i piedi ben
appoggiati per sostenere il peso della schiena e delle braccia e l’utilizzo di cuscini può essere d’aiuto per tenere il bambino all’altezza del seno. Allattare da sdraiate è utile dopo un taglio cesareo o nei primi giorni successivi al parto [6]. Massaggiare il seno per favorire la fuoriuscita del latte è sempre una buona abitudine perché il calore generato dal movimento della mano può attivare l’ossitocina e promuovere il flusso del latte materno. Al contrario, l’applicazione di impacchi freddi dopo la fuoriuscita del latte aiuta a lenire l’infiammazione [3]. Infine, se utilizzato correttamente, il tiralatte aumenta il drenaggio del seno ed è quindi considerato uno strumento prezioso nel trattamento della mastite.
Si ricorre, invece, al trattamento farmacologico, di fronte a una mastite infettiva oppure in tutti quei casi che non si risolvono con delle terapie di supporto. La terapia empirica maggiormente impiegata prevede la somministrazione di amoxicillina-clavulanato, dicloxacillina e flucloxacillina, cefalexina (in caso di allergia alla penicillina) o la claritromicina (in caso di allergia ai beta-lattamici). Tuttavia, a causa della crescente resistenza agli antibiotici queste terapie potrebbero perdere di efficacia così, negli ultimi anni, l’integrazione con probiotici sia durante la gravidanza che l’allattamento è stata testata come alternativa e si è osservata una riduzione del rischio di sviluppare mastite [7]. Inoltre, già il normale microbiota del latte materno contiene probiotici potenzialmente in grado di aiutare a stabilire la flora ga-
strointestinale del bambino e prevenire la colonizzazione dei dotti mammari da parte dei patogeni [8]. Nel complesso, i microrganismi commensali trasmessi tramite il latte materno sembrano svolgere un ruolo chiave nello sviluppo del microbiota intestinale infantile. Durante la gravidanza e l’allattamento, sia l’intestino che le ghiandole mammarie subiscono cambiamenti a livello del microbiota. I commensali di origine intestinale possono essere trasportati al seno durante l’allattamento attraverso via cellulari endogene. Ad esempio, le cellule dendritiche possono penetrare direttamente le cellule che compongono il monostrato epiteliale dell’intestino e catturare la flora presente senza danneggiare la mucosa. I cambiamenti fisiologici e ormonali che si verificano nel terzo trimestre di gravidanza aumentano la permeabilità dell’epitelio intestinale favorendo così il trasferimento dei batteri intestinali al seno. Pertanto l’assunzione di probiotici da parte della madre può rappresentare un valido supporto nel potenziamento della risposta immunitaria del neonato mediata dal latte materno [8,9].

Staphylococcus aureus come principale agente eziologico
Il principale agente patogeno responsabile dell’insorgenza della mastite infettiva è lo Staphylococcus aureus (S. aureus) a causa della sua capacità di colonizzare la cute umana. Infatti, circa il 20% della popolazione mondiale è portatore nasale persistente, il 30% portatore intermittente (non sempre ne risulta colonizzato) mentre il rimanente 50% non ne risulta
colonizzato. La condizione di carriage in individui sani, che quindi diventano un vero e proprio “serbatoio” del patogeno, rappresenta un importante fattore di rischio per l’aumento delle mastiti infettive. Infatti, il rischio di acquisire il patogeno da parte del neonato durante l’allattamento è molto alto considerando lo stretto contatto con il seno materno, soprattutto nelle fasi iniziali dell’infezione quando le madri sono del tutto inconsapevoli di essere infette. La trasmissione può essere diretta perché mediata da una stretta interazione con i familiari in visita e operatori sanitari oppure indiretta attraverso il contatto con apparecchiature mediche non sterili che favoriscono prima la colonizzazione e poi l’instaurarsi dell’infezione. I ceppi più pericolosi sono gli MRSA (methicillin-resistant S. aureus) perché resistono agli antibiotici beta-lattamici, come la penicillina, ampiamente utilizzati per curare le infezioni. La circolazione degli MRSA in ambiente ospedaliero, soprattutto nei reparti a rischio come quelli delle terapie intensive neonatali, è un importante problema di sanità pubblica. Infatti, il sistema immunitario dei neonati non è ancora ben sviluppato e questo li rende maggiormente suscettibili a infezioni causate dallo S. aureus, soprattutto durante l’attraversamento del canale del parto e l’ allattamento al seno [10]. Inoltre, dopo le dimissioni sia le madri che i neonati colonizzati contribuiscono alla diffusione dei ceppi MRSA nella comunità trasmettendo il patogeno agli altri membri della famiglia. Attualmente non c’è traccia di studi di sorveglianza condotti nelle terapie intensive neonatali italiane e ancora più scarsi sono i dati riguardanti la sorveglianza della colonizzazione cutanea nelle madri. Uno screening precoce delle madri durante la gravidanza sarebbe utile per determinarne lo stato di portatrici sane mentre subito dopo il parto fornirebbe informazioni sulla possibile colonizzazione della cute mammaria.
A causa dell’elevato grado di resistenza, il trattamento prevede una terapia antibiotica combinata, generalmente amoxicillina e clavulanato, per una durata di circa 10-14 giorni. Se la mastite si sviluppa in un ascesso, alla terapia antibiotica è necessario affiancare il drenaggio per velocizzare il processo di guarigione. In questi casi, l’allattamento al seno può continuare assumendo una postura che eviti il contatto diretto tra la bocca del bambino e la ferita. Nel caso in cui questo non fosse possibile l’alternativa è l’utilizzo del tiralatte. Da non sottovalutare la ricorrenza di mastite nella stessa zona del seno perché potrebbe essere il campanello di allarme per patologie più gravi e una valutazione clinica più approfondita sarà utile a escludere eventuali forme tumorali o altre anomalie [3].
Conclusioni
La gravidanza e l’allattamento sono due fasi fondamentali da cui dipendono la salute sia della madre che del bambino. Supportare la donna durante questi mesi rendendola consapevole dei fattori che possono causare la stasi del latte è il punto di partenza per evitare casi di mastite oppure per im-
parare a gestirli. Continuare ad allattare, e quindi a svuotare il seno, nel modo corretto non solo favorisce la guarigione della mastite ma offre anche la possibilità ai piccoli di beneficiare delle proprietà del latte materno. L’allattamento, infatti, protegge i neonati dal rischio di infezioni premature anche gravi e da quello di sviluppare altre patologie in futuro, come l’obesità e le malattie metaboliche. Pertanto, la corretta gestione della mastite, infettiva e non, apporta benefici alla salute della madre e a quella del bambino.
1. Mitoulas, L.R.; Davanzo, R. Breast Pumps and Mastitis in Breastfeeding Women: Clarifying the Relationship. Front. Pediatr. 2022, 10, 1–6, doi:10.3389/fped.2022.856353.
2. Wilson, E.; Woodd, S.L.; Benova, L. Incidence of and Risk Factors for Lactational Mastitis: A Systematic Review. J. Hum. Lact. 2020, 36, 673–686, doi:10.1177/0890334420907898.
3. Pevzner, M.; Dahan, A. Mastitis While Breastfeeding: Prevention, the Importance of Proper Treatment, and Potential Complications. J. Clin. Med. 2020, 9, 1–6, doi:10.3390/jcm9082328.
4. Aydin, I.; Kesicioglu, T.; Vural, S.; Sengul, I.; Yilmaz, K.; Sengul, D. Idiopathic Granulomatous Lobular Mastitis: An Imitation of Breast Carcinoma. Cureus 2021, 13, 10–13, doi:10.7759/cureus.15206.
5. Wolfrum, A.; Kümmel, S.; Reinisch, M.; Theuerkauf, I.; Pelz, E. Granulomatous Mastitis: A Therapeutic and Diagnostic Challenge. Breast Care 2018, 13, 413–418, doi:10.1159/000495146.
6. Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali; Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione Allattare Al Seno. Un Investimento per La Vita. Minist. della Salut. 2019, 56.
7. Jiménez, E.; Manzano, S.; Schlembach, D.; Arciszewski, K.; Martin, R.; Ben Amor, K.; Roelofs, M.; Knol, J.; Rodríguez, J.M.; Abou-Dakn, M. Ligilactobacillus Salivarius Ps2 Supplementation during Pregnancy and Lactation Prevents Mastitis: A Randomised Controlled Trial. Microorganisms 2021, 9, doi:10.3390/microorganisms9091933.
8. Yu, Q.; Xu, C.; Wang, M.; Zhu, J.; Yu, L.; Yang, Z.; Liu, S.; Gao, X. The Preventive and Therapeutic Effects of Probiotics on Mastitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One 2022, 17, 1–13, doi:10.1371/journal.pone.0274467.
9. Guo, Q.; Goldenberg, J.Z.; Humphrey, C.; El Dib, R.; Johnston, B.C. Probiotics for the Prevention of Pediatric Antibiotic-Associated Diarrhea. Cochrane Database Syst. Rev. 2019, 2019, doi:10.1002/14651858. CD004827.pub5.
10. Cremers, A.J.H.; Coolen, J.P.M.; Bleeker-Rovers, C.P.; van der Geest-Blankert, A.D.J.; Haverkate, D.; Hendriks, H.; Henriet, S.S.V.; Huynen, M.A.; Kolwijck, E.; Liem, D.; et al. Surveillance-Embedded Genomic Outbreak Resolution of Methicillin-Susceptible Staphylococcus Aureus in a Neonatal Intensive Care Unit. Sci. Rep. 2020, 10, 1–10, doi:10.1038/s41598-020-59015-1.
Il ruolo dei giornalisti scientifici è prioritario per i cittadini e per informare in modo corretto su temi importanti come la salute, la ricerca e l’innovazione
Ci sono diversi studi che ci aiutano confrontando la natura e i cicli annuali a comprendere meglio chi siamo e in quali patologie possiamo incorrere, in base a ciò che scegliamo dal cibo agli stili di vita, agli animali con cui interagiamo. Ad esempio, bisogna tenere presente che, se si prende una lente d’ingrandimento e una torcia, e si osservano i propri denti con molta attenzione allo specchio, in alcuni punti è possibile notare un disegno di linee sottili e parallele che attraversano i denti. Queste linee corrispondono alle strie di Retzius che segnano la crescita progressiva dello smalto dentale. Lo smalto inizia a formarsi nel grembo materno e continua a mineralizzarsi fino all’adolescenza, quando gli ultimi denti da latte cadono e vengono sostituiti da quelli permanenti.
Come in tutti i vertebrati terrestri, anche nell’uomo lo smalto si mineralizza gradualmente in strati microscopicamente sottili, le strie di Retzius appunto, la cui analisi consente di comprendere la velocità di sviluppo dello smalto stesso. Stress fisiologici e/o esterni, come ad esempio la nascita, lo svezzamento o le malattie infettive lasciano tracce visibili, dette strie di Retzius accentuate, che aiutano a comprendere lo stato di salute degli individui. Le strie di Retzius permettono anche di ricostruire il quadro cronologico della composizione chimica dello smalto dei denti, che a sua volta riflette i cambiamenti della dieta individuale I cicli annuali, visibili nello smalto dei denti, offrono informazioni sulla life-history di uomini che vissero oltre un milione di anni fa. Un team interdisciplinare di scienziati, guidato dalla Goethe University di Francoforte e dal Senckenberg Research Institute and Natural History Museum di Francoforte, che raccoglie ricercatori di diversi Stati e istituzioni, tra le quali l’Università degli
Studi di Padova e il Museo delle Civiltà di Roma, ha scoperto, proprio attraverso l’analisi dei loro denti, cosa mangiavano i nostri antenati della specie Homo erectus, vissuti centinaia di migliaia di anni fa sull’isola di Giava, nel sud-est asiatico.
I dati emersi evidenziano che i nostri progenitori durante l’arco dell’anno passavano da una dieta a base vegetale ad una dieta mista, ma erano molto meno dipendenti dalla disponibilità di cibo stagionale rispetto ad altre specie che abitavano l’isola come ad esempio gli oranghi. Per analizzare lo smalto dei denti, i ricercatori hanno inglobato i denti nella resina e poi li hanno tagliati in fettine sottilissime di circa 150 micrometri di spessore. Questi preziosissimi campioni dentali fanno parte della Collezione “Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald” dell’Istituto di Ricerca Senckenberg e del Museo di Storia Naturale di Francoforte, un prestito permanente della Fondazione Werner Reimers. L’équipe internazionale di scienziati della Goethe University di Francoforte, guidata dal professor Wolfgang Müller e dalla sua studentessa Jülide Kubat, ora dottoranda all’Université Paris Cité, insieme ad altri ricercatori, tra cui Alessia Nava (già all’Università del Kent, ora a Sapienza Università di Roma), Luca Bondioli (Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica dell’Università di Padova) e Beatrice Peripoli (ex studentessa del Dipartimento di Beni Culturali, Università di Padova, ora dottoranda a Sapienza Università di Roma) ha confrontato le abitudini alimentari di un antenato dell’uomo moderno, Homo erectus, con quelle degli oranghi e di altre specie animali, tra loro contemporanee, attraverso lo studio dei denti.
Questo nostro antenato e le altre specie animali sono vissuti durante il Pleistocene, tra 1,4 milioni e 700.000 anni fa,
sull’isola Giava, che all’epoca era caratterizzata sia da foreste pluviali monsoniche, sia da paesaggi aperti alberati che da savane erbose. Per analizzare lo smalto dei denti, evidenzia l’ufficio stampa dell’Università di Padova, i ricercatori hanno inglobato i denti nella resina e poi li hanno tagliati in fettine sottilissime di circa 150 micrometri di spessore. Successivamente, è stato utilizzato un laser speciale per asportare una piccola quantità di smalto dalle sezioni sottili, che è stato analizzato chimicamente tramite l’utilizzo dello spettrometro di massa per rilevare la presenza di diversi elementi chimici, tra cui lo stronzio e il calcio, che si trovano sia nelle ossa che nei denti (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry -LA-ICPMS).
Il rapporto tra stronzio e calcio (Sr/Ca) dipende dalla dieta. Wolfgang Müller che fa parte del team di ricerca spiega: “Lo stronzio viene gradualmente espulso dall’organismo, per così dire come un’impurità del calcio vitale. Nella catena alimentare, questo porta a una continua diminuzione del rapporto stronzio-calcio (Sr/Ca) dagli erbivori, agli onnivori, fino ai carnivori”. Il team di ricerca è riuscito a confermare questa tesi confrontando i dati provenienti dall’analisi dei denti di diversi animali del Pleistocene provenienti da Giava: i predatori felini mostravano un basso rapporto stronzio-calcio, i predecessori degli attuali rinoceronti, cervi e ippopotami mostravano alti rapporti stronzio-calcio e i maiali del Pleistocene, in quanto onnivori, si trovavano nel mezzo. I risultati ottenuti dai denti degli oranghi e di Homo erectus sono stati entusiasmanti perché i ricercatori hanno scoperto cicli annuali durante i quali la composizione della dieta delle grandi scimmie e degli esseri umani cambiava: entrambi mostravano variazioni nel corso dell’anno, ma i picchi regolari di Sr/Ca erano molto più pronunciati per gli oranghi che per l’Homo erectus. Jülide Kubat, primo autore dello studio pubblicato, sottolinea: “Questi picchi indicano un’abbondante disponibilità di cibo vegetale nella stagione umida, durante la quale la foresta pluviale produceva molti tipi di frutta.
Durante la stagione secca, gli oranghi passavano ad altre fonti di cibo, che potevano includere insetti o uova. Al contrario, Homo erectus, in quanto onnivoro e carnivoro occasionale, era meno dipendente dall’approvvigionamento alimentare stagionale, come indicano i picchi meno pronunciati e i valori
più bassi di Sr/Ca”. Nel complesso, spiegano i ricercatori, lo studio dimostra che l’analisi laser ad alta risoluzione spaziale degli elementi, unita alla ricostruzione della cronologia di formazione dello smalto dentale, può fornire informazioni temporali straordinariamente dettagliate sulla storia della vita dei nostri antenati. Lo studio ci fa sentire molto vicini a questi primi esseri umani perché viene evidenziato come interagivano con il loro mondo circostante. Durante il Pleistocene inferiore e medio, Giava era abitata da taxa ominidi di grande diversità. Tuttavia, le loro strategie dietetiche stagionali non erano mai state esplorate. I ricercatori hanno intrapreso analisi geochimiche di orangutan (Pongo sp.), Homo erectus e altri denti di mammiferi del Pleistocene da Sangiran.
Hanno ricostruito le strategie dietetiche del passato a risoluzione infrasettimanale e dedotto modelli ecologici stagionali. Le analisi elementali risolte spazialmente controllate istologicamente mediante spettrometria di massa al plasma basata su laser hanno confermato la conservazione di segnali biogenici autentici nonostante l’effetto della sovrastampa diagenetica spazialmente limitata. Il record Sr/Ca dei resti faunistici è in linea con le posizioni trofiche attese, contestualizzando la dieta degli ominidi fossili. Pongo sp. mostra cicli stagionali marcati con picchi Sr/Ca fortemente elevati della durata di circa 3 mesi, che riflettono un consumo di cibo vegetale contrastante presumibilmente durante la stagione dei monsoni, mentre rapporti Sr/Ca più bassi suggeriscono una diversa disponibilità di cibo durante la stagione secca. Al contrario, l’onnivoro H. erectus mostra una variabilità Sr/Ca intra-annuale bassa e meno accentuata rispetto a Pongo sp., con i dati

δ13C di un individuo che indicano uno spostamento nella dieta da C4 a un mix di piante C3 e C4.
I dati suggeriscono che H. erectus su Java massimizzava le risorse disponibili in habitat più aperti ed era quindi meno dipendente dalle variazioni nella disponibilità stagionale delle risorse. Sebbene sia stato influenzato dalla disponibilità stagionale di cibo, i ricercatori hanno dedotto che H. erectus ne era influito in misura minore rispetto a Pongo sp., che abitava le foreste pluviali monsoniche a Giava. I ricercatori hanno evidenziato che H. erectus abbia mantenuto un maggior grado di indipendenza nutrizionale sfruttando la diversità regionale delle risorse alimentari attraverso le stagioni. Curioso ricordare ad esempio che una delle tappe fondamentali dell’evoluzione di Homo erectus, cioè lo sviluppo di una mandibola meno pronunciata in avanti e denti più piccoli, fu probabilmente segnata dal passaggio verso nuove abitudini alimentari come il maggior consumo di carne e l’uso di utensili di pietra per battere i vegetali ricchi di amido. Furono infatti queste pratiche di preparazione, e non la cottura, a diminuire l’intensità e la frequenza della masticazione necessaria per rendere digeribili i cibi. Ci sono altri studi che analizzano come noi esseri umani interagiamo con la natura.
Tra i ricercatori italiani più dinamici ed attivi in progetti europei legati alla diagnosi clinica delle malattie neurodegenerative c’è ad esempio il dott. Fabio Moda con il suo team che ha partecipato al progetto European Innovative Research & Technological Development Projects in NanomedicineEuroNanoMed III (Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying system for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology –SPEEDY- 20192021) dedicato allo studio della malattia di Alzheimer; al progetto “Prodromal biomarkers in fatal familial insomnia: a longitudinal study in humans and mice “ finanziato dall’EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) dedicato allo studio dell’insonnia fatale familiare (Prodromal biomarkers in fatal familial insomnia: a longitudinal study in humans and mice ProFFIle - Durata 2022-2025); e infine un progetto dedicato allo studio di una malattia da prioni che colpisce i cervidi in Norvegia finanziato dal Norwegian Research Council (Chronic wasting disease prions from Norwegian cervids: Assessing the pathogenesis, shedding, spillover and zoonotic potential –EmergingCWD –e lo studio precedente Norwegian research funding for agriculture and food industry - Reindeer CWD prion ecology: Risk of dissemination by sheep) “Stiamo sviluppando,” spiega il dott. Fabio Moda,”nuovi test diagnostici per identificare soggetti a maggior rischio di sviluppare la malattia di Parkinson, la malattia di Alzheimer, la demenza con corpi di Lewy e le malattie da prioni (es. la malattia di Creutzfeldt-Jakob) che sono patologie neurodegenerative caratterizzate dall’accumulo intracerebrale di proteine tossiche.
Queste proteine rappresentano dei biomarcatori specifi-
ci di malattia e la loro identificazione nell’encefalo prelevato post-mortem permette di formulare una diagnosi certa. Senza riscontro neuropatologico, la diagnosi di queste malattie quando i pazienti sono in vita non può essere definitiva ma possibile o probabile. Con il mio gruppo di ricerca stiamo sviluppando e ottimizzando dei test diagnostici molto sensibili che consentano di identificare la presenza di queste proteine tossiche in tessuti periferici e fluidi biologici facilmente prelevabili, quali ad esempio le urine, il sangue, le lacrime e la mucosa olfattiva. Per alcune di queste patologie, quali ad esempio la malattia di Parkinson e la demenza con corpi di Lewy, esistono dei sintomi premonitori che possono manifestarsi anche 10-15 anni prima della comparsa dei sintomi caratteristici di queste malattie. Questi comprendono, tra gli altri, un deficit delle funzioni olfattive e disturbi del sonno REM (iRBD). Per alcuni soggetti questi disturbi possono rappresentare eventi occasionali che non hanno alcun legame con queste patologie neurodegenerative. Ma per altri soggetti rappresentano invece un sintomo prodromico di malattia”. Il dott. Fabio Moda e il Suo team stanno anche cercando di identificare i soggetti a maggior rischio di sviluppare tali patologie. “Con il mio gruppo di ricerca,” spiega il dott. Fabio Moda,” stiamo conducendo uno studio dove soggetti con iRBD vengono sottoposti a prelievo di mucosa olfattiva, urina e sangue per verificare se, mediante tecniche ultrasensibili, sia possibile già rilevare le proteine tossiche associate alle patologie neurodegenerative. Questi risultati, se confermati, consentirebbe di identificare i soggetti a maggior rischio di sviluppare la patologia, monitorarli nel tempo e valutare la possibilità di intraprendere terapie già in fasi precoci”.
Un altro argomento di interesse è rappresentato dallo studio delle alterazioni del microbiota (disbiosi) a livello della mucosa olfattiva e del sangue per valutare se queste possano avere una qualche influenza sull’insorgenza e/o sullo sviluppo di malattia. Le stesse tecniche analitiche vengono, dal team del dott. Fabio Moda, applicate ad uno studio sui cervidi norvegesi relativo alla malattia da prioni chiamata Deperimento Cronico (CWD) per azioni preventive di tutela della salute dell’uomo. “Stiamo impiegando le medesime tecniche analitiche per ricercare la presenza di una di queste proteine tossiche (il prione) in urina, sangue, muscolo e feci di cervidi (alci, renne e cervi) norvegesi in cui è recentemente comparsa una malattia da prioni chiamata Deperimento Cronico (CWD) e che si trasmette in modo efficiente all’interno di questa specie. È possibile che prioni escreti con urina e feci di animali apparentemente sani, ma che stanno in realtà incubando la malattia, siano in grado di infettare i cervidi (ma anche gli ovini) che brucano l’erba o leccano le rocce (per recuperare il sale) presenti in aree contaminate da questi campioni biologici. Non è oggi possibile escludere che questa malattia sia potenzialmente trasmissibile all’uomo, ad esempio mediante consumo di carni infette (come successe nel caso ben noto a
tutti della mucca pazza).
Tramite le piattaforme di cui siamo dotati nel nostro centro di ricerca dell’IRCCS Ist. Neurologico Carlo Besta, valuteremo se il prione può essere identificato in questi campioni biologici anche in fasi precliniche di malattia. Questo progetto sta valutando anche la potenziale trasmissibilità della CWD all’uomo mediante l’uso di specifici modelli sperimentali. Se si scoprisse che il prione è presente nei muscoli di animali in fase preclinica di malattia e se sarà evidenziato un rischio di trasmissione all’uomo, questo sarà fondamentale per permettere alle autorità competenti di mettere in atto delle strategie preventive adeguate”. La natura quindi e l’osservazione degli animali e dell’ambiente che ci circonda aiuta a comprendere meglio chi siamo, come nel passato ci siamo comportati e quali sono i rischi del futuro nel nostro interagire con cosa mangiamo, gli animali con cui veniamo in contatto, gli stili di vita che seguiamo.
Non è facile fare comunicazione su temi scientifici soprattutto di questo tipo e ci sono dei progetti europei da segnalare quali ENJOI (ENgagement and JOurnalism Innovation for Outstanding Open Science Communication – sito https:// enjoiscicomm.eu) che è stato presentato di recente a Milano alla assemblea generale di EUSJA, associazione dei giornalisti europei. Attraverso una combinazione di metodologie e in collaborazione con produttori, utenti target e parti interessate della comunicazione scientifica, ENJOI ha co-creato e selezionato una serie di standard, principi e indicatori (SPI) condensati in un Manifesto per una comunicazione della scienza aperta e sta implementando una serie di azioni quali workshop di coinvolgimento, laboratori, ricerca sul campo e partecipativa, fasi di valutazione e test. Sta inoltre costruendo un osservatorio come prodotto di riferimento per mettere a disposizione tutti i risultati e gli output per favorire lo sviluppo delle capacità e la collaborazione di tutti gli attori del settore. ENJOI sta lavorando in quattro Stati: Belgio, Italia, Portogallo e Spagna, tenendo conto di diversi contesti culturali.
Il progetto europeo QUEST (QUality and Effectiveness in Science and Technology communication - https://questproject.eu/) ha cercato invece di meglio definire, misurare e supportare una comunicazione scientifica efficace. Il progetto recentemente completato ha sostenuto la creazione di una comunità di parti interessate della comunicazione scientifica e ha migliorato la qualità della comunicazione con strumenti e linee guida innovativi in tre aree di interesse, tra cui il cambiamento climatico. QUEST ha progettato una serie di risorse per aiutare i comunicatori scientifici a migliorare il modo in cui trasmettono i loro messaggi. Il progetto RETHINK valuta i modi in cui si misura la qualità della comunicazione scientifica online. Ha preso in considerazione diversi approcci, tra cui la comunicazione web e i social media per aumentare la comprensione di argomenti correlati alla scienza.
RETHINK ha concluso che la comunicazione della scien-
za non riesce a connettersi con molti e tende a raggiungere quelli con livelli relativamente alti di istruzione formale e un interesse intrinseco per la scienza. Il progetto europeo TRESCA (Trustworthy, Reliable and Engaging Scientific Communication Approaches https://trescaproject.eu/) mira a capire come la comunicazione della scienza possa aiutare a ricostruire la fiducia nella scienza e negli esperti scientifici. TRESCA sta inoltre sviluppando una app per aiutare le persone a controllare le affermazioni scientifiche che leggono online.
Ma di progetti europei ce ne sono molti alti visto che ci si è resi contro, soprattutto con la pandemia, che il ruolo dei giornalisti scientifici è prioritario per i cittadini e per informare in modo corretto su temi importanti come la salute, la ricerca e l’innovazione in tutti settori e che in ogni progetto di ricerca ci dovrebbe essere anche un giornalista scientifico per le attività di dissemination.
-Von Koenigswald, G. H. R. Fossil hominids from the Lower Pleistocene of Java. In Report of the Eighteenth Session of the International Geological Congress (ed. Butler, A. J.) 59–61 (International Geological Congress, 1948).
-Grine, F. E. & Franzen, J. L. Fossil hominid teeth from the Sangiran Dome (Java, Indonesia). Cour. Forsch. Inst. Senckenberg 171, 75–103 (1994).
-Matsu’ura, S. et al. Age control of the first appearance datum for Javanese Homo erectus in the Sangiran area. Science 367, 210–214 (2020).
-Tyler, D. E. Sangiran 5, (‘Pithecanthropus dubius’), Homo erectus, ‘Meganthropus,’ or Pongo? Hum. Evol. 18, 229–241 (2003).
-Joannes-Boyau, R. et al. Elemental signatures of Australopithecus africanus teeth reveal seasonal dietary stress. Nature 572, 112–115 (2019).
-Lüdecke, T. et al. Dietary versatility of Early Pleistocene hominins. Proc. Natl Acad. Sci. USA 115, 13330–13335 (2018).
-Nava, A. et al. Early life of Neanderthals. Proc. Natl Acad. Sci. USA 117, 28719–28726 (2020).
-Hinz, E. A. & Kohn, M. J. The effect of tissue structure and soil chemistry on trace element uptake in fossils. Geochim. Cosmochim. Acta 74, 3213–3231 (2010).
-Smith, T. M. et al. Disentangling isolated dental remains of Asian Pleistocene hominins and pongines. PLoS ONE 13, e0204737 (2018).
-Müller, W. et al. Enamel mineralization and compositional time-resolution in human teeth evaluated via histologically-defined LA-ICPMS profiles. Geochim. Cosmochim. Acta 255, 105–126 (2019).
-Kohn, M. J., Morris, J. & Olin, P. Trace element concentrations in teeth—a modern Idaho baseline with implications for archeometry, forensics, and palaeontology. J. Archaeol. Sci. 40, 1689–1699 (2013).
-Leinders, J. J. M. et al. The age of the hominid-bearing deposits of Java: state of the art. Geol. Mijnb. 64, 167–173 (1985).
Edizione mensile di Agenbio (Agenzia di stampa della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi) Testata registrata al n. 52/2016 del Tribunale di Roma Diffusione: www.fnob.it
Direttore responsabile: Claudia Tancioni
Redazione: Ufficio stampa Fnob
Progetto grafico e impaginazione: Ufficio stampa Fnob. Questo magazine digitale è scaricabile on-line dal sito internet www.fnob.it
Questo numero del “Giornale dei Biologi” è stato chiuso in redazione mercoledì 28 giugno 2023.
Contatti: +39 0657090205, +39 0657090225, Per la pubblicità, scrivere all’indirizzo
Gli articoli e le note firmate esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la Federazione Nazionale degli
Immagine di copertina: Polignano a Mare (Bari) © essevu/www.shutterstock.com

Si informano gli iscritti che gli uffici della Federazione forniranno informazioni telefoniche di carattere generale dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Tutte le comunicazioni dovranno pervenire tramite posta (presso Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, via Icilio 7, 00153 Roma) o all’indirizzo protocollo@cert.fnob.it, indicando nell’oggetto l’ufficio a cui la comunicazione è destinata.
È possibile recarsi presso le sedi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi previo appuntamento e soltanto qualora non sia possibile ricevere assistenza telematica. L’appuntamento va concordato con l’ufficio interessato tramite mail o telefono.
UFFICIO CONTATTO
Centralino 06 57090 200
Ufficio protocollo protocollo@cert.fnob.it
Commissario straordinario commissario.fnob@pec.it
Ufficio segreteria segreteria@fnob.it
Direzione direzione@fnob.it
Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
www.fnob.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
Giornale dei Biologi
Il Giornale dei Biologi